
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). Una nota di Filippo Di Giacomo - a cura di Federico La Sala
martedì 23 ottobre 2007.
- [...] Nella storia dei Comuni il sistema maggioritario apparve solo nel 1143, nella Chiesa era in uso da otto secoli. Ai Domenicani si deve il bicameralismo, il voto di fiducia, la libera elezione dei rappresentanti alle assemblee elettive e legislative e l’espressione dei tre principi strutturali della democrazia parlamentare: corpo elettivo, collettività deliberante, autorità esecutiva. Ai Predicatori e al loro Definitorio dobbiamo la struttura dei consigli dei ministri; furono loro a conferire alle assemblee legislative il diritto di revocare a metà mandato il superiore eletto, secondo il grado di attuazione del programma espresso nel momento in cui si era candidato al superiorato. I nostri ordinamenti comunali, provinciali e regionali traggono buona parte delle loro istituzioni dalle costituzioni domenicane di Raimondo di Peñafort del 1238-1240 e di Raimondo Bandello del 1254-1256. Il sindaco, ad esempio, era un laico a cui veniva affidata la gestione dei beni di un istituto religioso [...]
E la Chiesa inventò il ballottaggio
Le istituzioni religiose modello di quelle laiche
di FILIPPO DI GIACOMO (La Stampa, 17/10/2007 - 8:33)
Il monoteismo ostacola la democrazia? Gli studi storico-giuridici dimostrano che la democrazia moderna ha radici già nel V secolo, quando la Chiesa reintroduce due grandi principi. Il primo, riscoperto da Leone I nel 440, insegna che colui che deve governare su tutti deve essere eletto da tutti. Il secondo, spiega che ciò che interessa tutti come singoli va discusso e approvato da tutti.
La decisione di affidare a un’assemblea (che ha la summa potestas) la scelta di colui che guiderà un’abbazia apparve nel VI secolo chiaramente stabilita nel capitolo 64 della regola benedettina; con l’elezione, a chi veniva affidato il comando era anche precisato il fine politico del mandato: adattare il suo governo alle circostanze e ai caratteri dei sudditi.
Il consenso popolare nelle assemblee ecclesiali veniva sottoposto allo scrutinio. Scrutari significa pesare, ponderare, esaminare, penetrare il significato esatto della portata dei voti espressi in un’assemblea. Lo scrutinio permise la nascita del voto segreto e la Chiesa lo accettò nei monasteri già dal V secolo: diventerà prassi comune con il Concilio di Trento.
Nei Comuni, voto segreto e scrutinio apparvero per la prima volta negli statuti di Verona del 1225. Tanto per essere casuidici: il Parlamento inglese ammise il voto e lo scrutinio segreto solo nel 1872. La nascita della democrazia parlamentare viene fatta coincidere con l’istituzione del parlamento inglese, la «Magna Charta» del 1215, ma già nel 1115 i cistercensi si erano già dotati di una «Charta Charitatis» con cui ricorrevano a un parliamentum (parola e istituzione, quindi, nascono monastiche) che si riuniva per chiedere l’accordo della comunità prima di impegnarla in azioni e gravarla di imposte.
Per rendere accessibile il voto segreto a coloro che erano analfabeti, la fantasia democratica cristiana del VI secolo ricorse alle ballotte: fave chiare e scure, monete e medaglie di colore diverso: un colore per il «sì», l’altro per il «no». Dalle ballotte derivano infatti la parola ballottaggio e la locuzione parlamentare inglese «to black ball», bocciare una legge.
Ai monaci illetterati i moderni parlamentari inglesi devono il loro usuale metodo di votazione: alzarsi in piedi per approvare o respingere. Quando gli ecclesiastici erano colti, lo scrutinio avveniva per schedulas segrete deposte in modo visibile nell’urna. Il voto di fiducia, invece, nacque certosino, a cavallo del Mille: ogni anno l’assemblea si riuniva giudicando l’operato del superiore, in base al quale quest’ultimo veniva confermato o deposto.
Anche la convocazione legale di un’assemblea e il quorum hanno un’impronta ecclesiastica. Nella storia dei Comuni il sistema maggioritario apparve solo nel 1143, nella Chiesa era in uso da otto secoli. Ai Domenicani si deve il bicameralismo, il voto di fiducia, la libera elezione dei rappresentanti alle assemblee elettive e legislative e l’espressione dei tre principi strutturali della democrazia parlamentare: corpo elettivo, collettività deliberante, autorità esecutiva.
Ai Predicatori e al loro Definitorio dobbiamo la struttura dei consigli dei ministri; furono loro a conferire alle assemblee legislative il diritto di revocare a metà mandato il superiore eletto, secondo il grado di attuazione del programma espresso nel momento in cui si era candidato al superiorato. I nostri ordinamenti comunali, provinciali e regionali traggono buona parte delle loro istituzioni dalle costituzioni domenicane di Raimondo di Peñafort del 1238-1240 e di Raimondo Bandello del 1254-1256. Il sindaco, ad esempio, era un laico a cui veniva affidata la gestione dei beni di un istituto religioso.
La maggioranza qualificata resuscitò nella Chiesa nel 915, divenendo regola per l’elezione del Papa a partire dal 1179, ma è sulla maggioranza relativa che vale la pena riflettere: non piaceva a nessuno, nel 1205 il Papa la vietò e per tutto il XIII secolo scomparve da ogni istituzione.
Ma, dotate di maggiore realismo sulle realtà soggettive e quelle strutturali, le comunità monastiche ignorarono il precetto papale e continuarono a decidere come sempre: maggioranza assoluta nei primi due scrutini, maggioranza semplice a partire dal terzo. Anche il Papa capitolò e nel 1247 Innocenzo IV canonizzò l’intuizione di Benedetto da Norcia che, sei secoli prima, aveva intravisto una presunzione di maggior saggezza nella maggioranza, non nella massa. Non è quindi un caso se oggi le uniche assise elettive sovrannazionali dove il voto di un africano abbia lo stesso valore di quello di un americano sono il conclave moderno. E, a leggere la lista dei Papi che hanno saputo liberamente eleggere, ai cardinali cattolici Dio non fa venire alcun complesso antidemocratico: hanno sempre scelto personalità capaci di attraversare il loro tempo con la bussola della pace in mano.
Insieme a loro, i credenti nel Dio di Gesù Cristo si stanno educando a riconoscerlo vivo e presente nella diversità dei popoli e delle culture. Invece, la divinità degli idoli ciclicamente proposti in nome della complessità sociale sembra soprattutto dedita a predicare l’omologazione di tutti verso il quasi niente.
Stiamo pensando all’Onu e all’Unione europea: siamo proprio sicuri che il potere di veto concesso ai cinque membri permanenti del Palazzo di vetro e l’unanimità imposta al Consiglio dei capi di governo dell’Unione, con gli approssimativi sistemi giuridico-politici che ne conseguono, siano la panacea imprescindibile per organizzare il mondo globalizzato in senso democratico e partecipativo?
Sul tema, da un punto di vista storico-filosofico, nel sito e in rete, si cfr.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- "L’immagine del
corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza
che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della
nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di
un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato
di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è
Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua
unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognuno di noi, come è tutto intero
nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.
 L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
- L’IMPERATORE COSTANTINO, LA "PAROLA" DI "DIO", E LA FIGURA DI "MICHELE" - OGGI: [...] San Michele. Voi sapete che cosa vuol dire Michele? È un nome prettamente orientale, ebraico, che vuol dire: “Quis ut Deus?”, “Chi è come Dio?”. Questa parola è parola che ha vinto, parola vincente nel grande scontro tra il bene e il male. Questa parola - Michele, “Chi è come Dio?” - ha vinto [...] “Quis ut Deus?”. E questa parola vince, vince come una volta l’imperatore romano Costantino ha vinto nella Croce: “in hoc signo”, in questo segno vincerai. Vi auguro questa vittoria (GIOVANNI PAOLO II, "Visita Pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta e San Michele a Castel Romano", 13 febbraio 1994).
- USA (1630) - Come fare le cose con i testi: A Modell of Christian Charity di John Winthrop (Carla Vergaro - "L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA", 2017.)
 MONOTEISMO, CRISTIANESIMO E DEMOCRAZIA.
MONOTEISMO, CRISTIANESIMO E DEMOCRAZIA.
 LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO ... DEI "DUE SOLI". IPOTESI DI RILETTURA DELLA "DIVINA COMMEDIA".
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO ... DEI "DUE SOLI". IPOTESI DI RILETTURA DELLA "DIVINA COMMEDIA".
- STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE.
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE.
- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA
- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA
 "Deus caritas est": la verità recintata!!!
"Deus caritas est": la verità recintata!!!
- Il Papa:"Vorrei che la Chiesa mostrasse l’amore di Dio"
 Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
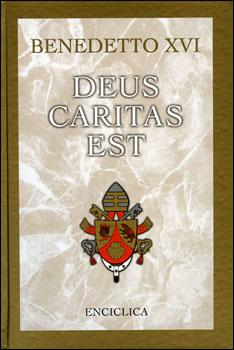
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
MESSAGGIO EV-ANGELICO E SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E MENZOGNA. L’ERRORE DI RATZINGER.
 SALVIAMO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA...
SALVIAMO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA...
Federico La Sala
Forum
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). --- La fraternità come principio di ordine sociale (di stefano Zamagni).19 gennaio 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA, E SOCIETÀ: LA COMUNE PATERNITÀ DI DIO, IL PROBLEMA DEI "TRE ANELLI", E I "FRATELLI TUTTI". A che gioco giochiamo?... *
- «Il deserto cresce; guai a chi in sè cela deserti» (F. Nietzsche) .
La fraternità come principio di ordine sociale
di Stefano Zamagni ("Bene comune", 31 dicembre 2020)
- Viviamo in un’epoca desertica del pensiero, che stenta a concepire la complessità della condizione umana. E’ un pensiero sbriciolato che fatica a vedere i rapporti fra le tante dimensioni della nostra crisi. Fraternità e amicizia sociale, al modo di vaccino sociale, ci indicano allora la via pervia di uscita dalla cupa situazione dell’esistente. In particolare la fraternità consente a persone che sono eguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali di esprimere diversamente il loro piano di vita, o il loro carisma, cioè la loro singolarità...
Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale è una autentica ispiera - il raggio di luce che, penetrando da una fessura in un ambiente in ombra, lo illumina rendendo visibile ciò che in esso staziona. Duplice la mira che la terza enciclica (dopo Lumen fidei, 2013 e Laudato sì, 2015) di papa Francesco persegue. Per un verso, risvegliare in tutti, credenti e non credenti o diversamente credenti, la passione per il bene comune, sollecitando tutti a trarne le conseguenze dirette. Per l’altro verso, fare chiarezza su concetti che troppo superficialmente vengono presi come sinonimi o quasi. La confusione di pensiero che ne deriva non giova né al dialogo né alla prospettazione delle necessarie linee di azione. Vedo di precisare.
Fraternità non ha lo stesso significato di fratellanza e ancor meno di solidarietà. Mentre quello di fratellanza è un concetto immanente che dice dell’appartenenza delle persone alla stessa specie o a una data comunità di destino, la fraternità è un concetto trascendente che pone il suo fondamento nel riconoscimento della comune paternità di Dio. La fratellanza unisce gli amici, ma li separa dai non amici; rende soci (socio è “colui che è associato per determinati interessi” (102) ) e quindi chiude gli uniti nei confronti degli altri.
 La fraternità, invece, proprio in quanto viene dall’alto (la paternità di Dio) è universale e crea fratelli, non soci, e dunque tende a cancellare i confini naturali e storici che separano. Il terzo termine che appare nella bandiera della Rivoluzione Francese (Liberté, egalité, fraternité) scaturisce dall’eguaglianza della specie e della natura di tutti gli uomini. Ma, come si legge nella Lumen fidei, 54, qualsiasi fraternità che sia priva del riferimento ad un Padre comune, quale suo fondamento, non riesce a sussistere.
La fraternità, invece, proprio in quanto viene dall’alto (la paternità di Dio) è universale e crea fratelli, non soci, e dunque tende a cancellare i confini naturali e storici che separano. Il terzo termine che appare nella bandiera della Rivoluzione Francese (Liberté, egalité, fraternité) scaturisce dall’eguaglianza della specie e della natura di tutti gli uomini. Ma, come si legge nella Lumen fidei, 54, qualsiasi fraternità che sia priva del riferimento ad un Padre comune, quale suo fondamento, non riesce a sussistere.Altrettanto diversa è la fraternità dalla solidarietà. È merito grande della cultura cristiana quello di aver saputo declinare, in termini sia istituzionali sia economici, il principio di fraternità facendolo diventare un asse portante dell’ordine sociale. È stata la scuola di pensiero francescana a dare a questo termine il significato che essa ha conservato nel corso del tempo. Ci sono pagine della Regola di Francesco che aiutano bene a comprendere il senso proprio del principio di fraternità. Che è quello di costituire, ad un tempo, il complemento e il superamento del principio di solidarietà. Infatti, mentre la solidarietà è il principio di organizzazione sociale che consente ai diseguali di diventare eguali, quello di fraternità è il principio che consente ai già eguali di esser diversi - si badi, non differenti.
La fraternità consente a persone che sono eguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali di esprimere diversamente il loro piano di vita, o il loro carisma, cioè la loro singolarità. Questa compresenza di uguaglianza e singolarità è ciò che caratterizza in modo unico il principio di fraternità. Le stagioni che abbiamo lasciato alle spalle, l’800 e soprattutto il ‘900, sono state caratterizzate da grosse battaglie, sia culturali sia politiche, in nome della solidarietà e questa è stata cosa buona; si pensi alla storia del movimento sindacale e alla lotta per la conquista dei diritti civili. Ma la buona società in cui vivere non può accontentarsi dell’orizzonte della solidarietà, perché mentre la società fraterna è anche una società solidale, il viceversa non è vero.
Cosa fa la differenza? La gratuità. Dove essa manca non può esserci fraternità. La gratuità, non è una virtù etica, come è la giustizia. Essa riguarda la dimensione sovraetica dell’agire umano; la sua logica è quella della sovrabbondanza. La logica della giustizia, invece, è quella dell’equivalenza, come già Aristotele insegnava. Capiamo allora perché la fraternità va oltre la giustizia. In una società, solo perfettamente giusta - posto che ciò sia realizzabile - non vi sarebbe spazio per la speranza. Cosa potrebbero mai sperare per l’avvenire i suoi cittadini? Non così in una società dove il principio di fraternità fosse riuscito a mettere radici profonde, proprio perché la speranza si nutre di sovrabbondanza.
Sorge spontanea la domanda: perché papa Francesco ha scelto la parabola del buon Samaritano come fondamento del suo approccio alla fraternità? La domanda ha senso perché il testo evangelico nulla dice (né lascia intendere) a proposito della relazione di reciprocità che, come sappiamo, è necessaria per conservare nel tempo il legame di fraternità. I rapporti tra fratelli sono di reciprocità, non di scambio e tanto meno di comando. La reciprocità è un dare senza perdere e un prendere senza togliere. Tra il Samaritano e la vittima che giace distesa a terra non sorge alcuna reciprocità. La parabola, dunque, è più icona della solidarietà o della fratellanza che non della fraternità in senso proprio. E allora? Il fatto è che papa Francesco con questa sua scelta ha voluto che comprendessimo appieno la differenza tra prossimità e vicinanza. Il levita e il sacerdote erano certamente vicini della vittima (tutti e tre giudei), ma non si sono fatti prossimo della stessa. Alla fratellanza basta la vicinanza; la fraternità postula la prossimità.
Dove ci portano, sul piano della pratica, le sottolineature di cui sopra? Per ragioni di spazio, soffermo qui l’attenzione su alcune soltanto delle implicazioni rilevanti quelle che reputo più urgenti per il tempo presente. Primo, occorre, una volta per tutte, rendersi conto dei guasti seri che la matrice culturale dell’individualismo libertario va producendo. L’individualismo è la posizione filosofica secondo cui è l’individuo che attribuisce valore alle cose e perfino alle relazioni interpersonali. Ed è sempre l’individuo il solo a decidere cosa è bene e cosa è male; quel che è lecito e illecito. In altro modo, è bene tutto ciò cui l’individuo attribuisce valore. Non esistono valori oggettivi per l’individualismo, ma solo valori soggettivi ovvero preferenze legittime. Di qui l’implicazione secondo cui si deve agire “etsi communitas non daretur” (come se la comunità non esistesse).
D’altro canto, il libertarismo è la tesi secondo cui per fondare la libertà e la responsabilità individuale è necessario ricorrere all’idea di autocausazione, per la quale pienamente libero è solamente l’agente auto-causato, quasi fosse Dio. Si può ora capire perché dal connubio tra individualismo e libertarismo, cioè dall’individualismo libertario, sia potuta scaturire la parola d’ordine di questa epoca: “volo ergo sum”, cioè, “io sono quel che voglio”. La radicalizzazione dell’individualismo in termini libertari, e quindi antisociali, ha portato a concludere che ogni individuo ha “diritto” di espandersi fin dove la sua potenza glielo consente. E’ la libertà come scioglimento dai legami l’idea oggi dominante nelle nostre società. Poiché limiterebbero la libertà, i legami sono ciò che deve essere sciolto. Equiparando erroneamente il concetto di legame a quello di vincolo si confondono i condizionamenti della libertà - i vincoli - con le condizioni della libertà - i legami, appunto. E questo perché l’individualismo libertario non riesce a concettualizzare la libertà di soggetti “quae sine invicem esse non possunt” (che senza reciprocità non possono essere). Se si ammette che la persona è un ente in relazione di prossimità con l’altro, il libertarismo non ha ragione d’essere.
Un secondo potente invito che ci viene dall’incalzante magistero di papa Francesco è quello di affrettare i tempi del passaggio dal modello tradizionale (e ormai obsoleto) di responsabilità ad un modello più ricco, all’altezza delle sfide in atto. L’interpretazione tradizionale di responsabilità la identifica infatti con il dare conto, rendere ragione (accountability) di ciò che un soggetto, autonomo e libero, produce o pone in essere. Tale nozione, postula dunque la capacità di un agente di essere causa dei suoi atti e in quanto tale di essere tenuto a “pagare” per le conseguenze negative che ne derivano. Questa, ancora prevalente, concezione della responsabilità lascia però in ombra il cosa significhi essere responsabili.
Da qualche tempo a questa parte, però, ha iniziato a prendere forma un’accezione di responsabilità che la colloca al di là del principio del libero arbitrio e della sola sfera della soggettività, per porla in funzione della vita, per fondare un impegno che vincoli nel mondo. Dal latino res-pondus, responsabilità significa essenzialmente portare il peso delle cose, prendersi cura dell’altro - come l’ “I care” di Lorenzo Milani (nella foto) ci ha insegnato. Non solamente si risponde “a” ma anche “di”. Da una parte, la responsabilità richiede, oggi, di porsi il problema dei vincoli cui le decisioni che assumiamo saranno esposte nel tempo per continuare ad essere efficaci. Dall’altra, la capacità di risposta non può essere solo riferita all’immediatezza delle circostanze presenti, ma deve includere quelle dimensioni temporali che assicurano una qualche continuità della risposta stessa. Ecco perché l’esperienza della responsabilità non può esaurirsi nella semplice imputabilità.
 E’ rimasta giustamente celebre l’affermazione di M.L. King secondo cui “può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Si è responsabili non solo e non tanto per quel che si fa, quanto piuttosto per quel che non si fa, pur potendolo fare. L’azione omissiva è sempre più grave di quella commissiva.
E’ rimasta giustamente celebre l’affermazione di M.L. King secondo cui “può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Si è responsabili non solo e non tanto per quel che si fa, quanto piuttosto per quel che non si fa, pur potendolo fare. L’azione omissiva è sempre più grave di quella commissiva.Di una terza implicazione pratica del discorso sviluppato in Fratelli tutti giova dire. Se si vuole avere ragione dell’indegno fenomeno delle crescenti ingiustizie sociali e della diffusione a macchia d’olio di atteggiamenti aporofobici - l’aporofobia nel senso di A. Cortina è il disprezzo del povero e del diverso - occorre pensare seriamente ad un modello credibile di governance a livello globale. Qual è la difficoltà a tale riguardo? Quella di come conciliare le regole della governance interna dei singoli paesi, ognuno dei quali ha la sua storia specifica, le sue norme sociali di comportamento, la sua matrice culturale con l’uniformità delle regole che inevitabilmente caratterizzano la governance globale. Mai dimenticare, infatti, che i vincoli esterni al paese, quando questo deve dare forma alle proprie politiche domestiche, comportano sempre un costo in termini di legittimità democratica - costo che, come in questo tempo sta accadendo, finisce col rafforzare le spinte irrazionali verso il populismo sovranista. Si tratta allora di scegliere tra due concezioni alternative di governance economica globale, note come “globalization enhancing global governance” e “democracy-enhancing global governance”.
L’idea di fondo della seconda opzione è che quando si mette mano al disegno delle regole a livello transnazionale occorre inserire tra gli obiettivi da perseguire non solamente l’aumento dell’efficienza nell’allocazione delle risorse, e quindi del reddito, ma anche l’allargamento della base democratica. Per dirla in altro modo, è bensì vero che la globalizzazione accresce lo spazio dei diritti umani negativi (cioè la libertà da), ma restringe lo spazio, se non corretta da clausole di salvaguardia sociale, dei diritti umani positivi (cioè la libertà di). Papa Francesco non esita a prendere posizione a favore della seconda opzione. (Cfr. n.154 e segg.).
Una novità di non poco conto di questa enciclica, che non è passata inosservata e che continuerà a lungo a far discutere, è costituita dal cap. V, significativamente e provocatoriamente intitolato “La migliore politica”. Vi sono due modi errati - ci dice papa Francesco - di porsi di fronte alle sfide di questo momento. Da un lato, quello di chi cede alla tentazione di restare al di sopra della realtà con l’utopia; dall’altro, quello di chi si colloca al di sotto della realtà con la distopia, con la rassegnazione. Non possiamo cadere in trappole del genere. Non possiamo vagare tra l’ottimismo spensierato di chi vede il processo storico come una marcia trionfale dell’umanità verso la sua completa realizzazione e il cinismo disperante di chi pensa, con Kafka, che “esiste un punto di arrivo, ma nessuna via”.
Accogliere lo sguardo della fraternità significa oggi, questo: non considerarsi né come il mero risultato di processi che cadono fuori del nostro controllo, né come una realtà autosufficiente senza bisogno di rapporti con l’altro. Significa, in altri termini, pensare che ciò che ci aspetta non è mai del tutto determinato da quanto ci precede. Se si vuole che l’ordine sociale che chiamiamo capitalismo possa rispettare pienamente il diritto di ciascun individuo a decidere da sé come dare valore alla propria vita e, al tempo stesso, possa dimostrare uguale considerazione per il destino di ciascuna persona, non c’è altra via che quella della politica, ma che sia migliore! Prendere atto che il capitalismo rischia oggi la paralisi, o, peggio, il collasso, perché sta diventando più capitalistico di quanto gli sia utile, è il primo passo per avviare un progetto credibile di trasformazione dell’esistente ordine sociale.
Un passo famoso di William Blake - poeta e artista nutrito delle Sacre Scritture - ci aiuta ad afferrare la potenza del principio di fraternità: “Ho cercato la mia anima e non l’ho trovata. Ho cercato Dio e non l’ho trovato. Ho cercato mio fratello e li ho trovati tutti e tre”. Invero, è nella pratica del dono come gratuità che la persona incontra congiuntamente il proprio io, l’altro e Dio. Viviamo in un’epoca desertica del pensiero, che stenta a concepire la complessità della condizione umana. E’ un pensiero sbriciolato che fatica a vedere i rapporti fra le tante dimensioni della nostra crisi. Fraternità e amicizia sociale, al modo di vaccino sociale, ci indicano allora la via pervia di uscita dalla cupa situazione dell’esistente.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CIVILTÀ DELL’AMORE E VOLONTÀ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica di Papa Ratzinger.
"AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FLS
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). ---Alla scuola della Buona Notizia.“Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano”, pubblicato dalla Cei (di Riccardo Maccioni).9 gennaio 2021, di Federico La Sala
Cei. Alla scuola della Buona Notizia. “Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano”
“Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano” pubblicato dalla Cei, strumento al servizio della Parola
 Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti
Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recentidi Riccardo Maccioni *
- [Foto] Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti
Nel segno dello studio, della conoscenza, del dialogo. Soprattutto nel segno della Parola, che diventa preghiera, vita spirituale, servizio, faro della comunità. La pubblicazione de “Il Nuovo Testamento greco latino italiano” non riguarda infatti solo gli specialisti ma, nella ricerca di una sempre maggiore fedeltà alle fonti, si propone anche come sostegno a un cammino di fede maturo.
Per tutti. Dal parroco che prepara l’omelia domenicale, al credente forse un po’ più preparato della media e desideroso di approfondire la Buona Notizia. Il volume (1854 pagine su carta Bibbia avoriata, 80 euro) è pubblicato dalla “Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena” della Conferenza episcopale italiana. A curarlo il cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze e Valdo Bertalot già segretario generale della Società Biblica in Italia.
Un’opera importante che riporta il testo del Nuovo Testamento greco con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti: The Greek New Testament-5th Revised edition/GNT (Deutsche Bibelgesellschaft DBG, 2014, con relativo apparato critico-testuale), Nova Vulgata-Bibliorum Sacrorum Editio, Editio typica altera/NV (Libreria Editrice Vaticana 1986 con relative note), La Sacra Bibbia-Versione ufficiale della Conferenza episcopale italiana/Cei 2008 con relative note.
- Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti. I curatori dell’opera sono stati il cardinale Betori e Bertalot già segretario generale della Società Biblica in Italia
Il nostro lavoro - spiega Bertalot - si caratterizza per alcune significative novità. Sotto il profilo editoriale «rappresenta, fatta eccezione per quella della DBG, l’unica pubblicazione che riporta il testo greco insieme all’intero apparato di critica testuale del GNT frutto di un comitato editoriale internazionale e interconfessionale». Inoltre «è la prima volta che una Conferenza episcopale nazionale presenta ufficialmente il GNT e la propria versione ufficiale della Bibbia arricchita dal testo con valore normativo della Nova Vulgata». C’è poi da sottolineare l’aspetto più prettamente ecumenico del lavoro, nel solco di un percorso iniziato con la stagione conciliare. Una dimensione - prosegue Bertalot - che «investe pienamente la collaborazione fra le diverse confessioni cristiane per lo studio della Bibbia, per la sua traduzione e trasmissione nell’opera missionaria di annuncio della Parola di Dio». Ma c’è un altro aspetto da sottolineare, quantomeno da non sottovalutare, e riguarda il dato per così dire “temporale” della pubblicazione. Il Nuovo Testamento trilingue esce infatti in parallelo alla Lettera apostolica “Scripturae Sacrae affectus” scritta da papa Francesco per il XVI centenario della morte di san Girolamo cui si deve la celebre, fulminante espressione: «Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est». L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo.
 Un “monito” ricordato dal cardinale Betori durante la presentazione, il 29 ottobre scorso, dell’opera al Papa, nella speranza «che possa essere uno strumento per far crescere la conoscenza di Cristo, perché, come da lei auspicato, ciascuno diventi capace di aprire il libro sacro e di trarne i frutti inestimabili di sapienza, di speranza e di vita».
Un “monito” ricordato dal cardinale Betori durante la presentazione, il 29 ottobre scorso, dell’opera al Papa, nella speranza «che possa essere uno strumento per far crescere la conoscenza di Cristo, perché, come da lei auspicato, ciascuno diventi capace di aprire il libro sacro e di trarne i frutti inestimabili di sapienza, di speranza e di vita».- Due estratti da “Il Nuovo Testamento” trilingue con il raffronto tra italiano, latino e greco. Riguardano la preghiera del Padre Nostro e l’Inno alla carità.
IL PADRE NOSTRO (Matteo 6,8-13)
 9 Voi dunque pregate cosi: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
9 Voi dunque pregate cosi: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
 10 venga il tuo regno, sia fatta la tua volonta, come in cielo cosi in terra.
10 venga il tuo regno, sia fatta la tua volonta, come in cielo cosi in terra.
 11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
 12 e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
12 e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
 13 e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
13 e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 9 Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
9 Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
 10 adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
10 adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
 11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie;
11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie;
 12 et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
12 et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
 13 et ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a Malo.
13 et ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a Malo.- [...]
PIÙ GRANDE E’ LA CARITÀ
(1 Corinzi 13, 1-6)
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
 2 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
2 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
 3 E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
3 E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
 4 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,
4 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,
 5 non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
5 non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
 6 non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
6 non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
 7 Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
7 Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Si linguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens.
Si linguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens.
 2 Et si habuero prophetiam et noverim mysteria omnia et omnem scientiam, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non habuero, nihil sum.
2 Et si habuero prophetiam et noverim mysteria omnia et omnem scientiam, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non habuero, nihil sum.
 3 Et si distribuero in cibos omnes facultates meas et si tradidero corpus meum, ut glorier, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest.
3 Et si distribuero in cibos omnes facultates meas et si tradidero corpus meum, ut glorier, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest.
 4 Caritas patiens est, benigna est caritas, non aemulatur, non agit superbe, non inflatur,
4 Caritas patiens est, benigna est caritas, non aemulatur, non agit superbe, non inflatur,
 5 non est ambitiosa, non quaerit, quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum,
5 non est ambitiosa, non quaerit, quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum,
 6 non gaudet super iniquitatem, congaudet autem veritati;
6 non gaudet super iniquitatem, congaudet autem veritati;
 7 omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
7 omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.- [...]
DA SAPERE Lo scorso 29 ottobre la consegna al Papa
Il “Nuovo Testamento greco latino italiano”, è pubblicato dalla Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena della Conferenza episcopale italiana. Si tratta di un ampio volume (1854 pagine su carta avoriata) che presenta il testo greco con a fronte quello italiano e latino nelle recenti autorevoli edizioni: “The Greek New Testament-5th Revised edition” (Deutsche Bibelgesellschaft o DBG 2014), Nova Vulgata-Bibliorum Sacrorum Editio, Editio typica altera (Libreria editrice vaticana 1986), La Sacra Bibbia versione ufficiale della Cei (Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena 2008)). La pubblicazione si apre con una ricca presentazione di A. Kurschus, praeses della Chiesa evangelica della Westfalia e presidente della DBG, del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura e del cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze, quest’ultimo curatore dell’opera insieme a Valdo Bertalot, già segretario generale della Società Biblica in Italia che firma invece la prefazione.
A completare il libro anche introduzioni specifiche per ogni lingua del testo, sei diversi indici e quattro carte geografiche sul mondo biblico. Il Nuovo Testamento trilingue è stato consegnato il 29 ottobre scorso al Papa di cui richiama, nella presentazione, la Lettera apostolica “Scripturae Sacrae affectus” dedicata, nel XVI centenario della morte, a san Girolamo, definito dal Pontefice «infaticabile studioso, traduttore, esegeta, profondo conoscitore e appassionato divulgatore della Sacra Scrittura». Un amore alla Bibbia che Francesco sottolinea attraverso l’immagine spesso associata al santo di “Biblioteca di Cristo. Una biblioteca perenne - spiega Francesco - che continua a insegnarci che cosa significhi l’amore di Gesù, «indissociabile dall’incontro con la sua Parola». La distribuzione dell’opera è curata direttamente dalla Libreria Editrice Vaticana (Via della Posta, 00120 Città del Vaticano; email: commerciale.lev@spc.va; sito: https://www.libreriaeditricevaticana.va/it/).
* Avvenire, sabato 9 gennaio 2021 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. --- "OIKONOMIA" E cAPITALISMO. È quel poco che vale davvero (di Luigino Bruni).).19 gennaio 2020, di Federico La Sala
Oikonomia /2.
È quel poco che vale davvero
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 18 gennaio 2020)
- Il capitalismo non è, in primo luogo, un sistema economico di distribuzione di possesso, ma un sistema complessivo di cultura e di vita
- Max Scheler, L’avvenire del capitalismo
Il pensiero economico di Karl Marx è ancora un passaggio obbligato per chi voglia indagare la natura sacrale del nostro capitalismo. Le sue domande - meno le sue risposte - sono ancora capaci di aprirci squarci profondi sull’economia del nostro tempo, farci intravedere orizzonti alti ancora troppo poco esplorati, soprattutto da quando, una trentina di anni fa, con il crollo del comunismo reale si pensò di far crollare anche Marx, come se un autore non sia eccedente rispetto alla traduzione storica del suo stesso pensiero. Sia Walter Benjamin sia Marx nella loro analisi della religione capitalistica attribuiscono un ruolo centrale ai prodotti: alle merci. Marx nel "Capitale" pone all’inizio del suo ragionamento il tema del carattere feticistico delle merci, uno dei pilastri metodologici della sua critica. Carattere feticistico, cioè la merce come feticcio.
Il feticcio è un elemento del mondo sacro, tipico degli stadi originari e primitivi della religiosità umana. È un oggetto inanimato, cui le comunità e le singole persone attribuiscono proprietà magiche o soprannaturali. La parola portoghese (feitiço) venne usata dai navigatori moderni per indicare amuleti e totem che trovavano nei popoli africani, e più tardi fu parzialmente estesa anche a oggetti religiosi di tipo sacrale, a immagini di forze soprannaturali.
 Quando Marx ricorre a questa espressione per caratterizzare le merci nel capitalismo, il suo riferimento alla religione era molto esplicito e intenzionale. Scriveva infatti: «Per trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti, dotate di vita propria, che stanno in rapporto fra di loro e in rapporto con gli uomini. Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. Questo io chiamo il feticismo che s’appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono prodotti come merci, e che quindi è inseparabile dalla produzione delle merci». (Il capitale, Libro 1). Come dirà in una nota, citando l’economista italiano Ferdinando Galiani, «il valore è un rapporto tra persone, celato nel guscio di un rapporto tra merci».
Quando Marx ricorre a questa espressione per caratterizzare le merci nel capitalismo, il suo riferimento alla religione era molto esplicito e intenzionale. Scriveva infatti: «Per trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti, dotate di vita propria, che stanno in rapporto fra di loro e in rapporto con gli uomini. Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. Questo io chiamo il feticismo che s’appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono prodotti come merci, e che quindi è inseparabile dalla produzione delle merci». (Il capitale, Libro 1). Come dirà in una nota, citando l’economista italiano Ferdinando Galiani, «il valore è un rapporto tra persone, celato nel guscio di un rapporto tra merci».Per Marx le merci sono feticci perché sono realtà inanimate che rimandano a qualcosa di vivo: ai rapporti tra persone. Nei sistemi di produzione passata, era immediato legare la merce al suo produttore, ma nel sistema capitalistico noi attribuiamo alle merci una esistenza autonoma, quasi magica o arcana.
 Ecco allora la definizione di merce che ci dà Marx: «A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. ... Appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare».
Ecco allora la definizione di merce che ci dà Marx: «A prima vista, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi, risulta che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici. ... Appena si presenta come merce, il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente sovrasensibile. Non solo sta coi piedi per terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che se cominciasse spontaneamente a ballare».
 Le merci acquistano dunque una esistenza propria rispetto agli uomini e alle donne che le hanno prodotte (e alle macchine e ai robot): qui sta quello che Marx chiama l’arcano. Inoltre, per Marx, è evidente che questo potere religioso si attiva solo nel capitalismo: «Appena ci rifugiamo in altre forme di produzione, scompare subito tutto il misticismo del mondo delle merci, tutto l’incantesimo e la stregoneria che circondano di nebbia i prodotti del lavoro sulla base della produzione di merci».
Le merci acquistano dunque una esistenza propria rispetto agli uomini e alle donne che le hanno prodotte (e alle macchine e ai robot): qui sta quello che Marx chiama l’arcano. Inoltre, per Marx, è evidente che questo potere religioso si attiva solo nel capitalismo: «Appena ci rifugiamo in altre forme di produzione, scompare subito tutto il misticismo del mondo delle merci, tutto l’incantesimo e la stregoneria che circondano di nebbia i prodotti del lavoro sulla base della produzione di merci».Misticismo, incantesimo, stregoneria.
In realtà, se prendiamo sul serio l’immagine forte della merce come feticcio, ci accorgiamo subito che il nome più adatto per il capitalismo sarebbe idolatria, essendo i feticci gli abitanti del tipico ambiente sacro dei culti idolatrici, non delle religioni, tanto meno quella ebraico-cristiana.
 Ma che cos’è l’idolatria? E perché la Bibbia l’ha tanto combattuta, e i profeti in particolare ne hanno fatto il loro principale nemico (insieme ai falsi profeti)? Perché dietro la loro battaglia teologica ce n’è una antropologica che vi si aggiunge: tutte le volte che un uomo inizia ad adorare un oggetto, diventa meno uomo; perché quando qualcuno rappresenta Dio in oggetti o immagini, non riuscirà mai a eguagliare la sola immagine vera e lecita di Dio sulla terra: l’uomo e la donna, creati "a sua immagine". Tutte le altre immagini della divinità sono scarabocchi teologici e antropologici. Dietro la lotta anti-idolatrica c’è dunque un grande umanesimo.
Ma che cos’è l’idolatria? E perché la Bibbia l’ha tanto combattuta, e i profeti in particolare ne hanno fatto il loro principale nemico (insieme ai falsi profeti)? Perché dietro la loro battaglia teologica ce n’è una antropologica che vi si aggiunge: tutte le volte che un uomo inizia ad adorare un oggetto, diventa meno uomo; perché quando qualcuno rappresenta Dio in oggetti o immagini, non riuscirà mai a eguagliare la sola immagine vera e lecita di Dio sulla terra: l’uomo e la donna, creati "a sua immagine". Tutte le altre immagini della divinità sono scarabocchi teologici e antropologici. Dietro la lotta anti-idolatrica c’è dunque un grande umanesimo.Questa stessa battaglia ha portato la Bibbia a criticare radicalmente anche tutte le presenze "naturali" di Dio nel mondo, arrivando a cancellare dai suoi racconti anche le tracce di riti religiosi agricoli, come i canti di lutto per l’ultimo covone o per l’ultimo grappolo d’uva, dove i contadini, piangendo, chiedevano loro perdono di doverli "uccidere", e li pregavano di "risorgere" ancora nella nuova stagione. In alcune culture si inumava l’ultimo covone, si recitava il credo e si attendeva che "risorgesse".
 Non dobbiamo dimenticare che le prime intuizioni di una vita che potesse continuare oltre la morte naturale, gli esseri umani l’hanno imparata dal ciclo di morte-resurrezione dei campi. E non a caso molti padri della Chiesa e molti vescovi hanno continuato a recitare queste preghiere naturali e agricole, intrecciandole con quelle cristiane. Come in un Paternoster medio alto-tedesco del XIII secolo, citato da Ernesto de Martino, dove si legge che Cristo fu «seminato dal Creatore, germogliò, venne a maturazione, fu mietuto, legato in un covone, trasportato nell’aia, trebbiato, vagliato, macinato, chiuso nel forno, e infine dopo tre giorni tratto fuori e mangiato come pane». Non sarà perfetta teologia, ma è Padrenostro splendido e vero come la nostra gente povera delle campagne.
Non dobbiamo dimenticare che le prime intuizioni di una vita che potesse continuare oltre la morte naturale, gli esseri umani l’hanno imparata dal ciclo di morte-resurrezione dei campi. E non a caso molti padri della Chiesa e molti vescovi hanno continuato a recitare queste preghiere naturali e agricole, intrecciandole con quelle cristiane. Come in un Paternoster medio alto-tedesco del XIII secolo, citato da Ernesto de Martino, dove si legge che Cristo fu «seminato dal Creatore, germogliò, venne a maturazione, fu mietuto, legato in un covone, trasportato nell’aia, trebbiato, vagliato, macinato, chiuso nel forno, e infine dopo tre giorni tratto fuori e mangiato come pane». Non sarà perfetta teologia, ma è Padrenostro splendido e vero come la nostra gente povera delle campagne.Ricordo ancora, bambino, i miei bisnonni recitare improbabili preghiere meticce di latino-dialetto-italiano, durante i tempi del raccolto o nei lutti. Non conoscevano i dogmi trinitari, avevano idee molto vaghe sulla differenza ontologica tra Gesù e la Madonna. Quando prendevano la comunione non sapevano nulla della "sostanza" e degli "accidenti". Ma sapevano che quel pane era pane, e quindi era già sacro perché da esso dipendeva la vita e la morte; e capivano che quel pane della Messa era un pane diverso, e per questo accostarsi alla comunione aveva per loro una solennità e una densità teologica che io prego sempre di ritrovare, un giorno, fosse anche l’ultimo.
 Certo, troveremo sempre teologi e scribi capaci di fini ragionamenti con in mano pezze d’appoggio in documenti del magistero per condannare i canti del lutto del covone e le preghiere dei miei nonni, per separarsi da quel mondo di ignoranza e di feticci. Ma se c’è un paradiso - e deve esserci, e i poveri lo devono abitare - insieme ai salmi degli angeli vi ritroveremo anche i canti della vendemmia e del raccolto, perché impastati di carne e di sangue, e quindi più veri di molti canti polifonici cantati senza poveri e senza dolore.
Certo, troveremo sempre teologi e scribi capaci di fini ragionamenti con in mano pezze d’appoggio in documenti del magistero per condannare i canti del lutto del covone e le preghiere dei miei nonni, per separarsi da quel mondo di ignoranza e di feticci. Ma se c’è un paradiso - e deve esserci, e i poveri lo devono abitare - insieme ai salmi degli angeli vi ritroveremo anche i canti della vendemmia e del raccolto, perché impastati di carne e di sangue, e quindi più veri di molti canti polifonici cantati senza poveri e senza dolore.Ed ecco perché la stessa Bibbia, mentre ha combattuto duramente i riti e i simboli della fertilità insieme a quelli astrali, nelle sue pagine poetiche e sapienziali ci dona meravigliose parole sulla luna, le stelle, sui cieli "che narrano la gloria di Dio", sulla bellezza degli animali (Giobbe), sull’eros e sulla vita (Cantico). L’uomo biblico vede Dio (senza vederlo), lo sente nel tempio, lo ascolta nei profeti, lo vede e lo sente nell’uomo e nella donna, ma lo vede e lo sente anche nella "nube", nella "colonna di fuoco", nel fuoco di Elia, "nella leggera brezza del silenzio". Per affermare la sua vera diversità in un mondo dominato da una religione naturale, la Bibbia ha dovuto assolutizzare la sua critica alla dimensione religiosa delle cose, alla natura, agli alberi, alla creazione. Ma non l’ha mai cancellata, perché era vera.
 Credo che un profeta biblico avrebbe almeno capito la frase che Ismaele dice parlando del suo compagno idolatra, Queequeg, in Moby Dick, il capolavoro (anche teologico) di Melville: «Come potevo allora unirmi a questo selvaggio idolatra nell’adorazione del suo pezzo di legno? Ma che cos’è adorare? Credi davvero, Ismaele, che il magnanimo Dio del cielo e della terra - pagani e tutti quanti inclusi - possa mai essere geloso di un insignificante pezzo di legno nero? Impossibile! Allora, che cos’è adorare?». Non sarebbe possibile nessun dialogo vero con il mondo delle religioni animiste, né con l’induismo, se non pensassimo qualcosa di simile a quanto dice Ismaele.
Credo che un profeta biblico avrebbe almeno capito la frase che Ismaele dice parlando del suo compagno idolatra, Queequeg, in Moby Dick, il capolavoro (anche teologico) di Melville: «Come potevo allora unirmi a questo selvaggio idolatra nell’adorazione del suo pezzo di legno? Ma che cos’è adorare? Credi davvero, Ismaele, che il magnanimo Dio del cielo e della terra - pagani e tutti quanti inclusi - possa mai essere geloso di un insignificante pezzo di legno nero? Impossibile! Allora, che cos’è adorare?». Non sarebbe possibile nessun dialogo vero con il mondo delle religioni animiste, né con l’induismo, se non pensassimo qualcosa di simile a quanto dice Ismaele.Non a caso né per sbaglio il cattolicesimo ha sviluppato e coltivato una visione sacramentale della realtà, dove le "cose" possono contenere segni e messaggi che dicono qualcosa su Dio, senza essere Dio. L’incarnazione ha dato sostanza spirituale alla storia, e quindi alle sue cose, al lavoro umano, ai suoi manufatti. Quel giovane albero del bosco di Gerusalemme, lavorato da un falegname di patiboli, non poteva saperlo ma è entrato, con i chiodi, nel seno della Trinità, per sempre.
 Farebbe solo sorridere, se non fosse drammatico, vedere grandi difensori della fede autentica che oggi si scagliano contro l’idolatria (vedi Sinodo per l’Amazzonia) a motivo dei sincretismi che i poveri hanno sempre fatto e fanno, mentre non sono affatto turbati dall’idolatria del capitalismo, che in genere applaudono. In realtà, l’idolatria del capitalismo è molto più vicina, nello spirito, a quella combattuta dalla Bibbia. Perché, diversamente dai riti della campagna dei nostri antenati, che sentivano nelle cose la presenza vera dello stesso Dio, sotto le merci del nostro consumismo c’è lo stesso hevel (nulla) degli spaventapasseri-idoli criticati da Geremia.
Farebbe solo sorridere, se non fosse drammatico, vedere grandi difensori della fede autentica che oggi si scagliano contro l’idolatria (vedi Sinodo per l’Amazzonia) a motivo dei sincretismi che i poveri hanno sempre fatto e fanno, mentre non sono affatto turbati dall’idolatria del capitalismo, che in genere applaudono. In realtà, l’idolatria del capitalismo è molto più vicina, nello spirito, a quella combattuta dalla Bibbia. Perché, diversamente dai riti della campagna dei nostri antenati, che sentivano nelle cose la presenza vera dello stesso Dio, sotto le merci del nostro consumismo c’è lo stesso hevel (nulla) degli spaventapasseri-idoli criticati da Geremia.Nel mondo della povertà, dentro le cose - nel pane, nel grano, nel vino, nelle piante, nei pochi oggetti... - si riesce a sentire il sacro buono anche perché attraverso quelle pochissime cose scorrevano la vita e la morte. Il nostro capitalismo moltiplica all’infinito le cose, ma non ne moltiplica il valore. Se possiedo un solo vestito buono, una sola penna buona, una sola bicicletta, un solo giocattolo e questi da uno diventano due, tre, dieci, il valore del primo vestito e della prima penna non aumentano ma si dimezzano, si riducono sempre più fino a scomparire se il numero (denominatore) diventa infinito. Il vestito buono ha un valore infinito proprio perché è unico. E quindi lo riparo, lo salvo, lo curo, e non lo "uso e getto". Nella povertà le cose hanno un grande valore, e la prima povertà dell’abbondanza è la scomparsa del valore dei beni che abbiamo, diventati tutti merci.
 Quando la vita ci occupa tutte le energie vitali per sopravvivere e far vivere i figli, spesso sappiamo anche pregare. E quando preghiamo usiamo solo le pochissime preghiere che ricordiamo e che amiamo perché ce li ha insegnate un genitore o una nonna, che hanno certificato la verità di quelle parole, non con la teologia ma con la loro carne donata. Nelle povertà anche le preghiere sono poche. Nessuna preghiera cristiana supera l’unico urlo inarticolato nell’altissima povertà del Golgota.
Quando la vita ci occupa tutte le energie vitali per sopravvivere e far vivere i figli, spesso sappiamo anche pregare. E quando preghiamo usiamo solo le pochissime preghiere che ricordiamo e che amiamo perché ce li ha insegnate un genitore o una nonna, che hanno certificato la verità di quelle parole, non con la teologia ma con la loro carne donata. Nelle povertà anche le preghiere sono poche. Nessuna preghiera cristiana supera l’unico urlo inarticolato nell’altissima povertà del Golgota. -
>LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E --- "IL PRINCIPIO DI CARITÀ. Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica" (F. Gandellini, 2016).19 gennaio 2020, di Federico La Sala
FILOSOFIA E FILOLOGIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS: CHARITAS....
- LA CARITÀ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia), NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!) *
Tesi di Laurea
IL PRINCIPIO DI CARITÀ [2016]
Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica
a cura di Francesco Gandellini **
- La tesi si preoccupa di analizzare l’origine e il decorso storico del principio di carità o benevolenza, con particolare riferimento alla linea etico-ermeneutica e alla linea logico-ontologica, al fine di metterne in luce gli aspetti significativi che lo identificano e ne caratterizzano l’uso nella storia della filosofia.
SOMMARIO Introduzione .................................................................................................................
 1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
 1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
 1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
 1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
 1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
 1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
 1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
 Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
 2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
 α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
 β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
 2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
 2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
 Conclusione .............................................................................................................. 157
Conclusione .............................................................................................................. 157
 Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163
Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163***
INTRODUZIONE
Il termine “carità” deriva etimologicamente dal latino caritas (acc. caritatem, «benevolenza», «amore», questo da carus, «caro», «costoso», «diletto», «amato»), e a sua volta dal greco χάρις, «grazia». Dal punto di vista dell’etimo, la parola cattura l’idea dell’amore disinteressato ma prezioso verso qualcuno, della benevolenza gratuitamente concessa al destinatario, senza riserve rispetto alla sua condizione.
 Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
 Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
 Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
 La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
 È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
 Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
 Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
 Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.
Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.1 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, il Saggiatore 2008, pag. 35
** UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 Dipartimento Lettere e Filosofia
Dipartimento Lettere e Filosofia
 Corso di Laurea in FILOSOFIA.
Corso di Laurea in FILOSOFIA.
 Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
 Laureando: GANDELLINI Francesco.
Laureando: GANDELLINI Francesco.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA QUESTIONE DELLA "H"....SCIENZA E FILOSOFIA. "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia" (di Antonio Rainone)
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) ... E "La carità che uccide" [Dead aid"] di Dambisa Moyo (di Habtè Weldemariam).8 gennaio 2020, di Federico La Sala
Una riflessione sul testo "La carità che uccide" di Dambisa Moyo (Rizzoli, 2009)
di Habtè Weldemariam *
È noto che la civiltà Occidentale è permeata dalla cultura degli aiuti, cioè da quella cultura che muove dall’imperativo morale di donare a chi è svantaggiato. Questa cultura, che nei paesi occidentali ha radici cristiane, negli ultimi trent’anni si è incrociata con il mondo dell’intrattenimento: personalità mediatiche, "leggende" del rock, abbracciano con entusiasmo la filosofia degli aiuti, ne fanno propaganda e rimproverano i governi di non fare abbastanza.
Per bacchettare certi iniziative e le politiche di aiuto finora perseguite è uscito il libro-saggio dell’autorevole economista africana, Dambisa Moyo, con l’abrasivo titolo “La carità che uccide. Come gli aiuti dell’Occidente stanno devastando il Terzo Mondo", una traduzione dal titolo peraltro non corretto rispetto a quello originale che voleva significare invece un certo modo di intendere gli aiuti: Dead Aid: Why aid is not working and how there is a better way for Africa (perchè l’aiuto non sta funzionando e qual è la strada migliore per l’Africa) .
Si tratta della storia del fallimento delle politiche allo sviluppo postbellico e postcoloniale dei Paesi occidentali nei confronti delle disastrate economie dell’Africa subsahariana. Il titolo originale "Dead Aid" richiama polemicamente il concerto di solidarietà di Geldof e Bono Live Aid del 1985, i quali "hanno solo contribuito alla diffusione di uno stato di perenne dipendenza alimentando corruzione, violenza", il cui obiettivo, sempre secondo l’autrice, non è aumentare la consapevolezza di ciò che provoca la fame e la povertà, ma "lisciare il pelo" all’emotività superficiale che porta all’elemosina. Ma la critica è anche per i miliardi di dollari trasferiti direttamente ai governi dei paesi poveri mediante accordi bilaterali o attraverso istituzioni come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale.
Non è tanto il supporto di cifre, report e quant’altro a rendere il libro davvero assertivo; è la esposizione logica e piana di un ragionamento basato sull’osservazione di sessant’anni di politiche fallimentari che hanno inondato l’Africa di fiumi di denaro - in 50 anni più di un trilione di dollari - creando solo una classe politica inefficiente e priva del senso di responsabilità. Gli aiuti provenienti dai singoli stati occidentali o dalla longa manus del capitalismo occidentale hanno soffocato sul nascere la possibilità di favorire lo sviluppo agricolo o una classe di piccoli e medi imprenditori locali, diventando così gli aiuti stessi la principale causa della tragedia africana.
Infatti, «tra il 1970 e il 1998, quando il livello degli aiuti era al suo livello massimo, il tasso di povertà del continente è passato dal 11 % al 66%. Si tratta di circa 600 milioni di africani, più della metà della popolazione del Continente, costretta a vivere sotto la linea della povertà»(p.88).
Da qui la risposta diretta e tranchant dell’autrice: gli aiuti al "Terzo Mondo", così come li abbiamo sempre intesi, fanno male! E inoltre, un certo modo di intendere la solidarietà non solo rischia di alimentare la cultura dell’accattonaggio, ma anche crea un legame vizioso tra donatore e ricevente favorendo il perpetuarsi di una logica perversa dell’auto-consolazione del donatore e un senso di gratificazione del ricevente nella propria condizione di subordinazione ed inferiorità.
La Moyo mette in luce tutti i punti deboli delle tradizionali politiche di aiuto internazionale esponendo un ragionamento molto articolato: da quando l’Occidente ha iniziato a far confluire fiumi di denaro verso il Continente ha messo in moto un circolo vizioso fatto di dipendenza dagli aiuti, di demotivazione e di uccisione del mercato locale:
- "... In Africa c’ è un fabbricante di zanzariere che ne produce circa cinquecento la settimana. Dà lavoro a dieci persone, ognuna delle quali deve mantenere fino a quindici famigliari. Per quanto lavorino sodo, la loro produzione non è sufficiente per combattere gli insetti portatori di malaria. Entra in scena un divo di Hollywood che fa un gran chiasso per mobilitare le masse e incitare i governi occidentali a raccogliere e inviare centomila zanzariere nella regione infestata dalla malattia, al costo di un milione di dollari. Le zanzariere arrivano e vengono distribuite: davvero una «buona azione». Col mercato inondato dalle zanzariere estere, però, il nostro fabbricante viene immediatamente estromesso dal mercato, i suoi dieci operai non possono più mantenere le centocinquanta persone che dipendono da loro e, fatto non trascurabile, entro cinque anni al massimo la maggior parte delle zanzariere importate sarà lacera, danneggiata e inutilizzabile. [così] “un intervento efficace a breve termine può involontariamente minare ogni fragile possibilità di sviluppo già esistente” (pp.83-84)
La Moyo, come tanti altri africani della sua generazione, si chiede allora senza giri di parole: perché, nonostante questi miliardi, l’Africa è incapace di posare il piede sulla scala economica in modo convincente e che cosa la trattiene dal rendersi capace di unirsi al resto del globo nel XXI secolo? Perché, caso unico al mondo, l’Africa è prigioniera di un ciclo di malfunzionamento? Cosa impedisce al continente di affrancarsi da una condizione di povertà cronica? Soprattutto la Moyo ritorna con insistenza sulla domanda: se gli altri paesi ce l’hanno fatta senza aiuti umanitari perché i paesi africani non possono farcela?
La risposta, secondo l’autrice, affonda le sue radici appunto negli aiuti: quelli umanitari o di emergenza, attivati e distribuiti in seguito a catastrofi e calamità; quelli distribuiti in loco da organizzazioni non governative (ONG) a istituzioni o persone (1);quelli sistematici, ossia pagamenti effettuati direttamente ai governi, sia tramite trasferimenti da governo a governo ("aiuti bilaterali") sia tramite enti quali la Banca Mondiale (noti come "aiuti multilaterali"). Si tratta della somma complessiva dei prestiti e delle sovvenzioni, che sono poi i miliardi "che hanno ostacolato, soffocato e ritardato lo sviluppo dell’Africa". Ed è di questi miliardi che si occupa il libro.
* RIPRESA PARZIALE. Per proseguire nella lettura integrale del testo, vedi: SCRITTI D’AFRICA, 26 MAGGIO 2011
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. --- MEMORIA DI SAN NICOLA (6 DICEMBRE 2019): FILOLOGIA EED ECUMENISMO. VERSO "NICEA 2025"? Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?6 dicembre 2019, di Federico La Sala
VERSO "BARI 2020", "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?! *
Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 6 dicembre 2018)
La carità è il "miracolo" più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313.
Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
 Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
 Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
 Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Commenti a Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.Federico La Sala
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. --- ITALIA, UN PAESE FONDATO SULL’ INQUISIZIONE. Tribunali della coscienza (Rec. di Carlo Ginzburg).10 ottobre 2019, di Federico La Sala
ITALIA, UN PAESE FONDATO SULL’ INQUISIZIONE
di Carlo Ginzburg *
Sulla soglia di quest’opera imponente, dedicata alla storia religiosa e civile dell’ Italia del ’500 (Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, pagg. 708, lire 60.000) incontriamo eventi molto più vicini a noi: "l’appello alle Brigate rosse di Paolo VI e la cupa solenne cerimonia funebre sul corpo di Aldo Moro con gli uomini di Stato italiani inginocchiati ai piedi del pontefice romano" (pag. X). Prosperi vede in essi "i momenti simbolici di una rifondazione dello Stato italiano" (io parlerei piuttosto di inizio simbolico della fine della prima repubblica) "che ancora una volta - dopo gli anni della guerra nazifascista - ha dovuto far leva sulle ragioni ultime della sua unità". L’ ironia amara di questa battuta diventa esplicita nel corso del libro, là dove Prosperi osserva che "una forma di alta sovranità del papa sull’ Italia è ancora visibile" (pag. 74). La legittimazione profonda dello Stato italiano si trova, ancora oggi, al di fuori di esso. Tribunali della coscienza rintraccia le premesse di questo persistente dato di fatto nei modi in cui la Chiesa cattolica affrontò e superò la crisi gravissima provocata dalla Riforma protestante. Ci troviamo dunque di fronte a un’ ennesima variazione sul tema della Riforma protestante mancata, che sarebbe all’ origine delle debolezze morali e politiche italiane? Neanche per sogno.
Anziché da quest’idea, cara a Edgar Quinet, a Francesco De Sanctis, a Piero Gobetti (degli odierni ripetitori è meglio tacere), Prosperi parte da ciò che è stato, non da ciò che sarebbe potuto essere. In un libro di originalità non comune (Il sovrano pontefice, Il Mulino, 1988) Paolo Prodi ha sostenuto che nel corso del ’400 lo Stato della Chiesa emerse come prototipo degli Stati nazionali europei: sia dal punto di vista della legittimazione, sia da quello dell’ organizzazione burocratica, imperniata sul sistema delle congregazioni cardinalizie, quasi una prefigurazione dei ministeri moderni. Una di queste congregazioni, la più potente, era quella del Sant’ Uffizio, istituito da Paolo III nel 1542 per rendere più efficace l’ attività antiereticale svolta dall’ Inquisizione fin dal Medioevo.
 Prodi invitava a studiare quest’Inquisizione moderna dal punto di vista dello Stato pontificio e della politica italiana.
Prodi invitava a studiare quest’Inquisizione moderna dal punto di vista dello Stato pontificio e della politica italiana.Tribunali della coscienza raccoglie l’esortazione ma la inserisce in una prospettiva di ricerca molto diversa. L’Inquisizione non fu soltanto "il principal nervo del pontificato", secondo le celebri parole di Paolo IV riferite da Paolo Sarpi: fu anche, osserva Prosperi, "l’unica forma di potere centralizzato che funzionò in Italia durante l’epoca moderna" (pag. 74) attraverso il fittissimo scambio di lettere tra la congregazione romana e i tribunali periferici. In qualche caso, come a Venezia, gli Stati italiani cercarono di difendersi dall’ intrusione del potere ecclesiastico: ma finirono col cedere di fronte alla minaccia di sovversione politica, oltre che religiosa, che aleggiava attorno alla Riforma protestante.
 Si arrivò così a quella che Prosperi definisce "unità inquisitoriale dell’ Italia" (pag. 114), basata sulla repressione poliziesca, sul sospetto, sulla delazione, sulla tortura e sui roghi. Sono elementi su cui gli storici cattolici degli ultimi cinquant’anni hanno preferito sorvolare. Essi si sono soffermati piuttosto sui vescovi, sui parroci, sulle visite pastorali: una scelta comprensibile, osserva Prosperi, in un momento in cui la Chiesa, attraverso le sue strutture diocesane, si era posta alla "guida politica delle masse cattoliche".
Si arrivò così a quella che Prosperi definisce "unità inquisitoriale dell’ Italia" (pag. 114), basata sulla repressione poliziesca, sul sospetto, sulla delazione, sulla tortura e sui roghi. Sono elementi su cui gli storici cattolici degli ultimi cinquant’anni hanno preferito sorvolare. Essi si sono soffermati piuttosto sui vescovi, sui parroci, sulle visite pastorali: una scelta comprensibile, osserva Prosperi, in un momento in cui la Chiesa, attraverso le sue strutture diocesane, si era posta alla "guida politica delle masse cattoliche".Tribunali della coscienza segue un’ altra strada. La prima parte è dedicata all’ attività dell’Inquisizione romana nella penisola italiana; la Sicilia e la Sardegna, soggette a un’ altra istituzione - l’Inquisizione spagnola - restano fuori dal quadro. Ma in questo libro la storia istituzionale, che pure funziona da filo conduttore, non ha nulla di astratto: parte dal vertice e dal centro e si dirama verso il basso e la periferia, fino a cogliere il modo in cui le istituzioni della Chiesa cattolica romana hanno modellato i comportamenti e gli atteggiamenti, dai più esteriori ai più intimi, di innumerevoli uomini e donne. (Le loro strategie di resistenza rimangono necessariamente un po’ in ombra: ma ogni prospettiva di ricerca comporta qualche sacrificio conoscitivo).
 Il perdurante divieto, al tempo stesso scandaloso e ridicolo, che impedisce agli studiosi di accedere all’ archivio romano del Sant’ Uffizio, ha imposto un limite all’ indagine. Esistono però gli archivi dei tribunali periferici, talvolta ricchissimi: Venezia, Modena, Pisa, eccetera. Prosperi li ha esplorati minuziosamente per più di vent’ anni, senza trascurare le carte inquisitoriali finite dopo varie vicissitudini a Dublino e a Bruxelles. Eresie, stregoneria e incantesimi, bestemmie, lettura di libri proibiti, seduzione in confessionale: il Sant’ Uffizio si occupava di questo e d’ altro.
Il perdurante divieto, al tempo stesso scandaloso e ridicolo, che impedisce agli studiosi di accedere all’ archivio romano del Sant’ Uffizio, ha imposto un limite all’ indagine. Esistono però gli archivi dei tribunali periferici, talvolta ricchissimi: Venezia, Modena, Pisa, eccetera. Prosperi li ha esplorati minuziosamente per più di vent’ anni, senza trascurare le carte inquisitoriali finite dopo varie vicissitudini a Dublino e a Bruxelles. Eresie, stregoneria e incantesimi, bestemmie, lettura di libri proibiti, seduzione in confessionale: il Sant’ Uffizio si occupava di questo e d’ altro.Nel corso della sua lunghissima ricerca Prosperi deve aver temuto più di una volta di perdersi in una simile foresta. Il rischio c’era, ma è stato superato splendidamente. Tribunali della coscienza non è una storia dell’ Inquisizione. Analizza tutti questi temi sulla base di una documentazione ricchissima, spesso inedita, ma inserendoli in una struttura argomentativa elegante e rigorosa, scandita dai termini enunciati nel sottotitolo del libro: inquisitori, confessori, missionari. I primi due emergono fin dal prologo ("L’esperimento calabrese").
 In Calabria, dopo la guerra condotta contro le comunità valdesi dal governatore Martino Caracciolo, si scontrarono tra il 1561 e il 1563 la strategia dura degli inquisitori e quella morbida, imperniata sulla confessione, dei padri gesuiti. Ma si trattava di tensioni episodiche: il rapporto tra inquisitori e confessori era di regola strettissimo. A questa conclusione erano arrivati quasi contemporaneamente alcuni anni fa due valenti studiosi, Giovanni Romeo e Ottavia Niccoli. Studiando l’atteggiamento dell’Inquisizione verso, rispettivamente, streghe e false sante, essi avevano scoperto che in molti casi il confessore impartiva l’assoluzione a patto che il penitente o la penitente si presentassero "spontaneamente" al Sant’Uffizio a denunciare se stessi e gli eventuali complici.
In Calabria, dopo la guerra condotta contro le comunità valdesi dal governatore Martino Caracciolo, si scontrarono tra il 1561 e il 1563 la strategia dura degli inquisitori e quella morbida, imperniata sulla confessione, dei padri gesuiti. Ma si trattava di tensioni episodiche: il rapporto tra inquisitori e confessori era di regola strettissimo. A questa conclusione erano arrivati quasi contemporaneamente alcuni anni fa due valenti studiosi, Giovanni Romeo e Ottavia Niccoli. Studiando l’atteggiamento dell’Inquisizione verso, rispettivamente, streghe e false sante, essi avevano scoperto che in molti casi il confessore impartiva l’assoluzione a patto che il penitente o la penitente si presentassero "spontaneamente" al Sant’Uffizio a denunciare se stessi e gli eventuali complici.
 Con un balzo d’immaginazione storiografica Prosperi ha posto il rapporto tra inquisitori e confessori al centro della sua indagine sulle lontane premesse dell’ Italia moderna. Ciò gli ha consentito di liberarsi in due righe delle annose diatribe sul rapporto tra Riforma cattolica e Controriforma, e soprattutto di affrontare il tema delicatissimo della Inquisizione superando vecchi e nuovi luoghi comuni.
Con un balzo d’immaginazione storiografica Prosperi ha posto il rapporto tra inquisitori e confessori al centro della sua indagine sulle lontane premesse dell’ Italia moderna. Ciò gli ha consentito di liberarsi in due righe delle annose diatribe sul rapporto tra Riforma cattolica e Controriforma, e soprattutto di affrontare il tema delicatissimo della Inquisizione superando vecchi e nuovi luoghi comuni.Negli ultimi decenni una serie di ricerche di prim’ordine (a cominciare da quelle di John Tedeschi, parzialmente raccolte in un volume di cui è annunciata la traduzione italiana) hanno gettato molta luce sulle strutture e sul funzionamento dell’ Inquisizione romana. Un’ immagine più realistica si è sostituita all’ antico stereotipo, affermatosi nel ’700, dell’ Inquisizione come sinonimo di tribunale feroce e arbitrario. Ma sta emergendo uno stereotipo di segno opposto, secondo cui l’Inquisizione sarebbe stato un tribunale equo e addirittura mite.
 Prosperi, partendo dal legame tra inquisitori e confessori, mostra l’inadeguatezza di queste formule. In una prima fase l’Inquisizione fu soprattutto, com’ è ormai accertato, lo strumento di una feroce lotta ai vertici della Curia. Il cardinale Giovanni Morone fu messo sotto processo; un altro cardinale, l’inglese Reginald Pole, accusato di eresia in pieno conclave, vide dileguare le proprie aspirazioni al pontificato; due personaggi di umile estrazione sociale come Michele Ghislieri e Felice Peretti riuscirono, grazie alla carriera fatta come inquisitori, a diventare papi sotto il nome, rispettivamente, di Pio V (poi santo) e Sisto V.
Prosperi, partendo dal legame tra inquisitori e confessori, mostra l’inadeguatezza di queste formule. In una prima fase l’Inquisizione fu soprattutto, com’ è ormai accertato, lo strumento di una feroce lotta ai vertici della Curia. Il cardinale Giovanni Morone fu messo sotto processo; un altro cardinale, l’inglese Reginald Pole, accusato di eresia in pieno conclave, vide dileguare le proprie aspirazioni al pontificato; due personaggi di umile estrazione sociale come Michele Ghislieri e Felice Peretti riuscirono, grazie alla carriera fatta come inquisitori, a diventare papi sotto il nome, rispettivamente, di Pio V (poi santo) e Sisto V.
 Attraverso la rete dei suoi vicari l’ Inquisizione romana, ormai centro di potere quasi incontrastato, penetrò nella società italiana scalzando le prerogative degli ordini religiosi e sovrapponendosi alle stesse istituzioni diocesane. Il confessore, che il Concilio di Trento aveva già trasformato in un funzionario di stato civile, divenne un "braccio spirituale dell’ Inquisizione" e "un agente della specie più insidiosa di polizia" (pagg. 244, 541).
Attraverso la rete dei suoi vicari l’ Inquisizione romana, ormai centro di potere quasi incontrastato, penetrò nella società italiana scalzando le prerogative degli ordini religiosi e sovrapponendosi alle stesse istituzioni diocesane. Il confessore, che il Concilio di Trento aveva già trasformato in un funzionario di stato civile, divenne un "braccio spirituale dell’ Inquisizione" e "un agente della specie più insidiosa di polizia" (pagg. 244, 541).
 Soltanto quando il pericolo protestante si attenuò le parti si rovesciarono: gli inquisitori assunsero una fisionomia prossima a quella dei confessori, impartendo con frequenza sempre maggiore perdoni generali e penitenze salutari. Un analogo mutamento di rotta si verificò nei casi di stregoneria. Il Sant’ Uffizio riuscì a imporre la propria cautela perfino a Carlo Borromeo: ossia a colui che, saputo del rogo delle streghe della valle Mesolcina, esortò il gesuita che l’ aveva informato "a far abondante ricolta spirituale da questi semi" (pag. 376).
Soltanto quando il pericolo protestante si attenuò le parti si rovesciarono: gli inquisitori assunsero una fisionomia prossima a quella dei confessori, impartendo con frequenza sempre maggiore perdoni generali e penitenze salutari. Un analogo mutamento di rotta si verificò nei casi di stregoneria. Il Sant’ Uffizio riuscì a imporre la propria cautela perfino a Carlo Borromeo: ossia a colui che, saputo del rogo delle streghe della valle Mesolcina, esortò il gesuita che l’ aveva informato "a far abondante ricolta spirituale da questi semi" (pag. 376).Negli scorsi decenni vari studiosi hanno insistito sul parallelismo tra i fenomeni di disciplinamento che si sarebbero verificati nei paesi protestanti e in quelli cattolici. Un contributo decisivo in questa direzione venne dato dai missionari, ai quali è dedicata la terza parte, forse la più nuova, di questo libro ricchissimo.
 Con grande efficacia Prosperi ricostruisce l’entusiasmo di una generazione scossa e affascinata dalle lettere che descrivevano l’ attività svolta dai missionari, soprattutto gesuiti, in Asia e nelle Americhe. Gli stessi metodi di catechizzazione, lo stesso sguardo distaccato, quasi etnografico s’ incontrano nelle relazioni dedicate a quelle che vennero allora definite "nostre Indie" o "Indie di quaggiù": la Corsica, la Lunigiana, la Campagna romana o i dintorni di Eboli.
Con grande efficacia Prosperi ricostruisce l’entusiasmo di una generazione scossa e affascinata dalle lettere che descrivevano l’ attività svolta dai missionari, soprattutto gesuiti, in Asia e nelle Americhe. Gli stessi metodi di catechizzazione, lo stesso sguardo distaccato, quasi etnografico s’ incontrano nelle relazioni dedicate a quelle che vennero allora definite "nostre Indie" o "Indie di quaggiù": la Corsica, la Lunigiana, la Campagna romana o i dintorni di Eboli.Prosperi collega suggestivamente questa straordinaria spregiudicatezza intellettuale all’ apertura dei gesuiti verso i "nuovi cristiani", ossia gli ebrei convertiti o i discendenti di ebrei convertiti. Tra loro troviamo uomini come Diego Lainez, uno dei fondatori della Compagnia; Juan de Polanco, segretario di Ignazio di Loyola; il celebre missionario Antonio Possevino. E del resto, l’adattamento teorizzato dai gesuiti - fino all’ estrema disponibilità verso i riti cinesi - non riecheggiava forse la strategia praticata in Spagna dai marrani?
 Le missioni ebbero un successo enorme, ma il prezzo pagato fu alto. "La catechizzazione delle masse avvenne" scrive Prosperi "per via di meccanismi di indottrinamento collettivo che prescindevano dalla lettura diretta e dalla riflessione individuale" (pagg. 634-635). Per il protestantesimo liberale ottocentesco questi fenomeni contrassegnavano l’esclusione del cattolicesimo dal mondo moderno (condannato anche dal Sillabo). Oggi, giunti alla fine del ventesimo secolo, riconosciamo senza sforzo la modernità dei gesuiti.
Le missioni ebbero un successo enorme, ma il prezzo pagato fu alto. "La catechizzazione delle masse avvenne" scrive Prosperi "per via di meccanismi di indottrinamento collettivo che prescindevano dalla lettura diretta e dalla riflessione individuale" (pagg. 634-635). Per il protestantesimo liberale ottocentesco questi fenomeni contrassegnavano l’esclusione del cattolicesimo dal mondo moderno (condannato anche dal Sillabo). Oggi, giunti alla fine del ventesimo secolo, riconosciamo senza sforzo la modernità dei gesuiti.
 "Modernità" e "mondo moderno" significano ormai tutto e il contrario di tutto: forse è venuto il momento di congedare questi termini, insieme alla loro vacua appendice postmoderna, come mera chiacchiera.
"Modernità" e "mondo moderno" significano ormai tutto e il contrario di tutto: forse è venuto il momento di congedare questi termini, insieme alla loro vacua appendice postmoderna, come mera chiacchiera.
 I gesuiti sono un tema più interessante. Speriamo che Prosperi ci dia un giorno il libro sui gesuiti che egli solo è in grado di scrivere.
I gesuiti sono un tema più interessante. Speriamo che Prosperi ci dia un giorno il libro sui gesuiti che egli solo è in grado di scrivere.Intanto festeggiamo questo Tribunali della coscienza: un’opera che, per la nitidezza della costruzione, la vastità del materiale utilizzato, la calma autorevolezza della prosa è destinata a diventare un classico. Classico è anche l’ ideale, alto e austero, di equanimità storiografica che il suo autore persegue. Esso presuppone il controllo, non l’assenza, delle passioni: prima fra tutte, l’ indignazione (si legga il bellissimo capitolo "Confessori e donne").
 La storia che Prosperi racconta è grandiosa e terribile. Dolcezza e minaccia, misericordia e tormenti: l’azione congiunta, segreta e pubblica, di inquisitori, confessori e missionari modellò coscienze e comportamenti individuali e collettivi; insomma, l’ Italia cattolica.
La storia che Prosperi racconta è grandiosa e terribile. Dolcezza e minaccia, misericordia e tormenti: l’azione congiunta, segreta e pubblica, di inquisitori, confessori e missionari modellò coscienze e comportamenti individuali e collettivi; insomma, l’ Italia cattolica.
 Ma questa, dice Prosperi, è una storia conclusa: la scomparsa di una società prevalentemente contadina, in cui "i ritmi lenti e ripetitivi della vita sociale" erano "regolati dai riti di passaggio coincidenti con i sacramenti della Chiesa" ha "lasciato il posto ad un orizzonte sociale del tutto secolarizzato" (pag. XXI).
Ma questa, dice Prosperi, è una storia conclusa: la scomparsa di una società prevalentemente contadina, in cui "i ritmi lenti e ripetitivi della vita sociale" erano "regolati dai riti di passaggio coincidenti con i sacramenti della Chiesa" ha "lasciato il posto ad un orizzonte sociale del tutto secolarizzato" (pag. XXI).
 E’ una conclusione che lascia interdetti. Come conciliarla con la presenza attiva della Chiesa cattolica nei settori più diversi della società italiana - le banche, le parrocchie, le organizzazioni del volontariato, e così via? - e come conciliarla con quella sorta di "alta sovranità" del papa sull’ Italia di cui ci parla lo stesso Prosperi? Nell’ accenno all’ "orizzonte sociale del tutto secolarizzato" sembra risuonare inaspettatamente, anche se con un timbro completamente diverso, la voce di papa Wojtyla - come se Prosperi si fosse identificato per un attimo, senza volerlo, con l’ estrema propaggine delle sue fonti.
E’ una conclusione che lascia interdetti. Come conciliarla con la presenza attiva della Chiesa cattolica nei settori più diversi della società italiana - le banche, le parrocchie, le organizzazioni del volontariato, e così via? - e come conciliarla con quella sorta di "alta sovranità" del papa sull’ Italia di cui ci parla lo stesso Prosperi? Nell’ accenno all’ "orizzonte sociale del tutto secolarizzato" sembra risuonare inaspettatamente, anche se con un timbro completamente diverso, la voce di papa Wojtyla - come se Prosperi si fosse identificato per un attimo, senza volerlo, con l’ estrema propaggine delle sue fonti.Certo, confrontata con l’ Italia di quattro secoli fa, o con l’ Iran e l’ Afghanistan odierni, l’ Italia appare come un paese secolarizzato. Ma "secolarizzazione" è un termine relativo. Il potere, qualunque potere, trova necessariamente la propria legittimazione in ambiti non secolari come il rituale e il mito. Lo ricorda Angelo Torre, al termine di una ricerca ardua e importante (Il consumo di devozioni, Marsilio, 1995) condotta in una prospettiva che Prosperi, nella prefazione a Tribunali della coscienza, presenta rapidamente, e respinge, in termini che non condivido.
Torniamo alla debole legittimazione dello Stato italiano: il tema attualissimo da cui parte il libro di Prosperi. Questa debolezza ha radici lontane e vicine. L’idea di Italia nasce all’ombra di due poteri universali, il papato e l’Impero (di cui l’ Italia, disse Dante, era il giardino). Nel 1870 la classe dirigente italiana si trovò di fronte al dilemma, analizzato da Federico Chabod in pagine famose, sull’opportunità o no di trasportare a Roma, centro del papato, la capitale del nuovo Stato. La scelta fatta allora ci appare oggi forse inevitabile, ma sicuramente perdente. Ricordiamocene nel momento in cui si annuncia il sinistro baraccone del Giubileo. Le realtà sgradevoli vanno guardate in faccia.
-
> LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) ... E LA DEA "HOSTILINA". Chi è effettivamente l’ospite (di Angela Frati e Stefania Iannizzotto).4 ottobre 2019, di Federico La Sala
Chi è effettivamente l’ospite
- Quesito:
- È molta la curiosità dei nostri lettori intorno alla parola ospite: perché in italiano indica sia chi riceve ospitalità sia chi dà ospitalità?
Chi è effettivamente l’ospite
Come si legge in tutti i vocabolari dell’italiano contemporaneo, ospite ha un duplice significato: è sia chi dà ospitalità (un ospite premuroso) sia, più comunemente, chi la riceve (un ospite gradito). Con il primo significato si ritrova soprattutto in contesti formali e letterari (nel GDLI si riscontrano esempi a partire dalla prima metà del XIV secolo fino ad autori quali Foscolo, Manzoni, Pascoli ecc.).
La parola ospite deriva dal latino hospes, -ĭtis, che aveva già il doppio significato di ‘colui che ospita e quindi albergatore’ e di ‘colui che è ospitato e quindi forestiero’, significato - comune alla parola greca xénos - che si è tramandato in quasi tutte le lingue romanze (antico francese (h)oste; francese moderno hôte; occitano e catalano oste; spagnolo huésped; portoghese hóspede). Ed è dunque proprio alla storia della lingua latina che dovremo guardare per rispondere alla curiosità che questa parola suscita.
L’etimologia del termine latino hospes risulta spesso incerta nei più comuni dizionari della lingua italiana e, se vengono date delle spiegazioni, esse risultano parziali e non rispondono pienamente alla nostra domanda. Ad esempio, il Devoto-Oli 2012 e il Sabatini-Coletti 2008 fanno risalire la voce a un più antico *hostipotis, composto da hŏstis ‘straniero’ e pŏtis ‘signore, padrone’, cioè ‘signore dello straniero’, ma non dicono niente di più. Il Vocabolario Treccani scrive sinteticamente che il termine ha “tutti e due i significati fondamentali, in quanto la parola alludeva soprattutto ai reciproci doveri dell’ospitalità”, in accordo con il Dir Dizionario italiano ragionato (D’Anna, 1988).
Tra gli etimologici, il DELI riconosce il doppio significato del termine, ma aggiunge “senza etimologia evidente”. L’etimologico di Nocentini approfondisce invece la questione e rimanda all’indoeuropeo *ghos(ti)-potis ‘signore dello straniero’ cioè il padrone di casa che esercitava il diritto di ospitalità nei confronti del forestiero, composto da *ghostis ‘straniero’ e *potis ‘signore’. A favore di tale ipotesi cita i corrispettivi gospodĭ ‘padrone, signore’ in antico slavo e gospodín ‘signore’ in russo.
Hospesin origine è dunque il “padrone di casa” che dà ospitalità al forestiero; i rapporti che si istauravano tra chi accoglieva e chi era accolto erano così stretti - legati anche al fatto che chi era ospitato si impegnava a sua volta a ricambiare l’ospitalità - che, sin dai tempi più antichi, hospes ha indicato anche la persona accolta in casa d’altri. La reciprocità del patto di ospitalità è dunque all’origine del doppio significato della parola ospite. Riconoscendo questa “squisita umanità degli antichi”, anche Leopardi nello Zibaldone scriveva: “di tal genere è ancora quella tanta ospitalità esercitata dagli antichi con tanto scrupolo, e protetta da tanto severe leggi, opinioni religiose ecc. quei diritti d’ospizio ecc. affinità d’ospizio ecc. Ben diversi in ciò dai moderni” (5 luglio 1827).
Vale la pena soffermarsi un po’ di più sulla parola hostis che, insieme a potis ‘signore’, è all’origine di hospes. Emile Benveniste introduce così la questione:
- Tra i termini comuni al vocabolario preistorico delle lingue dell’Europa, questo ha un interesse particolare: hŏstis del latino corrisponde al gasts del gotico e al gostĭ dell’antico slavo, che presenta inoltre gos-podĭ ‘signore’, formato come hospes. Ma il senso del gotico gasts e dell’antico slavo gostĭ è ‘ospite’, quello del latino hŏstis è ‘nemico’. Per spiegare il rapporto tra ‘ospite’ e ‘nemico’, si ammette di solito che l’uno e l’altro derivino dal senso di ‘straniero’ che è ancora attestato in latino; da cui ‘straniero favorevole → ospite’ e ‘straniero ostile → nemico’.
Benveniste ricorda, infatti, che hostis è usato nella Legge delle XII tavole con il valore arcaico di ‘straniero’, ma riporta anche un’interessante testimonianza di Sesto Pompeo Festo (II secolo d.C.) da cui si ricava che il termine hostis indicava colui a cui erano riconosciuti gli stessi diritti del popolo Romano (quod erant pari iure cum populo Romano). A conferma di ciò Festo ricorda anche che il verbo hostire aveva lo stesso significato di aequare (con valore simile si trovano hostire in Plauto, hostus in Varrone e il nome della dea Hostilina in sant’Agostino). Il legame di hostis con i concetti di uguaglianza e di reciprocità è confermato anche da una parola più conosciuta, hostia, che nel rituale romano indica propriamente ‘la vittima che serve a compensare l’ira degli dei’ (l’offerta è considerata quindi di un valore tale da bilanciare l’offesa), in contrapposizione con il termine meno specifico victima che indica un semplice ‘animale offerto in sacrificio’ (cioè senza nessun intento riparatorio).
Si ricava dunque che il significato originario di hostis non era quello di ‘straniero’ in generale, né tanto meno di ‘nemico’, ma quello di ‘straniero a cui si riconoscono dei diritti uguali a quelli dei cittadini romani’, a differenza del peregrinus che indica invece ‘colui che abita al di fuori del territorio’.
 Il legame di uguaglianza e reciprocità che si stabilisce tra un hostis e un cittadino di Roma conduce alla nozione di ospitalità.
Il legame di uguaglianza e reciprocità che si stabilisce tra un hostis e un cittadino di Roma conduce alla nozione di ospitalità.
 In un dato momento dunque hostis ha indicato ‘colui che è in relazione di compenso’ e di scambio nei confronti del civis e quindi, in ultima analisi, l’ospite. Di questo erano ben consapevoli gli scrittori classici, come scrive Cicerone nel De officiis: “hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus” [infatti i nostri antenati chiamavano hostis quello che noi oggi chiamiamo peregrinus (‘forestiero’)].
In un dato momento dunque hostis ha indicato ‘colui che è in relazione di compenso’ e di scambio nei confronti del civis e quindi, in ultima analisi, l’ospite. Di questo erano ben consapevoli gli scrittori classici, come scrive Cicerone nel De officiis: “hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus” [infatti i nostri antenati chiamavano hostis quello che noi oggi chiamiamo peregrinus (‘forestiero’)].Più tardi, quando alle relazioni di scambio tra clan e clan sono subentrate le relazioni di inclusione o di esclusione dalla civitas, hostis ha assunto un’accezione negativa e ha preso il significato classico di ‘nemico’ (da cui deriva, per esempio, la parola italiana ostile), e in tal senso la storia di hostis riassume il cambiamento che le istituzioni romane hanno attraversato nei secoli.
 In conseguenza del vuoto semantico lasciato da hostis si è dovuto pertanto ricorrere a un nuovo termine per indicare la nozione di ospitalità e si è creato, come già detto, partendo dalla stessa parola hostis, il termine hospes. Hospes dunque eredita e conserva in sé il valore intrinseco di reciprocità e di mutuo scambio: è forse anche per questo che la stessa parola nelle lingue derivate dal latino ha facilmente continuato a indicare sia chi ospita sia chi è ospitato.
In conseguenza del vuoto semantico lasciato da hostis si è dovuto pertanto ricorrere a un nuovo termine per indicare la nozione di ospitalità e si è creato, come già detto, partendo dalla stessa parola hostis, il termine hospes. Hospes dunque eredita e conserva in sé il valore intrinseco di reciprocità e di mutuo scambio: è forse anche per questo che la stessa parola nelle lingue derivate dal latino ha facilmente continuato a indicare sia chi ospita sia chi è ospitato.Un’ultima osservazione. Un lettore, un po’ infastidito dalla polisemia di ospite e preoccupato che nella lingua comune non ci sia una parola per indicare ‘colui che ospita’, propone di usare due termini diversi come nella lingua inglese, che ha host per ‘ospitante’ e guest per ‘ospitato’ (da notare che entrambi i termini derivano dalla stessa radice indoeuropea *ghostis, anche se host passa attraverso il francese antico (h)oste). Ci suggerisce, come sostantivo per indicare chi ospita, il termine ospitante (o addirittura trimalcione). Ma in realtà, come spesso accade nei fatti di lingua, sarà probabilmente l’uso alla fine a trovare da solo la soluzione. E a ben guardare, quando è necessario distinguere tra i due significati di ospite, l’italiano ha già preso delle decisioni e mette a disposizione un ventaglio di scelte. Se per ospite ormai si intende comunemente ‘colui che è ospitato’, per indicare ‘colui che ospita’ invece, in relazione al contesto e al grado di formalità, si può oggi già scegliere tra: il forse troppo letterario ospitatore (cfr. GDLI), il padrone di casa o semplicemente l’amico che mi ospita. Infine, il termine ospitante con il valore di ‘chi dà ospitalità’ esiste già in italiano, ad esempio nelle espressioni squadra ospitante e famiglia ospitante, e può darsi che prima o poi riuscirà a imporsi pienamente sul termine ospite con lo stesso valore.
Per approfondimenti:
 E. Benveniste, Il vocabolario della istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società, I, edizione italiana a cura di Mariantonia Liborio, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-75
E. Benveniste, Il vocabolario della istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società, I, edizione italiana a cura di Mariantonia Liborio, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-75
 Dictionnaire Étymologique de la langue latine, a cura di A. Ernout e A. Meillet, Parigi, Librairie C. Klincksieck, 1967, s.v. hospes
Dictionnaire Étymologique de la langue latine, a cura di A. Ernout e A. Meillet, Parigi, Librairie C. Klincksieck, 1967, s.v. hospes
 E. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, Padova, Tipografia del Seminario, 1771, s.v. hospes
Thesaurus linguae Latinae, Leipzig, Teubner, 1900 e sgg.,.s.v. hospes
E. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, Padova, Tipografia del Seminario, 1771, s.v. hospes
Thesaurus linguae Latinae, Leipzig, Teubner, 1900 e sgg.,.s.v. hospes
 F. Venier, La corrente di Humboldt. Una lettura di La lingua franca di Hugo Schuchardt; Roma, Carocci, 2012
F. Venier, La corrente di Humboldt. Una lettura di La lingua franca di Hugo Schuchardt; Roma, Carocci, 2012*
A cura di Angela Frati e Stefania Iannizzotto
 Redazione Consulenza Linguistica
Redazione Consulenza Linguistica
 Accademia della Crusca (13 luglio 2012).
Accademia della Crusca (13 luglio 2012). -
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006) - CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE".. Una nota di Filippo Di Giacomo - a cura di Federico La Sala23 agosto 2018, di Federico La Sala
AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE".
L’*AMORE* Di MARIA E GIUSEPPE E LA "PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018" :
- Preghiera dei bambini (1870): “Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” (http://www.fondazioneterradotranto.it/2018/07/06/ggimentu-gimmientu-e-ggimintare/#comment-96032).
- Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16).
PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 *
 Dio, nostro Padre,
Dio, nostro Padre,
 Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
 Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
 Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
 Rendici pazienti e gentili,
Rendici pazienti e gentili,
 Amorevoli e generosi,
Amorevoli e generosi,
 Accoglienti con i bisognosi.
Accoglienti con i bisognosi.
 Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
 Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
 Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
 [facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
 persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
 Aumenta la nostra fede,
Aumenta la nostra fede,
 Rendi forte la nostra speranza,
Rendi forte la nostra speranza,
 Conservaci nel tuo amore,
Conservaci nel tuo amore,
 Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
 Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, Amen
Amen Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
 San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
 Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
 San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.*Fonte: https://www.worldmeeting2018.ie/WMOF/media/downloads/prayerA4-IT.pdf
* L’Incontro mondiale. «Famiglia, sfida globale». Ecco il senso dell’incontro di Dublino. L’arcivescovo Martin, primate della Chiesa d’Irlanda: Amoris Laetitia, messaggio di misericordia nella complessità. Uno spazio dedicato anche al doloroso tema degli abusi (di Luciano Moia, Avvenire, venerdì 17 agosto 2018: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/famiglia-sfida-globale-ecco-il-senso-di-dublino).
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala (18.08.2018)
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. --- Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato (di Stefano Zamagni).12 giugno 2018, di Federico La Sala
TEOLOGIA, ECONOMIA, E STORIA ..... *
Il documento vaticano.
Verso una nuova finanza: il cammino ora è segnato
Il testo della Congregazione per la Dottrina della Fede «Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» offre spunti per un discernimento etico sul sistema attuale e offre soluzioni per il bene comune
di Stefano Zamagni (Avvenire, martedì 12 giugno 2018)
«Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones» (Opq) è un documento - reso di dominio pubblico il 17 maggio 2018 - originale e intrigante.
Originale per il taglio espositivo e soprattutto perché è la prima volta che la Congregazione per la Dottrina della Fede - la cui competenza copre anche le questioni di natura morale - interviene su una materia di Dottrina Sociale della Chiesa. Il lavoro congiunto tra Congregazione e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è già di per sé qualcosa che non può passare inosservato e che lascerà il segno.
Opq è poi un contributo intrigante per il modo e per lo spessore con cui affronta una tematica che, come quella della nuova finanza, è oggi al centro delle preoccupazioni della Chiesa e della società in generale. (Papa Francesco ha approvato il Documento che entra pertanto nel Magistero ordinario). Come recita il sottotitolo («considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario» - corsivo aggiunto), non ci troviamo di fronte ad una sorta di esortazione apostolica o ad un testo di taglio pastorale. Piuttosto, vi si legge un’analisi, scientificamente fondata, delle cause remote dei disordini e dei guasti che l’architettura dell’attuale sistema finanziario va determinando.
Si legge al n. 5: «La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, neutralizzandone gli aspetti predatori e speculativi (sic!) e valorizzandone il servizio all’economia reale. Sebbene siano stati intrapresi molti sforzi positivi... non c’è stata però una reazione che abbia portato a ripensare quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo».
 A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.
A scanso di equivoci, è bene precisare che il documento non parla affatto contro la finanza, di cui riconosce la rilevanza e anzi la necessità (e non potrebbe essere diversamente, se si considera che la finanza moderna nasce entro l’alveo del pensiero economico francescano). Esso prende piuttosto posizione nei confronti di una realtà efficacemente descritta dal seguente dato: nel 1980, l’insieme degli attivi finanziari a livello mondiale era pressoché eguale al Pil sempre mondiale; nel 2015 la prima variabile era diventata dodici volte superiore alla seconda.Il punto centrale dell’argomento sviluppato nel Documento è l’affermazione del principio secondo cui etica e finanza non possano continuare a vivere in sfere separate. Ciò implica il rigetto della tesi del Noma (Non Overlapping Magisteria) per primo formulata in economia nel 1829 da Richard Whateley, cattedratico all’Università di Oxford e vescovo della Chiesa Anglicana.
 Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
Secondo questa tesi, la sfera dell’economia va tenuta separata sia dalla sfera dell’etica sia da quella della politica, se si vuole che l’economia ambisca a vedersi riconosciuto lo statuto di disciplina scientifica. E così è stato, almeno fino a tempi recenti, quando si è cominciato a parlare con Amartya Sen e altri, di economia e etica.
 I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.
I paragrafi 7-12 di Opq si soffermano con grande incisività a descrivere come dall’accettazione del principio del Noma sia derivato l’accoglimento dell’assunto antropologico (di ascendenza Hobbesiana) dell’homo homini lupus, posto a fondamento della figura dell’homo oeconomicus.Ben diverso è l’assunto antropologico da cui parte il paradigma dell’economia civile - fondato da Antonio Genovesi nel 1753 a Napoli - che, rifiutando esplicitamente il Noma, riconosce che homo homini natura amicus. («L’uomo è per natura amico dell’altro uomo»).
Seconda novità di rilievo del Documento è la rilevanza attribuita al principio della responsabilità adiaforica, di cui quasi mai si fa cenno. Il par. 14 recita: «Ad li là del fatto che molti operatori siano singolarmente animati da buone e rette intenzioni, non è possibile ignorare che oggi l’industria finanziaria, a causa della sua pervasività e della sua inevitabile capacità di condizionare e di dominare l’economia reale, è un luogo dove gli egoismi e le sopraffazioni hanno un potenziale di dannosità della collettività che ha pochi eguali».
È questo un esempio notevole di struttura di peccato, come la chiamò, per primo nella Dottrina Sociale della Chiesa, Giovanni Paolo II nella sua Sollecitudo Rei Socialis (1987). Non è il solo operatore di borsa, o banchiere o uomo d’affari ad essere responsabile delle conseguenze delle azioni che pone in atto. Anche le istituzioni economiche, se costruite su premesse di valore contrarie ad un’etica amica dell’uomo, possono generare danni enormi a prescindere dalle intenzioni di coloro che in esse operano. Per meglio comprendere la ragione di ciò, conviene fissare l’attenzione su tre caratteristiche specifiche della nuova finanza.
La prima è l’impersonalità dei contesti di mercato, la quale oscura il fatto che da qualche parte vi è sempre un qualcuno sull’altro lato dell’affare. La seconda caratteristica è la complessità della nuova finanza che fa sorgere problemi di agentività indiretta: il principale si riconosce moralmente disimpegnato nei confronti delle azioni poste in essere dal suo ’ingegnere finanziario’, cioè dall’esperto cui affida il compito di disegnare un certo prodotto, il quale a sua volta si mette il cuore in pace perché convinto di eseguire un ordine.
Accade così che ognuno svolge il suo ruolo separando la propria azione dal contesto generale, rifiutandosi di accettare che, anche se solo amministrativamente, era parte dell’ingranaggio. Infine, la nuova finanza tende ad attrarre le persone meno attrezzate dal punto di vista etico, persone cioè che non hanno scrupoli morali e soprattutto molto avide. Riusciamo così a comprendere perché il problema non risiede unicamente nella presenza di poche o tante mele marce; ma è sulla stessa cesta delle mele che si deve intervenire.
Il Documento in questione, infine, prende definitiva ed esplicita posizione contro la tesi della doppia moralità - purtroppo diffusa anche tra alcune organizzazioni di tipo finanziario che dichiarano di ispirarsi alla Dottrina Sociale della Chiesa. Per capire di che si tratta conviene partire dal saggio di Albert Carr, ’Is business bluffing ethical?’ pubblicato sulla prestigiosa Harvard Business Review nel 1968. È questo il saggio che, più di ogni altro, ha guidato fino ad oggi la riflessione etica nel mondo degli affari. Vi si legge che l’uomo d’affari di successo deve essere guidato da «un diverso insieme di standars etici», poiché «l’etica degli affari è l’etica del gioco [d’azzardo], diversa dall’etica religiosa». Assimilando il business al gioco del poker, il noto economista americano conclude che «gli unici vincoli di ogni mossa nel business sono la legalità e il profitto.
Se qualcosa non è illegale in senso stretto (sic!) ed è profittevole allora è eticamente obbligante che l’uomo d’affari lo realizzi». I paragrafi dal 22 al 34 di Opq si soffermano sul faciendum: che fare per cercare di invertire la situazione? Parecchie le proposte - tutte realizzabili - che vengono avanzate. Dal sostegno a istituti che praticano la finanza non speculativa, come le Banche di Credito Cooperativo, il microcredito, l’investimento socialmente responsabile, alle tante forme di finanza etica. Dalla chiusura della finanza offshore e dalle forme di cannibalismo economico di chi, con i credit default swaps, specula sul fallimento altrui, alla regolamentazione dello shadow-banking, soggetti finanziari non bancari che agiscono come banche ma operando al di fuori di ogni quadro normativo ufficiale.
L’obiettivo da perseguire è quello di assicurare una effettiva biodiversità bancaria e finanziaria. Di speciale interesse è inoltre la proposta di affiancare ai Cda delle grandi banche Comitati Etici costituiti da persone moralmente integre oltre che competenti - così come già accade nei grandi policlinici. Nell’aprile 2015 la ’Dutch Banking Association’ (l’Associazione di tutte le banche olandesi) stabilì di esigere dai dipendenti delle banche (circa 87.000 persone) il ’Giuramento del Banchiere’, stilato sulla falsariga del giuramento ippocratico per i medici.
Il giuramento consta di otto impegni specifici. Ne indico solamente un paio: «Prometto e giuro di mai abusare delle mia conoscenze»; «Prometto e giuro di svolgere le mie funzioni in modo etico e con cura, adoperandomi di conciliare gli interessi di tutte le parti coinvolte: clienti, azionisti; occupati; società». Si opera dunque a favore di tutte le classi di stakeholder e non solamente di quella degli azionisti. Sarebbe bello se sull’esempio dell’Olanda - un Paese non certo sprovveduto né arretrato in materia finanziaria - anche l’Italia volesse seguirne la traccia.
Delle tre principali strategie con le quale si può cercare di uscire da una crisi di tipo entropico - quale è l’attuale - e cioè quella rivoluzionaria, quella riformista, quella trasformazionale, il Documento Opq sposa, in linea con il Magistero di papa Francesco, la terza. Si tratta di trasformare - non basta riformare - interi blocchi del sistema finanziario che si è venuto formando nell’ultimo quarantennio per riportare la finanza alla sua vocazione originaria: quella di servire il bene comune della civitas che, come ci ricorda Cicerone, è la «città delle anime», a differenza dell’urbs che è la «città delle pietre». È questa la strategia che vale, ad un tempo, a scongiurare il rischio sia di utopiche palingenesi sia del misoneismo, che è l’atteggiamento tipico di chi detesta la novità e osteggia l’emergenza del nuovo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
STORIA D’ITALIA. INTELLETTUALI E SOCIETA’....
 VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggere
VICO, LA «SCUOLA» DEL GENOVESI, E IL FILO SPEZZATO DEL SETTECENTO RIFORMATORE. Una ’Introduzione’ di Franco Venturi, tutta da rileggereGUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" --- ”Chi prega si salva” chi non prega si danna). Intervista all’arcivescovo di Modena-Nonantola, Erio Castellucci.4 giugno 2018, di Federico La Sala
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! .... *
Pregare, questione di umiltà. Il modello? È il Padre Nostro
Castellucci: Il Signore ci insegna la logica del "noi".
L’arcivescovo di Modena-Nonantola: «La preghiera di domanda, con le formule imparate a memoria, non è di serie B rispetto a espressioni più alte della vita dello Spirito» .
- [Foto] L’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci, presidente della Commissione episcopale Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio.
Intervista di Riccardo Maccioni (Avvenire, domenica 3 giugno 2018)
La preghiera come dialogo d’amore, che non ha bisogno di frasi mirabolanti o immagini di alta poesia, perché cresce nel rapporto cuore a cuore. L’umiltà e la disponibilità come condizioni necessarie per aprirsi all’azione della grazia, per accettare la logica della salvezza che viene da Dio. E si realizza, per così dire è resa possibile, dal rapporto con gli altri. Un atteggiamento di fiducia, di legame filiale tra la creatura e il Creatore che trova semplice e al tempo stesso profonda sintesi nel libretto ”Chi prega si salva”, in cui sono raccolte le preghiere più note della tradizione cristiana. A partire dalla famosa espressione, di sant’Alfonso Maria de’ Liguori scelta come titolo. E che nella sua formulazione completa suona un tantino inquietante: chi prega si salva, chi non prega si danna.
 «Credo che sant’Alfonso non intenda proporre, con questa espressione, una “teoria universale” riguardante la salvezza o la condanna, ma muoversi dentro all’orizzonte del credente - spiega monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e neo presidente della Commissione episcopale Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio -. In altre parole, il suo interesse è concentrato sul cristiano: in questo senso chi prega si salva e chi non prega si danna. Chi prega, cioè, mantiene quell’apertura umile e disponibile al Signore che è il requisito fondamentale per lasciare entrare nel cuore la grazia. Chi non prega, si illude di tenere in mano la propria vita da solo, si chiude ermeticamente all’amore di Dio, crede di salvarsi da solo. Papa Francesco direbbe che cade nel pelagianesimo ».
«Credo che sant’Alfonso non intenda proporre, con questa espressione, una “teoria universale” riguardante la salvezza o la condanna, ma muoversi dentro all’orizzonte del credente - spiega monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e neo presidente della Commissione episcopale Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio -. In altre parole, il suo interesse è concentrato sul cristiano: in questo senso chi prega si salva e chi non prega si danna. Chi prega, cioè, mantiene quell’apertura umile e disponibile al Signore che è il requisito fondamentale per lasciare entrare nel cuore la grazia. Chi non prega, si illude di tenere in mano la propria vita da solo, si chiude ermeticamente all’amore di Dio, crede di salvarsi da solo. Papa Francesco direbbe che cade nel pelagianesimo ».Nel libretto sono raccolte le preghiere più semplici della vita cristiana, quelle che impariamo da bambini, in famiglia i più fortunati o al catechismo. Perché è importante “frequentarle” anche da adulti?
La memoria orante, come quella liturgica, rappresenta per l’essere umano un punto di riferimento costante nella vita. Tante persone, che poi nemmeno proseguono nella pratica della fede cristiana, continuano quotidianamente a recitare almeno in qualche circostanza le preghiere imparate da bambini. È come il recupero costante di quella dimensione fanciullesca che abita sempre dentro di noi, anche a ottant’anni; e che mantiene viva la condizione posta da Gesù per «entrare nel regno dei cieli»: diventare come bambini. Di nuovo è questione di umiltà e disponibilità.
Quindi la preghiera di domanda, con le formule imparate a memoria, non è di serie B rispetto a espressioni più alte della vita dello Spirito, come l’adorazione o la preghiera del cuore.
Nella preghiera non ci sono le categorie, come nel calcio. Niente serie A, B o C. Piuttosto c’è un modello, al quale ogni preghiera si riconduce: il Padre Nostro, che i padri della Chiesa chiamavano oratio dominica, la preghiera del Signore. In quella breve preghiera, che tutti conoscono a memoria, Gesù suggerisce ben quattro domande: il pane quotidiano, il perdono dei peccati, la custodia dalle tentazioni e la liberazione dal male. Richieste per il corpo, la mente e lo spirito. Queste richieste sono precedute dalla lode, per mettere in evidenza che non sono richieste fatte dagli schiavi al padrone o dai clienti al negoziante, ma dai figli al Padre. Chiedere, quindi, è da figli: purché avvenga nel rispetto della grandezza del Padre. Se siamo figli, dobbiamo chiedere umilmente.
Nella prefazione alla nuova edizione del libro il Papa cita anche una buona preparazione al sacramento della Confessione. Troppe volte abbiamo quasi paura di essere perdonati.
È vero. Forse la difficoltà di prepararci dipende anche dalla sensazione sgradevole che ciascuno di noi prova di fronte ai propri limiti e peccati. Prepararsi significa riflettere, concen-trarsi, calarsi nella propria condizione fragile: e questo dà fastidio. Ma è necessario, se vogliamo sperimentare la misericordia di Dio e correggere i nostri difetti.
Come preparazione al confessionale, che cosa consiglia?
Prima di tutto di ripetere lentamente il “Padre Nostro”, che rappresenta quasi un esame di coscienza: non è infatti la preghiera dell’io, ma la preghiera del noi. «Dacci», «rimetti i nostri debiti », «non ci indurre», «liberaci». È la preghiera di una comunità: mentre dunque chiedo per me, chiedo per noi. E mi interrogo su come io mi rapporto agli altri. Se domando il perdono dei miei debiti, so poi rimetterli ai miei debitori? Se domando il pane per me, so poi condividerlo con gli altri, con quelli che insieme a me formano il “noi” e hanno diritto come me al pane quotidiano?
E per imparare a pregare da dove si comincia?
Si comincia dal cuore, non dalla carta. O meglio, la preghiera scritta e imparata a memoria deve diventare preghiera del cuore, relazione con il Signore. Quando uno si innamora, non si preoccupa di andare a cercare su Internet le frasi giuste da dire. Sarà la relazione a suggerirle. Bastano poche formule - ripeto, Gesù ce ne ha data una esemplare e la Chiesa ce ne offre alcune essenziali - ma occorre molto affetto. Le preghiere stesse incentivano l’affetto, perché l’espressione dell’amore aumenta il grado stesso dell’amore. Se io voglio bene a una persona, ma non glielo dico mai, non scatta la relazione e facilmente quell’amore si raffredda. Così con Dio: non resiste e serve a poco una fede “intellettuale”, fredda, che non si rivolga mai a lui.
Se posso permettermi... c’è una preghiera che lei sente particolarmente “sua’” che la accompagna da sempre?
A questo punto è chiaro che la mia preferita è il Padre Nostro. Dico spesso anche l’Ave Maria. Fin da piccolo ho imparato la preghiera del Rosario, che recito ogni giorno. È come una ripetuta professione d’amore verso la Madre. Quando, insomma, ci si rivolge a Dio come Padre e a Maria come Madre, ci si sente ben custoditi e spronati ad essere paterni e materni verso i fratelli.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?! Un resoconto dell’incontro, con note
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Federico La Sala
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO... LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) --IL "DE OFFICIIS MINISTRORUM" DI AMBROGIO, VESCOVO DI MILANO, E IL MOTTO DELLO STEMMA EPISCOPALE DEL VESCOVO AUSILIARE DI ROMA.21 marzo 2018, di Federico La Sala
IL "LOGOS" E LA "CHARITAS". Sul Vaticano, e su Roma, il "Logo" del Grande Mercante. Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- SANT’AMBROGIO - AMBROSIUS, In Epistolam Beati Pauli Ad Corinthios Primam, Caput XIII, Vers. 4-8: "Charitas Deus est" (I Joan. 4,8).
- Ambrosius, De Officiis ministrorum, Liber 2, Caput XXX, 155: "Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil charitate dulcius, nihil pace gratius"()
Il motto dello stemma episcopale del Vescovo Ausiliare di Roma, S.E.R. Mons. Angelo De Donatis
- NIHIL CARITATE DULCIUS (Ambrosius “De Officiis ministrorum” Liber 2, Caput XXX, 155)
Le parole scelte da Don Angelo per il proprio motto episcopale sono tratte dal “De officiis ministrorum” di Sant’Ambrogio laddove dice “Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”(“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) *
*
Fonte: http://www.sanmarcoevangelista.it (ripresa parziale).
Federico La Sala
-
> IL MOTTO DELLO STEMMA EPISCOPALE DEL VESCOVO AUSILIARE DI ROMA --- Covid-19. Migliora il cardinale Angelo De Donatis. Parametri nella norma (di Mimmo Muolo).1 aprile 2020, di Federico La Sala
Covid-19.
Migliora il cardinale De Donatis. Parametri nella norma
Buone notizie dal Policlinico Gemelli, dove il vicario del Papa per Roma è ricoverato da lunedì, dopo la positività al test. La febbre è scesa e il paziente è sereno. Tanti i messaggi di affetto
di Mimmo Muolo (Avvenire, lunedì 30 marzo 2020)
Migliorano le condizioni del cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, ricoverato al Gemelli dopo essere risultato positivo al test per il Covid-19. Il porporato è sereno, ha trascorso bene la notte tra lunedì e martedì e la febbre si è abbassata. Ha tutti i parametri nella norma e continua la terapia antivirale iniziata al momento del ricovero. A dare notizia del contagio era stato lunedì lo stesso Vicariato di Roma con una nota nella quale tuttavia, già dai primi momenti si precisiava che pur in presenza della febbre, «le condizioni generali» erano «buone». I suoi più stretti collaboratori restano comunque in autoisolamento in via preventiva. Migliaia di messaggi augurali e di affetto, con l’assicurazione delle preghiere, sono giunti al cardinale vicario anche e soprattutto attraverso i social.
«Sto vivendo anche io questa prova, sono sereno e fiducioso - aveva dichiarato lunedì il cardinale De Donatis, che ha compiuto 66 anni lo scorso gennaio -. Mi affido al Signore e al sostegno della preghiera di tutti voi, carissimi fedeli della Chiesa di Roma! Vivo questo momento come un’occasione che la Provvidenza mi dona per condividere le sofferenze di tanti fratelli e sorelle. Offro la mia preghiera per loro, per tutta la comunità diocesana e per gli abitanti della città di Roma!».
Il 26 marzo il cardinale aveva scritto una lettera ai sacerdoti fidei donum: "Sappiamo bene che il Signore non ci abbandona mai. Intuiamo nel discernimento dello Spirito Santo che in questo momento si sta realizzando una purificazione profonda, non solo in noi stessi ma nell’intera comunità cristiana, e che questo passaggio ha a che fare con la Pasqua di Gesù. Stiamo attraversando una Quaresima che ci segnerà profondamente, perché ci spinge a entrare, attraverso la vita, nella Sapientia Crucis".
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). - L’ETICA "CATTOLICA", LO SPIRITO DEL CAPITALISMO "NARRATIVO", E LA SINDROME PARASSITARIA.21 novembre 2017, di Federico La Sala
L’ETICA CATTOLICA E LO SPIRITO DEL CAPITALISMO NARRATIVO. IL "CARISMA" E LA SINDROME PARASSITARIA...
Capitali narrativi /1.Far vivere l’albero degli ideali
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 11 novembre 2017)
- Dobbiamo lavorare in quelle zone intermedie fra parecchi ordini di discipline, nelle quali come al contatto di due terreni diversi si trovano sovente accumulate ricchezze eccezionali
 Achille Loria
Achille Loria
 Le basi economiche della costituzione sociale
Le basi economiche della costituzione sociale
Le comunità, le associazioni, i movimenti, le istituzioni e le imprese vivono grazie a molte forme di capitali. Una di queste è il capitale narrativo, una risorsa preziosa in molte organizzazioni, che diventa essenziale nei momenti di crisi e nei grandi cambiamenti dai quali dipendono la qualità del presente, la possibilità del futuro, la benedizione o la maledizione del passato. È quel patrimonio - cioè munus / dono dei padri - fatto di racconti, storie, scritti, a volte poesie, canti, miti. È un autentico capitale perché, come tutti i capitali, genera frutti e futuro. Se gli ideali della organizzazione o della comunità sono alti e ambiziosi, come accade in molte Organizzazioni a Movente Ideale (OMI), anche il suo capitale narrativo è grande. È una risorsa preziosa durante le prime difficoltà, quando raccontarsi l’un l’altro i grandi episodi di ieri dà il coraggio per continuare a sperare, credere, amare oggi.
Il capitale narrativo, poi, è anche il primo meccanismo di selezione dei nuovi membri dell’organizzazione o della comunità. Noi amiamo molte cose, ma soprattutto amiamo le storie meravigliose, quelle che risvegliano la parte più profonda e vera dell’anima, che ci fanno diventare migliori semplicemente ascoltandole. Più grandi sono i nostri ideali, più grande la nostra anima, più grande deve essere la promessa contenuta nel capitale narrativo per attivarci e farci diventare parte di quella stessa storia. Le storie piccole attraggono persone con desideri e ideali piccoli, le grandi storie conquistano le anime grandi, storie straordinarie attirano persone straordinarie.
Nei primi tempi della fondazione questo capitale narrativo è l’unico bene che una comunità possiede, soprattutto quelle comunità-movimenti che nascono da ideali spirituali - dentro e fuori le religioni. Ci si nutre della vita che si genera, delle prime storie e dei "miracoli", della vita e le parole dei fondatori che si vivono e si raccontano.
 La nuova vita è immediatamente un vangelo, una buona nuova novella. Chi viene raggiunto da quella storia generativa vi riconosce il suo proprio racconto, passato e futuro. In quei primi tempi il tasso di accumulazione del capitale narrativo è molto alto, e la sua crescita è esponenziale. Nei primissimi anni, a volte nei primi mesi o giorni, si forma la gran parte di questo patrimonio speciale. La sua "produttività" è straordinaria e sbalorditiva: è sufficiente evocare, in ogni ambiente, quei primi racconti per assistere ad autentici miracoli, come e (a volte) più impressionanti dei primi. Dire e ripetere le frasi e i fatti dell’inizio produce effetti letteralmente straordinari, che oltre a far crescere la comunità alimenta in chi annuncia la convinzione della verità e forza dell’ideale annunciato, in un circolo virtuoso (storie-annuncio-frutti-rafforzamento-nuovo annuncio...) potentissimo e mirabile.
La nuova vita è immediatamente un vangelo, una buona nuova novella. Chi viene raggiunto da quella storia generativa vi riconosce il suo proprio racconto, passato e futuro. In quei primi tempi il tasso di accumulazione del capitale narrativo è molto alto, e la sua crescita è esponenziale. Nei primissimi anni, a volte nei primi mesi o giorni, si forma la gran parte di questo patrimonio speciale. La sua "produttività" è straordinaria e sbalorditiva: è sufficiente evocare, in ogni ambiente, quei primi racconti per assistere ad autentici miracoli, come e (a volte) più impressionanti dei primi. Dire e ripetere le frasi e i fatti dell’inizio produce effetti letteralmente straordinari, che oltre a far crescere la comunità alimenta in chi annuncia la convinzione della verità e forza dell’ideale annunciato, in un circolo virtuoso (storie-annuncio-frutti-rafforzamento-nuovo annuncio...) potentissimo e mirabile.Se il "carisma" all’origine di queste esperienze è ricco e innovativo, e il fondatore è generoso e creativo, ci si può nutrire per decenni - per secoli - delle storie e delle parole dei primi tempi, senza avvertire il bisogno di aggiungerne neanche una nuova. Ma è dentro questa ricchezza che si sviluppa la cosiddetta sindrome parassitaria. Quasi inevitabilmente e sempre inintenzionalmente gli immensi frutti che generano i racconti del passato diventano un ostacolo alla creazione di nuovo capitale narrativo. E si comincia oggi a vivere con le rendite di ieri - come quell’imprenditore che smette di innovare e generare nuovo reddito perché vive molto bene delle rendite dei capitali del passato. Più è grande il primo capitale narrativo più lunga è la fase della vita alimentata dalla rendita. È questa una forma del cosiddetto "paradosso dell’abbondanza" (o "maledizione delle risorse"), quella trappola nella quale cadono Paesi ricchissimi grazie a una sola risorsa naturale, che finiscono per impoverirsi proprio a causa di quella enorme ricchezza.
 Un fondatore e un carisma spiritualmente ricchissimi possono, senza né volerlo né saperlo, trasformarsi da "benedizione" in "maledizione" se la ricchezza spirituale del suo carisma fa scattare più facilmente e più velocemente la sindrome parassitaria (che può iniziare già durante la vita degli stessi fondatori che smettono di innovare per nutrirsi soprattutto del proprio passato). Perché, paradossalmente, più grande è la ricchezza spirituale, più è probabile che si attivi la sindrome parassitaria. Comunità con fondatori e carismi semplici hanno altri problemi, ma non conoscono la sindrome parassitaria, che è una tipica malattia della ricchezza.
Un fondatore e un carisma spiritualmente ricchissimi possono, senza né volerlo né saperlo, trasformarsi da "benedizione" in "maledizione" se la ricchezza spirituale del suo carisma fa scattare più facilmente e più velocemente la sindrome parassitaria (che può iniziare già durante la vita degli stessi fondatori che smettono di innovare per nutrirsi soprattutto del proprio passato). Perché, paradossalmente, più grande è la ricchezza spirituale, più è probabile che si attivi la sindrome parassitaria. Comunità con fondatori e carismi semplici hanno altri problemi, ma non conoscono la sindrome parassitaria, che è una tipica malattia della ricchezza.Ma a differenza dei capitali finanziari o immobiliari, che possono consentire un flusso costante o crescente di rendita, i capitali narrativi se non vengono aggiornati e rinnovati iniziano a invecchiare e a ridursi. Per loro è massimamente vera la frase di Edgar Morin: «Ciò che non si rigenera degenera».
Un’obsolescenza/degenerazione che nei momenti di accelerazione della storia (come è il nostro) può essere estremamente e drammaticamente rapida. Da un giorno all’altro ci si ritrova con una grave carestia di storie da raccontare. Quei primi racconti che fino a ieri convincevano e convertivano, che erano il nostro grande tesoro, che ci avevano incantato e avevano fondato la nostra vita individuale e collettiva, diventano muti, freddi, morti. La distanza tra il linguaggio e le sfide del presente e i racconti del passato diventa enorme - i giovani sono, anche qui, sentinelle, i primi che segnalano la malattia.
Nelle storie ideali e carismatiche le prime storie continuano a parlare nella seconda e nelle future generazioni solo se accompagnate dalle seconde e terze storie. I francescani hanno tenuto vivo il francescanesimo e il cristianesimo aggiungendo le storie di Francesco a quelle dei Vangeli, e i francescani di oggi tengono vivo Francesco (e il Vangelo) aggiungendo i loro "atti" a quelli del Poverello di Assisi. Il primo patrimonio, il dono narrativo dei padri, non basta per continuare a vivere: è indispensabile anche il dono dei figli - che è anche dono per i padri, che riescono a non morire per sempre.
L’esaurimento del capitale narrativo è la causa più comune di crisi e di morte di una OMI. Non è facile sfuggire da questa sindrome mortale. Spesso ci si ammala e si soffre senza riuscire ad arrivare neanche alla diagnosi, e si attribuisce la crisi ad altre cause (mancanza di radicalità dei giovani, la cattiveria del mondo...). Altre volte si capisce che la crisi ha a che fare con la nostra incapacità di narrazione del cuore del carisma, si constata che il capitale narrativo non (ci) parla più, o non parla abbastanza, o parla alle persone sbagliate, ma si sbaglia la cura.
La cura errata più comune è l’aggiunta di nuove storie più facili da comprendere nel "secolo presente", ma che non hanno più il Dna della prima storia. Tanti finalmente capiscono, perché, semplicemente, stiamo raccontando un’altra storia. Così accade che una comunità nata da un carisma che voleva evangelizzare il mondo della famiglia, di fronte alla difficoltà di continuare a spiegare a loro stessi e a loro mondo le parole evangeliche della prima generazione, col tempo inizia a occuparsi di politiche familiari, adozioni, metodi naturali.
 Queste nuove storie sono molto più vicine alla mutata sensibilità culturale, molto più facili da spiegare e da capire, più adatte per trovare finanziamenti e sostenitori. Ma il problema decisivo che si nasconde in simili operazioni, oggi comunissime, riguarda direttamente il capitale narrativo. La nuova associazione non può più utilizzare il primo capitale narrativo, che resta una risorsa per i soli archivi o per qualche frase per i biglietti di Natale. Qui non c’è innesto di nuove storie sul vecchio albero, ma soltanto la sostituzione del primo capitale narrativo con il nuovo. In certi casi, che sono una specie di questo stesso genere, in una prima fase la nuova parte del capitale narrativo cerca di mantenere il contatto con la sua componente originaria. Ma progressivamente le nuove storie di maggiore successo erodono le vecchie, fino a consumarle interamente.
Queste nuove storie sono molto più vicine alla mutata sensibilità culturale, molto più facili da spiegare e da capire, più adatte per trovare finanziamenti e sostenitori. Ma il problema decisivo che si nasconde in simili operazioni, oggi comunissime, riguarda direttamente il capitale narrativo. La nuova associazione non può più utilizzare il primo capitale narrativo, che resta una risorsa per i soli archivi o per qualche frase per i biglietti di Natale. Qui non c’è innesto di nuove storie sul vecchio albero, ma soltanto la sostituzione del primo capitale narrativo con il nuovo. In certi casi, che sono una specie di questo stesso genere, in una prima fase la nuova parte del capitale narrativo cerca di mantenere il contatto con la sua componente originaria. Ma progressivamente le nuove storie di maggiore successo erodono le vecchie, fino a consumarle interamente.Per molte persone queste trasformazione ed evoluzioni sono insite nella natura delle cose e della storia, ci sono sempre state, e sempre ci saranno. Altri, invece, vi vedono un problema grave e decisivo. Il nuovo capitale narrativo, semplice e facilmente comprensibile, non attrae vocazioni. La prima generazione era stata capace di conquistare persone disposte a dedicare la vita per quell’ideale, perché affascinate dalla profezia e dalla radicalità della promessa. Se la grande difficoltà di spiegare il primo messaggio genera progressivamente parole più semplici da capire perché depotenziate di carica ideale, ciò che accade è la trasformazione del tipo di persone attratte da quel messaggio. Quella persona che nella prima generazione aveva fatto di quell’ideale la o una dimensione identitaria della sua vita (questa è l’essenza di ogni vocazione) poco a poco scompare e al suo posto arrivano membri con una adesione sempre più leggera. In altre parole, il nuovo capitale narrativo non seleziona più vocazioni ma simpatizzanti, o lavoratori impiegati nelle opere (si spende la vita per Dio o per un mondo senza povertà, non per la "responsabilità sociale dell’impresa").
È così che si stanno estinguendo migliaia di comunità carismatiche e movimenti spirituali nati nel Novecento e nei secoli passati. Qualche volta dalla loro morte nascono nuove istituzioni, altre volte muoiono e basta, quando di fronte al probabile snaturamento dell’identità la comunità e i suoi responsabili reagiscono ostacolando o impedendo ogni aggiornamento del primo capitale narrativo. Si continuano a raccontare le prime storie, con lo stesso linguaggio, con le stesse parole che non affascinano più nessuno.
Un terzo esito, altrettanto infelice, è il riassorbimento del carisma dentro la tradizione che quel carisma avrebbe voluto innovare e cambiare. Di fronte alla difficoltà di spiegare, a se stessi e agli altri, il portato carismatico della propria comunità, si rinuncia alle componenti specifiche e nuove, e si "torna" a fare quelle stesse attività tradizionali che si volevano innovare - da giovani si voleva annunciare ad altre religioni e a non-credenti, da adulti si torna a fare catechismo per la cresima.
Questi e molti altri ancora sono gli scenari che approfondiremo e sviscereremo nelle prossime puntate di questa nuove serie. Cercheremo di capire quali buone strade di futuro esistono perché gli ideali possano continuare a nutrire la coscienza del mondo, perché l’innesto delle nuove storie sulle prime funzioni generi una nuova fioritura, nuovi frutti, nuovi colori. Ci chiederemo: è possibile davvero aggiornare, rigenerare, i capitali narrativi delle nostre comunità? Oppure la loro morte è inevitabile? Quali sono le trasformazioni generative? Come capire se stiamo tradendo la promessa o se la stiamo avverando? Domande e risposte difficili e rischiose, ma soprattutto necessarie.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LA’ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA.
- LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola? Una riflessione di Angelo Casati
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est"). Al di là della semantica e del paradigma degli affari e del "caro-prezzo" ("caritas").
 PER UNA "ECONOMIA CIVILE" E UNA TEOLOGIA "CIVILE"!!!
PER UNA "ECONOMIA CIVILE" E UNA TEOLOGIA "CIVILE"!!!"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
- Dobbiamo lavorare in quelle zone intermedie fra parecchi ordini di discipline, nelle quali come al contatto di due terreni diversi si trovano sovente accumulate ricchezze eccezionali
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. -- LA "CARTA DI FONDI". Scelte evangeliche per un cammino di liberazione.10 settembre 2016, di Federico La Sala
Carta di responsabilità e impegno
Scelte evangeliche per un cammino di liberazione
Siamo sacerdoti, religiosi e religiose impegnati da anni con le nostre comunità e i nostri gruppi a far incontrare le fatiche degli uomini con la tenerezza di Dio,
ci sentiamo sollecitati dal Magistero e dall’azione di Papa Francesco a favore degli ultimi e degli emarginati, ci poniamo sulla scia dell’impegno sottoscritto nel “Patto delle catacombe” da numerosi vescovi partecipanti al Concilio Vaticano II,
ci ritroviamo alla fine di un percorso di riflessione e di preghiera che dura da molti mesi, nel Monastero San Magno di Fondi, luogo di antica spiritualità benedettina olivetana e di un’attuale presenza di Fraternità e preghiera,
consapevoli che il momento attuale, portatore di grandi e profondi mutamenti, chiedendo la fatica della conversione, genera un diffuso clima di sospetto e spesso di chiusura e di indifferenza di fronte alla vita,
provocati dall’evangelista Luca che parlandoci di Maria nel viaggio verso Elisabetta scrive, secondo una traduzione più fedele del termine greco anastàsa, “risorta, Maria in piedi”, indicandola dunque come la prima tra i risorti e prima del Risorto stesso,
con lo stile di Maria, da figli del Risorto,
insieme alle nostre comunità ci impegniamo
 a non tacere dinanzi alle ingiustizie e ad ogni tipo di illegalità,
a non tacere dinanzi alle ingiustizie e ad ogni tipo di illegalità, a camminare al fianco delle vittime innocenti delle mafie e di quanti subiscono violenze e sopraffazioni, condividendo il loro dolore e la loro richiesta di giustizia e di verità,
a camminare al fianco delle vittime innocenti delle mafie e di quanti subiscono violenze e sopraffazioni, condividendo il loro dolore e la loro richiesta di giustizia e di verità, a contrastare ogni forma di corruzione perché cancro della civiltà e della democrazia,
a contrastare ogni forma di corruzione perché cancro della civiltà e della democrazia, a leggere la Storia e la strada con lo sguardo dei contemplativi,
a leggere la Storia e la strada con lo sguardo dei contemplativi, ad evitare qualunque forma di religiosità ritualistica e alienante che deturpa il volto paterno di Dio,
ad evitare qualunque forma di religiosità ritualistica e alienante che deturpa il volto paterno di Dio, a vivere ogni manifestazione di pietà popolare nella logica della semplicità e della radicalità evangelica affinché non si trasformino in esaltazione di personaggi potenti e boss mafiosi, e in mortificazione di poveri ed ultimi,
a vivere ogni manifestazione di pietà popolare nella logica della semplicità e della radicalità evangelica affinché non si trasformino in esaltazione di personaggi potenti e boss mafiosi, e in mortificazione di poveri ed ultimi, ad accompagnare il cammino di coloro che intendono pentirsi del male compiuto distinguendo il peccato dal peccatore,
ad accompagnare il cammino di coloro che intendono pentirsi del male compiuto distinguendo il peccato dal peccatore, a realizzare luoghi nei quali trovino accoglienza uomini e donne senza nessun pregiudizio di tipo religioso, etnico e sociale,
a realizzare luoghi nei quali trovino accoglienza uomini e donne senza nessun pregiudizio di tipo religioso, etnico e sociale, a vivere la misericordia come risposta ad ogni tipo di violenza e come accoglienza agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e ai migranti,
a vivere la misericordia come risposta ad ogni tipo di violenza e come accoglienza agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e ai migranti, a promuovere e ad affermare i principi di una cultura di ecologia integrale,
a promuovere e ad affermare i principi di una cultura di ecologia integrale, a sentirci parte integrante dell’ambiente perché ogni aggressione ad esso venga vissuto come una ferita inferta a ciascuno di noi,
a sentirci parte integrante dell’ambiente perché ogni aggressione ad esso venga vissuto come una ferita inferta a ciascuno di noi, a denunciare ogni tipo di connivenza anche istituzionale che favorisce il degrado ambientale agevolando gli affari delle ecomafie,
a denunciare ogni tipo di connivenza anche istituzionale che favorisce il degrado ambientale agevolando gli affari delle ecomafie, a vivere nella libertà ogni tipo di rapporto con la politica per non cadere nelle maglie di facili strumentalizzazioni,
a vivere nella libertà ogni tipo di rapporto con la politica per non cadere nelle maglie di facili strumentalizzazioni, a promuovere l’affermazione di un’informazione che cerchi sempre la verità e tuteli gli ultimi,
a promuovere l’affermazione di un’informazione che cerchi sempre la verità e tuteli gli ultimi, a liberarci e a liberare da una concezione economicistica della terra, dell’ambiente, del lavoro e delle relazioni umane,
a liberarci e a liberare da una concezione economicistica della terra, dell’ambiente, del lavoro e delle relazioni umane, a denunciare quella finanza che uccide i poveri e crea disuguaglianze sociali su scala planetaria,
a denunciare quella finanza che uccide i poveri e crea disuguaglianze sociali su scala planetaria, a lavorare nell’educazione ad una finanza etica e giusta, e ad un’economia di pace
a lavorare nell’educazione ad una finanza etica e giusta, e ad un’economia di pace a vivere il rapporto con il denaro nella logica della trasparenza e della competenza perché non si alimentino favoritismi né si assicurino privilegi,
a vivere il rapporto con il denaro nella logica della trasparenza e della competenza perché non si alimentino favoritismi né si assicurino privilegi, ad orientare le risorse economiche sempre verso il bene comune e mai verso interessi di pochi individui o di singoli gruppi, anteponendo il primato della destinazione universale dei beni ai principi della proprietà privata,
ad orientare le risorse economiche sempre verso il bene comune e mai verso interessi di pochi individui o di singoli gruppi, anteponendo il primato della destinazione universale dei beni ai principi della proprietà privata, ad accompagnare i passi dei giovani scommettendo ulteriormente sulle sfide educative e sostenendo percorsi concreti che generino un lavoro che aiuti più a cooperare che a competere,
ad accompagnare i passi dei giovani scommettendo ulteriormente sulle sfide educative e sostenendo percorsi concreti che generino un lavoro che aiuti più a cooperare che a competere, a tutelare i principi costitutivi della nostra Carta costituzionale,
a tutelare i principi costitutivi della nostra Carta costituzionale, a difendere la sacralità della laicità,
a difendere la sacralità della laicità, a promuovere percorsi virtuosi e responsabili di cittadinanza attiva.
a promuovere percorsi virtuosi e responsabili di cittadinanza attiva.Certi che questi impegni già caratterizzano ogni credente radicato nel Vangelo e che tanti altri fratelli e sorelle, sacerdoti, religiosi e laici vogliano sottoscriverli insieme a noi, sentiamo la responsabilità di ribadire insieme le nostre scelte, e con le nostre comunità, come Maria, vogliamo impegnarci a riconoscere e ad essere strumenti dell’azione misericordiosa e capovolgente di Dio che “rovescia i potenti dai troni e rimanda a mani vuote i ricchi” (Lc 1,52-53), perché anche noi come il profeta Geremia nello scrutare questi orizzonti incerti, con gli occhi pieni di speranza vogliamo sussurrare al mondo: “vedo un ramo di mandorlo” (Ger 1,11).
Fondi, Monastero San Magno
8 settembre 2016
Festa della Natività della Beata Vergine Maria
Luigi Ciotti, Francesco Fiorillo, Marcello Cozzi, Giorgio De Checchi, Ennio Stamile, Giuseppe Fiorillo, Sandra Rosina, Giancarlo Loriggio,
Pierluigi Di Piazza, Mario Vatta, Aldo Antonelli, Pasquale Mascaro, Giorgio Moriconi, Alfredo Micalusi, Pino Demasi, Salvatore Larocca, Luigi Tellatin, Tonio Dell’Olio, Luca Facco, Marco Galletti, Gabriele Pipinato, Giuseppe Gobbo, Tommaso Scicchitano, Giorgio Pisano, Livio Gaio, Narciso Del Poz, Pasquale Aceto, Giovanni D’Andrea, Domenico Francavilla, Mimmo Nasone, Luigi Pellegrino, Tonino Palmese.
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO. LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006) - La “moneta falsa” della filantropia capitalistica. Una riflessione sulla «carità dei ricchi» (di Renato Piccini)26 luglio 2016, di Federico La Sala
La “moneta falsa” del filantrocapitalismo.
Una riflessione sulla «carità dei ricchi» *
- doc-2801. brescia-adisTa. (...) Di seguito ampi stralci dell’articolo di Piccini (rimandando per la sua versione integrale al sito della Fondazione (http://www.fondazionegpiccini.org/Filantropia_tra_carita_e_giustizia.asp). (claudia fanti)
FILANTROPIA
Tra cariTà e giusTizia
Renato Piccini
La filantropia è diventata di moda nel sistema neoliberista. Per capire, quindi, cos’è, la sua vera natura, il peso che ha nei rapporti economico-sociali, quali sono i suoi meriti e demeriti, è necessario guardare dentro il sistema economico capitalista. Oggi, infatti, vi è una nuova concezione, definita filantrocapitalismo.
La filantropia vuol essere la faccia buona del capitalismo, il suo volto pulito, che giustifica le sue scelte fondamentali, anche quelle della più assurda sperequazione sociale, l’impressionante ingiustizia che genera. (...). Non per niente, infatti, il Paese in cui è più diffusa la filantropia, gli USA, è anche quello in cui la sperequazione sociale raggiunge livelli tra i più alti del mondo.
La filantropia, nella concezione capitalista, esclude ogni senso di giustizia. (...). Chi “fa” filantropia non si sente legato ad alcun obbligo né legge e la esercita in piena libertà, secondo i propri “sentimenti” ma, soprattutto, secondo calcoli economico-politici. Chi la riceve sa che non ha alcun diritto e quindi raccoglie quella “moneta” con un duplice obbligo morale: non calcolare il dono secondo le proprie necessità; accoglierlo, soprattutto, con la massima gratitudine per aver ricevuto ciò cui non aveva diritto.
La giustizia è un obbligo di coscienza (e di legge) per chi deve praticarla e, per il destinatario, è un diritto da rivendicare. (...). Linsey McGoey (...) si interroga sull’efficacia ed efficienza dell’attuale filantropia (non molto diversa da quella del passato), soprattutto nell’ottica del filantrocapitalismo, rendendo evidente che la filantropia non viene esercitata secondo i bisogni e le necessità dell’uguaglianza - un diritto che è di tutti, al di là di ogni cultura, fede, geografia... - ma solo secondo la “bontà” (leggi “interessi”) dei padroni del denaro.
È DAVVERO EFFICIENTE LA FILANTROPIA?
In uno dei suoi racconti brevi, La moneta falsa, Charles Baudelaire descrive un incontro immaginario tra due amici che incrociano per strada un mendicante. Entrambi danno l’elemosina, però la moneta che lascia cadere uno di essi è molto più preziosa. Il narratore elogia la sua generosità e il suo compagno gradisce il complimento, però poi, lontano dal mendicante, aggiunge: «Era una moneta falsa».
Il narratore rimane sbalordito. Non soltanto perché il suo amico ha ingannato il mendicante, ma per la sua soddisfazione di apparire generoso. La soddisfazione deriva dal fatto che il mendicante non si rende conto di essere stato ingannato. Il narratore considera che «aveva voluto fare, a un tempo, la carità e un buon affare; guadagnarsi quaranta soldi e il cuore di Dio; pigliarsi senza spesa la fama d’uomo caritatevole».
Baudelaire scrisse questa storia nella seconda metà del XIX secolo, quando industriali come Andrew Carnegie e John Rockefeller cominciavano a investire le loro grandi fortune nelle maggiori azioni di filantropia mai viste prima. Dalle donazioni di Carnegie a biblioteche pubbliche sino agli investimenti di Rockefeller in ricerche biomediche, entrambi cambiarono il modo di fare carità, che passò da donazioni poco sistematiche a una forma di affare in se stesso, controllato da consulenti pagati.
Molti, tuttavia, non si sentivano riconoscenti per la generosità di questi robber barons (baroni ladri). Nel suo saggio L’anima dell’uomo sotto il socialismo, Oscar Wilde criticò la tendenza dei benefattori di usare la carità come copertura dinanzi alle richieste di una giusta redistribuzione della ricchezza. «I migliori tra i poveri - scrisse Wilde - non sono mai riconoscenti [ai benefattori]. Sono scontenti, ingrati, disobbedienti e ribelli, e hanno ragione di esserlo. [...]. Perché dovrebbero essere grati delle briciole che cadono dalla mensa del ricco? Dovrebbero essere seduti intorno al tavolo con gli altri commensali condividendo la festa!».
Ora che la filantropia entra in una seconda epoca d’oro, con donazioni di benefattori come Bill Gates e Warren Buffett (...), gli scettici cominciano a chiedersi se le preoccupazioni di Wilde e Baudelaire siano ancora attuali. I filantropi di oggi stanno coscientemente distribuendo “monete false”? Stanno cercando di “conquistarsi senza sforzi la fama d’uomo caritatevole”?
Nella maggior parte dei casi non è così. Le donazioni vengono realizzate in buona fede, con empatia verso vicini o lontani sconosciuti. Sta però affermandosi una nuova tendenza: il filantrocapitalismo, che cerca di combinare il guadagno con la riduzione della povertà. Dietro a questa nuova filantropia c’è il tentativo di fare una buona azione e, allo stesso tempo, realizzare un buon affare. È ancora valido l’interrogativo che si pose Baudelaire: chi trae più vantaggio dagli aiuti di carità, il donatore o il destinatario?
MISURAZIONE DEI RISULTATI
Nell’avanguardia della nuova filantropia si trova il movimento dell’“altruismo efficiente”, che (...) pone l’accento sulla misurazione dei risultati. Un pioniere è Peter Singer, discusso bioetico che ha elogiato Buffett e Gates come “gli altruisti più efficienti della storia”. (...).
L’organizzatore di una recente conferenza sull’altruismo efficiente, svoltasi nel campus di Google in Mountain View, arrivò al punto di affermare che «l’altruismo efficiente potrebbe essere l’ultimo movimento sociale di cui abbiamo bisogno ». Tuttavia è evidente che l’aumento globale delle donazioni negli ultimi dieci anni non è riuscito a ridurre le disuguaglianze economiche. (...).
Carnagie pubblicò il suo primo saggio sulla ricchezza, nel quale esortava i ricchi a condividere il loro bottino, solo pochi anni prima dello sciopero di Homestead del 1892, una delle più sanguinose rivolte di lavoratori della storia degli USA. Carnagie, nel momento in cui combatteva e annientava i grandi sforzi sindacali in espansione, dispensava anche “generosi aiuti” ai suoi lavoratori.
«Paradossalmente - ha segnalato David Nasaw, biografo del filantropo - Carnagie divenne sempre più spietato nella ricerca di guadagni una volta che decise di distribuirne i benefici». «Nel sostenere che il milionario è l’unico a poter decidere dove destinare i suoi milioni e che quanto egli considera migliore è il meglio - aggiunge Nasaw - Carnagie promulgava una verità profondamente antidemocratica, quasi feudale, del suo paternalismo».
Gli altruisti efficienti insistono sul fatto che la filantropia privata è la via più adatta per migliorare la vita. «I filantrocapitalisti di oggi vedono un mondo pieno di grandi problemi che loro, e forse soltanto loro, possono e debbono risolvere », scrivono Matthew Bishop e Michael Green in Filantrocapitalismo: come i ricchi possono cambiare il mondo, la Bibbia dei nuovi filantropi. (...).
Come ai tempi di Carnegie, la filantropia in molte occasioni viene utilizzata come giustificazione per decisioni lesive per la maggioranza della popolazione. «Ho donato 5 milioni di dollari per diverse cause. E ho una grande voglia di farlo sapere», scriveva su Twitter, a metà settembre del 2015, Martin Shkreli, consigliere delegato dell’impresa farmaceutica Turing, criticata duramente per aver aumentato il prezzo del Darapi (un medicinale di prima necessità usato contro gravi malattie infettive che colpiscono il sistema immunitario, ndt) di oltre il 5.000%. Questo è un eccellente esempio di filantrocapitalismo in azione: l’uso della filantropia per sviare l’attenzione da pratiche commerciali che impediscono l’accesso a medicinali salvavita. (...).
LE CONTRADDIZIONI DELLA FILANTROPIA: OPPORTUNITÀ DI PROGRESSO O AMMORTIZZATORE SOCIALE?
La filantropia viene ritenuta in diversi settori della società essenziale nel contesto del XXI secolo. I fautori ne difendono l’importanza e la necessità come argine agli effetti dell’attuale sistema capitalista “selvaggio”. Molte, però, sono le voci contrarie. (...).
«La filantropia - scrive Slavoj Zizek - è il modo in cui il sistema conserva lo status quo. La sua funzione è nascondere l’origine del problema. Grazie alla beneficienza il capitalismo si può auto-assolvere. La beneficienza diviene parte integrante del sistema, la carità fa parte dell’ideologia generale di oggi». Invece di porsi interrogativi seri su cosa sta succedendo e cercare vie d’uscita che garantiscano il bene comune, si delegano le soluzioni al “buon cuore” di chi ha denaro. (...). «La carità - continua Slavoj Zizek - è la maschera comunitaria che si nasconde dietro lo sfruttamento
economico. Per me il modello insuperabile di ciò che io considero “carità falsa” continua a essere Carnegie. Va bene, fece di tutto, costruì anche spazi culturali, per concerti, ecc... però assunse anche centinaia di detective Pinkerton in Texas per piegare i lavoratori in sciopero e liquidare i sindacati. Questo è per me il modello: prima colpisce brutalmente i lavoratori e poi... offre loro un concerto».
Peter Buffett, figlio di Warren Buffett e, come lui, uno dei più grandi filantropi statunitensi - quindi non “sospettabile” di sentimenti antifilantropici - fa un’analisi interessante: «La carità dei ricchi ha creato una macchina di povertà eterna. [...]. Nelle riunioni dei grandi filantropi si possono vedere capi di Stato, operatori economici, direttori di grandi imprese, capi di corporation transnazionali... che con la mano destra cercano soluzioni per risolvere problemi che i presenti nella sala hanno creato con la mano sinistra. [...]. Nella misura in cui la vita di un numero sempre più alto di individui e comunità viene distrutta da un sistema che crea enormi volumi di ricchezza per poche persone, si rafforza la filantropia come sistema per lavarsi la coscienza con la donazione di qualche briciola». (...).
La carità non arriva mai al nucleo del problema, nei casi migliori lo sfiora soltanto. Non si tratta di essere contro la carità, ma è necessario riconoscere l’ipocrisia di un sistema che, con una mano, “accumula e centralizza il capitale” e, con l’altra, “fa la carità per ridistribuire qualcosa”. (...).
José Ignacio Fernández scrive: «Nel capitalismo carità e ipocrisia sono due pilastri essenziali per la sua sopravvivenza: permettono ai ricchi di nascondere l’esistenza di meccanismi sistemici che generano disuguaglianza e ingiustizia sociale. È un po’ il gioco delle maschere per nascondere il comportamento egoista e il furto sistematico».
I sostenitori della filantropia la difendono come garanzia della vera “sostenibilità” che consiste non nel limitarsi “a dare un pesce a chi ha fame, ma nell’insegnargli a pescare”. La “legge della foresta” che “regola” i mercati, affermano, continuerà a creare bolle speculative che apriranno crisi ricorrenti... e il capitalismo produrrà sempre vincitori e vinti, lasciando molta gente vulnerabile e in grandi difficoltà. Se non si corregge qualcosa di queste disuguaglianze, i “vinti”, anche grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, hanno la possibilità di “rovinare la festa” ai vincitori. La filantropia è essenziale per la sopravvivenza dell’umanità perché i grandi filantropi sono gli unici che possono “pensare in grande”. (...).
Il filantrocapitalismo non è altro che applicare alla solidarietà e alla carità i meccanismi imprenditoriali che hanno permesso di accumulare ricchezze multimilionarie. Harry Browne scrive: «L’idea è geniale: fatti ricco nello stesso tempo in cui salvi il mondo!».
Stephan Ernest Schmidheiny è un imprenditore svizzero condannato a 18 anni di carcere dalla Corte d’Appello di Torino per il disastro ambientale provocato dall’amianto negli stabilimenti Eternit in Italia e nei territori limitrofi, poi prosciolto in via definitiva per intervenuta prescrizione di reato e rimasto unico imputato nel processo Eternit-bis per l’ipotesi di reato di omicidio volontario di 258 persone.
In giro per il mondo, Schmidheiny è ben conosciuto e rispettato in quanto filantropo. Non solo, un’università americana gli ha dato una laurea honoris causa per il suo presunto impegno a favore dell’ambiente. In Italia l’hanno giudicato colpevole di disastro ambientale.
Slavoj Zizek (e molti altri) afferma che l’economia capitalistica attuale ingloba l’etica filantropica assumendola come proprio fondamento, un fondamento contraddetto dalle stesse logiche del capitale. Questo meccanismo perverso fa sì che, di fatto, si verifichi «una sovrapposizione tra etica e consumo: chi consuma può comprare, allo stesso tempo, un’azione etica. La redenzione del consumismo è nel consumo stesso».
La pubblicità che si fa delle grandi donazioni filantropiche aiuta a migliorare l’immagine della marca del donatore, associandola a una percezione di impegno sociale. (...). La filantropia diventa così un’ottima arma di concorrenza, un ottimo strumento di pubblicità e marketing.
La filantropia serve al cambiamento sociale? (...). Il giornalista Pere Rusiñol scrive: «L’età d’oro della filantropia è indiscutibile, però le maggiori quote storiche di fondi della filantropia coincidono con le maggiori quote di disuguaglianza della storia contemporanea. L’aumento delle elargizioni della filantropia e della disuguaglianza percorrono strade parallele». Le donazioni filantropiche negli USA si sono triplicate nello stesso periodo in cui gli ultraricchi hanno triplicato anche la loro parte di torta.
Naturalmente ci sono ragioni precise ed evidenti (...). Secondo i calcoli dell’economista francese Thomas Piketty, negli ultimi trent’anni il tasso effettivo delle imposte del 99% dei cittadini statunitensi è stato, praticamente, costante, mentre per i super-ricchi, in seguito alle detrazioni per “opere benefiche”, è passato dal 72 al 35%.
Lo stesso avviene per le grandi corporazioni con la diminuzione delle imposte per l’aumento della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR - Corporate Social Responsability). (...). L’economista francese Gabriel Zucman mette in guardia sul fatto che questa nuova età d’oro della filantropia, basata sulla riduzione delle imposte pagate dai ricchi e dalle imprese, «mina le fondamenta stesse del controllo sociale. Una società nella quale i ricchi decidono per proprio conto quante imposte pagare e a quali servizi pubblici sono disposti a contribuire non è una società civile. Questo è ciò che succedeva nella società vittoriana del XIX secolo e non dovrebbe succedere nel XXI. Se i multimilionari sono liberi di contribuire alla società, perché debbono pagare imposte? L’atteggiamento di molti, in particolare in Silicon Valley, si riassume in: smetti di farmi pagare imposte e darò la mia ricchezza alle cause che ritengo valgano la pena».
Molte “cause che valgono la pena” hanno quasi sempre a che vedere con la fede assoluta nella tecnologia in grado di risolvere, per se stessa, i problemi dell’umanità. Le fondazioni dei filantrocapitalisti sono lo strumento più importante usato dal capitale per penetrare in settori strategici dove fare affari (salute, educazione, ambiente, comunicazione...).
Ricercatori inglesi e tedeschi sono molto critici circa il potere decisionale dei grandi filantropi in grado di imporre a entità pubbliche e organizzazioni internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale del Commercio, ONU, ecc...) sia l’agenda - i problemi che debbono essere presi in considerazione - sia la metodologia per affrontarli e gli obiettivi che ci si pongono, privilegiando le “soluzioni” idonee e congeniali alle transnazionali. Questi milionari rappresentano un pericolo poiché possono imporre le loro priorità nel mondo, al margine di governi e del sistema democratico: la democrazia diventa una mera facciata al servizio del potere economico-finanziario.
La Fondazione Gates, ad esempio, finanzia campagne in campo sanitario, ma, attraverso intense campagne di lobby, difende anche la validità della proprietà intellettuale per assicurare ampi benefici ai suoi brevetti di software. I brevetti, però, colpiscono anche medicinali e sementi, condizionando pesantemente il diritto alla salute e all’alimentazione di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi più poveri.
La filantropia, infatti, è anche espressione delle lobby più potenti, in grado di condizionare ogni aspetto della vita, della politica, dell’economia. (...). Per il mondo della filantropia l’accesso ai mezzi di comunicazione di massa è abituale: è indispensabile poter contare sull’informazione per far passare il proprio messaggio e portare a casa grandi profitti. (...). Naturalmente, anche in questo campo c’è un uso perverso del linguaggio: cancellati termini riconducibili a diritti sociali, si parla di “necessità” a cui rispondere con azioni filantropiche. (...).
Slavoj Zizek afferma: «La filantropia ha sostituito la politica ». La politica non è più un “affare comune”, è affidata a “professionisti” e rappresentanti, mentre il semplice cittadino deve limitarsi a preoccuparsi/occuparsi dei propri “affari privati”.
Nella privatizzazione “selvaggia”, a tutto campo, del sistema neoliberale, il “cittadino” diviene “insignificante”, non ha voce né spazio, non è ritenuto in grado di decidere cosa sia bene per lui - e tanto meno per la società - per cui ha l’obbligo di “scegliere” ciò che è stato scelto da altri per lui. (...).
Rhodes Diaves, responsabile del programma Giving Thought, della Charities Aid Foundation, chiede: «Come è possibile affrontare ingiustizia e disuguaglianze, quando la filantropia è possibile proprio come risultato della mancanza di equità?». (...).
Andando al di là di ideologie ed emozioni, se analizziamo a grandi linee il ruolo storico della filantropia, le sue conseguenze sociali, economiche e culturali, sembra che questa sia stata più una nemica che un’alleata nella trasformazione dell’attuale sistema economico verso uno più giusto ed equilibrato: una società veramente sana, retta da un modello basato su giustizia ed equità, non avrebbe alcun bisogno di gesti filantropici. Oscar Wilde diceva: «Il vero obiettivo deve esser quello di ricostruire la società in modo tale che la povertà sia impossibile ».
La filantropia rientra nella logica di privatizzare gli interventi su effetti, sintomi, conseguenze che non colpiscono mai le cause, perché queste sono originate dal sistema e ne perpetuano la priorità, prima tra tutto la demolizione del Welfare.
Di certo lo Stato attuale si allontana sempre più da un reale Stato di diritto, rappresentativo dei diritti e degli interessi delle maggioranze, preso com’è tra le spire soffocanti dell’economia e del potere finanziario internazionale, però il futuro della storia non può essere affidato a chi del sistema vive e che tale sistema ha creato e perpetuato: pure questo è un campo aperto da affrontare e per cui lottare.
* Adista/Documenti, 30 LUGLIO 2016 • N. 28
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO. LA FALSA "CARTA" - La “moneta falsa” della filantropia capitalistica - Dio e marketing:Francesco prima di Jobs (di Alessandro Barbero).6 settembre 2016, di Federico La Sala
- CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
- PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est") . Al di là della semantica e del paradigma degli affari e del "caro-prezzo" ("caritas").
 PER UNA "ECONOMIA CIVILE" E UNA TEOLOGIA "CIVILE"!!!
PER UNA "ECONOMIA CIVILE" E UNA TEOLOGIA "CIVILE"!!!
Dio e marketing
Francesco prima di Jobs
Furono i francescani del Medioevo a inventare la politica aziendale adottata oggi dai giganti globali
diALESSANDRO BARBERO (La Stampa, 06.09.2016)
Immaginiamo una grande organizzazione multinazionale, conosciuta in tutto il mondo, fondata grazie allo slancio visionario di un giovane fondatore carismatico, che è diventato un mito già da vivo e ancor più dopo la morte; un’organizzazione riconoscibile anche visivamente per le sue scelte di comunicazione e per il look inconfondibile che la caratterizza.
Sto parlando della Apple e di Steve Jobs? No, sto parlando di san Francesco e dell’ordine francescano. Le analogie tra gli ordini religiosi del Medioevo e le grandi aziende odierne sono così vistose che viene da chiedersi se le strategie e il linguaggio delle multinazionali non si siano ispirati consapevolmente a quell’esperienza.
Oggi non c’è documento di marketing o manuale di comunicazione aziendale che non impieghi a ogni riga le parole vision e mission, che rivelano immediatamente la loro appartenenza al linguaggio dei frati e dei monaci. E d’altra parte, perché le aziende non dovrebbero ispirarsi a un modello di tale successo?
Dieci anni dopo che Francesco ebbe l’intuizione di fondare il suo ordine, i francescani erano già alcune migliaia, il che vuol dire che erano quasi raddoppiati ogni anno; per l’esattezza, si è calcolato un tasso di crescita dell’80% annuo. La conquista di nuovi mercati era gestita con campagne mirate: nati in Italia Centrale, dopo un po’ i francescani decidono di espandersi a Nord, e mandano apposite task force in Lombardia e in Germania, affidate a frati che sanno predicare nelle lingue straniere, «in lombardico et in theutonico».
Nel 1219 Francesco decide di mandare un gruppo di frati in Francia, per diffondere l’Ordine anche in quel regno; ven t’anni dopo sono già fondati qualcosa come 72 conventi.
Non stupisce che Francesco, a un certo punto, abbia aperto gli occhi e si sia accorto di aver creato un mostro: era a capo di una multinazionale, lui che voleva andare in giro scalzo con un gruppetto di amici, parlando di Gesù alla gente e scaricando casse al mercato per mantenersi. Negli ultimi anni di vita Francesco si dimise dalla guida dell’ordine, creando grossissimi problemi ai suoi successori, perché per l’immagine dell’organizzazione e la motivazione dei membri il mito del fondatore è essenziale.
Fra il Novecento e il Duemila i grandi fondatori di aziende, gli Henry Ford, i Bill Gates, gli Steve Jobs sono stati mitizzati in vita, e sono diventati delle leggende dopo la morte, grazie anche all’invenzione di quel peculiare genere letterario, la biografia autorizzata, erede diretto dell’agiografia medievale.
Il caso di Steve Jobs conferma che i visionari del Medioevo avevano ragione quando insistevano sull’importanza del look. La biografia autorizzata di Walter Isaacson ci svela che non era certo un caso se Jobs vestiva sempre uguale, jeans blu senza cintura e maglioncino nero a collo alto. Più volte il fondatore di Apple propose che tutti i dipendenti dell’azienda si vestissero allo stesso modo, ma i lavoratori non apprezzavano l’idea, e Jobs dovette accontentarsi di vestirsi lui così: nell’armadio aveva un centinaio di dolcevita neri, tutti uguali, e previde correttamente che gli sarebbero bastati per tutta la vita.
Francesco, invece, riuscì a imporre ai frati di vestirsi tutti allo stesso modo, con un saio bigio e un cappuccio a punta, da contadino; ma dopo la sua morte i francescani ebbero dei sai larghi e comodi, di ottima stoffa, e il cappuccio diventò ampio e arrotondato, come voleva la moda.
Grazie alle tecnologie moderne gli storici dell’arte hanno scoperto che diverse tavole col ritratto di San Francesco sono state modificate dopo la sua morte, cancellando l’odiato cappuccio a punta e sostituendolo con un cappuccio da giovanotto elegante.
Tutti sapevano che l’immediata riconoscibilità era un ingrediente del successo. Quando il monastero di Cîteaux cominciò a fare concorrenza a quello di Cluny, i cistercensi scoprirono che nella regola benedettina non stava scritto da nessuna parte di che colore doveva essere l’abito; per tradizione era nero, ma loro si vestirono di bianco, perché la gente doveva vedere la differenza.
Il mantello bianco era anche la prerogativa dei Templari, e quando un ordine concorrente, i Teutonici, volle adottarlo, i templari protestarono col papa, perché impedisse quella concorrenza sleale: il copyright era loro! Poi gli ordini militari ebbero il problema, comune a tante aziende, di una crisi di mercato che ridusse la domanda.
Dopo la perdita della Terrasanta e la fine delle crociate non c’era più un gran bisogno di monaci guerrieri. C’erano ben tre ordini militari, i Templari, gli Ospedalieri e i Teutonici, e sempre più voci si levavano contro questi enti inutili, che per la cristianità rappresentavano un passivo netto. Gli ordini reagirono presentando un progetto di fusione: così, argomentò il Gran Maestro del Tempio, si realizzeranno dei grossi risparmi, dove prima c’erano tre poltrone ne rimarrà una sola.
Ma l’antitrust intervenne: i sovrani europei fecero sapere al papa che non avevano nessuna voglia di trovarsi fra i piedi una multinazionale monopolistica e strapotente .
Alla fine, com’è noto, Filippo il Bello risolse a modo suo il problema della ridondanza dei templari; ma i loro rivali , gli Ospedalieri , esistono ancora, col nome di Ordine di Malta. E a questo proposito, ci sono due organizzazioni che recentemente hanno lanciato un progetto chiamato Vision 2050.
Sono progetti che non hanno niente in comune, ma sono stati chiamati nello stesso modo per caso da manager che condividono lo stesso tipo di linguaggio.
Una è il Wbcsd, organizzazione che riunisce circa 200 multinazionali , e che col progetto Vision 2000 si propone di guidare la « global business community» verso un futuro sostenibile. L’altra è appunto l’Ordine di Malta, che col progetto Vision 2000 si propone di reclutare giovani e finanziare iniziative fino alla metà del secolo. Così una potentissima associazione di multinazionali, fondata nel 1992, con sede a Ginevra, e l’Ordine di Malta, il vecchio concorrente dei Templari, che nel suo sito ufficiale dichiara di essere in attività dal 1048, usano lo stesso linguaggio ; ed è molto difficile decidere chi è che sta imitando l’altro.
-
>LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" --- AMORE E MISERICORDIA, OGGI. I nuovi idoli nascosti nei nostri desideri.15 maggio 2016, di Federico La Sala
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
I nuovi idoli nascosti nei nostri desideri
 Il saggio di Petrosino mette in discussione alcune analisi sulla società liquida di Bauman
Il saggio di Petrosino mette in discussione alcune analisi sulla società liquida di Bauman
 Per Dostoevskij un uomo rimasto libero non ha altra cura che di cercare un essere cui inchinarsi
Per Dostoevskij un uomo rimasto libero non ha altra cura che di cercare un essere cui inchinarsi
 Il godimento compulsivo degli oggetti finisce per annientarci
Il godimento compulsivo degli oggetti finisce per annientarcidi Massimo Recalcati (la Repubblica, 02 giugno 2015)
- Silvano Petrosino, L’idolo. Teoria di una tentazione. Dalla Bibbia a Lacan (Mimesis pagg. 129, euro 14)
IL nostro tempo ha sostituito al culto di Dio il culto degli idoli di cui il denaro è l’espressione più semplice e radicale in quanto rende possibile l’illusione che il suo possesso in grandi quantità consenta la realizzazione di una vita soddisfatta. Il Pasolini corsaro l’aveva indicata come una vera e propria "mutazione antropologica": il monoteismo che sosteneva le società religiose e che affondava le sue radici nella potenza simbolica del Padre, ha lasciato il posto al politeismo del mercato e alle sue nuove divinità.
Al verticalismo piramidale dell’ideologia patriarcale è subentrata la diffusione orizzontale dell’oggetto di godimento divenuto un idolo che ha trasformato l’uomo da "suddito" a "consumatore".
È il tratto perverso che caratterizza il discorso del capitalista: la feticizzazione della merce vorrebbe cancellare la struttura in perdita e necessariamente mancante del desiderio umano, riducendo la mancanza ad un vuoto che esige di essere compulsivamente riempito. Al punto che la strategia dell’idolo non è semplicemente quella di colmare la mancanza, ma di alimentarla continuamente offrendo sempre nuovi idoli che sappiano rendere caduchi e obsoleti quelli precedenti.
In un libro che mette coraggiosamente a colloquio la lezione della Bibbia e quella di Lacan, titolato L’idolo. Teoria di una tentazione: dalla Bibbia a Lacan ( Mimesis), Silvano Petrosino prosegue la sua perlustrazione critica del nostro tempo iniziata con due formidabili e saettanti libri: Babele. Architettura, filosofia e linguaggio di un delirio (Melangolo, 2002) e Soggettività e denaro. Logica di un inganno ( Jaca Book, 2012). Se le analisi sociologiche di Bauman mettono l’accento sul carattere "liquido" del discorso del capitalista, sulla sua tendenza alla dispersione e alla dissoluzione dei legami sociali, Petrosino ci indica come quel discorso proprio mentre azzera l’orizzonte simbolico del mondo offre al soggetto, attraverso la proliferazione mercificata di nuovi idoli, un rifugio, un riparo fantasmatico, una solidificazione della sua esistenza.
Cos’è, infatti, un idolo? È una promessa di compattamento della vita umana. È una parte che il soggetto eleva alla dignità del tutto per sconfessare il carattere infinito del desiderio e la mancanza che esso porta irrimediabilmente con sé. In questo senso il culto dell’idolo è sempre un’operazione perversa, se la perversione è il tentativo di diventare padroni assoluti del proprio desiderio. Se, infatti, il desiderio è un’apertura che non si lascia mai colmare da nulla e se il soggetto del desiderio è un soggetto, come ci invita a pensare Lacan, lacunare, mancante, leso, l’inganno del discorso del capitalista consiste, secondo Petrosino, nel voler convertire la logica del desiderio in quella del bisogno offrendo al soggetto un oggetto in grado di garantirgli una consistenza.
L’idolo sorge, infatti, come un oggetto capace di catturare fantasmaticamente il desiderio assorbendone la trascendenza. Per questa ragione l’idolo più grande, il più pericoloso, il più folle, è quello dell’Io. L’Io - come Lacan indica - non è altro che il soggetto "allo stato di idolo", poiché l’idolo non è solo una falsa immagine di Dio, ma è soprattutto una falsa immagine dell’uomo.
La tentazione più estrema sulla quale sia il testo biblico che quello di Lacan non risparmiano di ammonirci, è quella di fare dell’Io un oggetto capace di spurgare il soggetto di ogni mancanza e di ogni trascendenza. È il miraggio di falsa padronanza che ispira la perversione: il soggetto non appare più assoggettato alla trascendenza del desiderio, ma diventa padrone dell’oggetto del suo bisogno attraverso il suo possesso. È lo stesso inganno che pilota il collezionista che insegue l’ultimo agognato "pezzo" della sua collezione pur sapendo che nemmeno il possesso di questo pezzo potrà estinguere davvero la sua passione.
L’idolo vorrebbe dare una consistenza sostanziale all’Io, renderlo autosufficiente, emanciparlo dalla trascendenza del desiderio, farne davvero l’ultimo "pezzo" della collezione. In realtà il culto dell’idolo si rivela essere una forma radicale di schiavitù: il soggetto si consegna al suo idolo perdendo se stesso. Non si soddisfa mai nel consumare l’oggetto, ma è piuttosto il godimento compulsivo degli oggetti che finisce per consumarlo. Cosa spinge l’uomo a fabbricare continuamente idoli se non per scansare l’impatto angosciante con la trascendenza del proprio desiderio? Con la propria libertà? Non è forse questo a cui alludeva anche Dostoevskij quando scriveva che «non c’è per l’uomo rimasto libero più assidua e tormentosa cura che quella di cercare un essere a cui inchinarsi »?
L’"uso" che Petrosino ci propone nella sua opera filosofica di Lèvinas, Derrida e Lacan cerca di individuare dei punti di resistenza a questa deriva idolatrica. In essi egli trova un pensiero che non vuole rinunciare alla trascendenza e che ostinatamente pensa l’Altro nella sua radicale differenza, come quell’Altro che abitandoci ci espropria di ogni ideale omogeneo di padronanza. Di qui il suo rifiuto ad appiattire la vita umana sull’immediatezza ingenua di ogni materialismo.
L’immanentismo che nega la trascendenza commette il grave errore di misconoscere quell’apertura all’Altro che anima l’esistenza e di cui il desiderio è l’incarnazione più radicale e più sconcertante. In questo egli porta il "suo" Derrida e il "suo" Lèvinas, ma anche, per certi versi, il "suo" Lacan, con rispetto ma con decisione, verso il salto più radicale che caratterizza l’esperienza cristiana: il problema non è contrapporre la trascendenza all’immanenza, ma mostrare che la trascendenza abita da cima a fondo l’immanenza, l’attraversa, la vivifica, la scompagina, la illumina. Per questa ragione la figura del desiderio costituisce un motivo che unifica tutta la sua ricerca; essa è la cifra ultima dell’umano, la sua radicalissima trascendenza interna, l’apertura inesauribile verso una alterità che oltrepassa il nostro Io costringendolo ad un decentramento tanto spaesante quanto generativo.
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" --- AMORE E MISERICORDIA, OGGI. Vuoi fare il bene? Devi imparare ad avvicinare l’Altro (di Enzo Bianchi)15 maggio 2016, di Federico La Sala
Vuoi fare il bene? Devi imparare ad avvicinare l’Altro
La carità a distanza, virtuale, è solo filantropia: amiamo il corpo dei bisognosi accanto (che non vediamo)
- Enzo Bianchi dialoga con Massimo Recalcati, sabato 14, ore 15, all’Auditorium, sul suo ultimo libro «Amore e misericordia» (Edizioni San Paolo). Alle 17,30, il priore di Bose sarà in Sala Blu, con Alessandro Leogrande e Luigi Manconi, autore di «Corpo e anima. Se vi viene voglia di fare politica» (Minimum Fax)
di Enzo Bianchi (La Stampa, 12/05/2016)
Parlare di misericordia e tentare di viverla significa anche sapersi fermare per avvicinarsi all’altro, rendersi prossimo a chi incontriamo: operazione assolutamente necessaria per noi umani, perché io e l’altro siamo innanzitutto corpi, ed è nella vicinanza dei corpi, nell’osare la carne, che può avvenire l’incontro. Solo in questa situazione l’altro può essere ascoltato mentre esprime il suo bisogno. Dovremmo imparare a porre più spesso a quanti incontriamo una domanda che nei Vangeli troviamo in bocca a Gesù: «Cosa vuoi che io faccia per te?» (Mc 10,51).
Nessuna azione imposta, nessuna decisione aprioristica di cosa fare a servizio dell’altro, ma innanzitutto ascolto, atteggiamento semplice eppure difficilissimo per ciascuno: ascoltare per obbedire al bisogno reale, alla povertà concreta dell’altro e non per tacitare la nostra smania di «fare il bene». Solo così il povero, il bisognoso non risultano un oggetto o un pretesto per la nostra azione, ma si ergono come in verità li ha letti la tradizione biblica: soggetti davanti ai quali inchinarci, sacramenti di Dio, segni capaci di indicarci il Signore; sono i veri maestri, i detentori di un magistero silenzioso che dobbiamo discernere e accogliere. Solo in questa situazione di autentico ascolto del povero possiamo metterci al suo servizio e diventare strumenti della carità, dell’amore di Dio.
Noi umani non sempre siamo cattivi come ci giudichiamo: possiamo constatare che in noi c’è la capacità della misericordia, di questo sentimento che si sprigiona dalle nostre viscere di fronte al male. Poi però non abbiamo tempo di sostare accanto al bisogno dell’altro, andiamo oltre (cf. Lc 10,31-32) e i nostri peccati diventano soprattutto peccati di omissione. Raramente facciamo azioni cattive contro i bisognosi, ma quasi sempre non facciamo nulla! Questo è il problema, perché «non aver fatto» è il rimprovero che il Figlio dell’uomo rivolgerà nel giorno del giudizio: «Ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato» (Mt 25,42-43).
Come dimenticare il racconto dell’incontro tra Gesù e l’uomo ricco? A quell’uomo che dice di aver osservato tutti i comandamenti fin dalla giovinezza (cf. Mc 10,19-20 e par.) Gesù, secondo l’apocrifo Vangelo degli Ebrei, replica: «Come puoi dire: ho osservato la Legge e i Profeti? È scritto nella Legge: “Tu amerai il tuo prossimo come te stesso”, ed ecco che un gran numero dei tuoi fratelli, figli di Abramo sono vestiti di cenci e muoiono di fame mentre la tua casa è piena di beni in abbondanza e assolutamente nulla esce da essa per loro».
Sì, esiste un peccato di omissione verso i bisognosi, nient’altro che omissione! Ma quante sono le forme di povertà? Tante quanti sono i bisogni! E la misericordia deve spingerci a «fare misericordia», a passare dal sentimento così naturale in ogni persona alla scelta di impegnarsi e fare concretamente gesti e azioni che siano cura dell’altro, aiuto affinché possa uscire dalla condizione di bisognoso. Se una persona sa praticare verso l’altro le operazioni del vedere, dell’avvicinarsi, dell’ascoltarlo nel suo bisogno, allora farà misericordia, si metterà a servizio dei poveri, sentendo in sé prepotente la responsabilità verso l’altro che è fratello o sorella, che è la mia carne, che - se sono cristiano - è la carne di Cristo, come ama ricordare papa Francesco.
In un libro dal titolo emblematico, La morte del prossimo (Einaudi 2009), lo psicoanalista Luigi Zoja, dopo aver ricordato l’annuncio della morte di Dio da parte di Nietzsche, ha aggiunto che è avvenuta, per l’appunto, anche la morte del prossimo, perché oggi viviamo misconoscendo soprattutto la prossimità. La società tecnologica elimina sempre di più la dimensione della prossimità dei vissuti e crea una concreta distanza tra gli umani. Non c’è più l’altro che sta vicino, quello su cui poso la mano, e così il trionfo dell’indifferenza e dell’individualismo esasperato conduce alla morte della carità, o meglio al non poter più esercitare la carità, la solidarietà, la com-passione come soffrire insieme. Ce ne stiamo ciascuno lontano dagli altri per indifferenza o per paura; perché non abbiamo tempo e corriamo dal mattino alla sera; perché non abbiamo più voglia dell’altro, sempre più lontano, sempre meno invitato e accolto in casa nostra; perché non abbiamo più desiderio di prendere tra le mani il volto e le mani di un altro.
Ora la carità a distanza, virtuale, impersonale è solo filantropia che si nutre di sentimenti e di buone dichiarazioni, ma che si rivela ostacolo fondamentale all’esercizio dell’amore e della carità verso il corpo dei poveri, verso i bisognosi che vivono accanto a noi e dei quali tragicamente neppure ci accorgiamo.
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. -- "CONTRO AMBROGIO" (F. Cardini). Il patrono di Milano affermò per primo la supremazia della chiesa sullo stato (di P. Mieli)..26 aprile 2016, di Federico La Sala
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
La teocrazia di AmbrogioIl patrono di Milano affermò per primo la supremazia della chiesa sullo stato
di Paolo Mieli (Corriere della Sera, 26.04.2016)
Nel IV secolo il mondo cristiano fu sconvolto dall’eresia ariana. Ario, teologo nordafricano, sosteneva che Cristo, essendo stato «generato» da Dio unico, eterno e indivisibile, era «venuto dopo» e non poteva essere considerato allo stesso modo del Padre: c’era stato, cioè, «un tempo in cui il Figlio non c’era». Ai tempi di Costantino, che aveva spalancato le porte dell’impero ai seguaci di Cristo, si tenne il Concilio di Nicea (325) che condannò la dottrina ariana. Ma qualche tempo dopo l’imperatore riabilitò Ario e costrinse all’esilio il suo grande nemico, Atanasio vescovo di Alessandria. Dopodiché i decenni successivi furono contrassegnati da una lunga controversia tra ariani e atanasiani e la Chiesa di Roma faticò non poco per venire a capo della dottrina eretica che nel frattempo aveva conquistato vescovi e sovrani. Un grande protagonista di questa battaglia fu Ambrogio, che pure sulle prime aveva avuto qualche indulgenza (o qualcosa di più) nei confronti dell’arianesimo. È questo il punto di partenza di un originale libro di Franco Cardini Contro Ambrogio, che sta per essere dato alle stampe dalla Salerno.
Fin dalle prime righe, Cardini mette le mani avanti per difendersi dalle accuse che potrebbe ricevere per questo saggio impertinente. Il suo non vuol essere né un pamphlet «provocatorio», né «un’indecorosa dissacrazione», tantomeno «un dissennato attacco a livello storico o peggio ancora teologico» all’indirizzo dell’uomo che, tra l’altro, fu ispiratore e modello per sant’Agostino. Non vogliono essere, i suoi, «giudizi moralistici del tutto antistorici», né «paradossali esercitazioni ucroniche» e neppure «fatue e faziose polemiche» con il senno del poi. È, quello di Contro Ambrogio , solo un tentativo di «uscire dal comodo riparo dello storico» a favore di una modalità che gli consenta di «scoprirsi», «esporsi», «prendere posizione». Il tutto non disgiunto da un «pizzico di autoironia per aver tentato, al cospetto di un gigante della storia e del pensiero, una specie di ruggito del topo».
Tra l’altro che ci siano aspetti controversi nella vita di Ambrogio traspariva già, tra le righe, dalle impeccabili note di Marco Navoni alla Vita di sant’Ambrogio (edizioni San Paolo) scritta da Paolino, coevo e principale collaboratore del patrono di Milano. Così come, sempre tra le righe, dalle biografie di Cesare Pasini, Ambrogio di Milano. Azione e pensiero di un vescovo (edizioni San Paolo) e di Angelo Paredi, S. Ambrogio e la sua età (Jaca Book). E anche, sia pur marginalmente, dallo straordinario Teodosio il Grande (Salerno) di Hartmut Leppin.
Il libro di Cardini prende le mosse dal 374 allorché, avendo esercitato fin lì il ruolo di governatore laico di una regione che all’epoca corrispondeva alla Liguria e all’Emilia e pur non essendo ancora battezzato, il trentacinquenne Aurelio Ambrogio (era nato nel 339 a Treviri, città che dal 292 era la residenza ufficiale dell’imperatore romano d’Occidente) fu nominato vescovo di Milano, dal 286 «sede imperiale».
Era figlio di un alto magistrato del sovrano Costantino II, ma su suo padre c’è un «ambiguo silenzio» che ci indurrebbe a sospettare fosse stato coinvolto in una delle controversie dell’epoca e avesse «militato dalla parte degli sconfitti». A «portarlo così in alto» era stato il prefetto Sesto Petronio Probo, un uomo molto chiacchierato con evidenti inclinazioni all’arianesimo, così come l’imperatrice Giustina (moglie di Valentiniano I e madre di Valentiniano II) protettrice di Probo. Ariano fu anche il suo predecessore alla cattedra episcopale milanese, Aussenzio.
A decidere della sua elevazione a quell’importantissimo incarico sarebbe stato il grido di un bambino, che in una riunione popolare avrebbe invocato «Ambrogio vescovo!», suscitando un immediato entusiasmo popolare in quella che Cardini definisce una evidente «messinscena», un «ben architettato episodio di organizzazione del consenso», un genere di «spontaneità popolare accuratamente pilotata». Dietro la quale è ancora ben riconoscibile la regia di Probo. In ogni caso, a seguito di quell’acclamazione, Ambrogio si fece battezzare, divenne vescovo (con qualche irregolarità formale) e non tardò a liberarsi dell’ingombrante appoggio del suo potente protettore.
Da quel momento comparve al suo fianco il presbitero Simpliciano, fedele di Atanasio, che gli fu accanto tutta la vita e, nonostante avesse venti anni più di lui, gli sopravvisse. Per un breve periodo ci fu anche suo fratello Satiro, che Cardini sospetta nutrisse simpatie ariane. Quanto a lui, nel 376, in contrasto con l’imperatrice Giustina, si oppose all’elezione a Sirmio di un vescovo seguace di Ario e dal 378 iniziarono a comparire spunti anti-ariani nelle sue omelie. Giusto in tempo per essere in sintonia con l’editto di Tessalonica (380), con il quale l’imperatore d’Oriente, Teodosio, impose «a tutti i popoli a noi soggetti» la disciplina apostolica e la dottrina evangelica del credo «nell’unica divinità» di Padre, Figlio e Spirito Santo. Sicché Teodosio, secondo Franco Cardini, «ben più adeguatamente di Costantino, può essere considerato il vero fondatore dell’impero romano-cristiano».
Comunque la partita religiosa si riaprì nel 386, quando Giustina impose un decreto per la libertà di culto che consentiva agli ariani di pretendere una basilica in cui poter celebrare il rito. Ambrogio si oppose con forza e una folla («spontaneamente convocata», ironizza Cardini) scese in piazza a spalleggiare il vescovo, creando «una situazione al limite della legalità». La «contesa delle basiliche» andò avanti per settimane, incrinò il rapporto di Giustina con il proprio figlio Valentiniano, si concluse con il trionfo di Ambrogio e la sconfitta della libertà di professare religioni diverse da quella stabilita al Concilio di Nicea.
Il vescovo di Milano, una volta piegata la corona d’Occidente, si dedicò a sottomettere quella d’Oriente. Vale a dire Teodosio. Una prima volta, nel corso di una cerimonia religiosa, il vescovo invitò l’imperatore a lasciare il presbiterio e ad andarsi a sedere, sia pure in prima fila, tra i fedeli. Quasi esplicito il significato, sotto il profilo simbolico, di questo gesto. Ma l’occasione decisiva si presentò, dopo una serie di piccoli e grandi sgarbi da parte dell’autorità religiosa nei confronti di quella imperiale, con l’orrenda vicenda del tempio di Callinicum (l’odierna Raqqa). Lì un gruppo di cristiani aveva date alle fiamme una sinagoga, l’imperatore li aveva condannati a risarcire la comunità ebraica: Ambrogio impose a Teodosio di revocare quell’ingiunzione.
Poi, nel 390, ci fu la strage di Tessalonica. Un auriga dei giochi circensi era stato imprigionato per «comportamento immorale». I suoi tifosi avevano reagito aggredendo a sassate un funzionario imperiale, Buterico, che era stato ucciso e trascinato per le vie della città greca. Teodosio giudicò sospetta quell’esplosione di rabbia e accondiscese alla richiesta dei militari di reprimere con violenza (migliaia di morti) i rivoltosi. Ambrogio ne approfittò per umiliare una seconda volta Teodosio, chiedendogli un pubblico pentimento per l’eccidio. L’imperatore provò a resistere, ma poi decise di sottomettersi all’ingiunzione.
Secondo la ricostruzione di Paolino, Teodosio «pianse pubblicamente nella Chiesa il suo peccato... con lamenti e lacrime invocò il perdono». Anche Agostino, nel De civitate Dei, ricorda la scena: Teodosio «fece penitenza con tale impegno» che tra i fedeli il «dolore nel vedere umiliata la maestà dell’imperatore» prevalse sullo sdegno per il ricordo della strage. Teodosio si accorse probabilmente di quel che era accaduto nel profondo e, per rimediare, si recò a Roma dove fu accolto da senatori e ottimati con feste che più o meno esplicitamente rendevano omaggio agli antichi culti pagani.
Tuttavia l’episodio dell’imperatore «penitente per imposizione di un vescovo», osserva l’autore, fece scalpore in tutta l’ecumene romana: era la prima volta che «l’Augusto, da principe aureolato di autorità sacrale qual era sempre stato, da vicario del Cristo in terra, era sceso al livello di un semplice fedele, pronto ad umiliarsi per ricevere il perdono».
Ambrogio approfittò di quell’atto di sottomissione per riprendere e condurre a compimento «il progetto di delegittimazione totale e irreversibile dei ceti diversi da quello cristiano niceno in tutto l’impero». Fu lui ad ispirare l’editto del 391 che vietava qualunque forma di ossequio alle divinità «gentili» nella città di Roma e prevedeva pesanti sanzioni per i funzionari inadempienti. Era la «totale palinodia» rispetto al comportamento tenuto e alle misure adottate dall’imperatore un po’ meno di due anni prima nel corso della menzionata visita a Roma.
Da quel momento fino alla morte, nel 397, Ambrogio esercitò una sorta di «dittatura» sottile sul potere imperiale d’Oriente e d’Occidente. Anche a costo di lasciarsi andare ad imprudenze, di commettere errori, e di fare scelte in contraddizione con i suoi principi. Ma la sua missione era compiuta.
Il suo lascito fu inequivocabile. Dal momento che il sovrano era stato per lui non al di sopra, bensì all’interno della Chiesa, ne discendeva che risultava subordinato all’autorità ecclesiale. In tal senso, Ambrogio si pone alla base «di un lungo e complesso itinerario che in vario modo, attraverso l’agostinismo politico, la riforma della Chiesa dell’XI secolo e il monarchismo pontificio», ha configurato una ben delineata tradizione. Tradizione «che in ambito cattolico - una volta battute le eresie e isolati come eretici o comunque pericolosi molti movimenti “non conformisti” medievali - solo il conciliarismo quattrocentesco, in una certa misura il Vaticano II e, oggi, le scelte innovatrici di papa Francesco, hanno teso in qualche modo a limitare e a correggere».
Un messaggio venuto da lontano, radicato nella certezza che «il liberare e il mantener libero il clero dai controlli e dai condizionamenti di qualunque autorità terrena - ben al di là se non al contrario di quanto Gesù dichiara esplicitamente a Pilato - sarebbe stata condizione necessaria e sufficiente per salvarlo dalle tentazioni terrene». E sappiamo, aggiunge Cardini, che «l’intera storia della Chiesa dimostra l’opposto».
Dopo Ambrogio, la Chiesa romana divenne potente «con la forza di una mirabile espansione intellettuale e missionaria, ma anche con l’inflessibilità e l’intransigenza della fedeltà a un disegno egemonico affermatosi poi tra l’XI e il XVI secolo attraverso la rimozione delle istanze provenienti dal mondo greco, da quello orientale, da quello vario, insidioso e imprevedibile delle eresie, da quello musulmano (pensiero filosofico-scientifico a parte), salvo dover poi subire i contraccolpi degli scismi, della Riforma protestante, dell’offensiva razionalistico-scientifica».
Traendo ispirazioni e suggestioni da Francesco d’Assisi, Nicola Cusano ed Erasmo da Rotterdam, Cardini si chiede se, «astraendo dal modello e dal magistero ambrosiani la Chiesa sarebbe mai giunta a dover concepire i tribunali inquisitoriali, ad affrontare scismi e riforme, a subire lo “strappo culturale” della “modernità” con il relativo processo di secolarizzazione». Dubbi e rilievi che, come è evidente, vanno ben al di là della figura storica di Ambrogio.
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). -- Contro le dittature serve una Magna Carta globale (di Garry Kasparov)16 marzo 2016, di Federico La Sala
- A Mikhail Gorbaciov e a Karol J. Wojtyla ... per la pace e il dialogo, quello vero!!!
 "AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
"AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
Kasparov: contro le dittature serve una Magna Carta globale
Un’anticipazione dell’ultimo libro dello scacchista e dissidente russo che domani esce in Italia. “Le democrazie aiutino chi non è libero”
di Garry Kasparov (La Stampa, 16.03.2016)
Il 9 novembre del 1989 è stato uno dei giorni più gloriosi della storia mondiale. Centinaia di milioni di persone furono liberate dal comunismo totalitario dopo generazioni di tenebre. Non vi è certo carenza né di dottrine né di opinioni sul perché a suo tempo sia caduto il Muro. Io sono ben felice di imbarcarmi in simili discussioni infinite, tuttavia dobbiamo riconoscere che cercare una causa precisa per un evento specifico significa perdere di vista l’essenziale. Sappiamo bene che, senza l’unità del mondo libero contro un nemico comune, e senza una presa di posizione forte basata sul rifiuto di negoziare sul valore della libertà individuale, il Muro sarebbe in piedi ancora oggi e io starei ancora giocando a scacchi per l’Unione Sovietica. [...]
Singoli individui hanno giocato un ruolo da ambo le parti, da Roland Reagan a Margaret Thatcher, da Lech Walesa a papa Giovani Paolo II, fino a Michael Gorbaciov, scatenando delle forze che quest’ultimo non poteva controllare. L’argomento decisivo era tanto semplice quanto vero: la Guerra Fredda era una guerra dei buoni contro i cattivi e, cosa ancora più importante, non era una faccenda meramente filosofica, ma una battaglia reale che valeva la pena di combattere. [...]
Il Muro è caduto e il mondo ha tirato un sospiro di sollievo. La lunga guerra che andava avanti da generazioni era finita. La minaccia nucleare che pendeva sulle nostre teste sarebbe presto scomparsa. Tuttavia le vittorie, perfino le più grandi, hanno un prezzo, anche se si tratta semplicemente di abbassare la guardia.
Non ci sono state commissioni per la verità sul comunismo, né processi né condanne per gli impressionanti crimini perpetrati da questi regimi. Il Kgb ha cambiato nome ma non pelle. È stata chiaramente la compiacenza dell’Occidente ad aver dato mano libera a tutti i suoi nemici, non solamente a Putin.
Le odierne dittature possiedono ciò che i soviet potevano a malapena sognare: un facile accesso ai mercati globali per finanziare la repressione al loro interno. Non soltanto i petrol-Stati come la Russia, l’Iran e il Venezuela, ma anche gli Stati industriali.
L’idea che il mondo libero avrebbe usato a favore dei diritti umani la linea del compromesso per esercitare pressioni sui dittatori è stata vanificata dagli stessi Stati autoritari, giacché questi ultimi sono disposti a sfruttare quel tipo di leva senza alcuna esitazione, laddove nel mondo libero non c’è una simile volontà.
Anzi, la linea del compromesso ha fornito alle dittature ancor più consumatori del petrolio che estraggono e degli iPhone che assemblano. Questi regimi utilizzano l’Interpol per perseguitare i dissidenti all’estero; finanziano o creano partiti politici e Ong per esercitare pressioni a favore della propria causa; scrivono editoriali sul New York Times zeppi di appelli ipocriti per la pace e l’armonia. E tutto questo mentre a casa propria attuano un giro di vite più duro che mai. [...]
Che cosa bisogna fare, dunque? Ogni situazione, ogni crisi, ha chiaramente le proprie necessità. Negli scacchi, lo spostamento di una singola pedina cambia l’intera posizione. È per questo che mi piace dire che io invoco i principi, non e politiche. Quando si possiedono principi solidi e tutto il mondo li conosce, le politiche poi tendono a essere più semplici da sviluppare e da rafforzare. Spetta ai leader, a coloro che sono responsabili del proprio popolo, formulare delle politiche. [...] Fare delle raccomandazioni senza l’autorità per renderle esecutive o la responsabilità di doverne rispondere è una stravaganza. Offre il fianco all’ipocrisia e alla follia della peggior specie.
Mi rendo conto che una simile strategia, per quanto onesta e appropriata, risulta essere anche una forma di fuga. Nessuno sarebbe contento se un medico gli diagnosticasse una malattia mortale per poi rifiutarsi di indicargli un rimedio. Ci sono molti passi che possono essere compiuti e che richiedono coraggio e volontà. Una Magna Carta globale è uno di questi, un documento che possa condurre alla creazione di un’organizzazione delle nazioni democratiche unite che sostenga e rinforzi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. [...]
Il mondo libero possiede risorse e potere al di là dell’immaginazione e questo deve essere usato per aiutare i non liberi a unirsi a noi, altrimenti è un potere sprecato. Un altro motivo per cui non serve fare raccomandazioni per delle politiche specifiche sta nel fatto che queste diventano inevitabilmente obsolete.
Nel corso degli anni ho compilato una lunga lista di cose che andrebbero fatte per rispondere, ad esempio, alla dittatura di Vladimir Putin. Perfino adesso che questi ha dato prova di quanto fossero fondate le mie peggiori paure e che tutti mi dicono quanto io avessi ragione, ben poche delle mie raccomandazioni sono state messe in atto. Altre sono state portate avanti, come ad esempio le sanzioni e l’espulsione della Russia dal G7, ma in modo troppo debole o lento perché avessero l’effetto deterrente da me auspicato.
 ©2015 by Garry Kasparov, Edizione Italiana Fandango Libri 2016, published by arrangement with Berla & Griffini Rights Agency
©2015 by Garry Kasparov, Edizione Italiana Fandango Libri 2016, published by arrangement with Berla & Griffini Rights Agency - A Mikhail Gorbaciov e a Karol J. Wojtyla ... per la pace e il dialogo, quello vero!!!
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO ... E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" --- Vatileaks 2, verifiche sulle canonizzazioni: bloccati 409 conti Ior tra cui quello di padre Georg5 novembre 2015, di Federico La Sala
Vatileaks 2, verifiche sulle canonizzazioni: bloccati 409 conti Ior tra cui quello di padre Georg
Lo scandalo dei "cacciatori dei miracoli": tariffa media di 500mila euro a caso. La figura chiave è il cosiddetto postulatore, una sorta di pm che deve indagare sulla presunta santità e mostrarne le prove sotto forma di prodigi. Coinvolto anche l’ex segretario personale di Benedetto XVI
di Fabrizio d’Esposito *
Senza soldi non si diventa santi. È stato tre lustri fa, che con il suo L’ora di religione, Sergio Castellitto protagonista, Marco Bellocchio denudò crudelmente il commercio vaticano sulle canonizzazioni, raccontando la storia di una famiglia romana decaduta che cerca di risollevarsi economicamente investendo tutto sul processo di santità della mamma morta. Ed è propria la causa per la canonizzazione il segreto per moltiplicare il denaro. In merito, uno dei libri del nuovo Vatileaks, quello di Gianluigi Nuzzi, Via Crucis (Chiarelettere) contiene una notizia clamorosa.
Quattrocento conti per 40 milioni di euro
Quando papa Bergoglio, appena eletto, dispone un’inchiesta sui traffici milionari della Congregazione che si occupa di portare sugli altari uomini e donne di fede - e retta da un fedelissimo bertoniano, il cardinale Angelo Amato - la neocommissione per la riforma delle finanze (la fatidica Cosea) ordina il blocco di 409 conti dello Ior, la banca vaticana, per un totale di 40 milioni di euro. Tra questi c’è anche un nome pesantissimo, quello di monsignor di Georg Gänswein, storico segretario di Benedetto XVI e rimasto al servizio di papa Bergoglio. Il numero dell’importante cliente, presso la banca vaticana, è 29913. Scrive Nuzzi: “La disposizione dunque coinvolge anche il conto corrente di monsignor Georg Gänswein, già segretario personale di Benedetto XVI e ora prefetto della casa pontificia. C’è anche il conto corrente di padre Antonio Marrazzo, postulatore per la beatificazione di papa Paolo VI, Giovanni Battista Montini; e quello di monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio consiglio per la famiglia. Si rischia un incidente diplomatico già dopo i primi passi della commissione”. Alla fine del 2013, la Cosea fa sbloccare 114 dei 409 depositi.
Diventare santi e fatturazione
Il processo per diventare santi è particolarmente lungo, anni se non decenni. La figura chiave è il cosiddetto postulatore, una sorta di pm che deve indagare sulla presunta santità e mostrarne le prove sotto forma di miracoli. In Vaticano sono due avvocati laici ad avere il monopolio delle cause. Il più noto e prestigioso si chiama Andrea Ambrosi ed è un legale che fa solo questo. Per avere il patentino di postulatore c’è un corso parauniversitario da frequentare e superare. La famiglia Ambrosi, poi, è anche proprietaria della tipografia che stampa in esclusiva gli atti delle cause. Si tratta di montagne di carta, un altro affare a tantissimi zeri. Insieme allo studio Ambrosi, altra postulatrice è Silvia Correale. In media, la santità costa tra i 400mila e i 500mila euro. Per il filosofo Antonio Rosmini, si è arrivati a ben 750mila euro, di cui la metà solo per organizzare la cerimonia di beatificazione in piazza San Pietro. Avviare una causa presuppone già un anticipo di 20mila. Poi ci sono i costi di trasferte e di studio di documenti più la traduzione della mole di atti in latino, lingua ufficiale della Santa Sede.
Mezzo milione per la beatificazione
Nel secondo libro che esce oggi, quello di Emiliano Fittipaldi, Avarizia (Feltrinelli), c’è un ampio elenco di cause costate centinaia di migliaia di euro. A gestire i soldi sono i postulatori, con conti dello Ior, e quando la Cosea ha chiesto i bilanci o un rendiconto delle spese, il cardinale Amato ha risposto che questa certificazione non esiste. Un pozzo senza fondo. Nell’autunno di due anni fa, per esempio, una congrega spagnola di Palma di Maiorca ha messo 482.693 euro sul conto della banca vaticana per la canonizzazione della beata Francisca Ana de los Dolores. La fabbrica dei santi, nata nel 1588 su impulso di Sisto V, ha ricevuto un formidabile impulso alla produzione sotto il pontificato dell’ultimo papa magno, Giovanni Paolo II: 1.338 beati e 482 santi proclamati in 27 anni di regno. I più attivi e dispendiosi sono gli americani. Solo dal 2008 al 2013, la beatificazione dell’arcivescovo e telepredicatore Fulton John Sheen è lievitata a 332mila euro, pagati da una fondazione intestata all’“esaminando”. Il grosso della cifra rappresenta gli onorari di Ambrosi, che si è giustificato così nel gennaio del 2014: “La stesura della positio (la relazione finale, ndr) si basa sullo studio e l’elaborazione di oltre settanta volumi. Essendo poi stato monsignor Sheen uno dei più fecondi scrittori di Gesù e Maria, ho dovuto farmi mandare e leggere - per trovare spunti aggiunti sull’esercizio virtuoso - la sua opera omnia, ammontante a ben ottantatré volumi”. La vita dei “cacciatori di miracoli” è senza dubbio durissima. Iniziata nel 2002, la beatificazione di Sheen è stata sospesa a tempo indeterminato perché l’arcidiocesi di New York non ha voluto spostare le spoglie del monsignore nella sua città natale, Peoria.
Le trattative con i re del tabacco
Dai santi alle sigarette, la disinvoltura della curia vaticana non ha confini. Nuzzi pubblica una bozza di accordo segreto tra la Santa Sede e una multinazionale del tabacco, la Philip Morris in cui quest’ultima si impegna a dare compensi per la promozione della vendita delle sigarette tra le mure leonine, dove c’è un autentico duty free.
*
-
> LA DEMOCRAZIA, LA "MAGNA CHARTA", E LA FALSA "CARTA" DEL "DEUS CARITAS EST" --- IL SINODO, LA TONACA, E IL PARLAMENTO (di Nadia Urbinati)7 ottobre 2015, di Federico La Sala
- PENSARE UN ALTRO ABRAMO. GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE.
La tonaca e il Parlamento
di Nadia Urbinati (la Repubblica, 07.10.2015)
LA RIUNIONE del Sinodo segue al viaggio del Papa a Cuba e negli Stati Uniti. Un viaggio nel quale il tema del Sinodo - la famiglia e il matrimonio - è stato al centro tanto delle sue omelie e dei suoi discorsi pubblici quanto dell’opinione che lo ha interpellato - sulla sessualità e la pedofilia nella Chiesa, sul matrimionio di coppie dello stesso sesso, sul ruolo dei divorziati. Tante attese per il Sinodo sono dunque giustificate dalla forte presenza del Papa sulla scena dell’opinione pubblica mondiale. È comprensibile dunque che ci sia attenzione per le risoluzioni del Sinodo e speranza che esse non siano indifferenti all’opinione del mondo. Il comunicato rilasciato all’apertura dei lavori mostra preoccupazione per questo rapporto di reciproca influenza quando osserva che su questi temi, sul matrimonio e la famiglia, «è del tutto inaccettabile che i Pastori della Chiesa subiscano pressioni».
Il gioco dell’opinione è orizzontale e senza esiti predeterminati. Nel tentativo di influenzare l’opinione delle persone a seguire o a respingere alcune pratiche di vita, non possiamo evitare di essere a nostra volta interpellati e portati a riflettere sulle nostre posizioni. Il gioco dell’opinione è un ping pong, chi lo mette in moto e lo anima ne viene tirato dentro e influenzato. La corrente che determina non è mai unidirezionale. Questo rende l’opinione una forza formidabile, in virtù della quale, scriveva David Hume, i molti sono governati dai pochi e i pochi non possono sottrarsi al controllo dei molti. Lo vediamo accadere ogni giorno, con qualunque leader si metta in relazione al pubblico. Anche quando a parlare è il rappresentante di Dio.
Papa Francesco ha attraversato l’America per entrare in contatto diretto con la gente di tutte le religioni e le convizioni morali, parlando a milioni di persone dei problemi che sentono vicini, dalla povertà e disoccupazione alla libertà sessuale e di relazioni matrimoniali. Egli vuole contribuire a formare l’opinione pubblica su questi temi centrali per la Chiesa e l’opinione preme a sua volta per farsi ascoltare. È davvero “inaccettabile” che questo avvenga o che i Pastori della Chiesa sentano la pressione da parte dell’opinione del mondo? Se la subiscono o meno dipenderà da loro, ma non c’è scandalo se quell’opinione alla quale essi si rivolgono ogni giorno non cerchi di influenzare la loro verità. La quale è certamente indifferente all’opinione del mondo. E tuttavia, se entra nella sfera pubblica e vuole diventare opinione diffusa a livello globale, al di là della comunità dei fedeli, essa si espone ai “rischi” del dialogo, ovvero ad essere influenzata e interpellata a sua volta.
In età predemocratica i papi scrivevavo encicliche che giungevano ai fedeli tramite i pastori e gli interpreti. Oggi scrivono encicliche che diventano bestseller e vanno direttamente al lettore e al grande pubblico del quale essi si fanno oratori. Questo comporta accettare la sfida di entrare nel circolo dell’opinione, che come sappiamo non ha riguardi nei confronti dell’autorità e interviene, cercando di discutere e influenzare, mettendosi cioè sullo stesso piano, come appunto nel ping pong. I commenti sulla pretesa dell’opinione di influenzare le verità dei prelati chiusi nel Sinodo non possono che destare stupore. È comprensibile che i prelati debbano restare fedeli alla verità e che si sentano compressi dalle pressioni dell’opinione, alla quale non devono rendere conto come i politici. Tuttavia, è altrettanto comprensibile che quell’opinione cercata con l’intento di modellarla esprima se stessa a sua volta. Difficile gioco democratico, ma impossibile da mettere a tacere una volta cominciato.
Il Sinodo, ha detto il Papa proprio per spiegare la distanza tra l’opinione del mondo e la verità dei Pastori della Chiesa, non è come il Parlamento dove «per raggiungere un consenso o un accordo comune si ricorre al negoziato, al patteggiamento o ai compromessi ». Ma da questa comparazione il Parlamento ne esce bene, poiché la discussione tra diversi e la ricerca di una soluzione per via di compromessi è segno di una pratica nobile e civile - l’opposto sarebbe la violenza o l’unanimità, la quale, a meno di non emergere spontaneamente in un solo afflato, deve comunque essere conquistata. E per muovere le convinzioni degli interlocutori verso un esito unanime non è escluso che non si usino forme di persuasione e di mediazione. Il fatto è che il Sinodo lavora a porte chiuse per non mostrare come discute e non essere sotto l’occhio giudicante del mondo, mentre il Parlamento non può esimersi da questo controllo e mostra al mondo tutti i pregi e i difetti della deliberazione pubblica.
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). ---«Quando Martini disse a Ratzinger: la Curia non cambia, devi lasciare» (di Gian Guido Vecchi)17 luglio 2015, di Federico La Sala
«Quando Martini disse a Ratzinger: la Curia non cambia, devi lasciare»
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 16.07.2015)
CITTÀ DEL VATICANO Padre Silvano Fausti raccontava che il momento era stato quando Benedetto XVI e Carlo Maria Martini si videro per l’ultima volta. Milano, incontro mondiale delle Famiglie, 2 giugno 2012, il cardinale malato da tempo era uscito dall’Aloisium di Gallarate per raggiungere il Papa. Fu allora che si guardarono negli occhi e Martini, che sarebbe morto il 31 agosto, disse a Ratzinger: la Curia non si riforma, non ti resta che lasciare.
 Benedetto XVI era tornato sfinito dal viaggio a Cuba, a fine marzo. In estate cominciò a parlarne ai collaboratori più stretti che tentavano di dissuaderlo, a dicembre convocò il concistoro dove creò sei cardinali e neanche un europeo per «riequilibrare» il Collegio, l’11 febbraio 2013 dichiarò la sua «rinuncia» al pontificato. Dimissioni «già programmate» dall’inizio del papato - se le cose non fossero andate come dovevano -, fin da quando al Conclave del 2005 Martini spostò i suoi consensi su Ratzinger per evitare i «giochi sporchi» che puntavano a eliminare tutti e due ed eleggere «uno di Curia, molto strisciante, che non ci è riuscito», rivela il padre gesuita.
Benedetto XVI era tornato sfinito dal viaggio a Cuba, a fine marzo. In estate cominciò a parlarne ai collaboratori più stretti che tentavano di dissuaderlo, a dicembre convocò il concistoro dove creò sei cardinali e neanche un europeo per «riequilibrare» il Collegio, l’11 febbraio 2013 dichiarò la sua «rinuncia» al pontificato. Dimissioni «già programmate» dall’inizio del papato - se le cose non fossero andate come dovevano -, fin da quando al Conclave del 2005 Martini spostò i suoi consensi su Ratzinger per evitare i «giochi sporchi» che puntavano a eliminare tutti e due ed eleggere «uno di Curia, molto strisciante, che non ci è riuscito», rivela il padre gesuita.Silvano Fausti è morto il 24 giugno a 75 anni, dopo una lunga malattia. Biblista e teologo, una delle voci più ascoltate e lette del pensiero cristiano contemporaneo, era la persona più vicina a Carlo Maria Martini, il cardinale lo aveva scelto come guida spirituale e confessore, si confidava con lui. Il retroscena affidato tre mesi prima di morire a glistatigenerali.com - l’intervista video è stata ora diffusa in Rete - corrisponde a ciò che padre Fausti raccontava in privato nella cascina di Villapizzone, alla periferia di Milano, dove viveva da 37 anni con altri gesuiti nella comunità che aveva fondato. Quasi un testamento che, a proposito di Ratzinger e Martini, risale ai giorni del Conclave di dieci anni fa. Erano le due personalità più autorevoli e, racconta Fausti, «i due che avevano più voti, un po’ di più Martini» (già allora malato di Parkinson), uno per i «conservatori» e l’altro per i «progressisti». C’era una manovra per «far cadere ambedue» ed eleggere il cardinale «molto strisciante» di Curia. «Scoperto il trucco, Martini è andato la sera da Ratzinger e gli ha detto: accetta domani di diventare Papa con i miei voti» . Si trattava di fare pulizia. «Gli aveva detto: accetta tu, che sei in Curia da trent’anni e sei intelligente e onesto: se riesci a riformare la Curia bene, se no te ne vai».
Martini, rivela Fausti, disse che il Papa fece poi un discorso «che denunciava queste manovre sporche e ha fatto arrossire molti cardinali». Il 24 aprile 2005, nell’omelia di inizio pontificato, Benedetto XVI disse: «Pregate per me, perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi». Padre Fausti ricorda anche il gesto che avrebbe fatto Ratzinger, il 28 aprile 2009 nell’Aquila devastata dal terremoto. Era previsto solo un omaggio, ma Benedetto XVI seminò il panico varcando la porta santa della basilica pericolante di Collemaggio per deporre il suo pallio sulla teca di Celestino V, il Papa del «gran rifiuto». Ratzinger e Martini, pur diversi, si riconoscevano e si stimavano. «Cercavano sempre di metterli contro per fare notizia. Mentre, con Wojtyla, Martini dava ogni anno le dimissioni...». Le dimissioni di Benedetto XVI erano una possibilità dall’inizio del pontificato, spiega Fausti. Finché a Milano, quel giorno, Martini gli disse «è proprio ora, qui non si riesce a fare nulla». Nell’ultima intervista, Martini parlò di una Chiesa «rimasta indietro di 200 anni: come mai non si scuote?».
Ratzinger non è scappato davanti ai lupi, nonostante attacchi e veleni interni che fino a Vatileaks ne hanno funestato il pontificato. Sa che è urgente agire e fare pulizia, ma sente di non averne più la forza. Ci vuole una scossa. Nella sua rinuncia «in piena libertà» dice che «per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo» che «negli ultimi mesi» gli è venuto a mancare. Il conclave, di lì a un mese, eleggerà Jorge Mario Bergoglio. Padre Fausti, nel video, sorride: «Quando ho visto Francesco vescovo di Roma ho cantato il nunc dimittis , finalmente!, ho aspettato dai tempi di Gregorio Magno un Papa così...».
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). --- MILANO - COSTANTINO, 313 - 2013 d. C.: FINE DEL CATTOLICESIMO IMPERIALE.13 dicembre 2012, di Federico La Sala
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
MILANO: PISAPIA E SCOLA. Chi è il Buon Pastore e chi il Mercenario? Il Sindaco, "eletto dal popolo", o il Vescovo mandato dal Vaticano? Un’intervista a Pisapia e un’omelia di Scola - con allegati
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO ---- Elena anticipa quella che in epoche successive sarà la Regina Madre. Costantino sarà in un certo modo sottomesso a Elena (di Marco Garzonio - Tre donne «forti» dietro tre padri della fede)25 ottobre 2012, di Federico La Sala
Tre donne «forti» dietro tre padri della fede
di Marco Garzonio (Corriere della Sera, 25 ottobre 2012)
Il IV secolo è fine di un’epoca e nascita di tempi nuovi anche per i modelli femminili nella cultura cristiana e nella società. Mentre le istituzioni dell’Impero si sfaldano, popoli premono ai confini, corruzione e violenze dilagano e le casse sono vuote, causa guerre ed evasione fiscale, alcune donne sono protagoniste delle trasformazioni almeno tanto quanto gli uomini accanto ai quali la storia le ha accolte. Elena, madre di Costantino, Monica madre di Agostino, Marcellina sorella di Ambrogio.
Ma ci son pure Fausta, moglie di Costantino, da lui fatta assassinare per sospetto tradimento (violenza in famiglia anzi tempo) e la compagna di Agostino, giovane cartaginese vissuta anni more uxorio («coppia di fatto» si direbbe oggi) col futuro santo vescovo d’Ippona. Gli diede pure un figlio, Adeodato, di lei però non è rimasto nemmeno il nome: una rimozione del femminile, nonostante la straordinaria autoanalisi ante litteram compiuta da Agostino nelle Confessioni; un archetipo delle rimozioni collettive della donna praticate dalla cattolicità e di tanta misoginia e sessuofobia che affliggeranno la Chiesa per secoli e ancora la affliggono. Ma andiamo con ordine nel considerare i tipi.
La madre solerte, forte, premurosa, ambiziosa, molto attaccata al figlio maschio, possessiva: è il modello di madre che emerge dalle testimonianze. In parte è un’icona ritagliata sul prototipo della matrona romana, su cui s’innesta la novità del cristianesimo. Questo dalle origini si dibatte in una contraddizione. C’è l’esempio di Gesù che «libera» la donna dalle sudditanze; per lui non è alla stregua di una «cosa» (come negli usi romani); negli incontri rivela l’alta considerazione verso una persona non certo inferiore all’uomo e contraddice così la cultura del tempo. Narrano i vangeli che Gesù si mostra a Maria di Magdala e alle altre donne come il Risorto davanti al sepolcro vuoto: loro sono le protagoniste, a esse affida l’annuncio pasquale. Dall’altra parte c’è San Paolo che invita le mogli a stare sottomesse ai mariti e ispira la visione di un ruolo ancillare, silenzioso, subordinato.
Ecco, allora: Elena anticipa quella che in epoche successive sarà la Regina Madre. Locandiera, legata a Costanzo Cloro cui darà un figlio, Costantino, fa di tutto perché questi diventi padrone dell’Impero: tesse rapporti, guida, consiglia. Verrà ricambiata: Costantino cingerà lei del diadema imperiale (invece della «traditrice» Fausta) introducendo nell’iconografia una coppia un po’ incestuosa: madre e figlio. Psicologicamente Costantino sarà in un certo modo sottomesso a Elena. A Gerusalemme lei troverà le reliquie del Santo Sepolcro. Dei chiodi della Croce ornerà la corona imperiale (posta sul capo dei padroni del mondo sino a Napoleone) per dire che chi governa è sottomesso a Dio, e farà il morso del cavallo del figlio: anche i sovrani devono frenare le pulsioni. Madre altrettanto ingombrante, sul piano degli affetti in questo caso, fu Monica per Agostino.
Questi aveva cercato di liberarsene partendo per Roma senza dir nulla ma Monica non si scoraggiò, lo inseguì e raggiunse sino a Milano, capitale ai tempi. Qui convinse il figlio, all’apice del successo come retore, a rispedire in Africa la compagna e si diede da fare perché trovasse a corte una moglie. Intanto s’era pure spesa affinché Agostino conoscesse Ambrogio, che a Milano contava più delle insegne imperiali. Così l’amore di madre si trasformò: cadde il progetto di ascesa sociale, venne la conversione e il futuro padre della Chiesa riprese la via dell’Africa, senza più Monica però, che morirà sulla via del ritorno.
Un altro genere di donna, che ebbe e ha importanza nella Chiesa, nei costumi, nella cultura è incarnato da Marcellina. La sorella di Ambrogio, dopo aver contribuito a crescere i fratelli, prese il velo con papa Liberio. Grazie a lei si prospettò una scelta di vita ricalcata sul modello del monachesimo orientale, di cui Ambrogio era estimatore: la verginità (su questa il Patrono di Milano compose una delle sue opere principali), la consacrazione, il chiostro in cui ritirarsi, pregare e, in taluni sviluppi, lavorare, garantire il prosieguo delle tradizioni e aprirsi al mondo attraverso opere di carità. Costantino, Ambrogio, Agostino e lo loro donne: esempi d’una storia plurale che continua, viene costruita giorno dopo giorno ancora, si evolve.
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO ---- Ecco perché Costantino non fu tollerante. Corrado Augias risponde ad Arturo Schwarz9 novembre 2012, di Federico La Sala
Ecco perché Costantino non fu tollerante
risponde Corrado Augias (la Repubblica, 9.11.2012)
Caro Augias,
vari quotidiani, dando notizia della mostra milanese su Costantino, hanno titolato sulla sua “tolleranza”. -Vorrei ricordare che fu proprio Costantino il padre dell’antisemitismo. Egli emanò, l’11 dicembre 321, l’edito Codex Judaeis, prima legge penale antiebraica, segnando così l’inizio di una persecuzione e del tentativo di genocidio degli ebrei.
 L’editto definiva l’ebraismo: “secta nefaria, abominevole, feralis, mortale” e formalizzava l’accusa di deicidio. Da allora, il processo antisemitico non s’è più interrotto, ad eccezione del breve periodo di reggenza dell’imperatore Giuliano detto (a torto) l’Apostata.
L’editto definiva l’ebraismo: “secta nefaria, abominevole, feralis, mortale” e formalizzava l’accusa di deicidio. Da allora, il processo antisemitico non s’è più interrotto, ad eccezione del breve periodo di reggenza dell’imperatore Giuliano detto (a torto) l’Apostata.
 I successivi imperatori introdussero le Norme Canoniche dei Concili nel Codice Civile e Penale.
I successivi imperatori introdussero le Norme Canoniche dei Concili nel Codice Civile e Penale.
 Con Costantino II, Valentiniano e Graziano, dal 321 al 399 d.C., una serie spietata di leggi ha progressivamente e drasticamente ridotto i diritti degli ebrei.
Con Costantino II, Valentiniano e Graziano, dal 321 al 399 d.C., una serie spietata di leggi ha progressivamente e drasticamente ridotto i diritti degli ebrei.
 Si condannava ogni ebreo ad autoaccusarsi di esserlo: in caso contrario c’erano l’infamia e l’esilio. -Proibito costruire sinagoghe. Leggi contro la circoncisione. Obbligo di sepoltura in luoghi lontani e separati da quelli cristiani. Altro che tolleranza, c’è un limite anche alla falsificazione della storia.
Si condannava ogni ebreo ad autoaccusarsi di esserlo: in caso contrario c’erano l’infamia e l’esilio. -Proibito costruire sinagoghe. Leggi contro la circoncisione. Obbligo di sepoltura in luoghi lontani e separati da quelli cristiani. Altro che tolleranza, c’è un limite anche alla falsificazione della storia.
 Arturo Schwarz
Arturo SchwarzLa mostra milanese celebra i 17 secoli che ci separano dalla promulgazione di quell’editto di Milano (313 e.v.) con il quale il grande imperatore rendeva il cristianesimo “religio licita”, dopo che per secoli i suoi seguaci erano stati perseguitati. Le ragioni del provvedimento, al di là delle letture agiografiche, furono ovviamente politiche: l’impero tendeva a spaccarsi, la nuova religione parve un “collante” più efficace dei vecchi culti. Costantino peraltro conservò per tutta la vita il titolo “pagano” di pontifex maximus e si convertì al cristianesimo solo in punto di morte.
Né il suo comportamento personale ebbe nulla di veramente cristiano (fece uccidere moglie e figlio) anche se gli ortodossi lo hanno santificato. Quel che più conta, considerata la lettera del signor Schwarz, fu il suo fiero antigiudaismo. Arrivò a definire quella religione “superstitio hebraica” contrapponendola alla “venerabilis religio” dei cristiani. Presiedette, da imperatore, e diremmo da “papa”, il fondamentale Concilio di Nicea (325).
Soprattutto aprì la strada all’unificazione dei due poteri, temporale e religioso, in uniche mani. All’inizio furono quelle dell’imperatore, cioè le sue, col passare degli anni diventarono quelle del pontefice romano. Alla fine di quello stesso IV secolo il percorso si concluse quando un altro imperatore, Teodosio I, proclamò il cristianesimo religione di Stato, unica ammessa, facendo così passare i cristiani dal ruolo di perseguitati a quello di persecutori di ogni altro culto, ebrei compresi.
-
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. --- DELITTI E CASTIGHI SUL SOGLIO DI PIETRO (di Corradio Augias)28 maggio 2012, di Federico La Sala
Delitti e castighi sul soglio di Pietro
di Corrado Augias (la Repubblica, 28 maggio 2012)
Più volte nel corso dei secoli il vento ha scosso la casa di Dio con raffiche anche più intense di quelle attuali. Più volte il fumo di Satana si è infiltrato nelle stanze più sacre dei sacri palazzi, come ebbe a lamentare Paolo VI.
Un ambiente come quello vaticano sembra fatto apposta per scuotimenti e infiltrazioni data la sua scarsa trasparenza, l’ostinata paura di aprirsi al mondo, l’atmosfera che sempre si crea in una corte dove un sovrano assoluto regna su uomini senza famiglia e dipende dal suo favore l’intera loro vita. Il che spiega quasi da solo perché le storie vaticane abbiano dato vita ad un intero filone narrativo che vede nei romanzi di Dan Brown (celebre "Il Codice da Vinci") solo gli ultimi esempi di un ’amplissima casistica.
Uno degli esempi più antichi di violenza e tradimento consumati per la conquista del soglio di Pietro è quello di cui fu protagonista Benedetto Caetani che costrinse il suo predecessore Celestino V (Pietro da Morrone) ad abdicare per l’impazienza di salire al trono dove regnerà col nome, famigerato, di Bonifacio VIII (1235-1303). Il povero Celestino era un uomo umile e pio, certamente inadatto all’incarico. Ma la violenza con la quale il futuro Bonifacio lo scalzò rimane degna delle più sinistre tradizioni del potere. Dante infatti lo caccerà, ancora vivo, all’inferno.
Il periodo più fecondo dal punto di vista narrativo è quello rinascimentale quando la corte di Alessandro VI Borgia divenne sede di intrighi e di delitti commessi a volte alla stessa presenza del papa. Celebre l’episodio di quando Cesare, figlio del papa e fratello di Lucrezia, assalì nei corridoi vaticani un tal Pedro Caldes, detto Perotto, 22 anni, primo cameriere del pontefice proprio come il Paolo Gabriele di cui si parla in questi giorni. Perotto si tratteneva affettuosamente con Lucrezia cosa che rischiava di compromettere il matrimonio al quale la bellissima donna era stata destinata.
Un giorno che Perotto passava per un corridoio s’imbatté casualmente in Cesare. Intuì da uno sguardo ciò che stava per accadere e cominciò a correre gridando a perdifiato, inseguito dall’altro che aveva estratto il pugnale. La corsa ebbe termine nella sala delle udienze dove Perotto si gettò ai piedi del pontefice implorando protezione. Non bastò. Cesare si avventò su di lui trafiggendolo con tale impeto che "il sangue saltò in faccia al papa" macchiandogli di rosso la bianca tonaca.
Non solo delitti ma anche orge caratterizzavano in quegli anni la corte. Preti e cardinali mantenevano una o più concubine "a maggior gloria di Dio", come scrive sarcastico lo storico Infessura, mentre il maestro di cerimonie pontificio Jacob Burchkardt nota che i monasteri di donne erano ormai "quasi tutti lupanari" poco o nulla distinguendo le religiose dalle "meretrices".
Cronache vivacissime ha lasciato il protonotario apostolico Johannes Burchard. Racconta ad esempio che una sera, a una delle consuete feste date dal papa: «Presero parte cinquanta meretrici oneste, di quelle che si chiamano cortigiane e non sono della feccia del popolo. Dopo la cena esse danzarono con i servi e con altri che vi erano, da principio coi loro abiti indosso, poi nude». La serata si concluse come si può immaginare, il protonotario riferisce dettagli che richiamano altre e assai recenti serate di ugual tenore.
Del resto fu questo tipo di atmosfera, aggiunto alla vendita scandalosa delle indulgenze, a convincere il frate agostiniano Martin Lutero a proclamare quella Riforma (1517) che avrebbe drammaticamente spaccato la cristianità fino ai nostri giorni.
Per venire ad anni a noi vicini, una vasta eco ha sollevato una mossa assai ambigua dell’allora segretario di Stato Eugenio Pacelli. Nel 1939, papa Pio XI avrebbe voluto pronunciare un discorso nel decennale del Concordato dove tra l’altro avrebbe denunciato le violenze del regime fascista e la persecuzione razziale dei nazisti contro gli ebrei. Alla vigilia dell’importante allocuzione papa Ratti venne però a morte e Pacelli, che sarebbe stato suo successore, fece prontamente sparire il discorso avendo in mente un diverso tipo di rapporti con le due dittature. Divenuto papa a sua volta col nome di Pio XII, lo dimostrerà. Intrighi e tradimenti all’ombra del trono di Pietro sono tutti accomunati da elementi rimasti invariati nel tempo: ritrosia a dare informazioni e addirittura a collaborare ad eventuali indagini, ostinati silenzi a costo di alimentare le ipotesi peggiori.
Se n’è avuta una prova in occasione della morte, altrettanto repentina, di Giovanni Paolo I, papa Luciani. Ancora una volta l’evento si verificò alla vigilia di una decisione importante con la quale il papa avrebbe riorganizzato la famigerata banca vaticana, in sigla Ior. Così oscure le circostanze dell ’evento che i media anglo-sassoni avanzarono apertamente l’ipotesi di un assassinio. L’autopsia avrebbe probabilmente fugato le voci ma le gerarchie vaticane la rifiutarono preferendo mantenere un silenzio che le ha ulteriormente alimentate.
Il caso più grave di reticenza si è però avuto quando, la sera del 4 maggio 1998, tre cadaveri vennero trovati in una palazzina a pochi metri dagli appartamenti pontifici. Il colonnello Alois Estermann, 44 anni, comandante delle "guardie svizzere"; sua moglie, Gladys Meza Romero di origine venezuelana; il vice-caporale Cédric Tornay, nato a Monthey (Svizzera), 24 anni. Poche ore dopo il portavoce vaticano Joaquin Navarro Valls dette ai giornalisti questa versione: il caporale, in un accesso di collera incontrollata, aveva ucciso il colonnello e sua moglie per poi togliersi la vita. Invano l’avvocato francese Luc Brossolet ha fatto eseguire (in Svizzera) perizie che dimostrano l ’incongruenza grossolana di quella versione. Da allora non è più stata cambiata.
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. --- GIUSTIZIA SI’, ELEMOSINA NO (di Filippo Di Giacomo).25 novembre 2011, di Federico La Sala
la fede al tempo della crisidi Filippo Di Giacomo (l’Unità, 25 novembre 2011)
In uno dei suoi sermoni Lutero, con un inciso assai efficace, osservava: «Per giungere sulla retta via, l’uomo di tanto in tanto deve anche spaventarsi di se stesso». Secondo la tesi ideologica introdotta nella cultura occidentale dalla rivoluzione francese, il cristianesimo (che crede nella fine del mondo, nel giudizio, nel premio o nella punizione) è per sua natura pessimista mentre la modernità (che crede nel progresso come legge della storia) sarebbe per sua natura ottimista.
Oggi, invece, abbiamo tutti i mezzi per osservare in diretta l’inesorabile sgretolarsi della presunzione che la modernità continua a diffondere di se stessa. Le “crisi” che si sono succedute nei sistemi socio-politici dell’Occidente, da quella “energetica” di inizio anni Settanta all’ultima finanziaria ancora in corso, ci hanno tolto ogni possibile alibi, obbligandoci a prendere atto di quanto il progresso sia anche un progresso dalle possibilità distruttive. Perché, come persone e come società, dal punto di vista morale, non sempre siamo all’altezza della nostra ragione. Tanto per fare un esempio, se volessimo ridurre il problema economico-finanziario in corso anche in Italia al suo nucleo essenziale, dovremmo per forza riportarci a quella idiosincrasia tra moralità e razionalità che spinge il nostro modello di sviluppo ad abusare delle risorse della terra e delle società politiche senza porci mai, e comunque non in modo oggettivo, il problema dei limiti, cioè di una condivisione equa e sostenibile di quanto pianeta e nazioni offrono.
L’idea che le cose umane, mercato compreso, lasciate a se stesse, diventino necessariamente migliori non trova alcun sostegno nel cristianesimo. Il cristiano infatti, come ogni altra persona dotata di ragione, sa che la storia è disseminata di gravi crisi. E che una di esse, è oggi davanti all’umanità intera. Tuttavia, secondo l’ottimismo cristiano, anche orrori spaventosamente inumani come Auschwitz, i quali devono assolutamente sconvolgerci (cosa che invece nonostante gli anni trascorsi non ancora avviene), possono essere ricollocati e ricompresi a partire dal fatto che, comunque e sempre, Dio è più forte del male. Se la Shoah fosse stata solo minimamente compresa dai nostri politici, i bambini nati e cresciuti in Italia, già da tempo sarebbero stati accolti e riconosciuti e considerati ricchezza per tutta la nazione. Eppure l’inverno demografico nel quale siamo precipitati, destinato a prolungare le sue fredde ombre nei prossimi decenni, non ci ha ancora ispirato alcuna paura di noi stessi. E così preferiamo illuderci che, coltivando presunte paure per “l’altro”, possiamo legittimamente privare una parte importante del nostro esiguo ricambio generazionale dei propri diritti civili, mantenendola sotto il giogo di una possibile espulsione dal nostro territorio nazionale, obbligandola a costruirsi ghetti di una imposta marginalizzazione e di una costante precarietà.
Proprio parlando dell’accoglienza di chi viene considerato “altro” dalla mentalità corrente, a Cotonou, Benedetto XVI ha suggerito, paragonando una società ad una mano: «La compongono cinque dita, diverse tra loro. Ognuna di esse però è essenziale e la loro unità forma la mano. La buona intesa tra le culture, la considerazione non accondiscendente delle une per le altre e il rispetto dei diritti di ciascuno sono un dovere vitale (...). L’odio è una sconfitta, l’indifferenza un vicolo cieco (...). Tendere la mano significa sperare per arrivare, in un secondo tempo, ad amare. Cosa c’è di più bello di una mano tesa?».
Tra qualche mese, l’anno prossimo ricorrerà il cinquantesimo anniversario dell’inizio del Concilio ecumenico vaticano II, la prima (forse, inconsapevole) assise del mondo globalizzato, la cattedra che ci ha consegnato le lezioni di quei due giganteschi maestri di umanità che sono stati Giovanni XXIII e Paolo VI. Nel 1959, proprio indicendo il Concilio, il beato Giovanni XXIII aveva spiegato come la Chiesa non fosse un museo da custodire ma un giardino da coltivare. Anzi, la sua metafora era «nella piazza che è il mondo, la Chiesa deve essere come la fontana che sta al centro». E ancora non si parlava di villaggio globale...
A ben ricordare, tra i Papi che hanno accompagnato i cinque decenni trascorsi dal Concilio, nessunoha mai insegnato il pessimismo. Ne consegue che, se proprio si vuole misurare “il tasso di cattolicità apparente” inserito dall’attuale governo nella sua compagine, devono arrivare in Parlamento (accantonando le pretese di chi, già in questi primi giorni, tenta di ottenere migliorie esistenziali per i suoi protetti nello Stato e nel parastato) anche le leggi sulla cittadinanza, l’asilo, i centri di permanenza temporanei, le carceri... Insomma, anche in politica, per una volta, giustizia sì, elemosina no.
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, ---- I cappellani militari chiedono più soldi per fare le guerre. Hanno una rivista che si chiama "Bonus Miles Christi", il buon soldato di Cristo (di don Paolo Farinella)13 ottobre 2011, di Federico La Sala
Hanno una rivista che si chiama "Bonus Miles Christi", il buon soldato di Cristo. Ma siamo sicuri sia proprio Cristo ad arruolare soldati "buoni" che bombardano figli, figlie e anziani di popoli che nemmeno conoscono?
I cappellani militari chiedono più soldi per fare le guerre
di don Paolo Farinella *
Un’amica mi ha passato un articolo di Manlio Dinucci con il titolo «Aggressioni “benedette”». Fin dalle parole d’incipit ci si chiede se ancora a dieci anni del terzo millennio, dobbiamo ancora subire come cristiani parole che sono il segno di una vita più indecente conclamata in nome di Cristo. Il vescovo castrense (non equivocare, dicesi castrense il vescovo insignito della carica vescovile e contemporaneamente di quella di generale di corpo di armata, con stellette incorporate ); il vescovo castrense guida diocesi dei militari (si chiama Ordinariato militare) che hanno una rivista il cui titolo è - indovinate un po’? - «Bonus Miles Christi - Il buon soldato di Cristo». Sì, proprio così: Cristo è uno che arruola soldati e per giunta buoni, anche quando vanno a sparare ai figli, figlie, bambini, bambine, anziani di popoli che non ci conoscevano nemmeno se non per avere a capo del governo un degenerato, pazzo e tronfio piccoletto dai tacchi rialzati.
Fin dove può arrivare la mistificazione! Si mescola l’acqua santa col diavolo, Dice il capo di questa diocesi di soldati di Cristo armati ed educati alla violenza con armi sofisticate per ammazzarne più che sia possibile; dice che «prova amarezza di fronte a chi invoca lo scioglimento degli eserciti, l’obiezione contro le spese militari» perché «il mondo militare contribuisce a edificare una cultura di responsabilità globale, che ha la radice nella legge naturale e trova il suo ultimo fondamento nell’unità del genere umano». Monsignor Vincenzo Pelvi continua, e non s’accorge delle bestialità: «l’Italia, con i suoi soldati fa la sua parte per promuovere stabilità, disarmo, sviluppo e sostenere ovunque la causa dei diritti umani». Parole messe in fila una dopo l’altra dal giornale dei vescovi «Avvenire» (2 giugno 2011), segno che la presidenza approva. Sia benedetto l’esercito e gli eserciti che tanto bene fanno all’umanità con amore e compassione: sparando, squartando, bruciando, violentando, stuprando, bestemmiando. Cosa importa! Alla rientro da queste battaglie di civiltà c’è sempre un pincopallo di cappellano, con aspersorio e stola, pronto ad assolvere e con la penitenza di andare ancora contro il nemico e «di farlo fuori prima che ti faccia fuori lui».
Manlio Dinucci, Manifesto, ricorda alcuni momenti topici che dovrebbero fare impallidire anche la Madonna nera, mentre di questi fatti, i preti di ieri e di oggi non se ne fanno un baffo:
1. Nel 1911, nella chiesa di S. Stefano dei Cavalieri in Pisa, parata con bandiere strappate ai turchi nel Cinquecento, il cardinale Maffi invitava i soldati in partenza per la guerra di Libia, a «incrociare le baionette con le scimitarre» per portare nella chiesa «altre bandiere sorelle» e in tal modo «redimere l’Italia, la terra nostra, di novelle glorie».
2. Il 2 ottobre 1935, all’annuncio di Mussolini che iniziava la guerra di Etiopia, Mons. Cazzani, vescovo di Cremona, da perfetto fascista indirizzava al popolo una sua pastorale, dove si leggono queste perle: «Veri cristiani, preghiamo per quel povero popolo di Etiopia, perché si persuada di aprire le sue porte al progresso dell’umanità, e di concedere le terre, ch’egli non sa e non può rendere fruttifere, alle braccia esuberanti di un altro popolo più numeroso e più avanzato». 3. Il 28 ottobre 1935, ricorrendo il 13° anniversario della marcia su Roma, nel Duomo di Milano, il cardinale Alfredo Ildelfonso Schuster così celebrava: «Cooperiamo con Dio, in questa missione nazionale e cattolica di bene, nel momento in cui, sui campi di Etiopia, il vessillo d’Italia reca in trionfo la Croce di Cristo, spezza le catene agli schiavi. Invochiamo la benedizione e protezione del Signore sul nostro incomparabile Condottiero».
4. L’8 novembre 1935, sempre in relazione alla guerra di Etiopia Mons. Valeri, arcivescovo di Brindisi e Ostuni, scrive anch’egli una pastorale al suo popolo: «L’Italia non domandava che un po’ di spazio per i suoi figli, aumentati meravigliosamente da formare una grande Nazione di oltre 45 milioni di abitanti, e lo domandava a un popolo 5 volte meno numeroso del nostro e che detiene, non si sa perché e con quale diritto, un’estensione di territorio 4 volte più grande dell’Italia senza che sappia sfruttare i tesori di cui lo ha arricchito la Provvidenza a vantaggio dell’uomo. Per molti anni si pazientò, sopportando aggressioni e soprusi, e quando, non potendone più, ricorremmo al diritto delle armi, fummo giudicati aggressori». 5. Oggi dopo 76 anni, un altro cappellano militare, anima persa e senza Dio, tale don Vincenzo Caiazzo, che celebra messa sulla portaerei Garibaldi, che di fatto è la sua parrocchia, popolata di caccia, missili bombe con cui lui e quelli come lui bombardano la Libia - garantisce che «l’Italia sta proteggendo i diritti umani e dei popoli, per questo siamo in mezzo al mare» perché la motivazione teologica è chiara: «I valori militari vanno a braccetto con i valori cristiani». (Oggi, 29 giugno 2011).
Di fronte a questo rinnegamento del Vangelo viene solo voglia di dire «Povero Cristo!». Costoro dovrebbero essere le «guide», coloro che dovrebbero insegnare a «discernere» il grano dal loglio, la violenza dalla non-violenza, il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, la pace dalla guerra. Costoro sono l’autorità nella Chiesa che si annettono Cristo a loro uso e consumo, lo militarizzano, lo circondano di armi e di morte e poi vanno nei salotti clericali a difendere la vita. Che Dio li perdoni, se può, perché costoro non hanno smarrito solo la fede, ma «c’hanno perduto il ben de l’intelletto» (Dante, Inf. III,18).
* DOMANI/ARCOIRIS. 13-10-2011
-http://domani.arcoiris.tv/i-cappellani-militari-chiedono-piu-soldi-per-fare-le-guerre/
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E ---- L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE WULFF Il Papa a Berlino: «Sono qui per parlare di Dio».22 settembre 2011, di Federico La Sala
L’INCONTRO CON IL PRESIDENTE WULFF
Il Papa a Berlino: «Sono qui per parlare di Dio» *
Signor Presidente Federale,
Signore e Signori,
Cari amici,
mi sento molto onorato per l’amabile accoglienza che mi riservate qui al Castello Bellevue. Sono particolarmente grato a Lei, Signor Presidente Wulff, per l’invito a questa Visita ufficiale, che è il mio terzo soggiorno come Papa nella Repubblica Federale di Germania. La ringrazio di cuore per le gentili parole di benvenuto che mi ha rivolto. La mia gratitudine va ugualmente ai rappresentanti del Governo Federale, del Bundestag e del Bundesrat nonché della Città di Berlino per la loro presenza con cui esprimono il loro rispetto per il Papa come Successore dell’Apostolo Pietro. E non da ultimo ringrazio i tre Vescovi ospitanti, l’Arcivescovo Woelki di Berlino, il Vescovo Wanke di Erfurt e l’Arcivescovo Zollitsch di Friburgo, nonché tutti coloro che, a vari livelli ecclesiali e pubblici, hanno collaborato nei preparativi di questo Viaggio nella mia patria, contribuendo in tal modo alla sua buona riuscita.
Pur essendo questo Viaggio una Visita ufficiale che rafforzerà le buone relazioni tra la Repubblica Federale di Germania e la Santa Sede, in primo luogo non sono venuto qui per perseguire determinati obiettivi politici o economici, come fanno giustamente altri uomini di stato, ma per incontrare la gente e parlare di Dio.
Nei confronti della religione vediamo una crescente indifferenza nella società che, nelle sue decisioni, ritiene la questione della verità piuttosto come un ostacolo, e dà invece la priorità alle considerazioni utilitaristiche.
D’altra parte c’è bisogno di una base vincolante per la nostra convivenza, altrimenti ognuno vive solo seguendo il proprio individualismo. La religione è uno di questi fondamenti per una convivenza riuscita. “Come la religione ha bisogno della libertà, così anche la libertà ha bisogno della religione.” Queste parole del grande vescovo e riformatore sociale Wilhelm von Ketteler, di cui si celebra quest’anno il secondo centenario della nascita, sono ancora attuali.
La libertà ha bisogno di un legame originario ad un’istanza superiore. Il fatto che ci sono valori che non sono assolutamente manipolabili, è la vera garanzia della nostra libertà. Chi si sente obbligato al vero e al bene, subito sarà d’accordo con questo: la libertà si sviluppa solo nella responsabilità di fronte a un bene maggiore. Tale bene esiste solamente per tutti insieme; quindi devo interessarmi sempre anche dei miei prossimi. La libertà non può essere vissuta in assenza di relazioni.
Nella convivenza umana non si dà libertà senza solidarietà. Ciò che sto facendo a scapito degli altri, non è libertà, ma azione colpevole che nuoce agli altri e anche a me stesso. Posso realizzarmi veramente quale persona libera solo usando le mie forze anche per il bene degli altri. Questo vale non soltanto per l’ambito privato ma anche per la società. Secondo il principio di sussidiarietà, la società deve dare spazio sufficiente alle strutture più piccole per il loro sviluppo e, allo stesso tempo, deve essere di supporto, in modo che esse, un giorno, possano reggersi anche da sole.
Qui, al Castello Bellevue, che deve il suo nome alla splendida vista sulla riva della Sprea e che è situato non lontano dalla Colonna della Vittoria, dal Bundestag e dalla Porta di Brandeburgo, siamo proprio nel centro di Berlino, la capitale della Repubblica Federale di Germania. Il castello con il suo passato movimentato è - come tanti edifici della città - una testimonianza della storia tedesca. Lo sguardo chiaro anche sulle pagine scure del passato ci permette di imparare da esso e di ricevere impulsi per il presente. La Repubblica Federale di Germania è diventata ciò che è oggi attraverso la forza della libertà plasmata dalla responsabilità davanti a Dio e dell’uno davanti all’altro. Essa ha bisogno di questa dinamica che coinvolge tutti gli ambiti dell’umano per poter continuare a svilupparsi nelle condizioni attuali. Ne ha bisogno in un mondo che necessita di un profondo rinnovamento culturale e della riscoperta di valori fondamentali su cui costruire un futuro migliore (Enciclica Caritas in veritate, 21).
Auspico che gli incontri durante le varie tappe del mio Viaggio - qui a Berlino, a Erfurt, nell’Eichsfeld e a Friburgo - possano dare un piccolo contributo in merito. Che in questi giorni Dio conceda la sua benedizione a noi tutti.
* Avvenire, 22 settembre 2011
-
>LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). ---- Il Papa e la «campagna» dell’anima (di Filippo Di Giacomo).7 luglio 2011, di Federico La Sala
Il Papa e la «campagna» dell’anima
di Filippo Di Giacomo (l’Unità, 6 luglio 2011)
«Anima», una parola che negli insegnamenti di Benedetto XVI, ricorre spesso. Anzi, per riassumere ciò che il Pontefice indica come «identità» specifica del cattolico contemporaneo, si potrebbe dire che Papa Ratzinger non ha dubbi: essere credenti, oggi, significa cercare di dare un’anima alla storia e alle realtà che la stanno costituendo. Osservando il vasto mare del web, e scorgendovi anche per la Chiesa un «passaggio epocale...ricco e fecondo di nuove opportunità» il Papa vi ha riconosciuto un campo dove abitare «con un cuore credente, che contribuisca a dare un’anima all’ininterrotto flusso comunicativo della rete».
«La via per andare a Dio», diceva Raïssa Maritain, «è infinitamente corta perché egli è vicino a noi come la nostra anima». La nostra anima è sempre viva. Ma se vogliamo afferrarla, se vogliamo costringerla nei paramenti della nostra razionalità, ci sfugge. E nonostante questo, continua ad avvolgerci. E’ dentro e fuori di noi. Sottrarsi alla sua presenza sarebbe come sottrarsi alla realtà che incarniamo. La possiamo gettare dalla finestra, ma rientra dalla porta. Quando siamo stanchi di chiamarla “anima”, la chiamiamo “psiche”.
Il poeta Omero, che di anime complesse e confuse se ne intendeva, sosteneva che è come «l’occhio che vede e l’orecchio che ode». E forse a questo alludeva Cristo quando proclamava beati chi ha occhi per vedere e orecchie per sentire. Ma l’anima è anche la pelle che profuma, l’olfatto che odora, il palato che gusta, il cuore che ama, il cervello che pensa. E se l’atteggiamento religioso che ci avvicina a Dio è l’umile ammirazione, lo stesso atteggiamento vale per avvicinarci alla nostra anima. Dobbiamo “ammirarci” perché coscienti, con la parole della Bibbia, che Dio ci ha “costruiti” come dei prodigi.
Siamo diventati tutti più poveri da quando le parole della meraviglia delle nostre origini sono state confuse con l’uso improprio dei linguaggi delle religioni, della psicoanalisi, della sociologia, della medicina, della filosofia, della politica...
E proprio perché così ricchi di idee, così complessi, così confusi in un miscuglio di teorie, modelli, opinioni, sentiamo di dover tornare all’essenziale. Cosa che, spesso, equivale ad interrogarsi sulla propria anima, sul proprio io, sullo spessore che questo “io” che ognuno di noi crede di possedere, di essere. E se in questo percorso il nostro cuore, la nostra anima, dovesse “condannarci”, il cristiano può avere la certezza che viene da Giovanni quando assicura che, anche in questo caso «Dio è più grande del nostro cuore».
Benedetto XVI ha esortato più volte, in questi sei anni di pontificato, sia le istituzioni pubbliche sia le società religiosamente motivate a ritrovare la loro «anima» allo scopo di «dare nuova consistenza ai valori etici e giuridici di riferimento e quindi all’azione pratica».
Il mondo in cui viviamo è diventato ormai, uno spaventoso palcoscenico planetario teletrasmesso non-stop ventiquattro ore su ventiquattro. E miliardi di persone, quotidianamente vengono nutrite di orrore e di avanspettacolo, di decapitazioni e di consigli per gli acquisti. Sono cioè, continuamente indotte ad uscire dall’umano che è in loro. Tuttavia riuscire a separare il proprio stile di vita dal furore del mondo contemporaneo è vana illusione, una impossibile fuga dalla realtà.
Quello che invece, dal punto di vista morale, sembra improrogabile è l’assunzione della vocazione, condivisibile con l’umanità intera senza alcuna esclusione, a scoprire il bene più o meno celato nel nuovo che sta nascendo. Una vocazione, questa, facilitata dalla straordinaria ricchezza culturale che ereditiamo dall’Occidente cristiano e che i credenti in Cristo sono chiamati, ancora una volta, a far fruttificare.
Il nostro è un tempo straordinariamente propizio affinché i cristiani, riprendano a meditare, a Milano e altrove, su come suscitare risposte serie all’esigenza politica di una convivenza sensata e pacificata tra persone e popoli.
Questa possibilità, da Giovanni Paolo II in poi, la Chiesa la chiama “nuova evangelizzazione”, in favore della quale il teologo ortodosso Olivier Clément, per decenni, ha suggerito alle Chiese d’Oriente e d’Occidente di interrogarsi in forma poli-fonica e poli-croma, cioè in modo interculturale e interreligioso. Perché questo è il solo modo che abbiamo, riflettendo seriamente sulla nostra e sull’altrui anima, per costruire le categorie di un’antropologia dell’umanità realmente globale. Di un’umanità che non abbia più bisogno, per affermare la propria identitàculturale e religiosa, di contrapporsi agli altri con i consueti strumenti dialettici e militari del conflitto politico e della guerra. Perché la storia di tutte le religioni ci insegna che solo dall’ascolto e dalla cura della nostra più fragile interiorità si sprigiona la critica più lucida e radicale alle tante inumanità del nostro mondo.
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115)... LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). --- LAICITA’. Gianfranco Ravasi continua nella sua ’giusta’ pretesa di far dialogare l’amore insegnato da Benedetto XVI ("caritas") con l’amore dei mercanti ("caritas").8 febbraio 2011, di Federico La SalaDOPO CRISTO, DOPO DANTE, dopo galilei, dopo kant, E DOPO LA NOSTRA COSTITUZIONE, ANCORA IL RILANCIO DELLA VECCHIA ALLEANZA TRA I SACERDOTI DEL TEMPIO E IL RE ERODE?!
 LA VECCHIA E ASTUTA LAICITA’, VENDUTA COME NUOVA: "IL CORTILE DEI GENTILI" E L’APOLOGIA (E LA GENEALOGIA) DELLA LIBERTA’ DI COMMERCIO. Il cardinale Gianfranco Ravasi continua nella sua ’giusta’ pretesa di far dialogare l’amore insegnato da Benedetto XVI ("caritas") con l’amore dei mercanti ("caritas").
LA VECCHIA E ASTUTA LAICITA’, VENDUTA COME NUOVA: "IL CORTILE DEI GENTILI" E L’APOLOGIA (E LA GENEALOGIA) DELLA LIBERTA’ DI COMMERCIO. Il cardinale Gianfranco Ravasi continua nella sua ’giusta’ pretesa di far dialogare l’amore insegnato da Benedetto XVI ("caritas") con l’amore dei mercanti ("caritas").
-
> LA "CHARTA CHARITATIS" (1115)... LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). --- NOSTALGIA DI COSTANTINO? (di Giancarlo Zizola).10 aprile 2011, di Federico La Sala
Nostalgia di Costantino?
di Giancarlo Zizola (Rocca, 7, 1° aprile 2011)
Nel discorso pronunciato al Quirinale il 24 giugno 2005, nella sua prima visita ufficiale, Benedetto XVI formulava un riconoscimento solenne della «sana laicità dello Stato, in virtù della quale le realtà temporali si reggono secondo le norme loro proprie». Ma il papa subito precisava che la laicità dello Stato è legittima «senza tuttavia escludere quei riferimenti etici che trovano il loro fondamento ultimo nella religione». E rafforzava questo paradigma aggiungendo che «l’autonomia della sfera temporale non esclude un’intima armonia con le esigenze superiori e complesse derivanti da una visione integrale dell’uomo e del suo eterno destino» (1).
Probabilmente non erano molti allora a notare che la rilettura ratzingeriana della laicità - come anche l’interpretazione massimalista sulla libertà religiosa nel discorso dell’11 gennaio scorso al Corpo Diplomatico - si proiettava, al di là della comunità cattolica, anche sullo Stato, invitato a riconoscere nel suo ordinamento i paradigmi propri dell’ordinamento della confessione maggioritaria in Italia.
La visione etica della laicità veniva invocata cioè, insieme al classico principio della collaborazione tra Stato e Chiesa per il bene comune, per legittimare le esigenze della Chiesa, anche se nei modi di un potere di persuasione morale, per misure legislative forgiate secondo i suoi principi morali e i suoi interessi sui terreni critici del matrimonio e della famiglia, della legislazione del vivente e del finanziamento delle scuole private, malgrado la diversa direttiva formulata dalla Costituzione italiana.
Le ripercussioni concrete di questa piattaforma della politica ecclesiastica non cessano di sgomentare molti seguaci della fede nel Cristo dei Vangeli nel nostro avventurato Paese. In una lettera al nuovo arcivescovo paracadutato dall’alto a Torino, un leader cristiano ben conosciuto di quella comunità cristiana Enrico Peyretti lamentava che la Chiesa «appare come un partito, una forza sociale tra le altre, coi suoi interessi, addirittura interessi economici non puliti, forse peggiori delle offese sessuali, con le sue alleanze calcolate, non di rado impresentabili». E constatava con sofferenza che la gerarchia episcopale dava l’impressione di «vivere nel sogno di una società coincidente con la Chiesa, un matrimonio trono-altare».
Al punto che non sembrava azzardato, con tutte le cautele storiografiche del caso, il parallelo tra «l’odierno catto-berlusconismo della gerarchia cattolica italiana e il catto-fascismo del ventennio violento che fu il fallimento dei pastori e l’abbandono dei fedeli al potere malvagio e falso, può accadere di peggio alla Chiesa? - si chiedeva Peyretti - Questo è peggio della persecuzione». Non è da oggi che si accumulano segnali di una ristrutturazione più o meno raffinata del paradigma «costantiniano» nelle relazioni della Chiesa con gli Stati, e particolarmente con lo Stato italiano.
All’avanzata di una società secolarizzata, che sembra insidiare l’egemonia del cattolicesimo nei paesi di antica cristianità e di fatto mette in crisi la riproduzione sociale della cristianità, il rischio crescente è la nostalgia dello Stato cattolico. L’esito di questa deriva è fra l’altro l’offuscamento delle direttive del Concilio Vaticano II il quale aveva affermato che la Chiesa «in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non si lega ad alcun sistema politico per essere segno e salvaguardia del carattere trascendente della persona umana... La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo... La Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall’autorità civile, anzi rinuncerà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti ove constatasse che il loro uso potrebbe far dubitare della sincerità della sua testimonianza».
catto-berlusconismo
L’insorgere di una tentazione neo-costantiniana è senza dubbio facilitato dalla deriva liberistica del governo Berlusconi che ha applicato la politica della privatizzazione anche ai rapporti con la Santa Sede e con la Cei, riducendoli ad un aberrante mercato di privilegi confessionali in cambio di consenso. Anche all’interno della coalizione governativa si nota con allarme che è invalsa una prassi per cui vengono sistematicamente saltati i canali diplomatici dello Stato per privilegiare comunicazioni dirette tra membri del governo e prelati romani e trattare a questo livello privatistico misure legislative di interesse ecclesiastico.
Una prassi del genere è andata incontro al neo-costantinianesimo di settori ecclesiastici, segnando la crisi dell’impianto conciliare della «Gaudium et Spes» sul quale si fondava l’aspettativa che la Chiesa seguisse altre strade, diverse da quella delle posizioni di potere, per farsi strada nel mondo delle anime.
Di fatto, la Chiesa reale ha ceduto alla facilità di una Chiesa «di Stato» esorbitando dal proprio campo con interventi invasivi nei campi in cui, in una società pluralista, lo Stato può e deve legiferare, cioè sulle coppie di fatto, sul trattamento di fine vita, sulla «pillola abortiva» eccetera: altrettanti campi sui quali lo Stato ha competenza ed è tenuto a intervenire con attente mediazioni fra l’ordine dei valori e la complessa realtà sociale in rapida trasformazione. Si tratta di situazioni che di fatto sono presenti nella nostra società, e sui quali il potere civile è pienamente legittimato a legiferare per inquadrarle in un minimo di normativa civile, ad evitare mali maggiori.
Le derive citate rendono attuale il monito dell’abate Rosmini: «quando la Chiesa si fa arbitra delle sorti umane, allora solo è impotente, quello è il tempo del suo decadimento»
strategie interventiste
Le sortite di alcuni vescovi di regime ne hanno dato una corposa convalida, nella congiuntura delle notti orgiastiche del premier. Tra le scorciatoie assolutorie escogitate, nessun discepolo laicista di Machiavelli avrebbe saputo toccare le altezze cognitive raggiunte da Giampaolo Crepaldi, il vescovo che sta dividendo la comunità cristiana di Trieste. In un volume Il cattolico in politica. Manuale per la ripresa» (Cantagalli, 2011), Crepaldi afferma: «Tra un partito che contemplasse nel suo programma la difesa della famiglia fondata sul matrimonio e il cui segretario fosse separato dalla moglie, e un partito che contemplasse nel programma il riconoscimento delle coppie di fatto e il cui segretario fosse regolarmente sposato, la preferenza andrebbe al primo partito». E aggiungeva: «È più grave la presenza di principi non accettabili nel programma che non nella pratica di qualche militante, in quanto il programma è strategico ed ha un chiaro valore di cambiamento politico della realtà più che le incoerenze personali».
Il suo confratello Luigi Negri, vescovo di San Marino e Montefeltro, non esitava a schierarsi a difesa di Berlusconi, adducendo (in un articolo al settimanale Tempi, poi in una intervista a La Stampa) l’appoggio assicurato da questo governo ai «principi non negoziabili», quali la difesa della vita dal suo inizio al suo termine naturale, ai valori della famiglia, avvalorando questi vantaggi come sufficienti a giustificare la mancanza di «indignazione» verso le condotte personali del premier (in realtà, verso le presunte sue violazioni di leggi dello Stato sulla concussione e la prostituzione minorile, contestategli dalla Procura di Milano).
Lo spettacolo di vescovi che si prodigavano ad affondare alcuni principi fondamentali dell’ordine cristiano tradizionale per tenere a galla Berlusconi non poteva lasciare indifferenti. Già al Consiglio Permanente della Cei, aperto i124 gennaio ad Ancona dalla prolusione del Cardinale Bagnasco, si erano manifestate le inquietudini di alcuni vescovi secondo i quali la Chiesa con il suo atteggiamento ancillare nei confronti del regime avrebbe assunto «la responsabilità di intrattenere questo governo». «Un conto è pazientare, tutt’altro sostenere» era stato osservato da chi avvertiva dei gravi danni che una sostanziale collusione col regime avrebbe procurato alla missione pastorale, chiamata a rivolgersi a tutti, al di là di opzioni politiche settarie.
A Crepaldi hanno risposto alcuni gruppi cristiani di Verona (in «Segni dei tempi», anno II, n. 10) indicando il pericolo dell’immoralismo berlusconiano, dei suoi fiancheggiatori e della vasta pletora dei tolleranti per il suo potere destrutturante dal punto di vista civile e politico. Essi contestavano «la pretesa di scindere vita privata e vita pubblica» come uno dei fattori (accanto all’eventuale responsabilità per atti penalmente rilevanti) che «inquinano alla radice la possibilità della costruzione di una vita sociale in cui si possa riconoscere». E parlando della strategia interventista dei vescovi, sottolineava la decadenza dell’autonomia politica del laicato cattolico, costretta - contrariamente alle direttive esplicite del Vaticano II (messo da parte dal Crepaldi) - a rifluire entro i quadri clericali dell’obbedienza agli indirizzi dei vescovi, considerata «tratto distintivo della loroazione politica».
la vera alternativa a Dio
Sulle tesi neo-costantiniane di Negri interveniva poi, uscendo da un prolungato silenzio, l’emerito vescovo di Ivrea Luigi Bettazzi. In una «Lettera aperta» egli difendeva lo statuto originalmente evangelico dell’«indignazione» e rammentava che tra i principi «non negoziabili» è presente quello fondamentale della solidarietà, in forza del quale ci si deve impegnare non solo in difesa delle vite più deboli ma anche di tutte le vite «minacciate», «come sono quelle di quanti sfuggono la miseria insopportabile o la persecuzione politica, che sono invece fortemente condizionate dal nostro Governo». Del resto, anche sotto il profilo delle «consonanze cristiane», «non si è fatto nulla per favorire la vita nascente con leggi che incoraggino il matrimonio e la procreazione come ha fatto la ’laica’ Francia».
Infine, a contraddire la tesi che il politico va giudicato solo per la politica, Bettazzi ricordava che «chi sta in alto deve dare il buon esempio perché egli tanto più in quest’era mediatica, influisce sull’opinione pubblica. Ed è questo che dovrebbe preoccupare noi vescovi, cioè il diffondersi, soprattutto fra i giovani, dell’opinione che quello che conta è ’fare i furbi’, è riuscire in ogni modo a conquistare e difendere il proprio interesse, il bene particolare, anche a costo di compromessi, come abbiamo visto nei genitori e nei fratelli che suggerivano alle ragazze di casa di vendersi ad alto prezzo». Così si diffonde l’idolatria del fare soldi, del fare ciò che si vuole, concludeva Bettazzi. Si instaura nella società «la vera alternativa a Dio» («o Dio o mammona»), si ignorano le raccomandazioni della Cei sul bene comune come impegno specifico dei cristiani.
la potente armata morale di Ruini
Tuttavia non erano in questione soltanto le propensioni politiche di questo o quel vescovo, o il grado più o meno profetico delle trepidazioni gerarchiche dinanzi all’immoralismo politico. In realtà a trovarsi implicata era un’intera politica ecclesiastica, troppo esposta all’obiezione di perseguire vantaggi materiali mediante uno spericolato compromesso con il regime al comando. E questa situazione rinviava all’opzione decisa fin dagli inizi dell’«era Ruini», nello scenario del pontificato spettacolare di Wojtyla, quando si era adottato per l’avvenire della Chiesa cattolica in Italia il paradigma di un cattolicesimo dimostrativo, presente nella mischia politica e nel frastuono mediatico, ma anche desideroso di allargare il deposito dell’8 per mille concordatario, dei privilegi confessionali, delle leggi conformi al suo credo, in una società pluralista.
Si profilavano fin da allora i presupposti di fenomeni di involuzione, caratterizzati dal ritorno ad una pretesa di autosufficienza della Chiesa verso la società moderna, dal tentativo di costituire nella Chiesa, favorita dai nuovi privilegi concordatari, la base organizzativa di una potente armata morale, quasi a rincorrere il sogno di una nuova cristianità clericale per tamponare le crepe della cristianità sociologica, serrando le fila per far fronte al mondo.
Nel vuoto lasciato dal Partito cattolico dopo la disfatta della Dc era chiaro che la Chiesa cercava di assumere un nuovo potere di supplenza politica nel Paese, come agenzia di valori e lobby di pressione, pronta a scendere in campo direttamente come minoranza attiva, per ottenere per via parlamentare, col favore di governi compiacenti, ciò che evidentemente disperava di raggiungere per le vie lunghe della testimonianza e delle convinzioni.
Una volta constatata la perdita di influsso dei suoi modelli morali sulla vita privata degli individui, la Chiesa operava un completo cambiamento di strategia: senza abbandonare del tutto le vie consuete della sua pastorale delle coscienze, cominciava a dirottare l’investimento principale sul pubblico, cercando di far leva sulla potenza della comunicazione mediatica, sulla legislazione favorevole dello Stato, sugli strumenti concordatari (specialmente nel campo della scuola e in quello del matrimonio) per difendere e promuovere nell’ordine politico statuti di vita privata che possano riprodurre il più fedelmente possibile le sue visioni antropologiche e sociali.
Una prospettiva tale da permettere alla Chiesa istituzionale, al meglio dell’ipotesi, di rimanere una forza sociale consistente e centrale nella società italiana ed europea, valorizzando quel fondo di eredità cristiana che viene considerato un dato strutturale, ben radicato e insostituibile della cultura diffusa del Paese. Di qui la piega neocostantiniana e mondanizzante di una Chiesa che preferisce negoziare spazi per i suoi modelli morali con i poteri politici del momento piuttosto che concentrarsi sulle proprie vie religiose per la formazione degli spiriti liberi.
Con pericoli per lo sviluppo delle dinamiche democratiche (altro che puritanesimo moralistico!), ma anzitutto pericoli «per l’anima della Chiesa stessa, per la sua mistica» ammoniva Achille Ardigò poco prima di morire. «Vedo il pericolo - sottolineava il discepolo di Giuseppe Dossetti - nella volontà ormai esplicita della gerarchia di scendere direttamente, in prima persona, sul terreno politico più operativo, quello dell’organizzazione, delle scelte tattiche, delle valutazioni di convenienza e opportunità, del fine che giustifica i mezzi (...). La Chiesa non può farsi partito politico senza rischiare di dissolvere il proprio fondamento mistico» (2).
Note
 (1) Il testo in Osservatore Romano, 25 giugno 2005.
(1) Il testo in Osservatore Romano, 25 giugno 2005.
 (2) «L’attacco al Concilio e l’interventismo dei vescovi: intervista con Achille Ardigò», La
Repubblica, 7 luglio 2005.
(2) «L’attacco al Concilio e l’interventismo dei vescovi: intervista con Achille Ardigò», La
Repubblica, 7 luglio 2005.
-
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. --- IL "LIBER PARADISUS" (BOLOGNA, 1257). "Paradiso vuol dire libertà, la libertà è per il paradiso": colloquio con Raniero La Valle a cura di Maurizio Chierici.26 settembre 2010, di Federico La Sala
ALLE ORIGINI DEL MODERNO!!! BOLOGNA, 1257: IL "LIBER PARADISUS" *
Quest’ atto ricorda la manomissione effettuata dal comune di Bologna di servi e serve della gleba: lo si deve chiamare giustamente Paradiso.
Dio onnipotente piantò un piacevole Paradiso (giardino) e vi pose l’uomo, il cui corpo ornò di candida veste donandogli una libertà perfettissima ed eterna. Ma l’ uomo, misero, immemore della sua dignità e del dono divino, gustò del frutto proibito contro il comando del Signore. Con questo atto tirò se stesso e i suoi posteri in questa valle di lagrime e avvelenò il genere umano legandolo con le catene della schiavitù al Diavolo; cosi l’ uomo da incorruttibile divenne corruttibile, da immortale mortale, sottoposto a una gravissima schiavitù. Dio vedendo tutto il mondo perito (nella schiavitù) ebbe pietà e mandò il Figlio suo unigenito nato, per opera dello Spirito Santo, dalla Vergine madre affinché con la gloria della Sua dignità celeste rompesse i legami della nostra schiavitù e ci restituisse alla pristina libertà. Assai utilmente agisce perciò chi restituisce col beneficio della manomissione alla libertà nella quale sono nati, gli uomini che la natura crea liberi e il diritto delle genti sottopone al giogo della schiavitù.
Considerato ciò, la nobile città di Bologna, che ha sempre combattuto per la libertà, memore del passato e provvida del futuro, in onore del Redentore Gesù Cristo ha liberato pagando in danaro, tutti quelli che ha ritrovato nella città e diocesi di Bologna astretti a condizione servile; li ha dichiarati liberi e ha stabilito che d’ora in poi nessuno schiavo osi abitar nel territorio di Bologna affinché non si corrompa con qualche fermento di schiavitù una massa di uomini naturalmente liberi.
Al tempo di Bonaccorso di Soresina, podestà di Bologna, del giudice ed assessore Giacomo Grattacello, fu scritto quest’ atto, che deve essere detto Paradiso, che contiene i nomi dei servi e delle serve perché si sappia quali di essi hanno riacquistato la libertà e a qual prezzo: dodici libbre per i maggiori di tredici anni, e per le serve: otto libbre bolognesi per i minori di anni tredici [...]
* Cfr. Federico La Sala, Dante (e Bacone), alle origini del moderno!!! Pace, giustizia e libertà nell’aiuola dei mortali, Èuresis, Notizie e scritti di varia indole del Liceo classico “M.Tullio Cicerone” di Sala Consilina, Boccia editore, Salerno 1988.
Paradiso vuol dire libertà, la libertà è per il paradisocolloquio con Raniero La Valle a cura di Maurizio Chierici (domani, 20 settembre 2010)
L’ultimo saggio [Paradiso e libertà] di Raniero la Valle completa la triologia pubblicata da Ponte delle Grazie: “Prima che l’amore finisca” analizza l’eredità del Novecento e “Se questo è un Dio” risponde alla questione di Dio che la modernità aveva chiuso. Quel Dio morto negli anni ’60, il Dio che la borghesia del benessere rifiuta di incontrare o nega di aver mai conosciuto.
 Perché il libro riprende il filo dei saggi che lo precedono?
Perché il libro riprende il filo dei saggi che lo precedono?Perché avevo un debito. Io fin da piccolo sono stato nella Chiesa, ho patito la guerra, sono andato all’Università, ho diretto un quotidiano, ho vissuto il Concilio Vaticano II e ne ho raccontato, prima di ogni altro storico, la storia, perché ne facevo giorno per giorno la cronaca mettendo insieme notizie, documenti e testimoni. Sono stato sedici anni in Parlamento, prima al Senato poi alla Camera, ho partecipato per breve tempo al governo di Roma da un ufficio che stava sotto Marco Aurelio nella piazza del Campidoglio, ho girato molte terre, alcune in fiamme, ho conosciuto persone straordinarie di ogni mondo, scomparsa la prima moglie mi sono sposato due volte, non ho figli ma tanti nipoti e nipotini che talvolta è perfino difficile ricordarne il nome, e a questo punto qualcuno potrebbe chiedermi: “Che cosa hai capito?” A suo modo questo libro, come i due precedenti, è una risposta.
 Che cosa hai capito?
Che cosa hai capito?Anzitutto perché ci si innamora così fortemente.
 Perché?
Perché?Perché quando ad esempio nell’”Aida” un prode capitano egiziano dice a una schiava etiope che ama: “Celeste Aida”; quando nell’”Iliade” i saggi Troiani che siedono alle Porte Scee vedendo arrivare la bella Elena dicono: “è divina”; quando nel Cantico dei Cantici, che è il più bel libro della Bibbia, si dice che l’amore tra quell’uomo e quella donna “è fiamma di Dio”, ed è la sola volta che lì Dio è nominato, queste espressioni non sono iperboliche, sono vere. Vero è che la donna è divina, che l’uomo è divino. Perciò anche l’amore è divino.
 Come può l’uomo essere divino? Tutta la civiltà occidentale dice che se è un uomo, non può
essere Dio.
Come può l’uomo essere divino? Tutta la civiltà occidentale dice che se è un uomo, non può
essere Dio.Non è vero. In Occidente si afferma con forza la dignità, la “dignitas” dell’uomo. Ma che cos’è la “dignitas” dell’uomo se non la sua “divinitas”? È questo lo specifico umano, ciò che distingue l’uomo dagli “altri” animali, quella differenza sostanziale che nel processo evolutivo gli scienziati non riescono a trovare. Del resto nella lettera a Tito san Paolo per definire la natura buona di Dio parlava della “humanitas” di Dio: Dio è buono in quanto è “umano”. Così, in questo scambio dei linguaggi, per dire la vera natura dell’uomo si deve parlare della sua “divinitas”, nel che sta la sua dignità.
 Non tutti gli uomini sono degni, se sono così capaci di male.
Non tutti gli uomini sono degni, se sono così capaci di male.Gli uomini non peccherebbero, non farebbero il male, se non fossero liberi. La libertà è ciò che di Dio è in loro. Si è discusso, nella Chiesa, in che senso l’uomo fosse, come dice la Bibbia, “immagine di Dio”. La risposta prevalente (che arriva fino a Benedetto XVI) è che l’immagine sta nella ragione. Invece (lo diceva con forza San Bernardo) sta nella libertà. Perciò la libertà è santa: altro che “bieco illuminismo” come è stato scritto in recenti polemiche guelfe in Italia. Nel Duecento un editto con cui a Bologna furono liberati i servi, si chiamò “Liber Paradisus”, libro Paradiso. Il Paradiso è dunque il luogo, e gli eventi, in cui gli uomini vengono a libertà. Perciò ogni volta che gli uomini si liberano, o sono liberati, c’è più paradiso in terra, e si prepara quello celeste.
 Però, se si fa il male, l’immagine di Dio si perde, e il paradiso non c’è.
Però, se si fa il male, l’immagine di Dio si perde, e il paradiso non c’è.No, l’immagine permane, anche se si compie ciò che è male. I teologi medievali erano fermissimi su questo. Perché una cosa è l’immagine, l’impronta divina nell’uomo, altra cosa è la somiglianza. Anche Hitler portava in sé l’immagine di Dio, ma non gli rassomigliava per niente. La somiglianza sta nell’usare la libertà per il bene, di cui non è vero che l’uomo non sia capace, nonostante le antropologie pessimistiche fondate sul peccato. Questo è dunque il senso di “Paradiso e libertà”: il Paradiso è libertà, ma la libertà si deve usare per il Paradiso.
 Che cos’altro hai capito?
Che cos’altro hai capito?Ho capito che nonostante la tragica situazione in cui l’umanità è venuta oggi a cadere, anche per colpa sua, l’uomo può farcela a riprendere in mano la terra e la storia. Nel Novecento furono espresse sentenze un po’ disperate, si disse che a questo punto solo un Dio ci poteva salvare, cioè solo un miracolo. Ma l’uomo è questo miracolo. Le risorse ci sono, e sono nella natura stessa dell’uomo e della donna, come sono usciti dalle mani di Dio o, come dico nel libro, messi in vita dal “bacio di Dio”.
 Ma ce la può fare l’uomo da solo?
Ma ce la può fare l’uomo da solo?Ce la può fare l’umanità tutta intera, perché l’umanità non è solo umana, è il corpo di Dio (“corpus Domini”, dice la Chiesa).
 Ma questo non vuol dire consegnarsi alla Chiesa?
Ma questo non vuol dire consegnarsi alla Chiesa?L’amore di Dio sta nella Chiesa, ma è oltre la Chiesa ed è prima della Chiesa. Non tutto comincia con la Chiesa visibile. Anche prima del Cristo storico l’umanità giungeva a salvezza, perché il Cristo, il “Verbo”, è da sempre, come il Padre. Non vedere ciò porta gravi conseguenze. GS e Comunione e Liberazione nacquero dall’idea che Cristo fosse il cominciamento assoluto, e perciò credettero che l’unica cosa necessaria fosse “essere Chiesa”, e che la loro comunità era questa Chiesa, come luogo in cui stare in continuazione di lui. A questa condizione si poteva senza remore usare il potere, prendere in appalto il mondo, con l’idea che la Chiesa stessa fosse il mondo salvato, e così le critiche al cattivo uso del potere e del mondo potevano essere tacciate di “moralismo”: e ancora lo sono, così si arriva fino a Berlusconi, e alla sua assoluzione da ogni peccato, compresi i cari, vecchi peccati “de sexto”. Ma il Cristo storico non è lo spartiacque tra l’essere e il non essere del mondo, l’essere o non essere di Dio nel mondo, egli viene dal principio e si inserisce in una storia, che non è solo quella del popolo ebreo, ma dell’umanità tutta con le sue religioni le sue civiltà e le sue culture; Gesù di Nazaret fa conoscere il Dio che c’era già prima e lo spiega agli ebrei che non l’avevano capito; e così comincia una storia nuova per tutti. La Chiesa, che nasce da lì, è distinta dal mondo, perché anch’essa deve stare a sentire quello che dice lo Spirito, ed è al servizio di questi “tutti” del mondo; rientrare nel ghetto, vuol dire tornare alla storia vecchia, e così l’umanità non ce la può fare.
 E ce la può fare?
E ce la può fare?Non i singoli popoli da soli, o peggio in guerra tra loro, ma l’umanità tutta intera composta nella sua unità, nella varietà delle forme, delle politiche e delle fedi, che sono le vie di transito tra l’uno e l’altro Paradiso. Come dice il Concilio: “Unico diventa il destino della umana società senza diversificarsi più in tante storie separate”.
* Raniero La Valle, Paradiso e libertà, Ponte alle Grazie
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO ---- Sulla "giustizia terrena del Papa", l’opinione entusiasta di Filippo Di Giacomo.17 febbraio 2010, di Federico La Sala
-
> LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). --- PER IL CARDINAL BERTONE IL POTERE DEL "DIO" DEL SUO PAPA E’ INDIVISIBILE E INDISCUTIBILE.12 febbraio 2010, di Federico La Sala
-
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). --- Biblioteca laica. Il pensiero libero dell’Italia moderna (lavoro c. di M. Ciliberto - recensione con schea).22 aprile 2009, di Federico La Sala
La laicità è più della polemica con la Chiesa cattolica
L’Italia ha avuto un pensiero laico di altissimo livello europeo, spesso in posizione di avanguardia. Un pensiero che ha attraversato tutta la modernità, e che non ha mai trovato adeguata rappresentazione nella dimensione più propriamente politica
di Biagio Di Giovanni (il Riformista, 22.04.2009)
Che cos’è la laicità? È qualcosa di molto più ampio di una polemica, per quanto aspra, nei confronti della Chiesa cattolica, avverte Michele Ciliberto, curatore di un bel volume elegantemente intitolato al tema: "Biblioteca laica. Il pensiero libero dell’Italia moderna" (Laterza 2008). E il primo commento che viene spontaneo al lettore, è che l’Italia ha avuto un pensiero laico di altissimo livello europeo, spesso in posizione di avanguardia: a opera di quella intellettualità italiana cosmopolitica che dall’umanesimo in poi ha contribuito a fare l’Europa. Un pensiero, quello laico, che ha attraversato tutta la modernità, e che forse non ha mai trovato una adeguata rappresentazione nella dimensione più propriamente politica.
Come se i pensieri che hanno percorso la cultura e la vita civile si inaridissero a contatto con un potere che raramente si è collocato alla loro altezza, pure per i ritardi nel farsi l’Italia nazione. Per cui i discorsi di Cavour sulla libera Chiesa in libero Stato, pronunciati in Parlamento fra il marzo e l’aprile del 1861, poco prima della morte (e riportati a conclusione del volume), restano esempio raro di una coscienza politica laica cristallina, che rapidamente declinò verso deboli compromessi istituzionali.
La storia della Chiesa ha costituito un ostacolo per la storia dell’Italia nazione secondo l’idea di Machiavelli, non di un agitatore sconsiderato: ma si è perso il seme del problema. Ne ha ritardato l’unità, prima operando attraverso la separazione, sottraendo parti di legittimazione allo Stato, lasciandolo guardare come una mera macchina di potere; poi, attraverso una costante invasione di campo (rare le eccezioni: il grande Giovanni XXIII su tutti) che fa del nostro Paese qualcosa di unico nel panorama europeo su questo tema. E qui tutti hanno avuto le loro responsabilità, soprattutto quella sinistra che intese costruire un aspetto del compromesso sociale e politico con la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi, condizione privilegiata per la Chiesa, cui non corrisponde, per essa, una uguale serie di doveri civili.
Ma torniamo al libro, che consiglio soprattutto, al giovane lettore, di tenere sul comodino, ogni sera qualche pagina da leggere. «Nella laicità - scrive Ciliberto - si è espressa una vera e propria concezione della sapienza - quella mondana, civile che appare in modo luminoso nei testi qui adunati. Se si vanno a leggere i capisaldi di tale cultura, ci imbattiamo in concetti decisivi come quelli di legge, di conflitto, di eguaglianza, di dissimulazione, di bisogno, di libertà di stampa, di opinione pubblica, fino all’argomentazione del rifiuto della tortura e della pena di morte».
Laicità, dunque, come sapienza mondana, dove si affollano i temi della condizione umana finita, che si muove fra necessità, libertà e dubbio, tra virtù e fortuna, che accetta di stare nel mare della vita, sapendo che «gli uomini non comandano alle stelle», come scriveva Machiavelli, o che «gli uomini sono al buio delle cose», come diceva lo scarno Guicciardini, e che «le religioni nascono, crescono e muoiono», come insegnava Pietro Pomponazzi.
Gli straordinari frammenti sulla religione di fra’ Paolo Sarpi, che, liberamente religioso, paventava quei pensieri che rendevano gli avvenimenti «più soggetti alla provvidenza che alla disposizione umana». E la "libertas philosophandi" nasce in questo orizzonte, conquista combattendo la sua autonomia, per cui «chi proibisce ai Cristiani lo studio della filosofia e delle scienze proibisce loro anche di essere cristiani», come scriveva fra’ Tommaso Campanella, dal carcere dell’inquisizione contro le pretese della Chiesa di allora. E Giordano Bruno, con eroico furore, scelse di morire per non abiurare alla sua convinzione.
Insomma, il senso di una sapienza assai umana, premessa di vita civile, che contribuì alla rappresentazione di una cultura non preda di un relativismo algido e agnostico, ma che pose pure le basi di quella religione civile capace di costruire istituzioni, la religione civile che va da Machiavelli a Francesco De Sanctis e a Bertrando Spaventa. Proprio questa sapienza diventa rispettosa della vita, fonte di istituzioni umane. Essa condanna, nelle pagine di Beccaria, con anticipo su tutta Europa, la pena di morte e la tortura, condanna motivata nell’autonomia della vita morale. E poi afferma la necessità della educazione pubblica, della libera stampa, del conflitto da cui nasce armonia, di una autonoma costituzione politica, di una legge che spezzi i privilegi, e di una religiosità cristiana intrinsecamente non clericale, come nelle pagine di Alessandro Manzoni dedicate al tema della responsabilità umana.
Insomma, una grande Italia, di cui qualche volta ci dimentichiamo, persi nelle nostre controversie quotidiane, in alcune miserie presenti e passate, o supini rispetto a visioni che riportano indietro la nostra coscienza civile, quasi che la religione non dovesse germinare dall’interno della nostra viva umanità, ma si scandisse in un suo tempo separato come un recinto del sacro da cui promanano i custodi della verità.
SCHEDA -LATERZA
 Michele Ciliberto (a cura di)
Michele Ciliberto (a cura di) Biblioteca laica
Biblioteca laica
 Il pensiero libero dell’Italia moderna
Il pensiero libero dell’Italia moderna con la coll. di O. Catanorchi e F. Dell’Omodarme
con la coll. di O. Catanorchi e F. Dell’OmodarmeIn breve
«Chi proibisce ai cristiani lo studio della filosofia e delle scienze proibisce loro anche di essere cristiani.» Così scriveva Tommaso Campanella, nell’Apologia di Galileo del 1616, in difesa del principio della libertas philosophandi, predicato specifico e irrinunciabile dell’indagine umana cui non sfuggono né la natura né la religione. È solo un esempio del significato e del valore di quella cultura italiana nella quale si è raccolto quanto di meglio la nostra storia ha generato lungo i secoli moderni. Cultura laica - da non confondere con anticlericale, come spesso è accaduto - nella quale si è espressa una vera e propria concezione del sapere. «Se si vanno a leggere i capisaldi della cultura laica, ci imbattiamo in concetti decisivi come legge, conflitto, eguaglianza, dissimulazione, bisogno, libertà di stampa, opinione pubblica, fino all’argomentazione del rifiuto della tortura e della pena di morte. Princìpi, ieri come oggi, di una sapienza che in Italia ha trovato uno dei suoi luoghi di nascita e di maggiore sviluppo.» Una sapienza mondana e civile, che appare in modo luminoso nei testi qui raccolti - da Leon Battista Alberti a Camillo Benso di Cavour, passando, tra gli altri, per Giordano Bruno, Machiavelli, Leopardi, Manzoni - i quali, organizzati tematicamente, affrontano argomenti come la condizione umana, la nascita (e la morte) delle religioni, la loro funzione civile, la critica della Chiesa di Roma e del cristianesimo, la teorizzazione della ‘libera Chiesa in libero Stato’.
Indice
 Premessa - Introduzione - I TESTI - 1. Sulla condizione umana - 2. Nascita (e morte) delle religioni - 3. Miracoli, ‘contrazioni’, indemoniati - 4. Sulla funzione civile della religione - 5. Critica della Chiesa di Roma e del cristianesimo - 6. ‘Libertas philosophandi’ - 7. Sapienza mondana - 8. Né guelfi né ghibellini: libera Chiesa in libero Stato - Indice dei nomi Indice completo
Premessa - Introduzione - I TESTI - 1. Sulla condizione umana - 2. Nascita (e morte) delle religioni - 3. Miracoli, ‘contrazioni’, indemoniati - 4. Sulla funzione civile della religione - 5. Critica della Chiesa di Roma e del cristianesimo - 6. ‘Libertas philosophandi’ - 7. Sapienza mondana - 8. Né guelfi né ghibellini: libera Chiesa in libero Stato - Indice dei nomi Indice completo Recensione di Massimo Todori - Il Sole-24 ore
Recensione di Massimo Todori - Il Sole-24 ore -
> LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. ---- Nel 60.mo della dichiarazione dei diritti umani, la chiesa continua a negarli al suo interno (Juan José Tamayo).23 dicembre 2008, di Federico La Sala
CATTOLICI SENZA DIRITTI
di Atrio
Due pesi e due misure: nel 60.mo della dichiarazione dei diritti umani, la chiesa continua a negarli al suo interno.
Questo articolo del teologo spagnolo juan josé tamayo è stato pubblicato sul sito internet spagnolo di informazione religiosa progressista “atrio” (10/12/2008). Titolo originale: “derechos humanos en la iglesia: la incoherencia vaticana”*
La celebrazione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti umani invita a riflettere sulla situazione dei diritti umani nella Chiesa Cattolica, una delle istituzioni che storicamente ha opposto maggiore resistenza alle libertà moderne.
La Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, promulgata nel febbraio del 2001, stabilisce nel suo 1.mo articolo che “il Papa detiene nella sua persona la pienezza del potere legislativo, esecutivo e giudiziario”.
Dopo il Concilio c’era l’intenzione di scrivere una Legge Fondamentale della Chiesa, ma il progetto non andò in porto. Solo nel 1983 venne promulgato il Codice di Diritto Canonico che, sebbene sia valido solo per la Chiesa Latina, praticamente con i suoi 1752 articoli (o canoni) è la Magna Carta della Chiesa cattolica. Qui non c’è la divisione dei poteri, ma la potestà suprema: “Il vescovo della Chiesa di Roma, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente” (can. 331).
Di conseguenza, la cultura dei diritti umani è assente dalla sua organizzazione, che si configura con una struttura bipolare (chierici e laici, Chiesa docente e Chiesa discente, gerarchia e popolo di Dio), funziona in modo gerarchico-piramidale (pastori-gregge) e rifiuta la democratizzazione sostenendo che è di istituzione divina e che ha fini spirituali. Cosa che, di primo impatto, cozza con il titolo di capo di Stato della Città del Vaticano che ostenta il papa. Per questo la trasgressione dei diritti umani nella Chiesa cattolica non è una patologia, ma una pratica strutturale, inerente al paradigma ecclesiastico attuale che non corrisponde all’intenzione del fondatore né alle origini del cristianesimo.
Il papa e i vescovi cattolici difendono i diritti umani nella società e ne denunciano la trasgressione, ma disconoscono e non rispettano i diritti dei cristiani e delle cristiane in seno alla Chiesa. Difendono la libertà nella società, ma si dimenticano della libertà cristiana, riconosciuta in molteplici forme nei testi fondamentali del cristianesimo. Come si può negare la libertà ai cristiani e alle cristiane quando Paolo di Tarso dichiara: “Cristo ci ha liberato per essere liberi” (Gal 5,1)? È l’incoerenza vaticana. Vediamone alcuni esempi.
Le donne sono escluse dal sacerdozio, dall’episcopato e dal papato e dai posti di responsabilità ecclesiale, con la giustificazione che Gesù era maschio e che può essere rappresentato solo da maschi. Si fa diventare Gesù di Nazaret un maschilista quando è stato quello che ha messo in moto il movimento egualitario di donne e uomini. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha minacciato di scomunica il teologo nordamericano Roy Bourgeois perché ha affermato che le donne hanno la stessa dignità degli uomini per essere sacerdoti e che nella Bibbia non c’è niente che si opponga all’ordinazione delle donne. La sua risposta è stata che il sessismo e il razzismo sono peccati e che la discriminazione di genere è immorale. Come si può praticare la discriminazione contro le donne impunemente nella Chiesa cattolica quando Paolo di Tarso ha scritto, a metà del primo secolo, che “non c’è greco, né schiavo, né libero, né uomo, né donna, perché tutti sono uno in Cristo Gesù” (Gal 3,26)?
Si obbligano i sacerdoti ad essere celibi e a rinunciare al matrimonio quando teologicamente e storicamente non esiste un vincolo intrinseco fra sacerdozio e celibato. Non si riconoscono né si rispettano libertà quali quelle di espressione, ricerca, insegnamento e stampa. Ci sono decine di teologhe e teologi condannati per i loro scritti e le loro dichiarazioni pubbliche, che, inoltre, vengono obbligati a sottomettere a censura previa tutto quello che scrivono. In qualche caso, libri pubblicati “con i nullaosta” ecclesiastici vengono ritirati dal commercio. Anche l’opzione per i poveri è condannata talvolta con pene severissime, come nel caso della teologia della liberazione - demonizzata dal cardinal Ratzinger quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nell’Istruzione su alcuni aspetti della teologia della liberazione - e di alcuni suoi principali rappresentanti, per esempio Leonardo Boff. I processi contro i teologi e le teologhe non sono precisamente un esempio di trasparenza e di rispetto dei diritti umani; al contrario, gli accusati constatano come questi processi violino sistematicamente i diritti riconosciuti dalla giustizia civile. Si sentono soli davanti al pericolo, senza difesa né possibilità d’appello. Inoltre, la sentenza è dettata a priori.
E non contenta di reprimere i diritti umani all’interno della Chiesa, la gerarchia cattolica si oppone all’esercizio di alcuni diritti e libertà fondamentali nella società: il diritto al libero esercizio della sessualità, condannando l’omosessualità, opponendosi alla sua totale depenalizzazione e generando con le sue condanne atteggiamenti omofonici. Condanna la ricerca sulle cellule staminali embrionali a fini terapeutici, pratica che alcuni leader della Chiesa cattolica paragonano agli esperimenti nazisti nei campi di concentramento. Nega i diritti riproduttivi e sessuali delle donne.
I rappresentanti della Chiesa cattolica giocano un ruolo molto attivo contro i diritti delle donne nelle Conferenze Internazionali su Ambiente, Sviluppo e Povertà, Emancipazione della donna, ecc., facendo causa comune con altre realtà religiose integriste. Succede che, in questi casi, estendono la proibizione di questi diritti a tutti i cittadini e le cittadine. Ancor più, si oppongono alle leggi che regolano questi diritti, sollecitando che non siano rispettati, perché considerano che sono contrari alla legge naturale. Si ripete l’atteggiamento di condanna delle libertà e dei diritti umani adottato dalla gerarchia cattolica durante il secolo XIX e buona parte del XX. Sembra che la storia della Chiesa sia tornata indietro e che si sia fermata a due secoli fa.
Due fatti recenti mettono a nudo l’insensibilità del Vaticano in questo campo: il suo rifiuto di firmare la convenzione dell’Onu sui diritti delle persone disabili e l’opposizione alla proposta avanzata dalla Francia alle Nazioni Unite di depenalizzare totalmente l’omosessualità nel mondo, visto che in vari Paesi l’omosessualità viene punita con la pena di morte. Non accettare la depenalizzazione implica la condanna a morte di gay e lesbiche che vivono in questi Paesi. Con il suo atteggiamento, il Vaticano sta violando in modo flagrante il primo fra tutti i diritti umani: quello alla vita. Che credibilità ha quando reclama il diritto per i non nati se legittima la pena di morte di cittadini e cittadine a causa del libero esercizio della loro sessualità?
La celebrazione del 60.mo anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani mi sembra una buona occasione perché la Chiesa cattolica nel suo insieme, a partire dai suoi dirigenti, faccia un “esame di coscienza” sulla violazione dei diritti umani al suo interno, manifesti un fermo proposito di ammenda, elabori una carta dei diritti e delle libertà dei credenti e metta in pratica i principi della Dichiarazione a tutti i livelli della sua organizzazione. Recentemente il Vaticano ha ampliato il catalogo dei peccati, ma non ne ha inserito uno che certamente è un “peccato mortale”: la trasgressione dei diritti umani in seno alla Chiesa.
 Articolo tratto da
Articolo tratto da
 ADISTA
ADISTA
 La redazione di ADISTA si trova in via Acciaioli n.7 - 00186 Roma
La redazione di ADISTA si trova in via Acciaioli n.7 - 00186 Roma
 Telefono +39 06 686.86.92 +39 06 688.019.24 Fax +39 06 686.58.98
Telefono +39 06 686.86.92 +39 06 688.019.24 Fax +39 06 686.58.98
 E-mail info@adista.it Sito www.adista.it
E-mail info@adista.it Sito www.adista.it -
> L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA "CARTA" FALSA DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). --- La carità vaticana e la visita del Papa a Napoli. Una nota di Flavia Amabile.21 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
Carità vaticana
Spesi più di 1,5 milioni di euro per la visita del papa a Napoli
di FLAVIA AMABILE (La Stampa, 21/10/2007)
Uno legge le parole del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, in un’intervista rilasciata proprio a ’La Stampa’ e pubblicata sabato 20. Si parla delle scritte contro il papa alla vigilia della sua visita a Napoli. Che cosa direbbe ai responsabili, chiede l’intervistatore. E il cardinale: ’Direi: questa è una scuola di violenza, di odio. E gli direi: ti insegno un’altra scuola, la scuola della convivenza, della carità, della solidarietà’.
Uno poi legge il conto finale delle spese che tutti noi sosteniamo per permettere proprio la visita di papa Benedetto XVI a Napoli. E scopre che per dodici ore di trasferta in totale, duecento chilometri di viaggio, si superano i 1,5 milioni di euro. Più in dettaglio: 750 milioni di euro stanziati da palazzo Chigi (a Napoli per l’occasione arriva anche Prodi), 350 mila euro dal Comune, 400 mila dalla Regione per addobbi floreali, accoglienza, interventi strutturali. A questi vanno aggiunti 120 mila euro previsti dall’Autorità portuale per l’atterraggio con l’elicottero.
Ora, è vero che la visita fa parte di una kermesse di tre giorni di dialogo interreligioso ma è anche vero che questi fondi servono soprattutto a garantire la sicurezza e il funzionamento della città durante la visita del papa visto che ci saranno centinaia di migliaia di persone in strada.
E, allora, se per esempio il Vaticano pronunciasse la classica frase ’non fiori ma opere di bene’ riferendosi agli addobbi floreali in strada e in chiesa, oppure ’niente pranzo per noi’ o qualcosa del genere, uno potrebbe trovare più credibili le parole del cardinale Sepe e condannare con maggiore forza le scritte contro il papa sui muri della città.
-
> L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA "CARTA" FALSA DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). .... e la "falsificazione" del messaggio eu-angerlico.21 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
LIBRI
esegesi
Geovisti «falsari» della Bibbia
di MAURIZIO SCHOEPFLIN (Avvenire, 20.10.2007)
Dei Testimoni di Geova - 250.000 in Italia, poco più di sei milioni nel mondo - colpisce in particolare la facilità con cui penetrano negli ambienti cristiani. Tale facilità, come nota padre Tarcisio Stramare nella presentazione del nuovo libro di Valerio Polidori, «è dovuta in gran parte al massiccio utilizzo degli strumenti cristiani - Bibbia e vocabolario - di cui essi si servono in modo equivoco come propri, creando nelle persone non preparate quella confusione che fa di ogni erba un fascio». Dunque, il primo impegno di chiunque voglia confrontarsi con i geovisti consiste nello smascherare la tendenziosità della traduzione del testo biblico di cui si essi si servono. E Polidori fa proprio questo: non a caso il suo lavoro si conclude con un indice dei principali brani biblici citati in modo alterato dalla «Traduzione del Nuovo Mondo» (il testo che i Testimoni di Geova pongono a fondamento delle loro interpretazioni), brani peraltro presi direttamente in considerazione nelle dense pagine del volume, ove vengono sviluppate analisi e comparazioni molto precise che indicano gli errori che stanno alla base della lettura geovista della Sacra Scrittura. Tali errori - sostiene Polidori - assumono una particolare gravità nell’ambito, ovviamente decisivo, della cristologia. I Testimoni di Geova, per esempio, affermano che Cristo non è coeterno al Padre e lo considerano la prima delle sue creature. Per suffragare questa dottrina, essi leggono l’inizio del Vangelo di San Giovanni nel modo seguente: «In principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era un dio». Come è facile osservare, tale traduzione del testo giovanneo è frutto di un evidente travisamento, e Polidori è bravo nel mostrare con dovizia di particolari e mediante dotti approfondimenti linguistici in quale modo si sia concretizzata una simile erronea interpretazione. Particolarmente interessante è la parte del libro dedicata all’escatologia geovista, al centro della quale sta la negazione dell’immortalità dell’anima, sostenuta a partire dalla convinzione che il concetto di anima immortale sia totalmente extrabiblico, frutto di contaminazioni greche che influenzarono il pensiero giudaico. Altre fini puntualizzazioni sono riservate alla questione del significato che i Testimoni di Geova attribuiscono al termine parousia. Il primo capitolo del libro, in cui viene ricostruita la storia del geovismo, risulta utilissimo per comprendere il contesto nel quale si è realizzata la falsificazione della Bibbia, che Polidori contesta con nitida sicurezza.
 Valerio Polidori
Valerio Polidori
 I TESTIMONI DI GEOVA E LA FALSIFICAZIONE DELLA BIBBIA
I TESTIMONI DI GEOVA E LA FALSIFICAZIONE DELLA BIBBIA
 Edb. Pagine 164. Euro 14,00.
Edb. Pagine 164. Euro 14,00.-
> L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA "CARTA" FALSA DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). .... I conservatori della "carta"!!! Ci si risparmi almeno la retorica.23 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
 Costituzione, le riforme e l’antipolitica
Costituzione, le riforme e l’antipolitica
 I conservatori della carta
I conservatori della cartadi Angelo Panebianco
Uno dei paradossi che caratterizzano la nostra democrazia può essere così sintetizzato: da un lato, la consapevolezza della radicale inadeguatezza della nostra carta costituzionale, del fondamentale contributo che essa ha dato e dà alle tante inefficienze della democrazia italiana è universalmente diffusa. Al punto che da circa trent’anni si tenta, senza mai riuscirci, di modificarla in profondità. Dall’ altro lato, schizofrenicamente, si continua a circondare la Costituzione del ’48 dell’aura del mito, spargendo retorica sugli «istituti di libertà e democrazia » che essa egregiamente difenderebbe. Come si spiega la singolare coesistenza (talvolta nelle stesse persone) della consapevolezza dei gravi difetti del testo costituzionale e di cotanta vis retorica? In linea di principio non è sbagliato tentare di difendere una costituzione mitizzandola a volte anche al di là dei suoi autentici meriti. Però, ne deve valere davvero la pena. La varrebbe se la nostra fosse simile a quella britannica (che non è un unico testo scritto ma un insieme di convenzioni e di statuti accumulatisi nei secoli), a quella americana o a quella francese della Quinta Repubblica, poiché quelle costituzioni hanno reso buoni servigi alle rispettive democrazie. Ma come si può credibilmente diffondere tanta retorica intorno a una carta costituzionale che ci ha regalato una democrazia acefala, ossia priva di un capo di governo dai forti poteri, e assembleare (l’assemblearismo è una degenerazione del parlamentarismo), un mostruoso bicameralismo simmetrico, e ben 56 governi in meno di sessant’anni, dal ’48 ad oggi? E sto parlando, sia chiaro, solo della seconda parte della Costituzione, relativa ai poteri dello Stato e ai rapporti costituzionali. Non mi dilungo, invece, sulla prima parte, quella attinente ai cosiddetti «valori costituzionali ». Mi limito solo a osservare che una Repubblica democratica fondata sul «lavoro» anziché sui diritti di libertà, e nella quale il diritto di proprietà e la libertà economica sono stati rigidamente separati dai diritti fondamentali, ha sempre creato notevoli problemi alle libertà: ad esempio, ci ha lasciato senza anticorpi e difese contro gli eccessi di statalismo e di dirigismo, vizi nazionali dai quali non riusciamo tuttora a sbarazzarci. Non è chiaro perché di questa schizofrenia non riescano a liberarsi nemmeno uomini di qualità e di spessore come, ad esempio, l’ex ministro per la Funzione pubblica, Franco Bassanini.
Da un lato, Bassanini apprezza a tal punto le democrazie governanti (quelle vere) da accettare di entrare in una commissione di studio voluta dal f r a n c e s e N i c o l a s Sarkozy, un presidente i cui (enormi) poteri dipendono dalla Costituzione della Quinta Repubblica. Dall’altro lato, Bassanini contribuisce a promuovere un documento, firmato da numerose personalità, teso a ottenere dal costituendo Partito democratico l’impegno a immolarsi sull’altare del più ortodosso conservatorismo costituzionale, a difesa di una Costituzione in virtù della quale abbiamo, e continueremo ad avere fin quando resterà in vigore, una democrazia assembleare e non governante. Poiché chiedere, come fa quel documento, un impegno a blindare l’articolo 138 (quello che riguarda le revisioni costituzionali), equivale a pretendere che mai una vera riforma della Costituzione possa essere realizzata.
La Francia, nel 1958, spazzò via, grazie a de Gaulle (all’epoca, stupidamente, considerato un fascista da tanti anche in Italia), una pessima Costituzione molto simile alla nostra e ben pochi colà la rimpiangono. Da noi non è possibile. Troppi sono affezionati ai poteri di veto diffusi, alle capacità di interdizione che la democrazia acefala e assembleare assicura anche alla più piccola delle corporazioni: a scapito, ovviamente, del potere decisionale dei governi. Come ha confermato anche il referendum che ha respinto la riforma costituzionale voluta dal Polo.
Riforma che non era, come per eccesso di faziosità si dice nel documento sopra citato, una «controriforma » (lo ha ricordato Piero Ostellino sul Corriere): era piuttosto un riforma con chiari e scuri, che conteneva alcune cose buone (il rafforzamento del potere del premier, la riduzione dei parlamentari, qualche correttivo alla folle riforma del Titolo Quinto voluta dal centrosinistra) e alcune cose cattive (soprattutto, un pasticcio in materia di poteri del Senato). Si dice: la Costituzione ha garantito la democrazia e la libertà anche quando il Paese era diviso fra comunisti e anticomunisti.
Ma no.A garantire democrazia e libertà, all’epoca, fu la nostra appartenenza al blocco occidentale e a un’Europa in costruzione. Ciò che quella Costituzione «garantì » fu il fatto che la nostra democrazia fosse una delle più inefficienti all’interno di quel blocco. Peraltro, abbiamo potuto constatare, fin dagli anni 90, che le riforme del sistema elettorale, pur necessarie, non sono sufficienti per ottenere stabili democrazie governanti. E’ un punto, quest’ultimo, sul quale concordo con Andrea Manzella (la Repubblica di ieri) dal quale però mi divide la mia minore deferenza per lo «spirito costituente» del ’47 e, tenuto conto dei gravi errori (riconosciuti dallo stesso Manzella) allora commessi, per la «maggioranza costituzionale » dell’epoca. Siamo costretti a tenerci, antipolitica permettendo, la carta costituzionale che abbiamo e, con essa, la democrazia acefala e assembleare, con la sua paralisi e le sue mille inefficienze. Ci si risparmi almeno la retorica.
* Corriere della Sera, 11 ottobre 2007(modificato il: 16 ottobre 2007)
-
> L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA "CARTA" FALSA DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). .... In breve, la Chiesa è retta da un ordinamento dove il potere politico coincide con quello religioso, e dove vengono smentite le più elementari regole dello Stato di diritto (Michele Ainis).23 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
Libera Chiesa in debole Stato
Troppe le ingerenze vaticane nella politica italiana
di MICHELE AINIS (Corriere della Sera, 23/10/2007 - 8:10)
Negli ultimi tempi la laicità si è trasformata in un prezzemolo buono per ogni salsa. Ma se tutti sono laici, allora questa parola non significa più nulla: tanto varrebbe sbarazzarsene. È una tentazione irresistibile, davanti alle acrobazie verbali che ci consegna l’esperienza. Nel dibattito pubblico ricorre l’appello verso una «sana» laicità pronunziato da Benedetto XVI e dai suoi predecessori; ma ricorre inoltre, e per esempio, il monito col quale un capo dello Stato (Scalfaro) definisce «sacra» la laicità delle istituzioni, che è un po’ come dichiarare ateo il Padreterno. Insomma abbiamo in circolo pontefici laici e presidenti ieratici. D’altra parte, «laos» era in origine il popolo di Dio; evidentemente stiamo riportando a nudo le radici.
In realtà queste radici hanno alimentato lo sviluppo degli Stati nazionali. Perché lo Stato nasce laico, o altrimenti non sarebbe nato. Nasce quando il potere politico divorzia da quello religioso, attraverso un processo storico che ha origine nella Lotta delle Investiture (1057-1122), trova la sua prima sistemazione teorica nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes, viene poi codificato dalla Costituzione francese del 1791, quando la libertà di fede sancisce la definitiva emancipazione dello Stato rispetto alla cura degli affari religiosi. Come diceva Locke, la salvezza delle anime non ricade fra i compiti dello Stato. Sicché la laicità si risolve in un’indicazione puramente negativa, che vieta alla legge di farsi contaminare da valori religiosi. Evoca il «muro» fra Stato e chiese di cui parlava Jefferson, e ripete in qualche modo il verso di Montale: «codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo».
Questa idea si specchia nell’articolo 7 della Costituzione italiana, che dichiara l’indipendenza dello Stato dalla Chiesa. Al contempo, esso riconosce la sovranità della Chiesa cattolica, e perciò la riconosce come Stato. Uno Stato enclave, ma pur sempre uno Stato, che intrattiene relazioni diplomatiche con 176 Paesi. Insomma il cattolicesimo è l’unica confessione religiosa il cui organo di governo è posto al vertice d’uno Stato sovrano. Ma dal fatto che la Santa Sede sia uno Stato derivano vincoli e divieti. A una garanzia in più (e quale garanzia!) fa da contrappeso un limite in più. Quindi se un monaco buddista o un rabbino ebreo possono ben intervenire sulle vicende legislative della Repubblica italiana, non può farlo il Vaticano. Qui, difatti, non viene in campo la libertà di religione. Non viene in campo una questione di diritto costituzionale, bensì una questione di diritto internazionale. Quando non i parroci, ma il governo stesso della Chiesa attraverso la Cei invita per esempio a disertare un referendum, è come se a pronunziare quell’invito fosse il presidente francese Sarkozy. E la reazione dovrebbe essere affidata ai nostri rappresentanti diplomatici, se vogliamo prendere sul serio l’articolo 7.
D’altronde, che accadrebbe se il premier italiano si scagliasse contro i principi che governano il diritto della Chiesa? Gli argomenti, diciamo così, non mancherebbero. Il diritto canonico non conosce la separazione dei poteri, dato che il Pontefice è al vertice del potere legislativo, esecutivo, giudiziario: una concentrazione che a suo tempo Cavour aveva definito come «il più schifoso despotismo». Non conosce il suffragio universale per la preposizione alle cariche ecclesiastiche. Non conosce la certezza del diritto, sepolta da un sistema di dispense e privilegi. Non conosce la libertà di culto, giacché qualunque offesa alla religione cattolica riveste la natura di reato. Non conosce la regola della maggiore età, dal momento che le leggi ecclesiastiche obbligano tutti i battezzati che abbiano compiuto 7 anni. Non conosce il principio d’eguaglianza fra i sessi, negando il sacerdozio femminile. Ma neppure lo riconosce all’interno del sesso maschile, dato che laici e chierici hanno una differente capacità giuridica, dato che i diritti politici restano in appannaggio ai sacerdoti, e dato infine che questi ultimi sono una casta con proprie norme, sanzioni, tribunali.
In breve, la Chiesa è retta da un ordinamento dove il potere politico coincide con quello religioso, e dove vengono smentite le più elementari regole dello Stato di diritto. Eppure da quel pulpito piovono scomuniche e indirizzi per condizionare la vita pubblica italiana. Basterà rievocare un episodio: il 16 marzo scorso Benedetto XVI ha esortato all’obiezione di coscienza in difesa della vita non solo farmacisti e medici, ma anche i giudici italiani. Sennonché i giudici - afferma la Costituzione - «sono soggetti soltanto alla legge»; l’unica obiezione di coscienza che viene loro consentita è impugnare la legge per incostituzionalità. Se potessero rifiutarsi di rendere giustizia appellandosi ai propri umori e amori personali, verrebbe scardinato non tanto lo Stato di diritto, bensì lo Stato in sé e per sé, l’ordine civile.
Tuttavia le nostre istituzioni hanno risposto, ancora una volta, col silenzio. Un silenzio complice, non soltanto perché la degenerazione d’un regime democratico in regime clericale (diceva Salvemini) avviene gradualmente, e te ne accorgi quando si è già consumata; non soltanto perché altrove i governi reagiscono con una protesta diplomatica, come ha fatto Zapatero nel 2005, dopo la scomunica ecclesiastica dei matrimoni gay; ma infine perché tale atteggiamento implica una cessione di sovranità. Peraltro in molti casi gli interventi della Santa Sede vengono sollecitati proprio da chi ci rappresenta: è accaduto in agosto, quando Prodi ha chiesto l’aiuto della Chiesa per far pagare le tasse ai cittadini, ottenendo una dichiarazione del segretario di Stato vaticano. Appelli come questo rivelano tutta la debolezza della classe politica italiana, ma il loro effetto è legittimare le istituzioni di uno Stato straniero all’esercizio d’un anomalo ruolo di supplenza sulle nostre istituzioni. Che perciò si spogliano della propria laicità, e insieme della propria sovranità.
micheleainis@tin.it
-
> L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA "CARTA" FALSA DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006). .... Intervista a Rémi Brague: "Eppure non sono stati i Greci, ma il Vangelo a rendere possibile la democrazia".24 ottobre 2007, di Maria Paola Falqui
intervista
 «La modernità non è crescita perpetua; si fa ciò che si vuole e si pensa che tutto finirà bene. Solo i cristiani sono rimasti lucidi».
«La modernità non è crescita perpetua; si fa ciò che si vuole e si pensa che tutto finirà bene. Solo i cristiani sono rimasti lucidi».
 La provocazione del pensatore Rémi Brague
La provocazione del pensatore Rémi BragueIl progresso? È il Medioevo
«Per definire un massacro oggi si parla di ’barbarie da secoli bui’. Ma quando si esce da un periodo che ha inventato, tra l’altro, la Shoah, il gulag e i khmer rossi, mi chiedo dove stia la barbarie!» «Il rifiuto dell’età di mezzo si muta, in epoca illuminista, in rottura col cristianesimo. Come se prima non ci fosse nulla. Eppure non sono stati i Greci, ma il Vangelo a rendere possibile la democrazia»
DA PARIGI JEAN MERCIER (Avvenire, 24.10.2007)
Parla poco e non ama i riflettori. Attraverso gli strumenti della filosofia, che insegna a Paris I (PantheonSorbona) e in Germania, all’università Ludwig Maximilian di Monaco, si sforza di pensare la civiltà occidentale nel suo legame con la Bibbia, il Medioevo e l’islam. Nel 1992 il suo Europa, la via romana rivelava al grande pubblico un non-conformista che decripta gli ancoraggi filosofici dei valori europei e l’articolazione tra religione e società. Nella sua ultima opera, Au moyen du Moyen Age («In mezzo al Medioevo», ma anche «Al modo del Medioevo» o «Per mezzo del Medioevo»), ci invita a guardare con occhi diversi un periodo troppo spesso disprezzato dai nostri contemporanei. Spiritoso e impassibile, appassionato di letteratura umoristica inglese, Brague ha il gusto della provocazione. Gli piace scovare «le derive oscurantiste della modernità», così come una certa «ingenuità» nel dialogo dei cristiani con l’islam.
Innanzitutto la vita. Qual è il suo percorso?
«Sono cresciuto nella periferia parigina, ma ho radici nella Nièvre, in Borgogna. Non ho mai conosciuto mio padre, ucciso in Indocina. Quanto agli studi, ho esitato a lungo tra filosofia e storia. Alla fine sono entrato all’Ecole normale supérieure, poi ho insegnato filosofia in un istituto tecnico. Sono stati quattro anni difficili. Ma sono convinto che i docenti universitari che non hanno fatto questo tipo d’esperienza restano sempre un po’ nel loro mondo. Ho imparato a insegnare davvero, e non solo a stupire la platea con belle frasi... Specialista di filosofia greca, ho discusso la tesi su Aristotele. Ma poiché volevo esplorare l’aspetto biblico, ho imparato l’ebraico. All’inizio non ero interessato ai filosofi musulmani, ma all’ebreo Maimonide. Solo in un secondo momento, lavorando su testi ebraici tradotti dall’arabo, ho cominciato a studiare quella lingua. E in seguito sono stato chiamato a occupare una cattedra di filosofia araba e medievale».
In Occidente si ha una visione piuttosto negativa del Medioevo, visto come periodo buio della storia...
«È vero. Per definire un massacro, ovunque sia accaduto, i giornalisti parlano di ’barbarie da Medioevo’. Ma quando si esce da un secolo che ha inventato, tra le altre cose, la Shoah, il gulag, la carestia artificiale in Ucraina nel 1932 e i khmer rossi, mi chiedo dove stia la barbarie! Si è creato in maniera ideologica un ’Medioevo’, per contrapporlo ai cosiddetti tempi ’moderni’. La cosa più bizzarra è che si fanno iniziare questi tempi da una data fissa (come il 1492, scoperta dell’America) quasi il progresso ci fosse caduto addosso un bel giorno. Il rifiuto del Medioevo traduce, in epoca illuminista, la volontà di rottura con il cristianesimo. Il nostro problema è credere che prima dei Lumi non ci fosse nulla, nessuna intelligenza. Eppure è stato il cristianesimo a rendere possibile la democrazia. Sono stati gli ordini religiosi cristiani a inventarla».
...e non la società ateniese?
«Ad Atene si tiravano a sorte gli adulti maschi e liberi. Gli esseri umani non erano tutti uguali. Dire che bisogna dare la stessa scheda elettorale a Einstein e allo scemo del villaggio, dire che hanno lo stesso valore, presuppone una trascendenza, una fonte ultima che fondi tale valore. Questa fonte è Dio. Bergson ha ragione a sostenere che ’la democrazia è, nella sua essenza, evangelica’. Essa non è possibile senza l’idea di coscienza, ossia senza l’idea che Dio parla nella coscienza. Rousseau la chiama ancora ’istinto divino’».
Lei fa parte di quei cristiani fortemente critici della modernità?
«Solo i cristiani sono rimasti lucidi. La modernità è vista come avanzamento perpetuo. I nostri contemporanei, che non credono più in nulla, come bambini di quattro anni s’immaginano che esistano dei folletti che, di notte, riparano i danni creati dal nostro sfruttamento sfrenato della natura. E cicogne che ci porteranno i figli che rifiutiamo di mettere al mondo. Si fa quel che si vuole e si pensa che alla fine tutto andrà per il meglio. La verità è che potrebbe finire malissimo...».
È necessario che il cristianesimo denunci senza sosta questa crisi di valori?
«Sì. Dio ha detto al profeta Ezechiele: ’Se le persone muoiono nel peccato senza che tu le abbia avvertite, è a te che chiederò conto’. Si vorrebbe mascherare l’immensa crisi di fiducia dell’Occidente, evidentissima, con la sola gestione del vivere comune, mentre la nostra sopravvivenza passa attraverso la scoperta di una verità ultima sulla vita, legata alla trascendenza. Facciamo un esempio di questa crisi gravissima: il modo in cui la società parla del bambino. Ci si rallegra della natalità francese, che è un po’ meno catastrofica di quella dei nostri vicini, dicendo che avremo chi ci pagherà le pensioni...».
Il cristianesimo è vittima di un’aggressione? L’impressione è che prevalga l’indifferenza. A parte Michel Onfray...
«Vedo soprattutto simpatici becchini, atei benevoli che si rendono conto che i cristiani comprano molti libri e dunque non bisogna essere loro ostili. Così dicono che il cristianesimo ha fatto cose buone, e lo si può seppellire con incensi e ghirlande. Lusingano il cristiano mostrandogli al tempo stesso che la sua fede non è più attuale».
Lei ha scritto spesso che, tra cristiani e musulmani, è difficile dialogare. Perché?
«Ma no! Con i musulmani è possibile e necessario dialogare. Semplicemente, bisogna partire dalla ragione che ogni uomo possiede. E non basarsi su elementi religiosi comuni, perché sono falsati. L’islam si definisce per principio un postcristianesimo che sostiene che ebrei e cristiani hanno alterato i testi sacri. Per i musulmani, gli ebrei sarebbero infedeli a Moussa (Mosè) e i cristiani a Issa (Gesù). Di conseguenza ne deducono di essere loro i veri discepoli di Gesù e Mosè. Per loro il cristiano adora tre divinità, ha perso il treno quando non ha ricevuto la rivelazione di Maometto. È difficilissimo far capire ai musulmani che essi non conoscono il cristianesimo e l’ebraismo. Dal punto di vista dell’islam, il cristiano crede di essere cristiano ma non lo è veramente... Il cristianesimo accetta di essere secondo rispetto all’ebraismo, mentre l’islam non si sente secondo rispetto al giudeo-cristianesimo. Da un lato, il cristianesimo include l’Antica Alleanza, riprendendo la Bibbia ebraica senza tagli. Dall’altro, l’islam assorbe e fa scomparire il giudeocristianesimo quasi digerendolo. I cristiani poi tendono ad applicare la loro visione di Dio ad Allah. Hanno difficoltà a riconoscere il posto occupato da Maometto nelle società islamiche. Secondo l’islam tradizionale, poiché Dio è immensamente al di sopra degli esseri umani, è meno grave essere blasfemi contro Dio che prendersela con Maometto, poiché in tal caso si scalza il fondamento della società musulmana, il suo legislatore.
Altro esempio d’ignoranza: spesso si sente dire che, di fronte alla violenza, tutte le religioni si equivalgono. Per quanto riguarda il cristianesimo si citano le Crociate e l’Inquisizione. Ma si rifiuta di vedere che il rapporto con la violenza nell’islam e nel cristianesimo non è identico.
Certo, nel Corano si trovano versetti pacifici; ma altri versetti, che richiamano alla guerra, li contraddicono. La regola islamica vuole che questi versetti più recenti abroghino i più antichi, e perciò talvolta è difficile accettare il fatto che l’islam legittimi la violenza verso gli infedeli».
© «La vie» e per l’Italia «Avvenire» (traduzione di Anna Maria Brogi)
-
-
