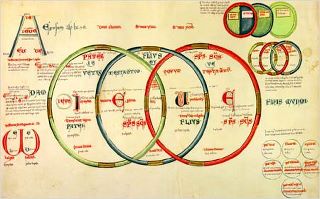
I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! Sulla "autenticità" del suo anello, una recensione senza amore ("charitas") di Gianfranco Ravasi del lavoro di Lessing, curato da Leo Lestingi - a cura di Federico La Sala
- [...] L’anello, lasciato in eredità di generazione in generazione, «giunse alla fine a un padre di tre figli,
tutti e tre ugualmente obbedienti e da lui amati allo stesso modo... Così, con affettuosa debolezza,
egli promise l’anello a tutti e tre». Ma come alla fine assegnarlo? La soluzione è nota: ne fece
cesellare altri due identici e, in punto di morte, chiamò i figli uno per uno e a ciascuno consegnò un
anello. Nessuno dei tre sapeva quale fosse quello vero.
 La metafora è sciolta da Lessing nello spirito
della tipica liberalità illuministica, che animava il nostro autore tedesco e che sarà celebrata anche
dal famoso elogio della tolleranza intessuto da Voltaire. [...]
La metafora è sciolta da Lessing nello spirito
della tipica liberalità illuministica, che animava il nostro autore tedesco e che sarà celebrata anche
dal famoso elogio della tolleranza intessuto da Voltaire. [...]
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- FILOLOGIA: ANTROPOLOGIA PIETRINA - 1 PIETRO, 3. 1-7:
- "Ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν [...] Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ ⸀συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς"
Che illusione affidarsi al «concordismo»
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 01.08.2010)
«Molti anni fa un uomo, in Oriente, possedeva un anello inestimabile, un dono caro. La sua pietra, un opale dai cento bei riflessi colorati, aveva un potere segreto: rendere grato a Dio e agli uomini chiunque la portasse...». Comincia così la parabola che Nathan, un saggio ebreo gerosolimitano, narra al sultano Saladino nel 1192, durante una parentesi delle lotte tra musulmani e cristiani in Terrasanta.
Questa parabola è nota a tutti nel suo esito finale, anche perché secoli prima che Ephraim Lessing nel 1779 la incastonasse nel suo poema drammatico Nathan il saggio, fatto di 3.849 pentapodie giambiche, il nostro Boccaccio l’aveva messa in bocca a "Melchisedech giudeo" nella terza novella della prima giornata del suo Decameron.
L’anello, lasciato in eredità di generazione in generazione, «giunse alla fine a un padre di tre figli, tutti e tre ugualmente obbedienti e da lui amati allo stesso modo... Così, con affettuosa debolezza, egli promise l’anello a tutti e tre». Ma come alla fine assegnarlo? La soluzione è nota: ne fece cesellare altri due identici e, in punto di morte, chiamò i figli uno per uno e a ciascuno consegnò un anello. Nessuno dei tre sapeva quale fosse quello vero.
La metafora è sciolta da Lessing nello spirito della tipica liberalità illuministica, che animava il nostro autore tedesco e che sarà celebrata anche dal famoso elogio della tolleranza intessuto da Voltaire.
I tre monoteismi, incarnati dai tre anelli, devono coesistere in spirito ecumenico e armonico. Sarà ciò che espliciterà il giudice a cui i tre figli ricorrono per dirimere la questione dell’autenticità e, quindi, del primato: «Ognuno di voi ebbe l’anello da suo padre, ognuno di voi sia sicuro che esso è quello vero. Egli vi ha amati ugualmente tutti e tre; non volle, infatti, umiliare due di voi per favorirne uno solo. Sforzatevi di imitare il suo amore incorruttibile e senza pregiudizi! Ognuno faccia a gara per dimostrare alla luce del giorno la virtù della pietra del suo anello! E aiuti questa virtù con la dolcezza, con indomita pazienza, con la carità e con profonda devozione a Dio».
Giustamente nella nuova edizione di questo "dramma di idee", il curatore Leo Lestingi appaia alle parole del giudice un passo del Corano molto significativo di cui il testo di Lessing sembra essere quasi una «riscrittura laica»: «Se Dio avesse voluto, avrebbe fatto una comunità unica, ma ciò non ha fatto per provarvi in quello che vi ha dato. Gareggiate, allora, nelle opere buone perché tutti a Dio tornerete e in quel momento Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia» (5, 46-48).
Non è ora nostro compito illustrare la tesi di Lessing, secondo il quale la vera religione è quella che rende migliore l’uomo, adottando così un parametro veritativo esistenziale, etico e antropologico. Come osserva Lestingi, per lo scrittore tedesco «ciò che conta non è il fatto di essere cristiani, ebrei o musulmani, se ciò porta a oscurare la dignità umana, ma è l’essere uomini; decisivi sono i valori e i compiti di un umanitarismo qualitativo».
Questa concezione esalta, certo, il pluralismo, ribadisce che ogni religione ha un suo frammento di verità, ma anche introduce consequenzialmente una sorta di soggettivismo e persino di relativismo.
Infatti, i tre devono adattarsi a considerare come autentici tutti e tre gli anelli, ignorando la realtà oggettiva per la quale uno solo è l’anello vero. A questo proposito desidererei accennare molto sinteticamente a una questione più attuale e più complessa nelle sue formulazioni teoriche e pratiche.
Intendo riferirmi al dialogo interreligioso che ai nostri giorni ha un rilievo straordinario, soprattutto con l’irruzione della globalizzazione e con l’affacciarsi impetuoso di un monoteismo, quello islamico, nelle nostre città cristiane. Il dialogo tra le religioni è diventato, quindi, anche un nuovo capitolo della teologia contemporanea. Anzi, aveva ragione il teologo Heinz R. Schiette quando, già nel 1963, nel suo saggio Le religioni come tema della teologia osservava che «ci si trova di fronte a un terreno dogmaticamente nuovo, paragonabile alle zone in bianco degli antichi atlanti».
Al tradizionale paradigma dell’ “esclusivismo” (extra ecclesiam nulla salus) si è sostituito quello dell’ “inclusivismo”, suggerito soprattutto dal famoso teologo tedesco Karl Rahner, mentre il Concilio Vaticano II ha dato impulso «al dialogo e alla collaborazione dei cristiani coi seguaci delle altre religioni» (Nostra Aetate 2), così come si sono tentate mediazioni ulteriori tra i due paradigmi citati attraverso la proposta di un cristianesimo "relazionale".
Si è, però, corso anche il rischio di procedere verso la deriva di un pluralismo che in pratica faceva perdere l’identità alla teologia cristiana stingendone, se non estinguendone, il volto proprio. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto paradigma "geocentrico" proposto dal teologo presbiteriano britannico John Hick nelle sue opere Dio e l’universo delle fedi (1973) e Dio ha molti nomi (198o), destinato a cancellare la speciticità cristologica.
In sede meno teorica e più etico-politica - e, quindi, con minore assertività - si è mosso anche il noto Progetto per un’etica mondiale, elaborato nel1990 da Hans Küng (in italiano fu tradotto da Rizzoli nel 2001) e adottato dal "Parlamento delle religioni" di Chicago nel 1993: esso si basava su un consenso morale minimo verso cui le grandi tradizioni culturali e religiose dovevano convergere per essere al servizio dell’humanum, così da creare un mondo «giusto, pacifico e sostenibile».
È significativo notare che Küng rimandava proprio a Lessing, affermando che la bontà o meno di una religione, e quindi la sua "verità", dipende dalla sua promozione autentica della dignità dell’uomo e del bene comune.
Se è vero che il fondamentalismo etnocentrico e integralistico è la negazione esplicita del dialogo interreligioso e dell’ecumenismo, lo sono però anche le forme di sincretismo e relativismo, che più facilmente tentano civiltà stanche e divenute meno identitarie come quelle occidentali.
Anche questo atteggiamento - come quello che propone vaghe religioni "unitarie" su pallidi e inoffensivi denominatori comuni (ne sono esempi le tesi dello storico inglese Arnold Toynbee o del pensatore indiano Vivekananda) - si oppone al vero dialogo. Esso, infatti, suppone nei due soggetti un confronto di identità e di valori, certo per un arricchimento reciproco, ma non per una dissoluzione in una generica confusione o in un appiattimento.
Come l’eccesso di affermazione identitaria può diventare duello non soltanto teorico, ma anche armato, così il concordismo generico può degenerare in un incolore uniformismo o in una "con-fusione" relativistica. Conservare l’armonia della diversità nel dialogo e nell’incontro, come accade nel duetto musicale (che crea armonia pur nella radicale differenza dei timbri di un basso e di un soprano), è la meta di una genuina e feconda esperienza multiculturale, interculturale e interreligiosa.
Lestingi è, comunque, convinto che Lessing «non abbia mai voluto sfilarsi di dosso il cristianesimo come una vecchia tunica logorata, ma ha inteso interpretarlo in maniera nuova e ardita facendogli fare un salto in avanti». Un salto, però, piuttosto rischioso che ha sotto di sé anche il vuoto di uno smarrimento della specificità e dell’autenticità teologica.
Gotthold Ephraim Lessing, «Nathan il saggio», a cura di Leo Lestingi, Palomar, Bari, (via Nicolai, 47), pagg. 246, € 24,00.
- HANNAH ARENDT E IL "SELBSTDENKEN" DI LESSING: «La verità è che io non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa d’altro o
diversa da quello che sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come dire che ero un uomo e non una donna - cioè qualcosa di insensato. [...] ho
sempre considerato la mia ebraicità come uno di quei fatti indiscutibili della mia vita, che non ho mai desiderato cambiare o ripudiare. [...] Ciò che ti confonde è che
le mie argomentazioni e il mio metodo sono diversi da quelli cui tu sei abituato; in altre parole, il guaio è che sono indipendente.
 Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa
tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).
Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa
tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
- "Nuove battaglie. Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna - un’immensa orribile ombra. Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. - E noi - noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!" (F. Nietzsche, "La Gaia Scienza", L. III, fr. 108.).
 L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
 L’"UOMO SUPREMO" DELLA CHIESA CATTOLICA: "Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff.
L’"UOMO SUPREMO" DELLA CHIESA CATTOLICA: "Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff.
- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.
- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo
- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- «Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello» (Papa Francesco, Esortazione Amoris laetitia, n. 183).
 "Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!!
"Deus caritas est". Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante!!!
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
Federico La Sala
Forum
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- ANTROPOLOGIA E STORIA E LETTERATURA: UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS"): NICEA (325-2025).8 giugno 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E FILOLOGIA.
UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS").
STORIA E METASTORIA: AL TEMPO DI DANTE (E DI "AMLETO"), «L’«ENTRÉE D’ESPAGNE», UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).
- "Questo poema è l’opera di gran lunga più importante dell’epica trecentesca d’Italia in lingua francese.. Vigore creativo e spessore culturale ne fanno un monumento letterario autentico, e molto resta ancora da portare alla luce" (A. Limentani). "[...] Disse Feragu [a Rolando]: «Se mi dimostrate / in modo chiaro come fece Dio / a far nascere suo figlio in una donna/ con carne umana - e ne spiegate il motivo -, / e come sua madre si mantenen vergine / sia prima, sia dopo averlo partorito, / oggi mi battezzerò al sacro fonte» (Anonimo Padovano, "L’Entrée d’Espagne", Interlinea edizioni, Novara 2021, pp. 138-139).
- NOTA:
STORIA MEMORIA E STORIOGRAFIA: NICEA 325-2025.
UNA CITAZIONE DAL DISCORSO DI PAPA LEONE XIV AL SIMPOSIO "NICEA E LA CHIESA DEL #TERZOMILLENNIO: VERSO L’UNITÀ CATTOLICA-ORTODOSSA” (4-7 GIUGNO 2025):
"[...] I tre temi del vostro Simposio sono particolarmente rilevanti per il nostro cammino ecumenico. Innanzitutto, la fede di Nicea. Come ha osservato la Commissione Teologica Internazionale nel suo recente Documento per il 1700° anniversario di Nicea, l’anno 2025 rappresenta
- «un’occasione inestimabile per sottolineare che ciò che abbiamo in comune è molto più forte, quantitativamente e qualitativamente, di ciò che ci divide: tutti insieme, noi crediamo nel Dio trinitario, nel Cristo vero uomo e vero Dio, nella salvezza in Gesù Cristo, secondo le Scritture lette nella Chiesa e sotto la mozione dello Spirito Santo. Insieme, noi crediamo la Chiesa, il battesimo, la risurrezione dei morti e la vita eterna» (Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore, 43).
Sono convinto che ritornando al Concilio di Nicea e attingendo insieme a questa sorgente comune, saremo in grado di vedere in una luce diversa i punti che ancora ci separano [...]" (cit.).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- STORIA METASTORIA E ARCHEOLOGIA: MA DI "CHI" E’ IL PIANETA TERRA?! "PENSARE UN ALTRO ABRAMO" (FRANZ KAFKA, 1921).23 maggio 2025, di Federico La Sala
MA DI "CHI" E’ IL PIANETA TERRA?! DEL "PRIMO CHE RECINSE UN PEZZO DI TERRA E DISSE QUESTO E’ MIO" (J.-J. ROUSSEAU)?!
"PENSARE UN ALTRO ABRAMO" (FRANZ KAFKA, 1921). STORIA METASTORIA E ARCHEOLOGIA DELLA "NOSTRA ETÀ" CONTEMPORANEA:
Alla luce delle considerazioni e dell’analisi fatta da Flavio Piero Cuniberto (cfr. "Considerazioni sullo stato di Israele", Fbook, 23 maggio 2025), forse, è bene riconsiderare anche l’ipotesi "letteraria" e la saggia indicazione che ognuno dei tre possessori del famoso "vero" anello della "Paterna Carità" (Leone XIII, "Paterna Caritas") possa pensare per sé, in cuor suo - come ha detto e scritto Franz Kafka (in una lettera al suo amico medico, Robert Klopstock, nel 1921) - "immaginare, concepire, la finzione di un altro Abramo" e, così, andare a sé stesso (Moni Ovadia, "Vai a te stesso"), a "Sé stesso come un altro" (Paul Ricoeur).
-
>LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, E UN PROBLEMA DI LINGUISTICA GENERALE: IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").1 dicembre 2024, di Federico La Sala
LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, UN PROBLEMA ANTROPOLOGICO DI "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE" (SAUSSURE): IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").
Due note a margine di due riflessioni relative alla storia delle idee e all’immaginario biblico della tradizione culturale mediterranea:
- A) Una, di cinque anni fa (1 dicembre 2019), del prof. Franco Lo Piparo;
- B) l’altra, del 26 novembre 2024, del prof. Flavio Piero Cuniberto:
A) SU CATTOLICESIMO E ANTISEMITISMO:
Sollecitati dal recente film di Polanski , “L’ufficiale e la spia”, sul caso Dreyfus molti sono tornati a interrogarsi sulle ragioni dell’irrazionalità delle persecuzioni degli ebrei.
 Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.
Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.
 Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.
Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.- Orémus et pro pérfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non répellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis ténebris eruantur. Per eumdem Dominum. Amen
- «Preghiamo anche per i PERFIDI GIUDEI, affinché Dio nostro Signore tolga il velo dai loro cuori e riconoscano anch’essi Gesù Cristo Signore Nostro. Dio Onnipotente ed eterno che non ricusi la tua misericordia neppure ai PERFIDI GIUDEI, degnati di esaudire le preghiere che ti rivolgiamo per QUESTO POPOLO CIECO, affinché, riconoscendo la luce della tua verità, che è Cristo, siano LIBERATI DALLE LORO TENEBRE.Per NSGC».
Dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti solo nel 1973 la preghiera viene riformulata in maniera radicale:
- «Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome e nella fedeltà della sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo ed alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché IL POPOLO PRIMOGENITO DELLA TUA ALLEANZA possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo Nostro Signore. Amen». (Franco Lo Piparo)
- N0TA:
Chiarissimo prof. Franco Lo Piparo, un ricordo di cinque anni fa che è ancora carico di "radioattività" e sollecita a riflettere: condivido. Tuttavia, detto che "dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti - come egli scrive - solo nel 1973 la preghiera ["per i pefidi giudei"] viene riformulata in maniera radicale" (cit.), non si può non affermare che si resta sempre nell’orizzonte di una vecchia "alleanza" cosmoteandrica, di una concezione molto tragica e poco "olimpica"di una "storia" come quella di Melchisedeck e dei "tre anelli" (del Decamerone" di Boccaccio), e, con essa, della incapacità dell’intera #umanità di pensare - come "principio" - il #Logos e la sua #Armonia ("in-dic-azione", già di Eraclito di Efeso).
Sostenere - come i leader israeliani colpiti da un «mandato d’arresto» - che una condanna dei loro crimini è «antisemitismo», è un gesto di arroganza così sfacciata da sconfinare nella stupidità. (Ed è in questa tenaglia che rischia di consumarsi il «suicidio di Israele» di cui parla Anna Foa).
 E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.
E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.
 Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».
Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».
 I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto).
I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto).- NOTA:
SVEGLIARSI DAL COSMOTEANDRICO #LETARGO (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 94) NARCISISTICO, CONNESSO CON LA "#CADUTA" IN PICCHIATA CON LA "#TESTA" PER "#TERRA", USCIRE DALLO "STATO DI MINORITà" (#KANT, #Koenigsberg 1784 / #Kaliningrad 2024), E #RINASCERE ANTROPOLOGICAMENTE ("SANO E SALVO"), FORSE, E’ ANCORA POSSIBILE....
Federico La Sala
-
>LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, UN PROBLEMA DI LINGUISTICA GENERALE: IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").1 dicembre 2024, di Federico La Sala
LA TERRA, VISTA DALLO SPAZIO, IL DISAGIO NELLA CIVILTA’, UN PROBLEMA DI LINGUISTICA GENERALE: IL "SORGERE DELLA TERRA" ("EARTHRISE").
- Due note a margine di due riflessioni relative alla storia delle idee e all’immaginario biblico della tradizione culturale mediterranea: una, di cinque anni fa (1 dicembre 2019), del prof. Franco Lo Piparo; l’altra, del 26 novembre 2024, del prof. Flavio Piero Cuniberto:
a) SU CATTOLICESIMO E ANTISEMITISMO:
Sollecitati dal recente film di Polanski , “L’ufficiale e la spia”, sul caso Dreyfus molti sono tornati a interrogarsi sulle ragioni dell’irrazionalità delle persecuzioni degli ebrei.
 Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.
Bisogna ricordare, a chi non lo sapesse o volesse dimenticarlo, che la diffidenza verso gli ebrei (etichettati come «deicidi» in alcuni testi) è stata parte non secondaria del senso comune cattolico. Per fortuna ciò appartiene al passato e non tutto il mondo cattolico ne è stato coinvolto.
 Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.
Ricordo che ancora nel 1958 nella liturgia cattolica del Venerdì santo il fedele diceva la preghiera che riporto in latino e in italiano.- Orémus et pro pérfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum.Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam judaicam perfidiam a tua misericordia non répellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis ténebris eruantur. Per eumdem Dominum. Amen
- «Preghiamo anche per i PERFIDI GIUDEI, affinché Dio nostro Signore tolga il velo dai loro cuori e riconoscano anch’essi Gesù Cristo Signore Nostro. Dio Onnipotente ed eterno che non ricusi la tua misericordia neppure ai PERFIDI GIUDEI, degnati di esaudire le preghiere che ti rivolgiamo per QUESTO POPOLO CIECO, affinché, riconoscendo la luce della tua verità, che è Cristo, siano LIBERATI DALLE LORO TENEBRE.Per NSGC».
Dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti solo nel 1973 la preghiera viene riformulata in maniera radicale:
- «Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome e nella fedeltà della sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo ed alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché IL POPOLO PRIMOGENITO DELLA TUA ALLEANZA possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo Nostro Signore. Amen». (Franco Lo Piparo)
- N0TA:
Chiarissimo prof. Franco Lo Piparo, un ricordo di cinque anni fa che è ancora carico di storica "radioattività" e sollecita a riflettere: condivido. Tuttavia, detto che "dopo vari aggiustamenti e rimozioni delle parti più imbarazzanti - come egli scrive - solo nel 1973 la preghiera ["per i pefidi giudei"] viene riformulata in maniera radicale" (cit.), non si può non affermare che si resta sempre nell’orizzonte di una vecchia "alleanza" cosmoteandrica, di una concezione molto tragica e poco "olimpica"di una "storia" come quella di Melchisedeck e dei "tre anelli" (del Decamerone" di Boccaccio), e, con essa, della incapacità dell’intera #umanità di pensare - come "principio" - il #Logos e la sua #Armonia ("in-dic-azione", già di #Eraclito di #Efeso).
Sostenere - come i leader israeliani colpiti da un «mandato d’arresto» - che una condanna dei loro crimini è «antisemitismo», è un gesto di arroganza così sfacciata da sconfinare nella stupidità. (Ed è in questa tenaglia che rischia di consumarsi il «suicidio di Israele» di cui parla Anna Foa).
 E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.
E’ come dire che il Popolo Eletto non PUO’ commettere alcun crimine perché è «legibus solutus» come il sovrano hobbesiano, al di sopra di ogni legge umana e divina, e che se mai è razzista chi pretende di condannare crimini a loro dire inesistenti.
 Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».
Il vero ebreo, l’ebreo pensoso che non straparla e non bestemmia con la parola Elezione ma ne porta il peso, sa quanto è assillante il rischio di deviare dalla Via, di allontanarsi dalla Legge, il rischio eterno dell’«adulterio» (essendo l’Elezione un’idea nuziale, l’idea di un esigentissimo eros divino) e della «vendetta» di un Dio giusto e «geloso» (che è poi, più in profondità, la legge metafisica di chi si allontana dalle «acque nutrienti» e si perde nel nulla). Il rischio insomma di «profanizzare» Israele, trasformando il mistero dell’«elezione» nel peggiore dei suprematismi etnici. Già il pensoso Scholem la temeva negli anni ’30, quella «vendetta».
 I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto
I profeti biblici sarebbero inorriditi di fronte a questi pseudo-nipoti in puro delirio. Un nuovo Elia, forse, evocherebbe la pioggia di fuoco non più sui culti fenici ma su quel capolavoro di empietà arrogante che è l’attuale politica israeliana (longa manus, fin dall’inizio, del più cinico espansionismo anglosassone). (Flavio Piero Cuniberto- NOTA:
SVEGLIARSI DAL COSMOTEANDRICO #LETARGO (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 94) NARCISISTICO, CONNESSO CON LA "#CADUTA" IN PICCHIATA CON LA "#TESTA" PER "#TERRA", USCIRE DALLO "STATO DI MINORITà" (#KANT, #Koenigsberg 1784 / #Kaliningrad 2024), E #RINASCERE ANTROPOLOGICAMENTE ("SANO E SALVO"), FORSE, E’ ANCORA POSSIBILE....
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- ARTE IMMAGINAZIONE ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA: PER UNA PENTECOSTE IN UN PIANETA TERRA IN FIORE:21 maggio 2024, di Federico La Sala
PER UNA PENTECOSTE IN UN PIANETA TERRA IN FIORE: COME NASCONO I BAMBINI (20MAGGIO2024).
ARTE IMMAGINAZIONE ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA...
- Una nota in memoria di #GioacchinodaFiore e di #GianniVattimo
"DIVINA COMMEDIA" (#DANTE2021). Flavio Piero Cuniberto, in una nota di commento all’opera di "Andrea Orcagna (e Jacopo di Cione), Pentecoste, 1362-1365; Firenze, Gallerie dell’Accademia" intitolata "La pentecoste fiorentina", scrive e sollecita a pensare:
- "Non è un pittore simpatico, Andrea di Cione detto l’Orcagna. E’ arcigno, l’Orcagna (un po’ come il suo affine senese Taddeo di Bartolo). Ha un umore aspro, severo, austero, che non gli impedisce però di prodigare una mirabile raffinatezza nella veste rosa-arancio della Vergine e in quel tappeto fiorito, tra le figure scultoree degli Apostoli. Né gli impedisce la trovata geniale di presentarla, la Vergine, come in levitazione, sollevata da terra, perché è Lei la prima destinataria di quel Fuoco spirituale. Ed è così. Dal giorno della Pentecoste la Chiesa o è mariana o non è: come se l’opera dello Spirito si compisse nuovamente in lei , dopo il giorno lontano dell’Annuncio.
- Il vaso fiorito, o il ramo di giglio offerto dall’Arcangelo, è diventato una fiamma che non si estingue.Il vaso fiorito, o il ramo di giglio offerto dall’Arcangelo, è diventato una fiamma che non si estingue" (cit.).
Ma, una domanda (una "question" hamletica) sorge "spontanea", come mai nella tradizione iconografica dell’altro "Vas d’elezione" (dell’altro «strumento della scelta»), lo sposo di Maria ( la stessa Madre di Gesù e della Chiesa della intera "umanità", la nuova #Eva) quello con l’altro ramo del #giglio, quello "offerto dall’Arcangelo" proprio di colui che è il "Vero_giglio", il "Vir_gilio", l’Uomo ("Vir") con il ramo altrettanto fiorito, il #padre di #Gesù, quel "#Giuseppe", della "casa di Davide" ("de domo David"), e si parla solo del "Vas" paolino (Atti ap., IX, 15)?!
A che edipico gioco giochiamo? Non ha forse ragione #DanteAlighieri ("io non Enea, io non Paulo sono ") con la sua "Monarchia" dei #DueSoli, Shakespeare con il suo "Amleto, #Nietzsche con il suo "Zarathustra"?! E #Freud con la sua "Interpretazione dei sogni?! Jakob #Böhme, cosa pensava del tempo in cui allo #sposo sarà possibile finalmente incoronare la #sposa, non pensava a un nuovo "mondo #possibile", a un #sorgeredellaTerra (#Earthrise), e a #Gioacchino da Fiore - per "caso", per "#charitas"?
NOTE:
- LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DELLA CHIESA CATTOLICA E IL PROBLEMA (DELL’ANDROCENTRISMO) DEL "CORPO MISTICO" DI "CRISTO" (#NICEA, 325-2025).
 Papa Paolo VI, rivolgendosi ai padri conciliari del Vaticano II, dichiarò che Maria Santissima è la Madre della Chiesa.
Papa Paolo VI, rivolgendosi ai padri conciliari del Vaticano II, dichiarò che Maria Santissima è la Madre della Chiesa.
 La Vergine Maria è la Madre di tutti gli uomini e specialmente dei membri del Corpo Mistico di Cristo, poiché è la Madre di Gesù per l'#Incarnazione. Gesù stesso lo confermò dalla Croce prima di morire, dandoci sua Madre come nostra madre nella persona di San Giovanni dicendo: "Donna, ecco tuo figlio!". E poi: "Ecco tua madre!". Ecco perché la pietà della Chiesa verso la Beata Vergine è un elemento intrinseco del culto cristiano. Adempiendo così la profezia della Vergine, che ha detto: "Tutte le generazioni mi chiameranno beata" [..." class="spip_out">20 MAGGIO 2024, Commemorazione della "Madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa" ( https://www.santodelgiorno.it/maria-madre-della-chiesa/ ).
La Vergine Maria è la Madre di tutti gli uomini e specialmente dei membri del Corpo Mistico di Cristo, poiché è la Madre di Gesù per l'#Incarnazione. Gesù stesso lo confermò dalla Croce prima di morire, dandoci sua Madre come nostra madre nella persona di San Giovanni dicendo: "Donna, ecco tuo figlio!". E poi: "Ecco tua madre!". Ecco perché la pietà della Chiesa verso la Beata Vergine è un elemento intrinseco del culto cristiano. Adempiendo così la profezia della Vergine, che ha detto: "Tutte le generazioni mi chiameranno beata" [..." class="spip_out">20 MAGGIO 2024, Commemorazione della "Madre dei fedeli e dei pastori della Chiesa" ( https://www.santodelgiorno.it/maria-madre-della-chiesa/ ).
- STORIA E LETTERATURA, ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA BIBLICA: JAKOB BOEHME E "LA STORIA DI GIUSEPPE". Sul tema, una citazione dalla nota dello storico della filosofia Valerio Verra:
- "Al termine di una vita tutta dedicata ad approfondire e sviluppare un’intensa esperienza religiosa e speculativa, #Jakob #Böhme (1575-1624) raccoglie e condensa nel #Mysterium #Magnum (1623) il frutto delle sue meditazioni sul primo libro di #Mosè. L’opera è destinata a spiegare la rivelazione della parola divina, , la creazione, il regno della natura e della grazia, affinché l’uomo possa giungere a comprendere meglio che cosa sia Adamo e che cosa sia Cristo, come debba considerare se stesso nella luce della natura e in che cosa consista la sua vita temporale ed eterna. Contro le forme di interpretazione dottrinale ed erudita che minacciavano di ridurre l’incontro vivificante con la Scrittura a semplice decifrazione storico-filologica di una « lettera» morta e mortificante, Bohme propone una lettura della Genesi fondata sullo sforzo di riportare il testo sacro alla tensione insieme storica ed eterna tra l’uomo caduto e l’uomo redento.
 Rivelazione e redenzione vengono viste così in un quadro che è insieme cosmico e storico e nel quale confluiscono e si intrecciano in una sintesi non sempre perspicua, ma per molti aspetti suggestiva, motivi mistici ed alchimistici, teosofici e naturalistici, che avranno notevole risonanza anche nel romanticismo e nell’idealismo tedesco. Alla grandiosità dello scenario e alla complessità dei contrasti nei suoi elementi corrisponde un linguaggio ricco di immagini e di simboli inteso a ricreare con forza poetica e profetica insieme quel legame profondo tra microcosmo e macrocosmo - motivo anche questo assai caro all’« età di Goethe» - dal quale soltanto l’anima può trarre la forza per comprendere il proprio destino di salvezza e riesprimere con parola visibile la parola invisibile da cui deriva ed è sostanziata l’intera creazione. Nei personaggi e negli eventi biblici si possono così ravvisare « figure » che anticipano ed esprimono il senso tanto di ogni singolo uomo quanto dell’intera umanità e cristianità.
Rivelazione e redenzione vengono viste così in un quadro che è insieme cosmico e storico e nel quale confluiscono e si intrecciano in una sintesi non sempre perspicua, ma per molti aspetti suggestiva, motivi mistici ed alchimistici, teosofici e naturalistici, che avranno notevole risonanza anche nel romanticismo e nell’idealismo tedesco. Alla grandiosità dello scenario e alla complessità dei contrasti nei suoi elementi corrisponde un linguaggio ricco di immagini e di simboli inteso a ricreare con forza poetica e profetica insieme quel legame profondo tra microcosmo e macrocosmo - motivo anche questo assai caro all’« età di Goethe» - dal quale soltanto l’anima può trarre la forza per comprendere il proprio destino di salvezza e riesprimere con parola visibile la parola invisibile da cui deriva ed è sostanziata l’intera creazione. Nei personaggi e negli eventi biblici si possono così ravvisare « figure » che anticipano ed esprimono il senso tanto di ogni singolo uomo quanto dell’intera umanità e cristianità.
 Di questo grande affresco biblico è presentata qui l’ultima parte che tratteggia ed interpreta la storia di Giuseppe, una figura che non ha mancato di affascinare anche grandi artisti, da #Goethe a #ThomasMann. Giuseppe rappresenta per Bohme l’intera condizione del cristiano di fronte a Dio e al mondo e la sua storia ci insegna come #Adamo possa diventare #Cristo o, meglio, come Cristo assuma in sé la natura umana caduta per rigenerarla [...]. La storia di Giuseppe si conclude con il Testamento di #Giacobbe dove il processo di redenzione si dispiega come una vera e propria teologia della storia in cui Bohme, nella linea delle grandi interpretazioni delle diverse epoche in chiave biblica e profetica, descrive simbolicamente, attraverso il destino delle tribù di Israele, « tutto il tempo che dura il mondo da Adamo alla fine»." (Valerio Verra).
Di questo grande affresco biblico è presentata qui l’ultima parte che tratteggia ed interpreta la storia di Giuseppe, una figura che non ha mancato di affascinare anche grandi artisti, da #Goethe a #ThomasMann. Giuseppe rappresenta per Bohme l’intera condizione del cristiano di fronte a Dio e al mondo e la sua storia ci insegna come #Adamo possa diventare #Cristo o, meglio, come Cristo assuma in sé la natura umana caduta per rigenerarla [...]. La storia di Giuseppe si conclude con il Testamento di #Giacobbe dove il processo di redenzione si dispiega come una vera e propria teologia della storia in cui Bohme, nella linea delle grandi interpretazioni delle diverse epoche in chiave biblica e profetica, descrive simbolicamente, attraverso il destino delle tribù di Israele, « tutto il tempo che dura il mondo da Adamo alla fine»." (Valerio Verra).
- "Il #Protovangelo (apocrifo) di #Giacomo ci parla [..." class="spip_out">IL MATRIMONIO DI GIUSEPPE E MARIA “del bastone fiorito di San Giuseppe” [...]: «Indossato il manto dai dodici sonagli, il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò a riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un angelo del Signore, dicendogli: “Zaccaria, Zaccaria! Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno porti un bastone: sarà la moglie di colui che il Signore designerà per mezzo di un segno”. Uscirono i banditori per tutta la regione della Giudea, echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero. Gettata l’ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portando i bastoni. Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a pregare. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li restituì loro; ma in essi non v’era alcun segno. Giuseppe prese l’ultimo bastone: ed ecco che una colomba uscì dal suo bastone e volò sul capo di Giuseppe. Il sacerdote disse allora a Giuseppe: “Tu sei stato eletto a ricevere in custodia la vergine del Signore”»[...]" (cfr. Antonio Tarallo, "San Francesco", 23-01-2021).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- LA "MONARCHIA" DI DANTE ALIGHIERI CON LA SUA CITAZIONE DA "SALMI 1.3": "Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, /che darà frutto a suo tempo /e le sue foglie non cadranno mai; / riusciranno tutte le sue opere"18 aprile 2024, di Federico La Sala
"DUE SOLI", A #GLORIA E A #MEMORIA DI #DANTE, UN "#ALBERO" SEMPRE VERDE DEL #PIANETATERRA:
#ENIGMISTICA #CRUCIVERBA, #FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA #POLITICA.
Una breve nota alla parte iniziale del primo capoverso del Libro Primo del capitolo I della #Monarchia di #Dante Alighieri:
- "Gli uomini tutti, cui la natura superiore ha infuso l’impulso ad amare la verità, sembrano dare il massimo valore al fatto di lavorare per i posteri, onde questi ricavino un arricchimento dalle loro fatiche, così come essi stessi sono stati arricchiti dal lavoro degli antichi. Stia quindi pur certo di aver mancato al proprio dovere colui che, dopo aver fruito di tanti insegnamenti forniti dalla società, non si cura poi a sua volta di recare qualche contributo al bene comune: egli infatti non è un “albero che lungo il corso delle acque porta frutti nella sua stagione” [Salmi, 1.3], ma piuttosto è una voragine perniciosa che ingoia sempre senza mai restituire quanto ha ingoiato. Perciò, ripensando spesso fra me queste cose e non volendo un giorno essere tacciato di aver colpevolmente sotterrato il mio talento, desidero non solo accrescere la mia cultura, ma anche portare frutti per il bene pubblico, dimostrando delle verità che altri non hanno mai affrontato. [...]" (cfr. Dante Alighieri, "Monarchia", in "Opere minori di Dante Alighieri", vol. II, #UTET, Torino, 1986).
RILEGGENDO #OGGI QUESTE CHIARISSIME PAROLE DI AVVIO DEL "DISCORSO" E, CONTEMPORANEAMENTE, GUARDANDO DAL #TEMPO IN CUI è stata scritta l’Opera, appunto, la #Monarchia, non c’è che da riferire allo stesso Autore , cioè #DanteAlighieri, la "visione profetica" incorporata nella citazione dei versi ripresi dal testo biblico: "Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, /che darà frutto a suo tempo /e le sue foglie non cadranno mai; / riusciranno tutte le sue opere" (Salmi, 1.3); RINGRAZIARLO E, POSSIBILMENTE, CERCARE DI CAPIRE MEGLIO LA SUA PROPOSTA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA, SINTETIZZABILE NELLA #FORMULA PARADIGMATICA DEI "#DUE SOLI".
***
"DUE SOLI" IN #TERRA, E UN SOLO #SOLE IN CIELO: "#TRE SOLI". #GENERE UMANO: "I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE"! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- UNA "CADUTA", UNA "MITICA" PRODUZIONE DI INFINITI ANELLI DI RECINZIONI, E DELL’ AMORE "CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE #STELLE" (#DANTEALIGHIERI).8 aprile 2024, di Federico La Sala
ALL’ORIGINE DEL #DISAGIO DELLA #CIVILTA’ #EUROPEA,
- UNA CADUTA E UNA "MITICA" PRODUZIONE DI INFINITI #TREANELLI DI #RECINZIONI ("#ENCLOSURES") DELLA #TERRA (J. - J. #ROUSSEAU) E DELL’#AMORE CHE MOVE IL #SOLE E LE ALTRE #STELLE" (#DANTEALIGHIERI). *
Così #SigmundFreud nel suo lavoro "L’infelicità nella civiltà ("Das Ungluck in der Kultur"): "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]" (S. #Freud, Il disagio della civiltà, 1929).
* I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO
Nota:
- Jean-Jacques #Rousseau, "L’#origine della #disuguaglianza": "[... Il primo che, recintato un terreno, ebbe l’idea di dire: Questo è mio, e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre, assassini, quante miserie ed orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: Guardatevi dall’ascoltare quest’impostore; siete perduti, se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno. Ma con ogni probabilità allora le cose erano già arrivate al punto da non poter continuare come prima; infatti questa idea di proprietà, in quanto dipende da molte idee che la precedono e che son potute nascere solo gradualmente, non si formò all’improvviso nello spirito umano: si dovettero fare molti progressi, acquisire molte abilità e conoscenze, trasmetterle ed accrescerle di epoca in epoca, prima di arrivare a questo estremo limite dello stato di natura. [...]" (Jean-Jacques Rousseau, "Sull’origine dell’ineguaglianza", a cura di V. Gerratana, Roma, Editori Riuniti,1968)
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI: UNA QUESTIONE DI LOGOS (NON DI LOGO).20 marzo 2023, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE DI LOGOS (NON DI LOGO) E DI ANTROPOLOGIA (NON DI ANDROLOGIA).
 APPUNTI:
APPUNTI:A)
"IL PROFETA GIUSEPPE" è L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI.
«Josephologie»: pochi anni fa (2007) è stato pubblicato un importante studio di #MassimoCampanini sul patriarca di Israele e sul profeta del Corano, forse, è opportuno ri-leggerlo. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della hChiesacattolica dell’altro Giuseppe, quello del cristianesimo, che dà il nome "Gesù" a suo figlio?!
B) IL PROBLEMA DEI "TRE ANELLI" E L’ANELLO DELLE "RECINZIONI" (ENCLOSURES): L’AMORE EVANGELICO (CHARITAS, gr. #XAPITAS) E "IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (S. FREUD, 1929).
La "question" (Shakespeare, "Amleto"), nella sua semplicità, richiama la questione antropologica (della buona madre e del buon padre) e la questione teologica: "In principio era il Logos" (non il logo dell’alleanza edipica del furbo e della furba di turno).
C) L’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO, LA FILOLOGIA, E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO"), OGGI:
- "CHI È QUESTO FIGLIO DELL’UOMO?" (Gv. 12, 34).
RESTITUIRE A SAN GIUSEPPE ONORE E GLORIA. UNA INDICAZIONE E UNA EREDITÀ DI TERESA D’AVILA:
- "La devozione a san Giuseppe, a livello personale e locale, si viveva fin dalla venuta dei carmelitani in Europa, anche se la festa del santo Patriarca, a livello di Ordine, non appare sino alla seconda metà del XV secolo.
- Tale devozione nel Carmelo teresiano, va essenzialmente unita a santa Teresa. È uno dei legati più ricchi e caratteristici che la Santa lasciò ai suoi figli. Non si comprende il Carmelo teresiano senza san Giuseppe, senza l’esperienza giuseppina della Santa. Per la Santa Madre, i conventi che fonda, a immagine del primo (#Avila 1562), sono ‘case’ di san Giuseppe. Per questo procura che la maggior parte di essi porti il nome e titolo di san Giuseppe.
- Dei diciassette, fondati dalla Santa, undici stanno sotto il titolo di san Giuseppe. Se non tutte le fondazioni della Santa Madre portano quel titolo, non ce n’è nessuna dove non ci sia un’immagine del Santo che presieda e protegga la comunità. È un’ulteriore manifestazione, più della sua devozione ed esperienza giuseppina, il diffondere nei conventi le immagini del santo, la maggior parte delle quali ancora si conserva.
- È da notare, a questo riguardo, il dato che portava con sé in tutte le fondazioni, una statua di san Giuseppe, che riceveva il titolo di “Patrocinio di san Giuseppe” [...]". (Cfr. Antonio Faita, "Un inedito di Giuseppe Sarno: san Giuseppe con Gesù Bambino presso la chiesa teresiana di Gallipoli", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2020).
D) Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo #Buonarroti e al suo "Tondo Doni" e al suo "Mosè", forse, è bene ed è tempo di riproblematizzare la questione antropologica ("Ecce Homo", non "Ecce Vir") e portarsi oltre la cosmoteandria del cattolicesimo costantiniano (Nicea 325 - 2025). Uscire dall’inferno epistemologico. Se non ora, quando?!
E) B) STORIA STORIOGRAFIA ED ECUMENISMO: L’EUROPA E COSTANTINOPOLI. Riprendendo il filo dalla #Dotta Ignoranza (Niccolò Cusano, 1440), la "Donazione di Costantino" (Lorenzo Valla, 1440), e dall’assedio e caduta di Costantinopoli (1453) e il fallimento della proposta "cristologica" del "De pace fidei" (N. Cusano, "La pace della fede", 1453), non è forse tempo di correre ai ripari, di ristrutturare il campo e riequilibrare la bilancia antropologica?!
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---EUROPA2023: DANTE, GIORDANO BRUNO, GALILEO, E KEPLERO, A PRAGA, NELLA "CASA DEI DUE SOLI".20 gennaio 2023, di Federico La Sala
DANTE E LA TEORIA DEI "TRE SOLI":
- COSMOLOGIA,TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA (oltre la cosmoteandria teologico-politica dei "due poteri").
"OCEANO CELESTE" (KEPLERO, 1611). Per non buttare il #bambino (Dante Alighieri) con l’acqua sporca ("Dante è di destra"), un invito storiografico a riprendere la navigazione nella #nave di Galileo (quella del "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano", 1632) e rileggere Giordano Bruno:
FILOLOGIA E FILOSOFIA. Da ricordare che la ’casa’ di Dante Alighieri (la sua opera, la "Monarchia") era la "Casa dei Due soli", e ogni "potere" era non l’accoppiata "platonica" di un servo e di un signore, ma "due in uno" (al contempo, re e sacerdote) alla #luce del Sole - non di un solo Sole (come pretendeva Tommaso Campanella con la sua "Città del Sole" e le varie "monarchie" cosmoteandriche). Dante, a mio parere, è in sintonia con lo spirito di Giordano Bruno e le "TRE CORONE" dello "Spaccio de la Bestia trionfante" e con Keplero che a Galileo Galilei, e al suo "Sidereus Nuncius" (1610). da Praga (1611) quasi grida: "VICISTI, GALILAEE" ("HAI VINTO GALILEO")!
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" ---- I "TRE SCRIGNI" E IL "MERCANTE DI VENEZIA" (SHAKESPEARE). La favola del buon consumo (di Luigino Bruni).2 ottobre 2022, di Federico La Sala
Radici di futuro/5.
La favola del buon consumo
di Luigino Bruni (Avvenire, domenica 2 ottobre 2022
Per cogliere l’essenziale di una civiltà, la sua arte è sempre strada maestra. Il Mercante di Venezia di William Shakespeare, da solo dice quasi tutto sulla nascita dello spirito del capitalismo. Siamo alla fine del Cinquecento, a Londra. Shakespeare è nella sua maturità artistica. Viene in contatto, ancora una volta, con materiali narrativi italiani. In particolare con la novella "Il pecorone", di Ser Giovanni Fiorentino, composta attorno agli anni ottanta del Trecento, dove ci sono tutti gli elementi del Mercante di Venezia, incluso il centro narrativo della tragedia: la penale di carne prevista dal contratto tra il ricco mercante di Venezia (Ansaldo) e l’usuraio ebreo di Mestre (novella I). Elio Toaf, nel 1966, ha poi riportato un fatto realmente accaduto a Roma (narrato da G. Leti nel 1852) durante il pontificato di Sisto V (1585-1590): Paolo M. Secchi, mercante romano, aveva scommesso una libbra della sua carne con il «giudeo» Sansone Ceneda, un episodio forse conosciuto anche a Londra.
La trama del Mercante di Shakespeare è nota. Bassanio, giovane scialacquatore, ha bisogno di 3mila ducati per poter partecipare a una sorta di concorso amoroso (i "tre scrigni") e poter sposare la ricca e bella Porzia. Si rivolge così al suo amico Antonio, un ricco mercante di Venezia (che, forse, dà il nome all’opera), che non avendo i contanti ma amando follemente Bassanio, cerca di ottenere i denari da un noto usuraio di Rialto: l’ebreo Shyloch. Questi però non gli propone un normale contratto usuraio a interesse. Gli fa un’offerta bizzarra e tremenda: se non restituirà il denaro alla scadenza, l’usuraio preleverà come penale «una libbra della vostra bella carne, su quella parte del corpo che mi piacerà di scegliere». Antonio accetta - sul seguito della storia ci soffermeremo domenica prossima.
Perché un tale contratto? Perché presentare questo usuraio come un carne-fice? Si è molto discusso sulla presenza di un sentimento antisemita in quest’opera. In realtà Shakespeare registra i sentimenti del suo tempo senza esprimere un suo proprio giudizio sul tema - nelle opere d’arte, soprattutto nei capolavori, la descrizione del mondo è la prima critica dell’artista. Studiando quest’opera, e guardandola con gli occhi dell’economista quale sono, mi sono convinto che il giudizio etico di Shakespeare si possa rintracciare, e forse ci sorprenderà. È verosimile che il Mercante contenga una descrizione e una critica del proto-capitalismo di Venezia e, soprattutto, della "sua" Londra.
Shyloch è figura complessa e ambivalente. Una prima chiave di lettura la troviamo nel dialogo iniziale con Antonio, il mercante debitore: «Shyloch: "Ma, udite; mi parve diceste che voi non prestate mai né prendete a prestito con frutto". Antonio: "No, mai"». Antonio era un mercante che svolgeva anche attività bancaria, ma si vantava di prestare senza interessi. Infatti, quando lo vede, Shyloch pensa: «"Come ha l’aspetto di un ipocrita pubblicano! Lo odio perché è cristiano, e lo odio anche più perché nel suo umile candore presta denaro gratis, e fa così scendere a Venezia il tasso d’interesse».
Una prima tensione narrativa: da una parte l’usuraio ebreo e dall’altra il filantropo cristiano. I due si conoscevano: «Shyloch: "Inveisce contro di me, contro i miei leciti guadagni che lui chiama usura"». Antonio lo offende quindi nella piazza di Rialto. Inoltre - dato importante - Antonio non presta a interesse, eppure ora sta accettando un contratto usuraio. Ed è qui che troviamo una prima chiave di lettura. Shyloch cita la Bibbia, riporta il noto episodio dell’astuzia di Giacobbe grazie alla quale si arricchì presso il suocero Labano, un pagano (Genesi, cap. 30). Antonio commenta: «"E che c’entra? Giacobbe prese interessi?". Shyloch: "Non erano interessi diretti, come dite voi"».
 L’ebreo spiega allora quell’episodio centrale nella storia d’Israele e nella storia del Mercante di Venezia. Labano vuole liquidare il salario di Giacobbe per il servizio resogli, ma la prima importante risposta di Giacobbe fu: "Non mi devi dare nulla" (Gn 30,31). Una risposta che somiglia al "gratis" di Antonio. Giacobbe e Labano stipulano poi un contratto bizzarro che al lettore appare quasi una burla, non troppo dissimile dal contratto tra Shyloch e Antonio: stabiliscono che tutti gli agnelli nati con il manto striato sarebbero stati di Giacobbe, gli altri di Labano. Il lettore sapeva che in un gregge gli agnelli striati sono molto pochi, quindi si immagina che il contratto sfavorisca Giacobbe, e pensa che quel suo "non voler nulla" fosse quasi vero. E invece ecco il colpo di scena.
L’ebreo spiega allora quell’episodio centrale nella storia d’Israele e nella storia del Mercante di Venezia. Labano vuole liquidare il salario di Giacobbe per il servizio resogli, ma la prima importante risposta di Giacobbe fu: "Non mi devi dare nulla" (Gn 30,31). Una risposta che somiglia al "gratis" di Antonio. Giacobbe e Labano stipulano poi un contratto bizzarro che al lettore appare quasi una burla, non troppo dissimile dal contratto tra Shyloch e Antonio: stabiliscono che tutti gli agnelli nati con il manto striato sarebbero stati di Giacobbe, gli altri di Labano. Il lettore sapeva che in un gregge gli agnelli striati sono molto pochi, quindi si immagina che il contratto sfavorisca Giacobbe, e pensa che quel suo "non voler nulla" fosse quasi vero. E invece ecco il colpo di scena.Giacobbe trova un espediente (non fa quindi un furto): mentre le pecore più robuste si accoppiavano le metteva di fronte a delle verghe da lui scorticate con striature verticali, in modo - pensava - che guardando pali striati le pecore partorissero agnelli striati (Gn 30,39). L’espediente funzionò, gli agnelli migliori nacquero striati, e Giacobbe divenne molto ricco.
Il riferimento a questo episodio della Genesi è cruciale nell’economia del Mercante di Venezia (trascurato dagli interpreti). Innanzitutto, nella saga di Labano e Giacobbe, il disonesto è il suocero, che continua a non rispettare i patti (li cambiò «dieci volte»: Gn 31,5). L’imbroglione è il pagano: Giacobbe qui è solo furbo e astuto ma, a modo suo, rispetta i patti. Inoltre, Giacobbe non prese il suo salario sotto forma di denaro: prese pecore, che però furono per lui un profitto molto maggiore del salario in denaro. E Antonio chiede: «Vorreste trar da ciò qualche deduzione in favore dell’usura? Il vostro oro e il vostro argento è simile alle pecore e alle capre di Giacobbe?». In realtà la risposta è: le tue pecore lo sono. Shyloch stava infatti dicendo ad Antonio: non c’è nessuna differenza etica tra le tue "pecore" (i tuoi guadagni dai commerci) e i miei interessi sul denaro. Siamo uguali, ma tu sei ipocrita e imbroglione, come Labano, pagano come te.
Ma il senso ultimo della citazione di Giacobbe emerge alla fine: «Il suo era un modo di prosperare [thrive] e Giacobbe fu benedetto: la prosperità [thrift] è benedizione, a meno che non sia un furto». Thrift in inglese non significa profitto né tantomeno usura; significa invece prosperità, beneficio, vantaggio, persino parsimonia, e non ha quindi una accezione negativa. Per l’etica di Shyloch prosperare con la furbizia è benedizione, non è un furto né un comportamento moralmente detestabile. E se fosse questa anche l’etica di Shakespeare?
C’è infatti un secondo elemento altrettanto importante. Ciò che potrebbe essere moralmente condannabile era la prodigalità di Bassanio: «Tu non ignori, Antonio, quanto io abbia dissestato il mio patrimonio conducendo un tenore di vita molto più fastoso dei miei mezzi». Infatti, a guardar bene, nell’opera gli ossessionati dal denaro sono i cristiani (Bassanio su tutti). Shyloch chiede una libbra di carne, di nessun valore economico - il suo spirito è simile a quello di Mazzarò verso la sua "roba".
Le domande della commedia-tragedia diventano: perché prestare denaro a interesse dovrebbe essere più immorale del profitto di un mercante?: «Mi chiamate miscredente, cane assassino... e tutto per l’uso che faccio di ciò che è mio?». E perché, invece, gli scialacquatori come Bassanio sono amici, amati e rispettati? È etico poi per Antonio rischiare la propria carne per soddisfare i capricci di un amico prodigo? Da quale parte sta, allora, l’etica buona?
Ecco dunque una prima conclusione. Con il Mercante siamo in un momento di svolta dell’etica economica nella nascita del capitalismo - va notato che la parola usata per il contratto della libra di carne è «bond».
In questo dialogo-conflitto tra Shyloch e Bassanio ci sono molte radici della modernità. C’è il seme del "vangelo della prosperità", ideologia centrata sulla benedizione della ricchezza che oggi è di nuovo di moda, soprattutto nei Paesi di cultura protestante. C’è anche una radice di quella visione romantica del denaro che è buono solo se viene speso, di una ricchezza etica solo se è consumata, non importa se quel denaro è preso a prestito da istituzioni finanziarie che condanniamo. Vi si trova pure una icona del declino del primo proto-capitalismo italiano del Rinascimento. L’Italia, infatti, che entrò nell’Inghilterra puritana non era più quella dei mercanti parsimoniosi del Trecento. Era invece quella di Francesco Benni: «Non c’è più bella vita al mondo di un debitore, fallito, rovinato e disperato. Questi è colui che si può dir beato. Fate, parente mio, pur de gli stocchi [prestiti], pigliate spesso a credenza, a ’nteresse, e lasciate ch’agli altri il pensier tocchi: perché la tela ordisce uno, l’altro la tesse» (In lode del debito, 1548).
Il Mercante è un’opera cerniera tra due mondi. Nella Londra elisabettiana di Shakespeare era ancora viva un’etica feudale cristiana che lodava il consumo, la terra, la nobiltà, che permetteva il prendere in prestito, ma condannava il dare a prestito - è davvero curioso che alla condanna del prestito a usura non corrisponde una altrettanto ferma condanna del debito a usura, pratica molto più popolare e diffusa. Quell’etica cristiana approvava il debito per il lusso, e stimava i mercanti come Antonio che accumulavano grandi ricchezze nei commerci e potevano permettersi anche di prestare gratis, ma condannava e malediceva il prestito a interesse di ebrei che con il loro denaro consentivano ai mercanti cristiani di arricchirsi e fare beneficenza e lussi: «Come ha l’aspetto di un ipocrita pubblicano». Chi prestava denaro era "come Giuda", chi lo prendeva in prestito per il consumo o per gli affari era invece un "buon cristiano", imitava la "Maddalena" che "sprecò" un profumo dal valore di 300 denari. Non capiamo l’Europa moderna senza queste ambivalenze e ipocrisie, e pochissimi come Shakespeare ce lo fanno vedere con una chiarezza aurorale.
Nella prima parte del Mercante l’ambivalenza decisiva è dunque quella tutta interna a Shakespeare e alla sua età, combattuto tra il vecchio mondo e il nuovo spirito capitalista. Fino al contratto di carne, la tragedia-commedia è ancora tutta aperta: quale delle due etiche prevarrà alla fine?
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- IL "GIOCO" DELLA TUNICA DEI "GIOCATORI DI DADI": IMPARARE A CONTARE. "UNO. IL BATTITO INVISIBILE". Note a margine del libro di Giulio Busi.26 gennaio 2022, di Federico La Sala
IMPARARE A CONTARE! "UNO. IL BATTITO INVISIBILE". Note a margine del libro di Giulio Busi *
RICOMINCIARE DA CAPO, DALLA COSTITUZIONE: UNO NON EQUIVALE UNO (=1), MA RENDE POSSIBILE E FONDA OGNI - UNO (= 1). IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS, NON UN LOGO! TRACCE PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA....
NONOSTANTE GIOACCHINO DA FIORE, NONOSTANTE DANTE ALIGHIERI (E LA DIVINA COMMEDIA) , NONOSTANTE GIOVANNI BOCCACCIO (E LA MEMORIA DI MELCHISEDEC E DEI TRE ANELLI), NONOSTANTE MICHELANGELO (E IL SUO TONDO DONI), NONOSTANTE LESSING (E IL SUO ELOGIO DEL SAGGIO NATHAN), NONOSTANTE FREUD E NONOSTANTE EINSTEIN ....
...SI VIVE ANCORA NEL REGIME DELL’UNO (= 1) E DELLA "DOTTA IGNORANZA" (1440) E DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA?!
"Dio non gioca a dadi" ma, dopo la lezione di Georges de La Tour (cfr. Giulio Busi, "Uno. Il battito invisibile": [...] A Preston Hall, nella grande serra in vetro e ferro trasformata in museo, i "Giocatori di Dadi" di Georges de la Tour accolgono i visitatori con il loro sorprendente mistero. Tre lanci, un unico risultato... I tre lanci hanno dato lo stesso risultato. Uno [...]"), l’Uno è ancora il più sfuggente e misterioso tra i numeri? Ogni essereu mano è un uno, ma ancora non si sa chi è l’Uno? Ma a che gioco giochiamo?! La storia è sempre e solo fatta da Uno (=1) solo? E i tre moschettieri lavorano ancora per il solito Uno (=1)?!
UNO. IL BATTITO INVISIBILE: "L’Uno ci avvolge, pulsa in noi. Troviamolo. L’Uno è stupore, incompletezza, mistero. A tratti, in una grande sventura o in una gioia profonda, per caso o dopo avere cercato a lungo, ci rendiamo conto d’essere parte di un tutto che ci sovrasta, ci avvolge e allo stesso tempo si sottrae alla nostra #comprensione. Lo sentiamo, il tutto, senza poterlo distinguere con esattezza. Sebbene non ci sia consentito misurarlo con la #ragione, ci pare quasi di toccarlo, tanto è vicino, intimo.
 Vecchie storie bibliche, sogni di mistici, saggezza indiana, inquietudini dei filosofi greci, poesia del Novecento. Sono i bracci di un fiume immenso e segreto, che questo libro risale passo dopo passo in cerca dell’Uno, del suo fulgore, del suo battito lieve, profondo, invisibile. L’Uno, il più sfuggente e misterioso tra i numeri" (G. Busi, "Uno. Il battito invisibile", Il Mulino).
Vecchie storie bibliche, sogni di mistici, saggezza indiana, inquietudini dei filosofi greci, poesia del Novecento. Sono i bracci di un fiume immenso e segreto, che questo libro risale passo dopo passo in cerca dell’Uno, del suo fulgore, del suo battito lieve, profondo, invisibile. L’Uno, il più sfuggente e misterioso tra i numeri" (G. Busi, "Uno. Il battito invisibile", Il Mulino).- IMPARARE A CONTARE: FILOLOGIA ARTE ARTE TERAPIA E RINASCIMENTO, OGGI...
QUATTRO PROFETI (1+1+1+1) O DUE PROFETI + DUE SIBILLE?! Nella cornice del Tondo Doni di Michelangelo, secondo gli esperti della Galleria degli Uffizi, "Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti" (https://www.uffizi.it/opere/sacra-famiglia-detta-tondo-doni)? Non è bene, forse, rianalizzare il quadro e la cornice e ri-verificare la situazione, data la strettissima connesione anche con il lavoro portato avanti nella Cappella Sistina?!
- COSMOLOGIA ANTROPOLOGIA E CIVILTA’...
... IMPARARE A CONTARE E USCIRE da interi millenni di labirinto (Nietzsche) e riprendere la diritta via (Dante2021), comporta un globale capovolgimento del puntodivista e, con Freud, l’aprire gli occhi (tutti e due) e guardare finalmente "da dove veniamo"... e lo straordinario sorgere della Terra, come è apparso ai primi esploratori del cosmo ...
DANTE2021, QUESTIONE ANTROPOLOGICA (ECCE HOMO) E GIOCO DELLA TUNICA:
 QUATTRO SOLDATI, TRE GIOCATORI DI DADI E PROBLEMA DELL’UNO.
QUATTRO SOLDATI, TRE GIOCATORI DI DADI E PROBLEMA DELL’UNO.
 A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ancora al Grand Tour della cosmoteandria?
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ancora al Grand Tour della cosmoteandria?FLS
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI DEL FARAONE DA PARTE DI GIUSEPPE, LA TRAGEDIA DI EDIPO, E LA RICERCA DI SIGMUND FREUD.23 gennaio 2022, di Federico La Sala
FILOSOFIA, PSICOANALISI E SONNO DOGMATICO: TEATRO, TRAGEDIA, E ANTROPOLOGIA CULTURALE...
- TEATRO E FILOSOFIA:“... ho conosciuto eminenti uomini di cultura, artisti, uomini politici (e le loro belle, ma per lo più frustrate, signore) e devo la mia carriera accademica all’amichevole aiuto di alcuni di questi signori (e signore). Ben presto mi si chiarì anche che in una discussione pubblica non contano gli argomenti, ma certe doti teatrali.
- Per controllare il mio sospetto, intervenni nelle discussioni e sostenni con grande sicurezza idee assurde. Dentro di me tremavo di paura - in definitiva non ero altro che un piccolo studente in mezzo a grossi calibri - ma in fondo ero uno studente di teatro e così potei dimostrare l’ipotesi con mia piena soddisfazione.” (Paul K. Feyerabend, “La scienza in una società libera”, Milano 1981)
SOFISTICA E STORIA. ALL’ORLO DELLA "FINE DEL MONDO" (Ernesto De Martino, 1977) emerge con chiarezza che non solo ieri ma anche oggi (e sempre più pericolosamente) che "in una discussione pubblica non contano gli argomenti, ma certe doti teatrali" è un problema epocale di lunga durata.
EDIPO E "SAPERE AUDE!" (KANT). Platone andò a scuola dai sacerdoti egiziani (Nietzsche). A BEN VEDERE è una mossa di grande astuzia, di intelligenza metica (metis, non medica!) propria di Platone che, conosciuto Socrate, distrusse tutte le sue composizioni poetiche/tragiche per dedicarsi completamente alla filosofia, a farsi credere Figlio di Dio (Apollo), a colonizzare le menti dell’intero Occidente, fino a ispirare Freud e Ferenczi che si rifecero esplicitamente alla sua opera "repubblicana" per fondare l’istituzione psicoanalitica!
LO SPIRITO CRITICO E LA SCIENZA IN UNA SOCIETÀ LIBERA. Senza l’interpretazione dei sogni del Faraone da parte di Giuseppe (il penultimo dei dodici figli di Giacobbe), non ci sarebbe stato né Mosè, né Gesù né Maometto, e, neppure Freud sarebbe mai arrivato a Londra e l’opera "L’uomo Mosè e la religione monoteistica" avrebbe mai vista la luce (Amsterdam, 1938)! E... non avremmo mai visto il Sorgere della Terra (Earthrise,1968).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale, nell’immaginazione cosmoteandrica. (9 gennaio 2022, di Federico La Sala
IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS (NON IL ... LOGO)
L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale *
"[...] Citando l’appello costante di Papa Francesco per una Chiesa missionaria,
 monsignor Gómez ha ricordato che
ogni cattolico
monsignor Gómez ha ricordato che
ogni cattolico
 condivide
la responsabilità per la missione:
condivide
la responsabilità per la missione:«Vescovi,
sacerdoti,
diaconi,
seminaristi,
religiosi e consacrati,
uomini e donne laici:
siamo tutti
battezzati per essere missionari».
* Cfr. Amedeo Lomonaco, L’Osservatore Romano, 17 novembre 2021.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- STATI UNITI: CONFERENZA DEI VESCOVI. L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale. Citando l’appello costante di Papa Francesco per una Chiesa missionaria, così nell’ordine secondo monsignor Gomez: «Vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi e consacrati, uomini e donne laici: siamo tutti battezzati per essere missionari» (di Amedeo Lomonaco).17 novembre 2021, di Federico La Sala
L’intervento del nunzio apostolico Pierre all’assemblea generale dei vescovi degli Stati Uniti
L’unità è il futuro di una Chiesa sinodale
di Amedeo Lomonaco (L’Osservatore Romano, 17 novembre 2021)
«Il cammino verso il futuro implica necessariamente l’unità. Una Chiesa divisa non sarà mai in grado di condurre gli altri all’unità più profonda voluta da Cristo». È quanto ha affermato, martedì 16 novembre, l’arcivescovo Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti, nella giornata di apertura dell’assemblea generale della Conferenza dei vescovi cattolici del Paese (Usccb). L’appuntamento si svolge a Baltimora, nel Maryland, fino al 18 novembre, con la partecipazione di quasi 300 vescovi chiamati a riflettere sul tema dell’Eucaristia.
Il presule ha centrato il suo intervento sul tema della sinodalità, sulla scia del processo avviato da Papa Francesco in tutta la Chiesa. La sinodalità, ha detto, «non è un concetto astratto», ma aiuta ad affrontare «la realtà della nostra situazione attuale» come «una risposta alle sfide del nostro tempo e al confronto che minaccia di dividere questo Paese e che ha anche i suoi echi nella Chiesa. Sembra che molti non si rendano conto di essere impegnati in questo confronto, prendendo posizioni radicate in certe verità, ma isolate nel mondo delle idee e non applicate alla realtà dell’esperienza di fede, vissuta dal popolo di Dio nelle situazioni concrete».
Il nunzio ha ricordato «diverse questioni urgenti che la Chiesa deve affrontare oggi». Una di queste è la vita: «Non possiamo abbandonare la nostra difesa della vita umana innocente o della persona vulnerabile». Tuttavia, ha aggiunto, un approccio sinodale «sarebbe quello di capire meglio perché le persone cercano di interrompere le gravidanze», quali sono «le cause profonde delle scelte contro la vita» e quali sono i fattori che rendono queste scelte «così complicate per alcuni».
Sul tema dell’Eucaristia ha affermato che «le realtà sono più importanti delle idee. Possiamo avere tutte le idee teologiche sull’Eucaristia - e, naturalmente, ne abbiamo bisogno - ma nessuna di queste idee è paragonabile alla realtà del Mistero eucaristico, che ha bisogno di essere scoperto e riscoperto attraverso l’esperienza pratica della Chiesa, vivendo in comunione, particolarmente in questo tempo di pandemia. Possiamo diventare così concentrati sulla sacralità delle forme della liturgia che perdiamo il vero incontro con la Sua presenza reale. C’è la tentazione di trattare l’Eucaristia come qualcosa da offrire a pochi privilegiati piuttosto che cercare di camminare con coloro la cui teologia o discepolato è carente, aiutandoli a comprendere e apprezzare il dono dell’Eucaristia e aiutandoli a superare le loro difficoltà. Piuttosto che rimanere intrappolati in una “ideologia del sacro”, la sinodalità è un metodo che ci aiuta a scoprire insieme una via da seguire».
Dopo l’intervento del nunzio, ha preso la parola monsignor José Horacio Gómez, arcivescovo di Los Angeles e presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, che ha ricordato come la missione della Chiesa sia «la stessa in ogni tempo e in ogni luogo»: è quella di «proclamare Gesù Cristo e aiutare ogni persona a trovarlo e a camminare con Lui». Dio, ha sottolineato, ci chiama «a costruire il suo Regno» e a infondere nella società «i valori del Vangelo». «La sfida che abbiamo è quella di capire come la Chiesa dovrebbe svolgere la propria missione in un’America che ora è altamente secolarizzata».
Citando l’appello costante di Papa Francesco per una Chiesa missionaria, monsignor Gómez ha ricordato che ogni cattolico condivide la responsabilità per la missione:
«Vescovi,
sacerdoti,
diaconi,
seminaristi,
religiosi e consacrati,
uomini e donne laici:
siamo tutti battezzati per essere missionari».
Nonostante uno scenario difficile, reso ancora più critico dall’attuale pandemia, l’arcivescovo di Los Angeles afferma che ci sono segni di speranza: c’è «un risveglio spirituale» nel Paese e molti «sono alla ricerca» in un momento in cui «la società americana sembra perdere la sua storia, radicata in una visione biblica del mondo». «Stanno cercando una nuova storia che dia senso alla loro vita». Ma «non hanno bisogno - ha affermato monsignor Gómez - di una nuova storia». «Ciò di cui hanno bisogno è ascoltare la vera storia, la bellissima storia dell’amore di Cristo per noi, il suo morire e risorgere dalla morte per noi, e la speranza che egli porta alle nostre vite». Infine, ha parlato del piano pastorale per «una rinascita eucaristica». Si tratta di un progetto missionario che mira a portare le persone nel cuore del mistero della fede: l’Eucaristia - ha concluso - è «la chiave di accesso alla civiltà dell’amore che desideriamo creare».
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- PRIORITA’ DEL CAMMINO SINODALE. Le «alleanze» come chiave di lettura: il nuovo Adamo riapre il Paradiso e ci chiama “fratelli tutti” (di Filomena Rizzo e Paolo Scarafoni).17 novembre 2021, di Federico La Sala
Cammino sinodale e discernimento comunitario
Parola, alleanze e pietà popolare
di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo (L’Osservatore Romano, 24 agosto 2021)
Una delle priorità del cammino sinodale della Chiesa italiana, nella chiamata al discernimento comunitario, è riportare al centro la Parola nelle comunità reali, le parrocchie e le famiglie. Non c’è autentico discernimento cristiano senza la luce della Parola di Dio. Per il timore dell’eresia della libera interpretazione, la Bibbia di fatto scomparve dalle case dei cattolici. Il concilio Vaticano ii con la costituzione dogmatica Dei Verbum ha riproposto l’ascolto e la proclamazione della Parola nel cammino della Chiesa. Come farla tornare al centro della vita cristiana affinché si realizzi la Chiesa comunità?
 Indichiamo le «alleanze» come chiave di lettura antropologica e teologica della Parola. Mostrano il rapporto vivo di Dio con il popolo. Lungo la storia, Dio ha stabilito alleanze con l’umanità, legami d’amore e promesse per concedere i suoi doni e ricevere la risposta dell’uomo. Sono reali, non ideologiche, e ne sono prova i tanti fallimenti.
Indichiamo le «alleanze» come chiave di lettura antropologica e teologica della Parola. Mostrano il rapporto vivo di Dio con il popolo. Lungo la storia, Dio ha stabilito alleanze con l’umanità, legami d’amore e promesse per concedere i suoi doni e ricevere la risposta dell’uomo. Sono reali, non ideologiche, e ne sono prova i tanti fallimenti.L’alleanza della creazione, di Adamo ed Eva: è il Paradiso. Fallita per il peccato e per l’orgoglio, è vigente perché Dio continua a volerci tutti in Paradiso. È l’alleanza della felicità.
L’alleanza di Noè, con tutta l’umanità. Dio si impegna a non distruggere mai più ciò che ha creato. Il simbolo è l’arcobaleno fra il cielo e la terra. È fallita per l’orgoglio umano e la dispersione dei popoli, e sempre fedele nella regolarità delle stagioni. È l’alleanza della pace.
L’alleanza di Abramo, la scelta del popolo ebraico, come primogenito. Un vincolo segnato nella carne con la circoncisione. È fallita perché il popolo eletto, invece di essere «un pedagogo che conduce a Dio» tutti i popoli, ha interpretato la sua elezione come privilegio. Essa permane perché il popolo ebraico non è maledetto, conserva la primogenitura. È l’alleanza della vocazione.
L’alleanza di Mosè: Dio rivela il suo nome, libera dalla schiavitù, dona la terra e la legge, che è luce e cammino sicuro per tutta l’umanità, e istituisce il rito come elemento di relazione. Fallisce per la sfiducia in Dio e si trasforma in legalismo e ritualismo. È mantenuta viva dai profeti che invitavano alla speranza. È l’alleanza della legge, dell’attaccamento e della memoria.
C’è poi la sorpresa della nuova ed eterna alleanza di Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, che compie le profezie. Da parte di Dio è un’alleanza definitiva, universale e irreversibile, che non abolisce le precedenti, ma «aggiunge», «porta a compimento» dando nuova vita a tutte le altre alleanze.
 Il nuovo Adamo riapre il Paradiso e ci chiama “fratelli tutti”. L’alleanza di Gesù Cristo svela che Dio vuole una comunione di amore e di pace e non di dominio e di violenza. È l’alleanza dell’amore nonostante i fallimenti da superare e gli sbagli da correggere.
Il nuovo Adamo riapre il Paradiso e ci chiama “fratelli tutti”. L’alleanza di Gesù Cristo svela che Dio vuole una comunione di amore e di pace e non di dominio e di violenza. È l’alleanza dell’amore nonostante i fallimenti da superare e gli sbagli da correggere.Il popolo nella Chiesa cattolica si relaziona con Dio nella liturgia, nella carità, nel rapporto con il creato e nella pietà popolare. Anche se solo una minoranza vi partecipa, la liturgia è il luogo teologico privilegiato per la Parola. I testi del lezionario delle domeniche e dei “tempi forti” sono stati selezionati alla luce delle alleanze, in modo che nel rapporto fra Antico e Nuovo testamento appaia chiaro il cammino di relazione fra Dio e umanità che apre al futuro di salvezza: promessa, compimento e pienezza. È importante, specialmente in parrocchia, preparare comunitariamente, alcune volte durante l’anno, la celebrazione domenicale e la predicazione, come suggerito in Evangelii gaudium, 135-151.
Negli ambiti della carità, specialmente con la scelta preferenziale per i poveri, e del rapporto con il creato, verso i quali molti si sentono oggi spontaneamente attratti, la Parola non è stata ancora sufficientemente valorizzata e talvolta è stata usata in modo riduttivo e ideologico; ma la teologia delle alleanze potrebbe apportare luce anche sulle grandi tragedie umanitarie di oggi.
Fin da subito invece si può ridare valore alla Parola di Dio nella pietà popolare. Una bella definizione di pietà popolare è di don Giuseppe De Luca: «La pietà è presenza amata di Dio; non è pietà una fiammata momentanea, per essere pietà deve essere come una vita. Si è pii come si è vivi». La pietà è consuetudine d’amore, tradizione assimilata, dal cuore del popolo. Non è mai solitaria e manifesta la vigenza delle alleanze. La comprensione teologica si trova in Evangelii nuntiandi, 48, dove si abbandona l’espressione “religiosità popolare” perché di sapore sociologico, e si chiede di prediligere l’espressione “pietà popolare”. Essa è naturalmente mistagogica, evangelizzatrice, perché contamina le generazioni in modo orizzontale e verticale, cioè sincronico e diacronico (Evangelii gaudium, 122). È universale come fenomeno che si riferisce a Dio, ma è particolare e locale come realtà vissuta, con testimoni conosciuti e amati e in rapporto con il creato in quel luogo specifico attraverso elementi simbolici.
Non sono bastati la lectio divina, i predicatori esperti, i gruppi selezionati, le élite, i movimenti, le scuole, perché sono cammini dall’alto. Per il popolo cattolico la pietà popolare è il luogo teologico per eccellenza “dal basso”, e in quel terreno fecondo da dissodare da ogni superstizione è importante che rifiorisca la Parola letta alla luce delle alleanze.
-
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- La storia perduta del Cristianesimo. Il millennio d’oro della Chiesa in Medio Oriente, Africa e Asia (V-XV sec.). Com’è finita una civiltà (di Philip Jenkins - prefaz.).25 luglio 2021, di Federico La Sala
Jenkins e la grande storia perduta del Cristianesimo tra Est e Ovest
di Giancarlo Bosetti (Reset, 14 Luglio 2016)
- Ripubblichiamo qui parte della prefazione di Giancarlo Bosetti all’edizione italiana de La storia perduta del Cristianesimo. Il millennio d’oro della Chiesa in Medio Oriente, Africa e Asia (V-XV sec.). Com’è finita una civiltà di Philip Jenkins (Editrice Missionaria Italiana, 2016)
Nell’Europa percorsa dagli incubi scatenati dalla “guerra mondiale a pezzi”, dai proclami folli e sanguinari dell’Islam radicale, dai massacri prima di Al Qaeda poi dell’Isis, dalle ondate di disperati che cercano riparo nelle nostre società, i lavori di Philip Jenkins giungono come un aiuto prezioso nella tempesta, per guardare con lucidità la vicenda passata e presente della cultura e della religione cristiana. L’invito è di straordinario interesse per tutti, perché per tutti è di fondamentale importanza sottrarsi a quel determinismo coatto che vorrebbe produrre il trionfo di un senso comune della paura. [...]
In questa Storia perduta del Cristianesimo l’esercizio anti deterministico di Jenkins, come accade a volte nelle pagine degli storici di valore, si applica a rompere molte idee correnti sul “centro di gravità” delle nostre visioni del mondo cui apparteniamo e della religione che tendiamo a identificare sbrigativamente con l’identità europea. La guerra, le persecuzioni e la fuga stanno cancellando i cristiani da tanta parte del Medio Oriente, la violenza si accanisce sui monasteri cristiani dalla Siria all’Iraq. I cristiani siriaci o nestoriani hanno alle spalle qui una presenza poderosa e millenaria, con enormi comunità - decine di metropoliti, centinaia di vescovi - che si irradiavano a Est, non meno che a Ovest, a partire dai luoghi dove questa religione “nazarena” è nata, e di cui Jenkins racconta le stagioni più gloriose, ridisegnando la geografia storica e soprattutto quella mentale del Cristianesimo: una volta esisteva un altro e più antico cristianesimo che per la maggior parte della sua storia è stato una religione tricontinentale, con potenti rappresentanze in Europa, Africa e Asia, tale rimanendo fino al XIV secolo inoltrato. Il carattere globalizzato del Cristianesimo sottolineato dal pontificato, non eurocentrico, di Francesco è la ripresa di una antica realtà. E altrettanto chiaro è, a chi per avventura abbia visitato i monasteri siriani prima della guerra civile del 2011, che una figura umana straordinaria e un martire del cattolicesimo siriano come Padre Paolo Dall’Oglio, non fosse un operatore “della periferia” cristiana, ma un protagonista di luoghi che sono centrali per la storia religiosa del mondo.
Sono luoghi che, ritrovata la pace, centrali potrebbero tornare per un futuro di dialogo tra le fedi e le comunità, quando si potranno riproporre in quelle terre modelli convivenza che hanno avuto un lungo corso in tempi diversi ad Alessandria, a Merv, a Baghdad, la città, quest’ultima, del potente patriarca Timoteo, che tra VIII e IX secolo dialogava con il califfo al Mahdi sulla vera religione, un po’ come Nathan il Saggio di Lessing faceva con il suo Sultano. [...]
Il libro di Jenkins ci costringe non solo a rimuovere assiomi stereotipati, ma anche a questo “spostamento di un centro” che assumevamo come irriflesso e ci costringe a riesaminare certezze che parevano indiscutibili, andando a illuminare aree della storia poco conosciute perché appartenute a comunità sconfitte. E ci propone il problema che forse è per l’autore quello principale di tutto il suo lavoro: come e perché le religioni muoiono? alcune svaniscono, altre si riducono “da grandi religioni mondiali a una manciata di seguaci”. È accaduto al manicheismo, è accaduto al buddismo, per mille anni dominante in India, ora marginale: sistemi di fede di portata mondiale si rivelano vulnerabili quanto le religioni azteca e maya. E come dimenticare gli ebrei, che appena un secolo fa prosperavano in tutto il Medio Oriente e che sono ormai quasi scomparsi con l’eccezione di Israele: dal 1950 a oggi in Egitto da centomila a cinquanta persone.
Jenkins, cristiano episcopale, costringe qui i credenti di ogni fede a una riflessione sulle estinzioni religiose, che è di grande interesse anche per i non credenti, perché apre un varco essenziale per una prospettiva di pluralismo: il varco è di natura teologica, ma presenta evidenti possibili riflessi politici. Le sorti cangianti delle religioni e gli esiti plurali e travagliati della geografia confessionale concentrano l’attenzione, per ciascuna religione, anche sul ruolo delle altre.
 Se il destino dei rapporti tra le fedi è così alterno e imprevedibile e può produrre l’esito umano della loro scomparsa su vaste porzioni del mondo e la loro sostituzione con altre a seguito di cambiamenti politici (o anche climatici, come Jenkins sottolinea), e se tutto ciò deve avere un senso “in un disegno divino” quale che sia, allora una possibile “teologia della estinzione” non può che essere una teologia delle religioni, una teologia che ne spieghi la molteplicità, i successi e la caducità, in una parola: una teologia pluralista.
Se il destino dei rapporti tra le fedi è così alterno e imprevedibile e può produrre l’esito umano della loro scomparsa su vaste porzioni del mondo e la loro sostituzione con altre a seguito di cambiamenti politici (o anche climatici, come Jenkins sottolinea), e se tutto ciò deve avere un senso “in un disegno divino” quale che sia, allora una possibile “teologia della estinzione” non può che essere una teologia delle religioni, una teologia che ne spieghi la molteplicità, i successi e la caducità, in una parola: una teologia pluralista. -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- “Bibbia e Corano, un confronto”. Comincio da una precisazione rilevante: i testi sacri sono in realtà tre. (di Piero Stefani - "Letture.org).7 giugno 2021, di Federico La Sala
Intervista - "Letture" *
“Bibbia e Corano, un confronto” di Piero Stefani
Prof. Piero Stefani, Lei è autore del libro Bibbia e Corano, un confronto edito da Carocci: quanto sono simili i due testi sacri?
Comincio da una precisazione rilevante: i testi sacri sono in realtà tre. Occorre infatti distinguere tra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana. Uno stereotipo ancora abbastanza diffuso parla di Bibbia e Vangelo. In realtà, esistono la Bibbia ebraica, e la Bibbia cristiana formata da Antico e Nuovo Testamento. I libri dell’Antico Testamento, salvo alcuni casi particolari, coincidono con quelli della Bibbia ebraica; tuttavia in questo caso si è trattato non di aggiungere alcuni libri a quelli precedenti bensì di creare un insieme da leggere e interpretare in maniera diversa.
La somiglianza più profonda è che Bibbia e Corano sono sacri soltanto a motivo dell’esistenza di tre comunità che li considerano tali, in quanto li ricevono, li leggono nella liturgia, li commentano e li trasmettono. Tutte e tre le comunità religiose condividono la convinzione che, nel corso della storia, Dio abbia fatto giungere agli esseri umani parole destinate in seguito ad assumere una forma scritta. Ciò è avvenuto grazie a specifici mediatori che hanno trascritto nella “lingua degli uomini” la volontà di Dio. Per ricorrere alla classificazione consueta, ebraismo, cristianesimo e islam sono «religioni rivelate». Tra esse ci sono molte e non lievi differenze, ma tutte emergono a partire da questo terreno comune. Le si può paragonare a un bosco in cui ci sono alberi molto differenti tra loro, anzi a volte uno di essi fa ombra a un altro, tutti però condividono lo stesso suolo.
Quali sono i più significativi punti comuni tra Bibbia e Corano?
Il primo, irrinunciabile punto in comune è che Dio è definito creatore. Ciò significa che la realtà nel suo insieme ha avuto inizio a causa di un atto libero di Dio. Per tutte e tre non si tratta di dimostrare l’esistenza di Dio a partire da quanto sperimentiamo in noi e attorno a noi; quanto affermato dalle tre religioni è che in noi e attorno a noi ci sono segni dell’opera creatrice di Dio. Per così dire, il Cantico delle creature di Francesco di Assisi esprime un convincimento comune a ebrei, cristiani e musulmani. Per tutte e tre le tradizioni religiose, specie di età moderna, nasce poi il problema di sapere come confrontarsi con la visione del cosmo e della natura proposta dalla ricerca scientifica. Qui le strategie sono in parte diverse.
Altro punto accomunante è che Dio abbia comunicato agli esseri umani delle leggi (per limitarci a un solo esempio, si pensi ai “Dieci comandamenti”) volte a regolare sia i rapporti interni alle singole comunità religiose sia quelli con le altre persone e società. In questo caso ci si deve confrontare con il problema di quale rapporto esista tra queste leggi credute di origine divina e i tempi storici in cui sono sorte. Nasce poi anche l’interrogativo di quale sia la relazione tra le leggi di natura divina e quelle, fondate su altri principi, che regolano la società civile. La questione è accomunante, le risposte sono invece molteplici e spesso non concordi. Sono tali non soltanto tra ebraismo, cristianesimo ed islam, ma anche tra i vari gruppi o membri interni alle singole comunità religiose.
Le tre grandi religioni monoteiste fondano sulla rivelazione divina la propria dottrina, tanto da meritare l’appellativo di ‘popolo del libro’: come definiscono, i due testi sacri, la comunità dei credenti?
Come accennato in precedenza è vero che tutte e tre le comunità hanno testi sacri, tutt’altro che certo è invece che le si possa chiamare concordemente «popolo del libro». Per limitarmi a un solo esempio, per il cristianesimo la fonte prima della rivelazione è Gesù stesso, di cui i Vangeli sono memoria e testimonianza. Si può affermare che tanto l’ebraismo quanto il cristianesimo definiscono i loro rispettivi testi sacri in modo gerarchizzato.
 La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
 Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
 Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.
Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.L’espressione «comunità dei credenti» calza bene per cristiani e musulmani in quanto l’appartenenza alla Chiesa e all’ Umma (comunità musulmana) presuppone la fede, meno agli ebrei che costituiscono un popolo vero e proprio, non a caso si è ebrei innanzitutto per nascita (secondo una discendenza matrilineare).
Come descrivono Bibbia e Corano l’origine del male?
Vi è una dimensione accomunante che individua l’origine del male nella trasgressione. Come ben compreso da Paolo nella Lettera ai Romani, perché ci sia una trasgressione bisogna che prima ci sia una legge o un comando. Occorre quindi trovare miti fondativi che si muovano in questa direzione; il più noto è quello della proibizione di mangiare l’albero della conoscenza del bene e del male. Non è difficile comprendere il suo valore simbolico incentrato propria sulla connessione tra divieto e violazione. Al pari di prospettive presenti nell’apocalittica tanto giudaica quanto cristiana, il Corano pensa a una violazione antecedente a quella compiuta dalle creature umane. Ecco allora irrompere il peccato angelico, nell’islam connesso alla figura di Iblis, angelo superbo e disobbediente. D’altra parte conviene riflettere sul fatto che una trasgressione c’è eppure non ci dovrebbe essere; in questo senso si vede chiaramente la sua connessione con il male, altra realtà che c’è ma non dovrebbe esserci. Individuare la radice del male nella trasgressione porta con sé però altri problemi: chi spinge a trasgredire? Ecco allora che si “personalizza” il peccato, presentandolo come una forza che induce a compiere atti brutali. Sia per la Bibbia sia per il Corano la storia di Caino rappresenta il simbolo più conosciuto di tutto ciò: quando uccise il fratello, il primo fra i nati da donna non aveva ricevuto il comando di non uccidere.
Aumentare a dismisura la forza del peccato o della tentazione come causa del male rischia però di fa scivolare la visione di insieme verso una forma troppo prossima al dualismo, vale a dire di prospettare l’esistenza di un Dio del male; ecco allora che in alcuni passi sia biblici sia coranici si legge che Dio crea il male (Isaia 45,7). Affermazione che non va assolutizzata ma neppure del tutto accantonata. La presenza del male rappresenta per tutti uno scoglio complesso.
In che modo Bibbia e Corano affrontano il tema della resurrezione dei morti?
Il tema è presentato in maniera per così dire defilata nella Bibbia ebraica, infatti lo si trova con chiarezza solo nel tardo e apocalittico libro di Daniele (che nella Bibbia ebraica non è annoverato neppure tra i libri profetici). La resurrezione dei morti svolge invece un ruolo centrale nel Nuovo Testamento; il motivo è evidente: il kerygma - cioè l’annuncio originario e fondamentale della fede - ha il proprio centro nella «buona novella» di Gesù Cristo morto e risorto. Come stabilito in modo definitivo da Paolo, per la fede cristiana vi è un legame inscindibile tra la risurrezione di Gesù Cristo e quella dei salvati. Anche per questo motivo nel cristianesimo, per quanto sia stato affermato più volte e venga attestato anche da alcuni passi neotestamentari, suscita sempre sconcerto la prospettiva secondo la quale ci sono dei risorti destinati alla dannazione eterna. Nel Corano la resurrezione dei morti è affermata in maniera forte e inequivocabile. Per trovarne il fondamento basta rifarsi alla perenne attività del Dio creatore: Allah, che ha plasmato l’uomo dalla polvere, è ben capace di dare nuova vita a ossa disseccate. La resurrezione è però intrinsecamente legata al giudizio in virtù del quale si è o beati o dannati; una prospettiva tanto presente nell’islam da essere anticipata da una specie di interrogatorio che avviene dentro le tombe.
Piero Stefani, di formazione filosofica, insegna “Bibbia e cultura” presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e “Diritto ebraico” all’Istituto internazionale di Diritto Canonico e Diritto comparato delle religioni dell’Università della Svizzera Italiana. È segretario generale di Biblia, associazione laica di cultura biblica. Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano Il grande racconto della Bibbia, il Mulino 2017 e per Carocci I volti della misericordia (2015).
* Fonte: Letture.org
Nota:
- "Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli" (Piero Stefani).
Al vertice del "cristianesimo" (cattolicesimo costantiniano), in realtà, non ci sono - come sostiene Piero Stefani - i "quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi)", ma - fondamentalmente - ma le lettere (e l’interpretazione "andrologica" della figura di Cristo) di Paolo di Tarso:
 "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- IN CAMMINO CON DANTE. "Contraffazione della plenitudine della Trinità": la noia di Satana, capace di essere solo una parodia el bene (di Carlo Ossola).31 maggio 2021, di Federico La Sala
In cammino con Dante/11.
La noia di Satana, capace solo di essere una parodia del bene
Dante descrive «lo ’mperador del doloroso regno» come il negativo della Trinità. Dalla sua tristezza glaciale molti autori sapranno trarre spunto per i loro inferni
di Carlo Ossola (Avvenire, domenica 30 maggio 2021)
- Le terzine eponime
- Con sei occhi piangëa, e per tre menti
 gocciava ’l pianto e sanguinosa bava.
gocciava ’l pianto e sanguinosa bava.
 Da ogne bocca dirompea co’ denti
Da ogne bocca dirompea co’ denti
 un peccatore, a guisa di maciulla,
un peccatore, a guisa di maciulla,
 sì che tre ne facea così dolenti.
sì che tre ne facea così dolenti. - Inferno XXXIV, 53-57
- [Foto] Lucifero in una illustrazione quattrocentesca della Divina Commedia
«Vexilla regis prodeunt inferni»: l’inizio del canto XXXIV e ultimo dell’Inferno è solenne e araldico: «Avanzano i vessilli del re dell’inferno», rovesciamento in eco parodica di un inno di Venanzio Fortunato, cantato il venerdì santo sulla croce del sacrificio: «Vexilla regis prodeunt,/ fulget crucis mysterium,/ quo carne carnis conditor/ suspensus est patibulo» [«Avanzano i vessilli regali / rifulge il mistero della croce, / al cui patibolo il creatore della carne / con la propria carne fu elevato»].
È un incipit memorabile, di grande forza teologica: il male non sa essere che la parodia degradante del bene; e di profonda iconicità metaforica. Nessuno meglio che Ignazio di Loyola seppe riscriverlo, nei propri Esercizi spirituali: «Quarto giorno. Meditazione su due bandiere, l’una di Cristo, nostro sommo capitano e Signore, l’altra di Lucifero, nemico mortale della nostra natura umana. [...] Il secondo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui sarà vedere un grande campo nella regione di Gerusalemme, dove Cristo nostro Signore è il capo supremo dei buoni, e un altro campo nella regione di Babilonia, dove Lucifero è il capo degli avversari. [...] Immagino nel vasto campo di Babilonia il capo degli avversari, che siede su un grande seggio di fuoco e di fumo, orribile e spaventoso nell’aspetto». Un «seggio di fuoco e di fumo»: come non pensare al dantesco: «Come quando una grossa nebbia spira» (XXXIV, 4)?
Sebbene Lucifero sia precipitato, la sua metamorfosi abietta, Satana, è sempre in campo: Dante lo ricorda, sulla scia del Pater noster: «et ne nos inducas in temptationem»: "non sottoporci alla prova", al cimento col Maligno, «cioè non permettere che noi commettiamo una colpa tale per cui si debba meritatamente precipitare in inferno» (Onorio d’Autun, Speculum ecclesiale, PL, 172, 822C). Nella figurazione di Dante balugina, per un sol verso, il ricordo della figura angelica che fu Lucifero: «la creatura ch’ebbe il bel sembiante» (v. 18); la fulminea trasformazione di quell’istante fatale è per il poeta acuto tormento: «S’el fu sì bel com’elli è ora brutto, / e contra ’l suo fattore alzò le ciglia, / ben dee da lui procedere ogne lutto» (vv. 34-36).
L’apparire del signore di Dite lascia Dante come in uno stato di paralisi: «Com’io divenni allor gelato e fioco / nol domandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo, / [...] / Io non mori’ e non rimasi vivo» (vv. 22-25), non dissimile dallo svenimento che coglie Dante di fronte al dramma di Paolo e Francesca: l’estremo amore e l’estrema abiezione dell’umano. Solo nel poemetto drammatico di Vladimir Holan (Praga 1905-1980), Una notte con Amleto, il dilemma torna con pari intensità: «riceve la luce, eppur non brilla».
Contraffazione della plenitudine della Trinità, l’ormai Satana, stretto nella morsa del ghiaccio, ha «tre facce a la sua testa», sotto le quali da ciascuna «uscivan due grand’ali, / [...] / Non avean penne, ma di vispistrello / era lor modo; e quelle svolazzava, / sì che tre venti si muovean da ello: / quindi Cocito tutto s’aggelava» (vv. 46-52). L’enorme cieco pipistrello del male muove quelle ali / pale che perennemente alimentano e consolidano il ghiaccio di cui è prigioniero: primo Héautontimorouménos (Baudelaire) di se stesso e dell’umanità: «Sono la piaga e il coltello! / Sono lo schiaffo e la guancia! / Sono le membra e la ruota, / la vittima e il carnefice! / Sono il vampiro del mio cuore».
Come la Trinità amandosi s’effonde per tutto il creato, colmandolo della propria pace: «Ciò che vedesti fu perché non scuse / d’aprir lo core a l’acque de la pace / che da l’etterno fonte son diffuse» (Purg XV, 130-132), così - in simmetrico contrapposto - «Lo ’mperador del doloroso regno» (XXXIV, 28) a sé porta e divora i corpi che ha soggiogato: «Da ogne bocca dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla, / sì che tre ne facea così dolenti» (vv. 55-57).
 Lo schema dantesco tornerà nelle più memorabili rappresentazioni infere, come nel libro X del Paradiso perduto di Milton: «intorno ai muri / di Pandemonio, città e reggia / di Lucifero, così per abbaglio chiamato, / dal fulgi d’astro cui Satana fu paragonato. / Là in armi stavano le legioni...» (X, 423-427), o nelle Visioni di William Blake, proprio dal suo Milton (1804-1808): «Gli Occhi nel timore che le salde ossa non si facessero crosta di ghiaccio su tutto, guardarono l’Abisso» e ancora, dal Matrimonio del Cielo e dell’Inferno: «Una parte dell’essere è il Prolifico, l’altra il Divorante. Al divoratore può sembrare di tenere il produttore nelle sue catene, ma non è affatto così; egli afferra solo brani di esistenza, e gli pare il tutto» (entrambi i passi nella traduzione di Giuseppe Ungaretti, dalle Visioni di William Blake).
Lo schema dantesco tornerà nelle più memorabili rappresentazioni infere, come nel libro X del Paradiso perduto di Milton: «intorno ai muri / di Pandemonio, città e reggia / di Lucifero, così per abbaglio chiamato, / dal fulgi d’astro cui Satana fu paragonato. / Là in armi stavano le legioni...» (X, 423-427), o nelle Visioni di William Blake, proprio dal suo Milton (1804-1808): «Gli Occhi nel timore che le salde ossa non si facessero crosta di ghiaccio su tutto, guardarono l’Abisso» e ancora, dal Matrimonio del Cielo e dell’Inferno: «Una parte dell’essere è il Prolifico, l’altra il Divorante. Al divoratore può sembrare di tenere il produttore nelle sue catene, ma non è affatto così; egli afferra solo brani di esistenza, e gli pare il tutto» (entrambi i passi nella traduzione di Giuseppe Ungaretti, dalle Visioni di William Blake).L’antinomia manichea del Bene e del Male, che perdura da Dante sino a Blake, sarà ancora confermata da Baudelaire: «Ci sono in ogni uomo, in ogni istante, due aneliti simultanei, l’uno verso Dio, l’altro verso Satana. L’invocazione a Dio, o spiritualità, è un desiderio di elevarsi; quella a Satana, o animalità, è il compiacimento di abbassarsi » (Mon coeur mis à nu, XI); ma le Fleurs du Mal hanno tuttavia sancito la coscienza tragica dell’incedere del male: «Ogni giorno verso l’Inferno scendiamo d’un passo / Senza orrore, attraversando fetide tenebre» (dedica Al lettore).
Di quel secolo, la meditazione più acuta è forse quella che ci ha lasciato Michail Jur’evic Lermontov (1814-1841) nel suo poemetto Il Demone, ove contempla, per tutti noi, la nausea di Satana nel non avere qui avversari, l’invincibile noia di uno squallido trionfo: «Sulla nostra terra meschina / Il Demone esercita le sue arti. / Ovunque il suo spirito predomini / si estende il male... ma da nessuna parte / avendo trovato resistenza, / è tedio la sua potenza» (Il Demone, 183841, parte I, II). E tuttavia non c’è in Dante che un istante di ribrezzo per il «vermo reo» (v. 108), poi il viaggio continua, verso la luce - infine!: «salimmo su, el primo e io secondo, / tanto ch’i’ vidi de le cose belle / che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. / E quindi uscimmo a riveder le stelle» (vv. 136-139).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- ISRAELE E PALESTINA/SENZA FINE. LA "TERRA PROMESSA": ABITARE DA STRANIERI UNA TERRA-SPOSA (di Donatella Di Cesare).26 maggio 2021, di Federico La Sala
ISRAELE - PALESTINA /SENZA FINE
ABITARE DA STRANIERI UNA TERRA-SPOSA
Tra Israele e Palestina l’idea dei due popoli e due stati non regge più
Chi conosce i territori sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. Per questo serve immaginare un laboratorio politico nuovo
di Donatella Di Cesare (L’Espresso, 25.05.2021)
«Quelli sono occupanti! E gli altri sono occupati». Più esplicitamente: «Quel paese è frutto di occupazione!». Oppure con il nuovo motto: «Basta con l’esproprio etnico!». Sono solo alcuni esempi di slogan che circolano ovunque, dal web alle piazze, e che rilanciano una vecchia, vecchissima accusa (quasi immemoriale): Israele non dovrebbe essere lì dov’è. Non ci sarebbe quasi altro da aggiungere.
Il «peccato originale» che avrebbe segnato la nascita di Israele sarebbe quello di aver scalzato un popolo che c’era prima, indigeno, nativo, insomma autoctono. Alla fin fine non si tratta neppure tanto di limiti e confini, di linea verde e territori contestati. Dietro calcolo e contabilità, a cui spesso si fermano statisti e politologi, si nascondono questioni ben più profonde che di solito vengono aggirate. Forse perché non riguardano solo Israele e Palestina, ma investono tutti noi, le nostre frontiere, gli stati nazionali in cui siamo inseriti, il nostro abitare e il rapporto con gli altri.
 Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?
Perciò occorre forse una prospettiva nuova, un modo diverso a cui guardare quel terribile conflitto che non per caso ci turba e ci coinvolge tutti con un’ondata di emozioni talvolta irrefrenabili, al punto da rendere impossibile una riflessione. E se nella tragedia si nascondesse invece una chance? Se Israele e Palestina fossero il laboratorio politico della globalizzazione?Forse bisognerebbe chiedersi anzitutto che cosa significa «occupare». Questo verbo, che è il punto dirimente, non sembra solo legato alla frontiera e al fronteggiarsi. Rinvia anche al possesso originario, alla mitologia dell’origine, a cui non si sottraggono neppure i palestinesi quando rivendicano di essere i primi abitanti. La battaglia delle cartine è arrivata anche su facebook. Colori e bandiere diversi si avvicendano per quello stretto lembo di terra che va dal Giordano al Mediterraneo. E di nuovo: lo scontro non è tanto sulla geografia, quanto sulla storia. Chi c’era prima? I palestinesi che sono stati poi scalzati. Sono loro gli abitanti originari, gli autoctoni. Quelli che sono arrivati dopo - gli ebrei, gli israeliani - sono occupanti, colonialisti, ecc. Ma i nomi contengono anche una testimonianza storica. L’etimologia di «palestinese» va ricondotta a liflosh, ovvero filisteo, cioè invasore, e si riferisce a un popolo venuto dal mare. Dopo aver raso al suolo Gerusalemme i romani chiamarono Palestina la terra di Israele per sottolineare la rottura rappresentata dall’Impero e cancellare anche nel nome il ricordo del popolo ebraico. I palestinesi di oggi, discendenti in gran parte dall’immigrazione araba intorno al 1930, sono andati costruendo una identità nazionale nel confronto-scontro con Israele rivendicando radicamento e possesso originario.
Sono allora gli ebrei i veri autoctoni? No - e lo dice il nome. Perché ivrì, cioè venuto da altrove, non può essere del luogo. Abramo, il primo emigrante, segue l’ingiunzione: «va, vattene!». E così lascia tutto per andare a vivere da straniero in una terra non sua, promessa. Insomma, quelli che credono di essere venuti prima sono invece sempre venuti dopo.
 Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.
Chi sono allora gli abitanti originari, gli autoctoni, di questa terra, e di ogni terra? Ma forse sbagliata è proprio la domanda: nessun popolo può dimostrare di essere autoctono.Eppure, questo mito potentissimo alimenta ancora oggi la politica degli stati nazionali. Basti pensare alla guerra contro i migranti. È l’idea della terra-madre che, mettendo fuori gioco le donne, genera direttamente i suoi figli, tutti maschi e tutti cittadini, perché nati proprio lì, in quella zolla di terra, nel suolo stesso della città. Perciò sono i proprietari esclusivi, i figli legittimi, ben nati, in grado di respingere gli altri, i bastardi e gli stranieri. Questo avviene nell’Atene patria del sé, modello fulgido di pura, presunta autoctonia. Ma l’esempio - lo sappiamo - può vantare una tradizione secolare che nulla ha interrotto, nemmeno l’hitlerismo, la forma più esasperata dello ius soli. E oggi quel mito continua ad affermarsi tra radici inestirpabili e malattia identitaria, che ovunque rischiano di ridurre la democrazia a etnocrazia, una forma politica dove valgono non i diritti del popolo, ma quelli della stessa etnia. Si può puntare l’indice solo su Israele, parlando di stato etnico e magari usando una parola grave come «apartheid»? Oppure non si dovrebbe guardare anzitutto a quel che avviene nei paesi europei, anzitutto in Italia, dove la cittadinanza è basata ancora sul sangue e sul suolo?
Chi conosce i territori israeliani e palestinesi sa bene che sono strettamente intrecciati e che sotto ogni aspetto una divisione netta, oltre a essere irrealistica, sarebbe artificiosa e alla fin fine nociva. Quasi una resa. E infatti sono sempre più le voci critiche che negli ultimi anni si sono levate contro la «soluzione dei due stati», giudicata una fantasia che dimentica la storia e ignora il contesto politico. D’altronde ovunque, sotto la spinta della globalizzazione, lo stato perde sovranità e i confini diventano un limite. In tale scenario quello tra Israele e Palestina è il conflitto tra uno stato post-nazionale e uno stato proto-nazionale. Sta qui in gran parte l’insolubilità. Le due parti non si incontrano anche perché si trovano in fasi diverse della propria storia. Israele ha compiuto la «liberazione nazionale» e in molti ambiti (dallo high tech all’informatica) oltrepassa continuamente i referenti statuali. Resta allora la questione dello Stato palestinese. Al di là delle divisioni interne, si può essere sicuri che la fondazione di un nuovo stato sarebbe criterio di equità e favorirebbe la pace? La logica degli stati nazionali, che ancora nel secolo scorso poteva essere considerata la via dell’emancipazione, da tempo mostra tutte le proprie pecche, dall’aggressività nazionalistica alla costruzione di identità artificiali. Le «patrie» che gli stati nazionali hanno costruito per i propri popoli si sono rivelate trappole senza uscita.
Puntare a una comune cittadinanza deterritorializzata e denazionalizzata sarebbe invece la strada insieme più concreta, ma anche più lungimirante. Si tratta peraltro di un esperimento che viene praticato anche in altre parti del mondo, dove gli stati gomito a gomito impediscono la convivenza, oppure in alcune grandi città nelle quali è molto alto il numero degli immigrati (esemplare è il caso di New Haven che ha concesso stato civile e diritti politici). Tutto questo non potrebbe in nessun modo lasciare immutato lo stato di Israele che, anzi, proprio perciò, dovrebbe andare al di là dello stato.
Non avrebbe dovuto essere questo il suo compito? Mentre è accusato di occupare una terra non sua, mostrare la possibilità di un altro abitare? Era questo il senso della promessa, una promessa certo non dettata dalla Shoah, dei cui esiti atroci Israele ha dovuto semmai farsi carico. Eppure, ancora oggi Israele è inquisito nel suo essere: si contesta quel ritorno, negando la continuità della presenza su quella terra, e dunque la storia stessa del popolo ebraico. Capita che lo facciano subdolamente esimi storici che su youtube ironizzano sull’antico regno di Israele. Come se questo fosse il punto.
Ma che dire degli sfratti a Sheikh Jarrah? Soprattutto per ciò di cui sono simbolo? E tutta la miope e belligerante politica di espansione della destra che in questi ultimi anni ha provocato enormi e inutili tensioni? Si può ormai parlare di una tragicità del sionismo politico che sulla scia della normalizzazione ha inscritto Israele nella modernità al prezzo di un nazionalismo esasperato e una simbiosi con la terra. Proprio il popolo che dovrebbe mostrare la possibilità di un altro abitare, non nel solco del radicamento, bensì nella separazione. Questo vuol dire kadosh, santo, separato. Terra in cui si risiede come stranieri, venuti da fuori, come ospiti che non possono non concedere ospitalità.
 Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.
Non una terra-madre, bensì una terra-sposa. Impossibile dimenticare l’estraneità, sacralizzando idolatricamente la terra. D’altronde in ebraico gher, straniero, è connesso con ghur, abitare. Si può e si deve abitare da stranieri. Nessun mito di autoctonia.Abitare e coabitare sono verbi oggi politicamente decisivi e vanno al di là di vecchie categorie politiche che non rispondono più allo scenario attuale e all’ordine statocentrico. Si capisce che il conflitto tra Israele e Palestina abbia ripercussioni ovunque. Già solo perché viene tacitamente scossa la sovrana autocoscienza delle nazioni che vantano radici e possesso territoriali. Israele è una effrazione nel dimorare della Palestina e i palestinesi, i più prossimi, sono quasi delegati degli altri popoli, che d’un tratto si trovano faccia a faccia con il vuoto statuale e nazionale di cui Israele è memoria. In tal senso, guardando oltre il quadro bellico, è quello il laboratorio politico dove due popoli, loro malgrado, sono costretti a inaugurare nuove forme di coabitazione che saranno forse modello per gli altri.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- Memoria di Hans Küng (1928-2021): "Infallibile? Una domanda" (1970), "Essere cristiani" (1974), "Ebraismo" (1991), "Cristianesimo" (1994), "Islam" (2004).8 aprile 2021, di Federico La Sala
Hans Küng (1928-2021)
di Antonio Ballarò (Il Mulino, 08 aprile 2021)
Cattolico, prete, teologo, perito conciliare e professore universitario: difficile dire che cosa non sia stato Hans Küng durante questa vita. Che si è conclusa due giorni fa, all’età di 93 anni a Tubinga, la città in cui più di ogni altra sarebbe dovuto succedere.
Küng era nato il 19 marzo 1928 a Sursee, in Svizzera e precisamente nel cantone lucernese. La sua infanzia coincide con l’ascesa al potere di Hitler, minaccia che avvertirà profondamente grazie al deciso anti-nazismo che segna presto parenti e conoscenze. Ma anche prima indubbia esperienza di misurazione con una libertà non tanto ricercata, quanto ammessa e praticata. La sua è una Svizzera lontana dai contesti opachi della finanza per cui tra molte cose essa è conosciuta: Küng nasce da una famiglia benestante ma non elitaria, di cui sembra costituire una riuscita sintesi, anche ma non solo in senso intellettuale. Determinante, evidentemente, è il quadro religioso: non estraneo alle cornici medievali e barocche in voga al tempo, eppure anche, come ogni realtà complessa, capace di generare personalità i cui vissuti trasudano testimonianza. Nel caso del giovane Küng, ciò si concretizza quando nella sua città natale giunge il reverendo Franz Xaver Kaufmann, poi parroco nella stessa, cui dedicherà pagine di gratitudine e stima per ciò che riconoscerà come lo spirito di Gesù operante in lui. E che lo affascinerà al punto da condurlo al presbiterato: una scelta mai rinnegata e rivelatrice anche, forse, della sua fermezza. Una fermezza non insensibile.
Così Küng ricalca il percorso che era di tutti i candidati al ministero cattolico. Fino alla decisione di partire per Roma, dopo la scuola ginnasiale, per studiare teologia all’università Gregoriana, retta dai gesuiti: dove si accosterà al modello teologico neotomista, diffusosi su impulso di papa Leone XIII e dell’enciclica Aeterni Patris di quasi un secolo prima (1879), il cui impianto si mostrava razionale se non sillogistico, ma non sempre direttamente antimoderno. La teologia appresa da Küng è stretta tra sistole e diastole nel suo rapporto con la filosofia: della quale si concepisce, quindi, orientamento e compimento. Ma la formazione romana del giovane Küng include anche il Pontificium collegium germanicum et hungaricum, presso cui risiede e dove realmente pratica una teologia sostanzialmente mnemonica. Che si unisce a decisive frequentazioni romane (tra gli altri, Peter Lengsfeld e Josef Fischer).
E Roma diventa, in effetti, il convitato di pietra di un’esistenza, la sua, mai condotta senza la Chiesa, della quale non smetterà mai di dichiararsi membro. Il suo sentire cum ecclesia significherà sempre sentire in ecclesia, come imparerà dal gesuita Wilhelm Klein, allora direttore spirituale del collegio germanico. Sostenuto, in questo, dalla duratura fascinazione per il filosofo francese Jean-Paul Sartre, forse l’autore principale cui Küng deve uno spazio di libertà intellettuale (non intellettualistica) nella Chiesa, per la Chiesa.
La romanità della teologia che studia nella capitale d’Italia gli permette di dubitare della compatibilità di questa con la cattolicità della Chiesa: così che dirà, del tutto serenamente, che è la Roma cattolica ad averlo reso un cattolico critico verso Roma. Intendendo con questo soprattutto un fatto: la graduale attestazione dell’impossibilità di lasciare la Chiesa, come in uno scontro intimo e sconosciuto tra una libertà dell’agire e una libertà dell’esistere, in cui ha indubbiamente voluto che risuonasse il vangelo. Ne avrà modo specialmente a Parigi, dove si trasferirà, all’Institut catholique, per il completamento degli studi con il conseguimento di un dottorato in teologia incentrato sul grande teologo protestante Karl Barth, anch’egli svizzero, cui ricorre per un’indagine sulla dottrina della giustificazione.
Ma sono gli anni del concilio, annunciato da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, quelli probabilmente più densi di stimoli. Il Vaticano II (1962-1965), che il papa definisce «pastorale», permette a Küng, allora sui trent’anni, di coniugare idealmente cura d’anime e accademia, il che è sicuramente uno dei motivi per cui confesserà la sua parziale delusione per i risultati raggiunti dall’assise. Che il giovane teologo vivrà da perito, cioè esperto, senza cedere all’invito di rientrare nella Commissione teologica: una scelta che resta più di altre discutibile, specie alla luce di quanto avrà modo di ammettere da sé circa l’effettiva possibilità di cambiare le cose. Per Küng, che aveva da poco ottenuto una cattedra a Tubinga e pubblicato, oltre la tesi dottorale, Strutture della Chiesa e Concilio e riunificazione (1960), sembrò non essere scattata quella «veracità» che avrebbe predicato della Chiesa, andando a ricoprire una posizione esterna e non senza conseguenze per i successivi rapporti tra la teologia e la Chiesa, a maggior ragione nel post-concilio.
Si può fare l’esperienza, dunque, di ricostruire e interpretare perfino in questo modo la sua indubbia partecipazione attiva al Vaticano II, che a volte ha sfiorato, però, come noterà uno del calibro di Yves Congar, la creazione di un para-concilio dei teologi. Impressione, questa, che Küng smentirà solo in parte grazie alla pubblicazione del suo La Chiesa (1967), dal quale emergerà un’ecclesiologia biblica e fondata sui carismi, che non riuscirà a evitare del tutto una visione compartimentale della Chiesa.
Ma il successo del teologo svizzero si lega all’uscita di Infallibile? Una domanda (1970), che porrà questioni fondamentali per la comprensione del dogma dell’infallibilità papale e gli varrà l’apertura di un procedimento disciplinare che nove anni dopo produrrà la revoca del mandato di insegnamento della teologia a nome della Chiesa cattolica. Un procedimento contro il quale si schiererà la stessa università di Tubinga: che gli consentirà di mantenere lo status di professore.
 Da allora, per il teologo Küng si schiudono gli orizzonti sconfinati di una teologia interessata all’altro, attraverso grandiose e leggibilissime esposizioni della fede cristiana (Essere cristiani, 1974), ambiziosi progetti etici (Progetto per un’etica mondiale. Una morale ecumenica per la sopravvivenza umana, 1991), il dialogo tra le religioni, specie i tre monoteismi (Ebraismo, 1991; Cristianesimo, 1994; Islam, 2004).
Da allora, per il teologo Küng si schiudono gli orizzonti sconfinati di una teologia interessata all’altro, attraverso grandiose e leggibilissime esposizioni della fede cristiana (Essere cristiani, 1974), ambiziosi progetti etici (Progetto per un’etica mondiale. Una morale ecumenica per la sopravvivenza umana, 1991), il dialogo tra le religioni, specie i tre monoteismi (Ebraismo, 1991; Cristianesimo, 1994; Islam, 2004).Con la morte di Hans Küng, sarà interessante seguire le prese di posizione ecclesiali. Perché non si può dire ancora quale posto avrà avuto rispetto alla Chiesa, ma soprattutto rispetto alla teologia, in un momento a dir poco magmatico per la sussistenza dell’impianto intellettuale di sostegno alla fede.
 Con Hans Küng, non se ne va solo un uomo profondamente versato nella ricerca teologica, ma un largo frammento di storia della Chiesa e del secolo che ereditiamo. Un frammento che il pontificato di Francesco dovrà continuare in parte a smuovere e in parte a rimuovere.
Con Hans Küng, non se ne va solo un uomo profondamente versato nella ricerca teologica, ma un largo frammento di storia della Chiesa e del secolo che ereditiamo. Un frammento che il pontificato di Francesco dovrà continuare in parte a smuovere e in parte a rimuovere. -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- Non c’è tempo per l’indifferenza, "o siamo fratelli o ci distruggiamo". Prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana (di Mimmo Muolo).5 febbraio 2021, di Federico La Sala
La Giornata.
Papa Francesco: la fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità
L’intervento del Papa in occasione della celebrazione virtuale per la prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana: non c’è tempo per l’indifferenza, "o siamo fratelli o ci distruggiamo"
di Mimmo Muolo (Avvenire, giovedì 4 febbraio 2021)
C’è un giardino ad Abu Dhabi dove lo scorso anno i giovani hanno appeso alle fronde degli alberi i loro pensieri di pace, scritti su centinaia di foglietti. Oggi, idealmente, anche il Papa e il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, hanno aggiunto i loro.
 Per ribadire di fronte al mondo - come ha sottolineato Francesco - che «la fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità». Che si è «o fratelli o nemici». Altrimenti «crolla tutto e ci distruggiamo a vicenda». E noi, ha aggiunto il Pontefice, «siamo fratelli, nati da uno stesso Padre. Con culture, tradizioni diverse, ma tutti fratelli. E nel rispetto delle nostre culture e tradizioni diverse, delle nostre cittadinanze diverse, bisogna costruire questa fratellanza». Messaggio di pace che oltre tutto giunge mentre si prepara il viaggio in Iraq a maggioranza islamica.
Per ribadire di fronte al mondo - come ha sottolineato Francesco - che «la fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità». Che si è «o fratelli o nemici». Altrimenti «crolla tutto e ci distruggiamo a vicenda». E noi, ha aggiunto il Pontefice, «siamo fratelli, nati da uno stesso Padre. Con culture, tradizioni diverse, ma tutti fratelli. E nel rispetto delle nostre culture e tradizioni diverse, delle nostre cittadinanze diverse, bisogna costruire questa fratellanza». Messaggio di pace che oltre tutto giunge mentre si prepara il viaggio in Iraq a maggioranza islamica.Per il secondo anniversario dell’incontro di Abu Dhabi, dove il 4 febbraio 2019 insieme firmarono il Documento sulla fratellanza umana, il Papa e l’imam si sono di nuovo “riuniti”, questa volta sul web, per la prima Giornata internazionale sulla fratellanza umana, istituita il 21 dicembre 2020 dall’Onu, che l’ha fatta coincidere proprio con il giorno in cui avvenne la storica firma.
 È stata l’occasione non solo per ascoltare Francesco e Ahmad Al-Tayyeb chiamarsi nuovamente e reciprocamente «fratelli», ma anche per presentare i vincitori (presenti in collegamento) del primo Premio Zayed, ispirato anch’esso al documento, che quest’anno va al segretario generale dell’Onu, António Guterres, e a Latifa Ibn Ziaten, una mamma di cinque figli, che dopo averne perso uno, vittima del terrorismo, ha fondato un’associazione per i giovani e la pace, che porta il suo nome: Imad. Allo specialissimo “webinar” era presente anche il giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam, segretario generale dell’Alto Comitato per la fratellanza umana, cioè l’organismo che tramite una giuria internazionale ha scelto i premiati.
È stata l’occasione non solo per ascoltare Francesco e Ahmad Al-Tayyeb chiamarsi nuovamente e reciprocamente «fratelli», ma anche per presentare i vincitori (presenti in collegamento) del primo Premio Zayed, ispirato anch’esso al documento, che quest’anno va al segretario generale dell’Onu, António Guterres, e a Latifa Ibn Ziaten, una mamma di cinque figli, che dopo averne perso uno, vittima del terrorismo, ha fondato un’associazione per i giovani e la pace, che porta il suo nome: Imad. Allo specialissimo “webinar” era presente anche il giudice Mohamed Mahmoud Abdel Salam, segretario generale dell’Alto Comitato per la fratellanza umana, cioè l’organismo che tramite una giuria internazionale ha scelto i premiati.Le prime parole di papa Francesco sono state per l’imam, «fratello mio, amico mio, mio compagno di sfide e di rischi - ha rimarcato - nella lotta per la fratellanza». «La sua testimonianza - ha quindi proseguito il Pontefice - mi ha aiutato molto perché è stata una testimonianza coraggiosa. So che non era un compito facile. Ma con lei abbiamo potuto farlo insieme, e aiutarci reciprocamente. La cosa più bella è che quel primo desiderio di fratellanza si è consolidato in vera fratellanza. Grazie, fratello, grazie». Successivamente papa Bergoglio ha ringraziato lo sceicco Mohammed bin Zayed «per tutti gli sforzi che ha compiuto perché si potesse procedere in questo cammino. Ha creduto nel progetto. Ci ha creduto», ha detto. E un grazie il Papa lo ha detto anche al giudice Abdel Salam, «“l’enfant terrible” di tutto questo progetto, amico, lavoratore, pieno d’idee, che ci ha aiutato ad andare avanti». Espressioni di gratitudine e di affetto anche Guterres e Latifa.
Visibilmente contento, Francesco ha ribadito: «Grazie a tutti per aver scommesso sulla fratellanza, perché oggi la fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità. O siamo fratelli o ci distruggiamo a vicenda». E per questo ha messo in guardia dall’indifferenza: «Non possiamo lavarcene le mani, con la distanza, con la non-curanza, col disinteresse. O siamo fratelli o crolla tutto. È la frontiera. La frontiera sulla quale dobbiamo costruire; è la sfida del nostro secolo, è la sfida dei nostri tempi». Anche la «non-curanza», infatti, è per il Papa «una forma molto sottile d’inimicizia. Non c’è bisogno di una guerra per fare dei nemici. Basta la non-curanza. Basta con questa tecnica - si è trasformata in una tecnica -, basta con questo atteggiamento di guardare dall’altra parte, non curandosi dell’altro, come se non esistesse».
Bergoglio ha quindi spiegato che cosa intende per fratellanza. «Vuol dire mano tesa; fratellanza vuol dire rispetto. Fratellanza vuol dire ascoltare con il cuore aperto. Fratellanza vuol dire fermezza nelle proprie convinzioni. Perché non c’è vera fratellanza se si negoziano le proprie convinzioni». E perciò «un mondo senza fratelli è un mondo di nemici».
Anche da parte di Al-Tayyeb sono giunte parole di grande rispetto verso il Papa, «mio fratello, amico sulla via della fraternità e della pace». E la promessa di continuare a lavorare per il resto della sua vita con Francesco e con ogni sostenitore della pace «per rendere i principi di fratellanza umana una realtà in tutto il mondo». Da qui il suo auspicio concreto che il 4 febbraio sia «ogni anno un campanello d’allarme per il mondo e per i suoi leader, che li spinga a consolidare» questi principi.
 Guterres, dal canto suo ha ringraziato per il premio, definendolo «un riconoscimento per il lavoro dell’Onu». -E Latifa ha ricordato: «Ho perso un figlio, ma oggi riesco a raggiungere tanti bambini che ho salvato anche nei centri di detenzione, perché non cadessero nell’odio».
Guterres, dal canto suo ha ringraziato per il premio, definendolo «un riconoscimento per il lavoro dell’Onu». -E Latifa ha ricordato: «Ho perso un figlio, ma oggi riesco a raggiungere tanti bambini che ho salvato anche nei centri di detenzione, perché non cadessero nell’odio». -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- UN AMORE SEMPLICE. Lo sposalizio di Maria e Giuseppe (di Antonio Tarallo - L’Osservatore Romano).23 gennaio 2021, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE, MARIA, E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE... *
Lo sposalizio di Maria e Giuseppe
Un amore semplice
- [Foto] Raffaello, «Sposalizio della Vergine» (1504)
di Antonio Tarallo *
Si erge con magnifico splendore la pala del Raffaello, insigne maestro del Rinascimento: «Sposalizio della Vergine», olio su tavola firmato Raphael Vrbinas, datato mdiiii . Colpisce la maestria dei colori. Colpisce l’equilibrio perfetto delle forme. La scena del matrimonio di Maria e Giuseppe è posta in primo piano. Dietro di loro, al centro, un sacerdote. Tiene le mani di entrambi, custode delle nozze. Alla sinistra di Maria, le donne. A destra di Giuseppe, un gruppo di uomini. Nell’iconografia tradizionale, usualmente, proprio uno di questi uomini è colto nell’atto di spezzare un bastone. È un ramo secco destinato a non fiorire, a non portare frutto. Solo quello di Giuseppe, invece, fiorisce. Ma da dove proviene questa tradizione?
Secondo i vangeli apocrifi, Maria era cresciuta nel Tempio di Gerusalemme - conservando, quindi, la castità - e, quando giunta in età di matrimonio (secondo la tradizione ebraica) la troviamo promessa sposa di Giuseppe. Il Protovangelo di Giacomo ( ii secolo) ci fornisce alcune informazioni a riguardo. Giuseppe è discendente dalla famiglia di David e originario di Betlemme. Prima del matrimonio con Maria, si sposò con una donna con la quale ebbe sei figli. Rimase però, poi, vedovo. Ed è in questo contesto che si introduce la famosa tradizione del bastone fiorito di Giuseppe. Come? Andando ad approfondire il tema - grazie al lavoro che sta compiendo, da tempo, la Pontificia Accademia mariana internationale sul recupero di una vera ed autentica “storia di Maria”, su un sempre maggiore approfondimento della sua figura, scrostando le sovrastrutture che il tempo ha costruito sopra la Vergine - riusciamo a comprendere meglio questo “arcano” che si dipana tra tradizione e iconografia. Basterebbe pensare a tutte le immagini che raffigurano Giuseppe che tiene in mano un bastone fiorito. È, allora, assai interessante andare a scovare le parole che il vangelo apocrifo riserva a questo episodio: «Indossato il manto dai dodici sonagli, il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò a riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un angelo del Signore, dicendogli: “Zaccaria, Zaccaria! Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. Ognuno porti un bastone: sarà la moglie di colui che il Signore designerà per mezzo di un segno”. Uscirono i banditori per tutta la regione della Giudea, echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero. Gettata l’ascia, Giuseppe uscì per raggiungerli. Riunitisi, andarono dal sommo sacerdote, portando i bastoni. Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a pregare. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li restituì loro; ma in essi non v’era alcun segno. Giuseppe prese l’ultimo bastone: ed ecco che una colomba uscì dal suo bastone e volò sul capo di Giuseppe. Il sacerdote disse allora a Giuseppe: “Tu sei stato eletto a ricevere in custodia la vergine del Signore”». Fin qui, ciò che una errata tradizione ci dice. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su questo evento che ha segnato il piano di salvezza di Dio per l’umanità intera.
Il mese di Adar era il mese dei matrimoni. Un proverbio diceva: «Quando arriva Adar, Israele si riempie di gioia!». Troviamo una Maria quindicenne, allora. È una fanciulla che si avvicina all’età in cui le ragazze d’Israele erano solite contrarre matrimonio. Molto probabile che i genitori fossero già morti. Maria era, allora, nella casa di qualche parente della sua famiglia. Il capo di quella famiglia, come rappresentante del padre di Myriam, deve occuparsi del suo futuro. Viene concordato il matrimonio di Maria con Giuseppe. Sono poche le notizie che i Vangeli ci offrono sul “promesso sposo” di Maria. Del loro incontro, nulla sappiamo. È molto probabile che si conoscessero già prima del matrimonio. Il villaggio è piccolo: Nazaret, questo piccolo paese della Galilea.
Giuseppe era della stirpe reale di Davide e, in virtù del suo matrimonio con Maria, conferirà al figlio della Vergine - Figlio di Dio - il titolo legale di figlio di Davide. È l’adempimento delle profezie. Maria sa soltanto che il Signore l’ha voluta sposa di Giuseppe, un “uomo giusto”. Come immaginare, allora, il loro matrimonio? La tradizione giudaica antica ci viene in aiuto. Sappiamo bene che tutta la comunità del villaggio partecipava a questa gioia. Gran sfarzo di abiti. Frasi dell’Antico Testamento che riecheggiavano nella cerimonia: il Talmud, il libro principe di tutto. Gli anziani della città coprivano il loro capo con veli bianchi in segno di superiorità: sono gli anziani, gli uomini più rispettati della comunità. I bambini, in quel giorno così particolare, ricevevano dolci di miele e noci. E lo sposo faceva un regalo alla sposa, un regalo significativo.
«Il ragazzo e Maria si capivano senza parole, non c’era mai tra i due il minimo urto: sembrava che entrassero l’uno nell’altra, che costituissero un’unica persona, tanto era stretta la loro unione», così lo scrittore Pasquale Festa Campanile ci presenta i due coniugi nel suo romanzo Per amore, solo per amore (1983). E a noi, piace trovare in quella parola, «amore», l’infinito Amore di Dio per l’umanità, espresso proprio in un matrimonio, in una unione sponsale tra un giovane e una giovane. Così, semplicemente. Perché Dio è semplice nel suo Amore.
* Fonte: L’Osservatore Romano, 23 gennaio 2021
* Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Il Trittico di Mérode è un dipinto di Robert Campin, olio su tavola (129x64,50 cm) conservato nel Metropolitan Museum di New York, nella sezione The Cloisters, e databile al 1427. - Il trittico, formato tipico della produzione di Campin, poteva essere chiuso, ed era probabilmente destinato alla devozione privata. La scena centrale mostra l’Annunciazione, mentre gli scomparti laterali mostrano i due committenti inginocchiati e San Giuseppe al lavoro
- TEOLOGIA E BIOLOGIA: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio" (Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE...
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FLS
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---TEOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E SOCIETÀ. La fraternità come principio di ordine sociale (di Stefano Zamagni).19 gennaio 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA, E SOCIETÀ: LA COMUNE PATERNITÀ DI DIO, IL PROBLEMA DEI "TRE ANELLI", E I "FRATELLI TUTTI". A che gioco giochiamo?... *
- «Il deserto cresce; guai a chi in sè cela deserti» (F. Nietzsche) .
La fraternità come principio di ordine sociale
di Stefano Zamagni ("Bene comune", 31 dicembre 2020)
- Viviamo in un’epoca desertica del pensiero, che stenta a concepire la complessità della condizione umana. E’ un pensiero sbriciolato che fatica a vedere i rapporti fra le tante dimensioni della nostra crisi. Fraternità e amicizia sociale, al modo di vaccino sociale, ci indicano allora la via pervia di uscita dalla cupa situazione dell’esistente. In particolare la fraternità consente a persone che sono eguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali di esprimere diversamente il loro piano di vita, o il loro carisma, cioè la loro singolarità...
Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale è una autentica ispiera - il raggio di luce che, penetrando da una fessura in un ambiente in ombra, lo illumina rendendo visibile ciò che in esso staziona. Duplice la mira che la terza enciclica (dopo Lumen fidei, 2013 e Laudato sì, 2015) di papa Francesco persegue. Per un verso, risvegliare in tutti, credenti e non credenti o diversamente credenti, la passione per il bene comune, sollecitando tutti a trarne le conseguenze dirette. Per l’altro verso, fare chiarezza su concetti che troppo superficialmente vengono presi come sinonimi o quasi. La confusione di pensiero che ne deriva non giova né al dialogo né alla prospettazione delle necessarie linee di azione. Vedo di precisare.
Fraternità non ha lo stesso significato di fratellanza e ancor meno di solidarietà. Mentre quello di fratellanza è un concetto immanente che dice dell’appartenenza delle persone alla stessa specie o a una data comunità di destino, la fraternità è un concetto trascendente che pone il suo fondamento nel riconoscimento della comune paternità di Dio. La fratellanza unisce gli amici, ma li separa dai non amici; rende soci (socio è “colui che è associato per determinati interessi” (102) ) e quindi chiude gli uniti nei confronti degli altri.
 La fraternità, invece, proprio in quanto viene dall’alto (la paternità di Dio) è universale e crea fratelli, non soci, e dunque tende a cancellare i confini naturali e storici che separano. Il terzo termine che appare nella bandiera della Rivoluzione Francese (Liberté, egalité, fraternité) scaturisce dall’eguaglianza della specie e della natura di tutti gli uomini. Ma, come si legge nella Lumen fidei, 54, qualsiasi fraternità che sia priva del riferimento ad un Padre comune, quale suo fondamento, non riesce a sussistere.
La fraternità, invece, proprio in quanto viene dall’alto (la paternità di Dio) è universale e crea fratelli, non soci, e dunque tende a cancellare i confini naturali e storici che separano. Il terzo termine che appare nella bandiera della Rivoluzione Francese (Liberté, egalité, fraternité) scaturisce dall’eguaglianza della specie e della natura di tutti gli uomini. Ma, come si legge nella Lumen fidei, 54, qualsiasi fraternità che sia priva del riferimento ad un Padre comune, quale suo fondamento, non riesce a sussistere.Altrettanto diversa è la fraternità dalla solidarietà. È merito grande della cultura cristiana quello di aver saputo declinare, in termini sia istituzionali sia economici, il principio di fraternità facendolo diventare un asse portante dell’ordine sociale. È stata la scuola di pensiero francescana a dare a questo termine il significato che essa ha conservato nel corso del tempo. Ci sono pagine della Regola di Francesco che aiutano bene a comprendere il senso proprio del principio di fraternità. Che è quello di costituire, ad un tempo, il complemento e il superamento del principio di solidarietà. Infatti, mentre la solidarietà è il principio di organizzazione sociale che consente ai diseguali di diventare eguali, quello di fraternità è il principio che consente ai già eguali di esser diversi - si badi, non differenti.
La fraternità consente a persone che sono eguali nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali di esprimere diversamente il loro piano di vita, o il loro carisma, cioè la loro singolarità. Questa compresenza di uguaglianza e singolarità è ciò che caratterizza in modo unico il principio di fraternità. Le stagioni che abbiamo lasciato alle spalle, l’800 e soprattutto il ‘900, sono state caratterizzate da grosse battaglie, sia culturali sia politiche, in nome della solidarietà e questa è stata cosa buona; si pensi alla storia del movimento sindacale e alla lotta per la conquista dei diritti civili. Ma la buona società in cui vivere non può accontentarsi dell’orizzonte della solidarietà, perché mentre la società fraterna è anche una società solidale, il viceversa non è vero.
Cosa fa la differenza? La gratuità. Dove essa manca non può esserci fraternità. La gratuità, non è una virtù etica, come è la giustizia. Essa riguarda la dimensione sovraetica dell’agire umano; la sua logica è quella della sovrabbondanza. La logica della giustizia, invece, è quella dell’equivalenza, come già Aristotele insegnava. Capiamo allora perché la fraternità va oltre la giustizia. In una società, solo perfettamente giusta - posto che ciò sia realizzabile - non vi sarebbe spazio per la speranza. Cosa potrebbero mai sperare per l’avvenire i suoi cittadini? Non così in una società dove il principio di fraternità fosse riuscito a mettere radici profonde, proprio perché la speranza si nutre di sovrabbondanza.
Sorge spontanea la domanda: perché papa Francesco ha scelto la parabola del buon Samaritano come fondamento del suo approccio alla fraternità? La domanda ha senso perché il testo evangelico nulla dice (né lascia intendere) a proposito della relazione di reciprocità che, come sappiamo, è necessaria per conservare nel tempo il legame di fraternità. I rapporti tra fratelli sono di reciprocità, non di scambio e tanto meno di comando. La reciprocità è un dare senza perdere e un prendere senza togliere. Tra il Samaritano e la vittima che giace distesa a terra non sorge alcuna reciprocità. La parabola, dunque, è più icona della solidarietà o della fratellanza che non della fraternità in senso proprio. E allora? Il fatto è che papa Francesco con questa sua scelta ha voluto che comprendessimo appieno la differenza tra prossimità e vicinanza. Il levita e il sacerdote erano certamente vicini della vittima (tutti e tre giudei), ma non si sono fatti prossimo della stessa. Alla fratellanza basta la vicinanza; la fraternità postula la prossimità.
Dove ci portano, sul piano della pratica, le sottolineature di cui sopra? Per ragioni di spazio, soffermo qui l’attenzione su alcune soltanto delle implicazioni rilevanti quelle che reputo più urgenti per il tempo presente. Primo, occorre, una volta per tutte, rendersi conto dei guasti seri che la matrice culturale dell’individualismo libertario va producendo. L’individualismo è la posizione filosofica secondo cui è l’individuo che attribuisce valore alle cose e perfino alle relazioni interpersonali. Ed è sempre l’individuo il solo a decidere cosa è bene e cosa è male; quel che è lecito e illecito. In altro modo, è bene tutto ciò cui l’individuo attribuisce valore. Non esistono valori oggettivi per l’individualismo, ma solo valori soggettivi ovvero preferenze legittime. Di qui l’implicazione secondo cui si deve agire “etsi communitas non daretur” (come se la comunità non esistesse).
D’altro canto, il libertarismo è la tesi secondo cui per fondare la libertà e la responsabilità individuale è necessario ricorrere all’idea di autocausazione, per la quale pienamente libero è solamente l’agente auto-causato, quasi fosse Dio. Si può ora capire perché dal connubio tra individualismo e libertarismo, cioè dall’individualismo libertario, sia potuta scaturire la parola d’ordine di questa epoca: “volo ergo sum”, cioè, “io sono quel che voglio”. La radicalizzazione dell’individualismo in termini libertari, e quindi antisociali, ha portato a concludere che ogni individuo ha “diritto” di espandersi fin dove la sua potenza glielo consente. E’ la libertà come scioglimento dai legami l’idea oggi dominante nelle nostre società. Poiché limiterebbero la libertà, i legami sono ciò che deve essere sciolto. Equiparando erroneamente il concetto di legame a quello di vincolo si confondono i condizionamenti della libertà - i vincoli - con le condizioni della libertà - i legami, appunto. E questo perché l’individualismo libertario non riesce a concettualizzare la libertà di soggetti “quae sine invicem esse non possunt” (che senza reciprocità non possono essere). Se si ammette che la persona è un ente in relazione di prossimità con l’altro, il libertarismo non ha ragione d’essere.
Un secondo potente invito che ci viene dall’incalzante magistero di papa Francesco è quello di affrettare i tempi del passaggio dal modello tradizionale (e ormai obsoleto) di responsabilità ad un modello più ricco, all’altezza delle sfide in atto. L’interpretazione tradizionale di responsabilità la identifica infatti con il dare conto, rendere ragione (accountability) di ciò che un soggetto, autonomo e libero, produce o pone in essere. Tale nozione, postula dunque la capacità di un agente di essere causa dei suoi atti e in quanto tale di essere tenuto a “pagare” per le conseguenze negative che ne derivano. Questa, ancora prevalente, concezione della responsabilità lascia però in ombra il cosa significhi essere responsabili.
Da qualche tempo a questa parte, però, ha iniziato a prendere forma un’accezione di responsabilità che la colloca al di là del principio del libero arbitrio e della sola sfera della soggettività, per porla in funzione della vita, per fondare un impegno che vincoli nel mondo. Dal latino res-pondus, responsabilità significa essenzialmente portare il peso delle cose, prendersi cura dell’altro - come l’ “I care” di Lorenzo Milani (nella foto) ci ha insegnato. Non solamente si risponde “a” ma anche “di”. Da una parte, la responsabilità richiede, oggi, di porsi il problema dei vincoli cui le decisioni che assumiamo saranno esposte nel tempo per continuare ad essere efficaci. Dall’altra, la capacità di risposta non può essere solo riferita all’immediatezza delle circostanze presenti, ma deve includere quelle dimensioni temporali che assicurano una qualche continuità della risposta stessa. Ecco perché l’esperienza della responsabilità non può esaurirsi nella semplice imputabilità.
 E’ rimasta giustamente celebre l’affermazione di M.L. King secondo cui “può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Si è responsabili non solo e non tanto per quel che si fa, quanto piuttosto per quel che non si fa, pur potendolo fare. L’azione omissiva è sempre più grave di quella commissiva.
E’ rimasta giustamente celebre l’affermazione di M.L. King secondo cui “può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”. Si è responsabili non solo e non tanto per quel che si fa, quanto piuttosto per quel che non si fa, pur potendolo fare. L’azione omissiva è sempre più grave di quella commissiva.Di una terza implicazione pratica del discorso sviluppato in Fratelli tutti giova dire. Se si vuole avere ragione dell’indegno fenomeno delle crescenti ingiustizie sociali e della diffusione a macchia d’olio di atteggiamenti aporofobici - l’aporofobia nel senso di A. Cortina è il disprezzo del povero e del diverso - occorre pensare seriamente ad un modello credibile di governance a livello globale. Qual è la difficoltà a tale riguardo? Quella di come conciliare le regole della governance interna dei singoli paesi, ognuno dei quali ha la sua storia specifica, le sue norme sociali di comportamento, la sua matrice culturale con l’uniformità delle regole che inevitabilmente caratterizzano la governance globale. Mai dimenticare, infatti, che i vincoli esterni al paese, quando questo deve dare forma alle proprie politiche domestiche, comportano sempre un costo in termini di legittimità democratica - costo che, come in questo tempo sta accadendo, finisce col rafforzare le spinte irrazionali verso il populismo sovranista. Si tratta allora di scegliere tra due concezioni alternative di governance economica globale, note come “globalization enhancing global governance” e “democracy-enhancing global governance”.
L’idea di fondo della seconda opzione è che quando si mette mano al disegno delle regole a livello transnazionale occorre inserire tra gli obiettivi da perseguire non solamente l’aumento dell’efficienza nell’allocazione delle risorse, e quindi del reddito, ma anche l’allargamento della base democratica. Per dirla in altro modo, è bensì vero che la globalizzazione accresce lo spazio dei diritti umani negativi (cioè la libertà da), ma restringe lo spazio, se non corretta da clausole di salvaguardia sociale, dei diritti umani positivi (cioè la libertà di). Papa Francesco non esita a prendere posizione a favore della seconda opzione. (Cfr. n.154 e segg.).
Una novità di non poco conto di questa enciclica, che non è passata inosservata e che continuerà a lungo a far discutere, è costituita dal cap. V, significativamente e provocatoriamente intitolato “La migliore politica”. Vi sono due modi errati - ci dice papa Francesco - di porsi di fronte alle sfide di questo momento. Da un lato, quello di chi cede alla tentazione di restare al di sopra della realtà con l’utopia; dall’altro, quello di chi si colloca al di sotto della realtà con la distopia, con la rassegnazione. Non possiamo cadere in trappole del genere. Non possiamo vagare tra l’ottimismo spensierato di chi vede il processo storico come una marcia trionfale dell’umanità verso la sua completa realizzazione e il cinismo disperante di chi pensa, con Kafka, che “esiste un punto di arrivo, ma nessuna via”.
Accogliere lo sguardo della fraternità significa oggi, questo: non considerarsi né come il mero risultato di processi che cadono fuori del nostro controllo, né come una realtà autosufficiente senza bisogno di rapporti con l’altro. Significa, in altri termini, pensare che ciò che ci aspetta non è mai del tutto determinato da quanto ci precede. Se si vuole che l’ordine sociale che chiamiamo capitalismo possa rispettare pienamente il diritto di ciascun individuo a decidere da sé come dare valore alla propria vita e, al tempo stesso, possa dimostrare uguale considerazione per il destino di ciascuna persona, non c’è altra via che quella della politica, ma che sia migliore! Prendere atto che il capitalismo rischia oggi la paralisi, o, peggio, il collasso, perché sta diventando più capitalistico di quanto gli sia utile, è il primo passo per avviare un progetto credibile di trasformazione dell’esistente ordine sociale.
Un passo famoso di William Blake - poeta e artista nutrito delle Sacre Scritture - ci aiuta ad afferrare la potenza del principio di fraternità: “Ho cercato la mia anima e non l’ho trovata. Ho cercato Dio e non l’ho trovato. Ho cercato mio fratello e li ho trovati tutti e tre”. Invero, è nella pratica del dono come gratuità che la persona incontra congiuntamente il proprio io, l’altro e Dio. Viviamo in un’epoca desertica del pensiero, che stenta a concepire la complessità della condizione umana. E’ un pensiero sbriciolato che fatica a vedere i rapporti fra le tante dimensioni della nostra crisi. Fraternità e amicizia sociale, al modo di vaccino sociale, ci indicano allora la via pervia di uscita dalla cupa situazione dell’esistente.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CIVILTÀ DELL’AMORE E VOLONTÀ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica di Papa Ratzinger.
"AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FLS
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- LA NOTTE DI NATALE. «Te piace ’o presepio?» ("Ti piace il presepe?").21 dicembre 2020, di Federico La Sala
IL PRESEPE E LA NOTTE DI NATALE. La lezione di Pirandello (1918) e di Eduardo De Filippo (1931):
A) PIRANDELLO (Un "Goj",1918) .
B)EDUARDO DE FILIPPO ("Natale in casa Cupiello", 1931) *
Natale in casa Cupiello è un’opera teatrale tragicomica scritta da Eduardo De Filippo nel 1931.
Genesi dell’opera
Portata in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli (oggi Cinema Filangieri), il 25 dicembre 1931, Natale in casa Cupiello segna di fatto l’avvio vero e proprio della felice esperienza della Compagnia del "Teatro Umoristico I De Filippo", composta dai tre fratelli e da attori già famosi o giovani alle prime armi che lo diventeranno (Agostino Salvietti, Pietro Carloni, Tina Pica, Dolores Palumbo, Luigi De Martino, Alfredo Crispo, Gennaro Pisano). A giugno Eduardo aveva firmato un contratto con l’impresario teatrale che lo impegnava per soli nove giorni di recite per presentare il suo nuovo atto unico subito dopo la proiezione di un film. Il successo della commedia fu tale che la durata del contratto fu prolungata sino al 21 maggio 1932. -Originariamente si trattava di una commedia ad atto unico (quello che, nella versione definitiva, costituisce oggi il secondo atto), ampliato successivamente in due distinte fasi: la prima, nel 1932, vide aggiungersi l’attuale primo atto e la conclusiva, nel 1934[1] (secondo anche quanto dichiarato da Eduardo sul numero 240 della rivista Il Dramma uscito nel 1936) o nel 1937[2] o addirittura nel 1943 (secondo un’ipotesi avallata più tardi dallo stesso autore[3]), che configurò l’opera nella sua versione attuale, composta da tre atti. La complessa genesi della commedia portò Eduardo stesso ad affermare che essa era nata come un "parto trigemino con una gravidanza di quattro anni" [4].
Trama
La scena si svolge nell’arco di circa cinque giorni nella casa della famiglia Cupiello, della quale vengono rappresentate la camera da letto (atti I e III) e la sala da pranzo (atto II).
I atto
È la mattina dell’antivigilia di Natale. Luca Cupiello e sua moglie Concetta si svegliano, ma il loro risveglio è reso comicamente faticoso dalle bizze dell’uomo, che si lamenta per il freddo e per il pessimo caffè che lei gli ha preparato. Luca è un fervente amante delle tradizioni natalizie, e non vede l’ora di potersi dedicare maniacalmente alla composizione del Presepe, nonostante le critiche della moglie e del figlio Tommasino (Nennillo), che lo ritengono anacronistico (questa situazione costituirà una gag ricorrente per tutta la messa in scena). La sua impresa è inoltre resa difficoltosa dall’intervento di suo fratello Pasqualino, scapolo collerico in perenne guerra col pestifero Nennillo; Luca sembra inoltre avere alcune difficoltà nei movimenti e nel ricordare le cose, tragicomiche anticipazioni del dramma che seguirà. Irrompe in casa la figlia Ninuccia, agitata per l’ennesima lite con suo marito Nicolino. Ninuccia, che non ha mai amato il marito, vuole scappare con il suo amante Vittorio e confessa alla madre di voler lasciare Nicolino a cui ha scritto una lettera di addio. La donna, a causa delle forti resistenze della madre, ha un attacco nervoso e, nell’impeto, rompe alcune suppellettili e la struttura del presepe. Nel caos che segue Concetta ha un mancamento, e riesce a strappare a Ninuccia la promessa di fare la pace con Nicolino; tuttavia nel trambusto la ragazza perde la lettera, che sarà ritrovata da Luca il quale, ignaro di tutto, la consegna a Nicolino.
II atto
In casa Cupiello è tutto pronto per festeggiare la vigilia di Natale. Tommasino, ignaro della relazione della sorella, arriva a casa accompagnato da Vittorio che, oltre a essere l’amante di sua sorella, è anche suo amico. Il ragazzo insiste perché si trattenga qualche minuto a casa sua. Rimasti soli, Concetta chiede a Vittorio di andarsene immediatamente e permettere a Ninuccia di salvare il suo matrimonio con Nicolino: quest’ultimo infatti, dopo aver letto la lettera consegnatagli incolpevolmente dal suocero, è a conoscenza della loro relazione, e solo i copiosi sforzi di Concetta hanno evitato il peggio. In quel momento tuttavia rincasa Luca che, anch’esso ignaro della relazione extraconiugale della figlia, insiste perché Vittorio si fermi a cena. La serata prosegue con una tensione di sottofondo, stemperata dai pasticci di Luca, Nennillo e Pasqualino e da mille disavventure che costellano la preparazione della cena. Approfittando di un momento di solitudine, Ninuccia e Vittorio hanno un drammatico incontro che sfocia nell’esplosione della passione tra i due; Nicolino li sorprende nell’atto di scambiarsi un dolce bacio, e accusa Ninuccia e Concetta di averlo ingannato. I due uomini e Ninuccia abbandonano quindi la casa per potersi sfidare a duello. Mentre Concetta, rimasta sola in scena, si dispera, giungono Luca, Pasqualino e Tommasino vestiti da re magi con i loro regali per lei.
III atto
Venuto brutalmente a conoscenza della situazione familiare, Luca, per anni vissuto nell’illusione di aver creato una famiglia felice, ha un colpo apoplettico e si ritrova a letto in preda a difficoltà motorie e verbali per l’ictus sopravvenuto. L’intero vicinato è ormai costantemente presente al suo capezzale, dove Luca accusa deliri e allucinazioni che hanno come protagonista il genero Nicolino, che ha lasciato immediatamente la moglie e si è recato da alcuni suoi parenti a Roma. Pur nel delirio Luca spera ancora di vederlo riappacificato con sua figlia, la quale è distrutta dal dolore in quanto è perfettamente cosciente che su di lei ricadono le colpe della malattia del padre. Sopraggiunge il medico, che improvvisa una diagnosi incoraggiante alla moglie ed alla figlia di Luca, ma rivela invece al fratello la cruda verità: Luca non ha scampo e la sua morte è ormai questione di ore. Una improvvisa visita dell’amante Vittorio, che si sente moralmente responsabile dello stato di salute di Luca, ne provoca l’ennesimo equivoco allucinatorio e Luca, scambiandolo per Nicolino, arriva a benedire inconsapevolmente l’unione dei due amanti proprio all’arrivo del marito di lei, che viene subito trattenuto a viva forza e portato fuori dai presenti. Luca Cupiello, ormai definitivamente ripiegato nelle sue allucinazioni, si avvia così a morire ignaro ancora una volta della realtà.
Tommasino, alla domanda che suo padre gli rivolge in punto di morte, «Te piace ’o presepio?» ("Ti piace il presepe?"), alla quale egli in precedenza aveva sempre risposto di no con stizzita protervia, finalmente si "scioglie" e tra le lacrime gli sussurra un laconico sì, proprio mentre suo padre sembra entrare nella gioiosa allucinazione di un "enorme presepe nei cieli".
* Fonte: Wikipedia (ripresa parziale).
C) "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi" (Emilio Gentile).
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- Con lo stesso nome di Dio (di Luigino Bruni).18 ottobre 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra /29.
Con lo stesso nome di Dio
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 17 ottobre 2020)
- Il divieto sulle immagini era un precetto capitale che fatalmente sarebbe stato violato. Innanzitutto da YHWH stesso, che aveva plasmato l’uomo "a nostra immagine e a nostra somiglianza". YHWH aveva voluto creare un essere a immagine di se stesso - e anche a quell’essere si sarebbe trasmessa l’inclinazione a creare qualcosa a immagine di se stesso
- Roberto Calasso, Il libro di tutti i libri
In alcune regioni italiane, e tra queste la mia, in certi dialoghi intimi le madri e i padri chiamano il figlio e la figlia con il loro stesso nome. Gli dicono: "Dai, mamma, fai il buono", "Ma quanto sei brava, babbo". Lo dicono ai bambini, ma a volte continuano a chiamarli così anche da adulti. Non è scritto in nessun libro di grammatica, non lo si impara a scuola. Lo ripetiamo perché lo abbiamo sentito dai nostri genitori, in giorni meravigliosi. Sono parole diverse assimilate per osmosi, e poi trasmesse da una generazione a un’altra, parte di quella trasmissione dell’essenziale della vita. Sono tra le parole più belle nei dialoghi del cuore, in quei tu-a-tu delicati e segreti, che contengono tutta la tipica e unica tenerezza che scorre tra genitori e figli, che nutre gli uni e gli altri, sempre, ma soprattutto nei momenti delle grandi gioie e dei grandi dolori.
La Bibbia ci dice che il primo che ci ha chiamato con il suo stesso nome è stato ed è Dio, quando ci ha creato "a sua immagine e somiglianza". Dicendoci disse se stesso, e ripete il nostro nome in ogni attimo. Perché se da una parte il Dio biblico è la divinità più trascendente e diversa di tutte, dall’altra non c’è nulla sulla Terra che gli assomigli più di un essere umano, non c’è cuore più simile al suo del nostro, non c’è nome che più del nostro abbia lo stesso suono del suo. La Bibbia ebraica ci ha tolto l’immagine di Dio, ma ci ha donato una meravigliosa immagine di uomo e di donna: nascondendoci il volto di Dio ha esaltato il nostro volto. E allora ogni volta che si ama e si rispetta il nome di un uomo o di una donna si sta amando e rispettando anche il nome di Dio; e, per la legge di reciprocità, ogni volta che un uomo prega e loda il nome di Dio sta pregando e lodando l’umanità intera, ogni uomo e ogni donna.
Nasce qui lo sguardo positivo che la Bibbia, con tenacia e resilienza, ha sugli uomini e sulle donne. Ne vede i limiti, i peccati, gli omicidi e i fratricidi, ma prima e soprattutto ne vede l’immagine di Dio riflessa, non è capace di uscire dall’Eden. Vede i molti gesti degli uomini, ma prima continua a vederlo nel suo dialogo con Elohim sul finire del giorno. Come le madri e i padri, che anche quando la vita porta i loro figli a fare cose brutte e pessime, per salvarsi e salvarli continuano a sognarli bambini puri e bellissimi, a chiamarli fino alla fine "babbo" e "mamma", anche dentro le carceri. Tra la fede, la speranza e l’agape c’è lo stesso tipo di rapporto che lega le tre Persone divine: in ognuna ci sono le altre due, ciascuna è rivolta contemporaneamente verso le altre, è impossibile separarle senza distruggerle tutte. E così nei Salmi, pur popolati da sentimenti di tristezza, di delusione e di dolore, più forte e più grande è lo sguardo di speranza-fede-amore che domina l’intero Salterio, che lo rende forse il libro più bello di tutti, perché il libro più capace di parlarci di paradiso dagli inferi, di speranza dentro la disperazione, di bellezza in mezzo alla bruttezza.
La forza dei Salmi sta nella loro verità. Un inferno vero è preferibile a un paradiso finto, perché finché chiamiamo l’inferno col suo vero nome possiamo sempre desiderare un paradiso, che invece non desideriamo più se pensiamo di averlo già raggiunto: «Alleluia. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d’Israele; risana i cuori affranti e fascia le loro ferite... Intonate al Signore un canto di grazie, sulla cetra cantate inni al nostro Dio» (Salmo 147,1-7). È bello cantare inni al Signore. È bello e buono lodare YHWH, è bello e buono per Dio ma è bello e buono anche per noi. Il salmo inizia con una lode della lode. È il momento di auto-coscienza dell’orante, che arriva (se arriva) quando ci rendiamo conto che il primo premio della lode è prendere coscienza della sua bellezza e del suo dono intrinseco. Quando scopriamo che noi preghiamo per lodare Dio, ma mentre cantiamo sentiamo che è Dio che sta lodando e cantando noi. Noi diciamo il suo nome e un giorno sentiamo che in realtà è Dio che sta dicendo il nostro, e che nel nostro nome dice il nome di tutti, il nome di ogni creatura, il nome delle stelle e dell’universo intero. Ed è meraviglia. E mentre cerchiamo le parole e le note più belle e alte per lodare Dio stiamo anche imparando le note e le parole più belle per lodarci gli uni gli altri. Forse non c’è stata una parola splendida pensata per dar lode a Dio che qualche poeta non abbia usata anche per una persona amata, e forse non c’è poesia d’amore che qualcuno, in un altro giorno, magari senza saperlo, ha usato per cantare Dio. Anche tutto questo è immagine e reciprocità. Benedicendo gli umani abbiamo imparato a benedire Dio, e benedicendo Dio stiamo già benedicendo uomini e donne, anche se non lo sappiamo.
L’essere immagine del Creatore rende immediatamente la nostra lode a Dio una lode cosmica: «Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome... Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l’erba sui monti, provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano» (147,4;8-9). Essere immagine di Elohim ci rende più grandi della sola immagine umana. Sentiamo fin da piccoli una profonda fraternità cosmica - solo i bambini sanno sentire veramente fratelli e sorelle i gatti e gli uccellini, i fiori e le foglie -, dovremmo riuscire a non perderla invecchiando e se la vita funziona questa grande fraternità cresce con noi, e si conclude con il canto per sorella morte.
 La fraternità inter-umana non ci basta, è troppo piccola sebbene già immensa. Perché la fraternità e sororità umana siano autentico umanesimo, dobbiamo imparare a sentire sorelle anche le stelle, il sole, gli uccellini, la natura intera - ci sono pochi canti (se ce ne sono) più biblici del Cantico di Francesco. Molto bello e delicato è qui il riferimento ai «piccoli del corvo che gridano». In questo verso ci sono i corvi che nutrivano Elia nella sua fuga (1 Re 17,6), ma ci sono anche gli uccellini del nido guardati dalla Legge di Mosè, che comanda di non catturare la madre-uccello che cova le sue uova o custodisce i suoi piccoli, di lasciarla volare via, «perché tu sia felice e goda lunga vita» (Dt 22,7). Una Legge di YHWH che scruta anche dentro un nido di uccelli, e poi pone una equivalenza che a noi può apparire ardita e stupenda. La promessa riservata a chi lascia volar via la madre senza catturarla è la stessa promessa del Quarto comandamento, Onora tuo padre e tua madre: «Perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice» (Dt 5,16).
La fraternità inter-umana non ci basta, è troppo piccola sebbene già immensa. Perché la fraternità e sororità umana siano autentico umanesimo, dobbiamo imparare a sentire sorelle anche le stelle, il sole, gli uccellini, la natura intera - ci sono pochi canti (se ce ne sono) più biblici del Cantico di Francesco. Molto bello e delicato è qui il riferimento ai «piccoli del corvo che gridano». In questo verso ci sono i corvi che nutrivano Elia nella sua fuga (1 Re 17,6), ma ci sono anche gli uccellini del nido guardati dalla Legge di Mosè, che comanda di non catturare la madre-uccello che cova le sue uova o custodisce i suoi piccoli, di lasciarla volare via, «perché tu sia felice e goda lunga vita» (Dt 22,7). Una Legge di YHWH che scruta anche dentro un nido di uccelli, e poi pone una equivalenza che a noi può apparire ardita e stupenda. La promessa riservata a chi lascia volar via la madre senza catturarla è la stessa promessa del Quarto comandamento, Onora tuo padre e tua madre: «Perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice» (Dt 5,16).Nella Bibbia tutto è creazione: tutto è figlio. Dio guarda così il mondo, è così che ci guarda, e noi, sua immagine, impariamo a guardare il mondo nello stesso modo, anche se ancora tutta la creazione "geme ed è in travaglio", perché "attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio" (Rm 8,19-23). Tutta la creazione geme e attende di essere guardata finalmente così. Mai come in questi anni di crisi ambientale e di distruzione del pianeta siamo nelle condizioni di poter capire i Salmi e quel misterioso passaggio di Paolo ai Romani: la terra soffre e attende che gli uomini finalmente si rivelino per quello che sono, che si comportino con essa da figli, e immagine, di Dio creatore e padre.
 Il Salmo 147 si distingue poi anche per il suo essere un canto civile. Non ci sono né sacerdoti né re, non è menzionato Davide né si allude al tempio. Sono i cittadini a elevare il loro canto, coloro che conoscono i tempi e i ritmi delle stagioni e del lavoro, il valore della pace e del pane quotidiano. Un salmo molto amato da sempre dai contadini: «Dio ha messo la pace sulle tue frontiere, e ti sazia con fior di farina... Invia la neve come lana e sparge come cenere la brina, i suoi ghiacci formano blocchi: chi potrà reggere tanto gelo? Invia un ordine: ecco il disgelo, soffia il suo alito e scorrono le acque» (139,14-18). Tutta la terra è avvolta da uno sguardo buono, tutto è retto da provvidenza.
Il Salmo 147 si distingue poi anche per il suo essere un canto civile. Non ci sono né sacerdoti né re, non è menzionato Davide né si allude al tempio. Sono i cittadini a elevare il loro canto, coloro che conoscono i tempi e i ritmi delle stagioni e del lavoro, il valore della pace e del pane quotidiano. Un salmo molto amato da sempre dai contadini: «Dio ha messo la pace sulle tue frontiere, e ti sazia con fior di farina... Invia la neve come lana e sparge come cenere la brina, i suoi ghiacci formano blocchi: chi potrà reggere tanto gelo? Invia un ordine: ecco il disgelo, soffia il suo alito e scorrono le acque» (139,14-18). Tutta la terra è avvolta da uno sguardo buono, tutto è retto da provvidenza.Dopo averci donato fin qui parole bellissime su Dio e su di noi, il Salmo termina lodando direttamente la parola, e l’Alleanza e la Legge che ne sono il culmine (147,19-20). La parola è vista come un messaggio inviato per noi, una intelligenza che ci fa scoprire l’ordine e il senso della creazione: «Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce» (147,15). La parola è anche logos, è ragionamento e ordine. Israele ha stimato la parola in una misura altissima e per noi oggi incomprensibile. Ne ha fatto esperienza straordinaria con i Patriarchi, con Mosè e i profeti - "... e c’era soltanto una voce". Dovendo rinunciare all’immagine di Dio ha maturato una immensa competenza sulla parola, ha dovuto imparare a disegnare Dio con le parole, ha scoperto le mille dimensioni nascoste dentro la parola biblica e nelle parole umane. Una grande povertà produsse una ricchezza infinita. Forse non avremo la straordinaria tradizione letteraria occidentale senza questa parola biblica privata delle immagini, che la costrinse a diventare immagine senza diventare idolatria.
Quando Giovanni scrisse il Prologo del suo Vangelo, uno dei brani più geniali della storia, aveva in mente molte cose, ma certamente pensava alle parole dei Salmi, a quel logos capace di benedire l’uomo mentre benediceva e lodava Dio. Nel dirci che quel logos si era fatto carne, che era diventato uomo come noi, ci ha detto molte cose e tutte stupende, e ci ha chiamato ancora con lo stesso nome di Dio. E continua a chiamarci così ogni giorno.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- Arte e fede. Gerusalemme: sui muri del Colosseo la mappa della “sposa contesa” (di Gianfranco Ravasi).16 ottobre 2020, di Federico La Sala
Arte e fede.
Gerusalemme: sui muri del Colosseo la mappa della “sposa contesa”
Il dialogo interreligioso tra i monoteismi e quello ecumenico, tra cristiani d’Occidente e cristiani d’Oriente, è nell’imprinting stesso di Gerusalemme e dovrebbe essere impegno costante di tutti
di Gianfranco Ravasi *
- Si è concluso di recente il cantiere di restauro dell’affresco raffigurante una veduta ideale della città di Gerusalemme, realizzato nell’Anfiteatro Flavio sull’arco di fondo della Porta Triumphalis, verso il Foro Romano. -***Il dipinto è ascrivibile al XVII secolo, come conferma il risultato del restauro, che ha consentito di confermare la fonte iconografica nella stampa unita alla seconda edizione del volumetto del teologo Christian van Adrichom Urbis Hierosolimae quemadmodum ea Christi tempore floruit (1585), disegnata e incisa da Franz Hogenberg e Arnold de Loose.
- Il restauro sarà presentato oggi, alle 17.30, con una lectio magistralis del cardinale Gianfranco Ravasi (che ne anticipa in queste colonne i punti principali) la cui registrazione sarà disponibile sul canale Facebook e sulla pagina YouTube del Parco archeologico del Colosseo a partire dalle ore 19.00 di sabato 23 ottobre.
Ai mille legami storici, religiosi e culturali che collegano Roma e Gerusalemme si aggiunge la sorprendente mappa simbolica della città santa all’interno di uno dei segni maggiori della romanità classica, il Colosseo. In occasione del suo restauro sono stato invitato a proporre un profilo biblicoculturale di Gerusalemme proprio all’interno di quello spazio così emblematico com’è l’Anfiteatro Flavio.
Tutte e tre le religioni monoteistiche sono protese verso Sion che è simile a una sposa contesa, spiritualmente e materialmente. Basta solo gettare uno sguardo su una mappa dell’area antica della città. Si leggono le indicazioni topografiche di un quartiere ebraico, di uno cristiano, di un altro musulmano e di quello armeno. Se si avanza per quelle viuzze e si entra nei luoghi sacri delle varie religioni, si sente parlare in arabo ed ebraico, in greco e armeno, in siriano ed etiopico, in russo e inglese o in yiddish: si prega e si discute in almeno quindici lingue con sette alfabeti differenti! Ma tutti sono certi di avere un legame unico, insostituibile, inscindibile con quella città.
Infatti, le tre grandi fedi monoteistiche hanno in questa città ciascuna una sua pietra reale e simbolica su cui fondarsi. Così, gli Ebrei non possono non risalire a Davide e fondarsi sulla pietra sacra del tempio eretto da suo figlio Salomone (anche se le pietre del cosiddetto Muro del pianto sono di un millennio dopo, appartenendo al tempio eretto da Erode). È, infatti, questo il cuore della fede e della storia di Israele.
Un famoso detto rabbinico afferma che «il mondo è come l’occhio: il mare è il bianco, la terra è l’iride, Gerusalemme è la pupilla e l’immagine in essa riflessa è il tempio». Il poeta ebreo spagnolo Giuda Levita, che la leggenda farà morire nel 1140 calpestato dai cavalli appena giunto pellegrino a Sion, cantava: «Io amo le tue pietre che voglio baciare e saporite mi saranno le tue zolle più del miele!». Ma già il Salmista aveva esclamato: «Ai tuoi servi sono care le pietre di Sion!» (Salmo 102,15). Gesù stesso era convinto che queste pietre possono gridare una storia di fede e di sangue (Luca 19,40). Elena, la madre di Costantino, era giunta qui nel 326 alla ricerca delle memorie di Gesù e in particolare della sua tomba.
La pietra ribaltata del sepolcro di Cristo, ora custodita nella possente basilica crociata omonima, è il cuore della cristianità, che da allora non si è staccata più da Gerusalemme, pur sfrangiandosi in decine di comunità diverse (per i cattolici pensiamo alla presenza francescana) e non esitando a ricorrere alle crociate. Quella pietra, custodita nella basilica del Santo Sepolcro, è il segno della risurrezione, il mistero centrale della fede cristiana.
Anche i musulmani hanno a Gerusalemme una loro pietra fondante, quella che è protetta dalla sfolgorante cupola dorata della moschea di Omar, memoria del sacrificio di Abramo (Genesi 22) ma soprattutto dell’ascensione al cielo del Profeta, Maometto, che è ricordato anche dall’altra moschea della Spianata, al’Aqsa, come si legge nel Corano: «Lode a Dio che trasportò di notte il suo Servo [Maometto] dalla moschea sacra [Mecca] alla moschea al-’Aqsa [l’altra, più lontana]» (17,1). È per questo che in arabo Gerusalemme è al-Quds, cioè “la (città) santa” per eccellenza.
Tre pietre, quindi, sono per le tre religioni - che pure in Abramo hanno una radice comune - segno di una presenza propria, non solo spirituale ma anche “fisica”. È per questo che Gerusalemme è oggetto di un amore non solo ideale e quelle pietre sono state striate nella loro storia secolare anche dal sangue. È per questo che è arduo trovare accordi politici o religiosi attorno a questo simbolo così "personale".
Eppure il testo sacro ebraico-cristiano, la Bibbia che cita 656 volte Gerusalemme, è un ininterrotto appello a ritrovare unità nella molteplicità in Sion. Come sogna il profeta Sofonia verso la fine del VII secolo a.C., «allora io darò ai popoli un labbro puro perché tutti invochino il nome del Signore e lo servano tutti spalla a spalla» (3,9).
Certo, prima di ogni altro popolo è Israele che convergeva verso la città santa non solo nelle cosiddette “feste di pellegrinaggio”, cioè Pasqua, Settimane (o “Pentecoste”) e Capanne, che postulavano un itinerario orante al tempio di Sion, ma anche nella testimonianza orante e poetica - adottata pure dalla liturgia e dalla fede cristiana - dei “cantici delle ascensioni”, cioè in quel fascicolo di 15 Salmi (dal 120 al 134) che nel Salterio recano questo titolo. Essi sembrano appartenere quasi a un libretto del pellegrino che “ascende” materialmente (Gerusalemme è a 800 metri di altezza) e spiritualmente verso la città di Dio. Basterebbe solo ascoltare alcune battute del Salmo 122: «Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore! E ora i nostri piedi sono fermi alle tue porte, Gerusalemme! Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Là salgono insieme le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore!».
Anzi, quell’itinerario verso le proprie sorgenti di fede e di vita si trasforma in un’esperienza non solo mistica ma anche esistenziale. Certo, prima di tutto c’è la gioia di un incontro col mistero di Dio perché lassù si sale «per lodare il nome del Signore», ossia per il culto: «L’anima mia languisce e brama gli atri del Signore, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re e mio Dio!» (Salmo 84,3-4).
Ma a Gerusalemme avviene anche un’altra esperienza di indole più sociale. «Là, infatti, sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide», canta l’orante del Salmo (v. 5). Si aveva nella capitale l’istanza suprema del potere politico e giudiziario e idealmente il popolo trovava quella giustizia a cui tanto anelava e che altrove gli era negata. In questa linea è capitale la voce dei profeti che ininterrottamente combattono ogni sacralismo fine a se stesso. Il tempio stesso, se privo di fede e di giustizia, è «una spelonca di ladri» (Geremia 7,11; cfr. Matteo 21,13), il culto senza l’impegno dell’esistenza è magia, i riti senza vita sono una farsa. Implacabili sono le parole di Isaia: «Quando vi presentate a me - dice il Signore - chi vi chiede di venire a calpestare i pavimenti del tempio? Finitela di presentare offerte inutili! L’incenso mi fa nausea, come noviluni, sabati, assemblee sacre. Non riesco a sopportare delitto e solennità. Odio i vostri noviluni e le vostre feste: sono un peso per me e sono stanco di sopportarli. Quando alzate le mani, io allontano da voi gli occhi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non le ascolto. Le vostre mani, infatti, grondano sangue. Allora, lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista! Smettetela di fare il male, imparate e fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!» (1,12-17).
Questa prospettiva è esaltata anche da Cristo che, pur amando e frequentando Sion, non esita a “smitizzarne” la funzione materiale sacrale per celebrarne il valore di santità, di simbolo di gloria, di pace e di vita. Infatti, di fronte al tempio di Gerusalemme Gesù non esita a dire: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere!». E Giovanni annota: «Egli parlava del tempio del suo corpo e, quando fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo» (2,19-22). Anzi, Gesù - stando al Vangelo di Marco - avrà come capo di imputazione iniziale durante il processo presso il tribunale giudaico del Sinedrio proprio questa testimonianza: «Noi lo abbiamo udito dire: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d’uomo» (14,58). È in questa luce che l’ultimo libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse, non solo sostituisce alla Gerusalemme terrena, materiale e spaziale, «la città santa, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da Dio» (21,2) ma la descrive come ormai priva del tempio: «Non vidi in essa alcun tempio perché il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio» (21,22).
È proprio su questa traiettoria ideale che possiamo pensare alle divisioni di Gerusalemme sotto una nuova luce. Quei segni di sacralità, di separatezza e di separazione potrebbero diventare simboli di santità, di comunione, di incontro. È ciò che aveva configurato il profeta Isaia in una sua pagina indimenticabile (2,1-5). Gerusalemme si erge come un monte immerso nella luce su un pianeta avvolto nel sudario delle tenebre. In essa sfolgora la Parola divina. Ed ecco che da ogni angolo di quel mondo oscuro si muovono processioni di popoli che convergono verso quella città di luce. Giunti lassù, essi trasformano le armi che impugnano: «Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra» (2,4).
Finalmente Gerusalemme attuerà il suo nome di città di shalôm, della pace. Perché là tutti hanno un ideale diritto nativo di cittadinanza che li dovrebbe rendere fratelli e non avversari. È ciò che canta il Salmo 87 che descrive le nazioni mentre danzano e cantano rivolti a Sion: «Sono in te tutte le nostre sorgenti«. In questo canto “natale” di Gerusalemme come genitrice di tutte le nazioni per tre volte nell’originale ebraico risuona la locuzione jullad sham/bah, “è nato là / in essa”. Tutti i punti cardinali della terra, pur nella loro diversità, sentono di appartenere a un’unica matrice: c’è Rahab, cioè l’Egitto, la grande potenza occidentale, e c’è Babele, la grande potenza orientale babilonese; c’è Tiro, la potenza commerciale del nord, c’è la Filistea (o Palestina) che è l’area centrale, e l’Etiopia che rappresenta il profondo sud. Nell’anagrafe di Sion tutti sono registrati come figli: la citata locuzione jullad sham/bahera appunto la formula ufficiale giuridica con cui si dichiarava un individuo nativo di una determinata città e, come tale, dotato della pienezza dei diritti municipali.
*Avvenire, venerdì 16 ottobre 2020 (ripresa parziale, senza immagine).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- "FRATELLI TUTTI": L’ULTIMA CARTA PER CAMBIARE IL PARADIGMA (di Raniero La Valle).).7 ottobre 2020, di Federico La Sala
Papa Francesco indica l’ultima carta per cambiare il paradigma dell’umano
Fratelli tutti. Poiché è sull’amore, questa è un’enciclica laica, di una straordinaria laicità, perché l’amore non si lascia irretire in un solo stampo, in un unico codice
di Raniero La Valle (il manifesto, 07.10.2020)
È una lettera sconcertante e potente questa che papa Francesco, facendosi “trasformare” dal dolore del mondo nei lunghi giorni della pandemia, ha scritto a una società che invece mira a costruirsi “voltando le spalle al dolore”.
Per questo la figura emblematica che fa l’identità di questa enciclica, prima ancora che quella di Francesco d’Assisi, è quella del Samaritano, che ci pone di fronte a una scelta stringente: davanti all’uomo ferito (e oggi sempre di più ci sono persone ferite, tutti i popoli sono feriti) ci sono solo tre possibilità: o noi siamo i briganti, e come tali armiamo la società dell’esclusione e dell’iniquità, o siamo quelli dell’indifferenza che passano oltre immersi nelle loro faccende e nelle loro religioni, o riconosciamo l’uomo caduto e ci facciamo carico del suo dolore: e dobbiamo farlo non solo con il nostro amore privato, ma col nostro amore politico, perché dobbiamo pure far sì che ci sia una locanda a cui affidare la vittima, e istituzioni che giungano là dove il denaro non compra e il mercato non arriva.
Ci si poteva chiedere che cosa avesse ancora da dire papa Francesco dopo sette anni di così eloquenti gesti e parole, cominciati a Lampedusa e culminati ad Abu Dhabi nell’incontro in cui si è proclamato con l’Islam che “se è uccisa una persona è uccisa l’umanità intera”, ragione per cui non sono più possibili né guerre né pena di morte.
E per Francesco neanche l’ergastolo, che “è una pena di morte nascosta”, e tanto meno le esecuzioni extragiudiziarie degli squadroni della morte e dei servizi segreti. Ebbene, la risposta sul perché dell’enciclica è che ormai non si tratta di operare qualche ritocco qua e là, ma si tratta di cambiare il paradigma dell’umano, che regge tutte le nostre culture e i nostri ordinamenti: si tratta di passare da una società di soci a una comunità di fratelli.
Perciò questa seconda lettera (l’altra è stata la Laudato sì, mentre la prima era in realtà di Ratzinger) non è un’enciclica sociale; solo una volta il papa si fa sfuggire di aver scritto un’”enciclica sociale”; in realtà essa non ha nessuna somiglianza con il “Compendio della dottrina sociale della Chiesa” fatto pubblicare nel 2004 da papa Wojtyla, in cui si pretendeva di definire per filo e per segno tutto ciò che si doveva fare nella società.
Questa invece è un’enciclica sull’amore perché passare da soci a figli vuol dire passare dalla ricerca dell’utile all’amore senza ragione: i migranti non si devono accogliere perché possono essere utili, ma perché sono persone, e i disabili e gli anziani non si devono scartare perché una società dello scarto è essa stessa inumana.
Poiché è sull’amore, questa è un’enciclica laica, anzi di una straordinaria laicità, perché l’amore non si lascia irretire in un solo stampo, in una sola proposta, in un unico codice. È impressionante come papa Francesco lasci aperte sempre altre possibilità, altre considerazioni del reale, altre strade possibili, perfino dinanzi al peccato e all’errore; sempre è invocata la pluralità, mai il relativismo, sempre il gusto delle differenze, dell’inedito, del non ancora compreso; il poliedro, mai la torre di Babele, dalla pretesa unificante.
Ci vuole fantasia per costruire la società fraterna e non è facile passare dal “legame di coppia e di amicizia” all’accoglienza verso tutti e all’”amicizia sociale”. Alle volte sembra di leggere una lezione di laicità al mondo, alle culture fissiste, come il liberismo, che fa della proprietà privata, che è “un diritto secondario”, un valore primario e assoluto, mentre originario e prioritario è il diritto all’uso comune dei beni creati per tutti; come c’è una lezione al populismo e al nazionalismo, incapaci di farsi interpellare da ciò che è diverso, di aprirsi all’universalità, chiusi come sono nei loro angusti recinti come in “un museo folkloristico di eremiti localisti”; il male è che così si perdono proprio beni irrinunciabili come la libertà o la nazione: l’economia che si sostituisce alla politica non ha messo fine alla storia ma ruba la libertà; e con la demagogia il rischio è che si perda il concetto di popolo, “mito” e istituzione insieme, a cui non si può rinunziare perché altrimenti si rinunzia alla stessa democrazia.
La stessa fraternità, dice Francesco, va strutturata in un’organizzazione mondiale garantista e efficiente, sotto “il dominio incontrastato del diritto”, anche se un progetto per lo sviluppo di tutta l’umanità “oggi suona come un delirio”.
Mentre l’enciclica si distribuiva in piazza san Pietro ed era tolto l’embargo, nelle chiese si leggeva, tra le letture del giorno, questa frase del profeta Isaia: “Egli (il Signore) si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi”. Sembrava un giudizio scritto per l’oggi, mentre Francesco è assediato, fin dentro al tempio, da mercanti e falsi difensori della fede.
È forse questo il segreto di questa enciclica: c’è, per un mondo malato, dove “tutto sembra dissolversi e perdere consistenza”, da giocare l’ultima carta, cambiare i soci in fratelli. Si potrà poi essere anche cattivi fratelli, incapaci di memoria, di pietà, di perdono, però tutti si riconosceranno investiti della infinita dignità dell’umano, questa verità che non muta, accessibile a tutti e obbligante per tutti.
Ma per essere fratelli ci vuole un padre. Perciò tutto il ministero di papa Francesco è volto a “narrare” al mondo la misericordia del Padre; lui che è il primo pastore della religione del Figlio, si mette nei panni del Figlio (com’è del resto suo compito) per recuperare la religione del Padre, per dare agli uomini un Padre in cui si riconoscano finalmente fratelli. Una cosa così “religiosa” che la voleva perfino la Rivoluzione francese; solo che, dice ora papa Francesco, se la fraternità non si esercita veramente anche la libertà e l’uguaglianza sono perdute. E il mondo, ora, sarebbe perduto con loro.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- «Fratelli tutti»: la chiave di volta della fraternità universale. La nuova enciclica sociale di papa Francesco, firmata ad Assisi (di Stefanaia Falasca).4 ottobre 2020, di Federico La Sala
Enciclica.
«Fratelli tutti»: la chiave di volta della fraternità universale
La nuova enciclica sociale di papa Francesco, firmata ad Assisi, per superare i mali e le ombre del mondo. Ecco i contenuti
di Stefania Falasca (Avvenire, domenica 4 ottobre 2020)
Un manifesto per i nostri tempi. Con l’intento di «far rinascere un’aspirazione mondiale alla fraternità». La nuova lettera enciclica di papa Francesco che si rivolge «a tutti i fratelli e le sorelle», «a tutte le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose» è «uno spazio di riflessione sulla fraternità universale». Necessaria, nel solco della dottrina sociale della Chiesa, per un futuro «modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana». Per «agire insieme e guarire dalla chiusura del consumismo, l’individualismo radicale e l’auto-protezione egoistica». Per superare «le ombre di un mondo chiuso» e conflittuale e «rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale che viva l’amicizia sociale». Per la crescita di società eque e senza frontiere. Perché l’economia e la politica siano poste «al servizio del vero bene comune e non siano ostacolo al cammino verso un mondo diverso». Perché quanto stiamo attraversando con la pandemia «non sia l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare». Perché le religioni possono offrire «un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società».
La fonte d’ispirazione per questa nuova pagina di dottrina sociale della Chiesa viene ancora una volta dal Santo dell’amore fraterno, il Povero d’Assisi «che - afferma il Papa - mi ha ispirato a scrivere l’enciclica Laudato si’, e nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale».
Sulla scia dell’adagio terenziano ripreso da Paolo VI nella sua enciclica programmatica Ecclesiam Suam, papa Francesco ricorda nell’incipit stesso della sua lettera enciclica quanto «tutto ciò che è umano ci riguardi» e che «dovunque i consessi dei popoli si riuniscono per stabilire i diritti e i doveri dell’uomo, noi siamo onorati, quando ce lo consentono, di assiderci fra loro». La Chiesa del resto, affermava Paolo VI, «chiamata a incarnarsi in ogni situazione e ad essere presente attraverso i secoli in ogni luogo della terra - questo significa “cattolica” -, può comprendere, a partire dalla propria esperienza di grazia e di peccato, la bellezza dell’invito all’amore universale».
Francesco spiega poi che le questioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre state tra le sue preoccupazioni e che negli ultimi anni ha fatto riferimento ad esse più volte. L’enciclica raccoglie molti di questi interventi collocandoli in un contesto più ampio di riflessione. E se la redazione della Laudato si’ ha avuto una fonte di ispirazione dal suo fratello ortodosso Bartolomeo, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli che ha proposto con molta forza la cura del creato, in questo caso si è sentito stimolato in modo speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale il Papa si è incontrato nel febbraio del 2019 ad Abu Dhabi per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro».
Papa Francesco ricorda che quello non è stato «un mero atto diplomatico, bensì il frutto di una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto». E che questa enciclica, pertanto, raccoglie e sviluppa i grandi temi esposti in quel Documento firmato insieme e recepisce, nel suo linguaggio, «numerosi documenti e lettere ricevute da tante persone e gruppi di tutto il mondo».
 La genesi della lettera tuttavia è stata accelerata da un’emergenza: l’irruzione inattesa della pandemia del Covid-19, «che - come scrive Francesco - ha messo in luce le nostre false sicurezze, e al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme». Perché «malgrado si sia iper-connessi - spiega ancora il Papa - si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti». E adesso «se qualcuno pensa che si tratti solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà».
La genesi della lettera tuttavia è stata accelerata da un’emergenza: l’irruzione inattesa della pandemia del Covid-19, «che - come scrive Francesco - ha messo in luce le nostre false sicurezze, e al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme». Perché «malgrado si sia iper-connessi - spiega ancora il Papa - si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti». E adesso «se qualcuno pensa che si tratti solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l’unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà».Il Papa afferma inoltre che se ancora una volta si è sentito motivato specialmente da san Francesco d’Assisi, anche altri fratelli non cattolici sono stati ispiratori: Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi. In particolare cita però il beato Charles de Foucauld. E prendendo a prestito la sue parole così chiosa la sua conclusione agli otto capitoli e 287 punti di Fratelli tutti: «“Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese”. Voleva essere, in definitiva, “il fratello universale”. Ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi. Amen».
Le ombre di un mondo chiuso
Nel primo capitolo vengono passate in rassegna le tendenze del mondo attuale che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. Tra queste i diritti umani non sufficientemente universali, le nuove forme di colonizzazione culturale, lo scarto mondiale dove «certe parti dell’umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti». «Mentre, infatti, una parte dell’umanità vive nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti fondamentali ignorati o violati. «La storia - afferma il Papa - sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si accendono conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. Nuove forme di egoismo e di perdita del senso sociale mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali». «Abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa comune. Tale cura non interessa ai poteri economici che hanno bisogno di entrate veloci. Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a tacere o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi particolari. In questa cultura che stiamo producendo, vuota, protesa all’immediato e priva di un progetto comune, «è prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni». E non manca un’attenzione anche verso la condizione delle donne: «L’organizzazione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamente la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A parole si affermano certe cose, ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio». È un fatto che «doppiamente povere sono le donne che soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza, perché spesso si trovano con minori possibilità di difendere i loro diritti».
L’esempio del Buon Samaritano
Per il superamento delle ombre il Papa indica la strada d’uscita nella figura del Buon Samaritano a cui dedica il secondo capitolo, sottolineando come in una società malata che volta le spalle al dolore e che è “analfabeta” nella cura dei deboli e dei fragili, tutti siamo chiamati - proprio come il Buon Samaritano - a farci prossimi all’altro, superando pregiudizi, interessi personali, barriere storiche o culturali. «È un richiamo sempre nuovo, benché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere: che la società si incammini verso il perseguimento del bene comune e, a partire da questa finalità, ricostruisca sempre nuovamente il suo ordine politico e sociale, il suo tessuto di relazioni, il suo progetto umano». Dunque, afferma Francesco, «non dico più che ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi sento chiamato a diventare io un prossimo degli altri». E spiega che «in quelli che passano a distanza c’è un particolare che non possiamo ignorare: erano persone religiose. Questo indica che il fatto di credere in Dio e di adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace». «Una persona di fede - spiega - può non essere fedele a tutto ciò la fede stessa esige, e tuttavia può sentirsi vicina a Dio e ritenersi più degna degli altri. Ci sono invece dei modi di vivere la fede che favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, e quella sarà la garanzia di un’autentica apertura a Dio».
Società aperte che integrano tutti
«L’individualismo radicale - afferma Francesco nel terzo capitolo “Pensare e generare un mondo aperto” - è il virus più difficile da sconfiggere». «Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire il bene comune. Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c’è futuro né per la fraternità né per la sopravvivenza dell’umanità. Se la società si regge primariamente sui criteri della libertà di mercato e dell’efficienza, non c’è posto per costoro, e la fraternità sarà tutt’al più un’espressione romantica». Francesco indica la necessità di promuovere il bene morale e il valore della solidarietà: «È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia, si tratta di un’altra logica - spiega - Se non ci si sforza di entrare in questa logica, le mie parole suoneranno come fantasie. Ma se si accetta il grande principio dei diritti che promanano dal solo fatto di possedere l’inalienabile dignità umana, è possibile desiderare un pianeta che assicuri terra, casa e lavoro a tutti. Questa è la vera via della pace, e non la strategia stolta e miope di seminare timore e diffidenza nei confronti di minacce esterne». Il diritto a vivere con dignità non può essere negato a nessuno, afferma ancora il Papa, e poiché i diritti sono senza frontiere, nessuno può rimanere escluso, a prescindere da dove sia nato. In quest’ottica, il Papa richiama anche a pensare ad «un’etica delle relazioni internazionali», perché ogni Paese è anche dello straniero ed i beni del territorio non si possono negare a chi ha bisogno e proviene da un altro luogo. Il diritto naturale alla proprietà privata sarà, quindi, secondario al principio della destinazione universale dei beni creati. Una sottolineatura specifica viene fatta anche per la questione del debito estero: fermo restando il principio che esso va saldato, si auspica tuttavia che ciò non comprometta la crescita e la sussistenza dei Paesi più poveri.
Interscambio e governance globale per i migranti
L’aiuto reciproco tra Paesi in definitiva va a beneficio di tutti e al tema delle migrazioni l’enciclica dedica l’intero quarto capitolo: “Un cuore aperto al mondo intero”. L’altro diverso da noi è un dono ed un arricchimento per tutti - scrive Francesco - perché le differenze rappresentano una possibilità di crescita. Nello specifico, il Papa indica alcune risposte soprattutto per chi fugge da «gravi crisi umanitarie»: -incrementare e semplificare la concessione di visti; aprire corridoi umanitari; assicurare alloggi, sicurezza e servizi essenziali; offrire possibilità di lavoro e formazione; favorire i ricongiungimenti familiari; tutelare i minori; garantire la libertà religiosa e promuovere l’inserimento sociale. Dal Papa anche l’invito a stabilire, nella società, il concetto di «piena cittadinanza», rinunciando all’uso discriminatorio del termine “minoranze”. «Quello che occorre soprattutto - si legge nel documento - è una governance globale, una collaborazione internazionale per le migrazioni che avvii progetti a lungo termine, andando oltre le singole emergenze, in nome di uno sviluppo solidale di tutti i popoli che sia basato sul principio della gratuità. In tal modo, i Paesi potranno pensare come una famiglia umana».
La politica di cui c’è bisogno e la riforma dell’ONU
“La migliore politica” è al centro del quinto capitolo. «Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale - scrive Francesco - capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale, è necessaria la migliore politica, posta al servizio del vero bene comune. Purtroppo, invece, la politica oggi spesso assume forme che ostacolano il cammino verso un mondo diverso». «Mi permetto di ribadire - afferma - che la politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia». «Non si può giustificare un’economia senza politica, che sarebbe incapace di propiziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale». Al contrario, «abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi». «Penso - afferma - a una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni e inerzie viziose». Non si può chiedere ciò all’economia, né si può accettare che questa assuma il potere reale dello Stato. «Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale. I politici sono chiamati a prendersi «cura della fragilità, della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità e fecondità in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla “cultura dello scarto”.
Davanti a tante forme di politica meschine e tese all’interesse immediato, ricorda che «la grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. Compito della politica, inoltre, è trovare una soluzione a tutto ciò che attenta contro i diritti umani fondamentali, come l’esclusione sociale; il traffico di organi, tessuti, armi e droga; lo sfruttamento sessuale; il lavoro schiavo; il terrorismo ed il crimine organizzato.
 L’appello del Papa si volge a eliminare definitivamente la tratta, «vergogna per l’umanità», e la fame, in quanto è «criminale». Un altro auspicio riguarda la riforma dell’Onu: di fronte al predominio della dimensione economica che annulla il potere del singolo Stato, infatti, il compito delle Nazioni Unite sarà quello di dare concretezza al concetto di «famiglia di nazioni» lavorando per il bene comune, lo sradicamento dell’indigenza e la tutela dei diritti umani. Ricorrendo «al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato» - afferma il documento pontificio - l’Onu deve promuovere la forza del diritto sul diritto della forza, favorendo accordi multilaterali che tutelino al meglio anche gli Stati più deboli.
L’appello del Papa si volge a eliminare definitivamente la tratta, «vergogna per l’umanità», e la fame, in quanto è «criminale». Un altro auspicio riguarda la riforma dell’Onu: di fronte al predominio della dimensione economica che annulla il potere del singolo Stato, infatti, il compito delle Nazioni Unite sarà quello di dare concretezza al concetto di «famiglia di nazioni» lavorando per il bene comune, lo sradicamento dell’indigenza e la tutela dei diritti umani. Ricorrendo «al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato» - afferma il documento pontificio - l’Onu deve promuovere la forza del diritto sul diritto della forza, favorendo accordi multilaterali che tutelino al meglio anche gli Stati più deboli.Dialogo e amicizia sociale
Il vero dialogo - si afferma nel sesto capitolo - è quello che permette di rispettare la verità della dignità umana. Quanti pretendono di portare la pace in una società non devono dimenticare che l’inequità e la mancanza di sviluppo umano integrale non permettono che si generi pace. Che «senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società - locale, nazionale o mondiale - abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità». Per il Papa «se si tratta di ricominciare, sarà sempre a partire dagli ultimi».
L’artigianato della pace
Il settimo capitolo si sofferma sul valore e la promozione della pace. «La Shoah non va dimenticata - afferma - è il «simbolo di dove può arrivare la malvagità dell’uomo quando, fomentata da false ideologie, dimentica la dignità fondamentale di ogni persona, la quale merita rispetto assoluto qualunque sia il popolo a cui appartiene e la religione che professa». Non vanno neppure dimenticati i bombardamenti atomici a Hiroshima e Nagasaki. E nemmeno vanno dimenticati le persecuzioni, il traffico di schiavi e i massacri etnici che sono avvenuti e avvengono in diversi Paesi, e tanti altri fatti storici che ci fanno vergognare di essere umani. «Vanno ricordati sempre, sempre nuovamente. Per questo, non mi riferisco solo alla memoria degli orrori, ma anche al ricordo di quanti, in mezzo a un contesto avvelenato e corrotto, sono stati capaci di recuperare la dignità e con piccoli o grandi gesti hanno scelto la solidarietà, il perdono, la fraternità. Fa molto bene fare memoria del bene». E considerando che viviamo «una terza guerra mondiale a pezzi», perché tutti i conflitti sono connessi tra loro, l’eliminazione totale delle armi nucleari è «un imperativo morale ed umanitario». Piuttosto - suggerisce il Papa - con il denaro che si investe negli armamenti, si costituisca un Fondo mondiale per eliminare la fame. Non manca anche il riferimento alla pena di morte: «È inammissibile. È impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano disporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per difendere dall’aggressore ingiusto la vita di altre persone».
Le religioni al servizio della fraternità
Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. «Il comandamento della pace - spiega il Papa - è inscritto nel profondo delle tradizioni religiose che rappresentiamo. Come leader religiosi siamo chiamati ad essere veri “dialoganti”, ad agire nella costruzione della pace non come intermediari, ma come autentici mediatori. Come credenti ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci sull’essenziale: l’adorazione di Dio e l’amore del prossimo, in modo tale che alcuni aspetti della nostra dottrina, fuori dal loro contesto, non finiscano per alimentare forme di disprezzo, di odio, di xenofobia, di negazione dell’altro. La verità è che la violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni». Infine, richiamando i leader religiosi al loro ruolo di «mediatori autentici» che si spendono per costruire la pace, Francesco cita il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza”, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, insieme al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. Dalla pietra miliare del dialogo interreligioso, il Papa riprende l’appello affinché, in nome della fratellanza umana, si adotti il dialogo come via, la collaborazione comune come condotta e la conoscenza reciproca come metodo e criterio. La conclusione dell’enciclica è affidata a due preghiere: una «al Creatore» e l’altra «cristiana ecumenica» per infondere «uno spirito di fratelli».
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" - IL "SEGNAVIA DELLA NOSTRA VITA": IL "CHARAKTER", L’IMPRONTA (di Nunzio Galantino).2 ottobre 2020, di Federico La Sala
DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?! Quale il "carattere" (Charaktèr: gr. Χαρακτήρ) di Gesù?!
- "Come nella Bibbia (Ebr 1,3), dove Gesù è χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, è impronta - nel senso di piena ed esatta rappresentazione - della sostanza di Dio" ... ma di Dio Charitas (Amore) o Dio Caritas (Mammona)?!
Abitare le parole
Impronta.
SEGNAVIA DELLA NOSTRA STORIA
di Nunzio Galantino *
Per coprire il campo semantico della parola “impronta”, oltre al contributo che viene dalla derivazione etimologica, è opportuno porre attenzione al significato del termine χαρακτήρ che rende, in greco, la parola impronta e identificare gli attributi che, di volta in volta, l’accompagnano.
Sul piano etimologico, la parola impronta deriva dal latino imprĭmere (premere sopra, calcare). Χαρακτήρ - dal verbo χαράσσω (incidere, scolpire) - nella cultura greca è un nomen agentis: è cioè più di una traccia lasciata. È invece una persona che ritrae qualcuno o qualcosa. Come nella Bibbia (Ebr 1,3), dove Gesù è χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, è impronta - nel senso di piena ed esatta rappresentazione - della sostanza di Dio.
A proposito, poi, dell’impronta e degli attributi che l’accompagnano, si parla di impronta fisica lasciata da una parte del corpo o da uno strumento fisico, di impronta digitale cellulare e di impronta genetica. Sempre più spesso sentiamo, inoltre, rivolto a tutti l’invito a ridurre l’impronta ecologica; una sorta di indicatore che misura la quantità e la qualità del consumo delle risorse naturali prodotte dal pianeta Terra.
In senso generico, l’impronta è un segno tracciato con una pressione su una superficie. In senso figurato, la parola impronta indica una caratteristica che permette di identificare una persona o una sua produzione artistica, letteraria ecc. È vero che, almeno dal punto di vista fisico, non si può non lasciare un’impronta. Ma è anche vero che l’impronta non è solo il frutto inconsapevole di un gesto, di una presenza o di un passaggio.
 Il più delle volte, proprio perché espressione di una identità, l’impronta è frutto di una scelta consapevole, attraverso la quale io, di fatto, racconto la mia vita, le priorità che mi guidano e la qualità che scelgo di far ricadere in modo incisivo sulle mie relazioni.
Il più delle volte, proprio perché espressione di una identità, l’impronta è frutto di una scelta consapevole, attraverso la quale io, di fatto, racconto la mia vita, le priorità che mi guidano e la qualità che scelgo di far ricadere in modo incisivo sulle mie relazioni.E, proprio perché contengono pezzi di noi e della nostra interiorità, le impronte possono trasmettere un’immagine positiva di noi o comunicarne una negativa. Sono lì, come segnavia della nostra storia personale.
 Bisogna avere, di tanto in tanto, il coraggio di prenderle in mano e di fermarci per verificare cosa le impronte di cui disseminiamo la nostra presenza e le nostre relazioni stanno raccontando di noi.
Bisogna avere, di tanto in tanto, il coraggio di prenderle in mano e di fermarci per verificare cosa le impronte di cui disseminiamo la nostra presenza e le nostre relazioni stanno raccontando di noi.
 Uno sguardo attento e onesto sulle impronte ci permetterebbe di verificare se, quelle lasciate nel cuore e nella storia delle persone incontrate sul nostro cammino, sono impronte che generano e tramettono vita o piuttosto dolorose cicatrici.
Uno sguardo attento e onesto sulle impronte ci permetterebbe di verificare se, quelle lasciate nel cuore e nella storia delle persone incontrate sul nostro cammino, sono impronte che generano e tramettono vita o piuttosto dolorose cicatrici.La storia personale e quella relazionale in genere vive di impronte lasciate e di impronte subìte, attraverso uno sguardo, una parola, una carezza o un’emozione provocata. Ma essa è esposta anche a impronte che assomigliano molto di più a ferite. Quelle provocate da rifiuti, sguardi indifferenti o evidenti strumentalizzazioni. Se le prime hanno la capacità di ricomporre pezzi di vita andati in frantumi, le altre, più che impronte, sono cicatrici che rendono sempre più insopportabile la vita.
*Rubrica de Il Sole 24ore, 28/09/2020.
Sul tema, nel sito, si cfr. :
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA ? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA !!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- Enciclica “Fratelli tutti”. Parla Shahrzad Houshmand Zadeh, teologa musulmana e docente a "La Sapienza" (di M. Chiara Biagioni)..2 ottobre 2020, di Federico La Sala
Attesa
Enciclica “Fratelli tutti”. Houshmand (teologa musulmana): “Vincere il male con un Bene più grande”
di M. Chiara Biagioni *
- “Stiamo vivendo una situazione mondiale molto grave che la pandemia ha peggiorato spargendo un fumo di tristezza e paura. Di fronte ad una sfida così grande, abbiamo bisogno di una risposta di bene altrettanto se non maggiormente grande. Al male, creato dalle ingiustizie sociali, l’umanità deve rispondere con il Bene. Il Papa lo ha capito e sta proponendo un patto di fratellanza”. Parla Shahrzad Houshmand Zadeh, teologa musulmana e docente alla Facoltà di studi orientali all’Università La Sapienza
“Di fronte ad una sfida così grande che l’umanità sta vivendo oggi, abbiamo bisogno di una risposta di bene altrettanto se non maggiormente grande. Al male, creato dalle ingiustizie sociali, l’umanità deve rispondere con il Bene. Il Papa lo ha capito e sta proponendo un patto di fratellanza”. Con questa lettura, Shahrzad Houshmand Zadeh, teologa musulmana e docente alla Facoltà di studi orientali all’Università La Sapienza, si prepara ad accogliere la terza Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale. Il Papa la firmerà ad Assisi nel pomeriggio del 3 ottobre. La professoressa Houshmand aggiunge: “Come scriveva Civiltà Cattolica, stiamo assistendo oggi ad una forma nuova di apocalisse. Prendiamo, per esempio, le immagini delle navi cariche di vite umane che cercano un approdo sicuro in una terra dove sopravvivere o semplicemente dove non morire. O ancora, pensiamo all’immagine di minorenni che salgono su questi gommoni e alle loro madri che li lasciano andare verso un destino sconosciuto e incerto. Mi vengono in mente anche nuovi e vecchi conflitti che insanguinano molte zone del mondo.
 Stiamo vivendo una situazione mondiale molto grave che la pandemia ha peggiorato, spargendo un fumo di tristezza e paura”.
Stiamo vivendo una situazione mondiale molto grave che la pandemia ha peggiorato, spargendo un fumo di tristezza e paura”.Ma come si concretizza il patto di fratellanza che il Papa propone?
È un messaggio solo apparentemente nuovo perché ha radici profondissime che risalgono al nostro vissuto antico, ai testi sacri e ai documenti delle nostre rispettive religioni. Ma è un messaggio dimenticato. Francesco ci chiede con questa Enciclica di svegliarci, di aprire gli occhi, di riandare al messaggio più profondo delle nostre religioni e della nostra spiritualità. Senza la fratellanza non si concretizza il messaggio spirituale e religioso insito nel cristianesimo e nell’Islam.
 Senza la fratellanza, le nostre religioni rischiano di essere solo parole vuote, non realizzate, non incarnate nel vissuto concreto.
Senza la fratellanza, le nostre religioni rischiano di essere solo parole vuote, non realizzate, non incarnate nel vissuto concreto.Perché abbiamo perso o dimenticato questa capacità di vederci fratelli?
- Perché abbiamo avuto paura. La paura è la radice del male.
Quando si ha paura, ci si rifugia in luoghi chiusi, si alzano i muri. Ci si nasconde dietro i “titoli” e questi “titoli” creano i nazionalismi, le ideologie, i partiti e l’altro diventa un nemico. Papa Francesco ci sta quindi scuotendo: ci chiede di abbattere questi muri, uscire dalla paura, guardare negli occhi l’altro e vedere che l’altro, come noi, sta piangendo e le sue lacrime hanno lo stesso colore delle nostre.
Quanto ha influito sulla redazione di questa Enciclica, l’incontro di Papa Francesco con l’Islam?
Mi ricorda l’incontro di Francesco di Assisi con il sultano. Anche i momenti storici sono simili. Allora c’erano le crociate. Oggi ci sono altre forme di crociate e jihadismi. Stiamo vivendo una situazione mondiale simile se non peggiore perché le nuove tecnologie hanno dato all’umanità armi molto più potenti e distruttive. Le immagini iconografiche dell’incontro di San Francesco di Assisi e il sultano sono stupefacenti: rappresentano due volti che si guardano negli occhi e si abbracciano. Papa Francesco sta praticamente replicando quell’incontro in una forma nuova.
Forma nuova che è stata espressa nel documento di Abu Dhabi.
Mai un Papa si era recato negli Emirati Arabi, mai un Papa si è messo sullo stesso livello e allo stesso tavolo per dialogare e pensare insieme all’umanità intera. Il Documento di Abu Dhabi è destinato ad illuminare il nostro futuro. Forse è stato ancora poco elaborato e trasmesso, ma è un testo rivoluzionario e al tempo stesso fedele ai fondamenti delle due religioni. Il documento indica come chiave della fratellanza lo spirito del servizio. Se una religione non si traduce in servizio concreto verso il prossimo perde la sua stessa radice. Una sfida al momento storico che stiamo vivendo.
Alcuni in questi giorni hanno osservato che il titolo dell’Enciclica, in rispetto alla parità, avrebbe dovuto includere “Fratelli e sorelle tutti”. Lei cosa ne pensa?
Nella lingua persiana, che è la mia lingua materna, quando si dice “fratelli”, si intende solo il genere maschile per cui in questo caso, va aggiunto la parola “sorelle”. In altre lingue, come quella italiana ma anche araba, quando si usa la parola “fratelli”, il termine può includere anche il genere femminile. Se però si vuole portare avanti questa osservazione, credo che la critica vada fatta anche per parole relative, per esempio, alle professioni di medico, ministro, avvocato, trovando un modo per declinarle al femminile.
 Ma non è il momento adesso per fare una critica linguistica di questo tipo ad un documento che propone un patto umanamente e spiritualmente molto elevato.
Ma non è il momento adesso per fare una critica linguistica di questo tipo ad un documento che propone un patto umanamente e spiritualmente molto elevato.A proposito di questione femminile, c’è un modo specifico delle donne a vivere la fraternità?
Penso che la donna abbia una capacità particolare e straordinaria nel vivere la misericordia, il perdono e l’accoglienza. Penso che questo Documento si rivolge a tutti, uomini e donne, ma le donne vengono illuminate in modo particolare. Per natura, la donna accoglie dentro di sé il diverso, lo riconosce figlio e lo ama. E soprattutto ha occhi più attenti verso il più piccolo e bisognoso.
* AgenSir, 1 ottobre 2020 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. «Fratelli tutti», un’alternativa nel mondo malato (di Stefania Falasca).).23 settembre 2020, di Federico La Sala
Verso l’enciclica.
«Fratelli tutti», c’è un’alternativa nel mondo malato
Il 3 ottobre la sigla dell’atteso documento magistrale che sarà diffuso l’indomani, memoria di san Francesco d’Assisi
di Stefania Falasca (Avvenire, mercoledì 23 settembre 2020)
Una nuova enciclica è alle porte: Fratelli tutti è il titolo annunciato per un testo che esce in un crinale della storia segnato da una triplice crisi mondiale: socio-economica, ecologica e sanitaria. E che ancora una volta - 5 anni dopo la profetica Laudato si’ sulla cura della casa comune - ci interpella su un cambio di rotta e s’ispira al magistero di san Francesco traendo spunto dai suoi scritti. È proprio sulla tomba del santo d’Assisi che il 3 ottobre papa Francesco firmerà il documento sulla fraternità e l’amicizia sociale che nel titolo riprende alla lettera un passo delle Ammonizioni del Poverello. E proprio il 4 ottobre, festività del Santo, verrà pubblicata.
Il Papa ha deciso di siglarla dopo la Messa che celebrerà nella Basilica francescana, senza presenza di fedeli a motivo del Covid. E proprio dalle sue riflessioni sulla pandemia, su come guarire il mondo, riparare la casa comune dai danni umani e ambientali, ridurre le conseguenze della crescente diseguaglianza sociale ed economica, sembra scaturire l’urgenza del nuovo documento magisteriale.
 La scelta delle date per la firma e la pubblicazione appaiono infatti significative anche nell’orizzonte del Giubileo della Terra promosso dalla famiglia ecumenica per la celebrazione del Tempo del Creato 2020 che si conclude proprio il 4 ottobre, affinché sia custodita la memoria del nostro esistere inter-relazionale. Perché, come ha affermato papa Francesco il 1° settembre nella Giornata mondiale per la Cura del creato, «esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una famiglia comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa».
La scelta delle date per la firma e la pubblicazione appaiono infatti significative anche nell’orizzonte del Giubileo della Terra promosso dalla famiglia ecumenica per la celebrazione del Tempo del Creato 2020 che si conclude proprio il 4 ottobre, affinché sia custodita la memoria del nostro esistere inter-relazionale. Perché, come ha affermato papa Francesco il 1° settembre nella Giornata mondiale per la Cura del creato, «esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una famiglia comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa».
 Se «tutto è in relazione», e se «tutti siamo sulla stessa barca» - come aveva ricordato il 27 marzo in piazza San Pietro, nel mezzo del lockdown - le comunità dei credenti debbono convergere «per dare vita a un mondo più giusto, pacifico e sostenibile», continuando a crescere «nella consapevolezza che tutti noi abitiamo una casa comune in quanto membri della stessa famiglia».
Se «tutto è in relazione», e se «tutti siamo sulla stessa barca» - come aveva ricordato il 27 marzo in piazza San Pietro, nel mezzo del lockdown - le comunità dei credenti debbono convergere «per dare vita a un mondo più giusto, pacifico e sostenibile», continuando a crescere «nella consapevolezza che tutti noi abitiamo una casa comune in quanto membri della stessa famiglia».Ricordare costantemente che apparteniamo tutti alla stessa famiglia, che tutto è in relazione, significa aver presente «che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri». Papa Francesco ci ha abituati e provocati alle sintesi universali.
 La prossima enciclica metterà dunque al centro la fratellanza, principio umano e cristiano costantemente promosso dal Papa, al centro dello storico «Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune» - pietra miliare nel dialogo delle grandi religioni - firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi insieme ad Ahmed Al Tayyeb, grande Imam dell’Università Al-Azhar del Cairo. Ma la fratellanza è anche concetto che ha a che fare con le responsabilità globali di cui i modelli economici sono l’architettura principale. E quelli disegnati fin qui stanno dimostrando il loro fallimento: la pandemia ha solo accelerato il processo ma non è affatto la causa.
La prossima enciclica metterà dunque al centro la fratellanza, principio umano e cristiano costantemente promosso dal Papa, al centro dello storico «Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune» - pietra miliare nel dialogo delle grandi religioni - firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi insieme ad Ahmed Al Tayyeb, grande Imam dell’Università Al-Azhar del Cairo. Ma la fratellanza è anche concetto che ha a che fare con le responsabilità globali di cui i modelli economici sono l’architettura principale. E quelli disegnati fin qui stanno dimostrando il loro fallimento: la pandemia ha solo accelerato il processo ma non è affatto la causa.
 Ed è dunque significativo che la firma dell’enciclica avvenga anche nell’orizzonte dell’evento voluto ad Assisi dal Papa - «The Economy of Francesco» - e rivolto ai giovani per disegnare una nuova economia, un’iniziativa di enormi proporzioni che doveva svolgersi in maggio ma che proprio a causa del coronavirus si svolgerà dal 19 al 21 novembre online, sempre da Assisi.
Ed è dunque significativo che la firma dell’enciclica avvenga anche nell’orizzonte dell’evento voluto ad Assisi dal Papa - «The Economy of Francesco» - e rivolto ai giovani per disegnare una nuova economia, un’iniziativa di enormi proporzioni che doveva svolgersi in maggio ma che proprio a causa del coronavirus si svolgerà dal 19 al 21 novembre online, sempre da Assisi.Con essa papa Francesco manda a dire al vecchio regime dell’economia che non è più il tempo degli adoratori della finanza ma dell’economia reale fondata sulla persona: «Quest’anno - ha detto il 4 settembre rivolgendosi al gotha della finanza internazionale e della politica al Forum Ambrosetti di Cernobbio - il confronto su temi importanti relativi alla società, all’economia e all’innovazione richiede un impegno straordinario, per rispondere alle sfide provocate o rese più acute dall’emergenza sanitaria, economica e sociale».
Le parole di Bergoglio sono quelle, ripetute tante volte, su un modello di sviluppo economico che agli idoli della finanza non sacrifichi più la dignità dell’uomo stigmatizzando il «paradigma tecnocratico», quello per cui tutto è possibile nel nome dell’oligarchia del non-limite e del dominio su tutto. «Dall’esperienza della pandemia tutti stiamo imparando che nessuno si salva da solo - ha detto ancora il Papa al meeting economico -, abbiamo toccato con mano la fragilità che ci segna e ci accomuna. Abbiamo compreso meglio che ogni scelta personale ricade sulla vita del prossimo. Siamo stati costretti dagli eventi a guardare in faccia la nostra reciproca appartenenza, il nostro essere fratelli in una casa comune».
Ed è proprio «in questa situazione» che «l’economia, nel suo senso umanistico di "legge della casa del mondo", è un campo privilegiato per il suo stretto legame con le situazioni reali e concrete di ogni uomo e di ogni donna. Essa può diventare espressione di "cura", che non esclude ma include, non mortifica ma vivifica, non sacrifica la dignità dell’uomo agli idoli della finanza, non genera violenza e disuguaglianza, non usa il denaro per dominare ma per servire. L’autentico profitto, infatti, consiste in una ricchezza a cui tutti possano accedere».
 Per il Papa si tratta quindi di rallentare un ritmo disumano di consumo e produzione per imparare a comprendere la natura e a riconnetterci con la realtà. Una conversione per la quale è indispensabile formare e sostenere nuove generazioni di economisti e imprenditori: è per questo il Papa le ha invitate in novembre «nella Assisi del giovane Francesco che, spogliatosi di tutto per scegliere Dio come stella polare della sua vita, si è fatto povero con i poveri e fratello universale. Dalla sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima». Si noti: visione economica «attualissima». Si noti ancora: Assisi. Il luogo dove verrà pubblicata l’enciclica.
Per il Papa si tratta quindi di rallentare un ritmo disumano di consumo e produzione per imparare a comprendere la natura e a riconnetterci con la realtà. Una conversione per la quale è indispensabile formare e sostenere nuove generazioni di economisti e imprenditori: è per questo il Papa le ha invitate in novembre «nella Assisi del giovane Francesco che, spogliatosi di tutto per scegliere Dio come stella polare della sua vita, si è fatto povero con i poveri e fratello universale. Dalla sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima». Si noti: visione economica «attualissima». Si noti ancora: Assisi. Il luogo dove verrà pubblicata l’enciclica.Dal 5 agosto papa Francesco ha inaugurato nelle udienze generali del mercoledì una serie di catechesi dal tema «Guarire il mondo», nelle quali riprende e approfondisce tutti questi grandi temi con uno sguardo di fede chiamando a «una rivoluzione della cura», perché «per uscire da una pandemia occorre curarsi e curarci a vicenda». «Quando l’ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone dai beni primari - ha detto Francesco nell’udienza introduttiva -, quando la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale, e quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune, allora non possiamo stare a guardare».
 E ha posto questa domanda: «Allora ci chiediamo: in che modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo, oggi?». E ancora, nella quarta catechesi, il 26 agosto: «Sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale; è un virus che viene da un’economia malata. Dobbiamo dirlo semplicemente: l’economia è malata. Si è ammalata, è il frutto di una crescita economica iniqua che prescinde dai valori umani fondamentali. Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa "normalità" non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell’ambiente» dal quale dipende la nostra salute.
E ha posto questa domanda: «Allora ci chiediamo: in che modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo, oggi?». E ancora, nella quarta catechesi, il 26 agosto: «Sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale; è un virus che viene da un’economia malata. Dobbiamo dirlo semplicemente: l’economia è malata. Si è ammalata, è il frutto di una crescita economica iniqua che prescinde dai valori umani fondamentali. Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa "normalità" non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell’ambiente» dal quale dipende la nostra salute.Per il Papa è il momento di riscoprire «alcuni princìpi sociali che sono fondamentali» e che «la Chiesa ha sviluppato nel corso dei secoli, e alla luce del Vangelo», perché «possono aiutarci ad andare avanti, per preparare il futuro di cui abbiamo bisogno». È lui stesso a indicare «i principali, tra loro strettamente connessi: il principio della dignità della persona, il principio del bene comune, il principio dell’opzione preferenziale per i poveri, il principio della destinazione universale dei beni, il principio della solidarietà, della sussidiarietà, il principio della cura per la nostra casa comune. Questi princìpi aiutano i dirigenti, i responsabili della società a portare avanti la crescita e anche, come in questo caso di pandemia, la guarigione del tessuto personale e sociale. Tutti questi princìpi esprimono, in modi diversi, le virtù della fede, della speranza e dell’amore».
Se dunque la pandemia ha evidenziato ancora di più la nostra interdipendenza, il Papa ci sta dicendo che per uscire migliori dalla crisi si deve agire insieme: «E lo faremo - ha detto - alla luce del Vangelo, delle virtù teologali e dei princìpi della dottrina sociale della Chiesa. Esploreremo insieme come la nostra tradizione sociale cattolica può aiutare la famiglia umana a guarire questo mondo che soffre di gravi malattie. È mio desiderio riflettere e lavorare tutti insieme, come discepoli di Gesù che guarisce, per costruire un mondo migliore, pieno di speranza per le future generazioni», per «costruire una "civiltà dell’amore", come amava dire san Paolo VI».
 Da queste catechesi sembra dunque mostrarsi in filigrana la nuova enciclica Fratelli tutti, che dopo la Laudato si’ non potrà che segnare un balzo avanti nel solco della dottrina sociale della Chiesa, e non solo.
Da queste catechesi sembra dunque mostrarsi in filigrana la nuova enciclica Fratelli tutti, che dopo la Laudato si’ non potrà che segnare un balzo avanti nel solco della dottrina sociale della Chiesa, e non solo. -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- "FRATELLI TUTTI", "FRATELLI" (SENZA SORELLE), E IL TITOLO DELL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO..22 settembre 2020, di Federico La Sala
Caro Papa Francesco.
Finché è ancora in tempo, per favore cambi il titolo della nuova encliclica. *
Quel ’Fratelli’ (senza sorelle) non si può usare nel 2020.
Lei ci ha insegnato il peso delle parole.
Il titolo si mangerà il contenuto.
L’altro nome di Francesco è Chiara.
(Luigino Bruni - Twitter, 23 settembre 2020).
*
- Fratelli tutti è la terza enciclica di papa Francesco scritta nel suo ottavo anno di pontificato. Annunciata dalla Sala stampa vaticana il 5 settembre 2020[1], verrà firmata dal Papa il 3 ottobre 2020, in occasione della visita al santuario di Assisi e porterà la data del 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica ricorda san Francesco d’Assisi[2]. Il nucleo tematico è rappresentato dalla fraternità e dalla amicizia sociale, a partire da riflessioni circa la pandemia da COVID-19 del 2020. (Wikipedia - ripresa parziale.)
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- “Fratres omnes” - fratelli e sorelle tutti (di Niklaus Kuster).23 settembre 2020, di Federico La Sala
“Fratres omnes” - fratelli e sorelle tutti
A chi si rivolge Francesco d’Assisi nell’incipit della nuova enciclica
di Niklaus Kuster (Vatican-News, 22.09.2020)
- Il titolo della terza enciclica di Papa Francesco, con il suo incipit “Fratelli tutti”, suscita reazioni talvolta forti. Di fatto, Francesco d’Assisi, che viene qui citato, si rivolge a tutti i credenti - fratelli e sorelle nel mondo intero. Il seguente contributo illustra la fonte che dà il nome alla nuova enciclica e chiede traduzioni accurate.
Ancor prima che la terza enciclica di Papa Francesco sia firmata ad Assisi e che ne venga pubblicato il testo (1) si è scatenato un dibattito sul suo titolo. Nell’area di cultura tedesca, ci sono donne che si propongono di non leggere uno scritto che si rivolge solo ai “fratelli tutti”. Le traduzioni poco sensibili ignorano che nell’opera citata Francesco d’Assisi si rivolge sia alle donne sia agli uomini. L’autore medievale sostiene, come la nuova enciclica, una fratellanza universale. Papa Francesco mette in luce una perla spirituale del Medioevo capace di sorprendere le lettrici e i lettori moderni. Una citazione di Frate Francesco
All’annuncio dell’enciclica, la reazione dei media è stata giustamente quella di chiedersi se Papa Francesco pone una citazione discriminante all’inizio della sua terza enciclica. Come è possibile che colui, le cui prime parole pubbliche dopo l’elezione sono state “fratelli e sorelle”, ora si rivolga solo ai “fratelli tutti”? Perché l’incipit escludendo le donne esclude metà della Chiesa? “Solo i fratelli - o cosa?”, domanda un contributo critico di Roland Juchem. Il direttore del servizio vaticano della KNA spiega che la nuova enciclica inizia consapevolmente con le parole del mistico medievale d’Assisi, che sono state tradotte fedelmente. Dal momento che Frate Francesco si rivolge ai suoi frati, l’espressione “omnes fratres” andrebbe formulata al maschile. Secondo tale logica, però, la traduzione corretta sarebbe “Frati tutti“! E allora il testo verrebbe letto solo da una minoranza infinitesimale nella Chiesa. Papa Francesco inizia la sua nuova enciclica con una massima di saggezza del suo modello. Chi con presunta fedeltà al testo insiste su una traduzione solo al maschile, non riconosce il vero destinatario della raccolta medievale: Francesco d’Assisi, con la composizione finale delle sue “ammonizioni”, si rivolge a tutte le donne e gli uomini cristiani. Le traduzioni nelle lingue moderne devono esprimerlo in modo accurato e immediatamente comprensibile.
Raccolta di saggezze
Se l’enciclica Laudato si‘ nel suo incipit citava il Cantico di Frate Sole composto dal Poverello nella lingua volgare medievale, la terza enciclica del Papa rimanda a una raccolta delle sue massime di saggezza. La fonte utilizzata da Papa Francesco nelle edizioni moderne degli scritti francescani reca il titolo Admonitiones. -L’espressione “ammonizioni” è riduttiva, poiché i 28 insegnamenti spirituali comprendono anche numerose beatitudini, un breve trattato e perfino un cantico alla forza dei doni dello Spirito. L’edizione olandese di fatto preferisce parlare di “Wijsheidsspreuken” (massime di saggezza). L’essere indirizzate ai frati vale per la genesi delle singole massime, non per la successiva raccolta.
 Quando i traduttori si basano sul fatto che tutte le edizioni standard degli scritti francescani in tutte le lingue del mondo traducono l’omnes fratres della massima citata nella forma maschile, colgono solo una mezza verità.
Quando i traduttori si basano sul fatto che tutte le edizioni standard degli scritti francescani in tutte le lingue del mondo traducono l’omnes fratres della massima citata nella forma maschile, colgono solo una mezza verità.
 In altre parole: La traduzione letterale della frase latina non riflette il pieno significato che il testo intende esprimere nella sua forma finale!
In altre parole: La traduzione letterale della frase latina non riflette il pieno significato che il testo intende esprimere nella sua forma finale!
 Nell’edizione italiana delle Fonti Francescane, la sesta ammonizione inizia con le parole: “Guardiamo con attenzione, fratelli tutti, il buon pastore, che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce”. Si può subito notare che l’immagine del pastore e del suo gregge utilizzata nel testo comprende l’intera Chiesa, e non solo una schiera di frati. Per riconoscere il destinatario finale della raccolta di testi citata dal Papa occorre distinguere tra la nascita delle diverse parti di testo e la loro composizione finale. In quest’ultima, la parola fratres si allarga dalla piccola cerchia della fraternitas francescana a tutta la Chiesa.
Nell’edizione italiana delle Fonti Francescane, la sesta ammonizione inizia con le parole: “Guardiamo con attenzione, fratelli tutti, il buon pastore, che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce”. Si può subito notare che l’immagine del pastore e del suo gregge utilizzata nel testo comprende l’intera Chiesa, e non solo una schiera di frati. Per riconoscere il destinatario finale della raccolta di testi citata dal Papa occorre distinguere tra la nascita delle diverse parti di testo e la loro composizione finale. In quest’ultima, la parola fratres si allarga dalla piccola cerchia della fraternitas francescana a tutta la Chiesa.Dalla tessera del puzzle al quadro completo
La citata allocuzione proviene da una raccolta che riflette discussioni spirituali tra i frati Minori e le loro conclusioni maturate. La composizione complessiva allarga l’orizzonte oltre la cerchia iniziale. Le singole massime sono rivolte ai frati di Francesco, ai “religiosi” in generale e anche a tutte le persone al servizio di Dio (servi Dei).
 Negli ultimi anni della sua vita, Francesco d’Assisi mise insieme 28 insegnamenti spirituali ben selezionati per formare un ciclo che conduce in un edificio spirituale e ricorda la “casa della Sapienza” biblica, con le sue “colonne intagliate”. Il numero simbolico 28 è composto da 4 x 7: il quattro indica il mondo e il sette la creazione di Dio, il 28 rappresenta simbolicamente la Chiesa come opera di Dio. Chi entra sotto un porticato allestito in modo artistico e si limita a guardare una sola colonna? In questo edificio spirituale sono invitate tutte le persone, senza eccezioni, e di fatto le singole parole nella raccolta sono rivolte a tutti.
Negli ultimi anni della sua vita, Francesco d’Assisi mise insieme 28 insegnamenti spirituali ben selezionati per formare un ciclo che conduce in un edificio spirituale e ricorda la “casa della Sapienza” biblica, con le sue “colonne intagliate”. Il numero simbolico 28 è composto da 4 x 7: il quattro indica il mondo e il sette la creazione di Dio, il 28 rappresenta simbolicamente la Chiesa come opera di Dio. Chi entra sotto un porticato allestito in modo artistico e si limita a guardare una sola colonna? In questo edificio spirituale sono invitate tutte le persone, senza eccezioni, e di fatto le singole parole nella raccolta sono rivolte a tutti.Omnes fratres
In apertura della raccolta finale, la prima admonitio parla dell’eucaristia, ma si rivolge anche in modo programmatico a tutte le figlie i “figli degli uomini”: così, il testo latino nell’invitante breve trattato indica che l’orizzonte della speranza si apre su tutta la Chiesa e tutti i membri dell’umanità. Nel loro percorso attraverso la casa della Sapienza scopriranno un cammino verso una “vita che rende felici”. Di fatto, al centro di questo ciclo di lezioni spirituali, Francesco d’Assisi commenta beatitudini bibliche, anch’esse rivolte a tutte le persone, aggiungendovi dieci beatitudini proprie.
 Papa Francesco non mette in luce un testo singolo, bensì un’intera raccolta di testi, definita già da Kajetan Esser la “Magna Charta” della fratellanza cristiana. Il sottotitolo dell’enciclica rende evidente che essa è rivolta, come il documento comune cristiano-islamico di Abu Dhabi sulla fratellanza universale, al di là della propria Chiesa all’intera umanità: Papa Francesco scrive “sulla fraternità e l’amicizia sociale”, che deve unire, senza alcuna esclusione, tutte le persone in un mondo solidale.
Papa Francesco non mette in luce un testo singolo, bensì un’intera raccolta di testi, definita già da Kajetan Esser la “Magna Charta” della fratellanza cristiana. Il sottotitolo dell’enciclica rende evidente che essa è rivolta, come il documento comune cristiano-islamico di Abu Dhabi sulla fratellanza universale, al di là della propria Chiesa all’intera umanità: Papa Francesco scrive “sulla fraternità e l’amicizia sociale”, che deve unire, senza alcuna esclusione, tutte le persone in un mondo solidale.Da “frati” a “fratelli e sorelle”
La ragione per cui Papa Francesco con la sua visione fraterna dell’umanità fa giustamente riferimento al suo modello Francesco d’Assisi e pone una citazione fraterna all’inizio della sua enciclica può essere illustrato in breve. Gli scritti tramandati del santo contengono una raccolta di lettere, alcune delle quali sono rivolte a singoli frati (Leone, Antonio, responsabili del governo), altre all’intera fraternitas dei Minori e a tutti i fedeli. C’è però anche una lettera circolare che estende l’orizzonte all’universale e si rivolge “A tutti i podestà e ai consoli, ai giudici e ai reggitori di ogni parte del mondo, e a tutti gli altri ai quali giungerà questa lettera”. Nessun papa e nessun imperatore dell’alto Medioevo si è rivolto in modo così universale all’umanità.
 Nella Regola del 1221, diretta ai suoi frati, Francesco inserisce un invito a tutta l’umanità che travalica ogni confine di nazione e religione: non solo i fedeli cristiani e non solo le persone impegnate a livello ecclesiale, bensì “tutti i popoli, genti, razze e lingue, tutte le nazioni e tutti gli uomini d’ogni parte della terra, che sono e che saranno... tutti amiamo... il Signore Iddio”.
Nella Regola del 1221, diretta ai suoi frati, Francesco inserisce un invito a tutta l’umanità che travalica ogni confine di nazione e religione: non solo i fedeli cristiani e non solo le persone impegnate a livello ecclesiale, bensì “tutti i popoli, genti, razze e lingue, tutte le nazioni e tutti gli uomini d’ogni parte della terra, che sono e che saranno... tutti amiamo... il Signore Iddio”.
 Il mistico allarga i propri orizzonti all’intera famiglia umana nella Regola specifica per i frati, pochi mesi dopo essere giunto in Egitto nella quinta Crociata e aver sperimentato in modo impressionante, attraverso l’incontro con l’islam, che è possibile trovare la saggezza spirituale e l’amore di Dio anche al di fuori della propria religione. La stessa apertura universale avviene anche con le sue massime di saggezza, che nelle Admonitiones vengono unite in un ciclo artistico di brevi lezioni.
Il mistico allarga i propri orizzonti all’intera famiglia umana nella Regola specifica per i frati, pochi mesi dopo essere giunto in Egitto nella quinta Crociata e aver sperimentato in modo impressionante, attraverso l’incontro con l’islam, che è possibile trovare la saggezza spirituale e l’amore di Dio anche al di fuori della propria religione. La stessa apertura universale avviene anche con le sue massime di saggezza, che nelle Admonitiones vengono unite in un ciclo artistico di brevi lezioni.
 Negli ultimi anni di vita, Francesco inserisce quelle che erano state parole di saggezza ai suoi frati in una composizione che si rivolge a tutti i fedeli. Il testo latino non richiede nessuna aggiunta o modificazione: l’espressione “fratres” usata per i frati comprende anche fratelli e le sorelle carnali o spirituali, come fanno ancora oggi “fratelli”, “hermanos” e “frères” nelle lingue latine. Oggi, le lingue germaniche invece distinguono tra “Brüder” (solo fratelli maschi) e “Geschwister” (fratelli e sorelle), e ugualmente tra “Brüderlichkeit” (senza le sorelle) e “Geschwisterlichkeit” (con le sorelle).
Negli ultimi anni di vita, Francesco inserisce quelle che erano state parole di saggezza ai suoi frati in una composizione che si rivolge a tutti i fedeli. Il testo latino non richiede nessuna aggiunta o modificazione: l’espressione “fratres” usata per i frati comprende anche fratelli e le sorelle carnali o spirituali, come fanno ancora oggi “fratelli”, “hermanos” e “frères” nelle lingue latine. Oggi, le lingue germaniche invece distinguono tra “Brüder” (solo fratelli maschi) e “Geschwister” (fratelli e sorelle), e ugualmente tra “Brüderlichkeit” (senza le sorelle) e “Geschwisterlichkeit” (con le sorelle).Similmente, l’inglese distingue tra “brothers” (unicamente maschile) e “siblings” (fratelli e sorelle), e tra “brotherhood” (spesso senza sorelle) e “fraternity” o “siblinghood” (che include tutti).
Dopo che all’inizio la prima ammonizione fa entrare tutti “i figli e le figlie dell’uomo” nella bella casa della Sapienza, tale destinatario universale deve essere riferito anche al fratres della sesta admonitio: si rivolge a tutte le donne e gli uomini cristiani, e riguarda tutte le persone sulla terra.
Sulla nascita della fonte citata
Riguardo alla raccolta delle 28 Admonitiones, le ricerche francescane affermano quanto segue: i singoli testi tramandati dovrebbero condensare discorsi che in origine hanno trattato questioni relative alla vita spirituale e comune nell’ambito dei frati. Nel corso del tempo, alcuni colloqui sono stati riassunti per iscritto e messe in rilievo. È avvenuto così qualcosa di analogo a quanto è successo con i detti degli antichi padri e madri del deserto nella cerchia dei loro seguaci, tramandati in modo condensato negli Apophthegmata e nel Meterikon. Anche i singoli insegnamenti di Francesco sono stati annotati nelle situazioni più disparate da compagni capaci di scrivere e condensati nella loro essenza. Lui stesso, verso la fine della sua vita, ha unito questi risultati di discorsi comuni così raccolti in un’opera completa, nella quale i singoli insegnamenti hanno acquisito una nuova dimensione e un nuovo indirizzo.
Non a caso il primo insegnamento inizia con una citazione scritturale programmatica: “Il Signore Gesù disse a tutti coloro che lo seguono: Io sono la via, la verità e la vita”. I portali romanici delle chiese a volte invitano a entrare nell’edificio passando sotto una figura di Cristo nel timpano che presenta questa stessa citazione in un libro aperto.
 Nell’edificio spirituale delle Admonitiones, dopo due insegnamenti preparatori, dieci massime di saggezza tracciano il cammino verso il luogo della cena. Ad esse seguono quattro beatitudini bibliche a altre dieci beatitudini francescane, prima che due insegnamenti conclusivi preparino al ritorno alla quotidianità. I singoli insegnamenti si uniscono così per comporre una casa spirituale della saggezza che assomiglia a una basilica: a sinistra della navata dodici colonne conducono, come “via della verità” verso l’area dell’altare, il cui baldacchino è sorretto da quattro esili colonne e definisce il luogo di comunione intima con Dio. Poi, sull’altro lato della navata, dodici colonne riconducono al portale e segnano la “via della vita”. Via - veritas - vita sono le chiavi della composizione di un’opera completa, le cui singole parole staccate dal contesto in cui sono nate, diventano un messaggio per tutti i cristiani, uomini e donne.
Nell’edificio spirituale delle Admonitiones, dopo due insegnamenti preparatori, dieci massime di saggezza tracciano il cammino verso il luogo della cena. Ad esse seguono quattro beatitudini bibliche a altre dieci beatitudini francescane, prima che due insegnamenti conclusivi preparino al ritorno alla quotidianità. I singoli insegnamenti si uniscono così per comporre una casa spirituale della saggezza che assomiglia a una basilica: a sinistra della navata dodici colonne conducono, come “via della verità” verso l’area dell’altare, il cui baldacchino è sorretto da quattro esili colonne e definisce il luogo di comunione intima con Dio. Poi, sull’altro lato della navata, dodici colonne riconducono al portale e segnano la “via della vita”. Via - veritas - vita sono le chiavi della composizione di un’opera completa, le cui singole parole staccate dal contesto in cui sono nate, diventano un messaggio per tutti i cristiani, uomini e donne.
 Chiunque fosse interessato alla raccolta delle Ammonizioni dalla quale Papa Francesco trae l’incipit della sua enciclica, troverà prossimamente un’analisi della composizione e del messaggio completo in una collana specializzata della PTH Münster.
Chiunque fosse interessato alla raccolta delle Ammonizioni dalla quale Papa Francesco trae l’incipit della sua enciclica, troverà prossimamente un’analisi della composizione e del messaggio completo in una collana specializzata della PTH Münster.Conclusione
Con l’incipit della sua terza enciclica, Papa Francesco rimanda espressamente a Francesco d’Assisi. Il patrono del suo pontificato parla di una fratellanza universale che, nel Cantico di Frate Sole, si estende a tutte le persone e a tutte le creature. Tra le lettere circolari del santo ce n’è una che si rivolge in modo universale a tutte le persone sulla terra. Perfino nella Regola dell’Ordine del 1221, composta per i frati francescani, egli si rivolge a tutte le persone e a tutti i popoli con un invito ad amare insieme il Dio unico.
 La sesta admonitio citata dal Papa condensa, partendo dal contesto in cui è nata, i risultati di un discorso spirituale nell’ambito dei frati minori. L’insegnamento spirituale che ispira l’incipit della nuova enciclica viene però inserito da frate Francesco verso la fine della sua vita come una colonna nella “casa della Sapienza”, dove i capitelli sono ornati da sculture e corrispondono tra loro. A percorrere questo edificio spirituale non sono invitati solo i fratelli, bensì tutti i credenti e ogni persona sulla terra.
La sesta admonitio citata dal Papa condensa, partendo dal contesto in cui è nata, i risultati di un discorso spirituale nell’ambito dei frati minori. L’insegnamento spirituale che ispira l’incipit della nuova enciclica viene però inserito da frate Francesco verso la fine della sua vita come una colonna nella “casa della Sapienza”, dove i capitelli sono ornati da sculture e corrispondono tra loro. A percorrere questo edificio spirituale non sono invitati solo i fratelli, bensì tutti i credenti e ogni persona sulla terra.
 L‘ “omnes fratres” o “fratelli tutti” dell’enciclica va quindi tradotto come citazione di san Francesco in modo tale che tutti i cristiani, uomini e donne, si sentano coinvolti. Il destinatario della citata raccolta di testi va oltre “tutti i fratelli e le sorelle” che s’incontrano negli spazi ecclesiali reali e ideali, estendendosi a tutte le persone sulla terra.
L‘ “omnes fratres” o “fratelli tutti” dell’enciclica va quindi tradotto come citazione di san Francesco in modo tale che tutti i cristiani, uomini e donne, si sentano coinvolti. Il destinatario della citata raccolta di testi va oltre “tutti i fratelli e le sorelle” che s’incontrano negli spazi ecclesiali reali e ideali, estendendosi a tutte le persone sulla terra.Niklaus Kuster (1962) è un frate cappuccino svizzero, laureato in teologia e noto studioso di san Francesco. Insegna storia della Chiesa all’università di Lucerna e spiritualità francescana negli istituti superiori dell’ordine a Münster (PTH) e a Madrid (ESEF). Ha reso omaggio al profilo francescano di Papa Francesco nel suo libro: Franz von Assisi. Freiheit und Geschwisterlichkeit in der Kirche, (Verlag Echter) Würzburg 2019.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- Non a immagine d’idolo. Solo recuperando il senso biblico del divieto di immagine per custodire il mistero Dio potremo imparare l’arte del dialogo con chi ha altre idee di Dio (di Luigino Bruni)13 settembre 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra / 24.
Non a immagine d’idolo
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 12 settembre 2020)
- La domanda come io sia pervenuto a una materia così arcaica non ha ancora trovato risposta. Vi influirono circostanze varie, connesse con gli anni, con l’età. Ripeness is all. Come uomo e come artista io dovevo in qualche modo trovarmi in uno stato di "ricettività"
- Thomas Mann, Appendice a Giuseppe e i suoi fratelli
Dovremmo ringraziare la Bibbia solo per aver custodito nei secoli il mistero intimo di Dio, protetto dalle nostre manipolazioni teologiche e ideologiche. L’esilio babilonese non è stato soltanto il luogo e il tempo dove sono nati alcuni dei libri biblici più grandi e dove hanno parlato e scritto profeti immensi come Ezechiele e il Secondo Isaia. Quell’esilio generò anche alcuni dei salmi più belli. Canti e preghiere sgorgate dall’anima di un popolo umiliato, offeso nella sua identità nazionale, colpito al cuore della sua religione. L’esilio fu molte cose, ma fu soprattutto una grande prova religiosa. Ritrovarsi in una terra dalla religione ricchissima, circondati da molti dèi ognuno con il suo santuario, rappresentati da statue luccicanti e portati in processioni spettacolari, costrinse Israele a ripensare profondamente la propria fede. Anche la dura polemica biblica anti-idolatrica si sviluppò durante l’esilio. L’assenza del tempio e di immagini di YHWH rendeva forte e drammatica la domanda che i babilonesi rivolgevano ironicamente agli ebrei: "Dov’è il vostro Dio?".
In quelle culture antiche, un Dio senza luogo era un dio inesistente. Come risposta a quella domanda tremenda giunse a maturazione la grande idea biblica del divieto di rappresentazioni di Dio (Es 20,4). Un divieto unico, e fondato su un evento decisivo: «Poiché non vedeste alcuna figura nel giorno in cui il Signore vi parlò sull’Oreb» (Dt 4,15). L’esperienza dell’incontro con YHWH era stato l’incontro con una voce, con qualcosa reale ma invisibile. Né Abramo né Mosè né i profeti hanno visto l’immagine di Dio - Mosè lo vide passare di spalle, come dire che non lo vide. Hanno invece udito la sua voce, il suo sussurro (Elia). Allora ogni pretesa immagine di Dio non può che essere un falso, perché la voce non si può rappresentare.
«Perché le genti dovrebbero dire: "Dov’è il loro Dio?". Il nostro Dio è nei cieli... I loro idoli hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano; dalla loro gola non escono suoni» (Salmo 115,2-7). La lotta idolatrica della Bibbia ha due componenti: una critica esterna alle immagini degli dèi degli altri popoli e una critica interna a Israele che è stato sempre tentato di farsi immagini del suo Dio.
 La critica del Salmo 115 sembra, a prima vista, tutta centrata sulla prima componente dell’idolatria, ridicolizzare gli altri popoli che adorano stupidi pezzi di legno. Questa, però, non è la dimensione più interessante e profonda della polemica biblica, perché se fosse stata formulata in presenza dei sacerdoti e profeti babilonesi questi avrebbero potuto rispondere che quelle immagini erano solo simboli e segni dei loro dèi che, al pari del Dio di Israele, "abitavano nel cielo". Avrebbero potuto rispondere con argomentazioni simili a quelle con cui i cattolici difendevano le statue dei santi dalla furia iconoclastica di alcuni movimenti della Riforma protestante. La critica biblica alle immagini torna anche oggi quando ci dimentichiamo che statue e icone sono segni di un Dio che non vediamo e che riconosciamo da una voce che pronuncia un nome: "Maria".
La critica del Salmo 115 sembra, a prima vista, tutta centrata sulla prima componente dell’idolatria, ridicolizzare gli altri popoli che adorano stupidi pezzi di legno. Questa, però, non è la dimensione più interessante e profonda della polemica biblica, perché se fosse stata formulata in presenza dei sacerdoti e profeti babilonesi questi avrebbero potuto rispondere che quelle immagini erano solo simboli e segni dei loro dèi che, al pari del Dio di Israele, "abitavano nel cielo". Avrebbero potuto rispondere con argomentazioni simili a quelle con cui i cattolici difendevano le statue dei santi dalla furia iconoclastica di alcuni movimenti della Riforma protestante. La critica biblica alle immagini torna anche oggi quando ci dimentichiamo che statue e icone sono segni di un Dio che non vediamo e che riconosciamo da una voce che pronuncia un nome: "Maria".La seconda critica, quella rivolta agli ebrei, è invece molto più importante. Israele è stato accompagnato in tutta la sua storia biblica dalla tentazione di avere una religione semplice come quella degli altri popoli, con le stesse statue e le stesse processioni, con gli stessi riti naturali della fertilità. Il vitello d’oro sotto il Sinai è condannato e poi distrutto da Mosè perché immagine del loro Dio - il nome che il popolo diede al vitello aureo fu: YHWH. Rappresentare un Dio invisibile può produrre soltanto immagini sbagliate.
 La linea anti-idolatrica più importante è allora quella che Israele sviluppò non per criticare gli altri popoli ma come meccanismo di auto-protezione della propria fede, che non era solo minacciata (soprattutto prima dell’esilio) dai tentativi di importare dèi stranieri (i culti di Baal o della dea "moglie" di YHWH) e di collocarli nel loro tempio, ma dalla tentazione di semplificare la loro fede. L’idolatria più rilevante è infatti un riduzionismo religioso che diventa riduzionismo antropologico.
La linea anti-idolatrica più importante è allora quella che Israele sviluppò non per criticare gli altri popoli ma come meccanismo di auto-protezione della propria fede, che non era solo minacciata (soprattutto prima dell’esilio) dai tentativi di importare dèi stranieri (i culti di Baal o della dea "moglie" di YHWH) e di collocarli nel loro tempio, ma dalla tentazione di semplificare la loro fede. L’idolatria più rilevante è infatti un riduzionismo religioso che diventa riduzionismo antropologico.Lo sfondo di tutta la riflessione anti-idolatrica della Bibbia è la Genesi, e in particolare quei versi stupendi sull’Adam creato a "immagine di Dio" (1,27). Se noi umani siamo immagine di Dio, allora se riduciamo Dio a una sua immagine inevitabilmente sbagliata, stiamo riducendo ancor di più noi, che siamo l’immagine di quell’immagine ridotta. Tenere YHWH lassù, nell’alto dei cieli, invisibile ma parlante, significa tenere altissima la dignità delle donne e degli uomini; e dire che l’immagine di Dio che portiamo impressa appartiene al regno dello spirito e dell’essere non a quello dell’apparire.
 Chi vede un uomo, una donna, un bambino non vede la statua di Dio, ma una scintilla vera del suo mistero invisibile. Qui davvero l’essenziale dell’immagine è invisibile agli occhi. Non è la vista il senso necessario per vedere questa immagine. Importante è l’inizio del Salmo: «Non sarà a noi, non sarà a noi Signore che darai gloria! La Grazia tua e la tua Verità la innalzeranno solo al tuo Nome» (115,1).
Chi vede un uomo, una donna, un bambino non vede la statua di Dio, ma una scintilla vera del suo mistero invisibile. Qui davvero l’essenziale dell’immagine è invisibile agli occhi. Non è la vista il senso necessario per vedere questa immagine. Importante è l’inizio del Salmo: «Non sarà a noi, non sarà a noi Signore che darai gloria! La Grazia tua e la tua Verità la innalzeranno solo al tuo Nome» (115,1).
 Torna un tema molto caro alla Bibbia: il Nome. Con l’avvicinarsi all’era cristiana, gli ebrei pronunziarono sempre meno il nome di YHWH (Es 20,7). Scrivevano il tetragramma (YHWH) ma pronunciavano "Adonai", Signore. Il Nome YHWH veniva pronunciato dal sacerdote solo nel tempio, forse solo nella festa di Kippur. Con la seconda distruzione del tempio nel 70 d.C. si smarrì anche il ricordo della pronuncia del Nome rivelato a Mosè. Ma cosa c’è dietro al Nome?
Torna un tema molto caro alla Bibbia: il Nome. Con l’avvicinarsi all’era cristiana, gli ebrei pronunziarono sempre meno il nome di YHWH (Es 20,7). Scrivevano il tetragramma (YHWH) ma pronunciavano "Adonai", Signore. Il Nome YHWH veniva pronunciato dal sacerdote solo nel tempio, forse solo nella festa di Kippur. Con la seconda distruzione del tempio nel 70 d.C. si smarrì anche il ricordo della pronuncia del Nome rivelato a Mosè. Ma cosa c’è dietro al Nome?Quegli esiliati avevano una grande nostalgia dell’esperienza di Dio fatta in patria, quando YHWH "abitava" nel suo tempio ormai distrutto. Fecero molta fatica per ritrovare l’esperienza del sacro senza il loro luogo sacro. Ma questa immane fatica generò più cose straordinarie. Innanzitutto, l’assenza del tempio sacro inventò il tempo sacro: nacque lo Shabbat. Il tempo divenne più importante dello spazio. Lo Shabbat divenne il tempio del tempo, e resta ancora una delle più grandi profezie della Bibbia - senza una nuova cultura dello Shabbat non usciremo mai dalle crisi ambientali e sociali del capitalismo, che è l’anti-Shabbat. Lì scoprirono anche una nuova dimensione del Nome, che impararono grazie ai profeti sentinelle dell’esilio (si sente molto Ezechiele dentro il Salmo 115: «Dice il Signore: Ma io agii diversamente per onore del mio Nome»: Ez 20,9).
Con quel primo verso il salmista dice a Dio: non ti chiedo che tu mostri qui la tua gloria per noi. No, noi non abbiamo meriti per questo (il popolo visse l’esilio come punizione per le sue infedeltà). Mostra invece la tua gloria per fedeltà a te stesso, per fedeltà al tuo Nome. Non farlo per noi: fallo per te. È questa una delle più belle espressioni della gratuità nella fede. Il salmista sapeva che non possiamo eliminare il nostro vantaggio dalle nostre preghiere, possiamo però pregare Dio di non tenerne conto.
 Forse è questo il massimo della gratuità possibile sotto il sole: Dio, io non riesco a dimenticare i miei interessi, tu lo sai, ma non tenerne conto mentre ti prego. Qui la fede si distingue dal commercio, la preghiera dalla magia. Si prega Dio per Dio. Uno dei frutti religiosi e umani più grandi dell’esilio: la gratuità della preghiera, la capacità dell’uomo di auto-trascendersi, di essere più grande dei propri bisogni.
Forse è questo il massimo della gratuità possibile sotto il sole: Dio, io non riesco a dimenticare i miei interessi, tu lo sai, ma non tenerne conto mentre ti prego. Qui la fede si distingue dal commercio, la preghiera dalla magia. Si prega Dio per Dio. Uno dei frutti religiosi e umani più grandi dell’esilio: la gratuità della preghiera, la capacità dell’uomo di auto-trascendersi, di essere più grande dei propri bisogni.Un ultimo passaggio sull’idolatria. Il divieto biblico di rappresentare la divinità con statue o disegni, generò come sua bellezza collaterale una grande produzione di immagini letterarie e narrative su Dio. La Bibbia ha vietato immagini plastiche di Dio, ma ha prodotto una quantità sterminata di immagini intellettuali. Midrash rabbinici, leggende ebraiche, e poi la immensa, in qualità e quantità, letteratura ispirata da episodi biblici. Quel limite all’immagine ha impoverito il mondo ebraico di arti visive ma, come la siepe leopardiana, ha generato una letteratura infinita. Dio non è stato dipinto ma è stato molto pensato e meravigliosamente narrato. La filosofia greca ha pensato soprattutto l’uomo, la sapienza biblica ha pensato soprattutto Dio. Ma la Bibbia, forse, non è stata abbastanza consapevole del grande pericolo delle rappresentazioni intellettuali di Dio (L.A. Schoekel). La Bibbia vietò l’immagine (e la pronuncia del nome) di Dio per salvare Dio nel suo mistero e nella sua intimità, per proteggerlo dalle nostre molte manipolazioni. Ma le immagini più potenti non sono quelle visive, sono quelle mentali. L’idolatria non si manifesta solo con pupazzi e statue, i pupazzi più perniciosi sono i pupazzi intellettuali. Quella parola, cuore e anima profonda della Bibbia, è molto più capace delle mani di produrre feticci, di fabbricare vitelli d’oro.
Il nome delle idolatrie intellettuali è ideologia. E tra le ideologie molto dannose sono quelle religiose, perché dimenticano spesso il divieto di "farsi immagine" di Dio. La tentazione della teologia è violare il comandamento del divieto di farsi immagini di Dio. Mentre il bravo scienziato o il bravo economista sanno che il modello che usano per descrivere il mondo non è il mondo (per esempio: la concorrenza perfetta non è il mercato), il teologo (tranne i grandissimi, e tra questi san Tommaso) è tentato di credere che i modelli che ha costruito per descrivere Dio siano l’immagine di Dio. E così, una volta costruito un modello pensato come immagine, catturano Dio dentro quella immagine. Abbiamo ucciso migliaia di persone, bruciato eretici perché troppo sicuri che l’idea che ci eravamo fatti di Dio fosse la sua immagine. Solo recuperando il senso biblico del divieto di immagine per custodire il mistero Dio potremo imparare l’arte del dialogo con chi ha altre idee di Dio.
Molto bello e suggestivo è l’ultimo verso di critica agli idoli: «Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida!» (115,8). Nel tempo abbiamo imparato che il congiuntivo ("diventi") può essere sostituito dall’indicativo: diventa. Noi diventiamo gli oggetti e le immagini che adoriamo. Non ce ne stiamo accorgendo, ma stiamo diventando sempre più simili alle nostre merci, cittadini sempre più simili al consumatore-idolo. Il Salmo termina con una splendida serie di benedizioni. Sono per noi, non ce ne perdiamo neanche una: «Vi renda numerosi il Signore, voi e i vostri figli. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l’ha data ai figli dell’uomo» (115,14-16).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- CORONA -VIRTUS E COVID-19. "Nessun sincretismo". Bartolomeo I: la preghiera comune vero atto di libertà per evitare il baratro.15 maggio 2020, di Federico La Sala
Covid-19.
Bartolomeo I: la preghiera comune vero atto di libertà per evitare il baratro
Sulla giornata di preghiera di oggi il patriarca ecumenico di Costantinopoli: "Nessun sincretismo". "Chiudersi all’altro tradisce l’idea di Dio". "Amore e solidarietà è la via"
di Stefania Falasca (Avvenire, giovedì 14 maggio 2020)
- [Foto] Il patriarca ecumenico Bartolomeo. Il leader ortodosso ha aderito alla Giornata di preghiera e digiuno promossa dall’Alto Comitato per la fratellanza umana
«Amore e solidarietà sono gli aspetti positivi della preghiera mondiale, per un cambio di mentalità... Il tempo delle parole è finito, ora possono solo iniziare le opere. Possiamo pertanto affermare che la preghiera comune sarà un passo importante nella volontà di evitare il baratro». Aderendo alla proposta dell’Alto Comitato per la fratellanza umana, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I ha fin dal primo momento sottolineato l’importanza che i credenti di tutte le religioni si uniscano in preghiera a implorare l’aiuto per tutta l’umanità nel tempo segnato dalla pandemia che il mondo sta attraversando. E per “Avvenire” così risponde.
Santità, perché è importante questo momento di preghiera comune fatta da appartenenti di diverse religioni? La preghiera comune non è un atto di sincretismo religioso ma un vero atto di libertà, caratterizzato dalla capacità di ogni essere umano di porsi in relazione con Dio per il bene di tutti. La libertà della preghiera è il primo elemento che caratterizza ogni dialogo umano, perché è dialogo con Dio. Non è altresì una forma di panteismo, ma è relazione intima, profonda e sacra tra il creato e il Creatore. È intima, perché nella preghiera di ogni essere umano vi è una sinergia relazionale che parte dal cuore sensibile dell’uomo. È profonda, perché pone ogni creatura a guardare in sé stesso, senza essere vittima di condizionamenti esterni, che alterano la visione profonda di Dio. Infine, è sacra, perché nella sacralità della persona umana vi è la comune appartenenza alla famiglia umana, che non propone rapporti di tolleranza, ma rapporti di uguaglianza, che non è fondamenta-lista o fanatica, ma capace di trovare le ricchezze della fede o anche dei riferimenti metafisici in tutti gli aspetti della religiosità dell’uomo. La preghiera comune pertanto supera le persecuzioni, perché esse non hanno diritto di cittadinanza; supera ogni atto di tolleranza, perché non c’è qualcuno che permette e qualcuno che accetta il permesso dell’altro; supera l’integralismo, perché esso è la negazione della libertà e se si nega la libertà, si nega anche il rapporto tra Dio e l’uomo.
Come si deve intendere anche il gesto del digiuno legato alle opere di carità? Il digiuno, come modo di preghiera e le opere di carità, come atto di ogni rapporto umano. Nella storia bimillenaria della Chiesa, il digiuno non è assenza o riduzione di cibo o altro, ma è un atteggiamento insito nell’uomo che si fa preghiera in Dio. Gesù stesso ha digiunato e ha insegnato come il vero digiuno spirituale possa vincere ogni forza avversa. E nella libera preghiera e nel digiuno spirituale non può mancare l’attenzione verso i fratelli. Allora questa preghiera mondiale trova il suo vero modo di essere vissuta, partecipata e sicuramente ascoltata e ne spiega la sua importanza.
Questi gesti quali sviluppi posso portare in questa umanità sconvolta dalla pandemia? Da troppi anni, l’umanità non è stata attenta al grido di dolore che saliva dalla creazione di Dio. Un piccolissimo e sconosciuto virus, ci ha fermati. L’intera umanità si è accorta della sua fragilità, della importanza dei rapporti interpersonali e ancora una volta si trova ad un bivio dopo questa esperienza. Il tempo delle parole è finito, ora possono solo iniziare le opere. Possiamo pertanto affermare che la preghiera comune sarà un passo importante nella volontà di evitare il baratro. Innalziamo la nostra preghiera a Dio con fede, supplichiamo con la certezza dell’ascolto, imploriamo con lacrime di vera contrizione. Come sviluppo positivo del gesto della preghiera comune di tutta l’umanità ribadiamo di vivere questo periodo come un cammino del deserto per giungere in sicurezza alla Terra Promessa, quando la scienza, per grazia di Dio, vincerà la battaglia col virus. Perché siamo sicuri che, anche con le nostre preghiere, vincerà. E la prova è una occasione per cambiare al meglio. Nella direzione di rafforzare l’amore e la solidarietà. Amore e solidarietà sono gli aspetti positivi della preghiera mondiale per un cambio di mentalità.
Qual è il contributo che possono dare le religioni per un mondo più vivibile? Possono aprire alla vera conoscenza dell’altro. La chiusura, in ogni religione, è da considerarsi di per sé stessa un tradimento e un offuscamento dell’idea di Dio e di Divinità. Conoscere significa partecipare alla vita intima del fratello che abbiamo accanto, significa superare gli stereotipi che arrivano da altre epoche, significa capire, comprendere, apprezzare e quindi rispettare e amare. Il rispetto e l’amore portano al dialogo, non per una “unica religione mondiale”, come alcune volte sentiamo dire, ma perché il dialogo forma la base profonda etica e spirituale dell’uomo. Se le religioni del mondo sapranno fare di questo dialogo la loro forza, allora anche la loro fede, il loro Credo sarà rafforzato, non contro qualcuno, ma a favore di tutti. Le religioni saranno così portavoci di una “società aperta” dove non avrà la ultima parola solamente la omogeneizzazione economica e lo sviluppo basato sul principio della autonomia dell’economia, ma saranno espressioni di fede nella libertà e nella dignità umana. (Si ringrazia per la traduzione p. Athinagoras e Nikos Tzotis)
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- IL CIELO, LA TERRA, E L’ANTROPOLOGIA BIBLICA. Non è bene che Dio sia solo (di Luigino Bruni).11 maggio 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra/7.
Non è bene che Dio sia solo
di Luigino Bruni (Avvenire, domenica 10 maggio 2020)
- E quando miro in cielo arder le stelle; / Dico fra me pensando: / A che tante facelle? / Che fa l’aria infinita, e quel profondo / Infinito Seren? che vuol dir questa / Solitudine immensa? ed io che sono?
- Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
Alcune persone ricordano per tutta la vita il giorno in cui hanno visto per la prima volta il cielo stellato. Lo avevano "visto" altre volte, ma in una benedetta notte è successo qualcosa di speciale e lo hanno visto veramente. Hanno fatto l’esperienza metafisica dell’immensità e, simultaneamente, hanno avvertito tutta la propria piccolezza e fragilità. Si sono, ci siamo, visti infinitamente piccoli. E lì, sotto il firmamento, sono fiorite domande diverse, quelle che quando arrivano segnano una tappa nuova e decisiva della vita: dove sono e cosa sono i miei affari? e i miei problemi? cosa è la mia vita? cosa i miei amori, i miei dolori? E poi è arrivata la domanda più difficile: e io, che sono? È il giorno tremendo e bellissimo; per alcuni segna l’inizio della domanda religiosa, per altri la fine della prima fede e l’inizio dell’ateismo - per poi scoprire, ma solo alla fine, che le due esperienze erano simili, che magari c’era molto mistero nella risposta atea e molta illusione in quella religiosa, ma lì non potevamo saperlo. Non tutti fanno questa esperienza, ma se la desideriamo possiamo provare a uscire di casa in queste notti fatte più calme e nitide dai mesi sabbatici, cercare le stelle, fare silenzio, attendere le domande - che, mi hanno detto, qualche volta arrivano.
Per qualcuno, poi, c’è stato un altro giorno decisivo. Quando quell’infinitamente piccolo ha fatto l’esperienza che quell’«Amor che move il sole e l’altre stelle» si interessava di lui, di lei, lo cercava, gli parlava, la incontrava. Giorno altrettanto decisivo, perché non basta l’esperienza vera del giorno delle stelle perché inizi la vita religiosa. Ci sono molte persone che sentono veramente vibrare lo spirito di Dio nella natura, odono la sua voce risuonare nelle notti stellate e in molti altri luoghi, ma non si sono mai sentite chiamare per nome da quella stessa voce. Come ci sono altri che hanno fatto un autentico incontro personale con la voce dentro, ma che poi non l’hanno mai sentita vivere nell’universo intero, che non si sono mai commossi riconoscendola nell’immensità del cosmo. È l’incontro tra questi due giorni che segna l’inizio della vita spirituale matura, quando l’immensità che ci svela la nostra infinita piccolezza diventa un tu più intimo del nostro nome.
L’autore del Salmo 8 ha fatto, credo, l’esperienza di entrambi questi giorni. Ha riconosciuto la presenza di YHWH nel firmamento infinitamente grande e si è sentito infinitamente piccolo; e poi ha intuito che la voce che gli parlava tra le galassie era la stessa voce che gli parlava nel cuore: «Come splende, YHWH, il tuo nome su tutta la terra: la bellezza tua voglio cantare, essa riempie i cieli immensi... Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, io mi chiedo davanti al creato: e l’uomo che cos’è? perché di lui ti ricordi? Che cosa è mai questo figlio d’uomo perché tu ne abbia una tale cura?» (8, 2-5). Versi meravigliosi. Dovremmo avere il cuore e le stigmate di Francesco per cantarli.
Assistiamo in presa diretta a una esperienza dell’assoluto. Quell’antico poeta ha avvertito l’immensità e la piccolezza, non si è sentito schiacciato, e ha iniziato un nuovo canto. Il canto dell’umiltà (humilitas) vera, perché l’humus ci dice chi siamo veramente solo se riusciamo per un attimo a guardarlo da distanza siderale; l’adamah (terra) svela l’Adam solo se vista dall’alto. È questa la gioia per la verità finalmente rivelatasi, per una nuova ignoranza che non umilia. L’umiltà è l’opposto dell’umiliazione. E si sperimenta una nuova infanzia, una sconfinata giovinezza: «Da fanciullo e lattante balbetto» (8,3).
Al centro del salmo una domanda: cosa è il figlio d’uomo (Ben Adam: espressione cara ai profeti e ai vangeli), di fronte a tanta immensità?! Splendida è la risposta: nonostante la sua insignificanza in rapporto alle stelle e la sua piccolezza nel tempo e nello spazio, tu ti prendi cura dell’uomo, tu ti ricordi di lui. Come a dire: se tu tenessi conto, o Dio, di quello che l’Adam è oggettivamente in rapporto all’universo sterminato, non dovresti occupartene; e invece ti prendi cura di lui, di lei. E quindi la domanda necessaria: ma questa voce che mi parla dentro è proprio la stessa che ha parlato tra le galassie? La risposta del primo giorno può essere soltanto un sì, altrimenti il cammino non incomincia! Col passare del tempo la risposta diventa: forse. Poi arrivano i lunghi anni quando la risposta è: no. Infine ritorna il sì, ma - se e quando ritorna - è un sì detto con un’altra profondità e un’altra umiltà. E qui nasce una nuova meraviglia, trabocca la gratitudine, riaffiora la preghiera degli ultimi tempi.
Sta in questa tensione tra le stelle e il cuore, abitati entrambi dalla stessa presenza, la dignità dell’Adam, dei suoi figli e delle sue figlie, la sua gloria e il suo onore. Ci si perde nelle varie ideologie quando si perde uno di questi due poli. Dobbiamo leggere il Salmo 8 in parallelo con i primi capitoli della Genesi: «E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). Il versetto della Bibbia che, forse, amo di più. L’Adam è posto da Elohim al centro del giardino della creazione perché ne fosse custode e responsabile. Il Salmo ce lo ridice: «Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi» (Salmo 8,7). L’Adam diventa il primo interlocutore di Dio, perché con la sua reciprocità potesse accompagnare anche la solitudine di Dio - «non è bene che l’uomo sia solo» (Gn 2,18) va letto insieme all’altra frase non scritta nella Bibbia ma altrettanto presente: non è bene che Dio sia solo.
Non mi stupirebbe se l’autore di quell’antico salmo mentre cantava avesse sottomano questi versi della Genesi. Forse stava meditando e contemplando "cosa è l’uomo" quando, ad un certo punto, non ha più retto l’emozione e ha composto uno dei versi più belli sull’uomo mai scritti da tutta la letteratura religiosa e laica. Dopo averlo visto sub specie aeternitatis, dopo essere andato con l’anima sulla luna e averlo perso di vista tanta era la sua piccolezza, tornato a quelle parole della Genesi ha rivisto un altro uomo. E ha pronunciato questo capolavoro, che va letto dopo qualche attimo di silenzio: -«Eppure l’hai fatto poco meno di Elohim, di gloria e di onore lo hai coronato» (8,6). Eppure: a volte la Bibbia sa racchiudere in una umile congiunzione tutta la sua profezia. Siamo effimeri, siamo come l’erba ... eppure... «Una voce dice: "Grida", e io rispondo: "Che cosa dovrò gridare?". Ogni uomo è come l’erba. Secca l’erba, il fiore appassisce ... Veramente il popolo è come l’erba» (Isaia 40,6-7).
 Veramente ... eppure. Siamo stati pensati, cercati e amati tra un veramente e un eppure. Veramente effimeri come l’erba, veramente infinitamente piccoli, veramente infedeli e peccatori; eppure poco meno di Dio, eppure sua immagine e somiglianza, eppure amati, curati e attesi come figli.
Veramente ... eppure. Siamo stati pensati, cercati e amati tra un veramente e un eppure. Veramente effimeri come l’erba, veramente infinitamente piccoli, veramente infedeli e peccatori; eppure poco meno di Dio, eppure sua immagine e somiglianza, eppure amati, curati e attesi come figli.Questa è l’immensa antropologia biblica. La letteratura antica conosceva la metafora dell’immagine di Dio applicata all’uomo. Ma era usata per il re, per il faraone. La Bibbia la usa per ciascuno di noi, per ogni uomo e per ogni donna, per te, per me. È l’Adam, ogni Adam, l’immagine e somiglianza di Elohim; e quindi lo siamo anche noi, tutti noi. È questa la magna carta di ogni dichiarazione dei diritti dell’uomo e della donna, dei bambini, delle bambine, della dignità del creato. Il Salmo 8 è un inno a Dio e insieme un inno all’uomo. Esalta la persona dicendoci chi è quel Dio di cui egli è immagine, ed esalta Dio dicendoci chi sono l’uomo e la donna che lo riflettono. Perché se l’uno è immagine dell’altro, più l’Adam diventa bello più dice la bellezza del suo Creatore, e più lasciamo libero Dio di diventare migliore di noi, più abbelliamo noi stessi. Non capiamo l’antropologia biblica se usciamo dalla reciprocità intrinseca al simbolo dell’immagine.
Ma la bellezza e la forza di questo canto esplodono se immaginiamo il salmista cantare quel versetto 6 mentre leggeva anche i capitoli tre e quattro della Genesi: quelli della disobbedienza, della seduzione vincente del serpente, e poi Caino e il sangue di Abele, di cui il salmista sentiva ancora l’odore. È troppo semplice cantare la gloria e l’onore dell’uomo fermandosi al capitolo due. La sfida decisiva è riuscire a continuare il canto mentre i capitoli scorrono e si entra nelle pagine buie e buissime del no, quelle della rottura dell’armonia uomo-donna-creato-Dio, nelle pagine della cacciata da quel giardino meraviglioso, quelle della notte oscura del primo fratricidio della terra. E giunti lì, non smettere il canto. E poi continuarlo con l’urlo tremendo di Lamek l’uccisore di fanciulli, con la ribellione di Babele, con i peccati dei patriarchi, con le bugie e gli inganni di Giacobbe, con l’omicidio dei beniaminiti, fino all’omicidio di Davide, alle infedeltà di Salomone e di quasi tutti i re d’Israele. E non smettere mai di cantare: «Veramente ... Eppure lo hai fatto poco meno di un Dio».
Tutta la forza dell’antropologia biblica si sprigiona quando riusciamo a vincere il dolore e la vergogna e ripetiamo "veramente ... eppure" non solo di fronte al firmamento ma anche nelle carceri, nelle meschinità, nelle violenze, nei bassifondi di Calcutta, nelle via crucis che portano al Golgota. Non c’è condizione umana che non sia racchiusa tra quel veramente e quell’eppure, nessuno resta fuori. La Bibbia non ha avuto paura di narrarci i peccati e le bassezze dei suoi uomini perché credeva veramente all’immagine di Elohim. E ogni volta che nascondiamo nelle nostre storie le pagine più buie abbiamo smesso di credere che siamo immagine.
Caino ha cancellato la sua fraternità e i suoi figli continuano a cancellarla uccidendo ogni giorno Abele. Ma non ha potuto cancellare l’immagine - e se il "segno di Caino" fosse proprio l’immagine di Elohim? «O Dio, Signore nostro, come splende il tuo nome su tutta la terra!» (8,10).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- LIBERARE IL CIELO: IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU E L’ILLUMINISMO, OGGI.22 aprile 2020, di Federico La Sala
EPIDEMIA, POLITICA, E TEOLOGIA: IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU E L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO...
-
GOVERNO POLITICO ED EPIDEMIA: "[...] In una versione più accettabile e aggiornata della sovranità, come quella fornitaci da Jean-Jacques Rousseau, possiamo quindi dire che sovrano è sempre e solo il popolo; ma allo stesso tempo la volontà sovrana del popolo può venire ad esistenza solo nelle vesti di una volontà altra, quella dei governanti che si troveranno di volta in volta a fare esercizio del potere politico legittimo. Ciò che noi chiamiamo “democrazia”, e che senza indugio parafrasiamo come “potere del popolo”, si basa esattamente su questo semplice meccanismo: la posizione della pura immanenza (la volontà generale dei governati) richiede la posizione della pura trascendenza (una volontà particolare che, per dichiarare sovrani coloro che le obbediscono, deve mettere in forma questa loro generalità).
.Perché questo breve passaggio attraverso i classici del pensiero politico moderno? [...] è necessario articolare un campo tanto del sapere quanto delle istituzioni che sia capace di comprendere questo altro che per il momento resta “impossibile” o quantomeno “impensabile”. [...] La sfida, che gli antichi sono riusciti a modo loro a fare propria e che la modernità ha invece rifiutato, è quella di pensare l’unità di due momenti che, come abbiamo visto, il pensiero della democrazia non riesce a tenere fermi perché ci rimbalza all’infinito dall’uno all’altro [....]
 Questo significa anche che il problema della giustizia richiede non che sia data una risposta definitiva, valida per sempre, ma che sussista uno spazio “costituzionale” nel quale si dispieghi un processo di continua mediazione tra la pluralità sempre destabilizzante delle idee sul giusto e l’unità necessaria affinché la società nel suo complesso possa darsi un orientamento comune.
Questo significa anche che il problema della giustizia richiede non che sia data una risposta definitiva, valida per sempre, ma che sussista uno spazio “costituzionale” nel quale si dispieghi un processo di continua mediazione tra la pluralità sempre destabilizzante delle idee sul giusto e l’unità necessaria affinché la società nel suo complesso possa darsi un orientamento comune.
 Mediazione dunque tra la differenza e l’identità, senza cedere a quel gioco di specchi nel quale l’assolutizzazione di una pura differenza (la moltitudine degli individui privi di relazione) si ribalta immediatamente nell’assoluta indifferenza dell’Uno identico a sé (la legge incondizionata di un soggetto assoluto, sia esso Dio, il popolo o perfino un virus). È proprio questo spazio che il pensiero moderno della sovranità e della democrazia ha chiuso, perché assolutizzando la volontà dei cittadini come fondamento esclusivo della legge ha paradossalmente assolutizzato, di contro, l’arbitrio del tutto soggettivo del governante legittimo " (Pierpaolo Cesaroni e Lorenzo Rustighi, "Sul governo politico: riflessioni a partire dall’epidemia", Le parole e le cose, 22.04.2020).
Mediazione dunque tra la differenza e l’identità, senza cedere a quel gioco di specchi nel quale l’assolutizzazione di una pura differenza (la moltitudine degli individui privi di relazione) si ribalta immediatamente nell’assoluta indifferenza dell’Uno identico a sé (la legge incondizionata di un soggetto assoluto, sia esso Dio, il popolo o perfino un virus). È proprio questo spazio che il pensiero moderno della sovranità e della democrazia ha chiuso, perché assolutizzando la volontà dei cittadini come fondamento esclusivo della legge ha paradossalmente assolutizzato, di contro, l’arbitrio del tutto soggettivo del governante legittimo " (Pierpaolo Cesaroni e Lorenzo Rustighi, "Sul governo politico: riflessioni a partire dall’epidemia", Le parole e le cose, 22.04.2020).
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO: "[...] Rousseau cerca in tutti i modi di impostare bene il "trattato le cui condizioni siano eque" (Virgilio, Eneide, XI), ma perde il filo e, alla fine, si ritrova a riproporre la religione dei romani - la "religione civile", contro la "religione romana", cattolica ! Senza volerlo, prepara la strada "cattolico-romana" a Fichte, a Hegel, a Marx, a Gentile e a Lenin.
Kant reimposta il problema e riparte, bene : "tutto proviene dall’esperienza, ma non tutto si risolve nell’esperienza" o, diversamente, tutto viene dalla natura ma non tutto si risolve nella natura ; alla fine egli non riesce a sciogliere il nodo e resta in trappola. Al di là del mare di nebbia non può andare e - per non distruggere i risultati della sua esplorazione - si accampa lì dove è riuscito ad arrivare e decide: Io voglio che Dio esista.
Per Kant, Rousseau e Newton, come Locke, non sono stati affatto cattive guide per il suo viaggio. Il suo cammino è stato lungo, fruttuoso e coraggioso : la Legge morale dentro di me, il Cielo stellato sopra di me ! E, onestamente, rilancia di nuovo la domanda antropologica, quella fondamentale: "Che cosa è l’uomo?". Teniamone conto.
Ciò che essi cercavano di capire e quindi di sciogliere era proprio il nodo che lega il problema "religioso", il legame "sociale", il problema di "Dio", il problema della Legge, non quello o quella dei Faraoni e quella di una Terra concepita come un "campo recintato" o assoggettata alla "Moira" di Orfeo e alla Necessità.
Filosoficamente, è il problema dell’inizio ... e, con esso, dell’origine e dei fondamenti della disuguaglianza tra gli esseri umani. Il problema J.J. Rousseau, dunque: No King, no Bishop! Il problema della Legge - e della Lingua: il problema stesso del principio di ogni parola, la Langue, Essai sur l’origine des langues! Da dove il Logos e la Legge?! E, con queste domande, siamo già all’oggi, agli inizi del ’900 : Ferdinand de Saussure ! Ma ritorniamo al problema politico, della Legge della Polis o, come scrive Rousseau, della Citè. La questione è decisiva ed epocale: ed è al contempo questione antropologica, politica, e "teologica". In generale è la questione del rapporto Uno-Molti - una questione lasciata in eredità da Platone, e riproposta da Rousseau, nei termini del rapporto volontà generale - volontà di tutti o del cosiddetto "uno frazionario", e risolta ancor oggi nell’orizzonte moderno (cartesiano) - dopo Cristo, come dopo Dante, Rousseau e Kant - in modo greco, platonico-aristotelico. Una tragedia, e non solo quella di Nietzsche. In tutti i sensi.
Se continuiamo a truccare le carte e confondiamo l’Uno al numeratore con un "uno" degli "uno" o delle "uno" al denominatore finiremo per cadere sempre nella trappola della dittatura, e nel dominio del "grande fratello". E non riusciremo mai a distinguere tra "Dio" Amore [Charitas], e "Dio" Mammona [Caritas] - tra la "volontà generale" dell’Uno e la "volontà generale" di "uno", camuffato da "Uno". Liberare il cielo, pensare l’ "edipo completo" - come da progetto di Freud.
Vedere solo i molti (gli individui, meglio gli uomini e donne in carne ed ossa, le persone) che agiscono, discutono e lottano, e non vedere l’Uno, che è il Rapporto e il Fondamento di tutti e il Rapporto dell’Uno stesso con tutti i vari sotto-rapporti (economici, politici, religiosi, giuridici, pedagogici, familiari, e, persino, di amicizia) dei molti e tra i molti ... non porta da nessuna parte, se non alla guerra e alla morte. In tale orizzonte (relativistico, scettico e nichilistico), chi vuole guidare chi, che cosa può fare, che cosa può insegnare, che cosa può produrre ... se non il suo stesso "uno" - allo specchio ? Un narcisismo personale e istituzionale, imperialistico e ... desertificante !
È elementare, ma è così - come scriveva l’oscuro di Efeso, Eraclito : "bisogna seguire ciò che è comune : e ciò che è comune è il Logos" - la Costituzione, prima di ogni calcolo, per ragionare bene. La Costituzione è il fondamento, il principio, e la bilancia!!! Questo è il problema : la cima dell’iceberg davanti ai nostri occhi, e il punto più profondo sotto i nostri stessi piedi !!! E se non vogliamo permanere nella "preistoria" e, anzi, vogliamo uscirne, dobbiamo stare attenti e attente e ripensare tutto da capo, dalla radice (Kant, Marx), dalle radici: gli uomini e le donne, i molti, e il Rapporto-Fondamento che li collega e li porta - al di là della natura - nella società, e li fa essere ed esseri umani - dopo il lavoro in generale, il rapporto sociale di produzione in generale è la questione all’ordine del giorno nostro, oggi. [....]" . (Cfr.L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana").
-
GOVERNO POLITICO ED EPIDEMIA: "[...] In una versione più accettabile e aggiornata della sovranità, come quella fornitaci da Jean-Jacques Rousseau, possiamo quindi dire che sovrano è sempre e solo il popolo; ma allo stesso tempo la volontà sovrana del popolo può venire ad esistenza solo nelle vesti di una volontà altra, quella dei governanti che si troveranno di volta in volta a fare esercizio del potere politico legittimo. Ciò che noi chiamiamo “democrazia”, e che senza indugio parafrasiamo come “potere del popolo”, si basa esattamente su questo semplice meccanismo: la posizione della pura immanenza (la volontà generale dei governati) richiede la posizione della pura trascendenza (una volontà particolare che, per dichiarare sovrani coloro che le obbediscono, deve mettere in forma questa loro generalità).
.Perché questo breve passaggio attraverso i classici del pensiero politico moderno? [...] è necessario articolare un campo tanto del sapere quanto delle istituzioni che sia capace di comprendere questo altro che per il momento resta “impossibile” o quantomeno “impensabile”. [...] La sfida, che gli antichi sono riusciti a modo loro a fare propria e che la modernità ha invece rifiutato, è quella di pensare l’unità di due momenti che, come abbiamo visto, il pensiero della democrazia non riesce a tenere fermi perché ci rimbalza all’infinito dall’uno all’altro [....]
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- MESSAGGIO EVANGELICO E FIABA. Quarantena con Tolkien. Rileggere il Signore degli Anelli nei giorni del coronavirus.20 aprile 2020, di Federico La Sala
Le lacrime sono il vino del godimento
di Enrico Spadaro (Ondaiblea, 09 aprile 2020)
- Pasqua 2020, una pasqua particolare, vissuta in casa per il "lockdown" dovuto all’emergenza Covid-19. Dopo le lacrime arriva il godimento, dopo la contrizione la gioia : con queste riflessioni del dott. Enrico Spadaro (dottore di ricerca in Letteratura inglese ad Aix-en-Provence/Marsiglia) auguriamo ai lettori di Ondaiblea una serena Pasqua, di ripartenza e voglia di vita, di resurrezione e speranza (sm)
È con sensazioni di triste gioia che sembra avvicinarsi questa Pasqua, in cui quasi tutti i cristiani non possono fisicamente partecipare ai riti della Settimana Santa. Sembra quasi un paradosso, un ossimoro pronunciare queste parole, “triste gioia” : “gioia” nell’imminente resurrezione di Cristo, “triste” perché forse non totalmente vissuta.
Eppure esiste un termine greco, che racchiude un concetto forse maggiormente conosciuto nel mondo cristiano ortodosso, “charmolypi” (χαρμολύπη), che esprime al tempo stesso sentimenti di gioia (hara) e di tristezza (lypi). Si ritrova tale termine negli scritti di San Giovanni Climaco (525/575-603/650), monaco che visse quasi tutta la vita presso il monastero del Sinai. Nella sua dottrina, e in particolare nel suo scritto più celebre, La Scala della divina ascesa, vengono prevalentemente esaltati coloro che dopo aver peccato si pentono, poiché i dolori patiti permettono loro - attraverso il pentimento - di accedere alla vera “gioia” del Paradiso. Questi peccatori redenti sembrano aver provato la morte per poi essere risorti come Cristo, sono stati abbandonati e infine salvati dal Padre. Le lacrime che hanno versato sono così benedette : “Beati i sofferenti, perché essi saranno consolati”. (Matteo 5,4).
Il concetto espresso da San Giovanni Climaco potrebbe rinviare ad un elemento essenziale delle fiabe secondo lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien (1892-1973), vale a dire la consolazione del lieto fine, per cui l’autore, nel suo saggio Sulle Fiabe (1939) conia il termine “eucatastrofe”, l’improvviso capovolgimento felice degli eventi, “ed è in quanto tale un evangelium, che fornisce una visione fuggevole della Gioia, quella Gioia oltre le muraglie del mondo, intensa come il dolore”.[1]
 Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”
Con evangelium, Tolkien, fervente cattolico, non poteva che intendere il Vangelo, considerato come l’unica vera fiaba, e infatti continua il proprio saggio: “la Nascita di Cristo è l’eucatastrofe della storia dell’Uomo. La Resurrezione è l’eucatastrofe della storia dell’Incarnazione. Questa storia comincia e finisce nella gioia.”L’immensa opera letteraria di Tolkien e soprattutto i due romanzi principali, Lo Hobbit (1937) e Il Signore degli Anelli (1954-55), sono pieni di momenti in cui si verifica un’eucatastrofe, ma forse uno di quelli più evocativi è rappresentato dagli istanti immediatamente successivi la distruzione dell’Unico Anello tra le fiamme del Monte Fato. Frodo e Sam si credono spacciati e svengono, ma vengono salvati dalle grandi aquile e si risvegliano a Gondor con Gandalf al loro capezzale.
 Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam :
Tolkien descrive il momento attraverso le sensazioni di Sam :- [...] Sam si rese conto di non aver udito ridere, di non aver udito la semplice espressione della letizia, per giorni e giorni senza fine. Suonava alle sue orecchie come l’eco di tutte le gioie vissute. E improvvisamente si mise a piangere. Poi, come il vento di primavera spazza via la pioggia perché il sole brilli con maggiore intensità, le sue lacrime cessarono ed egli scoppiò a ridere, e balzò ridendo dal letto.[2]
E qualche pagina dopo :
- E quando Sam lo udì, rise dalla gioia ; poi si alzò in piedi ed esclamò : «O grande gloria e splendore ! Tutti i miei desideri sono stati esauditi!». E pianse.
- E tutto l’esercito rise e pianse e in mezzo alla loro allegria e alle lacrime si alzò come argento la voce del menestrello e tutti tacquero. Ed egli cantò, a volte in Lingua Elfica, a volte dell’idioma dell’Ovest, finché i loro cuori, trafitti dalle dolci parole, traboccarono, e la loro gioia fu simile a spade, e il loro pensiero vagò nelle regioni ove delizie e dolori sono un’unica cosa e le lacrime sono il vino del godimento.[3]
Gioia e dolore sembrano fondersi e le lacrime sono la via che porta alla gioia, secondo la teorizzazione tolkieniana dell’eucatastrofe, ma anche secondo il concetto di “charmolypi” di San Giovanni Climaco. Inoltre, occorre sottolineare la data della distruzione dell’Anello, il 25 marzo, che è sì il giorno dell’Annunciazione a Maria, ma nella tradizione medievale era anche il giorno della crocifissione, il Venerdì Santo, un giorno di dolore che anticipava la gioia della Pasqua.
I momenti d’eucatastrofe in Tolkien non saranno forse l’espressione totale di beautitudine, ma potrebbero essere una rappresentazione di gioia e dolore, che preannuncia la “Gioia” finale del Paradiso.
Enrico Spadaro
Note
[1] Tolkien. Il medioevo e il fantastico. Milano, Bompiani, p. 225.
[2] Tolkien. Il Signore degli Anelli. Milano, Bombiani, p. 1136.
[3] Ibid., p. 1139.
Quarantena con Tolkien.Rileggere il Signore degli Anelli nei giorni del coronavirus
Ci sono analogie tra l’opera di Tolkien e la situazione attuale; un nemico che non risparmia nessuno e il superamento delle differenze per affrontare la minaccia. Una serie per rileggere il capolavoro
di Francesco Marzella (Avvenire, venerdì 17 aprile 2020)
La metafora più usata per descrivere la situazione di emergenza che viviamo è, senza alcun dubbio, quella della guerra. “Siamo in guerra” è un ritornello che sentiamo ripetere ormai allo sfinimento, dal “Nous sommes en guerre” di Macron al più recente discorso pronunciato da Boris Johnson, che appena dimesso dall’ospedale, prima ancora di ringraziare chi lo ha curato, ha lodato gli abitanti del Regno Unito per aver formato uno “scudo umano” attorno al National Health Service (l’equivalente britannico dell’SSN) durante questa “battaglia nazionale”.
L’utilizzo della metafora divide e si può lecitamente dubitare che sia la più adatta. Si tratta, in ogni caso, di una metafora che ha conosciuto una costante fortuna nei secoli, venendo impiegata in diversi ambiti, e che nel contesto odierno ha diverse implicazioni - alcune delle quali potenzialmente pericolose, è evidente - ma che certo ci trasmette con efficacia un senso di precarietà e di emergenza. E ci ricorda anche che, bloccati come siamo in luoghi che non necessariamente consideriamo casa, siamo costretti a fronteggiare la situazione lì dove ci ha colto, accettando anche l’idea di non poter raggiungere i nostri cari. Anche perché si ha a che fare con un pericolo che incombe su tutti e ovunque e che almeno in teoria dovremmo affrontare insieme, superando egoismi e nazionalismi.
L’idea della guerra sembra suggerire o addirittura imporre, però, anche l’atteggiamento da assumere in queste circostanze straordinarie. Ci vuole eroismo, l’eroismo, appunto, di chi va in guerra. È inevitabile pensare al coraggio, alla determinazione, alla capacità di sopportare il dolore, allo spirito di sacrificio. L’immagine idealizzata del guerriero forte e impavido motiva e forse rassicura i più, ma probabilmente non lascia troppo spazio alla fragilità, al senso di smarrimento, all’umano timore che ci hanno fatto visita soprattutto nei primi tempi dell’emergenza.
L’avvento del virus è coinciso per me con la rilettura di Il Signore degli Anelli di Tolkien, un’opera che fra i tanti meriti ha proprio quello di proporre alcune declinazioni dell’eroismo tutt’altro che scontate. L’idea, in realtà, è nata dal desiderio di leggere finalmente il romanzo nel testo inglese originale, aggirando così l’acceso dibattito sulle traduzioni italiane che ha tenuto banco nell’inverno appena trascorso. È però innegabile che ci possano essere alcune analogie fra la situazione attuale e la grandiosa storia che culmina con la Guerra dell’Anello: un nemico che avanza inesorabile e che non risparmia nessuno, il superamento delle differenze per affrontare uniti la comune minaccia.
Del resto, lo stesso Tolkien sembra autorizzare simili letture quando nella celebre prefazione alla seconda edizione del romanzo manifesta la sua avversione per l’allegoria, preferendo di gran lunga l’“applicabilità” delle vicende narrate al pensiero e all’esperienza dei lettori. L’applicabilità - spiega Tolkien - “risiede nella libertà del lettore”, mentre l’allegoria “nel dominio intenzionale dell’autore” (tutte le traduzioni sono mie). E continua: “Di certo un autore non può essere per nulla influenzato dalla sua esperienza (...) In effetti bisogna trovarsi di persona all’ombra della guerra per sentirne pienamente l’oppressione; ma col passare degli anni sembra che ora quasi ci si dimentichi che essere sorpresi in gioventù dal 1914 fu un’esperienza non meno orribile dell’essere coinvolti nel 1939 e negli anni che seguirono. Alla fine del 1918 tutti i miei amici più cari, tranne uno, erano morti”.
Tolkien si sofferma su questi ricordi dolorosi per scoraggiare l’interpretazione di alcuni episodi della sua opera alla luce del secondo conflitto mondiale o come puntuali trasposizioni letterarie di situazioni vissute o testimoniate dall’autore. Allo stesso tempo, però, risulta evidente come la genesi del Signore degli Anelli sia legata alla tragedia delle guerre mondiali.
 Tolkien, infatti, combatté durante la prima e iniziò a scrivere quello che diventerà il suo capolavoro poco prima dello scoppio della seconda, cui presero parte due dei suoi figli. A uno di loro, Christopher - poi curatore delle edizioni delle sue opere postume - in servizio in Sudafrica, Tolkien inviò alcuni capitoli del Signore degli Anelli, tenendolo aggiornato sugli sviluppi del suo lavoro, che verrà pubblicato dopo lunghe revisioni solo fra 1954 e 1955.
Tolkien, infatti, combatté durante la prima e iniziò a scrivere quello che diventerà il suo capolavoro poco prima dello scoppio della seconda, cui presero parte due dei suoi figli. A uno di loro, Christopher - poi curatore delle edizioni delle sue opere postume - in servizio in Sudafrica, Tolkien inviò alcuni capitoli del Signore degli Anelli, tenendolo aggiornato sugli sviluppi del suo lavoro, che verrà pubblicato dopo lunghe revisioni solo fra 1954 e 1955.Forse anche perché concepita e scritta in anni così critici, l’opera di Tolkien ci sembra oggi ancora più vicina e capace di offrire conforto e ispirazione. Il fantasy è solitamente considerato un genere di evasione - almeno questo, un tipo di evasione che è autorizzato persino in quarantena! - ma fu lo stesso Tolkien, nel suo saggio sulle fiabe, a difendere i racconti di fantasia invitando a non far confusione fra “la fuga del disertore” (e qui torna la metafora della guerra!), cioè di colui che scappa dalla realtà per non fare i conti con essa, e “l’evasione del prigioniero”, che dalla realtà non si fa inchiodare, ma sempre cerca qualcosa di più alto.
Il viaggio nella Terra di Mezzo non è una fuga dal quotidiano che non ci soddisfa o solo un modo per ammazzare il tempo, al contrario: la sub-creazione tolkeniana, pur rifiutando il linguaggio allegorico, invita a scendere nelle profondità di ciò che viviamo e ci guida in una ricerca di senso oggi più che mai fondamentale. Sono convinto che la nostalgia della Contea di Frodo e Sam, il conflitto interiore di Boromir, il coraggio generoso di Éowyn abbiano qualcosa di nuovo da dirci in questo tempo di attesa e di incertezza, e pertanto desidero condividere alcune riflessioni, da lettore a lettori.
Il nostro viaggio con Tolkien inizierà con un episodio centrale di La Compagnia dell’Anello, il consiglio di Elrond, in cui si ricostruisce la storia dell’Anello e si decide come affrontare la minaccia che incombe sulla Terra di Mezzo. The road goes ever on and on... l’appuntamento è a domani e quindi tutti i lunedì sulle pagine avvenire.it.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO --- Il sogno di La Pira. «Mediterraneo messaggero di pace per il mondo» (del presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti).21 febbraio 2020, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Mediterranea-mente ... *
Anticipazione
«Mediterraneo messaggero di pace per il mondo».
Il sogno di La Pira
Culla della famiglia di Abramo deve essere esempio di riconciliazione fra i popoli. Partendo dal "sindaco santo" l’introduzione del presidente Cei al libro suile idee che ispirano l’incontro pugliese
Gualtiero Bassetti (Avvenire, martedì 18 febbraio 2020)
- [Foto] Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti
- Anticipiamo sintesi dell’introduzione di Una profezia per la pace (Lev, pagine 148, euro 20, fra pochi giorni in libreria), che raccoglie interventi del cardinale Gualtiero Bassetti. Un libro che illustra i principi ispiratori dell’Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo frontiera di pace, che inizia mercoledì 19 febbraio a Bari.
Sono vissuto in un paese di orfani e di poveri. Tra i banchi della scuola elementare di Fantino, una minuscola frazione del Comune di Marradi sull’Appennino tosco-romagnolo, molti alunni erano orfani. I padri di quei bambini, infatti, erano stati uccisi il 17 luglio 1944 da una crudele rappresaglia tedesca nella vicina località di Crespino sul Lamone: ben 45 persone erano state fucilate senza alcuna pietà. Tra di loro anche il parroco, don Fortunato Trioschi, che era stato preso dai soldati mentre stava recitando il vespro in chiesa con le donne. «Strappato a viva forza dal suo pietoso ufficio - si legge nel Bollettino mensile di Crespino del marzo 1946 - egli recitava per i moribondi la preghiera della speranza cristiana». «Un colpo di mitra gli mozzò le parole sul labbro» e cadde riverso sulla fossa che aveva precedentemente scavato insieme ai suoi parrocchiani. All’indomani della fine del conflitto eravamo tutti poveri, ma di una povertà dignitosa. Siamo sopravvissuti alla miseria tipica degli anni del dopoguerra perché avevamo capito che il condividere è moltiplicare. Se mia madre faceva il pane, quel pane era anche per i vicini. Se un contadino aveva munto una mucca, quel latte era anche per i bambini. Se qualcuno comprava il sale, che era un alimento preziosissimo, ne dava un po’ anche agli altri. Si condivideva tutto. E condividendo tutto siamo cresciuti insieme, uomini, donne e bambini, in una comunità coesa in cui la Chiesa svolgeva una funzione importantissima. L’anticlericalismo era ben presente anche nell’Italia degli anni Cinquanta ma, nella vita quotidiana, non metteva in discussione la figura del sacerdote. Il prete, soprattutto nelle campagne, era il segno di una presenza religiosa, culturale e sociale. Le persone andavano dal sacerdote per consigli di tutti i tipi, perché era l’unica persona che aveva una cultura e che, al tempo stesso, si prendeva cura concretamente della «povera gente». Quella «povera gente» a cui anche Giorgio La Pira (terziario domenicano e francescano, professore universitario di diritto romano, membro dell’Assemblea costituente, deputato alla Camera per tre legislature e, soprattutto, sindaco di Firenze per molti anni) dedicò gran parte della sua esistenza.
Nell’aprile del 1950, su "Cronache Sociali", La Pira pubblicò un saggio molto importante dal titolo L’attesa della povera gente. Sebbene svolgesse un’analisi che partiva dall’esame del reddito pro capite mondiale, quello scritto non era solo un testo che si inseriva nel dibattito economico, ma era soprattutto la traduzione concreta del messaggio evangelico di giustizia sociale e amore verso gli ultimi.
 Quando entrai in seminario nel 1956 a Firenze, La Pira era un personaggio straordinariamente amato dalla popolazione. Non era solo il sindaco, era molto di più. Era una testimonianza di fede autentica riconosciuta da tutti. Il nostro rettore, uomo di grande cultura biblica, lo invitava spesso in semi- nario. Lui ci incantava ad ascoltarlo, si fidava di noi piccoli e ci parlava dei suoi grandi progetti. I fiorentini, sin da vivo, lo consideravano un santo.
Quando entrai in seminario nel 1956 a Firenze, La Pira era un personaggio straordinariamente amato dalla popolazione. Non era solo il sindaco, era molto di più. Era una testimonianza di fede autentica riconosciuta da tutti. Il nostro rettore, uomo di grande cultura biblica, lo invitava spesso in semi- nario. Lui ci incantava ad ascoltarlo, si fidava di noi piccoli e ci parlava dei suoi grandi progetti. I fiorentini, sin da vivo, lo consideravano un santo.
 Ogni incontro con La Pira, anche fugace, lungo la strada, rappresentava per i cittadini un momento di arricchimento personale. Egli annunciava con gioia il Vangelo in ogni momento e tutto, per lui, era motivo di contemplazione: dal campanile di Giotto ai pescatori sotto il ponte Vespucci. È stato, senza dubbio, un mistico prestato alla politica. Nella sua visione del mondo, carità e politica si fondevano in un legame indivisibile. E al centro della sua azione si collocava il cosiddetto «pilotaggio della speranza».
Ogni incontro con La Pira, anche fugace, lungo la strada, rappresentava per i cittadini un momento di arricchimento personale. Egli annunciava con gioia il Vangelo in ogni momento e tutto, per lui, era motivo di contemplazione: dal campanile di Giotto ai pescatori sotto il ponte Vespucci. È stato, senza dubbio, un mistico prestato alla politica. Nella sua visione del mondo, carità e politica si fondevano in un legame indivisibile. E al centro della sua azione si collocava il cosiddetto «pilotaggio della speranza».La sua missione terrena, collocata in un’epoca storica dominata dalle ideologie, non si esauriva nella gestione della cosa pubblica ma era una «missione essenzialmente religiosa» che rispondeva a una «specifica chiamata» divina. Egli è stato un «ambasciatore di Cristo», cioè un uomo di Dio o, meglio, un « nabì (bocca di Dio)», un profeta dei tempi odierni. Il profeta è un chiamato dal Signore e colui che parla per conto del Creatore. È colui che sa mettersi in ascolto della parola di Dio e perciò riesce a leggere in profondità il mondo che gli sta attorno. Il profeta è una «sentinella per la casa d’Israele» ed esprime con passione e generosità, fino a sembrare stolto e ingenuo, questa sua missione divina.
 Giorgio La Pira è stato un profeta del dialogo, della speranza e della pace. La fede era il motore della sua azione, che si innestava in un contesto internazionale caratterizzato da un «crinale apocalittico» dominato dallo scontro tra le due superpotenze e dall’incubo nucleare. Alla logica del conflitto, La Pira opponeva la supremazia del dialogo. Un dialogo cercato con tutte le forze nei Paesi dell’Europa dell’Est, in Asia, in America Latina e in Africa.
Giorgio La Pira è stato un profeta del dialogo, della speranza e della pace. La fede era il motore della sua azione, che si innestava in un contesto internazionale caratterizzato da un «crinale apocalittico» dominato dallo scontro tra le due superpotenze e dall’incubo nucleare. Alla logica del conflitto, La Pira opponeva la supremazia del dialogo. Un dialogo cercato con tutte le forze nei Paesi dell’Europa dell’Est, in Asia, in America Latina e in Africa.In questo sforzo incessante il sindaco di Firenze traccia una strada; è il «sentiero di Isaia» che si basava sull’antica profezia messianica: «Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci». Il sentiero di Isaia tracciato da La Pira si proponeva di arrivare al disarmo generale trasformando le «armi distruttive in strumenti edificatori della pace e della civiltà». Secondo la sua visione escatologica, tutta la storia convergeva verso «il porto finale» della pace.
 Per raggiungere la pace, La Pira incontra molti capi di Stato. In uno di questi incontri, conia una delle sue espressioni più note: «Abbattere i muri e costruire i ponti». Un’immagine che mutuò da quello che vide al Cairo nel 1967 dopo aver incontrato il presidente egiziano Nasser. In quell’occasione notò «una squadra di operai abbattere i muri che erano stati costruiti davanti alle porte dell’albergo, come strumenti di difesa antiaerea». In quel gesto vide il simbolo di una grande azione politica e culturale. Bisognava abbattere «il muro della diffidenza» tra i popoli e costruire ponti di dialogo tra le genti. Occorreva unire e non dividere.
Per raggiungere la pace, La Pira incontra molti capi di Stato. In uno di questi incontri, conia una delle sue espressioni più note: «Abbattere i muri e costruire i ponti». Un’immagine che mutuò da quello che vide al Cairo nel 1967 dopo aver incontrato il presidente egiziano Nasser. In quell’occasione notò «una squadra di operai abbattere i muri che erano stati costruiti davanti alle porte dell’albergo, come strumenti di difesa antiaerea». In quel gesto vide il simbolo di una grande azione politica e culturale. Bisognava abbattere «il muro della diffidenza» tra i popoli e costruire ponti di dialogo tra le genti. Occorreva unire e non dividere.Dopo la crisi di Suez del 1956, matura il progetto di convocare a Firenze un grande incontro internazionale dedicato al Mediterraneo. Nel maggio del 1958, all’interno di una corrispondenza fittissima col pontefice, invia una lettera a Pio XII in cui presenta il suo progetto di Colloqui mediterranei.
 «Vi dico subito, Beatissimo Padre, quale è la ’intuizione’ che da qualche tempo fiorisce sempre più chiaramente nella mia anima. Questa: il Mediterraneo è il lago di Tiberiade del nuovo universo delle nazioni: le nazioni che sono nelle rive di questo lago sono nazioni adoratrici del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe; del Dio vero e vivo. Queste nazioni, col lago che esse circondano, costituiscono l’asse religioso e civile attorno a cui deve gravitare questo nuovo Cosmo delle nazioni: da Oriente e da Occidente si viene qui: questo è il Giordano misterioso nel quale il re siro (e tutti i ’re’ della terra) devono lavarsi per mondarsi della loro lebbra (4 Re V, 10)».
«Vi dico subito, Beatissimo Padre, quale è la ’intuizione’ che da qualche tempo fiorisce sempre più chiaramente nella mia anima. Questa: il Mediterraneo è il lago di Tiberiade del nuovo universo delle nazioni: le nazioni che sono nelle rive di questo lago sono nazioni adoratrici del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe; del Dio vero e vivo. Queste nazioni, col lago che esse circondano, costituiscono l’asse religioso e civile attorno a cui deve gravitare questo nuovo Cosmo delle nazioni: da Oriente e da Occidente si viene qui: questo è il Giordano misterioso nel quale il re siro (e tutti i ’re’ della terra) devono lavarsi per mondarsi della loro lebbra (4 Re V, 10)».Secondo La Pira, dunque, il Mediterraneo, culla delle civiltà monoteiste che egli chiamava «la triplice famiglia di Abramo», è chiamato a riprendere il suo posto nella storia in un mondo sempre più minacciato da guerre e distruzione. Una costruzione della pace che passava anche dalla preghiera e dalla contemplazione. Dal 1951 al 1974, divenuto presidente delle Conferenze di San Vincenzo della Toscana, La Pira aveva introdotto nel programma dell’associazione una novità: l’assistenza economica da offrire ai monasteri di clausura in difficoltà, in cambio di preghiere. In questo modo, veniva inviato alle claustrali un foglietto stampato come «lettera circolare» in cui riportava le motivazioni e le iniziative «politiche» per cui chiedeva di pregare. Centinaia di monache risposero a questi appelli. In una di queste lettere alle claustrali, La Pira allega anche un lungo telegramma che, il 26 ottobre 1961, aveva scritto all’ambasciatore sovietico a Roma, Semen Kozirev, pregandolo di trasmettere il suo messaggio a Nikita Krusciov. In quel telegramma, La Pira prega il leader dell’Urss di impegnarsi concretamente verso il disarmo nucleare. Se questo avverrà, scrive, «ve ne sarà grato il Padre celeste che saprà considerare con cuore di padre il vostro atto di buona volontà».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Pianeta Terra. Mediterranea-mente .... GELBISON, GIBSON E LA CHIESA CATTOLICA. DUE PAROLE, UN ’RIVELATIVO’ SEGNO DEI TEMPI. UNA ’MEMORIA’ DEL 2004
I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" -- Il falso mito dei "due Papi". L’unico segno, la necessaria chiarezza (di Giuseppe Lorizio)15 gennaio 2020, di Federico La Sala
L’unico segno, la necessaria chiarezza.
Il falso mito dei "due Papi"
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, mercoledì 15 gennaio 2020)
Per quanto suggestivo possa apparire nelle serie televisive e in un film di un certo successo, quello dei "due Papi" è un falso mito, che è necessario smascherare, anche perché viene sempre più spesso rappresentato in certe cronache che fanno specchio a vere o presunte polemiche e manovre, innescate da interventi intorno a temi scottanti per l’oggi della Chiesa e l’avvenire del cristianesimo.
A smentire la possibilità che nella Chiesa odierna vi siano due Papi è lo stesso Benedetto, il pontefice emerito, che ha sempre dichiarato «incondizionata reverenza e obbedienza» all’attuale Vescovo di Roma e ieri ha eliminato ogni equivoco, chiedendo di togliere il proprio nome sia dalla copertina sia dall’introduzione e dalle conclusioni dal volume del cardinal Robert Sarah sul celibato dei preti al quale aveva concesso un proprio saggio (uniche pagine che intende firmare). Questa chiarezza era indispensabile, così il lettore sa e comprende quale sia la posizione di Benedetto XVI e quanto invece non gli appartenga, perché scritto e divulgato da altri.
Finiscono con l’alimentare la falsa mitologia dei due Papi sia quelle rappresentazioni che sottolineano amicizia e continuità fra i due personaggi in questione, senza evidenziare l’obbedienza dell’emerito all’attuale Papa, ma molto più quelle che li contrappongono in maniera subdola e ideologicamente contrassegnata. La riflessione si impone, perché i credenti non vengano disorientati più di quanto non siano dal contesto culturale e sociale in cui vivono.
Il Papa è il segno tangibile e concreto dell’unità della Chiesa, altro ruolo oltre questo non gli compete. In questo senso non può essere che uno e unico. Le epoche, da questo punto di vista certamente buie, in cui sono convissuti contemporaneamente Papi e antipapi, non hanno prodotto nulla di buono per il tessuto ecclesiale e spirituale della comunità credente. E solo quando qualcuno, come Giovanni XXIII (l’antipapa quattrocentesco), ha saputo con umiltà farsi da parte, si è ricostituita l’unità ecclesiale e ha ripreso vigore l’evangelo nel mondo.
 Senza questo unico segno di unità, il cristianesimo vivrebbe una frammentazione devastante e la divisione regnerebbe sovrana, laddove al contrario, nella lettera agli Efesini leggiamo che «vi è [e quindi vi deve essere] un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti» (4, 4-6). Il dualismo non appartiene al cristianesimo cattolico, e quindi neanche alla fede cristiana tout court, è piuttosto frutto dello gnosticismo storico e perenne, che costituisce una costante tentazione per coloro che credono.
Senza questo unico segno di unità, il cristianesimo vivrebbe una frammentazione devastante e la divisione regnerebbe sovrana, laddove al contrario, nella lettera agli Efesini leggiamo che «vi è [e quindi vi deve essere] un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti» (4, 4-6). Il dualismo non appartiene al cristianesimo cattolico, e quindi neanche alla fede cristiana tout court, è piuttosto frutto dello gnosticismo storico e perenne, che costituisce una costante tentazione per coloro che credono.Per passare dalla Bibbia e dalla storia all’oggi, non possiamo dimenticare che il pontificato interrotto di papa Benedetto sia stato il vero gesto rivoluzionario che ha consentito la stagione di papa Francesco, con le sue innovazioni e la sua vivacità, sempre nel solco della tradizione della Chiesa cattolica. Abitare tale gesto, stupefacente e drammatico allo stesso tempo, significa rendersi conto che nella Chiesa vi è un solo Vescovo di Roma, ossia un solo Papa. Parlare di due Papi è insensato, come impegnarsi per contrapporre le due figure più significative dell’attuale contesto cattolico. E c’è da sospettare che dietro operazioni che adottano tale modalità, ci sia chi intende distruggere la Chiesa stessa, attentando alla sua prima nota costitutiva, che - come recitiamo nel Credo - è l’unità. Certo demitizzare i "due Papi" significa andare contro corrente e avere meno audience, ma non per questo ci si può esimere da tale compito.
Ritenere che la tradizione sia da una parte e l’innovazione dall’altra significa non comprendere il senso autentico della tradizione stessa, che è radicalmente innovativa, in quanto non guarda solo al passato, ma si innesta nel presente e si apre al futuro. Questo vale per le strutture costitutive di quella religione che pone a suo fondamento la fede cristiana. In primo luogo il culto e la liturgia, che, ininterrottamente, ma con linguaggio sempre nuovo, fa sì che il mistero si renda presente nell’oggi della sacramentalità. Qui il gesto e le parole fondamentali sono sempre le stesse: il pane che si spezza, l’acqua che si versa, le mani che si impongono, l’unzione con le parole che accompagnano e rendono sacramento il segno. Su questi fondamentali la Chiesa non ha alcun potere, in quanto le sono consegnati dalla rivelazione stessa, ma le modalità celebrative le sono affidate, perché la memoria non sia pura nostalgia e il presente non si rattrappisca in un passato preconfezionato. In secondo luogo la dottrina, che è chiamata a svilupparsi, secondo la feconda indicazione del santo cardinale John Henry Newman.
Uno sviluppo organico ed omogeneo, che, quando non è tale (o non è stato tale) ha prodotto i peggiori mali della Chiesa, ossia l’eresia e lo scisma. In terzo luogo le strutture, chiamate a trasformarsi e modificarsi, nello spirito di quanto disegnato da papa Francesco nel suo ultimo discorso alla Curia romana (21 dicembre 2019). I binari di tale trasformazione sono stati indicati nell’evangelizzazione e nella promozione umana, cardini portanti dell’agire ecclesiale nel presente e nel futuro, su cui devono poggiare e di cui devono nutrirsi le sovrastrutture o impalcature giuridiche e istituzionali.
Il falso mito dei due Papi veniva smascherato dallo stesso Benedetto XVI, quando, in un famoso discorso alla curia romana (22 dicembre 2005), riflettendo sul Concilio Vaticano II, contrapponeva un’ermeneutica della ’discontinuità’, ovvero dell’innovazione per l’innovazione, che avrebbe di fatto offerto il fianco al dualismo, non a quella della ’continuità’, come ci si sarebbe aspettato da un Papa ritenuto conservatore, ma a quella della ’riforma’. Una riforma che non ha nulla a che vedere con la rivoluzione, ma significa sviluppo e vita, apertura al futuro nel necessario e sempre fecondo radicamento nel passato, con attenzione vigile a un presente certamente problematico, ma anche affascinante e provocatorio per la fede.
 Teologo, Pontificia Università Lateranense
Teologo, Pontificia Università Lateranense -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- FILOLOGIA E "GIOIA DELL’AMORE": LA "FEDE" DEL SINDACO DI MILANO E LA "CARITÀ" DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA.30 dicembre 2019, di Federico La Sala
COSTITUZIONE, MESSAGGIO EVANGELICO, CATTOLICESIMO ROMANO, E FILOLOGIA... *
- SE LA "CARISSIMA" EU-CARESTIA è figlia DELLA CARITA’ ("CARITAS") è e resta SEMPRE una ELEMOSINA, E L’EU-CHARIS-TIA è e resta sempre una CARITA’ ("Caritas") senza GRAZIA ("CHARItaS"):
- AMORIS LAETITIA [La gioia dell’amore]: "296. Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al riguardo, desidero qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di sbagliare strada: «due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare [...]. La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione [...]. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero [...]. Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!».[326] Pertanto, «sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione».[327]" (ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE di Papa Francesco SULL’AMORE NELLA FAMIGLIA, 19 marzo 2016).
- "Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!».[326]": "Nam, vera caritas semper immerita interminataque et gratuita est! [326]" (cfr.: "Homilia in Eucharistia cum Cardinalibus nuper electis celebrata habita, 15 februarii 2015)"
Sala: “La fede mi guida. Ma da divorziato soffro senza la comunione”
La lettera del sindaco di Milano. Riflessione sul rapporto con la religione: “Mi aiuta nell’impegno a favore dei più deboli. Altrimenti la parola di Dio rimane scritta solo nei libri e non nei nostri cuori”
di GIUSEPPE SALA (la Repubblica, 24 dicembre 2019)
Caro direttore, sono un uomo fortunato perché la fede è per me qualcosa di irrinunciabile. È un dono fondamentale che apprezzo ancor di più adesso, dopo i sessant’anni, con tanta vita alle spalle. Ho avuto momenti di stanchezza, ho vissuto dubbi e contraddizioni ma non ho mai smesso di ricercare il Signore. Tra tante vicende della vita sento di non potere fare a meno del confronto con il Mistero e, in definitiva, con me stesso.
Ed è proprio da questa esperienza che conosco i miei limiti. Non mi sono mai sentito così profondo da potermi nutrire solo di fede, di farmi “bastare” l’intima relazione con Dio. Penso spesso che la mia fede non reggerebbe senza la pratica, senza la possibilità di entrare in un luogo di culto, senza la Messa della domenica. Ho bisogno della Messa, di sentire la voce, più o meno ispirata, di un pastore e di misurarmi con Gesù e con il suo Vangelo. Pur nella consapevolezza dell’ineluttabilità del confronto che nasce in me e ritorna in me.
La Messa della domenica è un momento di pace e di verità. Mi fa star bene, mi aiuta a sentire la mia umanità, i miei dolori, la mia essenza. La gratitudine e la precarietà. Sono solo a disagio rispetto al momento della comunione, essendo divorziato e in uno stato che non mi consente di accostarmi al Sacramento. Amo stare insieme agli altri, condividere quel senso di solitudine e, allo stesso tempo, di comunione che la Messa ti dà. La liturgia ci insegna l’umiltà di essere come (e peggio) degli altri, di condividere la speranza, di far ammenda delle nostre miserie.
Si deve essere popolo anche fuori dalle porte della Chiesa. Tra tante urla, la ricerca della verità e della giustizia è l’impegno che dà senso alla mia fede, quella fede che mi dà l’energia giorno per giorno per rendere concreto il mio cammino sulla via dell’equità, del rispetto e dell’accoglienza soprattutto verso i più deboli e i più abbandonati. Altrimenti la parola di Dio rischia di rimanere scritta solo nei libri e non nei nostri cuori.
Per tutto ciò amo parlare di religione, ma ne aborro l’ostentazione. Sorrido pensando che ne sto scrivendo, ma è come se stessi parlando a me stesso.
I divorziati e l’eucarestia.
La lettera del sindaco Sala e le risposte che dà la Chiesa
È raro che un politico parli della sua vita di fede. Il primo cittadino di Milano lo ha fatto rivelando un’adesione di fede e una ferita
di Luciano Moia (Avvenire, sabato 28 dicembre 2019)
- [Foto] Giuseppe Sala, sindaco di Milano
È raro che un politico parli della sua vita di fede. Il sindaco Beppe Sala lo ha fatto rivelando un’adesione e una ferita. Un atto di coraggio e di chiarezza. Che non può che essere apprezzato da chi, come noi, da anni è impegnato a divulgare e promuovere la svolta pastorale voluta da papa Francesco all’insegna dell’accoglienza e della misericordia. Nella confessione spirituale che ha affidato, la vigilia di Natale, alle pagine de "la Repubblica", il sindaco di Milano rivela «di non poter fare a meno del confronto con il Mistero» e di partecipare regolarmente alla Messa domenicale, ma di sentirsi «a disagio rispetto al momento della Comunione, essendo divorziato e in uno stato che non mi consente di accostarmi al Sacramento».
Se una persona seria e preparata come Sala, è costretta ad ammettere un disorientamento spirituale per la sua condizione di divorziato risposato, significa che la strada per trasformare in consapevolezza diffusa le indicazioni uscite dal doppio Sinodo sulla famiglia (2014 e 2015) voluto da papa Francesco e poi dall’esortazione apostolica Amoris laetitia, è ancora lunga.
In quel testo il Papa scrive in modo esplicito che nessuno deve sentirsi condannato per sempre e che la Chiesa è chiamata ad offrire a tutti, compresi i divorziati risposati a cui è dedicato un intero capitolo - l’VIII - la possibilità di vivere pienamente il proprio cammino di fede. In questo cammino si può comprendere anche l’aiuto dei sacramenti (nota 351).
Non è un’opinione. È quanto emerso da un cammino sinodale proseguito per oltre tre anni che il Papa ha sancito con la sua parola. Poi, di fronte alle critiche e ai distinguo, Francesco ha voluto che l’interpretazione da lui considerata più efficace, quella dei vescovi della regione di Buenos Aires, fosse inserita nei cosiddetti Acta apostolica sedis - gli atti ufficiali della Santa Sede - a ribadire che indietro non si torna e che tutte le diocesi del mondo devono incamminarsi lungo quella strada.
Milano non fa eccezione. Inutile far riferimento al rito ambrosiano e alle aperture del cardinale Carlo Maria Martini, che su questi aspetti non ci sono state, in quanto scelte che non si potevano e non si possono pretendere da una singola Chiesa locale.
Francesco, come detto, ha ritenuto necessarie due assemblee mondiali dei vescovi per gettare i semi del cambiamento. Una persona divorziata e risposata che desidera riaccostarsi alla Comunione - spiega il Papa - può chiedere l’aiuto di un sacerdote preparato per avviare un serio esame di coscienza sulle proprie scelte esistenziali.
Sei, in rapidissima sintesi, i punti da non trascurare: quali sforzi sono stati fatti per salvare il precedente matrimonio e ci sono stati tentativi di riconciliazione? La separazione è stata voluta o subita? Che rapporto c’è con il precedente coniuge? Quale comportamento verso i figli? Quali ripercussioni ha avuto la nuova unione sul resto della famiglia? E sulla comunità? Domande spesso laceranti e risposte non codificabili, che possono richiedere anche lunghi tempi di elaborazione e da cui non derivano conseguenze uguali per tutti. Ma anche modalità pastorali efficaci per metterle in pratica.
Trovare e attuare queste buone prassi è faticoso e Sala, con le sue parole, ha dato voce a un disagio e una sofferenza spirituale, ma anche a una speranza, che condivide con tanti altri credenti, divorziati e risposati.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
FLS
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- IL CATTOLICESIMO ROMANO E L’ICONA UNIVERSALE DELLA "SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE".29 dicembre 2019, di Federico La Sala
ECUMENISMO E PROBLEMA DELL "UNO" ... *
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Contemplando con fede la casa di Nazareth ogni credente può scorgervi un modello
di Matteo Liut (Avvenire, domenica 29 dicembre 2019)
La vita nasce da una relazione che si apre all’infinito, perché ogni essere umano che viene al mondo è segno dell’amore sconfinato di Dio. La famiglia è scrigno prezioso che ha la responsabilità di dare forma a questa continua promessa di futuro.
Oggi il rito romano pone la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, icona universale di un’intimità domestica portatrice di un messaggio rivoluzionario: Dio abita in mezzo a noi. Contemplando la casa di Nazareth ogni credente non può non scorgervi un’ispirazione e un modello: i piccoli gesti di cura e attenzione vissuti tra quelle mura testimoniano lo stile dell’agire di Dio nella storia. Ecco perché per i cristiani farsi compagni di strada degli ultimi significa prima di tutto essere luce di speranza e di amore per le persone più vicine: tutti abbiamo bisogno di aprirci continuamente alla vita attraverso relazioni d’amore.
 Altri santi. San Davide, re (X sec. a.C.); san Tommaso Becket, martire (1118-1170).
Altri santi. San Davide, re (X sec. a.C.); san Tommaso Becket, martire (1118-1170).
 Letture. Sir 3,3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
Letture. Sir 3,3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
 Ambrosiano. Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14.
Ambrosiano. Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO".NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FLS
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- I "CONFLITTI TRA I RESTI" E LE POLEMICHE PER L’EREDITA’. La custodia del primo nome (di L. Bruni).15 dicembre 2019, di Federico La Sala
I "CONFLITTI TRA I RESTI" E UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".... *
Profezia è verità /28.
La custodia del primo nome
Luigino Bruni (Avvenire, sabato 14 dicembre 2019)
- Fra l’ultima parola detta e la prima nuova da dire è lì che abitiamo
- Pierluigi Cappello, Assetto di volo
Non basta essere minoranza per essere minoranza profetica. Non è l’essere parte di un resto di superstiti a fare il resto della Bibbia. Nella conquista babilonese, alcuni ebrei furono deportati e altri restarono in patria. In ciascuna di queste due comunità - quella in esilio e quella in patria - c’era chi si auto-attribuiva lo status di "resto" annunciato da Isaia. Ezechiele e Geremia ci parlano, in pagine bellissime, di questi "conflitti tra resti", delle polemiche tra i figli per l’eredità ideale dei padri. Le crisi, soprattutto quelle grandi e decisive, generano molti "resti", vari gruppi che pretendono di essere i veri custodi del primo patto, i garanti della prima alleanza, gli eredi del primo testamento. In questi conflitti identitari è probabile che ogni gruppo possieda alcuni elementi autentici del vero "resto"; ma non appena una minoranza inizia a rivendicare la primogenitura contro gli altri gruppi, i semi buoni cominciano a guastarsi.
Durante e dopo le crisi, fondamentale è infatti la capacità di non pretendere il monopolio dell’eredità, di saper convivere con altri che si rifanno allo stesso patrimonio. Perché una virtù importante di chi si sente onestamente parte del "resto" fedele sta nel saper convivere con altri che dicono cose molto diverse in nome della stessa eredità - inclusi imbroglioni e falsi profeti, che accompagnano sempre i profeti veri. Perché quando è un solo gruppo a sentirsi il legittimo proprietario della promessa e a essere riconosciuto da tutti come tale, è quasi certo che quel gruppo sia quello sbagliato. Lo spirito ama l’eccedenza e gli sprechi. L’eredità spirituale, come la verità, è sinfonica. Solo il tempo e la storia sanno separare il grano dalla zizzania, e nessun grano può essere sicuro prima dell’ultimo attimo di non essere zizzania. Si vive tra parole dette e parole da dire senza essere i padroni della verità delle une e delle altre. I dubbi sull’autenticità della propria vocazione ed elezione sono, paradossalmente, il primo segno di autenticità. C’è anche questa buona ignoranza nel repertorio umano.
Siamo arrivati al culmine dei Libri dei Re e della storia biblica. Ed ecco un nome che da solo dice moltissime cose, quasi tutto: Nabucodonosor. «Nei suoi giorni, Nabucodonosor, re di Babilonia, salì contro di lui e Ioiakìm gli fu sottomesso per tre anni, poi di nuovo si ribellò contro di lui. YHWH mandò contro di lui bande armate di Caldei, di Aramei, di Moabiti e di Ammoniti; le mandò in Giuda per annientarlo, secondo la parola che YHWH aveva pronunciato per mezzo dei suoi servi, i profeti» (2 Re 24,1-2). Le mandò in Giuda per annientarlo... Abbiamo immediatamente l’interpretazione di quanto il testo sta narrando. L’assedio di Gerusalemme, la distruzione del tempio, l’esilio in Babilonia, la fine del regno di Giuda, sono voluti da Dio, perché sono la conseguenza della violazione dell’Alleanza. Lo aveva detto per mezzo dei profeti, e ora quella parola si compie, per dirci la serietà della parola, il valore assoluto di una promessa, la radicale verità dell’alleanza.
 Se un patto è vero, se la parola che lo crea pronunciandolo non è fumo e vanitas, allora deve essere vero tutto ciò che quella reciprocità essenziale implica. Un patto è un bene relazionale, è quindi fatto di reciprocità, che muore quando quella reciprocità viene meno. Allora la distruzione del tempio e la fine del regno sono inerenti alla verità dell’alleanza con Abramo e Mosè. E questa è una cosa davvero importante.
Se un patto è vero, se la parola che lo crea pronunciandolo non è fumo e vanitas, allora deve essere vero tutto ciò che quella reciprocità essenziale implica. Un patto è un bene relazionale, è quindi fatto di reciprocità, che muore quando quella reciprocità viene meno. Allora la distruzione del tempio e la fine del regno sono inerenti alla verità dell’alleanza con Abramo e Mosè. E questa è una cosa davvero importante.I Libri dei Re ci dicono che la fine era già iniziata nel momento in cui Salomone importò a Gerusalemme gli dèi stranieri. Molto suggestiva e forte è allora la scena della devastazione del tempio: «In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l’assediavano. Ioiachìn, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia... Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell’anno ottavo del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del tempio di YHWH e i tesori della reggia; fece a pezzi tutti gli oggetti d’oro che Salomone, re d’Israele, aveva fatto nel tempio di YHWH, come aveva detto YHWH» (24,10-13). Come aveva detto YHWH: ancora la stessa tesi.
 Con il bottino dei tesori del tempio e della reggia (forse un dato anacronistico, poiché questo episodio avvenne probabilmente dieci anni dopo, con la seconda deportazione durante la distruzione di Gerusalemme e del tempio), si chiude un lunghissimo ciclo durato secoli. La corruzione del cuore di Salomone e dei molti re che dopo di lui si sono succeduti, raggiunge ora il suo culmine, con l’asportazione di quel tesoro e "facendo a pezzi" gli oggetti.
Con il bottino dei tesori del tempio e della reggia (forse un dato anacronistico, poiché questo episodio avvenne probabilmente dieci anni dopo, con la seconda deportazione durante la distruzione di Gerusalemme e del tempio), si chiude un lunghissimo ciclo durato secoli. La corruzione del cuore di Salomone e dei molti re che dopo di lui si sono succeduti, raggiunge ora il suo culmine, con l’asportazione di quel tesoro e "facendo a pezzi" gli oggetti.La parola che conduce Nabucodonosor a Gerusalemme è la stessa parola della benedizione ingannata e irrevocabile di Isacco per Giacobbe, la stessa parola che creò la luce e l’Adam. Se è vero l’Adam, se sono vere le dieci parole, se è vera Betlemme, allora deve essere vero anche Nabucodonosor. È questa la verità tremenda, drammatica e stupenda della parola biblica, una parola che è vera perché è fedele fino alle conseguenze estreme della parola: «YHWH non volle usare indulgenza» (24,4). Anche questo è la parola biblica, anche qui sta la sua unicità, è anche questo il suo messaggio rivolto alle nostre parole.
 Gli scribi che componevano questi capitoli ci volevano allora dire che quella distruzione conteneva la stessa verità dell’Alleanza e del Sinai. Nella Bibbia l’alleanza e i patti sono qualcosa di immenso, dal valore infinito che noi lettori del XXI secolo non capiamo più.
Gli scribi che componevano questi capitoli ci volevano allora dire che quella distruzione conteneva la stessa verità dell’Alleanza e del Sinai. Nella Bibbia l’alleanza e i patti sono qualcosa di immenso, dal valore infinito che noi lettori del XXI secolo non capiamo più.
 Nell’umanesimo biblico i patti umani hanno il loro fondamento in un meraviglioso e impensabile patto con Dio. Una religione dell’alleanza ha potuto fondare una cultura dell’alleanza che ancora, sebbene soffra, continua a sostenere la cultura occidentale. È stato anche per il valore di quel patto fondativo che abbiamo saputo dar vita ai matrimoni, alle imprese, alle cooperative, alle città e poi agli Stati nazionali e all’Unione Europea.
Nell’umanesimo biblico i patti umani hanno il loro fondamento in un meraviglioso e impensabile patto con Dio. Una religione dell’alleanza ha potuto fondare una cultura dell’alleanza che ancora, sebbene soffra, continua a sostenere la cultura occidentale. È stato anche per il valore di quel patto fondativo che abbiamo saputo dar vita ai matrimoni, alle imprese, alle cooperative, alle città e poi agli Stati nazionali e all’Unione Europea.
 La religione dell’alleanza è la possibilità che i nostri "per sempre" possano essere veri mentre li pronunciamo nell’ignoranza del futuro; ma questa alleanza è anche la fonte del valore infinito della reciprocità nei patti.
Quando esco per l’ultima volta dalla porta di casa, ti dico che quel patto di reciprocità che avevamo fatto anni prima era vero, che non era fumo e vento.
La religione dell’alleanza è la possibilità che i nostri "per sempre" possano essere veri mentre li pronunciamo nell’ignoranza del futuro; ma questa alleanza è anche la fonte del valore infinito della reciprocità nei patti.
Quando esco per l’ultima volta dalla porta di casa, ti dico che quel patto di reciprocità che avevamo fatto anni prima era vero, che non era fumo e vento.
 Mentre vado via dico a me e a te la verità del primo patto e del tempo in cui sono restato. Certo, posso anche perdonarti e restare a casa - tanti, tante lo fanno ogni giorno, e risuscitano molti patti dai loro sepolcri -, ma ciò non toglie verità a quell’andare; anche se poi è la stessa Bibbia a dirci che quell’andare, sebbene vero, non è l’ultima parola perché "un resto tornerà".
Mentre vado via dico a me e a te la verità del primo patto e del tempo in cui sono restato. Certo, posso anche perdonarti e restare a casa - tanti, tante lo fanno ogni giorno, e risuscitano molti patti dai loro sepolcri -, ma ciò non toglie verità a quell’andare; anche se poi è la stessa Bibbia a dirci che quell’andare, sebbene vero, non è l’ultima parola perché "un resto tornerà".L’interpretazione che quella comunità di redattori diede della distruzione di Gerusalemme, è allora qualcosa di straordinario e di essenziale. Di fronte alla tragedia, quegli scribi avrebbero potuto gridare l’abbandono, lamentarsi con YHWH per aver rinnegato l’alleanza. E invece scelsero di leggere quella terribile realtà nella fede, aggrappati alla corda-fides che li teneva legati al cielo, al loro passato, al futuro possibile e al "resto" che avrebbe continuato la storia. Quella lettura fu l’unica capace di salvare la loro fede e il loro popolo diverso, perché la vera alternativa che avevano era affermare che il loro Dio fosse solo un idolo, una vanitas come tutti gli altri. E invece salvarono la fede, salvarono la parola e l’alleanza, salvarono Dio. Come Giobbe.
Ecco perché la distruzione di Gerusalemme è veramente il cuore della Bibbia, il centro gravitazionale della sua fede e del suo umanesimo. Con ogni probabilità non avremmo la Bibbia, o l’avremmo totalmente diversa, se quella comunità di scribi, sacerdoti e profeti, schiantati dall’esilio, avesse scelto di salvare se stessa condannando Dio. Il "resto" potrà tornare e continuare la storia se teniamo viva la verità di quel primo patto assumendocene tutte le conseguenze.
L’esilio babilonese produsse una delle più grandi rivoluzioni religiose e etiche della storia dell’umanità. Lì, in quella terra straniera e idolatra, nacque il culto senza tempio, Dio non fu più prigioniero del suo territorio. E soprattutto terminò l’era dell’identificazione della verità con la vittoria, perché si capì che YHWH poteva restare vero anche se sconfitto, che le nostre verità possono essere vere anche se non vincono, che una vita può essere vera mentre muore.
 Una innovazione antropologica e teologica decisiva, possibile perché quella comunità di scrittori-interpreti scelse la propria condanna religiosa per salvare la verità del Dio dell’alleanza e della promessa, per donarcela in eredità.
Una innovazione antropologica e teologica decisiva, possibile perché quella comunità di scrittori-interpreti scelse la propria condanna religiosa per salvare la verità del Dio dell’alleanza e della promessa, per donarcela in eredità.Insieme agli ori del tempio e della reggia, in questa prima deportazione (del 598-597) i babilonesi portarono via anche le élite militari, tecniche e intellettuali: «Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di diecimila esuli, tutti i falegnami e i fabbri; non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia il re Ioiachìn» (24,14-15).
 Non rimase che la gente povera... Anche in questo racconto tragico riemerge la polemica dei "resti". Quella che scrisse o completò questo verso era una mano che apparteneva a quel gruppo (golà di deportati in Babilonia che si considerava il vero resto fedele. Così definisce "gente povera" i rimasti in patria, che in quanto poveri non potevano quindi pretendere lo status di eredi della promessa - come se l’essere poveri non fosse compatibile con l’abitare il Regno, con l’essere chiamati "beati".
Non rimase che la gente povera... Anche in questo racconto tragico riemerge la polemica dei "resti". Quella che scrisse o completò questo verso era una mano che apparteneva a quel gruppo (golà di deportati in Babilonia che si considerava il vero resto fedele. Così definisce "gente povera" i rimasti in patria, che in quanto poveri non potevano quindi pretendere lo status di eredi della promessa - come se l’essere poveri non fosse compatibile con l’abitare il Regno, con l’essere chiamati "beati".Dentro queste pagine tragiche c’è infine un dettaglio che può passare inosservato: «Il re di Babilonia nominò re, al posto di Ioiachìn, Mattania suo zio, cambiandogli il nome in Sedecìa» (24,17). Il nuovo sovrano cambia nome al re da lui nominato. La stessa operazione l’avevano fatta qualche anno prima gli egiziani con il padre del re Ioiachìn: «Il faraone Necao nominò re Eliakìm, figlio di Giosia, al posto di Giosia, suo padre, cambiandogli il nome in Ioiakìm» (23,34).
È un’antica e sempre attuale abitudine dei padroni cambiare il nome ai loro sudditi. Quando un uomo o una donna ci cambia il nome, quel nuovo nome è sigillo di proprietà privata. Il Dio biblico non ci cambia il nome. Ci lascia il nostro, lo ama, vi legge la nostra vocazione, ed è con quel primo nome che ci sa chiamare: Samuele, Agar, Maria. E le poche volte in cui lo cambia (con Abramo, Sara, Giacobbe, Simone), è per indicarci un orizzonte o una vocazione ancora più liberi e larghi.
È difficile attraversare il mondo e terminare il viaggio con il nome con cui vi siamo giunti. Gli incontri e le ferite, mentre ci in-segnano il nome dell’altro, cercano fino alla fine non solo di ferire il nostro (cosa necessaria e in genere buona), ma di cambiarlo, di metterci il sigillo e da figli trasformarci in schiavi. Che possiamo custodire il nome del primo giorno per sentirlo pronunciare nell’ultimo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI.3 ottobre 2019, di Federico La SalaEU-ANGELO, EU-ROPA .... "SCRITTURA ED EU-CARESTIA"?!
 LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- IL FIGLIO DI DIO E LA FORZA DELLA VERITA’. Cosa significa Gesù per me (di Mohandas Karamchand Gandhi).3 ottobre 2019, di Federico La Sala
Cosa significa Gesù per me
di Mohandas Karamchand Gandhi *
Benché io abbia dedicato gran parte della mia vita allo studio della religione e alla discussione con i capi religiosi di tutte le fedi, riconosco molto bene di non poter non sembrare presuntuoso nel momento in cui mi accingo a scrivere di Gesù Cristo e a cercare di spiegare ciò che Lui significa per me. (...)
... Egli è stato sicuramente il più alto esempio di chi ha desiderato di dare tutto senza chiedere in cambio niente e senza interessarsi a quale sarebbe stato il credo che avrebbe professato il ricevente. Sono sicuro che se Lui in questo momento vivesse tra gli uomini, Egli benedirebbe le vite di molti di coloro che forse non hanno mai sentito il Suo nome, se soltanto le loro vite incarnassero le virtù delle quali Lui è stato l’esempio vivente sulla terra, la virtù di amare il prossimo come se stessi e del fare del bene e della carità tra i propri simili.
 Allora, cosa può significare per me Gesù? Per me Egli è stato uno dei più grandi maestri che l’umanità abbia mai conosciuto.
Allora, cosa può significare per me Gesù? Per me Egli è stato uno dei più grandi maestri che l’umanità abbia mai conosciuto.
 Secondo i Suoi credenti Egli è stato l’Unigenito Figlio di Dio. Ma il fatto che io accetti o meno questa convinzione può far sì che Gesù abbia maggiore o minore influenza nella mia vita? È forse che tutta la grandezza dei Suoi insegnamenti e della Sua dottrina devono essermi vietati? Non posso crederci.
Secondo i Suoi credenti Egli è stato l’Unigenito Figlio di Dio. Ma il fatto che io accetti o meno questa convinzione può far sì che Gesù abbia maggiore o minore influenza nella mia vita? È forse che tutta la grandezza dei Suoi insegnamenti e della Sua dottrina devono essermi vietati? Non posso crederci.Per me ciò implica una nascita spirituale. In altre parole, la mia interpretazione è che nella vita di Gesù vi è la chiave della Sua vicinanza a Dio e che Egli espresse, come nessun altro ha saputo fare, lo spirito e la volontà di Dio. È in questo senso che io Lo vedo e Lo riconosco come Figlio di Dio.
(...)
E poiché la vita di Gesù ha quel senso e quella trascendenza ai quali io ho alluso, credo che Egli appartenga non soltanto al cristianesimo ma al mondo intero, a tutte le razze e a tutti i popoli, poco importa sotto quale bandiera, nome o dottrina essi possano lavorare o professare una fede o adorare un dio ereditato dai propri avi.[1]
*
[1] Mohandas Karamchand Gandhi, Cosa significa Gesù per me, «Modern Review», ottobre 1941. Pubblicato in Mohandas Karamchand Gandhi, La forza della verità. Scritti etici e politici, Edizioni Sonda, Torino 1991, vol. I, pp. 458-460 .
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- ARITMETICA, ANTROPOLOGIA, E "MONOTONISMO". Il numero benedetto è il numero uno (di Luigino Bruni).31 agosto 2019, di Federico La Sala
ARITMETICA, ANTROPOLOGIA, E "MONOTONISMO"... *
Profezia è storia /13.
Benedetto è il numero uno
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 31 agosto 2019)
- Tutti i corpi insieme, e tutti gli spiriti insieme, e tutte le loro produzioni, non valgono un minimo moto di carità. Questo è di un ordine infinitamente più elevato
- Blaise Pascal, Pensieri. *
In questo racconto, tra i più noti della letteratura religiosa antica, il numero benedetto è il numero uno. Con Elia, solo contro le centinaia di profeti di Baal, e Abdia unico salvatore di profeti, la Bibbia ci dice che in molte crisi tremende la salvezza arriva perché c’è rimasto un giusto che salva tutti. In alcuni momenti decisivi, la massa critica è uno. Noè, Abramo, Mosè, i profeti, Elia, Abdia, Maria, Gesù: per quanto importante e bello sia il "noi", la Bibbia esalta anche l’"io". Il noi non salva nessuno se al suo cuore non c’è almeno un io che obbedisce a una voce e liberamente agisce. Un io giusto è il lievito della buona massa del noi. È questa la radice di quel principio personalista al centro dell’umanesimo occidentale, che oggi, nel fascino esercitato da nuovi noi, continua a ripeterci che nessun gruppo supera in dignità la singola persona, al massimo la può uguagliare. Nel "calcolo della dignità" nei gruppi umani le regole dell’aritmetica non valgono. Questo valore non aumenta con la somma, perché il primo addendo ha già un valore infinito - qui uno più uno più uno fa sempre e solo uno.
Durante una carestia tremenda e lunghissima, mentre una regina sanguinaria sta sterminando i profeti di YHWH, un uomo li salva: «A Samaria c’era una grande carestia. Acab convocò Abdia, che era il maggiordomo. Abdia temeva molto YHWH; quando Gezabele uccideva i profeti di YHWH, Abdia aveva preso cento profeti e ne aveva nascosti cinquanta alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua» (1 Re 18, 2-4). Abdia è un amico dei profeti. Come l’etiope Ebed-Melec l’eunuco che salvò Geremia dalla cisterna (Ger 38), anche ora incontriamo un uomo, un "maggiordomo", che salva i profeti dalla morte.
 Anche la storia delle religioni e delle civiltà conosce questa categoria di giusti, questi goel. I profeti hanno molti nemici; ma hanno anche alcuni amici e "salvatori". Li ospitano nelle loro case-Betania, li nascondono, li curano, li consolano, credono in loro quando tutti li abbandonano. I profeti hanno questi amici, ne hanno almeno uno, almeno una, che diventa il tozzo di pane e il palmo d’acqua per non morire nell’attraversamento dei deserti. A volte sono i genitori, una sorella. Non sono sempre discepoli dei profeti, a volte sono solo amici. Un amico di profeta vale più di mille discepoli.
Anche la storia delle religioni e delle civiltà conosce questa categoria di giusti, questi goel. I profeti hanno molti nemici; ma hanno anche alcuni amici e "salvatori". Li ospitano nelle loro case-Betania, li nascondono, li curano, li consolano, credono in loro quando tutti li abbandonano. I profeti hanno questi amici, ne hanno almeno uno, almeno una, che diventa il tozzo di pane e il palmo d’acqua per non morire nell’attraversamento dei deserti. A volte sono i genitori, una sorella. Non sono sempre discepoli dei profeti, a volte sono solo amici. Un amico di profeta vale più di mille discepoli.Abdia incontra Elia, e la dote con cui si presenta sono i cento profeti che ha salvato: «Io nascosi cento profeti, cinquanta alla volta, in una caverna e procurai loro pane e acqua?» (18, 13). Elia gli si fa incontro: «Quello lo riconobbe e cadde con la faccia a terra dicendo: "Sei proprio tu il mio signore Elia?". Gli rispose: "Lo sono; va’ a dire al tuo signore: c’è qui Elia"» (18, 7-8). Abdia ha paura. Elia lo rassicura, e lui va: «Abdia andò incontro ad Acab e gli riferì la cosa». (18, 16). Elia incontra finalmente Acab. Ed entriamo in una delle pagine più note e tremende della Bibbia: la sfida, la cosiddetta ordalia del Monte Carmelo tra Elia e quattrocentocinquanta profeti di Baal. Una scena potente ed epica, che ci fa vivere in presa diretta un brano della religione di quei popoli arcaici, in bilico tra magia e fede.
«Acab convocò tutti gli Israeliti e radunò i profeti sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: "Fino a quando salterete da una parte all’altra? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!"» (18, 20-21). Elia propone un duello tra YHWH, il Dio di Israele e Baal, il dio locale fenicio-cananeo. Dalla parte di Baal ci sono centinaia di profeti; accanto a YHWH c’è il solo Elia.
 Ancora una lotta impari, un altro Davide contro un altro Golia. Ma, anche qui, la vittoria non è una faccenda di forza né di numeri. È la qualità, non la quantità, il principio attivo di queste vittorie. Dal resto del racconto si comprende, infatti, che la sfida non è tra due dèi entrambi vivi, ma piuttosto tra Dio e il nulla. Questa vittoria di YHWH è una delle prime attestazioni monoteistiche di Israele. «Ci vengano dati due giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l’altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro dio e io invocherò il nome di YHWH. Il dio che risponderà col fuoco è Dio!"» (18, 23-24).
Ancora una lotta impari, un altro Davide contro un altro Golia. Ma, anche qui, la vittoria non è una faccenda di forza né di numeri. È la qualità, non la quantità, il principio attivo di queste vittorie. Dal resto del racconto si comprende, infatti, che la sfida non è tra due dèi entrambi vivi, ma piuttosto tra Dio e il nulla. Questa vittoria di YHWH è una delle prime attestazioni monoteistiche di Israele. «Ci vengano dati due giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l’altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro dio e io invocherò il nome di YHWH. Il dio che risponderà col fuoco è Dio!"» (18, 23-24).I profeti di Baal apparecchiano per primi il loro altare, e attendono che Baal, il dio dei fulmini, faccia bruciare la legna per il sacrificio. E poi «invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: "Baal, rispondici!". Ma non vi fu voce, né chi rispondesse» (18, 26).
 Non vi fu voce... Torna quella nota bellissima che accompagna l’intera Bibbia: il Dio vero è il Dio della voce. YHWH parla, chiama, sussurra. Gli idoli sono falsi perché non hanno voce, sono sfiatati. La frenesia profetica cresce, svelandoci dettagli interessanti di quegli antichi riti: «Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue» (18, 28). Il fuoco non ci accende, Baal non risponde. Elia ironizza e li sbeffeggia: «Gridate a gran voce, perché è un dio! È occupato, è in affari o è in viaggio; forse dorme» (18, 27). In questo sfottò Elia "si dimentica" che molti salmi sono un grido per "svegliare" Dio, e che la prima preghiera collettiva della Bibbia fu un urlo di schiavi perché YHWH, distratto, si ricordasse della sua promessa (Es 2). Anche i profeti più grandi nell’agone della lotta religiosa possono usare contro l’avversario le parole più umane e più belle imparate sotto la tenda di casa. Come noi.
Non vi fu voce... Torna quella nota bellissima che accompagna l’intera Bibbia: il Dio vero è il Dio della voce. YHWH parla, chiama, sussurra. Gli idoli sono falsi perché non hanno voce, sono sfiatati. La frenesia profetica cresce, svelandoci dettagli interessanti di quegli antichi riti: «Gridarono a gran voce e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue» (18, 28). Il fuoco non ci accende, Baal non risponde. Elia ironizza e li sbeffeggia: «Gridate a gran voce, perché è un dio! È occupato, è in affari o è in viaggio; forse dorme» (18, 27). In questo sfottò Elia "si dimentica" che molti salmi sono un grido per "svegliare" Dio, e che la prima preghiera collettiva della Bibbia fu un urlo di schiavi perché YHWH, distratto, si ricordasse della sua promessa (Es 2). Anche i profeti più grandi nell’agone della lotta religiosa possono usare contro l’avversario le parole più umane e più belle imparate sotto la tenda di casa. Come noi.Quindi arriva il turno di Elia: «Elia prese dodici pietre... Eresse un altare nel nome di YHWH... Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna... Elia disse: "YHWH, Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele... Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore!". Cadde il fuoco del Signore e consumò l’olocausto, la legna, le pietre e la cenere» (18, 31-38). Colpisce l’essenzialità sobria della preghiera di Elia, se confrontata alla spettacolarità barocca dei profeti di Baal - le liturgie eccessive ed emozionali sono quasi sempre segno di fedi larvatamente idolatriche. Elia vince la sfida, e il popolo esclama: «YHWH è Dio! YHWH è Dio!» (18, 39). Elia celebra la sua vittoria facendo sgozzare uno a uno i quattrocentocinquanta profeti di Baal: «Elia disse loro: "Afferrate i profeti di Baal; non ne scappi neppure uno!". Li afferrarono. Elia li fece scendere al torrente Kison, ove li ammazzò» (18, 40). Un epilogo tremendo, come tutta la scena.
L’ordalia, o "giudizio di Dio", è una prova il cui esito veniva interpretato come diretta manifestazione della volontà degli dèi. Era molto diffusa nell’antichità e in molte culture. In Europa le ordalie furono introdotte soprattutto dai popoli germanici, in Italia dai Longobardi, per molti secoli tollerate anche dalla Chiesa. Nell’ordalia - del fuoco, dei veleni, dei metalli fusi... - chi usciva illeso dalla prova era considerato giusto e/o innocente. Il dato di fatto veniva eretto a volontà divina. Quindi il più forte in duello, o il più scaltro a camminare sul fuoco, era benedetto da Dio e portatore di un suo messaggio. E così, i forti diventavano ancora più forti, i deboli ancora più deboli. Qualcosa di molto simile alla religione economico-retributiva, che leggeva nella ricchezza la benedizione di Dio e nella povertà la maledizione, che rendeva i ricchi due volte benedetti e i poveri due volte maledetti.
 La Bibbia ha dovuto lottare molto per liberarsi da questa visione arcaica e "naturalistica" della fede, e c’è riuscita solo in parte. Ha cercato di mostrarci che i "miracoli" non sono di per sé prove della verità della fede, ma solo segni imperfetti e sempre parziali. Perché anche i falsi profeti sanno fare miracoli, anche i maghi in Egitto simulavano le piaghe, e Simon Mago con i suoi gesti "strabiliava" gli abitanti di Samaria (Atti degli Apostoli, cap. 8). Geremia era avversato e perseguitato dai falsi profeti che invocavano il miracolo che li avrebbe salvati - che non ci fu.
La Bibbia ha dovuto lottare molto per liberarsi da questa visione arcaica e "naturalistica" della fede, e c’è riuscita solo in parte. Ha cercato di mostrarci che i "miracoli" non sono di per sé prove della verità della fede, ma solo segni imperfetti e sempre parziali. Perché anche i falsi profeti sanno fare miracoli, anche i maghi in Egitto simulavano le piaghe, e Simon Mago con i suoi gesti "strabiliava" gli abitanti di Samaria (Atti degli Apostoli, cap. 8). Geremia era avversato e perseguitato dai falsi profeti che invocavano il miracolo che li avrebbe salvati - che non ci fu.C’è voluto l’Esilio per capire che YHWH non è vero perché vincitore, che continuava a essere il Dio della promessa anche da Dio sconfitto. Ma noi nonostante tutta la Bibbia, i Vangeli, san Paolo, san Francesco, nonostante il non-miracolo della croce e la non-ordalia dei chiodi e del legno, siamo troppo tentati di imitare Elia, di pensare che il nostro Dio è vero perché è vincente, e poi sgozziamo i perdenti.
 Il miracolo del fuoco sul Monte Carmelo non prova che YHWH è Dio. Forse prova soltanto che Baal è un idolo, ma questo lo sapevamo prima dell’ordalia. Non è bene "tentare Dio", dirà un’altra anima della stessa Bibbia. Anche perché noi troppe volte apparecchiamo gli altari, facciamo veglie, urliamo e chiediamo il miracolo che non arriva. E come noi siamo capaci di non perdere la fede davanti a un figlio che non guarisce e muore, quella stessa fede vera non può essere creata da nessun miracolo. Anche perché di fronte a un miracolo per noi dobbiamo sempre continuare a chiedere a Dio: "Perché non agli altri"?
Il miracolo del fuoco sul Monte Carmelo non prova che YHWH è Dio. Forse prova soltanto che Baal è un idolo, ma questo lo sapevamo prima dell’ordalia. Non è bene "tentare Dio", dirà un’altra anima della stessa Bibbia. Anche perché noi troppe volte apparecchiamo gli altari, facciamo veglie, urliamo e chiediamo il miracolo che non arriva. E come noi siamo capaci di non perdere la fede davanti a un figlio che non guarisce e muore, quella stessa fede vera non può essere creata da nessun miracolo. Anche perché di fronte a un miracolo per noi dobbiamo sempre continuare a chiedere a Dio: "Perché non agli altri"?La parte luminosa di questa pagina buia del Monte Carmelo non sta allora nella luce del fuoco che irrompe sulla scena, ma nella domanda che Elia rivolge al suo popolo: «Fino a quando salterete da una parte all’altra? Se YHWH è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!» (18,21).
 La tentazione idolatrica è tenace, sempre presente e attiva nel cuore dell’uomo e della donna perché, diversamente dall’ateismo, non nega Dio ma prima lo riduce a idolo e poi lo moltiplica - ogni idolatria è politeista, perché ogni consumatore ama la varietà delle merci. L’idolatra non rinnega Dio, lo rimpicciolisce per manipolarlo. I profeti ci dicono: "scegli", perché è meglio, paradossalmente, passare interamente a Baal che aggiungerlo nel tempio accanto a YHWH. Ma noi preferiamo molti piccoli dèi innocui a un unico Dio vero e scomodo. Ecco perché sulla terra l’idolatria è molto più presente della fede. Quando il figlio dell’uomo tornerà sulla terra vi troverà certamente l’idolatria. La fede non lo sappiamo. Speriamo che la trovi almeno in uno. E se viene presto, che quell’uno possiamo essere noi.
La tentazione idolatrica è tenace, sempre presente e attiva nel cuore dell’uomo e della donna perché, diversamente dall’ateismo, non nega Dio ma prima lo riduce a idolo e poi lo moltiplica - ogni idolatria è politeista, perché ogni consumatore ama la varietà delle merci. L’idolatra non rinnega Dio, lo rimpicciolisce per manipolarlo. I profeti ci dicono: "scegli", perché è meglio, paradossalmente, passare interamente a Baal che aggiungerlo nel tempio accanto a YHWH. Ma noi preferiamo molti piccoli dèi innocui a un unico Dio vero e scomodo. Ecco perché sulla terra l’idolatria è molto più presente della fede. Quando il figlio dell’uomo tornerà sulla terra vi troverà certamente l’idolatria. La fede non lo sappiamo. Speriamo che la trovi almeno in uno. E se viene presto, che quell’uno possiamo essere noi.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Tutti i corpi insieme, e tutti gli spiriti insieme, e tutte le loro produzioni, non valgono un minimo moto di carità [charité, fls]. Questo è di un ordine infinitamente più elevato
- Blaise Pascal, Pensieri, S. 795; B. 793.
- ««Fino a quando zoppicherete con i due piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!» 1 Re, 21).
- UN FALSO FILOLOGICO, ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO. DIO e’ AMORE ("CHARITAS") non MAMMONA ("CARITAS"), COME SCRIVE BENEDETTO XVI ("Deus caritas est", 2006). Così "il Dio del denaro" inganna Papa Ratzinger, e Papa Ratzinger inganna gli uomini.... e rende cieco anche Enzo Bianchi
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
- ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
SVOLTA IN FRANCIA. DALLA CARITÀ ("CHARITE’") DI PASCAL ALLA CARITA’ DI PAPA RAZTINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006), DALLA CHIAREZZA DI CARTESIO ALLA "CONFUSIO-NE" ("COMMUNIO") DI J.-L. MARION .... IL PRESIDENTE SARKOZY E IL FILOSOFO J.-L. MARION: DALL’ACCOGLIENZA DELLA DIVERSITÀ ALLA DIFESA DELL’IDENTITÀ, ’NAZIONALE’ E ’CATTOLICA’.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- Al di là della Trinità edipica: la Trinità evangelica e francescana. Note.17 giugno 2019, di Federico La Sala
LA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA O LA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA?! Al di là della Trintà edipica....*
La Trinità
di José Tolentino Mendonça (Avvenire, domenica 16 giugno 2019)
Come si rappresenta il mistero? Noi ci accostiamo a esso a tastoni, consapevoli che i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre immagini vacillano e arrivano appena a intravvederne, poveramente, la realtà. Ma questo nostro tentativo di approssimazione costituisce comunque un importante patrimonio di fede.
Pensiamo ad Andrej Rublëv: siamo nella seconda metà del XV secolo quando egli crea quella che sarà la più celebre icona della Trinità. Il testo biblico soggiacente (Gen 18,1-15) è quello dell’ospitalità che Abramo offre ai tre personaggi celesti che lo visitano. Nella contemplazione di questa stupenda icona della Trinità, l’orante viene condotto al centro del mistero di Dio.
In effetti, ciò che vien lì focalizzato è il Dio unico, un solo Dio con la stessa natura divina in tre persone. I tratti fisionomici coincidono esattamente, come se fosse la medesima figura mostrata per tre volte, anche se in tre posizioni differenti.
I personaggi hanno lo stesso volto, lo stesso atteggiamento del corpo, le stesse ali. Inoltre, tutti hanno in mano uno scettro e posseggono un’aureola per indicare eguali dignità e regalità.
Ciascun personaggio, però, occupa una posizione differente nello spazio e sono diversi i gesti, i colori degli abiti e il gioco degli sguardi.
Il Padre, da cui proviene ogni benedizione, guarda all’umanità attraverso il Figlio. E il Figlio guarda a noi attraverso lo Spirito Santo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- PROVANDO E RIPROVANDO. LA STELLA E IL NARDO .... Ripartire dalle radici moderne, eu-angeliche e francescane -dal "presepe"!
"NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- SUL FILO DI (OVIDIO E ) BRUNETTO LATINI, CON DANTE, FINO ALL’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE.20 febbraio 2019, di Federico La Sala
IL "DIO DI AMORE" DI (OVIDIO E) BRUNETTO LATINI E "L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" DI DANTE.... *
Su Brunetto Latini, “Poesie”, a cura di Stefano Carrai
di Claudio Giunta (Domenicale del Sole 24 ore, 20 marzo 2016)
- Brunetto Latini, Poesie, a cura di Stefano Carrai, Torino, Einaudi 2016, euro 15.
Il Tesoretto di Brunetto Latini non è certamente quel misconosciuto «capolavoro della letteratura allegorica» che diceva Jauss (ma come mai lo abbiamo preso sul serio?), ma è un modo eccellente per avvicinarsi alla poesia dei primi secoli; e questa nuova edizione a cura di Stefano Carrai è un modo eccellente per avvicinarsi al Tesoretto.
Si tratta di un poemetto, 2944 versi in tutto, scritto da Brunetto Latini al principio degli anni Settanta del Duecento. È uno strano ibrido. Comincia come un racconto di viaggio (il poeta-protagonista si trova a Roncisvalle, e qui incontra uno studente bolognese che gli comunica la sconfitta dei guelfi a Montaperti), prosegue come un trattato didascalico (la Natura personificata illustra al poeta l’ordinamento del cielo e della terra), poi come un trattato morale (il poeta incontra in successione le virtù, il dio d’Amore, il poeta Ovidio), e finisce con una bizzarra ‘Penitenza’, circa 500 versi in cui Brunetto riflette sulla caducità delle cose umane ed esorta un amico a cambiare vita come lui l’ha cambiata («che sai che sén tenuti», scrive, «un poco mondanetti»); dopodiché il racconto riprende e il protagonista si trova sul monte Olimpo, dove incontra il grande Tolomeo, «maestro di storlomia». Qui il testo s’interrompe di colpo.
Al di là però del contenuto, né originale né profondo, e al di là dello stile, senza veneri (anche perché imprigionato in una gabbia metrica da filastrocca: coppie di settenari a rima baciata), il Tesoretto è un testo interessantissimo perché è davvero un repertorio di topoi immaginativi, un campione di medievalità: c’è il viaggio nella foresta, c’è un mondo fantastico all’interno del quale il personaggio-poeta può dialogare via via con la Natura, con Ovidio o con Tolomeo, ci sono le ipostasi delle virtù e delle percezioni, che pescano dall’identico immaginario da cui hanno pescato gli sceneggiatori di Inside Out (Desianza=Joy, Paura=Fear): «Desïanza ... sforza malamente / d’aver presentemente / la cosa disïata / ed è sì disvïata / che non cura d’onore / né morte né romore, / se non che la Paura / la tira ciascun’ora, / sì che non osa gire / né solo un motto dire».
Il commento di Carrai è un commento esatto e intelligente. Sembra poco, ma è tantissimo, perché i commenti alla poesia (e soprattutto alla poesia antica) sono spesso un po’ stupidi. Chi ha studiato per anni un autore o un testo non si rassegna facilmente a farsi da parte, cioè a tacere una volta chiarito ciò che nel testo c’è da chiarire, ed eventualmente a far riflettere il lettore su ciò che il testo può dire sul suo autore o sulla mentalità dell’epoca in cui venne scritto: non si rassegna, gli viene, come diceva il dottor Johnson, «la fregola di dire qualcosa anche quando non c’è nulla da dire», o peggio - e la cosa è specialmente frequente nel campo della medievistica - gli viene la fregola di trovare verità nascoste, di sciogliere gli enigmi, il che porta spesso a postulare enigmi là dove non ce ne sono, onde una ridda di ipotesi e contro-ipotesi da stancare un causidico. E poi, a riempire le pagine, valanghe di ‘riscontri intertestuali’, come se importasse qualcosa che il poeta X ha preso quella parola dal poeta Y o dal poeta Z. Carrai invece non scaraventa sul lettore tutto il contenuto delle sue schede, spiega il testo dove occorre, e dove non riesce a spiegare prospetta delle ipotesi d’interpretazione, appoggiandosi - per consentire o per dissentire - a chi del Tesoretto si è occupato prima di lui.
Al Tesoretto Carrai fa seguire, com’è consuetudine, il Favolello, che è un altro breve poemetto in settenari baciati, più pedestre nel contenuto (è uno scialbo trattatello sull’amicizia), ma interessante soprattutto perché cita come amici-destinatari due rimatori contemporanei, Rustico Filippi e Palamidesse di Bellindote. E al Favolello segue, nel volume (che appunto per questo s’intitola Poesie: è l’opera omnia in volgare italiano di Brunetto), l’unica canzone di Brunetto che ci venga tramandata dai manoscritti, S’eo son distretto, strana poesia d’amore e devozione che alcuni hanno interpretato come un documento dell’omosessualità dell’autore (con ovvi riflessi sull’interpretazione di Inferno XV) e altri, direi più plausibilmente, come canto nostalgico per la patria, Firenze, dal quale il guelfo Brunetto viene bandito dopo Montaperti.
Manca, e avrebbe invece dovuto esserci, la canzone responsiva di Bondie Dietaiuti (così, nel Medioevo, si dissolvevano le tenzoni poetiche: gli scribi copiavano i corpora personali degli autori obliterando i testi missivi e responsivi dei loro corrispondenti, che in questo modo si disperdevano; ma in un’edizione moderna non si vede perché le tenzoni non debbano essere date nella loro integrità).
Il discorso sul Tesoretto e sul Favolello non è chiuso. Sono testi facili solo all’apparenza, specie a causa delle contorsioni che il metro e lo schema delle rime impongono all’autore. Di certi hapax resta poco chiaro, nonostante lo sforzo degli interpreti, il significato. Altri termini sono ambigui (per esempio non parafraserei con ‘verità’, con Contini e Carrai, il drittura di Favolello 7 «e fàllati drittura»: ‘giustizia’, che è il senso che drittura ha usualmente, mi pare più aderente al contesto). E certi passi dovranno forse essere riconsiderati in una futura edizione critica. Per esempio, ai vv. 1275-79 tutti gli editori postulano un (credo inattestato altrove) ablativo assoluto: «E vidi ne la corte, / là dentro, fra le porte, / quattro donne reali / che corte principali / tenean ragione ed uso». Dove «corte principali» vorrebbe dire ‘nella prima corte’. Ma dato che le «donne» di cui si parla sono virtù, e che principales è l’aggettivo che nel Medioevo spesso si predica delle virtù, in genere le cardinali, ci si deve domandare se la lezione corretta non sia piuttosto, con minimo emendamento, «come principali», cioè ‘come signore, regine di quella corte di giustizia’ (e sarebbe un altro errore d’archetipo, da aggiungere a quelli registrati da Pozzi e Contini nei Poeti del Duecento).
Forse potremmo chiudere, invece, il discorso sui rapporti tra Brunetto e Dante, salvo che non saltino fuori nuovi testi che permettano di riconsiderare sotto nuova luce la questione. Questione che è nota ad ogni studente liceale: Dante mette Brunetto all’Inferno, tra i sodomiti, ma non dice nulla della sua colpa (il che sorprende fino a un certo punto, dato che non sempre Dante lo fa), né di questa colpa si parla nelle fonti che non dipendono da Dante (il che non sorprende per niente: ci si aspetta che l’omicidio o la simonia lascino traccia nelle cronache, non necessariamente le inclinazioni sessuali).
Sodomia va allora inteso figuratamente, come ‘peccato contro la propria lingua materna’ (perché Brunetto, fiorentino, ha scritto il suo Tresor in francese)? Oppure come peccato politico (perché Brunetto non avrebbe «riconosciuto la sacra autorità dell’Impero»)? Mi sembra che la soluzione proposta da Zanato e ora da Carrai resti la più sensata: dato che Brunetto ci appare in compagnia di «Prisciano, Francesco Accursio e Andrea de’ Mozzi, [cioè] del gruppo di intellettuali, perlopiù pedagoghi ed ecclesiastici, che si sono resi colpevoli di pratiche omosessuali», non c’è ragione di pensare che lui non si sia macchiato dello stesso - non metaforico - peccato.
Non andrei oltre; né speculerei, per le ragioni che ho già accennato, sulla ‘memoria’ della poesia brunettiana nel canto XV. Il poeta Brunetto non aveva niente da insegnare a Dante, perché il peggior Dante (per esempio quello un po’ lezioso di Inferno IV: «Venimmo al piè d’un nobile castello, / sette volte cerchiato d’alte mura, / difeso intorno d’un bel fiumicello...») è migliore del migliore Brunetto. E l’idea che quando Dante mette in scena un altro poeta si serva - attraverso accorte allusioni - delle parole che quel poeta ha adoperato nelle sue opere mi sembra davvero un’idea tutta nostra, un’idea da filologi moderni, che mettiamo a forza nella testa di scrittori molto meno sottili di noi.
E questo vale anche per la testimonianza che molti (anche Carrai) considerano più probante: l’avvio del canto XV, «Ora cen porta l’un de’ duri margini...», nel quale si condenserebbero «gli echi di mosse identiche del Tesoretto, vv. 1183-84 “Or va mastro Burnetto / per un sentiero stretto”, e 2181-82 “Or si ne va il maestro / per lo camino a destro”». Ma direi di no: è una formula di transizione che si trova molte volte nella poesia narrativa francese, per esempio nel Girart de Rossillon («Ere s’en vait Girarz egal solel / per un estreit sender...» (l’identica immagine del sentiero stretto che si trova in Brunetto Latini), nella chanson de toile Gaiete et Oriour («Or s’an vat Oriour stinte et marrie»), nel Macaire franco-veneto, «Ora se voit sor un corant destrer». Langue, insomma, non parole, come nella poesia medievale capita non dico sempre, ma quasi.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI". DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- PER UNA NUOVA "BUSSOLA TEOLOGICA", OGGI. Più fede nella politica, la lezione di Dante.19 febbraio 2019, di Federico La Sala
DANTE, OGGI. PER UNA NUOVA "BUSSOLA TEOLOGICA" .... *
Classici.
Più fede nella politica, la lezione di Dante
La vicenda biografica e intellettuale del grande fiorentino si rivela di grande attualità ancora oggi, specie per quanto riguarda l’impegno dei credenti a favore del bene comune
di Gabriella M.Di Paola Dollorenzo (Avvenire, 17 febbraio 2019)
- [Foto] La visione del «Paradiso» dantesco in un’incisione di Gustave Doré
L’intervista al cardinale Gualtiero Bassetti (Avvenire, 9 dicembre 2018) ha riportato la nostra attenzione «sull’impegno concreto e responsabile dei cattolici in politica». Già nell’inchiesta del mensile Jesus sul «tempo del rammendo » (ottobre 2018), il presidente della Cei aveva rimarcato l’urgenza di ricostruire una presenza laicale che guardasse alla politica come a un’avventura positiva, nella necessità di una classe dirigente in grado di opporre alla sfiducia popolare un forte senso di concretezza e di responsabilità. Queste virtù o, per meglio dire, questi talenti ci permettono di richiamare la coerenza del pensiero politico di Dante così come ebbe a svilupparsi, sia negli anni di politica attiva sia dopo l’esilio e parallelamente allo svolgersi del suo pensiero teologico nella Commedia. Considerare l’architettura del suo pensiero, il rapporto tra teoria e prassi, l’utilizzo anzi l’interazione delle fonti (Sacre Scritture, autori grecolatini, testi arabi) può essere utile per individuare l’archetipo del cristiano impegnato nella realtà politica del proprio tempo, con l’ambizione di tradurre l’imitatio Christi nel concreto operare all’interno della res publica.
La vicenda umana del Poeta incardinato nella realtà politica del suo tempo, specialmente negli anni che vanno dalla morte di Beatrice (1290) alla condanna all’esilio (1302), ci permette di riflettere sul rapporto teologia- politica, così come fu duramente ma appassionatamente vissuto, in «un crescendo di temerarietà e di coerenza» (Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, 1993) e, nello stesso tempo, avendo ben salda la «coscienza della storia», quell’habitus morale in base al quale «gli avvenimenti non si confondono caoticamente nella memoria, ma sono collegati dalla coscienza della causa e dell’effetto, dell’iniziativa e della responsabilità» (Romano Guardini, Dante, 2008). Se accogliamo l’approccio euristico di Jürgen Moltmann (si veda in particolare Dio nel progetto del mondo moderno, edito da Queriniana nel 1999), possiamo capire in che senso la teologia può “binarizzarsi” con la politica determinando le scelte tra il bene e il male, nel concreto avvicendarsi della storia di una città, di una nazione, di un popolo. Non è un caso che la formazione filosofico-teologica di Dante preceda cronologicamente l’attività politica, anzi ne sia quasi il trampolino di lancio: «Io che cercava di consolarme, trovai non solamente a le mie lagrime rimedio, ma vocaboli d’autori e di scienze e di libri: li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. E da questo imaginare cominciai ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti » ( Convivio, II, xii, 5-7).
Dopo aver approfondito l’Etica Nicomachea e la Politica di Aristotele (nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke e col commento di Tommaso d’Aquino), nel libro II del Convivio si rivendica il primato della morale. Dante va oltre Tommaso d’Aquino: se la metafisica è la scienza di Dio, l’uomo potrà cercare lo status felicitatis in questa vita e, dato che l’uomo è un animale sociale, in una politica regolata dalla morale. Pertanto non è conforme alla morale rinchiudersi nella contemplazione dell’intelligibile, quando l’odio e la violenza di parte sconvolgono la comunità in cui si vive.
Nel 1294, anno dell’elezione e successiva abdicazione di Celestino V, nonché dell’ascesa al papato di Bonifacio VIII, Dante ha un ruolo diplomatico- culturale di primo piano nella delegazione dei cavalieri destinati dal Comune al seguito dell’imperatore Carlo Martello. In seguito, con la stesura del Paradiso, Dante potrà immaginare un incontro con Carlo al cospetto di Dio; il dialogo tra i due, con esplicito richiamo alla Politica di Aristotele, ma anche al De Anima, ha una precisa connotazione teologica: «“Vuo’ tu che questo ver più ti s’imbianchi?”. /E io: “Non già; ché impossibil veggio / che la natura, in quel ch’è uopo, stanchi”. / Ond’ elli ancora: “Or dì: sarebbe il peggio /per l’omo in terra, se non fosse cive?”. / “Sì”, rispuos’ io; “e qui ragion non cheggio”. / “E puot’ elli esser, se giù non si vive /diversamente per diversi offici? / Non, se ’l maestro vostro ben vi scrive”» ( Paradiso, VIII, 113-120).
Sarebbe un male per l’uomo sulla terra se non facesse parte di un ordine civile, di un organismo sociale? E può esistere un’organizzazione civile se i suoi membri non siano ordinati a vivere esercitando diverse funzioni? E Dante risponde “sì” alla prima domanda e “no” alla seconda. La naturale politicità dell’uomo si accompagna alla necessità di distinguere gli offici poiché Nihil frustra natura facit (Politica I, 2).
Il quinquennio successivo al 1294 segnerà intensamente la vita e l’opera di Dante proprio perché continuo sarà lo scambio tra teoria e prassi, una prassi in toga candida: dalla riflessione filosofica riguardo al primato della morale alla traduzione di ciò nella vita della polis, una sorta di ragion pratica kantiana ante litteram: impegno civile, riflessione morale, tenace inseguimento della giustizia.
Proprio quando Firenze è dilaniata da lotte sociali interne e lo stesso papato non è immune dalla brama di potere che assale i partiti politici, Dante tiene ben ferma la barra del suo operare cristiano, perché è fermamente convinto di agire nella direzione indicata dalla bussola teologica. In questo atteggiamento riconosciamo l’attualità del suo pensiero politico e del suo agire politico. Dopo la condanna, negli anni dell’esilio, Dante consegnerà alle pagine del Convivio, della Commedia, ma soprattutto del trattato Monarchia, la riflessione teorica frutto della sua esperienza politica. È un progetto in fieri perché dovrà fare i conti col divenire della storia, è un progetto politico voluto da Dio per il bene dell’umanità.
Dopo la fine del potere temporale dei Papi, la Chiesa, a partire dall’enciclica In praeclara summorum (1921) di Benedetto XV, fino al Messaggio al presidente del Pontificio Consiglio della cultura in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (2015) di papa Francesco, ha pienamente rivendicato, si pensi alla mirabile Altissimi cantus, la lettera apostolica di Paolo VI, l’appartenenza di Dante alla Chiesa cattolica e alla fede di Cristo, proprio considerando la sua battaglia di cristiano impegnato nella vita politica del suo tempo e nella sua somma opera teologica.
Oggi l’umanesimo cristiano di Dante può essere una traccia da seguire nella comunicazione religiosa e laica che stiamo vivendo. Per la preparazione del laicato cattolico alla vita politica, il pensiero di Dante può diventare una “bussola teologica”. Il rapporto tra fede, morale e politica, vissuto alla luce dei valori cristiani, che fece di Dante il segno di contraddizione della sua epoca, oggi fa di lui un nostro contemporaneo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- Dio vide tutto quello che aveva fatto e allora creò l’umorismo (di E. Lowenyhal).9 febbraio 2019, di Federico La Sala
Dio vide tutto quello che aveva fatto e allora creò l’umorismo ebraico
di Elena Loewenthal (La Stampa, 09.02.2019)
Tutto cominciò con una sghignazzata. Breve, sommessa, con una mano che dobbiamo immaginare avvizzita e costellata di macchie scure di vecchiaia davanti alla bocca, nel vano tentativo di passare sotto silenzio quello sfogo di ilarità. Quando infatti, tramite dei viandanti per il deserto che nella realtà del testo sacro sono angeli, l’Altissimo annuncia al patriarca Abramo che sta per dargli un figlio con Sara, che intende cioè aprirle finalmente l’utero tristemente occluso, quella povera donna che in novant’anni suonati di vita ne aveva già viste tante di quelle tante, scoppia a ridere. «Ma figuriamoci!», «Questa è buona!», «Che scherzo di cattivo gusto», e tanto altro dice il sottotesto della prima risata di tutta la Bibbia, frutto della disillusione e dell’amarezza di una donna che non è riuscita a procreare sino a quel momento ed è ormai certa che non ci riuscirà mai più. Altissimo o non Altissimo. Di lì a nove mesi, nello stupore generale, Sara metterà al mondo Isacco, il cui nome in ebraico significa per l’appunto riderà.
Dalla tenda di Abramo e Sara in poi, ridere è per i figli d’Israele una faccenda alquanto seria: «Metropolitana di New York. Un nero sta leggendo un giornale in yiddish. Qualcuno si ferma e gli domanda: - Lei è ebreo? -. Oy gevalt (tipica esclamazione di sconforto in yiddish) - risponde - mi ci manca solo quello».
«La barzelletta ebraica è vecchia come Abramo. Insieme agli ebrei in carne e ossa ha errato per il mondo, imparato svariate lingue, lavorato con una vasta gamma di materiali e dato il meglio di sé al cospetto di folle piuttosto ostili», spiega Devorah Baum in apertura del suo libro, La barzelletta ebraica (in uscita per Einaudi) con un eloquente sottotitolo che chiarisce trattarsi di «Un saggio con esempi (meno saggio più esempi». Perché se tutto che comincia con Abramo, non si può negare che a fare la prima battuta sia stata Sara, e suo marito - a quanto pare - non l’ha presa troppo bene. In quanto donna, discendente cioè in linea diretta della spiritosa matriarca e del suo umorismo irriverente, fors’anche un pizzico macabro, anche Devorah Baum - giovane scrittrice americana - la sa lunga in fatto di battute ebraiche.
E’ vero, nel libro ci sono più battute che argomentazione, più esempi che saggio. Ma è anche vero che quando si fa umorismo ebraico non si può fare a meno di parlarne.
Che sia battuta fulminante o lenta narrazione, la storiella ebraica porta sempre con sé un significato, anzi di più. È come se dicesse sempre, in sottofondo: «Cari gentili (di nome ma spesso non di fatto), oltre a perseguitarci, emarginarci e cacciarci ai quattro angoli del mondo, non state anche a ridere di noi ebrei. Quello lo facciamo da soli, e di sicuro meglio di quanto non possiate fare voi».
L’umorismo è insomma da secoli un’arma di sopravvivenza per il popolo d’Israele, un modo per conciliarsi con il mondo, con le avversità, con i contrattempi. Altro che contrattempi: «Burt: ti importa dell’Olocausto o pensi che non sia mai successo? Harry: Non solo so che abbiamo perso sei milioni di ebrei, ma quello che mi preoccupa è che i record sono fatti per essere battuti». (Copyright Woody Allen).
Baum affronta uno dei tanti percorsi possibili nell’umorismo ebraico con una serie di domande che echeggiano il rituale della Pasqua ebraica e marcano la differenza fra la sera festiva e quella feriale. Non per niente la tradizione ebraica si costruisce sull’analisi puntuale, sul pelo nell’uovo: «Che differenza c’è fra l’uomo e Dio?», «Che differenza c’è fra moralità e nevrosi?», «Che differenza c’è fra un ebreo e un pappagallo?», «Che differenza c’è fra uno shlemiel e uno shlimazel?» (spoiler: lo shlemiel è quello che si sbrodola, e quello su cui si rovescia la minestra è lo shlimazel).
Nel riscontro di una serie di differenze, Baum traccia una storia della battuta ebraica, o meglio un percorso divertente e interessante in questo umorismo che può piacere o non piacere, che a volte è immediato e a volte criptico - soprattutto quando più che una battuta diventa un larvato test d’intelligenza a spese dell’ignaro ascoltatore -, ma che ha sempre molto da raccontare.
Baum spazia dal cinema alla tradizione orale, dalla letteratura contemporanea al Talmud, ma ha una particolare - e giustificata - predilezione per quella stand-up comedy americana (a malapena traducibile con «cabaret») che ha dato il meglio di sé con una certa comicità ebraica fatta tanto di improvvisazione quanto di sapienza, con giganti quali Lenny Bruce e Mrs Maisel - che sarà pure il protagonista dell’omonima serie televisiva, ma è più reale e fantastica che mai.
E in fondo, fra le tante, davvero tante cose confortanti che l’umorismo ebraico porta con sé da secoli e millenni, c’è anche una parità di genere che non fa sconti a nessuno, perché quando si tratta di ridere - o far ridere - non c’è sesso che tenga. E da che mondo è mondo, le donne si tramandano ricette, segreti, saggi consigli: «Mia mamma diceva sempre che per denaro non ci si sposa. Si divorzia».
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- Abu Dhabi. Storica intesa Vaticano-al Azhar: non ci può essere violenza nel nome di Dio.5 febbraio 2019, di Federico La Sala
Papa.
Storica intesa Vaticano-al Azhar: non ci può essere violenza nel nome di Dio
Pace, libertà e ruolo della donna nella dichiarazione congiunta firmata ad Abu Dhabi da papa Francesco e dal Grande Imam sunnita di al-Azhar, Ahamad al-Tayyib: «Basta sangue innocente»
di Stefania Falasca, inviata ad Abu Dhabi *
- [Foto] La storica firma: papa Francesco e il Grande Imam sunnita di al-Azhar, Ahamad al-Tayyib: «Basta sangue innocente» (Lapresse)
Abu Dhabi 4 febbraio 2019: «In nome di Dio Al-Azhar al-Sharif - con i musulmani d’Oriente e d’Occidente -, insieme alla Chiesa Cattolica - con i cattolici d’Oriente e d’Occidente -, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio». Non solo. È messo nero su bianco l’impegno per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze.
 Nero su bianco la condanna dell’estremismo e l’uso politico delle religioni, «il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi», la protezione dei luoghi di culto e il dovere di riconoscere alla donna il diritto all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici interrompendo «tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che ne umiliano la dignità e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti». E ancora: «Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione
e di formazione».
Nero su bianco la condanna dell’estremismo e l’uso politico delle religioni, «il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi», la protezione dei luoghi di culto e il dovere di riconoscere alla donna il diritto all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti politici interrompendo «tutte le pratiche disumane e i costumi volgari che ne umiliano la dignità e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente dei propri diritti». E ancora: «Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione
e di formazione».È questo l’epilogo di un incontro interreligioso decisamente coraggioso in un lacerato Medio Oriente che ha visto protagonisti nel Paese-ponte del Golfo Persico papa Francesco e il Grande Imam sunnita di al-Azhar, Ahamad al-Tayyib. Una solenne quanto impegnativa doppia firma a un documento comune sulla «Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune», che sigla un’appello congiunto senza precedenti rivolto a «tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli».
Una dichiarazione non annunciata, resa pubblica solo alla fine dal Founder’s Memorial, dedicato al padre fondatore degli Emirati arabi, dove davanti ai rappresentanti delle diverse religioni il Successore di Pietro e un leader musulmano hanno sottoscritto la lista di punti “non negoziabili” e chiesto a loro stessi e ai leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di invertire la rotta delle violenze e «impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace».
Un gesto forte, di parole altrettanto forti, soprattutto per la responsabilità assunta davanti ai leader e ai governanti islamici da parte di Ahmad al-Tayyib, che già nell’incontro con il Papa all’Università di al-Azhar a Il Cairo nel 2017, intervenendo alla Conferenza internazionale per la pace organizzata dal prestigioso centro accademico sunnita, aveva messo a tema il ruolo dei leader religiosi nel contrasto al terrorismo e nell’opera di consolidamento dei principi di cittadinanza e integrazione.
La dichiarazione comune che muove «da una riflessione profonda sulla realtà contemporanea» condanna l’ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali - delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra - che porta a far «morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani - in «un silenzio internazionale inaccettabile». Condanna tutte le pratiche che minacciano la vita e chiede a tutti di «cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e chiede di «smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione». Perché Dio «non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati» nella loro vita e nella loro esistenza», «non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la gente».
 Si dichiara perciò «fermamente» che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. «Queste sciagure - è scritto - sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione». Da qui, pertanto, in accordo con i precedenti documenti internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, viene attestata tra le atre anche la protezione dei luoghi di culto, templi, chiese e moschee e che «ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del
diritto internazionale».
Si dichiara perciò «fermamente» che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. «Queste sciagure - è scritto - sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione». Da qui, pertanto, in accordo con i precedenti documenti internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, viene attestata tra le atre anche la protezione dei luoghi di culto, templi, chiese e moschee e che «ogni tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del
diritto internazionale».Tutto questo è affermato in nome di Dio - come è ribadito - che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro. In nome dunque della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali - ma che è lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato, dalle tendenze ideologiche che manipolano le azioni e i destini degli uomini. In nome «dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità». In nome dei poveri, dei più vulnerabili. «In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre». La scossa doveva arrivare ed è arrivata. Inshallah.
* Avvenire. lunedì 4 febbraio 2019 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- Il segreto della regina di Saba e di Salomone (William Butler Yeats).22 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il segreto di Saba
di Roberto Mussapi (Avvenire, martedì 22 gennaio 2019)
«Non c’è uomo né donna sotto i cieli/ che possa osare competere/ in conoscenza e sapere con noi due,/ e noi per tutto il giorno abbiamo trovato/ che niente al mondo può fare del mondo/ uno stretto recinto, se non l’amore».
Versi di uno dei massimi poeti, William Butler Yeats. Il lettore ora conosca il titolo della poesia, Salomone a Saba, e i primi due versi: «Salomone cantò a Saba,/ baciandole il volto bruno»: il poeta immagina l’incontro tra il re più sapiente degli Ebrei e la maga, la donna regina di Saba depositaria del sapere antico, magico.
Le parole di Salomone sono quelle di Yeats che intuisce la fusione di magia e sapienza, le introduce con due versi: «Salomone cantò a Saba,/ baciandole gli occhi da araba». Salomone ha trovato la comprensione definitiva dell’essere umano, solo dopo avere baciato gli occhi d’araba di Saba: scopre che l’essenza della vita è fusione tra sapienza (che non è erudizione) e magia (che è senso creaturale, non occultismo): sapienza e magia si baciano e abbracciano, per trovare il segreto e l’ origine di tutto: l’amore. Che crea un impercettibile ai sensi ma reale recinto: senza amore tutto si disperde, anche le parole e i sospiri di chi ama. L’amore crea recinto, confine libero, spazio ordinato e definito, armonia.
-
> I TRE ANELLI --- «Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza». L’orizzonte della civiltà e i drammi con cui conviviamo (di Paolo Farinella, prete).15 giugno 2018, di Federico La Sala
LA STORIA DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE: L’ORIZZONTE DELLA CIVILTÀ E I DRAMMI CON CUI CONVIVIAMO.... *
L’ORIZZONTE DELLA CIVILTÀ E I DRAMMI CON CUI CONVIVIAMO
di don Paolo Farinella (la Repubblica, 10 giugno 2018)
«Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo». Queste parole sono scolpite nell’atrio del Palazzo dell’Onu.
 Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran 1203 - 1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, « Adamo » non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa « Umanità - Genere Umano » , senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale. L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di « civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.
Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran 1203 - 1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, « Adamo » non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa « Umanità - Genere Umano » , senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale. L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di « civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.Due giorni fa, di mattina presto, un’amica mi ha inviato due video ripresi nei pressi della Regione Liguria dove dormivano persone per terra, « figlie di Adamo » , carne e sangue « della sua essenza » . Mi sono chiesto se la nostra civiltà non stia regredendo verso la preistoria, verso il nulla.
 Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: « Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».
Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: « Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».A Genova sarà restaurata la Lanterna, simbolo della città, faro di luce nel buio e segnale per rotte sicure; a Genova si perseguitano i poveri, i senza dimora, gli sbandati, figli di una società impazzita che crede di potersi chiudere in sé, erigendo muri e fili spinati, mentre si difendono Istituzioni ed Europa. Chi costruisce muri distrugge l’Europa e il proprio Paese, chi perseguita il povero si attira la collera di Dio che è «il Dio degli umili, il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati» (Gdt 14,11).
 La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz. Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti.
La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz. Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti.
*
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- San Paolo: "Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. [...] Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. [...] Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. (1 Cor., 12-27)
- FORZA "CRISTO RE"! San Paolo: "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16).
"È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi" (Emilio Gentile)
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. "Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka).
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- Pasquino nel cielo papistico. Un nuovo studio sul bestseller del primo ’500: sotto accusa la corruzione della Chiesa cattolica (di Massimo Firpo).15 aprile 2018, di Federico La Sala
Pasquino nel cielo papistico
Un nuovo studio sul bestseller del primo ’500: sotto accusa la corruzione della Chiesa cattolica e l’armamentario di vuote pratiche devozionali
di Massimo Firpo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 15.04.2018)
- Celio Secondo Curione, «Pasquillus extaticus» e «Pasquino in estasi», Edizione storico-critica commentata, a cura di Giovanna Cordibella e Stefano Prandi, Olschki, Firenze, pagg. 314, € 38
Sempre apparso anonimo, il Pasquillus extaticus fu un vero e proprio best seller dei primi anni quaranta del Cinquecento, come testimoniano tre edizioni in latino con numerose varianti e tre in italiano (in due diverse versioni), destinate alla circolazione europea le prime e al proselitismo riformato al di qua delle Alpi le altre. Di queste esistono anche numerosi manoscritti che ne documentano ulteriormente la larga diffusione, attestata anche da una coeva traduzione tedesca e una più tarda traduzione olandese. A scriverlo e a raccogliere i testi che vi compaiono fu Celio Secondo Curione, un letterato piemontese convertitosi alla Riforma e rifugiatosi nel 1542 dopo varie peripezie in Svizzera, a Basilea, dove si sarebbe infine avvicinato a dottrine radicali, sempre più distanti dall’ortodossia calvinista.
È merito di questo studio aver stabilito con buona certezza che il testo latino fu pubblicato per la prima volta a Basilea nel 1541, quando il suo autore non aveva ancora preso la via della fuga oltralpe, all’indomani della quale fu stampata a Venezia la prima edizione italiana, che fu quindi successiva. Sono queste due editiones principes ad essere qui pubblicate con introduzioni storiche e testuali, note di commento e apparato critico. Non stupisce che il Sant’Ufficio romano giudicasse «perniciosissimo» il libello constatandone il successo nell’ambito dei gruppi e movimenti filoriformati in Italia.
 Con il Beneficio di Cristo, l’Alfabeto cristiano, la Tragedia del libero arbitrio, la Medicina dell’anima, testi anch’essi apparsi negli anni quaranta del secolo, sullo sfondo delle prime convocazioni del concilio di Trento, il libro fu uno dei più presenti sui piccoli scaffali clandestini di cui si nutriva una nuova identità religiosa sempre più costretta agli artifici della dissimulazione.
Con il Beneficio di Cristo, l’Alfabeto cristiano, la Tragedia del libero arbitrio, la Medicina dell’anima, testi anch’essi apparsi negli anni quaranta del secolo, sullo sfondo delle prime convocazioni del concilio di Trento, il libro fu uno dei più presenti sui piccoli scaffali clandestini di cui si nutriva una nuova identità religiosa sempre più costretta agli artifici della dissimulazione.In quelle pagine, infatti, la pungente satira delle pasquinate romane dei primi decenni del secolo si spersonalizzava, non investiva più singoli personaggi, ma un’intera istituzione, la Chiesa cattolica, passando dalla beffa morale alla polemica religiosa per denunciarne la corruzione e arricchire l’arsenale delle armi con cui combattere la battaglia per l’abbattimento dell’Anticristo papale.
Non più versi satirici fatti di insulti e più o meno triviali allusioni, ma un dialogo umanistico e pedagogico tra Pasquino e Marforio, sulla base di evidenti modelli erasmiani, che si propone come «una grandiosa ricapitolazione secolare in grado di mostrare al lettore come i tempi della rovina definitiva della Chiesa romana fossero ormai maturi» (p. 23).
Un’opera militante, dunque, in cui il racconto fatto da Pasquino di un viaggio nel cielo papistico (un demoniaco e infernale cielo alla rovescia) offre lo spunto per investire di una critica feroce frati e monache, confessori e martiri, scalzando dalle radici l’imponente edificio della Chiesa visibile e l’infausto armamentario di pratiche sacramentali, liturgiche e devozionali da essa proposto ai fedeli, spingendoli nell’abisso di una pietà farisaica e superstiziosa. -Venerazione delle immagini, purgatorio, voti, pellegrinaggi, digiuni, celibato ecclesiastico, messe di suffragio, indulgenze, miracoli, tutto veniva triturato nella macchina antipapale del Pasquillus curioniano, che investiva non solo e non tanto i comportamenti, ma soprattutto le dottrine erronee che li legittimavano, sì da configurare il discorso come una sintesi della teologia riformata.
Per esempio, se la denuncia dei «fratacci» che, anziché fuggire il mondo «lo portano seco ne’ monasterii, [...] dove non si vede già altro che passioni d’animo e mere pazzie, con che cercano di scacciarsi l’un l’altro o di innalzarsi» (p. 212), poteva rifarsi all’erasmiano «monachatus non est pietas», è evidente il magistero della Riforma laddove si criticavano coloro che preferivano lasciare il monopolio delle cose sacre ai presunti «gran teologi», perché credere «semplicemente» non significa credere «ignorantemente» e ogni cristiano ha il dovere di conoscere la Scrittura (p. 217).
 Se la denuncia del cielo papale come un empio «mercato» simoniaco (p. 230) ripropone antiche invettive anticuriali, di chiara matrice eterodossa sono gli strali contro il culto dei santi (vero e proprio pantheon neopagano), i «novi e orribili riti» e le infinite superstizioni popolari di cui si nutriva, per esortare invece a porre ogni speranza di salvezza solo e soltanto nella fede in Cristo (pp. 232-33), unico «advocato nostro» (p. 244), senza «tanti miracoli fatti a mano, tante fraterie, tanti publichi mercati di meriti e buone opere» (p. 237).
Se la denuncia del cielo papale come un empio «mercato» simoniaco (p. 230) ripropone antiche invettive anticuriali, di chiara matrice eterodossa sono gli strali contro il culto dei santi (vero e proprio pantheon neopagano), i «novi e orribili riti» e le infinite superstizioni popolari di cui si nutriva, per esortare invece a porre ogni speranza di salvezza solo e soltanto nella fede in Cristo (pp. 232-33), unico «advocato nostro» (p. 244), senza «tanti miracoli fatti a mano, tante fraterie, tanti publichi mercati di meriti e buone opere» (p. 237).Un cielo tuttavia, quello papistico, sempre più gravemente insidiato da moderni guastatori, «bravi uomini», in massima parte tedeschi, ma anche «assaissimi italiani et franzesi» che ne preparavano il definitivo crollo scavandone le malcerte fondamenta, fatte di «cappucci, rosari, vesti succide, capelli tagliati, veli di monache e mille fogge di vesti, mille di scarpe, mille di berette, mille di colori, [...] pesci fradici, erbaggi, ligumi, lasagne, mitre pontificali», e sostenute dai muri ormai pericolanti della Superstizione, della Persuasione, dell’Ignoranza e dell’Ipocrisia (pp. 229-30).
I tempi stavano cambiando rapidamente, scriveva Curione, evocando con grande violenza verbale quanti avevano ormai «comminciato a caccar nei capucci, a forbirsi il culo coi rosarii, a farsi beffe dei pelegrinaggi, ad aver a scherzo quelle putanesche astinenze e ad aver in somma abominazione tutte le superstizioni» (p. 235).
 Una violenza che scaturiva dal suo sentirsi schierato in prima linea nella guerra in corso tra verità ed errore, Riforma e papismo, evocata anche dai nomi di numerosi personaggi che compaiono in queste pagine, illustri riformatori come Zwingli, Melantone, Butzer e non meno illustri cardinali come Sadoleto, Aleandro, Carafa, o grandi sovrani europei in guerra tra loro.
Una violenza che scaturiva dal suo sentirsi schierato in prima linea nella guerra in corso tra verità ed errore, Riforma e papismo, evocata anche dai nomi di numerosi personaggi che compaiono in queste pagine, illustri riformatori come Zwingli, Melantone, Butzer e non meno illustri cardinali come Sadoleto, Aleandro, Carafa, o grandi sovrani europei in guerra tra loro.
 Tra di essi figura anche Erasmo da Rotterdam, rappresentato come una vela esposta a ogni vento perché «non si seppe mai, né dai suoi scritti si può sapere, s’ei s’appressasse più al ciel divino o al papistico» (p. 268). Un giudizio severo dal quale lo stesso Curione non tarderà a prendere le distanze, ispirandosi al De immensa Dei misericordia per il suo scritto più celebre, il De amplitudine beati regni Dei, pubblicato nel 1554.
Tra di essi figura anche Erasmo da Rotterdam, rappresentato come una vela esposta a ogni vento perché «non si seppe mai, né dai suoi scritti si può sapere, s’ei s’appressasse più al ciel divino o al papistico» (p. 268). Un giudizio severo dal quale lo stesso Curione non tarderà a prendere le distanze, ispirandosi al De immensa Dei misericordia per il suo scritto più celebre, il De amplitudine beati regni Dei, pubblicato nel 1554. -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- "VERA RELIGIO. Marsilio Ficino e la tradizione ebraica" (Guido Bartolucci). Note.13 aprile 2018, di Federico La Sala
Teologia
Guido Bartolucci (Paideia) analizza l’opera di uno dei maggiori esponenti del filone umanista fiorentino
E Marsilio Ficino recuperò la spiritualità ebraica
di Marco Rizzi (Corriere della Sera, 12.04.2018)
È ormai diventato un luogo comune l’affermazione secondo cui le radici della civiltà europea sarebbero, al tempo stesso, greco-latine, cristiane ed ebraiche.
È anche possibile individuare il momento preciso in cui si è costituita questa triplice eredità nella forma in cui ancora oggi la conosciamo. Essa è infatti il frutto della riscoperta, accanto a quella dei classici, della tradizione ebraica ad opera degli umanisti fiorentini del XV secolo, tra cui spicca il pensatore Marsilio Ficino. È costui, infatti, che per primo propone la conciliazione non solo tra la filosofia greca, specie quella platonica, e il cristianesimo, ma anche con il più antico strato della sapienza ebraica risalente ai patriarchi, che Ficino ritiene di ritrovare in alcuni elementi della qabbalah medievale.
L’interesse di Marsilio, osserva Guido Bartolucci nel libro Vera religio (Paideia), nasceva dal tentativo di ripensare la tradizione teologica e spirituale cristiana, di cui si avvertivano nitidamente i segni di una crisi destinata ad esplodere drammaticamente nel secolo successivo. Al momento, però, prevaleva ancora l’idea che un rinnovamento della Chiesa fosse possibile e che a questo fine la dimensione intellettuale potesse risultare decisiva.
Così, di lì a poco sarà Pico della Mirandola a sviluppare appieno l’idea di una originaria sapienza (la prisca theologia) di cui il cristianesimo rappresenta certo il culmine, ma cui a buon diritto appartengono anche ebraismo e classicità.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Guido Bartolucci, Vera religio Marsilio Ficino e la tradizione ebraica, Indice, Torino, Claudiana/Paideia, 2017, pp. 158, 32.00 EUR:
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE. Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale (...)
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGIFederico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- GERUSALEMME, LO SCOGLIO TEOLOGICO CONTRO CUI URTA LA POLITICA (Donatella Di Cesare).11 dicembre 2017, di Federico La Sala
PER LA PACE PERPETUA... *
Gerusalemme, città unica, indivisibile e inappropriabile
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, 11.12.2017)
Unica, indivisibile, inappropriabile, impossibile da capitalizzare, Gerusalemme è la città che si sottrae all’ordine degli Stati-nazione. Ne eccede la ripartizione, la trascende, la interdice. Contro questo scoglio, o meglio, contro questa rocca, sono naufragati tutti i tentativi che, in un’ottica statocentrica e nazionale, hanno mirato solo a frazionarla e segmentarla. Smacco della diplomazia e, ancor più, fallimento di una politica che procede con il metro e con il calcolo.
Gerusalemme non divide; al contrario, unisce. Ed è proprio questa unità la sfida che non è stata raccolta. Perché già da tempo avrebbe dovuto essere immaginata una nuova forma politica di governo capace di rispondere alla sovranità verticale di questa città straordinaria, di rispondere alla sua costitutiva apertura orizzontale.
Qui sta il punto della questione, ma nulla di ciò è avvenuto. Piuttosto si è fatta valere l’ipotesi, oramai sempre più lontana, di due Stati separati da confini incerti, precari, minacciosi.
Non sarebbe stata, non è, anzi, più saggia, seppure inedita, la via di due comunità confederate? Sono oramai molti a crederlo.
Città degli stranieri, culla dei monoteismi, residenza dell’Altro sulla terra, anche per i laici, Gerusalemme è quel luogo dell’ospitalità che resiste a una forzata e artificiosa spartizione.
Yerushalaim, capitale di Israele - chi potrebbe non riconoscerlo? - ma anche soglia che Israele è chiamato a oltrepassare. Come ha già fatto - è bene ricordarlo - con la libertà di culto. Ogni rivendicazione nazionalistica, da ambo le parti, è fuori luogo.
Qui dove si richiederebbero mitezza, prudenza, perspicacia, l’atto arrogante e fragoroso del trumpismo danneggia sia israeliani sia palestinesi. E tuttavia, proprio perché è lo scoglio teologico contro cui urta la politica, Gerusalemme può divenire modello extrastatale e banco di prova di future lungimiranti relazioni fra i popoli.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
- LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
 I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
I. BENITO MUSSOLINI E MARGHERITA SARFATTI - II. ARNALDO MUSSOLINI E MADDALENA SANTORO.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- La grazia e il perdono: l’essenza di Allah (di Pietro Citati).10 luglio 2017, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE....
- Nessuno nasce senza ombelico (antico prov. arabo).
La misericordia per i peccatori, spiegata nel Corano, avvicina il Dio dell’Islam a quello del cristianesimo
Perché l’essenza di Allah è nel perdono
Come dice il libro sacro: lui è “il Primo e l’Ultimo, il Manifesto e l’Occulto”
Non somiglia a niente. Eppure somiglia all’uomo e al mondo e questi gli assomigliano
di Pietro Citati (la Repubblica, 10.07.2017)
In nessuna religione, mai, l’unicità di Dio ha avuto un ruolo così intenso, violento ed esasperato come nell’Islam. “Non vi è divinità all’infuori di Dio”: vale a dire; “non vi è nulla che esiste all’infuori di Dio”. Come dice al-Ghazali (1058-1110), all’inizio del “Rinnovamento delle scienze religiose” (“Scritti scelti”, a cura di Laura Veccia Vaglieri e Roberto Rubinacci, Utet), “nella sua essenza egli è Uno senza socio, Singolo senza simile, Signore senza oppositore, Solo senza rivali, Eterno senza un prima, Perpetuo senza un principio, Perenne senza un ultimo, Sempiterno senza fine, Sussistente senza cessazione, Continuo senza interruzione”.
Allah è “il Primo e l’Ultimo, il Manifesto e l’Occulto”, dice il Corano. Non è un corpo con una forma, né una sostanza con limite e misura. Non è simile a cosa alcuna: misure non lo limitano, né lo contengono spazi. Egli è: non lo circoscrivono lati: non lo racchiudono terre né cieli; è seduto sul Trono senza contatto, assestamento, insediamento, dimora, spostamento. Egli non abita in cosa alcuna, né alcuna cosa abita in lui: è troppo elevato perché lo possano contenere luoghi, troppo puro perché lo possano limitare tempi; anzi Egli era prima di creare tempi e luoghi. Egli è l’Unico che non ha contrari, il Signore che non ha opposti, il Ricco che non ha bisogno, il Potente che fa ciò che vuole, il Sussistente, il Dominatore delle cose inerti, degli animali e delle piante, Colui che ha la grazia, la maestà, lo splendore e la perfezione. Se un uomo è rinchiuso nell’inferno, basta che egli conosca l’unicità di Dio perché lasci l’inferno. Come disse Maometto: “Chiunque dice: ‘non vi è Iddio se non Iddio, entrerà in Paradiso’”.
Nel suo bel libro L’esoterismo islamico (Adelphi), Alberto Ventura esplora Allah, senza cessare di paragonarlo alle figure divine nella Qabbalah, nel Tao, nella cultura indiana e in pseudo-Dionigi l’Areopagita. Non possiamo che implorare Allah: “O Dio, dice al-Ghazali, ti chiedo una grazia totale, una protezione continua, una misericordia completa, un’esistenza felice: ti chiedo beneficio perfetto e favore completo, generosità dolcissima, bontà affabile. O Dio sii con noi e non contro di noi. Attua largamente le nostre speranze, congiungi i nostri mattini e le nostre sere, versa in gran copia il tuo perdono sulle nostre colpe, accordaci il favore di correggere i nostri difetti, o Potente, o Perdonatore, o Generoso, o Sapiente, o Onnipotente. O Primo dei primi, o Ultimo degli ultimi, o più Misericordioso della misericordia”.
Al-Ghazali insegue tutti gli aspetti di Dio. Allah è oltre ogni nome e attributo, oltre ogni condizione e relazione, oltre tutte le apparenze e gli occultamenti, oltre ogni palesarsi e nascondersi, oltre ogni congiungimento e separazione, oltre tutte le contemplazioni e le intuizioni, oltre ogni cosa pensata e immaginata. Egli è oltre l’oltre, e poi oltre l’oltre, e poi ancora oltre l’oltre. Egli è il Principio infinito, incondizionato e immortale, che non può venire racchiuso entro i confini della ragione umana. È l’essere e il non-essere, il manifestato e il non manifestato, il suono e il silenzio. La sua immagine più adeguata è una notte tenebrosissima, nella quale non si può scorgere nulla di determinato e preciso.
Allah non somiglia a niente: nessuna cosa gli somiglia; la sua mano non somiglia alle altre mani, né la sua penna alle altre penne, né la sua parola alle altre parole, né la sua scrittura alle altre scritture. Eppure somiglia al mondo e all’uomo e il mondo e l’uomo gli assomigliano: “se non ci fossero le somiglianze, l’uomo non potrebbe elevarsi dalla conoscenza di sé stesso alla conoscenza del creatore”. Allah determina tutte le cose. Non avviene, nel mondo inferiore e in quello superiore, batter di ciglio, balenar di pensiero, subitaneo volgere di sguardo, se non per decreto, potere e volontà di Dio. Da lui proviene il male e il bene, l’utilità e il danno, l’Islam e la miscredenza, la conoscenza e la sconoscenza, il successo e la perdita, il vero e il falso, l’obbedienza e la disobbedienza, il politeismo e la fede. Anche il male - insiste al-Ghazali - e gli atti di ribellione umana non accadono per volontà di Satana ma di Dio. A volte egli proibisce ciò che vuole, e ordina ciò che non vuole. Non ha scopi, mentre gli uomini hanno scopi precisi. Desidera ciò che desidera senza alcun timore; e decide e fa quello che vuole, senza timore. Se ti fa perire, egli ha già fatto perire un numero infinito di tuoi simili e non ha smesso di tormentarli. “Sorveglia i tuoi respiri e i tuoi sguardi - dice al-Ghazali - e sta bene attento a non distrarti da Dio un solo istante”. A volte egli ci protegge da ogni tribolazione e malattia: ma egli non ha mai, in nessun momento, obblighi verso di noi o verso il mondo, di cui non ha assolutamente bisogno.
Come diceva Ali Bakr, la nostra assoluta incapacità di comprendere Dio è il nostro modo supremo di comprenderlo: sapere che noi siamo esclusi da lui è la nostra vera vicinanza. “Lode a colui che ha stabilito per le creature una via alla sua comprensione attraverso l’incapacità di comprenderlo”. Quando Dio entra nel cuore umano, la luce vi risplende, il petto si allarga, scopriamo il mistero del mondo, la grazia della misericordia cancella il velo dell’errore, e brilla in noi la realtà delle cose divine. Il cuore ripete il nome di Dio, fino a quando la lingua lo pronuncia incessantemente, senza essere comandata. Da principio è un rapido baleno che non permane, poi ritorna, si ritira, passa, ritorna. Tuttavia nemmeno in questo istante esiste in al-Ghazali quella identificazione con Dio, che altri mistici islamici (come al-Hal- laj) esperimentano e di cui parlano inebriati.
Al-Ghazali preferisce parlare di annientamento dell’uomo: anzi di annientamento dell’annientamento, “perché il fedele si è annientato rispetto a sé stesso, e si è annientato rispetto al proprio annientamento: in quello stato egli è incosciente di sé stesso e incosciente della propria incoscienza”. Rispetto al Principio supremo, ogni elemento della realtà, se viene considerato in sé e per sé, è quasi insignificante, quasi illusorio, quasi un puro nulla. Ma al tempo stesso esso è significante perché è capace di riflettere l’Assoluto increato. Allora il molteplice manifesta l’essenza, e il passaggio dal molteplice all’uno e dall’uno al molteplice è istantaneo. Così il mare, dice Ibn Arabi, si moltiplica nella forma delle onde, pur rimanendo sé stesso. Dio è altro rispetto alle cose: ma non così altro da escludere ogni somiglianza; dunque è insieme altro e simile. Se qualcuno dicesse: “non conosco che Dio eccelso” direbbe la verità; ma se dicesse “non conosco Dio eccelso”, direbbe ugualmente il vero. Questa - sottolinea Alberto Ventura - è la profonda doppiezza, ambiguità e ricchezza della vita e della cultura islamica.
Quando l’intelletto umano è libero dagli inganni della fantasia e dell’immaginazione, esso può vedere le cose come sono. È quella che al-Ghazali chiama la condizione profetica: nella quale rifulgono le tavole dell’invisibile, le leggi dell’Altra vita, le conoscenze su Dio che vanno oltre la portata dello spirito intellettivo. Dio dunque si può vedere. Ci sono persone che vedono le cose tramite lui, e altre che vedono le cose e tramite le cose vedono lui. I primi hanno una visione diretta di Dio: i secondi lo deducono dalle sue opere; i primi appartengono alla categoria dei giusti, i secondi a quella dei sapienti. Talvolta Dio si manifesta così intensamente e in modo così esorbitante, che viene occultato. Come dice il Corano, Dio è nascosto dietro settanta (o settecento o settemila) veli di luce e di tenebra: se egli li rimuovesse, il suo sublime splendore brucerebbe chiunque sia giunto vicino a lui con lo sguardo. Dio si nasconde dietro sé stesso. La sua luce è il suo velo.
Secondo una tradizione raccontata dal Al-Ghazali, Dio ha detto: “Se il mio servo commette un peccato grande come la terra, io lo accolgo con un perdono grande come la terra”. Quando l’uomo pecca, l’angelo tiene sollevata la penna per sei ore: se l’uomo si pente e chiede perdono, l’angelo non registra il peccato a suo carico; se continua a peccare, registra il suo peccato soltanto come una cattiva azione. Dio non si stanca di perdonare finché il suo servo non si stanca di chieder perdono. Se il fedele si propone una buona azione, l’angelo la segna prima che egli l’abbia compiuta e, se la compie, gliene vengono registrate dieci. Quindi Dio la moltiplica fino a settecento volte.
Allah perdona sopratutto i grandi peccatori. Come dice Maometto: “Io ho la facoltà di intercedere per i grandi peccatori. Credi forse che userei questa facoltà per gli uomini obbedienti e timorati? No, essa riguarda soltanto gli insozzati dalla mente confusa”. Ibrahim, figlio di un emiro della Battriana, racconta: “Mentre una volta giravo intorno alla Ka’ba, in una notte piovigginosa e scura, mi fermai presso la porta e dissi: ‘mio Signore preservami dal peccato, affinché mai io mi ribelli a Te’. Una voce proveniente dalla Ka’ba mi sussurrò: ‘O Ibrahim mi chiedi di preservarti dal peccato e tutti i miei servi mi chiedono questo. Se io preservassi te e loro dal peccato, su cosa riverserei la mia grazia e chi perdonerei?’”. Il perdono di Dio: sia per gli islamici sia per i cristiani, questa è l’essenza della rivelazione di Allah.
-
>NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! -- “La tecnica corre troppo e ci cambierà l’anima”. Parla Monsignor Ravasi (di Elena Dusi).25 giugno 2017, di Federico La Sala
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
IL COLLOQUIO. Parla Monsignor Ravasi: fede e scienza devono allearsi per battere la superficialità del momento
“La tecnica corre troppo e ci cambierà l’anima”
di Elena Dusi (la Repubblica, 25.06.2017)
ROMA. «La tecnologia corre e ci propone nuovi mezzi con una velocità che la teologia e gli altri canali della conoscenza umana non riescono a seguire». Il cardinale Gianfranco Ravasi, 74 anni, teologo, biblista, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, non è però uomo che si dia per vinto. Con il “Cortile dei Gentili” e il “Tavolo permanente per il dialogo fra scienza e religione” sta cercando “alleati” fra coloro che hanno ancora fiducia nell’uomo e nel suo pensiero. «Atei, scienziati, persino chi ancora crede nelle ideologie. Non è più tempo di contrapposizioni ma di dialogo». Nell’ultimo incontro del “Tavolo” si è parlato di intelligenza artificiale e del rapporto fra umani e umanoidi.
Perché questo dialogo fra fede e scienza?
«Religione e scienza sono spesso considerati magisteri indipendenti, due rette parallele. E dal punto di vista del metodo è giusto che sia così. Ma condividono lo stesso soggetto e lo stesso oggetto. Non possono non incontrarsi, prima o poi».
Scienza e fede sono due tonalità di una stessa musica?
«La conoscenza del mondo da parte dell’uomo avviene attraverso molti canali: la scienza e la razionalità, ma anche la teologia, l’estetica, l’amore, l’arte, il gioco, il simbolismo, che è poi il primo modo di conoscere che abbiamo da bambini. Perderli o semplificarli vuol dire impoverirsi. E purtroppo è quello che sta avvenendo oggi».
Per colpa della scienza?
«No, per colpa dell’ignoranza. Stiamo vivendo una globalizzazione della cultura contemporanea dominata solo dalla tecnica o dalla pura pratica. C’è, ad esempio, una sovrapproduzione di gadget tecnologici di fronte alla quale non riusciamo a elaborare un atteggiamento critico equilibrato. Ci ritroviamo in un’epoca di bulimia dei mezzi e atrofia dei fini. La formazione scolastica e universitaria si occupa troppo poco degli aspetti relativi all’antropologia generale. Così, l’insegnamento di arte, letteratura, greco e latino, filosofia viene progressivamente ridotto».
Con quali conseguenze?
«Ci ritroviamo spesso appiattiti, schiacciati su un’unica dimensione. Un certo uso della scienza e della tecnologia hanno prodotto in noi un cambiamento che non è solo di superficie. Se imparo a creare robot con qualità umane molto marcate, se sviluppo un’intelligenza artificiale, se intervengo in maniera sostanziale sul sistema nervoso, non sto solo facendo un grande passo avanti tecnologico, in molti casi prezioso a livello terapeutico medico. Sto compiendo anche un vero e proprio salto antropologico, che tocca questioni come libertà, responsabilità, colpa, coscienza e se vogliamo anima».
La scienza corre troppo?
«Non tanto la scienza, quanto la tecnologia: corre e ci propone nuovi mezzi con una velocità che la teologia e gli altri canali della conoscenza umana non riescono a seguire. Per questa via si può finire in una civiltà mediatica e digitale che sta diventando totalizzante. Parliamo di transumanesimo come una delle paure del futuro, ma per certi versi è già iniziato. I nativi digitali sono funzionalmente diversi rispetto agli uomini del passato. Capovolgono spesso sia il rapporto fra reale e virtuale, sia il modo tradizionale di considerare vero e falso. È come se si ritrovassero dentro a un videogioco. Inoltre, l’uomo, che è sempre stato un contemplatore e custode della natura, oggi è diventato una sorta di con-creatore. La biologia sintetica, la creazione di virus e batteri che in natura non esistono sono un’espressione di questa tendenza. Tutte queste operazioni hanno implicazioni etiche e culturali che devono essere considerate».
Scienza e fede come possono collaborare?
«Fra spiritualità e razionalità, tra fede e scienza, può instaurarsi una tensione creativa. Diceva Giovanni Paolo II che la scienza purifica la religione dalla superstizione e la religione purifica la scienza dall’idolatria e dai falsi assoluti».
L’ecologia è un altro terreno di incontro?
«Gli accordi di Parigi sono ora in difficoltà. Anche molti “laici” si riconoscono invece nella Laudato si’ di papa Francesco, che mi pare stia diventando il punto di riferimento della questione ecologica. D’altronde è scritto nei primi passi della Genesi che Dio ha affidato la Terra all’uomo per “coltivarla” ma anche per “custodirla”».
I suoi incontri con i laici ormai proseguono da qualche anno. Qual è il suo bilancio?
«Il fondatore del cristianesimo, Gesù di Nazaret, era un laico, non un sacerdote ebraico. Egli non ha esitato a formulare un principio capitale: “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. La contrapposizione fra clericali e anticlericali ormai è sorpassata. Alcuni aspetti della laicità ci accomunano tutti e la teologia ha smesso da tempo di considerare la filosofia e la scienza solo come sue ancelle. I problemi piuttosto sono altri. Semplificazione, indifferenza, banalità, superficialità, stereotipi, luoghi comuni.
 Una metafora del filosofo Kierkegaard mi sembra adatta ai tempi di oggi: la nave è finita in mano al cuoco di bordo e ciò che dice il comandante con il suo megafono non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. È indispensabile riproporre da parte di credenti e non credenti, i grandi valori culturali, spirituali, etici come shock positivo contro la superficialità ora che stiamo vivendo una svolta antropologica e culturale complessa e problematica, ma sicuramente anche esaltante».
Una metafora del filosofo Kierkegaard mi sembra adatta ai tempi di oggi: la nave è finita in mano al cuoco di bordo e ciò che dice il comandante con il suo megafono non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. È indispensabile riproporre da parte di credenti e non credenti, i grandi valori culturali, spirituali, etici come shock positivo contro la superficialità ora che stiamo vivendo una svolta antropologica e culturale complessa e problematica, ma sicuramente anche esaltante». -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- Migrazioni e metamorfosi di un racconto tra Oriente e Occidente. L’assenza luogo di rivelazione (di Marco Vannini).24 giugno 2017, di Federico La Sala
- PER BOCCACCIO, NEL 2013, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!! Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico. Materiali sul tema
SCHEDA EDITORIALEEDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA *
Roberto Celada Ballanti
La parabola dei tre anelli
Migrazioni e metamorfosi di un racconto tra Oriente e Occidente
Dalla più antica redazione conosciuta, la parabola della perla caduta nella notte, contenuta in un dialogo tra Timoteo I e al-Mahdī nella Baghdad del secolo VIII, alla terza novella della prima giornata del Decameron, fino al dramma teatrale illuminista Nathan il Saggio di Lessing, i racconti degli anelli, migrando tra Oriente e Occidente, trasformandosi, varcando confini identitari, ridisegnando mappe geopolitiche, schiudono nelle religioni del Libro - Ebraismo, Cristianesimo, Islam - un elemento di perturbante problematicità.
 Si tratta della ‘lacuna’ segnata dall’anello autentico confuso tra copie fatte forgiare da un buon padre - così nella versione di Boccaccio - per non mortificare nessuno dei tre figli, ugualmente amati, il cui esito è l’indistinguibilità del gioiello originale, il dubbio su chi lo possegga e sul luogo in cui rinvenirlo. È il ‘vuoto’ che, sospendendo la pretesa di un’origine esclusiva, ricorda alle religioni la vanità di ogni chiusura e intolleranza.
Si tratta della ‘lacuna’ segnata dall’anello autentico confuso tra copie fatte forgiare da un buon padre - così nella versione di Boccaccio - per non mortificare nessuno dei tre figli, ugualmente amati, il cui esito è l’indistinguibilità del gioiello originale, il dubbio su chi lo possegga e sul luogo in cui rinvenirlo. È il ‘vuoto’ che, sospendendo la pretesa di un’origine esclusiva, ricorda alle religioni la vanità di ogni chiusura e intolleranza.- Vedi: Indice
Recensioni:
 l’Osservatore Romano, 16 giugno 2017, L’assenza luogo di rivelazione, di Marco Vannini;
l’Osservatore Romano, 16 giugno 2017, L’assenza luogo di rivelazione, di Marco Vannini; L’Espresso blog, 20 giugno 2017, Boccaccio maestro di rispetto tra religioni, di Angiola Codacci Pisanelli.
L’Espresso blog, 20 giugno 2017, Boccaccio maestro di rispetto tra religioni, di Angiola Codacci Pisanelli.* Edizioni di Storia e Letteratura (RIPRESA PARZIALE).
L’assenza luogo di rivelazione
di Marco Vannini (l’Osservatore Romano, 16 giugno 2017)
Per le romane Edizioni di Storia e Letteratura è appena uscito un prezioso volume La parabola dei tre anelli. Migrazioni e metamorfosi di un racconto tra Oriente e Occidente (Roma, 2017, pagine 254, euro 18). Ne è autore Roberto Celada Ballanti, professore di filosofia della religione e filosofia del dialogo interreligioso presso l’università di Genova, al quale si devono, tra l’altro, importanti studi su Leibniz, su Jaspers, sul pensiero religioso liberale.
 Al lettore italiano quella che giustamente viene qui definita “parabola” è nota attraverso la versione del Decamerone, dove compare come Novella di tre anelli. Che essa avesse già nel Boccaccio il carattere religioso di parabola, è però chiaro anche dalla sua collocazione, terza della prima giornata, dopo le due altrettanto “religiose” novelle di ser Ciappelletto e di Abraham giudeo.
Al lettore italiano quella che giustamente viene qui definita “parabola” è nota attraverso la versione del Decamerone, dove compare come Novella di tre anelli. Che essa avesse già nel Boccaccio il carattere religioso di parabola, è però chiaro anche dalla sua collocazione, terza della prima giornata, dopo le due altrettanto “religiose” novelle di ser Ciappelletto e di Abraham giudeo.- Un barcone carico di migranti nelle acque del Mediterraneo
Il primo, per salvare da sicura rovina i compatrioti che lo ospitano, non fa conto della sorte dell’anima sua, nella certezza che, avendo «tante ingiurie fatte a Domenedio, per farnegli io una ora in su la mia morte, ne più né meno ne farà», ovvero non gli aggraverà il conto dei peccati, giacché giudica secondo lo spirito e non secondo le misure umane. Il secondo, vedendo la corruzione della corte papale e la Chiesa come una «fucina di diaboliche operazioni piuttosto che di divine», deduce che lo Spirito santo deve davvero esser fondamento e sostegno della religione cristiana, che sarebbe altrimenti scomparsa.
Questo messaggio di una religiosità vera, non legata alla lettera ma allo spirito, si conferma e si esplicita proprio nella Novella dei tre anelli, ove “Melchisedech giudeo”, interrogato a tranello dal Saladino su quale fosse la religione vera, «la giudaica, la saracina o la cristiana», racconta di quel padre che, avendo tre figli ugualmente amati e un anello prezioso, ne fa fare due copie identiche all’originale, dando a ciascuno dei figli un anello, ragion per cui, alla sua morte, ciascuno di essi pretende di essere in possesso dell’anello vero, ma senza che la questione possa essere risolta.
 E così è, conclude Melchisedek, per le tre religioni: ciascuna pretende che la sua legge sia la vera, data da Dio Padre, «ma chi se l’abbia, come degli anelli, ancora ne pende la quistione». Melchisedek è un nome scelto non a caso: rimanda al biblico re di Salem, «senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita [...] sacerdote in eterno» (Ebrei 7), figura di Cristo e di un cristianesimo ancora precedente all’ebraismo. V’è infatti nella novella del Decameron qualcosa di ben più importante di un generico appello a una tolleranza religiosa frutto del relativismo e dell’agnosticismo, - la tolleranza in versione mercantile, quella sostenuta ad esempio da Voltaire, che invita a entrare nella Borsa di Londra nella quale «l’ebreo, il maomettano e il cristiano trattano l’uno con l’altro come se fossero della stessa religione, e danno il nome di infedeli solo a quelli che fanno bancarotta».
E così è, conclude Melchisedek, per le tre religioni: ciascuna pretende che la sua legge sia la vera, data da Dio Padre, «ma chi se l’abbia, come degli anelli, ancora ne pende la quistione». Melchisedek è un nome scelto non a caso: rimanda al biblico re di Salem, «senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita [...] sacerdote in eterno» (Ebrei 7), figura di Cristo e di un cristianesimo ancora precedente all’ebraismo. V’è infatti nella novella del Decameron qualcosa di ben più importante di un generico appello a una tolleranza religiosa frutto del relativismo e dell’agnosticismo, - la tolleranza in versione mercantile, quella sostenuta ad esempio da Voltaire, che invita a entrare nella Borsa di Londra nella quale «l’ebreo, il maomettano e il cristiano trattano l’uno con l’altro come se fossero della stessa religione, e danno il nome di infedeli solo a quelli che fanno bancarotta».No, v’è qui il rimando a una verità che trascende le pretese dogmatiche dei singoli, una veritas che può esprimersi nella varietas, e che chiama non solo alla tolleranza, ma anche alla fratellanza, all’amicizia tra gli uomini. «La tolleranza dovrebbe in verità essere solo un sentimento provvisorio: essa deve portare al riconoscimento. Tollerare significa offendere”» scriveva non caso Goethe. Questo riconoscimento, con l’amicizia, appunto, che finisce per legare Saladino e Melchisedek, è la cifra anche dell’ultimo testo analizzato nel libro in oggetto, quello in cui più scopertamente il messaggio implicito nella novella viene alla luce: il dramma di Lessing Nathan il saggio.
Nato esplicitamente nell’ambito di una polemica che oppose l’illuminista tedesco a un pastore protestante geloso custode del letteralismo biblico, l’opera di Lessing ( 1779 ) ripropone la storia dei tre anelli riallacciandosi al Decamerone. L’ ebreo Nathan (nome del profeta che rimprovera a David il suo omicidio e adulterio) la racconta anch’egli al Saladino, e ne fa scaturire un messaggio di amore, ove ciascuno dei tre fratelli deve fare a gara per dimostrare il possesso dell’anello vero «con la dolcezza, con indomita pazienza e carità, e con profonda devozione a Dio».
La versione di Lessing è solo l’ultimo esito delle “migrazioni e metamorfosi” di un racconto la cui storia l’autore descrive, con straordinaria erudizione e capacità di coinvolgimento, a partire da un testo siriaco cristiano dell’viii secolo, per passare attraverso la cultura medievale ebraica veronese, quella multietnica della Andalusia musulmana, tornando infine nel mondo cristiano, ai repertori dei predicatori e alle redazioni apologetiche della novella, le cui diverse versioni presentano variazioni anche significative, ma che ne lasciano comunque intatta la sostanza.
Oltre all’insegnamento più evidente di questa affascinante storia, Celada Ballanti ne mostra però un altro, religiosamente ancora più profondo. Prendendo lo spunto dalle parole di Clarisse ne L’uomo senza qualità di Musil : - «l’anello nel centro non ha nulla, eppure sembra che per lui sia proprio il centro che contà!» - si può rilevare infatti come la parabola inviti a volgere lo sguardo non tanto a un’essenza, quanto a un’ assenza.
L’anello è infatti un cerchio che racchiude un vuoto, e proprio un vuoto, un’assenza, può essere il più autentico locus revelationis, il “luogo” ove si rivela il Dio nascosto. Allora il non-sapere dei tre fratelli, e di tutti gli uomini insieme, passa dalla condizione di mera ignoranza a quella di docta ignorantia, nel senso mistico che fu di Agostino e di Niccolò Cusano.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- IL MONOTEISMO E LA RAGIONE OSCURATA DALLA «GUIDA SUPREMA».11 giugno 2017, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
La ragione oscurata dalla «guida suprema»
Islam. Un’intervista con Hamed Abdel-Samad, autore di «Fascismo islamico», pubblicato da Garzanti
di Guido Caldiron (il manifesto, 10.06.2017)
Hamed Abdel-Samad è un uomo in guerra. Si muove scortato da guardie del corpo, riceve costanti minacce e il suo nome è oggetto di una fatwa e di un’accusa di «eresia» da parte dei religiosi di al Azhar. Quando, lo scorso anno, insieme alla giornalista Nazan Gökdemir ha realizzato per la tv pubblica tedesca Zdf l’inchiesta I musulmani d’Europa si è visto chiudere più di una porta in faccia. E questo malgrado il suo lavoro di studioso sia apprezzato da figure di rilievo dell’Islam europeo come l’islamologo Bassam Tibi e l’ex imam di Marsiglia, Soheib Bensheikh.
Quarantacinque anni, nato a Giza, non lontano dal Cairo, figlio di un noto imam e lui stesso cresciuto negli ambienti dei Fratelli Musulmani, Abdel-Samad vive in Germania da vent’anni dove si è fatto conoscere per il suo lavoro di politologo all’università di Monaco e dove ha acquisito grande notorietà per quella che considera come una sorta di battaglia esistenziale in nome di un «illuminismo arabo» contrapposto sia all’islamismo politico che all’«oscurantismo religioso» musulmano. Tesi ribadite nel suo libro più noto e polemico, Fascismo islamico, Garzanti (pp. 224, euro 16).
Fin dal titolo, il suo libro è stato percepito in molti ambienti musulmani come una provocazione, cosa l’ha spinta a scriverlo?
Mi sono formato attraverso lo studio dell’Islam e delle culture politiche che vi sono legate. Perciò mi ero già accorto di come buona parte degli studiosi occidentali considerino la relazione tra fede e politica in ambito musulmano, ed in modo particolare l’islamismo, come un fenomeno nuovo, sorto soltanto in reazione al colonialismo e che non avrebbe avuto alcuna genesi specifica e autonoma. È una grave semplificazione che rende poco comprensibile quanto accade oggi e perciò ho deciso di analizzarne le radici ideologiche e il modo in cui si è andato definendo nel corso del tempo, a partire dalle similitudini sinistre che sono emerse all’inizio del Novecento tra l’Islam politico e i fascismi europei.
Lei si concentra sulla nascita dei Fratelli Musulmani nell’Egitto degli anni Venti. I punti di contatto tra costoro e i fascisti non vanno però letti anche come una conseguenza del fatto che la democrazia inglese, erano all’origine del dominio coloniale al Cairo?
Una lettura di questa vicenda all’insegna di un’alleanza tattica con «il nemico del mio nemico» spiega solo superficialmente le cose. Fin dalla fondazione dei Fratelli Musulmani nel 1928, il loro leader, Hassan al-Banna dava più importanza al fatto che fossero banditi tutti gli altri partiti, tranne «quello di Allah» che non alla democratizzazione del paese o alla lotta per l’indipendenza. Quanto alle similitudini con il fascismo, appaiono a più livelli. Mi riferisco ad una visione del mondo che si basa sul fatto di considerare i musulmani superiori al resto dell’umanità, un po’ come avviene per il «mito ariano» dei nazisti.
 In entrambi i casi, i nemici sono disumanizzati, paragonati alle bestie, soprattutto gli ebrei, mentre la guerra e la morte sul campo di battaglia, o nella jihad, costituiscono il cuore dell’identità del movimento che si muove nella prospettiva di dominare il mondo con ogni mezzo e, nel frattempo, di ripristinare un rigido ritorno ai ruoli sociali e di genere tradizionali.
In entrambi i casi, i nemici sono disumanizzati, paragonati alle bestie, soprattutto gli ebrei, mentre la guerra e la morte sul campo di battaglia, o nella jihad, costituiscono il cuore dell’identità del movimento che si muove nella prospettiva di dominare il mondo con ogni mezzo e, nel frattempo, di ripristinare un rigido ritorno ai ruoli sociali e di genere tradizionali.
 Infine, al vertice c’è una «guida suprema», o un «duce» che traduce certezze metafisiche a beneficio delle masse. A tutto ciò, si può poi aggiungere che al-Banna scrisse pagine di ammirazione per Hitler e Mussolini e fu molto vicino al Gran muftì di Gerusalemme, Amin Al Husseini, tra i principali collaborazionisti arabi. Il problema è che le idee dei Fratelli Musulmani sono all’origine sia dei partiti islamisti contemporanei che di gruppi terroristici come Al Qaeda e l’Isis.
Infine, al vertice c’è una «guida suprema», o un «duce» che traduce certezze metafisiche a beneficio delle masse. A tutto ciò, si può poi aggiungere che al-Banna scrisse pagine di ammirazione per Hitler e Mussolini e fu molto vicino al Gran muftì di Gerusalemme, Amin Al Husseini, tra i principali collaborazionisti arabi. Il problema è che le idee dei Fratelli Musulmani sono all’origine sia dei partiti islamisti contemporanei che di gruppi terroristici come Al Qaeda e l’Isis.Dopo aver definito «il fascismo» come «un lontano cugino del monoteismo», lei spiega che nel mondo musulmano i consensi per gli islamisti traggono origine da una lunga tradizione di oscurantismo religioso consolidatasi nei secoli. Perciò, il suo lavoro a chi si rivolge?
Sono cresciuto nella fede, ma non faccio appello né alla cosiddetta «comunità dei credenti», né ai musulmani in quanto tali. Mi rivolgo ai singoli e alle loro coscienze. Di fronte alla minaccia incarnata da chi giustifica i propri orrori e il proprio dominio evocando «la parola di Dio», il Corano, è sul pensiero e gli sforzi individuali che possiamo ancora puntare per cambiare le cose.
Anche chi parla di una possibile «riforma» dell’Islam si inganna: la fede deve trasferirsi nella sfera privata di chi fa questa scelta e smetterla di voler dettare legge nella vita pubblica, sui corpi e le persone. Solo allora la minaccia che incombe su tutti noi potrà essere sconfitta davvero.
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> I TRE ANELLI, NATHAN IL SAGGIO, eLA CHIESA ’CATTOLICA’! --- DUE SOLI, DUE CHIAVI, E IL CAPO DEI CLAVIGERI DEI MUSEI DELLA SANTA SEDE.30 gennaio 2017, di Federico La Sala
"Due chiavi" e il capo dei clavigeri
 "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
- DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
L’uomo che apre le porte dei capolavori vaticani: “Ho le chiavi del paradiso”
Gianni Crea è il capo dei clavigeri dei musei della Santa sede. "Ogni mattina, quando entro nella Cappella Sistina, mi sento un privilegiato"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 gennaio 2017)
CITTÀ DEL VATICANO. "L’alba è il momento più magico. Entro nel bunker che custodisce le 2797 chiavi dei musei vaticani. Quando non ci sono gli addetti della sagrestia pontificia, tocca a me prelevare l’unica chiave che non ha numero né copie. È un modello antico come la porta che apre, quella della Cappella Sistina. Giro la serratura della Cappella, quella stessa che sigilla i cardinali in conclave, per pochi istanti mi sento investito da una meraviglia che non è facile spiegare. M’inginocchio, mi segno, e dico una preghiera in solitudine. Chiedo che tutti i visitatori che di lì a poco entreranno possano provare il medesimo stupore. Sono un privilegiato, ne sono consapevole. E so che di questo privilegio devo esserne sempre degno".
Gianni Crea, 45 anni, romano ma originario di Melito di Porto Salvo, in provincia diReggio Calabria, è capo clavigero dei musei vaticani. In sostanza, ha il compito di aprire e chiudere tutte le porte e le finestre, 500 in tutto, 300 del percorso dei visitatori e 200 dei vari laboratori collegati. A vent’anni il parroco della chiesa che frequentava sulla via Appia gli chiese se voleva lavorare nella basilica vaticana come custode ausiliario. La Fabbrica di San Pietro in cambio avrebbe contribuito ai suoi studi. Accettò.
Qualche anno dopo, giovane studente di giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato, partecipò a un concorso per diventare a tutti gli effetti custode. Per un anno lo osservarono, per valutare se fosse idoneo: puntualità, discrezione e serietà le principali doti richieste. Venne preso: "Da adesso - gli dissero - devi sempre ricordare dove ti trovi. Lavori nel centro della cristianità. I dieci comandamenti devono diventare il tuo secondo vestito". Una richiesta "non da poco", dice. "Tuttavia sono contento di non disattenderla".
Più immaginifica fu, invece, la consegna che gli fece Antonio Paolucci, fino a poche settimane fa direttore dei musei, quando da semplice clavigero venne nominato capo. "Adesso sei tu ad avere simbolicamente in mano le porte del Paradiso", gli disse per fargli comprendere la responsabilità a cui era chiamato. Con lui, infatti, collaborano altri dieci clavigeri che si dividono il lavoro in due turni, una metà dalle 5.30 del mattino alle due del pomeriggio. Gli altri fino a sera tardi. "Da quel momento il Vaticano è diventata la mia seconda casa - dice - Conosco le chiavi come le mie tasche. Ogni porta apre un mondo per me e per tutti i clavigeri familiare. Dietro ogni porta c’è un odore particolare, un profumo, riconoscibile soltanto da noi".
L’apertura e la chiusura di porte e finestre sono momenti entrambi delicati. Alle 5.30 la Gendarmeria di Porta Sant’Anna toglie l’allarme e il clavigero di turno procede con un lungo giro che dura quasi un’ora e mezzo. Dopo ogni apertura c’è il controllo che ogni cosa sia in ordine. "Se ad esempio si rompe un tubo dell’acqua - racconta - spesso tocca a me chiamare l’idraulico". Negli ultimi anni i visitatori dei musei sono parecchio aumentati, 28mila le sole presenze giornaliere in Sistina. Tutto deve essere perfetto. "Ma anche la chiusura non è facile. Bisogna controllare che nessuno rimanga all’interno. Gli imprevisti sono sempre possibili. Una sera chiudemmo tutto e di colpo suonò l’allarme. Accorremmo nella stanza nella quale veniva segnalata una presenza. Per fortuna era soltanto un passerotto rimasto dentro".
Il clavigero è l’erede delle chiavi del Maresciallo del Conclave, colui che fino al 1966 doveva sigillare le porte intorno alla Cappella quando i cardinali si riunivano per eleggere il Pontefice. La sua chiave non è l’unica a essere preziosa: c’è, ad esempio, la chiave numero 1, quella che apre il portone monumentale su viale Vaticano, che oggi è il portone d’uscita dei visitatori dei musei.
 E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera...
E poi c’è la 401, una delle più antiche: apre il portone d’entrata dei musei e pesa mezzo chilo. "Due chiavi decussate, cioè incrociate a X, appaiono negli stemmi ed emblemi dei papi - scrive Tiziana Lupi su "Il mio Papa" - Sono una d’oro (potere spirituale) e una d’argento (potere temporale); hanno i congegni traforati a croce e sono unite da un cordone, simbolo del legame tra i due poteri ". I musei sono divisi in quattro aree. Ad ogni area corrispondono dei numeri a cui le chiavi si riferiscono. Le chiavi con il numero 100 sono del museo etnologico, quelle col 200 sono del Gregoriano, eccetera..."La gioia più grande in questi anni - dice ancora Crea - l’ho avuta pochi anni fa. Prima che morisse mia madre ha potuto assistere a una messa del mattino a Casa Santa Marta. Ha ricevuto una carezza dal Papa. Un piccolo gesto che per me ha significato molto".
-
> I TRE ANELLI. NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- Logos e trascendenza nell’Islam, dopo il Discorso di Ratisbona (di M. campanini - Il Cortile dei Gentili)23 maggio 2016, di Federico La Sala
- Per l’inizio del dialogo, quello vero (B. Spinelli)
 ITALIA E PAKISTAN: LA DIVINA COMMEDIA (Dante Alighieri) E IL POEMA CELESTE (Muhammad Iqbal). Ri-leggiamo insieme... le due opere e i due Autori!
ITALIA E PAKISTAN: LA DIVINA COMMEDIA (Dante Alighieri) E IL POEMA CELESTE (Muhammad Iqbal). Ri-leggiamo insieme... le due opere e i due Autori!
- IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. PENSARE UN ALTRO ABRAMO.
- "GIUSEPPE", L’ANELLO DI CONGIUNZIONE DEI "TRE" MONOTEISMI. Un importante studio di Massimo Campanini sul patriarca d’Israele e sul profeta del Corano. A quando la ri-considerazione e il riconoscimento da parte della Chiesa cattolica dell’altro Giuseppe, quello ev-angelico?! Freud e Pirandello aspettano ancora
Logos e trascendenza nell’Islam, dopo il Discorso di Ratisbona
di Massimo Campanini*.
Cristianesimo e Islam sono religioni che derivano dal medesimo ceppo abramitico. Condividono molti concetti teologici e religiosi, ma anche si differenziano in molti altri. Il confronto comparativo tra le due teologie è un esercizio ermeneutico mai abbastanza praticato. Il controverso discorso di papa Benedetto XVI a Regensburg nel 2006, di cui appunto nel 2016 ricorre il decennale, ha vigorosamente sostenuto la fondazione della teologia cristiana nel Logos, mentre al riguardo l’Islam professa un approccio sostanzialmente divergente, nonostante alcune convergenze. Questo articolo è dedicato a puntualizzare criticamente questa osservazione. Partiamo col considerare un paio di premesse.
La frattura del monoteismo rispetto alle religioni del mondo antico, soprattutto mediterraneo, è consistita in almeno due elementi qualificanti. In primo luogo, nella rivelazione di un Dio persona, liberamente agente e volente, che conferisce all’universo le sue leggi di funzionamento e dirige la storia verso un fine teleologico. In secondo luogo, nel proporre il messaggio religioso attraverso l’invio di profeti, apportatori di libri rivelati.
 L’Islam, ultimo in ordine cronologico dei tre monoteismi, conferma e riafferma comunque questi due pilastri teologici fondativi, ma per quanto riguarda Dio, ne accentua il carattere di sovrano del mondo (Dio è sia malik cioè re, sia mālik cioè padrone dell’universo) e il carattere della trascendenza (tanzīh).
L’Islam, ultimo in ordine cronologico dei tre monoteismi, conferma e riafferma comunque questi due pilastri teologici fondativi, ma per quanto riguarda Dio, ne accentua il carattere di sovrano del mondo (Dio è sia malik cioè re, sia mālik cioè padrone dell’universo) e il carattere della trascendenza (tanzīh).
 Per quanto riguarda la profezia, l’Islam, come l’Ebraismo e il Cristianesimo, riconosce sostanzialmente al profeta un ruolo di testimonianza, di annunciazione di (liete) novelle, di ammonizione. In tal senso, si tratta di una funzione eminentemente dialogica e non è un caso - relativamente all’Islam - che un filosofo come al-Farabi abbia individuato realizzata nel profeta la massima perfezione della facoltà immaginativa utile a persuadere e a guidare le masse. Naturalmente, nell’Ebraismo e nell’Islam il profeta può essere anche apportatore della Legge, qualifica che nel Cristianesimo è andata perduta.
Per quanto riguarda la profezia, l’Islam, come l’Ebraismo e il Cristianesimo, riconosce sostanzialmente al profeta un ruolo di testimonianza, di annunciazione di (liete) novelle, di ammonizione. In tal senso, si tratta di una funzione eminentemente dialogica e non è un caso - relativamente all’Islam - che un filosofo come al-Farabi abbia individuato realizzata nel profeta la massima perfezione della facoltà immaginativa utile a persuadere e a guidare le masse. Naturalmente, nell’Ebraismo e nell’Islam il profeta può essere anche apportatore della Legge, qualifica che nel Cristianesimo è andata perduta.Quanto al concetto di Logos, prima di essere assimilato dalla teologia cristiana, a partire dal famoso incipit del Vangelo di Giovanni, esso è stato formulato nell’ambito della filosofia greca. Anassagora ed Eraclito hanno teorizzato il Nous (o intelletto) e il Logos come principi di ordinamento e organizzazione della realtà cosmica. Socrate ha enfatizzato il carattere dialogico del Logos come strumento di comunicazione, ma anche di educazione degli uomini. Anche Platone ha posto il Logos al centro della sua filosofia, come dialogo umano, nella pluralità delle opinioni e delle idee che si confrontano nell’arena filosofica in uno stile di pensiero aperto e flessibile. Il concetto greco di Logos sembra perciò intersecare aspetti antropologici con aspetti cosmici relativi a una potenziale “mente” o ratio che governa il reale.
Stabilite queste premesse, un discorso comparativo sull’idea di Logos nella teologia cristiana e in quella musulmana può svolgersi su due livelli: il livello dell’esegesi testuale dei libri sacri e il livello dell’elaborazione teologica. Si tratta, dal mio punto di vista, eminentemente di chiarire la posizione musulmana che appare non solo meno nota, ma anche più controversa. [...]
*
Lo speciale “Quel che resta di Ratisbona” è a cura di Gabriele Palasciano.
*Massimo Campanini (1954), orientalista e islamologo italiano, ha studiato filosofia e lingua araba. Ha insegnato nelle Università di Urbino, Milano e Napoli L’Orientale e attualmente è professore associato di studi islamici all’università di Trento. Ha pubblicato oltre 100 articoli e 33 monografie, tra cui cinque sul Corano: la traduzione commentata delle sure 12 e 18, la traduzione delle Perle del Corano di al-Ghazali e in inglese The Qur’an the Basics (Routledge) e The Qur’an: modern muslim interpretations (Routledge).
* IL CORTILE DEI GENTILI. Il dialogo tra credenti e non credenti, 23.05.2016
- Per l’inizio del dialogo, quello vero (B. Spinelli)
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! -- IL DOGMA DELL’INFALLIBILITA’. Papa Francesco apre il caso28 aprile 2016, di Federico La Sala
- LA GRAZIA DEL DIO DI GESU’ E’ "BENE COMUNE" DELL’INTERA UMANITA’, MA IL VATICANO LA GESTISCE COME SE FOSSE UNA SUA PROPRIETA’.
Il Dogma dell’infallibilità
di Hans Küng (la Repubblica, 28.04.2016)
IL 9 MARZO è apparso su importanti giornali di diversi Paesi il mio appello a papa Francesco per avviare una discussione libera, non prevenuta, aperta sulla questione dell’infallibilità. Mi ha fatto molto piacere ricevere già subito dopo Pasqua, attraverso la nunziatura di Berlino, una lettera personale di papa Francesco datata la domenica delle Palme (20 marzo).
In questa lettera sono per me molto significativi i seguenti punti: che papa Francesco mi abbia risposto e che non abbia, per così dire, lasciato cadere nel vuoto il mio appello; che abbia risposto di persona e non attraverso il suo segretario privato o il cardinale segretario di Stato; che sottolinei il carattere fraterno della sua lettera in spagnolo con l’appellativo tedesco «lieber Mitbruder» («caro confratello»), scritto in corsivo; che abbia letto attentamente l’appello che gli avevo rivolto anche in traduzione spagnola; che tenga in grande considerazione le riflessioni che mi hanno indotto a pubblicare il quinto volume dei miei scritti, nel quale propongo di discutere sul piano teologico, alla luce della Sacra Scrittura e della tradizione, le diverse questioni sollevate dal dogma dell’infallibilità, allo scopo di approfondire il dialogo costruttivo della Chiesa del ventunesimo secolo, «semper reformanda», con l’ecumene e la società postmoderna.
Papa Francesco non pone alcuna limitazione. Egli ha così corrisposto al mio desiderio di dar luogo a una libera discussione del dogma dell’infallibilità. Ritengo, perciò, che occorra utilizzare questo nuovo spazio libero per portare avanti il chiarimento delle definizioni dogmatiche contestate nella Chiesa e nell’ecumene cattolica.
Allora non potevo immaginare quale spazio libero avrebbe aperto pochi giorni dopo papa Francesco nello scritto apostolico post-sinodale Amoris laetitia. Già nell’introduzione egli dichiara che «non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero».
 Egli si volge contro una «una morale fredda da scrivania» e non vuole che i vescovi continuino a comportarsi come «controllori della grazia ».
Egli si volge contro una «una morale fredda da scrivania» e non vuole che i vescovi continuino a comportarsi come «controllori della grazia ».Non vede l’eucarestia come un premio per i perfetti, ma come un «alimento per i deboli». Cita ripetutamente affermazioni del sinodo dei vescovi e delle conferenze episcopali nazionali. Non vuole più essere il portavoce solitario della Chiesa. Questo è il nuovo spirito che ho sempre atteso dal magistero.
Sono convinto che in questo spirito anche il dogma dell’infallibilità, questa fondamentale questione chiave della Chiesa cattolica, potrà alla fine essere discussa in modo libero, non prevenuto e aperto.
Per questo libero spazio rivolgo a papa Francesco un ringraziamento profondamente sentito.
Aggiungo l’aspettativa che i vescovi, le teologhe e i teologi facciano proprio senza riserve questo spirito in un dialogo collegiale e collaborino a questo compito nel solco della Scrittura e della grande tradizione ecclesiale.
* Hans Küng è teologo, presbitero e saggista svizzero
Francesco apre il caso dell’infallibilità del Papa
Il teologo Küng: «Mi ha risposto con una lettera fraterna, non ha posto limiti alla discussione sul dogma»
Il dogma dell’infallibilità del Pontefice è stato sancito dal Concilio Vaticano I e da Pio IX il 18 luglio 1870. Stabilisce che il Papa non può sbagliare quando parla come dottore o pastore universale della Chiesa.
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 28.04.2016)
CITTÀ DEL VATICANO Racconta Hans Küng che la lettera di Francesco, con la data del 20 marzo, gli è stata recapitata attraverso la nunziatura di Berlino. Una lettera «che risponde alla mia richiesta di una libera discussione sul dogma dell’infallibilità» del Papa. «Mi ha risposto in maniera fraterna, in spagnolo, rivolgendosi a me come Lieber Mitbruder, caro fratello, e queste parole personali sono in corsivo», ha fatto sapere Küng.
Il grande teologo svizzero «per la riservatezza che devo al Papa» non cita frasi del pontefice. Però dice che «Francesco non ha fissato alcun limite alla discussione», che ha «apprezzato» le sue considerazioni. E con malcelato stupore fa notare quanto sia «per me importante» il fatto che abbia risposto di persona e soprattutto «non abbia lasciato, per così dire, cadere nel vuoto il mio testo».
E in effetti il testo, rivolto ad un pontefice, era impegnativo: «Imploro papa Francesco, che mi ha sempre risposto in modo fraterno: riceva questa ampia documentazione e consenta nella nostra Chiesa una discussione libera, non prevenuta e aperta su tutte le questioni irrisolte e rimosse legate al dogma dell’infallibilità. Non si tratta di banale relativismo, che mina i fondamenti etici della Chiesa e della società. E nemmeno di rigido e insulso dogmatismo legato all’interpretazione letterale. È in gioco il bene della Chiesa e dell’ecumene».
Küng lo aveva reso pubblico, tradotto in più lingue, il 9 marzo. Giunto all’ottantottesimo compleanno, «da teologo alla fine dei miei giorni, sostenuto da una profonda simpatia per lei e per la sua azione pastorale», il pensatore svizzero aveva rilanciato «un appello che ho più volte inutilmente lanciato nel corso di una discussione pluridecennale».
Francesco non ha mai parlato del dogma dell’infallibilità, sancito dal Concilio Vaticano I e da Pio IX il 18 luglio 1870. Del resto nessuno Oltretevere ritiene abbia mai pensato di metterlo in discussione. Bergoglio è il Papa della sinodalità ma ha ben presenti le prerogative del pontefice, che elencò in un discorso memorabile il 18 ottobre 2014, alla fine del Sinodo, citando il Codice di diritto canonico: il Papa è «il garante dell’ubbidienza e della conformità della Chiesa alla volontà di Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa, mettendo da parte ogni arbitrio personale, pur essendo - per volontà di Cristo stesso - il “Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli” (canone 749) e pur godendo “della potestà ordinaria che è suprema, piena, immediata e universale nella Chiesa” (canoni 331-334)».
Diverso è dire che Francesco non abbia posto «alcun limite alla discussione», come riferisce Küng. Anche perché si tratta del dogma forse più frainteso, oltre che dibattuto. Il Concilio Vaticano I non disse affatto, come molti credono, che il Papa è infallibile tout court . Il Papa è un essere umano e la prima cosa che Bergoglio disse al conclave, subito dopo l’elezione, fu: «Io sono un peccatore». Dopo lunghe discussioni, nel 1870 si stabilì che il Papa è infallibile solo «quando parla ex cathedra , cioè quando esercita il suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, e in forza del suo supremo potere Apostolico definisce una dottrina circa la fede e i costumi».
Sono casi rarissimi, come quando nel 1950 Pio XII proclamò solennemente l’Assunzione di Maria in cielo. Ma l’estensione dell’infallibilità resta dibattuta tra i teologi. La posizione di Küng è netta: vorrebbe abolirla o almeno sottoporla ad una revisione radicale. Già il fatto che Francesco non abbia posto un limite alla discussione, scrive, è una bella notizia: «Penso che sia ora indispensabile utilizzare questa nuova libertà per portare avanti la riflessione sulle definizioni dogmatiche, che sono motivo di polemica all’interno della Chiesa cattolica e nel suo rapporto con le altre chiese cristiane».
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO --- Ian Assmann, "Il disagio dei monoteismi". Nota di Lucetta Scaraffia.17 aprile 2016, di Federico La Sala
Jan Assmann
Monoteismi e violenza
di Lucetta Scaraffia (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.04.2016)
- Jan Assmann, Il disagio dei monoteismi. Sentieri teorici e autobiografici, Morcelliana, Brescia, pagg.95, € 11.
Se molti ritengono che ogni religione possa comunque divenire causa di violenza, la maggior parte delle persone tende a pensare che questa sia piuttosto connaturata ai monoteismi. Jan Assmann sotiene che «c’è molto da riflettere sul fatto che proprio la religione, che oggi appare come l’elemento principale di antagonismo politico e culturale, nel mondo antico al contrario servisse come elemento per mettersi in relazione con altri popoli e culture» scrive, collegando così i suoi studi sulle religioni egizia ed ebraica con i conflitti religiosi attuali.
Infatti è proprio sulla differenza fra le religioni “pagane” e i monoteismi che vertono le sue ricerche sulla tradizione religiosa egizia, che considera appartenente a una classe definibile come cosmoteismo.
La definizione presuppone un rapporto più simbiotico nei confronti della natura e si fonda sulla divinizzazione di entità cosmiche come il sole, la luna, l’acqua: divinità che, nella loro immediata esperibilità, erano in sostanza traducibili da una religione all’altra. Infatti erano solo i nomi delle divinità a cambiare, non la loro identità. Questa tecnica di traduzione dei nomi degli dei era funzionale al diritto internazionale: i trattati con gli altri stati venivano ratificati con giuramenti in nome delle divinità, e questo poteva essere fatto solo se c’era una corrispondenza degli dei.
Questa traducibilità degli dei è stata rotta dal monoteismo biblico, una religione della trascendenza: il Dio di Mosé, quello della Bibbia, non si lasciava mettere in relazione con alcun altro nome di Dio in un’altra religione. Assmann ha chiamato questa differenza fra cosmoteismo e monoteismo «distinzione mosaica».
Ciò che blocca la traducibilità delle religioni è secondo lo studioso il concetto di rivelazione, trasmessa una volta per sempre, che fonda una verità assoluta.
In seguito alla rivelazione, infatti, le religioni si dividono in vere o false, oppure fedeli o traditrici del vero Dio. Quindi non comparabili e profondamente differenti perché appartenenti a due realtà opposte: quella del vero e quella del falso.
Assmann pensa che un’attenuazione dei conflitti religiosi in corso si possa ottenere solo attraverso la creazione di una piattaforma comune condivisa, come dovrebbero essere i Diritti umani. Secondo lo studioso si potrà uscire dalla distinzione mosaica attraverso la costruzione di una religione a due piani, una religione che «ha imparato a concepirsi come una tra le molteplici e a guardarsi con gli occhi degli altri».
E riprendendo l’opera di Lessing Nathan il saggio, un rifacimento dell’antica leggenda delle “tre anella”, Assmann propone di considerare vera la religione di chi ne dà testimonianza con la sua vita, attraverso una condotta migliore degli altri.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". -- Quel legame che unisce ebrei e cristiani. La visita di Papa Francesco alla Sinagoga di Roma (di Bruno Forte)18 gennaio 2016, di Federico La Sala
- EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI")
La visita di Papa Francesco alla Sinagoga di Roma
Quel legame che unisce ebrei e cristiani
di Bruno Forte, monsignore (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.01.2016)
- DIALOGO. LA Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo afferma che più che parlare di dialogo interreligioso si dovrebbe dire «dialogo intra-familiare»
La visita odierna di Papa Francesco alla Sinagoga di Roma - analogamente a quelle di Giovanni Paolo II il 13 aprile 1986 e di Benedetto XVI il 17 gennaio 2010 - mette in evidenza non solo l’importanza che il popolo ebraico e la sua fede hanno per i cristiani, ma anche la rilevanza che il cristianesimo ha per l’ebraismo, come ancora una volta ho sperimentato di persona in questi giorni tenendo la «annual lecture» al Centro di studi sul cristianesimo della Hebrew University di Gerusalemme.
Perché questa rilevanza?
La risposta può essere cercata in una scena biblica, cui sono ricorsi gli antichi pensatori cristiani per illuminare il rapporto fra Israele e la Chiesa. Si tratta dei due esploratori di ritorno dalla terra di Canaan, che portano insieme un’asta da cui pende un grappolo d’uva, che essi accompagnano col melograno e il fico: «Giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche melagrane e fichi» (Numeri 13,23). Nell’asta i Padri della Chiesa hanno visto il legno della Croce, da cui pende Cristo: «Figura Christi pendentis in ligno» (così ad esempio Evagrio intorno al 430 nella «Altercatio inter Theophilum et Simonem»: PL 20,1175).
 Nei due portatori, uniti e separati da quel legno, hanno riconosciuto Israele e la Chiesa: «Portando l’asta, essi appresentavano i due popoli, l’uno avanti, quello ebraico che dà la spalle a Cristo, e l’altro indietro, che guarda al ramo, il popolo dei cristiani»(ivi: stesse idee in S. Massimo di Torino, alla metà del V secolo: Homilia 79: PL 57,423s). In quanto marciano l’uno dietro all’altro, chi precede guarda solo davanti a sé ed è perciò figura d’Israele, popolo della speranza e dell’attesa fondate sulla promessa di Dio; chi viene dietro vede, invece, colui che gli sta davanti e l’orizzonte da questi abbracciato attraverso il grappolo appeso al legno ed è perciò figura della Chiesa, che confessa in Cristo crocefisso la chiave di lettura anche dell’alleanza con Israele e della promessa fatta ai credenti. Col mostrare la differenza, l’immagine afferma non di meno la profonda continuità che esiste fra i due popoli, non solo per il legame dell’unico legno che entrambi gli esploratori portano, ma anche per l’orizzonte comune della meta cui si rivolge il loro sguardo.
Nei due portatori, uniti e separati da quel legno, hanno riconosciuto Israele e la Chiesa: «Portando l’asta, essi appresentavano i due popoli, l’uno avanti, quello ebraico che dà la spalle a Cristo, e l’altro indietro, che guarda al ramo, il popolo dei cristiani»(ivi: stesse idee in S. Massimo di Torino, alla metà del V secolo: Homilia 79: PL 57,423s). In quanto marciano l’uno dietro all’altro, chi precede guarda solo davanti a sé ed è perciò figura d’Israele, popolo della speranza e dell’attesa fondate sulla promessa di Dio; chi viene dietro vede, invece, colui che gli sta davanti e l’orizzonte da questi abbracciato attraverso il grappolo appeso al legno ed è perciò figura della Chiesa, che confessa in Cristo crocefisso la chiave di lettura anche dell’alleanza con Israele e della promessa fatta ai credenti. Col mostrare la differenza, l’immagine afferma non di meno la profonda continuità che esiste fra i due popoli, non solo per il legame dell’unico legno che entrambi gli esploratori portano, ma anche per l’orizzonte comune della meta cui si rivolge il loro sguardo.Uniti nella speranza e nell’attesa, Israele e la Chiesa avanzano insieme, distinti e congiunti al tempo stesso dal legno della Croce. Il legame è così forte, che il recente documento della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo della Chiesa Cattolica, pubblicato in occasione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione “Nostra Aetate” del Concilio Vaticano II (10 Dicembre 2015, dal titolo: «Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!», citazione della Lettera di Paolo ai Romani 11,29), non esita ad affermare:
 «Il dialogo con l’ebraismo occupa per i cristiani un posto unico: il cristianesimo, date le sue radici, è unito all’ebraismo più di quanto non lo sia a qualsiasi altra religione. Pertanto, solo con le dovute riserve, il dialogo ebraico-cristiano può essere definito dialogo interreligioso in senso stretto: si dovrebbe piuttosto parlare di un tipo di dialogo intra-religioso o intra-familiare» (n. 20).
«Il dialogo con l’ebraismo occupa per i cristiani un posto unico: il cristianesimo, date le sue radici, è unito all’ebraismo più di quanto non lo sia a qualsiasi altra religione. Pertanto, solo con le dovute riserve, il dialogo ebraico-cristiano può essere definito dialogo interreligioso in senso stretto: si dovrebbe piuttosto parlare di un tipo di dialogo intra-religioso o intra-familiare» (n. 20).In particolare, tre elementi di continuità e insieme di discontinuità fra Israele e la Chiesa possono essere evidenziati: il carattere escatologico della rivelazione biblica, tanto del Primo quanto del Nuovo Testamento, e cioè la convinzione che in essa ci è offerto il senso ultimo della vita e della storia, e pertanto ci è indicata la direzione di marcia che rende piena e significativa l’esistenza umana in questo mondo; il carattere comunitario della salvezza, determinato dal principio fondatore dell’alleanza fra l’Eterno e il Suo popolo; il significato messianico dei due popoli, tanto di quello dell’attesa, quanto di quello del compimento, e dunque la missione che essi hanno in forma simile ed insieme diversa per tener alto nella vicenda umana il senso religioso, inteso come l’apertura accogliente al Dio che si rivela per la nostra salvezza, motivato unicamente dall’amore per le sue creature.
 Ciò che unisce i due esploratori è dunque anzitutto l’orizzonte cui si volge il loro sguardo: la Verità per cui vale la pena di vivere sta davanti a loro. Verso di essa orientano i loro passi, ad essa anela il loro cuore. Perché questo avvenisse, la stessa Verità ha parlato il linguaggio degli uomini e infiammato di desiderio i loro cuori: l’Infinito è entrato nel finito per comunicarsi a noi! Questa convinzione è espressa dai maestri ebrei con un assioma ricorrente: «Il piccolo può contenere il grande»(cf. Genesi rabbah V.7 e Levitico rabbah X.9). Non diversamente si esprime la sapienza cristiana: «Non essere costretti dal massimo, essere invece contenuti dal minimo, questo è divino» (elogio sepolcrale di Sant’Ignazio di Loyola).
Ciò che unisce i due esploratori è dunque anzitutto l’orizzonte cui si volge il loro sguardo: la Verità per cui vale la pena di vivere sta davanti a loro. Verso di essa orientano i loro passi, ad essa anela il loro cuore. Perché questo avvenisse, la stessa Verità ha parlato il linguaggio degli uomini e infiammato di desiderio i loro cuori: l’Infinito è entrato nel finito per comunicarsi a noi! Questa convinzione è espressa dai maestri ebrei con un assioma ricorrente: «Il piccolo può contenere il grande»(cf. Genesi rabbah V.7 e Levitico rabbah X.9). Non diversamente si esprime la sapienza cristiana: «Non essere costretti dal massimo, essere invece contenuti dal minimo, questo è divino» (elogio sepolcrale di Sant’Ignazio di Loyola).Questa convinzione è alla base della dottrina dello “zimzum”, cara alla mistica ebraica, e dell’idea della “kenosi” del Verbo, centrale nel messaggio cristiano. “Zimzum” è l’atto del divino contrarsi, quel farsi piccolo del Dio vivo che consente alla creatura di esistere davanti a Lui nella libertà e nell’amore. L’invocazione “Tu sei Umiltà”, contenuta nelle Lodi del Dio Altissimo di San Francesco, mostra quanto questo messaggio corrisponda all’anima cristiana, per la quale la conferma suprema dell’attendarsi di Dio nella fragilità e piccolezza delle misure umane sta proprio nel farsi carne del Verbo eterno e nel suo “annientamento” (“kénosi”) per amore nostro. Questa “estasi” del divino, questo “star fuori” dell’Infinito nel finito, è al tempo stesso l’appello più alto che si possa concepire al cammino della creatura verso il Mistero, che è la vocazione ultima della creatura alla verità e alla bellezza che salva, e che per il cristiano è resa realizzabile dall’“abbreviarsi” del Verbo nella carne. Il tutto dimora nel frammento, l’infinito irrompe nel finito: qui la fede dell’ebreo Gesù unisce Israele e la Chiesa; qui la fede in Lui li distingue, pur senza separarli, nel comune cammino della speranza verso il compimento della promessa di Dio nel Regno che non avrà fine.
Nel messaggio di quest’anno per la giornata del dialogo ebraico cristiano, che cade sempre il 17 Gennaio, Rav. Giuseppe Momigliano, Presidente dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia, ed io in quanto Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, abbiamo perciò affermato:
 «Attraverso le nostre fedi riconosciamo anzitutto tutto il bene che c’è nel mondo, ed insieme viviamo con angoscia gli eventi del presente, che sono carichi di sofferenza e di inquietanti prospettive per il futuro, assistiamo sgomenti a gesti orrendi che profanano il Nome dell’Eterno, perpetrati con l’ignobile pretesa di adempiere alla Sua volontà, cogliamo con preoccupazione i segni sempre più frequenti di un’umanità smarrita, delusa da tante false idolatrie... Mentre rinnoviamo la nostra fedeltà ai principi e ai precetti che, con distinte peculiarità, caratterizzano le nostre fedi, sentiamo l’urgente necessità di ribadire la fiducia che, proprio dal fecondo dialogo da noi intrapreso, dalla ricerca di valori morali e spirituali condivisi nei quali operare in sintonia, possa scaturire una positiva testimonianza di fede, suscettibile di restituire speranza e di rivolgere nuovamente i cuori di molti verso l’Eterno».
«Attraverso le nostre fedi riconosciamo anzitutto tutto il bene che c’è nel mondo, ed insieme viviamo con angoscia gli eventi del presente, che sono carichi di sofferenza e di inquietanti prospettive per il futuro, assistiamo sgomenti a gesti orrendi che profanano il Nome dell’Eterno, perpetrati con l’ignobile pretesa di adempiere alla Sua volontà, cogliamo con preoccupazione i segni sempre più frequenti di un’umanità smarrita, delusa da tante false idolatrie... Mentre rinnoviamo la nostra fedeltà ai principi e ai precetti che, con distinte peculiarità, caratterizzano le nostre fedi, sentiamo l’urgente necessità di ribadire la fiducia che, proprio dal fecondo dialogo da noi intrapreso, dalla ricerca di valori morali e spirituali condivisi nei quali operare in sintonia, possa scaturire una positiva testimonianza di fede, suscettibile di restituire speranza e di rivolgere nuovamente i cuori di molti verso l’Eterno».Anche per questo la visita di Papa Francesco alla Sinagoga di Roma è un evento che tocca tutti, credenti e non credenti che siano.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- I TRE CAMMELLI E LA CELEBRAZIONE DELL’EPIFANIA. «I Magi ci insegnano a cercare il senso delle cose» (Papa Francesco)..7 gennaio 2016, di Federico La Sala
- GIORDANO BRUNO, LE "TRE CORONE" E IL VANGELO ARMATO. Nuccio Ordine rilegge la grande opera di Bruno (e fa intravedere impensate connessioni con Dante, Boccaccio, Lessing e noi, tutti e tutte). Intervista di Maria Mantello.
Celebrazione dell’Epifania. Il messaggio di Francesco
«I Magi ci insegnano a cercare il senso delle cose»
Un messaggio a tutta la Chiesa, ma in particolare ai suoi ministri, sacerdoti e vescovi: la vostra è una missione, dice il Papa.
di Carlo Marroni (Il Sole-24 Ore, 07.01.2016)
È la festività dell’Epifania, celebrazione solenne nella basilica vaticana: «Annunciare il Vangelo di Cristo non è una scelta tra le tante che possiamo fare, e non è neppure una professione». Le parole di Francesco sono sul solco di un messaggio che è centrale sin dall’inizio del pontificato, quando mise in guardia il clero da assumere ruoli di “funzionari” di un’organizzazione. E su questo spirito che si innesta l’azione della Chiesa: «Essere missionaria non significa fare proselitismo, per la Chiesa, essere missionaria equivale ad esprimere la sua stessa natura: essere illuminata da Dio e riflettere la sua luce. Non c’è un’altra strada. La missione è la sua vocazione. Quante persone attendono da noi questo impegno missionario, perché hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno di conoscere il volto del Padre». No al proselitismo, quindi: un altro tassello della pastorale bergogliana, che rimarca lo spirito profondo dello spirito missionario.
Nell’omelia dell’Epifania il papa ricorda che «l’esperienza dei Magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità, a non “vivacchiare”, ma a cercare il senso delle cose, a scrutare con passione il grande mistero della vita. E ci insegna a non scandalizzarci della piccolezza e della povertà, ma a riconoscere la maestà nell’umiltà, e saperci inginocchiare di fronte ad essa». La povertà della Chiesa, sempre al centro, che nella simbologia natalizia trova la sua rappresentazione più plastica, come in qualche modo ha voluto rimarcare nella visita a sorpresa due giorni fa a Greccio, il borgo del reatino dove secondo la tradizione San Francesco istituì il presepe: «È qui, nella semplicità di Betlemme, che trova sintesi la vita della Chiesa». E sempre su questo tema il Papa, parlando a braccio, ha offerto una nuova interpretazione della figura dei pastori, che secondo quanto tramandato sarebbero stati i primi ad arrivare alla mangiatoia: «Nella notte di Natale Gesù si è manifestato ai pastori, uomini umili e disprezzati, alcuni dicono dei briganti. Furono loro i primi a portare un po’ di calore in quella fredda grotta di Betlemme».
Nell’omelia di ieri, semplice nelle parole ma complessa nel suo messaggio, il Pontefice ha voluto ricordare come «la Chiesa non può illudersi di brillare di luce propria. Non può». E ha citato «una bella espressione di sant’Ambrogio, utilizzando la luna come metafora della Chiesa: «Veramente come la luna è la Chiesa: rifulge non della propria luce, ma di quella di Cristo. Cristo - ha spiegato - è la vera luce che rischiara; e nella misura in cui la Chiesa rimane ancorata a Lui, nella misura in cui si lascia illuminare da Lui, riesce a illuminare la vita delle persone e dei popoli. Per questo i santi Padri riconoscevano nella Chiesa il mysterium lunae».
Nel corso dell’Angelus, inoltre, Francesco ha chiesto alla folla di piazza San Pietro - presente un gruppo folkloristico con tre cammelli - un applauso per esprimere, ha detto, «la nostra vicinanza spirituale ai fratelli e alle sorelle dell’Oriente cristiano, cattolici e ortodossi, molti dei quali celebrano domani il Natale del Signore. Ad essi giunga il nostro augurio di pace e di bene».
La conclusione delle festività natalizie segna il ritorno agli impegni anche di carattere istituzionale: il primo è previsto per lunedì prossimo, 11 gennaio, con l’incontro annuale con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, dove è prevedibile che pronunci un discorso molto forte sui temi della pace, specie in questo inizio del 2016 segnato da nuove gravi tensioni, dalla crisi Iran-Arabia Saudita all’annuncio della Corea del Nord di un esperimento nucleare.
Inoltre il 17 gennaio, come annunciato da tempo, Francesco si recherà in visita alla Sinagoga di Roma. È il terzo Pontefice dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a varcare la soglia del Tempio maggiore della capitale. Alle sedici della domenica, su invito del Rabbino Capo, Riccardo di Segni e della Comunità, il Papa stringerà la mano ai cittadini di Roma di fede ebraica. Ad accoglierlo, oltre ai rappresentanti del mondo ebraico italiano religioso e civile, tra cui il presidente dell’Ucei, Renzo Gattegna, e ad un esponente del governo d’Israele, ci sarà soprattutto la gente, i giovani della comunità e anche gli ex deportati.
«Sarà una visita all’insegna del dialogo e della cordialità - ha dichiarato Ruth Dureghello, presidente della Comunità di Roma - È una bella occasione per continuare il percorso di dialogo che prosegue fra alti e bassi ma con la volontà consolidata di andare avanti».
E ieri si è appreso che la storica ebrea Anna Foa sostituisce la giornalista Ritanna Armeni nell’incarico di co-coordinatrice, con Lucetta Scaraffia, dell’inserto dell’Osservatore Romano «Donne Chiesa Mondo», iniziativa editoriale dal 2012 del quotidiano della Santa Sede diretto da Giovanni Maria Vian.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- A chi appartiene Maometto? Lo Stato Islamico usa la nostra storia dell’Islam per la sua guerra (di Tamim Ansary)4 gennaio 2016, di Federico La Sala
Stato Isamico [Daesh]: a chi appartiene Maometto?
Lo Stato Islamico usa la nostra storia dell’Islam per la sua guerra. Soltanto noi musulmani possiamo cambiare questo stato delle cose.
Un contributo di Tamim Ansary - nato a Kabul nel 1948, storico, vive a San Francisco.
Die Zeit online - 24 dicembre 2015
- traduzione dal tedesco di José F. Padova (Nota: A chi appartiene il Cristianesimo? Ai cattolici o ai protestanti? Per “rispondere” a questa domanda ci sono state le Guerre di Religione, i bruciati vivi sul rogo, cuius regio eius religio, devastazioni spaventose, Westfalia e le ripartizioni territoriali. Alla morte di Maometto, 632 d.C., iniziò una situazione analoga, con sciiti (devoti ai loro imam, vedi l’Iran odierno) e sunniti, di manica un poco più larga.
 Mi perdonino gli esperti questa banalizzazione. Nel campo di questa religione monoteista le cose si sono complicate nel 1492 (http://www.limesonline.com/il-califfato-di-spagna/37758) , quando il mirabile sviluppo di una civiltà si è bloccato - fino a oggi. In quel mondo tuttavia molti cominciano a farsi domande.)
Mi perdonino gli esperti questa banalizzazione. Nel campo di questa religione monoteista le cose si sono complicate nel 1492 (http://www.limesonline.com/il-califfato-di-spagna/37758) , quando il mirabile sviluppo di una civiltà si è bloccato - fino a oggi. In quel mondo tuttavia molti cominciano a farsi domande.)
Il vero potere di Daesh non sta nelle sue bombe e armamenti vari e neppure nella sua orrenda risolutezza. Esso si trova molto più nel modo geniale in cui l’organizzazione formula la sua immagine mondiale e la forgia come un’arma. È in corso un conflitto apocalittico fra ‘Islam e l’Occidente. «Non si tratta qui semplicemente di un’altra guerra, fratelli e sorelle, è l’inizio della fine, perché presto Dio riscriverà la storia e i suoi [figli] diletti sono predestinati come vincitori. Essi cancelleranno i satanici, gli altri, e unificheranno la Terra sotto il tetto dell’Islam. Chi vi si unisce farà parte dei benedetti da Dio. Chi perde la vita in battaglia raggiunge direttamente il paradiso, chi sopravvive diventa onorato membro di una società che vive esattamente secondo le regole che Dio ha trasmesso all’umanità attraverso il suo inviato Maometto».
Può Daesh venire sconfitto uccidendo il suo sedicente Califfo Al Bagdadi? Sterminando tutti i suoi adepti? Certamente no, perché si tratta soltanto di persone. Ma l’immagine mondiale, che sospinge la sua campagna militare, è una rete di idee che vive e respira nello scambio che ne fanno milioni di musulmani.
Il massacro di San Bernardino dimostra la sua potenza minacciosa. In quel luogo Tashfeen Malik, madre di un bambino di sei mesi, che viveva col marito in un esemplare sobborgo californiano, si mette in movimento con lui per falciare con il mitra persone che non aveva mai visto prima. Come ha potuto questa azione apparirle sensata e giusta?
Prima di partire per l’assassinio Tashfeen Malik ha giurato fedeltà allo “Stato Islamico” con un post su Facebook. Quando questo scritto è venuto alla luce, nessuno a dire il vero ha chiesto che cosa si sarebbe potuto intraprendere contro questa visione del mondo. Ben Carson, un candidato repubblicano alla Presidenza, ha detto che San Bernardino dovrebbe significare “la fine del dibattito” circa l’accoglienza dei profughi siriani. Donald Trump, che già si era dichiarato a favore della reintroduzione della tortura, ha preteso un divieto generale di entrata per i musulmani. Gran Bretagna, Francia e USA intensificano nel frattempo i bombardamenti in Siria.
È questo il piano? Chiudi i confini, bombarda il Medio Oriente, erigi un muro e mettigli in cima il filo spinato, perché i terroristi e le loro armi non entrino? Il filo spinato può tenere fuori le persone, ma le idee gli scorrono attraverso come acqua. Tuttavia deve essere sconfitta quella visione omicida del mondo che può fare apparire qualsiasi azione di insensata violenza come atto eroico.
A chi punta questa visione del mondo? Essa si indirizza soprattutto a quei musulmani marginalizzati, la cui vita non ha più alcun senso. I figli di musulmani emigrati in Europa o in America sono la prima linea di questo gruppo demografico - giovani uomini e donne, la cui identità è in crisi fin dalla nascita.
Conosco questo fenomeno per la mie esperienze fra i richiedenti asilo e i profughi afghani in America. Il loro primo contatto con il mainstream americano i bambini lo hanno avuto in quelle famiglie, in quelle scuole statali, in cui molti sono stati trattati con disprezzo per la loro appartenenza all’Islam. Se poi hanno cercato di comportarsi nel miglio modo possibile come americani, i loro sforzi sono andati a sbattere contro il sarcasmo e la derisione. Dopo queste lezioni sono tornati a casa dai loro genitori, i quali sognavano di una patria perduta, di un tempo e una cultura che i ragazzi non avevano mai conosciuto. Se i figli si comportavano lì come americani incombevano su di loro accuse e rimproveri. Così essi facevano del loro meglio per comportarsi come buoni afghani musulmani. Un giovane mi disse: «A casa faccio come se fossi afghano. Poi esco e faccio come fossi americano. Mi chiedo: quando sono veramente me stesso?».
Lo Stato Islamico (Daesh) conosceva il suo pubblico
Mentre l’espansionismo occidentale travolgeva la loro civiltà, nel mondo arabo le persone si attaccavano al loro solo sogno perduto - la fantasia romantica degli «incrollabili vincoli famigliari». Ma come dovunque altrove, anche qui è accaduto lo stesso: la modernità industriale e il capitalismo hanno dissolto le strutture della stirpe e del clan. La rete emotiva della società tradizionale è stata sostituita da un mondo di nuclei monofamiliari e di individui, ognuno dei quali segue il suo proprio singolo destino. I ruoli tipici tradizionali dei sessi non reggono più.
Poi sullo schermo appare lo Stato Islamico. Che conosceva il suo pubblico. Offriva una visione del mondo che era sintonizzata perfettamente su queste situazioni, questa schiera imponente di potenziali reclute.
L’ideologia dello Stato Islamico non ha niente a che fare con l’Islam, l’Islam è la religione della pace, perorano troppo spesso molte voci benpensanti. Tutto ciò è poco sincero. La visione del mondo delio Stato Islamico ha a che fare naturalmente con l’Islam. Se non fosse così non susciterebbe tanta eco. Effettivamente l’immagine del mondo [di Daesh] si inserisce perfettamente nella storia, tanto amata dai musulmani, delle loro origini. Molto tempo fa vi fu un piccolo gruppo di anime pure che si attenevano precisamente e minuziosamente alle direttive che Dio aveva loro imposto. Queste persone stavano di fronte a un nemico spietato, che le voleva eliminare. Ma la comunità aveva come guida l’unica persona sulla Terra che fosse ispirata direttamente dall’Unico Dio. Sotto la sua guida la piccola comunità si pose con successo in difesa e poi portò la lotta nel campo nemico. Essa conseguì vittoria dopo vittoria, finché dominò il mondo (o almeno la parte più importante di questo). Questa è la storia della quale lo Stato Islamico si serve. E ha la forza di un mito.
Questa storia, obiettivamente considerata, esiste, perché centinaia di milioni di persone la conoscono e con essa sono cresciute. Uccidere qualche persona che conosce questa storia non uccide la storia stessa. Una visione del mondo può essere eliminata soltanto da un’altra visione e quella che domina lo Stato Islamico non può sorgere da alcuna origine occidentale. Non può derivare da concetti e valori di una cultura occidentale laica, con idee come “Libertà”, “Democrazia”, “Capitalismo” e “Parificazione della donna” come punti di arrivo prestabiliti. Può avere forza soltanto se è nata dal mondo islamico, abbozzata da teologi musulmani, che godono di stima per la loro erudizione. Il punto-chiave: devono utilizzare la medesima storia delle origini della quale lo Stato Islamico fa uso, ma giungere a conclusioni differenti.
Ma da scritti, dottrine e tradizioni dell’Islam può veramente svilupparsi una visione del mondo progressista e modernistica? Naturalmente! Tutti gli ingredienti sono a portata di mano. La tolleranza nei confronti di chi crede diversamente, per esempio. Che cosa hanno fatto i primi musulmani, dopo essersi spostati da La Mecca a Medina, la loro nuova patria? Formularono il regolamento comunitario di Medina, la prima Costituzione apparsa al mondo. Le loro regole dovrebbero garantire che le diverse comunità vivano le une accanto alle altre con armonia, ognuna alla sua maniera.
E i diritti delle donne? Sotto la guida del profeta Maometto, nell’ambito interno della comunità svolsero un ruolo centrale alcune eminenti personalità femminili - come Chadisha, Aicha, Fatima. Nell’Islam primitivo lo status delle donne fu migliorato, per la prima volta fu concesso loro di ereditare denaro, avere proprietà, ottenere il divorzio. Per quei tempi furono passi radicali.
O il tema delle atrocità in guerra. Scritti musulmani e sentenze di Maometto fissarono regole e condizioni che avrebbero dovuto limitare gli eccessi in guerra - precoci precursori della Convenzione di Ginevra.
Tutti questi elementi sono parte della preistoria, mitica e originaria, dell’Islam. Sì, la visione jihadistica del mondo ha pienamente a che fare con l’Islam, ma non è la stessa cosa dell’Islam. È soltanto una delle molte visioni del mondo che si fanno originare dalle medesime fonti storiche. Nessun fondamento teologico di alcun genere smentisce che una forte visione opposta possa entrare in concorrenza con il jihadismo. Il risultato positivo dipenderà da questioni come la seguente: “Come può la sharia essere adattata a tempi in mutamento?”. Infatti, anche se gli esempi prima ricordati si spostassero come fossero stati formulati 1400 anni fa, questo non farebbe ancora dell’Islam una religione progressista.
Una questione di vita o di morte
Tuttavia si può pensare la sharia così che gli odierni musulmani possano agire diversamente da come avrebbero fatto nel VII secolo? I jihadisti dicono che questo non sarebbe possibile: la sharia non potrebbe adeguarsi ai tempi, ma i tempi dovrebbero adattarsi alla sharia. Ma si deve proprio intendere la sharia come un ammasso di prescrizione e istruzioni da prendere alla lettera? Non si può considerarla come un tesoro di principi profondi, che guidano il comportamento secondo la morale? E se sì, come vengono applicati questi principi? Nel mondo musulmano questa è oggi una questione di vita o di morte.
Essa non si deciderà alla fine sui campi di battaglia, ma nei seminari e nelle aule di studio. Perché possa avviarsi una interpretazione progressista dell’Islam, quest’ultimo deve oggi adattarsi alle realtà della vita islamica. I musulmani che vivono nel mondo occidentale si sentono marginalizzati e derubati della loro identità. La struttura sociale delle loro società di origine è inteso come in decadimento. I musulmani stanno sulle rovine del loro mondo davanti alla sfida di dare un senso alla loro vita.
Coloro che decidono politicamente in Occidente non possono sollevarli da tutto questo, ma hanno tuttavia una funzione da espletare. Essi possono rendere ciò più facile o più difficile per gli intellettuali musulmani. Quando in Europa o in America i politici vietano i copricapo religiosi, quando parlano di documenti d’identità speciali, quando chiudono le frontiere ai profughi musulmani oppure - come adesso negli Stati Uniti si dibatte durante la campagna elettorale - vogliono introdurre esami di religione, per fare sì che nel Paese entrino soltanto cristiani, essi li spingono nelle braccia dello Stato Islamico. È la conferma delle affermazioni dei jihadisti: che questo scatena una lotta apocalittica fra due potenti blocchi. Uomini come i candidati repubblicani Donald Trump, Ben Carson e Ted Cruz si comportano quasi come fossero adepti dormienti dello Stato Islamico. Quale pazzia! Infatti la vera competizione oggi ha luogo non già fra l’Islam e l’Occidente, bensì fra due visioni musulmane del mondo.
Immaginatevi di vivere da qualche parte nel mondo come musulmano. Vi trovereste nuovamente fra due visioni del mondo. Una delle quali indica che è iniziata una lotta di proporzioni epiche. Voi avete la possibilità di aggregarvi a lato di chi è predestinato ad essere il vincitore e potreste salire al rango di eroe immortale. L’altra visione spiega una volta di più che alcune persone sono civilizzate e degne, ma voi non ne fate parte. Voi non siete altro che gentaglia meritevole di abominio, che certo può vivere, ma che non ha nulla di buono da apportare. Vi si terrà continuamente d’occhio e vi si disprezzerà. Probabilmente finirete in prigione e sarete torturato. Ora vi chiedo: per quale visione del mondo optereste?
- traduzione dal tedesco di José F. Padova (Nota: A chi appartiene il Cristianesimo? Ai cattolici o ai protestanti? Per “rispondere” a questa domanda ci sono state le Guerre di Religione, i bruciati vivi sul rogo, cuius regio eius religio, devastazioni spaventose, Westfalia e le ripartizioni territoriali. Alla morte di Maometto, 632 d.C., iniziò una situazione analoga, con sciiti (devoti ai loro imam, vedi l’Iran odierno) e sunniti, di manica un poco più larga.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- LA SINGOLARE COINCIDENZA. Quest’anno il Natale cristiano e quello musulmano cadono la stessa notte. Non accadeva da mezzo millennio (di Monika Bulaj).21 dicembre 2015, di Federico La Sala
Quest’anno il Natale cristiano e quello musulmano cadono la stessa notte
Non accadeva da mezzo millennio. Una bella coincidenza di questi tempi
Quando gli dei si parlano
di Monika Bulaj (la Repubblica, 20.12.2015)
L’HO SENTITO NEI SOSPIRI DEI SUFI A KABUL, al Cairo e a Istanbul, durante i riti dionisiaci dei musulmani del Maghreb, tra le esplosioni di petardi e rulli di tamburi nella Tripoli agghindata con palloncini e teste di squalo. Era il canto natalizio dei musulmani. Quest’anno, per la prima volta negli ultimi quattrocentocinquantasette, quel canto si leverà nel mondo musulmano nella stessa notte in cui i cristiani celebreranno il loro Natale, quella tra il 24 e il 25 dicembre. Perché quest’anno Maometto nasce quando nasce Gesù. Sarà il secondo Mawlud del 2015, il primo è caduto tra il 3 e il 4 gennaio: l’anno liturgico dei musulmani, governato dalla Luna, corre più veloce di quello cristiano.
Coincidenze. Del resto - e oggi pare cos“ strano ricordarlo - le due religioni si sono rispecchiate l’una nell’altra nei secoli a suon di melodie e usanze, e si sono prestate poesie e riti come i buoni vicini si prestano il sale. E fu forse proprio per resistere all’incanto della notte di Betlemme che un califfo decretò la nascita del Profeta come festa popolare. Da allora il Natale musulmano viene festeggiato dal Maghreb fino all’Indonesia con fuochi d’artificio e regali per i bambini, cortei e danze estatiche, ed è replicato a sua volta per i santi locali in una infinità di Natali minori.
Sono anni che viaggio nelle sacre periferie delle religioni del Libro, zone franche assediate dai fanatismi armati, patrie perdute di un’umanità in fuga. Come i santuari dei mistici dell’Islam, che dal Pakistan al Mali stanno scomparendo a suon di bombe. Odiati dagli ultras dell’Islam e ignorati dall’Occidente, i sufi sono forse una delle poche barriere contro la barbarie. Riempiono le biblioteche, godono della lettura come i mistici ebrei, mettono l’esperienza al di sopra della teoria, chiamano la pratica "strada" e il fanatico "asino che porta sulla groppa una pila di libri".
Sono zone franche. Come le donne armene e turche che dormono assieme sulla tomba di un santo cristiano sul Bosforo; come i monasteri nel deserto egiziano, ora assediati dai fondamentalisti, dove Abuna Fanous ascolta i sogni dei pastori beduini che per parlare con lui si fanno ore di coda sotto il sole; oppure come la venerazione dei kosovari verso lo sfortunato santo dei serbi, il re Stefano, accecato dal proprio padre e ucciso dal figlio. Zone franche sono i cristiani e i musulmani che pregavano assieme nella moschea di Damasco, o quelli che hanno rimesso a posto le pietre del monastero di Deir Mar Musa, sempre nella povera Siria.
Sono queste le ultime oasi d’incontro tra le fedi, luoghi dove gli dei ancora si parlano, terre di promiscuitˆ millenaria scomoda ai predicatori dello scontro di civilt ˆ, luoghi dove la catena delle vendette si rompe, dove si mangiano le stesse pietanze, si intonano gli stessi canti, si fanno gli stessi gesti. Accadde anche nella mia Polonia prima della Seconda guerra, nel Marocco degli anni Cinquanta prima dell’esodo degli ebrei. Il buon santo è buono per tutti. A Mea Sharim, il quartiere dei Chassidim di Gerusalemme, i nomi delle sinagoghe rievocano paludi bielorusse, pianure polacche, bianche colline ucraine.
È un mondo parallelo e invisibile che va dall’Asia centrale all’America latina, dalle Russie al Medio Oriente. Il calendario dei miei spostamenti tra Gibilterra e l’Afghanistan segue anniversari di nascita e morte di uomini e profeti, pellegrinaggi e sacrifici, lune, solstizi e stagioni che annodano il tempo: persiano, aramaico, arabo o ebraico non importa, svela comunque una trama di sorprendenti parallelismi. Elia diventa tra i musulmani “Khidr il verde”; San Giorgio viene festeggiato nei Balcani da cristiani e musulmani; attorno alle Madonne si radunano donne musulmane e greco-ortodosse, di Napoli e di Istanbul.
Accade che a un certo punto sono le stesse immagini che vengono a cercarti. Svelano una continuità che abbiamo disimparato a osservare. Quello che faccio io è una cosa quasi infantile: raccolgo schegge di un grande specchio rotto, miliardi di schegge, frammenti incoerenti, pezzi, atomi, forse mattoni della Torre di Babele, tessere di un mosaico che non sarà mai completo. Poi metto tutto nell’ordine che mi sembra giusto, o forse solo possibile.
Dalla parte dei calendari
di Enzo Bianchi
LA SINGOLARE COINCIDENZA di calendario tra la festa della natività di Gesù e la commemorazione del profeta Muhammad dovrebbe scuoterci dal nostro analfabetismo nel dialogo islamo-cristiano, distoglierci dalle polemiche insensate sulla presenza o meno del presepe nelle scuole e nei luoghi pubblici istituzionali e spingerci alla pratica di quella “ospitalità culturale” di cui c’è grande urgenza per una convivenza buona e intelligente.
Conoscere le feste dell’altro, il significato delle celebrazioni, la reale portata delle tradizioni instauratesi nel corso dei secoli è il passo più semplice e tra i più fecondi per scoprire l’universo religioso di chi ci sta accanto e, al contempo, per riscoprire il fondamento di ciò che noi stessi ricordiamo, sovente offuscato dall’abitudine.
Dai primi secoli i cristiani fanno memoria della nascita di Gesù Cristo a Betlemme di Giudea il 25 dicembre: una data scelta perché in quel giorno il mondo romano celebrava e festeggiava il “sole invitto”, il sole che in quel giorno terminava il suo progressivo declinare all’orizzonte e ricominciava a salire in alto nel cielo, vincitore sulla tenebra che offusca la terra. Essendo Gesù Cristo vero sole, luce del mondo, era naturale fare memoria della sua nascita al solstizio d’inverno.
Per i musulmani invece la “commemorazione” (non la “festa”, perché nel calendario islamico solo due sono le “feste”: Id al-Fitr alla conclusione del mese di Ramadan, e Id al-Adha, la festa del Sacrificio) della nascita del Profeta, nel dodicesimo giorno del mese lunare di Rabi’ I che quest’anno cade appunto il 24 dicembre, risale a non prima del X secolo, con ispirazione alla festa cristiana, e oggi è particolarmente sentita a livello popolare e tra i bambini, sebbene sia contestata da alcuni che la giudicano troppo modellata sul Natale cristiano.
Due feste differenti, dunque, senza possibili sincretismi né simmetrie perché nella fede non si festeggia nulla insieme: ai cristiani è chiesto rispetto per la commemorazione dei musulmani, così come ai musulmani è chiesto rispetto per la festa cristiana della nascita di colui che per loro è comunque considerato un profeta, ma non colui che i cristiani confessano quale loro Signore e loro Dio. Insieme si può solo celebrare la gioia dell’altro e scambiarsi auguri di pace, e questo non è poco in un’umanità tentata di smentire la fraternità e di far divampare conflitti religiosi.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO" --- GIUBILEO DELLA MISERICORDIA. Dio? Onnipotente e giusto, ma innanzitutto misericordioso (di Gianfranco Ravasi)6 dicembre 2015, di Federico La Sala
- CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? (...) DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA (...) L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- [GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"->http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3699]
Dio? Onnipotente e giusto, ma innanzitutto misericordioso
di Gianfranco Ravasi (Famiglia cristiana, 06.12.2015)
«Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia!». Chi non conosce questa frase rivolta da Lucia all’Innominato nel ventunesimo capitolo dei Promessi Sposi? L’orizzonte umano e spirituale di questa virtù fondamentale si allarga alle tre grandi religioni monoteiste, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. L’itinerario di approfondimento in un tema così vasto potrebbe essere riassunto attraverso un particolare percorso, quello dei termini con cui la misericordia viene espressa nel libri sacri di queste religioni.
Ogni realtà, infatti, ha nel vocabolario adottato la sua identità più specifica: così, è evidente che per l’italiano l’organo “fisico” simbolico di questa virtù è il cuore (miseri-cordia) che conosce i fremiti della compassione e condivisione nei confronti del misero. Nel linguaggio biblico, invece, assistiamo a un fenomeno curioso perché, sia per l’ebraico sia per il greco, le due lingue capitali delle Sacre Scritture, la sede della misericordia è l’utero materno o la generatività paterna.
In ebraico è il sostantivo rehem, al plurale rahamîm, che designa primariamente il grembo materno e che viene trasformato in una metafora emozionale applicata innanzitutto a Dio che si ritrova, così, connotato anche femminilmente. Illuminante per l’immagine e il concetto è un passo del libro del profeta Isaia: «Si dimentica forse una mamma del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro ti dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai!» (49,15).
Esplicito è il Salmo 103 che rimanda, invece, alla generatività paterna: «Come un padre prova misericordia (rhm) per i suoi figli, così il Signore prova misericordia per quelli che lo temono» (v. 13), cioè per i suoi fedeli.
Non elenchiamo i passi biblici ove questa metafora generazionale è assegnata a Dio. Basti solo citare un paio di frasi: «Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immensa misericordia» (Isaia 54,7), ove è usato appunto il vocabolo rahamîm; «Pietà di me nel tuo amore, nella tua grande misericordia (rahamîm) cancella la mia iniquità», e questa è l’invocazione iniziale del celebre Miserere, il Salmo 51.
È interessante notare a questo punto che tutte le sure (o capitoli) del Corano (tranne la IX, frutto forse di un frazionamento) si aprono proprio con due aggettivi arabi modulati sulla stessa radice rhm del termine biblico: «Nel nome di Dio misericorde e misericordioso» (bismi Llah al-rahman al-rahim).
 È, perciò, paradossale che il fondamentalismo musulmano proceda proprio in senso opposto, ignorando il volto autentico del Dio del Corano che, prima di essere giusto, è compassionevole e misericordioso. Un tema esaltato in modo molto intenso da un’importante tradizione mistica musulmana nota come sufi, ove entra in scena ripetutamente il Dio amoroso e il fedele innamorato.
È, perciò, paradossale che il fondamentalismo musulmano proceda proprio in senso opposto, ignorando il volto autentico del Dio del Corano che, prima di essere giusto, è compassionevole e misericordioso. Un tema esaltato in modo molto intenso da un’importante tradizione mistica musulmana nota come sufi, ove entra in scena ripetutamente il Dio amoroso e il fedele innamorato. Certo, nel libro sacro dell’islam ci sono pagine aspre, e fin violente, come per altro accade nell’Antico Testamento. Ecco, quindi, l’importanza di un’interpretazione che cerchi di cogliere l’anima più profonda al di là delle formule contingenti. È il superamento del letteralismo fondamentalista perché, come scriveva san Paolo, «la lettera uccide, è lo Spirito che dà vita» (2Corinzi 3,6).
Certo, nel libro sacro dell’islam ci sono pagine aspre, e fin violente, come per altro accade nell’Antico Testamento. Ecco, quindi, l’importanza di un’interpretazione che cerchi di cogliere l’anima più profonda al di là delle formule contingenti. È il superamento del letteralismo fondamentalista perché, come scriveva san Paolo, «la lettera uccide, è lo Spirito che dà vita» (2Corinzi 3,6).Essere misericordiosi equivale, quindi, a essere presi “fin nelle viscere”, con un amore totale, spontaneo, assoluto, fino a compiere quel gesto estremo di donazione, delineato da Gesù nei discorsi dell’ultima sera della sua vita terrena: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Giovanni 15,13).
Passiamo, così, al greco neotestamentario ove - come accade anche per le Scritture ebraiche - sono adottati vari termini sinonimici, a partire dal verbo eleéô, presente nell’invocazione liturgica Kyrie eleison, «Signore, abbi misericordia!». Ma il più suggestivo è il verbo splanchnízomai, evocato 12 volte: esso rimanda proprio agli splánchna, le “viscere” materne della compassione. Gesù ha il cuore attanagliato da questa tenerezza misericordiosa quando incrocia i sofferenti sulle strade della sua terra.
Così gli accade quando s’imbatte nel funerale del ragazzo del villaggio galilaico di Nain, figlio unico di una vedova (Luca 7,13), o quando vede davanti a sé la folla affamata che lo ha seguito e ascoltato (Marco 6,34); anzi, in un altro caso, esplicitamente confessa: «Splanchnízomai per questa folla che mi segue da tre giorni senza mangiare» (Marco 8,3). La stessa esperienza si ripete davanti ai due ciechi di Gerico (Matteo 20,34), oppure con un lebbroso (Marco 1,41) e così via. È per questo che giustamente il grande scrittore Dostoevskij definiva nel suo romanzo L’idiota la misericordia come «la più importante e forse l’unica legge di vita dell’umanità intera».
-
> I TRE ANELLI. NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- NATALE, LA NASCITA DEL MESSIA - NON DELL’ "UNTO" DEL SIGNORE, E IL MESSIA CHE DEVE VENIRE1 dicembre 2015
ITALIA. NATALE 2008 DOPO LA NASCITA DEL MESSIA...
Per il generale e comune mondo accademico (laico e religioso), la parola "Cristo" (in greco) traduce la parola "Messia" (in ebraico), che viene fatta derivare dalla parola mashìach (משיח, "unto") ...
SEMBRA TUTTO CHIARO - COME L’ACQUA. Ma qui si parla di "unto" e, quindi, di "olio". E la cosa non è affatto chiara. E la "Vox populi", fosse anche la "voce" del popolo dotto e dei dottori, non è coincisa mai con la voce di Dio (Vox Dei). E’ stata sempre e solo uno strumento e uno slogan di manipolazione del popolo-massa da parte dei vari Signori della Terra e della Guerra.
IL MESSIA NON E’ AFFATTO UN "UNTO", UN MESSO DI DIO. A rigor di logica e di testi evangelici, la differenza è abissale, come tra il messaggio dell’Imperatore (ricordiamo la lezione di Kafka) portato da un com-messo - un funzionario, e il figlio dell’Imperatore, inviato dall’Imperatore stesso, che è uno con il Padre ed è il messaggio in persona - in carne ossa e spirito.
Per risalire la corrente e, come un pesce salomonico ("Ichthus"), ritrovare la sorgente d’acqua viva, dobbiamo quanto meno ripensare al "perch’io te sovra te corono e mitria" di Virgilio a Dante (Purg.; XXVII, 142) a Lutero (sacerdozio universale) e a don Milani (sovranità universale) e ricordarci di Melchisedech.
Il MESSIA è CHI sa CHI è, CHI sa CHI lo manda, e che sa CHE COSA vuole e CHE COSA viene a fare. Non è un servo - e non è "unto" (come un pesce morto, pronto da friggere)! Porta la "spada" come Salomone, e porta la "luce", il "fuoco" che non brucia, e illumina le tenebre! Egli sa da dove viene e dove va: al di qua e al di là di Mosè e di Elia, egli è il Principio e la Fine, l’Alfa e l’Omega.
IL MESSIA E’ IL FIGLIO DI DIO, E DEL DIO AMORE ("DEUS CHARITAS EST", 1 Gv., 4, 1-16). Con il Padre e insieme al Padre, lo Spirito Santo ("Deus charitas est"), Egli è il Messaggio e il Messaggero! La Verità, tutta intera, di fronte a Pilato: Gesù, "Dio salva". E’ la Persona che è la via la verità e la vita, per tutti gli esseri umani per procedere verso la Salvezza, la Terra Promessa - il Regno di Dio (Charitas - Amore).
QUESTO E’ IL MESSIA. E questo Messia è già venuto - ed è il figlio del Dio di Giuseppe e di Maria!!!. La luce splende nelle tenebre: è nato il Messia, è nato Gesù ("Dio salva") , oggi - e per l’eternità.
La tragedia è finita. Il buon-messaggio è arrivato sulla Terra: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli esseri umani di buona volontà...
ORA TUTTO CAMBIA ED E’ TUTTO CAMBIATO. "ORA", NOI, tutti gli esseri umani, SIAMO DIVENTATI PER NOI STESSI UN GRANDE PROBLEMA!!!
DA AGOSTINO, A ROUSSEAU, A NIETZSCHE, A WITTGENSTEIN, SEMPRE LO STESSO INTERROGATIVO. La questione antropologica antica ("che cosa è l’uomo?") diventa un’altra. Ora - dopo la venuta del Messia, dopo la venuta di "Cristo", siamo sollecitati e costretti a interrogarci diversamente, con più profondità e con più altezza: "CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?"(Nietzsche). "L’Io, l’IO, è il mistero profondo - e non in senso psicologico"(Wittgenstein).
"QUI E ORA", TOCCA A NOI DECIDERE. Siamo noi, tutti gli esseri umani, il Messia che deve venire sulla Terra.... ed è "qui e ora" che siamo chiamati a svegliarci e a decidere. Continuare ad essere servi, olive da schiacciare e farne olio dei vari Signori di Mammona di turno (come il teologo della "Dominus Jesus" e della "Deus caritas est" dell’af-faraonismo vaticano) per ungere il loro inviato di turno o, diversamente, diventare fratelli e compagni di viaggio di Gesù e quindi figli e figlie dello Spirito del Dio (Charitas)dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti.... decisi, finalmente, a vivere e a operare in Spirito di Giustizia e Pace?!
SAPERE AUDE! IL MOTTO DELL’ILLUMINISMO KANT LO RIPRENDE VIENE DAL LATINO DI ORAZIO E NON SIGNIFICA SOLO AVER IL CORAGGIO INTELLETTUALE DI SAPERE. Richiama l’esperienza e la sensibilità: significa anche avere il coraggio di as-saggiare. Nella Lingua d’Amore (Charitas) della Buona Novella (Eu-angelo) e della Buona-Grazia (Eu-Charistia), significa accogliere l’invito alla tavola della Sapienza del Messia (e non di qualche Cannibale unto dal Signore del posto) ed essere accolti a nostra volta come Messia: Prendete, questo è il mio corpo... questo è il mio sangue....
E’ una rinascita e una risurrezione, non la morte e la devastazione senza fine. Amore è più forte di Morte (Ct., 8.6). E’ l’inizio di un’amicizia infinita - non di una guerra, e di un dialogo nuovo - nella Lingua d’Amore.
La tragedia è finita. Inizia la Commedia. E Dante è sempre qui a ricordarcelo...
Il Messia è nato.
Che il Messia che deve venire, venga finalmente...
Moltissimi, moltissimi Auguri...
BUON NATALE
Federico La Sala
(18.12.2008
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- Giubileo: "L’Anno Santo sarà aperto ai musulmani": "I fatti di Parigi non cambiano l’agenda del Papa"16 novembre 2015
Giubileo, Parolin: "L’Anno Santo sarà aperto ai musulmani"
Il segretario di Stato Vaticano ribadisce che non ci sarà nessun passo indietro: "Lanciamo l’offensiva della misericordia. I fatti di Parigi non cambiano l’agenda del Papa". Bagnasco: "Non rispondiamo a violenza con altra violenza" *
CITTA’ DEL VATICANO - Rispondere alla violenza con la misericordia e l’accoglienza. Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ribadisce che il Giubileo (dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016) si farà, come aveva detto già il portavoce della Santa Sede Padre Lombardi, e che, anzi, accoglierà anche i musulmani: "Nel mondo lacerato dalla violenza, è il momento giusto per lanciare l’offensiva della misericordia" ha detto il cardinale in un’intervista al giornale cattolico francese La Croix. "Si può capire che dopo gli attentati ci sono sentimenti di vendetta ma bisogna davvero combatterli. Il Papa vuole che il Giubileo serva alle persone per incontrarsi, comprendersi e superare l’odio", spiega il segretario di Stato Vaticano. Dopo gli attentati, questa finalità esce rafforzata. Riceviamo la misericordia di dio per adottare questo atteggiamento verso gli altri. La misericordia è anche il più bel nome di dio per i musulmani, che possono essere coinvolti in questo Anno Santo, come l’ha voluto il Papa".
Gli attentati in Francia mostrano che "nessuno può considerarsi escluso dal terrorismo. Il Vaticano può essere un bersaglio per il suo significato religioso. Siamo in grado di aumentare il livello delle misure di sicurezza in Vaticano e nei dintorni. Ma non ci lasciamo paralizzare dalla paura" prosegue Parolin. "Questi fatti non cambiano niente nell’agenda del Papa".
Il cardinale è fermo nella condanna della violenza: "Non è possibile tollerare la violenza indiscriminata" e dunque, come ha detto il Papa lo scorso anno, è possibile fermare l’aggressore ingiusto. Parolin cita al proposito il Catechismo della Chiesa Cattolica, spiegando che per uno Stato è giusto difendersi, proteggere i suoi cittadini e respingere i terroristi. Ma "nel caso di un intervento dall’esterno, occorre cercare la legittimazione attraverso le organizzazioni che la comunità internazionale si è data".
Per rispondere a quanto è accaduto a Parigi "abbiamo bisogno di una mobilitazione generale in Francia, in Europa e in tutto il mondo. Una mobilitazione di tutti i mezzi di sicurezza, della polizia e delle forze di intelligence per sradicare il male del terrorismo. Ma anche una mobilitazione che dispieghi tutte le risorse spirituali per dare una risposta positiva al male. Ciò richiede l’educazione al rifiuto dell’odio, per dare risposte ai giovani che scelgono la jihad. Dobbiamo convocare tutti gli attori, politici e religiosi, nazionali e internazionali. Dobbiamo davvero fare uno sforzo per lottare e combattere insieme. Senza questa unità, questa battaglia, molto dura, non sarà vinta. Ed è necessario coinvolgere gli attori musulmani. Devono essere parte della soluzione".
I fatti di Parigi non devono spaventare e non devono fare reagire con violenza. L’arcivescovo di Genova e presidente della Cei Angelo Bagnasco invoca una maggiore vigilanza sì ma non una chiusura: "La strage di Parigi è un altro fatto dolorosissimo che mette inquietudine, ma che non deve spaventare l’Europa, né tanto meno la Francia a cui esprimo, come presidente dei vescovi italiani, tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza. Reagire alla violenza con altra violenza non risolverebbe nulla, ma moltiplicherebbe soltanto l’odio. La reazione deve essere quella di una maggiore vigilanza, che ritengo sia possibile in un senso di compattezza del popolo, non per rinchiudersi ma per continuare a vivere con fiducia".
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- "BASTARDI ISLAMICI". ’Ecco perché quel titolo istiga a odio e razzismo’, la lettera della scrittrice Houda Sboui.16 novembre 2015, di Federico La Sala
La scrittrice e docente italo-tunisina
’Ecco perché quel titolo istiga a odio e razzismo’, la lettera della scrittrice tunisina a Belpietro *
Houda Sboui (* ADNKRONOS, Pubblicato il: 16/11/2015
"Caro Maurizio, io e te non ci conosciamo. Tu sei italiano di nascita, io ho ottenuto la cittadinanza italiana più di quindici anni fa. Infatti, sono tunisina, musulmana e mi sono trasferita in Italia all’età di 23 anni per sposare mio marito, cattolico, dal quale abbiamo una figlia nata e cresciuta in Italia". Inizia così la lettera aperta scritta da Houda Sboui, studiosa e scrittrice tunisina di cittadinanza italiana, dopo il titolo ’Bastardi islamici’ pubblicato dal quotidiano Libero all’indomani dell’attentato di Parigi.
"Mia figlia è senza religione. Crede soltanto in un solo Dio. Un Dio che nessuno vede, che nessuno tocca eppure, ci crede e ci crediamo. In giro per il mondo, ci sono tantissime famiglie come la mia. Semplici famiglie che vivono giorno per giorno tutte le difficoltà della vita per dare il meglio ai figli", scrive Houda, autrice del libro ’Un ricordo per Jamal’, esperta in marketing, docente di lingua e civiltà araba nella scuola media di Palermo, ma anche autrice di uno studio comparato di legislazione tunisina ed europea, con particolare riguardo al diritto di famiglia islamico. "Per insegnare loro, valori come l’onestà, il rispetto, l’integrità e la tolleranza. Mi ricordo che a Tunisi, nella mia scuola elementare studiavamo Educazione Civica. Ci riempivano la testa di concetti come: rispettare il diverso, accettare le differenze, aiutare gli anziani e i malati, rispettare i genitori, la lista è lunga. Ed è esattamente quel che ho cercato di trasmettere a mia figlia", scrive la docente nella lettera affidata all’Adnkronos.
"Quel che accade oggi in nome dell’Islam mi fa riflettere molto. Poiché, persone come lei, intellettuali, intelligenti, colti e soprattutto giornalisti di professione, hanno una marcia in più rispetto a noi, semplici cittadini che viviamo lavorando e ascoltando le ’notizie’ che ci comunicate - scrive Houda - Notizie che prendiamo per ’vere’, poiché nel nostro immaginario collettivo sono ’verificate’ e ’fondate’. Eppure, mi rendo conto, che c’è sempre da parte vostra quel desiderio di colpire l’opinione pubblica con un titolo, che sai bene in fondo a te stesso, che è molto offensivo e soprattutto pericoloso. Pericoloso, quando viene percepito dal semplice lettore che non vuole approfondire l’argomento e non vuole addentrarsi in una materia così complessa come lo è l’Islam. Un titolo pericoloso che istiga all’odio e al razzismo. In fondo, con questo titolo, tu hai raggiunto il tuo obiettivo: sei in prima pagina, sui social è partita una petizione per radiarti dall’Albo dei giornalisti, hai venduto tante copie, sei sulla bocca di tutti, hai fatto simpatia a tanti che non ne possono più di avere gli immigrati sul territorio, per farla breve: hai colpito".
"Purtroppo, hai tralasciato un aspetto fondamentale che mette veramente in discussione la libertà di espressione - aggiunge Houda Sboui - Hai superato quella linea rossa necessaria, che distingue un bravo giornalista da un semplice giornalista divorato solo dalla voglia di vendere e raccogliere più denaro che può. Un giornalista che fa fatica a restare in prima linea e fa di tutto per essere in prima pagina. Capisco. È legittimo. Però, non hai pensato un attimo che hai fatto il gioco dei terroristi. Con il tuo titolo, hai dato loro la possibilità di sentirsi forti, bravi, intelligenti, perché percepiscono nell’opinione pubblica quel timore che indirettamente filtra da quel titolo. Che alcuni giornalisti, anziché andare fino in fondo e cercare la “vera verità” sul nuovo ordine mondiale, si lasciano andare a delle conclusioni superficiali, che fanno effetto sul momento e poi svaniscono nel nulla".
"Caro Maurizio, il tuo titolo come dicevo mi fa solo riflettere. Riflettere parecchio se insegni questo ai tuoi figli. Il tuo titolo mi preoccupa, perché, a mio avviso, non sei andato alla ricerca della vera notizia. Hai solo dato importanza ai terroristi - aggiunge nella lettera a Belpietro Houda Sboui - Ti invito, da musulmana molto tollerante, a rivedere la tua posizione in merito al Mondo di Oggi. T’invito a considerare il discorso del Presidente Putin all’occasione del Summit annuale di Valdai1, tenutosi dal 19 al 22 ottobre 2015. Un discorso, che l’editorialista dell’Asia Times, Pepe Escobar ritiene ’un discorso che merita di essere accolto con favore da tutto il mondo, in quanto espressione di ’politica vera”.
"Ti invito a rettificare il tiro e a chiedere scusa ai tanti musulmani che vivono in Italia e che giorno dopo giorno, insegnano ai loro figli il rispetto e la tolleranza. Ai tanti italiani che vogliono vivere in Pace e che costruiscono giorno dopo giorno un percorso di dialogo e fratellanza con i tanti stranieri che vivono in Italia - aggiunge - Ricordati che abbiamo sulla nostra coscienza, noi, i genitori di oggi, il dovere di lasciare un mondo in Pace ai ragazzi. Loro devono imparare a vivere insieme, l’uno nel rispetto dell’altro. Non puoi, solo perché hai in mano un potere straordinario, distruggere con un Titolo simile, anni e anni di integrazione e rispetto. Ancora di più se sono stati costruiti con fatica e difficoltà. Dimostra quanto sei grande facendo un piccolo passetto indietro. Sarai sicuramente apprezzato":
"’Bastardi Islamici’ mortifica i tanti italiani e i tanti musulmani per bene. ’Bastardi Islamici’ suona come “una chiamata alla guerra” e credimi, il mondo oggi, non ne ha bisogno - conclude la tunisina Houda Sboui -Cosa c’è meglio del dialogo e del confronto pacifico? Cosa c’è meglio della serenità e della fratellanza? E’ vero, sono concetti oramai seppelliti dal Dio Denaro, ma siamo esseri umani, e come tali, facciamo il nostro destino e insegniamo ai nostri figli di fare anche il loro. Quindi, la vita è nelle nostre mani, il mondo è nelle nostre mani e se vogliamo un mondo migliore, sicuramente, noi uomini lo possiamo ottenere. Tutto dipende da noi".
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO --- Ontologia massonica. I dialoghi di Lessing e Herder mettono in luce l’armonia scaturita dall’unione tra illuminismo e neoplatonismo (di S. Ronchey)7 giugno 2015, di Federico La Sala
Ontologia massonica
L’arpa del Gran Maestro
I dialoghi di Lessing e Herder mettono in luce l’armonia scaturita dall’unione tra illuminismo e neoplatonismo
di Silvia Ronchey (Il Sole-24 Ore, Domenica, 07.06.2015)
- E. Lessing - J.G. Herder, Dialoghi per massoni, a cura di Moreno Neri, Bompiani, pagg.542, € 30,00
Mozart e Goethe, Mesmer e Lavater, Robespierre e De Maistre. Quasi nessun intellettuale nel secolo della rivoluzione francese è riuscito a non essere massone. Il fatto è che illuminismo e massoneria non solo avevano ideali comuni, ma condividevano un linguaggio. Libertà, fraternità, soprattutto uguaglianza - tra classi e non solo tra pari grado - erano parole d’ordine anzitutto massoniche, come si vede bene negli scritti di due filosofi tedeschi, maestro e discepolo, illuministi e massoni, ora raccolti e per la prima volta tradotti in italiano con testo a fronte nel volume della collana di Giovanni Reale, Il Pensiero occidentale, l’ultimo ad avere visto la luce prima della morte del suo ideatore e direttore. L’Ernst e Falk di Lessing, suddiviso in cinque contraddittori, e i Massoni di Herder, due conversazioni che proseguono quelle del maestro, sono composti programmaticamente nella forma platonica - e teatrale - del dialogo e da molti considerati la vetta della filosofia massonica moderna.
Possiamo davvero parlare di vetta, o di filosofia? In un celebre aforisma Nietzsche scrisse che Herder «ebbe la sfortuna che i suoi scritti fossero sempre insieme troppo nuovi e già invecchiati», fossero «qualcosa di vecchio fin dal loro apparire». Forse aveva intuito una verità, ma senza comprenderne le implicazioni. Forse quella attribuita da Nietzsche a Herder è in realtà l’essenza del pensiero massonico: un pensiero antifilosofico che ha il preciso intento di essere al di sopra della portata degli incolti e al di sotto di quella degli intellettuali di professione.
Da parte di entrambe le categorie finisce per essere sottovalutato, ma è a un altro gruppo, per così dire mediano, che si rivolge: a quegli «uomini saggi che nei vari Stati non soggiacciono ai pregiudizi della loro religione di nascita, che non si lasciano abbagliare dalle elevate distinzioni civili, cui non ripugna l’irrilevanza sociale, ma che sono superiori ai pregiudizi del popolo e sanno esattamente quando il patriottismo cessa di essere virtù» - quegli uomini che Lessing fa descrivere a Falk alla fine del secondo dialogo con Ernst e che compongono il clero laico di una «chiesa invisibile».
Questi uomini “saggi” univano al culto della ragione proprio dell’illuminismo quello dell’antica sophia dei greci. Saggezza e ragione, Weisheit und Vernunft, canta Sarastro nel più celebre e diffuso manifesto massonico del Settecento tedesco, il Flauto magico di Schikaneder e Mozart. Secondo Lessing e Herder la massoneria è sempre esistita perché i suoi principi sono connaturati all’anima umana e perché il suo nucleo è innato, universale ed eterno come l’anima mundi e come lo spirito del mondo, il Weltgeist.
Che l’ontologia massonica di Lessing affondi le sue radici non solo nella tradizione degli antichi culti misterici ma specificamente in quella del neoplatonismo e nella sua idea di anima del mondo è stato già da tempo argomentato dal curatore del volume Moreno Neri, che ce lo ricorda a più riprese, sommessamente, con tipico understatement, nell’immenso lavoro di traduzione e di commento. È solo apparente il contrasto tra la matrice illuministica settecentesca e quella neoplatonica antica e bizantina, anche questa permeata di egualitarismo e utopia sociale, anche questa insieme mistica e razionale, esoterica e pratica, “speculativa” e “operativa”, per usare una distinzione avversata da Guénon.
È l’eredità delle scuole platoniche e neoplatoniche greche, perpetuate carsicamente lungo tutto il millennio di Bisanzio in un flusso ininterrotto dove la distinzione tra paganesimo e cristianesimo era irrilevante, a trasmettersi al rinascimento italiano e europeo per il concreto e personale tramite degli ultimi emigrés bizantini guidati da Giorgio Gemisto Pletone. È dalle fratrìai di quei greci, trapiantate a nordovest all’inizio dell’età moderna, che nascerà la fraternitas massonica settecentesca, nuova e globale fratrìa di cui l’illuminismo tedesco sgombrerà gli argini e sonderà i confini.
La complexio oppositorum illuminismo-neoplatonismo è l’elemento della cultura se non della filosofia massonica che i dialoghi di Lessing e Herder, grazie anche al loro commento, mettono in luce. Se nell’unione sapienziale degli opposti si realizza l’armonia universale, quella colossale arpa dalle molte corde che Herder vede in mano al Gran Maestro del mondo, come annoterà Heine in calce al suo secondo dialogo, è all’insegna di un’armonia discorde, dissonante e spesso dissacrante, che si rifonda la mass-masonry, la nuova massoneria massificata nel mondo della rivoluzione industriale.
Lessing sostiene il diritto all’autoiniziazione, fondata sul riscontro individuale, sull’intimo riconoscimento, sull’intuizione privata dei princìpi massonici, contrapposta al ritualismo narcististico dell’iniziazione esteriore. In politica legalista, democratico e libertario, in questi scritti esoterici Lessing fa balenare così un ideale anarchico e elitario, se non perfino reazionario, che culmina nel motto sibillino con cui si chiude il primo dei contraddittori tra Ernst e Falk: «Le vere azioni dei massoni hanno l’obiettivo di rendere superflua la maggior parte di quelle che si considerano comunemente buone opere». Più leggibile e forse più attuale la formula con cui Herder definisce lo scopo della «ricostruzione massonica dell’umanità»: essere onesti, prendere con semplicità in mano la cazzuola e «realizzare il bene là dove la politica dei governi non arriva o fallisce, ovvero dare aiuto ai deboli, ai poveri e ai giovani».
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO --- La geopolitica di Francesco e il dialogo (di Silvia Ronchey)8 giugno 2015, di Federico La Sala
Il cristianesimo non è un "cattolicismo"!
La geopolitica di Francesco e il dialogo
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 08.06.2015)
“UNA terza guerra mondiale combattuta a pezzi” l’ha definita Bergoglio nell’omelia tenuta sabato mattina allo stadio olimpico Koševo di Sarajevo durante l’oceanica messa gremita di reduci della guerra che ha insanguinato i Balcani negli anni ’90 del Novecento. Così, con l’usuale raffinatezza di un linguaggio solo apparentemente semplice, di una comunicazione intellettuale a più livelli, in contrapposizione a quello che ha definito “il clima di guerra della comunicazione globale”, papa Francesco ha fotografato lo scenario bellico su cui si è aperto il terzo millennio e rinominato il conflitto cui è stata applicata da molti, non ultimo il precedente papa, la contestabile nozione di scontro di civiltà.
“Scontro fra culture” al plurale, ha concesso Bergoglio, può se mai definirsi la guerra in corso. Non ci si aspetta di meno da un papa colto che ha fatto dell’understatement la propria cifra e del sottotesto il proprio mezzo; che ha adottato il motto di Ignazio di Loyola e di Hölderlin: Non coerceri maximo, contineri minimo, divinum est , “Scavalco il grande confinandomi nel piccolo”; che battendosi contro il “tomismo decadente” ha rivendicato il manifestarsi di dio nella rivelazione storica; il cui programma affonda nei millenni e guarda all’eredità dell’ellenismo e di Bisanzio, dunque all’ecumenismo come priorità; che sul dialogo interconfessionale, prima e oltre che interreligioso, gioca la sua partita a scacchi col secolo.
Il pontificato di Bergoglio è in questo senso erede diretto di quello del “papa geopolitico” Wojtyla. Dopo il definitivo esaurirsi nel secolo breve del fantasma imperiale postbizantino il blocco ottomano caduto al suo inizio, nel conflitto innescato proprio a Sarajevo, quello russo-sovietico dissolto alla sua fine, con la caduta del muro e il golpe di Eltsin - il millennio si è aperto su un nuovo scenario di conflitto.
La Terza Guerra Mondiale a Pezzi di Bergoglio è molteplice, scava più solchi, dischiude più fronti; faglie di attrito antichissime ricominciano a entrare in moto complesso; un unico macroscopico sussulto tellurico scuote i Balcani, il Caucaso, la Mesopotamia, dilaga nel Medio Oriente, destabilizza e arroventa pezzo a pezzo le aree geografiche in cui i due imperi avevano imposto identità unitarie trasversali sia alla divisione stereotipa tra oriente e occidente, sia a quella tra religioni. È allora che si insinua nella fantasia collettiva l’idea di uno scontro frontale di civiltà tra oriente islamico e occidente cristiano.
Un’idea che Bergoglio rifiuta. Lo indica già in sé la mossa del cavallo con cui ha fatto slittare il discorso sull’islam allo scacchiere balcanico e partire il messaggio da Sarajevo, covo di antichi demoni e città martire dall’uno all’altro capo del Novecento, menzionando le sue diversità etniche e religiose, sottolineando la sua sofferenza storica, definendola “la Gerusalemme dell’occidente” con l’antico linguaggio che i papi rinascimentali applicarono a Costantinopoli nel primo frangente geopolitico che cinque secoli fa, a metà del quindicesimo, fece riflettere l’élite della curia romana sulla sorte degli equilibri mondiali alla prima islamizzazione ottomana dei Balcani.
Non è un caso che Bergoglio lanci il suo messaggio alla vigilia del G7, dove sia sulla questione ucraina, sia sui dossier Libia, Iraq e Siria il principale invitato è quello assente: il convitato di pietra Putin.
Nella Terza Guerra Mondiale a Pezzi l’area slavo-balcanica interseca alla memoria islamica il più decisivo interlocutore di Bergoglio: la chiesa ortodossa, assuefatta a una perdurante fedeltà politica alla sfera russa, che già nel ’99 Julia Kristeva analizzava su Le monde partendo dalla millenaria alterità teologica tra chiesa d’oriente e d’occidente sintetizzabile nella contesa trinitaria sulla processione dello Spirito Santo.
Il problema di Francesco, più ancora che quello della jihad, è quello del Filioque. È il risanamento dello scisma tra le chiese cristiane, prima ancora del patteggiamento tra cristianesimo e islam, a pesare nell’agenda del papa che per primo dopo Wojtyla, con raffinatezza gesuitica, ha ripreso il filo della geopolitica.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO --- Globalizzazione e dialogo interreligioso (di Franco Toscani)30 gennaio 2015, di Federico La Sala
Globalizzazione e dialogo interreligioso
di Franco Toscani *
E’ possibile oggi - soprattutto riflettendo a partire dai tragici attentati parigini recenti - gettare le basi autentiche di un dialogo interreligioso che merita più che mai di essere perseguito nel nostro tempo tormentato, se vogliamo dare un futuro all’umanità, consistenza all’idea di “uomo planetario”, alle possibilità della convivenza nell’età della globalizzazione?
E’ possibile, ma è molto difficile. Da questo punto di vista possiamo rintracciare una linea filosofico-teologica, culturale e antropologica che da Lessing e dal meglio della cultura illuministica perviene a toccare e a intrecciarsi con alcune proposte e tematiche culturali e antropologiche decisive del nostro tempo.
Mi riferisco, per limitarci a qualche esempio, all’etica della responsabilità di Hans Jonas, al progetto di Weltethos (etica mondiale) di Hans Küng, all’idea di Terra-Patria di Edgar Morin, alla cultura e all’etica dell’ “uomo planetario” di Ernesto Balducci. Fin dal secolo XVIII Lessing suggeriva la necessità di evitare i settarismi per riconoscere le ragioni anche parziali dell’altro; se i “caratteri divini” possono essere rintracciati in tutte le religioni, è aperta la via al dialogo interreligioso, una via difficile, che si scontra con pregiudizi diffusi e mentalità radicate, ma possibile.
Nella mancanza del dialogo interreligioso è sempre possibile il prevalere della violenza, dell’odio, del muro contro muro, della minaccia alla convivenza fra diversi. La violenza è sempre in agguato, i più forti e prepotenti tendono a imporsi senza esitazioni grazie anche alla “bile bigotta” dei credenti fanatici di tutte le risme .
Centrale in Lessing è la metafora del palazzo, che molto probabilmente fa riferimento alla grandezza della verità e all’essenza della religione. Ora, del palazzo molti possiedono “schizzi” particolari che però tendono a essere scambiati per l’intero. Ognuno tende a considerare e a valorizzare solo il proprio schizzo per salvare il palazzo minacciato dalle fiamme, ma in realtà tende a salvare essenzialmente il proprio schizzo, il proprio punto di vista sul palazzo.
Il palazzo è destinato a bruciare se gli attaccabrighe hanno il campo libero. Gli “schizzi” del palazzo stanno a indicare il rapporto degli uomini con la verità. Tali “schizzi” non rappresentano soprattutto le nostre ostinate cecità e illusioni che ci fanno fissare lo sguardo solo su alcuni particolari, impedendoci di scorgere la verità in tutta la sua ampiezza? Gli “schizzi” non ci parlano dei nostri limiti, piccolezze, manchevolezze in rapporto alla verità che nessuno possiede, di cui siamo al servizio e parte, senza poterne scorgere tutta l’immensa portata?
La questione degli “schizzi” interroga tutte le religioni monoteistiche, secondo cui una sola di esse può esser vera. Si tratta qui della superbia che solo il proprio Dio sia il vero Dio, della pia follia di avere il “Dio migliore” . Tali superbia e follia mostrano il volto feroce della violenza tra le religioni, della rivalità, della diffidenza e dell’odio reciproci, della guerra e fanno dimenticare o sottovalutare il fatto essenziale che siamo tutti - prima di ogni altra aggiunta, definizione e caratteristica - uomini in mezzo ad altri uomini, abitanti mortali del pianeta, esseri fragili e bisognosi.
I guai cominciano quando ogni gruppo religioso proclama polemicamente il proprio primato culturale e spirituale sugli altri . Siccome è però impossibile provare e stabilire quale sia la vera fede ed è contemporaneamente giusto garantire in questo e altri campi la libertà di coscienza sancita dalla nostra Costituzione repubblicana e dalle carte europee, si tratta di individuare un minimo comune denominatore etico che possa unirci al di là di tutte le ovvie e necessarie differenze culturali e religiose: la legge dell’amore, l’invito all’amore reciproco, libero da pregiudizi, al rispetto della eguaglianza e dignità di tutti gli esseri umani.
Il Dio inafferrabile che “è amore” (come dicono tutte le religioni) ama tutti gli uomini senza distinzione alcuna. L’amore, la difesa ovunque della dignità umana: questo è il fondamento comune a tutte le religioni, conducente ad amare gli uomini nella loro libertà e autonomia, nella concretezza della loro condizione e vita quotidiana.
Molti s’illudono di essere saggi, ma sono soltanto furbi, vivono come tali e obliano che la saggezza - non la ricchezza, il potere, la gloria e altri miti mondani - è il nostro bene più grande . Per un’umanità evoluta - la cui coscienza del male in cui si radica la storia umana è acuta - la crudeltà e la disumanità sono il peccato dei peccati.
Sappiamo che la crisi dell’umanità e della civiltà è dovuta innanzi tutto alla sfiducia nell’uomo e nelle sue possibilità creative, è una crisi del senso e della direzione della nostra civiltà. Ma occorre avere il cuore aperto a ogni virtù, lo spirito sgombro dai pregiudizi e disposto a capire ogni bellezza; anche la religiosità, scevra da ogni integralismo e fanatismo, è intimamente, indissolubilmente congiunta al senso del buono e del bello.
Può darsi, allora, che il dialogo interreligioso non sia altro che una “dolce illusione”, ma esso merita comunque di essere tenacemente perseguito per contribuire a promuovere il presente e il futuro della civiltà planetaria.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
L’ILLUMINISMO, OGGI. Al di là del relativismo, dello scetticismo, e dell’assolutismo ....
 LESSING IL SAGGIO. LA "RELIGIONE DELL’UMANITA’" E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO. Un lavoro del prof. Franco Toscani
LESSING IL SAGGIO. LA "RELIGIONE DELL’UMANITA’" E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO. Un lavoro del prof. Franco Toscani -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- Dio ha molti nomi. Il saggio di John Hick (di Massimo Nava)28 gennaio 2015, di Federico La Sala
Per John Hick l’unico dio ha molti nomi
di Massimo Nava (Corriere della Sera, 28.01.2015)
In tempi di profeti di sventure e previsioni dello scontro di civiltà, giunge a proposito il saggio di John Hick Dio ha molti nomi (Fazi, pp. 139, e 17,50), il grande teologo inglese, noto anche per posizioni controcorrente che suscitarono aspre critiche nelle gerarchie. È un libro profondo, ma di facile lettura, come se soluzioni a problemi immensi fossero alla portata di tutti, una volta sgombrato il campo dall’ignoranza, dal pregiudizio, dal fanatismo ideologico. Ed è un libro che andrebbe adottato nelle scuole e nei luoghi di preghiera di ogni confessione, soprattutto dopo la tragedia di Parigi.
Hick parte dalla constatazione che la realtà è cambiata, anche se molti fingono di non vedere o sognano impossibili ritorni al passato. La globalizzazione economica, l’immigrazione, l’integrazione europea e americana hanno messo a stretto contatto culture, esperienze spirituali e pratiche religiose che un tempo rimanevano distanti, circoscritte al proprio ambito d’influenza. Oggi bambini di ogni razza e convinzione frequentano le stesse scuole, vivono negli stessi quartieri e i loro genitori fanno la spesa negli stessi negozi. Religioni poco conosciute, a volte minate da ostilità reciproca e pregiudizio, si trovano a convivere, mescolandosi al dibattito sulle radici della società, sull’identità collettiva, sulla diversità. Dibattito senza via d’uscita, che alza la soglia dell’intolleranza ogni volta che le possibilità di confronto vengono ridotte o azzerate da fatti criminali, episodi di terrorismo, cronache dell’«invasione». E ogni volta che una provocazione intellettuale (è il caso del libro di Houellebecq) raggiunge più la pancia che il cervello dei lettori.
Fortemente influenzato dalla filosofia kantiana, Hick sostiene che sia possibile e auspicabile andare oltre la tolleranza e il dialogo fra le diverse fedi, per cogliere il senso ultimo di un’esperienza spirituale comune che superi millenni di dogmi. Allo stesso modo in cui l’universalità dei diritti umani dovrebbe conciliare culture e sistemi diversi, la teologia universale di Hick non pretende di annullare le diversità, bensì di togliere di mezzo le pretese superiorità di una religione sull’altra.
A ben vedere - secondo Hick - dovrebbe sembrare assurdo che il Dio «signore e creatore di tutte le cose» non sia lo stesso per tutti, al di là delle tradizioni diverse nel corso dei secoli. Così come dovrebbe suonare assurdo - anche per i cristiani - che l’unico Dio abbia poi favorito una sorta di gerarchia dell’umanità, per cui alcuni miliardi di fedeli sarebbero esclusi dal paradiso. Hick ricorda il Concilio di Firenze del 1438, in cui si sostenne che «né pagani, né ebrei, né eretici o scismatici parteciperanno alla vita eterna, ma andranno al fuoco eterno».
Da allora, la Chiesa ha fatto passi giganteschi verso il dialogo interreligioso, ma l’ultimo passo, quello decisivo secondo Hick, è una reinterpretazione delle Scritture in chiave moderna, distinguendo fra valori etici del messaggio e sovrastrutture della tradizione. Un cammino immenso, che dovrebbe essere percorso anche dalle altre religioni, in grado di riconciliare gli uomini con la fede propria e degli altri, con la scienza e la tecnica, con l’insegnamento dei grandi maestri dell’umanità: Gesù, Maometto, Buddha, Mosè e i profeti.
-
> I TRE ANELLI. NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- AL DI LA’ DEL CATTOLICISMO E DEL TOTALITARISMO DELLE RELIGIONI. "Islam. Un nuovo spettro si aggira per l’Europa" (di Vito Mancuso))22 gennaio 2015, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
 Islam
Islam
 Un nuovo spettro si aggira per l’Europa
Un nuovo spettro si aggira per l’Europa
 Come il comunismo anche l’Islam è totalizzante, nel senso che non è solo religione e ciò che questa porta con sé
Come il comunismo anche l’Islam è totalizzante, nel senso che non è solo religione e ciò che questa porta con sé
 Ma è anche politica
Ma è anche politica
di Vito Mancuso (la Repubblica, 22.01.2015)
“UNO spettro si aggira per l’Europa, lo spettro del comunismo”. Così inizia il Manifesto del Partito Comunista che Marx ed Engels pubblicarono a Londra nel 1848 e da allora dovettero passare quasi 150 anni perché quello spettro si placasse trovando pace. Quanto tempo dovrà passare perché avvenga lo stesso per lo spettro che nel frattempo ne ha preso il posto? Anche oggi infatti uno spettro si aggira per l’Europa, lo spettro dell’Islam.
Il parallelo con il comunismo non è casuale. Ben prima di diventare totalitario infatti il comunismo fu già da subito totalizzante. Non era cioè solo prassi politica, ma riguardava anche la dimensione interiore della persona alla quale si proponeva come cultura, etica, estetica, visione complessiva del mondo, non senza un’accentuazione religiosa per la fede e l’obbedienza richieste.
Allo stesso modo anche l’Islam è totalizzante, nel senso che non è solo religione e ciò che la religione porta con sé (etica, estetica, Weltanschauung); è anche politica, e nel suo essere tale anch’esso, da totalizzante, diviene spesso totalitario.
È possibile che una religione o un’ideologia totalizzante non diventi totalitaria? È possibile che le religioni (le quali sono tutte totalizzanti, perché per meno non sarebbero religio) non producano totalitarismi? Oppure, perché si possa dare libertà e quindi democrazia, occorre necessariamente la destituzione del pensiero totalizzante a favore del relativismo?
Venne poi Cartesio che nel 1637 segnò la svolta del pensiero filosofico europeo dicendo «io penso, quindi sono» ( cogito ergo sum ), ovvero la più grande consapevolezza di me stesso in quanto uomo mi è data dal mio essere pensante. Da qui si aprì la strada all’Illuminismo e al cammino faticoso (e sanguinoso) verso la democrazia, dove l’io penso filosofico divenne un io penso politico e sociale.
La Chiesa cattolica si oppose sistematicamente a questo cammino: scomunicò Lutero, mise all’Indice Cartesio e gli illuministi, avversò ogni rivendicazione in tema di diritti umani, soprattutto la libertà di coscienza. Alla fine però dovette cedere e finì per rivedere la sua stessa dottrina: la libertà di coscienza, che Gregorio XVI in linea con molti altri pontefici aveva definito un “delirio” ( deliramentum), un secolo dopo, il 7 dicembre 1965, divenne parte della dottrina cattolica con il documento Dignitatis humanae del Vaticano II e oggi è parte integrante della predicazione dei Pontefici.
La Chiesa si è convertita? È stata costretta a convertirsi, avendo perso lo scontro con la modernità. La quale però, non lo si dimentichi, venne suscitata da credenti quali Lutero e Cartesio, e nutrita anche da altri credenti tra cui gli illuministi tedeschi Lessing e Kant, e se lo sottolineo è per evitare banali conclusioni laiciste e far comprendere quanto il discorso sia dialetticamente molto complesso. In ogni caso l’esito del processo di modernizzazione ci consegna oggi una religione quale quella cristiana che, mantenendo la sua carica totalizzante per la vita individuale, non cade per questo nel totalitarismo sociopolitico.
Potrà avvenire lo stesso per l’Islam? Potrà giungere esso ad accettare lo spirito della democrazia, della diversità, della dimensione plurale dell’esistenza che il mondo oggi impone? Nessuno lo sa e certamente sarà un processo molto duro che condizionerà la vita dell’Europa per tanti anni a venire.
Che fare per favorire questo processo? Vi sono misure a breve, a medio e a lungo termine. A breve termine si tratta di combattere il terrorismo con tutta la durezza necessaria, monitorando anche la predicazione dei vari imam e impedendo quella che si rivela fomentatrice di odio, ma senza mai associare al terrorismo l’Islam in quanto tale: la distinzione tra terroristi e musulmani è assolutamente decisiva se non si vuole avere un miliardo e mezzo di nemici e ostacolare l’evoluzione positiva dell’Islam.
A medio termine si tratta di giungere finalmente al riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte della comunità mondiale e mettere fine per sempre alla progressiva espansione dei coloni ebrei, facendo anzi tornare costoro nei territori di provenienza.
Oggi in Europa occorre sorvegliare con le armi le sinagoghe, ma l’Islam non è mai stato antisemita, gli ebrei hanno vissuto per secoli nei territori islamici, e quando il grande filosofo Mosè Maimonide fu costretto a lasciare Cordova sua città natale perché era giunta al potere una dinastia islamica oltranzista, non pensò minimamente di rifugiarsi nella Francia cristiana ma rimase ancora in terra musulmana, prima in Marocco poi in Egitto.
Se oggi molti musulmani stanno diventando nemici degli ebrei è solo per l’umiliazione sistematica cui è sottoposto da anni il popolo palestinese, con la compiacenza degli Usa. L’Europa non può e quindi non deve permettere più il protrarsi di questa ingiustizia.
Per quanto concerne le misure a lungo termine entra in gioco il discorso economico ed educativo, ovvero la possibilità di avere un lavoro e la scuola. Mi soffermo su quest’ultima. Il compito della scuola è offrire strumenti per la comprensione del mondo. Ora è evidente che senza mettere in gioco la religione il mondo oggi non lo si capisce.
In questa prospettiva l’Italia non può più permettersi di sprecare un’occasione così importante come l’ora di religione, di grande rilievo per la potenzialità geopolitica e al momento ben lungi dall’essere all’altezza della situazione.
Occorre trasformare l’ora attuale da insegnamento della religione cattolica in un’ora in cui siano presentate “tutte” le religioni, ovviamente in proporzione all’importanza di esse per l’Italia, e quindi con particolare attenzione ai monoteismi, ma senza trascurare le religioni orientali.
Quest’ora di “religioni”, in cui non si tratta di credere ma di conoscere, deve essere obbligatoria e avere la medesima dignità curricolare delle altre. La condizione è ovviamente togliere alla Chiesa cattolica ogni potere in merito a programmi e scelta degli insegnanti, costruendo un’ora del tutto laica, rispettosa in egual modo delle diverse religioni e super partes , dalla quale nessun cittadino deve temere condizionamenti a priori alla coscienza, per lo meno non diversamente da quanto li si tema nell’ora di letteratura o di filosofia.
Anche così i nostri ragazzi impareranno fin da piccoli a conoscere i lati positivi delle religioni altrui e a non averne paura, quella paura che genera l’odio di cui si nutre lo spettro che si aggira attualmente nelle nostre menti, ma senza la quale esso potrà placarsi e trovare finalmente accoglienza e pace.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- I pugni, Francesco e tutti gli altri, imparate a tenerli in tasca (di Monica Lanfranco - La mamma, Dio e la nonviolenza). .18 gennaio 2015, di Federico La Sala
Società
La mamma, Dio e la nonviolenza
di Monica Lanfranco (Il Fatto, 18 gennaio 2015)
Avevamo bisogno, dopo il bagno di sangue e le puntualizzazioni su chi è o non è Charlie, dell’esternazione del Papa circa l’onore della mamma da difendere?
No, purtroppo. Pur sapendo che ogni evento, notizia ed emozione viene triturata nella turbina social che nulla sedimenta qualche pulviscolo resta impresso, e il pugno papale è memorabile, quindi doppiamente dannoso.
Usando l’ottimo stile comunicatore tanto caro a Berlusconi e a Renzi (la scanzonata mescolanza di pop e friendly, con selfie, corna, barzellette e frasi a effetto) il campione della fede Papa Francesco smentisce la sobrietà manifestata nella scelta del suo nome e mette ko qualche decennio di faticosa costruzione di pratiche politiche collettive nonviolente e antisessiste.
Proprio lui che, pochi mesi fa, sull’omosessualità affermava ‘chi sono io per giudicare’, oggi sostiene che chi insulta la mamma si deve aspettare un pugno. Seguono interpretazioni della sottile metafora da parte di autorevoli uomini: Eugenio Scalfari scrive che non si può chiedere al Papa di essere volterriano, visto che la ‘mamma’ di Bergoglio è la chiesa cattolica, e Moni Ovadia trova l’esternazione lungimirante, plaudendone l’iniziativa, perché manda un messaggio di forza della comunità dei credenti cattolici, pronti anche loro a difendere la chiesa così come gli islamici han dimostrato di difendere la loro fede. Si profila dunque l’annuncio di una simpatica nuova crociata che, date le premesse, sarà la fine della vita sulla terra nel nome di una entità (dio) che non ha ancora manifestato la sua esistenza. Non era meglio morire nel nome di qualcosa di più sostanzioso? Pubblicità
Qui e ora, in attesa di sviluppi io, modestamente donna, madre e attivista nonviolenza e femminista, trovo che la frase così lungimirante mi scaraventi in un angolo per tre volte: come attivista, come donna e come madre.
I pugni non sono simboli, sono carne e ossa contro altra carne e ossa, chi ne ha fatto esperienza lo sa, e con buona pace dell’epos letterario che racconta di amicizie virili cementate dai cazzotti essi restano un gesto d’aggressione e di violenza, che raramente non ha conseguenze.
Nelle scuole in cui vado a fare formazione sulla violenza di genere affronto ogni volta la semplificazione da parte dei ragazzi e delle ragazze verso lo schiaffo, la spinta, il pugno, gesti spesso vissuti come ‘inevitabili’, ‘naturali’, giustificati dalla gelosia e dalla necessità di far rispettare onore, gerarchia, proprietà: lei guardava un altro, lui guardava un’altra, lei è mia, lui è mio, che hai da guardare, che cosa hai detto di mia sorella, di mia madre, della mia ragazza?
Clima da rissa, da stadio, da caserma, (ma siamo a scuola) inarginabile facendo sottili distinguo: un pugno non è peggio di uno schiaffo, di una spinta.
Le mani o si alzano o si tengono abbassate: la bella campagna di Intervita lo dice con efficacia, ma evidentemente al Papa è sfuggita. Dietro e prima del pugno c’è la visione delle donne come esseri da difendere, ma solo se e quando sono in una relazione di proprietà: non è forse vero che tutte le donne sono puttane, tranne mia madre e mia sorella? Eccolo il desolante riassunto dell’ancestrale, brutale logica (e pratica) del patriarcato globale, che spesso risuona nei nostri cortili con i proclami pro famiglia della subcultura leghista e fascista (donne e buoi dei paesi tuoi, un orrore senza fine).
Sono atea, e credo con passione che alla violenza di qualunque tipo si debba opporre altro, diametralmente lontano da ogni eco di aggressione.
Non possiamo smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone, scrive Audre Lorde. O s’insegna in famiglia, scuola, chiesa e dopolavoro una cultura del rispetto, del ripudio della violenza (dalle parole ai gesti), o presto si arriva a superare quella soglia, quel limite, che trasforma il faticoso ma fecondo terreno del conflitto nella rapida e mortale guerra.
Guerra tra le persone, le comunità, i popoli, il mondo. E’ una certezza, oggi: dal pugno alla guerra santa il passo non è lungo.
I pugni, Francesco e tutti gli altri, imparate a tenerli in tasca.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- Papa Francesco: "Se uno mi offende la madre gli do un pugno"!!!16 gennaio 2015, di Federico La SalaPapa Francesco: "Se uno mi offende la madre gli do un pugno"
 (ANSA, 15 gennaio 2015, 20:34 - video).
(ANSA, 15 gennaio 2015, 20:34 - video).
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- Papa Francesco: "Se uno mi offende la madre gli do un pugno"!!!17 gennaio 2015, di Federico La Sala
La battuta di Francesco sul pugno spiazza laici e fedeli
Commentano le parole del Papa sul volo dallo Sri Lanka alle Filippine De Paolis, Lajolo, Cacciari, Tarquinio e De Masi. «Ha posto un limite». «È poco cristiano»
di Giacomo Galeazzi *
Città del Vaticano
Il «pugno» del Papa scuote il Sacro Collegio, gli intellettuali laici, i media cattolici. «Quella del Pontefice è una constatazione: nella vita di ogni giorno accade così - afferma il cardinale canonista Velasio De Paolis -. Se offendo qualcuno devo attendermi una contro-offesa. Purtroppo, infatti, la quotidianità non segue lo spirito del Vangelo e viene disatteso il monito di Gesù a porgere l’altra guancia». Ma «la reazione a una offesa verbale dovrebbe, quantomeno, essere un’altra offesa verbale e non un atto di violenza fisica». Comunque «chi ha realizzato quelle vignette avrebbe dovuto trattenersi dal farlo nella consapevolezza delle prevedibili conseguenze», aggiunge De Paolis. Il porporato di Curia Giovanni Lajolo ribadisce che «il male si vince solo con il bene», però riconosce che «esiste la libertà di opinione, non quella di insulto», altrimenti «vivremmo in un mondo di rissa continua».
Il quinto comandamento
In ogni modo, sottolinea Lajolo, «è lo spirito che fa la musica» e «un pugno morale può essere più duro di quello fisico». Certo, precisa Lajolo, «niente giustifica la reazione estrema e vile alle vignette messa in atto dagli attentatori di Parigi» che «non combattono faccia a faccia ma aggrediscono alle spalle persone disarmate». Parimenti «non va calpestato il quinto comandamento: non uccidere, non offendere», avverte il cardinale.
A Milano l’arcivescovo Angelo Scola non commenta le parole del Pontefice ma rimanda alla giornata di preghiera contro la violenza del 18 gennaio. «È una battuta non proprio cristiana, ma simpatica - osserva il filosofo Massimo Cacciari -. Francesco esprime l’impossibilità in questo secolo di porgere l’altra guancia e di rispettare le Beatitudini evangeliche che chiedono di amare il proprio nemico. Il Papa ha cercato l’effetto umano, forse anche troppo umano». Per il sociologo Domenico De Masi «il pugno viene poco prima del colpo di kalashnikov». Inoltre «non è vero che la satira può dire tutto: nulla è svincolato dalla legge», però, avverte De Masi, «serve un principio di proporzionalità tra offesa e difesa: a chi insulta Allah o la Madonna si risponde con una querela, non con una revolverata e neppure con un cazzotto».
Sacralità intima
Quella del pugno la trova, invece, «un’immagine geniale» Marco Taquinio, direttore del quotidiano dei vescovi Avvenire, secondo cui il Pontefice indicando la figura della madre rimanda a una sacralità intima, valida sul piano umano sia per i credenti in qualunque fede sia per gli atei: «Anche tra amici può accadere di superare il senso del limite e di provocare una reazione violenta. Ma se niente è rispettato, precipitiamo in una condizione di scontro permamente e la trivialità è cieca».
Indifferenza e presunzione
Secondo Taquinio quando chiudiamo gli occhi su qualunque persecuzione verso chiunque ovunque sia perpetrata, prepariamo l’irruzione dell’odio e della violenza anche nelle nostre città, nei luoghi simbolo delle nostre libertà, nelle nostre stesse case. «Il male si nutre di indifferenza e di presunzione». E solo una scelta limpida e chiara per la pace nella giustizia e nella libertà possono sventare i piani di dominio e di morte dei terroristi che osano agire «in nome di Dio». E «le nostre società aperte sono vulnerabili», quindi «l’uscita del Papa è una sintesi perfetta del rifiuto della logica di morte».
-
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- Le malattie che Papa Francesco ha elencato e analizzato invitando alla riflessione, alla penitenza e alla confessione, in questi giorni che separano dal Natale.23 dicembre 2014, di Federico La Sala
Papa: ’Ecco le 15 malattie della Curia’
’Primo sentirsi immortale. Cimiteri pieni di chi si sentiva tale’
di Redazione (ANSA 22 dicembre 2014)
Ecco le malattie che il Papa, nella udienza alla curia per gli auguri di Natale, ha elencato e analizzato invitando alla riflessione, alla penitenza e alla confessione, in questi giorni che separano dal Natale.
La prima é la "malattia del sentirsi immortali, immuni da difetti, trascurando i controlli" un corpo che non fa "autocritica, non aggiorna e non cerca di migliorarsi, è un corpo infermo". Il Papa ha suggerito una "ordinaria visita ai cimiteri, dove vediamo i nomi di tante persone che si consideravano immuni e indispensabili". Questa malattia, ha commentato il Papa, "deriva spesso dalla patologia del potere, dal narcisismo che guarda la propria immagine e non vede il volto di Dio impresso" negli altri, sopratutto "i più deboli". "Antidoto a questa epidemia - ha suggerito il Pontefice - è la grazia di sentirci peccatori, e il dire ’siamo servi inutili’".
La secondo è la "malattia del martalismo, che viene da Marta, la malattia della eccessiva operosità", di coloro che "si immergono nel lavoro trascurando inevitabilmente la parte migliore, il sedersi ai piedi di Gesù". "Trascurare il necessario riposo - ha ammonito - porta allo stress e alla agitazione" un "tempo di riposo da trascorrere con i familiari è necessario", come necessario è "rispettare le ferie come momenti di ricarica spirituale e fisica", ricordando quanto dice il libro del biblico del Quelet, ’c’è un tempo per ogni cosa’".
La terza: "malattia dell’impietrimento mentale e spirituale", "il cuore di pietra e duro collo di coloro che strada facendo perdono serenità interiore audacia e si nascondono sotto le carte diventando macchine di pratiche e non uomini di Dio", "è pericoloso perdere la sensibilità umana, ed è la malattia di coloro che perdono i sentimenti di Gesù, il cuore col tempo si indurisce e diventa incapace di amare incondizionatamente il padre e il prossimo, essere cristiani infatti - ha ricordato il Papa - significa avere gli stessi sentimenti di distacco, donazione e generosità di Gesù".
La quarta è la "malattia della eccessiva pianificazione e funzionalismo, quando l’apostolo - ha osservato papa Bergoglio - pianifica tutto minuziosamente e crede che le cose progrediscono diventando così un contabile e un commercialista: preparare tutto e bene è necessario, ma senza voler mai richiudere e pilotare la libertà dello Spirito che è più generosa di ogni pianificazione". "Si cade in questa malattia - ha denunciato papa Francesco - perché è più comodo adagiarsi nella proprie posizioni immutate", voler "regolare e addomesticare lo Spirito Santo che è freschezza fantasia, novità".
La successiva malattia in agguato per ogni chiesa, curia e gruppo di fedeli elencata dal Papa, la quinta, é la "malattia del mal coordinamento: quando i membri perdono coordinamento tra loro" la curia diventa "un’orchestra che produce chiasso, perché le sue membra non collaborano e non vivono lo Spirito di grazia". Qui il Papa ha esemplificato parlando tra l’altro della "testa che dice al braccio ’comando io’".
La sesta é la "malattia dell’alzheimer spirituale, la dimenticanza della storia della salvezza, della storia personale con il Signore, del primo amore: si tratta - ha spiegato papa Francesco - di un declino progressivo delle facoltà spirituali" che "in un tempo più o meno lungo" rende la persona o il gruppo "incapace di un’attività autonoma, in uno stato di assoluta dipendenza dalle sue vedute spesso immaginarie: lo vediamo - ha rimarcato - in coloro che hanno perso la memoria del loro incontro con il Signore, dipendono dal loro presente, dalle loro passioni, capricci e manie, che costruiscono intorno a sé dei muri e delle abitudini e diventando sempre di più schiavi degli idoli che hanno scolpito con le loro stesse mani".
La settima é "la malattia della vanità e vanagloria" di chi vede solo "l’apparenza, i colori delle vesti e le insegne di onorificienza come vero obiettivo della vita, dimenticando le parole di san Paolo", e qui il Papa ha citato l’invito paolino a non considerare gli altri secondo il proprio interesse. "Questa malattia - ha denunciato il Pontefice davanti alla curia - ci porta ad essere uomini e donne falsi e a vivere un falso misticismo e un falso pietismo san paolo ’nemici della croce di cristo’ perché si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi".
L’ottava è la "malattia della schizofrenia esistenziale: avere una doppia vita frutto della ipocrisia del mediocre" e "del progressivo vuoto spirituale che lauree o titoli accademici non possono colmare, coloro che abbandonando il servizio pastorale si limitano a pratiche burocratiche, vivono in un loro mondo parallelo dove mettono da parte ciò che insegnano agli altri e iniziano una vita dissoluta". "La conversione per questa gravissima malattia - ha rimarcato il Papa dopo una frazione di silenzio - è urgente indispensabile".
La nona malattia è quella "di chiacchiere, mormorazioni pettegolezzi, ne ho parlato tante volte - ha ricordato - ma non è mai abbastanza: è grave, inizia magari per fare due chiacchiere, e si impadronisce della persona facendola diventare seminatrice di zizzania come Satana". Questa malattia è "delle persone vigliacche, che non avendo il coraggio di parlare direttamente, parlano dietro le spalle", e anche a questo proposito il Papa ha citato san Paolo con il suo invito a agire senza mormorare, ed essere irreprensibili e puri. "Guardiamoci - ha ancora esortato papa Francesco - dal terrorismo delle chiacchiere".
La decima è "la malattia di divinizzare i capi, di coloro che corteggiano i superiori sperando di ottenere la benevolenza. Sono vittime di carrierismo e opportunismo, onorano le persone e non Dio, sono persone meschine, infelici, ispirate solo dal proprio fatale egoismo. Questa malattia - ha osservato papa Bergoglio - potrebbe anche colpire i superiori quando corteggiano loro collaboratori per averne lealtà e dipendenza. Ma il risultato finale - ha sottolineato con forza - è una vera complicità".
L’undicesima: "la malattia dell’indifferenza verso gli altri, quando ognuno pensa solo a se stesso e perde la sincerità dei rapporti umani, quando si viene a conoscenza di qualcosa e la si tiene per sé invece di condividerla positivamente con gli atri, quando per gelosia o scaltrezza si prova gioia nel vedere altro cadere invece di incoraggiarlo e rialzarlo".
La dodicesima è "la malattia della faccia funerea, delle persone burbere e arcigne che ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di malinconia e trattare gli altri, soprattutto quelli ritenuti inferiori, con rigidezza e arroganza". La "severità teatrale e pessimismo sterile sono spesso sintomo di insicurezza di sé" ha detto il Papa, che ha invitato a "sforzarsi di essere una persona entusiasta e allegra che trasmette gioia: un cuore pieno di Dio è felice e contagia con la gioia attorno a sé; non perdiamo quello spirito gioioso, pieno di humour e persino autoironico che ci rende persone anche nella situazioni difficili. Quanto bene ci fa una buona dose di santo umorismo e ci farà bene recitare spesso la preghiera di Thomas Moore: io la prego tutti i giorni, mi fa bene".
La tredicesima malattia, ha spiegato Bergoglio, è quella "dell’accumulare, di chi cerca di riempire un vuoto esistenziale accumulando beni materiali, non per necessità ma solo per sentirsi sicuro". Il Papa ha ribadito che "il sudario non ha tasche", cioè che morendo non ci si porta dietro niente "e - ha sottolineato - tutti i tesori terreni, anche se sono regali, non riempiranno quel vuoto". "A queste persone - ha aggiunto il pontefice - il Signore ripete ’tu dici sono ricco, non ho bisogno di niente, ma non sai di essere un povero cieco’. L’accumulo appesantisce solamente e rallenta il cammino inesorabilmente". Ha quindi raccontato un aneddoto: "Un tempo - ha ricordato - i gesuiti spagnoli descrivevano la Compagnia di Gesù come la ’cavalleria leggera della Chiesa; ebbene, un giovane gesuita che doveva traslocare e stava sistemando il suo bagaglio, tanti regali, oggetti, si sente dire da un vecchio gesuita saggio, ’questa sarebbe la cavalleria leggera della Chiesa?’ I nostri traslochi".
Quattordicesima malattia quella "dei circoli chiusi, dove la appartenenza al gruppetto diventa più forte di quella al corpo e a Cristo stesso. Anche questa inizia sempre da buone intenzioni, ma con il passare del tempo schiavizza diventando un cancro" che causa tanto male e scandali, specialmente ai nostri fratelli più piccoli. La autodistruzione o il fuoco amico dei commilitoni è il pericolo più subdolo": ’ogni Regno bene diviso in se stesso va in rovina’".
Infine, "l’ultima malattia - ha detto Bergoglio alla curia romana - è quella del profitto mondano, degli esibizionismi, quando l’apostolo trasforma il suo servizio in potere e il suo potere in merce per ottenere profitti mondani, o per ottenere più potere". E’ la malattia "delle persone che cercano insaziabilmente di moltiplicare poteri e per questo capaci di calunniare, diffamare e screditare gli altri, persino su giornali e riviste, naturalmente per esibirsi e mostrarsi più capaci degli altri. Fa male al corpo - ha sottolineato il Pontefice - perché porta a usare qualsiasi scopo, spesso in nome della giustizia e della trasparenza". E a questo punto il Papa ha raccontato del prete che chiamava i giornalisti per spiattellargli i difetti dei confratelli, e lo ha chiamato "poverino".
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis (di Chiara Santomiero)15 dicembre 2014, di Federico La Sala
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI:
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI:
 INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
Un’intervista a John Chryssavgis
INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
Un’intervista a John Chryssavgis
 di Chiara Santomiero
di Chiara Santomiero
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO --- E’ legge l’Intesa con Buddisti e Induisti: l’Italia è un Paese multireligioso (di Marco Ventura)29 gennaio 2013, di Federico La Sala
E’ legge l’Intesa con Buddisti e Induisti: l’Italia è un Paese multireligioso
di Marco Ventura (Corriere della Sera, 29.01.2013)
Entrano in vigore venerdì le leggi che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e, rispettivamente, l’Unione buddista italiana e l’Unione induista italiana, sulla base delle intese sottoscritte tra il governo e le due confessioni. È un momento storico per il nostro Paese. Mai sinora il Parlamento aveva approvato accordi con confessioni non cristiane, con l’eccezione, nel 1989, delle Comunità ebraiche e, per chi non ritiene cristiani i mormoni, nel luglio scorso, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Il valore simbolico è alto per tutti gli italiani e non solo per i circa duecentomila interessati. Stipulando un patto con Buddisti e Induisti, lo Stato riconosce la multireligiosità della società italiana, riafferma l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose, scritta in Costituzione, e attua il principio supremo di laicità, dedotto dalla Corte costituzionale. Da quando non è più cattolico, lo Stato italiano non ha una religione e non può avere preferenze religiose. Perciò tutela la libertà di ogni credente e di ogni credo. Un principio lineare, in teoria, ma di tortuosa applicazione.
Nel 1989 il Consiglio di Stato spianò la strada al riconoscimento dell’Unione buddista, sancendo che in Italia è una fede protetta anche quella di chi non è ebreo, cristiano o musulmano. Nel 2000 fu firmata l’intesa con i Buddisti, ma il Parlamento rimase muto. Nel 2007 vi fu una nuova firma, stavolta anche con l’Unione induista. Negli ultimi mesi infine, un pugno di parlamentari ha profittato della distrazione dei colleghi e ha chiuso la partita.
La svolta simbolica è ora alla prova della realtà. Sta ai governi e al Parlamento continuare sulla strada intrapresa, a cominciare dall’approvazione dell’intesa firmata già nel 2000 con i Testimoni di Geova.
Sta ai Cattolici superare i seguaci di Budda e Dattatreya nei fatti, oltre che nelle verità rivelate. Sta a Buddisti e Induisti smentire il timore diffuso che il Paese si disgreghi senza il cemento cattolico, e dimostrare di non aver voluto l’intesa solo per riempirsi le tasche di otto per mille.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- I "TRE SOLI": "DUE SOLI" IN TERRA, E IL "TERZO" SEMPRE IN CIELO. LA LEZIONE DI DANTE.7 novembre 2012, di Federico La Sala
 "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
"DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
 LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.22 settembre 2012
 DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
 GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.
GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- RIATTIVARE LA MEMORIA della TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE. MOZART E MOSE’: "IL FLAUTO MAGICO", LA "MOS-ART"!1 dicembre 2011, di Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- aAd Assisi, leader religiosi non pregheranno per la Pace: paura di confondere i fedeli (di Franca Giansoldati).10 ottobre 2011, di Federico La Sala
 Ad Assisi niente preghiera comune fra le religioni
Ad Assisi niente preghiera comune fra le religioni Assisi, leader religiosi non pregheranno
Assisi, leader religiosi non pregheranno
 per la Pace: paura di confondere i fedeli
per la Pace: paura di confondere i fedeli di Franca Giansoldati *
di Franca Giansoldati *CITTA’ DEL VATICANO - Il nome di Dio non verrà invocato. Stavolta niente preghiere ad Assisi: i leader religiosi invitati dal Papa a riunirsi sulla tomba di San Francesco per riflettere sul tema della pace non pregheranno nè da soli, nè collettivamente. La «Giornata di riflessione, dialogo e preghiera» ideata da Papa Wojtyla 25 anni fa sarà solo una «Giornata di riflessione e dialogo» tra diverse fedi. In questo modo Benedetto XVI vuole evitare ogni possibile rischio di sincretismo religioso, confondendo i fedeli; e così nella cittadina umbra, il 26 ottobre prossimo, non si invocherà il nome del Signore. Anche da cardinale Papa Ratzinger aveva manifestato qualche perplessità al suo predecessore proprio su questo punto, pur condividendo ovviamente l’importanza di un momento di dialogo.
Cambiamenti a parte il venticinquesimo anniversario dello storico summit promosso da Papa Wojtyla nel 1986 sarà comunque importante e significativo. A cominciare dalle presenze. Hanno aderito in parecchi. Solo le delegazioni cristiane sono già una trentina e c’è il problema di contenerle. Saranno presenti l’Arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, l’arcivescovo ortodosso di Cipro, l’arcivescovo metropolita di Astana, Alexander, uomo di fiducia del Patriarca di Mosca, Kirill. Ortodossi, anglicani, luterani, evangelici, ma anche ebrei, rappresentanti del World Jewish Congress e rabbini di peso, poi induisti, animisti, buddisti.
Solo i musulmani saranno sotto rappresentati dal momento che l’università del Cairo di Al-Azhar, il maggiore centro teologico sunnita, ancora immensamente irritato con il Papa per il discorso fatto l’anno scorso davanti al Corpo Diplomatico, ha fermamente declinato l’invito (anche se al summit di Sant’Egidio a Monaco, nel settembre scorso, lo sceicco Al Tayyeb aveva inviato due rappresentanti). Sulla tomba di san Francesco ci sarà però il Principe Ghazi di Giordania, al quale spetterà l’onore di sedere accanto al pontefice al momento del pranzo.
Per la prima volta arriveranno anche 5 atei incalliti, tra cui Julia Kristeva, celebre psicanalista francese, allieva di Lacan, di origini bulgare. I nomi degli intellettuali atei sono stati forniti dal cardinale Gianfranco Ravasi, ideatore del Cortile dei Gentili, un think thank per il dialogo con i ’lontani’. La giornata si compone, grosso modo, in tre momenti. Un primo, nella basilica degli Angeli, dove gli ospiti parleranno (sono previsti una decina di interventi) e prenderanno visione di un filmato con le immagini di quel 26 ottobre 1986 ormai entrato nella Storia. Seguirà un frugale pranzo, nel rispetto delle regole alimentari previste dalle varie religioni e, infine, una visita alla tomba del santo seguita dalla lettura, in piazza, di un testo sulla pace nel mondo.
Papa Ratzinger, come aveva già fatto il suo predecessore, partirà con tutte le delegazioni dalla stazione vaticana con un convoglio con le insegne vaticane, messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato. Partenza alle 8 di mattina per circa trecento persone tra leader religiosi, prelati, autorità italiane e uomini della sicurezza. Al ritorno il treno rallenterà alle stazioni di Terni e Foligno per permettere al Pontefice di salutare i fedeli.
Venerdì 07 Ottobre 2011
* Articolo tratto dal sito: http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=165697&sez=HOME_NELMONDO
* Il Dialogo, Domenica 09 Ottobre,2011 Ore: 17:49
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- IL MAGISTERO DELL’INGANNARE IL PROSSIMO COME SE STESSO: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA.1 luglio 2011, di Federico La Sala
 DIO E’ SPIRITO, AMORE ("DEUS CHARITAS EST": 1 Gv. 4.8). SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
DIO E’ SPIRITO, AMORE ("DEUS CHARITAS EST": 1 Gv. 4.8). SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
 LA TRADIZIONALE "SCOLA" COSTANTINIANA DI BENEDETTO XVI: IL MAGISTERO DELL’INGANNARE IL PROSSIMO COME SE STESSO. Un’analisi di Giancarlo Zizola, con note
LA TRADIZIONALE "SCOLA" COSTANTINIANA DI BENEDETTO XVI: IL MAGISTERO DELL’INGANNARE IL PROSSIMO COME SE STESSO. Un’analisi di Giancarlo Zizola, con note
 (...) Von Balthasar, era molto netto (...). Diceva che «al cristiano è vietato il ricorso ai mezzi d’azione specificamente mondani per un preteso incremento del regno di Dio in terra». Criticava l’integralismo di gruppi di «mammalucchi cristiani che aspirano a conquistare il mondo» (...)
(...) Von Balthasar, era molto netto (...). Diceva che «al cristiano è vietato il ricorso ai mezzi d’azione specificamente mondani per un preteso incremento del regno di Dio in terra». Criticava l’integralismo di gruppi di «mammalucchi cristiani che aspirano a conquistare il mondo» (...) FAME NEL MONDO?! CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI. Una nota sull’evento - con appunti sul tema
FAME NEL MONDO?! CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI. Una nota sull’evento - con appunti sul tema -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ----- MONREALE E L’ECUMENISMO DI FEDERICO II. I mosaici del duomo completati da Federico II? Lo sostiene il professor Heinrich Pfeiffer (di Maria Modica)23 giugno 2011, di Federico La Sala
I mosaici del duomo completati da Federico II?
Lo sostiene il professor Heinrich Pfeiffer, che ha tenuto una lezione in cattedrale
di Maria Modica *
MONREALE, 26 febbraio - I mosaici del duomo di Monreale potrebbero essere stati completati da Federico II.
La rivoluzionaria tesi è sostenuta da uno dei maggiori esperti mondiali di Storia dell’arte, il gesuita Heinrich Pfeiffer della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Lo studioso è stato invitato dall’arcivescovo di Monreale, Monsignor Salvatore Di Cristina, per esporre la terza lezione - concerto, dedicata ai mosaici del duomo. Ultimo appuntamento del ciclo che ha voluto lanciare un dialogo ideale con la Settimana di Musica sacra in programma il prossimo anno.
La prolusione è stata preceduta dall’esecuzione del coro di voci bianche del Conservatorio Bellini di Palermo.
L’oratore ha incantato la platea con osservazioni acute e stimoli lanciati alla mente e al cuore.
«Questo luogo - ha esordito Pfeiffer - è unico al mondo. Presenta una divisione dello spazio basilicale per tematiche, ma quel che stupisce è l’ampiezza della descrizione dedicata al Vecchio testamento: tutta la navata centrale. La narrazione biblica comincia con la morte di Caino per il colpo di una freccia e termina con storia di Giacobbe e l’Angelo, centrale nella storia dell’Ebraismo perché da questo deriva il nome di Israele che significa lotta con Dio. Un’ampiezza descrittiva degna di una sinagoga. Questo spazio E .
Primo indizio che porta all’imperatore svevo è, dunque, l’ecumenismo religioso a lungo accarezzato da Federico II. Ma la stimolante tesi è suffragata dall’osservazione dei canoni estetici che contraddistinguono le raffigurazioni musive, una difformità di stile che non trova giustificazioni nell’esiguo spazio temporale, nemmeno un ventennio, durante il quale sarebbe stato ultimato il duomo.
«La differenza fra alcune icone - ha continuato Pfeiffer - di chiaro stile bizantine, di sicuro risalenti al XII s., e altre raffigurazioni, fra cui il Pantocratore, in cui la plasticità prelude alla soluzione prospettica del ’400, ci indica il trascorrere di almeno un secolo. La "sproporzione" fra il Cristo absidale e le figure circostanti non può essere stata concepita da una personalità mite quale quella del re normanno».
Secondo lo studioso tedesco, la conferma implicita si trova nella leggenda del Carrubo, sotto il quale Guglielmo avrebbe rinvenuto un immenso tesoro con cui edificare il tempio.
«La leggenda - ha proseguito - risponde ad una domanda cui manca una giustificazione storica: chi ha pagato tutto questo? Il regno normanno non avrebbe potuto permetterselo, soltanto l’Impero avrebbe potuto farlo».
La spiegazione del mistero si troverebbe nella "damnatio memoriae" che ha colpito gli Svevi snaturandone la reale portata storica, soprattutto in Sicilia.
«Una damnatio memoriae - ha concluso lo studioso - deve essere tolta da un cristiano: perciò ho parlato».
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- L’arbitro Abelardo così affrontò la contesa tra i monoteismi (di Luigi Accattoli).2 marzo 2011, di Federico La Sala
L’arbitro Abelardo così affrontò la contesa tra i monoteismi
di Luigi Accattoli (Corriere della Sera, 2 marzo 2011)
All’inizio di luglio del 1141 Pietro Abelardo, in cammino verso Roma, giunge in Borgogna, nella grande Abbazia di Cluny. A Sens un concilio dei vescovi di Francia l’ha condannato come eretico ed egli si è appellato al Papa e per questo sta viaggiando verso l’Italia. Mentre sosta nell’Abbazia gli arriva la notizia che il papa Innocenzo II ha ratificato la condanna di Sens, l’ha scomunicato e gli ha imposto l’obbligo di «tacere per sempre». Abelardo rinuncia al viaggio a Roma e muore a Cluny nove mesi più tardi, il 21 aprile 1142, di scabbia o di leucemia, riammesso in extremis nella comunione cattolica.
Nei mesi passati a Cluny osserva il silenzio che gli è stato imposto, ma la sua intenzione non è quella del «perpetuo silenzio», perché viene componendo l’ultima sua opera, la più matura e sinfonica, conciliante filosofia e teologia, Grecia, Gerusalemme e Roma: Dialogus inter Philosophum, Judeum et Christianum, ripubblicato ora dal «Corriere» nei «Classici del Pensiero Libero», con il titolo Dialogo tra un filosofo, un giudeo e un cristiano e la prefazione di Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri. Dialogo immaginario, protagonisti che egli aveva dentro di sé e riusciva a far parlare con pari dignità.
Opera incompiuta- Abelardo muore che la sta ancora dettando- essa è come un battello affidato un giorno al mare aperto e che ancora viene tracciando la sua rotta, nella mente di chi lo legge. «In una visione notturna vidi tre uomini che arrivavano per sentieri diversi»: è l’incipit affabulante del Dialogo.
I tre si presentano ad Abelardo e l’informano che dopo aver «discusso a lungo» sulle rispettive fedi hanno deciso di ricorrere al suo «giudizio». Qui dunque il maestro assume un ruolo super partes. Per nulla in dubbio sulla validità della propria dottrina, egli insedia se stesso come arbitro nel conflitto delle fedi e fa dire al filosofo del Dialogo: «Sappiamo che tu conosci bene sia la forza delle argomentazioni filosofiche, sia i fondamenti di entrambe le leggi».
Sempre quel filosofo più avanti afferma che a fare di Abelardo un arbitro «in grado di risolvere questa nostra contesa» sono tutti i titoli e la fama conquistati sul campo e c’è per ultima «quella tua mirabile opera di teologia che l’invidia non potè sopportare». Allude al trattato Theologia Christiana, scritto nel 1132-34, dal quale gli avversari avevano tratto le proposizioni per le quali era stato scomunicato.
Egli non riconosce valida la condanna. Non solo perché il suo ultimo protettore, l’ecumenico Pietro di Cluny, detto «il Venerabile», gli ha aperto le porte dell’Abbazia e si è adoperato per la cancellazione della scomunica presso il Papa. Non la riconosce valida perché ritiene di non essere stato capito ed è sicuro che sarà riabilitato dai posteri, come infatti è stato.
Orgoglioso e a volte temerario, Pietro Abelardo si segnala per una disposizione naturale alla disputa ed è tra i primi a istruire il metodo scolastico del vaglio di ogni opinione in campo prima di dare soluzione a una quaestio disputata (questione discussa). Antesignano in questo di Tommaso d’Aquino e del suo grandioso impegno a fare della teologia una scienza con un pieno statuto metodologico. Anticipatore di Tommaso egli è anche per il rapporto equilibrato che propone tra filosofia e teologia, in dialettica con la tendenza dei teologi mistici guidati da Bernardo di Chiaravalle, che fu il suo avversario.
Di che apertura alare fosse capace il raziocinio di Abelardo lo si intuisce dalle pagine in cui mette in bocca all’ebreo- nel Dialogo- un’appassionata difesa della propria stirpe: «Non si sa di nessun altro popolo che abbia sopportato tante prove in nome di Dio quante noi ne sopportiamo continuamente».
Morto Abelardo a Cluny, Pietro il Venerabile ne manda il corpo a Eloisa, che ora è monaca ma che era stata sua allieva, amante e sposa e gli aveva dato un figlio di nome Astrolabio. Per l’audacia di quell’amore, Abelardo era stato evirato da tre sicari inviati dallo zio di lei Fulberto. Morta anche lei - due decenni più tardi - i due vengono uniti nella stessa tomba, che è anche oggi visibile nel cimitero del Père Lachaise a Parigi.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". --- LA LIBIA E IL SILENZIO DI BENEDETTO XVI. Su cosa, allora, costruire un vero confronto, se non sul futuro comune? (di Roberto Monteforte - Quando la denuncia del papa?).25 febbraio 2011, di Federico La Sala
Quando la denuncia del papa?
di Roberto Monteforte (l’Unità, 25 febbraio 2011)
«È urgente risolvere i conflitti nei Paesi arabi». Lo ha affermato Papa Benedetto XVI ricevendo ieri in udienza il presidente libanese Sleiman. L’incontro, come pure quello seguente del presidente del paese dei Cedri con il segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone e i suoi collaboratori, è stato dedicato alla situazione del Libano, alla formazione del nuovo governo, alla stabilità della Nazione che ancora rappresenta - osserva il pontefice - «un messaggio di libertà e di rispettosa convivenza non solo per la Regione ma per il mondo intero». È il paese del Medio Oriente dove la comunità cristiana gioca ancora un suo ruolo. Il Papa valorizza «la collaborazione e il dialogo fra le confessioni religiose», come pure «l’importanza dell’impegno delle autorità civili e religiose per educare le coscienze alla pace e alla riconciliazione». Ma è tutto qui.
Mentre in Libia il rais Gheddafi fa massacrare il suo popolo, ci si aspettava di più. Anche se è alta la preoccupazione per i destini delle comunità cristiane in Medio Oriente. Oggi è il destino di interi popoli, il loro stesso futuro, non solo quello dei cristiani, ad essere messo in discussione.
Nelle piazze giovani musulmani e cristiani lottano insieme per la democrazia, per la giustizia e il rispetto delle libertà, per la domanda di futuro. Ne dà conto con professionalità l’Osservatore Romano che non ha incertezze a titolare «Senza pietà», denunciando Gheddafi che ordina di bombardare il suo popolo. Con i suoi approfondimenti Radio Vaticana aiuta a capire le situazioni reali di quelle società complesse. Da Benedetto XVI ci si sarebbe aspettato di più. Un appello per fermare la mano agli assassini. È vero che le parole del pontefice potrebbero scatenare l’estremismo islamico. Ma la domanda di futuro e di democrazia accomuna giovani cristiani, islamici e semplicemente laici. Su cosa, allora, costruire un vero confronto, se non sul futuro comune?
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- Un’eredità plurale (di Remo Cesarani).23 febbraio 2011, di Federico La Sala
Un’eredità plurale
L’attaccamento alle radici comporta inevitabili conflitti. Anziché affannarsi a cercare dubbie identità, è più utile rifarsi alle lezioni di Jürgen Habermas e di Denis de Rougemont che da prospettive differenti prefigurano comunità caratterizzate da valori di inclusione e solidarietà.
di Remo Ceserani (il manifesto, 23 febbraio 2011)
Tutti si affannano, in questi giorni, e riempiono le pagine dei giornali, dei siti web, dei blog, e delle trasmissioni televisive, per discutere di identità: l’identità italiana, le radici cristiane dell’Italia o dell’Europa, l’identità padana (del tutto immaginaria e composita), e così via. La parola «identità», usata a proposito e a sproposito, compare sempre più spesso nei discorsi degli storici e dei giornalisti italiani, con insistito riferimento, in questi ultimi tempi, all’identità italiana (un’identità, come è noto, abbastanza incerta e traballante e prodotta con qualche fatica attraverso le vicende del Risorgimento, del Fascismo e della Resistenza). Tutti sappiamo che l’idea di una identità forte, sia delle singole persone (gli imprenditori, i costruttori del proprio destino, i protagonisti della propria vita), sia delle singole comunità (i gruppi sociali, le classi, le nazioni) sono un prodotto tipico della modernità, basato su forti investimenti ideologici e su vere e proprie costruzioni di sé con tutti gli strumenti offerti dalla mitologia (le origini, le radici) e dall’immaginario (la storia, la bandiera, gli inni, le date fatidiche, sia delle vittorie sia persino in certi casi, delle sconfitte, come è avvenuto per l’identità serba in seguito alla vittoria turca nella Piana dei Merli, nel Kosovo, il 15 giugno 1389, giorno di San Vito).
Individui in movimento
Forse è il caso di dirci, sommessamente, che si corrono grossi rischi, e si cade in troppe rigidità ideologiche, quando si parla di identità. L’attaccamento alle radici, siano esse etniche, culturali o, peggio ancora, religiose, comporta un’inevitabile conseguenza di conflitti. La difesa della propria identità prevede un confronto, e spesso un contrasto (anche violento) con le identità altrui. Il panorama mondiale è ancor oggi pieno di conflitti che nascono proprio dalla rivendicazione delle proprie radici e dallo scontro fra identità diverse. E la storia offre esempi infiniti di guerre tribali, interetniche, civili, nazionali, mondiali, nate da simili rivendicazioni.
Oggi in teoria saremmo in un mondo, quello della globalizzazione o della modernità liquida, in cui gli individui si muovono sempre più rapidamente e attraversano molti confini: sono immigrati che lasciano i paesi poveri o i regimi polizieschi per andare a vivere in società più aperte e più ricche di opportunità di lavoro. Sono giovani che hanno ottenuto una formazione nelle università e in centri di ricerca del proprio paese e, per sfuggire a strutture chiuse e corporative, o per semplice desiderio di ampliare conoscenze ed esperienze, vanno a operare nei centri di ricerca o nei laboratori di altri paesi. Sono persone che si trapiantano per necessità o per gusto della novità e dell’avventura. Sono i protagonisti della mobilità sociale. Sono coppie che si formano dopo l’incontro fra individui (uomini o donne) appartenenti a culture diverse, che vanno a vivere presso uno di loro oppure si spostano entrambi in un paese terzo.
Nel segno dell’illuminismo
Se esaminiamo questo problema dal punto di vista della teoria sociale, non possiamo che contrapporre all’idea di «identità» (ossia l’attaccamento più o meno volontario alle proprie radici e alla propria comunità di origine, la disponibilità a rafforzarla e difenderla fino al sacrificio - «pro patria mori»), l’idea di «appartenenza», ossia la libera scelta della comunità in cui vivere e disponibilità a rafforzarla e difenderla, con juicio e possibilmente con armi pacifiche. È stato chiarissimo in proposito il filosofo tedesco Jürgen Habermas, che ne ha parlato al tempo della discussione sulla costituzione europea e dello scontro con chi insisteva - fra questi non solo i prelatidel Vaticano ma anche Fini, se ben ricordate - sulla necessità di inserire nel testo la rivendicazione dell’identità cristiana dell’Europa.
Habermas respingeva qualsiasi idea tradizionale di nazione come «una comunità del destino plasmata da una comune eredità, una lingua e una storia comuni», e dichiarava di concepire piuttosto le nostre nazioni moderne come comunità di cittadini: «una comunità civica, anziché etnica», la cui identità collettiva «non esiste indipendentemente o antecedentemente al processo democratico da cui scaturisce» (Tempo di passaggi, Milano, Feltrinelli, 2004, ma vedi anche Ach Europa!. Kleine politische Schriften XI, Frankfurt, Suhrkamp).
Rifacendosi all’idea illuministica degli Stati moderni come formazioni storiche fondate su un contratto costituzionale, procedure democratiche, condivisione d’interessi economici, valori culturali, interpretazioni del passato e sviluppo di una «sfera pubblica», Habermas concepisce l’Europa come una comunità specifica di cittadini (citoyen) caratterizzata dalla presenza condivisa di valori come la solidarietà, l’orientamento verso il sociale, l’inclusione politica ed economica. Questo passaggio del discorso di Habermas mi sembra di grande importanza: sarebbe bene che chi può scegliere la comunità alla quale aderire, ammesso che la possibilità di scelta sia reale (e temo che, pur con tutta la mobilità sociale del mondo globalizzato, quelli che possono scegliere non siano molti), preferisse una comunità caratterizzata da valori condivisi come «la solidarietà, l’orientamento verso il sociale, l’inclusione politica ed economica». Per fare qualche esempio dal mondo occidentale dopo la grande crisi: molti paesi europei sembrano poco inclini all’inclusione politica ed economica degli immigrati; l’Inghilterra e gli Stati Uniti, che tendono a cancellare il welfare, sembrano poco orientati verso la solidarietà e il sociale.
Il federalista Gioberti
Se poi esaminiamo il problema dal punto di vista della storia (di gran moda ai nostri giorni, in cui abbiamo delegato al bravissimo Benigni di tentare la ricostruzione, con l’aiuto di Aldo Cazzullo, delle vicende del Risorgimento - ma forse avrebbe fatto meglio a chiedere l’aiuto anche di Alberto Mario Banti), credo doveroso riconoscere che il problema dell’identità italiana sia un vero ginepraio. Tutti noi, nati nell’una o nell’altra regione italiana, abbiamo problemi non piccoli a risalire all’indietro nella storia e a identificare le nostre origini e identità. Cosa sono io, nato in Lombardia? Di eredità celtica, o germanico-longobarda, o villanoviana, etrusca, latina, romana? O addirittura pelasgica, come voleva Gioberti, uno dei padri della patria di cui si parla poco in questi giorni, il quale nel 1846 si fece sostenitore di un’Italia unificata con il consenso papale e nel 1848 si proclamò federalista? Sentite cosa scriveva nel Primato: «Il genio proprio degli Italiani nelle cose civili risulta da due componenti, l’uno dei quali è naturale, antico, pelasgico, dorico, etrusco, latino, romano, e s’attiene alla stirpe e alle abitudini primitive di essa; l’altro è sovrannaturale, moderno cristiano, cattolico, guelfo, e proviene dalle credenze e instituzioni radicate, mediante un uso di ben quindici secoli e tornate in seconda natura agli abitanti della penisola. Questi due elementi, che sono entrambi nostrani, ma il primo dei quali è specialmente civile e laicale, il secondo religioso e ieratico, insieme armonizzano, giacché essendo logicamente simultanei e cronologicamente successivi, ma con assidua vicenda, l’uno compie l’altro, e corrispondono ai due grandi periodi della nostra istoria prima e dopo di Cristo, e alle due instituzioni italiane più forti e mirabili (alle quali credo che niun’altra si possa paragonare) cioè all’imperio latino nato dalla civiltà etrusco pelasgica, e alla dittatura civile del Papa nel medio evo, procreata dal Cristianesimo».
Tre città-simbolo
Vorrei, a tutti quanti si tormentano sulla questione dell’identità italiana, e ancor più su quella dell’identità europea, ricordare le parole di un grande intellettuale ginevrino, Denis De Rougemont, calviniano, figlio di un pastore, ma anche spirito libero e coraggiosamente radicale, che negli ultimi anni della sua vita, dopo la formazione parigina (il cui frutto fu un libro curioso e controverso: L’amore e l’occidente, 1939) e un lungo soggiorno americano, da Ginevra si spese con grande energia in favore dell’Europa, proponendo uno Stato federale basato sul modello della Svizzera (Écrits sur l’Europe, a cura di Christophe Calame, Parigi 1994). De Rougemont insiste sullediversità delle tante componenti che formano l’Europa e sul loro ruolo fecondo (lo stesso, a maggior ragione, dovremmo dire dell’Italia): «la diversità delle tradizioni, delle lingue, dei partiti, delle nazioni e persino delle religioni, è una condizione fondamentale della creatività e dello spirito d’invenzione» propri dell’Europa.
Nella ricerca delle memorie condivise, De Rougemont mette in campo le tre città-simbolo della grande tradizione: Atene, Gerusalemme, Roma, e poi numerose culture: l’Oriente, la Grecia, il Cristianesimo, i Celti, i Germani, gli Arabi, gli Scandinavi, gli Slavi. Egli ricorda per esempio l’apporto celtico del gusto per l’avventura, per la dismisura e per la potenzialità trasfigurante del sacrificio e della sconfitta, oppure l’apporto germanico e celtico dell’ideologia cavalleresca e della fedeltà di appartenenza al clan e al ceto nobiliare, oppure ancora l’apporto occitanico della concezione cortese della vita e dell’amore, arricchita di elementi della gnosi e dell’erotismo arabo. Ma ricorda anche altri elementi, che spiegano l’insieme complesso e pieno di contraddizioni delle identità europee: 1) la molteplicità delle lingue ma anche le loro profonde e nascoste affinità, dovute all’eredità indoeuropea, che accomuna quasi tutte le lingue antiche e moderne del continente (ricorda per esempio la presenza in molti paesi dei derivati dei termini dubron e dour che in celtico e in brettone armoricano significavano «acqua», come dimostrano i nomi dei fiumi Douro in Spagna, Drance e Thur in Svizzera, Dordogne, Durance, Drôme e Dore in Francia, le due Dore in Italia, la Dordrecht in Olanda e venti altri fiumi europei); 2) la lunga tradizione di organizzazioni statali e burocratiche forti, ereditate dall’opera di romanizzazione, che ha portato gli Europei a costruire stati-nazione molto accentrati e autoreferenziali e, sottolinea De Rougemont, a non saper concepire Dio o la vita spirituale al di fuori dei quadri istituzionali delle Chiese; 3) la concezione della persona umana fortemente autonoma e impegnata a seguire una propria vocazione indipendente, ma capace di contribuire alla fondazione di valori condivisi della comunità (eredità greco-cristiana colorata di valori germanici e celtici); 4) lo spirito critico e la propensione a liberarsi dall’impalcatura del sacro e dal culto dei morti, dai miti tribali, dalle credenze religiose nate dalla paura (che De Rougemont considera una eredità propriamente evangelica); 5) la tendenza, purtroppo molto diffusa, a lasciarsi condizionare dai legami pesanti con la materialità (e quindi a essere meno distaccati e liberi rispetto, per esempio, ai popoli influenzati dall’induismo o dal buddismo); 6) la tendenza, inoltre, a lasciarsi attrarre dall’astrazione (e quindi essere meno capaci di comunicare con le proprie forze vitali dei popoli africani influenzati dall’animismo).
Appartenenza e egoismo
Mi pare un quadro straordinariamente efficace delle nostre tante diversità e un programma convincente in favore di un’Italia, e di un’Europa, non delle identità, ma delle differenze e delle appartenenze. De Rougemont aveva in mente la Svizzera: un paese in cui convivono tre religioni e quattro lingue, orgoglioso della sua indipendenza, delle sue istituzioni politiche, unito non da ragioni di identità etnica, linguistica o religiosa, ma da peculiari, rispettabilissime, tradizioni storiche (ma anche, si deve aggiungere, da non poche ragioni di convenienza e interessi economicomateriali, e da una solidarietà un po’ chiusa su di sé e corretta da un qualche egoismo - come dimostra il recente affacciarsi sulla scena politica di un movimento xenofobo come il Ppd di Christof Blocher).
Tutto considerato, mi pare che la lezione di De Rougemont, così come quella di Habermas, potrebbe essere estremamente salutare in un’Italia come è quella in cui viviamo, estremamente confusa e distratta.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! ---- «Intorno al Concilio la convergenza tra le fedi» (di Enzo Bianchi).26 gennaio 2011, di Federico La Sala
Bianchi: «Intorno al Concilio la convergenza tra le fedi»
di Enzo Bianchi (Avvenire, 26 gennaio 2011)
Fare memoria della Shoah per noi cristiani significa anche rileggere l’atteggiamento tenuto per due millenni verso gli ebrei e, nel contempo, essere consapevoli della svolta storica cui abbiamo assistito in questi ultimi cinquant’anni, svolta cui non è certo stata estranea la tragedia del ’male assoluto’. Se infatti vi è stato nei secoli un antigiudaismo cristiano teologico e pratico che, pur distinto dall’antisemitismo, di fatto ha finito per favorire il silenzio, l’indifferenza e la passività di tanti cristiani nell’ora della Shoah, dobbiamo anche ricordare l’inatteso mutamento del rapporto tra Chiesa cattolica ed ebrei sopraggiunto con Giovanni XXIII: pochi mesi dopo l’elezione a papa, interviene sul testo della liturgia del Venerdì santo, abolendo dalla preghiera l’invocazione ’ pro perfidis judaeis ’ che era ripresa anche in occasione del battesimo degli ebrei convertiti; poi, in vista della preparazione del Concilio da lui indetto, affida al cardinal Bea l’incarico di preparare la bozza per una dichiarazione sui rapporti tra Chiesa e popolo ebraico. Sarà la dichiarazione conciliare Nostra aetate: autentica svolta storica e teologica, avvenuta con l’autorevolezza massima per la Chiesa cattolica, quella di un concilio. Così recita quel documento: «Quanto è stato commesso durante la passione [di Cristo] non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi, né agli ebrei del nostro tempo. E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli ebrei tuttavia non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come maledetti... La Chiesa inoltre deplora gli odii, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque» ( Nostra aetate 4,28).
Sulla scia di questa dichiarazione e della nuova consapevolezza che essa manifestava, monsignor Elchinger, seguito dal cardinal Bea, osò suggerire che i cristiani avanzassero una richiesta di perdono agli ebrei, come Paolo VI aveva chiesto perdono ai cristiani non cattolici per le colpe imputabili alla Chiesa nelle dolorose divisioni, ma neanche in quella pur propizia ora conciliare si ebbe il coraggio per un’umile confessione di colpa.
Così trascorsero quasi vent’anni dal Concilio senza novità significative, durante i quali tuttavia la svolta fu confermata e mai smentita, finché Giovanni Paolo II, testimone diretto della barbarie antisemita, il 17 novembre 1980 a Magonza pronuncia una formula inedita, anzi contraddittoria a diciannove secoli di esegesi e teologia cristiana, in cui gli ebrei sono definiti «il popolo di Dio dell’antica alleanza che non è mai stata revocata» e in cui si afferma che «ebrei e cristiani, quali figli di Abramo, sono chiamati a essere benedizione per il mondo».
Si può notare la novità e l’audacia rispetto a tutto il magistero ecclesiastico precedente: il popolo di Dio comprende sia Israele che la Chiesa (popolo di Dio dell’antica e della nuova alleanza): la teologia della ’sostituzione’ è così abbandonata per sempre. Sigillo alla confessione delle colpe dei cristiani nei confronti di Israele sarà la liturgia penitenziale officiata da Giovanni Paolo II e dai cardinali della curia romana in occasione del Giubileo del 2000, in cui verrà proclamato con forza: «Noi siamo profondamente addolorati per il comportamento di quanti nel corso della storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli e, chiedendoti perdono, vogliamo impegnarci in un’autentica fraternità con il popolo dell’alleanza».
Dalla prece ’pro perfidis judaeis’ alla richiesta del perdono; dal disprezzo e dall’odio al gesto di Giovanni Paolo II che infila un biglietto, contenente la richiesta a Dio di perdono, tra le fessure del Muro del pianto, quasi a scolpire nella pietra questa invocazione.
E gesti di portata analoga sono proseguiti con Benedetto XVI: si pensi al pellegrinaggio ad Auschwitz o alla visita alla sinagoga di Roma. Il Giorno della memoria ci ricorda allora che non siamo immuni dalla tentazione di ridestare quella logica di inimicizia che crea il nemico, o quella pretesa di possedere la verità contro l’altro o senza l’altro. Nessun cristiano però potrà più invocare l’ignoranza a propria scusante: ciascuno è e sarà responsabile in prima persona di una conferma o di una contraddizione a questa svolta...
Materiali sul tema:
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- L’ECCLESIOLOGIA, L’ECUMENISMO, E L’ASTUZIA DELLA RAGIONE ’CATTOLICA’: LA CHIESA IN CAMMINO SULLA STRADA DI RATZINGER (di Gianfranco Ravasi - Studia la chiesa, scoprirai umanità).10 gennaio 2011, di Federico La Sala
L’ECCLESIOLOGIA, L’ECUMENISMO, E L’ASTUZIA DELLA RAGIONE ’CATTOLICA’: LA CHIESA IN CAMMINO SULLA STRADA DI RATZINGER.
Studia la chiesa, scoprirai umanità
Un dizionario offre la possibilità di capire la ricchezza comunitaria dell’evento religioso e di scoprire le dinamiche comuni alle fedi
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 09.01.2011)
Se siete "laici", non accantonate subito come non a voi pertinente questa segnalazione, convinti al massimo che il termine "Chiesa" valga solo per stare in guardia contro ogni tentazione teocratica, rimodulando e ribadendo la formula di Cavour della «Libera Chiesa in libero Stato» o, più aspramente temendo col Pasolini della Religione del mio tempo che «la Chiesa sia lo spietato cuore dello Stato». No, la categoria sottesa a questo vocabolo di matrice greca, ekklesía, è quella della "convocazione", certo di taglio sacrale e trascendente, ma che rimanda anche a un incontro sociale. Risaliamo, così, alle radici stesse dell’antropologia che non si accontenta di aggregazioni genetiche (famiglia, clan), ma segnala l’anelito a congregazioni di altra impronta, più civile e culturale (popolo, nazione), o corporativa (associazioni, ordini) o infine spirituale e simbolica. Ecco, allora, entrare in scena la Chiesa con le sue sotto-categorie (pensiamo alle comunità monastiche).
Ma non si creda che l’idea sia appannaggio del cristianesimo e in particolare del cattolicesimo. L’umma musulmana è la comunità "materna" (tale è l’etimologia della parola) che raccoglie in unità i fedeli di quella religione e che tende spesso a sovrapporsi alla stessa comunità civile in una sovrimpressione identitaria giuridico-politica.
Persino il buddhismo, a prima vista restio ad accogliere criteri di mutua appartenenza (al massimo c’è la sangha monastica rigidamente istituzionalizzata), ha prodotto forme di comunità nazionale religiosa: come non pensare al Tibet che ha - a partire dal Seicento - nel Dalai Lama l’unificazione dell’identità sacra, civica ed etnica? Il discorso è ancor più evidente per l’ebraismo che ha già nelle Scritture Sacre l’emergere della qahal, l’ekklesía appunto, una "convocazione" divina dai forti connotati istituzionali civili.
È, però, indubbio che la categoria "ecclesiale" sia capitale nel cristianesimo e sia uno dei nodi più intricati dell’odierno dialogo ecumenico, come lo fu in passato nello scontro, non di rado armato, tra le varie Chiese col relativo corteo di scismi, di scomuniche e persino di guerre di religione. Tempo fa, proprio su queste pagine, abbiamo spiegato - sulla scorta di un saggio di Giacomo Canobbio (Nessuna salvezza fuori della Chiesa?, Queriniana) - il senso autentico del celebre motto "inventato" da Origene e Cipriano, Extra Ecclesiam nulla salus, spesso ancor oggi imbracciato come un kalashnikov anti-ecumenico e integralistico.
Si capisce, allora, perché l’apparire di un dizionario di ecclesiologia debba essere segnalato anche ai lettori più diversi e non ai destinatari a prima vista specifici come gli "ecclesiastici" o le comunità "ecdesiali". Certo, quello che ora presentiamo è un manuale che lascia in sordina la prospettiva antropologica (ad esempio, la voce "Appartenenza" è esclusivamente teologica, così come le "società" qui evocate sono soltanto le "Società di vita apostolica").
Tuttavia, nelle 160 voci che compongono questo vasto arazzo tematico ci si imbatte nella trattazione della "Democrazia", della "Promozione umana", dei "Rapporti Chiesa-Stato", di "Arte e Chiesa", ma si lascia pure vasto campo alle mille iridescenze che la categoria "Chiesa" ha assunto nella storia al punto tale da essere applicata a soggetti disparati con reciproco dispiacere degli uni e degli altri. Significativo al riguardo sarebbe rincorrere la sequenza rubricata sotto "Ecclesiologia": ci sono gli anglicani, i congregazionalisti, i luterani, i bizantini medievali, l’occidente medievale, gli ortodossi, i cattolici conciliari e post-conciliari, i riformati, tanto per seguire l’ordine alfabetico.
Ma all’interno s’incunea l’ecclesiologia degli Atti degli apostoli, quella giovannea, delle Lettere pastorali neotestamentarie, la paolina, quella della patristica occidentale e orientale, della comunità cristiana primitiva, l’ecclesiologia sinottica e veterotestamentaria, anche qui per stare alla sequenza alfabetica, fermo restando poi che una decina di voci sono riservate alle specifiche Chiese in cui si è frammentata la cristianità.
L’oscillazione ondeggia, quindi, tra voci che isolano e approfondiscono i fondamenti teologici, come «Concilio, Corpo di Cristo, Dodici, Episcopato, Eucaristia, Evangelizzazione, Infallibilità, Liturgia, Magistero, Ministeri, Missione, Papato, Parola, Popolo di Dio, Presbiterato, Sacramentalità, Scisma, Spirito Santo, Tradizione» e così via, e voci che toccano questioni storiche o pastorali come l’architettura ecclesiale, il Gallicanesimo, le sette e i nuovi movimenti religiosi, la teologia della liberazione, la Scuola di Tubinga e di Roma o lemmi enigmatici ai profani come Subsistit in, sempre per fare qualche esempio. L’oscillazione si ripete - come è ovvio in simili prodotti affidati a una legione di collaboratori - tra impostazioni più sincroniche eapprocci diacronici, tra prospettiva tematica ed evoluzione storico-tematica.
Il Concilio Vaticano II, con la sua costituzione Lumen gentium, ha fatto sì che l’ecclesiologia tornasse al centro dell’interrogazione teologica, ma anche dell’impegno pastorale nel confronto col mondo. Lo ha fatto ribadendo che i suoi confini sono meno "ecclesiastici" di quanto si è soliti ipotizzare anche da parte dei non credenti. Ha riproposto con forza la necessità dell’incontro ecumenico per impedire integralismi e autoreferenzialità. Ha rettificato gli incroci con la società e la politica (Martin Luther King in quegli stessi anni nella sua Forza d’amare affermava che «la Chiesa non è la padrona o la serva dello Stato, è la coscienza dello Stato»). Mi sembra, comunque, significativo concludere con un passo dell’allora cardinale Ratzinger nel suo saggio sulla Chiesa, una comunità sempre in cammino (San Paolo 1991) passo che è posto in apertura a questo dizionario e che noi riproponiamo ai lettori credenti e "laici".
«La Chiesa non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme in un certo luogo per dare avvio a una vita comunitaria. La Chiesa non è nemmeno la grande schiera di coloro che alla domenica si radunano insieme per celebrare l’eucaristia. La Chiesa è anche di più che papa, vescovi e preti, di coloro che sono investiti del ministero sacramentale. Di essa fanno parte tutti i santi, a partire da Abele, da Abramo e da tutti i testimoni della speranza... Di essa fanno parte tutti gli sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio; di essa fanno parte gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi, il cui cuore si protende, sperando e amando, verso Cristo».
 DIZIONARIO DI ECCLESIOLOGIA
DIZIONARIO DI ECCLESIOLOGIA
 Gianfranco Calabrese, Philip Goyret, Orazio Francesco Piazza edd.
Gianfranco Calabrese, Philip Goyret, Orazio Francesco Piazza edd.
 Città Nuova, Roma
Città Nuova, Roma
 pagg. 1.568 € 140,00.
pagg. 1.568 € 140,00. -
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- È evidente che i due figli della parabola non hanno capito il loro padre (di Nandino Capovilla - Non è il Dio in cui credo).12 settembre 2010, di Federico La Sala
Non è il Dio in cui credo
di Nandino Capovilla (Adista/Notizie, n. 64, 31 luglio 2010)
Tra catechismi e compendi, guide e sussidi, le nostre librerie non riescono nemmeno ad esporre tutta la produzione di tentativi per ridurre, semplificare e sminuzzare l’unico testo veramente consigliabile, la Parola di Dio. Tutti questi Bignami vogliono spiegarci chi è Dio e come rapportarci con lui, ma spesso esco sconcertato dalla libreria col dubbio che quello non sia il Dio in cui credo.
Tutti vorrebbero insegnarmi a pregare Dio, ma non credo vada trascurata anche la testimonianza di Raymond Devos che dice di aver incontrato, in un villaggio della Lozerè, Dio che stava pregando. "Mi son detto: chi prega? Non prega certo se stesso. Non lui, non Dio. Pregava l’uomo! Egli mi pregava. Pregava me! Metteva in dubbio me come io avevo messo in dubbio lui. Diceva: ’O uomo, se tu esisti, dammi un segno’. Ho detto: ’Dio mio sono qui’. Lui ha detto: ’Miracolo! Un’apparizione umana’". Ogni giorno, allora, cerco di "dare un segno" a Dio dalla mia giornata affannata, sapendo che Lui mi ha preceduto e mi precede sempre, che non ho bisogno di cercare le prove della sua esistenza, ma casomai purificare costantemente l’immagine di Dio che mi sta davanti.
Mi basterebbe in realtà tornare più frequentemente a quelle pagine intrise di lacerante sofferenza e gioiosa consolazione con cui Luca ci racconta chi è il nostro Dio attraverso il suo amarci e il suo ostinato legame con ogni uomo. Altro che Dio come l’assoluto che sa tutto e non è giustificato da nulla, imperscrutabile nella sua dimora divina e praticamente micidiale per l’uomo! Il Dio che racconta Gesù, l’unico che vale la pena di ascoltare, non è l’entità che sa tutto e può tutto, ma l’appassionato Padre che ci ama indipendentemente dalla nostra risposta. La grandezza del mio Dio non ha bisogno di spiegarsi perché io ne accetti l’esistenza, visto che da sempre lui stesso si è definito in rapporto a noi uomini e che dalla prima passeggiata nel giardino si è messo in agitazione per cercare Adamo e, in lui, anche me.
Così, ogni giorno e in ogni tempo, Dio ha cercato di convincerci della sua misericordia, della sua enorme bontà e assoluta inermità di fronte al nostro rifiuto. Il Padre prodigo di amore percorre tutti i giorni le strade di tutti gli uomini: cerca, bussa, chiede trafelato e stanco di essere ascoltato e capito nella sua paternità.
È evidente che i due figli della parabola non hanno capito il loro padre. Uno ribelle e l’altro servo, non hanno saputo cogliere che il dono più grande è la libertà dei figli. Tra perdita e ritrovamento, il Padre si ritrova col cuore in gola finché non vede il figlio minore arrivare in fondo alla strada. Questo Dio è dunque sempre più altro rispetto a quello che i poteri politici e le ragioni di Stato stanno costantemente utilizzando.
Aspettiamo il giorno in cui la Chiesa, che si sente depositaria e custode della fede, alzerà forte la voce per fermare coloro che bestemmiano il nome di Dio confiscandolo a loro uso e consumo e facendo della sua storia una consuetudine popolare, una tradizione e una cultura.
Significativo è il modo in cui Luca introduce le tre parabole della misericordia: "Si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: ‘Costui riceve i peccatori e mangia con loro’”. Lo scandalo continua oggi, se siamo fedeli nel mostrare questo volto di Dio che fa saltare gli schemi e le norme acquisite solo col suo amore totalmente gratuito.
Perché allora non ci scuote la sofferenza di tanti per la rigidità di una Chiesa che giudica senza ascoltare, minaccia senza accogliere, condanna senza perdonare? E quanta strada dobbiamo fare per assomigliare a quel Padre che corse verso suo figlio "quando era ancora lontano"? Certo, abbiamo smesso di etichettare mezzo mondo con la categoria dei "lontani" ma non abbiamo ancora tolto il baricentro di questa ipotetica "vicinanza" a Dio dalla nostra Chiesa cattolica, e invece di andare noi verso i fratelli aspettiamo tranquilli che si convertano a noi e arrivino fin sulla porta a bussare.
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- Padroni in casa nostra? E’ la misura di Sodoma (di Piero Stefani).10 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". ---- USCIRE DAI RECINTI. L’uscita dalla religione, è un’opportunità? (di Bernard Rivière).16 agosto 2010, di Federico La Sala
Uscire dalla religione
di Bernard Rivière
 in “www.temoignagechretien.fr” del 13 agosto 2010
in “www.temoignagechretien.fr” del 13 agosto 2010
 traduzione: www.finesettimana.org
traduzione: www.finesettimana.orgLa Buona Novella deve essere annunciata a tutti. Alcuni preti operai spiegano come la Chiesa, diventando una religione nel corso dei secoli, si è appropriata, snaturandolo, del messaggio di Gesù Cristo, e lo ha quindi reso inudibile da coloro che cercano Dio in verità.
Cogliere l’occasione!
“La sortie de religion, est-ce une chance?” (L’uscita dalla religione, è un’opportunità?), è un libro frutto della partecipazione di molte mani, di cui sarebbe troppo lungo elencare tutti gli autori. Citiamone però alcuni, innanzitutto e fondamentalmente quelli di una “mano” formata da cinque preti operai del Calvados, alla base della progettazione del libro. Troviamo frequenti citazioni di teologi: del gesuita Joseph Moingt, del pastore Dietrich Bonhoeffer (morto in campo di concentramento nel 1945), di Hans Küng...; di pensatori e filosofi: Marcel Gauchet, Mary Balmary, Jacques Duquesne...; di vescovi, di preti e di laici in gran numero...
Insieme, con le loro parole, le loro esperienze personali, le loro convinzioni, le loro attese, uniti dalla fede in Gesù Cristo saldamente stretta al cuore, vogliono comunicare ai lettori, e al di là di questi, ai credenti, che “l’essenza del messaggio evangelico è che l’umanità si realizzi pienamente”.
Non a seguito di lunghe dispute teologiche né di discorsi ex cathedra, ma attraverso lo sguardo d’amore che hanno tentato di rivolgere ai loro compagni di lavoro, questi preti hanno preso coscienza, una coscienza di fede viva, che “è passato il tempo in cui si poteva dire tutto agli uomini con parole teologiche e pie... Stiamo andando verso un’epoca totalmente senza religione”. (1)
Appropriazione
Fin dal secondo secolo della nostra era nascono le primissime, sporadiche comunità di discepoli di Gesù, spesso segretamente, senza alcuna intenzione nascosta di creare una religione, nel ricordo dell’amicizia di Gesù che alcuni affermano essere risuscitato. Il messaggio evangelico lentamente si propaga tra i “testimoni” che naturalmente cercano in maniera spontanea di trasmettere il messaggio della Buona Novella. A poco a poco - era inevitabile? - una certa organizzazione, comunque leggera, prenderà forma a partire dal IV secolo con l’impulso di Costantino e di Teodosio. E fu nei secoli seguenti che rapidamente prenderà il sopravvento l’aspetto istituzionale, soffocando a volte e troppo spesso, la spontaneità di una fede che chiede comunque solo di diffondersi.
Nel Nord Ovest
Alcuni preti del Calvados hanno percepito nella loro vita di tutti i giorni, durante il loro servizio come preti e lavoratori, che il messaggio di Gesù nel XX e nel XXI secolo era diventato inudibile. I primi capitoli del libro presentano molteplici testimonianze rese da loro stessi e dai loro compagni operai che esemplificano la deriva della Chiesa, che è diventata, da umile e al servizio della Buona Novella, una istituzione umana che viene chiamata “religione”.
Joseph Moingt riassume così l’evoluzione: “Il seguito di questa storia, che non ha mantenuto le promesse delle origini, lo si può riassumere dicendo che a poco a poco, nella Chiesa, la forma della religione ha coperto quella dell’annuncio, invece del contrario! L’annuncio è appello alla libertà, la religione è la costrizione di una determinata via di salvezza. Da questa conversione della Chiesa in semplice religione, che trasformava l’invito alla salvezza in ingiunzione minacciosa, è derivato il fatto che essa non ha più fatto sentire agli uomini la via della libertà né dell’umanesimo, poiché essa parlava solo un linguaggio religioso, tessuto di comandamenti, di mistero e di simbolismi sacri”. (2) Da questa convinzione nasce allora una lunga, semplice e appassionante scoperta di ciò che può essere ancora oggi l’annuncio della Buona Novella.
La pratica
Essere “praticante” consiste nel contribuire alla riuscita e alla crescita dell’umanità e non nel compiere atti rituali di una religione. “Essere cristiano, diceva Bonhoeffer, significa diventare radicalmente uomo e invitare anche gli altri a diventarlo”. Gesù invita a reintegrare l’uomo ferito, nudo, prigioniero, infermo nella società degli uomini.
“Ciò che fate al più piccolo, lo fate a me” (Matteo 25, 31-46). La salvezza assume un altro senso in questa prospettiva. La liberazione dal giogo della religione è uno degli aspetti della salvezza portati da Gesù. È il Regno che bisogna testimoniare e la Chiesa ha un senso solo se ciò che essa fa e dice è a servizio della vita e della felicità degli uomini e li apre così al vero progetto di Dio.
E gli autori, come una sorta di riassunto dell’opera, affermano, a rischio di scioccare: “Dio si è fatto presente in una umanità da umanizzare, ciò obbliga a pensare un Dio in divenire, Dio impegnato nella storia degli uomini. Dio non sarà totalmente Dio finché l’umanità non sarà davvero in piedi, autenticamente umana”. E terminano - o quasi - il loro saggio con un paragrafo importante: “La salvezza, (la riuscita dell’umanità) si gioca nell’oggi, nel quotidiano della vita”.
Queste conclusioni, che si basano sull’esperienza di uomini di fede impegnati nel mondo operaio, si rivolgono anche a tutti coloro che vogliono vivere intensamente la loro fede, quale che sia il contesto in cui vivono: “Sì, noi crediamo che non ci sia altro luogo per incontrare Dio che l’umanità”. “Il cristianesimo, è la religione dell’uscita dalla religione”, scrive con umorismo ma seriamente Marcel Gauchet. (3)
È un libro molto facile da leggere, che invita ciascuno ad interrogarsi sulla propria fede: “Credo in te, Dio in divenire, Dio in movimento, Dio presente ma allo stesso tempo futuro, Dio che rendi liberi e che ci aiuti a scrollarci di dosso la polvere delle nostre certezze” (Claude Simon).
 (1) Joseph Moingt, Dieu qui vient à l’homme, Le Cerf, 2002
(1) Joseph Moingt, Dieu qui vient à l’homme, Le Cerf, 2002
 (2) Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, Lettres et notes de captivité, Les Editions
Labor et fides
(2) Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, Lettres et notes de captivité, Les Editions
Labor et fides
 (3) La condition historique, Stock 2003
(3) La condition historique, Stock 2003
 La sortie de religion, est-ce une chance? (L’Harmattan), di Michel Gigand, Michel Lefort,
Jean-Marie Peynard, José Reis, Claude Simon, pp. 193, € 18.
La sortie de religion, est-ce une chance? (L’Harmattan), di Michel Gigand, Michel Lefort,
Jean-Marie Peynard, José Reis, Claude Simon, pp. 193, € 18.
-
-
> I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO". NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!! --- Rino Fisichella e la " nuova evangelizzazione" (con la parola truccata): «Quella violenza contro la Bibbia» (un’intervista di Armando Torno)9 agosto 2010, di Federico La Sala
«Quella violenza contro la Bibbia»
intervista a Rino Fisichella,
a cura di Armando Torno (Corriere della Sera, 9 agosto 2010)
Monsignor Rino Fisichella sulla strage di cristiani in Afghanistan: «La Bibbia non è un libro che provoca violenza, è ciò che essa rappresenta che può suscitare reazioni differenti». Gli otto medici, tra i quali tre donne, oltre due collaboratori afghani, uccisi con raffiche di kalashnikov dai talebani avevano con sé - lo ha sottolineato un portavoce degli esecutori - delle Bibbie. Mentre le ipotesi si moltiplicano intorno all’esecuzione sommaria da codice militare di guerra, le domande si moltiplicano. Ne abbiamo rivolte alcune a monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione.
Perché la Bibbia è oggetto di tanta violenza?
«La Bibbia non è un libro che provoca violenza, è ciò che essa rappresenta che può suscitare reazioni differenti». Intende dire che... «...Che vanno dalla conversione alla violenza. Diciamolo senza infingimenti: si sono uccisi otto volontari perché cristiani. È un’esecuzione mascherata con motivi di ordine politico».
Insomma, il mondo islamico non tollera chi ha una Bibbia...
«Vorrei precisare che siamo dinanzi a un’espressione culturale che pensa di aver raggiunto il culmine e non desidera confrontarsi con altri. L’ideologia che ha armato gli uccisori dei medici e dei loro collaboratori è la medesima che ha messo la dinamite nelle mani, una decina di anni fa, di coloro che fecero saltare le antiche rappresentazioni di Buddha».
Quindi la Bibbia...
«Nell’Islam è considerata una tappa e non un punto di arrivo della rivelazione. Il Corano, invece, non può essere interpretato, né sottoposto a ermeneutica o a una lettura storica. I fedeli lo devono accettare letteralmente perché è l’ultima parola di Allah, pur avendo elementi in comune con ebraismo e cristianesimo. Il musulmano ritiene che sia stato dettato direttamente dall’arcangelo e nessun intervento umano è possibile».
Bibbia e Corano stanno dunque alla base di due culture. Dialogheranno un giorno senza violenza?
«Mentre era in corso questa esecuzione, negli Stati Uniti si stava discutendo abbastanza animatamente sulla opportunità di costruire una moschea a Ground Zero. C’è una situazione asimmetrica tra la nostra concezione del rapporto che la religione dovrebbe avere con cultura e quello che i talebani intendono fare per la vita e la società».
La Bibbia, insomma, non contiene detonatori...
«Mi risulta difficile pensare oggi che il testo sacro che da noi consideriamo ispirato da Dio possa essere una causa di violenza, di reazioni. La Chiesa insegna che la Bibbia deve essere presa nel suo insieme, come Parola che viene tenuta viva nelle comunità e quindi interpretata di volta in volta. Un episodio dell’Antico Testamento che richiama la violenza è mitigato da altri dove si ricorda la misericordia di Dio».
L’idea stessa di una verità rivelata può alimentare la violenza?
«Quanto è successo è deplorevole e inquietante. Non si può mai avere una argomentazione religiosa per versare sangue. Le rivelazioni non devono essere sorgenti di violenza e di conflittualità. Certo, è in corso una guerra e non vediamo la fine di questa strategia fondamentalista; ma la Chiesa continua a ricordare la forza della ragione, di una ragione che entra all’interno della fede e consente di avere rapporti tra religioni diverse, basati su rispetto e conoscenza reciproche. La pace ha bisogno di reciprocità. Anche gli Stati Arabi dovrebbero impegnarsi per fermare le schegge di fondamentalismo e per porre fine alla violenza. Sinergia di forze tra Chiesa e Stati Arabi. Questi ultimi non si limitino a decidere soltanto il prezzo del petrolio».
