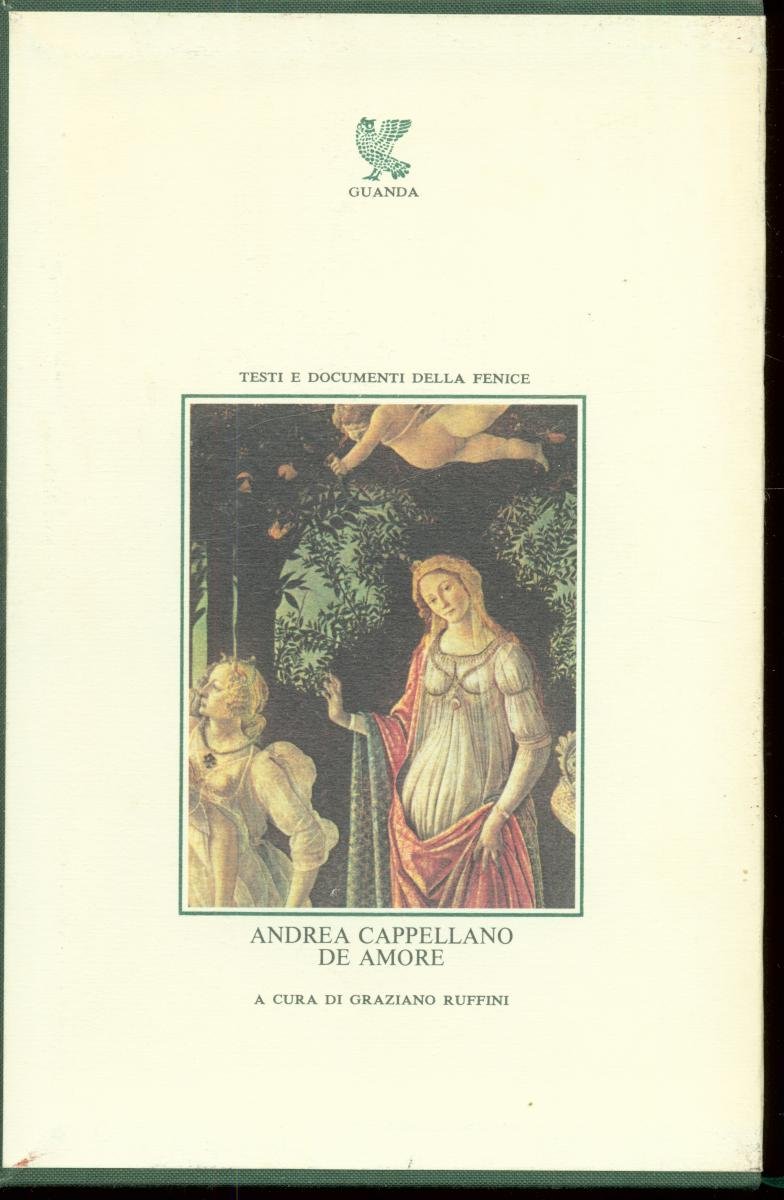
L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.), una recensione del prof. Federico La Sala
martedì 25 marzo 2008.
- [...] La contraddizione, quasi schizoide, del trattato di Andrea Cappellano è ancora più profonda di quanto non sembri; svela “le inquietudini di una cultura che era, insieme laica e clericale, spregiudicata e rispettosa dell’ordine sociale” (cfr. Storia e antologia della letteratura italiana, vol. I, Le origini, a cura di R. Antonelli, Firenze. La Nuova Italia, 1973, p.188) e la lacerazione che percorre la conoscenza dell’intellettuale europeo nel momento decisivo del suo formarsi. Nel trattato, cioè, resiste, latente non sciolto e alla fine vincente, lo stesso dilemma (labirinto morale) - con meno drammaticità ma non per questo di minor peso per la storia della coscienza intellettuale europea - di Abelardo (morto nel 1142) e di Eloisa (morta nel 1163) [...]
- DANTE E LA "MONARCHIA" DI AMORE...LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO.
ANDREA CAPPELLANO, De Amore *
All’interno del rinnovato interesse per il Medio Evo, giunge più che gradita la ripresentazione del De amore di Andrea Cappellano. Questo trattato in prosa latina, che ebbe grande diffusione in tutta Europa, trovò in Italia nel Trecento due traduttori, rimasti anonimi. Delle due versioni, entrambe toscane, Salvatore Battaglia nella sua edizione del De Amore (1947) utilizzò la più antica, che è anche la più valida, per l’efficace resa dei valori originali e per l’autonoma dignità dello stile. Ruffini propone invece, a fronte del testo latino che è quello stabilito dal Trojel nel 1892 (ristampa Monaco 1972), l’altra versione, “un volgarizzamento fiorentino (che si chiama traduzione romana solo perché il codice è alla Vaticana)”, il quale “impoverisce, confonde e pasticcia la sottigliezza dello stile di Andrea” (così Cesare Segre su “Alfabeta”, n. 22, 1981). Al Ruffini, cui si potrebbe rimproverare di non aver tentato una nuova traduzione (ma l’operazione interlinguistica, sempre difficile, sarebbe stata in questo caso difficilissima), è tuttavia da riconoscere il merito di aver richiamato l’attenzione su un trattato di notevole interesse letterario e culturale.
Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare, sono questi i nodi che Andrea Cappellano, “intellettuale” della seconda metà del XII secolo legato alla corte di Maria di Champagne (o, forse, del re Filippo Augusto di Francia), cerca di sciogliere a se stesso e alla società aristocratica del suo tempo. Definire i soggetti, i mezzi e i fini dell’amore è il tentativo e il programma del suo trattato.
L’opera, scritta su richiesta del nuovo cavaliere in amore, l’amico Gualtieri, che non sa “aconciamente direggiere li freni di quel cavallo” (p.5), è insieme, in due parti distinte (benché in tre libri), un vero e proprio trattato de amore e un trattato de reprobatione amoris. Nella prima parte si affronta da un punto di vista aristocratico-laico e naturalistico l’intero arco dei problemi amorosi; partendo da cosa sia l’amore fino alle regole d’amore; e nella seconda, aggiunta di spontanea volontà dall’Autore - per la “salute” del suo lettore Gualtieri - si sostiene “per aperta ragione che niuno dee ispendere male i suoi dì nell’amore” e che voler realizzare tutti i desideri del corpo porta “fuori della grazia di Dio e della compagnia e dell’amistà de’ buoni uomini per giusta ragione” (p.331). Nell’una c’è la riorganizzazione e sistematizzazione della tradizione classica e cortese, ove la donna gentile è punto di partenza e di arrivo della passione amorosa. Nell’altra c’è la ripresa e l’esposizione della maggior parte dei luoghi delle Sacre Scritture contro la donna: qui l’amore è concepito tout court come lussuria, forza e strumento del diavolo; il vero re d’Amore è Dio, l’unico e solo nostro Signore. Tra le due parti il contrasto non poteva essere più forte: quali le ragioni di questa “enorme contraddizione”, come la definisce anche Ruffini? “Si tratta - secondo quanto sostiene lo Zumthor - di una ritrattazione dopo che Andrea si era accorto del rischio che poteva correre con la sua teoria, cioè di essere condannato come eretico, condanna nella quale, nonostante tutto, incorrerà” (p. xix)?; o, secondo quanto sostiene lo stesso Ruffini, “dovremo invece, in tutta onestà, ammettere che queste contraddizioni furono dall’autore consapevolmente inserite nel trattato” per il fatto che la verità che Andrea desiderava trasmettere a Gualtieri andava protetta da sguardi indiscreti (p. xx)?
Di queste ipotesi né una né l’altra mostrano di cogliere il nodo cruciale della questione. Nel De Amore è in gioco un tentativo di separazione e di autonomizzazione del profano dal sacro (cfr. il cap. xix e il cap. xx, rispettivamente dedicati all’amore dei chierici e all’amore delle monache) e di fondazione della stessa attività intellettuale (si tenga presente che Andrea, oltre a voler “amaestrare con iscrittura” che non è Scrittura, pone il saver bene parlare come uno dei modi più importanti - insieme alla bellezza a ai belli costumi - per acquistare l’amore, tanto è vero che dedica al come parlare ben otto capitoli, dal xi al xviii)
Quando, nel 1277, “il vescovo di Parigi Stefano Tempier, facendo seguito a una bolla di papa Giovanni XXI, pronuncia contro il libro di Andrea Cappellano una solenne condanna, che ne accomuna le dottrine ad altre tesi naturalistiche e razionalistiche nonché, significativamente, alla dottrina della doppia verità” (A. Roncaglia, Il mondo cortese, in La poesia dell’età cortese, Milano, Nuova Accademia,.1961, p. xiii), la Chiesa si rende ben conto di quale sia la portata del De Amore. E lo stesso Dante, allorquando l’Amore divino gli avrà dato “intelligenza nova” (Vita Nuova, xli), non giudicherà diversamente chi del trattato ha sostenuto le teorie. In Dante, infatti, è la sintesi mistico - razionale incarnata da Beatrice a rendere possibile l’uscita “de la volgare schiera”, il grande Viaggio e il superamento delle “vecchie” teorie. Non a caso Guido Guinizelli e Arnault Daniel si trovano nel Purgatorio tra i lussuriosi a far penitenza per il loro peccato ermafrodito, cioè per non aver osservato “umana legge, / seguendo come bestie l’appetito”: questo non vuol forse dire che essi non solo non hanno saputo trarre dal De Amore il novo intendimento, ma neppure il vero, come invece hanno saputo fare Cino (“e studio sol nel libro di Gualtieri / per trarne vero e novo intendimento”) e, implicitamente, Dante stesso?
La contraddizione, quasi schizoide, del trattato di Andrea Cappellano è ancora più profonda di quanto non sembri; svela “le inquietudini di una cultura che era, insieme laica e clericale, spregiudicata e rispettosa dell’ordine sociale” (cfr. Storia e antologia della letteratura italiana, vol. I, Le origini, a cura di R. Antonelli, Firenze. La Nuova Italia, 1973, p.188) e la lacerazione che percorre la conoscenza dell’intellettuale europeo nel momento decisivo del suo formarsi. Nel trattato, cioè, resiste, latente non sciolto e alla fine vincente, lo stesso dilemma (labirinto morale) - con meno drammaticità ma non per questo di minor peso per la storia della coscienza intellettuale europea - di Abelardo (morto nel 1142) e di Eloisa (morta nel 1163), che la saggezza e la conoscenza presuppongono la continenza, che “la grandezza di un filosofo e di un chierico è legata alla sua continenza” (cfr. il suggestivo lavoro di E. Gilson, Eloisa e Abelardo, Torino, Einaudi, 1950, p.64).
È da tener presente, inoltre, che il De Amore, proprio per l’essere sforzo e luogo di codificazione di rapporti non solo amorosi ma etici e sociali da parte di una società aristocratica “progressista” quale quella francese, avrà un peso notevole sulla formazione ideologica della nascente borghesia: “La cortesia cavalleresca era l’ambizione della cortesia cittadina, e fino dalle più sue antiche formulazioni l’ideale presentato alla società comunale, da vari precettori, da Dante fino all’anonimo autore-fiorentino, popolano, mercante - del Novellino, era il “parlare” e l’ “operare” dei “nobili e i gentili”.(cfr. Ph. Jones, Economia e società nell’Italia medievale: la leggenda della borghesia, in Storia d’Italia,Annali I, Torino, Einaudi,1978, p. 268). Il dualistico groviglio di componenti aristocratico-laiche e mistico-ascetiche resterà nodo non sciolto al fondo della futura classe dominante ("Laica e mistica insieme, la borghesia del Medioevo [...]": H . Pirenne, La città del Medioevo, Bari, Laterza,1971, p.155); e sia quando il mistico riuscirà a funzionalizzare a sé il laico, sia quando il laico riuscirà a “separare” da sé il mistico, l’uno diverrà sempre il perturbante doppio dell’altro, pur nell’apparente vittoria.
Nel tentativo non riuscito di Andrea Cappellano di venir fuori da tale groviglio e, quindi, di dar vita a una gaia scienza (nello specifico a una vera ars erotica: “Nell’arte erotica la verità è estratta dal piacere stesso, considerato come pratica e raccolto come esperienza”) è da vedersi il sintomo e l’avvio di quel processo che porterà la nostra civiltà a essere - come rileva Foucault (La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1978, pp.53-54) - la sola, probabilmente, a praticare una scientia sexualis, “o piuttosto ad aver sviluppato, nel corso dei secoli, per dire la verità sul sesso, procedure finalizzate nell’essenziale ad una forma di potere-sapere rigorosamente opposta all’arte dell’iniziazione e al segreto magistrale: la confessione”.
Non è semplice coincidenza che, ancor prima della condanna del De Amore, la Chiesa proceda con il IV Concilio lateranense, nel 1215, a regolamentare il sacramento della penitenza e a rendere obbligatoria per tutti i cristiani, cioè per tutti gli occidentali, la confessione annuale. Facendo della confessione uno dei “riti più importanti da cui si attende la produzione della verità” e, al contempo, facendo del sesso la “materia privilegiata di confessione”, la Chiesa poneva implicitamente le basi di quella nuova e diversa scientia sexualis che, sviluppatasi a partire dal XIX secolo, avrebbe avuto di nuovo come nucleo centrale, paradossalmente, il singolare rito della “confessione” obbligatoria ed esaustiva.
*
 Si riprende, qui, la recensione
Si riprende, qui, la recensione
 di Federico La Sala
del testo di
di Federico La Sala
del testo di
 Andrea Cappellano,
Andrea Cappellano,
 De amore,
De amore,
 a cura di Graziano Ruffini,
a cura di Graziano Ruffini,
 Milano, Guanda, 1980,
pp xxxv-359,
Milano, Guanda, 1980,
pp xxxv-359,
 apparsa nella rivista “Filologia e critica” (maggio- giugno 1981, pp. 311-313, Salerno Editrice, Roma).
apparsa nella rivista “Filologia e critica” (maggio- giugno 1981, pp. 311-313, Salerno Editrice, Roma).
- Andrea Cappellano,
 De amore, Traduzione di Jolanda Insana
Con uno scritto di D’Arco Silvio Avalle, SE Studio Editoriale (1991 e ss.):
De amore, Traduzione di Jolanda Insana
Con uno scritto di D’Arco Silvio Avalle, SE Studio Editoriale (1991 e ss.):
- "Con il "De amore" di Andrea Cappellano è come se un nuovo patto venisse stipulato fra l’uomo e la donna. Dalla decadenza del peccato originale, di cui ultime e vistose tracce sono facilmente reperibili nella coeva letteratura misogina, si passa ad un nuovo genere di rapporto dominato dalla figura enigmatica e «tirannica» di Amore. Le responsabilità della vita morale scendono, in un certo qual senso, dal cielo alla terra, e l’uomo riscopre le radici del bene nel suo rapporto solitario con la donna. L’operazione non poteva non comportare rischi, e non solo per ciò che riguarda l’aspetto materiale delle sanzioni secolari. L’opinione pubblica infatti non era ancora matura per un tale ribaltamento dei valori comunemente accettati, ed era quindi necessario che l’amore profano portasse in sé tutte le stigmate e i segni di riconoscimento dell’amore sacro. [...] La solitudine delle coppie più celebri della letteratura «cortese», dagli amanti della tradizione trobadorica ad Abelardo e Eloisa, Tristano e Isotta, Ginevra e Lancillotto, e così via, è il durissimo scotto pagato per portare alla luce una società finalmente aperta a quelli che oggi definiremmo i diritti del cuore: esperienza questa indubbiamente più femminile che maschile, almeno in rapporto alla media dell’erotismo medievale. [...] Una volta accettato il principio di ritirare la delega dei poteri a chi per secoli ne aveva ricevuto una sia pur legittima investitura, e una volta ingabbiata nella teologia la figura paterna intervenuta a riscattare il mondo in uno dei momenti più tragici nella storia della civiltà greco-latina, è ovvio che l’uomo e la donna, nuovi Adamo ed Eva, fossero costretti a ripiegarsi su se stessi, a cercare in sé l’energia necessaria a preservare le istituzioni umane dal caos e dal disordine di un mondo retto dalle sole forze dell’istinto." (Dallo scritto di D’Arco Silvio Avalle)
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
- DANTE E LA "MONARCHIA" DI AMORE. L’Arca dell’Alleanza, il Logos, e l’ordine di Melchisedech...
- DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO.
- AL DI LA’ DI LACAN, LA LEZIONE DI BAUBO’: L’autr’ier vi un pelerin, | nes estoit de Limosin, | malades de l’esvertin, | si gisoit ens enun lit, | mout par estoit entrepris, | de grant mal amaladis; | tu passas devant son lit, | sisoulevas ton traïn | et ton peliçon ermin, | la cemisse de blanc lin, | tant que ta ganbetevit: | garis fu li pelerins | et tos sains, ainc ne fu si; | si se leva de son lit, | si rala en sonpaïs | sains et saus et tos garis. (XI, 16-31)(Aucassin e Nicolette, a cura di Mariantonia Liborio, Parma, Pratiche, 1991 (Roma, Carocci,2001)).
- "L’amore di Cimone. Tradizione medica e memoria cavalcantiana in Decameron V 1." Studi sul Boccaccio 44 (2016): 251-275 (Matteo Pace - Academia.Edu)
Dante (e Bacone), alle origini del moderno!!! Pace, giustizia e libertà nell’aiuola dei mortali
PERVERSIONI di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
Federico La Sala
Forum
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- ANTROPOLOGIA, ARTE, E COMUNICAZIONE: CON DANTE, UN OMAGGIO ALLA MEMORIA DELLA "DONNA-RAGNO" (ARACNE), ALL’ARTISTA LOUISE JOSEPHINE BOURGEOIS (1911-2010).3 luglio 2024, di Federico La Sala
CON DANTE ALIGHIERI, UN PASSO FUORI DALLA RAGNATELA "OLIMPICA" DELLA TRAGEDIA...
- UN OMAGGIO ALLA MEMORIA DELLA "DONNA-RAGNO" (ARACNE), ALL’ARTISTA LOUISE JOSEPHINE BOURGEOIS (1911-2010). *
ANTROPOLOGIA, ARTE, COMUNICAZIONE, LINGUISTICA, PSICOANALISI, E FILOSOFIA. Quella di Louise Bourgeois è, a mio parere, una lezione di #antropologia culturale che manda in frantumi la piramide "androcentrica" del "Sapiente" (1509-1510) di #Bovillus (v. allegato), e, con essa, in "pensione" la "#ScuoladiAtene" di #Raffaello (1509-1511), grandi "manifesti" di "propaganda e fede" della tradizione teologico-politica occidentale (e non solo) e sollecita a riequilibrare il campo della #relazione antropologica e a rendere giustizia alla arte critica di ogni mitica "Aracne" (#Ovidio, "Metamorfosi").
DIVINA COMMEDIA. Dante Alighieri aveva capito: "In principio era il #Logos", non un #Logo, ed è "l’amor che move il Sole e le altre stelle" (Pd. XXXIII, 145).
NOTE:
- LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA: #ANTROPOLOGIA, ANDROCENTRISMO, ANATOMIA, E #PSICOANALISI. L’ammissione di Giovanni Amusco de Valverde, del 1560 (v. allegato) e la straordinaria #lezione di "#Louise Bourgeois: la donna che portava il suo pene sottobraccio" (di Francesca Serra, "Doppiozero").
- LA TELA DEL RAGNO (MEMORIA DI ARACNE), IL PROBLEMA DEI NOMI (PLATONE E SAN PAOLO), E IL #TARANTISMO, COME TRACCIA DI UN #DISAGIO DELLA CIVILTÀ DI LUNGA DURATA.
- Mostra: “I had a flashback of something that never existed” (Louise #Bourgeois. L’inconscio della memoria. Villa Borghese, Roma). "Grand Tour di Louise Bourgeois" (Matteo Piccioni, "Doppiozero, 1 Luglio 2024.
- PSICOANALISI E ANTROPOLOGIA: "LA GRANDE #DOMANDA". A MARIE BONAPARTE, S. FREUD: "Was will ein Weib? Cosa vuole una #donna?" (Freud):
- "Oggi [#2LUGLIO] festeggiamo il genetliaco di una donna senza la quale la psicoanalisi avrebbe avuto ben altri destini e a cui dovremmo essere tutti molto grati: questa donna si chiamava MARIE BONAPARTE. [...] Nel 1923, cominciò a frequentare lo psichiatra Laforgue, e incappó in un libro di un tal Sigmund Freud. Marie ne fu molto colpita e decise che voleva conoscere meglio questa nuova scienza: la Psicoanalisi. [...] A 43 anni, la pronipote di Napoleone arrivó a Vienna per iniziare la seconda parte della sua vita. Restó molto impressionata dal rigore di Freud e dalla sua gentilezza. [...]. Marie Bonaparte si mise a tradurre in francese le opere di Freud e nel 1926 fondò, assieme ad altri 9, la Società Psicoanalitica di Parigi. Nell’ International Psychoanalytical Association (IPA) sostenne l’analisi didattica laica, aperta ai non medici. Scrisse più di 40 contributi scientifici tra cui un importante saggio sulla sessualità femminile. Il contributo della Bonaparte alla teoria psicoanalitica risiede proprio in questo testo d’avanguardia. Freud scrivendo alla Bonaparte ammetterà: "La grande #domanda, alla quale nemmeno io ho saputo rispondere, è questa: che cosa vuole la donna?” (Freud 1933). Nel tempo, Marie divenne una cara amica della famiglia Freud e seppe usare con intelligenza la propria posizione per aiutarli senza invadenze. [...] Quando il 12 marzo 1938 l’Austria venne annessa alla Germania nazista, Marie non esitò ad agire.
 Il 17 marzo arrivò a Vienna per difendere, con la sua posizione diplomatica di principessa di Grecia e Danimarca, Freud e Famiglia. Dopo che l’incarcerazione di Anna da parte della Gestapo, Freud finalmente si convinse che era necessario partire. Marie, troverà il modo di organizzare tutto e in breve tempo fece ottenere i visti alla famiglia, pagò ai nazisti un ingente riscatto perché i Freud potessero partire, con l’aiuto di Jones trovò una casa a Londra e fece anche arrivare in Inghilterra i beni di Freud. I fatti di quel salvataggio sono noti ma spesso non si nota con quanta abilità la Bonaparte seppe organizzare questa impresa in tempi così terribili.
Il 5 giugno 1938 fu lei lei ad attenderlo alla Gare de l’Est a Parigi e a ospitarlo prima della ripartenza verso l’Inghilterra. Marie era considerata di famiglia e visitò spesso Freud sia a Vienna che a Londra. Sempre a Marie dobbiamo alcune famose foto di Freud nei suoi anni più avanzati. [...] Nel dopoguerra tornò in Francia ed ebbe un ruolo fondamentale nella storia della psicoanalisi francese. In particolare si oppose strenuamente a Lacan, di cui non condivideva le scelte tecnico-teoriche e di cui aveva una pessima opinione. La Bonaparte dava molto valore allo studio dei testi di Freud e veniva soprannominata "Freud-ha-detto".
In realtà fu sempre una personalità forte all’interno della società psicoanalitica, fu capace di avere in mente sia i destino dell’istituzione sia la progressione della teoria. [...]" (Centro Veneto di Psicoanalisi).
Il 17 marzo arrivò a Vienna per difendere, con la sua posizione diplomatica di principessa di Grecia e Danimarca, Freud e Famiglia. Dopo che l’incarcerazione di Anna da parte della Gestapo, Freud finalmente si convinse che era necessario partire. Marie, troverà il modo di organizzare tutto e in breve tempo fece ottenere i visti alla famiglia, pagò ai nazisti un ingente riscatto perché i Freud potessero partire, con l’aiuto di Jones trovò una casa a Londra e fece anche arrivare in Inghilterra i beni di Freud. I fatti di quel salvataggio sono noti ma spesso non si nota con quanta abilità la Bonaparte seppe organizzare questa impresa in tempi così terribili.
Il 5 giugno 1938 fu lei lei ad attenderlo alla Gare de l’Est a Parigi e a ospitarlo prima della ripartenza verso l’Inghilterra. Marie era considerata di famiglia e visitò spesso Freud sia a Vienna che a Londra. Sempre a Marie dobbiamo alcune famose foto di Freud nei suoi anni più avanzati. [...] Nel dopoguerra tornò in Francia ed ebbe un ruolo fondamentale nella storia della psicoanalisi francese. In particolare si oppose strenuamente a Lacan, di cui non condivideva le scelte tecnico-teoriche e di cui aveva una pessima opinione. La Bonaparte dava molto valore allo studio dei testi di Freud e veniva soprannominata "Freud-ha-detto".
In realtà fu sempre una personalità forte all’interno della società psicoanalitica, fu capace di avere in mente sia i destino dell’istituzione sia la progressione della teoria. [...]" (Centro Veneto di Psicoanalisi).
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E LINGUAGGI. "A più voci. Filosofia dell’espressione vocale" di Adriana Cavarero: Voce, corpo, relazione (di Annalisa Pellino).16 aprile 2024, di Federico La Sala
LINGUAGGI
Voce, corpo, relazione
- "A più voci. Filosofia dell’espressione vocale" di Adriana Cavarero, a vent’anni dalla sua prima pubblicazione.
di ANNALISA PELLINO *
- Annalisa Pellino è PhD in Visual and Media Studies e attualmente collabora come assistente alla didattica e ricercatrice con il Dipartimento di Comunicazione, Arti e Media dell’Università IULM di Milano. I suoi saggi sono apparsi in volumi e riviste scientifiche peer-reviewed e ha scritto di cinema, arte contemporanea e cultura visuale per diversi magazine online, tra cui FlashArt, Doppiozero e Kabul Magazine. È co-fondatrice e attivista di AWI - Art Workers Italia
"Are the humanities undergoing a vocal turn?”. In un articolo del 2015 apparso sulla rivista Polygraph, Brian Kane avanza l’ipotesi che gli studi umanistici siano stati interessati negli ultimi anni da un vero e proprio vocal turn, in grado di competere con il linguistic turn e il visual turn. L’attenzione del musicologo per l’espressione vocale rientra in una più generale tendenza a riconsiderare l’importanza del suono e dell’ascolto nella lettura dell’esperienza audiovisiva contemporanea e nei processi di soggettivazione. Altri studiosi, invece, preferiscono parlare di auditory turn, che effettivamente esprime meglio la varietà dei fenomeni aurali che interpellano l’ascolto e la sua interazione con gli altri sensi. Che si scelga di usare l’una o l’altra formula, la voce è certo uno degli oggetti più interessanti da considerare in questo ripensamento radicale del modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo, entriamo in relazione, ripensiamo i termini della nostra stessa identità e il rapporto con la tecnologia: messaggi vocali, interfacce conversazionali, podcast, tecnologie di sintesi vocale per la lettura dei testi e deepfake della voce realizzati con sistemi di intelligenza artificiale (si pensi a quella di Warhol nella nuova serie di Netflix The Andy Warhol Diaries).
Di fronte a questo scenario, però, c’è un aspetto che viene sottovalutato nella riflessione sullo statuto della phoné, sulla sua materialità e sulle sue implicazioni socio-psicologiche, etiche, estetiche e politiche. È il fatto che essa resta comunque il più carnale di tutti i suoni, e a dispetto dei vari tentativi di ricreazione delle sue caratteristiche specifiche come il tono o il timbro, con effetti più o meno naturalistici. Di questa corporeità si è occupata Adriana Cavarero, che nel suo A più voci. Filosofia dell’espressione vocale (Castelvecchi, 2022) - appena ripubblicato dopo circa vent’anni dalla sua prima uscita - esplora lo statuto della voce risalendo alle origini metafisiche del pregiudizio epistemico che ci porta ad assegnare un peso conoscitivo più alla parola scritta che non alla voce che la esprime. L’analisi di Cavarero non solo scuote le fondamenta della cultura occidentale basata sul paradigma oculocentrico, ma sostiene la centralità della voce nell’articolazione del politico e del femminile e, a partire dal pensiero della differenza sessuale, mostra come tale articolazione sia orientata dal sistema del linguaggio. In particolare, la filosofa valorizza l’idea dell’eccedenza della phoné, che è insieme fonazione e relazione, misura del sé ma anche dell’altro, contemporaneamente medium del linguaggio e sua messa in discussione.
- Cavarero esplora lo statuto della voce risalendo alle origini metafisiche del pregiudizio epistemico che ci porta ad assegnare un peso conoscitivo più alla parola scritta che non alla voce che la esprime.
Il saggio parte da un confronto serrato con Platone per rileggere l’intera storia della filosofia come un processo di “devocalizzazione del logos”. Nelle concezioni arcaiche della voce, infatti, la phoné è assimilata sia al divino - come sua pura manifestazione sonora - sia al pensiero che si credeva prodotto dai polmoni e dall’apparato respiratorio e fonatorio: non a caso la parola nous (pensiero) rinvia a noos (naso). In questo senso è illuminante la differenza tra la cultura greca che, da Platone in poi, àncora la propria episteme alla sfera del visivo, e quella ebraica, che invece mantiene saldo il legame con la sfera uditiva. Nella prima la voce è sempre ricondotta alla parola scritta, quindi alla sua manifestazione visiva, insonora. Nella seconda, invece, la stessa potenza di Dio si manifesta non tanto nel Verbo, quanto nel respiro (ruah, in ebraico, pneuma nella versione greca dei Settanta e spiritus in latino) e nella voce (qol), sotto forma di “vento, brezza, bufera”, in una “sfera fondamentale di senso che viene prima della parola”. L’atto stesso della creazione consiste in un “puro vocalico, indifferente alla funzione semantica della lingua” e Dio diventa parola solo nella bocca dei profeti: è infatti la rilettura cristiana del Vecchio Testamento che riconduce alla parola (e non al respiro) l’atto della creazione. Sintomaticamente, la differenza si riflette anche nella lettura del testo sacro, che per gli ebrei avviene a voce alta con un’ondulazione ritmica del corpo che sottolinea la sonorità musicale della parola, mentre per i cristiani è silenziosa e immobile.
Un altro confronto importante per spiegare il fondamento “antiacustico e videocentrico” della filosofia e, per estensione, di tutto il pensiero occidentale, è quello che Cavarero stabilisce tra questa e l’epica, quindi tra Platone e Omero. Nell’epica, ciò che guida il discorso è la metrica, il ritmo e il suono, funzioni di un più complesso sistema mnemonico all’interno del quale il poeta cieco si fa cantore e interprete del messaggio della musa figlia di Mnemosyne. “Il vocalico comanda il semantico”, ma questo non è ammissibile nella casa della ratio androcentrica, tanto che Platone condanna l’epos e la mousiké, ovvero il piacere corporeo della musicalità: “sottratto all’evento dinamico del flusso vocale e consegnato alla fermezza del segno scritto, il linguaggio diventa un oggetto di osservazione [...] assume una forma organizzata, lineare e rivedibile”.
- Ciò che Cavarero contesta alla struttura del sapere occidentale, a partire dalle sue basi filosofiche, è il fatto di ridurre la voce a phoné semantiké, neutralizzandone la corporeità e il potere relazionale.
In particolare, ciò che Cavarero contesta alla struttura del sapere occidentale, a partire dalle sue basi filosofiche, è il fatto di ridurre la voce a phoné semantiké, neutralizzandone la corporeità e il potere relazionale. La filosofa, infatti, riconosce alla voce un ruolo centrale nella decostruzione del logocentrismo iniziata da Jacques Derrida con La voix et le phénomène (1967), al quale dedica l’appendice del libro riconoscendogli il merito di aver restituito indirettamente la voce alla sua materialità corporea. Nondimeno, se Derrida si concentra alla parola scritta (grammata) Cavarero si rivolge alla musicalità del vocalico che, attenzione, non va confuso con l’orale e, “come ogni strumento, necessita di una partitura”. Per chiarire la sottile ma sostanziale differenza fra le due dimensioni, la filosofa si richiama alla distinzione operata dal medievalista Paul Zumthor tra oralità, che indica “il funzionamento della voce in quanto portatrice di linguaggio”, e vocalità, intesa come “l’insieme delle attività e dei valori che le sono propri, indipendentemente dal linguaggio”. La voce, infatti, può essere sia portatrice di parola sia pura emissione sonora: del resto, se la prima può fare a meno della seconda, non si può certo dire il contrario. Che si tratti di parola scritta o proferita, la voce le contiene entrambe, ne stabilisce le condizioni di possibilità ma allo stesso tempo le eccede con la sua sonorità, stabilendo una tensione tra performativo e narrativo.
A questa tensione è dedicata tutta la seconda parte del libro, una galleria di ritratti di Donne che cantano, spesso figure femminili mostruose, teriomorfe e mortifere. Si pensi al canto mellifluo e seduttivo delle sirene, che sfidano il raziocinio di Odisseo, e sul cui corpo si consuma il complesso intreccio tra sistema del linguaggio e stereotipi di genere. Quella delle sirene, infatti, è originariamente una voce narrante, proprio come quella della Musa aedica, ma questo legame tra il canto e la phoné semantiké delle donne-uccello viene a perdersi nelle successive rappresentazioni che, non a caso, le trasforma in “sinuose, scarmigliate e pisciformi”, ridotte a puri vocalizzi o addirittura al silenzio. È questa solo la prima di tutta una serie di figurazioni in cui le voci femminili non sono mai presenti come parola o discorso, ma vanno incontro a un processo di sottrazione e fluidificazione: nell’acqua diventano puro suono ambientale che annacqua la soggettività e, per dirla con Douglas Kahn “spegne la scintilla dell’agency” (Noise, Water, Meat. A History of Sound in the Arts, MIT Press, 2001).
Un analogo destino di “nientificazione” (che nella nuova edizione diventa erroneamente “mentificazione”) tocca alla ninfa Eco. Punita da Giunone per il suo eccesso verbale e condannata a ripetere i suoni altrui. La ragazza ciarliera perde la facoltà di articolare i propri discorsi, il suo corpo si scarnifica fino quasi a mineralizzarsi e, assorbito dal paesaggio, si disperde nell’atmosfera. Nell’incontro erotico con Narciso, inoltre, Eco diventa un osceno “specchio acustico”, aspetto fortemente valorizzato nelle Metamorfosi di Ovidio, per cui l’huc coeamus (qui riuniamoci) di Narciso, muta, nella bocca di Eco, in coeamus (uniamoci) con riferimento al coito. Il loro duetto si basa sull’equivoco generato proprio dall’eccesso del vocalico che mina la comprensibilità del semantico: sul ritorno dello stesso suono da una parte e della stessa immagine dall’altra.
- Cavarero si sofferma a lungo sul confinamento della voce femminile nell’inarticolato o nei due estremi del canto e del silenzio, che si configurano sia come campi speciali di interdizione da parte dell’ordine simbolico patriarcale, sia della sua sovversione.
Cavarero si sofferma a lungo sul confinamento della voce femminile nell’inarticolato o nei due estremi del canto e del silenzio, che si configurano sia come campi speciali di interdizione da parte dell’ordine simbolico patriarcale, sia della sua sovversione. Si pensi ad Ada (Holly Hunter) in The piano (Jane Campion, 1993), o ancora a tutti i personaggi femminili inaddomesticati del melodramma che muoiono cantando: “Carmen è una zingara, Butterfly e Turandot sono esotiche, Tosca è una cantante, Violetta è una poco di buono. Donne che vivono al di fuori dei ruoli familiari, figure trasgressive e spesso capaci di indipendenza, esse non si limitano a morire, ma devono morire perché tutto torni a posto”. L’opera, fra l’altro, è per Cavarero il luogo per eccellenza dove il principio acustico che orienta il femminile vince su quello videocentrico del maschile: ciò avviene attraverso la figura del castrato che rinuncia ai propri connotati virili per farsi corpo-voce di donna. E anche quando si riversa nella scrittura, la voce femminile mantiene il suo legame con la “sfera preverbale e inconscia, non ancora abitata dalla legge del segno, dove regna l’impulso ritmico e vocale”. A tal proposito la filosofa fa riferimento a l’écriture feminine di Hélène Cixous - qui assimilata alla nozione di chora semiotica di Julia Kristeva - insieme gesto estetico e politico: “scrittura fluida, ritmica e debordante, che rompe le regole del simbolico facendo esplodere la sintassi. Essa precede ed eccede i codici che governano il logos fallocentrico.” Cixous è un’ebrea algerina che prova a scompaginare e reinventare la sintassi della lingua paterna - il francese, la lingua del colonizzatore - musicandola con il tedesco da ebrea askenazita della madre in maniera del tutto in(a)udita: si tratta di un piacere legato alla voce materna che si mescola con quello orale del latte e informa una “lingualatte (languelait) che, nella sua effusione gratuita, ricopre tutto il registro dei piaceri orali e delle vocalizzazioni infantili”.
Ma allora, viene da chiedersi, cosa significa la voce quando si sottrae al sistema della significazione? Due sono gli aspetti su cui insiste Cavarero: l’unicità della persona e la relazione. La phoné esprime innanzitutto il corpo che la emette, in quanto manifestazione di una “singolarità irripetibile” che si manifesta nel dire piuttosto che il detto: “la voce pertiene al vivente, comunica una presenza in carne e ossa, segnala una gola e un corpo particolare”. Inoltre, al contrario dello sguardo, la voce è sempre relazionale: in latino, ci ricorda la filosofa, vocare è chiamare: “prima ancora di farsi parola, la voce è un’invocazione rivolta all’altro e fiduciosa di un orecchio che la accoglie”. Nella “prossimità pneumatica” si stabilisce dunque l’essere per l’altro, ovvero la relazione che ha luogo nel contatto diretto tra le cavità di un corpo che emette un suono e quelle di un corpo che lo riceve, in ciò che di più nascosto e vibrante c’è in ognuno di noi.
Anche qui sono numerose le voci, filosofiche e letterarie, che si incontrano in questo viaggio a ritroso alla scoperta della materialità della phoné: da Ida Dominijanni ad Hannah Arendt, da Jean-Luc Nancy a Emmanuel Lévinas; dal Re in ascolto di Italo Calvino a Hurbinek - il bambino nato nel campo di concentramento di Auschwitz la cui vicenda, narrata da Primo Levi ne La Tregua (1963), chiude significativamente il saggio. Proprio le storie del Re in ascolto e di Hurbinek dicono di quanto la voce sia un plus-de-corp - per usare un’espressione di Mladen Dolar (La voce del padrone. Una teoria della voce tra arte, politica e psicoanalisi, Orthotes, 2014) - che si rivela attraverso una serie di manifestazioni fisiologiche e somatiche capaci di eccedere la struttura del linguaggio, occupando uno spazio di verità e di relazione non linguistica con l’alterità, dove umano e animale si approssimano e la voce “qualcosa dice, ma niente che si possa fissare in un significato. Mima il linguaggio, senza arrivare alla parola. Comanda, seduce”.
* cfr." LINGUAGGI ANNALISA PELLINO / IMMAGINE: JOHN WILLIAM WATERHOUSE, ULYSSES AND THE SIRENS, 1891 / 11.5.2022". Il Tascabile (ripresa parziale - senza immagine).
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- STORIOGRAFIA E CINEMA: “IL MIO DANTE”, BOCCACCIO E “DIECI FIORINI D’ORO“. Un omaggio a Pupi Avati.29 marzo 2023, di Federico La Sala
CINEMA, LETTERATURA, FILOLOGIA, E CRITICA:
BOCCACCIO, “IL MIO DANTE” E “DIECI FIORINI D’ORO“. *
Un omaggio a Pupi Avati...
Se è vero, come Pupi Avati scrive (“Il mio Dante”, Insula europea, 3 febbraio 2020), che «”L’origine delle idee non la si percepisce mai” lo asseriva il Budda e per quello che mi riguarda ho da sempre la sensazione che sia assolutamente vero» .... allora bisogna solo ringraziarlo per la schiettezza (sveglia da un sonno storiografico di lunga durata!) e, al contempo, prendere atto che, con il suo film “il mio Dante”, si assiste solo all’ennesimo ritornello storiografico che del viaggio di Dante (dell’uomo e del poeta), per “dieci fiorini d’oro”, si compra lo spirito fondante (“l’amor che move il sole e le altre stelle”) e si finisce per celebrare il desiderio di fama e di gloria di Boccaccio (non di Dante Alighieri): “Insomma Boccaccio voleva davvero che si facesse questo film” (Pupi Avati)!
Ma non è il caso e il tempo di uscire dal letargo (Pd. XXXIII, 94) e ricordare che la primavera è già arrivata e che uscire dall’inferno è possibile?!
Dopo i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, e Freud), come è possibile (Kant) continuare a pensare, all’altezza del Dantedì ( 25 marzo 2023 ), che Dante tradisca spiritualmente la sua sposa Gemma Donati e i suoi figli e la sua figlia Antonia, suor Beatrice? (Sul tema, forse, può essere utile tenere presente una mia “vecchia” ipotesi di ri-lettura della vita e delle opere di Dante.
*
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- STORIA E STORIOGRAFIA. IL "DE AMORE" (Andrea Cappellano), LA "VITA NUOVA" (Dante Alighieri), E IL "DECAMERON" (Giovanni Boccaccio). Una nota su un nodo non sciolto.3 marzo 2023, di Federico La Sala
LETTERATURA, ANTROPOLOGIA, E PSICOANALISI:
IL "DE AMORE" (Andrea Cappellano), LA "VITA NUOVA" (Dante Alighieri), E IL "DECAMERON" (Giovanni Boccaccio). Una nota su un nodo non sciolto... *
STORIA E STORIOGRAFIA. Sulle ragioni da parte di Boccaccio della costruzione nell’analisi della vita di Dante, forse, concorrono insieme
A) la non comprensione della "Vita Nuova" e della "Commedia" stessa di Dante, che, con l’aiuto di #Virgilio (e di #Beatrice, sollecitata da #Lucia, su intervento di #Maria), cerca di riprendere il filo di tutta la storia dell’#umanità e ri-indicare la "diritta via" per ritrovare il #paradisoterrestre, con la ricostruzione del #presepe (come da indicazione di Francesco d’Assisi),
B) e, al contempo, la volontà di rinchiudere il messaggio di Dante nel suo tempo, quello segnato ancora dall’ amore, entro le coordinate non chiare e non risolte della "sintesi", proposta nel "De amore" di Andrea Cappellano, della letteratura «#cortese»,
C) e, non ultima, una interpretazione della tradizione religiosa diversa dalla radicalità teologico-politica di Dante. Il risultato si vede (ancora) dinanzi agli occhi delll’attuale presente storico: il "De amore" di Cappellano si confonde con l’amore della Divina Commedia e con l’amore del Decameron; e lo sguardo antropologico (prima che politico) dei "due soli" di Dante è ancora addirittura difficile da concepirsi e si confonde ancora "charitas" (amore), con "caritas" (#mammona) e con l’avidità di Eros (#Cupìdo).
#DANTE, #MILTON, E #FREUD. Alla fidanzata Martha, il 7 agosto 1882, Freud scrive che, nel "Paradiso perduto" (John Milton, 1667), «ancora di recente, in un momento in cui non mi sono sentito sicuro del tuo #amore, ho trovato consolazione e conforto».
#EARTHRISE #METAPHYSICS #ANTHROPOLOGY #ELEUSIS2023 #ROMA2024
*
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E PSICOANALISI. APPRENDIMENTO DELLA LINGUA MATERNA, RICORDO DELLA "FATINA MUTA", ED "ECOLALIE" (di Pietro Barbetta).22 novembre 2022, di Federico La Sala
Chi ricorda la fatina muta?
di Pietro Barbetta (Doppiozero, 20 Novembre 2022)
- Nothing will come of nothing (Shakespeare, King Lear)
Ricordo che, in prima elementare, sui muri della classe, erano appese alcune tavole di cartoncino bianco, simili a quelle di un test proiettivo, come le macchie di Rorschach. In ognuna di queste tavole c’era un’immagine. Rivedo con nitidezza il dado che rappresenta la letterina D dell’alfabeto. Ma, tra le altre, ricordo anche una strana tavola, inquietante, o, come direbbe uno psicoanalista, perturbante: la fatina muta, che rappresenta un fonema afono, la lettera H della lingua italiana. Esiste tra le ventuno, come ottava lettera dell’alfabeto, ma non si pronuncia. Pensare alla negazione mi riporta a questa immagine, a interrogare, quindi, il linguaggio e il suo rapporto con quel che gli sta fuori: il corpo, l’immaginario e il niente.
La fatina muta potrà servire al lettore per cogliere intuitivamente la realtà complessa di questo strano fenomeno: quello di un suono assente. Aspetto relativo alla negazione che silenziosamente si mostra durante l’apprendimento della lingua materna.
Nel 2007 è stata pubblicata per Quodlibet la traduzione di un testo di Daniel Heller-Roazen, Ecolalie: l’autore, in questo volume ci parla in modo completo di tutti quei fenomeni linguistici che somigliano alla fatina muta. Il processo infantile di apprendimento della lingua è inevitabilmente una perdita, la caduta di un’enorme quantità di fonemi dallo spazio cognitivo dell’infante. Così esordisce Heller-Roazen: “I suoni prodotti dal bambino nelle onomatopee rappresenterebbero forse gli ultimi scampoli di un balbettio altrimenti dimenticato, o non sarebbero piuttosto i segni di una lingua di là da venire?”
In prima elementare, quando non sentiamo la presenza evidente della fatina muta, cosa stiamo perdendo? Da un caotico sistema di rumori, suoni, versi e fonemi, che la voce può emettere, per apprendere la lingua materna bisogna eliminarne alcuni. Mentre si crea un ordine linguistico, dunque, si riducono drasticamente le potenzialità fonetiche del soggetto. Questo è apprendere.
Il termine “ecolalie”, usato da Heller-Roazen, si riferisce al suo maestro Roman Jakobson, autore di Linguaggio infantile, afasia ed universali fonologici, apparso nel 1971 per Einaudi in Il farsi e il disfarsi del linguaggio. Linguaggio infantile e afasia.
Il paradosso della negazione linguistica è che, quando si perdono le competenze linguistiche di base, emergono le ecolalie, suoni inusitati. Quei fonemi che avevamo perduto durante l’apprendimento della lingua materna riemergono, senza significato, assieme a uno strano modo di gesticolare. Heller-Roazen conclude che la lingua madre non basta a se stessa: “È qui che la lingua, gesticolando oltre se stessa in un discorso che non può dirsi tale, si apre a una non-lingua che la precede e la segue”.
Queste ricerche insistono sulla relazione tra il corpo e il linguaggio, come se, questi due fenomeni dell’esistenza, corpo e linguaggio, non fossero due, ma uno solo: tra corpo e linguaggio vi è reciproca immanenza, ce lo insegnano i corpi teneri dei neonati e dei feriti, che gridano, lamentano, gioiscono e non si lasciano comprendere nel loro dirci, con espressione. Qualcosa che per l’altro rimane oscuro.
Che cosa accade durante la prima infanzia e nella patologia? Suoni strani, inusitati, vengono emessi dell’infante e, nella patologia, recuperati.
Nel linguaggio psicopatologico viene imposta una distinzione tra ecolalia e glossolalia. Per ecolalia si intende, di norma, una ripetizione senza senso di alcune frasi o parole, udite dal paziente; con glossolalia invece ci si riferisce a una sorta di nuovo linguaggio idiosincrasico inventato dal paziente. Nel caso ecolalico si parla di afasia, un danno al sistema nervoso; la glossolalia invece riguarda la follia, ma anche l’esperienza religiosa pentecostale, o i canti delle donne durante i funerali. In entrambi i casi però la questione riguarda la produzione di rumori, suoni, versi, grida che evocano fonemi negati al discorso, cioè alla lingua ufficiale del parlante. Ma anche esperienze del corpo; le tarantate di Galatina, studiate da Ernesto De Martino, per esempio, producono glossolalie e movimenti eco-gestuali, simili a quelli delle bambine quando l’adulto le rimprovera di stare “composte”.
Le ecolalie perdute durante l’apprendimento della lingua materna riemergono nei fenomeni afasici conseguenti ai danni focali di un’ischemia o di una violenta contusione alla testa oppure, nelle glossolalie, di un paziente schizofrenico, quale fu Antonin Artaud, che ne ricavò forme poetiche, o non schizofrenico, quale fu James Joyce in Finnegans Wake.
Negli anni Sessanta, presso le scuole elementari si insegnava l’alfabeto a partire da un rapporto biunivoco tra il segno e la pronuncia. In quel contesto, tutto funziona bene fin quando ci si trova di fronte alla “fatina muta”.
L’infante alle prese con la parola scritta si chiede che senso ha una lettera che non si emette, una funzione che serve solo a rendere dure un paio di consonanti gutturali. Il testo di Heller-Roazen indaga questo fenomeno sul piano ontogenetico, nei primi due capitoli - quando scrive intorno alla crescita/perdita infantile - e filogenetico, quando parla, con grande competenza, della creazione storico sociale delle lingue. Le lingue sono tali perché esiste un’indefinita quantità di suoni che vengono negati. Un po’ come nella Biblioteca di Babele raccontata da Jorge Luis Borges.
Esiste un modo per ricreare quel tempo perduto? Forse sì, ma bisogna cambiare epistemologia.
-
> L’AMORE E LA PAROLA --- ALLA RICERCA DELLA LINGUA D’AMORE: LETTERATURA, PSICOANALISI, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA.18 novembre 2022, di Federico La Sala
ALLA RICERCA DELLA LINGUA D’AMORE: LETTERATURA, PSICOANALISI, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA.
Note a margine del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West e tra Sigmund Freud e Wilhelm Fliess...
PREMESSO CHE "Una stanza tutta per sé" è un saggio pubblicato nell’ottobre del 1929, e il romanzo Orlando ("Orlando: A Biography") era stato pubblicato l’anno prima, nel 1928, forse, può essere una buona traccia per ulteriori approfondimenti porre accanto e "coniugare" il carteggio tra "Judith, la sorella di Shakespeare", Virginia Woolf e Vita Sackville-West (“Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio”, Donzelli, 2019) e il carteggio tra "Guglielmo il Conquistatore", Sigmund Freud e Wilhelm Fliess ("Lettere a Wilhelm Fliess, 1887-1904", Boringhieri, 1986): nel fuoco della relazione e della ricerca delle due coppie sono proprio i temi dell’antropologia e del "disagio della civiltà" (S. Freud, 1929), con le loro profonde tragiche radici nel "Simposio" di Platone e nella tradizione del "platonismo per il popolo" (Nietzsche):
A) ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI: «Ho cominciato a considerare con attenzione il concetto di bisessualità e considero la tua idea in proposito come la più significativa per il mio lavoro, dopo quella di "difesa"» (S. Freud a W. Fliess, 04.01.1898).
B) "DE AMORE": L’AMORE E LA PAROLA. "[...] cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: Orlando, il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile [...] La stesura di Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno." (Caterina Venturini, "Ti nomino meglio che posso: la lingua d’amore di due donne libere. Sul carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West", Femministerie 26 settembre 2019).
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- Ti nomino meglio che posso: la lingua d’amore di due donne libere. Sul carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West (di Caterina Venturini).17 novembre 2022, di Federico La Sala
VITA E FILOSOFIA, PSICOANALISI, LETTERATURA, E RICERCA ANTROPOLOGICA. A proposito del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West... *
- Cum grano salis, il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West (“Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio”, Donzelli, 2019) può essere messo accanto al carteggio tra Sigmund Freud e Wilhelm Fliess ("Lettere a Wilhelm Fliess, 1887-1904", Boringhieri, 1986):
- "[...] cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: hashtag#Orlando , il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile [...] La stesura di hashtag#Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno." (Caterina Venturini ).
*
Ti nomino meglio che posso: la lingua d’amore di due donne libere.
Sul carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West
di Caterina Venturini ("femministerie",26 settembre 2019)
“Se questo libro avrà contribuito a mettere ancora una volta in luce la vitalità di Virginia Woolf e, attraverso il legame con Vita, a mostrare il suo amore per il canto del mondo reale e per tutto ciò che vive e respira, avrà raggiunto il suo obiettivo.” Così si augura Elena Munafò nella bella postfazione al carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West “Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio” (Donzelli, 2019) e mi viene da risponderle: certamente.
Ho scoperto in queste lettere molte cose che non sapevo, altre che non ricordavo, infine alcune che non immaginavo affatto. Intanto il tono, vivace, “sbarazzino” addirittura di Virginia e Vita (reso magistralmente dalla traduzione di Nadia Fusini e Sara De Simone), la delicatezza del loro parlato che diventa scritto senza abbandonare certe luminosità del quotidiano; e poi la spregiudicatezza di una società - da una parte gli intellettuali borghesi di Virginia, dall’altra la classe aristocratica di Vita - e di un tempo molto più libero, per certi versi, del nostro. Un viversi sentimentalmente, sperimentare, incrociare persone e situazioni, senza rinunciare mai al rispetto e all’amicizia, qualsiasi cosa accada. E infine la grande cura per i libri, soprattutto di Virginia editrice (anche dei libri di Vita) che trascorre intere giornate a leggere i manoscritti per la Hogarth Press, casa editrice da lei fondata insieme con il marito Leonard Woolf. Una cosa oggi inimmaginabile.
Comincio dunque dal primo contenuto che mi ha appassionato di queste lettere: lo stile, la lingua usata dalle due amanti per esprimere il reciproco affetto, l’ammirazione, l’amore e il sostegno, che mai viene a mancare per tutto il tempo del carteggio che dura fino a due settimane prima della morte di Virginia nel marzo del ’41, in piena Seconda guerra mondiale. La vivacità del tono, che potrebbe essere assimilata a qualcosa di più contemporaneo, si situa invece precisamente nel tempo a cui appartiene per una gentilezza, un’eleganza, un calore che è quello di comunicazioni che vogliono esprimere il più possibile sulla carta, ancora rare le telefonate. Questo tono, dicevo, conserva intatta l’emozione delle due donne nell’inviare e ricevere lettere che al momento sono il loro principale mezzo di comunicazione, anche quando i loro incontri si faranno più radi. Colpisce e quasi turba, se paragonata all’oggi, la ricerca della parola esatta, che lungi dall’essere un inutile sfoggio, diventa invece la prima espressione di cura reciproca, come a dire: ti nomino meglio che posso; al tempo stesso ricorrono epiteti affettuosamente triviali come “somara” e “scandalosa ruffiana”, che non fanno che comporre il quadro di questa relazione con quanti più colori ci sia dato immaginare per l’incontro di due sensibilità in fondo così diverse, ma che riescono a riverberare l’una sull’altra parte del proprio temperamento.
Se finora conoscevamo una Virginia “lunare” e una Vita mondanissima, alla vertiginosa altezza del suo nome, queste lettere ci consentono finalmente di cogliere altri aspetti del loro carattere e delle loro inclinazioni, esaltate dal doppio dell’amica: sono sempre l’una davanti all’altra. Virginia acquista degli aspetti più giocosi e Vita scende nelle profondità d’animo che l’amata la invita a penetrare, anche come scrittrice: sembra infatti esserci qualcosa che non vibra in Vita - dice Virginia - c’è un nucleo freddo in questa nobildonna che sembra muoversi a proprio agio ovunque, ma che rivela in ultimo una cupezza, di cui anche Vita è/diventa più consapevole, scrivendone poi sbalordita al marito Harold Nicolson. Già, perché intorno a queste lettere ce ne sono molte altre (suggerite in alcune note di questa edizione): quelle che Vita e Virginia scrivono ai loro amici, alle amiche, alle amanti e ai rispettivi mariti. Ed è questo un altro aspetto inter e extra testuale che si rivela molto affascinante a una lettura contemporanea: la ricchezza degli affetti e delle relazioni, di cui probabilmente neppure loro stesse sono del tutto consapevoli, ma che al nostro sguardo, risulta tra le più grandi qualità di questa epoca post-vittoriana e modernista in cui la borghesia intellettuale e l’aristocrazia, pur non amandosi tra loro (vedi il sospetto con cui il circolo di Bloomsbury guardava Vita), godono del grande privilegio, anche economico e sociale, di poter costruire forme di rapporto così libero, da essere oggi - nell’epoca dei sacrosanti diritti riconosciuti - considerato quasi stravagante.
- [Foto] Virginia Woolf / Vita Sackville-West
Nelle lettere di Vita e Virginia, vengono raccontati matrimoni che sono in realtà delle amicizie; amicizie che diventano passioni; ménage à trois che si aprono a ulteriori geometrie. Virginia confessa a Vita la sua perplessità, dopo la lettura di Anna Karenina, per “la crescente irrealtà del suo tema principale”, l’adulterio, “che in fondo al cuore non condanniamo più [...] mentre Tolstoj basa tutto il libro su quello. Ma tolto quello, se non mi scandalizza che AK copuli con Vrònskij, che cosa rimane?”.
 Quella di Virginia è una domanda vera, che si pone anche e soprattutto in scrittura: cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: Orlando, il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile, attraversando tre secoli pieni di avventure tra l’Inghilterra e l’Asia, luoghi cari proprio a Vita che seguì il marito ambasciatore fino a Teheran. La stesura di Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno.
Quella di Virginia è una domanda vera, che si pone anche e soprattutto in scrittura: cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: Orlando, il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile, attraversando tre secoli pieni di avventure tra l’Inghilterra e l’Asia, luoghi cari proprio a Vita che seguì il marito ambasciatore fino a Teheran. La stesura di Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno.La sperimentazione est/etica di Orlando, invece, non si configura in quell’assenza di trama, cui ci ha abituato Woolf nei romanzi precedenti, ma proprio nei comportamenti del personaggio, nel suo mettere costantemente alla berlina la tradizione cavalleresca ed eroica della nobile famiglia cui appartiene (si veda a tal proposito L’atto sospeso. Azione e inazione dell’eroe nella tradizione letteraria europea, tesi di dottorato di Sara De Simone). Durante i tre secoli che Orlando attraversa, l’unica sua opera sarà infine un poema ispirato da una quercia a lui cara. Del resto, in letteratura l’eroe che non combatte è l’intellettuale.
Eppure, l’ironia che Woolf esercita nel 1928 sull’epica cavalleresca, al solito, si riferisce più al suo presente e risponde a quella retorica della guerra che tanto si era espressa durante il primo conflitto mondiale e che porterà coerentemente la scrittrice - esattamente dieci anni dopo, nel ’38 - con il pamphlet Le tre ghinee, a condannare radicalmente anche il nuovo incipiente conflitto, legando la guerra e la militarizzazione al patriarcato e individuando nella marginalizzazione della donna, esclusa storicamente dal potere, un’occasione di pensiero non conforme, appunto. Si può notare dunque, come a una non conformità sentimentale ne corrisponda e discenda un’altra di ordine etico e politico, che pone le basi del pensiero divergente dei futuri femminismi.
Tuttavia, e ciò è evidente proprio nel carteggio tra Vita e Virginia, quest’ironia post-vittoriana non distrugge mai l’oggetto, letterario e amoroso; questa leggerezza, sempre dubitante, direi che è anzi il contrario del nostro contemporaneo e progressista pensare di essere sempre migliori di chi ci ha preceduto, e ci ricorda che anche in un’epoca di mancati diritti civili come quella dei primi del Novecento - cui non s’intende certo tornare - si poteva aspirare a un’originalità di costumi oggi rara tra i contemporanei, stretti tra il neo-moralismo dei social che insieme ai prodotti ci vendono modelli di comportamento e pensiero, e apparati tecnologi che ci illudono di poter essere/contenere tutto, togliendoci in cambio molte umane abilità.
Se si guarda alle nuove generazioni, poi, non si può non notare che i legami affettivi e sessuali sono spesso parte integrante di una dimostrazione di successo complessivo della persona, con una gigantesca contraddizione tutta da sciogliere tra una sorta di capitalismo dell’amore, che propone l’accumulo di relazioni e appuntamenti spesso normati dalle app e, dall’altra parte, un nuovo puritanesimo soprattutto dei giovanissimi in cui la coppia (famosa) è sacra e chiunque attenti ad essa, è meritevole di morte. D’altra parte, quelli che diventano famosi soltanto esibendo la loro vita sentimentale (specialmente nei reality), devono costantemente recitare il copione di una vita sessuale morigerata e fedele, pena la disaffezione dei fans che possono adorare/comprare soltanto l’eterna favola a lieto fine.
La nuova tecnologia degli smartphone, d’altra parte, illudendoci di controllare tempi e luoghi della comunicazione con e dell’Altro, non di rado limita, se non annulla, la nostra capacità di attesa e ri/elaborazione del pensiero. Appare oggi difficile, rara, a tratti impensabile, la concentrazione e la profondità del discorso amoroso di Vita e Virginia, che avevano tutto il tempo e i luoghi, appunto, per ri-pensare e ri-significare la loro comunicazione in totale assenza dell’altra. Un’assenza riproducibile forse solo dalle email, alle quali tuttavia manca una serie di imponderabilità che appartenevano invece alle lettere. Cosa resta oggi di quella capacità di ascolto? Cosa resta di quell’assenza, di quella morte apparente del destinatario che ricreava ogni volta il desiderio dell’altro, dell’altra da sé?
 È ancora possibile oggi, salvare qualcosa da altre epoche, pure imperfette quanto e talvolta più della nostra, affinché l’auspicata normalità dei diritti non si traduca sempre di più in una normalizzazione dei comportamenti e dei desideri?
È ancora possibile oggi, salvare qualcosa da altre epoche, pure imperfette quanto e talvolta più della nostra, affinché l’auspicata normalità dei diritti non si traduca sempre di più in una normalizzazione dei comportamenti e dei desideri?
Sul tema nel sito, si cfr.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.).
Federico La Sala
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? --- "Carte d’Amore". Dialogo sull’amore con Antonio Prete (di Anna Stefi - "Doppiozero).3 maggio 2022, di Federico La Sala
CARTE D’AMORE /
Dialogo sull’amore con Antonio Prete
di Anna Stefi (Doppiozero, 02 maggio 2022)
“Tutti li miei penser” - scrive Dante Alighieri nella Vita Nuova - “parlan d’Amore”.
 Ma come si scrive di amore? Non c’è forse un certo pudore nell’avvicinarsi a questo “paese che non ha confini”, nel cercare di circoscriverlo, raccontarlo al di là di nomi, corpi, ricordi, al di là del “tu” cui ogni amore si rivolge? E ancora: che cosa è questo “tu”? Già Fedro nel Simposio ricordava quanto nessun uomo avesse mai osato celebrare degnamente Eros. Eppure l’amore è esperienza comune.
Ma come si scrive di amore? Non c’è forse un certo pudore nell’avvicinarsi a questo “paese che non ha confini”, nel cercare di circoscriverlo, raccontarlo al di là di nomi, corpi, ricordi, al di là del “tu” cui ogni amore si rivolge? E ancora: che cosa è questo “tu”? Già Fedro nel Simposio ricordava quanto nessun uomo avesse mai osato celebrare degnamente Eros. Eppure l’amore è esperienza comune.Carte d’Amore prosegue il cammino di Antonio Prete attorno ai modi del sentire: nostalgia, lontananza, compassione, interiorità. Un cammino che qui si fa figure dell’amore - apparizione, seduzione, tenerezza, e ancora ombra, lettera, gelosia - e paesaggi dell’amore - giardino, mare, strada, corpo. A separare questi due momenti un intermezzo: il Simposio. Sappiamo del banchetto in onore di Eros, sappiamo di Pausania, di Aristofane, sappiamo di Agatone e di Diotima. Antonio Prete in questo nuovo libro procede per indugi e divagazioni: l’amore, sembra raccontare la forma di questo saggio che saggio non è, si può solo provare a dire, nominare qualcosa della sua lingua, affacciarsi, lasciare che “appaia”, che qualcosa si dia a vedere nel tentativo sempre fallito di un’ultima parola, di una verità. Dire dell’amore è sostare nello stesso scacco cui l’esperienza dell’amore ci consegna: una pienezza e il suo vuoto; una necessità e un impossibile; un dappertutto e un sempre altrove.
Partirei da questo ampio intermezzo che dedichi al Simposio e che separa le due sezioni da cui sono composte queste tue carte: figure e paesaggio. Partirei da qui perché l’apertura del Simposio mette in forma il problema che attraversa il tuo libro così come ogni tentativo di portare una parola sull’amore: c’è, all’inizio, il racconto di un racconto, Apollodoro racconta a Glaucone quel che Aristodemo ha riferito circa un lontano convito di Socrate con alcuni suoi amici e discepoli. Non solo: quando è il turno di Socrate, quando il filosofo deve portare la propria parola, anche lui racconta, riporta la parola di un’altra, una donna sapiente e divinatrice, Diotima.
Di fatto la domanda come dire l’amore è all’origine di questo libro. È una domanda che viene da lontano. Nel Simposio questa domanda è messa in scena, come ricordavi, in una forma particolare: racconto di un racconto. E non solo: dentro questo racconto c’è anche la posizione di Socrate, che questa volta non fa esplicitamente il maestro, non usa la maieutica per condurre i discepoli verso il riconoscimento della verità, ma semplicemente riporta sull’amore la parola di una donna. Una parola che ha a che fare con il confine del dire: Diotima è divinatrice, è sapiente, è maga, non ha un ruolo definito. La sua parola sull’amore viene dunque da un luogo autorevole ma senza autorità. Dire dell’amore è avere a che fare con l’indicibile, con il sacro, con il limite della parola stessa. Il femminile circola comunque in tutto il Simposio: è la presenza di una donna che è assente, e sulla cui parola si modula la parola di Socrate. Dire dell’amore è dire di qualcosa di cui non possiamo cogliere mai il confine, è mettere in scena il limite della parola stessa, cioè l’assenza del significato pieno e compiuto. L’amore, in effetti, è, tra i sentimenti, quello che più ha a che fare con la mancanza.
Questo tema della non autorità, del femminile, mi porta all’attraversamento che fai proprio a conclusione dell’Intermezzo dedicato al Simposio. Margine leopardiano, scrivi. Leopardi è occasione di interrogare il fantasma Amore in lotta con il fantasma Verità: Amore, scrivi, vuole affermare il diritto all’illusione e al sogno, “ma questo diritto è insediato dal mostrarsi del ‘vero’”. Se Platone, con il Simposio, ci invita ad allargare il discorso intorno ad Eros, ti chiedo se possiamo intendere questa “non autorità” come la possibilità di un dire non assertivo, un dire che ci invita a uno scarto rispetto all’autorità, alla verità, un dire che suggerisce - penso anche in rapporto al tempo storico che stiamo vivendo - una postura non autoritaria. Non il potere ma l’ospitalità, per riprendere temi a te cari.
Certo, ho messo al margine della lettura del Simposio un altro elogio di Eros, quello che è nella prima delle leopardiane Operette morali: Amore inviato tra gli uomini prima come fantasma poi come dio, con il compito di ridare agli animi che sceglie di abitare “l’infinita speranza e le belle e care immaginazioni degli anni teneri”. Contro la cruda cancellazione del sogno messa in opera dalla Verità, il dio Amore, eternamente fanciullo, richiama quell’assenza di confini, quell’oltrelimite, che era proprio della fanciullezza.
Quanto al “dire non assertivo” che richiami, certo, esso nasce dal fatto che l’amore è esperienza del “tu”, della prossimità. La parola dell’amore trova la sua autenticazione quando pronuncia il “tu”: l’amore è parola che si invera nel “tu”. Non solo il “tu” del dialogo, dell’incontro, ma il “tu” come principio stesso della condizione amorosa, principio che muove il desiderio e lo muove anche nell’assenza dell’altro. L’ospitalità è una figura precipua di questo tu che, accolto, diventa sorgente del riconoscimento di sé. “L’io è il miracolo del tu”, dice un passaggio di Jabès.
Questo “tu”, oltretutto, è figura corporea, fisica, di quell’altro che è il principio della relazione tra gli uomini. Figura, dunque, di un mondo in cui il singolare si mette in rapporto con il molteplice, e l’altro è fondamento per poter riconoscere il vivente, per riconoscersi vivente tra viventi. Il verso che chiude la Commedia, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, ci dice che l’amore non è solo principio della visibilità e presenza dell’altro ma principio che trascorre in tutto l’universo. Per questo movimento che porta l’amore oltre il recinto del soggetto ho dato rilievo nel libro anche al rapporto tra eros e agape. Sia nella linea verticale del rapporto tra l’amore e la mistica (la “noche oscura” di Giovanni della Croce) sia nella linea orizzontale della creaturalità, del rapporto con ogni vivente.
Torniamo dunque a Diotima, al suo rapporto con il sacro. Non accade mai, e per fortuna, quell’incontro di due metà che porta alla completezza, come voleva il mito raccontato da Aristofane; l’altro contiene un segreto, una distanza, anche solo per il fatto di esser sempre necessariamente e inevitabilmente altro da noi. E tuttavia mi pare che sia proprio in questo scacco l’occasione di questo “sacro”, di questo passaggio dal “tu” alla comunità dei viventi. Dunque mi domando, e ti domando, il ruolo dell’immaginazione in questo movimento.
Questa è l’esperienza della letteratura: la narrazione dell’amore, la poesia d’amore, hanno dispiegato meravigliosamente quello che dicevi: una rappresentazione in cui l’immaginazione dell’altro segue tutte le vie della presenza-assenza. Il soggetto innamorato partecipa con la sua sensibilità immaginativa costruendo dei mondi. Pensiamo alla Recherche di Proust: il rapporto di Marcel e Albertine è rapporto raccontato come reale ma al tempo stesso immaginativo, ed è quando Albertine non c’è che il sentimento dell’amore mostra la sua potenza. La letteratura rappresenta dell’amore il tempo e lo spazio in cui il soggetto fa esperienza di una vita interiore, che è tumultuosa, animatissima, interrogativa. È l’universo fantasmatico e sensitivo del desiderio, l’esperienza del suo rapporto con il vuoto, con lo scacco, con la mancanza che lo fonda e agita. La scrittura dell’amore rappresenta con situazioni e personaggi questo grande teatro. L’amore, inoltre, contiene ed evoca le figurazioni di molti altri sentimenti. Per questo è insieme la più universale e la più comune delle passioni.
Tu scrivi a un certo punto che è un rapporto con l’enigma delle cose, con l’interrogare: dialogare con il silenzio dell’altro, con la sua presenza interiore. In questo senso contiene un principio conoscitivo.
Come la propria interiorità, anche l’altro è insondabile: da qui lo stato costante di interrogazione, e dunque di conoscenza. Di una forma particolare della conoscenza, quella che conserva il senso del limite. Una conoscenza che non ha modi prestabiliti. Pensiamo al bellissimo racconto di Musil, Il compimento dell’amore. Dove proprio nell’assoluta lontananza dall’amore si dà conoscenza dell’amore. Del resto Musil in L’uomo senza qualità avrebbe poi mostrato, nella figurazione del rapporto tra fratello e sorella, tra Ulrich e Agathe, quanto insondabile e confinante con l’oltre e con un’inattingibile condizione paradisiaca possa essere la tensione amorosa.
Forse possiamo rintracciare qui la valenza politica dell’amore: quest’elemento di non compimento che è assolutamente estraneo a quello di cui facciamo esperienza, a quello cui tutto sembra invitarci.
Sì, il grande racconto d’amore mostra spesso dell’amore il suo svanire, il suo mancare all’approdo, il suo perdersi. Da Madame Bovary a Anna Karenina le creature romanzesche d’amore fanno esperienza di un vuoto che si spalanca e le consuma, e di una società, con le sue istituzioni dell’amore, che corrode e oltraggia il loro desiderio. Fino a farlo naufragare. Ma il romanzesco dà uno svolgimento drammaturgico e qualche volta tragico a quel che tuttavia è proprio dell’amore: la sua distanza da ogni forma di definizione, di compimento, di realizzazione. L’amore, come il desiderio che è la sua anima, e il suo ritmo, e la sua lingua, vive nell’al di qua del possibile, e del compiuto.
Forse è anche per questo che il solo tu che invera l’amore è il tu dell’interiorità, è l’altro del soggetto, l’altro dell’io.
Sì, in effetti, solo curando l’interiorità, lo spazio interiore, riusciamo a staccarci sia da un io affermativo, egotico, sia da un tu pensato come acquisito una volta per tutte, non più da scoprire e interrogare e conoscere. La narrazione e la poesia ci parlano di un amore che è ricerca, attesa, turbamento, raffigurazione dell’assenza, parvenza. E tutto questo sentire ha al centro il corpo, i suoi sensi.
Questa attenzione all’interiorità parla il linguaggio della tenerezza, e mi pare che la tenerezza attraversi tante di queste stanze, che la cura sia un filo che percorre queste carte. Ci sono alcune pagine in cui scrivi di una stagione della tua vita in cui si è interrogato il rapporto tra eros e philia: “dare un corpo all’amicizia: esperienza, certo, dei confini, facile a disperdersi o a ripiegare nella consuetudine delle distinzioni, che allontanano l’amicizia dall’amore. Ma anche esperienza che allude a quell’immagine utopica di una comunità d’amore in grado di liberare la dualità dell’io e del tu dalla sua separata dimora”. Queste carte mi sembrano attraversate da quello stesso tentativo della tua generazione: un desiderio di intersecare delle immagini dell’amore che si insiste a pensare separate, metterle in rapporto tra loro, farle circolare. Forse quella stagione che racconti in alcuni passaggi dice qualcosa di questo tentativo di non dividere il bene dal male, il tradimento dalla fedeltà, il due dai molti.
Sì, in questo libro, in qualche modo confluiscono due storie: da una parte, la mia personale esperienza didattica, che a più riprese, in corsi e seminari, ha indugiato sulla “lingua dell’amore”, sulle sue figure (la lectio pubblica di congedo dall’Università, e lo stesso ultimo corso, era Poesia d’amore e cosmologia); dall’altra, alcune esperienze della mia generazione, ma anche di una generazione successiva, che tra la fine degli anni Sessanta e tutti gli anni Settanta hanno tentato di smuovere i confini definiti delle istituzioni e dei rapporti tra soggetti, con una tensione certamente utopica, e con annaspamenti ed errori, ma con uno slancio che nell’agire e nel dire immaginava possibile un’altra cultura, un altro ordine di rapporti. Anche le forme di sapere, in quegli anni, interrogavano questi confini, cercavano nuovi statuti e nuovi linguaggi.
Forse è un po’ all’ombra di quel lontano cercare ed esperire che in questo libro sull’amore mi son trovato a dare rilievo sia al “dialogo” tra amicizia e amore sia a un sentire come quello della tenerezza, che è lingua mite della passione, sentimento che unisce desiderio e dolcezza, intimità e cura. E ha la sua forma visibile nella delicatezza. È vero quel che dici: la tenerezza è un po’ la tessitura nascosta di tutto il libro.
- CONTINUAZIONE FINE NEL POST SUCCESSIVO
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? --- "Carte d’Amore". Dialogo sull’amore con Antonio Prete (di Anna Stefi - "Doppiozero).3 maggio 2022, di Federico La Sala
- ... FINE
CARTE D’AMORE /
Dialogo sull’amore con Antonio Prete
di Anna Stefi (Doppiozero, 02 maggio 2022)
- [...]
La tenerezza, così mi sembra, è capace di muovere verso l’altro e, al tempo stesso, di custodirne la differenza.
Nella tenerezza la presenza dell’altro richiede una prossimità particolare, dolce, non appropriativa. La tenerezza è anche lentezza: la leopardiana “lenta ginestra” è anche immagine della tenerezza. “Tenero” è il ramo che si piega per dare ombra. Il piegarsi è entrare in dialogo con il vento, curvarsi alla presenza dell’altro attraverso una forma di amore che implica cura, attenzione, protezione. La tenerezza è parola opposta alla parola guerra, richiama la dolcezza. La tradizione poetica occidentale, quella che riconosciamo come la nostra tradizione poetica che muove dai provenzali e dagli stilnovisti, dà un grande rilievo a questa “dolcezza”: il Dolce Stil Novo apre la nostra poesia. La dolcezza attraversa tutta la poesia fino al leopardiano “naufragar m’è dolce”: la lingua della poesia permette di sopravvivere al naufragio del pensiero che non può dire l’infinito, è la lingua della poesia che porta la percezione di un sentire dolce.
Tenerezza e amicizia, dunque, come lingue intime dell’amore. Quanto all’amicizia, forse la sua forza è proprio nel fatto che non domanda il compimento: per questo, credo, mi piace parlare di “legami amorosi”, mi pare che sia un modo di scartare da quella spinta al compimento che l’amore tende sempre ad avere.
Sì, l’amicizia resta al di qua della domanda di istituzione, è aperta, fluida, esperienza di una fraternità prossima e visibile, figura di una, forse solo sognata, fraternità universale (Montaigne su questa amicizia come fraternità ha pagine bellissime). L’amicizia interroga l’amore, entrando nella sua lingua, animando il suo sentire. Togliendo all’amore il fantasma, appunto, del compimento, e dell’unità del due.
O forse possiamo giocare sul fatto che Carte d’amore contiene lo scarto - écart - e dunque prendere sul serio questa assonanza: la potenza dell’amore - se lo liberiamo da quella prospettiva aristofanea - è generare scarti.
Carte, scarto. Non ci avevo pensato a questa possibile rifrazione del titolo Carte d’amore. Dici: generare scarti. Certo, esperienza del resto, di quel che è sottratto alla pienezza dell’ideale d’amore, anche dell’immaginario d’amore. Scarto anche dal sapere: non c’è un sapere dell’amore, semmai, come mostrava Diotima, una sapienza dell’amore. Per questo il silenzio è la vera anima della lingua d’amore.
Non a caso il silenzio attraversa questo libro. Racconti un episodio molto bello: tu e Mario Luzi alla Galleria Borghese in silenzio davanti a Amor sacro e amor profano di Tiziano.
Visitavamo insieme, un giorno di molti anni fa, la riaperta Galleria Borghese. Con Luzi accadeva che dialogassimo per le strade di Firenze, di Pienza o di Siena, o attraversando in auto i poggi e le piane delle Crete. Quel giorno eravamo dinanzi alle meravigliose opere di Raffaello, di Caravaggio, di Bernini, di Canova... Un’occasione bellissima, per me, poter ascoltare le osservazioni di un poeta, che molto ammiravo, dinanzi alle opere d’arte. Se in ogni sosta dinanzi a un’opera c’era qualche frase, qualche breve considerazione sulla luce, sulle forme, sui particolari, dinanzi a Tiziano, all’amore rappresentato da Tiziano, sopravvenne un silenzio lungo, forte, un silenzio contemplativo. Un silenzio che mostrava la vuota ridondanza di ogni interpretazione, e del linguaggio stesso. Ogni parola sarebbe stata ordinaria, avrebbe come incrinato la bellezza misteriosa dell’opera. Solo uno sguardo silenzioso può corrispondere alla bellezza? L’amore ha a che fare con il silenzio, come con la tenerezza. Ovvero con quel che è al di qua della lingua e in certo senso oltre la lingua.
Nella seconda parte del libro dici del paesaggio d’amore: nelle tue carte i paesaggi parlano, si fanno presenza. L’amore, scrivi, convoca il visibile.
Il paesaggio non è cornice dell’amore, è parte della sua lingua, del suo accadere. Per questo la narrazione e la poesia d’amore contribuiscono a scrivere una storia per dir così intima del paesaggio. Diciamo paesaggio, usando una parola che ci viene dalla pittura del Cinquecento. Il paesaggio insieme contiene l’amore ed è intimo al suo sentire. Pensiamo, tra tanti, al paesaggio dell’amore nei versi di Baudelaire. Gli occhi sono essi stessi cieli, con lampi e tempeste e tramonti e aurore. Allo stesso tempo nella raffigurazione dell’amore si cerca un paesaggio che sia intimo all’amore stesso.
In questo senso - ancora a dire il “sacro” di cui prima parlavamo - il paesaggio forse diviene anche il luogo verso cui andiamo, l’orizzonte entro cui, grazie all’amore, ci proiettiamo.
C’è anche questo, nel paesaggio, la presenza di un’alterità: riconoscere il tu e insieme un’alterità che supera il tu, e cioè la Natura osservata nella sua prossimità a noi. Il visibile, il naturale, ci permette di cogliere la dimensione di alterità inscritta nell’amore stesso. Il paesaggio è poi, nella tradizione letteraria, messo in correlazione fortemente dialogica con il sentire: i sentimenti sono in sintonia con il paesaggio. Ho citato nel libro un racconto di Poe, Eleonora: tutto il sentire della coppia di giovanissimi innamorati è in rapporto profondo con il paesaggio, con il suo mostrarsi e il suo mutare, come se la percezione d’amore dovesse evocare quello che dicevi prima, la necessità di una relazione ulteriore.
Il paesaggio è - oltre il giardino, oltre la selva e la stanza - anche la strada, il treno.
Sì, pensiamo, tra tante situazioni, alla passante di Baudelaire: la strada “assourdissante” è l’avvio ma è anche una presenza che genera lo stacco della figura, il prender campo del suo sguardo, il lampo - l’éclair degli occhi - l’incontro che non avviene ma che è più forte di un incontro realmente accaduto.
Tornerei a dove siamo partiti: il Simposio è anche l’irrompere di Alcibiade sulla scena. Alcibiade che rompe le regole: eccesso, gelosia, corpo, comportamento sconveniente. L’amore è anche un al di là della parola e vorrei che dicessi qualcosa di questo a partire da quel corpo tutto particolare che sono le lacrime.
L’amore nell’immaginario - più che nell’immaginazione - è legato a serenità, gioia, ha a che fare con il piacere. Il racconto d’amore dà invece moltissimo spazio al pianto. Il pianto è la lingua che non può essere più parola o non è ancora parola. Il pianto è un modo corporeo dell’indicibile. C’è un pianto d’amore che è gioia d’amore, riconoscimento, scoperta: è il pianto che descrive Goethe nel Werther, l’abbraccio tra Werther e Carlotta dopo la lettura di Ossian. C’è poi il pianto come mancanza, come attesa. Tutti i sentimenti possono essere detti nel pianto, il pianto raccoglie il sentire in una lingua corporea. Il pianto è anche esperienza dell’impossibilità dell’amore. E c’è anche una strategia del pianto che appartiene alle tecniche della seduzione: non mancano esempi nei Trattati d’amore del Cinquecento, nella tradizione romanzesca libertina.
Quanto a quel che dici su Alcibiade, certo, l’amore si mostra come desiderio che dà al corpo, ai sensi, una forte centralità, ma il discorso socratico sull’amore indica come tutto questo è privo di bellezza e verità se non si misura con quel che è oltre il corpo.
C’è un pudore, una sorta di vergogna, nel dire dell’amore: è solo timore del patetico, di sconfinare nel campo del “banale”? Mi domando quanto questo abbia a che fare con la natura dell’oggetto e quanto invece con quel che dell’amore ne è stato fatto.
Sì, è vero, da una parte è la natura stessa dell’amore, la sua assenza di confini, la sua indicibilità, il suo stesso non sapere, a motivare questo pudore, dall’altra è il timore di implicare la parte più profonda e ignota di sé - “mon coeur mis à nu”, di Poe e Baudelaire! - a trattenere sulla soglia. Ma anche, come dici, quel che dell’amore è pronunciato e vulgato e anche perpetrato: il malinteso, e l’oltraggiato, e l’offeso dell’amore. Siamo ancora nella domanda da cui è nato il libro: Come dire l’amore?
- ... FINE
-
> PSICOANALISI CATTOLICESIMO. L’AMORE UNIVERSALE E UN’APPROPRIAZIONE INDEBITA: LA MEMORIA DI MOSÈ E IL CAMMINO DI SIGMUND FREUD15 novembre 2021, di Federico La Sala
L’AMORE UNIVERSALE E UN’APPROPRIAZIONE INDEBITA: LA MEMORIA DI MOSÈ E IL CAMMINO DI SIGMUND FREUD
PSICOANALISI CATTOLICESIMO E "DISAGIO NELLA CIVILTÀ" ("Das Unbehagen in der Kultur"). Un’appropriazione indebita dell’amore universale e "L’infelicità nella civiltà" ("Das Ungluck in der Kultur"):
"[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità critiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]".
“[...] mi manca il coraggio di erigermi a profeta di fronte ai miei simili e accetto il rimprovero di non saper portare loro nessuna consolazione, perché in fondo questo è ciò che tutti chiedono, i più fieri rivoluzionari non meno appassionatamente dei più virtuosi credenti. Il problema fondamentale del destino della specie umana a me sembra sia questo: se, e fino a che punto, l’evoluzione civile riuscirà a padroneggiare i turbamenti della vita collettiva provocati dalla pulsione aggressiva e auto distruttrice degli uomini. In questo aspetto proprio il tempo presentemerita forse particolare interesse. Gli uomini adesso hanno esteso talmente il proprio potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda fino all’ultimo uomo. Lo sanno, donde buona parte della loro presente inquietudine, infelicità, apprensione. E ora c’è da aspettarsi che l’altra delle due potenze celesti, l’Eros eterno farà uno sforzo per affermarsi nella lotta contro il suo avversario parimenti immortale. Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà l’esito?”(#SigmundFreud, "Il disagio della civiltà", 1929).
Per "orientarsi nel pensiero" (Kant), rileggere le note di Franca Ongaro Basaglia su "Così parlò Edipo a Cuernavaca" ("PM-Panorama Mese", novembre 1982) e ricordare il legame della "Interpretazione dei Sogni" (1900) con l’Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della Divina Commedia (Pg. II, 46-48) di Dante Alighieri.
Federico La Sala
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- Il cammino di Dante nell’amore. La “Commedia” è anche viaggio nel sentimento (di A. Zaccuri)..2 ottobre 2021, di Federico La Sala
Riletture.
Il cammino di Dante nell’amore
Non solo Paolo e Francesca: dalla passione fisica alla sublimazione mistica, la “Commedia” è anche viaggio nel sentimento.
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, venerdì 1 ottobre 2021)
- [Foto] Amos Cassioli, "Il bacio fra Paolo e Francesca"
L’etimologia è una scienza capricciosa: quanto più è inesatta, tanto più pretende di essere illuminante. Tecnicamente si chiamano “paretimologie”, corrispondenze superficiali dalle quali si prova a distillare il significato più autentico delle parole. Una delle più suggestive è suggerita da Andrea Cappellano nel De amore. Il sostantivo amor deriva dal verbo amo, ovviamente, ma a sua volta amo rimanda all’hamus, l’amo o gancio dal quale gli amanti fatalmente vengono catturati. Composto sul finire del XII secolo, il De amore è uno dei principali riferimenti per la dottrina dell’amor cortese e successivamente dello Stilnovo.
L’immagine dell’amo si presta bene, in particolare, a descrivere la concezione che Guido Cavalcanti affida alla canzone Donna me prega, dove amore è descritto come «accidente - che sovente - è fero». Conseguenza e non causa né tantomeno sostanza, per Cavalcanti l’amore è questione di azione e reazione fisica, di “spiritelli” che attraverso gli occhi si impossessano della volontà dell’amante, sottomettendolo all’amata. Sicut piscator astutus, commenterebbe Andrea Cappellano: come un pescatore che sa il fatto suo.
Se la definizione del De amore è celebre, ancor più famosa è la versione che ne fornisce Dante nel canto V dell’Inferno. Si tratta del citatissimo «Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende» con il quale Francesca si riferisce alla passione per il cognato Paolo. Uno dei testi della letteratura italiana più frequentati e commentati di sempre, avverte Maria Antonietta Terzoli in premessa alla sua bella lettura del canto V compresa in Voci sull’Inferno di Dante (Carocci, tre volumi di complessive pagine 1.064, euro 135,00), eppure ancora esposto a equivoci. Il più frequente consiste nel pregiudizio per cui, dando la parola a Francesca (ma forse anche a Paolo, secondo un’ipotesi che Terzoli prudentemente sostiene), Dante la elevi a eroina dell’amor fou, irriducibile a ogni convenienza sociale e a ogni scrupolo religioso.
Ma se così fosse, perché condannare Francesca alle pene infernali? Perché non riservarle una sorte più benigna, come quella che in Paradiso toccherà alla non meno sensuale Cunizza da Romano? È un problema che non si risolve limitandosi all’analisi del canto V, né isolando l’episodio di Paolo e Francesca all’interno del canto medesimo.
L’esigenza di una interpretazione organica della prima cantica è fortemente sostenuta anche dai diversi studiosi radunati in Voci sull’Inferno di Dante. Curata da Zygmunt G. Baranski e dalla stessa Terzoli, la pubblicazione fa seguito all’omonimo progetto realizzato a Basilea tra il 2019 e il 2021, in gran parte trasmesso via Zoom a causa della pandemia. Oltre all’autorevolezza dei singoli contributi, va registrata l’utilità dei saggi introduttivi, incentrati sull’importanza dell’elemento “popolare” nella Commedia (Lino Pertile), sulla cronologia compositiva (Paolo Pellegrini) e sulla tradizione manoscritta dell’Inferno (Michelangelo Zaccarello).
Il cofanetto arriva in libreria contemporaneamente all’atteso commento dei primi diciassette canti dell’Inferno allestito da Enrico Malato per la Necod, la “Nuova edizione commentata delle opere di Dante” in corso di pubblicazione presso Salerno (pagine XL+762, euro 55,00). Parliamo di un’impresa che, avviata ufficialmente nel 2010, in poco più di un decennio ha reso disponibile quasi tutto il corpus dantesco (manca ancora il Convivio) e che adesso, con la progressiva uscita del commento alla Divina Commedia, arriva veramente a compimento.
L’intera operazione porta l’impronta di Malato, professore emerito di Letteratura italiana alla Federico II di Napoli e convinto sostenitore della necessità di un’interpretazione ampia, documentata e innovativa. Il volume attuale contiene solo la metà dell’Inferno, è vero, ma offre già un nutrito apparato di risorse utili alla conoscenza del poema, tra cui un’introduzione generale alla Commedia. Fra i canti di cui viene offerto il commento - stratificato su dif- ferenti livelli di approfondimento - sono presenti alcuni dei capisaldi sui quali poggia la proposta interpretativa di Malato.
Facendo perno su Inferno X, nella fattispecie, il critico invita a inserire il viaggio di Dante (intrapreso, secondo Malato, nella notte tra il 7 e l’8 aprile 1300, data corrispondente al Venerdì Santo di quell’anno) nel contesto del dissidio ormai irreversibile con il già ricordato Cavalcanti. Sostenitore della natura “accidentale” dell’amore quest’ultimo, mentre Dante è guidato dal desiderio di perseguire l’unione spirituale con Beatrice, che nel passaggio verso l’Empireo si farà agente di una teologia trasfigurata in mistica. Anche il canto V dell’Inferno partecipa di questa concezione.
Secondo Malato, infatti, quello dedicato a Francesca non è cammeo elogiativo, ma al contrario un exemplum, ossia uno dei racconti esemplari, di esplicito ammonimento morale, così frequenti nella predicazione del Medioevo. Su un impianto per molti versi analogo, ma sviluppato con larga autonomia argomentativa, poggia il densissimo Amore e colpa di Donato Pirovano (Donzelli, pagine 164, euro 18,00), nel quale l’incontro del poeta con Francesca viene collocato al termine di una peregrinazione che dalla Vita nuova si snoda attraverso le Rime, in particolare le cosiddette “petrose” e quelle in cui è evocata la seducente “montanina”. In entrambi i casi, osserva Pirovano, è la tentazione dell’amore carnale a farsi avanti, tanto da far sospettare che proprio questa sia la “selva oscura” nella quale Dante si dibatte prima che Beatrice gli venga in soccorso.
Ordinario di Filologia e critica dantesca all’Università di Torino, Pirovano rivela uno sguardo acutissimo nell’individuare corrispondenze e riprese che, come sempre nella Commedia, hanno carattere intenzionale e rivelatore. Decisiva, fra tutte, la successione di rime “spense / offense / pense” con la quale Francesca allude alla propria uccisione e che tornerà, minimamente variata, sulle labbra di Beatrice nel canto XXXI del Purgatorio, in un brano nel quale Dante è chiamato a discolparsi per la propria incostanza. Ancora più in là si spinge Terzoli, registrando un analogo riecheggiamento tra il V dell’Inferno e l’VIII del Paradiso. Protagonista questa volta è Didone, emblema della schiera dei lussuriosi nella quale Francesca vortica misteriosamente stretta a Paolo. Povera regina, anche Didone, povera amante presa all’amo dall’amato.
Il linguista Francesco Bruni: «Necod, lezione di metodo»
Tre centenari in fila: Leonardo nel 2019, Raffaello nel 2020, Dante nel 2021. «Un trittico formidabile», commenta il linguista Francesco Bruni. «Nelle intenzioni - prosegue - avrebbe dovuto rilanciare l’immagine dell’Italia a livello internazionale. Certo, la pandemia non ha aiutato, però...». Però c’è il “cantiere Dante”, tornato in grande fermento già prima che scoccasse la ricorrenza del settimo centenario della morte del poeta.
 «Le celebrazioni del 1965, relative alla nascita di Dante, furono caratterizzate dall’edizione critica della Divina Commedia approntata da Giorgio Petrocchi - ricorda Bruni -. Oggi le iniziative sono molteplici. Da un lato, abbiamo il gruppo di lavoro coordinato da Paolo Trovato presso l’Università di Ferrara e impegnato nella valorizzazione dei manoscritti del poema riconducibili all’Italia settentrionale, dove Dante trascorse gli ultimi anni della sua esistenza. D’altro canto, è ormai imminente la pubblicazione della nuova edizione critica curata da Giorgio Inglese. Ma a mio avviso, almeno nell’immediato, le acquisizioni più rilevanti provengono dal versante dei commenti».
«Le celebrazioni del 1965, relative alla nascita di Dante, furono caratterizzate dall’edizione critica della Divina Commedia approntata da Giorgio Petrocchi - ricorda Bruni -. Oggi le iniziative sono molteplici. Da un lato, abbiamo il gruppo di lavoro coordinato da Paolo Trovato presso l’Università di Ferrara e impegnato nella valorizzazione dei manoscritti del poema riconducibili all’Italia settentrionale, dove Dante trascorse gli ultimi anni della sua esistenza. D’altro canto, è ormai imminente la pubblicazione della nuova edizione critica curata da Giorgio Inglese. Ma a mio avviso, almeno nell’immediato, le acquisizioni più rilevanti provengono dal versante dei commenti».
 Bruni si riferisce in particolare alla Necod, la “Nuova edizione commentata delle opere di Dante” diretta da Enrico Malato per Salerno. «Ho qui sotto mano il primo volume dell’Inferno - dice - e, per quanto si tratti ancora di una “edizione esemplare”, come viene definita, mi sembra ricchissima di spunti, che richiederanno tempo per essere apprezzati nella loro portata. Una volta metabolizzati, potrebbero contribuire notevolmente a migliorare l’insegnamento scolastico della Commedia.
Bruni si riferisce in particolare alla Necod, la “Nuova edizione commentata delle opere di Dante” diretta da Enrico Malato per Salerno. «Ho qui sotto mano il primo volume dell’Inferno - dice - e, per quanto si tratti ancora di una “edizione esemplare”, come viene definita, mi sembra ricchissima di spunti, che richiederanno tempo per essere apprezzati nella loro portata. Una volta metabolizzati, potrebbero contribuire notevolmente a migliorare l’insegnamento scolastico della Commedia.La Necod, del resto, ha una genesi singolare. Trae origine dal progetto dell’Edizione nazionale dei Commenti danteschi che, avviata una quarantina di anni fa, si è rivelata straordinariamente fertile di prospettive. È in questo contesto che, attorno al Centro Pio Rajna di Roma, si è radunata la comunità di studiosi alla quale si devono i commenti alle varie opere del corpus dantesco già apparse nella Necod. Ora, con questo primo passo nell’interpretazione della Commedia, il lettore si trova davanti a qualcosa di davvero imponente».
A colpire, insiste Bruni, è un elemento che potrebbe apparire marginale. «La perifrasi dei singoli canti proposta da Malato - dice - si presenta, in tutta umiltà, come strumento di servizio, ma è l’esito di un percorso niente affatto banale. Perché riesce nell’intento di adottare un linguaggio che, comprensibile nella sua modernità, non tradisca la parola di Dante. E poi perché porta alla luce una serie di rispondenze interne che passerebbero altrimenti inosservate. Questo avviene in modo sistematico, fino a costituirsi come vero e proprio metodo di lettura».
Per spiegarsi meglio, Bruni ricorre a una battuta molto in voga tra i filologi: «Nel 1920, nell’introduzione al suo Orazio lirico, Giorgio Pasquali sosteneva che in quel libro si sarebbero potuti trovare anche gli ombrelli smarriti. Era una maniera per alludere a una vastità di documentazione che contraddistingue anche il commento di Malato alla Commedia. Solo che qui, potremmo aggiungere, gli ombrelli vengono passati scrupolosamente in rassegna, così da rendere visibili i rapporti di uno con l’altro».
Fuor di metafora, è la trama più intima del poema che viene riportata in superficie. «C’è un centro di gravità ben riconoscibile, che per Malato corrisponde alla contrapposizione tra la concezione passionale dell’amore sostenuta da Cavalcanti (che nella Commedia è il grande assente) e quella spirituale e teologica di cui si fa promotore Dante - sintetizza Bruni -. Muovendo da questa ipotesi, si sviluppa una rete di riecheggiamenti tra un canto e l’altro, e tra una cantica e l’altra, che va radicalmente al di là della consuetudine della lectura Dantis. Non è più l’episodio in sé ad attirare l’attenzione, ma la sua rispondenza al disegno unitario dell’opera. È un metodo, lo ripeto, che ciascuno può fare proprio, con guadagni sempre sorprendenti».
Alessandro Zaccuri
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.) --- La "Vita Nuova", Guido Cavalcanti, e la "Commedia": in cammino con Dante, nel "paradiso" terrestre e celeste.19 luglio 2021, di Federico La Sala
Dante e Guido, chiave per la Commedia
A colloquio con Enrico Malato sul saggio dedicato al Canto X dell’Inferno: «Svela i motivi per cui vari passaggi del poema fanno riferimento a Cavalcanti, amico ma non troppo».
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 17 giugno 2020)
- [Foto] Il monumento a Dante in Piazza dei Signori a Verona - Ansa/Filippo Venezia
La prima ’anticipazione per estratto’, dedicata al canto I dell’Inferno, risale al 2007. Alla vigilia del settimo centenario della morte di Dante (1265-1321), Enrico Malato si sofferma ora su un altro canto dell’Inferno, il X. L’orizzonte complessivo è sempre quello della Necod, la ’Nuova edizione commentata delle opere di Dante’ che lo stesso Malato - professore emerito di Letteratura italiana alla Federico II di Napoli e presidente del Centro Pio Rajna - ha avviato nel 2012 presso la casa editrice Salerno. Otto i tomi già pubblicati, al quale se ne aggiungerà un nono in autunno. A coronare il progetto sarà poi la Commedia, di cui si annuncia un’edizione basata sullo storico testo stabilito da Giorgio Petrocchi, ma riveduto in centinaia di luoghi, con introduzioni di varianti e rettifiche di punteggiatura, accompagnato da un commento di forte originalità metodologica. Sono i criteri già seguiti, sia pure in modo sintetico, nella Divina Commedia ’tascabile’ curata nel 2018 da Malato per i ’Diamanti’.
 Adesso è la volta del saggio dedicato a Il canto X dell’Inferno (Salerno, pagine 56, euro 12), al quale Malato riconosce una funzione cruciale. Ma è la complessità del rapporto tra i vivi e i morti a colpire, una volta di più, il lettore di Dante. «Una sentenza di Cicerone asserisce che la vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi; ma anche i vivi si nutrono del ricordo dei morti - afferma Malato -. In questa dialettica si trovano le ragioni profonde della fortuna della Divina Commedia. Che naturalmente trova altre motivazioni, nell’opera in sé, nel fascino della sua poesia, nei modi suggestivi della scrittura, nell’imponenza della costruzione.
Adesso è la volta del saggio dedicato a Il canto X dell’Inferno (Salerno, pagine 56, euro 12), al quale Malato riconosce una funzione cruciale. Ma è la complessità del rapporto tra i vivi e i morti a colpire, una volta di più, il lettore di Dante. «Una sentenza di Cicerone asserisce che la vita dei morti è riposta nel ricordo dei vivi; ma anche i vivi si nutrono del ricordo dei morti - afferma Malato -. In questa dialettica si trovano le ragioni profonde della fortuna della Divina Commedia. Che naturalmente trova altre motivazioni, nell’opera in sé, nel fascino della sua poesia, nei modi suggestivi della scrittura, nell’imponenza della costruzione.Perché questo canto è così importante?
È uno snodo fondamentale, un architrave dell’intero poema. Nel canto X dell’Inferno Dante fa i conti con Guido Cavalcanti, il «primo amico» della giovinezza, dedicatario della Vita nuova, col quale è insorto in seguito un dissidio che ha portato forse a una frattura, certo a una contrapposizione che filtra fin nella Commedia. Tutto ciò è rimasto oscuro all’esegesi tradizionale. Che ancora nel ’900 avanzato discettava di quanto i due fossero amici per la pelle, Dante e Guido.
 In questo canto Guido è fatto comparire surrettiziamente sulla scena infernale, non di persona, perché ancora vivo al momento del viaggio, ma evocato dal padre Cavalcante, dannato, che sviene alla malintesa notizia della sua morte. Ciò che provoca il collasso è però il pensiero che Guido, se morto prima di aver maturato la consapevolezza del peccato ed essersene pentito, possa essere a sua volta dannato. Così Dante fa dichiarare al padre l’errore del figlio.
In questo canto Guido è fatto comparire surrettiziamente sulla scena infernale, non di persona, perché ancora vivo al momento del viaggio, ma evocato dal padre Cavalcante, dannato, che sviene alla malintesa notizia della sua morte. Ciò che provoca il collasso è però il pensiero che Guido, se morto prima di aver maturato la consapevolezza del peccato ed essersene pentito, possa essere a sua volta dannato. Così Dante fa dichiarare al padre l’errore del figlio.Ma il protagonista del canto non è Farinata degli Uberti?
Sì, tradizionalmente è ’il canto di Farinata’: e in quanto tale, dall’esaltazione del condottiero che salvò Firenze dalla distruzione decretata dai nemici vincitori, ha tratto il simbolo dell’amor di patria e della passione politica. Che Dante e Farinata ebbero comune e assai viva, benché apparentemente contrapposta (uno guelfo, l’altro ghibellino), ma in realtà meno distanti di quanto potesse apparire. Il nuovo commento mette in rilievo un aspetto non adeguatamente approfondito nella lettura storica, che poi si rivela di straordinaria portata. Al ’gigante’ Farinata viene infatti affiancata una figura esibita come minore, Cavalcante, che in realtà è solo una controfigura del figlio Guido, punto focale del canto e per molti riflessi, dell’intera Commedia.
Che cosa divideva Dante e Guido?
Partiti da posizioni più o meno comuni, più o meno coerenti con i principii dell’amor cortese, pervengono a concezioni diverse e addirittura opposte: per Dante l’amore è una forza virtuosa, beatifica, che eleva a Dio e porta alla salvezza dell’anima; per Guido è, al contrario, forza tormentosa, impetuosa, ’mortifera’. La divergenza investe l’ideologia di sostegno del fedele su un principio fondamentale del credo cristiano, dominante nella coscienza del XIV secolo. E diventa scontro aperto. Alla teorizzazione di Dante, nella canzone Donne ch’avete intelletto d’amore, poi nucleo della Vita nuova, Guido oppone, in contestazione, la sofisticatissima Donna me prega per ch’eo voglio dire. Il dissidio esplode pubblicamente. Poi Guido muore. Ma Dante non rinuncia alla replica di puntuale confutazione, trasferita nella Commedia e diluita in tutto il poema.
La rispondenza tra i testi è fittissima.
La Commedia è una ’rete mirabile’ di echi, riprese, intrecci di testi antichi e contemporanei di ogni genere, di cui nel commento è data ampia documentazione. Ma qui conviene mettere l’accento sulla continuità degli echi in replica a Guido, anch’essi sparsi in forma più o meno accentuata in tutte le cantiche. Per dare appena un’idea, basti rilevare che nel canto V dell’Inferno c’è l’episodio, costruito con la forza dell’exemplum medievale, di Francesca e Paolo che, per aver creduto nei principii dell’amor cortese asseverati da Guido, si trovano dannati all’Inferno.
 Mentre nel Purgatorio, dopo che Virgilio avrà corretto la definizione di Francesca («Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende, Amor ch’a nullo amato amar perdona») in chiave cristiana («Amore acceso di virtù sempre altro accese»), verrà l’incontro con Stazio, che per aver conosciuto e praticato quei principii ebbe salva l’anima pur essendo pagano.
Mentre nel Purgatorio, dopo che Virgilio avrà corretto la definizione di Francesca («Amor ch’al cor gentil ratto s’apprende, Amor ch’a nullo amato amar perdona») in chiave cristiana («Amore acceso di virtù sempre altro accese»), verrà l’incontro con Stazio, che per aver conosciuto e praticato quei principii ebbe salva l’anima pur essendo pagano.I dannati possono vedere il futuro ma ignorano il presente: come mai?
Il concetto fondamentale è che la vita è un dono di Dio, concesso all’uomo perché lo impieghi al meglio, con la promessa della beatitudine dopo la morte. Chi non sa meritarla, anche dannato non perde la memoria e la nostalgia di quel bene perduto, con una sofferenza che si rinnova e si esalta osservando ciò che ancora avviene nella vita dei viventi, in quello che non senza precisa ragione è definito «il dolce mondo». Questa facoltà viene meno nel presente: il momento in cui può intervenire il pentimento, e con esso il recupero della grazia di Dio e la salvezza dalla dannazione, evento la cui visione non può essere concessa ai dannati. Perciò è preclusa a Cavalcante, lasciando volutamente oscuro il destino di Guido. Dante, come acutamente aveva intuito Contini, non esprime un giudizio di condanna, ma lascia abilmente aperta la possibilità che, senza un atto di pentimento, l’altro poeta sia infine dannato.
In cammino con Dante/18.
La cattedrale dell’arte vince l’oblìo
Il fascino perenne del Purgatorio è anche nel continuo trapassare la barriera della morte grazie all’immaginazione poetica che congiunge i tempi umani all’eterno
di Carlo Ossola (Avvenire, domenica 18 luglio 2021)
- Terzine eponime
- «O frate, issa vegg’io», diss’elli, «il nodo
- che ’l Notaro e Guittone e me ritenne
- di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!
- Io veggio ben come le vostre penne
- di retro al dittator sen vanno strette,
- che de le nostre certo non avvenne».
- Purgatorio XXIV, 55-60
Il Purgatorio è la cantica delle arti, a cominciare dal musico Casella (canto II) che intona la canzone del Convivio: «Amor che ne la mente mi ragiona», sino al poeta Bonagiunta che nuovamente rende omaggio a Dante poeta: «Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore / trasse le nove rime, cominciando / ’Donne ch’avete intelletto d’amore» (XXIV, 49-51), per compiersi nell’elogio di Guido Guinizzelli e di Arnaut Daniel al canto XXVI.
 A ben vedere - a parte Brunetto Latini, condannato tra i sodomiti - gli amici e sodali di Dante son tutti a purificarsi nel Purgatorio, quasi le arti fossero - come additava don Giuseppe De Luca - quell’«imbastitura in bianco» che ancora non è abito di salvezza ma già ne annuncia la forma: «per me i poeti sono i maestri, non delle verità da credere, ma delle verità con cui credere. Più di ogni altro artista, il poeta si getta vivente nel suo fuoco, e dentro vi arde senza lasciar traccia d’estraneo né scoria» (G. De Luca, La poesia, paradiso artificiale, 1955; poi in “Archivio italiano per la storia della pietà”, X, 1997).
A ben vedere - a parte Brunetto Latini, condannato tra i sodomiti - gli amici e sodali di Dante son tutti a purificarsi nel Purgatorio, quasi le arti fossero - come additava don Giuseppe De Luca - quell’«imbastitura in bianco» che ancora non è abito di salvezza ma già ne annuncia la forma: «per me i poeti sono i maestri, non delle verità da credere, ma delle verità con cui credere. Più di ogni altro artista, il poeta si getta vivente nel suo fuoco, e dentro vi arde senza lasciar traccia d’estraneo né scoria» (G. De Luca, La poesia, paradiso artificiale, 1955; poi in “Archivio italiano per la storia della pietà”, X, 1997).
 L’arte è quell’ordinata forma che il divino dipintore dà all’intero creato: «Quei che dipinge lì, non ha chi ’l guidi; / ma esso guida, e da lui si rammenta / quella virtù ch’è forma per li nidi» ( Par., XVIII, 109-111); e che l’artefice umano imitando manifesta come “sorriso” e “miniatura” dell’eterna bellezza: «“Oh!”, diss’io lui, “non se’ tu Oderisi, / l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte / ch’alluminar chiamata è in Parisi?”. // “Frate”, diss’elli, “più ridon le carte / che pennelleggia Franco Bolognese; / l’onore è tutto or suo, e mio in parte”» (Purg., XI, 79-84).
L’arte è quell’ordinata forma che il divino dipintore dà all’intero creato: «Quei che dipinge lì, non ha chi ’l guidi; / ma esso guida, e da lui si rammenta / quella virtù ch’è forma per li nidi» ( Par., XVIII, 109-111); e che l’artefice umano imitando manifesta come “sorriso” e “miniatura” dell’eterna bellezza: «“Oh!”, diss’io lui, “non se’ tu Oderisi, / l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte / ch’alluminar chiamata è in Parisi?”. // “Frate”, diss’elli, “più ridon le carte / che pennelleggia Franco Bolognese; / l’onore è tutto or suo, e mio in parte”» (Purg., XI, 79-84).
 La forma stessa delle cornici che cingono la montagna del Purgatorio, con gli exempla di vizi e di virtù scolpiti a monito e incitamento, è parte di questo processo: nel canto XII Dante posa i propri piedi come su lastre sepolcrali della storia e del mito (quasi percorresse la navata di un’antica cattedrale) e vi vede scolpiti, in tredici terzine mirabili, figurazioni di superbia punita: da Lucifero a Nembrot, ai piedi della torre di Babele, da Niobe a Roboamo. L’arte “fa segno”, rappresentando addita: «Mostrava ancor lo duro pavimento /... Mostrava la ruina e ’l crudo scempio / ... Vedeva Troia in cenere e in caverne». La sua conclusione arriva a quella perfetta fusione di rappresentazione e verità: «Morti li morti e i vivi parean vivi: / non vide mei di me chi vide il vero» (XII, 67-68), che già il poeta aveva illustrato, con ammirato stupore, nel canto X, appena entrato nella prima cornice del Purgatorio: «Là sù non eran mossi i piè nostri anco, / quand’io conobbi quella ripa intorno / che dritto di salita aveva manco, / esser di marmo candido e addorno / d’intagli sì, che non pur Policleto, / ma la natura lì avrebbe scorno» (X, 28 33). Vi è - come nelle vetrate delle cattedrali medievali - incisa tutta la storia della salvezza, a iniziare dall’Ave dell’Annunciazione: «L’angel che venne in terra col decreto / de la molt’anni lagrimata pace, / ch’aperse il ciel del suo lungo divieto, / dinanzi a noi pareva sì verace / quivi intagliato in un atto soave, / che non sembiava imagine che tace. / Giurato si saria ch’el dicesse “Ave!”» (X, 34-40).
La forma stessa delle cornici che cingono la montagna del Purgatorio, con gli exempla di vizi e di virtù scolpiti a monito e incitamento, è parte di questo processo: nel canto XII Dante posa i propri piedi come su lastre sepolcrali della storia e del mito (quasi percorresse la navata di un’antica cattedrale) e vi vede scolpiti, in tredici terzine mirabili, figurazioni di superbia punita: da Lucifero a Nembrot, ai piedi della torre di Babele, da Niobe a Roboamo. L’arte “fa segno”, rappresentando addita: «Mostrava ancor lo duro pavimento /... Mostrava la ruina e ’l crudo scempio / ... Vedeva Troia in cenere e in caverne». La sua conclusione arriva a quella perfetta fusione di rappresentazione e verità: «Morti li morti e i vivi parean vivi: / non vide mei di me chi vide il vero» (XII, 67-68), che già il poeta aveva illustrato, con ammirato stupore, nel canto X, appena entrato nella prima cornice del Purgatorio: «Là sù non eran mossi i piè nostri anco, / quand’io conobbi quella ripa intorno / che dritto di salita aveva manco, / esser di marmo candido e addorno / d’intagli sì, che non pur Policleto, / ma la natura lì avrebbe scorno» (X, 28 33). Vi è - come nelle vetrate delle cattedrali medievali - incisa tutta la storia della salvezza, a iniziare dall’Ave dell’Annunciazione: «L’angel che venne in terra col decreto / de la molt’anni lagrimata pace, / ch’aperse il ciel del suo lungo divieto, / dinanzi a noi pareva sì verace / quivi intagliato in un atto soave, / che non sembiava imagine che tace. / Giurato si saria ch’el dicesse “Ave!”» (X, 34-40).
 Dante fa qui dell’arte lo «spazio dei tempi» (Friedrich Ohly, La cattedrale come spazio dei tempi. Il Duomo di Siena, 1979), il tramite tra la vita e la memoria quale ancora ci offrirà Marcel Proust: «Essi [gli uomini del Medioevo] entravano nella chiesa, vi prendevano quel posto che avrebbero conservato dopo la morte e dal quale essi potevano continuare, come in vita, a seguire il divino sacrificio, sia che - sporgendosi dalla loro sepoltura di marmo - volgessero lievemente la testa dal lato dell’Evangelo o da quello dell’Epistola, [...] sia che nel fondale delle vetrate, nei loro mantelli di porpora, o dell’azzurro oltremare che trattiene il sole, riempissero di colore i suoi raggi trasparenti, [...]; nel loro splendore, nella palpabile irrealtà, restano i donatori che avevano meritato la concessione d’una preghiera perpetua» (La morte delle cattedrali).
Dante fa qui dell’arte lo «spazio dei tempi» (Friedrich Ohly, La cattedrale come spazio dei tempi. Il Duomo di Siena, 1979), il tramite tra la vita e la memoria quale ancora ci offrirà Marcel Proust: «Essi [gli uomini del Medioevo] entravano nella chiesa, vi prendevano quel posto che avrebbero conservato dopo la morte e dal quale essi potevano continuare, come in vita, a seguire il divino sacrificio, sia che - sporgendosi dalla loro sepoltura di marmo - volgessero lievemente la testa dal lato dell’Evangelo o da quello dell’Epistola, [...] sia che nel fondale delle vetrate, nei loro mantelli di porpora, o dell’azzurro oltremare che trattiene il sole, riempissero di colore i suoi raggi trasparenti, [...]; nel loro splendore, nella palpabile irrealtà, restano i donatori che avevano meritato la concessione d’una preghiera perpetua» (La morte delle cattedrali).
 Non diversamente contempla Dante la storia raffigurata al vivo, che l’arte trasforma in presenza da una lontana storia biblica: «I’ mossi i piè del loco dov’io stava, / per avvisar da presso un’altra istoria, / che di dietro a Micòl mi biancheggiava » (X, 70-72). Il fascino inobliabile del Purgatorio è tanto nel commercio di intercessione e suffragio che lega le anime dei vivi a quelle dei defunti, quanto nel continuo trapassare la barriera della morte e dell’oblio che l’arte intraprende unendo i tempi umani all’eterno: «Intorno a lui [“i’ dico di Traiano imperadore”] parea calcato e pieno / di cavalieri, e l’aguglie ne l’oro / sovr’essi in vista al vento si movieno» (X, 79-81).
Non diversamente contempla Dante la storia raffigurata al vivo, che l’arte trasforma in presenza da una lontana storia biblica: «I’ mossi i piè del loco dov’io stava, / per avvisar da presso un’altra istoria, / che di dietro a Micòl mi biancheggiava » (X, 70-72). Il fascino inobliabile del Purgatorio è tanto nel commercio di intercessione e suffragio che lega le anime dei vivi a quelle dei defunti, quanto nel continuo trapassare la barriera della morte e dell’oblio che l’arte intraprende unendo i tempi umani all’eterno: «Intorno a lui [“i’ dico di Traiano imperadore”] parea calcato e pieno / di cavalieri, e l’aguglie ne l’oro / sovr’essi in vista al vento si movieno» (X, 79-81).Il dialogo con Forese Donati dunque (canto XXIII), con Bonagiunta (XXIV), con Guinizzelli (XXVI) dilata il potere “vivificante” della poesia; più che stabilire priorità e successioni di fama e di prestigio - che pure Dante puntigliosamente annota - giova osservare quel prorompere palpitante di vita che dà carne e affetti a quelle ombre: «sì lasciò trapassar la santa greggia / Forese, e dietro meno sen veniva, / dicendo: “Quando fia ch’io ti riveggia?”» (XXIV, 73-75), riportandole sul proscenio terreno, tra voli incantati di geometrie celesti: «Come li augei che vernan lungo ’l Nilo, / alcuna volta in aere fanno schiera, / poi volan più a fretta e vanno in filo, // così tutta la gente che lì era, / volgendo ’l viso, raffrettò suo passo, / e per magrezza e per voler leggera» (XXIV, 64-69). -Non diversamente, nel presentare al canto XXVI, Guido Guinizzelli e Arnaut Daniel (e nel porre in bocca a quest’ultimo tre terzine in provenzale che saranno care a T.S. Eliot), non tanto conta la certificazione del canone esibita dal primo: «“O frate”, disse, “questi ch’io ti cerno / col dito”, e additò un spirto innanzi, / “fu miglior fabbro del parlar materno. // Versi d’amore e prose di romanzi / soverchiò tutti [...]”» (XXVI, 115-119); bensì quel ravvivarsi, nel crogiolo dell’analogia, del mondo delle ombre e del creato, essendo ogni parvenza nell’unico grembo del Vivente: «Poi, forse per dar luogo altrui secondo / che presso avea, disparve per lo foco, / come per l’acqua il pesce andando al fondo» (XXVI, 133-135).
È, direbbe Eugenio d’Ors, quella «naturalezza del sovrannaturale» che Dante riserva ai suoi più cari; come qui l’immagine tornerà parimenti in Paradiso per segnalare l’allontanarsi, silente e dolce, di un’altra figura familiare, quella di Piccarda Donati: «Così parlommi, e poi cominciò “Ave, / Maria” cantando, e cantando vanio / come per acqua cupa cosa grave» (Par., III, 121-123). Identico raccoglimento, di limpidi affetti, è a noi richiesto come lettori, per ben seguire la poesia di Dante: «Voialtri pochi che drizzaste il collo / per tempo al pan de li angeli, del quale / vivesi qui ma non sen vien satollo, / metter potete ben per l’alto sale / vostro navigio, servando mio solco / dinanzi a l’acqua che ritorna equale» (Par., II, 10-15).
DANTE: ATTACCO A GUIDO CAVALCANTI ’SCOPERTO’ NELLA ’COMMEDIA’ NEL CANTO XVIII DEL PURGATORIO L’AMICO VIENE DEFINITO ’’CIECO’’
Roma, 31 lug. [1997] (Adnkronos) - C’e’ un duro attacco a Guido Cavalcanti nella ’’Divina Commedia’’, finora passato inosservato. Dante Alighieri avrebbe definito ’’cieco’’ il suo migliore amico, il piu’ grande poeta dello Stil Novo, in uno dei passi piu’ ambigui e misteriosi del Purgatorio. Lo ha ’’scoperto’’ lo storico della letteratura italiana Enrico Malato dell’universita’ di Viterbo, autore di un recente saggio nel quale ha ricostruito l’evoluzione dell’amicizia tra i due massimi poeti del Duecento, fino alla traumatica rottura.
Accanto alle due citazioni di Guido (nel decimo canto dell’Inferno e nell’undicesimo canto del Purgatorio), lo studioso ne ha individuata una terza in cui il nome di Cavalcanti non e’ esplicitamente formulato ma sembra ’’assolutamente evidente’’ il riferimento a lui. La polemica allusione si troverebbe nel diciottesimo canto del Purgatorio, dove il Sommo Poeta parla dell’’’error de’ ciechi che si fanno duci’’. Malato contesta l’interpretazione accettata finora dai critici e presente in tutti i commenti della ’’Commedia’’, secondo la quale questi versi sarebbero un’accusa contro i falsi maestri che si fanno condottieri.
Per lo studioso, che sull’argomento sta preparando un nuovo saggio di prossima pubblicazione, e’ ’’inverosimile un generico riferimento ai falsi maestri che avrebbero diffuso false dottrine, mentre un’attenta lettura dell’intero canto fa apparire che l’unico cieco, cioe’ privo della luce della verita’, che abbia preteso di insegnare cio’ che egli stesso non era in grado di vedere, non puo’ essere altri che Guido Cavalcanti: bersaglio innominato della contestazione di Dante’’. (segue).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO.
Federico La Sala
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? --- Divina Commedia. La singolare «invidia» di Dante per Paolo e Francesca (di Carlo Ossola).19 aprile 2021, di Federico La Sala
LA LINGUA D’AMORE E LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI"... *
- Dopo i #maestridelsospetto (#Marx #Nietzsche e #Freud), come è possibile (#Kant) continuare a pensare all’altezza del #Dantedi2021 che il #SommoPoeta tradisca spiritualmente la sua sposa #GemmaDonati e i suoi figli e la sua figlia Antonia, suor #Beatrice? #Sogno o son desto?
Divina Commedia. La singolare «invidia» di Dante per Paolo e Francesca
La popolarità del Canto V dell’Inferno si deve anche a come Alighieri si rapporta ai due amanti fedifraghi, quasi ne invidiasse la sorte: uniti per sempre, seppure nella dannazione
di Carlo Ossola (Avvenire, domenica 18 aprile 2021)
- [Foto] Ary Scheffer, “Dante e Virgilio incontrano Paolo e Francesca”, 1835, particolare / WikiCommons
Il canto V dell’Inferno è il più celebre e più commentato di tutta la Commedia: il solo Boccaccio vi dedica (tra Esposizione litterale ed Esposizione allegorica) ben 64 pagine del suo commento (le pp. 280-344 dell’edizione Padoan citata qui a fianco). L’Inferno come luogo di dannazione stenta, per arte e per amore, a impossessarsi del poema. Nel canto IV campeggia il «nobile castello» degli «spiriti magni»: Elettra, Ettore, Enea, Camilla, Marzia, Socrate, Platone, Diogene, Anassagora, Talete, Eraclito, Dioscoride, Orfeo, Tolomeo, Ippocrate, Avicenna, Galeno, Averroè «che ’l gran comento feo»; e soprattutto la «bella scola» dei grandi poeti con i quali Dante s’accompagna, «sesto tra cotanto senno»: Omero, «poeta sovrano», Orazio, Ovidio, Lucano e lo stesso Virgilio. Siamo ancora nei chiarori della fama che si prolungano anche nel V canto, ove l’episodio d’amore di Paolo e Francesca è comprensibile solo come imitazione del modello di Ginevra e Lancillotto nel Lancelot du Lac (romanzo francese del ciclo della Tavola Rotonda): «Noi leggiavamo un giorno per diletto /di Lancialotto come amor lo strinse; / soli eravamo e sanza alcun sospetto», in una sorta di contemplazione dell’idolo che comporta l’imitazione ad litteram.
 È un peccare non per mancanza, ma per eccesso d’amore, che però è all’umana creatura naturale: «Né creator né creatura mai / - cominciò el - figliuol, fu sanza amore » (Purg., XVII, 91-92); solo si pecca «o per troppo o per poco di vigore » (ivi, v. 96). E tali saranno poi le conclusioni del Boccaccio: «dico che, per ciò che il peccato della carne è naturale, quantunque abominevole e dannevole sia e cagione di molti mali, nondimeno, per la oportunità di quello e perché pur talvolta se n’aumenta la generazione umana, pare che meno che gli altri tutti offenda Idio; e per questo nel secondo cerchio dello ’nferno, il quale è più dal centro della terra che alcuno altro rimoto e più vicino a Dio, vuole l’autore questo peccato esser punito».
È un peccare non per mancanza, ma per eccesso d’amore, che però è all’umana creatura naturale: «Né creator né creatura mai / - cominciò el - figliuol, fu sanza amore » (Purg., XVII, 91-92); solo si pecca «o per troppo o per poco di vigore » (ivi, v. 96). E tali saranno poi le conclusioni del Boccaccio: «dico che, per ciò che il peccato della carne è naturale, quantunque abominevole e dannevole sia e cagione di molti mali, nondimeno, per la oportunità di quello e perché pur talvolta se n’aumenta la generazione umana, pare che meno che gli altri tutti offenda Idio; e per questo nel secondo cerchio dello ’nferno, il quale è più dal centro della terra che alcuno altro rimoto e più vicino a Dio, vuole l’autore questo peccato esser punito».In effetti, il loro amore sembra appartenere all’ordo naturae: il canto sviluppa infatti un affascinante parallelismo: leggiamo al v. 4o: «E come li stornei ne portan l’ali », incipit di una triplice comparazione ornitologica (seguono: «E come i gru van cantando lor lai», v. 46, e «Quali colombe dal disio chiamate», v. 82) che viene a formare una perfetta simmetria con la triplice invocazione d’amore che ritma la confessione di Francesca: «Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende», v. 100; «Amor ch’a nullo amato amar perdona», v.103; «Amor condusse noi ad una morte», v. 106).
 Borges, in modo analogo, coglie l’estraneità di Francesca all’ordo damnationis: unica, tra le anime infere, a dichiarar a Dante il proprio anelito a pregar per lui, se le fosse concesso: «Lì ci sono [...] uomini illustri. Dante ne vede due che non conosce, meno illustri e che appartengono al mondo contemporaneo: Paolo e Francesca. Sa come sono morti i due adulteri, li chiama ed essi accorrono. Dante ci dice: ’Quali colombe dal disio chiamate’. Siamo di fronte a due reprobi, e Dante li paragona a due colombe chiamate dal desiderio, perché la sensualità deve essere la parte essenziale della scena. Si avvicinano a lui e Francesca, che è l’unica a parlare [...], lo ringrazia di averli chiamati e dice queste patetiche parole: ’Se fosse amico il re de l’universo, [dice ’re de l’universo’ non potendo dire Dio essendo questo nome interdetto all’Inferno e in Purgatorio] / noi pregheremmo lui per la tua pace / poi c’hai pietà del nostro mal perverso’ (vv. 91-93).
Borges, in modo analogo, coglie l’estraneità di Francesca all’ordo damnationis: unica, tra le anime infere, a dichiarar a Dante il proprio anelito a pregar per lui, se le fosse concesso: «Lì ci sono [...] uomini illustri. Dante ne vede due che non conosce, meno illustri e che appartengono al mondo contemporaneo: Paolo e Francesca. Sa come sono morti i due adulteri, li chiama ed essi accorrono. Dante ci dice: ’Quali colombe dal disio chiamate’. Siamo di fronte a due reprobi, e Dante li paragona a due colombe chiamate dal desiderio, perché la sensualità deve essere la parte essenziale della scena. Si avvicinano a lui e Francesca, che è l’unica a parlare [...], lo ringrazia di averli chiamati e dice queste patetiche parole: ’Se fosse amico il re de l’universo, [dice ’re de l’universo’ non potendo dire Dio essendo questo nome interdetto all’Inferno e in Purgatorio] / noi pregheremmo lui per la tua pace / poi c’hai pietà del nostro mal perverso’ (vv. 91-93).Francesca racconta la sua storia e lo fa due volte. La prima, la racconta con discrezione, pur sottolineando di essere ancora innamorata di Paolo. Il pentimento è vietato all’Inferno, sa di aver peccato e segue fedele il suo peccato, dal che le viene una grandezza eroica» (La Divina Commedia, in Sette notti, cit., p. 21).
 Ma Borges che suggerisce, altrove, paradossalmente, che la Commedia sia stata scritta solo perché Dante possa ritrovare in sogno colei, Beatrice, che in vita non poté mai stringere a sé ( El encuentro en un sueño, da Nueve ensayos dantescos, 1982), insinua anche una ragione supplementare a quel finale venir meno di Dante di fronte ai due amanti: «C’è dell’altro che Dante non dice, e che aleggia in tutto l’episodio e forse ne costituisce la forza. Con infinita pietà, Dante ci rivela il destino dei due amanti, e sentiamo che egli invidia questo destino. Paolo e Francesca sono all’Inferno, egli si salverà, ma loro si sono amati ed egli non è riuscito ad avere l’amore della donna che ama, Beatrice. [...] Invece questi due reprobi sono uniti, non possono parlarsi, girano nell’ ’aere perso’ [v.89] senza speranza alcuna, senza neppure, ci dice Dante, la speranza che le loro sofferenze cessino, ma restano uniti. Francesca dice noi: parla per tutti e due, un altro modo, questo, di stare uniti. Sono uniti per l’eternità, condividono l’Inferno e ciò agli occhi di Dante deve essere stato una specie di Paradiso. L’emozione, sappiamo, sopraffà Dante, che cade come un corpo morto. Ognuno si definisce per sempre in un solo istante della sua vita, il momento in cui l’uomo si incontra per sempre con se stesso» ( La Divina Commedia). E non sarà forse così, e proprio nel «fiore / di tanta plenitudine volante » ( Paradiso, XXXI, 19-20), che Dante, ancora una volta, perderà la sua Beatrice?: «Uno intendëa, e altro mi rispuose: / credea veder Beatrice e vidi un sene / vestito con le genti glorïose. / [...] / E ’Ov’è ella?’ sùbito diss’io. / Ond’elli: ’A terminar lo tuo disiro / mosse Beatrice me del loco mio’» ( Paradiso, XXXI, 58-66). A terminar lo tuo disiro!: nella più pura lontananza, e prima ancora del compimento: «Così orai; e quella, sì lontana / come parea, sorrise e riguardommi; / poi si tornò a l’etterna fontana» ( Paradiso, XXXI, 91-93; e cfr. Borges, La última sonrisa de Beatriz, in Nueve ensayos dantescos, cit.). E qui invece, e per sempre: «questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante » (vv. 135-136). In fondo, sì, tutta la Commedia potrebbe essere pensata come un’infinita palinodia di quel solo verso, nella vita di Dante incompiuto: «Amor, ch’a nullo amato amar perdona » (v. 103).
Ma Borges che suggerisce, altrove, paradossalmente, che la Commedia sia stata scritta solo perché Dante possa ritrovare in sogno colei, Beatrice, che in vita non poté mai stringere a sé ( El encuentro en un sueño, da Nueve ensayos dantescos, 1982), insinua anche una ragione supplementare a quel finale venir meno di Dante di fronte ai due amanti: «C’è dell’altro che Dante non dice, e che aleggia in tutto l’episodio e forse ne costituisce la forza. Con infinita pietà, Dante ci rivela il destino dei due amanti, e sentiamo che egli invidia questo destino. Paolo e Francesca sono all’Inferno, egli si salverà, ma loro si sono amati ed egli non è riuscito ad avere l’amore della donna che ama, Beatrice. [...] Invece questi due reprobi sono uniti, non possono parlarsi, girano nell’ ’aere perso’ [v.89] senza speranza alcuna, senza neppure, ci dice Dante, la speranza che le loro sofferenze cessino, ma restano uniti. Francesca dice noi: parla per tutti e due, un altro modo, questo, di stare uniti. Sono uniti per l’eternità, condividono l’Inferno e ciò agli occhi di Dante deve essere stato una specie di Paradiso. L’emozione, sappiamo, sopraffà Dante, che cade come un corpo morto. Ognuno si definisce per sempre in un solo istante della sua vita, il momento in cui l’uomo si incontra per sempre con se stesso» ( La Divina Commedia). E non sarà forse così, e proprio nel «fiore / di tanta plenitudine volante » ( Paradiso, XXXI, 19-20), che Dante, ancora una volta, perderà la sua Beatrice?: «Uno intendëa, e altro mi rispuose: / credea veder Beatrice e vidi un sene / vestito con le genti glorïose. / [...] / E ’Ov’è ella?’ sùbito diss’io. / Ond’elli: ’A terminar lo tuo disiro / mosse Beatrice me del loco mio’» ( Paradiso, XXXI, 58-66). A terminar lo tuo disiro!: nella più pura lontananza, e prima ancora del compimento: «Così orai; e quella, sì lontana / come parea, sorrise e riguardommi; / poi si tornò a l’etterna fontana» ( Paradiso, XXXI, 91-93; e cfr. Borges, La última sonrisa de Beatriz, in Nueve ensayos dantescos, cit.). E qui invece, e per sempre: «questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante » (vv. 135-136). In fondo, sì, tutta la Commedia potrebbe essere pensata come un’infinita palinodia di quel solo verso, nella vita di Dante incompiuto: «Amor, ch’a nullo amato amar perdona » (v. 103).Bene lo intese, ancora una volta, Jorge Luis Borges che ha riscritto quell’incontro in una delle più belle liriche del mito di Francesca e di tutto il XX secolo: «Lasciano in un canto il libro, perché sanno / che sono i personaggi di quel libro. / (Lo saranno di un altro, il più grande, / ma non se ne curano). / Sono, adesso, Paolo e Francesca, / e non due amici che condividono / il sapore d’una favola. / Si guardano meravigliati, senza crederlo. / Le loro mani non si sfiorano. / Hanno trovato l’unico tesoro, / hanno scoperto l’altro. / Non stanno tradendo Malatesta, / poiché il tradire suppone un terzo / ma essi, ora, sono unici al mondo. / Sono Paolo e Francesca / e insieme la regina e il suo amante / e tutti gli amanti che sono vissuti / dopo il primo Adamo e la sua Eva / nei pascoli del Paradiso. / Un libro, un sogno loro rivela / ch’essi sono le forme di un sogno che fu sognato / in terra di Bretagna. / Un altro libro concederà agli uomini, / sogni anch’essi, / di sognarli» ( J.L. Borges, Inferno, V, 29, da La cifra, 1981).
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO (2007).
FLS
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.) --- "La bella veste della verità". Dante e i Fedeli d’Amore: soltanto fake news (di Franco Cardini).2 dicembre 2020, di Federico La Sala
Il caso.
Dante e i Fedeli d’Amore: soltanto fake news
La “setta” cataro-templare di cui avrebbe fatto parte Dante è il fortunato frutto di una mistificazione novecentesca Ma i filologi ignorano le lacune dantesche sul neoplatonismo
di Franco Cardini (Avvenire, martedì 1 dicembre 2020)
- [Foto] Il monumento a Dante Alighieri in Piazza dei Signori, a Verona - -
Nell’approssimarsi del 2021, “Anno Dantesco” - e nella speranza ch’esso ci porti in dono anche la liberazione dall’epidemia - , è utile auspicare che alcune questioni dantesche vengano definitivamente risolte; e che su alcuni equivoci si faccia finalmente piena luce. In tempi di trasformazione epocale della “cultura diffusa” in seguito alla crisi delle istituzioni tradizionali scolastiche e universitarie e del diffondersi dei social (con la conseguenza allarmante di un intensificarsi della confusione dei linguaggi e della perdita progressiva di ancoraggi culturali autorevoli sui quali fondarsi) stanno pericolosamente riemergendo questioni dalle quali speravamo di essere definitivamente usciti.
 Una delle più divertenti da un lato e angoscianti dall’altro, e che riguarda appunto Dante e il suo tempo, è quella dei “Fedeli d’Amore”. Una strana storia, un equivoco nato fra Otto e Novecento e in seguito bizzarramente trascinatosi in seguito all’affermarsi nella nostra cultura sia d’élite, sia “diffusa”, dell’interruzione di un dialogo che ha dato luogo a una sorta di schizofrenia, di dialogo tra sordi.
Una delle più divertenti da un lato e angoscianti dall’altro, e che riguarda appunto Dante e il suo tempo, è quella dei “Fedeli d’Amore”. Una strana storia, un equivoco nato fra Otto e Novecento e in seguito bizzarramente trascinatosi in seguito all’affermarsi nella nostra cultura sia d’élite, sia “diffusa”, dell’interruzione di un dialogo che ha dato luogo a una sorta di schizofrenia, di dialogo tra sordi.Nel sonetto dantesco A ciascun’alma, il primo accolto nella Vita Nova (III), il giovane poeta c’informa di essere stato còlto nella sua stanza “da un soave sonno” dopo aver incontrato diciottenne (si era quindi verso il 1283) per la secondo volta “la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice”. -Durante il sonno, egli narra di essere stato visitato verso l’alba da uno di quelli che Carl Gustav Jung avrebbe definito “sogni significanti”: svegliatosi, aveva composto un sonetto e lo aveva inviato alla ristretta cerchia di coloro che egli chiama “tutti li Fedeli d’Amore”- Guido Cavalcanti e Lapo Gianni principalmente -, pregandoli “che giudicassero la mia visione”. La quale era terribile: Dante aveva sognato il loro “signore”, cioè Amore personificato, in quale teneva fra le braccia “madonna” (cioè Beatrice) addormentata e in mano il cuore di Dante stesso, ardente; e, svegliatola, la costringeva spaventata a mangiarlo.
 Il “cuore ardente” e il “cuore mangiato” sono immagini archetipiche fondamentali nella nostra cultura, e anche in altre: ne parla anche il Boccaccio, nella nona novella della IV giornata del Decameron.
Il “cuore ardente” e il “cuore mangiato” sono immagini archetipiche fondamentali nella nostra cultura, e anche in altre: ne parla anche il Boccaccio, nella nona novella della IV giornata del Decameron.
 L’ispiratore primario del giovane Dante era il poeta Guido Guinizzelli, il quale a sua volta era divenuto un celebre caposcuola per la sua canzone Al cor gentil, nella quale con efficace e affascinante chiarezza, ma sulla base di un’esile autocoscienza filosofica, aveva diffuso la lezione ripresa in pieno XII secolo dal trattato De amore di Andrea Cappellano, chierico al servizio di Maria di Champagne, figlia di Luigi VII di Francia e della grande Eleonora d’Aquitania, e pertanto sorella di Riccardo Cuor di Leone.
L’ispiratore primario del giovane Dante era il poeta Guido Guinizzelli, il quale a sua volta era divenuto un celebre caposcuola per la sua canzone Al cor gentil, nella quale con efficace e affascinante chiarezza, ma sulla base di un’esile autocoscienza filosofica, aveva diffuso la lezione ripresa in pieno XII secolo dal trattato De amore di Andrea Cappellano, chierico al servizio di Maria di Champagne, figlia di Luigi VII di Francia e della grande Eleonora d’Aquitania, e pertanto sorella di Riccardo Cuor di Leone.Ora, Eleonora aveva fatto conoscere in Francia settentrionale, cioè nel “paese della lingua d’oïl”, la poetica di suo padre Guglielmo IX, duca d’Aquitania e celebre trovatore, fondata sul servizio dell’innamorato all’amata: il primo considerato vassallo ( fizel, cioè fidelis) della seconda, che gli ha concesso in feudo il suo stesso cuore.
 Ma la dottrina di Andrea era una metafora del magistero relativo all’amore che risaliva a Platone e che, dopo aver animato tutto il neoplatonismo medievale, era giunto nella cristianità occidentale alla sua piena maturazione con il platonismo della scuola di Chartres, cui ha dedicato un “classico” Tullio Gregory con il suo Anima mundi (nuova edizione, Fondazione CISAM, Spoleto 2020). Il fatto è che l’aristotelismo scolastico di Tommaso d’Aquino, principale referente di Dante, aveva spazzato via un insegnamento senza il quale gli stessi Agostino e Boezio, capifila della filosofia cristiana medievale, risultavano quasi incomprensibili, e durante il secolo XIX Dante e il suo richiamo ai “Fedeli d’Amore” (ormai divenuto un gruppo penitenziale esclusivo e segreto) era stato reinterpretato in modo tanto originale quanto obiettivamente mistificatorio da un professore liceale di filosofia, Luigi Valli (1878-1931), il quale aveva reinterpretato il misticismo politico laicista “ghibellino” di Ugo Foscolo e di Dante Gabriele Rossetti ohimè legittimato dalla sterminata, equivoca erudizione di Giovanni Pascoli. Era così nata la “sètta” medievale dei “Fedeli d’Amore”, oscuramente collegata al catarismo, al templarismo e alla Weltanschauung massonica, alla quale avevano fornito credibilità gli stessi saggi dell’esoterista René Guénon. Il tutto era stato sigillato da un altro geniale pasticcione, Alfonso Ricolfi, anch’egli documentatissimo critico dei “Fedeli d’Amore” e delle “Corti d’Amore” in polemica col Valli.
Ma la dottrina di Andrea era una metafora del magistero relativo all’amore che risaliva a Platone e che, dopo aver animato tutto il neoplatonismo medievale, era giunto nella cristianità occidentale alla sua piena maturazione con il platonismo della scuola di Chartres, cui ha dedicato un “classico” Tullio Gregory con il suo Anima mundi (nuova edizione, Fondazione CISAM, Spoleto 2020). Il fatto è che l’aristotelismo scolastico di Tommaso d’Aquino, principale referente di Dante, aveva spazzato via un insegnamento senza il quale gli stessi Agostino e Boezio, capifila della filosofia cristiana medievale, risultavano quasi incomprensibili, e durante il secolo XIX Dante e il suo richiamo ai “Fedeli d’Amore” (ormai divenuto un gruppo penitenziale esclusivo e segreto) era stato reinterpretato in modo tanto originale quanto obiettivamente mistificatorio da un professore liceale di filosofia, Luigi Valli (1878-1931), il quale aveva reinterpretato il misticismo politico laicista “ghibellino” di Ugo Foscolo e di Dante Gabriele Rossetti ohimè legittimato dalla sterminata, equivoca erudizione di Giovanni Pascoli. Era così nata la “sètta” medievale dei “Fedeli d’Amore”, oscuramente collegata al catarismo, al templarismo e alla Weltanschauung massonica, alla quale avevano fornito credibilità gli stessi saggi dell’esoterista René Guénon. Il tutto era stato sigillato da un altro geniale pasticcione, Alfonso Ricolfi, anch’egli documentatissimo critico dei “Fedeli d’Amore” e delle “Corti d’Amore” in polemica col Valli.
 Bisogna dire che i professionisti della ricerca storico-filolgica dantesca, anziché replicare mostrando semplicemente gli equivoci generati dalle scarse cognizioni filologiche del giovane Dante (e anche di quello non più giovane) a proposito del neoplatonismo antico e medievale, si erano dottamente impegnati a sottolineare che i “Fedeli d’Amore” non erano mai esistiti con l’aiuto di ottimi documenti autentici, che per loro natura tutto potevano però provare meno che l’inesistente fosse mai esistito. Risultato di tutto ciò, un’incredibile follia schizofrenica: da una parte storici e filologi occupati a scomunicare - si leggano le pagine del Garin, del Viscardi e del Sapegno - l’inconsistenza e l’irrazionalismo dei seguaci del Rossetti e del Valli, dall’altra coloro che ne approfondiscono incuranti le tematiche.
Bisogna dire che i professionisti della ricerca storico-filolgica dantesca, anziché replicare mostrando semplicemente gli equivoci generati dalle scarse cognizioni filologiche del giovane Dante (e anche di quello non più giovane) a proposito del neoplatonismo antico e medievale, si erano dottamente impegnati a sottolineare che i “Fedeli d’Amore” non erano mai esistiti con l’aiuto di ottimi documenti autentici, che per loro natura tutto potevano però provare meno che l’inesistente fosse mai esistito. Risultato di tutto ciò, un’incredibile follia schizofrenica: da una parte storici e filologi occupati a scomunicare - si leggano le pagine del Garin, del Viscardi e del Sapegno - l’inconsistenza e l’irrazionalismo dei seguaci del Rossetti e del Valli, dall’altra coloro che ne approfondiscono incuranti le tematiche.Il punto però è che entrambe le “scuole” - chiamiamole così - sono partite da Dante e hanno seguito le polemiche nate sui “Fedeli d’Amore” fino ai giorni nostri senza ascoltare mai l’altra campana. Sarebbe stato sufficiente che gli studiosi seri e i dantisti filologicamente attrezzati avessero ricostruito - e avrebbero potuto ben farlo - le lacune di Dante relative ai fondamenti neoplatonici dell’Amor cortese. Il Contini e il Vinay c’erano andati vicini; nel segno aveva colpito la scuola di Maria Teresa Beonio Brocchieri, che però non si era preoccupata di “disincantare” né il Pascoli né il Valli.
Oggi, Franco Galletti torna sui “Fedeli d’Amore” con La bella veste della verità (Mimesis, pagine 602, euro 32,00), nel quale ricostruisce l’influenza della dottrina avviata (involontariamente) dal giovane Dante sui secoli successivi senza però nemmeno toccare “l’anello debole”, la sua inconsistente conoscenza del neoplatonismo del XII secolo che gli avrebbe fatto capir tutto; e sì che nel frattempo il capolavoro di Tulio Gregory è stato ristampato (esaminate il silenzio della sua bibliografia su alcuni autori a proposito di catari, di poesia francese medievale e di templari: capirete tutto).
 Quanto ad Alberto Ventura, che ha fornito al Galletti l’assistenza delle sue solide cognizioni islamologiche, egli parla certamente con ottime ragioni del sufismo musulmano, senza avvertirci (non era suo compito il farlo) che esso - pur essendo l’islam, col commento aristotelico di Averroè, alla base della scolastica tomista - non aveva mai reciso né dissimulato il rapporto con la tradizione neoplatonica.
Quanto ad Alberto Ventura, che ha fornito al Galletti l’assistenza delle sue solide cognizioni islamologiche, egli parla certamente con ottime ragioni del sufismo musulmano, senza avvertirci (non era suo compito il farlo) che esso - pur essendo l’islam, col commento aristotelico di Averroè, alla base della scolastica tomista - non aveva mai reciso né dissimulato il rapporto con la tradizione neoplatonica.
 Insomma: un grazie a Rossetti che ha riportato la nostra attenzione sull’equivoco tardoromantico-esotericomassonico della lettura di Dante e un invito a tutti a riprendere in mano le cose dal principio. Cultura, alla fine e nella sostanza, è questo: avere il coraggio e l’energia di rimettersi in discussione.
Insomma: un grazie a Rossetti che ha riportato la nostra attenzione sull’equivoco tardoromantico-esotericomassonico della lettura di Dante e un invito a tutti a riprendere in mano le cose dal principio. Cultura, alla fine e nella sostanza, è questo: avere il coraggio e l’energia di rimettersi in discussione.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
Europa. Letteratura medioevale ...
 L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare ? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.), una recensione
L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare ? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.), una recensioneL VATICANO E IL CODICE DA VINCI - di Gian Enrico Rusconi
FLS
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- BRUNETTO LATINI, DANTE, E LA "QUESTIONE DELLA LINGUA": L’ITALIAN TOUGHT E L’ ITALIA SENZA NAZIONE.28 giugno 2019, di Federico La Sala
ITALIA SENZA NAZIONE
di Antonio Montefusco (Le parole e le cose, 24 giugno 2019)
- [E’ appena uscito per Quodlibet Italia senza nazione. Lingue, culture, conflitti tra Medioevo ed età contemporanea, a cura di Antonio Montefusco. Ne presentiamo l’introduzione].
- “La storia ha di meglio da fare che essere la serva della filosofia e raccontare la nascita necessaria della verità e del valore; deve essere la conoscenza differenziale delle energie e dei cedimenti, delle sommità e dei crolli, dei veleni e degli antidoti. Deve essere la scienza dei rimedi” (Foucault 1977, pp. 29-54)
Il libro Italia senza nazione ha l’ambizione di indagare, seppure parzialmente, il «non filosofico» che, secondo la ricostruzione di Roberto Esposito, costituisce il proprium dell’indagine filosofica della tradizione italiana: una «propensione» che è sentita come «singolare», quindi costitutiva di tale tradizione. L’origine di questa pratica di estroflessione del pensiero italiano deriva da due elementi: la connessione tra vita, politica e storia, da una parte e l’esigenza insopprimibile di evocare un’origine in ogni discorso sull’attualità, dall’altra. (Esposito 2010) Si può dire, dunque, che essa abbia una naturale e specifica vocazione alla genealogia; e che in questa genealogia, nei suoi gangli più o meno pieni, più o meno mancanti, essa cerchi naturalmente i caratteri principali, non filosofici appunto, della sua estroflessione. [...] Mario Tronti ha icasticamente riassunto che l’Italian Thought si identifica con “un pensiero che si è radicato in questo Paese, in questa ‘forma-nazione’, ancor prima che diventasse una vera e propria nazione o uno Stato.” (Lisciani-Petrini - Strummiello 2017, p. 41) Questa specificità del pensiero italiano, del suo quadro, diciamo così, debolmente istituzionale, imprime già una direzione precisa alla nostra indagine, perché, a guardare allo specifico della storia italiana, è facile, a tutta prima, sottolineare come, in assenza di istituzioni politiche forti e consolidate, sia stato il discorso linguistico e letterario a costruire, immaginare, depositare elementi di identità ben prima che un processo, più culturale che politico-sociale come il Risorgimento (Banti 1991), portasse alla formazione di quella particolare comunità immaginata (Anderson 1991) che è stata chiamata “nazione italiana”. Se un libro-fondatore questa immaginata nazione può rivendicare, questo è un libro di letteratura: o meglio, di storia della letteratura. Ed è la Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis (1996). Ne consegue, dunque, abbastanza chiaramente che sia il “letterario” a poter rivendicare un primato, un certo tipo di primato, se non come oggetto, certamente come spazio di esercizio della estroflessione dell’Italian Thought. Con delle avvertenze, tuttavia, e più d’una.
«Dante che dovea essere il principio di tutta una letteratura, ne fu la fine». Questa frase di De Sanctis rappresenta il carattere paradossale di un diagramma che si pretende ascendente - dalla fondazione di un canone linguistico-letterario con le “tre corone” alla creazione di uno stato - ma che è intimamente mosso da una decadenza e da un continuo chiaroscuro dovuta a scissioni molteplici. Gli storici della letteratura più acuti ne hanno assunto questo dato in senso letteralmente progressivo, e a ragione. Uno per tutti: Alberto Asor Rosa, che, introducendo l’impresa einaudiana della Letteratura italiana, affermava:
- “è vero: si tratta di una letteratura di scarsissima coscienza nazionale, che oscilla, combinandoli insieme con sapienza estrema, tra comunalismo e cosmopolitismo (come le rimproverava, infatti, il descanctisiano Gramsci). Ma, ove non si sia accecati dalla prospettiva della storia politico-ideologica della nazione italiana, non si può fare a meno di vedere che proprio questa misconoscenza del dato nazionale consente ai letterati italiani di questa lunga fase la brillantezza e la modernità dei risultati raggiunti. [...] La debolezza delle istituzioni politiche e le carenze del ceto politico-intellettuale stimolano nel letterato italiano una vocazione alla supplenza, che spesso però, come s’è detto, non esclude la persistenza nell’uso di codici estremamente sofisticati ed élitari. Si potrebbe dire che, paradossalmente, il letterato italiano pretende di fare il politico senza rinunziare ad essere retore.” (Asor Rosa 1982, p. 23, 27)
Per non dire di Carlo Dionisotti, che in un articolo d’avanguardia (del 1951!) mise in discussione, di quel diagramma, anche l’unico centro linguistico-culturale, e cioè la Toscana, proponendo prima un paradigma doppio, in cui il primato toscano risultava in conflitto con centri antagonisti (uno alla volta: Dionisotti 1967); optando pochi anni dopo (nel 1971) per un sistema ancora più complesso, che
- “in parte e fino a un certo segno è regionale, e in parte, al di sotto del Po e in tutta l’Italia centrale, serba ancora, semplificata, la vecchia struttura municipale, in parte, al sud, mantiene intatta la l’originaria struttura della monarchia feudale, passata di mano in mano dai Normanni agli Svevi, agli Angioini di Francia e finalmente agli Aragonesi di Spagna. Resta insomma un sistema, per la sua complessità e per la sua disparità, delicato e fragile nell’insieme e nelle singole parti, ma per ciò stesso un sistema aperto alla sperimentazione e collaborazione letteraria. Anche e in specie alla collaborazione letteraria. ” (Dionisotti 2009, p. 449)
I due nomi - Carlo Dionisotti e Alberto Asor Rosa - di due critici letterari valgano come particolarmente esemplari anche di una traiettoria critica e di un punto di vista originali: il primo formulato a distanza, dall’estero, perché Dionisotti lasciò l’Italia e sviluppò la sua carriera perlopiù a Londra; il secondo tipicamente operaista, quindi coscientemente estraneo all’eredità gramsciana (passata al vaglio della vulgata togliattiana) e storicista. Vale la pena di ricordare questi elementi di biografia intellettuale e politica perché ci servono anche a misurare l’innovazione che soprattutto Esposito ha dato alla direzione del dibattito. In Dionisotti e Asor Rosa il riconoscimento dell’eccezione italiana giunge nella fase matura di un percorso che tendeva a vedere quei caratteri come fortemente regressivi se comparati alle grandi tradizioni nazionali, soprattutto francese e inglese. Il caso di Scrittori e popolo di Asor Rosa, pubblicato poco più di 50 anni fa, è particolarmente significativo: la letteratura contemporanea italiana era travolta quasi interamente da un vizio d’origine, il “populismo”, la cui ombra si dilungava dai grandi risorgimentali a Gramsci. La provocazione verso un’intera generazione di intellettuali cresciuti all’ombra della “via italiana al socialismo” con il suo corollario gramsciano, più malinteso che reale, del nazional-popolare, era evidente. Esposito sposta evidentemente l’ago della bilancia del ragionamento, quando riassume:
- “diversamente da culture filosofiche fin dall’inizio segnate dal rapporto con un’istituzione politica già forte e consolidata, come l’Inghilterra di Hobbes, ma anche la Francia di Cartesio; diversamente anche da tradizioni di pensiero impegnate nella costruzione di un sapere dello Stato, come la Germania di Hegel, l’Italia pensa la politica nella sua dimensione prestatale e anche, a volte, di resistenza allo stato.” (Esposito 2010, p. 22)
In altri termini, l’Italian thought non contribuisce a definire o irrigidire una identità italiana. E questo non solo perché, come è stato ampiamento chiarito (Esposito 2016) esso non può risolversi in un tutto che neutralizza le differenze al suo interno; per non dire, che, se così fosse, saremmo di fronte a una dogmatica più che a una theory, che invece si deve caratterizzare per una programmatica deterritorializzazione. Il motivo principale sta nel fatto che questa tendenza all’estroflessione e al “fuori” non possono che disfare un discorso di identità (italiana o altra che sia). L’Italian Thought, come theory in lingua italiana, si ritaglia uno spazio differente sia dalla brandizzazione dell’italianità (con il Made in Italy) sia dal ripiegamento identitario: entrambi processi risultanti, evidentemente, dalla globalizzazione, alla quale il pensiero italiano si presenta costitutivamente alternativo.
 Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]
Ne risulta un sistema simbolico in tensione, in cui confliggono in maniera eclatante l’auto-percezione negativa che deriva dall’immagine del paese «mancato», maggioritario nel discorso più o meno pubblico nonché nella storiografia letteraria, e una costruzione positiva, al limite dell’apologetico, diffusa fuori dei confini nazionali. Di tale contrasto paradossale è “figura” - in senso biblico - il personaggio del «cervello in fuga», dell’intellettuale esiliato ed apolide che trova fuori d’Italia lo spazio per sviluppare il proprio talento, illuminando a ritroso il capitale culturale di partenza, che risulta impossibile da contenere nello spazio del paese, essenzialmente in ragione delle conseguenze di quello «sviluppo senza progresso» mostrato da Pasolini all’alba di quello che, un tempo, si era chiamato «neocapitalismo». [...]Nel suo andirivieni, tra ricezione fuori d’Italia e sua rielaborazione all’interno dei confini nazionali, l’Italian Thought supera questa dicotomia, assume l’oscillazione continua di questo sistema simbolico tra origine e storia, mettendo continuamente in discussione il presente e assumendo un’ottica di contestazione; Daniele Balicco ha recentemente trascinato questa oscillazione sul lato più scivoloso, se si vuole, ragionando sul Made in Italy con spregiudicatezza, sottraendolo all’univocità della già ricordata brandizzazione neoliberale e infine mostrandone la potenziale narrazione contro-egemonica che si sottrae alla performatività con la godibilità (Balicco 2016). [...]
 Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.
Nel libro, si è interrogato questo sistema simbolico in tensione rinunciando programmaticamente a dare centralità agli autori “maggiori”, non solo perché essi (in special modo Dante e Leopardi) sono stati già scandagliati in questo senso; si è voluto, piuttosto, verificare e dare spessore a linee convergenti di contestazione che sono la cifra caratteristica sia del momento genetico della tradizione letteraria, nell’età di Dante, sia della sua vicenda specificamente moderna e contemporanea. In tutte queste indagini, emerge il nodo che evocavo all’inizio: quella predisposizione alla genealogia che, nell’Italian Thought, si intreccia in maniera fortissima con quella persistenza del mito nella storia, dell’arcaicità che destruttura l’attualità; questa genealogia qui finalmente si allarga: Machiavelli, che è quasi un problematico “fondatore”, non solo qui è assente, ma la genealogia si confonde forzosamente con la ricerca di un’origine, o meglio di una genesi.Ci porta a questo la scelta di un fuori letterario, che esige soprattutto il definirsi di uno spazio linguistico autonomo, che i filologi chiamano “volgare”, che sarà l’italiano. In questo senso, sullo sfondo del volume, resta sottinteso, ma fortemente presente, il nesso con la tormentata “questione della lingua”, sempre legata, per richiamare di nuovo Gramsci, alla “formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale” (Gramsci 1975, 2346). Si tratta di un paesaggio esso stesso tipicamente in tensione, di tipo spiccatamente italianistico e che dà conto dello svolgersi delle peculiarità dell’Italian Thought: dallo sforzo di teorizzazione di Dante alla discussione sulla lingua cortigiana in Machiavelli, l’ossessione dello scrittore è meno l’italiano e più chi lo possa misurare, permettere, sviluppare. Più del linguistico, conta il politico. Non sorprenderà, dunque, che lo stesso concetto di italiano in senso moderno si trovi usato, per la prima volta, da Brunetto Latini (nella generazione precedente a Dante) in francese, in particolare per intendere la politica “selonc les usages as Ytaliens” (“secondo gli usi degli italiani”.) Siamo negli anni ’60 del ‘200: a significare anche che, se spazio per l’Italian Thought ci può essere, esso debba essere concepito anzitutto in maniera linguistica all’italiana, cioè in senso ospitale e plurilingue (Montefusco 2016).
Riferimenti bibliografici
Anderson, Benedict
1991, Comunità immaginate. Origine e diffusione dei nazionalismi, Roma-Bari, Laterza.
Asor Rosa, Alberto
1982, Letteratura italiana, I. Il letterato e le istituzioni, Torino, Einaudi.
2015 Scrittori e popolo 1965. Scrittori e massa 2015, Torino, Einaudi.
Balicco, Daniele
2016 Made in Italy e cultura. Indagine sull’identità italiana contemporanea, Palumbo, Palermo.
Banti, Aldo Maria
2011 Nel nome dell’Italia, Rome-Bari, Laterza.
De Sanctis, Francesco
1996 Storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo, intr. di G. Ficara, Torino, Einaudi-Gallimard.
Dionisotti, Carlo
1967 Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi.
2009, Scritti di storia della letteratura italiana. II 1963-1971, éd. par T. Basile, V. Fera, S. Villari, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura.
Esposito, Roberto
2010 Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino.
2016 Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino, Einaudi.
Foucault, Michel
1977 Microfisica del potere, Einaudi, Torino.
Gentili, Dario
2012 Italian Theory. Dall’operaismo alla biopolitica, il Mulino, Bologna.
Gentili, Dario - Stimilli, Elettra (a cura di)
2015 Differenze italiane, Roma, DeriveApprodi.
Gramsci, Antonio
1975, Quaderni dal carcere, Torino, Einaudi
Montefusco, Antonio
2016 Dal plurilinguismo all’ospitalità. Appunti sull’italiano (neo-epico e no), in “Nuova Rivista Letteraria”, vol. 4, pp. 43-49.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SPIRITO CRITICO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.
IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO.Federico La Sala
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.) - Il "Tesoretto" di Brunetto Latini, quel misconosciuto «capolavoro della letteratura allegorica» (di Claudio Giunta).20 febbraio 2019, di Federico La Sala
IL "DIO DI AMORE" DI (OVIDIO E) BRUNETTO LATINI E "L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" DI DANTE.... *
Su Brunetto Latini, “Poesie”, a cura di Stefano Carrai
di Claudio Giunta (Domenicale del Sole 24 ore, 20 marzo 2016)
- Brunetto Latini, Poesie, a cura di Stefano Carrai, Torino, Einaudi 2016, euro 15.
Il Tesoretto di Brunetto Latini non è certamente quel misconosciuto «capolavoro della letteratura allegorica» che diceva Jauss (ma come mai lo abbiamo preso sul serio?), ma è un modo eccellente per avvicinarsi alla poesia dei primi secoli; e questa nuova edizione a cura di Stefano Carrai è un modo eccellente per avvicinarsi al Tesoretto.
Si tratta di un poemetto, 2944 versi in tutto, scritto da Brunetto Latini al principio degli anni Settanta del Duecento. È uno strano ibrido. Comincia come un racconto di viaggio (il poeta-protagonista si trova a Roncisvalle, e qui incontra uno studente bolognese che gli comunica la sconfitta dei guelfi a Montaperti), prosegue come un trattato didascalico (la Natura personificata illustra al poeta l’ordinamento del cielo e della terra), poi come un trattato morale (il poeta incontra in successione le virtù, il dio d’Amore, il poeta Ovidio), e finisce con una bizzarra ‘Penitenza’, circa 500 versi in cui Brunetto riflette sulla caducità delle cose umane ed esorta un amico a cambiare vita come lui l’ha cambiata («che sai che sén tenuti», scrive, «un poco mondanetti»); dopodiché il racconto riprende e il protagonista si trova sul monte Olimpo, dove incontra il grande Tolomeo, «maestro di storlomia». Qui il testo s’interrompe di colpo.
Al di là però del contenuto, né originale né profondo, e al di là dello stile, senza veneri (anche perché imprigionato in una gabbia metrica da filastrocca: coppie di settenari a rima baciata), il Tesoretto è un testo interessantissimo perché è davvero un repertorio di topoi immaginativi, un campione di medievalità: c’è il viaggio nella foresta, c’è un mondo fantastico all’interno del quale il personaggio-poeta può dialogare via via con la Natura, con Ovidio o con Tolomeo, ci sono le ipostasi delle virtù e delle percezioni, che pescano dall’identico immaginario da cui hanno pescato gli sceneggiatori di Inside Out (Desianza=Joy, Paura=Fear): «Desïanza ... sforza malamente / d’aver presentemente / la cosa disïata / ed è sì disvïata / che non cura d’onore / né morte né romore, / se non che la Paura / la tira ciascun’ora, / sì che non osa gire / né solo un motto dire».
Il commento di Carrai è un commento esatto e intelligente. Sembra poco, ma è tantissimo, perché i commenti alla poesia (e soprattutto alla poesia antica) sono spesso un po’ stupidi. Chi ha studiato per anni un autore o un testo non si rassegna facilmente a farsi da parte, cioè a tacere una volta chiarito ciò che nel testo c’è da chiarire, ed eventualmente a far riflettere il lettore su ciò che il testo può dire sul suo autore o sulla mentalità dell’epoca in cui venne scritto: non si rassegna, gli viene, come diceva il dottor Johnson, «la fregola di dire qualcosa anche quando non c’è nulla da dire», o peggio - e la cosa è specialmente frequente nel campo della medievistica - gli viene la fregola di trovare verità nascoste, di sciogliere gli enigmi, il che porta spesso a postulare enigmi là dove non ce ne sono, onde una ridda di ipotesi e contro-ipotesi da stancare un causidico. E poi, a riempire le pagine, valanghe di ‘riscontri intertestuali’, come se importasse qualcosa che il poeta X ha preso quella parola dal poeta Y o dal poeta Z. Carrai invece non scaraventa sul lettore tutto il contenuto delle sue schede, spiega il testo dove occorre, e dove non riesce a spiegare prospetta delle ipotesi d’interpretazione, appoggiandosi - per consentire o per dissentire - a chi del Tesoretto si è occupato prima di lui.
Al Tesoretto Carrai fa seguire, com’è consuetudine, il Favolello, che è un altro breve poemetto in settenari baciati, più pedestre nel contenuto (è uno scialbo trattatello sull’amicizia), ma interessante soprattutto perché cita come amici-destinatari due rimatori contemporanei, Rustico Filippi e Palamidesse di Bellindote. E al Favolello segue, nel volume (che appunto per questo s’intitola Poesie: è l’opera omnia in volgare italiano di Brunetto), l’unica canzone di Brunetto che ci venga tramandata dai manoscritti, S’eo son distretto, strana poesia d’amore e devozione che alcuni hanno interpretato come un documento dell’omosessualità dell’autore (con ovvi riflessi sull’interpretazione di Inferno XV) e altri, direi più plausibilmente, come canto nostalgico per la patria, Firenze, dal quale il guelfo Brunetto viene bandito dopo Montaperti.
Manca, e avrebbe invece dovuto esserci, la canzone responsiva di Bondie Dietaiuti (così, nel Medioevo, si dissolvevano le tenzoni poetiche: gli scribi copiavano i corpora personali degli autori obliterando i testi missivi e responsivi dei loro corrispondenti, che in questo modo si disperdevano; ma in un’edizione moderna non si vede perché le tenzoni non debbano essere date nella loro integrità).
Il discorso sul Tesoretto e sul Favolello non è chiuso. Sono testi facili solo all’apparenza, specie a causa delle contorsioni che il metro e lo schema delle rime impongono all’autore. Di certi hapax resta poco chiaro, nonostante lo sforzo degli interpreti, il significato. Altri termini sono ambigui (per esempio non parafraserei con ‘verità’, con Contini e Carrai, il drittura di Favolello 7 «e fàllati drittura»: ‘giustizia’, che è il senso che drittura ha usualmente, mi pare più aderente al contesto). E certi passi dovranno forse essere riconsiderati in una futura edizione critica. Per esempio, ai vv. 1275-79 tutti gli editori postulano un (credo inattestato altrove) ablativo assoluto: «E vidi ne la corte, / là dentro, fra le porte, / quattro donne reali / che corte principali / tenean ragione ed uso». Dove «corte principali» vorrebbe dire ‘nella prima corte’. Ma dato che le «donne» di cui si parla sono virtù, e che principales è l’aggettivo che nel Medioevo spesso si predica delle virtù, in genere le cardinali, ci si deve domandare se la lezione corretta non sia piuttosto, con minimo emendamento, «come principali», cioè ‘come signore, regine di quella corte di giustizia’ (e sarebbe un altro errore d’archetipo, da aggiungere a quelli registrati da Pozzi e Contini nei Poeti del Duecento).
Forse potremmo chiudere, invece, il discorso sui rapporti tra Brunetto e Dante, salvo che non saltino fuori nuovi testi che permettano di riconsiderare sotto nuova luce la questione. Questione che è nota ad ogni studente liceale: Dante mette Brunetto all’Inferno, tra i sodomiti, ma non dice nulla della sua colpa (il che sorprende fino a un certo punto, dato che non sempre Dante lo fa), né di questa colpa si parla nelle fonti che non dipendono da Dante (il che non sorprende per niente: ci si aspetta che l’omicidio o la simonia lascino traccia nelle cronache, non necessariamente le inclinazioni sessuali).
Sodomia va allora inteso figuratamente, come ‘peccato contro la propria lingua materna’ (perché Brunetto, fiorentino, ha scritto il suo Tresor in francese)? Oppure come peccato politico (perché Brunetto non avrebbe «riconosciuto la sacra autorità dell’Impero»)? Mi sembra che la soluzione proposta da Zanato e ora da Carrai resti la più sensata: dato che Brunetto ci appare in compagnia di «Prisciano, Francesco Accursio e Andrea de’ Mozzi, [cioè] del gruppo di intellettuali, perlopiù pedagoghi ed ecclesiastici, che si sono resi colpevoli di pratiche omosessuali», non c’è ragione di pensare che lui non si sia macchiato dello stesso - non metaforico - peccato.
Non andrei oltre; né speculerei, per le ragioni che ho già accennato, sulla ‘memoria’ della poesia brunettiana nel canto XV. Il poeta Brunetto non aveva niente da insegnare a Dante, perché il peggior Dante (per esempio quello un po’ lezioso di Inferno IV: «Venimmo al piè d’un nobile castello, / sette volte cerchiato d’alte mura, / difeso intorno d’un bel fiumicello...») è migliore del migliore Brunetto. E l’idea che quando Dante mette in scena un altro poeta si serva - attraverso accorte allusioni - delle parole che quel poeta ha adoperato nelle sue opere mi sembra davvero un’idea tutta nostra, un’idea da filologi moderni, che mettiamo a forza nella testa di scrittori molto meno sottili di noi.
E questo vale anche per la testimonianza che molti (anche Carrai) considerano più probante: l’avvio del canto XV, «Ora cen porta l’un de’ duri margini...», nel quale si condenserebbero «gli echi di mosse identiche del Tesoretto, vv. 1183-84 “Or va mastro Burnetto / per un sentiero stretto”, e 2181-82 “Or si ne va il maestro / per lo camino a destro”». Ma direi di no: è una formula di transizione che si trova molte volte nella poesia narrativa francese, per esempio nel Girart de Rossillon («Ere s’en vait Girarz egal solel / per un estreit sender...» (l’identica immagine del sentiero stretto che si trova in Brunetto Latini), nella chanson de toile Gaiete et Oriour («Or s’an vat Oriour stinte et marrie»), nel Macaire franco-veneto, «Ora se voit sor un corant destrer». Langue, insomma, non parole, come nella poesia medievale capita non dico sempre, ma quasi.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI". DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> L’AMORE E LA PAROLA. -- Ovidio e la "Militia amoris". Il lessico erotico e quello bellico nell’antica Roma (di Alba Subrizio).3 febbraio 2019, di Federico La Sala
L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA" .... *
‘Militia amoris’: la guerra meglio farla a letto!
Il lessico erotico e quello bellico nell’antica Roma
di Alba Subrizio (Il Mattino di Foggia, 03.02.2019)
“Non fate la guerra, fate l’amore” recita un famoso motto; eppure per i latini l’amore era anche ‘guerra’, al punto che i poeti romani coniarono il celebre sintagma “militia amoris” (milizia/servizio militare d’amore). Questo, in virtù del fatto che, come sosteneva il ‘maestro’ dell’arte d’amore per antonomasia, Publio Ovidio Nasone, sotto le coperte gli amanti combattono effettivamente una guerra (!) fatta di strategie di seduzione, ritrosie, “assalti”, etc, fino alla conquista dell’oggetto del desiderio, all’espugnazione della roccaforte. A ben guardare il lessico erotico ben si adattava a veicolare idee e concetti propri del linguaggio e del codice bellico.
Ecco allora che gladium (spada) e hasta (asta, giavellotto) potevano indicare un altro genere di ‘strumento’ che l’uomo portava in battaglia, così come pugna (il combattimento) indicava la ‘lotta’ tra amanti e, pertanto, il letto era un ‘accampamento’ (castra). Ma c’è di più.
In un carme della raccolta “Amori” (1, 9) Ovidio chiarisce che “Militat omnis amans”, ovvero “ogni amante deve militare”, nel senso di diventare vero e proprio ‘soldato’ al servizio dell’amata: «Ogni amante è un soldato, e Cupido ha i suoi accampamenti / [...] al soldato toccano i lunghi viaggi, ma se parte l’amata / l’amante la seguirà con coraggio e senza limiti; / [...] Chi, se non un soldato o un amante, / sopporterà il freddo della notte, e la neve mista alla fitta pioggia? / [...] Uno assedia le grandi città, l’altro la soglia / dell’amante inflessibile, l’uno spezza le torri, l’altro i battenti. / [...] Io stesso ero pigro, nato per gli ozi sciatti; / il letto e l’ombra avevano rammollito il mio animo; / ma l’amore di una bella donna mi ha spinto, ignavo com’ero, / a prestare servizio nel suo accampamento. / Per questo mi vedi svelto e capace di ingaggiare battaglie notturne. / Ami, chi non vuol essere pigro!».
Non solo: l’amante si dice spesso preda o ‘prigioniero di guerra’ (captus) della sua donna, nonché dell’Amore i cui ‘soldati’ (milites) sono Blandizie, Errore e Follia. Che dire di più? Nulla si ottiene senza combattere e, dunque, non c’è amore senza ‘guerra’... Non siate pigri, ma buoni soldati!
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Europa. Letteratura medioevale ...
 L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.),
L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.),SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini")
Federico La Sala
-
> L’AMORE E LA PAROLA. - Storia (dei discorsi) sulla sessualità (M. Foucault). Riflessioni su "Les aveux de la chair" (di Sergio Benvenuto).13 gennaio 2019, di Federico La Sala
La pastorale, antica e moderna Riflessioni a partire da: Michel Foucault, Les aveux de la chair 2018.
di Sergio Benvenuto (Psychiatry on line, 18 settembre, 2018)
Ci sono voluti 34 anni, dalla morte di Foucault, perché si ricostruisse definitivamente quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo volume della sua Storia della Sessualità, il quarto. Lavoro portato a termine da Frédéric Gros, che ha ricostruito il libro - o quel che Foucault ne aveva scritto - a partire da manoscritti e da parti già edite. E’ il volume - Le confessioni della carne - in cui Foucault si confronta con le concezioni cristiane, pre-medievali, della sessualità.
Va ricordato che, a differenza di tanti altri storici di oggi, Foucault in questa Storia non si occupa dei costumi sessuali nel mondo occidentale se non marginalmente. Non cerca di ricostruire come la gente comune si comportasse a letto, chi sposasse, ecc.; si occupa dell’elaborazione teorica - da parte di filosofi, moralisti, teologi - a proposito della sessualità. Più che Storia della sessualità, dovrebbe essere chiamata Storia dei discorsi sulla sessualità. In fondo, l’approccio di Foucault è aristocratico: quel che conta è quel che i “filosofi” in senso lato hanno elaborato sul rapporto tra soggetto e impulsi sessuali. La decisione di Foucault sembra l’equivalente storiografico della strategia missionaria dei gesuiti: questi non perdevano tempo a convertire la gente comune, ma il loro principe. Foucault dà per scontato che, poi, anche le pratiche sessuali nelle varie epoche si adeguassero prima o poi allo stato dell’arte riflessiva sull’argomento.
Foucault mette in chiaro che l’austerità della “pastorale cristiana della vita quotidiana” non è un’invenzione cristiana, ma continua essenzialmente la morale filosofica di autori pagani, in particolare stoici, come Plutarco, Musonio, Seneca o Epitteto. (La differenza però, aggiungerei, è che mentre la morale ascetica pagana era riservata appunto alle persone molto colte, a esseri in qualche modo superiori, quella cristiana intende essere una direttiva per tutti i cristiani e quindi, in prospettiva, per tutti gli esseri umani. La morale cristiana antica popolarizzava, direi persino democratizzava, un’ascesi che nel paganesimo non intendeva educare le masse.)
La tesi di Foucault è che la differenza del cristianesimo rispetto ad altre morali di controllo della sensualità propria e degli altri è che questo controllo si fa attraverso una confessione (e questo ancora prima che la pratica della confessione venisse istituzionalizzata come sacramento). Confessando, una verità individuale si manifesta. “Enuncia la tua colpa al fine di distruggere la colpa” diceva S. Giovanni Crisostomo. L’enunciazione esplicita all’altro del proprio peccato, quindi del proprio desiderio colpevole, è nel cristianesimo un operatore fondamentale.
 Per esempio, secondo S. Ambrogio Dio punisce Caino non tanto per il fratricidio da lui commesso, quanto per l’impudenza di aver mentito a Dio, di non aver ammesso il proprio delitto davanti a Lui. E la confessione (aveu) non è tanto semplice comunicazione all’altro di qualcosa che già il soggetto sa di sé, ma è prima di tutto scoperta interiore della propria colpa. Si scopre di essere peccatori, e lo si deve riconoscere di fronte a un altro o all’Altro (Dio). “Il peccato quindi, nel momento stesso in cui infrange la verità di Dio o la sua legge - scrive Foucault - fa contrarre un obbligo di verità [...] Nel cuore dell’economia della colpa, il cristianesimo ha posto il dovere di dir-vero”. “Il ‘dir-vero’ della colpa occupa nel cristianesimo un posto indubbiamente ben più importante e vi gioca comunque un ruolo ben più complesso che nella maggior parte delle altre religioni [...] che richiedono la confessione dei peccati”. Ciò che perde il peccatore non è il peccato in sé, ma il non confessarlo e ammetterlo. “Il dovere di verità, come credenza e come confessione, è al centro del cristianesimo”. Foucault non lo dice esplicitamente in questo testo, ma è evidente quel che pensa: che l’etica della psicoanalisi oggi - riuscire a dire il proprio inconscio, ammettere i propri inammissibili fantasmi (quel che Lacan chiamerà “parola piena”) - deriva in qualche modo proprio dalla specificità cristiana, che lega la fede a una pratica del dir-vero. Anche se inventata da un ebreo, la psicoanalisi prosegue, in chiave laica, una strategia cristiana.
Per esempio, secondo S. Ambrogio Dio punisce Caino non tanto per il fratricidio da lui commesso, quanto per l’impudenza di aver mentito a Dio, di non aver ammesso il proprio delitto davanti a Lui. E la confessione (aveu) non è tanto semplice comunicazione all’altro di qualcosa che già il soggetto sa di sé, ma è prima di tutto scoperta interiore della propria colpa. Si scopre di essere peccatori, e lo si deve riconoscere di fronte a un altro o all’Altro (Dio). “Il peccato quindi, nel momento stesso in cui infrange la verità di Dio o la sua legge - scrive Foucault - fa contrarre un obbligo di verità [...] Nel cuore dell’economia della colpa, il cristianesimo ha posto il dovere di dir-vero”. “Il ‘dir-vero’ della colpa occupa nel cristianesimo un posto indubbiamente ben più importante e vi gioca comunque un ruolo ben più complesso che nella maggior parte delle altre religioni [...] che richiedono la confessione dei peccati”. Ciò che perde il peccatore non è il peccato in sé, ma il non confessarlo e ammetterlo. “Il dovere di verità, come credenza e come confessione, è al centro del cristianesimo”. Foucault non lo dice esplicitamente in questo testo, ma è evidente quel che pensa: che l’etica della psicoanalisi oggi - riuscire a dire il proprio inconscio, ammettere i propri inammissibili fantasmi (quel che Lacan chiamerà “parola piena”) - deriva in qualche modo proprio dalla specificità cristiana, che lega la fede a una pratica del dir-vero. Anche se inventata da un ebreo, la psicoanalisi prosegue, in chiave laica, una strategia cristiana.Descrivere il pensiero cristiano attorno alla sessualità significa ricostruire il modo in cui, per secoli, i teologi hanno dovuto affrontare vari puzzle; in particolare, il modo in cui cercano di rendere coerente la morale della Chiesa che si andava precisando con la lettera delle Sacre Scritture e con l’argomentazione razionale. Un puzzle era come mettere assieme l’esaltazione della verginità con una certa santificazione, più tardiva, del matrimonio.
 Già con S. Paolo, la verginità e la castità erano messe su un livello superiore rispetto al matrimonio (che all’epoca non era ancora un sacramento). Ma allora: perché Dio ha dato questa istituzione agli uomini? Ora, contrariamente alla Chiesa di oggi, nei primi secoli la morale cristiana non valorizza il matrimonio come strumento di procreazione. In un’epoca in cui la fine dei tempi appariva prossima, la necessità di riprodursi non era affatto in cima alle preoccupazioni teologiche. Il matrimonio era considerato soprattutto, paradossalmente, un modo di reprimere la concupiscenza ed esaltare la castità, dato che il cristiano sposato si accontenta della propria donna ed evita la fornicazione (ovvero, rapporti sessuali con persone diverse dal marito e dalla moglie).
Già con S. Paolo, la verginità e la castità erano messe su un livello superiore rispetto al matrimonio (che all’epoca non era ancora un sacramento). Ma allora: perché Dio ha dato questa istituzione agli uomini? Ora, contrariamente alla Chiesa di oggi, nei primi secoli la morale cristiana non valorizza il matrimonio come strumento di procreazione. In un’epoca in cui la fine dei tempi appariva prossima, la necessità di riprodursi non era affatto in cima alle preoccupazioni teologiche. Il matrimonio era considerato soprattutto, paradossalmente, un modo di reprimere la concupiscenza ed esaltare la castità, dato che il cristiano sposato si accontenta della propria donna ed evita la fornicazione (ovvero, rapporti sessuali con persone diverse dal marito e dalla moglie).Nei primi secoli, il matrimonio è un legame indissolubile grazie a cui il corpo di ciascun coniuge non appartiene più a sé stesso, ma all’altro. In una cultura in cui la donna era considerata inferiore all’uomo, il matrimonio cristiano introduce invece - straordinaria discrasia - una perfetta parità sessuale tra uomo e donna. Se uno dei due coniugi richiede l’atto sessuale, l’altro (fosse anche l’uomo!) non può sottrarvisi. Il matrimonio, insomma, è una forma di schiavitù sessuale in cui ciascuno è allo stesso tempo schiavo e padrone dell’altro. Ciascun coniuge è in debito di rapporti sessuali con l’altro, e ciascuno ha diritto di usare sessualmente il corpo dell’altro. Dato che ci si sposa per porre un limite agli eccessi della concupiscenza, si chiede all’altro di assicurare questa limitazione. “Se vuoi astenerti [dal sesso] in accordo con il tuo coniuge - prescrive san Giovanni Crisostomo - che la cosa non duri molto”. Chi ha deciso di sposarsi piuttosto che votarsi alla castità è obbligato al sesso, perché questo è il modo di evitare la tentazione della fornicazione a sé e all’altro.
Ora, per il pensiero cristiano dell’epoca il matrimonio è effetto della caduta dopo il peccato originale: nel paradiso terrestre non c’era matrimonio, ovvero - questa è la prima tesi che si fa strada - non c’erano rapporti sessuali. Il coito implica concupiscenza, che è effetto della caduta. Questa ha condannato gli umani al commercio sessuale e alla morte individuale (il rapporto sessuale era visto come una forma di corruzione del tutto simile alla morte; l’orgasmo era visto come un andare verso il limite della morte). Ma allora, che intendeva Dio quando ha detto ai due primi umani “crescete e moltiplicatevi”? E soprattutto, perché ha creato la donna, come se non bastasse Adamo? Il genesi dice “perché la donna aiuti l’uomo”, ma non nel senso di fare sesso assieme, perché allora non sarebbe stato paradiso. E allora, come si sarebbe procreato nel paradiso? Senza rapporto sessuale? Ma se non c’era bisogno del rapporto sessuale per riprodursi, perché allora la differenza sessuale?
Foucault mostra l’evoluzione di questa problematica, da Giovanni Crisostomo in poi, fino a quella che gli appare la sistemazione finale più sofisticata, quella di Agostino di Ippona. S. Agostino ipotizza che nel paradiso Adamo ed Eva avessero sì rapporti sessuali, ma senza concupiscenza: essi dovevano “fare sesso” così come con le mani si avvita la ruota di un carro o con i piedi si cammina, attività puramente volontarie che non implicano un desiderio sensuale alla fonte. All’epoca il proprio sesso era un organo controllato dagli umani con la pura volontà, come braccia e gambe. Perché è questo il discrimine essenziale per S. Agostino (e lo sarà poi per gran parte della Chiesa successiva): l’anima è soprattutto libera volontà, mentre la sensualità, e quella erotica in particolare, è costrizione, ha la forma del bisogno fisico. Dopo la caduta, gli umani - il maschio in particolare - hanno perso il libero uso dei genitali, che funzionano solo se stimolati da libido.
La Storia della sessualità nel suo insieme va letta su uno sfondo che l’autore ha esplicitato solo parzialmente nel primo volume, La volontà di sapere, e che chiamerei una presa di distanza dalla cultura di denuncia liberal-libertina dell’ascetismo. Una cultura da cui Foucault stesso proveniva. Questa cultura, oggi molto diffusa negli ambienti intellettuali, trova i suoi mentori essenziali in Nietzsche, Mill e Freud: tende a vedere la vocazione ascetica, prima pagana e poi cristiana, che si prolunga fino a fine Ottocento, come un “falso pregiudizio”, per usare un termine abusato. Essa prosegue la critica illuminista dei pregiudizi: come le fedi religiose sono superstizioni che devono lasciar posto alla razionalità scientifica, analogamente la repressione - sia laica che religiosa - della concupiscenza è effetto o di un errore cognitivo (l’idea che la sensualità sia dannosa alla salute) o di una lesione psichica, ovvero effetto di una morbosa rimozione delle pulsioni. Il controllo della libido è morbigeno. L’ascetismo è errore o patologia, o entrambe le cose assieme.
 Questa rivalutazione della sensualità e dei piaceri corporei (non si usa più il termine carne) da un secolo e poco più a questa parte ha finito con il contagiare la stessa teologia e moralità cristiane, che oggi appaiono molto meglio disposte nei confronti della vita pulsionale (purché non si commetta adulterio, la sessualità tende a essere oggi sacralizzata).
Questa rivalutazione della sensualità e dei piaceri corporei (non si usa più il termine carne) da un secolo e poco più a questa parte ha finito con il contagiare la stessa teologia e moralità cristiane, che oggi appaiono molto meglio disposte nei confronti della vita pulsionale (purché non si commetta adulterio, la sessualità tende a essere oggi sacralizzata).
 In questa prospettiva laica, che ho chiamato liberal-libertina, dei sette peccati capitali andrebbero defalcati almeno lussuria e gola, i due più intimamente connessi alla vita pulsionale. Se si pensa che a fine Ottocento i medici positivisti (non religiosi quindi) erano ossessionati dalla masturbazione infantile come causa di vari disastri psico-fisici, e che quindi occorreva usare ogni mezzo per impedirla, si misurerà la distanza della nostra mentalità attuale, improntata in gran parte alla libertà sessuale.
In questa prospettiva laica, che ho chiamato liberal-libertina, dei sette peccati capitali andrebbero defalcati almeno lussuria e gola, i due più intimamente connessi alla vita pulsionale. Se si pensa che a fine Ottocento i medici positivisti (non religiosi quindi) erano ossessionati dalla masturbazione infantile come causa di vari disastri psico-fisici, e che quindi occorreva usare ogni mezzo per impedirla, si misurerà la distanza della nostra mentalità attuale, improntata in gran parte alla libertà sessuale.
 In effetti, nell’ultimo secolo nell’Occidente cristiano prevale la filosofia utilitarista (di Bentham, Mill...), secondo la quale l’essere umano è essenzialmente tendenza ad avere piacere e a evitare dispiacere. Tendere al piacere e fuggire il dispiacere è ciò che l’essere umano in ultima istanza è, ma anche ciò che l’essere umano dovrebbe in qualche modo cercare di essere. Secondo l’etica (anche sessuale) utilitarista la contrapposizione tra anima e corpo, o tra volontà e carne, è annullata, perché piacere e dispiacere sono allo stesso tempo cosa del corpo e cosa della mente.
In effetti, nell’ultimo secolo nell’Occidente cristiano prevale la filosofia utilitarista (di Bentham, Mill...), secondo la quale l’essere umano è essenzialmente tendenza ad avere piacere e a evitare dispiacere. Tendere al piacere e fuggire il dispiacere è ciò che l’essere umano in ultima istanza è, ma anche ciò che l’essere umano dovrebbe in qualche modo cercare di essere. Secondo l’etica (anche sessuale) utilitarista la contrapposizione tra anima e corpo, o tra volontà e carne, è annullata, perché piacere e dispiacere sono allo stesso tempo cosa del corpo e cosa della mente.Così, alla nostra cultura la paura della concupiscenza appare per certi versi un enigma. In effetti, condannare la paura della concupiscenza non è ancora spiegarla. Perché, da Platone ai moralisti vittoriani, in Occidente è fiorita - senza prevalere sempre, è vero - questa cultura di condanna morale o medica della sensualità? Foucault, da storico, non avanza ipotesi esplicative. Ma la sua storiografia ci mette sulla strada se non di una risposta, almeno di una ricostruzione più perspicua dei perché delle varie “culture” sessuali.
Quel che diceva S. Agostino, che l’atto sessuale nel paradiso terrestre era compiuto senza concupiscenza, mi pare cruciale. Perché rivela come al centro della riflessione cristiana ci sia proprio quella che, a seguito di Nietzsche, chiamiamo la volontà di potenza. (Del resto, tutta l’opera di Foucault è, in sostanza, un’applicazione al campo storiografico della dottrina nietzscheana della Wille zur Macht.) Quel che sia i filosofi pagani che i teologi cristiani temono della sensualità è il suo essere pathos, passione, sottomissione passiva al desiderio. L’anima con le sue qualità viene identificata alla volontà consapevole dell’uomo: l’intelligibile si oppone al sensibile così come la libertà della volontà umana si oppone alla servitù della sensualità. -La libido è considerata una forza esterna alla volontà, che la condiziona e la annulla. L’anima come libertà della volontà è costantemente minacciata dalla “carne” che rischia di sommergerla. Dall’ascetismo stoico fino a quello cristiano si profila quindi la continuità di una concezione che identifica i desideri sensuali alla servitù, e la coscienza volontaria alla padronanza. Gran parte del pensiero antico, che si è prolungato in Occidente fino a non molto tempo fa, era una teoria-pratica che doveva assicurare il dominio del soggetto su sé stesso. Esso vedeva quindi i desideri sessuali (ma anche quelli puramente sensuali) un po’ come noi oggi consideriamo le dipendenze da sostanze, dall’alcool alla cocaina: coartazioni della libertà che provengono dal corpo stesso. In questa prospettiva, l’ascetismo di parte della cultura occidentale diventa una strategia comprensibile anche per noi moderni: declina un certo progetto che mette al centro la libertà della coscienza umana. E’ un progetto di separazione dalla propria carne in quanto bisognosa.
Significa questo che allora la cultura contemporanea ha rinunciato alla volontà di potenza? Sarebbe assurdo affermarlo. Oggi più che mai la nostra cultura è assillata dal controllo del proprio corpo e della propria mente, anche se attraverso le tecnologie, vale a dire attraverso un trattamento che si vuole sempre più scientifico del corpo e della mente. Da qui la passione per le diete, per le palestre, per la cosmetica, per i test mentali, insomma, per la fitness. La massimizzazione dell’efficienza del corpo e della mente sono oggi parte anche della cultura popolare. Ma la differenza rispetto al passato è che questa fitness, sulla falsariga della filosofia utilitarista, si applica sia alla vita sensuale che a quella intellettuale, senza alcuna barriera etico-ontologica tra le due: bisogna massimizzare gli orgasmi così come bisogna massimizzare le proprie capacità logico-matematiche o il proprio patrimonio. Sesso, danaro, potere, sapere: tutto va massimizzato. Si deve essere ottimi amanti così come ottimi imprenditori od ottimi buongustai, od ottimi filosofi se si fa una carriera accademica. La moderna volontà di potenza non distingue più l’anima e la carne. I desideri sensuali vanno soddisfatti il più possibile, purché non danneggino la fitness generale dell’individuo.
- CONTINUAZIONE - POST SUCCESSIVO
-
> L’AMORE E LA PAROLA. - Storia (dei discorsi) sulla sessualità (M. Foucault). Riflessioni su "Les aveux de la chair" (di Sergio Benvenuto).13 gennaio 2019, di Federico La Sala
CONTINUAZIONE - PARTE FINALE
- La pastorale, antica e moderna Riflessioni a partire da: Michel Foucault, Les aveux de la chair 2018.
Significa questo che nella nostra cultura non c’è più alcuna pastorale? Foucault dedica molta attenzione al tema tradizionale, nelle culture antiche, del potere politico figurato come relazione tra il pastore e il suo gregge di pecore. Il buon re, e nel mondo cristiano il vescovo o il papa, è un buon pastore del suo gregge umano. Come nota Foucault, questo non implica affatto un’indistinzione degli individui nel gregge: il buon pastore sa che le proprie pecore non sono tutte eguali, che ciascuna ha bisogno di un trattamento specifico.
 Omnes et singulatim, scrive Foucault: il gregge è considerato nella sua totalità ma ogni singolo è preso in carico. E il buon pastore, come nella parabola evangelica (Luca 15, 3-7; Matteo 18, 12-14), deve saper abbandonare il gregge per recuperare la singola pecora smarrita. L’immagine del re-pastore o del prete-pastore va trasposta anche all’interno del soggetto stesso: bisogna essere anche pastori di sé stessi, se consideriamo i nostri desideri un gregge di sensualità. Allora, nelle nostre società capitaliste e liberali, non c’è più alcuna pastorale?
Omnes et singulatim, scrive Foucault: il gregge è considerato nella sua totalità ma ogni singolo è preso in carico. E il buon pastore, come nella parabola evangelica (Luca 15, 3-7; Matteo 18, 12-14), deve saper abbandonare il gregge per recuperare la singola pecora smarrita. L’immagine del re-pastore o del prete-pastore va trasposta anche all’interno del soggetto stesso: bisogna essere anche pastori di sé stessi, se consideriamo i nostri desideri un gregge di sensualità. Allora, nelle nostre società capitaliste e liberali, non c’è più alcuna pastorale?Anche nella nostra cultura esiste una élite, intellettuale e scientifica. Come erano élites i filosofi antichi o teologi quali S. Crisostomo o S. Agostino - possiamo pensare che le larghe masse all’epoca, soprattutto contadine, non fossero granché ascetiche, che insomma la gente comune continuasse a comportarsi come nel passato. Foucault, abbiamo detto, analizza solo le opere delle élites. E allora, che cosa pensa l’élite liberal-libertina di oggi, incluso magari Foucault (e chi scrive)?
Credo che l’ideale moderno sia quello della creatività. Che si stia a letto con il proprio partner, che si lavori come manager in un ente, o che si faccia lavoro scientifico o informatico, l’importante è essere creativi. Non basta insomma massimizzare orgasmi, danaro, titoli: l’importante è avere una vita intellettuale, lavorativa, sessuale, familiare creativa. In questo senso l’accento posto dallo psicoanalista D.W. Winnicott sulla creatività, o la concezione surrealista di una creatività artistica di cui ciascuno sarebbe capace se solo desse libero corso al proprio inconscio, sono espressioni eloquenti delle idealità moderne. Ci si può quindi lasciar tranquillamente andare ai desideri dei sensi, purché la loro gestione sia creativa, non piatta e ripetitiva. La libido, le pulsioni (l’inconscio) non vanno rimossi ma assorbiti e integrati come occasioni e fonte di energia creativa.
 Nel passato, fino a Ottocento inoltrato, il primato era dato alla forza della volontà. Oggi però il motto non può essere più quello di Alfieri, “volli, sempre volli, fortissimamente volli” ma piuttosto “creai, sempre creai, ampiamente creai”. Il creatore di opere estetiche o tecniche, il pensatore originale, lo scopritore scientifico sono tutte figure idealizzate oggi, anche se hanno condotto una vita sessuale alquanto sregolata. L’importante oggi, insomma, è essere originali, che è una ricaduta della creatività. La dicotomia non è più quindi tra sensibile e intelligibile, tra sensualità e volontà forte, ma tra creatività e ripetitività, tra originalità e conformismo.
Nel passato, fino a Ottocento inoltrato, il primato era dato alla forza della volontà. Oggi però il motto non può essere più quello di Alfieri, “volli, sempre volli, fortissimamente volli” ma piuttosto “creai, sempre creai, ampiamente creai”. Il creatore di opere estetiche o tecniche, il pensatore originale, lo scopritore scientifico sono tutte figure idealizzate oggi, anche se hanno condotto una vita sessuale alquanto sregolata. L’importante oggi, insomma, è essere originali, che è una ricaduta della creatività. La dicotomia non è più quindi tra sensibile e intelligibile, tra sensualità e volontà forte, ma tra creatività e ripetitività, tra originalità e conformismo.L’ascetismo antico era, come ogni altra cultura sessuale, un tentativo di controllare il potenziale devastatore della sessualità. Siccome la sessualità umana ha un lato costruttivo (non foss’altro che come strumento di riproduzione) e un lato distruttivo, ogni cultura, ciascuna a proprio modo, cerca di ridurre al minimo questo secondo lato. Ricordiamo che anche Freud, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, descrive la coppia innamorata come qualcosa di anti-sociale capace di sfaldare il legame sociale. Ogni cultura, dalla più primitiva alla più moderna, deve confrontarsi con un Unbehagen in der Sexualität, inscindibile dall’Unbehagen in der Kultur. La sessualità è fonte di grandi piaceri, ma anche di grandi dolori.
La morale cristiana, fondata sul matrimonio indissolubile e sulla monogamia, parte dal fatto biologico che c’è un numero quasi pari di donne e uomini: se ciascuno si contentasse di avere un partner dell’altro sesso, la vita sociale sarebbe del tutto tranquilla. Naturalmente questo è vero sulla carta, di fatto, lo sappiamo, ci sono uomini che hanno tante donne e uomini che non ne hanno nessuna, e per le donne può esser detta la stessa cosa. Di fatto, la sessualità è una mina vagante nelle società che distrugge famiglie, genera delitti passionali, fa sprecare a uomini e donne molto tempo nel corteggiamento, nei flirt, nei litigi, in penosi divorzi, ecc. Ma la morale cristiana tende all’optimum di una società sessualmente pacificata.
Comunque, anche la morale laica moderna tende a un optimum: è disposta a pagare il prezzo di una certa anarchia sessuale, purché la sessualità venga incanalata, per dir così, verso mete creative. In ogni caso, sia nell’ascetismo che nel permissivismo, ogni cultura sessuale tende a ottimizzare il commercio sessuale. Diciamo che la volontà di potenza liberal-libertina è più sofisticata dell’ascetismo, nel senso che è ancora più ambiziosa: bisogna lasciarsi andare ai sensi, abbandonarsi a essi, perché così il soggetto accede a una potenza superiore, quella creativa.
Ma la creatività è un ideale per tanti, forse per i più, non meno duro da soddisfare dell’ascesi penitenziale cristiana. Tanti, forse i più, non vogliono essere creativi, a loro basta una vita tranquilla, ordinarie soddisfazioni, imboscarsi in una sorta di benessere di massa. Le élite appaiono, agli occhi dei più, portavoce di una pastorale troppo esigente. Cosa che, forse, potrebbe spiegare le svolte politiche in Occidente degli ultimi anni.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- "Les aveux de la chair" ("Le confessioni della carne"). Michel Foucault ripercorre la genesi della confessione (di Andrea Calzolari).13 gennaio 2019, di Federico La Sala
Alias Domenica
Il sesso è ribelle all’uomo come l’uomo a Dio
Saggi. Esce da Gallimard, "Les aveux de la chair", dove Michel Foucault ripercorre la genesi della confessione nella prospettiva del tema che lo assilla nei primi anni ’80: il rapporto del soggetto con la verità
di Andrea Calzolari (il manifesto, Alias Domenica, 13.01.2019)
Da quando Pierre Janet, nel 1903, scrisse che la confessione sembrava inventata da un alienista geniale che intendeva studiare gli ossessi, l’analogia tra il confessore e lo psicoanalista è stata ripetutamente riproposta, diventando un luogo comune. Ma, un secolo prima di Janet, le Liaisons dangereuses avevano mostrato un altro aspetto della confessione nella pagina in cui la Merteuil, protagonista «cattiva» del romanzo, racconta di quando, adolescente, per informarsi sui piaceri proibiti del sesso, aveva dichiarato falsamente al confessore di aver fatto «quel che fanno tutte le donne»; le indagini e le domande del sacerdote, ansioso di salvare l’anima della giovanissima penitente, l’avevano così resa edotta proprio sui seducenti vizi da cui il prete avrebbe voluto distoglierla.
n quell’episodio Laclos inscena la spirale di sapere, potere e godere che Foucault ha messo al centro de La volontà di sapere: «Piacere di esercitare un potere che interroga, sorveglia, indaga, spia, fruga, palpa, porta alla luce; e dall’altra parte, piacere che arde di doversi sottrarre a quel potere, di fuggirlo, ingannarlo o travestirlo. Potere che si lascia invadere dal piacere che perseguita; e di fronte a lui, potere che si afferma nel piacere di mostrarsi, di scandalizzare o di resistere». Chi non ricorda questa pagina superba? Se non si conosce quel libro, si ignora uno dei vertici della coscienza contemporanea, e si resta sordi a domande che non smettono, e a lungo non smetteranno, di farci pensare.
Ma dopo La volontà di sapere (datata 1976), primo volume della Storia della sessualità, il progetto sembrò arenarsi: negli anni seguenti Foucault non pubblicò niente, mentre i corsi al Collège de France e l’intensa attività di conferenziere testimoniano sia lo spostamento dei suoi interessi dall’età moderna all’antichità, sia una rimodulazione dei vettori d’indagine.
 Nel 1984, lo stesso anno della morte dell’autore, uscirono L’uso dei piaceri e La cura di sé, i due volumi sull’«esperienza greco-latina degli aphrodisia»; da qualche mese, in Francia, è uscito finalmente anche il quarto volume, Les aveux de la chair (Le confessioni della carne, sul cristianesimo delle origini, a cura di Frédéric Gros, Gallimard, pp. 427, € 24,00) nella stesura, che Foucault non considerava definitiva, consegnata a Gallimard nel 1982, e quindi prima dei due precedenti lavori. Se restano tracce della mancata elaborazione finale (quattro frammenti che non si sa dove collocare sono annessi in appendice), il libro è già compiutamente organizzato, splendidamente scritto e talmente concentrato che è persino difficile estrapolarne qualche esemplificazione.
Nel 1984, lo stesso anno della morte dell’autore, uscirono L’uso dei piaceri e La cura di sé, i due volumi sull’«esperienza greco-latina degli aphrodisia»; da qualche mese, in Francia, è uscito finalmente anche il quarto volume, Les aveux de la chair (Le confessioni della carne, sul cristianesimo delle origini, a cura di Frédéric Gros, Gallimard, pp. 427, € 24,00) nella stesura, che Foucault non considerava definitiva, consegnata a Gallimard nel 1982, e quindi prima dei due precedenti lavori. Se restano tracce della mancata elaborazione finale (quattro frammenti che non si sa dove collocare sono annessi in appendice), il libro è già compiutamente organizzato, splendidamente scritto e talmente concentrato che è persino difficile estrapolarne qualche esemplificazione.Basti un accenno a due temi cruciali, con cui Foucault sembra rispondere in anticipo alle obiezioni del filosofo medievista Alain de Libera, che nella ponderosa «archeologia del soggetto» a cui stava lavorando da una decina d’anni, criticava sia Foucault sia Heidegger, ai quali peraltro dichiaratamente si ispirava, per aver sostenuto che il soggetto è un’invenzione moderna. In realtà, nel pensiero medievale, secoli prima del cogito cartesiano, la questione del nesso tra la soggettità (il soggetto-sostanza, supporto di attributi: il sostantivo grammaticale) e la soggettività (il soggetto come io pensante e/o agente) fu posta e discussa, anche se per lo più sotto forma di dibattiti teologici o addirittura cristologici (del resto niente affatto alieni da raffinate analisi logiche).
Ora, Les aveux de la chair riconosce il ruolo cruciale del pensiero cristiano delle origini nella costituzione del soggetto cosiddetto moderno, a partire appunto dalla istituzione della confessione: la genesi del sacramento nei primi secoli della chiesa, già a lungo studiata dagli specialisti, è ripercorsa da Foucault nella prospettiva dei temi che lo assillano negli anni in cui scrive il libro, quelli in cui studia il rapporto del soggetto con la verità.
La novità del Cristianesimo
Non a caso il libro insiste nel distinguere concettualmente due modi della confessione, l’exomològesis e l’exagòreusis, che nella pratica si sovrappongono. L’exomològesis è propriamente un «far-vero» (una «veri-ficazione»), in quanto implica non solo ammettere le proprie colpe, ma dimostrare praticamente, ovvero performare il proprio pentimento al cospetto della comunità con digiuni e mortificazioni di ogni genere. Questa penitenza, che finirà per dare il nome al sacramento, ne costituisce però solo un aspetto, complementare all’exagòreusis, il «dire-vero» (o «veri-dizione»), cioè l’impegno a dichiarare i propri peccati nella maniera più esaustiva: ciò che presuppone un «esame ininterrotto di sé», connesso «alla confessione incessante all’altro» in modo tale, nota Foucault, che si può considerare quest’ultima come il «versante esteriore dell’esame, la sua faccia verbale volta verso l’altro».
L’exomològesis, l’exagòreusis e l’esame, veri-ficazione e veri-dizione, sfociano nell’obbedienza assoluta al direttore spirituale: rifacendosi a Cassiano e agli altri teorici del monachesimo, Foucault ricorda che l’ideale monastico comportava persino l’abdicazione a una volontà propria. Nello stesso ambiente monastico viene del resto elaborata la dottrina relativa alla direzione spirituale, descritta da Gregorio Nazianzeno come «l’arte delle arti, la scienza delle scienze», dove si stabilisce che può dirigere solo chi sa a sua volta obbedire.
Si viene così definendo la struttura del complesso apparato istituzionale, consolidatosi nei secoli, in cui il soggetto cristiano plasma se stesso e su cui si è fondato il potere della chiesa. Sta in questo quadro il tema della sessualità, la cui trattazione (focalizzata sull’amore coniugale e sulla verginità) culmina nell’ultimo capitolo di Les aveux de la chair, dedicato alla concezione agostiniana della libido che, sostiene Foucault, segna un passaggio fondamentale nella storia, non solo teologica, del concetto.
Nel fuoco delle polemiche contro manichei e pelagiani, Agostino aveva delineato un quadro destinato, pur con successivi sviluppi, a durare secoli, muovendo da una questione allora assai discussa: esisteva una sessualità nel paradiso terrestre? Per i manichei la sessualità, prodotta dal demiurgo malvagio, era irredimibile; per i pelagiani, essendo stata creata da Dio, non poteva essere in sé peccaminosa (condannabili erano solo gli eccessi, come per i moralisti classici).
Per Agostino nel paradiso terrestre il sesso era docile come qualunque altro organo, svolgeva cioè la sua funzione, come la mano, per esempio, senza alcuna oscenità e immune dalla attuale parossistica violenza. Perversioni, queste, che secondo Agostino, sono l’effetto della caduta: con una sorta di contrappasso, come Adamo si è ribellato a Dio, così il sesso si ribella alla volontà umana, una ribellione che si attesta appunto nella motilità autonoma, positiva o negativa (erezione o impotenza) del sesso maschile. In questa prospettiva, primariamente fallica, il sesso - scrive Foucault in una formula folgorante, «è per l’uomo ciò che l’uomo è per Dio: un ribelle. Uomo dell’uomo, eretto davanti a lui e contro di lui».
Sapere, potere, godere
Che la libido sia ereditata da tutti gli uomini venuti al mondo (tant’è vero che essa caratterizza necessariamente anche la sessualità lecita del matrimonio), non significa tuttavia che il peccato sia dovuto all’azione di una forza esterna all’anima (la carne che sovverte lo spirito) o a un conflitto tra la ragione e la volontà («et veggio ‘l meglio, et al peggior m’appiglio»). La libido, infatti, non è qualcosa di diverso dalla volontà stessa, in quanto non è che la sua forma decaduta. Per quanto forte sia la pulsione della libido, essa non potrebbe mai tradursi in atto, senza il consenso - concetto fondamentale in Agostino - della volontà, che nel peccato «vuole ciò che vuole la concupiscenza»; ed è tale consenso che rende il soggetto di concupiscenza soggetto di diritto, responsabile delle proprie azioni.
Questa la novità del Cristianesimo secondo Foucault: mentre per il pensiero antico non si trattava di analizzare la sessualità, ma «piuttosto di collocarla in un’economia generale dei piaceri e delle forze», il cristianesimo, con Agostino, fonda «l’analitica del soggetto della concupiscenza, dove sono legati, con nodi che la nostra cultura ha piuttosto rafforzato che allentato, il sesso, la verità e il diritto». È in queste parole, le ultime del libro, che andrebbe probabilmente letta la trasformazione, ma anche la continuità, di quel circuito di sapere, potere e godere di cui parlava la Volontà di sapere.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare ... Ovidio il valore dell’eros. Una mostra a Roma celebra il grande poeta che pagò con l’esilio la visione della vita espressa nelle Metamorfosi.17 ottobre 2018, di Federico La Sala
Ovidio il valore dell’eros
Una mostra a Roma celebra il grande poeta che pagò con l’esilio la visione della vita espressa nelle Metamorfosi
L’amore come simbolo del destino instabile così augusto punì il suo essere diverso
di Nicola Gardini (Corriere della Sera, 16.10.2018)
Ci sono poeti che dalla storia ricevono il dono del bifrontismo. Guardano indietro e guardano avanti, riepilogano una tradizione e ne iniziano una. A simili poeti capita di vivere in tempi di mutazioni radicali e alla loro opera, motivata dalla paura della disgregazione, di raccogliere e di contenere il più possibile, sistematizzando ed enciclopedizzando. Un caso emblematico è quello di Dante, nei primi secoli del secondo millennio dopo Cristo. Altrettanto emblematico, sulla soglia del primo, quello di Ovidio, che di Dante - guarda un po’ - è un alter ego.
Era finita dopo quasi cinque secoli la repubblica e Roma rinasceva nel principato di Augusto, riformulando istituzioni e propaganda. Ovidio reagì con un esibito disimpegno. Veniva da Sulmona, dove era nato nel 43 a. C. e dove il padre aveva progettato di avviarlo all’avvocatura. Nella capitale elevò il suo nome scrivendo d’amore, come già altri. L’amore, però, sotto la sua penna si raffinò da emozione in progetto. Perse di naturalezza, ma acquistò in autocoscienza. Gli istinti, perfino la fame di sesso, sono costruzioni; sono esercizio dell’intelligenza: ecco la lezione degli Amori, dell’Arte dell’amore, delle Lettere d’eroine.
Ovidio impersonò il libertino, l’intrigante, il dissoluto (e ancora, a torto, per molti la sua essenza si riduce a tale ruolo), senza badare alle moralizzazioni che stavano a cuore ad Augusto. Scherzava, si divertiva, divertiva, attribuiva al maschio e alla femmina uguale diritto al piacere, e intanto, dissidente suo malgrado, sfidava la legge, derideva gli stessi dei, adattava i luoghi del potere alle proiezioni del desiderio. Fu il primo Don Giovanni del mondo occidentale; bramoso, insoddisfacibile, votato a ripetere incessantemente l’impulso a possedere. Sarebbe diventato il poeta delle metamorfosi fisiche, ma la sorte del trasformarsi la scoprì e definì prima di tutto nella pratica dell’eros, perché il voglioso che parla nelle sue poesie non smette di rimodellarsi sull’oggetto voluto, sempre diverso. La voglia non è volontà; e senza volontà non hai identità. Fu una rivoluzione.
Arrivò, dunque, al grande poema, le Metamorfosi. Sembrava un salto nel buio. Di fatto, in quel cosmo trasportava la luce di precedenti invenzioni, una volta di più e tanto più stupendamente dimostrando che non esiste differenza tra corpo e psiche. Qualcosa di nuovo, senza dubbio, nacque: un intreccio di miti e personaggi che costituivano molta memoria antica e che avrebbero costituito un archivio di archetipi per secoli a venire, giù giù fino a noi; e una rappresentazione della natura che, pur continuando Lucrezio e Virgilio, metteva in scena l’universo in maniera inedita, con una capacità di osservazione che aveva del miracoloso. Ai suoi lettori e probabilmente anche a sé stesso dava a intendere che pure lui, Ovidio, finalmente era approdato all’epica, come Virgilio.
Ma che epica poteva essere un poema che della narrazione distesa faceva non un percorso provvidenziale, non il progredire della gloria romana verso un apice inviolabile, non la missione di un eroe, ma una continua esemplificazione dell’alterità? Che epica poteva essere l’esaltazione del transeunte, dell’instabile, del perituro, la distruzione di qualunque fede nell’eternità dell’impero e nell’assolutezza del romanocentrismo? Come poteva ormai Augusto non disapprovare apertamente? E infatti Augusto disapprovò e tanto apertamente che se lo tolse dai piedi una volta per tutte.
Le ragioni della cacciata rimangono incerte. Certo è che Ovidio dovette lasciare il carissimo caput mundi subito dopo aver completato le Metamorfosi. Non potremo mai capire fino in fondo lo sgomento e la disillusione che lo presero. Si ritrovò senza meriti, consapevole di aver cambiato la mente dell’umanità. Era l’8 d. C. Si smarrì a Tomi, sul mar Nero, la Costanza dell’odierna Romania, e lì morì, nel 17 d. C., nell’abbandono più umiliante. Laggiù, tra geli e minacce continue, come raccontano i Tristia e le Epistole dal Ponto, scoprì un’estrema alterità: la sua. A Tomi Ovidio comprese che ora lo straniero, l’altro, era lui: il civis Romanus. Fu l’ultimo, il più vitale dei suoi insegnamenti.
*
Nicola Gardini, professore di Letteratura italiana e comparata a Oxford, è autore di «Con Ovidio. La felicità di leggere un classico» (Garzanti, 2017)
Il rapporto con l’altro sesso
Amava (anche) le donne E fu il primo a parlare di orgasmo simultaneo nei versi dell’Ars Amatoria
di Eva Cantarella (Corriere della Sera, 16.10.2018)
Con le donne Ovidio aveva un rapporto speciale, per alcuni aspetti molto diverso da quello dei suoi concittadini. Da un canto, infatti, come tutti i maschi romani, egli riteneva normale avere rapporti sessuali con altri uomini - sempre che, quantomeno teoricamente, questi non fossero uomini liberi: il maschio romano, per definizione dominatore, doveva essere il partner attivo del rapporto, il partner passivo doveva essere schiavo.
E Ovidio dichiara di subire anche il fascino maschile: a ispirare la sua poesia, scrive infatti, poteva essere tanto una donna quanto un ragazzo (Amores I, 1, 20). Sin qui, dunque, era come gli altri. Ma a differenza di questi preferiva le donne. E ce ne spiega la ragione: il piacere doveva essere reciproco, e le donne, per lui, provavano maggior piacere degli uomini, soprattutto se assecondate nei loro desideri (cosa che non manca di raccomandare caldamente ai suoi concittadini di fare). In un mondo nel quale il rapporto tra generi era fondamentalmente predatorio per lui, dunque, dell’amore dovevano godere anche le donne, e scriveva: «il piacere concesso per dovere non mi è grato/ compiacenza di donna non la voglio» (Ars amatoria II, 687-688).
Cosa addirittura impensabile all’epoca, poi, assicurava che il piacere era maggiore se l’uomo e la donna raggiungevano contemporaneamente l’orgasmo, ammonendo: «non sorpassarla, con le tue vele al vento/ e non lasciarla andare innanzi a te./ Guadagnatela insieme, quella meta: solo allora/ quando ugualmente vinti giacciono/ la donna e l’ uomo, pieno è il piacere» (Ars amatoria II, 724-728). Ma come raggiungerlo questo piacere, come sedurre? Per Ovidio l’amore era un gioco che allietava la vita, ma quel gioco era un’arte: quella di godere solo degli aspetti positivi del rapporto, eliminando le inutili sofferenze che questo spesso comportava. Risultato non facile, raggiunto grazie a una guerra spietata in cui il fine giustificava i mezzi, consentendo menzogne e simulazioni, nel corso della quale ciascuno dei combattenti usava le armi tipiche del proprio sesso. E poiché come tutte le arti anche quella di amare richiedeva un’educazione, nell’Ars amatoria (la più celebre delle sue opere) Ovidio assume il ruolo del precettore, insegnandola ai suoi concittadini (nei primi due libri dell’opera alle donne, e nel terzo agli uomini).
Insegnamenti diversi, ovviamente, a seconda dei sessi (che hanno peraltro in comune l’idea che la conquista fosse affidata all’inganno), descritti ricorrendo a metafore, tra le quali quella della caccia: come il cacciatore, chi ama deve studiare la preda, deve conoscerne i gusti e le abitudini, perché solo così potrà tendere trappole efficaci e sfruttare ogni possibile occasione. Ma attenzione, la vittoria, l’oggetto della conquista non è l’amore, è il piacere sessuale. L’allievo-amante non deve mai farsi coinvolgere sentimentalmente, se vuol continuare a reggere le redini del gioco e dopo aver vinto la prima battaglia della conquista vincere la guerra.
A questo punto, ce n’è quanto basta per capire come la sua poesia (purtroppo per lui) fosse in contrasto con la politica di Augusto, in quegli anni impegnato in una grande opera di moralizzazione (peraltro destinata a fallire) contro quella che egli riteneva una generale dissolutezza causata dalla perdita dei valori familiari.
Caduto in disgrazia nell’8 d.C., Ovidio venne relegato nella lontana Tomi (oggi Costanza), sulle coste del Mar Nero, e ivi morrà, nel 17 o 18 d.C. A nulla valsero i tentativi degli amici e della moglie, rimasta a Roma, per ottenere che il bando venisse revocato. Nei Tristia, l’opera scritta negli anni dell’esilio, Ovidio scriverà che a causare la sua disgrazia erano stati un errore e un carmen. Quale fosse l’errore è cosa discussa, quale il carmen è invece evidente: è l’Ars amatoria.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. -- La psicoterapia? Ha le stesse basi della “confessione religiosa”: entrambe curano l’anima12 settembre 2018, di Federico La Sala
La psicoterapia? Ha le stesse basi della “confessione religiosa”: entrambe curano l’anima
Da Pitagora a Jung. Dall’”esame di coscienza” ai percorsi psicanalitici. Così, nei secoli, la scienza e l’uomo hanno esaminato i tormenti più profondi e la scoperta del sé
di Andrea Cionci (La Stampa, 12.09.2018)
«I primordi di ogni trattamento analitico della psiche vanno ricercati nella confessione religiosa». Sono parole di Carl Gustav Jung, psichiatra e psicoterapeuta fondatore della psicologia analitica, vissuto nella prima metà del Novecento. Del resto, se l’etimologia della parola «psicoterapia» significa appunto «cura dell’anima», questa pratica affonda le sue radici nella civiltà greca, secoli prima dell’affermarsi del Cristianesimo.
Pitagora e la tragedia greca
«Sull’esame di sé e la “confessione” delle proprie mancanze - spiega Claudio Risé, scrittore e psicoterapeuta autore del recente “La scoperta di sé” (San Paolo ed.) - nasce la filosofia e la psicologia occidentale, con Pitagora, filosofo e scienziato greco. Nel pitagorismo, tuttavia, la “confessione”, veniva fatta a sé stessi per riconoscere le proprie debolezze e gradualmente trasformarle. Questo era l’equivalente dell’”esame di coscienza” che il cristiano deve fare prima della confessione, ed ogni volta che può, per rimanere in contatto con la propria coscienza e mantenerla integra”.
Le intuizioni di Pitagora costituiscono il primo barlume di consapevolezza nella storia umana per sviluppare pratiche volte a organizzare la vita quotidiana, la personalità e la responsabilità delle persone. Per quanto la mentalità attuale spesso e volentieri conduca ad andare “dove ci porta il cuore” (cosa che spesso può coincidere con la soddisfazione immediata di ogni capriccio) già gli antichi Greci mettevano in guardia dal cedere a quelle che, con lessico freudiano, si possono definire pulsioni.
 “Ma tu non essere impulsivo” raccomandava Eschilo nel coro de “I Sette contro Tebe”: nella tragedia greca, il disastro avveniva sempre a causa del cedimento a un impulso. Questo poteva provenire indifferentemente da un dio o da un demone; ecco perché, già secondo gli antichi, esso doveva essere sempre meditato e filtrato dall’uomo in un modo che conducesse a un’azione perfettamente libera».
“Ma tu non essere impulsivo” raccomandava Eschilo nel coro de “I Sette contro Tebe”: nella tragedia greca, il disastro avveniva sempre a causa del cedimento a un impulso. Questo poteva provenire indifferentemente da un dio o da un demone; ecco perché, già secondo gli antichi, esso doveva essere sempre meditato e filtrato dall’uomo in un modo che conducesse a un’azione perfettamente libera».Un sentimento umano
Se l’insegnamento pitagorico giunse fino ai Romani («La confessione dei nostri peccati è il primo passo verso l’innocenza», scriveva il drammaturgo Publilio Siro nel I sec. a.C.) anche nel resto del mondo si è costantemente rivelata l’esigenza tipicamente umana di sgravarsi la coscienza parlando con qualcuno.
Nel Messico antico, i peccatori andavano a confessarsi dai sacerdoti della dea Tlaçolteotl (la «dea delle sozzure», cioè dei peccati specialmente carnali), i quali imponevano la penitenza. Nell’antico Perù, il penitente si confessava dall’ichuri, lo sciamano. Per espirare le proprie colpe ci si doveva sottoporre a lavacri o a salassi.
«Il senso di colpa - spiega il neuropsichiatra e scrittore Giuseppe Magnarapa - esiste da sempre ed è legato al principio di autorità il quale serve, a propria volta, a garantire la pace sociale. In assenza di un qualunque sistema di regole, infatti, non esiste la società. Se si infrange la regola, la psiche esprime l’esigenza di espiare, di produrre a se stessi lo stesso lutto o danneggiamento che si è procurato all’esterno per “pareggiare i conti” e ritrovare un nuovo adattamento. L’esigenza di confessare anche pubblicamente la propria colpa esprime esattamente questa necessità. Una forma ancestrale di questo bisogno si avverte, ad esempio nella cosiddetta “televisione verità” con persone che spettacolarizzano senza vergogna la propria intimità anche confessando azioni non esattamente edificanti».
Le prime confessioni cristiane
Pubbliche erano, non a caso, le confessioni dei peccatori nei primi secoli del Cristianesimo: la preghiera, le buone azioni, il digiuno e l’elemosina erano le azioni grazie alle quali si otteneva il perdono del peccato. Questo viene definito dal Catechismo «una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una trasgressione in ordine all’amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni».
All’inizio, lo stato di penitente era molto gravoso e comportava forme di temporanea emarginazione. Nei secoli, la confessione dei peccati si è sempre più sistematizzata, ha iniziato a svolgersi privatamente, prima col vescovo e poi col semplice sacerdote, il quale è tenuto ancor oggi a osservare il più totale segreto «professionale» su quanto ascoltato durante il sacramento.
Sovrapposizioni
Secondo Jung il processo psicoterapico si articola in quattro fasi. Durante quella che lui definisce Confessione, il paziente svuota i propri segreti, estrinsecando la propria condizione e sofferenza. Nella Chiarificazione, egli diventa consapevole dei propri sentimenti, intuisce i motivi che lo hanno condotto al dolore. Nell’Educazione, si propone di assumere nuovi comportamenti e atteggiamenti e infine, nella Trasformazione, il paziente assiste ai risultati dell’effettivo cambiamento nella sua vita.
Il parallelo col sacramento cattolico è abbastanza evidente, tanto che anche questo si articola in quattro fasi: la Contrizione, in cui il fedele si pente del male commesso, l’Esame di coscienza, in cui riflette su come e dove ha sbagliato; la Confessione, nella quale esprime al sacerdote tutti i peccati che in sincerità ricorda; infine la Soddisfazione, che implica un cambiamento nella propria vita e l’espiazione per il male compiuto con azioni risarcitorie, o con la preghiera.
Vi è infine da ricordare che alla base di tutto vi è il principio della Misericordia divina, che consente all’uomo di rialzarsi dopo i cedimenti e di proseguire sulla strada del perfezionamento spirituale. Negli ultimi anni, in ambito cattolico, si è parlato molto di Misericordia, meno spesso si è ricordato come questa non possa essere svincolata dal pentimento e dal riconoscimento dei propri peccati.
L’anonimato
Fu il cardinale santo Carlo Borromeo, alla metà del ‘500, a regolare e a diffondere il confessionale nella sua classica struttura che, poi, si diffuse in tutto il mondo. Si tratta, come noto, di una cabina di legno dotata di inginocchiatoi; fitte grate metalliche celano il viso del penitente il quale non è tenuto a rivelare la propria identità al prete. Con il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha aperto anche alla confessione vis à vis.
Tuttavia, sarebbe interessante indagare quali benefici possa produrre l’atto rituale di liberare la propria coscienza in un soffio di parole, «spifferando» il male compiuto all’orecchio del sacerdote, ieratico e invisibile intermediario fra Dio e l’uomo, senza vederlo e senza farsi da lui vedere. Il diaframma costituito dalla grata era pensato in modo utile anche per il prete, per metterlo al riparo da contatti troppo ravvicinati e forieri di tentazioni. Probabilmente San Carlo aveva intuito, già cinque secoli fa, quello di cui da pochi decenni si occupa la Programmazione Neuro Linguistica, ovvero il linguaggio più o meno volontario che esprimono gli occhi e la posizione del corpo.
Per quanto, infatti, un pastore debba ascoltare con neutra benevolenza la confessione di un penitente, non è detto che egli riesca a controllare le sottili reazioni della sua postura e del suo sguardo che possono veicolare una quantità di messaggi involontari.
Non sappiamo se, nel mondo della psicoterapia, si sia mai sperimentata una soluzione tecnica come quella della grata del confessionale tradizionale, magari nell’ottica di assicurare maggiore libertà e comfort emotivo al paziente attraverso il completo anonimato.
Un terreno ricco di spunti
Il grande scrittore cattolico Gilbert Keith Chesterton riassumeva: «La psicoanalisi è una confessione senza assoluzione». In effetti, l’ approccio laico non prevede generalmente un sistema morale, né la credenza in un’entità trascendente. Mentre il sacerdote, con un segno di croce, riporta il fedele nella pace con se stesso, lo psicoterapeuta conduce il paziente a sciogliere dai solo i propri nodi attraverso un percorso che può essere lungo e difficile.
Ciò che emerge è che i contatti fra tradizione religiosa, (cattolica, ma non solo) e il mondo della psicoterapia-psichiatria offrono un fertile terreno di scambio. Ad esempio, oggi si parla spesso di narcisismo, di depressione; di disturbi alimentari come anoressia e bulimia; di sex addiction o ipersessualità. Non ci si trova dunque di fronte a versioni più o meno patologiche degli antichi vizi come superbia, accidia, gola e lussuria?
Margriet Sitskoorn, docente di Neuropsicologia clinica all’Università di Tilburg (Olanda), in un capitolo del suo libro «I sette peccati capitali del cervello» mostra, attraverso vari studi neuroscientifici, come il soddisfacimento dei bisogni più elementari, privi di riflessione etica e di controllo, conduca al rilascio di sostanze come dopamina e oppioidi, che producono piacere immediato anche se questo comporterà conseguenze negative per se stessi e per gli altri. E’ stata scoperta, dunque, la radice biochimica della seduzione del Male?
Tra religione e scienza «c’è piuttosto antipatia sentimentale che opposizione logica», sentenziava il colombiano Nicolás Gómez Dávila. Tuttavia, considerando che l’esperienza religiosa si è applicata allo studio dell’uomo per alcuni millenni, si potrebbe dare ragione ad Albert Einstein quando aprì al confronto fra i due mondi con una frase rimasta celebre: «La religione senza la scienza è cieca, la scienza senza la religione è zoppa».
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- "Reis glorios". Un’antica versione italiana dell’alba di Giraut de Borneil scoperta da Nello Bertoletti (di Claudio Giunta).9 febbraio 2015, di Federico La Sala
Scoperte filologiche
La nuova alba dell’italiano
Nello Bertoletti ha scoperto e pubblicato un nuovo testo poetico delle origini
Datato 1239, in dialetto settentrionale, con ogni probabilità piemonese
di Claudio Giunta (Il Sole-24 Ore, Domenica, 08.02.2015)
«Il più antico documento della nostra letteratura è comunemente creduto la cantilena o canzone di Ciullo di Alcamo, e una canzone di Folcacchiero da Siena». Sono parole di Francesco De Sanctis, è l’inizio della sua Storia della letteratura italiana. Lo studente che le ripetesse oggi a un esame universitario verrebbe subito bocciato, perché ciò che oggi sappiamo circa le origini della nostra poesia è molto diverso (e molto di più) rispetto a ciò che sapeva De Sanctis.
Sappiamo intanto che la cronologia della scuola siciliana è diversa da quella «comunemente creduta» ai tempi di De Sanctis, e che non ci sono ragioni per attribuire a Cielo (non Ciullo) d’Alcamo, e men che meno a Folcacchiero da Siena, il ruolo dell’iniziatore. Sappiamo che esistono testi in versi di argomento religioso-devozionale che risalgono all’ultimo quarto del dodicesimo secolo o al primo quarto del tredicesimo (e uno di questi testi, per quanto atipico, è poi il Cantico delle creature di san Francesco).
Ma sappiamo anche che le strade della poesia profana furono meno lineari di quanto s’immaginasse non solo sino a De Sanctis ma sino a una quindicina d’anni fa, perché i filologi hanno trovato, frattanto, testi poetici databili agli ultimi decenni del secolo XII o ai primi del XIII in aree eccentriche rispetto a quelle in cui nasce e si sviluppa, nel secondo quarto del Duecento, la tradizione cosiddetta “siciliana”: si tratta, precisamente, della canzone Quando eu stava scoperta da Alfredo Stussi in un’antica pergamena ravennate, e del frammento piacentino Oi bella scoperto da Claudio Vela (2005).
Ora il quadro cambia di nuovo, e non per un dettaglio, perché Nello Bertoletti ha scoperto (non in un archivio ma tra le carte di un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana) e pubblicato un nuovo testo poetico delle origini che comincia così:
 Aiuta De’, vera lus et gartaç,
Aiuta De’, vera lus et gartaç,
 rex glorïoso, segnior, set a vu’ platz,
rex glorïoso, segnior, set a vu’ platz,
 chìa mon conpago sê la fedel aiuta.
chìa mon conpago sê la fedel aiuta.
 E’ nun lo vite, po’ la note fox veiota.
E’ nun lo vite, po’ la note fox veiota.Ovvero, nella traduzione offerta dallo stesso Bertoletti: «Sii d’aiuto Dio, vera luce e splendore, re glorioso, signore, se a voi piace, siate il fedele aiuto del mio compagno. Io non l’ho visto, da quando si è vista la notte». Il testo prosegue per altre quattro stanze, nelle quali l’io poetico, dopo aver invocato Dio, si rivolge a un «Bè conpagnó», cioè a un «Bel compagno», invitandolo a svegliarsi, perché l’alba si avvicina.
Alba è appunto il nome del genere poetico a cui questo testo appartiene, genere (o piuttosto motivo) diffuso in molte letterature, ma da un lato poco o nulla presente in quella italiana (giusto qualche traccia nel Duecento, nei cosiddetti Memoriali bolognesi), dall’altro invece vitalissimo fra i trovatori, cioè tra quei poeti che vissero nella Francia meridionale, e successivamente anche nell’Italia del nord, tra la fine del secolo XI e la fine del secolo XIII.
Ebbene, quali sono i motivi d’interesse di questa inedita alba? Molti, a cominciare dall’epoca in cui è stata scritta. Al centro della medesima carta sulla quale è trascritto il testo si legge infatti una data, «Millesimo Ducentesimo Trigesimo nono», cioè 1239: e Bertoletti mostra in maniera molto convincente (confortato anche dalla perizia paleografica di Antonio Ciaralli) che questa data è stata vergata in un momento successivo alla trascrizione di Aiuta De’: il 1239 rappresenta dunque un sicuro termine ante quem per la composizione e la copia del nostro testo, che sarà pertanto almeno sincrono rispetto alle poesie che in quegli anni venivano composte, molti chilometri più a sud, alla corte di Federico II.
Un altro motivo d’interesse è la pertinenza geografica del testo. I quattro versi citati sono difficili da capire perché non sono scritti nel limpido toscano, o nel siciliano toscanizzato, dei grandi poeti del Duecento che si leggono a scuola, ma in un dialetto settentrionale. Ora, buona parte degli sforzi di Bertoletti sono appunto rivolti a precisare di quale dialetto settentrionale si tratti, e al termine di un’analisi davvero esemplare per ampiezza e rigore Bertoletti conclude che l’origine del testo va ricondotta con ogni probabilità al Piemonte, e forse al Piemonte meridionale, cioè a un’area compresa «tra l’Oltregiogo ligure, le Langhe, l’Alessandrino e il Monferrato».
 Dato interessantissimo: da un lato perché di poesia scritta in un volgare assegnabile al basso Piemonte non s’era mai scoperta traccia sino ad ora; e dall’altro perché il basso Piemonte non era però, nel primo Duecento, una regione in cui mancassero i poeti: solo che scrivevano e cantavano non nel volgare locale bensì in lingua occitana.
Dato interessantissimo: da un lato perché di poesia scritta in un volgare assegnabile al basso Piemonte non s’era mai scoperta traccia sino ad ora; e dall’altro perché il basso Piemonte non era però, nel primo Duecento, una regione in cui mancassero i poeti: solo che scrivevano e cantavano non nel volgare locale bensì in lingua occitana.Col che veniamo al terzo (e forse maggiore) motivo d’interesse della scoperta di Bertoletti. Aiuta De’ non è un testo originale bensì la traduzione di una celebre alba del trovatore Giraut de Borneil, quello che Dante nel De vulgari eloquentia indica come esemplare della «poesia della rettitudine». L’alba di Giraut ha però un incipit diverso, comincia infatti Reis glorios, verays lums e clardatz (dove il Re glorioso è appunto Dio), né - come Bertoletti documenta minuziosamente nel suo commento - è questa l’unica licenza che il traduttore piemontese si prende nei confronti del suo testo-modello. Ma dimostrato che, comunque, di traduzione si tratta, il fuoco della ricerca si concentra appunto sul testo-modello e sulla sua folta tradizione manoscritta: a quale ramo di questa tradizione apparteneva il manoscritto che il poeta-traduttore piemontese aveva di fronte a sé, ovvero quale “versione” di Reis glorios leggeva costui?
Ed ecco l’ultima sorpresa: perché la tradizione a cui mostra di attingere il nostro poeta-traduttore è la stessa a cui attingerà il canzoniere (assai più tardo) che i provenzalisti conoscono come «T», canzoniere cruciale anche per la letteratura italiana perché fu probabilmente attraverso un manoscritto simile a «T» che Giacomo da Lentini e gli altri siciliani fecero conoscenza con la poesia trobadorica. Non solo: è anche la medesima tradizione alla quale attinse l’anonimo copista siciliano di un altro manoscritto latore di Reis glorios, oggi conservato a Monaco di Baviera.
 La conclusione di Bertoletti è sobria (com’è sobrio, misuratissimo, tutto questo suo splendido lavoro), ma darà certo materia di riflessione agli specialisti: «avremmo quindi la traccia concreta della trasmissione di un testo trobadorico [Reis glorios] dalla Provenza alla Sicilia attraverso una mediazione italiana nordoccidentale (piemontese), anziché veneta».
La conclusione di Bertoletti è sobria (com’è sobrio, misuratissimo, tutto questo suo splendido lavoro), ma darà certo materia di riflessione agli specialisti: «avremmo quindi la traccia concreta della trasmissione di un testo trobadorico [Reis glorios] dalla Provenza alla Sicilia attraverso una mediazione italiana nordoccidentale (piemontese), anziché veneta».*
Nello Bertoletti, Un’antica versione italiana dell’alba di Giraut de Borneil , con una nota paleografica di Antonio Ciaralli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura. Il volume è acquistabile direttamente dall’editore sul sito www.storiaeletteratura.it
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? ---- Ignazio di Loyola e gli esercizi d’immaginazione (di Pietro Citati)12 giugno 2014, di Federico La Sala
Ieri come oggi, sulle orme del Maestro
Ignazio di Loyola, esercizi d’immaginazione per tornare a vivere la realtà di Cristo
di Pietro Citati (Corriere della Sera, 12.06.2014)
Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù, aveva un’immensa immaginazione, e la coltivava e la faceva coltivare dai padri gesuiti, quando essi eseguivano gli esercizi spirituali, il cuore dell’insegnamento praticato nella Compagnia.
Imponeva loro di fissare con la mente i grandi e minimi aspetti dell’immaginario cristiano: la nascita di Gesù, la sua infanzia, il battesimo, la tentazione, la passione, la crocifissione, la sepoltura, la resurrezione. I gesuiti dovevano rovistare con un’intensità implacabile ciò che portavano dentro il cuore: niente doveva sfuggire loro, nemmeno un sasso o una pianta o un filo d’erba dei sentieri che Gesù aveva percorso; nemmeno una parola che egli aveva pronunciato nelle sinagoghe o lungo il mare.
«Bisognava considerare da lontano la strada da Betania a Gerusalemme, se ampia o stretta, se piana o montuosa»: guardare la tavola a cui Gesù era seduto, i piatti, le bottiglie, i bicchieri. Così la mente dei gesuiti scendeva dentro se stessa; e apprendeva l’insegnamento che Gesù Cristo aveva depositato nel paesaggio che aveva percorso, o nella stanza dove era vissuto.
Quante volte Dio, o Gesù, o lo Spirito era apparso alla mente dei padri gesuiti! La natura di Dio era un dono: pronto a illuminare e perfezionare con i raggi della sua grazia il cuore dei padri. Era disposta a effondersi, sempre più generosa e più vasta; e a ricevere ciò che dagli uomini saliva verso di lui:
 «Prendi, Signore, e ricevi/ tutta la mia libertà,/ la mia memoria,/ il mio intelletto,/ e tutta la mia volontà/ tutto ciò che ho e posseggo;/ tu me lo hai dato,/ a te, Signore, lo ridono;/ tutto è tuo».
«Prendi, Signore, e ricevi/ tutta la mia libertà,/ la mia memoria,/ il mio intelletto,/ e tutta la mia volontà/ tutto ciò che ho e posseggo;/ tu me lo hai dato,/ a te, Signore, lo ridono;/ tutto è tuo».Dio confortava, consolava, addolciva con una gioia inesauribile. «Ridete, figliolo, Ignazio disse a un novizio, e siate allegri nel Signore, poiché un religioso non ha nessun motivo per essere triste e ne ha mille per gioire».
Quando si voltavano indietro, i padri gesuiti cercavano di ritrovare la natura della propria anima: ciò che essa aveva di autentico, di originario, di puramente spirituale. L’emozione era grandiosa. Ma, al tempo stesso, essi trovavano in sé molte cose diverse: tumulti, peccati, passioni, disordini, sventure; gli effetti che la caduta aveva prodotto su ciascuno di loro. Così condannavano i disordini, le passioni e i capricci. Rafforzavano la volontà della ragione: certi che la ragione, sebbene nata dopo il peccato originale, sarebbe riuscita a salvarli dal peccato. Non temevano di appoggiarsi ad essa e alla sua sostanza umana: anzi cercavano di renderla più robusta e affinata, più solida e complicata.
Qualche volta i padri gesuiti si sentivano soffocare. La vita morale, sia pure virtuosa, costringeva la loro anima; gli altri esseri umani opponevano limiti e negazioni al loro slancio amoroso. Avevano bisogno di spazio. In alcuni testi cristiani trovarono l’invito a una severissima e strettissima condizione ascetica. Ma, proprio in Sant’Ignazio, scoprirono l’invito ad abolire ogni ascetismo e ogni strettezza. Come lui, i padri gesuiti amavano il cosmo: ammiravano tutte le creature, le stelle, le comete, le erbe e gli animali; visitavano le più lontane regioni del mondo; non rifiutavano i piaceri del corpo; e si ergevano sopra i cieli, ascoltando il palpito della creazione.
La Compagnia di Gesù esigeva dai padri attività estremamente complicate: essi dovevano, per esempio, lavorare come economi e amministratori. Sebbene ordini più spirituali condannassero queste attività pratiche, i padri gesuiti le difendevano con cautela e tenacia. Si rendevano conto che il rapporto quotidiano con la realtà allargava la loro mente, rendeva più sinuosa la loro intelligenza e la loro fantasia.
Come Sant’Ignazio, avevano altri timori: l’astrazione dello spirito puro, la follia della mente abbandonata a se stessa. Gli Esercizi spirituali erano strettamente legati al tempo del giorno, della settimana, del mese, dell’anno. La vita di ogni gesuita obbediva al tempo. Un certo esercizio doveva essere compiuto all’alba di ogni giorno: allora bisognava guardarsi con diligenza da un particolare peccato; dopo pranzo un altro esercizio ricordava loro quante volte erano caduti in quel peccato.
Tutti i padri gesuiti conoscevano il tempo proprio di ciascuno di loro: l’ordine temporale conteneva una grande e nascosta sapienza, che essi non avrebbero mai finito di apprendere. Solo coincidendo col tempo, solo facendolo battere regolarmente sugli orologi del cuore, essi tenevano aperta l’anima, e permettevano a Gesù Cristo e allo Spirito Santo di penetrare dentro di essa.
Chi compiva gli Esercizi spirituali correva un rischio: quello degli scrupoli; vale a dire i peccati immaginari, ricordi di peccati passati, dubbi, incertezze, insoddisfazioni, disgusti, torture dell’intelligenza. Da soli, i padri gesuiti non riuscivano a liberarsi dagli scrupoli; e rimanevano invischiati nei relitti della propria anima. Non restava loro che pregare a lungo Gesù e lo Spirito Santo, aprendo l’anima alla sovrabbondante grazia di Dio.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- I Trovatori. A caccia d’amore e disamore. Una pattuglia di poche centinaia di poeti nata tra Catalogna e Italia con centro la Provenza (di Lorenzo Tomasin)19 gennaio 2014, di Federico La Sala
I Trovatori
A caccia d’amore e disamore
Erano una pattuglia di poche centinaia di poeti nata tra Catalogna e Italia con centro la Provenza, prima di Dante e Petrarca
di Lorenzo Tomasin (Il Sole 24 Ore/Domenica, 19.01.2014)
- Alfred Pillet, Henry Carstens, Bibliographie des Trobadours, rist. anast. con aggiornamenti, a cura di
P. Borsa, R. Tagliani, S. Resconi. Introduzione di M.L. Meneghetti, Ledizioni, Milano, pagg. 614 € 48,00
 Canzoni occitane di disamore, a cura di F. Sanguineti e O. Scarpati, Carocci, Roma, pagg. 248, € 28,00
Canzoni occitane di disamore, a cura di F. Sanguineti e O. Scarpati, Carocci, Roma, pagg. 248, € 28,00
Che senso ha leggere i Trovatori? Tramontato il mito romantico del loro aurorale primitivismo (hanno fatto, sì, germinare la poesia europea, ma sopra radici culturali poderose, illuminate da generazioni di eruditi); appannato - forse - ai nostri occhi il fascino letterario dell’amor cortese con i suoi riti, tutto sommato ripetitivi e stilizzati; sommerse le loro rime dalle successive grandi stagioni della poesia lirica europea: perché proprio i Trovatori, cioè una pattuglia di poche centinaia di poeti fiorita, con centro la Provenza, tra Catalogna e Italia prima di Dante e Petrarca?
La domanda è facilmente eludibile con un’autogiustificazione accademica: esiste una disciplina chiamata Filologia romanza (i non-laureati-in-lettere spesso la ignorano, ma è, o dovrebbe essere, un cardine della nostra educazione umanistica: lo studio dei testi scritti nelle lingue derivate dal latino) che ha fatto della letteratura provenzale antica la sua principale palestra. La Filologia romanza, e in particolare occitanica, in Italia sta abbastanza bene, specie rispetto ad altri Paesi. In Francia, per dire, è stata praticamente sterminata con la stessa risolutezza che nel Duecento guidò la crociata contro gli eretici albigesi.
Pur nei mala tempora, in Italia si coltivano ancora gli studi di robusta scuola filologica che hanno svelato all’Europa i Trovatori: la monumentale Bibliographie des Trobadours del tedesco Alfred Pillet, del 1933, ancora utilissima, è stata ora ripubblicata e ben aggiornata da Paolo Borsa, Roberto Tagliani e Stefano Resconi (e Stefano Asperti l’aveva già messa in internet). In Italia si pubblicano le migliori edizioni dei poeti di Provenza e i loro commenti più raffinati. Ma di tutto questo al pubblico arriva poco, e ciò non risponde alla domanda da cui siamo partiti.
Tra le risposte possibili, se ne può cercarne una nelle Canzoni occitane di disamore appena pubblicate da Francesca Sanguineti e Oriana Scarpati. Ottimo campo di prova: è un’antologia, felicemente pensata, delle poesie che i trovatori dedicano al tema opposto a quello usuale: non l’innamoramento ma la fine dell’amore. Che significa: constatazione di crudeltà, scorrettezza, venalità o ingenerosità della donna che si è poeticamente servita e riverita. Con le parole di Bernart de Ventadorn: «Mout l’avia gen servida / tro ac vas mi cor volatge; / e pus ilh no m’es cobida, / mout sui fols, si mais la ser» («l’avevo servita molto nobilmente finché non manifestò un animo volubile nei miei confronti, e poiché ella non mi è destinata, sono davvero folle se la servo ancora»).
 Più esplicito e iattante Raimbaut de Vaqueiras: «Ges no pres un botacis / dona que aitals sia / c’un prenda et autre.n lais» («Non apprezzo uno sbuffo una donna che si comporti in modo tale da prendere uno e lasciarne un altro»).
Più esplicito e iattante Raimbaut de Vaqueiras: «Ges no pres un botacis / dona que aitals sia / c’un prenda et autre.n lais» («Non apprezzo uno sbuffo una donna che si comporti in modo tale da prendere uno e lasciarne un altro»).Come accade anche ai non-trovatori, il disamore implica deprecazione dell’amore in sé. Folchetto, con la sua eleganza: «Amor, per so m’en soi eu recresuz / de vos servir, que mais no n’aurai cura; / c’aissi com mais prez’hom laida pentura / de long, no fai cant es de pres venguz, prezava eu vos mais can no.us conoissia» («Amore, per questo ho abbandonato il vostro servizio e non me ne interesserò mai più; perché così come si apprezza maggiormente un brutto dipinto da lontano rispetto a quando è vicino, io vi apprezzavo di più quando non vi conoscevo»).
Più spesso, ci si risolve nella decisione di servire un’altra donna, da cui si spera di avere miglior guiderdone (guizardo). Raimbaut d’Aurenga: «Ar sui partitz de la pejor / c’anc fos vista ni trobada, / et am del mon la bellazor / dompna, e la plus prezada» («ora mi sono allontanato dalla peggiore che esista, e amo la più bella donna del mondo, e la più valente»). Resta il diritto se non proprio d’insultare la precedente amata (ché sarebbe contrario alle regole della cortesia), di esporla al dileggio. Peire Cardenal: «Ia m’amia no mi tenra / si ieu lieys non tenia, / ni ia de mi non iauzira / s’ieu de lieys non iauzia» («la mia amica non mi avrà mai se io non la posseggo, né di me godrà se io non godo di lei»).
Arguto, certo, anche se in fondo poco originale (di rado lo è la poesia medievale, nel senso che intendiamo oggi). Quel che forse è davvero suggestivo per il pubblico italiano - proprio perché familiare, ma altrove introvabile - è ciò cui il lettore di traduzioni non fa caso. Ottima la scelta delle curatrici di mettere una versione a fronte, ma di ridurla all’osso e di scioglierla in prosa, quasi per ricacciare continuamente l’occhio verso il testo originale, scritto in una lingua da cui italiani, francesi e spagnoli d’oggi si sentono allo stesso grado lontani e vicini.
Si capisce perché i pionieri degli studi trobadorici credettero (a torto, si chiarì poi) di vedere in questa lingua la madre comune di tutte quelle neolatine di oggi. Ecco: è forse la lingua dei trovatori - di fatto dimenticata o trascurata per secoli - a regalare il piacere maggiore a chi oggi la legge con occhi diversi da quelli dello studioso: una lingua difficile ma non impenetrabile, straniante e divertente, in cui si sperimenta nel modo più concreto la distanza, e insieme la mirabile familiarità di questi amorosi disamorati.
- Alfred Pillet, Henry Carstens, Bibliographie des Trobadours, rist. anast. con aggiornamenti, a cura di
P. Borsa, R. Tagliani, S. Resconi. Introduzione di M.L. Meneghetti, Ledizioni, Milano, pagg. 614 € 48,00
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- La Scuola siciliana in Lombardia. I testi dei poeti di Federico II diffusi prima nel Nord Italia e poi in Toscana (di Cesare Segre)14 giugno 2013, di Federico La Sala
La Scuola siciliana in Lombardia I testi dei poeti di Federico II diffusi prima nel Nord Italia e poi in Toscana
di Cesare Segre (Corriere della Sera, 13.06.2013)
Negli ultimi mesi, e persino giorni, sono saltati fuori da biblioteche pubbliche e private testi letterari che offrono notizie imprevedibili ed eclatanti sulla cultura letteraria dell’Italia medievale, e in particolare del Nord. Il primo importante ritrovamento è quello di Luca Cadioli, che ha riconosciuto in un manoscritto mutilo, rinvenuto nella soffitta di una casa signorile, l’unica fedele traduzione dal francese, finora sconosciuta, del Lancelot du Lac, il romanzo sugli amori di Lancillotto e Ginevra, di cui ci erano noti solo adattamenti molto liberi.
Quanto all’altra scoperta, il discorso è più complesso. Ci si era fatta l’idea che la Lombardia fosse rimasta sorda a quel fermento straordinario che fu la Scuola poetica siciliana, fiorita nell’isola alla corte di Federico II, e poi risalita lungo lo Stivale sino a trovare un ambiente favorevole nella Toscana predantesca. Si è discusso in altri tempi sui modi in cui questa poesia può essersi diffusa, oltre che attraverso la declamazione di esecutori professionali, o dei poeti stessi, fieri di sfoggiare le loro creazioni.
C’è in effetti una diffusione scritta, attraverso le copie tratte da qualche quaderno o libro d’autore: a noi sono rimasti alcuni canzonieri (detti così perché la canzone è la forma metrica prevalente in questi manoscritti), caratterizzati da un tratto specifico: la toscanizzazione di testi in origine scritti in siciliano.
È in prevalenza tramite questa toscanizzazione che i versi dei poeti della corte di Federico II sono stati conosciuti, tanto che si rimase, a suo tempo, spiazzati nei minimi casi in cui ci si è trovati davanti a una poesia siciliana in lingua originale. Ora un nuovo ritrovamento pare smentire questo scenario.
Ci si domanda il perché di questo improvviso rivelarsi di testi due e trecenteschi. Molto è dovuto a migliori strumenti di analisi. Ma prevale il cambiamento di prospettiva. Se prima il filologo si soffermava sulle pagine dei codici, ora ha imparato a guardare anche alle legature, in cui spesso si usavano, come riempitivo, fogli di altri manoscritti, spesso destinati a questo tipo di riutilizzo perché parzialmente danneggiati. E si fa più attenzione ai documenti di ambito notarile, ben consapevoli del fatto che i notai erano in buon numero poeti.
In effetti c’era già il precedente dei «Memoriali bolognesi», carte notarili dei secoli XIII e XIV in cui gli spazi bianchi, a evitare aggiunte fraudolente, venivano riempiti con poesie contemporanee. E poi, vent’anni fa, Giuseppina Brunetti aveva trovato, in un foglio di guardia di un manoscritto conservato a Zurigo, un frammento di Giacomino Pugliese in una veste linguistica probabilmente veneta.
Ora, Giuseppe Mascherpa, già allievo, come Cadioli, della Scuola di dottorato in Filologia romanza che ha unito le Università di Siena, Milano e Pavia, ha fatto un ritrovamento non meno straordinario dell’altro, nel quadro di una ricerca finanziata dallo Iuss di Pavia e dalla Regione Lombardia: alcune poesie della Scuola siciliana, reperite, in frammenti (le pergamene che le ospitano erano state, al solito, utilizzate per rinforzare la legatura di un codice), presso una biblioteca lombarda.
I fogli pergamenacei ospitano delle sentenze che condannano alcuni esponenti di note famiglie, in prevalenza guelfe, per violazioni delle norme sui tornei; ma negli spazi rimasti bianchi, sul verso delle pergamene stesse, trova posto la trascrizione di almeno quattro testi poetici siciliani ascrivibili ad autori come Giacomo da Lentini, Paganino da Sarzana, Percivalle Doria, e addirittura all’imperatore Federico II (la poesia qui trascritta è in realtà di attribuzione non sicura, dato che un altro testimone la dà a tale Ruggerone di Palermo).
È probabile dunque che queste trascrizioni derivino da un piccolo canzoniere di liriche della Scuola siciliana circolante in Lombardia, ma il dato ancora più importante è che questi componimenti non sembrano giunti attraverso la solita trafila toscana: la lingua dei testi presenta qualche lombardismo, eredità dell’ultimo copista, ma lascia intravedere una veste siciliana che sembra quella del modello. E se si considera che l’analisi paleografica e storica pare suggerire che ci troviamo, all’incirca, tra il 1270 e il 1290, dobbiamo dedurre che queste trascrizioni sono anteriori a quelle offerte dai principali canzonieri toscani.
Per farsi un’idea dei materiali appena ritrovati, riporterò i vv. 11-20 della poesia di Giacomo da Lentini, affiancandola all’edizione dell’unico testimone prima noto (l’illustre canzoniere Vaticano) e aggiungendo una parafrasi moderna.
Le prospettive che questa scoperta apre sono di notevole portata. La Lombardia risulterebbe aver avuto un interesse precoce e di prima mano per la poesia siciliana, cosa che non si poteva nemmeno sospettare: in quest’area sarebbero circolati i testi dei poeti della corte di Federico, in anni ancora anteriori a quelli in cui nasce la moda lirica attestata dai grandi canzonieri toscani. Tutto ciò apre un discorso che potrebbe portarci molto lontano.
P.S. Come accennato, gli autori delle due scoperte si sono entrambi formati presso una scuola di dottorato la cui esistenza, quantomeno nella forma originaria, è ora messa in crisi dalle nuove norme che regoleranno i dottorati di ricerca e che, nel nome di principi d’efficienza puramente quantitativi, obbligheranno, di fatto, ad accoppiamenti tra discipline anche lontane, il che andrà a scapito della serietà scientifica dei progetti e della possibilità di offrire ai dottorandi una formazione davvero specifica e approfondita.
Il nuovo amore cortese che cantavano i notai
Dopo il secondo decennio del Duecento, per opera di Federico II di Svevia, imperatore e poi re dei Romani, nell’Italia meridionale, tra Messina e Palermo, Capua e Napoli, si sviluppa una scuola poetica che trasforma la Sicilia nel centro letterario più attivo dell’epoca. Tra i protagonisti più influenti Giacomo da Lentini, che già Dante considerava il caposcuola della lirica illustre di provenienza siciliana. Altri nomi di spicco sono Stefano Protonotaro, Pier della Vigna e Guido delle Colonne.
All’origine di queste liriche ci sono i modelli trovadorici, incentrati sull’amore cortese nella concezione provenzale e cortigiana dei rapporti amorosi in senso feudale: ovvero un legame tra una donna superba od orgogliosa, distaccata, e un «servo» d’amore che protesta per la sua condizione e chiede pietà.
La Scuola siciliana arricchisce questo schema tradizionale con nuove scelte liriche, linguistiche e metaforiche, grazie al patrimonio di conoscenze scientifiche e retoriche che caratterizzava molti dei poeti che avevano ruoli di spicco nella pubblica amministrazione, in particolare notai. Le forme sono quelle del sonetto, della canzone, della tenzone.
Finora ci si è concentri sull’influenza che la Scuola siciliana ha avuto in Toscana, ma da recenti ritrovamenti è testimoniata anche la sua diffusione nel Nord Italia, in particolare in Lombardia.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- I magnifici sei ispirati da Amore. Un’antologia dei poeti stilnovisti contemporanei di Dante (di Cesare Segre)31 ottobre 2012, di Federico La Sala
I magnifici sei ispirati da Amore
Un’antologia dei poeti stilnovisti contemporanei di Dante
di Cesare Segre (Corriere della Sera, 31.10.2012)
Della scuola poetica toscana fiorita nella seconda metà del Duecento, era ovvio che Dante diventasse il capofila. Si sa che questi poeti seguivano le orme dei rimatori siciliani dell’età di Federico, soprattutto nella predilezione per la tematica amorosa. Stando anche alle testimonianze manoscritte, andrebbero divisi in due gruppi: quello dei poeti siculo-toscani, meno originali, e quello degli stilnovisti, cui si devono grandi innovazioni di lingua e di tematica.
Il nostro istinto classificatorio ci induce a considerare questi due gruppi l’uno successivo all’altro. Invece le date, quando ci sono, attenuano il rigore di questa distinzione: Onesto da Bologna e Bonagiunta, della vecchia scuola, scambiano sonetti e critiche con Guinizzelli e con Cino da Pistoia, Guittone discute con Guinizzelli, e Guido Orlandi con Guido Cavalcanti.
Queste tenzoni poetiche ci introducono nel pieno della polemica sulla poesia, dandoci un’idea dei temi affrontati, e anche delle novità in gioco. Sono polemiche anche interne alle scuole, come quella, importantissima, tra Cavalcanti e Dante, che continua anche nella Commedia. Degna di nota la varietà dei toni, dal rispettoso all’ironico, dal severo all’autorevole. E la gara mette subito in vista le qualità di ogni contendente: a differenza dai nostri blog, non si poteva sgarrare.
Si noti poi che Dante, mentre polemizzava con i rimatori contemporanei, stava elaborando un suo mito personale, cui rapportava le proprie idee di poetica e linguistica, in attesa di giudicare il mondo intero, come farà con la Commedia. La Vita nuova è già una storia della sua poesia sino alla maturità. Insomma, non si può parlare di Stilnovo senza mettere al centro Dante. Solo per opportunità di spazio, di solito si separa Dante dai poeti della sua scuola, e così fa Donato Pirovano, nel bel volumetto della collana «I diamanti» sui Poeti del Dolce Stil novo (Salerno Editrice, Roma, pp. XLVIII-798, € 22).
Non molte, stranamente, le raccolte di questo genere, come quelle di L. Di Benedetto 1939; M. Marti 1969; M. Berisso 2006; ancora meno quelle ancora in commercio. Uno degli ostacoli è la mancanza di un’edizione attendibile di Cino da Pistoia, il più prolifico della scuola; ma si può lavorare lo stesso. E Pirovano ci offre una raccolta praticamente completa e commentata, aiutando il lettore a orientarsi fra le composizioni dei sei poeti raccolti (Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi, Cino da Pistoia).
Ma è esistito lo Stilnovo? Non si tratta di un’ingegnosa ipotesi dei filologi? Certo, non esiste un atto ufficiale di fondazione. Ma Dante era ben consapevole dell’unità del gruppo, e si direbbe che il suo itinerario oltremondano sia concepito in modo da fargli incontrare i colleghi poeti (sempre in Purgatorio, mai in Paradiso!).
Si veda in particolare la lunga conversazione, in Purgatorio XXIV, con il siculo-toscano Bonagiunta, che sconta i suoi peccati di ingordigia (goloso anche lui di «anguille di Bolsena e di vernaccia» come il suo compagno di pena Martino IV?). Dante gli illustra la propria poetica, che consisterebbe, essenzialmente, nel comporre solo sotto l’ispirazione (la «dettatura») d’Amore. E Bonagiunta dichiara che ora finalmente ha capito che cosa è mancato a Guittone e a lui per essere all’altezza del «dolce stil novo ch’io odo».
Del sintagma «dolce stil novo» i filologi hanno fatto un manifesto; certo l’espressione è così felice che sembra inventata apposta, da Dante, per diventare un blasone. Si noti che, al tempo della Commedia, quella scuola era finita. Ma appunto per questo, Dante ne ricostruisce, in vari incontri, le caratteristiche. Per esempio, tra i lussuriosi del Purgatorio (XXVI), Dante ritrova Guinizelli, e lo definisce padre di quanti hanno saputo creare «rime d’amor dolci e leggiadre», cioè degli stilnovisti.
E già il miniatore Oderisi da Gubbio, nell’XI del Purgatorio, aveva confrontato la crescita della fama di Giotto rispetto al prima famoso Cimabue, col superamento di Guido Guinizelli da parte del Cavalcanti. E «forse», dice Oderisi, «è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido»: cioè Dante.
Dunque non solo si parla di poeti o di gruppi di poeti, ma dell’affermarsi e del decadere dei canoni: come fa Guinizelli parlando anche di Arnaldo Daniello e di Guittone e del segmento di civiltà letteraria che li aveva uniti. La forte coscienza di sé non cancellava certo nella mente di Dante la consapevolezza che la poesia ha una storia, di cui lui stesso si era fatto guida e garante.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- L’ombra di Narciso uccide la passione. Maria Bettetini, Quattro modi dell’amore (di Gillo Dorfles).4 ottobre 2012, di Federico La Sala
Maria Bettetini, Quattro modi dell’amore
L’ombra di Narciso uccide la passione
di Gillo Dorfles Corriere della Sera, 04.10.2012)
Che gli aspetti, le caratteristiche dell’amore siano quattro (o saranno una quarantina?) fatto sta che un argomento come questo non può che affascinare. Ed è con grande sottigliezza e coraggio che Maria Bettetini ha affrontato questo capitolo, a un tempo affascinante e pericoloso (Quattro modi dell’amore, Laterza, p.140, 14). Solo una studiosa della serietà e insieme dell’acutezza della Bettetini poteva avere il coraggio di compiere un viaggio a partire dall’antica Grecia (che le è particolarmente vicina) fino a giungere ai nostri giorni, analizzando i diversi autori che ne hanno trattato e soprattutto i diversi «personaggi» della lunga catena amorosa.
Se poi le «categorie amorose» siano davvero soltanto quattro nessuno potrà affermarlo o negarlo, giacché questo vocabolo vuoi nella sua versione maschile (amor, ljubav, love, eccetera) che in quella femminile (Liebe) (chissà perché questo diverso genere a seconda dei linguaggi?) non toglie che nessuna altra parola, anzi diciamo meglio nessun «sentimento», ha dato luogo ad altrettanta esaltazione, dispute, depravazioni. E non c’è dubbio che i «quattro modi», messi in luce dall’autrice ci dicono quante diverse sfumature presenti un termine che si adatta sia al dolce affetto materno sia a quello spesso invidioso fraterno, sia a quello orgoglioso del patriota, sia a quello morboso del nevrotico.
Che poi l’amore non possa essere analizzato senza indagarne gli aspetti materiali e sessuali appare un luogo comune ed è un lato positivo dell’analisi della Bettetini. Che, giustamente, ha proceduto senza servirsi degli ormai spesso tortuosi meandri di una psicoanalisi superata, né in quelli di morbosità sin troppo manovrate; con l’immancabile codazzo di omosessualità vuoi esaltate che vilipese.
Quello comunque che costituisce il maggiore pregio del saggio non è solo nell’aver fatto rinverdire i classici personaggi amorosi dell’antichità come dei nostri tempi - da Ulisse a Enea, da Adamo a Eva, da Ifigenia a Patroclo, da Menelao a Oreste - quanto di aver dato uno sguardo d’insieme ad alcune delle più note «sintesi amorose» della letteratura da Ovidio al Petrarca, da Omero a Proust, da Freud a Jung, da Saffo a Virginia Woolf.
Ma, giunti a questo punto, si potrebbe chiedersi se sia davvero lecito parlare di «quattro modi dell’amore», quando, anche nel più elementare degli stessi, le varanti sono infinite: si pensi soltanto entro i limiti della famiglia quale diversità amorosa esista tra l’amore materno e quello paterno, tra la amicizia quotidiana dei fratelli e le gelosie tra maschi e femmine d’una stessa covata. E, fuori dai limiti dell’amore familiare, si pensi alla camaraderie tra campioni sportivi, alla ambigua fratellanza degli atleti o dei professionisti; per giungere finalmente a quell’«amore per la divinità» di cui si è discusso come se fosse di dominio comune, mentre quasi sempre copre un lato patologico, la sua impostazione psicologica legata a dottrine e a culti ormai scaduti; ma spesso patologicamente recuperati.
Ma, accanto agli amori gioiosi e gaudiosi, e a quelli appassionati, ed esaltati, esiste tutta una serie di amori che vanno oltre il segno e che invadono l’ambito della patologia e si trasformano in delirio, martirio, crudeltà. Sono quelli che l’autrice definisce gli «amori estremi» e i «falsi amori».
Ne abbiamo, e ne abbiamo sempre avuti, esempi anche clamorosi: dalla spietata gelosia che trasforma la passione in segregazione e in carcere; dalla tenenza masochistica per la quale l’amore si accompagna alla sofferenza del partner; fino ai diversi gradi d’una passionalità che diventa minaccia.
Del resto anche l’amore per la divinità, quando si trasforma in autoflagellazioni o in altre forme di autotorture, dal digiuno alle sevizie autoimposte, non può certo essere considerato come appartenente a una vicenda amorosa, ma piuttosto come una delle tante derivazioni psicopatologiche della fede e del culto sacro.
Ma, da ultimo, tentiamo ancora un approccio all’«amore per noi stessi». Non certo a imitazione del Narciso greco, ma piuttosto di quello del «Narcissum» freudiano. Certamente l’impulso all’autoerotismo ben noto; ma piuttosto che da un punto di vista sessuale, vorrei riferirmi a un amore platonico che ammira se stessi non solo con compiacenza ma con vera «passione».
Ebbene, ritengo che il numero degli individui per i quali il «se stesso» è al di sopra di quello d’ogni altra persona sia davvero preoccupante; l’importanza, la compiacenza rivolta alla propria persona, alle proprie qualità; persino ai propri difetti, è tale da obnubilare molto spesso una oculata visione del prossimo. Un po’ più di «amore per il prossimo» credo che sarebbe il vero «trionfo dell’amore».
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- 2013: PER BOCCACCIO, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!!24 maggio 2012, di Federico La Sala
 LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ...
LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ...
 PER BOCCACCIO, NEL 2013, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!! Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico. Materiali sul tema
PER BOCCACCIO, NEL 2013, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA!!! Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico. Materiali sul tema
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- Provenzali e romantici, così abbiamo idealizzato il soggetto amoroso. Luisa Passerini racconta la nascita dei modelli sentimentali (di Simonetta Fiori)15 settembre 2012, di Federico La Sala
 I nostri miti
I nostri miti
 La studiosa Luisa Passerini, che nei suoi saggi di storia culturale si è occupata del tema, racconta la nascita dei modelli sentimentali
La studiosa Luisa Passerini, che nei suoi saggi di storia culturale si è occupata del tema, racconta la nascita dei modelli sentimentali
 Anche nei classici indiani e cinesi ci si innamora ma questo non è così rilevante per la costruzione dell’identità
Anche nei classici indiani e cinesi ci si innamora ma questo non è così rilevante per la costruzione dell’identità Provenzali e romantici, così abbiamo idealizzato il soggetto amoroso
Provenzali e romantici, così abbiamo idealizzato il soggetto amoroso di Simonetta Fiori
(la Repubblica, 15.09.2012)
di Simonetta Fiori
(la Repubblica, 15.09.2012)In che modo sentimenti, passioni, emozioni, affetti entrano nel recinto nobile della disciplina storiografica? L’amore, in sostanza, si può storicizzare? «Non solo si può, ma si deve», risponde Luisa Passerini, studiosa dalla fisionomia singolare, una delle poche ad essersi avventurata in un territorio impervio, tra molti riconoscimenti internazionali e non altrettanti nazionali. Classe 1941, una lunga esperienza tra l’Istituto Europeo di Firenze e l’Università di Torino, un nome importante per la cultura femminista, è ora in partenza per New York dove tra qualche settimana comincerà alla Columbia University un corso sull’amore. «Sì, in Italia ci sono difficoltà maggiori. La storia culturale ha da noi poca cittadinanza ». I suoi libri - come Storie d’amore e d’Europa, L’Europa e l’amore - intrecciano immaginario amoroso e identità culturali nel corso del Novecento, con radici che risalgono alla tradizione cortese e all’amor romantico, su cui Passerini ha molte cose da dire. Fuori dai sentieri più conosciuti.
Come fa uno storico a studiare l’amore?
«Noi non possiamo osservare l’amore come istinto “naturale”, il sentimento in sé, ma vediamo sempre delle costruzioni culturali, ossia i discorsi sull’amore. Sono fondamentali due prospettive: quella di lunga durata e quella comparativa».
E cosa ha scoperto?
«Che sull’amore ci sono molti pregiudizi. Prendiamone uno, quello che mi sta più a cuore: la pretesa esclusività europea di un certo tipo di relazione, che è quello rappresentato dalla coppia uomo-donna unita da un rapporto paritario. Per un lungo periodo si è ritenuto che questa concezione dell’amore distinguesse il nostro continente dal resto del mondo, segnato nell’Oriente asiatico da una marcata subalternità femminile. Questo preteso primato si traduceva - talvolta ancora si traduce - in una pretesa superiorità. Se però guardo le cose in una prospettiva comparativa, cambia completamente il quadro».
In che modo?
«Gli studi antropologici mostrano che sul piano del sentimento d’amore c’è una forte differenza tra l’Eurasia e l’Africa nera, dove il discorso amoroso è molto meno sviluppato».
Che cosa intende? C’è poca letteratura?
«Esiste un rapporto molto stretto tra amore, discorso amoroso e alfabetizzazione, intendendo con questo termine la cultura scritta. Gli studiosi hanno rilevato che nelle culture africane esclusivamente orali c’erano poche canzoni d’amore, quasi non esistevano».
Quindi la scrittura alimenta l’amore. Allora aveva ragione La Rochefoucauld...
«Sì, disse che ci si innamorerebbe molto meno se non si fosse mai sentito parlare d’amore. In parte è vero. Se io leggo molti romanzi sentimentali è più facile che mi innamori, perché riconosco le mie emozioni e mi sento legittimato a coltivarle. Però non è vero che in un’altra cultura, sprovvista di una letteratura scritta, nessuno s’innamori: si esprimerà attraverso il disegno o la musica, oppure con un dono».
La letteratura produce sentimento. Ma anche il sentimento amoroso può innescare cambiamenti linguistici.
«Il caso dell’antica Provenza è interessante, perché è cultura di transizione tra l’orale e la scritta. Un grande antropologo, Jack Goody, ha detto che l’amore è una potenzialità psicologica universale, ma questa non s’è espressa ovunque allo stesso modo. Dipende da tante circostanze».
Lei ha fatto riferimento all’Eurasia, come a una estesa geografia unita da una concezione simile dell’amore. Questo implica la rottura dello stereotipo secondo cui l’idea che fonda l’amor cortese sarebbe stata un’invenzione esclusivamente europea.
«Sì, dalla metà del XVIII alla metà del XX secolo molti intellettuali hanno ritenuto che la poesia provenzale rappresentasse l’origine non solo della poesia europea, ma anche di un modo specifico di amare e di definire l’individualità e la coscienza. Questo è stato poi corretto da chi ha mostrato le diverse influenze. Prendiamo i poemi d’amore prodotti dai beduini della penisola arabica tra il VII e il VI secolo a.C.: anche questi sono fondati sulla irraggiungibilità della persona desiderata. Non si può escludere che in un periodo successivo - attraverso la Spagna musulmana - gli stessi motivi si siano diffusi fino a innestarsi nella produzione trobadorica».
In sostanza il modello ritenuto fondante del sentimento amoroso europeo - ossia la tradizione dell’amor cortese - sarebbe nato in Arabia?
«Non lo sappiamo con certezza, ma le influenze e le corrispondenze sono state diverse. Potrei fare anche l’esempio della Storia di Genji, il romanzo giapponese scritto da una dama di corte nell’XI secolo. Anche qui affiora il motivo dell’inaccessibilità dell’amore».
La distanza dell’amata è un tema fondamentale dell’amor cortese.
«Sì, là nascono i termini che permarranno nella tradizione del dialogo amoroso. I provenzali lo chiamavano amor de lohn, amore da lontano, e questa lontananza può essere sociale o geografica. Un motivo che ritroviamo nel romanzo romantico, con l’idealizzazione dell’oggetto amoroso. Ma c’è una fondamentale differenza tra l’amor cortese e quello romantico, inteso come lo intendiamo noi oggi».
Cosa vuol dire?
«Amore romantico è diventato un’espressione che non fa riferimento specifico all’epoca romantica, ma a un atteggiamento che si pretende universale e che si collega al matrimonio eterosessuale. L’amore cortese non è eterosessuale, un termine che allora non significava niente. La parola omosessuale acquisterà un significato a partire dall’Ottocento. Nella poesia trobadorica non c’era ancora il legame tra identità e scelta sessuale».
C’erano anche trovatrici donne che cantavano per l’amata.
«Non solo. L’amore cortese non esclude la pratica amorosa tra uomini né tra donne. Ma da un certo momento in poi è prevalsa un’interpretazione rigida che ha fatto di questa tradizione letteraria l’epitome delle relazioni eterosessuali. Questo spostamento è corrisposto all’irrigidimento dell’identità europea».
In che modo?
«A partire dalla fine del Settecento il soggetto sia dell’identità europea sia del discorso amoroso diventa un soggetto maschio, bianco e cristiano. E dobbiamo aspettare i movimenti femministi e quelli di liberazione culturale a partire dagli anni Sessanta del Novecento per dire che il soggetto può essere una donna, un ebreo, un nero o un musulmano. Io riconduco questo irrigidimento al fatto che perdiamo di vista i grandi scambi culturali».
Ma lei poi riconosce una specificità alla cultura europea.
«Sì, in nessuna cultura come la nostra è stata usata l’idea dell’amore per rappresentare la propria identità. Anche nella cultura classica indiana o cinese ci si innamora, ma questo non è così rilevante per la costruzione della propria immagine».
Dai suoi libri si ricava anche l’ostilità degli europei verso il “flirt”, liquidato come una pratica americana.
«Dopo l’approvazione del divorzio negli Stati Uniti, li si accusava di aver distorto l’amore di coppia. E la passione di ascendenza romantica rischiava di essere ridotta a un flirt, ossia a una giocosità che contrastava con lo spirito originario dell’amore».
Questo tratto veniva ricondotto da Denis de Rougemont, l’autore di L’amour et l’Occident, al rapporto con la morte.
«Qui ritorna sotto altre vesti il tema dell’irraggiungibilità. Rougemont faceva riferimento al mito di Tristano e Isotta, che si ricongiungono solo nella morte. La fusione si può realizzare solo nell’aldilà, perché non si diventa mai uno, si resta sempre due. Anche nell’estremo sforzo di identificazione, l’individuo rimane un’altra persona, perché in caso contrario si perderebbe la stessa idea di amore».
Lei perché ha scelto di studiare questo tema?
«Oggi alcuni stereotipi sono venuti meno, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Mi piace pensare che le mie storie possano contribuire a stemperare molte rigidità».
-
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- Ars amatoria, L’arte di amare. Istruzioni per sedurre. Il manuale di Ovidio (di Nuccio Ordine - Astuzia e passione: le schermaglie d’amore).24 maggio 2012, di Federico La Sala
 Istruzioni per sedurre. Il manuale di Ovidio
Istruzioni per sedurre. Il manuale di Ovidio
 Astuzia e passione: le schermaglie d’amore
Astuzia e passione: le schermaglie d’amoredi Nuccio Ordine (Corriere delal Sera, 24.05.2012)
«Prima fatica, o tu che vieni all’armi,/soldato nuovo per la prima volta,/è cercare colei che vuoi amare;/quindi piegarla con le tue preghiere;/per ultimo, far sì che il vostro amore/possa durare a lungo»: in questi versi, collocati nel proemio del primo libro, Ovidio sintetizza la materia discussa nella sua Ars amatoria, L’arte di amare (1 a.C.-1 d.C.).
Nelle vesti di «maestro dell’amore lascivo» (praeceptor amoris lascivi), il nostro poeta si propone di insegnare le raffinate arti della seduzione amorosa («Se c’è tra voi chi non conosca ancora l’arte d’amare/legga il mio poema»): i precetti da seguire per andare a caccia di donne riguardano i luoghi dove cercarle per poi sceglierle e assoggettarle (I libro) e le strategie per mantenerne a lungo la conquista (II libro). Un’ultima parte, aggiunta successivamente, si rivolge invece alle stesse donne («La causa vi dirò che vi perdette:/vi mancò l’arte, non sapeste amare») per insegnare loro come attrarre un uomo e avvincerlo con sicuri nodi (III libro). Tra i destinatari non figurano i ricchi che comprano l’amore solo con i doni («Io precetti non do d’amore ai ricchi»).
Lontano dalle pene e dagli strazi dell’amore-passione cantato nell’elegia (da cui, però, Ovidio riprende il metro composto da distici: un esametro e un pentametro) e sotto forma di un’opera didascalica (di cui, invece, scarta l’esametro, sua forma espressiva per eccellenza), il poema si presenta al lettore nelle sue vesti di genere ibrido, di manuale per uomini e donne che aspirano alle avventure d’amore.
L’Ars amatoria, insomma, rivendica già nel titolo il suo ruolo: Ovidio vuole presentarla come una vera e propria «arte», come una tecnica fatta di regole e di prescrizioni. Pilotare una nave («Solcano l’onde con le vele o i remi,/sospinte ad arte l’agili carene») o guidare un carro («con arte noi guidiamo il lieve cocchio») richiedono un’abilità fatta di norme. Lo stesso accade nel complicato e complesso universo della seduzione amorosa («con arte dunque è da guidarsi Amore!»), in cui spesso ricorrono le comparazioni con altre artes: quella della caccia (fondata sulla cattura della preda), quelle della navigazione o dell’agricoltura (basate sulla conoscenza delle stagioni), quella della medicina (attenta alla scelta dei tempi).
Ma la prima abilità del seduttore risiede nella conoscenza di una regola «universalissima», che secoli dopo Baldassarre Castiglione chiamerà «sprezzatura»: «Giova l’arte, è vero,/ma solo se nascosta: quando appare,/reca vergogna e toglie poi per sempre/ogni fiducia nelle tue parole». Bisognerà parlare con eloquenza occultando l’eloquenza («Ma nascondi/questa tua forza, non far pompa inutile/della facondia»), pettinare i capelli dando l’impressione di non averlo fatto e truccarsi senza ostentare creme e unguenti («L’arte che vi fa belle sia segreta»).
L’universo amoroso, dominato dalle simulazioni e dalle dissimulazioni, presuppone una faticosa militanza che si fonda soprattutto sull’ingannare chi ci inganna. Il seduttore o la seduttrice debbono saper recitare in ogni occasione: fingere di essere ebbri (mentre sono sobri), di essere amici dei mariti (mentre lavorano per disonorarli), di piangere (mentre avrebbero voglia di ridere), di ridere (mentre avrebbero voglia di piangere). E se è vero che «Venere aiuta e la Fortuna insieme/chi sappia osare» (audentem Forsque Venusque iuvat), è anche vero che molto spesso chi tende trappole e lacci può finire vittima dei suoi stessi inganni. Per Ovidio ciò che conta è il «conoscere se stessi». Nell’Ars amatoria il precetto delfico (Nosce te ipsum) non viene piegato solo a generiche funzioni amorose («Solo chi si conosce saprà amare/e misurare al compito le forze»), ma diventa una preziosa guida pratica per le posture erotiche («E dunque cerca/di conoscerti bene; usa posture/secondo le tue forme:/non a tutte giova lo stesso modo»).
Nei versi finali, però, Ovidio rivela che il «suo gioco è finito» (Lusus habet finem). Ogni regola, infatti, dovrà fare i conti con il mutevole universo dell’amore. Se «tanti sono i volti/quanto nel mondo son diversi i cuori», bisognerà essere capaci, come Proteo, di adattarsi alle metamorfosi. E forse della lezione si ricorderà don Alfonso in Così fan tutte di Mozart: se «mille volte al dì cangiano amore», la colpa non è né delle donne, né degli uomini, ma di una naturale «necessità del core».
 Spregiudicato e moderno
Spregiudicato e moderno Corriere della Sera, 24.05.2012
Corriere della Sera, 24.05.2012Sabato prossimo in edicola con il «Corriere della Sera» esce L’arte di amare del poeta latino Ovidio, celebre opera sull’attività amatoria, sulla seduzione e sul piacere, che costò all’autore l’esilio da Roma al Mar Nero, fino alla morte. Come ricorda Eva Cantarella nella prefazione inedita al volume, in quel tempo Ottaviano Augusto moralizzava l’Impero con una legge che puniva l’adulterio con l’esilio: ne era stata vittima anche la figlia dell’imperatore, Giulia. E il bando di Ovidio può ben essere dovuto alle parti dell’opera in cui il poeta, dopo i consigli agli «amatori», uomini e donne, offre anche suggerimenti per gli adulteri. È il poeta dei Fasti e degli Amores, e soprattutto delle meravigliose Metamorfosi, e in questo libro, spiega Cantarella, «quel che colpisce è la modernità con la quale Ovidio declina a suo modo i temi dell’etica sessuale romana». Tuttavia a rendere sgradito il poeta all’imperatore può esser stata proprio la frequentazione con gli ambienti vicini alla figlia Giulia, in odor di cospirazione contro il severo governo del padre. (i.b.)
-
> UNA BANCA DATI SUI POETI MEDIOEVALI: IL DIZIONARIO EMOTIVO DELLA LIRICA AMOROSA. Il piacere della parola e le parole del piacere.... all’interno del pensiero cristiano: l’amore diventa charitas, fino all’amor «che muove il sole e l’altre stelle»» (di Simonetta Fiori).14 maggio 2011, di Federico La Sala
Una ricerca e una banca dati sull’affettività nei poeti medievali
Il dizionario emotivo della lirica amorosa
Una mappatura europea che va da "gioia" a "felicità"
La presentazione oggi ai Lincei
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 13.05.2011)
"Gioia" è la parola più ricorrente, seguita da «soffrire», «piacere» e «dolore». Nel lessico europeo delle emozioni, alla «felicità» spetta l’indiscusso primato. Ma che tipo di felicità intendiamo? Prima di soffermarci sulle implicazioni sessuali della gioia, è necessario introdurre la ricerca che sarà presentata oggi pomeriggio all’Accademia dei Lincei. Quali sono le parole affettive che più ricorrono nelle varie lingue e culture del nostro continente? Un primo passo nella definizione di questo dizionario emotivo è segnato da una preziosa mappatura realizzata da diverse università italiane ed europee mettendo a confronto diecimila testi della lirica romanza medievale, suddivisa nelle diverse tradizioni «nazionali»: provenzale, francese, galego-portoghese e antico-italiano (fino a Petrarca). Questa mappatura è in corso di definizione, ma la novità è costituita dalla creazione dell’unica banca dati della lirica medievale romanza.
Ma che cosa s’intende per emozioni? «Prima abbiamo dovuto perimetrare l’oggetto della ricerca», spiega Roberto Antonelli, ordinario di Filologia romanza, già autore di una ricerca sul canone europeo e ora coordinatore del progetto sul lessico dell’affettività (a cui hanno collaborato anche Rocco Distilo, Paolo Canettieri, Mercedes Brea, Lino Leonardi). «Nelle scienze sociali non c’è accordo su cosa siano le emozioni. Il rischio era quello di forzare dentro categorie moderne il lessico affettivo cortese, che risponde a paradigmi psicologici e culturali diversi». Alla fine, nel confronto con la tradizione filosofica classica e cristiana, sono state selezionate quattro grandi categorie emozionali Gioia, Afflizione, Paura, Ira a cui è stata aggiunta quella della Cupiditas, ovvero il desiderio, «che svolge un ruolo fondamentale nella rappresentazione dell’affettività e della psicologia cortese».
Il piacere della parola e le parole del piacere. Quali considerazioni se ne possono ricavare? «Siamo in presenza», spiega Antonelli, «di una concezione amorosa molto articolata che si distingue in due filoni. Un filone molto consistente è legato all’amore sensuale: la parola «joi» per la maggior parte delle volte è gioia sessuale, felicità del corpo fisico; così la parola «guiderdone» è la ricompensa sessuale dovuta dalla donna al servente leale (rimossa in Cavalcanti e Dante).
L’altro filone che porta appunto a Dante tenta di ricomprendere l’amore cortese all’interno del pensiero cristiano: l’amore diventa charitas, fino all’amor «che muove il sole e l’altre stelle»». Il lessico affettivo cambia a seconda dell’area culturale di appartenenza e a seconda del genere poetico usato. «Nella poesia galego-portoghese», continua Antonelli, «la parola «amor» si accompagna più frequentemente a «coita» («pena d’amore»), mentre nella lirica dei trovatori provenzali il termine che più ricorre accanto ad «amor» è «fin» ossia «perfetto»».
A conferma d’una maggiore mestizia dell’area portoghese interviene anche un’altra circostanza. Se nella lirica dei trovatori l’emozione più ricorrente è «joi» seguita da «sofrir», «plazen» e «dolor» nella lirica galego-portoghese la tonalità prevalente è l’afflizione. Ai poeti portoghesi è tuttavia sconosciuta l’angoscia, molto presente nella poesia amorosa cortese, dai trovatori ai poeti siciliani. «Angoscia», illustra Antonelli, «è uno dei termini che esprimono la condizione dolorosa dell’amante.
Nella poesia provenzale, come poi in quella italiana prestilnovista, è adoperato - oltre che in senso di generica sofferenza - nell’accezione di assillo del desiderio che non viene corrisposto. Nella lirica antico francese «angoisse» s’incontra con una frequenza maggiore, ma il significato è quello di dolore continuo e opprimente. L’angoscia si carica di risonanze inedite nella poesia di Cavalcanti, dove diviene uno stato di prostrazione psichica. Viene anticipata per molti aspetti l’angoscia novecentesca».
È già possibile fare una comparazione tra la lirica medievale e la poesia contemporanea? «Lo potremo fare solo in un secondo momento, perché per la lirica moderna mancano strumenti analoghi a quelli che abbiamo realizzato per la lirica medievale. Ma esistono già alcune banche dati su cui si può lavorare».
-
> L’AMORE E LA PAROLA. ---- L’ombra di Cavalcanti in Dante, un ricco e complesso saggio di Noemi Ghetti (di Maurizio Cucchi - Dante e la sua ombra).31 marzo 2011, di Federico La Sala
Dante e la sua ombra
di Maurizio Cucchi (La Stampa, 31.03.2011)
Guido Cavalcanti e Dante sono autori scrutati con passione e acribìa da sette secoli. Eppure continuano a invitarci a nuove indagini e approfondimenti. Lo vediamo nel ricco e complesso saggio di Noemi Ghetti, L’ombra di Cavalcanti in Dante (L’asino d’oro edizioni, pp. 230, 18), nel quale l’autrice compie un viaggio che parte dai poeti della Scuola siciliana, passando attraverso l’esperienza dei siculo-toscani, di Guinizzelli, senza dimenticare, sullo sfondo, i trovatori provenzali, per poi muoversi decisamente nei diversi passaggi di pensiero, vita e opera dei due grandi in questione. E producendo anche, in appendice, una sostanziosa antologia dei testi.
È il tema d’amore e della donna, il rapporto tra amore e conoscenza, nella varietà delle espressioni, a dominare la scena, mentre si andava «formando quella fitta rete di memorie intertestuali, echi, reminiscenze [...], riapparizioni di temi, sintagmi, parole chiave [...], che, tessuta di poeta in poeta, fu infine magistralmente rielaborata nel Canzoniere del Petrarca». È insomma il cammino che porta al crearsi di una tradizione che arriva fino a noi e che è quello della nostra grande poesia lirica.
Una poesia che si nutre profondamente di pensiero, come vediamo nel fondersi di poesia e filosofia dei grandi autori del ’200. E la figura della donna, della donna-angelo (che arriverà fino a Montale) è presente secondo diverse declinazioni dai siciliani a Dante, che ne farà infine un simbolo di mediazione tra uomo e Dio, mentre nell’altro grande, Guido Cavalcanti, l’amore è «passione che vive nell’oscurità, incomprensibile all’intelletto», che, come è detto in Donna me prega , «imaginar nol pote om che nol prova».
Il sodalizio tra i due poeti durerà un decennio, tra il 1282 e il 1292, prima che i loro percorsi intellettuali prendano strade diverse. Quella, umanissima, di Cavalcanti senza il conforto di un’ideologia definitiva, quella di Dante nella grandiosa costruzione del poema divino. Con la presenza costante, in lui, dell’«ombra» del nobilissimo amico, come ci dice Noemi Ghetti nel suo coinvolgente libro.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. ---- I VOCABOLI DEL DESIDERIO PIENO DI GRAZIA ("CHARITAS") E I VOCABOLI DEL DESIDERIO PIENO DI "MAMMONA" E "MAMMASANTISSIMA" ("CARITAS").7 ottobre 2010, di Federico La Sala
RIPARARE IL MONDO. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.
Sesso e corpo: i vocaboli del desideriodi Gianfranco Ravasi (Corriere della Sera, 06.10.2010)
È suggestivo osservare che il vocabolo ebraico del desiderio sessuale, teshuqah, che nella Genesi rappresentava l’oscura pulsione sessuale («Verso tuo marito sarà la tua teshuqah / desiderio, ed egli ti dominerà», 3,16), nel Cantico viene riproposto come segno di donazione e di comunione totale: «Io sono del mio amato e la sua teshuqah / desiderio è verso di me» (7,10).
Certo, il desiderio non elide la sua componente sessuale ed erotica, come appare nelle stupende rappresentazioni dei corpi dei due innamorati (capitoli 4; 5; 7). Anche Pio XII, in un discorso del 29 ottobre 1951, affermava: «Il Creatore stesso ha stabilito che nella reciproca donazione fisica totale gli sposi provino un piacere e una soddisfazione sia del corpo sia dello spirito. Quindi, gli sposi non commettono nessun male cercando tale piacere e godendone. Accettano quello che il Creatore ha voluto per loro».
La sessualità e l’eros devono però inserirsi nella donazione d’amore che trasforma e trasfigura il desiderio facendolo tendere a quella pienezza, totalità, assolutezza che la donna del Cantico esprime nella sua «professione d’amore»: «Il mio amato è mio e io sono sua. Io sono del mio amato e il mio amato è mio» (2,16; 6,3). La tensione rimane perché la creatura umana è fragile e può contaminare la purezza assoluta della donazione. Questa tensione, però, è anche positiva.
Infatti, il desiderio di sua natura rimane sempre mobile e dinamico, e dev’essere conservato anche in questa sua qualità: essa è ben rappresentata dallo stupore e dalla tenerezza, che brillano soprattutto nello sbocciare dell’amore. Il desiderio dovrebbe saper mantenere continuamente questo clima di dolcezza, questa sorta di «stato nascente» dell’amore che ne rivela la vitalità, ma anche il suo non essere un possesso acquisito.
Come si è già detto, pur nell’abbraccio, la coppia del Cantico sa che sempre deve correre verso «i monti dei balsami» (2,17; 8,14). Si intuisce, così, anche nel desiderio dell’amore umano, quell’ «insoddisfacibilità» che è tensione verso l’assoluto e l’infinito: è l’«inquietudine» agostiniana che può «riposare» solo nella trascendenza e quindi in Dio.
Per questo possiamo parlare di «simbolicità» del desiderio: esso vive nella realtà concreta, presente e temporale, ma al tempo stesso si protende verso l’Altro, l’Oltre, lo Spirito, l’Eterno. Lacan, che al desiderio ha dedicato un’analisi interessante (basata sulla nostalgia del bambino separato dalla madre), connettendosi proprio al linguaggio simbolico, dichiarava: «Se bisogna fondare la nozione dell’Altro con una A maiuscola come il luogo della parola, bisogna affermare che, essendo l’uomo un animale in preda al linguaggio, il suo desiderio è il desiderio dell’Altro».
La storia umana è scandita da grandi desideri che, come il mare è composto da tante gocce, si costruiscono e si sviluppano a partire da singoli desideri personali. Si ha, in tal modo, una tensione universale e costante non solo «verticale» nel procedere oltre che è propria del desiderio, ma anche «orizzontale» fra desideri opposti, negativi e positivi. È quello che è illustrato a livello generale dalla Città di Dio agostiniana ed è anche ciò che, nel microcosmo del singolo, ha descritto sant’Ignazio di Loyola nella sua parabola delle «due bandiere»: esse hanno schiere opposte di seguaci, in marcia verso mete antitetiche, spinti dai loro desideri.
La dinamica della storia universale e di quella personale presuppone, dunque, anche uno scenario tenebroso. Ai figli della luce si accostano e si oppongono i figli delle tenebre, alla tavola luminosa del desiderio dell’amore si allinea in un dittico anche la tavola notturna del desiderio degenerato che tende verso il negativo, l’abisso infernale. Anche la Bibbia raffigura in modo plastico questo desiderio cieco, indomabile e dotato di un suo insaziabile dinamismo, di un’insoddisfazione inestinguibile.
Pensiamo, per esempio, al racconto - straordinario anche a livello psicologico - della passione cieca di Ammon che lo conduce allo stupro di una sua sorellastra, la bellissima Tamar, figlia di suo padre, il re Davide: «Ammon afferrò Tamar e le disse: Dài, unisciti a me, amore mio! E lei: No, fratello mio, non farmi violenza! Non commettere questa infamia! Egli però non ne volle sapere: era più forte di lei e la violentò unendosi a lei. Ma dopo l’atto, Ammon provò verso di lei un odio grandissimo, l’odio che sentiva verso di lei era ben più potente dell’amore con cui l’aveva prima amata» (si legga l’intero testo 2 Sam 13, 1-17).
La brutalità della pulsione insita nel desiderio affiora spesso nelle narrazioni bibliche: le scene di Sodoma (Gen 19) e di Gàbaa, quest’ultima ancor più truculenta (Gdc 19), descrivono le crude e brutali passioni come pure le violente e infami pulsioni degli uomini della steppa che ancor oggi si ripetono nei deserti metropolitani.
E la donna non fu più una cosa
di Armando Torno (Corriere della Sera, 06.10.2010)
Nel libro dell’Esodo (20,17) si legge: «Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa appartenente al tuo prossimo». Un comandamento ribadito in una formulazione successiva nel libro del Deuteronomio (5,21), con alcune varianti.
Se nell’Esodo il primato spetta alla «casa» ( bêt), intesa nella sua dimensione globale che va oltre quella dell’edificio, nel Deuteronomio la donna è estrapolata dall’asse patrimoniale e acquista una posizione autonoma, anzi un primato distintivo: «Non desiderare la moglie del tuo prossimo» precede ed è separato dalla «brama» per le proprietà del capofamiglia. Non a caso l’autore sacro muta il verbo del «desiderio», introducendo la radicale ’wh che denota una maggiore avidità e materialità.
Queste osservazioni, con le varianti linguistiche e i relativi significati, si trovano nell’ultimo saggio di Gianfranco Ravasi che, con Andrea Tagliapietra, ha scritto per Il Mulino (nella serie dedicata ai comandamenti) Non desiderare la donna e la roba d’altri (in libreria domani, 7 ottobre, pp. 160 e 12).
Ravasi, che ha appena pubblicato da Mondadori Questioni di fede. 150 risposte ai perché di chi crede e di chi non crede ( pp. 266, 19) intervenendo sulle domande più spinose e cruciali, nonché su interrogativi insoliti e curiosi, ha intitolato il suo scritto per il libro de Il Mulino Non desidererai la moglie e la casa del tuo prossimo; Tagliapietra, invece, L’ultima delle dieci parole ovvero non desiderare.
Dalla nuova interpretazione del comandamento scritta da Ravasi per l’editrice bolognese offriamo in anteprima un estratto riguardante l’«oggetto del desiderio». Sì, il desiderio. Se per Aristotele nel De anima rappresenta «l’appetizione di ciò che è piacevole», Heidegger in Essere e tempo l’ha connesso ontologicamente alla natura dell’uomo, mentre Spinoza incantò romantici e idealisti con la definizione dell’Etica: «La tristezza che riguarda la mancanza della cosa che amiamo».
Ravasi in Non desidererai la moglie e la casa del tuo prossimo ricorda che il desiderio è una delle componenti capitali e positive della spiritualità biblica, anche se per la fede continua a conservare un’ambiguità.
Del resto, nella Prima Lettera di Giovanni (2,16) si legge il monito contro la bramosia che lo ha trasformato in concupiscenza. Senza la quale, tuttavia, per Oscar Wilde, la vita si riempirebbe di sbadigli. Ha scritto in Lady Windermere’s Fan: «Preferisco le donne con un passato. La loro conversazione è sempre così maledettamente divertente».
-
> L’AMORE E LA PAROLA. ---- Fernanda Alfieri, "Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità. Secoli XVI-XVII". Rec. di Adriano Prosperi - L’altro kamasutra scritto da un gesuita).1 ottobre 2010, di Federico La Sala
L’altro kamasutra scritto da un gesuita
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 01.10.2010)
Anche la cultura cristiana ha avuto il suo Kamasutra. Per secoli la scienza del sesso è stata una scienza ecclesiastica. Confessori e direttori di coscienze, messi a guardia del peccato della lussuria e delle infrazioni capitali o veniali ai comandamenti sesto e nono, hanno dovuto illuminare, istruire, punire uomini e soprattutto donne nel segreto della confessione. Un sapere, il loro, tutto e solo libresco, fatto di nozioni mediche, psicologiche, filosofiche innestate sul tronco originario di una religione sessuofobica, guidata da un clero celibatario e da ideali di perfezione angelica. Ma si tratta pur sempre di una religione che ha conosciuto grandi mutamenti: fondamentale fra tutti quello che vide l’ingresso della Chiesa cattolica «nella camera degli sposi», come dice il titolo del libro di Fernanda Alfieri (Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità. Secoli XVI-XVII, il Mulino, pagg. 423, euro 29).
Un libro importante, centrato su di un’analisi per molti aspetti magistrale del monumento della casuistica morale cattolica della Controriforma applicata all’economia sessuale del rapporto coniugale: le Disputationes de sancto matrimonii sacramento (1602-1605), del gesuita spagnolo Tomás Sánchez.
L’opera segnò una svolta rivoluzionaria rispetto alla tradizione perché fece posto al piacere del sesso e alla esplorazione dei suoi veicoli e delle sue tecniche ben al di là dei limiti concessi a denti stretti dai predecessori, tanto da scatenare proteste e censure. Ma se la cultura cattolica con l’opera di Sánchez «libito fè licito in sua legge» lo si dovette alla decisione della Chiesa tridentina di reagire alla proposta della Riforma protestante portando la guerra fuori dai suoi confini, nel bel mezzo del campo occupato dalla famiglia e dalle dinamiche della riproduzione.
La Chiesa tridentina non solo aprì i recinti sacri al matrimonio e portò davanti all’altare gli sposi ma si impegnò a seguirne tutto il percorso di vita, quello diurno e soprattutto quello notturno, riconoscendo una funzione essenziale e moralmente positiva ai rapporti sessuali. Da allora dura la marcia ininterrotta di un’avanzata del magistero ecclesiastico nelle cose del sesso.
Ne registriamo quasi quotidianamente gli esiti nella vita della nostra società civile ogni volta che è questione di concepimento, aborto e giù fino alle polemiche sulle cellule staminali e gli embrioni.
Ed è a certi aspetti radicati nel profondo della vita sociale dei paesi cattolici - al di là di una superficie apparentemente disinibita e di una solo presunta liberazione o parità della donna - che il libro di Fernanda Alfieri fa riflettere.
Ci sono modelli culturali ancora latenti che vennero elaborati e argomentati in quel monumento eretto al sesso coniugale da un missionario spagnolo negli intervalli di un’opera di conquista religiosa e sotto un cielo andaluso dominato dall’azzurro mantello della Madonna vergine e madre dell’Immacolata Concezione.
È a quell’orizzonte che rinvia lo stereotipo femminile degli occhi bassi e della passività affettiva e sessuale di una donna considerata solo un recipiente silenzioso e sottomesso del seme maschile. E tuttavia la persistente autorità ecclesiastica su materie di questo tipo non si capirebbe senza l’opera di Tomás Sánchez: fu lui che rielaborando le fonti di una cultura cristiana più che millenaria, dette argomenti alla avanzata della Chiesa sul terreno della famiglia e del sesso: in primo luogo riportando la materia degli affetti, degli istinti e delle pulsioni sotto il dominio della ragione e facendone oggetto di conoscenza intellettuale.
Per il gesuita come per i suoi discepoli destinati al sacerdozio si trattava di conoscere per guidare e governare. Per questa via si giunse al riconoscimento della positività di sentimenti e istinti e si aprì alla donna la possibilità di vedersi riconosciuta una parte essenziale nel piano divino ricavandone intanto il diritto al possesso del suo uomo e alle prestazioni maritali.
Nel perdurante silenzio delle donne, era la voce del corpo che bisognava interpretare perché il progetto del concepimento andasse pienamente in porto: e quella voce trovò ascoltatori attenti. Occhi freddi ed esperti studiarono fisiologia e psicologia, intercettando tutti i segnali e spiando ogni sintomo per costruire una scienza della psicopatologia sessuale dell’animale femminile, il tutto subordinato alla finalità della riproduzione.
E tuttavia la scienza casuistica del sesso e la pratica delle possibilità infinite di tatti e di contatti illustrata agli ecclesiastici celibatari e per loro tramite ai, e soprattutto alle, penitenti, non poteva non produrre effetti imprevisti dilatando l’orizzonte delle fantasie e innescando reazioni a catena. Non per niente il mondo del libro, ignorando o trasgredendo limitazioni e proibizioni, ha trasformato la scienza teologica della morale in letteratura pornografica: dal Paradiso delle coppie sposate all’Inferno delle biblioteche
-
> L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, ---- "I Papi e il sesso" di Eric Frattini (di Bruno Gambardella - I vizietti dei Papi).22 agosto 2010, di Federico La Sala
I vizietti dei Papi
di Bruno Gambardella *
Anche se ormai il tempo delle ferie volge al termine, qui, nella terra di mezzo tra Sparta e Atene ci permettiamo un’altra segnalazione per le vostre letture estive. I Papi e il sesso è scritto da uno storico spagnolo molto serio, Eric Frattini, che ha dato alle stampe un saggio sconvolgente e molto documentato, ma che si può leggere anche con spirito lieve, come se si avesse tra le mani uno di quei giornali che si trovano dal parrucchiere o sotto l’ombrellone. In questo libro sfilano secolo dopo secolo i sommi pontefici e i loro vizi davvero straordinari. Abbiamo contato almeno diciassette papi pedofili, dieci incestuosi, dieci ruffiani, nove stupratori. E poi, nonostante continue condanne dell’omosessualità, del matrimonio e del concubinato tra religiosi, decine di pontefici sposati, omosessuali, travestiti, concubinari, per non parlare dei sadici e dei masochisti, dei voyeur... Non è superfluo aggiungere che nemmeno il mangiapreti con la fantasia più fervida indovinerebbe quanti fra questi sono stati perfino canonizzati....
Qualche “assaggio” per stimolare la vostra curiosità.
Leone X (1513-1521) fu portato in lettiga alla cerimonia d’incoronazione a causa delle ulcere anali provocate dalla sodomia.
Tariffe - “L’ecclesiastico che commetta peccato carnale con suore, cugine, nipoti o figliocce oppure con una donna qualunque sia assolto se paga 67 libbre e 12 soldi di multa. Il sacerdote che svergini una fanciulla sia perdonato con 2 libbre e 8 soldi. La monaca che, dentro o fuori dal convento, si sia data a un uomo, o a più uomini, o a più uomini contemporaneamente, paghi per diventar badessa 131 libbre e 15 soldi” (Istruzioni della Taxa camarae, istituita dal Papa nel 1517).
Cullagium: imposta annuale versata dai sacerdoti che volevano tenere una concubina, estesa da Giovanni XXII ai clerici celibatari.
Martellate - Giovanni VIII (872-882) andava a letto col marito di una nobildonna genovese. I parenti di costei gli servirono perciò delle pernici avvelenate e, non essendo ancora il Papa morto al terzo giorno, entrarono nella sua camera di notte e lo finirono a martellate sul capo.
Galline - L’abate Eugenio di Brest morì d’infarto mentre copulava con una gallina.
Giovanni XII (955-963), che nutriva i suoi mille cavalli con mandorle e fichi inzuppati nel vino e morì ventiquattrenne per mano di un marito, ordinava vescovi i bambini, poi li deflorava e pervertiva. Il medesimo Giovanni XII organizzava assalti di asini e cani alle prostitute.
Cani e asini - Bisognò che Pio V (1566-1572) vietasse alle monache di tenere in convento cani e asini maschi.
Benedizioni - Benedetto IX, che fu papa a 11 anni, benediceva la sorella mentre questa s’accoppiava con altri uomini.
Banchetto - Giovanni XXII, al banchetto per le nozze della nipote, fece servire ai cento invitati quattromila porzioni di pane, cinquantacinque pecore, otto maiali, quattro cinghiali, duecento capponi, seicentonovanta polli, quaranta pivieri, trentasette anatre, cinquanta colombi, quattro cicogne, due fagiani, due pavoni, duecentonovantadue uccelletti, tre quintali di formaggio, tremila uova, duemila frutti, undici barili di vino.
Pellicce - Clemente VI, volendo celebrare la vittoria sui turchi (1347) utilizzò 1800 pellicce d’ermellino: “68 per i cappucci, 430 per un mantello papale, 310 per un manto, 150 per altri due cappucci, 30 per un cappello, 80 per un cappuccio grande e 88 per mantelli papali” (testimonianza di Francesco Petrarca).
Sotterranei - Urbano IV riunì tutte le prostitute nella cappella sotterranea di Santa Maria, pretese poi di incassare una parte degli introiti. Leone X, che aveva sistemato settemila donne in un quartiere controllato dalle truppe pontificie, esigeva poi il 40 per cento.
Sifilide sus saburre conu - Papa Alessandro VI, detto Papa Sifilide.
Donna - Un nobile tedesco, che partì per un’udienza privata con Giulio II, secondo le testimonianze dei suoi concittadini riportate dalle cronache del tempo “partì ragazzo e tornò in Germania donna fatta”.
Frattini conclude giustamente che “Nessuna religione al mondo ha mai dibattuto tanto l’intimità sessuale come il cattolicesimo e nessuna ha mai imposto altrettanto dettagliatamente i suoi codici di comportamento”. Uno psicologo recentemente scomparso, Luigi De Marchi, ha più volte dichiarato che solo menti perverse potevano fornire indicazioni tanto precise sulle pratiche sessuali che condannavano a parole, ma che in pratica dimostravano di conoscere molto, molto bene. La lettura di certi manuali per confessori può essere dunque più “stimolante” del mitico Kamasutra...
Da anticlericali impertinenti non possiamo che essere d’accordo con uomo innalzato alla gloria degli altari dalla stessa chiesa romana, San Girolamo, il quale, dimostrando di aver capito molte cose consigliava: “Una donna, che resti sola con un sacerdote, fugga dicendo che deve andar di corpo”. Parole sante...
-
> L’AMORE .... il "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.) ---- Francesco & i Trovatori. Da «Tristano e Isotta» ai romanzi cavallereschi: una ricerca indaga il rapporto fra il Santo di Assisi e le fonti (di Franco Cardini)6 maggio 2010, di Federico La Sala
Da «Tristano e Isotta» ai romanzi cavallereschi: una ricerca indaga il rapporto fra il Santo di Assisi e le fonti
Francesco & i Trovatori
Dai valori cortesi dei poemi, probabilmente conosciuti per averli letti o sentiti recitare, alla carità che supera anche l’ostilità
di Franco Cardini (Avvenire, 6 maggio 2010)
«Vedi, ho là cento compagni. Dacci Isotta e che appartenga a tutti noi! Il male accende i nostri desideri. Dalla ai tuoi lebbrosi...». Non è detto che il giovane Francesco, che sognava di diventar cavaliere, abbia mai letto parola per parola e rigo per rigo quella terribile pagina del troviere normanno Béroul, che nella seconda metà del XII secolo aveva scritto un Tristan in versi del quale ci resta solo un lungo frammento, più o meno di 4500 versi. Non è neppure sicuro che l’abbia mai finito, quel poema.
Del resto, a parte le due note versioni di Thomas e poi di Goffredo di Strasburgo, la storia di Tristano e d’Isotta era stata più volte raccontata, dal Galles alla Germania, e molti di quei racconti sono andati perduti. Ma si trattava di rifacimenti e di variazioni di una leggenda antica e celebre, alla quale certo nuovi e più forti e drammatici colori dovevano essere stati aggiunti proprio da quando, in seguito all’intensificarsi dei traffici e dei pellegrinaggi (e non solo, come oggi si ama ripetere, «alle crociate»!...), lebbra e lebbrosari erano divenuti sempre più frequenti.
Chissà che in quel famoso cum essem in peccatis, nimis mini videbatur amarum videre leprosos del Testamentum non vibri ancora in qualche modo la memoria d’un sentimento che a noi moderni sfugge, d’un tempo nel quale il giovane Francesco aveva aborrito la vista di quei miserabili ammalati non solo per un ovvio e comprensibile misto di paura e di repulsione, ma anche per qualcosa di forse più simile all’odio e al disprezzo nei confronti del «re dei lebbrosi» Yvain e dei suoi sventurati compari, coloro che nel racconto di Béroul osano sperare di avventarsi con i loro ripugnanti moncherini coperti di stracci luridi sul corpo candido e profumato della Bionda Signora e possederla a turno, ancora e ancora.
Quale giovane aspirante cavaliere non avrebbe sognato di trovarsi là, di sgominare quei ripugnanti infelici, d’affrontare lo stesso sovrano che l’umiliazione per l’adulterio aveva reso spietato rimproverandogli il suo disonore, di liberare la bella? Ma allora il bacio di Francesco al lebbroso acquista un valore ancor più intenso e profondo: vincendo se stesso, la paura, la repulsione, Francesco vince anche l’ombra di un’ostilità inespressa, la scia dei suoi sogni di ragazzo.
Questa «via cavalleresca alla santità», in Francesco, costituisce un tema che alcuni anni fa mi aveva molto attratto e sul quale, di quando in quando, mi capita di desiderar di tornare; o di rammaricarmi per non aver il tempo di farlo. È appunto la «via» che sembra dominare l’episodio della Vita beati Francisci di Tommaso da Celano nel quale Francesco, praeter morem suum, quia curialissimus erat, cuidam pauperi postulanti ab eo eleemosynam exprobrasset, ma subito se n’era pentito rendendosi conto che magni vituperii fore magnique dedecoris petenti pro nomine tanti Regis subtrahere postulata.
Egli aveva negato l’elemosina a un povero che gliel’aveva domandata nel nome di Dio: un atto che contrastava con la sua abituale curialitas, e ch’era anzi degno di vituperium e di dedecus. Parte necessaria della curialitas era la largitas, la liberalitas, la generosità che si trova nei poemi epici del tempo, come largesse , inseparabile compagna di prouesse, cioè di probitas, del coraggio.
Sono i valori cortesi-cavallereschi, che a proposito di questo passo di Tommaso da Celano hanno consentito a Chiara Frugoni di riflettere molto giustamente che «in questa fase della vita Francesco non è mosso dalla compassione per i più deboli ma dal codice morale dei suoi nobili amici, puntigliosamente preso a modello»: un’osservazione che Marco Bartoli riprende e approfondisce ritenendo probabile che Francesco conoscesse - per averli letti o più probabilmente ascoltati recitare - quei precetti che si trovano in poemi come il Garin le Lorrain, che cioè ad esempio «è col donare che un uomo di valore viene in alto pregio». Anche il dono della veste al povero cavaliere, altro episodio-chiave della conversio del santo, rientra quanto meno formalmente in questa tipologia dell’elemosina cortese».
D’altronde, c’è almeno un altro testo francescano nel quale il truce «re dei lebbrosi» di Béroul sembra tornar a insidiare direttamente Francesco, a metterlo alla prova. È il capitolo XXV dei Fioretti, quello del lebbroso «sì impaziente e sì incomportabile e protervo» che «isvillaneggiava di parole e di battiture sì sconciamente chiunque lo serviva» e «vituperosamente bestemmiava Cristo benedetto e la sua santissima madre Vergine Maria»: Francesco conquista questo povero tanto perfido con la bontà e la dolcezza ancor prima che con il miracolo, giacché il tocco delle sue mani ne monda le piaghe.
Si tratta di una pagina tanto intensa quanto complessa, dal momento che la malvagità del lebbroso è, in effetti, un segno di possessione demoniaca: per cui la scena della cura e della lavanda del corpo del perfido infermo è, al tempo stesso, un esorcismo. E il vero miracolo divino, ancor più di quello manifestatosi attraverso le mani del santo, sta nel pentimento e nella salvezza di un’anima che sembrava irrimediabilmente perduta. Al di là dell’aspetto propriamente materiale del servizio, cioè della cura fisica e della lavanda del corpo, sono la carità e la dolcezza profuse durante il suo corso a ottenere un miracolo duplice, la guarigione dalle piaghe e quella, più difficile e preziosa, dal peccato.
Che l’esperienza della povertà sia centrale nella vocazione di Francesco, è cosa tanto certa quanto nota. Quello delle sue nozze con Madonna Povertà è un tema di straordinaria pregnanza nella mistica e nella tradizione francescana, legittimato dallo splendido trattatello De sacro commercio beati Francisci cum domina Paupertate e dall’XI canto del Paradiso dantesco e celebrato da opere pittoriche di grande significato.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. --- LA CHIESA, IL SEGRETO E L’OBBEDIENZA (di Adriano Prosperi - La regola del segreto. Così la Chiesa nascose le sue colpe).30 aprile 2010, di Federico La Sala
 La regola del segreto
La regola del segreto
 così la Chiesa nascose le sue colpe
così la Chiesa nascose le sue colpe di Adriano Prosperi (la Repubblica,30 aprile 2010)
di Adriano Prosperi (la Repubblica,30 aprile 2010)Nella moderna società dei consumi l’occulto è un’industria e la ragione resta più che mai un’ospite importuna. Nelle nebbie dell’occulto si muovono i cercatori di misteri, coloro che frugano nei depositi inesauribili di un Medioevo di Templari e di sindoni per edificare i lettori.
Ma quando una ricerca autentica restaura il vero volto del passato scostando i fondali dipinti che lo nascondono si scopre qualcosa di diverso e insieme di familiare, qualcosa che permette di capire meglio caratteri e problemi del nostro presente. E in materia di occulto, niente potrebbe essere più opportuno di un restauro del significato storico della parola attraverso una indagine sulle cause e sulle conseguenze del suo ingresso nel linguaggio giuridico della Chiesa medievale.
È quello che ci viene proposto in un libro che Jacques Chiffoleau, un valente medievista francese noto per i suoi studi di storia della giustizia papale e dei grandi processi politici, ha costruito per i lettori italiani: La Chiesa, il segreto e l’obbedienza (il Mulino, pagg. 185, euro 18). Si tratta di un libro destinato a suscitare un’eco assai più vasta di quella che l’autore poteva immaginare quando lo ha consegnato alla stampa. Ed è augurabile che così sia: l’asciutta e puntuale esposizione della sua ricerca sui rapporti tra la Chiesa, il segreto e l’obbedienza offre a una opinione pubblica agitata dallo scandalo dei preti pedofili la possibilità di capire finalmente quale irriconoscibile fantasma di una lunghissima storia ci sia apparso davanti.
È una vicenda che comincia alla metà del XII secolo, con la compilazione del Decretum di Graziano, la prima e fondamentale sistemazione in un corpo unitario delle norme elaborate per governare la Chiesa cristiana d’Occidente. Qui si trovano i due canoni glossati da Giovanni Teutonico con la formula Ecclesia de occultis non iudicat («La giustizia della Chiesa non si occupa di colpe occulte»). Il significato di quella norma è stato oggetto di analisi di esperti di diritto canonico prima di accendere una discussione più generale tra gli storici. La formula condensava un’idea biblica della giustizia, quella che affidava all’onniscienza di Dio il compito di vedere e giudicare la verità nascosta nei cuori degli uomini.
Applicando quell’idea al funzionamento dei tribunali la formula segnava l’avvio di una distinzione tra i fori: da un lato il foro penitenziale della confessione segreta dei peccati dove il confessore agisce come orecchio di Dio, dall’altro il foro pubblico dove il giudice punisce i colpevoli di infrazioni alle leggi della comunità.
Intorno a questa articolazione dei fori nascerebbe anche - secondo alcuni - la prima separazione moderna tra pubblico e privato. Ed è comunque evidente l’affacciarsi di una Chiesa papale come potere mondano e soggetto creatore di diritto in un mondo dove era diffuso il senso religioso del mistero e delle cose occulte. La conoscenza della verità era attesa nel grandioso scenario dell’Apocalisse quando si sarebbe aperto il Libro dai sette sigilli.
Ma altri segreti furono quelli che interessarono da allora i giudici di una Chiesa che si stava affermando come titolare di ogni potere in terra. La loro opera è seguita da Jacques Chiffoleau per capire il modo in cui l’occulto venne definendosi nell’amministrazione della giustizia. E nota subito che quei due canoni glossati con la formula Ecclesia de occultis non iudicat riguardavano infrazioni di chierici all’obbligo della castità. Qui «occulto» vale come il contrario di «notorio» e significa concretamente che se le colpe dei chierici non erano di dominio pubblico allora la purgazione poteva rimanere segreta evitando lo scandalo. La minaccia dello scandalo era tanto più temuta quanto più forte era l’esigenza di esaltare la dignità del clero e di affermarne la supremazia sul laicato nell’età della Riforma gregoriana.
Si registra qui la nascita di una preoccupazione del potere ecclesiastico che connoterà nei secoli il modo di trattare le colpe del clero in tutti i casi in cui fu possibile lasciarle nell’ombra del segreto ed evitare il clamore del pubblico giudizio o l’umiliazione della penitenza pubblica. Il che fu possibile perfino nei casi dei cosiddetti «crimini enormi» (colpe di sesso, omicidio, simonia) i cui effetti fossero manifesti e noti alla società cristiana: se la teoria prevedeva la necessità di rompere il sigillo della segretezza confessionale, lo sviluppo di una raffinata casistica creò uno sbarramento protettivo intorno ai chierici criminali.
Tutto questo niente toglie alla fondamentale importanza della distinzione dei fori e all’efficacia degli esercizi di esame della coscienza ai fini della confessione segreta. Gli abissi della coscienza individuale esplorati da Agostino di Ippona rimasero per sempre un territorio fondamentale della costruzione della persona nella tradizione cristiana occidentale.
Ma il riconoscimento dovuto al peso storico della tradizione giuridica della Chiesa e alla creativa ricchezza della varietà di fori elaborati e messi in opera dalle sue autorità centrali e dai suoi intellettuali non può far dimenticare il carattere difensivo e corporativo di quella interpretazione dell’occulto a favore del clero. Anche perché quando l’occulto sembrò coprire il pericolo del dissenso il potere reagì con estrema aggressività e non si fermò nemmeno davanti al limite estremo: la criminalizzazione dei pensieri.
L’antica norma di saggezza giuridica raccolta nell’adagio romanistico per cui nessuno deve essere punito per i suoi pensieri fu travolta dall’avanzata degli inquisitori ecclesiastici a caccia di eretici, ben presto seguiti dagli inquisitori laici a caccia di ribelli politici. Il potere ecclesiastico ricorse al grimaldello giuridico di origine romanistica del delitto di «lesa maestà» contro i sospetti di eresia: il potere politico laico ne seguì l’esempio. La lesa maestà era definita come il crimine d’eccezione davanti al quale non valevano più le tutele della legge ordinaria.
Se è vero che «nessuno merita la pena per il solo pensiero» - scrisse il giudice Alberto da Gandino - «questo non vale nel crimine di lesa maestà o di eresia». E fu qui che si scatenò una insaziabile volontà di sapere. Nemmeno il sigillo della confessione teoricamente inviolabile fu rispettato.
Il panorama ricostruito da Chiffoleau per la tradizione medievale è impressionante: bastava il sospetto che l’eretico non collaborasse per far sì che si proponesse di sciogliere il suo confessore dall’obbligo del silenzio. Va detto che questa storia, ricostruita da Jacques Chiffoleau lungo il percorso medievale, non si chiuse lì: toccò al papato del ’500 aprire un canale di comunicazione obbligata e automatica tra il foro interno della confessione e il foro esterno dell’inquisizione. E quanto ai reati «enormi», «nefandi», «pessimi» e «turpissimi», è stato il cardinal Alfredo Ottaviani a redigere nel secolo scorso l’ultimo dispositivo - anch’esso segretissimo, naturalmente.
Da qui la storia trapassa nella cronaca dei nostri giorni. Oggi un lungo e coerente percorso della giustizia ecclesiastica come privilegio di impunità per una corporazione si sta chiudendo con la resa dei conti tra il senso comune della giustizia e l’anacronismo dell’occulto creato a difesa dei delitti dei preti pedofili.
-
> L’AMORE E LA PAROLA. ---- I giovani, l’amore, il sesso (di Michel Foucault, 1977 - rec. di "Comizi d’amore" di P.P. Pasolini, del 1963)27 aprile 2010, di Federico La Sala
 L’ANTICIPAZIONE / Ecco la recensione scritta da Michel Foucault nel 1977 al film
L’ANTICIPAZIONE / Ecco la recensione scritta da Michel Foucault nel 1977 al film
 inchiesta del regista di "Comizi d’amore". Un ritratto del Paese e dei suoi cambiamenti
inchiesta del regista di "Comizi d’amore". Un ritratto del Paese e dei suoi cambiamenti PIER PAOLO PASOLINI.
PIER PAOLO PASOLINI.
 I giovani, l’amore, il sesso
I giovani, l’amore, il sesso
 viaggio nell’Italia anni ’60
viaggio nell’Italia anni ’60 Qualcuno si decide, risponde esitando Si avvicinano, borbottano, le braccia sulle spalle, volto contro volto. Risa e tenerezza
Qualcuno si decide, risponde esitando Si avvicinano, borbottano, le braccia sulle spalle, volto contro volto. Risa e tenerezza
 Qualcuno manifesta anche il timore che molti comportamenti ora verranno tollerati Verrà meno una specie di ecosistema
Qualcuno manifesta anche il timore che molti comportamenti ora verranno tollerati Verrà meno una specie di ecosistemadi Michel Foucault (la Repubblica, 27.04.2010)
Come nascono i bambini? Li porta la cicogna, da un fiore, li manda il buon dio, o arrivano con lo zio calabrese. Guardate il volto di questi ragazzini, invece: non danno affatto l’impressione di credere a ciò che dicono. Con sorrisi, silenzi, un tono lontano, sguardi che fuggono a destra e sinistra, le risposte a tali domande da adulti possiedono una perfida docilità; affermano il diritto di tenere per sé ciò che si preferisce sussurrare. Dire "la cicogna" è un modo per prendersi gioco dei grandi, per rendergli la loro stessa moneta falsa; è il segno ironico e impaziente del fatto che il problema non avanzerà di un solo passo, che gli adulti sono indiscreti, che non entreranno a far parte del cerchio, e che il bambino continuerà a raccontarsi da solo il "resto". Così comincia il film di Pasolini.
Enquête sur la sexualité (Inchiesta sulla sessualità) è una traduzione assai strana per Comizi d’amore: comizi, riunioni o forse dibattiti d’amore. È il gioco millenario del "banchetto", ma a cielo aperto sulle spiagge e sui ponti, all’angolo delle strade, con bambini che giocano a palla, con ragazzi che gironzolano, con donne che si annoiano al mare, con prostitute che attendono il cliente su un viale, o con operai che escono dalla fabbrica. Molto distanti dal confessionale, molto distanti anche da quelle inchieste in cui, con la garanzia della discrezione, si indagano i segreti più intimi, queste sono delle Interviste di strada sull’amore. Dopo tutto, la strada è la forma più spontanea di convivialità mediterranea.
Al gruppo che passeggia o prende il sole, Pasolini tende il suo microfono come di sfuggita: all’improvviso fa una domanda sull’"amore", su quel terreno incerto in cui si incrociano il sesso, la coppia, il piacere, la famiglia, il fidanzamento con i suoi costumi, la prostituzione con le sue tariffe. Qualcuno si decide, risponde esitando un poco, prende coraggio, parla per gli altri; si avvicinano, approvano o borbottano, le braccia sulle spalle, volto contro volto: le risa, la tenerezza, un po’ di febbre circolano rapidamente tra quei corpi che si ammassano o si sfiorano. Corpi che parlano di loro stessi con tanto maggior ritegno e distanza quanto più vivo e caldo è il contatto: gli adulti parlano sovrapponendosi e discorrono, i giovani parlano rapidamente e si intrecciano. Pasolini l’intervistatore sfuma: Pasolini il regista guarda con le orecchie spalancate. Non si può apprezzare il documento se ci si interessa di più a ciò che viene detto rispetto al mistero che non viene pronunciato.
Dopo il regno così lungo di quella che viene chiamata (troppo rapidamente) morale cristiana, ci si poteva aspettare che nell’Italia di quei primi anni sessanta ci fosse un certo qual ribollimento sessuale. Niente affatto. Ostinatamente, le risposte sono date in termini giuridici: pro o contro il divorzio, pro o contro il ruolo preminente del marito, pro o contro l’obbligo per le ragazze a conservare la verginità, pro o contro la condanna degli omosessuali. Come se la società italiana dell’epoca, tra i segreti della penitenza e le prescrizioni della legge, non avesse ancora trovato voce per raccontare pubblicamente il sesso, come fanno oggi diffusamente i nostri media.
«Non parlano? Hanno paura di farlo», spiega banalmente lo psicanalista Musatti, interrogato ogni tanto da Pasolini, così come Moravia, durante la registrazione dell’inchiesta. Ma è chiaro che Pasolini non ci crede affatto. Credo che ciò che attraversi il film non è l’ossessione per il sesso, ma una specie di timore storico, un’esitazione premonitrice e confusa di fronte a un regime che allora stava nascendo in Italia: quello della tolleranza. È qui che si evidenziano le scissioni, in quella folla che tuttavia si trova d’accordo a parlare del diritto, quando viene interrogata sull’amore. Scissioni tra uomini e donne, contadini e cittadini, ricchi e poveri? Sì, certo, ma soprattutto quelle tra i giovani e gli altri. Questi ultimi temono un regime che rovescerà tutti gli adattamenti, dolorosi e sottili, che avevano assicurato l’ecosistema del sesso (con il divieto del divorzio che considera in modo diseguale l’uomo e la donna, con la casa chiusa che serve da figura complementare alla famiglia, con il prezzo della verginità e il costo del matrimonio).
I giovani affrontano questo cambiamento in modo molto diverso: non con grida di gioia, ma con una mescolanza di gravità e di diffidenza perché sanno che esso è legato a trasformazioni economiche che rischiano assai di rinnovare le diseguaglianze dell’età, della fortuna e dello status. In fondo, i mattini grigi della tolleranza non incantano nessuno, e nessuno vede in essi la festa del sesso. Con rassegnazione o furore, i vecchi si preoccupano: che fine farà il diritto? E i "giovani", con ostinazione, rispondono: che fine faranno i diritti, i nostri diritti?
Il film, girato quindici anni fa, può servire da punto di riferimento. Un anno dopo Mamma Roma, Pasolini continua su ciò che diventerà, nei suoi film, la grande saga dei giovani. Di quei giovani nei quali non vedeva affatto degli adolescenti da consegnare a psicologi, ma la forma attuale di quella "gioventù" che le nostre società, dopo il Medioevo, dopo Roma e la Grecia, non hanno mai saputo integrare, che hanno sempre avuto in sospetto o hanno rifiutato, che non sono mai riuscite a sottomettere, se non facendola morire in guerra di tanto in tanto. E poi il 1963 era il momento in cui l’Italia era entrata da poco e rumorosamente in quel processo di espansione-consumo-tolleranza di cui Pasolini doveva redigere il bilancio, dieci anni dopo, nei suoi Scritti corsari. La violenza del libro dà una risposta all’inquietudine del film.
Il 1963 era anche il momento in cui aveva inizio un po’ ovunque in Europa e negli Stati Uniti quella messa in questione delle forme molteplici del potere, che le persone sagge ci dicono essere "alla moda". E sia pure! Quella "moda" rischia di rimanere in voga ancora per un po’ di tempo, come accade in questi giorni a Bologna.
Traduzione dal francese di Raoul Kirchmayr
-
> L’AMORE E LA PAROLA. ---- Le dame, i cavalieri e il piacere proibito (di Franco Cardini) - Le Goff. "Mille anni di passioni segrete" (Intervista di Pietro Del Re)15 marzo 2009, di Federico La Sala
Le dame, i cavalieri e il piacere proibito
L’amore carnale nel Medioevo
di Franco Cardini (la Repubblica, 15.03.2009)
Nella storiografia divulgativa, quella scritta da "storici" amateurs, ricorre un buffo fenomeno che gli studiosi di professione ben conoscono: la frequente retrodatazione di usi e di tradizioni che appartengono al passato più o meno prossimo e che vengono presentati - e in genere entrano nell’immaginario collettivo - come ben più antichi di quanto non siano. Concorre, a configurare questo bizzarro effetto deformante, una sorta di superstizione progressista: s’immagina la storia come una sequenza di eventi, istituzioni e strutture in costante evoluzione positiva, in progresso; ed è quindi ovvio, se ne deduce, che l’oggi sia migliore dello ieri e che il domani sarà ancora migliore dell’oggi.
In questi ultimi anni, per la verità, tale beata illusione è stata messa a dura prova, e forse nessuno l’adotterebbe per le cose contemporanee. Ma sopravvive per il passato: difatti si parla di un Medioevo nel quale si bruciavano le streghe, che invece poverine andarono piuttosto con i loro roghi a illuminare il già «luminoso» Rinascimento, perché nel «buio Medioevo» erano quasi sconosciute. Oppure, ci s’immagina l’aristocrazia feudale dei secoli Dodicesimo e Tredicesimo come fatta tutta di signorotti a immagine del manzoniano don Rodrigo, la cui nobiliare prepotenza era, invece, del tutto seicentesca, e quattro-cinque secoli prima nessuno l’avrebbe tollerata.
Così accade quando s’immaginano i costumi sessuali. La pruderie ottocentesca discenderebbe dal casto e represso Medioevo, in un rassicurante continuismo che solo di recente avrebbe lasciato il passo a una crescente libertà sessuale. Inutile dire che così non era: tra il Medioevo e il casto romanticismo si è incuneata la cultura libertina, che dà dei punti alle nostre fantasie più osées. Ma che a sua volta, guarda caso, aveva nel Medioevo molti più modelli di riferimento di quanti non ci aspetteremmo.
Medioevo casto e represso. È uno dei più radicati fra i nostri luoghi comuni; come quello d’un Medioevo igienicamente poco raccomandabile, ad esempio. Errore. La nostra età di mezzo pullulava di «bagni» e di «stufe», in parte ereditate dall’età romana - ma anche da certe tradizioni barbariche, ad esempio dal bagno di vapore turcomongolo -, in parte reimportate attraverso il mondo musulmano, a sua volta erede della tradizione bizantina. E nei bagni non ci si limitava a lavarsi: «stufa» era sinonimo di bordello. D’altro canto, lo spettacolo della nudità - aborrito dalla Riforma protestante in poi - era nei secoli di mezzo alquanto comune e consueto.
E allora, il Medioevo mistico, innamorato della Vergine Maria e per il resto tutto onore e gelosia, nel quale circolavano congegni come le cinture di castità? L’amore mistico e spirituale, quello rivolto alla Madonna e passato poi, attraverso trovatori, trovieri e Minnesänger all’amor cortese e al culto della «donna angelicata», costituiva senza dubbio una grande forza spirituale, etica ed estetica. Ma c’era anche ben altro.
L’amore fatale, l’amore-passione travolgente e inestinguibile è, secondo un ormai classico studio di Denis de Rougemont, L’amour et l’Occident (1939), un’invenzione dell’Occidente medievale, i grandi modelli del quale sono uno romanzesco (Tristano e Isotta) e uno storico (Abelardo ed Eloisa). Jack Goody (Il furto della storia, Feltrinelli 2006) ha obiettato che le cose non stanno proprio così: e che anche l’antico Egitto, e poi almeno India, Cina e Giappone la sapessero lunga al riguardo. Certo comunque il Medioevo conosceva bene la lussuria, che Dante tratta come un grave peccato (il più lieve tuttavia tra quelli mortali) e ci mostra condannata nell’Inferno.
Ma eccoci al punto: la poesia cavalleresca e più tardi quella lirica e la novellistica, al pari di certe magari dissimulate forme d’arte plastico-figurativa, sono molto meno avare di quel che siamo abituati a pensare di esempi d’amore fisico anche alquanto spinto: al limite, non di rado, di quel che per noi sarebbe l’erotismo se non addirittura la pornografia.
Il bel libro recente di Florence Colin-Goguel, L’image de l’Amour charnel au Moyen Âge (Seuil 2008, prefazione di Michel Pastoureau) ci dà ampia materia di modificare, a proposito del nostro Medioevo, parecchie idées reçues che pigramente ci portiamo dietro. Zavorrato dall’austera continenza d’origine paolina e poi ascetica, ma insidiato non solo dall’eredità erotica della cultura latina bensì anche da certi modelli biblici (il Cantico dei Cantici...), il Medioevo occidentale ha coltivato un interesse e una propensione per l’amore fisico spesso sconfinato - come nella tradizione goliardica - in forme grottesche, dissacratorie e paradossali, ma alimentato anche da una raffinata tensione intellettuale che si sfogava perfino in un’accurata trattatistica e raggiungeva, invadendola, perfino la teologia morale.
Tempo di gelosia e di segregazione, il Medioevo era anche età di società di soli uomini e di donne sole, dove rapporti omosessuali e autoerotismo avevano modo di espandersi. Dietro le stesse tradizioni cavalleresche e monastiche, chiericali e universitarie, si avverte spesso, e nemmeno troppo nascosto, il brivido dell’androginia e dell’eros "alternativo". Gli stessi cacciatori d’una «repressione della donna» in età medievale avrebbero modo di ricredersi, quanto meno studiando la società aristocratica. in pieno Dodicesimo secolo, corti come quella di Eleonora duchessa d’Aquitania (la madre di Riccardo Cuor di Leone) erano luoghi nei quali si praticava e si teorizzava l’adulterio, mentre più tardi nelle società mercantili l’uso delle more, delle russe e delle circasse tenute come schiave domestiche avrebbe diffuso forme di poligamia pratica e popolato il mondo di bastardi: che sovente avevano anzi un loro ruolo sociale e perfino araldico riconosciuto.
Scorrendo le pagine e le immagini proposte dalla Colin-Goguel, allieva di Le Goff e di Chastel, si resta addirittura stupiti nel constatare come dalla musica ai tornei, dai giochi alle passeggiate in giardino, dagli usi enogastronomici alle stesse metafore religiose, il Medioevo fosse pervaso di erotismo e di attrazione carnale. La stessa eresia catara, che proclamava come il massimo peccato contro Dio fosse la riproduzione, che perpetuava la schiavitù dello spirito entro la prigione carnale, era poi molto meno severa nei confronti delle forme di erotismo che comportassero dispersione del seme e non dessero quindi frutti. E questa considerazione attenua di molto lo stupore di qualcuno, allorché constata quanto il catarismo fosse diffuso in contrade gioiose come la dolce Provenza. Per tacere dei frequenti coiti diabolici. Immaginari, d’accordo, anzi illusori. Ma, dopo il dottor Freud, la sappiamo lunga al riguardo.
intervistaLe Goff. "Mille anni di passioni segrete"
di Pietro Del Re (la Repubblica, 15.03.2009)
Eva è il demonio. È all’origine dei mali del mondo, perché tentatrice, istigatrice del peccato e colpevole della cacciata dell’umanità dal Paradiso. Con lei, nel Medioevo la donna diventa l’icona del vizio. «Eppure, non si può dire che la società dell’epoca sia stata antifemminista», spiega lo storico francese Jacques Le Goff. «Anche perché i rapporti tra i sessi avevano un carattere ambiguo: l’uomo medievale era spesso una creatura androgina». A ottantacinque anni, Le Goff è uno dei più illustri eredi della École des Annales. L’ultima sua fatica è quasi un instant book: sta scrivendo un libro sui soldi nel Medioevo, «per dimostrare che le banche hanno sempre fallito».
Professore, che cosa sappiamo del comportamento sessuale di quei secoli bui?
«Quasi nulla, perché salvo le espressioni letterarie o artistiche, abbiamo pochi documenti che ci permettono di capire che cosa realmente accadesse nel segreto dell’alcova».
Dopo il matrimonio medioevale, assieme all’uomo e alla donna nel letto nuziale c’è anche Dio. Era legittimo il coito coniugale o era soltanto una concessione alla procreazione?
«Il matrimonio diventa sacramento solo dopo il quarto Concilio lateranense, nel 1215. Fino ad allora non era riuscito a distinguersi da quello che era nell’antichità romana: un contratto. Tuttavia, anche se ci si sposava al di fuori della Chiesa, per essere valido agli occhi del clero, e quindi a quelli di Dio, il matrimonio doveva essere consumato».
Ma godere è sempre peccato?
«Generalmente sì. Nel Duecento, proprio quando la Chiesa inventa il Purgatorio per strappare l’uomo alla tradizionale opposizione Inferno-Paradiso, San Tommaso D’Aquino nega che possa esserci una parte legittima di piacere nel compimento dell’atto sessuale, anche nell’ambito del matrimonio».
All’epoca, il peccato originale era assimilato a quello carnale e l’immagine dell’Inferno spesso rappresentata come il sesso femminile: si può dire che nel Medioevo il Male fosse donna?
«Sì, ma fino a un certo punto. Contrariamente a quando accadeva a Bisanzio, fino all’Undicesimo secolo il culto della Vergine Maria non era celebrato dalla Chiesa. A partire da quel momento si sviluppò invece con forza straordinaria. È anche grazie al culto mariano che la donna è stata rivalutata nelle società medievali».
Contro l’infamia della lussuria e dell’adulterio erano previste punizioni corporali durissime. Queste rendevano l’uomo medievale più "puro" dell’uomo moderno?
«Il castigo ha senza dubbio contribuito a tenere nascosta la lussuria, benché i teologi e i predicatori dicessero che Dio vedesse tutto, compreso quello che si faceva nell’ombra. Tuttavia sul margine dei manoscritti dell’epoca sono spesso raffigurate scene di lussuria, che non esiterei a definire pornografiche: un vescovo sodomita, una donna che coglie falli da un albero o scene di sesso tra uomini e animali. Il Medioevo ammetteva il male, purché si manifestasse al margine della società, lontano dal suo centro sacro. Piuttosto che volerlo sradicare del tutto, il cristianesimo ha sempre cercato di limitare il male attraverso la confessione e il pentimento».
Le prostitute erano tollerate dalla Chiesa?
«Sì, la prostituzione era permessa. Quando il re moralista Luigi IX, detto San Luigi, volle vietarla, il vescovo di Parigi gli disse che era "un male necessario"».
L’amor cortese che sublima la donna è sempre un amore platonico?
«Su questo problema i medievisti sono divisi. Io credo che l’amor cortese sia puramente immaginario. Esiste soltanto nella letteratura. Ciò non significa che l’amore reale sia sempre stato brutale, che ci sia sempre stata una violenta dominazione dell’uomo sulla donna. Ma l’amore in cui la donna diventa il signore e il cavaliere il suo servo, non c’è mai stato. Neanche nelle classi superiori della società. Detto ciò, il Medioevo è durato dal Quinto al Quindicesimo secolo, e in mille anni molte cose sono cambiate. La svolta essenziale si produce nel Duecento, quando i valori del cielo scendono sulla Terra. Da quel momento la felicità non è riservata solo all’aldilà. C’è l’inizio di una possibile soddisfazione del piacere anche per noi mortali. Appaiono, per esempio, i primi trattati di gastronomia. Il lavoro, che era considerato una punizione del peccato originale, diventa invece un valore. È del resto in quell’epoca che si comincia a dire che l’uomo è stato creato a immagine di Dio».
Che cosa cambia con il Rinascimento?
«C’è l’esaltazione della bellezza e, in particolare, della nudità. La Chiesa medievale rifiutava la nudità, e con essa la maggior parte dell’arte antica che, soprattutto nella scultura, rappresentava corpi nudi. Con il Rinascimento in Europa, soprattutto nel Cinquecento, avviene la riscoperta dei nudi. Gli stessi che prima erano rappresentati negli affreschi delle basiliche soltanto nelle scene della resurrezione dei corpi».
-
> L’AMORE E LA PAROLA. ---- L’amore romantico e quello libertino (di Eugenio Scalfari)3 ottobre 2010, di Federico La Sala
L’amore romantico e quello libertino
di Eugenio Scalfari (la Repubblica, 03.10.2010)
FINALMENTE un felice giorno di tregua politica. Il governo ha incassato un voto di fiducia sui cinque titoli del suo programma; i finiani sono determinanti alla Camera; Berlusconi continua a lanciare insulti alla magistratura, a collezionare barzellette sconce da ogni punto di vista e a magnificare il suo ruolo di demiurgo della politica mondiale; l’opposizione è unita e aggressiva.
Insomma, soddisfazione per tutti e avanti finché durerà. Durerà poco, penso io, ma forse mi sbaglio. Il solo legittimamente preoccupato è Belpietro, direttore di Libero, che ancora non conosce la verità sulla causa delle sue preoccupazioni. Gli invio la mia convinta e doverosa solidarietà.
Posso dunque dedicarmi oggi al tema dell’amore, come avevo promesso ai nostri lettori. Non è un tema peregrino. In una società agitata da guerre, terrorismo, crisi economica, egoismi feroci, l’amore sembra un sentimento quasi scomparso. Le donne, che dell’amore rappresentano l’elemento cardine, sono vilipese e usate come è sempre accaduto; la loro emancipazione che sembrava ormai conquistata anche se ancora parziale e imperfetta, sta regredendo e molte di loro non si oppongono più, anzi sembrano felici di collaborare a questo «richiamo all’ordine» che va tutto a loro detrimento. Perciò riflettere sull’amore è un tema di stretta attualità. Umberto Veronesi, in un bel libro uscito in questi giorni, è del mio stesso avviso ed arriva addirittura ad augurarsi una qualche forma di matriarcato.
Sostiene che la famiglia a direzione maschile diseduca le donne. Proprio perché sono l’elemento debole di fronte alla cultura maschile tuttora dominante, l’educazione che ricevono le sospinge a far propri i valori di competizione che sono tipici del maschio. Quelle che riescono ad emanciparsi e a raggiungere posizioni di spicco hanno introitato l’immagine della virago e fanno concorrenza agli uomini sul loro stesso terreno.
Bisognerebbe dunque - scrive Veronesi - che la loro educazione avvenisse in famiglie culturalmente orientate da valori femminili: l’amore - appunto - la pace, la solidarietà, la comprensione. Non ha torto, Veronesi, anche se l’attuale temperie in tutto il mondo sta procedendo nella direzione opposta.
L’amore però è una parola che esprime una quantità di sentimenti. Ha una sua mitologia, un suo approccio religioso, una sua poetica ed anche una sua storia. Di tempo in tempo e di luogo in luogo, quella parola ha avuto significati diversi e spesso opposti l’uno all’altro. Questo è dunque il tema sul quale mi sembra opportuno fare chiarezza per poter meglio colmare un’evidente lacuna che affligge le nostre società, quelle ricche e quelle povere, ad Occidente e a Oriente del mondo.
* * *
Le civiltà antiche - e qui mi limito a parlare di quelle mediterranee che più da vicino ci riguardano - non conoscevano il «privato». Gli uomini si realizzavano nella «polis» della quale la famiglia e la tribù costituivano le cellule. L’amore faceva parte dei valori familiari, incoraggiati e protetti dagli dei del luogo. Si amavano i genitori, si amavano i fratelli e le sorelle, si amava la sposa, fonte di procreatività. Le tavole mosaiche contengono la normativa più antica dell’amore familiare: «Onora il padre e la madre. Non commettere atti impuri. Non desiderare la donna d’altri». Il destinatario di queste norme è il maschio, la donna resta in una zona d’ombra ma è anch’essa colpevole dell’eventuale trasgressione. Naturalmente i sentimenti amorosi finivano, allora come oggi e come sempre, anche al di fuori del recettacolo familiare, ma era un fatto privato e quindi del tutto irrilevante. Se però diventavano una sfida contro la famiglia l’irrilevanza diventava colpevolezza e veniva repressa con la massima severità.
Non è un caso che la guerra delle guerre, quella di Troia, scoppia a causa del tradimento di Elena e della sua fuga con Paride. È un pretesto, si sa. Simboleggiò lo scontro tra la civiltà achea e quella medio-orientale. Ma il pretesto dello scontro è la violazione dell’amore familiare e il ritorno di Elena a casa con il marito Menelao sancisce che l’ordine violato è stato ripristinato.
Nello stesso ambito leggendario il teatro greco racconta la vendetta di Elettra e di Oreste contro l’uccisore del loro padre e contro la loro madre che ne era stata l’amante durante la sua assenza da Argo.
C’è, al fondo di questa tragedia, l’ombra d’un sentimento incestuoso che si coglie nell’amore quasi morboso tra il fratello e la sorella vendicatori. L’incesto del resto rappresenta un elemento spesso presente nell’amore familiare; Edipo e il suo destino ne costituiscono il fondamento, non a caso recuperato da Freud come uno degli elementi fondanti della psicologia del profondo.
* * *
Il carattere «pubblico» e familiare dell’amore dura molto a lungo e scavalca i secoli. Neppure il Cristianesimo riesce ad intaccarlo. La predicazione di Gesù tramandataci dai Vangeli è intrisa di amore e questa è la grande innovazione rispetto al monoteismo ebraico che descrive il dio biblico come il condottiero del suo popolo, ancorato alla severità della Legge.
Il dio dei Vangeli è giusto ma soprattutto misericordioso e non si identifica con un popolo. Si rivolge a tutte le persone, ne riscatta la dignità, esalta i deboli e i poveri che saranno i primi a varcare la soglia della beatitudine. Parifica tutte le persone quando entreranno nel regno dei cieli, le donne come gli uomini, gli schiavi come i loro padroni. Ma sulla terra le istituzioni restano quelle che sono. I cristiani sono animati dalla fede e dalla speranza; il male e l’odio vanno ripagati dall’amore. E l’amore è la «caritas», indirizzata verso tutti, verso il prossimo, verso i nemici.
L’amore tra uomo e donna dà luogo alla famiglia, viene santificato nel sacramento del matrimonio, indissolubile con i vincoli della fedeltà e l’obiettivo della procreazione. Si tratta dunque d’un amore che sale dai coniugi verso Dio e si santifica attraverso i figli e la loro educazione cristiana. La «pubblicità» dell’amore rimane dunque intatta, con una differenza essenziale rispetto al politeismo pagano: la «caritas» diventa il fondamento della religione. Paolo e Agostino arrivano a farne un valore addirittura più importante della stessa fede.
* * *
La cultura medievale inventa un altro tipo di amore: l’amore cortese, cantato dai trovatori nei castelli e portato in giro per l’Europa della lingua occitana e dell’italiano volgare. Lo «stil novo» vagheggia amori immaginari e figure di amati e di amanti stereotipi. Di qui sorge la malinconia che occhieggia nei versi del Guinizelli e diventa sostanza poetica nel Cavalcanti, nel Dante della "Vita Nova" e nel Petrarca.
Ma accanto all’amore cortese si affaccia quello licenzioso del Boccaccio e più tardi di Machiavelli della "Mandragola" e dell’Aretino. Sono i primi segnali del "privato" ma ci vorranno ancora due secoli perché il "privato" si affermi nelle società dell’Europa moderna.
* * *
Il «privato» nasce con l’Illuminismo con l’abolizione degli assoluti e dell’assoluto come concetto. Trasforma l’economia e la politica. Poteva il sentimento amoroso sottrarsi all’irruenza di questa rivoluzione?
Nasce infatti l’amore libertino, l’amore individuale, il «privato» dell’amore e nasce nei salotti gestiti da donne emancipate da una prima sembianza di femminismo. Diderot teorizza l’amore per l’amore che prevede la libertà di amori molteplici in nome, appunto, di amare l’amore.
Dura un secolo questa forma amorosa. Se si vuol chiedere alla letteratura, alla poesia e alla musica la chiave di un nuovo mutamento, la si trova nel Werther di Goethe, nelle "Affinità elettive", nella poesia di Leopardi e in quella di Baudelaire. L’amore romantico, la poesia e la musica romantiche.
L’Ottocento è intriso di amore romantico, dove si uniscono i sentimenti e i sensi ed è questo l’amore «privato» che diventa costume pubblico e che tuttora rappresenta uno dei cardini della società moderna.
Quell’amore tuttavia contiene le spore d’un mutamento ulteriore che emerge nella seconda metà del secolo scorso ed è ora nel pieno del suo svolgimento. Deriva proprio dal «privato», dalla sopravvenuta libertà sessuale, dall’accentuarsi dell’elemento sessuale e dalla liberazione della donna e del suo accesso al lavoro fuori casa.
L’amore romantico non è scomparso ma è divenuto mobile. Sempre più raramente dura per tutta la vita. Si realizza nella fase iniziale dell’innamoramento, si trasforma dopo qualche tempo in affetto e poi in amicizia. Infine la coppia si scompone e si ricompone con altri soggetti e altri innamoramenti. Sono segmenti di amore romantico al posto della linea retta dell’amore ottocentesco.
È a questo punto che l’amore verso l’amore riacquista peso e può - potrebbe - intrecciarsi alla solidarietà laica e alla «caritas» cristiana verso il prossimo, con uno spessore sociale in grado di soverchiare l’egoismo esasperato e l’amore egolatrico verso il proprio ombelico. Questa è la scommessa affidata al futuro: un mondo dove l’essere assume una curvatura erotica capace di avere la meglio sull’istinto del potere.
-