
MONSIGNOR RAVASI, MA NON È POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Una nota di Federico La Sala
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
 CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE (...)
CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE (...)
 DEUS CHARITAS EST
DEUS CHARITAS EST
 (1Gv 4. 1-8).
(1Gv 4. 1-8).
 BENEDETTO XVI,
BENEDETTO XVI,
 DEUS CARITAS EST,
DEUS CARITAS EST,
 2006
2006
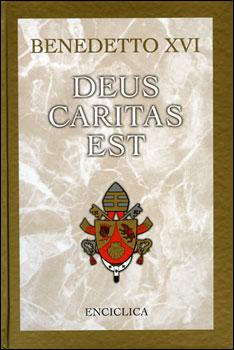
 CHARITAS (AMORE)
CHARITAS (AMORE)
 O
O
 CARITAS (CARO-PREZZO, DENARO, MAMMONA)?!
CARITAS (CARO-PREZZO, DENARO, MAMMONA)?!
 Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano.
Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano.
 Citazione: *
Citazione: *
GOD IS LOVE - This truth, which we consider foundational, was what I wished to emphasize in my first Encyclical, Deus Caritas Est...
DIO E’ AMORE - Questa verità, che consideriamo fondante, è ciò che ho voluto evidenziare nella mia prima Enciclica, Deus Caritas est ...
[...] The Christian tradition proclaims that God is Love (cf. 1 Jn 4: 16). It was out of love that he created the whole universe, and by his love he becomes present in human history. The love of God became visible, manifested fully and definitively in Jesus Christ. He thus came down to meet man and, while remaining God, took on our nature. He gave himself in order to restore full dignity to each person and to bring us salvation. How could we ever explain the mystery of the incarnation and the redemption except by Love? This infinite and eternal love enables us to respond by giving all our love in return: love for God and love for neighbour. This truth, which we consider foundational, was what I wished to emphasize in my first Encyclical, Deus Caritas Est, since this is a central teaching of the Christian faith. Our calling and mission is to share freely with others the love which God lavishes upon us without any merit of our own. [...]
[...] La tradizione cristiana proclama che Dio è Amore (cfr. 1 Gv 4, 16). È per amore che ha creato tutto l’universo, e con il suo amore si fa presente nella storia umana. L’amore di Dio è divenuto visibile, manifestato in maniera piena e definitiva in Gesù Cristo. Così egli è disceso per incontrare l’uomo e, pur rimanendo Dio, ha assunto la nostra natura. Ha donato se stesso per restituire la piena dignità a ogni persona e per portarci la salvezza. Come potremmo spiegare il mistero dell’incarnazione e della redenzione se non con l’Amore? Questo amore infinito ed eterno ci permette di rispondere dando in cambio tutto il nostro amore: amore verso Dio e amore verso il prossimo. Questa verità, che consideriamo fondante, è ciò che ho voluto evidenziare nella mia prima Enciclica, Deus Caritas est, poiché è un insegnamento centrale della fede cristiana. La nostra chiamata e la nostra missione sono di condividere liberamente con gli altri l’amore che Dio ci prodiga senza alcun merito da parte nostra [...]
*
Si cfr.:
 Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano
Il Papa incontra i partecipanti al primo seminario del forum cattolico-musulmano
 Il nome di Dio può essere solo
Il nome di Dio può essere solo
 un nome di pace e fratellanza,
un nome di pace e fratellanza,
 Osservatore Romano, 07 novembre 2008.
Osservatore Romano, 07 novembre 2008.
- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: «Il cristiano è un altro Cristo», sia diventata: «Il prete è un altro Cristo»" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
- PAOLO DI TARSO E COSTANTINO:"IN HOC SIGNO VINCES"!: «Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.
 Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
|
GRECIA - Una sede della "Caritas greca". |
- EPISTOLA ENCYCLICA - MIRAE CARITATIS SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI LEONIS PAPAE XIII. DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA
- MIRAE CARITATIS. LETTERA ENCICLICA
DI SUA SANTITÀ
LEONE PP. XIII. LA SANTA EUCARESTIA
|
IL PROTETTORE DEGLI ORAFI, SANT’ELIGIO DI NOYON (Petrus Christus, 1449) |
- Gianfranco Ravasi, Il principio della carità nella Scrittura
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
Il simbolo Chi-rho con Alfa e Omega, Catacombe di Domitilla, Roma:

- Del "Commento al Vangelo di Giovanni" di Agostino, Giovanni Reale ha curato una ’nuova’ edizione, basandosi sul classico testo dei Maurini, in cui è dato al Nome del Dio di Giovanni ("Deus charitas est) il nome della tradizione del "latinorum":"Deus caritas est".... E così - per la gloria del sacro e romano cattolicesimo - fa scomparire la traccia greca della Grazia e delle Grazie e celebra le "radici cristiane" dell’Europa!!!
- OGGI, COME IERI (CONTRO I "DUE SOLI" DELLA "MONARCHIA" DI DANTE), IL GIOCO "ETERNO" DELLA DIALETTICA ("SOLE E LUNA"): "IUSTITIA DUCE, CARITATE COMITE"! GAUDIUM ET SPES ( Paolo VI, 7 dic. 1965)):
 "69. De bonorum terrestrium ad universos homines destinatione.
"69. De bonorum terrestrium ad universos homines destinatione.
 Deus terram cum omnibus quae in ea continentur in usum universorum hominum et populorum destinavit, ita ut bona creata aequa ratione ad omnes affluere debeant, iustitia duce, caritate comite [...]" ("69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità [...]")
Deus terram cum omnibus quae in ea continentur in usum universorum hominum et populorum destinavit, ita ut bona creata aequa ratione ad omnes affluere debeant, iustitia duce, caritate comite [...]" ("69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità [...]")
- Il Papa:"Vorrei che la Chiesa mostrasse l’amore di Dio"
 Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
Francesco riceve i partecipanti a un convegno organizzato da Cor Unum nel decimo anniversario dell’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est.
|
FRANCESCO DI PAOLA (1416-1507) |
- MEMORIA EVANGELICA (CRISTICA E CRITICA): DA TREVISO E DALLA CALABRIA, SAN FRANCESCO DI PAOLA "RICORDA" ANCORA LA PAROLA-CHIAVE DELLA SUA VITA E DEL SUO ORDINE.
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE
- MESSAGGIO EVANGELICO E ANNO SACERDOTALE (2008-2010). Ai sacerdoti e ai religiosi che hanno abusato dei ragazzi, invece di dire "abbiamo", "noi", "dobbiamo", "abbiamo", Papa Ratzinger scrive: "Avete tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a Dio onnipotente, come pure davanti a tribunali debitamente costituiti. Avete perso la stima della gente" (Lettera, pf. 6)!!!
- UNA CRISI DELL’INTERO ORDINE SACERDOTALE E UNA "LETTERA PASTORALE" CHE PRENDE CON POCO CORAGGIO E MOLTA FURBIZIA (COME "TRADIZIONE" COMANDA) LE DISTANZE DA CRIMINI ABNORMI E DAL LAVORO DI INSABBIAMENTO ISTITUZIONALE. Una breve rassegna stampa sulle reazioni
- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- AL DI SOPRA DI TUTTO LA LEGGE, LA COSTITUZIONE, O "L’UOMO SUPREMO"?! LA "CHARITAS" O LA "CARITAS"?!
- LA PAROLA DEL VESCOVO (Mauro Russotto): "[...] In questa prima mia riflessione desidero soffermarmi sul motto episcopale del Vescovo Giovanni [Jacono],
con il quale abbiamo voluto titolare il bollettino:
Super omnia charitas. Si tratta delle parole che
San Paolo scrive nella Lettera ai Colossesi: «al di
sopra di tutto vi sia la carità» (Col 3,14). La carità è la dimensione e la virtù che sopravvive alla
stessa fede e alla speranza. Perché la carità è Dio,
è il nome nuovo di Dio... Deus charitas est [1 Gv. 4.8, giovanneo - non paolino, fls]. E
dunque Super omnia charitas è la nuova paolina formulazione del primo comandamento del decalogo di Mosè: Dio è l’Unico ed è sopra e al di
sopra di tutto!"
 (Cfr.
SVPER OMNIA CHARITAS - N. 1 •GIUGNO 2009,PERIODICO DELLA POSTULAZIONE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO MONS. GIOVANNI JACONO).
(Cfr.
SVPER OMNIA CHARITAS - N. 1 •GIUGNO 2009,PERIODICO DELLA POSTULAZIONE DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO MONS. GIOVANNI JACONO).
Doc.:
- CONSTITUTIO DOGMATICA DE ECCLESIA
 LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
- A) Testo latino
- 42. "Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo" (1 Io 4,16). Deus autem caritatem suam in cordibus nostris diffudit per Spiritum Sanctum qui datus est nobis (cf. Rom 5,5); ideoque donum primum et maxime necessarium est caritas, qua Deum super omnia et proximum propter Illum diligimus. Ut vero caritas tamquam bonum semen in anima increscat et fructificet, unusquisque fidelis debet verbum Dei libenter audire Eiusque voluntatem, opitulante Eius gratia, opere complere, sacramentis, praesertim Eucharistiae, et sacris actionibus frequenter participare, seseque orationi, sui ipsius abnegationi, fraterno actuoso servitio et omnium virtutum exercitationi constanter applicare. Caritas enim, ut vinculum perfectionis et plenitudo legis (cf. Col 3,14; Rom 13,10), omnia sanctificationis media regit, informat ad finemque perducit(132). Unde caritate tum in Deum tum in proximum signatur verus Christi discipulus.
- PAULUS EPISCOPUS
 SERVUS SERVORUM DEI
SERVUS SERVORUM DEI
 UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS
UNA CUM SACROSANCTI CONCILII PATRIBUS
 AD PERPETUAM REI MEMORIAM
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
- B) Testo italiano
- COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA
 LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
LUMEN GENTIUM (21 novembre 1964):
- 42. « Dio è amore e chi rimane nell’amore, rimane in Dio e Dio in lui » (1 Gv 4,16). Dio ha diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci fu dato (cfr. Rm 5,5); perciò il dono primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di lui. Ma perché la carità, come buon seme, cresca e nidifichi, ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e con l’aiuto della sua grazia compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto all’eucaristia, e alle azioni liturgiche; applicarsi costantemente alla preghiera, all’abnegazione di se stesso, all’attivo servizio dei fratelli e all’esercizio di tutte le virtù. La carità infatti, quale vincolo della perfezione e compimento della legge (cfr. Col 3,14; Rm 13,10), regola tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine [132]. Perciò il vero discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità verso Dio e verso il prossimo.
- PAOLO VI, "VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA"
- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.
- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo
- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).
Forum
-
>DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- TEOLOGIA E COSMOLOGIA. UN "SOGNO" DI TEOCRITO: L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».31 marzo 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA ("CHARITAS), E MEMORIA DEL CORAGGIO DI ASSAGGIARE ("SÀPERE AUDE") (ORAZIO - KANT):
- L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».
Una lezione di "recupero" di antropologia filosofica di Armando Massarenti ("Il Sole 24 Ore", 24 aprile 2011):
Sicuri che nessun pasto è gratis?
«Nessun pasto è gratis», fu la risposta che un re ebbe dai suoi consiglieri dopo aver a lungo insistito per sapere, in un sola frase, quale fosse il senso della scienza economica. #Michael #Brooks, già autore del best seller "13 cose che non hanno senso", nel volume sulla #Fisica nella collana "Le grandi domande", diretta da #Simon #Blackburn (Edizioni Dedalo) esordisce con queste parole: «La bellezza della fisica si riassume in un fatto semplicissimo: un #bambino può fare domande cui nessun professore può rispondere».
Una di queste è «Perché non esistono pranzi gratis?». Che, in fisica, ci spinge a dare risposte in termini di «energia, entropia e ricerca del moto perpetuo». #LeonardodaVinci fece un’analisi dettagliata di una famosa macchina che pretendeva di generare il moto perpetuo, e spiegò perché non poteva funzionare. «O ricercatori del moto perpetuo», concludeva, «quante idee sconclusionate avete concepito nel corso di questa ricerca. Sareste pronti per andare a fare gli alchimisti». Cioè a sognare altri pranzi gratis. Eppure un pasto gratis sembrerebbe esistere, ed sarebbe niente meno che il nostro stesso Universo.
Per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis», e ciò è dovuto al concetto cosmologico di «inflazione»: «l’Universo e tutta l’energia che contiene si sarebbero sviluppati a partire da un grammo di materiale. Una frazione di secondo dopo il #BigBang, l’Universo era cento miliardi di volte più piccolo di un protone, ma nel giro di 10-34 secondi aveva già raggiunto una dimensione pari a 1025 volte quella di partenza - qualcosa di simile a una biglia» e da lì sì è espanso sempre più fino alle immensità attuali. Nel corso di questo processo l’energia interna dell’Universo è cresciuta di un fattore 1075, il che sembrerebbe violare il principio che impedisce di avere qualcosa in cambio di nulla.
Invece c’è un dettaglio che permette di restare nell’ambito delle leggi fisiche conosciute: una parte dell’energia è negativa, come mostra la teoria della relatività generale. «L’energia associata alla materia è positiva - riassume Brooks -, e la creazione continua di materia fece aumentare l’energia positiva in modo tale da compensare l’aumento dell’energia negativa. In questo modo l’energia totale può rimanere costante. Gli antichi Greci affermavano che nulla può essere creato dal nulla, ma l’inflazione si permette di non essere d’accordo». E di affermare dunque la totale #gratuità dell’Universo.
Sarà proprio così? Di certo, nella nostra vita, ahinoi, continua a vigere la dura legge degli #economisti.
- NOTA:
- UN "SOGNO" DI TEOCRITO, LE GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE: UNA #DOMANDA DI ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...
- In ricordo di #LorenzoValla e di #GiambattistaVico, una breve nota....
-
>LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA! - ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E FILOLOGIA TEOLOGICO-POLITICA: "REMEMBER ME" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5).26 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA) ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E FILOLOGIA TEOLOGICO-POLITICA: "REMEMBER ME" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5).
Dantedi (#25marzo 2025). Un’indicazione per uscire dal "sottosuolo" ("underworld"): «#Trasumanar significar per verba / non si porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba.» (#Dante Alighieri, Par. I, 70-71).
- NOTE:
- Storia Letteratura e "Morfologia della Fiaba" (V. J. Propp): "#Divina Commedia" (#Dante Alighieri). Uscire dall’orizzonte più che millenario della #caverna polifemica e dalla cultura della #tragedia di #Platone, a quanto pare, se si tiene presente che il #24marzo si ricorda la #nascita di #Romolo e Remo e le cure della #Lupa, bisogna riconoscerlo, è possibile solo con l’aiuto di #animali #generosi - come l’ #ariete di #Ulisse o, addirittura, dello stesso #Lucifero, che rende facile a #Virgilio con #Dante attaccato al suo collo, la discesa "di #vello in vello" (Inf. XXXIV, 70-75), e, la stessa possibilità di #rinascere e rivedere le stelle.
- MEMORIA STORIA E ICONOGRAFIA EVANGELICA: IL #DANTEDI’ E L’ #ANNUNCIAZIONE (DELLA #NASCITA DI UN #BAMBINO) DELL’#ARCANGELO CON IL #FIORE DI #NARDO. Una nota sulla #coincidenza dei due temi del giorno (#25marzo 2025):
- a) "Annunciazione del Signore [...] Questo mistero era già stato preannunciato fin dal #ParadisoTerrestre, poi ripetuto più esplicitamente dai #Profeti. [...] Giunta la pienezza dei tempi, il tempo accettevole e propizio della Redenzione, mentre la purissima Vergine di Nazaret innalza le sue più ferventi preghiere per accelerare la venuta del Messia, le appare uno dei più fulgidi Arcangeli del Paradiso, Gabriele [...]"(cfr. "Santo del giorno", 25marzo);
- b) "Il nardo è il fiore di San Giuseppe [...] Solitamente il santo viene rappresentato con il bastone da cui sbocciano i gigli, il simbolo della purezza della Vergine Maria. Nei paesi ispanici molto spesso viene rappresentato nelle iconografie con un ramo di nardo in mano.
 Il nardo fa parte della famiglia delle valeriane ed è originario degli altopiani dell’Asia Centrale, con una diffusione anche in America Centrale e Messico" (cf. "Myriam", 10 maggio 2021).
Il nardo fa parte della famiglia delle valeriane ed è originario degli altopiani dell’Asia Centrale, con una diffusione anche in America Centrale e Messico" (cf. "Myriam", 10 maggio 2021).
- DANTE ALIGHIERI E LA "DIVINA #COMMEDIA": UNA #HAMLETICA #QUESTION(E) DI (#GIOACCHINO DA) #FIORE ("DI #SPIRITOPROFETICO DOTATO"): DAI #PROFETI E DALLE #SIBILLE (RICORDARE #MICHELANGELO), UNA INCESSANTE #RIVELAZIONE (#APOCALISSE).
- IL #DANTEDI’ (#25MARZO) COINCIDE CON L’ARRIVO DELLA #PRIMAVERA, LA #MEMORIA DELL’#ANNUNCIAZIONE (IL #CONCEPIMENTO DI UN #BAMBINO, CHIAMATO #GESU’), E, NON ULTIMO CON IL #CAPODANNO DI #FIRENZE, E CON LA BRILLANTISSIMA "CATTEDRALE DI #SANTA MARIA DEL FIORE".
- TEATRO (STORIA), METATEATRO (#METASTORIA), E #ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA): LA "#TRAPPOLA PER #TOPI" ("MOUSETRAP") E IL #DRAMMA DEI "#PROMESSI SPOSI" (#ALESSANDRO MANZONI, "1628").
- AMLETO E #OFELIA: UNA LOTTA CONTRO IL DIVIETO DEL "BRAVO" #RE CLAUDIO ("QUESTO #MATRIMONIO NON S’HA DA FARE"), PER PORTARE L’#EUROPA (LA "#DANIMARCA") FUORI DALL’ARIA PESTILENZIALE...
- L’ ATMOSFERA personale e politica nello #Stato, segnata dal #Re "falso e bugiardo" (come in #Terra, così in #Cielo), pesa sulla intera "#ricerca" di #Shakespeare. L’opera è un "work in progress": il "#marcio" del "#tempo fuori dai cardini" non pesa solo sui personaggi, e, in particolare, su Amleto e su Ofelia, ma sullo stesso Shakespeare (sul piano socio-culturale e politico-storico). L’importante (ai fini di una comprensione del "racconto") è la #memoria dei "fatti" da custodire da parte di #Orazio e l’arrivo di #Fortebraccio, sì da restituire senso e onore alla determinazione connessa all’aver portato avanti la lotta della "#vita contro la #morte".
- Alla luce di questa possibile linea di lettura dell’ #Amleto, e, sulle implicazioni teologico-politiche connesse, forse, è più che opportuno riflettere sulla interpretazione che, degli "ultimi drammi di Shakespeare", ne dà Frances A. #Yates ("Shakespeare’s Last Plays. A New Approach", 1975).
- STORIA DELLA FILOSOFIA E DELLA COSMOTEANDRIA MAMMONICA: "L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (#SHAKESPEARE, "SONETTO 116"). UNA CIT. DA "COSI’ PARLO’ #ZARATHUSTRA" (NIETZSCHE, 1885): "[...] Detto a tre occhi - disse argutamente il vecchio papa (perché era cieco da un occhio) - nelle cose di Dio ne so più io dello stesso Zarathustra; e può ben essere così. Il mio amore ha servito a lui per tanti anni, la mia volontà ha fatto sempre quanto lui voleva. Un buon servitore sa tutto, e sa anche le cose che il suo padrone spesso nasconde a se stesso.
 Era un Dio nascosto, pieno di segreti. Per dir la verità, ad avere un figlio ci arrivò per vie traverse. Alla soglia del suo Credo ci sta un adulterio.
Era un Dio nascosto, pieno di segreti. Per dir la verità, ad avere un figlio ci arrivò per vie traverse. Alla soglia del suo Credo ci sta un adulterio.
 Chi lo celebra come un dio d’amore non ha una grande opinione dell’amore. Non voleva forse questo dio fare anche il giudice? Ma chi ama, ama al di là del premio e della pena. [...] (F. Nietzsche, "Così parlò Zarathustra", parte IV, "A riposo").
Chi lo celebra come un dio d’amore non ha una grande opinione dell’amore. Non voleva forse questo dio fare anche il giudice? Ma chi ama, ama al di là del premio e della pena. [...] (F. Nietzsche, "Così parlò Zarathustra", parte IV, "A riposo").
-
> FEDE CRISTIANA: DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Betlemme dimenticata, è ormai un Natale senza Gesù? La Natività, quasi scomparsa dall’immaginario natalizio commerciale (di Marina Corradi)19 novembre 2024, di Federico La Sala
Betlemme dimenticata, è ormai un Natale senza Gesù?
di Marina Corradi (Avvenire, domenica 17 novembre 2024)
Cercavo, sapete, uno di quei calendari d’Avvento con le caselle, da aprire una al giorno, per ultima la capanna di Betlemme. Lo prendevo sempre, ai bambini. Ma i figli sono diventati grandi. Ora che il maggiore dei nipoti ha 4 anni volevo per lui un calendario d’Avvento. Nelle cartolerie in cui sono entrata ne avevano esclusivamente però con Babbi, renne e slitte. «E con Betlemme, niente?» ho chiesto. «Non ci arrivano più», mi hanno risposto. Cocciuta, vado sul web. Di calendari d’Avvento, mille, ma tutti nella nuova versione: Babbi, gnomi, e in ogni casella una caramella, un cioccolatino, veri. Tutte le marche di cioccolato hanno il loro calendario.
 Però io mi ostinavo con quello con Betlemme. Ne ho trovato due, infine, nel Vermont, Usa: faranno un bel viaggio, fino a qui. Dopo averli ordinati ho pensato che gli editori cattolici di certo fanno ancora i calendari con Gesù Bambino. Infatti: ma li si trova quasi solo nelle librerie cattoliche, che non sono molte. E, i libri? Ho girato il centro di Milano. A un mese dal Natale, in una lussuosa libreria di piazza Duomo, di volumi natalizi per bambini ce n’erano tanti: ma Babbi, Babbi, e renne ed elfi.
Però io mi ostinavo con quello con Betlemme. Ne ho trovato due, infine, nel Vermont, Usa: faranno un bel viaggio, fino a qui. Dopo averli ordinati ho pensato che gli editori cattolici di certo fanno ancora i calendari con Gesù Bambino. Infatti: ma li si trova quasi solo nelle librerie cattoliche, che non sono molte. E, i libri? Ho girato il centro di Milano. A un mese dal Natale, in una lussuosa libreria di piazza Duomo, di volumi natalizi per bambini ce n’erano tanti: ma Babbi, Babbi, e renne ed elfi.
 La Natività, quasi scomparsa dall’immaginario natalizio commerciale. Certo la Natività c’è nelle chiese, nelle case di molti, e in non tutte le scuole. Raramente oltre questi confini. Il Presepe in un recinto: roba cristiana, fanno intendere, gentili, le commesse di Milano. In vetrina fila di libri sul Natale, ma non uno con Maria e Giuseppe, la capanna, i Magi. Infine in un negozio di quartiere, gente gentile, una commessa dice con un po’ di imbarazzo: «Ce ne deve essere qualcuno lassù, in quella cassa in bagno». Infatti qualcosa, non fresco di stampa, c’era ancora, e me lo sono portato a casa.
La Natività, quasi scomparsa dall’immaginario natalizio commerciale. Certo la Natività c’è nelle chiese, nelle case di molti, e in non tutte le scuole. Raramente oltre questi confini. Il Presepe in un recinto: roba cristiana, fanno intendere, gentili, le commesse di Milano. In vetrina fila di libri sul Natale, ma non uno con Maria e Giuseppe, la capanna, i Magi. Infine in un negozio di quartiere, gente gentile, una commessa dice con un po’ di imbarazzo: «Ce ne deve essere qualcuno lassù, in quella cassa in bagno». Infatti qualcosa, non fresco di stampa, c’era ancora, e me lo sono portato a casa.
 Cose da poco? Invece Betlemme censurata mi ha turbato. I credenti in Italia ancora non sono così pochi, e al Giubileo a Roma sono attese milioni di persone. Dunque, commercialmente parlando, la “domanda” di libri sulla Natività per bambini dovrebbe persistere. La risolvono solo le librerie cattoliche?
Cose da poco? Invece Betlemme censurata mi ha turbato. I credenti in Italia ancora non sono così pochi, e al Giubileo a Roma sono attese milioni di persone. Dunque, commercialmente parlando, la “domanda” di libri sulla Natività per bambini dovrebbe persistere. La risolvono solo le librerie cattoliche?
 Confesso, mi brucia questa sensazione di apartheid. Roba per “noi” soltanto. È la cultura woke, mi sono chiesta? La rimozione di tutto ciò che non è culturalmente corretto, di quanto non è universalmente condivisibile con i non credenti, o credenti di altre fedi?
Di modo che la Natività sta in un angolo, per non dare fastidio. La storia dei due pellegrini stanchi che non trovavano un tetto, lei presa dalle doglie, e finalmente accolti in una stalla, fino a vent’anni ancora era tramandata ai figli. Ora è messa da parte, come un’ingenua fiaba. Invece così terribilmente attuale, quella coppia di migranti soli nella notte e nel freddo, che nessuno accoglie. E fino a qui, forse, ci starebbero anche quei due, nella nuova cultura “corretta”.
Confesso, mi brucia questa sensazione di apartheid. Roba per “noi” soltanto. È la cultura woke, mi sono chiesta? La rimozione di tutto ciò che non è culturalmente corretto, di quanto non è universalmente condivisibile con i non credenti, o credenti di altre fedi?
Di modo che la Natività sta in un angolo, per non dare fastidio. La storia dei due pellegrini stanchi che non trovavano un tetto, lei presa dalle doglie, e finalmente accolti in una stalla, fino a vent’anni ancora era tramandata ai figli. Ora è messa da parte, come un’ingenua fiaba. Invece così terribilmente attuale, quella coppia di migranti soli nella notte e nel freddo, che nessuno accoglie. E fino a qui, forse, ci starebbero anche quei due, nella nuova cultura “corretta”.
 Lo scandalo è quel bambino, nato da donna che non conosceva uomo; è la pretesa che quel bambino fosse il figlio di Dio. Come si fa a raccontare certe cose, ai bambini d’oggi? Eppure vanno matti per renne, Babbi e gnomi. Quelli, non danno fastidio a nessuno. La piccola ricerca fra vetrine mi ha colpito: la fede comincia da piccoli, milioni e milioni di volte è ricominciata davanti a un presepe. Milioni di bambini, crescendo, poi l’hanno rinnegata. Ma rimaneva nel fondo della coscienza, silenziosa, Betlemme - quell’incredibile salvifico dono. A volte Betlemme riemerge, carsica, negli ospedali in cui vecchi soli pronunciano, sessant’anni dopo, una preghiera. In chi spereranno i nipoti, in Babbo Natale, in un giorno lontano? La tradizione cristiana allontanata dai bambini sa di decadenza di un mondo. Natale, è dire ai figli che Cristo è nato. Altrimenti renne, e slitte colme di regali, ma niente che resti - niente che duri per sempre.
Lo scandalo è quel bambino, nato da donna che non conosceva uomo; è la pretesa che quel bambino fosse il figlio di Dio. Come si fa a raccontare certe cose, ai bambini d’oggi? Eppure vanno matti per renne, Babbi e gnomi. Quelli, non danno fastidio a nessuno. La piccola ricerca fra vetrine mi ha colpito: la fede comincia da piccoli, milioni e milioni di volte è ricominciata davanti a un presepe. Milioni di bambini, crescendo, poi l’hanno rinnegata. Ma rimaneva nel fondo della coscienza, silenziosa, Betlemme - quell’incredibile salvifico dono. A volte Betlemme riemerge, carsica, negli ospedali in cui vecchi soli pronunciano, sessant’anni dopo, una preghiera. In chi spereranno i nipoti, in Babbo Natale, in un giorno lontano? La tradizione cristiana allontanata dai bambini sa di decadenza di un mondo. Natale, è dire ai figli che Cristo è nato. Altrimenti renne, e slitte colme di regali, ma niente che resti - niente che duri per sempre. -
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON È POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- FILOLOGIA ("LOGOS") E STORIOGRAFIA. "Dio" non confonde "amore" ("CHARITAS") con "mammona" ("CARITAS").19 agosto 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA ("LOGOS")
E
"MAGNA CHARTA LIBERTATUM":
"IL BUON DIO STA NEL DETTAGLIO" (ABY WARBURG):
IL DIAVOLO FA LE PENTOLE, MA NON I COPERCHI.
"Dio" non imbroglia e non confonde "amore" ("CHARITAS") con "mammona" ("CARITAS").
-
>DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- FILOLOGIA-POLITICA AL SERVIZIO DELL’OCCIDENTE (325 -2025). UN "GIOGO" DI SOCIETÀ: "CERCARE L’AGO NEL PAGLIAIO".16 agosto 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA (PROMESSA), ONU (=UNO), E "UmaNITÀ" ("HUMANITAS"):
PROFEZIA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA-POLITICA.
- Una nota "per la pace perpetua". In #memoria di #Immanuel #Kant (1724-1804).
SE E’ VERO CHE "DA TEMPO I PROFETI PARLANO A UNA CITTA’ CHE NON LI VUOLE PIU’ ASCOLTARE!" (Nicola Fanizza), E’ ALTRETTANTO VERO CHE, DA #TEMPO, DA MOLTO TEMPO, nonostante tutta la #storia (già solo quella) dell’#arte e, in particolare, la grande lezione di #Michelangelo #Buonarroti, che sapeva anche di #anatomia e di "vecchio" e "nuovo" #testamento" , è anche colpa dei #PROFETI che hanno "silenziato" le #Sibille, hanno buttato via la #bilancia (Vermeer ), e vogliono continuare a "pesare" solo "l’ #oro"!!!
CON DANTE ALIGHIERI, GIORDANO BRUNO, GALILEO GALILEI, SPINOZA, FREUD, ED EINSTEIN, #OLTRE. Senza #Kant, solo milioni di milioni di "mille piani", vecchi "ritornelli", e "dotta ignoranza" (1440) a volontà.
NOTE:
- ANTROPOLOGIA ANATOMIA E STORIA: "COME NASCONO I BAMBINI".
- IL "TONDO DONI" E LA "PROFEZIA" DELLA "SIBILLA LIBICA" DI MICHELANGELO BUONARROTI:
- «[...] Uterus Matris erit #statera cunctorum. ("L’utero della Madre sarà la #bilancia di tutti gli esseri umani")».
- IPOTESI. Del dipinto "#Pesatrice di perle" (o "#Donna con una #bilancia) di Jan #Vermeer (databile al 1664 e conservato nella National Gallery of Art di Washington), anche alla luce del fatto che dentro il quadro c’è rappresentato un altro quadro - un dipinto con un #GiudizioUniversale - c’è da pensare, probabilmente, che la figura della donna in avanzato stato di #gravidanza rimandi alla figura della "Sibilla Libica" (raffigurata da tantissimi artisti e, in particolare, da Michelangelo nella #CappellaSistina) e al suo specifico #annuncio del #messaggio evangelico, e comunichi il rapporto che esiste tra la #bilancia (la #giustizia e l’#equilibrio), il #grembo (il #concepimento), e la nascita di un #bambino, una #bambina - una #maestra, un #maestro di #umanità...
- IPOTESI. Del dipinto "#Pesatrice di perle" (o "#Donna con una #bilancia) di Jan #Vermeer (databile al 1664 e conservato nella National Gallery of Art di Washington), anche alla luce del fatto che dentro il quadro c’è rappresentato un altro quadro - un dipinto con un #GiudizioUniversale - c’è da pensare, probabilmente, che la figura della donna in avanzato stato di #gravidanza rimandi alla figura della "Sibilla Libica" (raffigurata da tantissimi artisti e, in particolare, da Michelangelo nella #CappellaSistina) e al suo specifico #annuncio del #messaggio evangelico, e comunichi il rapporto che esiste tra la #bilancia (la #giustizia e l’#equilibrio), il #grembo (il #concepimento), e la nascita di un #bambino, una #bambina - una #maestra, un #maestro di #umanità...
- VITAEFILOSOFIA: #COMENASCONOIBAMBINI, COME NASCONO LE #IDEE, COME NASCONO I #SOGNI?
- RILEGGERE PLATONE ("SIMPOSIO")! DIOTIMA DI #MANTINEA SOLLECITA "SAN #SOCRATE" (#ERASMO) AD ANDARE DIRETTAMENTE A #DELFI E A NON #CREDERE DI CREDERE AGLI AMICI CHE LO HANNO ELETTO IL PIù #SAGGIO DI TUTTI: E’ ANCORA UN "PERFETTO FILOSOFO!" (COME #EROS, AVIDO, CIECO E PREPOTENTE) E NON CONOSCE SE’ STESSO! ( v. allegato: una "citazione" dal mio lavoro, "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", #AntonioPellicani, Roma 1991).
- ANTROPOLOGIACULTURALE E #FILOLOGIA-#POLITICA AL SERVIZIO DELL’#OCCIDENTE (325 -2025).
- UN "GIOGO" DI #SOCIETÀ: "CERCARE L’AGO NEL PAGLIAIO".
- Foto allegata:
 A) "CHERCHEZ LES FEMMES",
A) "CHERCHEZ LES FEMMES",
 B) "TROUVÉES: AU DERNIER RANG!"
B) "TROUVÉES: AU DERNIER RANG!"
-
>LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! --- UNA DOMANDA SULLA "PAROLA D’ORO": DEUS "CHARITAS" (AMORE) O DEUS "CARITAS" (MAMMONA)!?31 luglio 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA E TEOLOGIA E STORIA DEL CRISTIANESIMO.
UNA DOMANDA SULLA "PAROLA D’ORO":
DEUS "CHARITAS" (AMORE) O DEUS "CARITAS" (MAMMONA)!?
La "charitas" è diventata la"#caritas", una parola della lingua latina (anzi del "#latinorum"), e ha assunto un significato equivoco, che rinvia alla ricchezza economica e a un #caro, nel senso di "#tesoro", e dell’oro, economicamente e affettivamente).
RICORDO DI SAN PIETRO CRISOLOGO (30 LUGLIO 2024): "[...] Fu grande oratore, per questo fu detto «Crisologo» che vuol dire «Parola d’oro». Ma fu ancora più grande come scrittore tanto da essere proclamato Dottore della Chiesa. Lasciò moltissimi discorsi ed omelie di cui ben 176 sono pervenuti fino a noi. I più celebri sono quelli contro le calende di gennaio in cui non si stanca di ripetere che
 «non potrà godere con Cristo in cielo chi vuol godere col diavolo in terra ».
«non potrà godere con Cristo in cielo chi vuol godere col diavolo in terra ».Verso la fine della sua feconda vita, lavorò alla difesa del dogma cattolico contro Eutiche. Questo eretico confondeva in una sola le due distinte nature, umana e divina, esistenti nella persona di Gesù Cristo [...]". (ripresa parziale).
Federico La Sala
-
> MA NON È POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - ANTROPOLOGIA HAMLETICA, FILOLOGIA, E SERENDIPITY: "LA MADONNA DELLA GATTA" (DI FEDERICO BAROCCI) E "THE MOUSETRAP" DI AMLETO (SHAKESPEARE).22 luglio 2024, di Federico La Sala
TEATRO METATEATRO E SERENDIPITY:
UNA SORPRENDENTE LEZIONE DI FILOLOGIA HAMLETICA
SULLE RAGIONI DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE)!
- Una nota di commento in omaggio all’anima profetica ("prophetic soul") di Salvo Salvatore Micciché, un invito a rileggere l’#Amleto, e un grande "grazie" a Les Chatons Romantiques *
Il #gatto, una vera e propria "#trappola per #topi" ("The mousetrap"), ne ha mangiati tanti di "gatti", che ora non riesce più a "funzionare", nemmeno a muoversi, e dorme solo dalla mattina alla sera, e per tutta la notte, davanti allo #specchio!
- NOTA: AD "AMLETO", IL "PRESEPE" DELLO "STATO DI DANIMARCA" NON PIACE! SHAKESPEARE, IL MOSCHETTIERE DELL’ INGHILTERRA DELLA REGINA #ELISABETTA).
NOTE:
- ANTROPOLOGIA HAMLETICA, FILOSOFIA E STORIA DELL’ARTE. LA "MADONNA DELLA GATTA" di Federico Barocci (Urbino 1528/1535 - 30 settembre 1612): "Visita di Sant’Elisabetta, con San Giovanni Battista e San Zaccaria, alla Madonna col Bambino e San Giuseppe, detta "Madonna della gatta" (Galleria degli Uffizi).
- ENIGMI D’ARTE. Federico Barocci e il mistero della Madonna della Gatta" (Redazione "StileArte", 27 NOVEMBRE 2018).
-
> DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- BOTANICA FILOLOGIA E TEOLOGIA: "LE ERBE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA". Una nota a margine del libro di Carmine Lupia e Giancarlo Statti.10 maggio 2024, di Federico La Sala
ERBORISTERIA ANTICA E MODERNA: BOTANICA #FILOLOGIA, #ANTROPOLOGIA, STORIA, E #TEOLOGIA...
"LE ERBE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA". Una nota a margine della presentazione del libro di Carmine Lupia, Giancarlo Statti (*)
CONSIDERATO CHE LA VITA E LE OPERE DI FRANCESCO DI PAOLA SONO "SCRITTE" DENTRO IL SUO "CUORE" E SUL SUO PETTO (NELLA TRADIZIONE ICONOGRAFICA), NELLA PAROLA "CHARITAS",
 FORSE,
FORSE,
 E’ OPPORTUNO E NECESSARIO PRECISARE CHE "DIMENTICARE" L’ #ACCA ("H") SI PERDE (COME E’ SUCCESSO) LA #MEMORIA STESSA DELL’ESSENZIALE, E L’#ASSENZA DI UN ELEMENTO, UNA "LETTERA", PRODUCE EFFETTI "ATOMICI", COSTA #CARO, MOLTO CARO: IL #PREZZO SALE E LA "BUONA" ("#EU") CARESTIA ("CARITAS") ANCHE, FINO A DESERTIFICARE TUTTO.
E’ OPPORTUNO E NECESSARIO PRECISARE CHE "DIMENTICARE" L’ #ACCA ("H") SI PERDE (COME E’ SUCCESSO) LA #MEMORIA STESSA DELL’ESSENZIALE, E L’#ASSENZA DI UN ELEMENTO, UNA "LETTERA", PRODUCE EFFETTI "ATOMICI", COSTA #CARO, MOLTO CARO: IL #PREZZO SALE E LA "BUONA" ("#EU") CARESTIA ("CARITAS") ANCHE, FINO A DESERTIFICARE TUTTO.ALLA LUCE DI QUESTA BREVE PREMESSA FILO-#LOGICA, C’E’ DA AUGURARSI CHE II LIBRO SULLE "ERBE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA" (Rubbettino Editore) POSSA ESSERE (O DIVENTARE) UNA BELLA OPPORTUNITÀ PER RIFLETTERE
 SULLA GRANDE IMPORTANZA TEORICA E PRATICA DELL’ INSEGNARE E DELL’IMPARARE A SAPER #ACCOGLIERE BENE LE "DIFFERENZE" TRA LE VARIE "ERBE" E, CONSEGUENTEMENTE,
SULLA GRANDE IMPORTANZA TEORICA E PRATICA DELL’ INSEGNARE E DELL’IMPARARE A SAPER #ACCOGLIERE BENE LE "DIFFERENZE" TRA LE VARIE "ERBE" E, CONSEGUENTEMENTE,
 SULL’ USARE CON ATTENZIONE E RESPONSABILITÀ #PAROLE #CHIARE NELL’INDICARLE, SENZA PERDERE UN’ ACCA (UNA "H") E SENZA RENDERE CARO, TROPPO #CARO, IL #PREZZO ("#CARITAS") DEI PRODOTTI
SULL’ USARE CON ATTENZIONE E RESPONSABILITÀ #PAROLE #CHIARE NELL’INDICARLE, SENZA PERDERE UN’ ACCA (UNA "H") E SENZA RENDERE CARO, TROPPO #CARO, IL #PREZZO ("#CARITAS") DEI PRODOTTI
 DONO DI MADRE #TERRA E FRUTTO DELL’ INTELLIGENTE E ACCURATO #LAVORO DI #RICERCA DEGLI ESSERI UMANI SU TUTTO IL PIANETA
DONO DI MADRE #TERRA E FRUTTO DELL’ INTELLIGENTE E ACCURATO #LAVORO DI #RICERCA DEGLI ESSERI UMANI SU TUTTO IL PIANETA
 (E, POSSIBILMENTE, NON FARE DELLA "CARITÀ", CIOE’ DELLA "CARITAS", ADDIRITTURA LA "DEA" O, MEGLIO, IL "#DEUS EX #MACHINA" DEL #MERCATO PLANETARIO).
(E, POSSIBILMENTE, NON FARE DELLA "CARITÀ", CIOE’ DELLA "CARITAS", ADDIRITTURA LA "DEA" O, MEGLIO, IL "#DEUS EX #MACHINA" DEL #MERCATO PLANETARIO).NOTE:
- SONNODOGMATICO (#KANT), #PREISTORIA (#MARX), E #LETARGO (#Dante2021): SULLA #COSMOTEANDRIA DELLA #TEORIA PLATONICO-ARISTOTELICA DEL "#SAPIENTE" (#BOVILLUS, 1510), ALLEGO
- UNA "BELLA" SINTESI "ANTROPOLOGICA" DAL LAVORO DI #STEFANO MANCUSO E #ALESSANDRAVIOLA "VERDE BRILLANTE. SENSIBILITà E INTELLIGENZA DEL MONDO VEGETALE" (Giunti Editore).
- Dialoghi di Pistoia (#24MAGGIO 2024): Stefano Mancuso, "Una specie senza limiti: come fare a non mangiarsi la Terra".
- ANTROPOLOGIA CON #FILOSOFIA (#ANTHROPOS), #TEOLOGIA CON #POLITICA (#CORPOMISTICO), E #FILOLOGIA (NON CON #CARESTIA, MA) CON GRAZIA ("EU-#CHARIS -TIA"). Dialoghi di Pistoia: "Siamo ciò che mangiamo? #Nutrire il #corpo e la #mente".
-
> DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- IL PAPA, "PATRIARCA D’OCCIDENTE". L’approssimarsi del 17° centenario del Concilio di Nicea, svoltosi nel 325 dopo Cristo, "come per un nuovo inizio"..13 aprile 2024, di Federico La Sala
Santa Sede.
Il Papa torna a essere “patriarca d’Occidente”: che cosa vuol dire
di Redazione Catholica (Avvenire, giovedì 11 aprile 2024)
Il Papa torna a essere anche patriarca d’Occidente.
 Lo spiega l’agenzia Fides osservando come il titolo compaia nell’Annuario pontificio del 2024, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Tale definizione era scomparsa nel 2006 su disposizione di Benedetto XVI. Nel comunicato diffuso allora dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani si chiariva che il titolo di «patriarca d’Occidente» era stato adoperato nell’anno 642 da Papa Teodoro I. In seguito, il suo utilizzo aveva preso piede nel XVI e XVII secolo, «nel quadro del moltiplicarsi dei titoli del Papa» nell’’Annuario Pontificio esso era apparso per la prima volta nel 1863. Il termine “Occidente” - proseguiva il comunicato «non intende descrivere un territorio ecclesiastico né esso può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale». Quindi il titolo «patriarca d’Occidente» - prosegue Fides citando il comunicato del 2006 «descriverebbe la speciale relazione del Vescovo di Roma a quest’ultima, e potrebbe esprimere la giurisdizione particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina». Tuttavia, la soppressione di tale titolo non sottintendeva “nuove rivendicazioni” papali rispetto alle Chiese d’Oriente, ma era espressione di un “realismo storico e teologico” che spingeva a mettere da parte un titolo considerato obsoleto.
Lo spiega l’agenzia Fides osservando come il titolo compaia nell’Annuario pontificio del 2024, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Tale definizione era scomparsa nel 2006 su disposizione di Benedetto XVI. Nel comunicato diffuso allora dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani si chiariva che il titolo di «patriarca d’Occidente» era stato adoperato nell’anno 642 da Papa Teodoro I. In seguito, il suo utilizzo aveva preso piede nel XVI e XVII secolo, «nel quadro del moltiplicarsi dei titoli del Papa» nell’’Annuario Pontificio esso era apparso per la prima volta nel 1863. Il termine “Occidente” - proseguiva il comunicato «non intende descrivere un territorio ecclesiastico né esso può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale». Quindi il titolo «patriarca d’Occidente» - prosegue Fides citando il comunicato del 2006 «descriverebbe la speciale relazione del Vescovo di Roma a quest’ultima, e potrebbe esprimere la giurisdizione particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina». Tuttavia, la soppressione di tale titolo non sottintendeva “nuove rivendicazioni” papali rispetto alle Chiese d’Oriente, ma era espressione di un “realismo storico e teologico” che spingeva a mettere da parte un titolo considerato obsoleto.La scelta di papa Francesco di ripristinare il titolo di patriarca d’Occidente - prosegue ancora Fides - può essere collegata alla sua insistenza sulla importanza della sinodalità, e alla sollecitudine ecumenica che spinge a guardare sempre ai primi secoli del cristianesimo, quando tra le Chiese non c’erano lacerazioni di carattere dogmatico. Il titolo di patriarca d’Occidente richiama in qualche modo anche l’esperienza del Primo Millennio cristiano, quando le cinque sedi della cristianità antica (Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), pur nella differenza delle rispettive storie e dei diversi accenti spirituali, rivestivano un rilievo particolare per il vincolo che le univa alla Tradizione apostolica. I rapporti di queste cinque sedi, nella comunione, apparivano strutturati nella prassi che gli studi di storia della Chiesa definiscono come “Pentarchia”.
In un momento storico segnato dal dilagare di conflitti che spingono i popoli verso il baratro di una terza guerra mondiale, la sollecitudine ecumenica vede come occasione propizia l’approssimarsi del 17° centenario del Concilio di Nicea, svoltosi nel 325 dopo Cristo. I cristiani - come ha suggerito Papa Francesco già il 6 maggio 2022 - hanno la possibilità di riunirsi e celebrare insieme i 17 secoli dal Concilio di Nicea, come per un nuovo inizio. E nel 2025, tutti i cristiani per coincidenze di calendario, tutti i cristiani celebreranno la Pasqua nello stesso giorno, domenica 20 aprile.
Dunque, nell’Annuario pontificio, i titoli del Papa sono: vicario di Gesù Cristo, successore del principe degli apostoli, Sommo Pontefice della Chiesa universale, patriarca d’Occidente, primate d’Italia, arcivescovo e metropolita della provincia romana, sovrano dello Stato della Città del Vaticano, servo dei servi di Dio.
-
> DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - TEOLOGIA E FILOLOGIA. "Sur la montagne: l’aspérité et la grâce" (Adrien Candiard). Imparare a lasciarsi amare da Dio: il segreto perduto della grazia ( di Roberto I. Zanini).10 aprile 2024, di Federico La Sala
Teologia.
Imparare a lasciarsi amare da Dio: il segreto perduto della grazia
Il teologo domenicano Adrien Candiard torna su un tema antico ma dibattuto a suo avviso in modo fuorviante: la grazia è un incontro d’amore. Ma l’essenziale può essere abbagliante...
di Roberto Italo Zanini (Avvenire, martedì 9 aprile 2024)
«Maestro cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». Un libro che comincia con la domanda del “giovane ricco” (Mt19,16) e finisce con una limpida considerazione sull’essenzialità della grazia di Dio che «è un incontro ed è un incontro d’amore» è certamente provocatorio. Lo stesso autore, il teologo domenicano Adrien Candiard, sottolinea che «tutti i discorsi teologici sulla grazia sviluppati nel corso dei secoli... sono andati fuori strada quando hanno mancato l’essenziale». La lista è lunga e attraversa i millenni fra dotti dibattiti teologici (domenicani-gesuiti), scismi, controriforma, concili, contrapposizioni pastorali e via dicendo. Eppure, quell’essenziale «abbaglia come il sole estivo di Galilea che si avvicina allo zenit», dice l’autore ricordando un recente pellegrinaggio al Monte delle beatitudini. È l’ineguagliabile e spesso misconosciuta originalità della vita cristiana, oggi sperduta nella nebbia di senso e di verità che avvolge le sempre più esigue Chiese d’Occidente.
L’essenziale «abbaglia», ma evidentemente non è facile da cogliere. Il giovane ricco va cercando proprio quello: la vita vera, fatta delle cose che contano, che danno piena soddisfazione, che ci fanno felici e restano per l’eternità. Lui, che è un’anima bella e osserva tutti i comandamenti, lo va a chiedere proprio alla “luce che brilla come il sole”, che prontamente lo ama, ma lui non riesce a restarne illuminato. Come noi e come i discepoli nel racconto evangelico, viene travolto dalla cruda risposta di Gesù: «Se vuoi essere perfetto, vai, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!».
Candiard si dice travolto anch’egli dall’enormità delle parole di Gesù e nel libro pone il quesito che interroga i cristiani fin da san Paolo: ma se, come dice l’Apostolo, è la fiducia nella grazia a donare la vita eterna, perché Gesù, che è sempre accogliente con tutti, domanda al giovane come se la cava coi comandamenti e poi formula una proposta di perfezione così esigente che gli stessi discepoli, sgomenti, si chiedono, ma allora chi può essere salvato? In quest’ottica la replica di Gesù, «impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile», risulta un chiarimento efficace, ma non risponde al quesito sul valore della grazia e su quello delle opere.
 Dilemma millenario e scismatico che riemerge ciclicamente e con prepotenza condizionante, al punto che papa Francesco ha più volte sottolineato il pericolo per la Chiesa di oggi di restare ingabbiata in un nuovo pelagianesimo. Perché puntando tutto sulla prassi, sulla dottrina sociale, sulle opere assistenziali, sulle cose da fare, sulla liturgia ridotta a routine, sulle preghiere senz’anima si finisce per perdere il carisma profetico e autenticamente cristiano, che viene dall’apertura totale all’amore di Dio, all’azione dello Spirito.
Dilemma millenario e scismatico che riemerge ciclicamente e con prepotenza condizionante, al punto che papa Francesco ha più volte sottolineato il pericolo per la Chiesa di oggi di restare ingabbiata in un nuovo pelagianesimo. Perché puntando tutto sulla prassi, sulla dottrina sociale, sulle opere assistenziali, sulle cose da fare, sulla liturgia ridotta a routine, sulle preghiere senz’anima si finisce per perdere il carisma profetico e autenticamente cristiano, che viene dall’apertura totale all’amore di Dio, all’azione dello Spirito.Ecco allora la provocazione di questo libro, che nell’edizione italiana, (Lev, pagine 109, euro 13) ha un titolo esplicativo e pratico: La grazia è un incontro. E nel sottotitolo specifica: Se Dio ama gratis, perché i comandamenti? Nell’originale francese, invece, il titolo, più simbolico, indica il percorso teologico-spirituale seguito da Candiard per fondare evangelicamente le ragioni della Grazia. Percorso che pone le sue radici nel Discorso della montagna: Sur la Montagne. L’aspérité et la grâce. E sulla Montagna Gesù comincia con le Beatitudini (Mt5, 3-12) che certamente costituiscono un programma esigente, e prosegue con altre “asperità” come: amate i nemici, porgete l’altra guancia, date a chi chiede, non preoccupatevi di quello che mangerete, non potete servire Dio e cercare la ricchezza... Raccomandazioni che a metterle in pratica, specifica il Vangelo, si fa come chi costruisce la propria casa sulla roccia (Mt7,24-27).
Se la parola “beati”, dice Candiard, può agevolmente essere resa con “felici”, le Beatitudini sono il percorso della vera felicità e restarne spiazzati è la prima conseguenza per il lettore attento. Cosa c’entra la felicità con la fame di giustizia, con la persecuzione, col pianto, con la povertà? Tanto più, possiamo aggiungere, che la gioia della risurrezione è pura felicità? Per uscire da questa rischiosa incomprensione, il padre domenicano ci ricorda che per Gesù la felicità non è nel non avere nulla, ma nel possedere il Regno di Dio, nell’abitarlo. Pertanto, «Quello che conviene cercare non è essere poveri, tristi o affamati di giustizia, ma è: essere consolati, saziati, perdonati, essere chiamati figli di Dio, è vedere Dio». Insomma, ciò che genera e dona la vera felicità, la vita vera; ciò che cercava il giovane ricco e che probabilmente cerca nel proprio intimo ognuno di noi, è tutto questo insieme, è il Regno di Dio, la perla preziosa da desiderare più di ogni altro bene al mondo. E il Regno di Dio non è l’Onnipotente che viene a prendere il controllo del mondo, ma è il suo amore incondizionato che si rivela in una povera mangiatoia e si offre sulla croce rigenerando la vita, la felicità eterna. Il Regno di Dio è amore, ed è amore donato, offerto a tutti, gratis, per sempre. Amore capace di renderci figli: divini come lui è divino. Questa è la buona novella. Questa è la grazia, sottolinea Candiard. E per cambiare le nostre vite, secondo il desiderio del giovane ricco, dobbiamo semplicemente desiderare di essere sanati e lasciarci sanare, desiderare di essere amati e lasciarci amare.
Facile? Evidentemente no se Pietro rifiuta, in prima battuta, che il Maestro lavi i suoi piedi (Gv 13,8); se tanta gente si indigna nel vedere Gesù che accetta di farsi profumare i piedi da una prostituta (Lc 7,38); se c’è chi si presenta alla festa di nozze senza essersi lasciato vestire con l’abito nuziale (Mt 22,12); se dopo secoli di dibattito teologico ancora adesso corriamo il rischio di restare irretiti dall’inganno pelagiano di conquistarci il Regno con le nostre forze, pur essendo stati avvertiti da Gesù in persona che non ne abbiamo a sufficienza.
 «Nella Chiesa - aggiunge Candiard, che si chiede come mai ci sia tanta difficoltà per i cristiani a parlare di grazia - spendiamo un sacco di energie, di omelie e conferenze a lamentarci di quanto sia difficile obbedire al comandamento di Cristo e quindi amare il prossimo come noi stessi. Ci sforziamo di aggirare la difficoltà a forza di abilità esegetica e di retorica, spiegando che amare non è necessariamente quello che pensiamo, che è già tanto fare del proprio meglio, volere il bene o non fare del male. E non mi spiego come mai, nel frattempo, ci occupiamo molto meno del nostro vero campo di attenzione, cioè lasciarci rivestire dell’abito nuziale, lasciarci amare, accogliere il Regno che ci è dato».
«Nella Chiesa - aggiunge Candiard, che si chiede come mai ci sia tanta difficoltà per i cristiani a parlare di grazia - spendiamo un sacco di energie, di omelie e conferenze a lamentarci di quanto sia difficile obbedire al comandamento di Cristo e quindi amare il prossimo come noi stessi. Ci sforziamo di aggirare la difficoltà a forza di abilità esegetica e di retorica, spiegando che amare non è necessariamente quello che pensiamo, che è già tanto fare del proprio meglio, volere il bene o non fare del male. E non mi spiego come mai, nel frattempo, ci occupiamo molto meno del nostro vero campo di attenzione, cioè lasciarci rivestire dell’abito nuziale, lasciarci amare, accogliere il Regno che ci è dato».Qui, Candiard affronta con efficace semplicità il tema della preghiera. Perché la preghiera è semplicità; è volgere l’attenzione a Dio che è nel nostro cuore «più intimo a me di me stesso», come dice Agostino (più volte citato da Candiard quale campione della teologia della grazia), lasciandosi aiutare dallo Spirito, anzi, lasciando che lui preghi per noi, come scrive san Paolo nella Lettera ai romani, perché «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede per noi con gemiti inesprimibili» (8,26) e «per mezzo dello Spirito gridiamo “Abbà! Padre!”» (8,15). Estremo paradosso, per noi cristiani così poco avvezzi ad aprirci all’amore donato e alle cose autenticamente spirituali, scoprire, come anche Candiard, che Dio prega in noi. Perché, non solo lo Spirito è in noi, ma in noi «prega per farci pregare». Dio è nel nostro cuore che ci aspetta e cosa fa? Prega! E giunge incessantemente col suo Spirito a suscitare la nostra preghiera. Per il teologo domenicano è la Trinità che in noi mostra il suo volto: l’amore che si svela nell’amore. E allora: perché non lasciarsi amare?
Nota:
- LaCroix
- 6 novembre 2023
- Adrien Candiard, op, propose dans son ouvrage "Sur la montagne: l’aspérité et la grâce" un itinéraire spirituel à travers trois chapitres de l’Évangile de Matthieu où le don de la grâce supplante la loi morale.(LaCroix, 6 novembre 2023)
FLS
-
>DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - ARTE, FISICA, E METAFISICA: RICONSIDERARE LO "SPAZIOTEMPO" DEL "TONDO DONI" DI MICHELANGELO E RIPENSARE IL "PRESEPE" DI GALILEO GALILEI.18 marzo 2024, di Federico La Sala
"LO #ZODIACO DELLA #VITA" E LA #FILOLOGIA DEL #RINASCIMENTO: NELL’ARTISTICO #SPAZIOTEMPO DI #MICHELANGELOBUONARROTI, UNA "RILETTURA" DELLE FIGURE DI "MARIA" E "GIUSEPPE" E DELLA LORO #RELAZIONE CON LE "#SIBILLE" E I "#PROFETI" DELLA "#SACRAFAMIGLIA".
- ARTE, ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA E TEOLOGIA. Una nota a margine di una "scheda" della Galleria degli Uffizi *
DAL #LAOCOONTE (ROMA, 1506) AL #TONDODONI (FIRENZE, 1506-1508). NELLA "STORICA" LEZIONE ANTROPOLOGICA DELLA #CORNICE LIGNEA DEL #TONDODONI (E NELLA "NARRAZIONE" DELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA), CON DUE PROFETI E #DUE SIBILLE, #MICHELANGELO "INDICA" LA PARADIGMATICA #NASCITA "ETERNA" DEL #FIGLIO DI "MARIA E GIUSEPPE" NEL TEMPO.
*
- "SAPERE AUDE!" (#KANT2024): DOMANDA. Come mai gli esperti della Galleria degli Uffizi "insistono" a sostenere che nella "cornice del Tondo [...] sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti"?!. Non è meglio con #Dante, e, con "#Virgilio" e "#Beatrice", proseguire il cammino oltre "#Ulisse", e oltre "Paolo" ed "Enea", e, con le sibille e i profeti, uscire dal tragico LETARGO (Par. XXXIII, 94)?!
- #19MARZO #21MARZO #25MARZO #25DICEMBRE ...
NOTE:
- STORIAELETTERATURA #ARCHEOLOGIA E #ARTE: IL LAOCOONTE.
- ANTROPOLOGIA "BIBLICA", #STORIAELETTERATURA, E #FILOLOGIA "EV-ANGELICA". Per#Dante, il #profeta #ReDavide ("colui che l’arca traslatò di villa in villa", Pd XX 39) e la #SibillaCumana dicono della #Virgo "desponsata viro cui nomen erat #Ioseph, #dedomoDavid et nomen virginis #Maria"(Lc. 1, 27), non altro!
- FISICA E "METAFISICA CONCRETA" (#KANT2024): LA #LEZIONE DI #GALILEO #GALILEI E LA #QUESTIONE DELLO #SPAZIOTEMPO. Sul tema, si cfr. il brillante contributo di Roger Penrose, "LA #STRADA CHE PORTA ALLA #REALTÀ" ("THE #ROAD TO #REALITY. A Complete Guide to the Laws of the Universe", 2005).
- Metaphysics #Mathematics. Galileo (Keplero: "Vicisti, Galilaee") e il "#presepe" del #gran_navilio del "#Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" (1632): "Da quando un #Bambino nacque in una #mangiatoia, è #dubbio che un #Evento di così grande importanza abbia prodotto così poco scompiglio" (A.N. Whitehead).
-
> DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- 25 MARZO 2024 (DANTEDI’): "APRIRE GLI OCCHI" (S. FREUD, 1899), PER CARITÀ!7 marzo 2024, di Federico La Sala
EPOCALISSE: "APRIRE GLI OCCHI" (S. #FREUD, 1899), PER #CARITÀ! #FILOLOGIA E #ARCHITETTURA FILOSOFICA E ANTROPOLOGICA (#KANT2024).
#DANTEDI’, 25 MARZO 2024: UNA NOTA SULLA TRASVALUTAZIONE STORICA DELLA "VIOLENTA CARITÀ" ("VIOLENTAE CHARITATIS") DI RICCARDO DI SAN VITTORE.
STORIA E LETTERATURA. Nel bimillenario percorso planetario del #cattolicesimo romano (#Nicea 325-2025), la "#diritta via" (#Dante Alighieri) del filologico legame significante e significato tra il luogo dell’#amore e il luogo dell’#occhio ("Ubi amor, ibi oculus") è stata smarrita insieme con l’#acca ("h").
Incredibilmente, e inauditamente, l’amore, la #charitas dello stesso #Riccardo di San Vittore ("Riccardo /che a considerar fu più che #viro", più che uomo, come scrive Dante nel X del "Paradiso") è diventata la parola-chiave della teologia della ricchezza materiale e spirituale: la "caritas", senza più "h", senza più l’acca, è diventata semplicemente #Mammona, il dio ("#Deus #caritas est") dell’#economia mondiale, garante del "buon-andamento" del #carro delle borse e del #caro-prezzo del #mercato: la religione del #capitalismo, vecchio e nuovo (come aveva capito Karl #Marx, #WalterBenjamin, e, ovviamente, #DanteAlighieri).
-
> DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- IL CUORE E IL CARDINE DEL DISAGIO "FILOLOGICO" DI CIVILTA’: UN "LAPSUS" DI LUNGA DURATA.29 gennaio 2024, di Federico La Sala
LINGUISTICA STORIOGRAFIA E PSICOANALISI:
- UN "LAPSUS" ANTROPOLOGICO DI LUNGA DURATA E UNA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEL #LATINORUM.
RIFLETTENDO sul #nodo etimologico di #cuore e #cardine (in connessione con l’ #hamlet-ico tempo di #Shakespeare, "fuori dai cardini"), la memoria ha richiamato l’attenzione su una #immagine (qui, v. allegato) che continua a "#parlare" di un problematico #letargo di secoli (quantomeno a partire da #LorenzoValla, 1440), di uno strano "lapsus" storico e storiografico sul tema dell’#Amore per eccellenza: la #Carità, la #Charitas (gr. "#Xapitas"), e sulla famosa e falsa "donazione di Costantino".
IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS: CHARITAS (AMORE). Questa parola-chiave, la "password" del "regno dei cieli", è diventata nel tempo la Carità - #elemosina, la #Caritas (fatta derivare dal lat. "carus", "caro") e così, persa la "h" (l’#acca), anche in lingua greca (v. allegato) è diventata (addirittura) "#Kapitas" ( "Karitas").
"RIPENSARE #COSTANTINO"? NO! #DANTE2021? NO! RICORDARE L’ANNIVERSARIO DI #NICEA 325, 2025!
 OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.
OVVIAMENTE, così permanendo e stando le cose in tutte le Università e le Accademie del #PianetaTerra (con la loro forte segnatura culturale di epoca "rinascimentale"), il "sonno dogmatico" continua a tutti i livelli, sul piano non solo etimologico, ma filologico, antropologico, teologico e politico.- P. S. - Per meglio capire la questione del disagio "filologico" della civiltà, forse, è bene riflettere sulle parole e al contempo sulle persone: Chi (gr. X) sono le cosiddette "Cariti": sono le "dame della Carità / Elemosina", o, al contrario, sono l’altrà metà del "genere umano", il cuore e il cardine della stessa vita sul Pianeta Terra?.
-
> DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: IL PANETTONE DI SAN GIOVANNI IN FIORE E LA MEMORIA DEL DIBATTITO SU "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" («Berlinische Monatsschrift», 1784).20 gennaio 2024, di Federico La Sala
LA FILOSOFIA E LA "RISPOSTA" SU "CHE COSA E’ L’ ILLUMINISMO?", OGGI: IL "CORAGGIO DI ASSAGGIARE" ("Sàpere aude!")" DI KANT E L’ANALISI SU "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" ("Der Mensch ist, was er ißt") DI FRIEDRICH GEDIKE, nella «Berlinische Monatsschrift» del 1784.
UN "INVITO A RIFLETTERE" SU UNA QUESTIONE DI SOSTANZA, PROPAGANDA (FEDE), FILOLOGIA, E "FACOLTA’ DI GIUDIZIO" (#KANT2024) E, INSIEME, AD ACCOGLIERE "L’AFFASCINANTE «SFIDA» AL PANETTONE LOMBARDO" (si cfr. Emiliano Antonino Morrone, "Federica Greco, l’orgoglio calabro e l’affascinante «sfida» al panettone lombardo", Corriere della Calabria, 19 gennaio 2024):
- "[...] Nell’ambito delle stories, ormai divenute strumento principe della comunicazione #politica, non è concesso spazio al giudizio critico e la risposta emotiva ha contorni e dinamiche da #fideismo. Nelle #stories manca l’orizzonte e non c’è #logos, discorso articolato, cioè l’elemento chiave dell’altrui comprensione, concordia, consenso. In termini spiccioli, mediante le stories si presenta e offre un prodotto al consumo [...]" (E. A. Morrone, cit.).
Per meglio accogliere la sollecitazione del giornalista Emiliano Antonino Morrone, e, possibilmente, riprendere il filo dall’amore (#charitas) di Gioacchino da Fiore (San Giovanni in Fiore) e dal coraggio di assaggiare ("#Sàpere aude") di Orazio (Venosa), mi sia lecito, ricordare alcuni contributi storiografici sul tema del cibo e della antropologia filosofica:
a) Ludwig Feuerbach, "L’uomo è coà che mangia", a c. di Franco Tomasoni, Morcelliana, Brescia 2015.
b) Ludwig Feuerbach, L’uomo è ciò che mangia, a c. di Andrea Tagliapietra, Boringhieri, Torino 2017.
c) Gianfranco Ravasi, "L’uomo è ciò che mangia", Famiglia Cristiana,18 maggio 2023.
- Nota:
- L’ #ANTROPOLOGIA (L’ #ESSEREUMANO), L’#ALIMENTAZIONE ("L’#UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA"), E LA #RICERCA DI UNA VIA D’#USCITA DALL’#IMMAGINARIO STORICO-SOCIALE DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #CADUTA ("CAINO") E DELLA #TRAGEDIA ("EDIPO"): A CHE #GIOCO GIOCHIAMO, #OGGI? IL #PIANETATERRA, L’#ECOLOGIA, E "L’ECOSOCIALISMO DI MARX")
- PIANETA TERRA E "PACE PERPETUA"... "Amazzonia": non è ora di invertire (velocissimamente) la rotta bellica del "progresso" planetario e rispondere alla questione antropologica di Kant e Feuerbach: «L’uomo è ciò che mangia»; e, infine, partendo dal "Convivio" o "Simposio" di Platone (da quanto si mangia e si beve, anche a "cena"), fare chiarezza ("claritas") sulle risposte da dare alle domande del lettore "operaio" di Brecht, e, possibilmente, anche... agli interrogativi della lettrice "operaia"?
"Sàpere aude!" (Kant, 1784). L’Illuminismo e il buon uso della propria intelligenza, della propria facoltà di giudizio, per uscire dallo "stato di minorità":
- "Nel 1784 Friedrich Gedike, un teologo protestante di simpatie illuministe che, proprio per queste ultime, era incorso nella censura prussiana, aveva scritto il breve articolo Su «mangia» ed «è». Un contributo alla spiegazione dell’origine del sacrificio, pubblicandolo nello stesso numero della «Berlinische Monatsschrift» che conteneva il saggio sull’Illuminismo di Moses Mendelssohn a cui rispose, com’è noto, quello celeberrimo di Kant." (Andrea Tagliapietra. 2017) *
- "Friedrich Gedike, Über ißt und ist. Ein Beitrag zur Erklärung der Opfer, „Berlinische Monatsschrift“, Hrsg. F. Gedike u. J.E. Biester, Vierter Bd., Julius bis December 1784, pp. 175-180." (Francesco Tomasone, 2015).
A)
ANDREA TAGLIAPIETRA, "La metafora gustosa. Feuerbach e la gastroteologia": "[...] Il detto italiano «parla come mangi», al di là dell’invettiva del luogo comune, rivela un fondo di verità difficilmente smentibile. La cultura umana si specchia, infatti, vuoi nelle parole del linguaggio che dalla bocca escono, vuoi in quegli alimenti e in quelle pietanze che nella bocca, invece, entrano.
Si inizia a intravedere, quindi, tutto lo spessore e la ricchezza che la frase di Feuerbach racchiude e che sta alla base del suo successo e della capacità di condensare molti motivi del pensiero del filosofo tedesco ben oltre l’immagine scolastica e polverosa dei manuali, che ne hanno fatto una sorta di mero raccordo della storia della filosofia fra Hegel e Marx. Del resto l’efficacia della massima appartiene già alla dimensione del significante e all’ambivalenza fonetica che ne fa oscillare il significato fra l’affermazione ontologica e la descrizione dell’azione di mangiare. Il gioco di parole Mensch ist, was er ißt è di fatto intraducibile nella nostra lingua, come anche nei principali idiomi europei correnti di cui abbiamo dato conto in apertura di questo saggio.
 Traducendo «l’uomo è ciò che mangia», infatti, noi rendiamo il significato principale della «formula», ma non quello allusivo, veicolato non dal significato ma dal significante delle parole. Esso nasce dall’assonanza, nella lingua tedesca, fra ist (= «è», terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo sein, «essere») e ißt, ossia isst con la «s» raddoppiata (= «mangia», analoga voce del verbo essen, «mangiare»).
Traducendo «l’uomo è ciò che mangia», infatti, noi rendiamo il significato principale della «formula», ma non quello allusivo, veicolato non dal significato ma dal significante delle parole. Esso nasce dall’assonanza, nella lingua tedesca, fra ist (= «è», terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo sein, «essere») e ißt, ossia isst con la «s» raddoppiata (= «mangia», analoga voce del verbo essen, «mangiare»).
 Per dare un’idea di ciò che qui risulta intraducibile ci viene in soccorso la lingua latina che, in virtù di un gioco linguistico affine al tedesco e, anzi, ancora più sofisticato, dal momento che l’ambiguità non è solo fonetica ma anche grafica, ci permette di volgere la formula feuerbachiana in homo est quod est, dove il primo est è la terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo essere, mentre il secondo est è la terza persona singolare del verbo edere, cioè «mangiare». In questo caso, l’ambiguità grafica consente di leggere la «formula» in perfetta specularità, per cui possiamo tradurre sia con «l’uomo è ciò che mangia» sia con «l’uomo mangia ciò che è».
Per dare un’idea di ciò che qui risulta intraducibile ci viene in soccorso la lingua latina che, in virtù di un gioco linguistico affine al tedesco e, anzi, ancora più sofisticato, dal momento che l’ambiguità non è solo fonetica ma anche grafica, ci permette di volgere la formula feuerbachiana in homo est quod est, dove il primo est è la terza persona singolare dell’indicativo presente del verbo essere, mentre il secondo est è la terza persona singolare del verbo edere, cioè «mangiare». In questo caso, l’ambiguità grafica consente di leggere la «formula» in perfetta specularità, per cui possiamo tradurre sia con «l’uomo è ciò che mangia» sia con «l’uomo mangia ciò che è».Questi parallelismi linguistici avevano già una loro tradizione in cui forse Feuerbach, nelle sue ricerche intorno alla religione e al tema del sacrificio, può essersi imbattuto.
 Nel 1784 Friedrich Gedike, un teologo protestante di simpatie illuministe che, proprio per queste ultime, era incorso nella censura prussiana, aveva scritto il breve articolo Su «mangia» ed «è». Un contributo alla spiegazione dell’origine del sacrificio, pubblicandolo nello stesso numero della «Berlinische Monatsschrift» che conteneva il saggio sull’Illuminismo di Moses Mendelssohn a cui rispose, com’è noto, quello celeberrimo di Kant.
Nel 1784 Friedrich Gedike, un teologo protestante di simpatie illuministe che, proprio per queste ultime, era incorso nella censura prussiana, aveva scritto il breve articolo Su «mangia» ed «è». Un contributo alla spiegazione dell’origine del sacrificio, pubblicandolo nello stesso numero della «Berlinische Monatsschrift» che conteneva il saggio sull’Illuminismo di Moses Mendelssohn a cui rispose, com’è noto, quello celeberrimo di Kant.
 Nel saggio Gedike paragonava la prospettiva ontologica dell’uomo civilizzato, condensata nella massima cartesiana per cui cogito ergo sum («penso dunque sono») e per la quale il pensiero fa da fondamento all’essere, alla condizione naturale dei nostri progenitori, per i quali valeva piuttosto il detto edo ergo sum («mangio dunque sono»). La frase, volta alla terza persona singolare, suona, in latino, est, ergo est, con una coincidenza tra l’essere e il mangiare che la lingua tedesca conserva nella somiglianza fonetica fra ißt e ist. È quindi in questa prospettiva naturalistica ed elementare, concludeva Gedike, che mostra lo stretto legame, suggerito anche dal linguaggio, tra l’idea dell’essere e quella del nutrimento, che dobbiamo comprendere illuministicamente l’origine e l’importanza religiosa dei sacrifici e del pasto sacrificale.
Nel saggio Gedike paragonava la prospettiva ontologica dell’uomo civilizzato, condensata nella massima cartesiana per cui cogito ergo sum («penso dunque sono») e per la quale il pensiero fa da fondamento all’essere, alla condizione naturale dei nostri progenitori, per i quali valeva piuttosto il detto edo ergo sum («mangio dunque sono»). La frase, volta alla terza persona singolare, suona, in latino, est, ergo est, con una coincidenza tra l’essere e il mangiare che la lingua tedesca conserva nella somiglianza fonetica fra ißt e ist. È quindi in questa prospettiva naturalistica ed elementare, concludeva Gedike, che mostra lo stretto legame, suggerito anche dal linguaggio, tra l’idea dell’essere e quella del nutrimento, che dobbiamo comprendere illuministicamente l’origine e l’importanza religiosa dei sacrifici e del pasto sacrificale.Comincia a risaltare, allora, l’assonanza decisiva della massima, il suo senso duplice, ambivalente e intraducibile che, mentre afferma che l’«uomo è ciò che mangia», ribadisce anche che l’«uomo è ciò che è», richiamando la citazione diretta e, quindi, sottilmente dissacrante, del famoso versetto del libro biblico dell’Esodo in cui l’Altissimo, il Dio degli ebrei e dei cristiani, nomina se stesso. Un passo che ha, nell’originale ebraico, ehyeh asher ehyeh, un significato puramente negativo e antidolatrico, suonando più o meno come «io sarò quel che sarò», ossia un rifiuto da parte del Signore di rispondere all’impertinente domanda di Mosè su quale fosse il Suo nome. Eppure, già la Septuaginta, la Bibbia greca, in età alessandrina, trasporta l’enigmatico versetto scritturistico nei termini del linguaggio ontologico dei filosofi ellenici (egó eimí ho on) e la Vulgata traduce in latino ego sum qui sum, espressione che verrà interpretata dalla tradizione della Chiesa prevalentemente come un’affermazione. Anzi, come la dichiarazione stessa del fondamento metafisico dell’esistenza: «io sono colui che è». Si tratta del Qui est che, secondo la Summa Teologiae di Tommaso d’Aquino, è il nome proprio che più si addice a Dio.
 L’uomo, come la sua proiezione teologica alienata e fantasmatica, afferma dunque di essere ciò che è. Soltanto che, a differenza di Dio, ossia del desiderio che sublima se stesso nella vertigine dell’immaginazione, per essere ciò che è, l’uomo ha la necessità di mangiare, di nutrire il suo corpo, di misurarsi con la realtà della natura, con il bisogno e le difficoltà di soddisfarlo." (cfr. Ludwig Feuerbach, "L’uomo è ciò che mangia", di Andrea Tagliapietra, Boringhieri, Torino 2017, pp. 20-22. senza le note).
L’uomo, come la sua proiezione teologica alienata e fantasmatica, afferma dunque di essere ciò che è. Soltanto che, a differenza di Dio, ossia del desiderio che sublima se stesso nella vertigine dell’immaginazione, per essere ciò che è, l’uomo ha la necessità di mangiare, di nutrire il suo corpo, di misurarsi con la realtà della natura, con il bisogno e le difficoltà di soddisfarlo." (cfr. Ludwig Feuerbach, "L’uomo è ciò che mangia", di Andrea Tagliapietra, Boringhieri, Torino 2017, pp. 20-22. senza le note).B) FRANCESCO TOMASONI, "Ludwig Feuerbach: l’uomo e la sua alimentazione":
- "-La conclusione dell’opera ["L’Essenza del Cristianesimo", fls] consisteva nell’esaltazione dell’eucarestia [eucharistia, fls] secondo il suo significato etimologico, ossia come solenne ringraziamento per il pane e il vino grazie all’esperienza della fame" (Francesco Tomasoni).
"Nel 2015 si è svolto a Milano l’Expo, una manifestazione fieristica dal titolo “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” che in 184 giorni e con 145 nazioni partecipanti, fra cui ovviamente il Brasile, ha avuto 21 milioni di visitatori. Sull’onda di questo evento è tornato di attualità il celebre motto di Feuerbach: «L’uomo è (ist) ciò che mangia (isst)». Nella lingua tedesca l’assonanza fra le terze persone del verbo essere e del verbo mangiare è evidente e suggerisce una stretta relazione fra essere e mangiare. Non a caso i critici dell’epoca vi videro un’espressione di rozzo materialismo, che poteva essere avvicinata alla frase di Karl Vogt: «I pensieri stanno press’a poco nel medesimo rapporto col cervello, come la bile al fegato o l’urina alle reni». Vogt era ben consapevole di usare un’espressione «in un certo senso rozza», ma intendeva dire che «tutte le attività psichiche» erano «solo funzioni della sostanza cerebrale».
Eppure l’assonanza fra essere e mangiare era già stata messa in rilievo più di sessant’anni prima da un teologo protestante di tendenze razionalistiche, Friedrich Gedike, in un articolo della prestigiosa rivista “Berlinische Monatsschrift”, in cui comparvero anche gli interventi di Kant, Mendelssohn e altri sul significato dell’illuminismo.
 Già nel titolo [Friedrich Gedike, Über ißt und ist. Ein Beitrag zur Erklärung der Opfer, „Berlinische Monatsschrift“, Hrsg. F. Gedike u. J.E. Biester, Vierter Bd., Julius bis December 1784, pp. 175-180.] egli evidenziava l’assonanza e mostrava che, ancor più che nel tedesco, in latino e in greco i due verbi coincidevano per alcune forme della flessione. Non si trattava dunque di un caso, bensì dell’effetto di un processo naturale. Per i popoli primitivi i concetti astratti erano troppo ardui, perciò al loro posto subentravano riferimenti materiali. Così «per l’uomo rozzo e ancora del tutto sensuale il concetto di essere, nei tempi della prima origine delle lingue, era troppo sottile e remoto [...] al contrario il concetto del mangiare era certamente uno dei primi sviluppatisi in lui».
Già nel titolo [Friedrich Gedike, Über ißt und ist. Ein Beitrag zur Erklärung der Opfer, „Berlinische Monatsschrift“, Hrsg. F. Gedike u. J.E. Biester, Vierter Bd., Julius bis December 1784, pp. 175-180.] egli evidenziava l’assonanza e mostrava che, ancor più che nel tedesco, in latino e in greco i due verbi coincidevano per alcune forme della flessione. Non si trattava dunque di un caso, bensì dell’effetto di un processo naturale. Per i popoli primitivi i concetti astratti erano troppo ardui, perciò al loro posto subentravano riferimenti materiali. Così «per l’uomo rozzo e ancora del tutto sensuale il concetto di essere, nei tempi della prima origine delle lingue, era troppo sottile e remoto [...] al contrario il concetto del mangiare era certamente uno dei primi sviluppatisi in lui».
 Poteva dunque argomentare nel modo seguente: mangia, dunque è (in latino: est, ergo est). La terza persona, nella quale la coincidenza era perfetta, rifletteva la mentalità primitiva secondo cui il soggetto osservava le cose fuori di sé, ma non era ancora giunto all’autocoscienza. L’identità fra essere e mangiare aveva anche indotto i primitivi a concludere che se gli dei esistevano, dovevano mangiare.
Poteva dunque argomentare nel modo seguente: mangia, dunque è (in latino: est, ergo est). La terza persona, nella quale la coincidenza era perfetta, rifletteva la mentalità primitiva secondo cui il soggetto osservava le cose fuori di sé, ma non era ancora giunto all’autocoscienza. L’identità fra essere e mangiare aveva anche indotto i primitivi a concludere che se gli dei esistevano, dovevano mangiare.
 Da qui i banchetti sacrificali, in cui si invitavano le divinità a condividere la mensa con gli uomini. Quanto più però questi si convincevano della superiorità degli dei, tanto più offrivano loro cibi preziosi, addirittura carne umana. Secondo Gedike i sacrifici umani erano venuti non alle origini, bensì in un periodo «intermedio di civiltà». Solo il raggiungimento pieno dell’illuminazione (Aufklärung) e della civiltà aveva fatto percepire l’abominio di quelle pratiche. In antitesi all’identità fra essere e mangiare, Gedike ricordava l’affermazione di Cartesio: «cogito ergo sum». L’autocoscienza dell’uomo civile si fondava sull’identità fra essere e pensiero. Per il teologo dunque al materialismo del primitivo si contrapponeva il razionalismo o lo spiritualismo dell’uomo moderno.
Da qui i banchetti sacrificali, in cui si invitavano le divinità a condividere la mensa con gli uomini. Quanto più però questi si convincevano della superiorità degli dei, tanto più offrivano loro cibi preziosi, addirittura carne umana. Secondo Gedike i sacrifici umani erano venuti non alle origini, bensì in un periodo «intermedio di civiltà». Solo il raggiungimento pieno dell’illuminazione (Aufklärung) e della civiltà aveva fatto percepire l’abominio di quelle pratiche. In antitesi all’identità fra essere e mangiare, Gedike ricordava l’affermazione di Cartesio: «cogito ergo sum». L’autocoscienza dell’uomo civile si fondava sull’identità fra essere e pensiero. Per il teologo dunque al materialismo del primitivo si contrapponeva il razionalismo o lo spiritualismo dell’uomo moderno.Benché non esistano prove del fatto che Feuerbach abbia letto questo articolo, esso è utile per comprendere il suo distacco da Hegel e i suoi due interventi sull’alimentazione e sui sacrifici. Anch’egli nel suo periodo giovanile aveva sottoscritto la concezione cartesiana, secondo cui l’essenza umana era data dal pensiero o dall’autocoscienza. Poi però nei Principi della filosofia dell’avvenire aveva negato che il carattere distintivo dell’uomo risiedesse semplicemente in quelli. La sua essenza era una totalità che si rifletteva nel complesso della sua sensibilità. Non si trattava solo della capacità di sentire e percepire, bensì di tutta la relazione corporea con la natura. Anche lo stomaco umano era essenzialmente diverso da quello degli animali: «Dagli animali l’uomo non si distingue solo grazie al pensiero. Tutta la sua essenza costituisce piuttosto tale differenza [...] Anzi, persino lo stomaco dell’uomo, malgrado noi lo guardiamo dall’alto in basso con disprezzo non è un’essenza ferina, ma umana, perché è universale, perché non deve servirsi di un tipo determinato di alimenti. Proprio per questo l’uomo non è affetto da quel furore vorace (Freßbegierde) con cui l’animale si getta sulla preda».
 L’universalità, che già nell’Essenza del cristianesimo Feuerbach aveva attribuito al genere umano, faceva sì che questo non si limitasse a un tipo di alimenti e quindi dimostrasse, anche nel mangiare, la sua libertà. In proposito egli si appoggiava alla distinzione, presente nella lingua tedesca, fra “essen”, mangiare proprio degli umani, e “fressen”, divorare tipico degli animali, aggiungendo come nel secondo caso lo stomaco assumesse il predominio su tutto, mentre nel primo caso esso era in armonia con la testa, ossia con la ragione e l’etica.
L’universalità, che già nell’Essenza del cristianesimo Feuerbach aveva attribuito al genere umano, faceva sì che questo non si limitasse a un tipo di alimenti e quindi dimostrasse, anche nel mangiare, la sua libertà. In proposito egli si appoggiava alla distinzione, presente nella lingua tedesca, fra “essen”, mangiare proprio degli umani, e “fressen”, divorare tipico degli animali, aggiungendo come nel secondo caso lo stomaco assumesse il predominio su tutto, mentre nel primo caso esso era in armonia con la testa, ossia con la ragione e l’etica.
 Un amico di famiglia, Georg Friedrich Daumer, criticò l’esaltazione che in questo passo Feuerbach aveva fatto dell’uomo rispetto agli animali [...] Daumer toccava un punto, al quale Feuerbach era stato sensibile fin dai primi scritti, quello della fame.
Un amico di famiglia, Georg Friedrich Daumer, criticò l’esaltazione che in questo passo Feuerbach aveva fatto dell’uomo rispetto agli animali [...] Daumer toccava un punto, al quale Feuerbach era stato sensibile fin dai primi scritti, quello della fame.Nello stesso brano della Storia della filosofia moderna che prima abbiamo ricordato per l’identificazione dell’essenza umana col pensiero, Feuerbach accennava alla fame come esempio per distinguere vari gradi di essere: «Un essere con uno stomaco riempito in modo da star bene è un essere molto più reale di un essere con stomaco vuoto». Lo stomaco vuoto rappresentava sensibilmente la contraddizione fra la presenza ideale dell’oggetto e la sua assenza reale, ossia la separazione da un ente, al quale per natura si era uniti. Già nella dissertazione De ratione Feuerbach si era soffermato su questa situazione per mettere in luce la tensione dialettica del desiderio.
Nelle Lezioni tenute a Erlangen come Privatdozent era tornato sull’argomento trattando dell’impulso o della pulsione (Trieb), un concetto già elaborato da Fichte, che avrebbe avuto grande fortuna nell’Ottocento fino a Freud e al suo famoso saggio della Metapsicologia: Le pulsioni e i loro destini (Triebe und Triebschicksale). Aveva affermato: «Un altro esempio è l’appagamento dell’impulso (Triebes) stesso; quando calmo la fame, questo calmarla in quanto appagamento è affermazione della mia vita, un godimento, ma questo godimento c’è in me soltanto in quanto c’è la fame, il non godimento [...] al godimento spetta l’essere e il non essere». Nel Leibniz Feuerbach aveva spiegato ulteriormente il rapporto con l’oggetto, presente negli impulsi e, in particolare, nella fame e nella sete: «A dispetto di tutti gli empiristi fame e sete sono due filosofi a priori; esse anticipano e deducono a priori l’esistenza dei loro oggetti». Nella loro struttura ontica era dunque insito l’oggetto, prima che si presentasse nelle cose sensibili.
 Questa visione caratterizza nell’Essenza del cristianesimo la relazione del soggetto con l’oggetto: «L’uomo non è nulla senza oggetto [...] Tuttavia l’oggetto al quale un soggetto si riferisca essenzialmente, necessariamente non è altro che l’essenza propria di questo soggetto, ma resa oggettiva».
Questa visione caratterizza nell’Essenza del cristianesimo la relazione del soggetto con l’oggetto: «L’uomo non è nulla senza oggetto [...] Tuttavia l’oggetto al quale un soggetto si riferisca essenzialmente, necessariamente non è altro che l’essenza propria di questo soggetto, ma resa oggettiva».
 La conclusione dell’opera consisteva nell’esaltazione dell’eucarestia secondo il suo significato etimologico, ossia come solenne ringraziamento per il pane e il vino grazie all’esperienza della fame: «Per comprendere il significato religioso della consumazione del pane e del vino mettiti nella situazione in cui quell’atto altrimenti quotidiano venga, contro natura, violentemente, interrotto. La fame e la sete non distruggono solo la forza fisica, bensì anche quella spirituale e morale dell’uomo, lo spogliano dell’umanità, dell’intelletto, della coscienza. Oh! Se tu mai provassi tale mancanza, tale infelicità, allora come benediresti e loderesti la qualità naturale del pane e del vino che ti ridonano la tua umanità, il tuo intelletto! Così basta solo interrompere il consueto, comune corso delle cose per restituire a quanto è comune un significato non comune, alla vita in quanto tale un significato assolutamente religioso. Santo sia per noi quindi il pane, santo il vino, ma santa anche l’acqua! Amen» [...]" (cfr. Francesco Tomasoni, Università del Piemonte Orientale, Vercelli - ripresa parziale, senza le note, pp. 109-112).
La conclusione dell’opera consisteva nell’esaltazione dell’eucarestia secondo il suo significato etimologico, ossia come solenne ringraziamento per il pane e il vino grazie all’esperienza della fame: «Per comprendere il significato religioso della consumazione del pane e del vino mettiti nella situazione in cui quell’atto altrimenti quotidiano venga, contro natura, violentemente, interrotto. La fame e la sete non distruggono solo la forza fisica, bensì anche quella spirituale e morale dell’uomo, lo spogliano dell’umanità, dell’intelletto, della coscienza. Oh! Se tu mai provassi tale mancanza, tale infelicità, allora come benediresti e loderesti la qualità naturale del pane e del vino che ti ridonano la tua umanità, il tuo intelletto! Così basta solo interrompere il consueto, comune corso delle cose per restituire a quanto è comune un significato non comune, alla vita in quanto tale un significato assolutamente religioso. Santo sia per noi quindi il pane, santo il vino, ma santa anche l’acqua! Amen» [...]" (cfr. Francesco Tomasoni, Università del Piemonte Orientale, Vercelli - ripresa parziale, senza le note, pp. 109-112).FLS
-
>DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- PER UNA BUONA ALIMENTAZIONE, NOTE SUL "PRENDERE E MANGIARE" E SUL CORAGGIO DI ASSAGGIARE.6 gennaio 2024, di Federico La Sala
EPIFANIA (APPARIZIONE) E IMMAGINAZIONE ("EPINOIA"), #6 GENNAIO 2024. Per "orientarsi nel pensiero" (#Kant) e nella realtà (#Marx), e cercare di non scambiare il gioco dell’illusione (#Schein) con la realtà dell’apparenza (#Erscheinung),
- ALCUNI APPUNTI PER UNA BUONA ALIMENTAZIONE (MATERIALE E SPIRITUALE), SUL "PRENDERE E MANGIARE" ("ESSENZA DEL CRISTIANESIMO", DELLA "BUONA NOVELLA"), SUL "CORAGGIO DI ASSAGGIARE" (IL "#SàPERE AUDE" DI #ORAZIO), E SUL BUON USO DELLA PROPRIA PERSONALE INTELLIGENZA E "FACOLTA’ DI #GIUDIZIO" (KANT).
Un "invito alla lettura" dello studio sulla storia del #cibo "eu- caristico" ("EU-#CHARIS-TICO) del teologo, docente di "Storia della Chiesa", Anselm #Schubert, "Pasto divino. Storia culinaria dell’eucaristia" (Carocci editore 2019):
- "IN BREVE: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo [...]. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue». Con queste parole Gesù istituisce la #comunione. Oggi, però, sappiamo che l’eucaristia cristiana nasce dagli antichi simposi. Si è discusso a lungo su cosa si mangiasse e si bevesse nella #Chiesa delle origini: formaggio, pesce o verdure? Latte, succhi o miele? Oppure soltanto pane? Lievitato o azzimo? Vino rosso o bianco? Solo per l’officiante o anche per i fedeli? In epoca moderna i dubbi non hanno fatto che aumentare [...] Anselm Schubert racconta la storia dell’eucaristia dal primo Cristianesimo a oggi concentrandosi perla prima volta sugli alimenti utilizzati. Ne risulta una brillante ricostruzione che fa vedere con altri occhi il Cristianesimo e il suo #rito più solenne".
NOTA:
Epifania2024. #Memoria e #archeologia di un evento epocale: i #Magi erano #sapienti e sapevano #distinguere tra il #Bambino-re (#Gesù) e il #Re-bambinone "giocastolaio" (#Erode). Ma, oggi, dove sono i magi?
Kafka ancora agli inizi del secolo scorso sapeva la differenza tra la #manifestazione epifanica e il #giogo dei "giocastolai" e delle "giocastolaie", e ricordava: "[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (Lettera a Helli Hermann, autunno 1921).
Anselm Schubert, “Pasto divino”
- Anselm Schubert, Pasto divino. Storia culinaria dell’eucaristia. Roma: Carocci, 2019. 222 pp.
di Luca Arcari (Storica_mente.Laboratorio di storia)
Affrontare la storia dell’eucaristia dal punto di vista degli alimenti utilizzati e della loro preparazione rappresenta la novità principale del volume di Anselm Schubert, originariamente pubblicato in tedesco (Gott essen, München, C.H. Beck oHG, 2018). Il volume si pone nel ricco filone storiografico della recente storia dell’alimentazione, applicandola però alla storia dell’eucaristia, che in questo modo non emerge più, o non solo, come una storia di dottrine teologiche, ma come un complesso di pratiche di simbolizzazione di un atto culinario, con tutto ciò che questa prospettiva sembra implicare.
Nonostante una certa tensione verso l’istituzionalizzazione, che nella storia dei gruppi di seguaci di Gesù appare con una certa nitidezza alla fine del IV secolo, quando il concilio di Laodicea (363-364 e.v.) cerca di formulare la netta distinzione tra eucaristia e pasto comune, il focus chiarisce la varietà delle pratiche di ritualizzazione presenti nel frastagliato universo cristiano, a partire dai gruppi di giudei credenti in Gesù del I-II sec. e.v. (cap. 1), passando per quelli bollati come eretici da alcuni Padri della Chiesa del III-IV sec. - che in molti casi continuano a celebrare i loro riti imbandendo cibi vari (gli artotiriti menzionati da Epifanio di Salamina, nel IV sec., ad esempio consumano pane e formaggio) -, fino alle definizioni teologico-dottrinali di Agostino (cap. 2), e alle divaricazioni che distinguono sempre più l’Oriente e l’Occidente tra tardoantico e medioevo (cap. 3). Il medioevo sancisce anche quella che, di fatto, emerge come una vera e propria “clericalizzazione delle sostanze” (cap. 4), sia in Oriente (dalla “nuova Roma” alla chiesa russa) che in Occidente, con cibi e modalità di ritualizzazione del mangiare comune che appaiono sempre più come specchi identitari paralleli al consolidarsi dei vari cristianesimi come strumenti di auto-definizione “proto-nazionale”: «L’introduzione nella Chiesa franca della liturgia romana [scil. l’uso di orazioni da recitare durante l’eucaristia, che ormai è chiaramente definita come pasto rituale amministrato interamente da personale altamente specializzato e che prevede il consumo comunitario di pane e vino “purissimi”] determinò un cambiamento, in tutto l’Occidente latino, decisivo per il futuro del cristianesimo. Se all’inizio l’eucaristia era intesa ancora come un ringraziamento da parte della comunità, o come rievocazione del sacrificio espiatorio di Cristo, da quel momento divenne un atto sacro, con cui il sacerdote richiamava la divinità in terra sotto gli occhi dei fedeli» (51). Tra il 1050 e il 1525 la chiesa soprattutto latina vede inoltre una vera e propria esplosione di teologie e religiosità eucaristiche, che raggiungono il loro pieno sviluppo all’inizio del XIII secolo. Emergono soprattutto le ostie consacrate e il calice di vino, che diventeranno, per secoli, almeno in Occidente, «il vero e proprio centro religioso e culturale della cristianità. Nella trasformazione soprannaturale che la loro materia subisce, l’unità tra Dio e l’uomo si rende percepibile, sperimentabile, palpabile, commestibile» (65).
Una notevole attenzione Schubert la pone anche su quella che lui definisce come “la disputa sul corpo di Dio”, un ricco ambito interconnesso di problemi e questioni che attraversano la storia dei cristianesimi soprattutto occidentali tra il 1525 e il 1830 (cap. 6). Le varie scissioni e i multiformi gruppi soprattutto europei dibattono e si dividono anche per quanto concerne l’effettiva presenza di Cristo nella comunione e su quale fosse il significato di questa presenza più o meno “reale” per i fedeli. La luterana centralità della Bibbia come unica cartina al tornasole attraverso cui misurare l’aderenza all’originario messaggio di Gesù, mostra tutti i suoi riverberi anche per quanto concerne le pratiche di ritualizzazione della “comunione” all’interno delle varie forme di protestantesimo succedute alla esegesi e alla riflessione teologica di Lutero. Lutero, come già Hus, raccomanda di reintrodurre il vino della comunione anche per i laici, nonostante la forte propensione per l’acqua pura, mentre Calvino mostra una fondamentale apertura verso alimenti diversi oltre al pane e al vino, dato che non sono gli ingredienti terreni del pasto ritualizzato a contenere il Cristo celeste, rinviando, in quanto nutrimento corporeo, al nutrimento spirituale dell’anima che si realizza durante il pasto comunitario. Questa apertura a cibi diversi, d’altronde, si riscontra inevitabilmente anche nel cattolicesimo “mondiale” del XVI secolo che, nonostante il tentativo dichiarato di un ritorno esclusivo alla “tradizione” (con tutta le problematicità che questo termine implica e pone), mostra di avere coscienza di un dilemma rispetto alle chiese extraeuropee quando prescrive che le ostie siano fatte «perlomeno per la maggior parte di frumento» (111).
La disamina di Schubert prosegue con le dinamiche legate alle pratiche eucaristiche nell’epoca della riproducibilità industriale (1830-1970), che evidenziano alcune delle questioni connesse, da un lato, alla diffidenza soprattutto protestante nei confronti del pane industriale, che non si sapeva esattamente di cosa fosse fatto, e, dall’altro, alle critiche nei confronti del vino, a loro modo figlie delle istanze proprie dei movimenti di opposizione nei confronti dell’alcolismo (cap. 7). Per quanto concerne il mondo protestante, comunque, si sottolinea anche come a partire dagli anni Settanta del Novecento si verifichi un mutamento per quanto riguarda il dibattito sulla forma e sugli ingredienti dell’eucaristia, allora ripreso con una intensità che non si vedeva almeno dal Seicento, a fronte della maggiore uniformità propria nel mondo cattolico, nonostante alcune delle posizioni espresse nella Sacrosanctum Concilium del 1963 (cap. 8).
Il volume di Schubert, che si raccomanda per la chiarezza espositiva e la ricchezza di dettagli, evidenzia con particolare attenzione quanto le pratiche di ritualizzazione del pasto eucaristico nella storia dei cristianesimi siano, proprio in una prospettiva di lunga durata, strettamente intrecciate all’utilizzo di particolari alimenti e bevande o di specifiche modalità di preparazione dei cibi. Ne deriva un affresco per nulla omogeneo, che mostra quanto i processi di ritualizzazione - stando alla prospettiva inaugurata, tra gli altri, da C. Bell (di cui si veda almeno Ritual Theory, Ritual Practice, Oxford, Oxford University Press, 1992) - siano il frutto di dinamiche culturali mai totalmente definibili in maniera precostituita o predeterminata. In sostanza, dalla rigidità del concetto di “rito”, il volume invita a porsi nella prospettiva dei processi di ritualizzazione, con tutte le complessità diacroniche e diatopiche che tale prospettiva inevitabilmente implica.
FLS
-
> "SÀPERE AUDE" (DECIDERSI A DIVENTARE SAGGIO). UNA NOTA SU UNA AMLETICA "QUESTION" DI LUNGA DURATA DI FILOLOGIA E TEOLOGIA.31 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’UMANITÀ (ANTROPOLOGIA), IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE" (ECONOMIA POLITICA) E IL PERSISTERE DI UN "PREISTORICO" SIMPOSIO ALL’OMBRA DELLA "EU+CARESTIA"!!!
- UNA NOTA SU UNA AMLETICA "QUESTION" DI LUNGA DURATA DI FILOLOGIA E TEOLOGIA...
MINIMALISMO ED ESSENZIALISMO: "SÀPERE AUDE" (DECIDERSI A DIVENTARE SAGGIO, AD AS-SAGGIARE, A USCIRE DALLO "STATO DI MINORITÀ" (ORAZIO E KANT). A ben riflettere sulla "essenza del cristianesimo" di Ludwig Feuerbach, e, al contempo, sul problema della "eucharistia", del cibarsi della grazia ("charis") di Dio ("charitas"), forse, si può meglio cominciare a capire la profondità teologico-politica ed economica della sua "banalizzatissima" considerazione che «L’uomo è ciò che mangia»!
IN UN TESTO BRILLANTISSIMO, all’interno di un "presente storico" di secoli, segnato da una grande carestia filologica e logica, così è scritto: "La vita spirituale - di chi «nasce un seconda volta» aderendo a Cristo - poggia sulla preghiera continua e sull’#eucarestia [...]" (cfr. Flavio Piero Cuniberto, "SUL CRISTIANESIMO COME MITO E COME MISTERO). E, proseguendo; si arriva a fare propria la tesi di #RenéGirard: "L’idea che la morte di Cristo sulla croce sia il prezzo del riscatto («redenzione» da «red-imere», «riscattare») non è che una versione cristianizzata della pratica ancestrale del #bouc #émissaire, il #caproespiatorio di Girard. Una versione mitologica del mistero cristiano." (op. cit.).
IL CANTO DEL CAPRO E LA FENOMENOLOGIA DELLA TRAGEDIA: "ECCE HOMO" (PILATO). Accecati dall’astuzia della ragione platonico-hegeliana, invece di fare chiarezza sul "capro espiatorio", si rinnova la confusione e la condanna a morte proprio dell’agnello (dell’#ariete, del montone) che ha portato Ulisse (e Dante) in salvo, fuori dalla caverna e dall’inferno!
 Dopo Nietzsche ("Ecce Homo", 1888), che ha denunciato l’imbroglio storico-antropologico del #paolinismo, a partire dalla morte di Dio, e di Gesù ("Ecce Homo"), chi ha mai più visto sulla Terra un cristiano, una cristiana?
Dopo Nietzsche ("Ecce Homo", 1888), che ha denunciato l’imbroglio storico-antropologico del #paolinismo, a partire dalla morte di Dio, e di Gesù ("Ecce Homo"), chi ha mai più visto sulla Terra un cristiano, una cristiana?
 Nonostante Gioacchino da Fiore, Francesco d’Assisi, Chiara di Assisi, Dante Alighieri, e, addirittura, il lavoro iperstorico ("preistorico" e archeologico) sulle radici "Cosmicomiche" della Terra (Italo Calvino), Diogene di Sinope, definito dalla tradizione "Socrate pazzo", continua ad andare con la sua lanterna accesa, alla luce del sole, per i mercati, a cercare l’uomo ("anthropos") e a sognare il #sorgeredellaterra...
Nonostante Gioacchino da Fiore, Francesco d’Assisi, Chiara di Assisi, Dante Alighieri, e, addirittura, il lavoro iperstorico ("preistorico" e archeologico) sulle radici "Cosmicomiche" della Terra (Italo Calvino), Diogene di Sinope, definito dalla tradizione "Socrate pazzo", continua ad andare con la sua lanterna accesa, alla luce del sole, per i mercati, a cercare l’uomo ("anthropos") e a sognare il #sorgeredellaterra... -
> DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Veglia ecumenica in piazza San Pietro. Insieme, together, per dire Dio in tutte le lingue del mondo (di Riccardo Maccioni)..30 settembre 2023, di Federico La Sala
Oggi alle 18. I cristiani pregano per il Sinodo, veglia ecumenica in piazza San Pietro
Sarà presieduta da papa Francesco. Insieme per dire Dio in tutte le lingue del mondo e sottolineare in unità con i leader della altre confessioni cristiane il dovere di puntare alla comunione
di Riccardo Maccioni (Avvenire, sabato 30 settembre 2023
Insieme, together, per dire Dio in tutte le lingue del mondo. Per abbracciare nella stessa preghiera i tanti carismi che arricchiscono la Chiesa cattolica. Per sottolineare in unità con i leader della altre confessioni cristiane il dovere di puntare alla comunione. Soprattutto per chiedere al Padre il dono dello Spirito perché guidi i lavori della XVI Assemblea generale del Sinodo dei vescovi che inizierà mercoledì prossimo per concludersi il 29 ottobre.
Oggi in piazza San Pietro è il giorno, anzi la sera di “Together”, la grande veglia che il Papa presiederà alle 18, alla presenza del patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I e dell’arcivescovo di Canterbury, il primate anglicano Justin Welby. In realtà però l’appuntamento inizia molto prima, anzi è già partito. La maggior parte dei giovani dai 18 ai 35 anni, provenienti da diversi Paesi europei e di tutte le denominazioni cristiani hanno raggiunto Roma già da ieri pomeriggio. Per loro è stato preparato un programma apposito, che prevede l’accoglienza presso le comunità e le famiglie romane, quindi stamani dalle 9 alle 11 dei “laboratori” in diverse zone di Roma e, a seguire, il pranzo al sacco, la preghiera di lode in San Giovanni in Laterano, il cammino-pellegrinaggio fino a piazza San Pietro e l’animazione con canti e musiche nell’attesa del Papa.
Gli appuntamenti “giovani” inoltre non si esauriranno con la Veglia ma proseguiranno domani mattina con la Messa nelle varie parrocchie di Roma, seguite dal pranzo. Oltre ottanta le comunità dell’Urbe che hanno aperto le loro porte ai graditissimi ospiti. Together, spiega padre Davide Carbonaro, parroco di Santa Maria in Portico in Campitelli è un evento «molto atteso», perché esprime «l’ecumenismo e la sinodalità, che trovano completezza in questa esperienza» in cui un evento «della Chiesa cattolica è preceduto da un momento di preghiera con fratelli delle altre confessioni cristiane» . «L’accoglienza - aggiunge don Stefano Cascio che guida la comunità di San Bonaventura da Bagnoregio a Torre Spaccata - rientra nel concetto che la Chiesa di Roma presiede nella carità, quindi nell’apertura all’altro».
La Veglia stessa del resto respira l’aria dell’universalità. Non a caso l’appuntamento è stato organizzato nel proprio stile dalla Comunità di Taizé, che si è avvalsa della collaborazione della Segreteria del Sinodo dei vescovi, del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, di quello per i laici, la famiglia e la vita e del Vicariato di Roma. Giunge in questo modo a realizzarsi una proposta lanciata due anni. «All’interno della stessa Chiesa cattolica - disse nell’ottobre 2021 disse il priore di Taizé frerè Alois invitato a parlare a Roma - , il Sinodo porterà alla luce grandi diversità. Queste saranno tanto più feconde nella ricerca della comunione, non per evitare o nascondere i conflitti, ma per alimentare un dialogo che riconcilia. Per favorire questo - aggiunse Alois - , mi sembra auspicabile che nel cammino sinodale ci siano dei momenti di respiro, delle soste, per celebrare l’unità già realizzata in Cristo e renderla visibile».
E sottolineare una volta di più il carattere ecumenico della Veglia, il patriarca ortodosso Bartolomeo I guiderà la preghiera di apertura mentre l’arcivescovo Welby, introdurrà la recita del Padre Nostro. Con loro tante voci differenti legate idealmente insieme dall’impegno a superare le divisioni e a promuovere un cammino di riconciliazione. «È una gioia essere qui - sottolinea Serge Sollogoub, arciprete del Patriarcato ecumenico di Francia - perché quando succede qualcosa in una Chiesa, dobbiamo gioire con essa; il Sinodo della Chiesa cattolica è molto importante». «Questo modo di intendere i legami tra le nostre Chiese - aggiunge la pastora Anne-Laure Danet responsabile delle relazioni tra le Chiese cristiane per la Federazione protestante francese - , legami di interdipendenza, di solidarietà, è essenziale nel movimento ecumenico. E ascoltare la Parola di Dio, lasciare che lo Spirito Santo ci ispiri e ci guidi, è anche parte di questo cammino insieme».
«Taizé è un luogo di ascolto dello Spirito Santo - osserva Karin Johannesson, vescovo della Chiesa luterana di Svezia - parliamo molto nella Chiesa, ma qui vengo per ascoltare, per discernere cosa dobbiamo fare insieme. Il processo del Sinodo è anche un processo di ascolto». Roma più che mai città dialogo dunque. Ma anche scintilla di un percorso virtuoso che vedrà iniziative di preghiera collegate con l’Urbe pressoché in ogni parte del mondo. Come dire che la famiglia dei credenti in Cristo sa che l’invocazione a Dio risulta più efficace se fatta, magari in lingue differenti ma con lo stesso desiderio di unità. Se nata insieme. Together.
-
>DIO È AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- FILOLOGIA, TEOLOGIA ED ECONOMIA. Giustizia o Rettitudine e le "buone" intenzioni della carità.3 giugno 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, TEOLOGIA ED ECONOMIA.
Sulla differenza (già aristotelica) tra la Saggezza (Prudenza /Phronesis) e la Sapienza (Scienza / Sofia), forse, sarebbe opportuno (quanto prima) fare epocale chiarezza e, possibilmente, non continuare a confondere la caritatevole Giustizia o Rettitudine (ebr. Zedaqah, o Tzedakah), la CHARITAS (gr. XAPITAS) del Logos evangelico, che richiama la grazia (Charis, gr. Xapis), con la "CARITAS" del logo di Mammona (lat. "carus": "caro", affetto e prezzo; e carestia)!
Con-fondere "Deus charitas est", con "Deus caritas est", acceca sull’ "Initium sapientiae timor Domini" (Sap. 7, 7-11) e fa perdere ogni possibilità di uscita dall’inferno delle "buone" intenzioni e della "buona" elemosina (carità)!
Federico La Sala
-
>LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! --- STORIA DELL’ARTE, FILOLOGIA, E ITTICA: "LA MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO.26 febbraio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E RINASCIMENTO, OGGI (26 FEBBRAIO 2023):
ESSERE, O NON ESSERE? LA DOMANDA DI AMLETO E "LA LEZIONE DI "ABO" (Achille Bonito Oliva).
Una nota a margine ... *
"L’ARTE DA SOLA NON ESISTE. Senza un sistema composto da media, collezionisti, mercato, musei, pubblico, le opere in sé non avrebbero valore". Con questo titolo, di forte tonalità hegeliana e marxista, Achille Bonito Oliva, sul "Robinson" ("la Repubblica" del 18 febbraio 2023), sollecita in qualche modo lodevolmente a ripensare "tutto".
SOCIALITÀ CRITICA. A onore di Bonito Oliva, per non lasciar cadere l’ago nel pagliaio e rischiare di non ritrovarlo, tenendo presente che né la "religione" né la "filosofia", come l’arte, esiste da sola, forse, è opportuno allargare l’area della coscienza del tempo presente e riprendere a cercare di capire meglio la situazione storica attuale, a tutti i livelli.
NAPOLI E "LA MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO. Considerato che «il Pesce puzza dalla testa» (soprattutto se si continua a confondere inconsapevolmente ICTUS con IXTHUS, "I.X.TH.U.S."), a mio parere, solleciterei una urgentissima riflessione antropologica sulla millenaria e moribonda tradizione del “Pensare l’artista come un demiurgo, produttore isolato d’immagini"!
COSMOTEANDRIA. Continuare così, come precisa Achille Bonito Oliva, "vuol dire non riuscire a comprendere l’esistenza di una condizione filosofica dell’arte e dell’artista" e, al di là delle allusioni e delle illusioni dello stesso "ABO" (relative alla "teoria della catastrofe" e allo "spostamento che raccoglie l’esigenza di una struttura edipica uccidendo il padre, ovvero il movimento precedente"), vuol dire interrogarsi radicalmente sulla figura dell’artista e sull’arte stessa, in quanto "produzione linguistica, e dunque, operatività e pratica culturale", al di fuori della logica cosmoteandrica del mondo attuale, che anche il sistema dell’arte ha contribuito a costruire.
NOTA: FILOLOGIA E ITTICA. "Ichthỳs. Antico simbolo cristiano di Cristo; le lettere greche (ΙΧΘΥΣ) che compongono la parola, formano l’acrostico ᾿Ιησοὸς Χριστὸς Θεοῦ υἱὸς Σωτήρ «Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore». (Treccani).
#Earthrise #Metaphysics #Anthropology #Eleusis2023 #Roma2024
*
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- MESSAGGIO EVANGELICO E SHAKESPEARE. UNA NOTA SU "ST. VALENTINE, OPHELIA, & CLAUDIUS in HAMLET".18 febbraio 2023, di Federico La Sala
TEATRO E METATEATRO: ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E CINEMA...
- SHAKESPEARE, L’AMORE, E IL MESSAGGIO EVANGELICO.
A PROPOSITO DI "ST. VALENTINE, OPHELIA, & CLAUDIUS in HAMLET", nel post del "February 14, 2018" del suo blog, Paul Adrian Fried, nella sua lodevole ricerca intesa a precisare il senso ’nascosto’ della intenzione shakespeariana di mostrare nel comportamento del personaggio Amleto un continuo riferimento alla tradizione biblica e, in particolare, alla vita del personaggio Gesù, ha toccato il punto nevralgico e messo il dito nella piaga.
A proposito di quanto succede nel giorno di San Valentino, egli scrive:
- "ALSO CONSIDER: St. Valentine’s day was probably more of a Catholic and popular feast (taken over from paganism) than a Protestant church feast in Shakespeare’s time, because although it included a tale of martyrdom and divine "caritas" love (a theological virtue), it is transformed in popular culture into a feast of Eros or human and romantic love." (cit.).
A mio parere, il "progetto" di Shahespeare è un tentativo di trovare con Amleto, in un tempo fuori dai cardini, la via per operare una "instauratio magna" alla Dante Alighieri (la "Monarchia" dei "Due Soli"), non alla Francesco Bacone (con il "parto maschio del tempo", 1602 ca.), che riporti l’intera umanità nella condizione (simbolicamente indicata e indicabile con la metafora) del "paradiso terrestre".
Per potersi orientare, su quanto è successo storicamente e culturalmente nel tempo di Shakespeare (considerando, in particolare, gli effetti della Riforma Protestante), credo sia opportuno e necessario chiarirsi le idee sul significato della parola "caritas", che non parla affatto e per nulla dell’amore evangelico (lat. Charitas, gr. Xàpitas), ma solo di Mammona (ricchezza e carestia)!
SAPEREAUDE!: PER CAPIR(SI), FORSE, CONVIENE RITORNARE NELLA CAVERNA (AL CINEMA). Per cominciare a riflettere, e anche in modo piacevole, si potrebbe rivedere il film di Steven Spielberg "Indiana Jones e l’ultima crociata" (1989) e, al contempo, ripensare alla connessione che il titolo ha con la stessa metodologia della ricerca archeologica (e, se si vuole, shakespeariana): "La X è il punto dove scavare" (cit.).
"AUT - AUT". “To be, or not to be, that is the question”(HAMLET, III.1): "Voi non potete servire Dio ["Deus charitas est"] e Mammona ["Deus caritas est"] (Luca 16, 13).
- COMMENTO DI PAUL ADRIAN FRIED: "We allow Mammon to invade and dominate the realms where love should rule. Dowries, "bride-price," capitalist pressure to turn Valentine’s day into increased profits for florists, corporate chocolatiers, corporate greeting cards.
- There have also been other collective acts of thievery, as Jennifer Rust explains in her book, "The Body in Mystery":
 What was once a communal mystery, the Corpus Mysticum, was taken over by church hierarchy:
What was once a communal mystery, the Corpus Mysticum, was taken over by church hierarchy:
 Then it was also stolen by secular politics, where instead of Christ as head of the mysterious body of the church, a living body where all members had things to contribute, instead the monarch is the Head, and the parliament and Body Politic are the monarch’s "second body."
Then it was also stolen by secular politics, where instead of Christ as head of the mysterious body of the church, a living body where all members had things to contribute, instead the monarch is the Head, and the parliament and Body Politic are the monarch’s "second body." - It was as you say, Federico: A time unhinged - in many ways!
- There have also been other collective acts of thievery, as Jennifer Rust explains in her book, "The Body in Mystery":
- AMORE, MORTE, E PSICOANALISI. DISAGIO NELLA CIVILTA’:
- COME FARE LA FESTA AGLI INNAMORATI E ALLE INNAMORATE E PORTARLI E PORTARLE ALL’INFERNO...
Chiarissimo Paul Adrian Fried ... condivido pienamente: onore al suo lavoro su "Hamlet". Il suo commento sul "giorno di San Valentino" coglie nel segno e arriva a fare chiarezza sul puttanesimo (di cui già parlava Giambattista Vico, nella sua "Scienza Nuova" del 1730), in cui pericolosamente navighiamo sempre più.
La saggezza, la lucidità, la pazienza, la lungimiranza di Shakespeare, come di Dante Alighieri, a mio parere, riposano sulla consapevolezza indistruttibile che Amore (lat. Charitas, gr. Xàpitas) è più forte di Mammon (Mammona) e che sa ben guidare Eros e Psiche al loro incontro Amore (Love)!
- PSICOANALISI. "L’infelicità nella civiltà ("Das Ungluck in der Kultur"): "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori; i Romani, che non avevano fondato la loro collettività statale sull’amore, non conobbero l’intolleranza religiosa, benché per loro la religione fosse un affare di Stato e lo stato fosse imbevuto di religione. Non fu un puro caso che il sogno germanico del dominio del mondo facesse appello all’antisemitismo come a suo complemento, e non è inconcepibile che il tentativo di stabilire una nuova civiltà comunista in Russia trovi il suo sostegno psicologico nella persecuzione della borghesia. Ci si chiede soltanto, con apprensione, che cosa si metteranno a fare i Sovieti, dopo che avranno sterminato la loro borghesia [...]" (S. Freud, Il disagio della civiltà, 1929).
In principio era la Costituzione (il Logos), non il Logo di "corporate chocolatiers, corporate greeting cards".
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- CRISTIANESIMO E FILOLOGIA: NOTE IN MEMORIA DI CHARLES MOELLER. "Dio nella letteratura del ’900" (di Massimo Borghesi).2 dicembre 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA E STORIA: RITORNARE A SCUOLA DA LORENZO VALLA (1440) E RISALIRE ALLA SORGENTE DELLA DIFFERENZA DI SIGNIFICATO TRA "CHARITAS" E "CARITAS".
IN #MEMORIA DEL TEOLOGO BELGA CHARLES MOELLER, A 110 ANNI DALLA SUA NASCITA. Note a margine di un articolo di Massimo Borghesi (Insula Europea) *
A) "#Karitas (von lat. #caritas = Teuerung, Hochachtung, hingebende Liebe, uneigennütziges Wohlwollen) ist im Christentum die Bezeichnung für die tätige Nächstenliebe und Wohltätigkeit. [...]"(https://de.wikipedia.org/wiki/Karitas).
B) #CHARITAS (gr. #XAPITAS). Che la "charitas" sia partecipe dell’orizzonte #greco è chiaro, così come la "caritas" sia partecipe dell’orizzonte #latino è altrettanto chiaro, ma che si continui ad equiparare logicamente, teologicamente, antropologicamente e filologicamente, "Dio-amore" ("Deus #charitas est") e "Dio-mammona ("#Deus #caritas est") è semplicente folle e autodistruttivo!
C) "I 110 anni dalla nascita di Charles Moeller (1912-1986), teologo e critico letterario belga, ci offrono l’occasione per ricordare un autore che non può e non deve essere dimenticato. Moeller, professore di filosofia presso l’Università Cattolica di Lovanio, ha collaborato al #ConcilioVaticanoII svolgendo un ruolo decisivo nella stesura dello schema XIII, La Chiesa nel mondo, che ha poi dato vita alla costituzione Gaudium et Spes. È stato Segretario della Segreteria per l’Unità dei Cristiani e, su incarico di Paolo VI, Rettore dell’Istituto Ecumenico di Gerusalemme. È l’autore di due grandi opere.
La prima, Sagesse grecque et paradoxe chrétien, pubblicata nel 1948, è un libro splendido, che ha come interlocutore ideale la gioventù francese, disorientata e priva di certezze, quale emergeva dall’immane tragedia della guerra. A essa, poggiante su un umanesimo distrutto, ben espresso dall’esistenzialismo in auge, Moeller proponeva il “paradosso” cristiano quale umanesimo assolutamente nuovo. Il metodo seguito era, in analogia a quanto aveva fatto #RomanoGuardini nei suoi studi su Hölderlin, Dostojewski, Rilke, di far risultare la verità cristiana rapportandola alla rappresentazione dell’uomo propria dell’opera artistico-letteraria.
 Omero e i tragici, Eschilo, Sofocle, Euripide da un lato e i moderni Shakespeare, Racine, Dostojewski dall’altro erano le grandi voci di un coro chiamate a evidenziare tanto i conflitti irrisolti dell’animo greco (il tema del male, del dolore, della morte, ecc.) quanto il modo in cui l’avvenimento cristiano muta l’orizzonte della drammatica nei tragici moderni. Attraversato dall’enigma della morte lo spirito greco oscilla, secondo Moeller, tra un’adesione profonda alla vita e alla terra e un rifiuto delle medesime quale vuota apparenza. Questo dissidio tra amore della “carne” e nostalgia di una pienezza in un aldilà, viene a risolversi solo con il cristianesimo. Solo qui viene realizzato ciò che i greci sognavano: «salvare il reale visibile e trasfigurarlo». Solo la risurrezione della carne consente al cuore di riconciliarsi con la terra senza rinnegare il desiderio di infinito che lo abita. Il dissidio greco torna, non superato, in quella parte della letteratura contemporanea che si rifiuta alla speranza cristiana.
Omero e i tragici, Eschilo, Sofocle, Euripide da un lato e i moderni Shakespeare, Racine, Dostojewski dall’altro erano le grandi voci di un coro chiamate a evidenziare tanto i conflitti irrisolti dell’animo greco (il tema del male, del dolore, della morte, ecc.) quanto il modo in cui l’avvenimento cristiano muta l’orizzonte della drammatica nei tragici moderni. Attraversato dall’enigma della morte lo spirito greco oscilla, secondo Moeller, tra un’adesione profonda alla vita e alla terra e un rifiuto delle medesime quale vuota apparenza. Questo dissidio tra amore della “carne” e nostalgia di una pienezza in un aldilà, viene a risolversi solo con il cristianesimo. Solo qui viene realizzato ciò che i greci sognavano: «salvare il reale visibile e trasfigurarlo». Solo la risurrezione della carne consente al cuore di riconciliarsi con la terra senza rinnegare il desiderio di infinito che lo abita. Il dissidio greco torna, non superato, in quella parte della letteratura contemporanea che si rifiuta alla speranza cristiana.Nel primo dei sei volumi dell’altra grande sua opera, Litterature du XX siècle et christianisme, tradotta in italiano da Vita e Pensiero, dal titolo Il silenzio di Dio, la «fedeltà al mondo» viene espressa mediante le figure di Camus e di Gide mentre il rifiuto, l’ombra sulla realtà, è presente nelle tendenze “gnostiche” di Aldous Huxley e Simone Weil. Ancora una volta solo nel cristianesimo l’antitesi può essere superata. Esso afferma che il mondo è salvo in quanto è trasfigurato. Tale trasfigurazione non sopprime la materia, né la personalità. Julien Green, Graham Greene, Bernanos documentano la difficile strada della fede, speranza, carità in un mondo velato dal dolore e dalla corruzione, il sì al finito nella luce dell’infinito. Fede, speranza e amore - le tre virtù teologali - costituiscono pure il tema dei successivi volumi dell’opera in una forma per cui esse si situano in continuità e al contempo in rottura con la fede, l’attesa, l’amore puramente umani.
 Il secondo volume, La fede in Gesù Cristo, vede come interlocutori Sartre, Martin du Gard, H. James, Malègue. Il terzo, La speranza degli uomini, espressa da Malraux, Kafka, Vercors, Sciolokov, Maulnier, Bombard, Sagan, Reymont, prepara, non senza una chiara discontinuità, il quarto, La speranza in Dio Padre, i cui autori: Anna Frank, Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Charles Du Bos, Fritz Hockwälder, Charles Péguy, «hanno decifrato i segni della seconda virtù teologale in una umanità straziata dal dolore e abbrutita dalla morte». Parimenti il volume quinto, Gli amori umani, con saggi su Françoise Sagan, Brecht, Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir, Paul Valéry, Saint-John Perse, doveva aprire il campo al sesto e ultimo volume sull’amore di Dio, l’«amore dello Spirito Santo», che uscirà postumo nel 1993 con il titolo Esilio e ritorno, dove tratta di Marguerite Duras, Ingmar Bergman, Valery Larbaud, François Mauriac, Gertrud von le Fort, Sigrid Undset.
Il secondo volume, La fede in Gesù Cristo, vede come interlocutori Sartre, Martin du Gard, H. James, Malègue. Il terzo, La speranza degli uomini, espressa da Malraux, Kafka, Vercors, Sciolokov, Maulnier, Bombard, Sagan, Reymont, prepara, non senza una chiara discontinuità, il quarto, La speranza in Dio Padre, i cui autori: Anna Frank, Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Charles Du Bos, Fritz Hockwälder, Charles Péguy, «hanno decifrato i segni della seconda virtù teologale in una umanità straziata dal dolore e abbrutita dalla morte». Parimenti il volume quinto, Gli amori umani, con saggi su Françoise Sagan, Brecht, Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir, Paul Valéry, Saint-John Perse, doveva aprire il campo al sesto e ultimo volume sull’amore di Dio, l’«amore dello Spirito Santo», che uscirà postumo nel 1993 con il titolo Esilio e ritorno, dove tratta di Marguerite Duras, Ingmar Bergman, Valery Larbaud, François Mauriac, Gertrud von le Fort, Sigrid Undset.
 La prospettiva dei volumi era chiara: mostrare mediante un approccio non astratto quale quello della letteratura, il soprannaturale come compimento, impossibile all’uomo, dell’umana natura. Tra cristiano e umano non v’è abisso che il mistero dell’incarnazione non abbia già superato. Fuori da questo incontro vi sono due possibili interpretazioni cristianamente riduttive: «gli umanisti, i quali elaborano un ordine umano chiuso su se stesso; e gli escatologisti, i quali trovano che la cultura, davanti alla prospettiva della fine dei tempi, non ha importanza alcuna». Entrambi, scrive Moeller, «affermano che la cultura cristiana non conta solo che gli uni preferiscono, segretamente, una storia puramente profana, gli altri invece, una storia di contenuto puramente religioso, ma tanto gli uni che gli altri sono infedeli all’incarnazione di Dio nella storia». Essere fedeli a essa significa assumere, nella fede, la totalità dell’umano. Di qui il grande amore di Moeller per Péguy, come di un testimone profetico del regno futuro, regno «carnale-spirituale», «temporale-eterno». «Nel mio Paradiso - scriveva Péguy - ci saranno le cattedrali di Chartres... ci sarà tutto». E ancora, come per puntualizzare: «Nel mio Paradiso ci saranno delle cose». Le cose, spiegava Moeller, «sono le parrocchie, i villaggi, i campi di grano, in una parola il vero regno di Dio, celeste e terrestre».
La prospettiva dei volumi era chiara: mostrare mediante un approccio non astratto quale quello della letteratura, il soprannaturale come compimento, impossibile all’uomo, dell’umana natura. Tra cristiano e umano non v’è abisso che il mistero dell’incarnazione non abbia già superato. Fuori da questo incontro vi sono due possibili interpretazioni cristianamente riduttive: «gli umanisti, i quali elaborano un ordine umano chiuso su se stesso; e gli escatologisti, i quali trovano che la cultura, davanti alla prospettiva della fine dei tempi, non ha importanza alcuna». Entrambi, scrive Moeller, «affermano che la cultura cristiana non conta solo che gli uni preferiscono, segretamente, una storia puramente profana, gli altri invece, una storia di contenuto puramente religioso, ma tanto gli uni che gli altri sono infedeli all’incarnazione di Dio nella storia». Essere fedeli a essa significa assumere, nella fede, la totalità dell’umano. Di qui il grande amore di Moeller per Péguy, come di un testimone profetico del regno futuro, regno «carnale-spirituale», «temporale-eterno». «Nel mio Paradiso - scriveva Péguy - ci saranno le cattedrali di Chartres... ci sarà tutto». E ancora, come per puntualizzare: «Nel mio Paradiso ci saranno delle cose». Le cose, spiegava Moeller, «sono le parrocchie, i villaggi, i campi di grano, in una parola il vero regno di Dio, celeste e terrestre».Un’affermazione che manifestava, appieno, il suo realismo, la sua passione per la realtà, il suo modo di sentire il cristianesimo: come resurrezione della carne e non già come fuga idealistica dal mondo. Nel gennaio del 1979 ho avuto l’occasione di incontrarlo. Un amico doveva intervistarlo per il settimanale “Il Sabato” e mi chiese di accompagnarlo in via della Conciliazione, a Roma, dove si trovava. Ricordo che gli rivolsi una domanda su Simone Weil alla quale rispose: «Debbo dire che il capitolo su Simone Weil del primo volume di Letteratura e cristianesimo non è un buon capitolo. La reattività, con cui l’ho pensato e scritto, mi ha impedito di comprendere il profondo significato della Weil. Ho scritto in modo reattivo, perché in certi ambienti culturali e religiosi del Belgio e della Francia di quel tempo non vi era sufficiente coscienza del pericolo gnostico e dualista di alcuni testi della Weil. Oggi non vi è più questo pericolo nel leggere la Weil e, se si confrontano la prima e la settima edizione, si scorgono i mutamenti che vi ho apportato». Si trattava di una rettifica importante che consentiva di non contrapporre la Weil all’amato Péguy.
 Quando lo incontrammo, nel 1979, gli chiedemmo dei suoi progetti futuri. Ci rispose che stava lavorando al sesto volume di Letteratura e cristianesimo, che uscirà postumo, e poi ad un libro sul «metodo di lettura del passato» e, da ultimo, ad un testo su Proust. Instancabile e generoso fino alla fine ci ha lasciato pagine indimenticabili sulla letteratura classica e sulla grande letteratura del ‘900.
Quando lo incontrammo, nel 1979, gli chiedemmo dei suoi progetti futuri. Ci rispose che stava lavorando al sesto volume di Letteratura e cristianesimo, che uscirà postumo, e poi ad un libro sul «metodo di lettura del passato» e, da ultimo, ad un testo su Proust. Instancabile e generoso fino alla fine ci ha lasciato pagine indimenticabili sulla letteratura classica e sulla grande letteratura del ‘900.* Cfr. Massimo Borghesi, "Dio nella letteratura del ’900", Insula Europea, 30 novembre 2022.
-
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA! AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- SOLIDARIETÀ. Papa Francesco: alla Caritas spagnola, “non cadere nel grande business della carità”.15 ottobre 2022, di Federico La Sala
SOLIDARIETÀ
Papa Francesco: alla Caritas spagnola, “non cadere nel grande business della carità”
di AgenSir *
“Per favore, fate attenzione alle risorse, ma non cadete nel grande business della carità, dove il 40, 50, 60% delle risorse è destinato a pagare gli stipendi di quanti vi lavorano”. Lo ha detto il Papa, nel discorso - in spagnolo - rivolto oggi alla Caritas spagnola, ricevuta in udienza, infarcito di diverse aggiunte a braccio. “Ci sono aziende in Europa, ci sono, scusate, movimenti di istituzioni di carità, che arrivano al 60%, credo sia troppo... Ma 40 e oltre% è destinato agli stipendi”, il monito di Francesco: “No. Meno mediazioni possibili! E quelle che ci sono, per quanto possibile, per vocazione, non come lavoro.’Vieni che ti do un lavoro in Caritas...’ No, no. Questo non va bene”.
 “A motivarci, a farci raggiungere obiettivi programmati non sono i risultati ma il metterci dinanzi a una persona che è spezzata, che non trova il proprio posto, e accoglierla, aprire per lei cammini di recupero di modo che possa trovare se stessa, essendo capace, nonostante i suoi limiti e i nostri, di cercare il suo posto e di aprirsi agli altri e a Dio”, ha spiegato il Papa, che sempre a braccio, ha consigliato un romanzo, “Hermanito”, di Amets Arzallus Antia e Ibrahima Balde: “È la vita di un migrante dell’Africa centrale che arriva in Spagna, credo che abbia impiegato due anni e mezzo per arrivarci, o tre. Tutto ciò che ha dovuto subire e come è stato accolto con carità in quel luogo, e come è riuscito a rimettersi in piedi e a raccontare la sua esperienza”.
“A motivarci, a farci raggiungere obiettivi programmati non sono i risultati ma il metterci dinanzi a una persona che è spezzata, che non trova il proprio posto, e accoglierla, aprire per lei cammini di recupero di modo che possa trovare se stessa, essendo capace, nonostante i suoi limiti e i nostri, di cercare il suo posto e di aprirsi agli altri e a Dio”, ha spiegato il Papa, che sempre a braccio, ha consigliato un romanzo, “Hermanito”, di Amets Arzallus Antia e Ibrahima Balde: “È la vita di un migrante dell’Africa centrale che arriva in Spagna, credo che abbia impiegato due anni e mezzo per arrivarci, o tre. Tutto ciò che ha dovuto subire e come è stato accolto con carità in quel luogo, e come è riuscito a rimettersi in piedi e a raccontare la sua esperienza”.
 “I poveri devono essere sempre accolti, accompagnati e integrati”, la ricetta di Francesco: “Parafrasando il Vangelo di Giovanni, se venissimo cercati e venissimo lodati solo perché la gente ha mangiato pane e per questo motivo ci sentissimo come re, staremmo tradendo il messaggio di Gesù”.
“I poveri devono essere sempre accolti, accompagnati e integrati”, la ricetta di Francesco: “Parafrasando il Vangelo di Giovanni, se venissimo cercati e venissimo lodati solo perché la gente ha mangiato pane e per questo motivo ci sentissimo come re, staremmo tradendo il messaggio di Gesù”.(M.N.)
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- ARTEMISIA GENTILESCHI E LA "CARITAS ROMANA", RITROVATA IN AUSTRIA.21 luglio 2022, di Federico La Sala
LETTERATURA, ARTE, FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA:
ARTEMISIA GENTILESCHI E LA "CARITAS ROMANA". Una storia da approfondire...
***
RITROVATA IN AUSTRIA LA CARITAS ROMANA DI ARTEMISIA GENTILESCHI
IL DIPINTO STAVA PER ANDARE ALL’ASTA DA DOROTHEUM
- [Foto] Artemisia Gentileschi, Caritas romana. Foto Carabinieri TPC Bari
di FRANCESCA GREGO (Arte.it. 19/07/2022).
Bari - Un dipinto “di autore ignoto” del valore di 200 mila euro: nel 2019 questa dichiarazione sfacciatamente mendace aveva consentito alla Caritas Romana di Artemisia Gentileschi di varcare il confine italo-austriaco per essere battuta all’asta a Vienna, da Dorotheum. Ma i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari si sono gettati sulle tracce della tela e l’hanno riportata a casa prima della vendita, applicando per la prima volta un provvedimento di freezing a un’opera d’arte italiana.
Commissionato alla pittrice seicentesca dal conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, il quadro ha in realtà un valore di oltre 2 milioni di euro: una cifra talmente esorbitante da spingere gli eredi dell’ultimo discendente degli Acquaviva a tentare la strada dell’esportazione fraudolenta. Nascondendo l’attribuzione ad Artemisia, il valore reale dell’opera e il legame con lo storico Castello Marchione di Conversano (Bari), dove la Caritas Romana ha abitato ininterrottamente per quattro secoli, con l’aiuto di una società di intermediazione toscana i nuovi proprietari erano riusciti ad ottenere un attestato di libera circolazione dall’Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura a Genova. Ora sono indagati per truffa ed esportazione illecita, mentre il dipinto sarà sottoposto ad analisi tecniche e a un incidente probatorio che ne definirà con precisione caratteristiche e valore, prima di trovare una nuova casa.
Come molte tele di Artemisia, la Caritas Romana offre allo spettatore un’immagine forte: una giovane donna che allatta un uomo anziano, suo padre. È la storia di Cimone e Pero, narrata dallo storico romano Valerio Massimo, fonte di ispirazione per artisti come Caravaggio, Rubens e Vermeer. Siamo nella Roma repubblicana, dove il vecchio Cimone è stato imprigionato e condannato a morire di fame. Pero ottiene il permesso di fargli visita a patto di non portargli del cibo. Ma ha partorito da poco e decide di sfamarlo con il latte del suo seno. Un giorno una guardia scopre la verità e la comunica ai superiori che, commossi dal gesto della donna, liberano Cimone. Attratta come sempre da figure femminili di spiccata personalità, qui Artemisia ci regala una scena di impatto potente, che ricorda la pittura di Caravaggio nel realismo e nel contrasto tra luci e ombre: un’opera di pregio artistico straordinario che ha rischiato di non fare più ritorno in Italia, come è accaduto a un’altra tela della stessa autrice battuta all’asta per 2 milioni di euro proprio da Dorotheum.
“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. Bisognerebbe educare alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”, ha detto citando Peppino Impastato il procuratore di Bari Roberto Rossi questa mattina, durante la presentazione del dipinto ritrovato: “Il motivo per il quale abbiamo fatto questa conferenza stampa - ha proseguito - non è il reato nella sua gravità, ma il fatto che recuperiamo la nostra storia, il nostro passato, quello che rende noi uomini liberi”.
***
FILOLOGIA E TEOLOGIA. IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA ("LOGOS"): "CARITAS" (ROMANA) O CHARITAS GRECA (XAPITAS)?! Ai filologi e alle filologhe, e alle filosofe e ai filosofi, e alle teologhe e ai teologi del #futuro l’ardua sentenza...
CHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. [...] NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád. (Diccionario de Autoridades - Tomo II - 1729).
***
LETTERATURA E CINEMA: FURORE. "Furore ("The Grapes of Wrath") è un romanzo di John Steinbeck. [...] Il titolo originale The Grapes of Wrath, letteralmente I grappoli d’ira (o I grappoli d’odio), è un verso tratto da The Battle Hymn of the Republic, di Julia Ward Howe [...] A loro volta questi versi si riferiscono al passaggio dell’Apocalisse 14:19-20. [...] La vicenda narra l’epopea della ’biblica’ trasmigrazione della famiglia Joad, che è costretta ad abbandonare la propria fattoria nell’Oklahoma a bordo di un autocarro e - attraverso il Texas Panhandle, il New Mexico e l’Arizona, lungo la Route 66 - a tentare di insediarsi in California, dove spera di ricostruirsi un avvenire. [...]
 Il romanzo termina con una immagine di coraggio e solidarietà di Rosasharn, che appena dopo il parto allatta un pover’uomo sfinito dalla fame." (John Steinbeck...).
Il romanzo termina con una immagine di coraggio e solidarietà di Rosasharn, che appena dopo il parto allatta un pover’uomo sfinito dalla fame." (John Steinbeck...).Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- QUALE RICAPITOLAZIONE? QUALE CAMMINO SINODALE?. Sturm und drang: quando a lasciare la Chiesa è un vicario generale (di Ludovica Eugenio - "Adista").24 maggio 2022, di Federico La Sala
Sturm und drang: quando a lasciare la Chiesa è un vicario generale
di Ludovica Eugenio (21/05/2022) *
41088 SPEYER-ADISTA. Che un vescovo si dimetta non fa molta notizia. Ma che un vicario generale dia le dimissioni per lasciare la Chiesa cattolica ed entrare in un’altra confessione religiosa è invece alquanto singolare. È accaduto in Germania, nella diocesi di Speyer, dove il vicario generale mons. Andreas Sturm, 47 anni, ha rinunciato al suo incarico, dopo un tormento durato un anno e mezzo, secondo quanto ha dichiarato al Mannheimer Morgen (10/5), per aderire alla Chiesa vetero-cattolica come pastore. Il vescovo di Speyer mons. Karl-Heinz Wiesemann ha accettato le dimissioni e ha liberato Sturm da tutti i doveri sacerdotali, e ha nominato al suo posto Markus Magin, rettore del seminario, con effetto immediato.
Sturm, vicario dal 2018 e in questa veste responsabile di migliaia di dipendenti e di un budget di milioni, è stato sempre più il volto di una Chiesa capace di riformarsi, prendendo coraggiosamente posizione su questioni come la benedizione delle relazioni omosessuali e il celibato. Ha rilasciato una dichiarazione personale sulle motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo passo, pubblicata sul sito della diocesi: «Ho perso la speranza e la fiducia nel corso degli anni che la Chiesa cattolica romana possa davvero cambiare», ha affermato in una lettera. «Allo stesso tempo, vedo quanta speranza è riposta nei processi in corso come il Cammino sinodale», ma non si sente più di «annunciare questa speranza e di sostenerla onestamente e sinceramente perché semplicemente non ce l’ho più».
In una lettera alla diocesi, il vescovo Wiesemann afferma di aver accettato «con grande rammarico» le dimissioni del vicario, perché con lui aveva lavorato in «profonda fiducia». «Andreas Sturm ha portato molte cose positive nella nostra diocesi con i suoi modi pragmatici ed entusiasti e il suo impegno appassionato per una Chiesa rinnovata che è stata toccata da Dio ed è vicino alle persone». Il vicario ha guidato la diocesi di Speyer per diversi mesi, durante l’assenza del vescovo per motivi di salute. Nella sua dichiarazione personale, Sturm ha sottolineato di non andarsene con rabbia, «ma con grande speranza per me e per la mia stessa vocazione»; chiede perdono a tutti: «Semplicemente non ne avevo più le forze».
 Il 15 giugno uscirà il suo libro, per le edizioni Herder, intitolato Ich muss raus aus dieser Kirche (“Devo uscire da questa Chiesa”), nel quale mette a nudo se stesso e gli abusi nella Chiesa, facendo un bilancio spietato ma anche un’ammissione di fallimento personale. Il sottotitolo del libro è ancora più espressivo del titolo: Weil ich Mensch bleiben will, “Perché voglio rimanere umano”.
Il 15 giugno uscirà il suo libro, per le edizioni Herder, intitolato Ich muss raus aus dieser Kirche (“Devo uscire da questa Chiesa”), nel quale mette a nudo se stesso e gli abusi nella Chiesa, facendo un bilancio spietato ma anche un’ammissione di fallimento personale. Il sottotitolo del libro è ancora più espressivo del titolo: Weil ich Mensch bleiben will, “Perché voglio rimanere umano”.Sturm è stato parroco nella diocesi per 20 anni e, oltre alla pastorale comunitaria, ha lavorato come guida spirituale della Comunità dei Giovani Cattolici (KjG) e come presidente diocesano della Associazione della Gioventù Cattolica Tedesca (BDKJ).
Perché la scelta di unirsi alla Chiesa veterocattolica? Nata negli anni ‘70 dell’Ottocento in contrasto con le risoluzioni del Concilio Vaticano I (1869-1870) sull’infallibilità e il primato del papa, la diocesi tedesca veterocattolica conta ben 16.000 membri in 60 parrocchie. Negli ultimi anni, ha visto un grande afflusso di membri in precedenza cattolici per la sua apertura rispetto a diversi temi: celibato opzionale e preti sposati, sacerdozio femminile, accoglienza delle persone Lgbtq e matrimonio religioso per le coppie omosessuali.
Motivi profondi
«Gli abusi sono stati un grosso problema», ha affermato Sturm; Il rapporto dello studio MHG nel settembre 2018 «ha infranto» la sua visione del mondo. «Ho sempre pensato che ci fossero abusi nella Chiesa, ma il fatto che la percentuale di casi sia così alta rispetto alla società nel suo insieme, e vedere quanto sia difficile affrontare il problema nella Chiesa è stato determinante». Anche il ruolo delle donne nella Chiesa è stato per lui un punto dolente: «Gesù non ha chiamato solo gli uomini. Noi neghiamo le vocazioni femminili». C’è molta ricerca teologica in questo campo, «noi, invece, continuiamo a ingrandire le parrocchie solo perché pensiamo che possano esserci, come preti, solo uomini non sposati». Questa considerazione porta al terzo tema, il celibato obbligatorio per i preti. «Non possono essere ammessi anche uomini sposati o che vivono con un uomo?», ha chiesto. Lui stesso ha ammesso di aver violato il celibato: «Ma soprattutto ho ferito delle persone, cosa di cui mi dispiace molto». Sturm ha attirato l’attenzione a livello nazionale quando si è opposto al divieto del Vaticano, nel 2021, di celebrare benedizioni delle coppie omosessuali e ha annunciato che avrebbe continuato a benedirle.
Quando, all’inizio di quest’anno, 125 persone queer al servizio nella Chiesa - preti, ex preti, insegnanti, funzionari della Chiesa a vario titolo, volontari - hanno fatto coming out con la campagna #OutInChurch chiedendo di eliminare le «dichiarazioni obsolete della dottrina della Chiesa» sui temi di genere, una benedizione in chiesa per le coppie dello stesso sesso, un cambiamento nella legge sul lavoro della Chiesa, che considera l’omosessualità dei propri dipendenti una violazione della lealtà, e la fine della discriminazione nei confronti dei credenti omosessuali, bisessuali e transgender, Sturm è stato tra coloro che hanno garantito l’assenza di conseguenze sul diritto del lavoro per i dipendenti della Chiesa queer (v. Adista News, 28/1/22).
Sturm ebbe parole di forte critica anche quando il Vaticano, nel 2020, emanò l’Istruzione sulla vita parrocchiale dal titolo “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, che poneva l’accento sulla centralità della figura sacerdotale (v. Adista Notizie n. 30/20), dicendosi deluso del fatto «che i tentativi delle diocesi di affrontare in modo costruttivo la mancanza di sacerdoti e di trovare nuovi modi di cura pastorale stiano ricevendo così poco supporto da parte della Congregazione per il Clero». Per lui, la corresponsabilità tra clero e laici nelle parrocchie - una possibilità che il Vaticano escludeva chiaramente nella istruzione - non costituiva «una minaccia, ma un’opportunità per le parrocchie e anche per i sacerdoti», e la condivisione degli incarichi tra preti, diaconi, religiosi e laici «rafforzano l’unità in una comunità e arricchiscono la parrocchia di punti di vista differenti».
I commenti
Le dimissioni e l’uscita dalla Chiesa di mons. Sturm hanno suscitato molto scalpore, ma non eccessivo stupore: «La crisi della Chiesa scuote profondamente il popolo di Dio in questo Paese e nel frattempo ha raggiunto anche il livello di leadership» commenta su katholisch.de Christoph Brüwer (17/5). «Eppure questa reazione non sorprende». Di certo, continua, è palpabile «la disillusione e la delusione tra coloro che sperano in riforme nella Chiesa. Per molti Sturm è stato un pioniere che, ad esempio, ha chiesto l’ordinazione delle donne diacono». Le sue dimissioni - questo è il suo timore maggiore - «significano anche una battuta d’arresto per processi di riforma come il percorso sinodale: a quanto pare anche i rappresentanti di alto rango della Chiesa non credono più che le riforme in discussione saranno effettivamente decise e attuate in modo tempestivo, e non possono più annunciare in modo credibile questa speranza. -Alla prossima assemblea sinodale di settembre, i sinodali avranno l’opportunità di contrastare questa sensazione e di prendere decisioni concrete. Resta da vedere quante persone trarranno coraggio e speranza da questo».
* Tratto da: Adista Notizie n° 19 del 28/05/2022
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- DANTE, MICHELANGELO E LA FILOLOGIA: UNA QUESTIONE DI ANTROPOLOGIA E DI PRESEPE.23 novembre 2021, di Federico La Sala
#STORIA #ARTE #ARTERAPIA #FILOSOFIA #FILOLOGIA:
IL #QUADRO E LA #CORNICE DEL #TONDO DONI.
UNA #QUESTIONE DI #ANTROPOLOGIA E DI #PRESEPE ...
Ad #Arte? Se nella #cornice del #TondoDoni, "sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti" (Galleria degli Uffizi), e non quelle di #due profeti e di due #sibille, cosa si può capire dei #due soli di #Dante e del racconto della #Cappella Sistina?:
Michelangelo dipinse questa #SacraFamiglia per #AgnoloDoni, mercante fiorentino il cui prestigioso matrimonio nel 1504 con Maddalena Strozzi avvenne in un periodo cruciale per l’arte a #Firenze di inizio secolo. La compresenza in città di #Leonardo, #Michelangelo e #Raffaello apportò uno scatto di crescita al già vivace ambiente fiorentino, che nel primo decennio del secolo visse una stagione di altissimo fervore culturale.
 (...) La #cornice del #tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la #testa di #Cristo e quelle di #quattro #profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.
(...) La #cornice del #tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la #testa di #Cristo e quelle di #quattro #profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- L’avvio del Sinodo sulla Sinodalità e il "mettersi finalmente davvero in gioco seguendo la dinamica animata dallo Spirito" (di Antonio Spadaro)..6 novembre 2021, di Federico La Sala
Anticipazione.
Lo spirito autentico dei Sinodi è nel sapersi mettere in gioco
di Antonio Spadaro (Avvenire, giovedì 4 novembre 2021)
- L’articolo di questa pagina, scritto dal direttore di ’La Civiltà Cattolica’, padre Antonio Spadaro, è un’anticipazione tratta dal numero 4113 (6/20 Novembre 2021) del quindicinale della Compagnia di Gesù.
L’avvio del Sinodo sulla sinodalità, avvenuto il 9 ottobre scorso, c’invita a porre la domanda su che cosa significa oggi essere Chiesa e quale sia il suo senso nella storia. E tale domanda è pure alla base del Cammino sinodale che la Chiesa italiana sta avviando, e di quello in corso o in fase di avvio in Germania, Australia e Irlanda. Chi ha seguito le Assemblee del Sinodo dei vescovi degli ultimi anni si è certamente reso conto di quanto sia emersa la diversità che plasma la vita della Chiesa cattolica. Se un tempo una certa latinitas o romanitas costituiva e modellava la formazione dei vescovi - i quali, tra l’altro, capivano almeno un po’ di italiano -, oggi emerge con forza la diversità a ogni livello: mentalità, lingua, approccio alle questioni. E ciò, lungi dall’essere un problema, è una risorsa, perché la comunione ecclesiale si realizza attraverso la vita reale dei popoli e delle culture. In un mondo fratturato come il nostro, è una profezia.
Non si deve immaginare la Chiesa come una costruzione di mattoncini Lego diversi che si incastrano tutti al punto giusto. Sarebbe questa un’immagine meccanica della comunione. Potremmo meglio pensarla come una relazione sinfonica, di note diverse che insieme danno vita a una composizione. Se dovessimo proseguire usando questa immagine, direi che non si tratta di una sinfonia dove le parti sono già scritte e assegnate, ma di un concerto jazz, dove si suona seguendo l’ispirazione condivisa nel momento. Chi ha fatto l’esperienza dei recenti Sinodi dei vescovi avrà percepito le tensioni che emergevano all’interno dell’Assemblea, ma anche il clima spirituale nel quale erano - per lo più - immerse. Il Pontefice ha sempre molto insistito sul fatto che il Sinodo non è un’assemblea parlamentare dove si discute e si vota per maggioranza e minoranza. Il protagonista, in realtà, è lo Spirito Santo, che «muove e attira», come scrive sant’Ignazio nei suoi Esercizi spirituali. Il Sinodo è un’esperienza di discernimento spirituale alla ricerca della volontà di Dio sulla Chiesa.
Che questa visione del Sinodo sia anche una visione della Chiesa, non è da mettere in discussione. C’è una ecclesiologia - maturata negli anni grazie al Concilio Vaticano II - che oggi si dispiega. Per questo c’è bisogno di grande ascolto. Ascolto di Dio, nella preghiera, nella liturgia, nell’esercizio spirituale; ascolto delle comunità ecclesiali nel confronto e nel dibattito sulle esperienze (perché è sulle esperienze che si può far discernimento e non sulle idee); ascolto del mondo, perché Dio vi è sempre presente, ispirando, muovendo, agitando: abbiamo l’opportunità di diventare «una Chiesa che non si separa dalla vita», ha detto Francesco salutando i partecipanti intervenuti all’inizio del percorso sinodale (9 ottobre). Il Pontefice ha quindi sintetizzato così: «Siete venuti da tante strade e Chiese, ciascuno portando nel cuore domande e speranze, e sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le fatiche e i desideri dell’umanità». Mettere la Chiesa in stato sinodale significa renderla inquieta, scomoda, tesa perché agitata dal soffio divino, che certo non ama safe zones, aree protette: soffia dove vuole.
Il modo peggiore per fare sinodo allora sarebbe quello di prendere il modello delle conferenze, dei congressi, delle “settimane” di riflessione, e immaginare che così tutto possa procedere in modo ordinato, anche cosmeticamente. Altra tentazione è l’eccessiva premura per la «macchina sinodale», perché tutto funzioni come previsto. Se non c’è il senso della vertigine, se non si sperimenta il terremoto, se non c’è il dubbio metodico - non quello scettico -, la percezione della sorpresa scomoda, allora forse non c’è sinodo. Se lo Spirito Santo è in azione - una volta ha affermato Francesco -, allora «dà un calcio al tavolo». L’immagine è riuscita, perché è un implicito riferimento a Mt 21,12, quando Gesù «rovesciò i tavoli» dei mercanti del tempio.
Per fare sinodo occorre cacciare i mercanti e rovesciare i loro tavoli. Non sentiamo oggi il bisogno di un calcio dello Spirito, se non altro per svegliarci dal torpore? Ma chi sono oggi i «mercanti del tempio»? Solo una riflessione intrisa di preghiera potrà aiutarci a identificarli. Perché non sono i peccatori, non sono i «lontani», i non credenti, e neanche chi si professa anticlericale. Anzi, a volte essi ci aiutano a capire meglio il tesoro prezioso che conteniamo nei nostri poveri vasi di argilla. I mercanti sono sempre prossimi al tempio, perché lì fanno affari, lì vendono bene: formazione, organizzazione, strutture, certezze pastorali. I mercanti ispirano l’immobilismo delle soluzioni vecchie per problemi nuovi, cioè l’usato sicuro che è sempre un «rattoppo », come lo definisce il Pontefice. I mercanti si vantano di essere «al servizio » del religioso. Spesso offrono scuole di pensiero o ricette pronte all’uso e geolocalizzano la presenza di Dio che è «qui» e non «lì».
Fare sinodo allora implica essere umili, azzerare i pensieri, passare dall’«io» al «noi», aprirsi. Colpisce in questo senso, ad esempio, quanto ha detto il Relatore generale del Sinodo, cardinale Jean-Claude Hollerich, nel suo saluto il 9 ottobre durante l’inaugurazione: «Devo confessare che non ho ancora idea del tipo di strumento di lavoro che scriverò. Le pagine sono vuote, sta a voi riempirle». Occorre vivere il tempo sinodale con pazienza e attesa, aprendo bene occhi e orecchie. «Effatà cioè: “Apriti!”» (Mc 7,34) è la parola chiave del Sinodo. Roland Barthes - da esimio linguista e semiologo - aveva capito che gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola servono a creare un linguaggio di interlocuzione con Dio fatto di ascolto e parola. Occorre comprendere che il Sinodo, a suo modo, condivide questa natura linguistica, di creatore di linguaggio. Ed è per questo che è importante il metodo, cioè il modo e le regole del cammino, soprattutto in funzione del pieno coinvolgimento.
 In definitiva, la dinamica che si sviluppa nel Sinodo può essere descritta come un «giocarsi», un «mettersi in gioco». E, ad esempio, giocare a calcio non significa soltanto tirare una palla, ma anche correrle dietro, «essere giocati» dalle situazioni che si verificano in campo. Infatti, «il gioco raggiunge il proprio scopo solo se il giocatore si immerge totalmente in esso», come scrive Gadamer nel suo celebre saggio “Verità e metodo”. Il soggetto del gioco, dunque, non è il giocatore, ma il gioco stesso, che prende vita attraverso i giocatori. E questo è, in fondo, lo spirito del Sinodo: mettersi finalmente davvero in gioco seguendo la dinamica animata dallo Spirito.
In definitiva, la dinamica che si sviluppa nel Sinodo può essere descritta come un «giocarsi», un «mettersi in gioco». E, ad esempio, giocare a calcio non significa soltanto tirare una palla, ma anche correrle dietro, «essere giocati» dalle situazioni che si verificano in campo. Infatti, «il gioco raggiunge il proprio scopo solo se il giocatore si immerge totalmente in esso», come scrive Gadamer nel suo celebre saggio “Verità e metodo”. Il soggetto del gioco, dunque, non è il giocatore, ma il gioco stesso, che prende vita attraverso i giocatori. E questo è, in fondo, lo spirito del Sinodo: mettersi finalmente davvero in gioco seguendo la dinamica animata dallo Spirito.Direttore “La Civiltà Cattolica”
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- STORIA E FILOLOGIA. Il cardinal Ravasi ricostruisce la "Biografia di Gesù. Secondo i Vangeli", nello spirito di San Paolo (di Alesandro Zaccuri).29 ottobre 2021, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA: IL MESSAGGIO EVANGELICO, "IL FIGLIO DELL’UOMO", E IL "DIO AMORE", IL "DEUS CHARITAS"... *
Il nuovo libro di Ravasi. In parole e in opere: così si racconta Gesù
Il cardinal Ravasi ricostruisce la “biografia” di Cristo in una traversata della Scrittura che fa dell’Incarnazione un principio storico e interpretativo
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, mercoledì 27 ottobre 2021)
- [Foto] Giotto, ’L’ingresso a Gerusalemme’ - Padova, Cappella degli Scrovegni
Nessuno meglio del cardinale Gianfranco Ravasi conosce la complessità con la quale è chiamato a confrontarsi chi voglia ripercorrere la vicenda di Gesù. È una tradizione ricchissima, che risale perlomeno alla Vita Iesu Christi data alle stampe nel 1474 dal certosino Ludolfo di Sassonia, precoce best seller di età umanistica del quale si contano 88 edizioni. Ma anche prima, anche nella lunga stagione del Medioevo la storia del Figlio dell’Uomo era stata raccontata più volte, attraverso le immagini della Biblia Pauperum diffusa ovunque in Europa, nelle cattedrali più sfarzose come nelle più remote pievi di campagna. Per non parlare del Novecento, che è l’epoca di Giovanni Papini e di François Mauriac, di Norman Mailer e di José Saramago. Il «pensoso palpito» del Cristo di Ungaretti si percepisce chiaramente anche nel tempo dell’inquietudine e della secolarizzazione, secondo una traiettoria che lo stesso Ravasi ripercorre con la consueta precisione all’inizio di questa sua Biografia di Gesù. Secondo i Vangeli (Cortina, pagine 256, euro 19,00, in libreria dal 28 ottobre). A dispetto dell’apparente semplicità, titolo e sottotitolo meritano di essere esaminati con attenzione, perché comporre una biografia di Gesù “secondo i Vangeli” significa anche addentrarsi in una “biografia dei Vangeli”.
Forte della sua autorità di biblista, il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura segue appunto questa strada, che è quella di un’esegesi tanto ragionata quanto appassionata. Non per niente, la “vita di Gesù” che più di ogni altra somiglia a questa di Ravasi è l’estroso Volete andarvene anche voi? di Luigi Santucci, uno scrittore che dello stesso Ravasi è stato amico e perfino complice sul piano spirituale e intellettuale. In quel libro, anziché ricondurre l’esistenza terrena di Cristo a uno schema narrativo, Santucci trasceglieva alcuni brani o versetti salienti e li commentava con la sua sensibilità di narratore e credente. Il metodo di Ravasi è un altro, ma risponde alla medesima logica di aderenza al testo.
C’è una biografia dei Vangeli, dicevamo, che coincide con la scoperta e con la valorizzazione della loro dimensione storica. Ravasi, com’è noto, non ha mai considerato come dato dirimente l’antichità del singolo frammento, preferendo insistere sul principio di storicità interna che preside alla struttura del canone neotestamentario, a sua volta convalidato dalle attestazioni di ambito profano (su tutte, il celebre dispaccio di Plinio il Giovane all’imperatore Traiano e la controversa ma comunque sintomatica menzione da parte di Giuseppe Flavio). Radicati nella storia, i Vangeli non sono tuttavia resoconti storici in senso stretto, ricorda Ravasi. Fin dal principio nel racconto della vita di Gesù gli elementi di cronaca si mescolano con l’interpretazione da parte della comunità dei discepoli, che in questo modo si fa partecipe dell’Incarnazione: proprio perché si è fatto uomo, Cristo può essere fatto oggetto di racconto; proprio perché è Dio, non può essere raccontato se non nella consapevolezza del mistero.
A rigore, la biografia dei Vangeli comincia fuori dai Vangeli stessi. Ravasi indica come punto germinale la dichiarazione di fede che, nella Pasqua dell’anno 57, Paolo riproduce nella Prima lettera ai Corinzi: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e fu sepolto. È risorto il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a Cefa e quindi ai Dodici». La novità buona del kerygma si colloca qui, nell’indissolubilità tra Passione, Risurrezione e testimonianza proclamata dall’annuncio originario. Questo è anche il fuoco prospettico dell’intera Biografia di Gesù, nella quale Ravasi non si limita a passare in rassegna i quattro Vangeli, registrando le peculiarità di ciascuno dei Sinottici e argomentando la singolarità del testo di Giovanni.
L’aspetto più coinvolgente della sua Biografia di Gesù sta nell’individuazione dei grandi nuclei tematici che si ripresentando nelle sequenze narrative maggiori. Quelle riferite alla morte e Risurrezione, anzitutto, ma anche i racconti dell’infanzia, nei quali l’intonazione letteraria si fa più evidente, senza per questo inficiare la consistenza del fatto storico. Particolarmente convincente, fino a imporsi come l’aspetto più originale del libro, è la scelta di concentrarsi in modo specifico sulle due componenti essenziali del linguaggio di Gesù. La parola efficace delle parabole e il gesto eloquente dei miracoli sono indagati da Ravasi in capitoli carichi di spunti per la meditazione personale. «Le mani di Gesù - scrive tra l’altro l’autore - toccano ripetutamente carni malate, operano su persone sofferenti, s’intrecciano con le sue parole di speranza. Piaghe, organi paralizzati, corpi devastati o inerti sono ininterrottamente sotto l’azione di quelle mani».
Così come non comincia nei Vangeli, il racconto della vita di Gesù non si esaurisce in essi. A fianco del canone si situa infatti la lussureggiante biblioteca degli apocrifi, alla quale nel corso del tempo hanno attinto con larghezza artisti, poeti e narratori. Molte immagini alle quali siamo abituati e non poche figure fatte segno di devozione provengono da questa zona che Ravasi non manca di attraversare nelle ultime pagine del libro. Ancora una volta, si ritorna all’essenziale, ai giorni fatidici della condanna a morte e della Pasqua. Ripercorriamo così le peripezie di Pilato, che da personaggio storico diventa nella narrazione degli apocrifi esempio morale. E ci imbattiamo nella “correzione” più struggente, quella che nel Vangelo di Gamaliele rimedia al mancato incontro tra Gesù e la Madre. Episodio poi carissimo alla devozione popolare, a conferma di come la storia «di un Dio che si fa crocifiggere sul Golgota» (è la geniale sintesi di Borges) non smetta mai di essere raccontata.
* NOTARE BENE:
MESSAGGIO EVANGELICO E FIGLIO DELL’UOMO [nel senso di "Adamo" ed "Eva", di "Giuseppe" e "Maria"! - "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo [="Filius hominis" = "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"] deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34=C.E.I.]).
LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO. Prima lettera ai Corinzi, 11, 1-3: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «aner, andròs - uomo»], e capo di Cristo è Dio" .
Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- ORTOGRAFIA E ORTODOSSIA. Le avventure della lettera «H»: dall’alfabeto fenicio all’Ariosto, la vicenda millenaria del simbolo grafico «H» ricostruita dal ricercatore Fabio Copani e rilanciata dai social.23 ottobre 2021, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE DI SPIRITO. La storia millenaria di un errore ... *
Trappole dell’ortografia
«A» con l’acca o senza? Le avventure della lettera «H», la più odiata dagli italiani
Dall’alfabeto fenicio all’Ariosto, la vicenda millenaria del simbolo grafico «H» ricostruita dal ricercatore Fabio Copani e rilanciata dai social
di Redazione Scuola *
La più strana delle lettere dell’alfabeto
«Mamma, ma perché “Mario ha un amico” si scrive con l’acca visto che si pronuncia nello stesso identico modo di “Mario va a scuola”?». Perché è voce del verbo avere. «E allora perché non si scrive habbiamo e havete?». In latino effettivamente si scriveva così, ma si pronunciava anche diversamente, aspirando l’acca. Mentre in italiano la «H» è una lettera strana, una lettera muta.
Si scrive ma non si legge, si vede ma non si sente. Eppure è importantissima. Talmente importante che se non ci fosse si scatenerebbe l’Apocalisse: le chiese senza l’acca crollerebbero come sotto le bombe, i cherubini cadrebbero dal cielo, i bicchieri esploderebbero in mano, i galli invece di cantare starnutirebbero: CICCIRICÌ. E’ quanto immaginava Gianni Rodari in una filastrocca del Libro degli Errori in cui l’Acca - «stufa di non valere un’acca» - fuggiva dall’Italia. Ebbene a restituire l’onore perduto alla più bistrattata delle lettere dell’alfabeto ci ha pensato Fabio Copani, giovane dottore di ricerca in Storia greca, che ha ricostruito la sua lunga e travagliata odissea attraverso il Mediterraneo. Una storia che comincia sulle spiagge fenicie, monta a bordo delle navi dei commercianti libanesi, sbarca in Grecia, di lì a Cuma, e poi a Roma dove indispettisce Catullo e insuperbisce l’Ariosto, per atterrare infine sui manuali di scuola.
- [Foto] L’Acca in fuga di Gianni Rodari
La lettera Het nella lingua fenicia
La storia della H è antica quanto quella dell’alfabeto che, come si sa, fu inventato dai fenici. La «het» era l’ottava lettera dell’alfabeto fenicio e si scriveva con un segno a forma di rettangolo con un trattino in mezzo («acca chiusa»). Corrispondeva a un suono per noi sconosciuto che veniva prodotto con un restringimento della cavità orale all’altezza della faringe (i linguisti lo chiamano «spirante faringale»).
- [Foto] L’alfabeto fenicio
Dalle coste libanesi alla Grecia
A partire dal IX secolo a.C. i commercianti libanesi ebbero contatti sempre più frequenti con i greci i quali non restarono insensibili alle loro straordinarie invenzioni tecnologiche, dal vetro all’alfabeto. L’adozione dell’alfabeto fu un processo complesso perché il greco antico era una lingua indoeuropea con suoni diversi dal fenicio che era una lingua semitica. In greco molte parole iniziavano con delle vocali aspirate: quelle parole furono trascritte con il segno «het» davanti che stava a indicare appunto un’aspirazione.
- [Foto] Nave fenicia
Dalla acca chiusa all’acca aperta
Verso la fine del VII secolo a.C. vi fu una semplificazione dell’antico segno «het»: i due trattini superiore e inferiore vennero tralasciati e la lettera assunse la forma della nostra acca. Si passò così, gradualmente, dalla «acca chiusa» alle «acca aperta».
- [Foto] Alfabeto greco arcaico
L’alfabeto di Mileto
In greco antico esistevano però molti dialetti. A Mileto per esempio, e più in generale nella Ionia asiatica corrispondente alla costa centrale della Turchia, i greci parlavano un dialetto privo di aspirazioni (i linguisti lo chiamano «psilotico»). Loro usavano il simbolo «het» fenicio per indicare la vocale «e» lunga.
 Nel 403 a.C. la città di Atene decise con un decreto ufficiale di adottare l’alfabeto di Mileto. Fu così che il segno a forma di «acca» si impose quasi ovunque nel mondo greco come simbolo della lettera eta, cioè della «e» lunga, mentre per indicare il suono aspirato entrò in uso lo «spirito aspro» sopra le vocali iniziali.
Nel 403 a.C. la città di Atene decise con un decreto ufficiale di adottare l’alfabeto di Mileto. Fu così che il segno a forma di «acca» si impose quasi ovunque nel mondo greco come simbolo della lettera eta, cioè della «e» lunga, mentre per indicare il suono aspirato entrò in uso lo «spirito aspro» sopra le vocali iniziali.- [Foto] La porta del mercato di Mileto ricostruita al Pergamon di Berlino. Il reperto è di età romana
L’alfabeto dei cumani
Il segno a forma di acca ebbe una sorte diversa nelle colonie greche in Campania, prima fra tutte Cuma, che fu fondata dai greci dell’isola Eubea nell’VIII secolo. Nell’alfabeto dei cumani quel segno continuava a indicare il suono dell’acca aspirata e così passò anche ai romani che adottarono il simbolo nella sua variante aperta proprio per indicare il suono dell’aspirazione all’inizio di molte parole latine (homo, uomo, habere, avere, da cui l’acca che sopravvive ancora in italiano - anche se muta - nelle voci del verbo avere).
- [Foto] Cuma, l’antro della Sibilla
Catullo e l’acca del sussiegoso Arrio
Come avvenne il passaggio dalla acca aspirata latina all’acca muta italiana? Il fatto è che nell’Antica Roma i ricchi parlavano in un modo e i poveri in un altro: la lingua colta marcava l’acca all’inizio delle parole, il popolo ignorante invece non pronunciava l’acca. Ne dà testimonianza Catullo in una sua poesia in cui ironizza su un certo Arrio che per darsi un tono piazza l’acca aspirata a sproposito un po’ dappertutto.
- [Foto] Gaio Valerio Catullo
Ariosto e l’uomo senz’acca che è senza onore
La lingua parlata italiana ereditò la dizione del latino rustico che non pronunciava il suono aspirato all’inizio della parola. Tuttavia la acca sopravvisse nell’italiano scritto. Fra i suoi paladini più convinti, nel Rinascimento, vi fu Ludovico Ariosto («Chi leva la H all’huomo, e chi la leva all’honore, non è degno di honore»). Alla fine però i nemici dell’acca ebbero la meglio e imposero una grafia semplificata senza il segno «H» all’inizio della parola. A partire dalla fine del Seicento si definì una consuetudine ortografica che salvava l’acca solo nelle prime tre persone singolari e nella terza plurale dell’indicativo presente del verbo avere («ho», «hai», «ha», «hanno»), quelle cioè che si prestavano a confusione con altre parole dal suono uguale ma dal significato diverso («o», «ai», a», «anno»). E qui si chiude la storia millenaria di un errore secolare.
- [Foto] Ludovico Ariosto
* Corriere della Sera, 9 dicembre 1917 (ripresa parziale - senza immagini).
*
Sul tema, cfr.:
- IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione" [2006].
- Eric A. Havelock, "Dalla A alla Z. Le origini della civiltà della scrittura in Occidente", Il melangolo, 1987
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E AUTOANALISI ISTITUZIONALE. PER L’APERTURA DEL SINODO SULLA SINODALITÀ, UN INVITO E UNA SOLLECITAZIONE DI PAPA FRANCESCO.11 ottobre 2021, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E AUTOANALISI ISTITUZIONALE.
PER L’APERTURA DEL SINODO SULLA SINODALITÀ,
UN INVITO E UNA SOLLECITAZIONE
DI PAPA FRANCESCO
A TUTTA LA CHIESA CATTOLICA (E NON SOLO):
"[...] Chiediamoci, con sincerità, in questo itinerario sinodale: come stiamo con l’ascolto? Come va “l’udito” del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimersi, di camminare nella fede anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate?
Fare Sinodo è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo: è seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri. È scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È un #esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda - vescovi, preti, religiosi e laici, tutti, tutti i battezzati - evitando risposte artificiali e superficiali, risposte prêt-à-porter, no.
Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudono [...]"
 (cfr. IL TESTO INTEGRALE DELL’OMELIA DELLA MESSA DI APERTURA DEL SINODO)
(cfr. IL TESTO INTEGRALE DELL’OMELIA DELLA MESSA DI APERTURA DEL SINODO) -
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- ASSONANZE E DISSONANZE: EDITH STEIN E ANGELA ALES BELLO. Se, come diceva Freud, Eros unisce e Thanatos separa, ebbene il pensiero e l’esistenza di Edith Stein sono un inno alla relazione unitiva, all’amore e alla carità (di Massimo De Angelis).22 settembre 2021, di Federico La Sala
Un diario riflesso nella storia di due filosofe
Ales Bello scrive di sé rileggendo, commentando e dialogando con le pagine di Edith Stein. Un confronto su amicizia, fede e vita: inno alla carità
di MASSIMO DE ANGELIS (Avvenire, 19 settembre 2021).
La donna che visse molte volte si potrebbe dire di Edith Stein. Ebrea e cattolica, filosofa, femminista e monaca carmelitana, martire del nazismo e santa. Tutto racchiuso in una sola vita. Quella che viene ripercorsa in Assonanze e dissonanze di Angela Ales Bello, recentemente edito da Mimesis. Della Stein Ales Bello è tra le maggiori studiose e curatrici dell’opera in gran parte postuma e riportata alla luce con molte difficoltà nel corso del tempo.
Per l’autrice i mesi di "clausura" imposti dal Covid creano il clima adatto a un approfondimento ulteriore dell’intelletuale tedesca e danno il là alla struttura originale del volume. Ales Bello, infatti, scrive un proprio diario rileggendo, commentando e dialogando con pagine del diario del suo stesso "soggetto" di studio.
I due diari, così, s’intrecciano e alimentano "intersoggettivamente", dando vita a un confronto denso di amicizia e affetto tra due donne e filosofe distanziate da un secolo di pensiero e di storia.
Un confronto serrato su fenomenologia, fede, vita, amicizie-amori di Edith. Sullo sfondo una società e una cultura tedesche che si accartocciano, tra la prima guerra mondiale e l’ascesa del nazionalsocialismo, sino a quella "notte dei cristalli" che toglierà le bende dagli occhi di molti spalancando però già le porte dell’inferno.
Tre percorsi spiccano nel racconto. Quello della formazione e del lavoro filosofico di Stein, col suo ruolo prezioso di assistente di Edmund FIusserl, che le permette di conoscere tutte le pieghe della costruzione filosofica del maestro e persino di influirvi, consentendole poi di svolgere un ruolo equilibratore, che le è connaturato, nelle dispute tra i membri della scuola husserliana: tra chi pone l’accento sul fondamento "realista" della fenomenologia e chi invece ne sottolinea i legami con l’ "idealismo".
Per Edith la filosofia è la sua stessa vita anche se, in quanto donna, non può proporsi un chiaro percorso accademico e in quanto ebrea, a un certo punto, non potrà svolgere neppure alcun ruolo pubblico. Ma del suo esser donna e dell’unità tra pensiero e vita la sua filosofia reca il timbro, col rilievo che vengono ad assumere alcuni temi; insieme al momento dell"’intuizione", il tema dell’empatia e l’Erlebnis (l’esperienza) soprattutto, che Ales Bello invita Edith a rinominare rispettivamente "entropatia" e "vivenza".
Il secondo. percorso, profondamente legato a quello filosofico e messo bene a fuoco da Ales Bello, è proprio quello della a"femminilità ". Già da giovane Edith partecipa e anima i movimenti femministi. Ma anche in questo campo il suo contributo più che politico è filosofico.
Con grande anticipo, ella pone le basi di un pensiero della differenza sessuata, che delinea uno spartiacque ben più grande e radicale di quello aperto nella storia del pensiero dalla coppia "servo-signore". E, il suo, un contributo di straordinaria originalità.
La Stein studia il diverso modularsi del pensiero sulla base dei sessi, più unidirezionale quello maschile più portato alla completezza quello femminile (tendenze peraltro diversamente miscelate negli individui di entrambi i sessi) con grande attenzione alla psicologia e alle implirzioni pedagogiche.
Il terzo percorso, il più decisivo per la sua esistenza, è quello della fede. Dopo aver condiviso la religione ebraica del padre, così amato e prematuramente scomparso, dopo una transizione agnostica durante l’adolescenza, Edith scopre Gesù, e quindi il cristianesimo. E quello che ella stessa definisce «un passaggio, non una contrapposizione». Nel segno della continuità e del riferimento al medesimo Dio. E la dimensione personale della fede cristiana che la attrae.
Stein ama i mistici e Santa Teresa soprattutto, ma in lei anche la mistica è intessuta di filosofia e questa trova in sé luce dalla fede e dal rapporto con Dio. E il tema della sua ultima opera, Essere finito e Essere eterno ma è in fondo il sigillo di tutta la sua vita, sempre alla ricerca di continuità e relazioni: tra realismo e idealismo in filosofia e poi tra fenomenologia e tomismo, tra ebraismo e cristianesimo, tra maschile e femminile, tra filosofia e ragione.
Se, come diceva Freud, Eros unisce e Thanatos separa, ebbene il pensiero e l’esistenza della Stein sono un inno alla relazione unitiva, all’amore e alla carità, e la sua morte, subita in quanto ebrea e vissuta da cristiana, occupandosi nel campo di concentramento sino alla fine dei piccoli, è una trasfigurazione che illumina distintamente le radici (culturali, etiche e di fede) ebraico-cristiane di quell’Europa (quella che fu almeno) di cui Edith è patrona.
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- CHIESA, SINODO DEI VESCOVI, E "PROTAGONISMO" DEI BATTEZZATI. "Se io oggi domandassi: chi di voi sa la data del proprio battesimo?, credo che le mani alzate non sarebbero tante" (Papa Francesco - Udienza Generale, 8 settembre 2021).8 settembre 2021, di Federico La Sala
PAPA FRANCESCO
 UDIENZA GENERALE
UDIENZA GENERALE
 Aula Paolo VI
Aula Paolo VI
 Mercoledì, 8 settembre 2021 *
Mercoledì, 8 settembre 2021 *
Catechesi sulla Lettera ai Galati - 8. Siamo figli di Dio
Fratelli e sorelle, buongiorno!
Proseguiamo il nostro itinerario di approfondimento della fede - della nostra fede - alla luce della Lettera di San Paolo ai Galati. L’Apostolo insiste con quei cristiani perché non dimentichino la novità della rivelazione di Dio che è stata loro annunciata. In pieno accordo con l’evangelista Giovanni (cfr 1 Gv 3,1-2), Paolo sottolinea che la fede in Gesù Cristo ci ha permesso di diventare realmente figli di Dio e anche suoi eredi. Noi cristiani diamo spesso per scontato questa realtà di essere figli di Dio. È bene invece fare sempre memoria grata del momento in cui lo siamo diventati, quello del nostro battesimo, per vivere con più consapevolezza il grande dono ricevuto.
Se io oggi domandassi: chi di voi sa la data del proprio battesimo?, credo che le mani alzate non sarebbero tante. E invece è la data nella quale siamo stati salvati, è la data nella quale siamo diventati figli di Dio. Adesso, coloro che non la conoscono domandino al padrino, alla madrina, al papà, alla mamma, allo zio, alla zia: “Quando sono stato battezzato? Quando sono stata battezzata?”; e ricordare ogni anno quella data: è la data nella quale siamo stati fatti figli di Dio. D’accordo? Farete questo? [rispondono: sì!] È un “sì” così, eh? [ridono] Andiamo avanti...
Infatti, una volta che è «sopraggiunta la fede» in Gesù Cristo (v. 25), si crea la condizione radicalmente nuova che immette nella figliolanza divina. La figliolanza di cui parla Paolo non è più quella generale che coinvolge tutti gli uomini e le donne in quanto figli e figlie dell’unico Creatore. Nel brano che abbiamo ascoltato egli afferma che la fede permette di essere figli di Dio «in Cristo» (v. 26): questa è la novità. È questo “in Cristo” che fa la differenza. Non soltanto figli di Dio, come tutti: tutti gli uomini e donne siamo figli di Dio, tutti, qualsiasi sia la religione che abbiamo. No. Ma “in Cristo” è quello che fa la differenza nei cristiani, e questo soltanto avviene nella partecipazione alla redenzione di Cristo e in noi nel sacramento del battesimo, così incomincia. Gesù è diventato nostro fratello, e con la sua morte e risurrezione ci ha riconciliati con il Padre. Chi accoglie Cristo nella fede, per il battesimo viene “rivestito” di Lui e della dignità filiale (cfr v. 27).
San Paolo nelle sue Lettere fa riferimento più volte al battesimo. Per lui, essere battezzati equivale a prendere parte in maniera effettiva e reale al mistero di Gesù. Per esempio, nella Lettera ai Romani giungerà perfino a dire che, nel battesimo, siamo morti con Cristo e sepolti con Lui per poter vivere con Lui (cfr 6,3-14). Morti con Cristo, sepolti con Lui per poter vivere con Lui. E questa è la grazia del battesimo: partecipare della morte e resurrezione di Gesù. Il battesimo, quindi, non è un mero rito esteriore. Quanti lo ricevono vengono trasformati nel profondo, nell’essere più intimo, e possiedono una vita nuova, appunto quella che permette di rivolgersi a Dio e invocarlo con il nome di “Abbà”, cioè “papà”. “Padre”? No, “papà” (cfr Gal 4,6).
L’Apostolo afferma con grande audacia che quella ricevuta con il battesimo è un’identità totalmente nuova, tale da prevalere rispetto alle differenze che ci sono sul piano etnico-religioso. Cioè, lo spiega così: «non c’è Giudeo né Greco»; e anche su quello sociale: «non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina» (Gal 3,28). Si leggono spesso con troppa fretta queste espressioni, senza cogliere il valore rivoluzionario che possiedono. Per Paolo, scrivere ai Galati che in Cristo “non c’è Giudeo né Greco” equivaleva a un’autentica sovversione in ambito etnico-religioso. Il Giudeo, per il fatto di appartenere al popolo eletto, era privilegiato rispetto al pagano (cfr Rm 2,17-20), e Paolo stesso lo afferma (cfr Rm 9,4-5). Non stupisce, dunque, che questo nuovo insegnamento dell’Apostolo potesse suonare come eretico. “Ma come, uguali tutti? Siamo differenti!”. Suona un po’ eretico, no? Anche la seconda uguaglianza, tra “liberi” e “schiavi”, apre prospettive sconvolgenti. Per la società antica era vitale la distinzione tra schiavi e cittadini liberi. Questi godevano per legge di tutti i diritti, mentre agli schiavi non era riconosciuta nemmeno la dignità umana. Questo succede anche oggi: tanta gente nel mondo, tanta, milioni, che non hanno diritto a mangiare, non hanno diritto all’educazione, non hanno diritto al lavoro: sono i nuovi schiavi, sono coloro che sono alle periferie, che sono sfruttati da tutti. Anche oggi c’è la schiavitù. Pensiamo un poco a questo. Noi neghiamo a questa gente la dignità umana, sono schiavi. Così infine, l’uguaglianza in Cristo supera la differenza sociale tra i due sessi, stabilendo un’uguaglianza tra uomo e donna allora rivoluzionaria e che c’è bisogno di riaffermare anche oggi. C’è bisogno di riaffermarla anche oggi. Quante volte noi sentiamo espressioni che disprezzano le donne! Quante volte abbiamo sentito: “Ma no, non fare nulla, [sono] cose di donne”. Ma guarda che uomo e donna hanno la stessa dignità, e c’è nella storia, anche oggi, una schiavitù delle donne: le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini. Dobbiamo leggere quello che dice Paolo: siamo uguali in Cristo Gesù.
Come si può vedere, Paolo afferma la profonda unità che esiste tra tutti i battezzati, a qualsiasi condizione appartengano, siano uomini o donne, uguali, perché ciascuno di loro, in Cristo, è una creatura nuova. Ogni distinzione diventa secondaria rispetto alla dignità di essere figli di Dio, il quale con il suo amore realizza una vera e sostanziale uguaglianza. Tutti, tramite la redenzione di Cristo e il battesimo che abbiamo ricevuto, siamo uguali: figli e figlie di Dio. Uguali.
Fratelli e sorelle, siamo dunque chiamati in modo più positivo a vivere una nuova vita che trova nella figliolanza con Dio la sua espressione fondante. Uguali perché figli di Dio, e figli di Dio perché ci ha redento Gesù Cristo e siamo entrati in questa dignità tramite il battesimo. È decisivo anche per tutti noi oggi riscoprire la bellezza di essere figli di Dio, di essere fratelli e sorelle tra di noi perché inseriti in Cristo che ci ha redenti. Le differenze e i contrasti che creano separazione non dovrebbero avere dimora presso i credenti in Cristo. E uno degli apostoli, nella Lettera di Giacomo, dice così: “State attenti con le differenze, perché voi non siete giusti quando nell’assemblea (cioè nella Messa) entra uno che porta un anello d’oro, è ben vestito: ‘Ah, avanti, avanti!’, e lo fanno sedere al primo posto. Poi, se entra un altro che, poveretto, appena si può coprire e si vede che è povero, povero, povero: ‘sì, sì, accomodati lì, in fondo’”. Queste differenze le facciamo noi, tante volte, in modo inconscio. No, siamo uguali. La nostra vocazione è piuttosto quella di rendere concreta ed evidente la chiamata all’unità di tutto il genere umano (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 1). Tutto quello che esaspera le differenze tra le persone, causando spesso discriminazioni, tutto questo, davanti a Dio, non ha più consistenza, grazie alla salvezza realizzata in Cristo. Ciò che conta è la fede che opera seguendo il cammino dell’unità indicato dallo Spirito Santo. E la nostra responsabilità è camminare decisamente su questa strada dell’uguaglianza, ma l’uguaglianza che è sostenuta, che è stata fatta dalla redenzione di Gesù.
Grazie. E non dimenticatevi, quando tornerete a casa: “Quando sono stata battezzata? Quando sono stato battezzato?”. Domandare, per avere sempre in mente quella data. E anche festeggiare quando arriverà la data. Grazie.
* Fonte: Vatican.va, 08.09.2021
-
>LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- "Il Vangelo è uno solo": "Questo è importante: saper discernere. Tante volte abbiamo visto nella storia, e anche lo vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo con una modalità propria" (di Papa Francesco).4 agosto 2021, di Federico La Sala
PAPA FRANCESCO
 UDIENZA GENERALE
UDIENZA GENERALE
 Aula Paolo VI
Aula Paolo VI
 Mercoledì, 4 agosto 2021
Mercoledì, 4 agosto 2021
Catechesi sulla Lettera ai Galati - 3. Il Vangelo è uno solo
Fratelli e sorelle, buongiorno!
Quando si tratta del Vangelo e della missione di evangelizzare, Paolo si entusiasma, esce fuori di sé. Sembra non vedere altro che questa missione che il Signore gli ha affidato. Tutto in lui è dedicato a questo annuncio, e non possiede altro interesse se non il Vangelo. È l’amore di Paolo, l’interesse di Paolo, il mestiere di Paolo: annunciare. Arriva perfino a dire: «Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo» (1 Cor 1,17). Paolo interpreta tutta la sua esistenza come una chiamata a evangelizzare, a far conoscere il messaggio di Cristo, a far conoscere il Vangelo: «Guai a me - dice - se non annuncio il Vangelo» (1 Cor 9,16). E scrivendo ai cristiani di Roma, si presenta semplicemente così: «Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio» (Rm 1,1). Questa è la sua vocazione. Insomma, la sua consapevolezza è di essere stato “messo a parte” per portare il Vangelo a tutti, e non può fare altro che dedicarsi con tutte le sue forze a questa missione.
Si comprende quindi la tristezza, la delusione e perfino l’amara ironia dell’Apostolo nei confronti dei Galati, che ai suoi occhi stanno prendendo una strada sbagliata, che li porterà a un punto di non ritorno: hanno sbagliato strada. Il perno intorno a cui tutto ruota è il Vangelo. Paolo non pensa ai “quattro vangeli”, come è spontaneo per noi. Infatti, mentre sta inviando questa Lettera, nessuno dei quattro vangeli è ancora stato scritto. Per lui il Vangelo è ciò che lui predica, questo che si chiama il kerygma, cioè l’annuncio.
 E quale annuncio? Della morte e risurrezione di Gesù come fonte di salvezza. Un Vangelo che si esprime con quattro verbi: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto, è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a Cefa» (1 Cor 15,3-5). Questo è l’annuncio di Paolo, l’annuncio che ci dà vita a tutti. Questo Vangelo è il compimento delle promesse ed è la salvezza offerta a tutti gli uomini. Chi lo accoglie viene riconciliato con Dio, è accolto come un vero figlio e ottiene in eredità la vita eterna.
E quale annuncio? Della morte e risurrezione di Gesù come fonte di salvezza. Un Vangelo che si esprime con quattro verbi: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto, è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a Cefa» (1 Cor 15,3-5). Questo è l’annuncio di Paolo, l’annuncio che ci dà vita a tutti. Questo Vangelo è il compimento delle promesse ed è la salvezza offerta a tutti gli uomini. Chi lo accoglie viene riconciliato con Dio, è accolto come un vero figlio e ottiene in eredità la vita eterna.Davanti a un dono così grande che è stato fatto ai Galati, l’Apostolo non riesce a spiegarsi come mai essi stiano pensando di accogliere un altro “vangelo”, forse più sofisticato, più intellettuale... un altro “vangelo”. È da notare comunque che questi cristiani non hanno ancora abbandonato il Vangelo annunciato da Paolo. L’Apostolo sa che sono ancora in tempo a non compiere un passo falso, ma li ammonisce con forza, con tanta forza. La sua prima argomentazione punta direttamente sul fatto che la predicazione compiuta dai nuovi missionari - questi che predicano la novità - non può essere il Vangelo. Anzi, è un annuncio che stravolge il vero Vangelo perché impedisce di raggiungere la libertà - una parola chiave - acquisita venendo alla fede. I Galati sono ancora “principianti” e il loro disorientamento è comprensibile. Non conoscono ancora la complessità della Legge mosaica e l’entusiasmo nell’abbracciare la fede in Cristo li spinge a dare ascolto a questi nuovi predicatori, illudendosi che il loro messaggio sia complementare a quello di Paolo. E non è così.
L’Apostolo, però, non può rischiare che si creino compromessi su un terreno così decisivo. Il Vangelo è uno solo ed è quello che lui ha annunciato; un altro non può esistere. Attenzione! Paolo non dice che il vero Vangelo è il suo perché è stato lui ad annunciarlo, no! Questo non lo dice. Questo sarebbe presuntuoso, sarebbe vanagloria. Afferma, piuttosto, che il “suo” Vangelo, lo stesso che gli altri Apostoli andavano annunciando altrove, è l’unico autentico, perché è quello di Gesù Cristo.
 Scrive così: «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,11). Si comprende allora perché Paolo utilizzi termini molto duri.
Scrive così: «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,11). Si comprende allora perché Paolo utilizzi termini molto duri.
 Per due volte usa l’espressione “anatema”, che indica l’esigenza di tenere lontano dalla comunità ciò che minaccia le sue fondamenta. E questo nuovo “vangelo” minaccia le fondamenta della comunità. Insomma, su questo punto l’Apostolo non lascia spazio alla trattativa: non si può negoziare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è, come è stato annunciato, o ricevi un’altra cosa. Ma non si può negoziare, con il Vangelo. Non si può scendere a compromessi: la fede in Gesù non è merce da contrattare: è salvezza, è incontro, è redenzione. Non si vende a buon mercato.
Per due volte usa l’espressione “anatema”, che indica l’esigenza di tenere lontano dalla comunità ciò che minaccia le sue fondamenta. E questo nuovo “vangelo” minaccia le fondamenta della comunità. Insomma, su questo punto l’Apostolo non lascia spazio alla trattativa: non si può negoziare. Con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è, come è stato annunciato, o ricevi un’altra cosa. Ma non si può negoziare, con il Vangelo. Non si può scendere a compromessi: la fede in Gesù non è merce da contrattare: è salvezza, è incontro, è redenzione. Non si vende a buon mercato.Questa situazione descritta all’inizio della Lettera appare paradossale, perché tutti i soggetti in questione sembrano animati da buoni sentimenti. I Galati che danno ascolto ai nuovi missionari pensano che con la circoncisione potranno essere ancora più dediti alla volontà di Dio e quindi essere ancora più graditi a Paolo. I nemici di Paolo sembrano essere animati dalla fedeltà alla tradizione ricevuta dai padri e ritengono che la fede genuina consista nell’osservanza della Legge. Davanti a questa somma fedeltà giustificano perfino le insinuazioni e i sospetti su Paolo, ritenuto poco ortodosso nei confronti della tradizione. Lo stesso Apostolo è ben cosciente che la sua missione è di natura divina - è stata rivelata da Cristo stesso, a lui! - e quindi è mosso da totale entusiasmo per la novità del Vangelo, che è una novità radicale, non è una novità passeggera: non ci sono vangeli “alla moda”, il Vangelo è sempre nuovo, è la novità. La sua ansia pastorale lo porta a essere severo, perché vede il grande rischio incombente sui giovani cristiani.
 Insomma, in questo labirinto di buone intenzioni è necessario districarsi, per cogliere la verità suprema che si presenta come la più coerente con la Persona e la predicazione di Gesù e la sua rivelazione dell’amore del Padre. Questo è importante: saper discernere. Tante volte abbiamo visto nella storia, e anche lo vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo con una modalità propria, alle volte con carismi veri, propri; ma poi esagera e riduce tutto il Vangelo al “movimento”. E questo non è il Vangelo di Cristo: questo è il Vangelo del fondatore, della fondatrice e questo sì, potrà aiutare all’inizio, ma alla fine non fa frutti perché non ha radici profonde. Per questo, la parola chiara e decisa di Paolo fu salutare per i Galati ed è salutare anche per noi. Il Vangelo è il dono di Cristo a noi, è Lui stesso a rivelarlo. È questo che ci dà vita.
Insomma, in questo labirinto di buone intenzioni è necessario districarsi, per cogliere la verità suprema che si presenta come la più coerente con la Persona e la predicazione di Gesù e la sua rivelazione dell’amore del Padre. Questo è importante: saper discernere. Tante volte abbiamo visto nella storia, e anche lo vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo con una modalità propria, alle volte con carismi veri, propri; ma poi esagera e riduce tutto il Vangelo al “movimento”. E questo non è il Vangelo di Cristo: questo è il Vangelo del fondatore, della fondatrice e questo sì, potrà aiutare all’inizio, ma alla fine non fa frutti perché non ha radici profonde. Per questo, la parola chiara e decisa di Paolo fu salutare per i Galati ed è salutare anche per noi. Il Vangelo è il dono di Cristo a noi, è Lui stesso a rivelarlo. È questo che ci dà vita.- [...]
* Fonte: Vatican.va, 4 agosto 2021 (ripresa parziale).
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- DIO E’ UN UOMO (ANDRO-LOGICA-MENTE) O L’AMORE ("CHARITAS") DI DANTE ALIGHIERI?!28 giugno 2021, di Federico La Sala
Tweet
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza (Mc 12,29-30)
#Questione Antropologica.
La cit. di Mc 12, 29-30 ha un senso andrologico (e cosmo-te-andrico) o antropologico,
come il #Padre di ogni essere umano (#PonzioPilato: #Ecce homo),
quell’#Amore (di #Dante Alighieri),
che muove il #sole e le altre #stelle -
e anche la #Terra?!
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- Nel cinquantesimo anno di vita della "Caritas" Italiana, il testo del discorso di papa Francesco.26 giugno 2021, di Federico La Sala
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELLA CARITAS ITALIANA NEL 50° DI FONDAZIONE *
- Aula Paolo VI
- Sabato, 26 giugno 2021
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti, tutti!
Ringrazio il Cardinale Bassetti e il Presidente della Caritas Italiana, Monsignor Redaelli, per le parole che mi hanno rivolto a nome di tutti. Grazie. Siete venuti dall’Italia intera, in rappresentanza delle 218 Caritas diocesane e di Caritas Italiana, e io sono contento di condividere con voi questo Giubileo, il vostro cinquantesimo anno di vita! Siete parte viva della Chiesa, siete «la nostra Caritas», come amava dire San Paolo VI, il Papa che l’ha voluta e impostata. Egli incoraggiò la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di un organismo pastorale per promuovere la testimonianza della carità nello spirito del Concilio Vaticano II, perché la comunità cristiana fosse soggetto di carità. Confermo il vostro compito: nell’attuale cambiamento d’epoca le sfide e le difficoltà sono tante, sono sempre di più i volti dei poveri e le situazioni complesse sul territorio. Ma - diceva San Paolo VI - «le nostre Caritas si prodigano oltre le forze» (Angelus, 18 gennaio 1976). E questo è vero!
La ricorrenza dei 50 anni è una tappa di cui ringraziare il Signore per il cammino fatto e per rinnovare, con il suo aiuto, lo slancio e gli impegni. A questo proposito vorrei indicarvi tre vie, tre strade su cui proseguire il percorso.
La prima è la via degli ultimi. È da loro che si parte, dai più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, non si capisce nulla. E mi permetto una confidenza. L’altro giorno ho sentito, su questo, parole vissute dall’esperienza, dalla bocca di don Franco, qui presente. Lui non vuole che si dica “eminenza”, “cardinale Montenegro”: don Franco. E lui mi ha spiegato questo, la via degli ultimi, perché lui ha vissuto tutta la vita questo. In lui, ringrazio tanti uomini e donne che fanno la carità perché l’hanno vissuta così, hanno capito la via degli ultimi. La carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono e renderle protagoniste della propria vita. Molte scelte significative, in questi cinque decenni, hanno aiutato le Caritas e le Chiese locali a praticare questa misericordia: dall’obiezione di coscienza al sostegno al volontariato; dall’impegno nella cooperazione con il Sud del pianeta agli interventi in occasione di emergenze in Italia e nel mondo; dall’approccio globale al complesso fenomeno delle migrazioni, con proposte innovative come i corridoi umanitari, all’attivazione di strumenti capaci di avvicinare la realtà, come i Centri di ascolto, gli Osservatori delle povertà e delle risorse. È bello allargare i sentieri della carità, sempre tenendo fisso lo sguardo sugli ultimi di ogni tempo. Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi del povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, di guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla. È con i loro occhi che occorre guardare la realtà, perché guardando gli occhi dei poveri guardiamo la realtà in un modo differente da quello che viene nella nostra mentalità. La storia non si guarda dalla prospettiva dei vincenti, che la fanno apparire bella e perfetta, ma dalla prospettiva dei poveri, perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. E quando il nostro cuore, la nostra coscienza, guardando il povero, i poveri, non si inquieta, fermatevi..., dovremmo fermarci: qualcosa non funziona.
Una seconda via irrinunciabile: la via del Vangelo. Mi riferisco allo stile da avere, che è uno solo, quello appunto del Vangelo. È lo stile dell’amore umile, concreto ma non appariscente, che si propone ma non si impone. È lo stile dell’amore gratuito, che non cerca ricompense. È lo stile della disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù che si è fatto nostro servo. È lo stile descritto da San Paolo, quando dice che la carità «tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,7). Mi colpisce la parola tutto. Tutto. È detta a noi, a cui piace fare delle distinzioni. Tutto. La carità è inclusiva, non si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno solo di quello spirituale. La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero. Abbiamo bisogno di una carità dedicata allo sviluppo integrale della persona: una carità spirituale, materiale, intellettuale. È lo stile integrale che avete sperimentato in grandi calamità, anche attraverso i gemellaggi, bella esperienza di alleanza a tutto campo nella carità tra le Chiese in Italia, in Europa e nel mondo. Ma questo - lo sapete bene - non deve sorgere solo in occasione delle calamità: abbiamo bisogno che le Caritas e le comunità cristiane siano sempre in ricerca per servire tutto l’uomo, perché “l’uomo è la via della Chiesa”, secondo l’espressione sintetica di San Giovanni Paolo II (cfr Lett. enc. Redemptor hominis, 14).
La via del Vangelo ci indica che Gesù è presente in ogni povero. Ci fa bene ricordarlo per liberarci dalla tentazione, sempre ricorrente, dell’autoreferenzialità ecclesiastica ed essere una Chiesa della tenerezza e della vicinanza, dove i poveri sono beati, dove la missione è al centro, dove la gioia nasce dal servizio. Ricordiamo che lo stile di Dio è lo stile della prossimità, della compassione e della tenerezza. Questo è lo stile di Dio. Ci sono due mappe evangeliche che aiutano a non smarrirci nel cammino: le Beatitudini (Mt 5,3-12) e Matteo 25 (vv. 31-46). Nelle Beatitudini la condizione dei poveri si riveste di speranza e la loro consolazione diventa realtà, mentre le parole del Giudizio finale - il protocollo sul quale saremo giudicati - ci fanno trovare Gesù presente nei poveri di ogni tempo. E dalle forti espressioni di giudizio del Signore ricaviamo anche l’invito alla parresia della denuncia. Essa non è mai polemica contro qualcuno, ma profezia per tutti: è proclamare la dignità umana quando è calpestata, è far udire il grido soffocato dei poveri, è dare voce a chi non ne ha.
E la terza via è la via della creatività. La ricca esperienza di questi cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere; è la base su cui costruire per declinare in modo costante quella che San Giovanni Paolo II ha chiamato fantasia della carità (cfr Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). Non lasciatevi scoraggiare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e crescono! Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza. Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi condividendo la gioia di essere una grande famiglia. In questa atmosfera fraterna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo.
E ora - dopo questa predica di Quaresima! - vorrei dirvi grazie, grazie: grazie a voi, agli operatori, ai sacerdoti e ai volontari! Grazie anche perché in occasione della pandemia la rete Caritas ha intensificato la sua presenza e ha alleviato la solitudine, la sofferenza e i bisogni di molti. Sono decine di migliaia di volontari, tra cui tanti giovani, inclusi quelli impegnati nel servizio civile, che hanno offerto in questo tempo ascolto e risposte concrete a chi è nel disagio. Proprio ai giovani vorrei che si prestasse attenzione. Sono le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche i potenziali artefici di un cambiamento d’epoca. Sono loro i protagonisti dell’avvenire. Non sono l’avvenire, sono il presente, ma protagonisti dell’avvenire. Non è mai sprecato il tempo che si dedica ad essi, per tessere insieme, con amicizia, entusiasmo, pazienza, relazioni che superino le culture dell’indifferenza e dell’apparenza. Non bastano i “like” per vivere: c’è bisogno di fraternità, c’è bisogno di gioia vera. La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono di ritrovare sé stessi dedicando il proprio tempo agli altri. Così facendo la Caritas stessa rimarrà giovane e creativa, manterrà uno sguardo semplice e diretto, che si rivolge senza paura verso l’Alto e verso l’altro, come fanno i bambini. Non dimenticare il modello dei bambini: verso l’Alto e verso l’altro.
Cari amici, ricordatevi, per favore, di queste tre vie e percorretele con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, sviluppare la creatività. Vi saluto con una frase dell’Apostolo Paolo, che festeggeremo tra pochi giorni: «L’amore del Cristo ci possiede» (2 Cor 5,14). L’amore del Cristo ci possiede. Vi auguro di lasciarvi possedere da questa carità: sentitevi ogni giorno scelti per amore, sperimentate la carezza misericordiosa del Signore che si posa su di voi e portatela agli altri. Io vi accompagno con la preghiera e vi benedico; e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!
* Fonte: Vatican.va, 26.06.2021
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- «Non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale» (parole di papa Francesco alla Curia romana del 21 dicembre 2019).17 giugno 2021, di Federico La Sala
L’Italia in cammino sinodale. Processo che parte dal basso
Su La Civiltà Cattolica il direttore si sofferma sull’avvio del percorso nazionale. «Chiaro il contesto: un incontro organizzato dai vescovi italiani». Il ruolo del laicato e l’unità della coscienza
di Antonio Spadaro *
- [Foto] I vescovi italiani riuniti per l’assemblea generale - Siciliani
Dal 24 al 27 maggio scorsi si è svolta la 74ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Essa è stata aperta dalla preghiera, presieduta da papa Francesco, e dal suo dialogo con i vescovi presenti. I lavori dell’Assemblea, sotto la guida del cardinale presidente Gualtiero Bassetti, hanno riguardato il tema: “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita. Per avviare un cammino sinodale”. Tra l’altro, nella sua Introduzione, il cardinale Bassetti ha definito questo cammino come «quel processo necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre meglio, uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile».
Il Pontefice ha esortato i pastori a riprendere le linee tracciate dal Convegno ecclesiale di Firenze, e a valorizzare un percorso che parta dal basso e metta al centro il popolo di Dio. Egli ha sempre lamentato una certa «amnesia» riguardo alle indicazioni che diede nel capoluogo toscano il 10 novembre 2015. Chiaro che la concomitanza tra l’indizione del Sinodo della Chiesa universale - del quale parleremo successivamente - e l’avvio del percorso sinodale della Chiesa italiana sarà un’occasione unica per sintonizzare i cammini.
L’Assemblea generale ha quindi votato la seguente mozione: «I vescovi italiani danno avvio, con questa Assemblea, al cammino sinodale secondo quanto indicato da papa Francesco e proposto in una prima bozza della Carta d’intenti presentata al Santo Padre». Il Consiglio permanente della Cei costituirà un gruppo di lavoro per armonizzarne temi, tempi di sviluppo e forme.
Le misurate parole della mozione riassumono e rilanciano un dibattito durato sei anni. Ad aprirlo fu il Papa a Firenze, suggerendo il metodo sinodale: «La nazione non è un museo, ma è un’opera collettiva in permanente costruzione in cui sono da mettere in comune proprio le cose che differenziano, incluse le appartenenze politiche o religiose», disse Francesco. «Mi piace una Chiesa italiana inquieta - aggiunse - sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti».
Tutto rimase sottotraccia. All’inizio del 2019, “La Civiltà Cattolica” rilanciò la proposta di un Sinodo nazionale (cfr. A. Spadaro, “I cristiani che fanno l’Italia”, in Civ. Catt. 2019 I 250-252): ci parve la via più sicura da indicare a tutti, quella in grado di aiutarci a leggere a fondo la storia di oggi. Un luogo privilegiato di discernimento è infatti il processo sinodale, dove, se lo Spirito Santo è in azione, - come ha affermato Francesco - «dà un calcio al tavolo, lo butta e incomincia daccapo». E allora ecco la domanda: non sentiamo oggi il bisogno di un calcio dello Spirito? Se non altro per svegliarci dal torpore...
Alla nostra proposta fecero seguito interventi autorevoli di vescovi su “L’Osservatore Romano”, “Avvenire”, “Corriere della Sera”, e di teologi e studiosi su “Famiglia Cristiana”, “il Regno” e altra stampa cattolica e laica che, in generale, alimentarono il dibattito. Su “La Civiltà Cattolica” intervennero successivamente anche padre Bartolomeo Sorge e il sociologo Giuseppe De Rita.
«La sinodalità è una proposta che sentiamo di poter e dover fare a una società slabbrata come la nostra», puntualizzò il cardinale Bassetti il 1° aprile 2019. Il Pontefice ha poi effettivamente indicato il cammino sinodale alla Chiesa italiana, parlando ai vescovi del nostro Paese il successivo 20 maggio 2019, aprendo la 73ª Assemblea generale della Cei.
Il 21 gennaio scorso, la rotta è stata aggiornata. Andando «oltre le emergenze», ha detto il cardinale Bassetti, l’Italia deve ricomporre le quattro «fratture» (sanitaria, sociale, educativa, delle nuove povertà) che l’hanno piegata, con una capillare «opera di riconciliazione».
Il 30 gennaio Francesco, in un discorso in cui non a caso ha anche difeso con fermezza il Concilio Vaticano II («Chi non lo segue è fuori dalla Chiesa»), ha rilanciato la proposta in maniera decisa, affermando: «La Chiesa italiana deve tornare al Convegno di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà una catechesi». Il contesto è chiaro: un incontro organizzato dai vescovi italiani. Chiaro il messaggio: la Chiesa italiana deve incominciare un processo di Sinodo nazionale. Chiaro, infine, il metodo: camminare a partire dal basso verso l’alto; comunità per comunità, diocesi per diocesi. «Il momento è adesso», ha scandito Francesco.
* * *
È necessaria un’«opera di riconciliazione» con la realtà e la storia - anche recente - del nostro Paese, ripensando uno «stile di presenza» della Chiesa italiana nella storia e nella vita del Paese, consapevoli del fatto che «la Chiesa è il cuore di Dio che batte nella storia» (monsignor Aldo Del Monte).
Le parole di Francesco alla Curia romana del 21 dicembre 2019 devono guidare il discernimento: «Non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale». Quindi occorre anche fare un discernimento sulle dinamiche interne della stessa Chiesa italiana, in particolare quella del «clericalismo».
Il Sinodo è un mare aperto, e noi - ha detto Francesco in piena pandemia - «siamo tutti sulla stessa barca». Oggi i credenti sono chiamati a remare con tutti, e a farlo con la consapevolezza di essere anche cittadini. E questa è pure una vera «sfida» culturale, che è molto di più che un progetto. Sarà necessario, dunque, parlare dell’annuncio del Vangelo e delle sue difficoltà in un mondo mutato dalla pandemia, dagli stili di vita mobili, fluidi, veloci, plurali, dalle verità «alternative» dei social network e da tanti altri cambiamenti.
I processi ecclesiali di rinnovamento sono un fatto sinodale, il cui protagonista è il popolo di Dio. La Chiesa italiana ha bisogno di ritrovarsi in condizione sinodale. La richiesta di un «Sinodo dal basso» ha già messo in moto la riflessione, le discussioni, il coinvolgimento delle comunità e di alcune diocesi. Il metodo del Sinodo è né più né meno che lo stesso modo di esistere della Chiesa.
In questo senso pensiamo sia da riprendere il «voto finale» che padre Bartolomeo Sorge espresse al Convegno ecclesiale del 1976 e registrato negli Atti. Egli, dopo aver affermato che «la risposta pastorale della Chiesa italiana non può essere più affidata alla stesura di un documento», postulava la necessità di «dar vita a strutture permanenti di consultazione e di collaborazione tra Vescovi, rappresentanti delle varie componenti della comunità ecclesiale ed esperti provenienti da tutti i movimenti di ispirazione cristiana operanti in Italia».
Padre Sorge intendeva indicare quel modo di procedere che oggi Francesco definisce come «popolo e pastori insieme» (cfr. Documento di Aparecida n. 371). Infatti - proseguiva padre Sorge - «è urgente offrire alla nostra comunità ecclesiale un luogo di incontro, di dialogo, di analisi e di iniziativa che [...] superi in radice l’impossibile divisione tra "Chiesa istituzionale" e "Chiesa reale"», e che è anche il rischio dell’oggi. Allora la proposta rimase senza esito. Oggi le condizioni per riprendere quel voto ci sono. E sappiamo che i frutti del cammino sinodale verranno per la grazia dello Spirito Santo. Il Sinodo, finalmente!
*
Antonio Spadaro è direttore de "La Civiltà Cattolica"
* Avvenire, giovedì 17 giugno 2021 (ripresa parziale).
-
>LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- "Con gli occhi dell’altro". Quando tradurre diventa creatività semantica (di A. Fraccacreta).).14 aprile 2021, di Federico La Sala
TRADUZIONE E DISTRUTTIVITA’ SEMANTICA. UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga ... *
- NEOVULGATA."Sulla scia di Cicerone, Girolamo traduce agape in caritas e attua così un’importante svolta nella conformazione del pensiero occidentale: nasce «qualcosa di nuovo che è stato creato dal movimento del linguaggio»" (A. Fraccacreta, Quando tradurre diventa creatività semantica, Avvenire, 14.04.2021).
- VULGATA."Charissimi, nolite omni spiritui credere [...] quoniam Deus charitas est" ["Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione [...] perché Dio è amore" (1 Gv. 4, 1-8).
- CHARIDAD (1729).
Letteratura.
Quando tradurre diventa creatività semantica
In un saggio Arduini interviene su una polemica antica relativa alla trasposizione dei libri in altra lingua. Dalle Scritture al caso Amanda Gorman
di Alberto Fraccacreta (Avvenire, martedì 13 aprile 2021)
La traduzione è un problema? Lo sono i traduttori. È quello che sta succedendo in Europa particolarmente, in Paesi Bassi e Spagna - per la versione del nuovo libro (in uscita a fine marzo) di Amanda Gorman, la ventitrenne poetessa afroamericana resa celebre dalla lettura di The Hill We Climb durante la cerimonia di insediamento del presidente Biden. La polemica si può sintetizzare in questi termini: i bianchi non possono comprendere a fondo (e quindi tradurre) testi afroamericani specificamente dedicati a questioni razziali. Al di là di accese diatribe, certo è che il processo di traduzione non coincide soltanto con un trasferimento di figure e immagini in una lingua differente, ma ha la capacità di entrare nel cuore delle idee e modificarle.
È l’ipotesi affascinante che emerge dal saggio di Stefano Arduini, Con gli occhi dell’altro. Tradurre ( Jaca Book, pagine 216, euro 18), ruotante attorno a dieci nuclei tematici (tra cui ’verità’, ’bellezza’, ’intraducibile’) intessuti di citazioni e rimandi dall’Antico e Nuovo Testamento, con uno sguardo ai Padri della Chiesa e alle versioni dei primi secoli del cristianesimo. «Se la traduzione riscrive le nostre configurazioni di conoscenze - commenta Arduini, ordinario di Linguistica all’università Lcu di Roma -, non può essere intesa come qualcosa che ripete il già detto in modo diverso, ma come un’operazione cognitiva che crea nuovi concetti ». Il tradurre diviene così un’«esperienza intellettuale » a livello estremamente creativo. Esempio lampante è il concetto di altro, transitato attraverso un estenuante tourbillon di variazioni semantiche: i termini greci hèteros e allos, i latini alter e alius, ma anche le nozioni di ospitalità nell’indoeuropeo segnalate da Benveniste e poi riformulate alla luce della filosofia di Ricoeur (la reciprocità e la sollecitudine), Lévinas (l’invocazione), Florenskij (la sophia e la costruzione del soggetto fuori da sé) e Meschonnic (la signifiance).
Tradurre vuol dire mettere in gioco costantemente l’identità e l’alterità, instaurare un’amicizia che pervade l’io nel rapporto col tu. Evitando di annettere a sé una cultura diversa, Arduini scrive: «Dobbiamo stare in silenziosa attesa di fronte all’alterità e in qualche modo rispettarla, accettare quello spazio vuoto». Solo così il traduttore, «figura emblematica della nostra contemporaneità multiculturale», può assolvere al compito di cogliere le diversità e accoglierle. Qui ci soccorre di nuovo Ricoeur col mirag- gio dell’«ospitalità linguistica »: «abitare la lingua dell’altro», guardare le cose con i suoi occhi, nel solco di quell’incontro a cui la traduzione ci educa.
 L’indagine si sposta sul Prologo del Vangelo di Giovanni e in particolare su logos, divenuto verbum nella Vulgata. La sostanziale polisemia del sostantivo greco rende ardua un’adeguata trasposizione, ma ciò che più importa è che, sul piano linguistico e teologico, le speculazioni sorte attorno all’incipit giovanneo hanno modificato di fatto il corso della ricezione storica, configurandosi come «nuovi concetti per nuovi mondi».
L’indagine si sposta sul Prologo del Vangelo di Giovanni e in particolare su logos, divenuto verbum nella Vulgata. La sostanziale polisemia del sostantivo greco rende ardua un’adeguata trasposizione, ma ciò che più importa è che, sul piano linguistico e teologico, le speculazioni sorte attorno all’incipit giovanneo hanno modificato di fatto il corso della ricezione storica, configurandosi come «nuovi concetti per nuovi mondi».Lo stesso accade in Esodo 3,14 con la notissima espressione «Io sono colui che sono» (dall’ebraico ehyeh asher ehyeh). Siamo di fronte a un passo nei limiti del traducibile perché la posizione aspettuale del predicato nella lingua d’origine tecnicamente si tratta di un imperfettivo - pone alcune insanabili ambiguità. Ecco le possibili traduzioni: «Io ero quello che ero, Io sarò quello che sarò, Io ero quello che sarò, Io sarò quello che ero». (E tuttavia non ne esce scalfita l’immutabilità di Dio.) Aquila, Filone, Origene e poi Agostino, Girolamo e Tommaso: l’innesto del pensiero greco e latino nel sostrato ebraico fa scintille e la catena di rivolgimenti aggiunge e perde qualcosa, generando però un’identità completamente inedita. Gli slittamenti semantici del termine parresia (dire tutto) sembrano invece riscrivere un’intera ’enciclopedia culturale’: dibattito e libertà di parola nel greco precristiano, apertura del cuore e trasparenza dell’anima in Dio sul versante veterotestamentario, rivelazione di Gesù e presenza dello Spirito in ambito neotestamentario. Ma nei primi secoli dopo Cristo - come suggerisce Michel Foucault - parresia diviene coraggio della verità, coraggio dei martiri nel testimoniare la fede.
Universi concettuali affini o distanti sorgono anche nelle traduzioni dei presocratici e nelle variazioni dell’amore dall’ebraico ’ahavahfino alla diade inconciliabile di eros e agape, quest’ultimo forse non voce indoeuropea ma più probabilmente prestito di area semitica. Sulla scia di Cicerone, Girolamo traduce agape in caritas e attua così un’importante svolta nella conformazione del pensiero occidentale: nasce «qualcosa di nuovo che è stato creato dal movimento del linguaggio». Cognitivista di lunga data, esponente di spicco della traduzione biblica e dei Translation Studies, Arduini ci conduce nelle arcane radici delle lingue antiche (si pensi ai termini che in ebraico indicano bellezza, Jafeh, bello esteriore, e Tôb, lo spazio del bene della Genesi) lasciandoci, con la ’moltiplicazione degli sguardi’ data dal mito di Babele, alle soglie dell’Intraducibile. Il traducibile all’infinito.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
Federico La Sala
-
> FARE CHIAREZZA? --- PARRESIA. Cosa dice Dante alla Chiesa, ancora oggi? Il cardinale Ravasi: «Dante, profeta di speranza» (di Gian Guido Vecchi).23 marzo 2021, di Federico La Sala
Giovedì la Lettera apostolica del Papa
Ravasi: «Dante, profeta di speranza»
Il cardinale illustra l’attualità anche religiosa dell’autore della Commedia. La Candor Lucis æternæ di Francesco, dedicata al Poeta, esce il 25 marzo, giorno di inizio del viaggio raccontato nel poema
di Gian Guido Vecchi *
- [Foto] Dante ritratto da Raffaello con Omero e Virgilio nella Stanza della Segnatura
«Dante è davvero un profeta di speranza, come lo considera Papa Francesco. Nel tempo della pandemia viviamo un periodo di dolore, paura, sconforto. Anche Dante ha vissuto un periodo così e ci ha mostrato come la grande poesia e la fede possano fiorire anche in un terreno devastato».
 Il cardinale Gianfranco Ravasi sorride, «la Divina Commedia è un viaggio, un grande cammino che comincia il 25 marzo», e proprio giovedì sarà pubblicata la Lettera Apostolica Candor Lucis æternæ di Papa Francesco, dedicata a Dante Alighieri: il riferimento è al «candore de la etterna luce» che Dante, nel terzo trattato del Convivio, cita dal Libro della Sapienza.
Il cardinale Gianfranco Ravasi sorride, «la Divina Commedia è un viaggio, un grande cammino che comincia il 25 marzo», e proprio giovedì sarà pubblicata la Lettera Apostolica Candor Lucis æternæ di Papa Francesco, dedicata a Dante Alighieri: il riferimento è al «candore de la etterna luce» che Dante, nel terzo trattato del Convivio, cita dal Libro della Sapienza.
 Nella tradizione della Chiesa, il 25 marzo è il giorno dell’Annunciazione e anche della morte di Gesù, la data prossima all’equinozio di primavera che la dantistica indica (ma c’è chi opta per il Venerdì Santo del 1300, cioè l’8 aprile) come giorno d’inizio della Commedia. Il testo del Papa, come le iniziative programmate dal pontificio Consiglio della Cultura guidato dal cardinale Ravasi, mostra tutta l’attenzione della Santa Sede per Dante, nel settecentesimo anniversario di morte.
Nella tradizione della Chiesa, il 25 marzo è il giorno dell’Annunciazione e anche della morte di Gesù, la data prossima all’equinozio di primavera che la dantistica indica (ma c’è chi opta per il Venerdì Santo del 1300, cioè l’8 aprile) come giorno d’inizio della Commedia. Il testo del Papa, come le iniziative programmate dal pontificio Consiglio della Cultura guidato dal cardinale Ravasi, mostra tutta l’attenzione della Santa Sede per Dante, nel settecentesimo anniversario di morte.Eminenza, che cosa ci racconta, oggi, questo viaggio?
«Ciò che regge il cammino di Dante, il nostro cammino, è la speranza. Il viaggio comincia dall’Inferno, nel realismo del sottosuolo, nel fango della storia, la terra come «l’aiuola che ci fa tanto feroci» vista dall’alto del Paradiso, al canto XXII. Ma non è che finisca con il dolore irrimediabile di cerchi, gironi e bolge. Nel Purgatorio c’è la rappresentazione simbolica del passaggio dal peccato alla catarsi alla liberazione, dell’intreccio tra grazia divina e libertà umana. Ad esempio, quando nel canto terzo mette in scena la figura di Manfredi, che era stato trafitto da due colpi di spada...».
«...mentre che la speranza ha fior del verde».
«Proprio così. Manfredi, figlio illegittimo di Federico II, era stato scomunicato. E mentre sta morendo si rivolge a “quei che volontier perdona”, a Dio. Sono versi fondamentali: “Orribil furon li peccati miei;/ ma la bontà infinita ha sì gran braccia/ che prende ciò che si rivolge a lei”. Questa è la parabola del figliol prodigo: fino all’ultimo il Padre ti tende le “gran braccia”. Dante, oltre che poeta sommo, è un grande cristiano. Ed è di casa in Vaticano...».
In che senso?
«Nella Stanza della Segnatura, Raffaello lo rappresenta due volte. Nella cosiddetta Disputa del Santissimo Sacramento, sintesi della dottrina trinitaria, appare tra Agostino e Tommaso d’Aquino, come un teologo che annuncia la verità divina. La seconda immagine, col suo profilo segaligno, lo raffigura sul Parnaso come poeta, con Omero e Virgilio: la via pulchritudinis, la bellezza che parla anche a chi non crede. Interessante l’ interpretazione duplice: Dio gli ha dato il dono della poesia e lo ha incaricato di dire la verità. Il bello e il vero uniti».
Francesco è il terzo Papa a scrivere un testo ufficiale così importante su Dante.
«Sì, il primo fu Benedetto XV: nel 1921 compose un’enciclica, In Praeclara Summorum. Ma il Papa che in assoluto ha cantato più Dante è Paolo VI, che nel 1965 gli dedicò la Lettera Apostolica Altissimi cantus, un testo bellissimo. Da un lato scriveva “Dante è nostro”, non come trofeo ma per affermarne l’universalità e dire che vi si scoprono i tesori del pensiero e del sentimento cristiano. Dall’altra ammetteva: “Né rincresce ricordare che la voce di Dante si alzò sferzante e severa contro più d’un Pontefice romano, ed ebbe aspre rampogne per istituzioni ecclesiastiche e per persone che della Chiesa furono ministri e rappresentanti”».
In effetti nella «Commedia» abbondano i Papi all’inferno: nella terza bolgia dei simoniaci, ficcato a testa in giù in un pozzo occupato da svariati predecessori, Niccolò III si illude che Bonifacio VIII sia arrivato in anticipo e annuncia Clemente V...
«Sì, ci mette pure Papi ancora vivi! Del resto, negli anni del Concilio ero a Roma e ricordo che Paolo VI volle regalare a tutti i padri riuniti nelle Assise un’edizione della Divina Commedia...».
Sulla corruzione della Curia e della Chiesa è durissimo: «A la puttana e a la nova belva», scrive nel canto XXXII del Purgatorio. Forse non è un caso che i Papi ne abbiano scritto solo dopo la fine del potere temporale: imbarazzava la Chiesa?
«Probabilmente sì. Certo lo si celebrava: a chiamare Raffaello fu Giulio II, che magari Dante avrebbe messo, pure lui, all’inferno! Però lo si teneva un po’ a distanza. Era difficile elaborare la critica generale sulla corruzione della Chiesa: per questo fu molto significativo il dono di Paolo VI ai padri conciliari».
Dante è bellissimo da leggere, ma non facile...
«Michelangelo diceva di lui: “Simil uom né maggior non nacque mai”. Dispiega un’infinità di temi teologici, filosofici, astronomici, storici... Ci sarebbe un’infinità di cose da dire. Si pensi alla centralità delle figure femminili, Maria, Beatrice, Lucia...O alla visione della Trinità, al termine del Paradiso, che al centro “mi parve pinta de la nostra effige”: la nostra immagine, l’immagine del Cristo, il senso dell’essere nel volto umano...Chi non ha almeno una conoscenza essenziale della teologia non riesce a percorrere appieno questo viaggio. Inviterei la cultura contemporanea a non considerare la teologia come una cosa marginale, vecchia, decotta...».
Accade questo?
«Purtroppo sì. E invece qui vediamo la potenza di un pensiero che si fa poesia. In Dante si mostra quanto il pensiero cristiano sia importante nella cultura laica. Ed è drammatico il fatto che si tenda a insegnarlo in maniera superficiale, nelle scuole. Magari puoi scrivere note esplicative ma devi far capire la passione che animava Dante: un credente fervido e indefettibile. Non ti fa decollare dalla realtà: c’è l’inferno, tutti i vizi e le tragedie della storia le ha rappresentate. E poi c’è la forza della trasfigurazione, il “trasumanar” della redenzione cristiana. Lui è vissuto di quello».
Cosa dice Dante alla Chiesa, ancora oggi?
«L’autenticità del messaggio, senza compromessi mondani. E il coraggio della sincerità, anche nell’autocritica. -È la parresía che ci indica Francesco, segno di libertà interiore e di conversione».
Un poeta lo si celebra leggendolo. Che cosa direbbe per invitare a farlo?
«Le parole che confessava Jorge Luis Borges, grande poeta argentino che Francesco ha conosciuto, a proposito della Divina Commedia: “Nessuno ha il diritto di privarsi di questa felicità”».
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- "ECCE HOMO" (PONZIO PILATO): UNA QUESTIONE ANDROLOGICA O ANTROPOLOGICA?!12 marzo 2021, di Federico La Sala
Tweet
Gianfranco Ravasi
Federico La Sala
 In risposta:
In risposta: -
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- Cei. Alla scuola della Buona Notizia. “Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano” (di Riccardo Maccioni).9 gennaio 2021, di Federico La Sala
Cei. Alla scuola della Buona Notizia. “Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano”
“Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano” pubblicato dalla Cei, strumento al servizio della Parola
 Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti
Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti- [Foto] Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti
di Riccardo Maccioni *
Nel segno dello studio, della conoscenza, del dialogo. Soprattutto nel segno della Parola, che diventa preghiera, vita spirituale, servizio, faro della comunità. La pubblicazione de “Il Nuovo Testamento greco latino italiano” non riguarda infatti solo gli specialisti ma, nella ricerca di una sempre maggiore fedeltà alle fonti, si propone anche come sostegno a un cammino di fede maturo.
Per tutti. Dal parroco che prepara l’omelia domenicale, al credente forse un po’ più preparato della media e desideroso di approfondire la Buona Notizia. Il volume (1854 pagine su carta Bibbia avoriata, 80 euro) è pubblicato dalla “Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena” della Conferenza episcopale italiana. A curarlo il cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze e Valdo Bertalot già segretario generale della Società Biblica in Italia.
Un’opera importante che riporta il testo del Nuovo Testamento greco con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti: The Greek New Testament-5th Revised edition/GNT (Deutsche Bibelgesellschaft DBG, 2014, con relativo apparato critico-testuale), Nova Vulgata-Bibliorum Sacrorum Editio, Editio typica altera/NV (Libreria Editrice Vaticana 1986 con relative note), La Sacra Bibbia-Versione ufficiale della Conferenza episcopale italiana/Cei 2008 con relative note.
- Nell’opera il testo neotestamentario greco è presentato con a fronte quelli latino e italiano nelle loro edizioni autorevoli più recenti. I curatori dell’opera sono stati il cardinale Betori e Bertalot già segretario generale della Società Biblica in Italia
Il nostro lavoro - spiega Bertalot - si caratterizza per alcune significative novità. Sotto il profilo editoriale «rappresenta, fatta eccezione per quella della DBG, l’unica pubblicazione che riporta il testo greco insieme all’intero apparato di critica testuale del GNT frutto di un comitato editoriale internazionale e interconfessionale». Inoltre «è la prima volta che una Conferenza episcopale nazionale presenta ufficialmente il GNT e la propria versione ufficiale della Bibbia arricchita dal testo con valore normativo della Nova Vulgata». C’è poi da sottolineare l’aspetto più prettamente ecumenico del lavoro, nel solco di un percorso iniziato con la stagione conciliare. Una dimensione - prosegue Bertalot - che «investe pienamente la collaborazione fra le diverse confessioni cristiane per lo studio della Bibbia, per la sua traduzione e trasmissione nell’opera missionaria di annuncio della Parola di Dio». Ma c’è un altro aspetto da sottolineare, quantomeno da non sottovalutare, e riguarda il dato per così dire “temporale” della pubblicazione. Il Nuovo Testamento trilingue esce infatti in parallelo alla Lettera apostolica “Scripturae Sacrae affectus” scritta da papa Francesco per il XVI centenario della morte di san Girolamo cui si deve la celebre, fulminante espressione: «Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est». L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo.
 Un “monito” ricordato dal cardinale Betori durante la presentazione, il 29 ottobre scorso, dell’opera al Papa, nella speranza «che possa essere uno strumento per far crescere la conoscenza di Cristo, perché, come da lei auspicato, ciascuno diventi capace di aprire il libro sacro e di trarne i frutti inestimabili di sapienza, di speranza e di vita».
Un “monito” ricordato dal cardinale Betori durante la presentazione, il 29 ottobre scorso, dell’opera al Papa, nella speranza «che possa essere uno strumento per far crescere la conoscenza di Cristo, perché, come da lei auspicato, ciascuno diventi capace di aprire il libro sacro e di trarne i frutti inestimabili di sapienza, di speranza e di vita».- Due estratti da “Il Nuovo Testamento” trilingue con il raffronto tra italiano, latino e greco. Riguardano la preghiera del Padre Nostro e l’Inno alla carità.
IL PADRE NOSTRO (Matteo 6,8-13)
 9 Voi dunque pregate cosi: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
9 Voi dunque pregate cosi: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
 10 venga il tuo regno, sia fatta la tua volonta, come in cielo cosi in terra.
10 venga il tuo regno, sia fatta la tua volonta, come in cielo cosi in terra.
 11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
 12 e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
12 e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
 13 e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
13 e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 9 Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
9 Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
 10 adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
10 adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
 11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie;
11 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie;
 12 et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
12 et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
 13 et ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a Malo.
13 et ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a Malo.- [...]
PIÙ GRANDE E’ LA CARITÀ
(1 Corinzi 13, 1-6)
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
 2 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
2 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
 3 E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
3 E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
 4 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,
4 La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio,
 5 non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
5 non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
 6 non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
6 non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità.
 7 Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
7 Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Si linguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens.
Si linguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens.
 2 Et si habuero prophetiam et noverim mysteria omnia et omnem scientiam, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non habuero, nihil sum.
2 Et si habuero prophetiam et noverim mysteria omnia et omnem scientiam, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non habuero, nihil sum.
 3 Et si distribuero in cibos omnes facultates meas et si tradidero corpus meum, ut glorier, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest.
3 Et si distribuero in cibos omnes facultates meas et si tradidero corpus meum, ut glorier, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest.
 4 Caritas patiens est, benigna est caritas, non aemulatur, non agit superbe, non inflatur,
4 Caritas patiens est, benigna est caritas, non aemulatur, non agit superbe, non inflatur,
 5 non est ambitiosa, non quaerit, quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum,
5 non est ambitiosa, non quaerit, quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum,
 6 non gaudet super iniquitatem, congaudet autem veritati;
6 non gaudet super iniquitatem, congaudet autem veritati;
 7 omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.
7 omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet.- [...]
DA SAPERE Lo scorso 29 ottobre la consegna al Papa
Il “Nuovo Testamento greco latino italiano”, è pubblicato dalla Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena della Conferenza episcopale italiana. Si tratta di un ampio volume (1854 pagine su carta avoriata) che presenta il testo greco con a fronte quello italiano e latino nelle recenti autorevoli edizioni: “The Greek New Testament-5th Revised edition” (Deutsche Bibelgesellschaft o DBG 2014), Nova Vulgata-Bibliorum Sacrorum Editio, Editio typica altera (Libreria editrice vaticana 1986), La Sacra Bibbia versione ufficiale della Cei (Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena 2008)). La pubblicazione si apre con una ricca presentazione di A. Kurschus, praeses della Chiesa evangelica della Westfalia e presidente della DBG, del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura e del cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze, quest’ultimo curatore dell’opera insieme a Valdo Bertalot, già segretario generale della Società Biblica in Italia che firma invece la prefazione.
A completare il libro anche introduzioni specifiche per ogni lingua del testo, sei diversi indici e quattro carte geografiche sul mondo biblico. Il Nuovo Testamento trilingue è stato consegnato il 29 ottobre scorso al Papa di cui richiama, nella presentazione, la Lettera apostolica “Scripturae Sacrae affectus” dedicata, nel XVI centenario della morte, a san Girolamo, definito dal Pontefice «infaticabile studioso, traduttore, esegeta, profondo conoscitore e appassionato divulgatore della Sacra Scrittura». Un amore alla Bibbia che Francesco sottolinea attraverso l’immagine spesso associata al santo di “Biblioteca di Cristo. Una biblioteca perenne - spiega Francesco - che continua a insegnarci che cosa significhi l’amore di Gesù, «indissociabile dall’incontro con la sua Parola». La distribuzione dell’opera è curata direttamente dalla Libreria Editrice Vaticana (Via della Posta, 00120 Città del Vaticano; email: commerciale.lev@spc.va; sito: https://www.libreriaeditricevaticana.va/it/).
* Avvenire, sabato 9 gennaio 2021 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- L’analisi. Quando il debito pubblico era una faccenda di dono (di Luigino Bruni).21 dicembre 2020, di Federico La Sala
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Come Gesù divenne il "Christus monetarius" ...*
- DUE SOLI. Pagare il tributo a Cesare «è un dovere»! Con la precisazione evangelica sulla necessità di pagare le tasse allo Stato (secondo la Costituzione della Repubblica italiana), Papa Francesco apre la strada a Dante-2021 e, insieme, a una comprensione più precisa e contestualizzata della "misteriosa" figura che "fece per viltade il gran rifiuto": Ponzio Pilato!
L’analisi
Quando il debito pubblico era una faccenda di dono
di Luigino Bruni *
Se vogliamo capire come si è sviluppata l’etica economica nella cristianità medioevale e poi nel capitalismo, dovremmo cercare di abitare la sua radicale ambivalenza. La prima teologia cristiana ha fatto ampio uso del lessico e delle metafore economico-commerciali per cercare di spiegare l’evento cristiano, l’incarnazione e la salvezza. A partire dalla stessa parola oikonomia, che divenne fondamentale nella prima mediazione teologico-filosofica del cristianesimo: l’economia della salvezza, la Trinità economica.
 Gesù definisce il denaro (mammona) un dio suo rivale, ma lo stesso Gesù è presentato come "divin mercante", il cui sangue era stato il "prezzo" della salvezza, una redenzione "pagata" dal sacrificio della croce. -Tutto il Medioevo, poi, è stato un proliferare di parole economico-teologiche: dalle anime "lucrate" al "guadagnarsi" il paradiso o il purgatorio; fino alla tradizione, molto cara ad Agostino (Sermone 9) dell’uomo come la "moneta di Dio", perché porta impressa la sua effigie/immagine.
Gesù definisce il denaro (mammona) un dio suo rivale, ma lo stesso Gesù è presentato come "divin mercante", il cui sangue era stato il "prezzo" della salvezza, una redenzione "pagata" dal sacrificio della croce. -Tutto il Medioevo, poi, è stato un proliferare di parole economico-teologiche: dalle anime "lucrate" al "guadagnarsi" il paradiso o il purgatorio; fino alla tradizione, molto cara ad Agostino (Sermone 9) dell’uomo come la "moneta di Dio", perché porta impressa la sua effigie/immagine.
 Una delle frasi riportate dalla tradizione ma non dai Vangeli né canonici né apocrifi, i cosiddetti agrapha di Gesù, citata da Clemente d’Alessandria contiene un concetto importante: «Giustamente la Scrittura ci esorta a essere un competente cambiavalute, disapprovando alcune cose, ma tenendo fermo ciò che è buono» (Stromateis 1, 28,177, fine II secolo). Da qui la tradizione del Christus monetarius, il "buon cambiavalute", perché capace di discernere tra "monete" buone e cattive.
Una delle frasi riportate dalla tradizione ma non dai Vangeli né canonici né apocrifi, i cosiddetti agrapha di Gesù, citata da Clemente d’Alessandria contiene un concetto importante: «Giustamente la Scrittura ci esorta a essere un competente cambiavalute, disapprovando alcune cose, ma tenendo fermo ciò che è buono» (Stromateis 1, 28,177, fine II secolo). Da qui la tradizione del Christus monetarius, il "buon cambiavalute", perché capace di discernere tra "monete" buone e cattive.Con tutta questa ricca complessità in tema di monete e di economia non ci stupisce trovare nel Medioevo un’ambivalenza e una incertezza morale nei confronti dell’uso proprio delle monete e dell’economia. Una premessa. Per capire la nascita dell’etica economica europea non dobbiamo mai dimenticare che mentre i teologi disquisivano sulle monete e sui prestiti, i mercanti esistevano e dovevano lavorare. I mercanti erano e sono uomini pragmatici, talmente pragmatici da sfiorare il cinismo: la moneta serve, servono i cambiavalute (erano molte le monete in circolazione), servono i banchieri. Tutti sapevano che questi operatori non lavoravano gratis, ricorrere ai loro servizi costava, e quel prezzo da pagare si chiamava "interesse", che era accettato se non era eccessivo. I mercanti veri non avrebbero mai chiamato "usuraio" un mutuo (o una lettera di cambio, o un contratto di commenda) al tasso annuo del 5%, ma neanche del 10%. Erano ben coscienti che esistevano banchieri buoni e cattivi, come esistevano monete buone e altre cattive, e che monete e banchieri cattivi scacciavano i buoni. Operavano e vivevano tra queste cose buone e cattive, abitavano nell’economia l’ambivalenza della vita.
Allora la presenza di professionisti conoscitori delle monete era molto importante per la stabilità dei commerci e quindi per il bene comune. Questo lo sapevano tutti, come tutti sapevano che quando nelle città mancavano cambiavalute/banchieri ufficiali e quindi controllati periodicamente dal Comune nei loro pesi, bilance, libri e misure, la città si riempiva di banchetti clandestini di cattivi prestatori e "bagarini", che spesso finivano in bancarotta l’espressione deriva dal banco su cui il cambiavalute metteva le sue monete, la mensa argentaria: quando non riusciva più a pagare i suoi debiti, i suoi creditori gli spezzavano il banco.
 Tra il XIV e il XV secolo Venezia contava più di cento banchi, cristiani ed ebrei, Firenze settanta, Napoli quaranta, Palermo quattordici (Vito Cusumano, "Storia dei banchi della Sicilia"). Il banchiere era anche un cambiavalute, e non di rado il suo ufficio era lo stesso di quello del notaio. I banchieri erano per molti versi equiparati a funzionari pubblici, ne condividevano alcune dimensioni dello status, dei privilegi, degli oneri. A nessuna persona perbene veniva in mente di chiamare questi banchieri pubblici "usurai", anche se prestavano a interesse. Tutti sapevano che i banchieri lucravano sul denaro, vescovi e papi per primi, che da una parte erano i primi clienti delle banche e dall’altra facevano omelie e scrivevano testi di condanna del prestito a interesse sulla base della Bibbia e dei Vangeli.
Tra il XIV e il XV secolo Venezia contava più di cento banchi, cristiani ed ebrei, Firenze settanta, Napoli quaranta, Palermo quattordici (Vito Cusumano, "Storia dei banchi della Sicilia"). Il banchiere era anche un cambiavalute, e non di rado il suo ufficio era lo stesso di quello del notaio. I banchieri erano per molti versi equiparati a funzionari pubblici, ne condividevano alcune dimensioni dello status, dei privilegi, degli oneri. A nessuna persona perbene veniva in mente di chiamare questi banchieri pubblici "usurai", anche se prestavano a interesse. Tutti sapevano che i banchieri lucravano sul denaro, vescovi e papi per primi, che da una parte erano i primi clienti delle banche e dall’altra facevano omelie e scrivevano testi di condanna del prestito a interesse sulla base della Bibbia e dei Vangeli.La Chiesa sapeva molto bene tutto questo, era esperta di ambivalenze, anche di quelle economiche. Conosceva bene i grandi banchieri, perché erano quasi sempre legati alle grandi famiglie borghesi e aristocratiche, sedevano nei consigli di governo delle città. Ma non dobbiamo pensare che la Chiesa, nelle sue varie componenti, fosse unanime in materie di monete, commerci, interessi e usura. La Chiesa era realtà plurale e antagonista, in teologia e in materia di prassi civile, più di quanto non lo sia in epoca moderna. Non deve quindi stupirci il grande numero di libri e omelie dedicati, soprattutto tra il XII e il XVII secolo, a temi finanziari e commerciali.
 L’economia, dopo la teologia, fu la materia più trattata dai teologi tra Medioevo e Modernità. In questi dibattiti un grande peso lo aveva ancora il mondo monacale, antico, ricco e potente.
L’economia, dopo la teologia, fu la materia più trattata dai teologi tra Medioevo e Modernità. In questi dibattiti un grande peso lo aveva ancora il mondo monacale, antico, ricco e potente.L’ora et labora dei monasteri e delle abbazie aveva creato una sua etica economica, molto attenta ai valori del lavoro e delle cose terrene. In particolare i monaci erano i grandi nemici del vizio capitale dell’accidia, cioè dell’inattività e della pigrizia; di conseguenza la prima lode per la sollecitudine del mercante, visto come l’anti-accidioso per eccellenza, nacque nei monasteri, dove si sviluppò anche l’esegesi della "parabola dei talenti" come lode dell’intrapresa dei primi due servitori e condanna della pigrizia del terzo. Il mercante piace perché mette in circolo la ricchezza, mentre l’avaro la blocca nei suoi forzieri.
Ma la riflessione specifica sulla moneta si sviluppò soprattutto tra i nuovi ordini mendicanti, attenti osservatori, per i loro carismi, della civiltà cittadina. In questo contesto, un ruolo importante nella riflessione teologica sul prestito a interesse lo svolse la nascita dei debiti pubblici delle città commerciali, in particolare Venezia e Firenze.
 Interessante a questo riguardo fu un dibattito che coinvolse a Venezia nella metà del Trecento alcuni grandi teologi, centrato sulla liceità di pagare l’interesse sul debito pubblico e di vendere quei titoli di credito (al prezzo di circa il 60-70% del loro valore nominale).
Interessante a questo riguardo fu un dibattito che coinvolse a Venezia nella metà del Trecento alcuni grandi teologi, centrato sulla liceità di pagare l’interesse sul debito pubblico e di vendere quei titoli di credito (al prezzo di circa il 60-70% del loro valore nominale).
 Dalla fine del XII secolo le città commerciali italiane si trovarono di fronte a un forte aumento della spesa pubblica, anche a causa delle spese militari. Quelle città erano di fatto dei consorzi di famiglie, una specie di società cooperativa, dove i cittadini erano anche soci e proprietari di un bene comune: la città. Nelle prime fasi le spese pubbliche erano coperte con varie forme di contributi e tasse da parte dei cittadini. Di fronte però all’esplosione della spesa pubblica, i cittadini pensarono che invece di continuare ad aumentare le loro tasse poteva essere più conveniente emettere titoli di debito pubblico. Questi titoli dovevano pagare interessi periodici (il versamento degli interessi si chiamava paga) ai creditori, nella misura del 5% annuo (stessa percentuale del coevo Monte di Firenze). Quel debito pubblico venne visto dai cittadini come un mutuo vantaggio rispetto alle tasse: a differenza delle tasse il debito pubblico pagava interessi periodici e la città copriva le sue spese pubbliche.
Dalla fine del XII secolo le città commerciali italiane si trovarono di fronte a un forte aumento della spesa pubblica, anche a causa delle spese militari. Quelle città erano di fatto dei consorzi di famiglie, una specie di società cooperativa, dove i cittadini erano anche soci e proprietari di un bene comune: la città. Nelle prime fasi le spese pubbliche erano coperte con varie forme di contributi e tasse da parte dei cittadini. Di fronte però all’esplosione della spesa pubblica, i cittadini pensarono che invece di continuare ad aumentare le loro tasse poteva essere più conveniente emettere titoli di debito pubblico. Questi titoli dovevano pagare interessi periodici (il versamento degli interessi si chiamava paga) ai creditori, nella misura del 5% annuo (stessa percentuale del coevo Monte di Firenze). Quel debito pubblico venne visto dai cittadini come un mutuo vantaggio rispetto alle tasse: a differenza delle tasse il debito pubblico pagava interessi periodici e la città copriva le sue spese pubbliche.Interessante notare che mentre i teologi discutevano e in genere condannavano l’interesse sui prestiti privati, tanto che fu necessaria una Bolla papale (nel 1515) per rendere lecito l’interesse, sempre del 5%, chiesto dai Monti di Pietà francescani, tutti erano invece molto sereni sul pagamento dell’interesse sul debito pubblico. Il dibattito teologico a Venezia, infatti, non verteva sulla liceità dell’interesse accettato come un dato di realtà, ma sulla ragione che portava a considerare lecito quell’interesse. Protagonisti della disputa erano il francescano Francesco da Empoli, i domenicani Pietro Strozzi e Domenico Pantaleoni, e l’agostiniano Gregorio da Rimini.
 Il francescano accettava l’interesse sulla base della teoria francescana del "danno emergente" e del "lucro cessante": se un cittadino doveva prestare del denaro alla città (a volte i prestiti erano forzosi), la città doveva ricompensare quel danno subìto con il pagamento dell’interesse (termine usato da Francesco). Non c’era bisogno d’altro, l’interesse era un prezzo. Il francescano, poi, coerentemente non mette in discussione neanche la liceità di vendere i titoli del debito.
Il francescano accettava l’interesse sulla base della teoria francescana del "danno emergente" e del "lucro cessante": se un cittadino doveva prestare del denaro alla città (a volte i prestiti erano forzosi), la città doveva ricompensare quel danno subìto con il pagamento dell’interesse (termine usato da Francesco). Non c’era bisogno d’altro, l’interesse era un prezzo. Il francescano, poi, coerentemente non mette in discussione neanche la liceità di vendere i titoli del debito.Più articolato era invece il discorso dei teologi domenicani, che in genere erano più critici dei francescani sugli interessi. Sulla scia di Tommaso d’Aquino, i due teologi domenicani cambiano radicalmente argomentazione e costruiscono la loro tesi sulla liceità dell’interesse su una base totalmente diversa: quell’interesse non deve essere inteso comeprezzo del denaro prestato, ma come dono per chi ha agito per amore civico: «Il domenicano non contesta la liceità dell’attribuzione di un 5% annuo ai creditori del Monte, ma ne propone una interpretazione come dono spontaneo, da parte della comunità, che manifesta così la sua gratitudine al cittadino» (Roberto Lambertini, "Il dibattito medievale sul consolidamento del debito pubblico dei Comuni", 2009). L’interesse che, coerentemente con la sua etimologia (inter-esse>), era inteso come il legame in un rapporto di reciprocità tra doni. Ma se quel 5% è dono, allora, diversamente da Francesco da Empoli, per i domenicani il possessore del titolo non può rivenderlo, perché i doni non si vendono.
Ed è qui che entra in gioco un elemento decisivo, ripreso e potenziato dall’agostiniano Gregorio da Rimini: la retta intenzione. Ciò che rende quel 5% lecito è l’intenzione con la quale la città lo paga e il cittadino lo riceve. Se l’intenzione, di uno o di entrambe le parti, è il lucro privato, quell’interesse è illecito; se è il bene comune, è lecito. Da qui la non ammissibilità del commercio dei titoli, proprio perché in chi vende e acquista non c’è più l’originario bene comune, ma solo il lucro privato.
 Interessante, infine, la spiegazione che dà Gregorio per affermare che la città di Venezia non aveva la retta intenzione nell’emettere quei titoli di debito. Per il teologo agostiniano, è il pagamento della stessa percentuale del 5% a tutti, senza dunque tener conto delle diverse condizioni soggettive dei prestatori, delle loro ricchezza e necessità, che rende illecito quel debito pubblico; come a dire che quella mancata differenziazione evidenzia l’intenzione di lucro e non di bene comune. È l’antica idea che l’uguaglianza sostanziale, quindi la giustizia, non coincide con quella formale.
Interessante, infine, la spiegazione che dà Gregorio per affermare che la città di Venezia non aveva la retta intenzione nell’emettere quei titoli di debito. Per il teologo agostiniano, è il pagamento della stessa percentuale del 5% a tutti, senza dunque tener conto delle diverse condizioni soggettive dei prestatori, delle loro ricchezza e necessità, che rende illecito quel debito pubblico; come a dire che quella mancata differenziazione evidenzia l’intenzione di lucro e non di bene comune. È l’antica idea che l’uguaglianza sostanziale, quindi la giustizia, non coincide con quella formale.Oggi siamo nuovamente in una fase fondativa, a livello europeo, sul senso di debiti, di prestiti, di tasse, di interessi. Quei primi dibattiti etici hanno molte cose da dirci. Ci dicono che le intenzioni contano, contano ancora in economia. I Paesi europei hanno accettato l’emissione di molto debito pubblico in questo tempo pandemico perché hanno interpretato le intenzioni di chi chiedeva e di chi concedeva prestiti. Un male comune - la pandemia di Covidc-19 - ha fatto riscoprire il bene comune, e quindi un altro interesse, il legame necessario tra debito e bene comune. In questo terribile 2020 abbiamo riscoperto anche il dono, i doni fatti e quelli ricevuti, dal dono della vita di medici e infermieri fino al dono del vaccino gratuito e universale. E se fosse anche l’inizio di una nuova economia?
* Avvenire, sabato 19 dicembre 2020 (ripresa parziale).
_________________________________________________________
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... Francesco D’Agostino (dall’Avvenire) vuole dare lezioni a Rosy Bindi e mostra solo tutto il livore di un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio con "Mammona"!!!
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile, recensito da Riccardo Chiaberge
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- MEMORIA DI SANT’AMBROGIO: "CHARITAS DEUS EST".7 dicembre 2020, di Federico La Sala
SANT’AMBROGIO - AMBROSIUS,
In Epistolam Beati Pauli
Ad Corinthios Primam,
Caput XIII, Vers. 4-8:
"Charitas Deus est" (I Joan. 4,8).
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- LA CARITÀ POMPOSA. "L’Orologio" di Carlo Levi. Speranze e delusioni in un tornante decisivo del Novecento italiano (di Andrea Mariuzzo).7 dicembre 2020, di Federico La Sala
LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.... *
- « L’Italia è il paese classico dell’ospitalità (...). Ma lo spirito evangelico non ha saputo trasformarsi nella forma moderna della solidarietà e dell’organizzazione disinteressata e civile (...). L’assistenza, che è un diritto, diventa un regalo, una umiliante carità, che si può e non si può fare » (A. Gramsci, Odio gli indifferenti, pp.13 e 14).
- "Si usa dire che ci sono due sole strade, due soli principi su cui costruire lo Stato e la Società : quello russo e quello americano. Ebbene, ce n’è un terzo, del tutto diverso e ugualmente importante, ed è quello italiano. La via americana sarebbe, dicono, quella della Libertà, la via russa quella della Giustizia : ma la via italiana è un’altra, è quella della Carità. - Naturalmente, questa carità statale, ha certi suoi caratteri speciali : è una carità che si rivolge a se stessa, che riguarda anzitutto e unicamente i componenti dello Stato che su di essa si fonda. Lo Stato è l’incarnazione della Carità, e il suo dispensatore : e la sparge sui propri membri, sui funzionari, sui parenti, sugli amici, su coloro che direttamente o indirettamente ne vivono". (Carlo Levi, L’Orologio, Einaudi, 1950)
Speranze e delusioni in un tornante decisivo del Novecento italiano
L’Orologio di Carlo Levi
di Andrea Mariuzzo (Il Mulino, 02 dicembre 2020])
Il 29 novembre del 1902 nasceva a Torino uno degli intellettuali più brillanti e sottovalutati del Novecento italiano: Carlo Levi. Esponente di quella generazione di figli della buona borghesia del capoluogo piemontese che in tanti casi si sarebbe impegnata nel gruppo cittadino di Giustizia e Libertà sgominato dalla polizia politica fascista nel 1935 a causa della delazione di Dino “Pitigrilli” Segre, Levi fu per tutta la vita attivista politico della sinistra antifascista, ma anche scrittore e giornalista, osservatore con occhio quasi antropologico delle dinamiche sociali piccole e grandi di un Paese, del suo Mezzogiorno più profondo e di una classe politica, e soprattutto pittore molto apprezzato dai suoi contemporanei.
Tuttora, Levi deve la sua fama alle riflessioni nate nel periodo del confino in un villaggio della Lucania, e raccolte in Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato da Einaudi subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e tradotto in tutto il mondo. Ormai quasi dimenticata è, invece, la sua opera letteraria forse più matura, L’Orologio, pubblicato sempre con la casa editrice torinese nel 1950. Eppure, esso rappresenta forse l’unico esempio riuscito, quantomeno tra i pochi applicati a materia relativa all’età repubblicana italiana, di un genere assai raramente praticato nella letteratura italiana, quello del “romanzo politico”.
Riletto oggi, di certo, il libro presenta al pubblico una difficoltà non da poco che pure deve essere affrontata per apprezzarlo, cioè la necessità di immaginarsi come all’epoca e nel contesto della sua stesura un protagonista degli eventi narrati, risalenti a cinque anni prima, potesse rileggerli e guardare criticamente al modo in cui li visse. Vale tuttavia la pena di provarci, per poter godere di una riflessione che ha ancora molto da dirci sull’attualità e sulle sue radici storiche.
L’Orologio, dunque, prende esplicitamente le mosse dalle conclusioni del Cristo si è fermato a Eboli, in alcune pagine citando esplicitamente il libro precedente. Nell’Italia fossilizzata su illusori contrasti all’interno della propria classe dirigente che in realtà celavano la realtà profonda della dialettica di sopraffazione sui “contadini” dei “donluigini”, occorreva ricostruire da zero una comunità nazionale realmente coesa, strutturata attorno a istituzioni davvero al servizio dei cittadini e capaci di accompagnarli nel loro sforzo di elevazione sociale, ma prima di tutto occorreva smantellare fino in fondo gli apparati amministrativi e burocratici dal precedente assetto strutturalmente ineguale. A quegli apparati burocratici i privilegiati di ogni livello, dai grandi imprenditori monopolisti ai piccoli titolari della concessione di una farmacia, erano avvinghiati per ottenere ciò che sanciva in modo inequivocabile la propria condizione di privilegio: una sinecura pubblica, una sovvenzione, una deroga, una norma spudoratamente favorevole.
Su questi rapporti istituzionali e politici malati, che pure lo precedevano di decenni negli interstizi della società italiana, si era retto per vent’anni il regime fascista, e allo smantellamento di questa patologia che era stata una delle basi portanti della dittatura doveva dedicarsi, per completare la sua opera, l’antifascismo vittorioso nel 1945. Era del resto questo l’obiettivo di quella che il Partito d’Azione, allora soggetto politico di riferimento di Carlo Levi nonché interprete più convinto dell’epopea resistenziale, intendeva raggiungere con quella che con un certo understatement era presentata come “riforma della pubblica amministrazione”, ma che in realtà doveva essere una rivoluzione culturale, un lavacro purificatore di tutti i germi socio-culturali alla radice del fascismo. Lavacro purificatore forse utopistico, ragione fondamentale per cui tanta parte delle culture politiche italiane, da quelle raccolte nei partiti di massa della sinistra marxista a quella del cattolicesimo organizzato di governo fino agli opinionisti liberal-conservatori a la Montanelli, avrebbe ricordato il Pda come un partito di anime belle, di illusi sospesi tra il desiderio di crogiolarsi nei loro sogni e la volontà di realizzarli con un colpo di mano giacobino, in definitiva figure storicamente inutili o peggio ancora (per chi guardava da destra) mosche cocchiere per utopie assai meglio armate.
Scrivendo L’Orologio nel 1950, Levi non rinnegava affatto quell’obiettivo ideale, ma in una certa misura ammetteva la necessità di riflettere su quanto esso fosse effettivamente realizzabile, poiché chiariva che esso poteva essere spiegato, e “fatto passare” al pubblico, solo nella forma del romanzo, della scrittura di finzione. Il canovaccio del racconto era però intessuto di fatti reali, poiché l’azione si svolgeva effettivamente tra il 22 e il 24 novembre del 1945, nelle convulse giornate in cui si consumò la crisi del governo guidato da Ferruccio Parri, l’esecutivo in cui gli azionisti avevano riposto le speranze di vedere realizzate le loro istanze di rinnovamento al soffio del “vento del Nord” dell’esperienza resistenziale. Allo stesso modo aveva radici nella realtà anche il ruolo del protagonista e voce narrante, direttore del quotidiano del partito che esprimeva “il Presidente”, proprio come nel novembre 1945 Levi era direttore dell’organo azionista “L’Italia libera”.
In fondo tutto il romanzo è la riflessione su quanto la compagine azionista ed ex-partigiana alla guida del governo chiede troppo a quel “vento del Nord”, per il quale era impossibile soffiare così forte da abbattere abitudini e necessità radicate troppo in profondità nel sentire del Paese, soprattutto delle sue zone più problematiche.
Questa riflessione si dipana, sul piano narrativo, nella forma di due viaggi.
Dapprima il protagonista-narratore si trova a compiere un giro per Roma alla ricerca di esponenti politici più o meno importanti, ma soprattutto alla scoperta di funzionari e impiegati passati dal pre-fascismo al post-fascismo senza mutare di una virgola il loro atteggiamento e il modo di interpretare il loro ruolo. Essi, ai suoi occhi, rappresentavano la vera forza materiale della conservazione, in quanto legati in maniera irremovibile a quei piccoli privilegi che di fatto non permettevano loro null’altro che di galleggiare appena sopra la miseria, ma senza i quali essi non sapevano neppure immaginarsi.
Al protagonista toccò poi compiere un viaggio di andata e ritorno per Napoli che assunse i caratteri di un’odissea tra strade bombardate e paesi ridotti all’inesistenza. Il viaggio di ritorno, in particolare, avverrà in automobile, privilegio che il direttore di un giornale di partito non si sarebbe mai potuto concedere se nel capoluogo campano non avesse ricevuto un passaggio da due esponenti di spicco dei due grandi partiti che si apprestavano a gestire in proprio il governo e il potere: Colombi (figura sotto cui si cela il democratico-cristiano Attilio Piccioni) e Tempesti (il comunista Emilio Sereni).
Proprio nel corso del viaggio due rappresentanti dei grandi partiti di massa, a cui simbolicamente sarebbe passata la responsabilità di guidare il Paese pochi giorni dopo con l’incarico di formare il governo affidato direttamente al leader della Dc Alcide De Gasperi, si rendono protagonisti di un dialogo di cui il protagonista è muto testimone, forse profetico per il dibattito pubblico degli anni successivi: un dialogo in cui moderati e sinistra si confrontano da posizioni opposte, ma portandolo avanti utilizzando le stesse parole e riconoscendo reciprocamente il ruolo l’uno dell’altro. Si manifestava insomma come inevitabile la conclusione che avrebbe condotto all’esito delle elezioni per la Costituente nel giugno 1946, ovvero quella per cui per avere successo nella politica italiana si doveva finire per accettare, e quasi per incorporare e rappresentare, ciò che nel Paese non funzionava, costruendo su tale comune accettazione la collaborazione e il conflitto.
Si chiudeva così la riflessione sul recente passato di Levi, che aveva accompagnato parole e pensieri del protagonista col pensiero ricorrente di un vecchio orologio di famiglia che aveva portato a riparare, ma che non avrebbe più ritirato anche perché nel frattempo gli eventi gliene avevano regalato uno nuovo, come a simboleggiare anche sul piano materiale una netta cesura nel suo percorso esistenziale di attivista politico antifascista che però si stagliava sulla continuità della verità destinata a uscire in modo più evidente dalle pagine del volume: «il nostro [Stato] è una grande organizzazione caritatevole per coloro che ne fanno parte [...]. Qualcuno deve pagare le spese della pubblica carità, le spese di Stato: e questi sono coloro che dello Stato non fanno parte».
Dopo settant’anni queste parole restano allo stesso modo suggestive, anche se l’effettiva partecipazione o meno alla “carità di Stato” si è fatta sempre meno facilmente intuibile.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO" !
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
-
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! --- "IL MASSIMO NECESSARIO": UNA QUESTIONE DI AMORE ("CHARITAS").Tutte le voci cantano la Fede e la Speranza (di Gianfranco Ravasi).8 novembre 2020, di Federico La Sala
Tutte le voci cantano la Fede e la Speranza
Virtù teologali. Sul tema Eugenio Borgna ripercorre le strade cliniche delle terapie psichiatriche e ricorda le riflessioni di scrittori e pensatori, da Leopardi a Sant’Agostino, da Kierkegaard a Bloch.
di Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 08.11.2020, p. X)
- SPERANZA E DISPERAZIONE Eugenio Borgna Einaudi, Torino, pagg. 111, e. 12
- IL MASSIMO NECESSARIO Stefano Biancu Mimesis, Sesto San Giovanni (Milano), pagg. 135, e. 14
«È sperare la cosa difficile - a voce bassa e vergognosamente. E la cosa facile è disperare, ed è la grande tentazione». Così Charles Péguy nel suo poema Il portico del mistero della seconda virtù (1911), dedicato a questa che è appunto la seconda delle virtù teologali, la «sorella più piccola» rispetto alle altre due, la fede e la carità. Ma, come spesso accade ai bambini che strattonano i loro genitori fermi per strada davanti alle vetrine o a chiacchierare con una persona incontrata, è la speranza a far avanzare le due sorelle maggiori nella via della vita.
A questa virtù e al suo rovescio oscuro, la disperazione, lo psichiatra Eugenio Borgna ha riservato un fascicolo essenziale di pagine, ma che mettono a dura prova il recensore perché sarebbero quasi semplicemente da trascrivere, tanto sono trasparenti e intense, frutto anche di una ricerca come la sua, condotta non solo sui picchi innevati e soleggiati della speranza ma anche negli abissi oscuri e nelle caverne tenebrose della disperazione. Strettamente parlando la sua riflessione è impostata su un dittico.
La prima tavola evoca l’orizzonte immenso che sboccia dalla speranza, vista come «infinita ricerca di senso». Curiosamente la parola spes è ancorata alla radice indoeuropea spat- che genera anche spatium. In realtà questa virtù è più annodata alla categoria «tempo», è infatti soprattutto proiezione sul futuro, sia pur tenendo i piedi piantati nel presente e con le spalle e il volto pronti a girarsi anche verso il passato. Non per nulla il secondo quadro del dittico s’intitola la «speranza come memoria del futuro», intrecciando così in pienezza la tridimensionalità del tempo alla maniera agostiniana. Davanti alle due tavole il lettore è invitato a scoprire i registri molteplici che le compongono.
Da un lato, attesa e paura, etica ed escatologia, ma anche il piombare nel gorgo del suicidio. Emozionante è l’esegesi del diario di Pavese con le sue righe roventi, con le trame inquietanti e sospese fino all’approdo in quell’ultima pagina fremente che vira persino verso un’invocazione orante («Tu, abbi pietà») ma che sarà suggellata da un freddo dato di cronaca: «nella notte tra il 26 e il 27 agosto 1950 moriva ingerendo alte dosi di barbiturici». Borgna convoca, infatti, nella sua ricerca almeno due tipologie testimoniali. Ci sono le voci delle persone che hanno percorso le strade cliniche delle terapie psichiatriche.
L’autore, però, non le fa risuonare mai secondo un freddo referto medico (come è noto, egli ha praticato anche questa via nel manicomio femminile di Novara), bensì si rivela un compagno di viaggio, persino tenero e delicato, con la ricchezza della sua umanità che ben conoscono tutti coloro che l’hanno incontrato (tra l’altro, uno dei suoi testi precedente s’intitolava L’ascolto gentile).
 D’altro lato, c’è una voce ulteriore dalle mille iridescenze, ed è quella molteplice degli scrittori, a partire dall’amato Leopardi, ma anche dei pensatori come Agostino, Kierkegaard o Bloch e persino del cinema col folgorante balenare del Posto delle fragole di Bergman, parabola ideale della «memoria del futuro», e dell’apostolo Paolo con la sua lezione sullo «sperare contro ogni speranza».
D’altro lato, c’è una voce ulteriore dalle mille iridescenze, ed è quella molteplice degli scrittori, a partire dall’amato Leopardi, ma anche dei pensatori come Agostino, Kierkegaard o Bloch e persino del cinema col folgorante balenare del Posto delle fragole di Bergman, parabola ideale della «memoria del futuro», e dell’apostolo Paolo con la sua lezione sullo «sperare contro ogni speranza».
 Come dicevamo, tante altre sono le suggestioni che fioriscono nel lettore di questo volumetto che è posto all’insegna di un incisivo detto leopardiano: «Insomma la disperazione medesima non sussisterebbe senza la speranza, e l’uomo non dispererebbe se non isperasse». Per il teologo, poi, è aperto un campo molto vasto di ricerca e non solo per la meta escatologica che regge il concetto di storia della salvezza (l’Apocalisse insegna), ma per il profilo stesso del Dio cristiano e per la sua parola che invita l’umanità ad alzare sempre lo sguardo, come è dimostrato dall’importante Teologia della speranza di Jürgen Moltmann (1964), tradotta dalla Queriniana di Brescia.
Come dicevamo, tante altre sono le suggestioni che fioriscono nel lettore di questo volumetto che è posto all’insegna di un incisivo detto leopardiano: «Insomma la disperazione medesima non sussisterebbe senza la speranza, e l’uomo non dispererebbe se non isperasse». Per il teologo, poi, è aperto un campo molto vasto di ricerca e non solo per la meta escatologica che regge il concetto di storia della salvezza (l’Apocalisse insegna), ma per il profilo stesso del Dio cristiano e per la sua parola che invita l’umanità ad alzare sempre lo sguardo, come è dimostrato dall’importante Teologia della speranza di Jürgen Moltmann (1964), tradotta dalla Queriniana di Brescia.- Originale l’angolatura scelta da Stefano Biancu per illustrare il tema della Carità.
Si è già detto che la speranza ha una sorella maggiore nella carità, e a questa virtù dedica un suo studio un docente universitario, Stefano Biancu, ma lo fa da un’angolatura molto originale. Certo, il dettato ora è quello accademico e le pagine hanno rimandi sistematici e grondano di note, ma l’approccio potrà interessare molti. Se volessimo sintetizzarlo in modo semplificatorio, potremmo ricorrere proprio al titolo, Il massimo necessario. L’amore, infatti, è di sua natura eccedente, non calcola, anzi sciala, tant’è vero che quando due innamorati cominciano a soppesare il valore dei regali che si sono fatti, è segno che stanno per lasciarsi.
Non per nulla, il Nuovo Testamento ha coniato come suprema definizione divina quella giovannea che suona ho Thèos agápe estín, «Dio è amore». La carità s’incrocia con l’infinito e l’eterno e san Paolo ci ha lasciato uno strepitoso inno dell’agápe nel c. 13 della Prima Lettera ai Corinzi, ove dichiara che «la carità non avrà mai fine» (letteralmente «non cadrà mai»).
Per illustrare questa qualità «eccessiva» dell’amore, che diventa anche la cartina di tornasole dell’autentica etica, Biancu ricorre a un curioso vocabolo adottato dalla tradizione teologico-morale, «supererogatorio». Il termine ha la sua sorgente genetica nella versione latina di un celebre passo del Vangelo di Luca, quello dalla parabola del Buon samaritano (10,29‑37): dopo aver raccolto, curato e condotto in un albergo la vittima di un assalto di brigantaggio, il samaritano rassicura l’albergatore - al quale ha già consegnato due denari - di non esitare a «spendere di più» qualora fosse necessario, pronto a rifondere la spesa successivamente (v. 35).
Quello «spendere di più» nel greco neotestamentario è un hapax, prosdapanáô, che si basa sui termini correlati dapánê, «spesa», e dapanáô, «spendere», e che san Paolo userà in un’altra forma composita, ekdapanáô, proprio per indicare il suo «spendersi senza riserve, il consumarsi, il sacrificare se stesso» per l’evangelo (2Corinzi 12,15).
Eccoci, dunque, nel cuore dell’amore che anela al massimo della donazione e che, nel suo scritto, Biancu incarna in una categoria radicale, la fraternità. Essa si sostiene su una duplice base: da un lato, la libertà e l’uguaglianza, che appartengono alla modernità politica e secolare; d’altro lato sull’ospitalità e sul perdono, virtù pertinenti soprattutto alla morale religiosa e che, alla fine, sfociano nella «misericordia impensabile». Non per nulla, a quest’ultimo proposito, Antico e Nuovo Testamento, pur nella loro diversità linguistica, per esprimerla non ricorrono come nel nostro caso al «cuore» (misericordia), bensì al grembo materno (rahamîm in ebraico, splánchna in greco) che simboleggia un amore totale, assoluto, istintivo e radicale.
È quello che Cristo aveva rappresentato nell’asserto pronunciato nell’ultima sera della sua vita terrena nel Cenacolo: «Non c’è amore più grande di chi dà la vita per la persona che ama» (Giovanni 15,13). Naturalmente molto ramificato e sostenuto da un ampio apparato di riflessioni, di applicazioni, di rimandi alla ricerca filosofica è lo studio proposto dall’autore. Certo è che il paradigma del «supererogatorio » è un po’ la pietra di paragone del «dovere» veramente umano e dell’etica genuina, nonostante la deriva attuale che, tendendo sempre al minimo, impedisce e rende incapaci di tentare l’ascesa verso l’alto, fino al «massimo necessario».
 Una delle domande conclusive che affiora nel testo è, allora, questa: «come pensare l’antropologia, l’etica, la politica a partire da ciò che è stato fino ad ora impensabile?».
Una delle domande conclusive che affiora nel testo è, allora, questa: «come pensare l’antropologia, l’etica, la politica a partire da ciò che è stato fino ad ora impensabile?».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA !!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM".
L’ULTIMO PAPA CEDE IL PASSO A ZARATHUSTRA: "CHI AMA, AMA AL DI LA’ DEL PREMIO E DELLA RIVALSA". Una pagina di Nietzsche
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- FILOLOGIA E INFANZIA. La ninnananna è il convincimento alla fiducia in una presenza affidabile (di Giovanni C. Pagazzi).20 ottobre 2020, di Federico La Sala
Tradizioni.
Nella ninnananna si condensa la prima teologia
La ninnananna è il convincimento alla fiducia in una presenza affidabile, che assicura al risveglio il ritrovamento di tutti gli affetti: coagula la prima filosofia e la prima teologia della storia
di Giovanni Cesare Pagazzi (Avvenire, martedì 28 luglio 2020)
- [Foto] “Ninnananna” di François Riss - WikiCommons
Si può guardare all’universale usanza della ninnananna con gli occhi altezzosi di chi ha cose ben più serie da studiare, o solo con la simpatia suscitata dalle cose infantili. In realtà essa contribuisce a comporre la prima visione del mondo, offerta a chi da poco è venuto alla luce. È quanto emerge anche dalle ricerche dell’antropologa Gianfranca Ranisio, dell’etnomusicologo Sandro Biagiola e del musicista e teologo Pierangelo Sequeri.
 Da tempo immemorabile è avvertita l’esigenza di accompagnare il bambino nel sonno, garantendogli vicinanza corporea e affettiva, inventando un genere letterario e musicale specifico: la ninnananna, appunto. Ritmicità, musicalità, vocalità e corporeità sono i punti fermi di questi componimenti che esaltano il rapporto tra il bambino e l’adulto nel momento più critico del giorno: il sopraggiungere della notte.
Da tempo immemorabile è avvertita l’esigenza di accompagnare il bambino nel sonno, garantendogli vicinanza corporea e affettiva, inventando un genere letterario e musicale specifico: la ninnananna, appunto. Ritmicità, musicalità, vocalità e corporeità sono i punti fermi di questi componimenti che esaltano il rapporto tra il bambino e l’adulto nel momento più critico del giorno: il sopraggiungere della notte.
 In genere si tratta di nenie cantilenanti dal movimento moderato e dal ritmo pari che ben si accompagna al movimento binario del cullare. Il sistema musicale non è temperato, si avvale cioè della sonorità originaria, ben più complessa e ricca rispetto alla classificazione artificiale dei suoni data dal sistema temperato. -L’aspetto fortemente ripetitivo di testo, musica e gesto accende nel bambino il senso di affidabilità e di attendibilità. Infatti qualsiasi evento ripetuto inclina ad attenderlo nuovamente, abituando al suo arrivo, tanto da coglierlo come “attendibile”: lo si può aspettare, poiché arriverà; è affidabile.
In genere si tratta di nenie cantilenanti dal movimento moderato e dal ritmo pari che ben si accompagna al movimento binario del cullare. Il sistema musicale non è temperato, si avvale cioè della sonorità originaria, ben più complessa e ricca rispetto alla classificazione artificiale dei suoni data dal sistema temperato. -L’aspetto fortemente ripetitivo di testo, musica e gesto accende nel bambino il senso di affidabilità e di attendibilità. Infatti qualsiasi evento ripetuto inclina ad attenderlo nuovamente, abituando al suo arrivo, tanto da coglierlo come “attendibile”: lo si può aspettare, poiché arriverà; è affidabile.Per l’adulto è scontato che domani sorga il sole, camminando passo dopo passo il terreno continui a sostenere il corpo e la persona amata si faccia trovare all’appuntamento fissato. Per il bambino non è così; la fiducia deve essergli accesa da esperienze che affettivamente gli dimostrino l’esistenza di realtà attendibili: come la mamma che arriva tutte le volte che piange, i giocattoli rimasti al loro posto e sempre pronti a far compagnia, il pavimento che esibisce metro dopo metro la sua fedele solidità mentre il piccolo, gattonando, lo tasta. -Senza l’accensione del senso di affidabilità fin dagli inizi della vita, non ci si aspetterebbe niente da nessuno, per l’ottima ragione che niente e nessuno risulterebbe attendibile (e, naturalmente, questo vale anche per Dio). È indicativo che tutto nella ninnananna abbia la forma della ripetizione e che a questo genere di composizione si ricorra all’inizio della notte, per favorire il sonno del piccolo. Il bambino spesso non vuole addormentarsi, rifiuta di andare a letto non per capriccio infantile, ma per paura di essere abbandonato dalla mamma, dal papà, dai giocattoli, dalla casa che l’oscurità della notte si porta via.
 La paura del bimbo è spesso evocata dalle ninnananne riferendo di pericoli, minacce, animali mostruosi; in Europa il lupo è il predatore più spaventoso.
La paura del bimbo è spesso evocata dalle ninnananne riferendo di pericoli, minacce, animali mostruosi; in Europa il lupo è il predatore più spaventoso.
 Al richiamo del rischio notturno fa comunque da contrappunto l’assicurazione della presenza vigile della mamma che in alcuni casi chiede aiuto a un angelo, un santo, alla Madonna, o Gesù stesso, invocato con riferimenti alla sua infanzia. La garanzia della cura e il coinvolgimento di Dio evidenziano quanto il momento dell’abbandono al sonno da parte del piccolo sia effettivamente drammatico e quanto gli adulti intuiscano e rispettino il dolore del bimbo come ne fossero esperti.
Al richiamo del rischio notturno fa comunque da contrappunto l’assicurazione della presenza vigile della mamma che in alcuni casi chiede aiuto a un angelo, un santo, alla Madonna, o Gesù stesso, invocato con riferimenti alla sua infanzia. La garanzia della cura e il coinvolgimento di Dio evidenziano quanto il momento dell’abbandono al sonno da parte del piccolo sia effettivamente drammatico e quanto gli adulti intuiscano e rispettino il dolore del bimbo come ne fossero esperti.Non per nulla, infatti, il linguaggio musicale, gestuale e testuale delle ninnenanne è molto simile alle oscillazioni ritmiche e cantilenate dei lamenti funebri. Sicché la ninnananna è anche il rimedio agli oscuri presentimenti degli adulti che intuiscono quanto il dormire somigli alla morte.
 La ninnananna è il convincimento alla fiducia a motivo di una presenza affidabile che assicura, insieme al risveglio, la permanenza e il ritrovamento di tutti gli affetti. Avanzando la pretesa di dire una parola decisiva sul sonno e sulla notte, la ninnananna coagula la prima filosofia e la prima teologia della storia, capaci di integrare il buio e la morte. Una filosofia e una teologia gestuale, vocale, musicale.
La ninnananna è il convincimento alla fiducia a motivo di una presenza affidabile che assicura, insieme al risveglio, la permanenza e il ritrovamento di tutti gli affetti. Avanzando la pretesa di dire una parola decisiva sul sonno e sulla notte, la ninnananna coagula la prima filosofia e la prima teologia della storia, capaci di integrare il buio e la morte. Una filosofia e una teologia gestuale, vocale, musicale.
 Il bimbo si abbandona al sonno quando è sicuro che non sarà abbandonato; solo a patto che gli risulti affidabile la promessa del ritorno del mattino e, con esso, della mamma, del papà, dei giocattoli e della casa. Esigendo la vicinanza dei genitori al lettino (come il morente desidera avere al capezzale tutti i suoi affetti), il bimbo si lascia andare, sicuro che essi staranno con lui, anche se non visti, per tutta la durata della notte. Il suo sonno risulta dalla veglia di qualcun altro che gli annuncia e prepara il domani.
Il bimbo si abbandona al sonno quando è sicuro che non sarà abbandonato; solo a patto che gli risulti affidabile la promessa del ritorno del mattino e, con esso, della mamma, del papà, dei giocattoli e della casa. Esigendo la vicinanza dei genitori al lettino (come il morente desidera avere al capezzale tutti i suoi affetti), il bimbo si lascia andare, sicuro che essi staranno con lui, anche se non visti, per tutta la durata della notte. Il suo sonno risulta dalla veglia di qualcun altro che gli annuncia e prepara il domani. -
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - “Ripensare al nostro rapporto col denaro”. Invito del Papa, all’udienza concessa al Comitato di esperti del Consiglio d’Europa (Moneyval).8 ottobre 2020, di Federico La Sala
Vaticano.
Il Papa a Moneyval: impedire ai mercanti di speculare nel tempio dell’umanità
L’incontro con gli esperti del Comitato del Consiglio d’Europa, giunti in Vaticano per la valutazione periodica delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
di Redazione Internet (Avvenire, giovedì 8 ottobre 2020)
- “Ripensare al nostro rapporto col denaro”. È l’invito del Papa, durante l’udienza concessa oggi al Comitato di esperti del Consiglio d’Europa (Moneyval). “In certi casi pare che si sia accettato il predominio del denaro sull’uomo”, il monito di Francesco: “Talora, pur di accumulare ricchezza, non si bada alla sua provenienza, alle attività più o meno lecite che l’abbiano originata e alle logiche di sfruttamento che possono soggiacervi. Così, accade che in alcuni ambiti si tocchino soldi e ci si sporchi le mani di sangue, del sangue dei fratelli. - Vatican Media
Il Papa ha incontrato il Comitato Moneyval e li ha ringraziati per il loro servizio "a tutela di una finanza pulita, nell’ambito della quale ai ’mercanti’ è impedito di speculare in quel sacro tempio che è l’umanità, secondo il disegno d’amore del Creatore".
"Il lavoro che voi svolgete in relazione a questo duplice obiettivo mi sta particolarmente a cuore", ha detto il Papa sottolineando la necessità di "una finanza che non opprima i più deboli e i bisognosi". "Ritengo necessario ripensare al nostro rapporto col denaro", ha ribadito il Papa.
“Gesù ha scacciato dal tempio i mercanti e ha insegnato che non si può servire Dio e la ricchezza”, ha ricordato Francesco, secondo il quale “quando l’economia perde il suo volto umano, non ci si serve del denaro, ma si serve il denaro. È questa una forma di idolatria contro cui siamo chiamati a reagire, riproponendo l’ordine razionale delle cose che riconduce al bene comune,il denaro deve servire e non governare!”. E proprio per attuare tali principi, ha sottolineato il Papa, “l’Ordinamento vaticano ha intrapreso, anche recentemente, alcune misure sulla trasparenza nella gestione del denaro e per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo”. Il 1° giugno scorso, infatti, è stato promulgato un Motu Proprio per una più efficace gestione delle risorse e per favorire la trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, mentre i 19 agosto scorso, una ordinanza del presidente del Governatorato ha sottoposto le organizzazioni di volontariato e le persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano all’obbligo di segnalazione di attività sospette all’Autorità di Informazione Finanziaria.
Le politiche di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo costituiscono "uno strumento per monitorare i flussi finanziari, consentendo di intervenire laddove emergano tali attività irregolari o, addirittura, criminali. Gesù ha scacciato dal tempio i mercanti - ha detto Papa Francesco nell’udienza a Moneyval - e ha insegnato che non si può servire Dio e la ricchezza. Quando, infatti, l’economia perde il suo volto umano, non ci si serve del denaro, ma si serve il denaro. È questa una forma di idolatria contro cui siamo chiamati a reagire, riproponendo l’ordine razionale delle cose che riconduce al bene comune, secondo il quale il denaro deve servire e non governare".
Operare per una “finanza pulita”, nell’ambito della quale “ai mercanti è impedito di speculare in quel sacro tempio che è l’umanità, secondo il disegno d’amore del Creatore”, l’appello finale.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- "Fratelli tutti": Papa Francesco indica l’ultima carta per cambiare il paradigma (di Raniero La Valle).7 ottobre 2020, di Federico La Sala
Papa Francesco indica l’ultima carta per cambiare il paradigma dell’umano
Fratelli tutti. Poiché è sull’amore, questa è un’enciclica laica, di una straordinaria laicità, perché l’amore non si lascia irretire in un solo stampo, in un unico codice
di Raniero La Valle (il manifesto, 07.10.2020)
È una lettera sconcertante e potente questa che papa Francesco, facendosi “trasformare” dal dolore del mondo nei lunghi giorni della pandemia, ha scritto a una società che invece mira a costruirsi “voltando le spalle al dolore”.
Per questo la figura emblematica che fa l’identità di questa enciclica, prima ancora che quella di Francesco d’Assisi, è quella del Samaritano, che ci pone di fronte a una scelta stringente: davanti all’uomo ferito (e oggi sempre di più ci sono persone ferite, tutti i popoli sono feriti) ci sono solo tre possibilità: o noi siamo i briganti, e come tali armiamo la società dell’esclusione e dell’iniquità, o siamo quelli dell’indifferenza che passano oltre immersi nelle loro faccende e nelle loro religioni, o riconosciamo l’uomo caduto e ci facciamo carico del suo dolore: e dobbiamo farlo non solo con il nostro amore privato, ma col nostro amore politico, perché dobbiamo pure far sì che ci sia una locanda a cui affidare la vittima, e istituzioni che giungano là dove il denaro non compra e il mercato non arriva.
Ci si poteva chiedere che cosa avesse ancora da dire papa Francesco dopo sette anni di così eloquenti gesti e parole, cominciati a Lampedusa e culminati ad Abu Dhabi nell’incontro in cui si è proclamato con l’Islam che “se è uccisa una persona è uccisa l’umanità intera”, ragione per cui non sono più possibili né guerre né pena di morte.
E per Francesco neanche l’ergastolo, che “è una pena di morte nascosta”, e tanto meno le esecuzioni extragiudiziarie degli squadroni della morte e dei servizi segreti. Ebbene, la risposta sul perché dell’enciclica è che ormai non si tratta di operare qualche ritocco qua e là, ma si tratta di cambiare il paradigma dell’umano, che regge tutte le nostre culture e i nostri ordinamenti: si tratta di passare da una società di soci a una comunità di fratelli.
Perciò questa seconda lettera (l’altra è stata la Laudato sì, mentre la prima era in realtà di Ratzinger) non è un’enciclica sociale; solo una volta il papa si fa sfuggire di aver scritto un’”enciclica sociale”; in realtà essa non ha nessuna somiglianza con il “Compendio della dottrina sociale della Chiesa” fatto pubblicare nel 2004 da papa Wojtyla, in cui si pretendeva di definire per filo e per segno tutto ciò che si doveva fare nella società.
Questa invece è un’enciclica sull’amore perché passare da soci a figli vuol dire passare dalla ricerca dell’utile all’amore senza ragione: i migranti non si devono accogliere perché possono essere utili, ma perché sono persone, e i disabili e gli anziani non si devono scartare perché una società dello scarto è essa stessa inumana.
Poiché è sull’amore, questa è un’enciclica laica, anzi di una straordinaria laicità, perché l’amore non si lascia irretire in un solo stampo, in una sola proposta, in un unico codice. È impressionante come papa Francesco lasci aperte sempre altre possibilità, altre considerazioni del reale, altre strade possibili, perfino dinanzi al peccato e all’errore; sempre è invocata la pluralità, mai il relativismo, sempre il gusto delle differenze, dell’inedito, del non ancora compreso; il poliedro, mai la torre di Babele, dalla pretesa unificante.
Ci vuole fantasia per costruire la società fraterna e non è facile passare dal “legame di coppia e di amicizia” all’accoglienza verso tutti e all’”amicizia sociale”. Alle volte sembra di leggere una lezione di laicità al mondo, alle culture fissiste, come il liberismo, che fa della proprietà privata, che è “un diritto secondario”, un valore primario e assoluto, mentre originario e prioritario è il diritto all’uso comune dei beni creati per tutti; come c’è una lezione al populismo e al nazionalismo, incapaci di farsi interpellare da ciò che è diverso, di aprirsi all’universalità, chiusi come sono nei loro angusti recinti come in “un museo folkloristico di eremiti localisti”; il male è che così si perdono proprio beni irrinunciabili come la libertà o la nazione: l’economia che si sostituisce alla politica non ha messo fine alla storia ma ruba la libertà; e con la demagogia il rischio è che si perda il concetto di popolo, “mito” e istituzione insieme, a cui non si può rinunziare perché altrimenti si rinunzia alla stessa democrazia.
La stessa fraternità, dice Francesco, va strutturata in un’organizzazione mondiale garantista e efficiente, sotto “il dominio incontrastato del diritto”, anche se un progetto per lo sviluppo di tutta l’umanità “oggi suona come un delirio”.
Mentre l’enciclica si distribuiva in piazza san Pietro ed era tolto l’embargo, nelle chiese si leggeva, tra le letture del giorno, questa frase del profeta Isaia: “Egli (il Signore) si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi”. Sembrava un giudizio scritto per l’oggi, mentre Francesco è assediato, fin dentro al tempio, da mercanti e falsi difensori della fede.
È forse questo il segreto di questa enciclica: c’è, per un mondo malato, dove “tutto sembra dissolversi e perdere consistenza”, da giocare l’ultima carta, cambiare i soci in fratelli. Si potrà poi essere anche cattivi fratelli, incapaci di memoria, di pietà, di perdono, però tutti si riconosceranno investiti della infinita dignità dell’umano, questa verità che non muta, accessibile a tutti e obbligante per tutti.
Ma per essere fratelli ci vuole un padre. Perciò tutto il ministero di papa Francesco è volto a “narrare” al mondo la misericordia del Padre; lui che è il primo pastore della religione del Figlio, si mette nei panni del Figlio (com’è del resto suo compito) per recuperare la religione del Padre, per dare agli uomini un Padre in cui si riconoscano finalmente fratelli. Una cosa così “religiosa” che la voleva perfino la Rivoluzione francese; solo che, dice ora papa Francesco, se la fraternità non si esercita veramente anche la libertà e l’uguaglianza sono perdute. E il mondo, ora, sarebbe perduto con loro.
-
>MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- Abitare le parole: Impronta. Segnavia della nostra storia (di Nunzio Galantino).2 ottobre 2020, di Federico La Sala
DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!
- "Come nella Bibbia (Ebr 1,3), doveGesù è χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, è impronta - nel senso di piena ed esatta rappresentazione - della sostanza di Dio" ... ma di Dio Charitas (Amore) o Dio Caritas (Mammona)?!
Abitare le parole
Impronta.
SEGNAVIA DELLA NOSTRA STORIA
di Nunzio Galantino *
Per coprire il campo semantico della parola “impronta”, oltre al contributo che viene dalla derivazione etimologica, è opportuno porre attenzione al significato del termine χαρακτήρ che rende, in greco, la parola impronta e identificare gli attributi che, di volta in volta, l’accompagnano.
Sul piano etimologico, la parola impronta deriva dal latino imprĭmere (premere sopra, calcare). Χαρακτήρ - dal verbo χαράσσω (incidere, scolpire) - nella cultura greca è un nomen agentis: è cioè più di una traccia lasciata. È invece una persona che ritrae qualcuno o qualcosa. Come nella Bibbia (Ebr 1,3), dove Gesù è χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, è impronta - nel senso di piena ed esatta rappresentazione - della sostanza di Dio.
A proposito, poi, dell’impronta e degli attributi che l’accompagnano, si parla di impronta fisica lasciata da una parte del corpo o da uno strumento fisico, di impronta digitale cellulare e di impronta genetica. Sempre più spesso sentiamo, inoltre, rivolto a tutti l’invito a ridurre l’impronta ecologica; una sorta di indicatore che misura la quantità e la qualità del consumo delle risorse naturali prodotte dal pianeta Terra.
In senso generico, l’impronta è un segno tracciato con una pressione su una superficie. In senso figurato, la parola impronta indica una caratteristica che permette di identificare una persona o una sua produzione artistica, letteraria ecc. È vero che, almeno dal punto di vista fisico, non si può non lasciare un’impronta. Ma è anche vero che l’impronta non è solo il frutto inconsapevole di un gesto, di una presenza o di un passaggio.
 Il più delle volte, proprio perché espressione di una identità, l’impronta è frutto di una scelta consapevole, attraverso la quale io, di fatto, racconto la mia vita, le priorità che mi guidano e la qualità che scelgo di far ricadere in modo incisivo sulle mie relazioni.
Il più delle volte, proprio perché espressione di una identità, l’impronta è frutto di una scelta consapevole, attraverso la quale io, di fatto, racconto la mia vita, le priorità che mi guidano e la qualità che scelgo di far ricadere in modo incisivo sulle mie relazioni.E, proprio perché contengono pezzi di noi e della nostra interiorità, le impronte possono trasmettere un’immagine positiva di noi o comunicarne una negativa. Sono lì, come segnavia della nostra storia personale.
 Bisogna avere, di tanto in tanto, il coraggio di prenderle in mano e di fermarci per verificare cosa le impronte di cui disseminiamo la nostra presenza e le nostre relazioni stanno raccontando di noi.
Bisogna avere, di tanto in tanto, il coraggio di prenderle in mano e di fermarci per verificare cosa le impronte di cui disseminiamo la nostra presenza e le nostre relazioni stanno raccontando di noi.
 Uno sguardo attento e onesto sulle impronte ci permetterebbe di verificare se, quelle lasciate nel cuore e nella storia delle persone incontrate sul nostro cammino, sono impronte che generano e tramettono vita o piuttosto dolorose cicatrici.
Uno sguardo attento e onesto sulle impronte ci permetterebbe di verificare se, quelle lasciate nel cuore e nella storia delle persone incontrate sul nostro cammino, sono impronte che generano e tramettono vita o piuttosto dolorose cicatrici.La storia personale e quella relazionale in genere vive di impronte lasciate e di impronte subìte, attraverso uno sguardo, una parola, una carezza o un’emozione provocata. Ma essa è esposta anche a impronte che assomigliano molto di più a ferite. Quelle provocate da rifiuti, sguardi indifferenti o evidenti strumentalizzazioni. Se le prime hanno la capacità di ricomporre pezzi di vita andati in frantumi, le altre, più che impronte, sono cicatrici che rendono sempre più insopportabile la vita.
*Rubrica de Il Sole 24ore, 28/09/2020.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA ? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA !!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas") ?!
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Al di là della fede commerciale: la civiltà della cicogna (di Luigino Bruni).30 agosto 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra /22.
La civiltà della cicogna
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 29 agosto 2020)
- «I preti non possono accettare regali», disse don Paolo. La donna protestò: «Allora non vale», ella disse. «Se non accettate la gallina, la grazia non vale, e il bambino nascerà cieco». «La grazia è gratuita», disse don Paolo. «Le grazie gratuite non esistono», rispose la donna.
- Ignazio Silone, Vino e pane
Gratitudine è una parola essenziale. È parola prima nella famiglia, nelle comunità, meno nelle imprese moderne, dove la gratitudine con le sue parole gemelle riconoscenza e ringraziamento non trova lo spazio che meriterebbe a causa della sua fragilità. Gratitudine - da gratia, charis - è molto imparentata con il "grazie", una parola che impariamo dai genitori da bambini e che poi non esce più dai nostri rapporti. Anche quei "grazie" che diciamo, più volte al giorno, per rispetto delle norme sociali, portano qualche traccia della gratitudine, che però si manifesta più pienamente in altri "grazie", quelli attesi e desiderati, non pretesi. Sono quelli decisivi nei rapporti più importanti, quelle gratitudini delicate, più femminili che maschili, più sussurrate che dette, che arrivano nei momenti cruciali della vita. Il grazie di quel collega nell’ultimo giorno di lavoro, uguale e diverso da tutti gli altri, scritto nel biglietto con il regalo di addio. Quello dello studente con più difficoltà, che nell’ultimo giorno di scuola ti lascia sulla cattedra un post-it: "Grazie prof"; o quello che nel giorno della partenza da casa, per seguire una voce, non siamo riusciti a dire ai genitori perché rimasto strozzato in gola, e che poi molti anni dopo abbiamo scoperto essere simile a quei grazie ineffabili che vengono sussurrati ogni giorno nei capezzali.
Questa gratitudine ha nella gratuità la sua bellezza e il suo dramma. Non essendo un contratto, la gratitudine ha valore solo se gratuita (gratitudine e gratuità sono quasi la stessa parola). Ma contiene anche una dimensione di dovere e di obbligo. Perché se da una parte le qualità più preziose della gratitudine sono libertà e dono, dall’altra ci sono alcune gratitudini che quando mancano generano ingratitudine, una delle passioni più forti e portatrici di sofferenza. La gratitudine è infatti una forma della reciprocità (ri-ngraziare, ri-conoscenza), e quindi c’è in essa anche una dimensione di restituzione di qualcosa che si è avuto prima. La presenza dell’ingratitudine accanto alla riconoscenza rende il ringraziare un’esperienza complessa. Perché con la gratitudine siamo al centro della paradossale semantica del dono e della reciprocità, quindi di quelle emozioni e azioni che sono un intreccio di attese e pretese, libertà e obbligo, gratuito e doveroso. Non possiamo pretendere che prima del trasloco la vicina di casa ci inviti e ci dica grazie per le piante annaffiate per lei nelle molti estati passate, ma se non lo fa non siamo contenti, e quella ingratitudine rovina qualcosa d’importante in quel rapporto. E forse pochissimi aggettivi più di "ingrato" ci fanno male, se pronunciati dalle persone cui teniamo.
Come è vero che noi conosciamo veramente, riconosciamo le persone solo alla fine di un rapporto, quando si manifesta la loro capacità di riconoscenza - che a volte si estende anche oltre la vita: mi colpisce sempre vedere la fedeltà grata di molti e soprattutto molte donne che per anni, decenni, curano la tomba dei loro cari. Noi soffriamo molto per l’ingratitudine, anche perché c’è in ognuno la tendenza a sovrastimare il credito di riconoscenza nei confronti degli altri (e a sottostimare il proprio debito), e così siamo accompagnati da una costante sensazione di non essere ringraziati abbastanza. La gratitudine, poi, è un sentimento che ha bisogno della durata. Non nasce se non dentro rapporti stabili e durevoli. Si manifesta oggi ma è maturata ieri, e quindi è un esercizio della memoria: ricordando ciò che sei stato per me mi nasce ora in cuore la gratitudine. Ecco perché l’icona che accompagnava nell’antichità classica la raffigurazione della gratitudine era la cicogna, perché aveva fama leggendaria di prendersi cura dei genitori diventati vecchi.
La Bibbia insegna a coltivare ed esprimere la gratitudine anche verso Dio: «Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre» (Salmo 107,1). La comunità dei credenti è anche comunità di grati, perché comunità di salvati. Il Salmo 107 è infatti un canto di rendimento di grazie (ce ne sono molti nel Salterio) che nasce dall’esperienza della salvezza. Sono quattro i paradigmi di salvezza del salmo: dalla fame e sete («vagavano nel deserto su strade perdute... Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita»: 107,4-5), dalla prigione («Altri abitavano nelle tenebre e nell’ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ferri... perché ha spezzato le sbarre di ferro»: 10-16), da malattie mortali («rifiutavano ogni sorta di cibo e già toccavano le soglie della morte. Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li salvò dalle loro angosce»: 18-19), dai pericoli in mare: «Altri, che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque... La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare» (23-29). E dopo ogni scena, quattro volte il ritornello di ringraziamento: «Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini» (15). È l’esperienza concreta della salvezza che genera il rendimento di grazie, che fa fiorire la gratitudine. Una salvezza concreta, da mali del corpo, che ricorda le salvezze del Gesù storico, che mentre annunciava una salvezza spirituale liberava le persone da mali concreti, sfamava e guariva. La salvezza che produce gratitudine è sempre puntuale, è sempre una resurrezione concreta.
La salvezza, parola decisiva nella Bibbia e poi nel cristianesimo, ha molto a che fare con la dinamica paradossale della gratitudine. Da una parte, sul lato di Dio, è tutta dono, non è spiegabile dentro un registro di condizionalità, di do-ut-des. No: siamo salvati e basta. La salvezza non è guadagnata dalle nostre virtù e meriti - forse dal nostro grido: «Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li salvò dalle loro angosce» (107,13). La salvezza è risposta a un grido, ma non è risposta a un’azione che la giustifica: il grido è espressione di fede, e la giustificazione per quella salvezza è la fede (qui si vede, tra l’altro, quanto la teologia di san Paolo fosse ancorata nell’Antico Testamento). Ma è molto bello e consolante che in tutto questo Salmo gli uomini salvati non sono il popolo di Israele, non sono gli eletti: sono uomini e basta.
 Questa salvezza è universale: basta gridare - e forse lo facciamo troppo poco. Al tempo stesso la Bibbia chiede al salvato la riconoscenza, lo invita a ringraziare Dio per la salvezza. Sta qui un altro grande senso della preghiera: non si prega solo (né tanto) per ottenere la salvezza (il grido biblico è una strana forma di preghiera), ma si deve pregare soprattutto per ringraziare. Lo stesso Gesù si mostra sensibile alla gratitudine e all’ingratitudine. Spesso le persone hanno imparato a pregare per dire grazie: non avevano chiesto nulla, hanno sperimentato una salvezza, e hanno ringraziato. E da quel ringraziamento è nata la preghiera.
Questa salvezza è universale: basta gridare - e forse lo facciamo troppo poco. Al tempo stesso la Bibbia chiede al salvato la riconoscenza, lo invita a ringraziare Dio per la salvezza. Sta qui un altro grande senso della preghiera: non si prega solo (né tanto) per ottenere la salvezza (il grido biblico è una strana forma di preghiera), ma si deve pregare soprattutto per ringraziare. Lo stesso Gesù si mostra sensibile alla gratitudine e all’ingratitudine. Spesso le persone hanno imparato a pregare per dire grazie: non avevano chiesto nulla, hanno sperimentato una salvezza, e hanno ringraziato. E da quel ringraziamento è nata la preghiera.
 La nascita più bella, tutta gratuità, liberata da ogni residuo di fede commerciale.
La nascita più bella, tutta gratuità, liberata da ogni residuo di fede commerciale.È difficile restare nella gratitudine, è arduo rimanere nella condi-zione di chi ringrazia perché sa che ciò che possiede è tutto dono, che la salvezza che sperimenta ogni giorno è tutta gratuità. È difficile soprattutto per l’uomo di fede. Perché, una volta sperimentata una salvezza e imparata la gratitudine, negli uomini (meno nelle donne) nasce progressivamente e naturalmente l’esigenza di volersi meritare le salvezze future, di sentire che nella salvezza che ci arriva ogni mattina c’è anche qualcosa di nostro, che abbiamo contribuito anche noi, che c’è una quota di co-finanziamento in quel mutuo dal valore infinito che ci viene offerto, che quella misericordia, quell’amore fedele (hesed) un poco ce lo siamo meritato. Così l’esperienza dell’"essere salvati" si trasforma, poco alla volta e senza rendersene conto, nel "salvarsi". E ogni volta che il salvarsi ruba terreno all’essere salvati si riduce inevitabilmente il valore della gratitudine.
È umano, è umanissimo. Perché a noi uomini non piace dipendere interamente dalla gratuità degli altri, ci piace conquistarci con il nostro sudore e i nostri meriti le nostre salvezze, amiamo troppo quella reciprocità dove ci si alterna nei movimenti del dare e dell’avere. Anche perché abbiamo visto quanta ingiustizia ha prodotto la mancanza di reciprocità, quanta diseguaglianza, quanti poveri tenuti in una condizione di perenne sudditanza per il fatto di dipendere interamente dai loro padroni.
 L’idea di un Dio che ci dona tutto e da cui dipendiamo totalmente ha prodotto anche una teologia politica-economica che non ha certo aiutato i poveri a liberarsi dalla loro condizione di inferiorità, e una gratitudine sbagliata, unidirezionale e obbligatoria, che ha lasciato sull’Europa e sul mondo una sofferenza infinita. I riscatti dei popoli sono stati anche riscatti da queste teologie che avevano usato una certa idea di Dio per legittimare, sacralizzandole, strutture ingiuste di potere. Da qui il meraviglioso movimento civile, economico e politico che negli ultimi secoli ha voluto legare i diritti alla natura o a un patto sociale ugualitario originario, e gli stipendi al lavoro.
L’idea di un Dio che ci dona tutto e da cui dipendiamo totalmente ha prodotto anche una teologia politica-economica che non ha certo aiutato i poveri a liberarsi dalla loro condizione di inferiorità, e una gratitudine sbagliata, unidirezionale e obbligatoria, che ha lasciato sull’Europa e sul mondo una sofferenza infinita. I riscatti dei popoli sono stati anche riscatti da queste teologie che avevano usato una certa idea di Dio per legittimare, sacralizzandole, strutture ingiuste di potere. Da qui il meraviglioso movimento civile, economico e politico che negli ultimi secoli ha voluto legare i diritti alla natura o a un patto sociale ugualitario originario, e gli stipendi al lavoro.E mentre si svolgeva, e continua a svolgersi, questo grande movimento etico dei popoli, la Bibbia sta lì, fedele a se stessa, a ricordarci che queste logiche, essenziali e benedette nei rapporti inter-umani, non vanno applicate a Dio, che va tenuto al di sopra dai nostri meriti. Perché se manca un principio di gratuità assoluta nella fondazione della nostra vita a ricordarci che prima e dopo i meriti c’è un dono infinito, ogni meritocrazia diventa dittatura dei più forti sui deboli.
 Il Dio biblico non ci ama perché ce lo meritiamo - o perché ce lo meritiamo più degli altri - ma perché siamo, semplicemente, suoi figli e figlie, e la figliolanza non è una relazione meritocratica, nonostante le proteste del figlio maggiore della parabola. Dobbiamo ringraziare, è questo il nostro dovere, ma il nostro dire grazie oggi non è la pre-condizione meritoria per essere salvati domani: Dio ci salverebbe ancora anche se fossimo ingrati. Sapere e ricordare questa gratuità assoluta di Dio ci dice, poi, che da qualche parte del nostro essere, fatto a sua immagine, siamo più grandi della reciprocità, e anche noi, almeno una volta, possiamo amare chi non non se lo merita, possiamo amare un ingrato.
Il Dio biblico non ci ama perché ce lo meritiamo - o perché ce lo meritiamo più degli altri - ma perché siamo, semplicemente, suoi figli e figlie, e la figliolanza non è una relazione meritocratica, nonostante le proteste del figlio maggiore della parabola. Dobbiamo ringraziare, è questo il nostro dovere, ma il nostro dire grazie oggi non è la pre-condizione meritoria per essere salvati domani: Dio ci salverebbe ancora anche se fossimo ingrati. Sapere e ricordare questa gratuità assoluta di Dio ci dice, poi, che da qualche parte del nostro essere, fatto a sua immagine, siamo più grandi della reciprocità, e anche noi, almeno una volta, possiamo amare chi non non se lo merita, possiamo amare un ingrato.La cicogna è anche colei che ci porta i bambini. Le civiltà della cicogna sono quelle che hanno saputo tenere insieme la gratitudine verso i vecchi e l’amore per i bambini. Questo lo sapeva bene il Quarto comandamento, che associa l’onora il padre e la madre al "prolungamento dei nostri giorni sulla terra". Solo i bambini sanno allungarci la vita.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- LA COSTITUZIONE "PASTOR AETERNUS" E DUE DOGMI. Il primato del Papa e l’infallibilità (di Filippo Rizzi).19 luglio 2020, di Federico La Sala
Chiesa.
Il primato del Papa e l’infallibilità, i due dogmi compiono 150 anni
Approvati dal Concilio Vaticano I, affrontano temi dibattuti per secoli. Lo storico Fantappiè: una scelta per ribadire la sovranità spirituale della Chiesa. Il Vaticano II aprirà poi alla collegialità
di Filippo Rizzi (Avvenire, sabato 18 luglio 2020)
- [Foto] Il Concilio Vaticano I - Dipinto
Era il 18 luglio 1870, esattamente centocinquanta anni fa, quando veniva promulgata la Costituzione Pastor Aeternus approvata dal Concilio Vaticano I. Con questa Costituzione il Concilio presieduto dal futuro beato il papa Pio IX ha definito due dogmi della Chiesa cattolica: il primato di giurisdizione del Vescovo di Roma e l’infallibilità papale. Un evento di portata storica che suscitò reazioni fortissime sia all’esterno sia in alcuni settori della Chiesa, provocando lo scisma dei “vecchi cattolici”.
Il documento venne approvato due mesi prima della fine del potere temporale dei Papi che avvenne con l’ingresso delle truppe piemontesi a Porta Pia a Roma.
A giudizio di Carlo Fantappiè, docente di storia del diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, il testo conciliare «rappresentò il coronamento di un processo di verticalizzazione interna alla Chiesa, dall’età gregoriana al Concilio di Trento, dopo la sconfitta delle tesi conciliariste intorno al primato del Concilio sul Papa e la consacrazione delle sue prerogative magisteriali dopo secolari discussioni intorno alla infallibilità del Papa».
Infatti, se fin dai primi secoli fu riconosciuto il ruolo del Vescovo di Roma come «custode della fede», nell’età moderna, prima Lutero e i riformatori, poi i gallicani e i giansenisti, tentarono più volte di negare o di limitare l’infallibilità papale.
Il professore che è anche ordinario di diritto canonico all’Università Roma Tre si sofferma sul legame stretto che si venne a creare nel corso dell’Ottocento fra l’affermazione del potere assoluto di governo del Papa nella Chiesa, sollecitato dalle correnti ultramontane e dal pensiero controrivoluzionario di De Maistre, e la formazione della sovranità negli Stati-nazione.
«Il conflitto fra Stati e Chiesa romana si venne a focalizzare sul problema della sovranità e dell’appartenenza dei fedeli alla Chiesa o alla nazione. Pio IX volle affermare la sovranità spirituale della Chiesa con i due dogmi del Vaticano I contro la sovranità temporale degli Stati che assoggettavano le strutture della Chiesa ai poteri secolari e minacciavano lo Stato pontificio».
 In questo secolo e mezzo si è avvalso della prerogativa dell’infallibilità papale Pio XII per la proclamazione nel 1950 del dogma dell’Assunzione della Vergine in anima e corpo in Cielo.
In questo secolo e mezzo si è avvalso della prerogativa dell’infallibilità papale Pio XII per la proclamazione nel 1950 del dogma dell’Assunzione della Vergine in anima e corpo in Cielo.Fantappié si sofferma su alcuni aspetti della Pastor Aeternus che, visti con gli occhi di oggi, possono apparire controversi. «Il testo definitivo che noi conosciamo - spiega - è concentrato sulle prerogative del Papa. In verità si pensava di elaborare una seconda Costituzione che completasse gli aspetti mancanti ma, a causa della sospensione del Vaticano I, ciò non fu possibile.
Anche per questo il Vaticano I fu un “Concilio monco”. In questa Costituzione avviene un sbilanciamento dottrinale a favore delle funzioni e dei poteri del Vescovo di Roma mentre vengono sottaciuti i diritti e le prerogative dell’episcopato come la partecipazione della “comunità dei fedeli” all’elaborazione del magistero e della vita della Chiesa. Per la verità diversi padri conciliari si resero conto di questo “sbilanciamento”. Una lacuna che sarà colmata cento anni dopo solo con il Vaticano II».
Inoltre osserva: «I padri conciliari ebbero l’avvertenza di restringere le prerogative del Pontefice quando egli parla “ex cathedra” nella sua veste di “pastore e dottore di tutti i cristiani” in materia di fede e di costumi, cioè lasciando lo spazio all’idea che anche un Papa quando esprime una semplice opinione può errare....». Bisogna distinguere infatti fra infallibilità e inerranza.
Fantappié legge soprattutto il filo rosso di continuità «non solo ideale di magistero» che i successori di Pio IX (in particolare Giovanni XXIII e Paolo VI, «entrambi grandi estimatori di papa Giovanni Maria Mastai Ferretti») hanno intravisto nel Vaticano II come «il completamento di ciò che non fu possibile realizzare durante l’assise conciliare del 1869-1870».
Di qui la riflessione finale: «In un certo senso lo stesso cardinale e oggi santo John Henry Newman comprese prima di altri che ogni Concilio, incluso il Vaticano I, doveva essere letto alla luce di quelli precedenti. Egli era convinto che, proprio perché il Vaticano I fu oggetto di “grandi opposizioni e prove” a livello di discussioni teologiche, avesse avuto bisogno di un riassetto e di un riequilibrio che ridefinisse quelle verità di fede che rimanevano valide. E cento anni dopo il suo auspicio fu esaudito con il Vaticano II. Per questo Newman per le sue intuizioni è considerato tra i migliori ermeneuti del Vaticano I e il precursore, secondo Jean Guitton, del Concilio successivo».
Leggi anche
-
> DIO AMORE, MAMMONA (DANARO), E COERENZA --- Evasori fiscali, non si tradiscono così Dio e la nazione (Lettera di Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea).9 luglio 2020, di Federico La Sala
Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio... *
Un vescovo emerito scrive.
Evasori fiscali, non si tradiscono così Dio e la nazione
di Luigi Bettazzi (Avvenire, mercoledì 8 luglio 2020)
Egregi evasori fiscali,
(e-gregio vuol dire infatti "fuori, al di sopra del gregge", della gente comune) da vescovo più giovane e da presidente di Pax Christi, Movimento internazionale per la pace, m’era venuto di scrivere ai politici del tempo - ad esempio al democristiano Benigno Zaccagnini e al comunista Enrico Berlinguer - invitandoli a essere coerenti con le loro scelte politiche e convergenti al bene della nazione, ora, al termine della mia vita (ho ormai più di 96 anni), mi viene di scrivere una lettera a voi.
La pandemia che stiamo vivendo ci ha obbligati a vivere più ritirati, quindi più pensosi per la nostra vita personale e per il bene della collettività. Ed è così, ad esempio, che ci siamo resi conto del lavoro delle varie mafie che, attente a evitare situazioni più clamorose, come quelle che finiscono in uccisioni e stragi, sfruttano la situazione per aumentare le loro ricchezze, ad esempio con prestiti a usura a chi non riesce a trovare mezzi legali per sovvenire alla mancanza di danaro causata dalla limitazione del lavoro o dalla sua perdita. Al contrario, v’è chi arriva a frodare per avere sovvenzioni a cui non ha diritto.
Questo ci ha fatto pensare come le limitazioni, sia del sistema sanitario antecedente come dei provvedimenti per arginare l’espandersi della pandemia e frenare le crisi dell’industria e delle aziende, derivi anche dalle minori disponibilità economiche dovute anche a quanto viene evaso da chi non paga le tasse, soprattutto di chi, con la ricchezza, riesce a trovare i mezzi per portare i suoi beni nei cosiddetti paradisi fiscali. Questa è una grossa ingiustizia perché quanto viene portato fuori dalla nazione è stato raggranellato con il lavoro dei concittadini e utilizzando le leggi (e le sottigliezze) dello Stato. È triste pensare che la nazione vi abbia fatti crescere e sviluppare fino al punto di poterla tradire.
Non voglio pensare che tra voi ci siano quelli che formalmente figurano come rispettosi - o addirittura partecipi attivi - del cristianesimo che ha accompagnato la storia della nostra nazione, ma poi trasgrediscono il suo messaggio fondamentale, che è quello di non chiudersi nel proprio egoismo, ma di aprirsi agli altri, proprio cominciando dai più piccoli, dai più poveri, dai più emarginati.
 Così fanno i boss delle varie mafie, che poi a copertura delle loro violenze proteggono le devozioni popolari e se ne fanno riverire, o quei politici che nel mondo ostentano oggetti e proteggono frange di strutture religiose per coprire le loro minori attenzioni umane. Non vorrei che anche voi, magari sovvenendo pubblicamente alcune opere di solidarietà, vogliate così "scontare" la vostra ingiustizia di fondo.
Così fanno i boss delle varie mafie, che poi a copertura delle loro violenze proteggono le devozioni popolari e se ne fanno riverire, o quei politici che nel mondo ostentano oggetti e proteggono frange di strutture religiose per coprire le loro minori attenzioni umane. Non vorrei che anche voi, magari sovvenendo pubblicamente alcune opere di solidarietà, vogliate così "scontare" la vostra ingiustizia di fondo.È vero che alle volte, nel mondo, le tassazioni possono sembrare eccessive o ingiuste. Ma, in democrazia, si devono trovare i mezzi, soprattutto da parte dei più abbienti come siete voi, per correggerle, non per avere un pretesto per evaderle, portando il proprio danaro negli... inferni fiscali.
 Perché purtroppo il danaro diventa quasi una divinità, anzi la vera alternativa a Dio: aveva già detto chiaramente Gesù (usando un termine locale) che non si possono servire due padroni: o Dio o mammona (il danaro).
Perché purtroppo il danaro diventa quasi una divinità, anzi la vera alternativa a Dio: aveva già detto chiaramente Gesù (usando un termine locale) che non si possono servire due padroni: o Dio o mammona (il danaro).Non so se anche qualche parroco vi ha mai detto che l’evasione fiscale è peccato mortale: l’ha detto qualche tempo fa laicamente Romano Prodi, ve lo ripete oggi un vescovo, anche se emerito. Mi verrebbe da ripetere la frase forte che san Giovanni Paolo II proclamò, nella valle di Agrigento, contro le mafie: "Convertitevi! Un giorno dovrete risponderne di fronte a Dio". E allora non ci saranno pretesti e coperture.
Vi chiedo scusa se vi ho attaccati pubblicamente. Spero comunque di avervi fatto pensare.
Da vescovo, pregherò per voi, per le vostre famiglie e per le vostre attività, ovviamente purché siano oneste.
Vescovo emerito di Ivrea
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio ... un cattolicesimo che ha sempre confuso "Erode" con Cesare e Dio con "Mammona" !!!
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
VIVA L’ITALIA !!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
Federico La Sala
-
>MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Mistica cristiana: le nozze di eros e caritas (di Rosita Copioli - "Avvenire").6 luglio 2020, di Federico La Sala
Uscire dal letargo "teologico" e "filologico" e dalla notte «in cui tutte le vacche sono nere»! La mistica dell’Amore (Deus charitas est), o quella di "Mammasantissima" e di "Mammona" ("Deus caritas est")?! *
- CHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád.
- Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729)
Spiritualità.
Mistica cristiana: le nozze di eros e caritas
I Meridiani pubblicano il primo di tre volumi dedicati alla mistica cristiana. L’incontro con Dio supera ogni limite, fisico e linguistico, e si configura come esperienza sensibile di un amore totale
di Rosita Copioli (Avvenire, mercoledì 1 luglio 2020)
La Mistica Cristiana (Mondadori, I Meridiani, pagine. LXXXVIII+1624, euro 70,00), è il primo dei tre volumi di una vastissima opera - estesa dalle origini ai nostri giorni - ideata dieci anni fa e curata da Francesco Zambon, su ’impulso’ di Pietro Citati. Questo libro, curato da Zambon con Marco Rizzi, Sabino Chialà, Boghos Levon Zekiyan, comprende la mistica tardogreca e bizantina, siriaca, armena, latina e italiana medievale; il secondo volume presenterà la mistica tedesca e fiamminga, francese, italiana moderna; il terzo la mistica iberica (spagnola, portoghese e catalana), inglese e americana, russa, svedese. Nessun progetto ha avuto la medesima ampiezza, né pari cura filologica e critica: nemmeno i Mistici occidentali curati da Elémire Zolla; e altre pregevoli sillogi sono parziali.
Le radici sono ebraiche - nel Cantico dei Cantici, il testo più ardente e complesso dell’amore umano e divino - e greche: nel Fedro e nel Simposio di Platone, dove la ricerca della conoscenza diviene quella del bene e del bello, l’intelletto sale verso il divino: la mente si unisce allo slancio erotico, la mania che porta all’estasi: invasa da una luce alla quale tenderà tutta la tradizione occidentale fino al Rinascimento, e oltre: da Plotino, per il quale la contemplazione è superiore all’azione poiché permette la visione del vero, a Proclo; da Apuleio a Tasso, i poeti barocchi, i romantici, Yeats, Ungaretti, Luzi, Milosz.
La potenza della vista interiore è previsione e profezia. Lo afferma già Esiodo, e poi Saffo e Platone, seguiti da sant’Agostino e Dante: il poeta sprofonda nella memoria bevendo l’acqua di vita di Oceano, e lascia che il soffio del dio spiri dentro di lui, investendolo del suo nume sconvolgente. «Entra nel petto mio, e spira tue / sì come quando Marsia traesti / de la vagina de le membra sue». È il solo modo per riceverne il barlume, per glorificarlo: «O divina virtù, se mi ti presti / tanto che l’ombra del beato regno / segnata nel mio capo io manifesti».
 Il mistico ricapitola ogni passaggio del Verbo incarnato e dello Spirito Santo che permette - osano i più temerari - di diventare Dio, trascinando con sé l’intera creazione. La trasfigurazione, la passione, la morte sulla croce di Gesù, il suo corpo martoriato sono lo strumento-specchio per rivivere Gesù in anima-spirito-corpo, oltrepassando i ’sensi spirituali’. Francesco nutre nelle viscere il sole - Cristo. Dalle mani e dai piedi spuntano chiodi di carne, sul costato si apre la ferita di Cristo.
Il mistico ricapitola ogni passaggio del Verbo incarnato e dello Spirito Santo che permette - osano i più temerari - di diventare Dio, trascinando con sé l’intera creazione. La trasfigurazione, la passione, la morte sulla croce di Gesù, il suo corpo martoriato sono lo strumento-specchio per rivivere Gesù in anima-spirito-corpo, oltrepassando i ’sensi spirituali’. Francesco nutre nelle viscere il sole - Cristo. Dalle mani e dai piedi spuntano chiodi di carne, sul costato si apre la ferita di Cristo.
 Angela da Foligno aderisce al Crocifisso con i sensi dell’eros totale: «Tu sei me e io sono te». La mente di Iacopone da Todi, «En Cristo trasformata, è quasi Cristo, /cun Deo conionta tutta sta devina». Chi osa tanto, non teme la sintassi, scardina ogni figura e senso. Se fa miracoli, sfida la gravità e si innalza dal suolo, come Doucelina di Digne, altri aboliscono gli intermediari con Dio nel linguaggio, come Caterina Fieschi: «Il mio Mi è Dio, io non conosco altro Mi che esso Dio mio».
Angela da Foligno aderisce al Crocifisso con i sensi dell’eros totale: «Tu sei me e io sono te». La mente di Iacopone da Todi, «En Cristo trasformata, è quasi Cristo, /cun Deo conionta tutta sta devina». Chi osa tanto, non teme la sintassi, scardina ogni figura e senso. Se fa miracoli, sfida la gravità e si innalza dal suolo, come Doucelina di Digne, altri aboliscono gli intermediari con Dio nel linguaggio, come Caterina Fieschi: «Il mio Mi è Dio, io non conosco altro Mi che esso Dio mio».I mistici non hanno paura di niente, né del pudore, né di “ardiri” che il volgo deride: come i patriarchi della Bibbia, variano la metafora del latte della sapienza, con una passione tenerissima. Nel II secolo in Siria, un’Ode di Salomone, e Clemente Alessandrino suggono i seni del Padre e le dolci mammelle di sposa di Gesù; nel X secolo Gregorio di Narek, autore di inni inarrivabili al Cristo glorioso, invoca «comunione che distilla latte»: siamo in Armenia, dove la teologia del sacerdozio di tutti i fedeli - i corpi sono templi e altari - renderà possibile il sacrificio dell’intero popolo: il “Martirio armeno”. Misakh Metzarents (1886-1908) ne è l’ultimo fiore: «Nella notte discende ancora il ruscello di luce, / una goccia di latte della tua santità divenuta un mare; / e vedi, o Madre di Dio, ecco sto diventando bambino».
Come diceva san Tommaso d’Aquino, la mistica è la Cognitio Dei experimentalis, che Jean Gerson esplica: «Theologia mistica est cognitio experimentalis habita de Deo per amoris unitivi complexum». Ma è la più abissale delle imprese gnoseologiche e amorose. Per la “teognosia” dell’ombra, che deriva da Plotino e si distanzia da seguaci di Gesù come Giovanni e Paolo, e Agostino, mai giungeremo a conoscere Dio. La sua trascendenza rispetto a ciò che è, e all’essere stesso, è superessentialis: Dio non può essere conosciuto, descritto, visto, nemmeno dagli angeli e dai santi. Di Dio non si può parlare né in forma positiva, né in forma negativa. Ma la forma negativa si avvicina di più al suo mistero. Lo si contempla tra luce e tenebra.
Scrive Zambon: «Anche nella vita beata, al termine del reditus di tutta la creazione nel seno del Verbo, Dio sarà conoscibile solo attraverso delle mediazioni, delle teofanie (in greco, “manifestazioni, immagini di Dio”)». La teofania segue i gradi della contemplazione, della deificazione (theosis), e coincide con l’unione mistica. Ricorre alle immagini, al loro fantasma, alla fantasia: l’“alta fantasia” di Dante. La docta ignorantia fa apparire Chi è superiore alla Luce come tenebra, caligine, nube: nella “notte oscura” di Giovanni della Croce.
Una rivoluzione accade in pieno XII secolo: Guglielmo di Saint-Thierry, Bernardo di Clairvaux, Aelredo di Rievaulx, Ivo, e Riccardo di San Vittore (di cui Zambon ha curato sapientemente i Trattati d’amore cristiani del XII secolo per Valla Mondadori) mostrano a quale fuoco di trasformazione può accendersi l’intelletto d’amore che guida fino a Dio, intrecciando eros platonico e caritas paolina. Come in Ildegarda di Bingen, il grande impeto d’amore dà le ali. Culminano la poesia della fin’amor dei trovatori, le storie di Tristano e Isotta, il romanzo cortese.
 Con Beatrice davanti alla candida rosa dei beati, Bernardo invita Dante a fissare Dio, nel movimento rapidissimo che imprime al creato e a noi: la metamorfosi dell’anima in Dio, l’excessus mentis, avviene per opera divina in un solo istante: «ma già volgeva il mio disio e ’l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle». Riccardo di San Vittore è il più ardito. Amore terreno e carità hanno la stessa fonte, ma la carità non è mite. Ha la stessa struttura, manifestazioni e gradi della passione violenta. I Quattro gradi della violenta carità gridano in Iacopone da Todi: «Amor de caritate, perché m’ài ssì feruto? / Lo cor tutt’ho partuto, et arde per amore».
Con Beatrice davanti alla candida rosa dei beati, Bernardo invita Dante a fissare Dio, nel movimento rapidissimo che imprime al creato e a noi: la metamorfosi dell’anima in Dio, l’excessus mentis, avviene per opera divina in un solo istante: «ma già volgeva il mio disio e ’l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle». Riccardo di San Vittore è il più ardito. Amore terreno e carità hanno la stessa fonte, ma la carità non è mite. Ha la stessa struttura, manifestazioni e gradi della passione violenta. I Quattro gradi della violenta carità gridano in Iacopone da Todi: «Amor de caritate, perché m’ài ssì feruto? / Lo cor tutt’ho partuto, et arde per amore».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus !!! O, meglio, che progetto!!!
Federico La Sala
-
>MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? - FILOLOGIA E "ANDROLOGIA"?! "UN UOMO, TUTTI GLI UOMINI". SARA’ UN "NOI" A SALVARCI?!27 giugno 2020, di Federico La Sala
FILOLOGIA E "ANDROLOGIA". DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE: "UN UOMO, TUTTI GLI UOMINI"?! *
- MEMORIA DI PONZIO PILATO. Nella lingua di Roma (come nella lingua di Atene), L’«ECCE HOMO» ha significato antropologico (non "andrologico" - limitato all’«omuncolo» di qualche "uomo supremo" o “superuomo”!):
- PONZIO PILATO «disse loro : "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro : "«Ecco l’uomo» (gr. « idou ho anthropos », vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi ! Crocifiggi!" Disse loro Pilato : "Prendetelo voi e crocifiggetelo ; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei : "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
La raccolta.
Ivano Dionigi tra parola, vita e smarrimenti
Uno sguardo sul nostro tempo e le sue emergenze partendo dalla lettura dei classici e dei testi biblici. Un estratto dall’ultimo libro di Dionigi che trae linfa dalla rubrica “Tu quis es” per Avvenire
di Ivano Dionigi (Avvenire, giovedì 25 giugno 2020)
- Con la prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi e un’ampia premessa dello stesso autore (dalla quale abbiamo tratto il significativo stralcio che introduce i testi qui anticipati), Raffaello Cortina manda in libreria Parole che allungano la vita. Pensieri per il nostro tempo, il libro di Ivano Dionigi (pagine 112, euro 12,00) che raccoglie, con l’aggiunta di inediti, i brani pubblicati fra gennaio e marzo 2020 su “Avvenire” nella rubrica di prima pagina “Tu quis es”. Uno sguardo sulla quotidianità, nei giorni che in Italia e in Europa hanno aperto la crisi della pandemia, attraverso l’esperienza della classici greci e latini.
La parola, lógos per i Greci, verbum per i Latini, è il miracolo per cui l’uomo da creatura diventa creatore: essa può affascinare (delectare), insegnare (docere), mobilitare le coscienze (movere). La parola può unire e dividere, consolare e affannare, salvare e uccidere. Non solo custodisce e veicola il pensiero, ma lo genera. La Parola divina, quel Logos con cui si aprono l’Antico e il Nuovo Testamento: la Genesi («In principio Dio disse») e il Vangelo di Giovanni («In principio era la Parola»). Il lógos di Eraclito: «così profondo che della sua anima, per quanto tu possa camminare e neppure percorrendo intera la via, mai potresti trovare i confini». La parola che con Gorgia tutto può: «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione ». La parola della “democratica” Atene, che uccise Socrate prima e più della cicuta.
 La parola che, usata male, secondo Platone oltre a essere una cosa brutta in sé fa male anche all’anima. La parola che con Aristotele ci caratterizza come uomini distinguendoci dagli animali. La parola che con Cicerone salva la res publica, se prerogativa degli eloquentes e sapientes; la manda in rovina, se prerogativa dei disertissimi homines, i demagoghi. La parola della ragione di Lucrezio, l’arma più efficace per debellare i nemici interiori della cupido e del timor. La parola terapeutica di Seneca che interiorizza e consola. La parola che con l’apostolo Giacomo ora benedice ora maledice. La parola che con Elias Canetti si fa antidoto alla guerra. La parola che con don Milani diviene «la chiave fatata che apre ogni porta». La parola che con Mario Luzi «vola alta» e profonda, e «tocca nadir e zenith».
La parola che, usata male, secondo Platone oltre a essere una cosa brutta in sé fa male anche all’anima. La parola che con Aristotele ci caratterizza come uomini distinguendoci dagli animali. La parola che con Cicerone salva la res publica, se prerogativa degli eloquentes e sapientes; la manda in rovina, se prerogativa dei disertissimi homines, i demagoghi. La parola della ragione di Lucrezio, l’arma più efficace per debellare i nemici interiori della cupido e del timor. La parola terapeutica di Seneca che interiorizza e consola. La parola che con l’apostolo Giacomo ora benedice ora maledice. La parola che con Elias Canetti si fa antidoto alla guerra. La parola che con don Milani diviene «la chiave fatata che apre ogni porta». La parola che con Mario Luzi «vola alta» e profonda, e «tocca nadir e zenith».
 Questa parola oggi non gode di buona salute: ridotta a chiacchiera e barattata come merce qualunque, ci chiede di abbassare il volume, di ricongiungerla alle cose, di imboccare la strada del rigore. Soprattutto in questo tempo di calamità, in cui ci apprestiamo a un lungo esodo e alla traversata del deserto, le parole note suonano inadeguate se non improprie. -Abbiamo bisogno di parole nuove per nominare questo presente imprevisto, inaudito, alieno. Uguale, eppure così frantumato; estraneo, eppure così invadente attorno a noi e dentro di noi.
Questa parola oggi non gode di buona salute: ridotta a chiacchiera e barattata come merce qualunque, ci chiede di abbassare il volume, di ricongiungerla alle cose, di imboccare la strada del rigore. Soprattutto in questo tempo di calamità, in cui ci apprestiamo a un lungo esodo e alla traversata del deserto, le parole note suonano inadeguate se non improprie. -Abbiamo bisogno di parole nuove per nominare questo presente imprevisto, inaudito, alieno. Uguale, eppure così frantumato; estraneo, eppure così invadente attorno a noi e dentro di noi.Orfeo e Euridice
A Orfeo è concesso di riportare la dolce sposa dall’Ade sulla terra a patto di non girarsi a guardarla. Ma, racconta Virgilio (Georgiche, 4, 485 sgg.), lo sprovveduto amante uscendo dagli Inferi viene preso dalla follia d’amore e viola i patti (rupta foedera): «Quale furia d’amore ha portato me misera, ha portato te Orfeo, alla perdizione? » (4, 494 sg.: Quis et me [...] miseram et te perdidit, Orpheu, / quis tantus furor?), grida Euridice quando Orfeo si volta a guardarla. «Muto e impaziente» Orfeo, «mite nella sua pazienza» Euridice, dirà Rilke. Non è forse vero che non bisogna amarla troppo questa vita per non perderla? Come non è forse vero che non bisogna attaccarsi troppo a una persona per non soffocarla?
 Se non sopportiamo il peso della privazione, il prezzo dell’attesa, il páthos della distanza, perdiamo coloro che amiamo e perdiamo noi stessi. Restiamo agli Inferi: nell’Inferno della nostra identità. Questa favola vale per la scuola come per la vita. -Penso al nostro modo di leggere i classici, oscillante fra due estremi malsani: o non cogliamo le interrogazioni dei testi e li consideriamo come fossili, muti, inanimati, cadaverici, oppure vi sovrapponiamo le nostre domande e li riduciamo a pretesti per le nostre ragioni. Non abbiamo forse pietrificato i classici tutte le volte che, affetti da miopia e incapaci di resistere all’impazienza e all’illusione del possesso, abbiamo anteposto le ragioni della vicinanza e della presenza, incuranti di ogni distanza passata e futura?
Se non sopportiamo il peso della privazione, il prezzo dell’attesa, il páthos della distanza, perdiamo coloro che amiamo e perdiamo noi stessi. Restiamo agli Inferi: nell’Inferno della nostra identità. Questa favola vale per la scuola come per la vita. -Penso al nostro modo di leggere i classici, oscillante fra due estremi malsani: o non cogliamo le interrogazioni dei testi e li consideriamo come fossili, muti, inanimati, cadaverici, oppure vi sovrapponiamo le nostre domande e li riduciamo a pretesti per le nostre ragioni. Non abbiamo forse pietrificato i classici tutte le volte che, affetti da miopia e incapaci di resistere all’impazienza e all’illusione del possesso, abbiamo anteposto le ragioni della vicinanza e della presenza, incuranti di ogni distanza passata e futura?Parole per noi
Negata anche la pietas: non si può abbracciare né chi nasce né chi muore. Catastrofe, inferno, tragedia sono le parole giuste per questi giorni. Va pensata la genesi dopo l’apocalisse: la scienza medica deve curare e guarire, la politica provvedere e prevedere, con l’auspicio che i tanti eurobond siano affiancati da altrettanti neurobond. Avremo bisogno di Mosè, di tanti Mosè che ci guidino nella traversata del deserto. Non è l’ora delle nostre parole che suonano inutili o inopportune. Altro timbro possiedono le parole di coloro che hanno scritto per noi e di noi, che resistono al tempo e alle mode. Ci ricordano con il Prometeo di Eschilo e l’Antigone di Sofocle che l’uomo ha posto rimedio a tutti i mali ma non al suo destino mortale; con il Platone della Repubblica, che non si possono privatizzare i beni materiali ma neppure i sentimenti quali la gioia e il dolore, e che nella città al vertice dell’istruzione deve sedere il migliore; con l’Aristotele della Politica, che l’uomo dotato di norme civili e di senso del giusto è la migliore delle creature; con Lucrezio, che solo la scienza può rimuovere la paura, frutto dell’ignoranza e causa di tutti i mali; con Virgilio, che i vecchi valgono non meno dei giovani; con Seneca, che è cosa diversa vivere (vivere) dallo stare al mondo (esse); con Marco Aurelio, che ognuno di noi vale quanto la causa per cui lotta; con Agostino, che la qualità dei tempi dipende da quella degli uomini (Sermoni, 80, 8: Nos sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora).
Lucrezio lo aveva detto
La storia ama non solo sorprendere ma anche ripetersi. Si vada alla peste di Atene (430 a.C.) descritta da Lucrezio nel finale del suo poema: vi si troveranno consonanze raggelanti con i nostri giorni. Sotto scacco, la medicina allora mostrava tutta la sua incertezza e impotenza: silenziosa e timorosa esitava e balbettava (6, 1179: Mussabat tacito medicina timore). Parimenti disarmata e svilita la religione (vv. 1276-1277: Nec iam religio divum nec numina magni / pendebantur): i templi stipati di cadaveri accatastati (vv. 1272-1273: omnia sancta deum delubra replerat / corporibus mors) e impediti in città perfino i riti della sepoltura (v. 1278: nec mos ille sepulturae remanebat in urbe). Anche la pietà parentale era messa a dura prova: quanti erano accorsi al capezzale dei loro cari, incorrevano nel contagio (v. 1243: Qui fuerant autem praesto, contagibus ibant) e quanti si rifiutavano di portare soccorso morivano soli e abbandonati (vv. 1239 sgg.: Nam quicumque suos fugitabant visere ad aegros / [...] / poenibat [...] / desertos, opis expertis, incuria mactans).
 Con i nostri occhi li abbiamo visti i medici supplire con la compassione alla carenza di terapie; le abbiamo viste le chiese diventate cimiteri, piazza San Pietro deserta e il Papa, solo, a testimoniare non la potenza del rito ma la passione della croce; li abbiamo visti negli ospedali i mariti separati dalle mogli, i fratelli dai fratelli, gli amici dagli amici. E morire senza potere prendersi la mano e neppure salutarsi.
Con i nostri occhi li abbiamo visti i medici supplire con la compassione alla carenza di terapie; le abbiamo viste le chiese diventate cimiteri, piazza San Pietro deserta e il Papa, solo, a testimoniare non la potenza del rito ma la passione della croce; li abbiamo visti negli ospedali i mariti separati dalle mogli, i fratelli dai fratelli, gli amici dagli amici. E morire senza potere prendersi la mano e neppure salutarsi.Un uomo, tutti gli uomini
I rimedi per la ricostruzione del Paese dovranno essere proporzionati ai danni: incalcolabili. Ci vorranno braccia e menti, e una duplice chiamata: da un lato, quella dei migliori cervelli, in seduta permanente in una sorta di “cern” politico, economico, sociale, culturale per progettare il futuro; dall’altro, quella dei ventenni, perché siano i protagonisti della rinascita. Arrivati in un mondo fatto su misura dei loro padri, dovranno ora costruirne uno per i loro figli. A nulla valgono le retoriche consolatorie di questi giorni: il ricorso al patriottismo d’occasione, l’enfasi sull’eroismo dei medici oggi sull’altare e domani di nuovo nella polvere, l’illusione che ne usciremo migliori. I retti saranno ancora retti, gli acuti torneranno acuti, e gli ottusi resteranno ottusi. Più facile prevedere un indurimento degli animi, un ulteriore divario fra chi ha e chi non ha, un ripopolamento di umiliati e gregari che al riconoscimento delle istituzioni e alla rivendicazione dei diritti preferiranno panem et circenses. Avremo imparato che il mondo non è in equilibrio economico, ambientale, sanitario? Che sapere e potere, competenza e politica, cultura e amministrazione sono inseparabili? Che sarà il pronome noi a salvarci? Ce lo ricorda Borges: «Ciò che fa un uomo è come se lo facessero tutti gli uomini. Per questo non è ingiusto che una disobbedienza in un giardino contamini il genere umano; per questo non è ingiusto che la crocifissione di un solo giudeo basti a salvarlo» (La forma della spada).
*
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE. Da Giovanni Pico della Mirandola* a Herbert Marcuse** e ...
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.FLS
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- MONACI “BRASILIANI” NELLA TERRA DELLA “TRECCANI” (MA NON NELLA TERRA D’OTRANTO)! Filologia e civiltà.26 giugno 2020, di Federico La Sala
MONACI “BRASILIANI” NELLA TERRA DELLA “TRECCANI” (MA NON NELLA TERRA D’OTRANTO)! Filologia e civiltà...
di Federico La Sala *
ALLA LUCE DELLA PRESENTE STORICA SITUAZIONE, ricordando il recente intervento del prof. Armando Polito dal titolo “Quando l’Amazzonia era vicina a noi, ma c’è speranza...” e della mia nota su L’EUROPA E LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE (Fondazione Terra d’Otranto, 28/29 maggio 2020), sottoscrivo la sua “Lettera aperta a Massimo Bray,titolare del Mibac1″(Fondazione Terra d’Otranto, 26 maggio 2013) e rinnovo la sua costituzionale sollecitazione a non alimentare la già iperbolica diffusione di “fake news” e a correggere l’involontario refuso tecnologico.
PER LA STORIA E LA MEMORIA DELLA TERRA D’OTRANTO, non è più sopportabile che nella scheda relativa a Cesare Maccari ("Dizionario Biografico degli Italiani" - Treccani ) si legga e si continui a leggere che “Nel 1895 [...] fu incaricato da monsignor G. Ricciardi, vescovo di Nardò, di affrescare la cattedrale di S. Maria de Nerito [...] Il programma iconografico, dettato dal committente, era dedicato alla storia della salvezza dell’uomo e agli episodi locali del Trasporto delle reliquie di s. Gregorio Armeno, protettore della città, da parte dei monaci *BRASILIANI* e del Miracolo del crocifisso nero”! O no?!
*
-
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA! -- IL DESTINO DI ROMA. L’impero romano tra cambiamenti climatici e pestilenze. un libro dello storico statunitense Kyle Harper.16 aprile 2020, di Federico La Sala
L’impero romano tra cambiamenti climatici e pestilenze
In un libro dello storico statunitense Kyle Harper
di Gabriele Nicolò (L’Osservatore Romano, 15 aprile 2020)
Si racconta che uno storico tedesco abbia addotto duecentodieci motivi per spiegare il crollo dell’impero romano. Molto più parco è lo storico statunitense Kyle Harper che nel libro Il destino di Roma. Clima, epidemie e la fine di un impero (Torino, Einaudi, 2019, pagine 520, euro 34) di cause - a parte quelle “istituzionali” legate sia alle farraginose dinamiche della ormai fatiscente struttura governativa che al logorio dell’esercito e delle forze di combattimento in generale - ne individua due: i cambiamenti climatici e le pestilenze. Vale a dire, due cause che rivestono, evidentemente, un valore di attualità sorprendente e disarmante.
È vero che Giulio Cesare si vantava che i suoi soldati erano così vigorosi nel fisico che potevano resistere sia ai rigori dell’inverno che ai torridi raggi del sole d’estate, ma è altrettanto vero - rileva lo storico statunitense in un’intervista al settimanale francese «Nouvelle Observateur» - che i bruschi cambiamenti del clima, attestati tra l’altro da numerosi documenti d’epoca, con graduale e non arginata pressione finirono per incidere profondamente sulla popolazione dell’impero, e in particolare sulla psiche dei soldati, resi più vulnerabili dalle continue privazioni, inevitabile prezzo da pagare in una vita spesa sui campi di battaglia. E a dare il colpo di grazia al già fatiscente impero - sottolinea Harper - furono le pestilenze, la cui propagazione fu alimentata dalla vertiginosa crescita del numero della popolazione, non solo a Roma, ma anche nelle zone limitrofe, ovvero nelle campagne che, col declinare dell’impero, non vennero più adeguatamente bonificate come invece accadeva nei giorni di gloria.
In particolare - sostiene lo storico - a sbaragliare ogni forma di resistenza fu lo Yersinia pestis, che corrisponde alla moderna accezione di peste bubbonica. Un inquietante intreccio di morbi e di germi invase vaste regioni dell’impero mietendo, senza pietà, lutti e devastazione. I romani - ricorda Kyle Harper - avevano saputo come sconfiggere i nemici, anche perché aveva saputo imparare dalle lezioni derivanti dalle sconfitte subite. Ma non avevano le conoscenze e i mezzi adeguati per fronteggiare le ricorrenti pestilenze che certo potevano “approfittare”, per attecchire e poi infuriare, anche della mancanza di social distancing, misura certo non praticabile visto che i romani solevano vivere in ambienti molto ristretti e in accampamenti sovraffollati.
NOTA:
L’Impero romano e la ragione nascosta della sua caduta: una questione "filologica", epocale! L’ "In principio era il logos" (e sulla testa di tutti e di tutte, c’era la corona-virtus) diventa piano-piano l’ "In principio era il Logo" (e sul capo c’era il coronavirus)!!!
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- La vita, la resurrezione dei popoli, e il dio denaro. Papa Francesco prega perché i governanti e gli scienziati trovino la strada giusta.14 aprile 2020, di Federico La Sala
Santa Marta.
Il Papa: si trovino soluzioni a favore dei popoli, non del denaro
Francesco prega perché i governanti e gli scienziati trovino la strada giusta alla crisi causata dal Covid-19, soluzioni che siano a favore della gente
di Vatican News *
- Francesco ha presieduto la Messa a Casa Santa Marta nel lunedì nell’Ottava di Pasqua. Nell’introduzione, Francesco rivolge il suo pensiero a politici e scienziati: Preghiamo oggi per i governanti, gli scienziati, i politici, che hanno incominciato a studiare la via d’uscita, il dopo-pandemia, questo “dopo” che è già incominciato: perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli. (Vatican Media News)
Nell’omelia, Francesco ha commentato il Vangelo odierno (Mt 28, 8-15) in cui Gesù risorto appare ad alcune donne esortandole a riferire ai suoi discepoli di andare in Galilea: là lo vedranno. Nel frattempo, annota l’evangelista, i sacerdoti corrompono i soldati posti a guardia del sepolcro, dicendo di riferire che i discepoli di Gesù erano giunti di notte rubando il corpo mentre loro dormivano. Il Vangelo - ha affermato il Papa - propone una scelta che vale anche per oggi: la speranza della resurrezione di Gesù e la nostalgia del sepolcro.
 Così, nel trovare soluzioni a questa pandemia, la scelta sarà tra la vita, la resurrezione dei popoli, e il dio denaro. Se si sceglie il denaro, si sceglie la via della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione ... lì c’è il sepolcro. Il Signore, è la preghiera del Papa, ci aiuti a scegliere il bene della gente, senza mai cadere nel sepolcro del dio denaro.
Così, nel trovare soluzioni a questa pandemia, la scelta sarà tra la vita, la resurrezione dei popoli, e il dio denaro. Se si sceglie il denaro, si sceglie la via della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione ... lì c’è il sepolcro. Il Signore, è la preghiera del Papa, ci aiuti a scegliere il bene della gente, senza mai cadere nel sepolcro del dio denaro.Il Vangelo di oggi ci presenta un’opzione, un’opzione di tutti i giorni, un’opzione umana ma che regge da quel giorno: l’opzione tra la gioia, la speranza della resurrezione di Gesù, e la nostalgia del sepolcro.
Le donne vanno avanti a portare l’annuncio: sempre Dio incomincia con le donne, sempre. Aprono strade. Non dubitano: sanno; lo hanno visto, lo hanno toccato. Hanno anche visto il sepolcro vuoto. È vero che i discepoli non potevano crederlo e hanno detto: “Ma queste donne forse sono un po’ troppo fantasiose” ... non so, avevano i loro dubbi. Ma loro erano sicure e loro alla fine hanno portato avanti questa strada fino al giorno d’oggi: Gesù è risorto, è vivo tra noi. E poi c’è l’altro: è meglio non vivere, con il sepolcro vuoto. Tanti problemi ci porterà, questo sepolcro vuoto. E la decisione di nascondere il fatto. È come sempre: quando non serviamo Dio, il Signore, serviamo l’altro dio, il denaro. Ricordiamo quello che Gesù ha detto: sono due signori, il Signore Dio e il signore denaro. Non si può servire ambedue. E per uscire da questa evidenza, da questa realtà, i sacerdoti, i dottori della Legge hanno scelto l’altra strada, quella che offriva loro il dio denaro e hanno pagato: hanno pagato il silenzio. Il silenzio dei testimoni. Una delle guardie aveva confessato, appena morto Gesù: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”. Questi poveretti non capiscono, hanno paura perché ne va della vita ... e sono andati dai sacerdoti, dai dottori della Legge. E loro hanno pagato: hanno pagato il silenzio, e questo, cari fratelli e sorelle, non è una tangente: questa è corruzione pura, corruzione allo stato puro. Se tu non confessi Gesù Cristo il Signore, pensa perché dove c’è il sigillo del tuo sepolcro, dove c’è la corruzione. È vero che tanta gente non confessa Gesù perché non lo conosce, perché noi non lo abbiamo annunciato con coerenza, e questo è colpa nostra. Ma quando davanti alle evidenze si prende questa strada, è la strada del diavolo, è la strada della corruzione. Si paga e stai zitto.
Anche oggi, davanti alla prossima - speriamo che sia presto - prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione: o la nostra scommessa sarà per la vita, per la resurrezione dei popoli o sarà per il dio denaro: tornare al sepolcro della fame, della schiavitù, delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione ... lì c’è il sepolcro.
Il Signore, sia nella nostra vita personale sia nella nostra vita sociale, sempre ci aiuti a scegliere l’annuncio: l’annuncio che è orizzonte, è aperto, sempre; ci porti a scegliere il bene della gente. E mai cadere nel sepolcro del dio denaro.
Il Papa ha terminato la celebrazione con l’adorazione e la benedizione eucaristica, invitando a fare la Comunione spirituale. [...].
* Avvenire, lunedì 13 aprile 2020 (ripresa parziale).
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Pasqua. Aramaico, ebraico, greco, latino... in che lingua Gesù parlò con Pilato? (di Mimmo Muolo).7 aprile 2020, di Federico La Sala
Pasqua. Aramaico, ebraico, greco, latino... in che lingua Gesù parlò con Pilato?
Oltre l’aramaico, conosceva anche l’ebraico e il greco? E in che lingua avvenne il processo davanti a Pilato? Le ipotesi degli studiosi e l’importanza degli idiomi per l’evangelizzazione
di Mimmo Muolo (Avvenire, martedì 7 aprile 2020).
In che lingua parlava Gesù? E i protagonisti dei grandi eventi che portarono alla sua morte in croce? La questione, da tempo al centro del dibattito tra gli studiosi, può essere assunta proprio nei giorni della Settimana Santa, come filo rosso per comprendere alcune dinamiche fondamentali dell’annuncio della Buona Novella dall’inizio fino a noi.
Le quattro lingue della Palestina
Va detto innanzitutto che al tempo in cui si svolsero gli eventi descritti nei Vangeli quattro erano le lingue parlate in Palestina. Quella ufficiale (ma anche la meno diffusa: usata solo da un ristretto numero di funzionari pubblico) era il latino. Quella religiosa era l’ebraico, parlata nelle sinagoghe, dove si leggevano i testi della Torah, e dai farisei che erano gli ebrei più osservanti. Quella della vita quotidiana era invece l’aramaico, che il popolo aveva adottato dopo il ritorno dall’esilio babilonese (VI sec. a.C.). E infine il greco della koiné, che era un po’ come l’inglese di oggi, parlata ovunque. Ebraico e aramaico erano lingue semitiche, imparentate tra loro come ad esempio l’italiano e il napoletano, dato che l’aramaico (nell’VIII secolo a.C. lingua delle comunicazioni internazionali nella Mesopotamia) era diventata una sorta di dialetto.
Gesù parlava solo l’aramaico?
Tra queste quattro lingue è ormai certo che quella usata da Gesù per la predicazione e per i colloqui con i discepoli fosse l’aramaico. Come ricorda Rinaldo Fabris, nel suo “Gesù il Nazareno” (Cittadella Editrice), sono almeno una ventina i passi dei Vangeli canonici (scritti in greco) in cui vengono citate parole o espressioni aramaiche. Per limitarci a quelle che riguardano la Settimana Santa: “Abba” (Padre), usato da Gesù nel Getsemani; “Eloi Eloi lemà sabachtani” (Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato) cioè le ultime parole di Cristo sulla croce secondo Marco e Matteo; il toponomastico Golgotha (“Luogo del cranio”) per indicare l’altura della crocifissione; e infine l’appellativo “rabbunì” (maestro mio) con cui Maria di Madgala chiama Gesù dopo la risurrezione. E a proposito di vittoria sulla morte, possiamo citare ancora il “talità qum”, (ragazza alzati) con cui Cristo riporta in vita la figlia di Giairo.
Del resto è naturale: cresciuto ed educato in una modesta famiglia della Galilea che abitava a Nazareth, villaggio di poche centinaia di abitanti, Egli certamente aveva come lingua materna l’aramaico occidentale che si parlava nella sua terra. Tra l’altro connotato da accento diverso da quello in uso a Gerusalemme, come attesta il “riconoscimento” di Pietro, nella notte dell’arresto di Gesù (Mt 26,73) proprio a motivo di come parlava.
L’aramaico, scelta di incarnazione
Questo fatto ci dice già una cosa importante. La concretezza dell’incarnazione vale per tutti gli aspetti della vita. Gesù si esprime in un idioma che tutti possono comprendere e poco importa se non è la lingua dei dotti. Anzi proprio questa vicinanza ai “piccoli”, al punto da parlare in “dialetto”, conferma se mai ce ne fosse bisogno la sua “rivoluzione” delle periferie, come direbbe papa Francesco. Il quale, parlando ai genitori dei bambini che stava battezzando nella Cappella Sistina il 7 gennaio 2018, raccomandò: “La trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto, la lingua intima delle coppie. Nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna”. E non è un caso che un grande santo e teologo come Tommaso d’Aquino abbia predicato il quaresimale del 1273 in dialetto napoletano.
Le ipotesi sull’ebraico e il greco
Ciò che resta ancora incerto è se Gesù sapesse parlare nelle altre lingue. Almeno l’ebraico e il greco. Quanto all’ebraico, bisogna registrare un simpatico siparietto durante la visita di papa Francesco in Medio Oriente nel 2014. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante un incontro ufficiale, disse al Pontefice: «Gesù ha vissuto qui, parlava ebraico». «Aramaico», lo corresse Francesco. Al che Netanyahu, immediatamente, precisò: «Parlava aramaico ma conosceva l’ebraico, perché leggeva le Scritture». Al di là dei cordiali sorrisi che chiusero l’episodio, viene da chiedersi: è proprio così?
 Secondo Fabris, “sulla base delle scarne informazioni del Vangeli non si è in grado di dare una risposta categorica alla domanda se Gesù sapesse leggere e scrivere”. E anche l’episodio riferito da san Luca, in cui nella sinagoga di Nazareth Egli prende e legge il rotolo del profeta Isaia, “non può essere addotto come prova che egli è in grado di leggere il testo ebraico della Bibbia”. Probabilmente infatti, argomenta lo studioso, quel racconto è il frutto di una rielaborazione dell’evangelista al quale interessa dire che Gesù è il Messia.
Secondo Fabris, “sulla base delle scarne informazioni del Vangeli non si è in grado di dare una risposta categorica alla domanda se Gesù sapesse leggere e scrivere”. E anche l’episodio riferito da san Luca, in cui nella sinagoga di Nazareth Egli prende e legge il rotolo del profeta Isaia, “non può essere addotto come prova che egli è in grado di leggere il testo ebraico della Bibbia”. Probabilmente infatti, argomenta lo studioso, quel racconto è il frutto di una rielaborazione dell’evangelista al quale interessa dire che Gesù è il Messia.Tuttavia questo punto non è pacifico fra gli esegeti. Stefano Tarocchi, biblista e preside emerito della Facoltà Teologica dell’Italia centrale, nota infatti che “diversi altri racconti dei Vangeli favoriscono la teoria secondo cui Gesù era in grado di servirsi anche dell’ebraico quando la situazione lo richiedeva”. Soprattutto le conversazioni e discussioni con capi religiosi ebrei. “Questi dialoghi di solito avvenivano in ebraico anche tra chi aveva come prima lingua l’aramaico. Per essere credibile come interlocutore, con molta probabilità Gesù usava l’ebraico quando era impegnato in discorsi teologici con i farisei, gli scribi e gli altri capi ebrei”.
Quanto al greco, alcuni esegeti hanno ipotizzato che Gesù potesse conoscerlo, dato che vicino a Nazaret c’erano Sepphoris, capitale della tetrarchia di Erode Antipa, e Tiberiade, centro commerciale di una certa importanza, dove i mercanti greci arrivavano facilmente. Ma Fabris esclude un’ipotesi del genere, così come la possibilità che egli abbia conversato o insegnato in greco.
In che lingua parlarono Pilato e Gesù durante il processo?
Più possibilista è invece Tarocchi, citando la conversazione con il centurione romano di Matteo 8,5-13. “Anche Pilato nel processo - afferma - avrebbe usato il greco, non il latino, come ha invece immaginato Mel Gibson in The Passion. Non è nemmeno ipotizzabile che un governatore romano abbia potuto conoscere ed usare l’aramaico”. Tuttavia il dialogo potrebbe essersi svolto con l’intermediazione di un interprete (anche se nei Vangeli non se ne fa menzione), perché quello a Gesù non era certamente l’unico processo che Pilato fece nella sua carriera e la registrazione di un particolare così scontato può essere stata considerata superflua.
L’importanza del greco per l’evangelizzazione
Il greco però sicuramente entra in scena - e pesantemente - dopo la risurrezione. Soprattutto grazie alle lettere di Paolo, che sono i documenti più antichi del Nuovo Testamento, tutto scritto nell’”inglese” dell’epoca.
A questo punto il cambio di priorità, e dunque di paradigma anche linguistico, appare evidente. Alla logica dell’incarnazione si affianca quella dell’universalità del messaggio evangelico, che essendo destinato a tutti gli uomini, ha bisogno di un veicolo comunicativo il più possibile conosciuto. Il greco, appunto, che diviene così la lingua della “fase due” dell’evangelizzazione, dopo il primo annuncio del Nazareno. A quel punto l’idioma originale parlato da da Gesù diventa secondario, quasi ininfluente.
 "Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio", esclameranno i presenti alla predicazione degli Apostoli, il giorno di Pentecoste. La voce di Cristo raggiunge ognuno nel suo linguaggio, secondo la doppia regola dell’incarnazione e dell’universalizzazione del messaggio della salvezza. E non è un caso che la Bibbia sia oggi il libro tradotto nel maggior numero di lingue al mondo.
"Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio", esclameranno i presenti alla predicazione degli Apostoli, il giorno di Pentecoste. La voce di Cristo raggiunge ognuno nel suo linguaggio, secondo la doppia regola dell’incarnazione e dell’universalizzazione del messaggio della salvezza. E non è un caso che la Bibbia sia oggi il libro tradotto nel maggior numero di lingue al mondo. -
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- CHARIDAD ( "Diccionario de Autoridades", 1729).2 aprile 2020, di Federico La SalaCHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K : y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád ("Diccionario de Autoridades" - Tomo II, 1729).
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Papa a Bari. "L’amore è l’unico estremismo cristiano" (di Mimmo Muolo).23 febbraio 2020, di Federico La Sala
Papa a Bari. "L’amore è l’unico estremismo cristiano"
Francesco nell’omelia della Messa, celebrata davanti a 40mila fedeli, richiama il cuore del Vangelo: "Sull’amore verso tutti non accettiamo scuse" L’appello per la Siria
di Mimmo Muolo, inviato a Bari (Avvenire, domenica 23 febbraio 2020)
"Amate i vostri nemici". Ecco la rivoluzione di Gesù. "Dal nemico da odiare al nemico da amare". E’ la sottolineatura forte di papa Francesco nell’omelia della Messa che il Pontefice celebra al centro di Bari, davanti a circa 40mila fedeli, presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, calorosamente applaudito quando l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, lo saluta a nome di tutti. "Il Signore - dice il Vescovo di Roma - ci ha chiesto l’estremismo della carità. E’ l’unico estremismo cristiano: quello dell’amore".
"Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano", ha ripetuto più volte il Pontefice. "È la novità cristiana. È la differenza cristiana. Pregare e amare: ecco quello che dobbiamo fare; e non solo verso chi ci vuol bene, non solo verso gli amici, non solo verso il nostro popolo. Perché l’amore di Gesù non conosce confini e barriere. Il Signore ci chiede il coraggio di un amore senza calcoli. Perché la misura di Gesù è l’amore senza misura".
Il Papa ha invitato a non preoccuparsi "della cattiveria altrui, di chi pensa male di te". "Inizia invece - ha esortato - a disarmare il tuo cuore per amore di Gesù. Perché chi ama Dio non ha nemici nel cuore. Il culto a Dio è il contrario della cultura dell’odio. E la cultura dell’odio si combatte contrastando il culto del lamento. Quante volte ci lamentiamo per quello che non riceviamo, per quello che non va! Gesù sa che tante cose non vanno, che ci sarà sempre qualcuno che ci vorrà male, anche qualcuno che ci perseguiterà. Ma ci chiede solo di pregare e amare. Ecco la rivoluzione di Gesù, la più grande della storia: dal nemico da odiare al nemico da amare, dal culto del lamento alla cultura del dono. Se siamo di Gesù, questo è il cammino".
Sono parole perfettamente complementari al discorso fatto poco prima nella Basilica di San Nicola e di cui riferiamo a parte. Se lì il Papa aveva messo l’accento sulla follia della guerra e sull’inevitabilità della pace, qui indica la strada per disarmare ogni violenza e arrivare alla vera riconciliazione del cuore. Ecco perché Francesco ricorda: "Dio sa che il male si vince solo col bene. Ci ha salvati così: non con la spada, ma con la croce. Amare e perdonare è vivere da vincitori. Perderemo se difenderemo la fede con la forza. Il Signore ripeterebbe anche a noi le parole che disse a Pietro nel Getsemani: ’Rimetti la spada nel fodero’. Nei Getsemani di oggi, nel nostro mondo indifferente e ingiusto, dove sembra di assistere all’agonia della speranza, il cristiano non può fare come quei discepoli, che prima impugnarono la spada e poi fuggirono. No, la soluzione non è sfoderare la spada contro qualcuno e nemmeno fuggire dai tempi che viviamo. La soluzione è la via di Gesù: l’amore attivo, l’amore umile, l’amore fino alla fine". Il Papa così conclude la sua omelia: "Oggi Gesù, col suo amore senza limiti, alza l’asticella della nostra umanità". Dunque "va chiesta anche la grazia di vedere gli altri non come ostacoli e complicazioni, ma come fratelli e sorelle da amare". Infattti "alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore". Scegliamo oggi l’amore, anche se costa, anche se va controcorrente. Non lasciamoci condizionare dal pensiero comune, non accontentiamoci di mezze misure".
All’Angelus l’appello per la Siria
All’Angelus, poi, il Papa ha rivolto un appello per la pace "nel nord-ovest della Siria, dove si consuma un’immane tragedia". "Dai nostri cuori di pastori - ha sottolineato - si eleva un forte appello agli attori coinvolti e alla comunità internazionale, perché taccia il frastuono delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli e degli indifesi; perché si mettano da parte i calcoli e gli interessi per salvaguardare levite dei civili e dei tanti bambini innocenti che ne pagano le conseguenze. Preghiamo il Signore affinché muova i cuori e tutti possano superare la logica dello scontro, dell’odio e della vendetta per riscoprirsi fratelli, figli di un solo Padre".
Il grazie di Cacucci
Nel ringraziamento al Papa monsignor Cacucci ha ricordato il librarsi della colomba della pace, nella precedente visita di Francesco a Bari. UNa colomba che idealmente torna a volare anche oggi, ha detto il presule. "Benvenuti voi tutti, fratelli e sorelle, nella città di San Nicola - ha concluso -, confermata in questi giorni «cantiere di pace». Le ossa di San Nicola, giunte da Myra a Bari, solcando il Mediterraneo, hanno innalzato un ponte che né il temponé le divisioni hanno mai demolito".
Lungo il Corso Vittorio Emanuele II, chiuso dal palco papale sul cui sfondo giganteggia la riproduzione di un rosone romanico con il colore azzurro del Mare Mediterraneo, la folla dei fedeli ha assistito con grande raccoglimento alla Messa, riservando al Pontefice, all’arrivo e alla partenza, particolare calore. Tra le autorità anche i ministri Francesco Boccia e Teresa Bellanova. Mentre il premier Giuseppe Conte, con una telefonata al cardinale presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, ha annunciato di dover rinunciare alla trasferta barese per continuare a gestire da Roma l’emergenza Coronavirus.
Con il Papa hanno concelebrato, oltre ai 58 membri dell’Incontro, 18 cardinali, tutti i vescovi pugliesi, un centinaio di altri vescovi italiani, 4 patriarchi orientali, 500 sacerdoti, 100 diaconi e 600 religiosi. Molto belli e ben eseguiti i canti di don Antonio Parisi, alla guida del coro diocesano (80 persone), e dell’orchestra del Conservatorio di Bari, formata da 25 elementi.
Quasi mille i volontari hanno supporteranno le forze dell’ordine per garantire l’ordinato svolgimento dell’evento. Circa 500 provenivano dalle parrocchie della diocesi, altri 300 dalla Protezione civile regionale, un centinaio dal sistema sanitario e ci saranno anche circa 60 addetti alla sicurezza della Polizia locale. Treni speciali dalla provincia e servizi navetta da e per i parcheggi allestiti nella periferia barese hanno agevolato il flusso e il deflusso dei pellegrini, che nella zona della celebrazione hanno potuto seguire la liturgia, anche grazie a una decina di maxischermi
Il Papa è ripartito poi alla volta di Roma subito dopo la fine della celebrazione, mentre i vescovi hanno partecipato al pranzo con i poveri, gli ex tossicodipendenti, alcune donne vittime di violenza e un gruppo di ex detenuti organizzato nei padiglioni della Fiera del Levante.
-
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! --- GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA: LO STRUMENTO ELETTO. Note.18 febbraio 2020, di Federico La Sala
LINGUA GRECA E CRISTIANESIMO: LO STRUMENTO ELETTO E L’EU-CARESTIA... *
GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA
LO STRUMENTO ELETTO
ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ • VAS ELECTIONIS
Il ruolo della lingua greca nella diffusione del pensiero cristiano
Sabato 8 febbraio 2020, ore 10
Sala conferenze - Palazzo Reale, Piazza Duomo 14, Milano
Interventi
Sua Eminenza Gennadios - Arcivescovo d’Italia e Malta
L’educazione e la cultura sono la via per la pace
Stefano Martinelli Tempesta - Università degli Studi, Milano
Fede cristiana e tradizione classica nei codici della Biblioteca Ambrosiana
Alberto Barzanò - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
La lingua greca: strumento e veicolo di comunicazione tra primo cristianesimo e Impero romano
Emanuela Fogliadini - Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano
Eikōn, “icona”: somiglianza, rappresentazione, rivelazione del prototipo
Gilda Tentorio - Università degli Studi, Milano L’anima senza tempo dell’Athos: scrittori e impressioni di viaggio
Marco Roncalli - Saggista e scrittore
Patristica greca, ortodossia orientale ed ecumenismo in san Giovanni XXIII
Massimo Cazzulo - Presidente Società Filellenica Lombarda
Il lessico liturgico della poesia neogreca del Novecento: l’esempio di To ʼΆξιoν ἐστί di Odisseas Elitis
L’inizio dei lavori sarà preceduto dai saluti delle Autorità di
Filippo Del Corno Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Nikolaos Sakkaris Console onorario della Repubblica di Grecia a Milano,
Dimitri Fessas Presidente della Federazione delle comunità e delle confraternite greche di Italia, Sofia Zafiropoulou Presidente della Comunità ellenica di Milano
* FONTE: LICEO CLASSICO STATALE "TITO LIVIO" - MILANO (27 gennaio 2020)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata... MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
EU-ANGELO, EU-ROPA .... E "SCRITTURA ED EU-CARESTIA"?! LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM".
Federico La Sala
-
>AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ----" UNA GUIDA RIMASTA FINORA COL CAPO COPERTO": IL PRINCIPIO DI CARITÀ. Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica (di Francesco Gandellini, 2016).19 gennaio 2020, di Federico La Sala
FILOSOFIA E FILOLOGIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS: CHARITAS....
- LA CARITÀ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia), NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!) *
Tesi di Laurea
IL PRINCIPIO DI CARITÀ [2016]
Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica
a cura di Francesco Gandellini **
- La tesi si preoccupa di analizzare l’origine e il decorso storico del principio di carità o benevolenza, con particolare riferimento alla linea etico-ermeneutica e alla linea logico-ontologica, al fine di metterne in luce gli aspetti significativi che lo identificano e ne caratterizzano l’uso nella storia della filosofia.
SOMMARIO Introduzione .................................................................................................................
 1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
 1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
 1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
 1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
 1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
 1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
 1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
 Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
 2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
 α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
 β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
 2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
 2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
 Conclusione .............................................................................................................. 157
Conclusione .............................................................................................................. 157
 Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163
Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163***
INTRODUZIONE
Il termine “carità” deriva etimologicamente dal latino caritas (acc. caritatem, «benevolenza», «amore», questo da carus, «caro», «costoso», «diletto», «amato»), e a sua volta dal greco χάρις, «grazia». Dal punto di vista dell’etimo, la parola cattura l’idea dell’amore disinteressato ma prezioso verso qualcuno, della benevolenza gratuitamente concessa al destinatario, senza riserve rispetto alla sua condizione.
 Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
 Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
 Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
 La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
 È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
 Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
 Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
 Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.
Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.1 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, il Saggiatore 2008, pag. 35
** UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 Dipartimento Lettere e Filosofia
Dipartimento Lettere e Filosofia
 Corso di Laurea in FILOSOFIA.
Corso di Laurea in FILOSOFIA.
 Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
 Laureando: GANDELLINI Francesco.
Laureando: GANDELLINI Francesco.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA QUESTIONE DELLA "H"....SCIENZA E FILOSOFIA. "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia" (di Antonio Rainone)
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- I "due Papi" e l’unico segno, la necessaria chiarezza - "per l’oggi della Chiesa e l’avvenire del cristianesimo" (di Giuseppe Lorizio)15 gennaio 2020, di Federico La Sala
L’unico segno, la necessaria chiarezza.
Il falso mito dei "due Papi"
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, mercoledì 15 gennaio 2020)
Per quanto suggestivo possa apparire nelle serie televisive e in un film di un certo successo, quello dei "due Papi" è un falso mito, che è necessario smascherare, anche perché viene sempre più spesso rappresentato in certe cronache che fanno specchio a vere o presunte polemiche e manovre, innescate da interventi intorno a temi scottanti per l’oggi della Chiesa e l’avvenire del cristianesimo.
A smentire la possibilità che nella Chiesa odierna vi siano due Papi è lo stesso Benedetto, il pontefice emerito, che ha sempre dichiarato «incondizionata reverenza e obbedienza» all’attuale Vescovo di Roma e ieri ha eliminato ogni equivoco, chiedendo di togliere il proprio nome sia dalla copertina sia dall’introduzione e dalle conclusioni dal volume del cardinal Robert Sarah sul celibato dei preti al quale aveva concesso un proprio saggio (uniche pagine che intende firmare). Questa chiarezza era indispensabile, così il lettore sa e comprende quale sia la posizione di Benedetto XVI e quanto invece non gli appartenga, perché scritto e divulgato da altri.
Finiscono con l’alimentare la falsa mitologia dei due Papi sia quelle rappresentazioni che sottolineano amicizia e continuità fra i due personaggi in questione, senza evidenziare l’obbedienza dell’emerito all’attuale Papa, ma molto più quelle che li contrappongono in maniera subdola e ideologicamente contrassegnata. La riflessione si impone, perché i credenti non vengano disorientati più di quanto non siano dal contesto culturale e sociale in cui vivono.
Il Papa è il segno tangibile e concreto dell’unità della Chiesa, altro ruolo oltre questo non gli compete. In questo senso non può essere che uno e unico. Le epoche, da questo punto di vista certamente buie, in cui sono convissuti contemporaneamente Papi e antipapi, non hanno prodotto nulla di buono per il tessuto ecclesiale e spirituale della comunità credente. E solo quando qualcuno, come Giovanni XXIII (l’antipapa quattrocentesco), ha saputo con umiltà farsi da parte, si è ricostituita l’unità ecclesiale e ha ripreso vigore l’evangelo nel mondo.
 Senza questo unico segno di unità, il cristianesimo vivrebbe una frammentazione devastante e la divisione regnerebbe sovrana, laddove al contrario, nella lettera agli Efesini leggiamo che «vi è [e quindi vi deve essere] un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti» (4, 4-6). Il dualismo non appartiene al cristianesimo cattolico, e quindi neanche alla fede cristiana tout court, è piuttosto frutto dello gnosticismo storico e perenne, che costituisce una costante tentazione per coloro che credono.
Senza questo unico segno di unità, il cristianesimo vivrebbe una frammentazione devastante e la divisione regnerebbe sovrana, laddove al contrario, nella lettera agli Efesini leggiamo che «vi è [e quindi vi deve essere] un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti» (4, 4-6). Il dualismo non appartiene al cristianesimo cattolico, e quindi neanche alla fede cristiana tout court, è piuttosto frutto dello gnosticismo storico e perenne, che costituisce una costante tentazione per coloro che credono.Per passare dalla Bibbia e dalla storia all’oggi, non possiamo dimenticare che il pontificato interrotto di papa Benedetto sia stato il vero gesto rivoluzionario che ha consentito la stagione di papa Francesco, con le sue innovazioni e la sua vivacità, sempre nel solco della tradizione della Chiesa cattolica. Abitare tale gesto, stupefacente e drammatico allo stesso tempo, significa rendersi conto che nella Chiesa vi è un solo Vescovo di Roma, ossia un solo Papa. Parlare di due Papi è insensato, come impegnarsi per contrapporre le due figure più significative dell’attuale contesto cattolico. E c’è da sospettare che dietro operazioni che adottano tale modalità, ci sia chi intende distruggere la Chiesa stessa, attentando alla sua prima nota costitutiva, che - come recitiamo nel Credo - è l’unità. Certo demitizzare i "due Papi" significa andare contro corrente e avere meno audience, ma non per questo ci si può esimere da tale compito.
Ritenere che la tradizione sia da una parte e l’innovazione dall’altra significa non comprendere il senso autentico della tradizione stessa, che è radicalmente innovativa, in quanto non guarda solo al passato, ma si innesta nel presente e si apre al futuro. Questo vale per le strutture costitutive di quella religione che pone a suo fondamento la fede cristiana. In primo luogo il culto e la liturgia, che, ininterrottamente, ma con linguaggio sempre nuovo, fa sì che il mistero si renda presente nell’oggi della sacramentalità. Qui il gesto e le parole fondamentali sono sempre le stesse: il pane che si spezza, l’acqua che si versa, le mani che si impongono, l’unzione con le parole che accompagnano e rendono sacramento il segno. Su questi fondamentali la Chiesa non ha alcun potere, in quanto le sono consegnati dalla rivelazione stessa, ma le modalità celebrative le sono affidate, perché la memoria non sia pura nostalgia e il presente non si rattrappisca in un passato preconfezionato. In secondo luogo la dottrina, che è chiamata a svilupparsi, secondo la feconda indicazione del santo cardinale John Henry Newman.
Uno sviluppo organico ed omogeneo, che, quando non è tale (o non è stato tale) ha prodotto i peggiori mali della Chiesa, ossia l’eresia e lo scisma. In terzo luogo le strutture, chiamate a trasformarsi e modificarsi, nello spirito di quanto disegnato da papa Francesco nel suo ultimo discorso alla Curia romana (21 dicembre 2019). I binari di tale trasformazione sono stati indicati nell’evangelizzazione e nella promozione umana, cardini portanti dell’agire ecclesiale nel presente e nel futuro, su cui devono poggiare e di cui devono nutrirsi le sovrastrutture o impalcature giuridiche e istituzionali.
Il falso mito dei due Papi veniva smascherato dallo stesso Benedetto XVI, quando, in un famoso discorso alla curia romana (22 dicembre 2005), riflettendo sul Concilio Vaticano II, contrapponeva un’ermeneutica della ’discontinuità’, ovvero dell’innovazione per l’innovazione, che avrebbe di fatto offerto il fianco al dualismo, non a quella della ’continuità’, come ci si sarebbe aspettato da un Papa ritenuto conservatore, ma a quella della ’riforma’. Una riforma che non ha nulla a che vedere con la rivoluzione, ma significa sviluppo e vita, apertura al futuro nel necessario e sempre fecondo radicamento nel passato, con attenzione vigile a un presente certamente problematico, ma anche affascinante e provocatorio per la fede.
 Teologo, Pontificia Università Lateranense
Teologo, Pontificia Università Lateranense -
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - "CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO. Carità o empatia? (di Antonio Rainone).17 dicembre 2019, di Federico La Sala
USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO. Amore (Charitas) o Mammona (Caritas)?! Il "principle of charity", il «principio di carità» ("caritas"!), un assunzione di tipo «imperialistico» (Robert Nozick, "The Nature of Rationality", 1993) *
CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO.
di Antonio Rainone *
- 3.Linguaggio ed empatia in W. V. Quine
Carità o empatia?
Esiste una tematica nella filosofia del linguaggio e nell’epistemologia di W. V. Quine che può apparire per molti versi atipica o sorprendente a chi abbia del celebre filosofo statunitense un’immagine limitata alle sue concezioni fisicalistiche e comportamentistiche, per non dire “scientistiche”, non di rado considerate le più caratteristiche della sua produzione filosofica. Si tratta della tematica dell’empatia, cioè della capacità di avanzare spiegazioni o interpretazioni del comportamento (linguistico e non) di altri soggetti “mettendosi nei loro panni” o “simulandone” la situazione cognitiva o, ancora, assumendone immaginativamente il ruolo.
 L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.
L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.A partire dagli anni Settanta, ma più esplicitamente negli anni Novanta, Quine ha considerato il metodo dell’empatia come il metodo fondamentale di traduzione nel celebre Gedankenexperiment della traduzione radicale (ovvero la traduzione di una lingua completamente sconosciuta), ma anche come una capacità naturale ai fini dell’acquisizione del linguaggio e dell’attribuzione di stati mentali intenzionali (ossia percezioni, credenze, desideri ecc.) ad altri. In effetti, l’empatia ha acquisito un rilievo così crescente in Quine che nei suoi due ultimi lavori sistematici, Pursuit of Truth (1992) e From Stimulus to Science (1995), essa appare come un nucleo centrale della sua filosofia del linguaggio e della mente.
È stato del resto lo stesso Quine a sottolineare la rilevanza dell’empatia nella sua filosofia del linguaggio, “retrodatandone”, per così dire, la teorizzazione agli anni Cinquanta. Così Quine si esprime in uno dei suoi ultimi interventi sulla questione:
- Il mio uso della parola “empatia” è piuttosto recente ed è stato notato, ma io avevo già riconosciuto che l’approccio del traduttore radicale è di tipo empatico in Word and Object e, in realtà, già nove anni prima. «Il lessicografo - avevo scritto - dipende [...] da una proiezione di sé stesso, con la sua Weltanschauung indo-europea, nei sandali del suo informatore Kalaba» (Quine, 2000, p. 410).
Il brano qui citato da Quine, ripreso dall’importante The Problem of Meaning in Linguistics (1951b, p. 63) - una notevole anticipazione della problematica della traduzione radicale - non è privo di una certa ambiguità, prestandosi a una duplice lettura. È forse vero che in Word and Object alcune affermazioni di Quine potrebbero essere interpretate come la proposta di un metodo empatico, sostenuto comunque in modo non del tutto esplicito (cfr. Rainone, 1995), ma possono essere avanzati dei dubbi circa la difesa di tale metodo nel saggio del 1951. Se da un lato il concetto di proiezione sembra proporre il metodo dell’empatia nell’attività di traduzione di una lingua completamente sconosciuta da parte di un etnolinguista, dall’altro sembra in effetti riferirsi non tanto al metodo empatico, quanto, piuttosto, a quello che, grazie allo stesso Quine, e in seguito a Donald Davidson (cfr. Davidson, 1984), sarebbe diventato noto come «principio di carità» (principle of charity). Il linguista - asseriva infatti Quine - proietta sé stesso con la sua Weltanschauung nei panni del nativo che usa una lingua sconosciuta, presupponendo (o ipotizzando) così che il suo informatore si conformi ai suoi principi logici e abbia le sue stesse credenze (ritenute vere) riguardo alla realtà (sono questi, grosso modo, i principali tenet del principio di carità, che presuppone una comune natura razionale tra interprete/ traduttore e interpretato/parlante).
In Word and Object Quine avrebbe esplicitamente utilizzato - e teorizzato - il principio di carità riguardo alla traduzione dei connettivi logici e degli enunciati “ovvi”. L’esempio più pertinente, in merito, è rappresentato dal «caso estremo» di qualche nativo che accetti come veri enunciati traducibili nella forma “p e non-p” (per esempio, “piove e non piove”), una forma enunciativa che, violando il principio di non contraddizione, deporrebbe per Quine non a favore dell’irrazionalità dei parlanti - come riteneva Lévy-Bruhl con la sua teoria della «mentalità prelogica» - ma contro la correttezza della traduzione (Quine, 1960, p. 58).
Il medesimo argomento varrebbe inoltre per la traduzione di enunciati ovvi: una risposta negativa da parte del nativo alla domanda (nella lingua nativa) “sta piovendo?” fatta sotto la pioggia costituirebbe una prova di cattiva traduzione nella lingua nativa, non del fatto che il nativo non condivida con il traduttore la credenza in qualcosa di così evidente. In generale, nota Quine in un famoso passo di Word and Object, «quanto più assurde o esotiche sono le credenze attribuite a una persona tanto più sospetti abbiamo il diritto di essere nei confronti delle traduzioni; il mito dei popoli prelogici segna solo il caso estremo» (ivi, p. 68).
Difficilmente, pertanto, la «proiezione» del linguista nei «sandali» del nativo di cui Quine parlava nel saggio del 1951 potrebbe apparire come una forma di metodo empatico, dal momento che essa “imporrebbe” al nativo uno «schema concettuale» (quello del linguista) che, per quanto il linguista può saperne, potrebbe essergli del tutto estraneo. Questo è, in fondo, il problema sottostante a tutto il celebre secondo capitolo di Word and Object3. Non vi sarebbe alcuna garanzia, infatti, secondo Quine, che i nativi condividano lo stesso schema concettuale (la stessa Weltanschauung) del linguista. Ma il linguista non può, d’altro canto, che fare affidamento sul proprio linguaggio (o schema concettuale), data la scarsa evidenza empirica di cui dispone nel tradurre la lingua sconosciuta. Basarsi sul proprio schema concettuale, proiettandolo sul «linguaggio della giungla», è una necessità pratica, che - asseriva Quine in Word and Object - investirebbe soprattutto l’elaborazione delle «ipotesi analitiche», ovvero le ipotetiche correlazioni tra le emissioni verbali olofrastiche dei nativi e le loro possibili traduzioni mediante cui il linguista deve stabilire quali frammenti di enunciati andranno considerati termini (singolari e generali), quali congiunzioni, quali articoli, quali desinenze per il plurale e quali pronomi, sulla cui base individuare un insieme plausibile di credenze ontologiche ed epistemiche. La scelta delle ipotesi analitiche, infatti, non è altro che un modo di «catapultarsi nel linguaggio della giungla utilizzando i propri modelli linguistici » (ivi, p. 70).
 Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.
Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.Utilizzare i modelli del proprio linguaggio per tradurre un linguaggio alieno non equivale quindi ad applicare un metodo empatico di comprensione, trattandosi al massimo di un’ulteriore e più ampia applicazione del principio di carità. L’empatia sembra in realtà qualcosa di diverso dalla carità: a differenza di quest’ultima, l’empatia non presuppone necessariamente una condivisione di significati e stati cognitivi (credenze). Forse l’assunzione di un’analogia di stati cognitivi tra interprete e interpretato - il «ritrovamento dell’io nel tu», secondo la celebre formula di Wilhelm Dilthey (1927, trad. it. p. 293) - può apparire inevitabile ed efficace riguardo alle risposte verbali fenomenologiche direttamente connesse a stimolazioni elementari provenienti da eventi osservativi intersoggettivi del mondo esterno (la pioggia, il colore rosso, il caldo e il freddo ecc.): ci si aspetta infatti che i nativi, che presentano una conformazione neurofisiologica e neuropsicologica analoga alla nostra, non abbiano percezioni di tipo diverso dalle nostre, rispondendo linguisticamente a tali percezioni in modo analogo a come risponderemmo noi; in tal caso l’empatia sembrerebbe indistinguibile dalla carità interpretativa, in quanto fondata sull’assunzione dell’esistenza di meccanismi percettivi comuni ai soggetti coinvolti. Ma difficilmente tale analogia potrebbe essere presupposta allorché si tratti di tradurre il linguaggio o spiegare il comportamento di soggetti appartenenti a una cultura del tutto estranea a quella dell’interprete. In questo caso l’interprete dovrà in qualche modo “entrare”, per così dire, nella “mente” dei soggetti da interpretare per comprendere il loro peculiare punto di vista, le loro credenze sulla realtà e i significati delle loro parole.
In definitiva, la differenza tra carità ed empatia può essere intesa come la differenza tra imporre il proprio punto di vista all’altro e assumere il punto di vista dell’altro. La differenza è particolarmente rilevante nei casi di interpretazione di soggetti appartenenti a “mondi” radicalmente diversi da quello dell’interprete. Se così non fosse, difficilmente gli etnoantropologi avrebbero potuto attribuire credenze animistiche o culti religiosi atipici (come i celebri cargo cults) alle popolazioni studiate (in entrambi i casi si dovrebbe trattare, secondo un’interpretazione caritatevole, di errori di traduzione o interpretazione).
Non dovrebbe costituire motivo di sorpresa, allora, che David K. Lewis, in un saggio dedicato alla problematica davidsoniana dell’«interpretazione radicale», avesse dato una definizione del principio di carità che ingloba, per così dire, anche il procedimento empatico: un soggetto di interpretazione, asseriva Lewis, «dovrebbe credere ciò che crediamo noi, o forse ciò che avremmo creduto noi al suo posto; e dovrebbe desiderare ciò che desideriamo noi, o forse ciò che avremmo desiderato noi al suo posto» (Lewis, 1974, p. 336; corsivi aggiunti). In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.
Ma forse c’è ancora qualcosa da dire: mentre la carità impone dei vincoli normativi sulla razionalità dei soggetti da interpretare - vincoli a priori basati sui principi logici e sulle norme di razionalità epistemica e pratica dell’interprete, ritenuti universali 4 -, l’empatia sembrerebbe invece un metodo descrittivo ed empirico, essendo subordinata all’acquisizione di un’ampia gamma di informazioni relative alle credenze, alla cultura e alle esperienze passate dei soggetti da interpretare (inutile aggiungere che non c’è accordo su quest’ultimo punto).
4. Si può ricordare, riguardo a questa presunta universalità, che Robert Nozick ha contestato il principio di carità in quanto assunzione di tipo «imperialistico», conferendo tale principio «un peso indebito alla posizione che accade di occupare a noi, alle nostre credenze e alle nostre preferenze» (Nozick, 1993, p. 153). Giustamente, Nozick fa notare che difficilmente questa sarebbe l’assunzione di un antropologo relativamente alle cosiddette società “primitive” (ivi, p. 154).
* Cfr. Antonio Rainone, "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia", Carocci editore, Roma, 2019, pp. 55-59, ripresa parziale.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità"?!6 dicembre 2019, di Federico La Sala
VERSO "BARI 2020", "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?! *
Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 6 dicembre 2018)
La carità è il "miracolo" più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313.
Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
 Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
 Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
 Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Commenti a Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano (Fondazione Terra d’Otranto).
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - "IL COLORE DELL’INFERNO". Dal mondo greco a oggi, passando dalla lettura cristiana della società, lo storico Curi indaga sul dramma filosofico del far coincidere il diritto con la giusta pena.16 novembre 2019, di Federico La Sala
LA COSTITUZIONE (LA LEGGE, IL "NOMOS") E IL PARADOSSO DELLA GIUSTIZIA TRA DIRITTO E PENA .... *
- "[...] Curi richiama alla memoria un frammento di Pindaro, considerato il testo fondativo del diritto occidentale: «La legge ["nomos", fls] è re ["basileus", fls] di tutte le cose, mortali e immortali. Essa ["Esso", fls] le guida con la sua mano sovrana e rende giusta ["dikaion", fls] la cosa più violenta ["biaiotaton", fls]». Versi che in realtà testimoniano, come avrebbe scritto Pascal, l’irriducibilità totale fra giustizia e diritto. Anzi, l’esistenza stessa del diritto sembra essere prova dell’impossibilità per l’uomo di realizzare la giustizia" (cfr., R. Righetto, qui - sotto, ma - per la cit. di Pindaro - cfr. anche U. Curi, "Il paradosso della pena", in AA.VV, "Dirittto penale minimo", Donzelli, Roma 2002, p. 404).
- Eraclito, fr. B 53: "πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους." (Eraclito, fr. B 53).
- Eraclito, fr. B 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi» (Gianfranco Ravasi, La santa violenza, Avvenire, 17.10.2019).
- Eraclito, fr. B 53: "Il conflitto (pólemos) è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi" (Eraclito, fr. B 53)
Filosofia.
Da Edipo a Simone Weil: il dilemma della giustizia tra pena e diritto
Dal mondo greco a oggi, passando dalla lettura cristiana della società, lo storico Curi indaga sul dramma filosofico del far coincidere il diritto con la giusta pena
di Roberto Righetto (Avvenire, venerdì 15 novembre 2019)
- [Foto] Antonio Canova, "Allegoria della Giustizia", particolare (Fondazione Cariplo / CC 3.0)
È nota la posizione di Pascal, che possiamo definire pessimista o realista, sulla relazione tra forza e giustizia. In alcuni dei suoi Pensieri, il grande filosofo che volle morire in un ospizio dei poveri sostiene che l’ideale sarebbe che i due poli potessero convivere per il bene dell’uomo. Ma poiché in questo mondo la giustizia non ha possibilità di affermarsi e di utilizzare la forza per questo scopo, è inevitabile che la forza abbia la preponderanza. «La giustizia senza la forza è impotente, la forza senza la giustizia è tirannica», sentenzia il pensatore che inventò la prima macchina calcolatrice, ammettendo alfine con desolazione: «La giustizia è soggetta a discussione, la forza è molto riconosciuta e indiscussa. Così non si è potuto dare la forza alla giustizia perché la forza ha contraddetto la giustizia e ha affermato che solo lei era giusta. E così, non potendo ottenere che ciò che è giusto sia forte, si è fatto sì che ciò che è forte sia giusto».
Il Seicento era ancora un secolo dell’assolutismo e solo successivamente si è imposta una concezione della giustizia meno disfattista, quella che è arrivata sino a noi con lo Stato di diritto e la moderna democrazia. Eppure anche nel XXI secolo qualcosa non torna quando si parla di colpa, pena, legge, diritto, giustizia. Lo rileva Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia all’Università di Padova, nel suo ultimo saggio, Il colore dell’inferno, La pena tra vendetta e giustizia (Bollati Borlinghieri) che prende l’avvio da una citazione folgorante di Simone Weil: «A causa dell’assenza di Cristo, la mendicità in senso lato e l’atto penale sono forse le due cose più atroci di questa terra, due cose quasi infernali. Hanno il colore stesso dell’inferno».
Secondo la pensatrice francese che rimase sempre sulla soglia della conversione, nel dare il castigo al colpevole la giustizia si comporta come nel gesto dell’elemosina: presta attenzione allo sventurato «considerandolo un essere umano e non una cosa». Ma non può fare questo se prescinde da un’impostazione religiosa: senza un riferimento a Dio, la prospettiva che si delinea non può che essere infernale.
Si sa che Simone Weil aveva un culto particolare per la civiltà greca, che considerava premessa al cristianesimo, e forse non è un caso che anche Curi nella sua analisi prenda spunto dal mondo della poesia e della tragedia antica, a partire proprio dalla domanda cruciale: che cos’è una pena? Ragionando sull’etimologia, egli chiarisce come il termine poiné (da cui il latino poena, l’italiano e lo spagnolo pena, il francese peine e l’inglese penalty) abbia il significato di "riparare" e "compensare" da una parte, e di "punire" dall’altra. È ciò che viene dato "in compenso" di qualcos’altro e indica la riparazione e il castigo. Non solo, essa riveste un significato sacrale ed è un corrispettivo della colpa commessa solo se provoca sofferenza, in un modo che sia proporzionale fra colpa e pena.
C’è insomma nella logica della pena l’affermarsi di un’espiazione in senso religioso, che sarà via via accentuata dal cristianesimo con il concetto di contrappasso, mirabilmente esemplificato da Dante. Ma cosa succede se una persona viene punita, ma non ha colpa? La vicenda di Edipo in questo senso è paradigmatica: egli paga il fio delle sue azioni senza esserne fino in fondo responsabile. È un eroe tragico che ben raffigura la visione greca dell’uomo e del mondo illustrata da un frammento del giovane Aristotele pervenutoci tramite Giamblico: «Siamo stati costituiti per natura» come se «fossimo tutti destinati a una punizione».
Per i Greci c’è un’infelicità di fondo nella condizione umana che accomuna tutti i mortali e che sarà risolta solo dal cristianesimo che ha reso possibile la redenzione. Come Edipo, anche Oreste si macchia del sangue dei genitori e a differenza del re di Tebe egli è ben consapevole di dare la morte alla madre Clitennestra, ma poiché commette il matricidio per vendicare l’assassinio del padre viene prosciolto al termine del processo che si svolge davanti al tribunale dell’Areopago. In questo senso egli assomiglia più ad Amleto che a Edipo.
Giustamente in un altro passo Curi richiama alla memoria un frammento di Pindaro, considerato il testo fondativo del diritto occidentale: «La legge è re di tutte le cose, mortali e immortali. Essa le guida con la sua mano sovrana e rende giusta la cosa più violenta». Versi che in realtà testimoniano, come avrebbe scritto Pascal, l’irriducibilità totale fra giustizia e diritto. Anzi, l’esistenza stessa del diritto sembra essere prova dell’impossibilità per l’uomo di realizzare la giustizia.
L’incapacità della nostra cultura, giuridica ma non solo, di fare i conti con questi temi fondativi è testimoniata dalla sfasatura evidente fra le risposte insufficienti che vengono date allo statuto della pena e l’attività giurisdizionale, che procede come se tutto fosse già stabilito.
Il modello correzionalista e quello preventivo sono in scacco, in balia di quella che Nietzsche definì l’origine economica e contrattualista della legge e della pena, da ricercarsi nel rapporto fra creditore e debitore e nella promessa della restituzione. Una ricostruzione genealogica che alla fine si basa sul piacere della sofferenza dell’altro, nel momento in cui chi contrae il debito offre come pegno il proprio corpo, la propria donna o la propria libertà e finanche la propria vita.
Un’idea assai materiale e non etica del debito e perciò della colpa e della pena, che certo ha il suo fascino ma che per Curi può essere ribaltata solo da un’altra logica, quella della sovrabbondanza. È la logica del surplus e dell’eccesso contenuta nell’Epistola ai Romani, ove Paolo supera l’economia della corrispondenza proporzionale fra colpa e pena.
Sulla scia di pensatori contemporanei come Jankélévitch, Derrida e Girard, si affaccia la chance del perdono, che talora è stata applicata alla giustizia in anni recenti, come nella Commissione Verità e riconciliazione in Sudafrica o nei processi sul genocidio del Ruanda. In entrambi i casi si è infatti constatato che la sola punizione può alimentare la sete di vendetta. Chance che si ripresenta pure nella formula della cosiddetta "giustizia riparativa", un modello che coinvolge i colpevoli, le vittime e la comunità intera alla ricerca non solo di una riparazione del danno ma di una soluzione ai conflitti e di una riconciliazione.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA LEZIONE DI NELSON MANDELA: GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- L’Archivio Segreto Vaticano e i mutamenti semantici: cambiamento della denominazione ("Motu Proprio" di Papa Francesco).14 novembre 2019, di Federico La Sala
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
PER IL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
DA
- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
AD
- ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO *
L’esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a volte necessari.
Anche l’Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell’ingente e rilevante patrimonio documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali inevitabili condizionamenti.
Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta Bibliotheca secreta) fra il primo e secondo decennio del XVII secolo, l’Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto (Archivum Secretum Vaticanum) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte dell’Europa e del mondo. Se è vero che l’apertura ufficiale dell’Archivio ai ricercatori di ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte opere erudite si poterono pubblicare con l’ausilio di copie documentarie fedeli o autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell’Archivio Segreto Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo modo l’Archivio centrale dell’Europa (quod quodam modo totius Europae commune Archivum censeri debet).
Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all’Archivio Segreto Vaticano stima e riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione delle progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato di Pio XII), sia in ragione dell’aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi all’Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche.
Tale meritorio servizio ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei prefetti pro tempore, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal modo si è provveduto alla graduale crescita della struttura dell’Archivio stesso per il suo sempre più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici.
Vi è tuttavia un aspetto che penso possa essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione dell’Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell’istituto: Archivio Segreto Vaticano.
Nato, come accennato, dalla Bibliotheca secreta del Romano Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto la giurisdizione diretta del Papa, l’Archivio si intitolò dapprima semplicemente Archivum novum, poi Archivum Apostolicum, quindi Archivum Secretum (le prime attestazioni del termine risalgono al 1646 circa).
Il termine Secretum, entrato a formare la denominazione propria dell’istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l’archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente secreti.
Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di Archivum Secretum. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine Secretum accostato all’Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine secretum e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l’accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l’Archivio Segreto Vaticano, che - come disse il mio santo predecessore Paolo VI - conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia (Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, p. 614). E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!» (Discorso agli Officiali dell’Archivio Segreto Vaticano, 4 marzo 2019: L’Osservatore Romano, 4-5 marzo 2019, p. 6).
Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che:
da ora in poi l’attuale Archivio Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, sia denominato Archivio Apostolico Vaticano.
Riaffermando la fattiva volontà di servizio alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame della Sede romana con l’Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al tempo stesso ne sottolinea l’immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato.
Francesco
* Fonte: http://w2.vatican.va/
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. Un commento a "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò".11 novembre 2019, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”: GIUSEPPE E IL “PADRE NOSTRO”. UNA QUESTIONE EPOCALE E CRUCIALE.
 Un commento a De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò
Un commento a De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò
PROVANDO E RIPROVANDO. LA STELLA E IL NARDO... Ricordando quanto sia determinante e fondamentale, oggi, ripensare sul piano antropologico (andrologico e ginecologico) e teologico la figura della “sacra famiglia” e di san Giuseppe (si cfr. i commenti a "Ggimentu, gimmientu e ggimintare" di A. Polito, Fondazione Terra d’Otranto, 06.07.2018), e “come nascono i bambini”, non posso non PLAUDIRE alla realizzazione del “convegno e del libro per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò”, con tutti i suoi molteplici contributi!!!
SUL TEMA DELLA «GIUSEPPOLOGIA», MI SIA LECITO, si cfr.: GESU’ “CRISTO”, GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE (“CHARITAS”) DI GIUSEPPE E DI MARIA!!!
Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Una lettura della Passione come prezzo - ci dà una idea di Dio molto più vicina a Mardok e a Baal che al Dio Amore di Gesù (di Luigino Bruni).30 ottobre 2019, di Federico La Sala
IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT.... *
Botta e riposta.
Cristo ci rivela che l’espiazione non è prezzo, ma sinonimo di perdono
La croce del Figlio è il ’luogo’ dove Dio Padre dà risposta d’amore all’amore fedele estremo. E io resto convinto che una lettura della Passione come prezzo della salvezza rischia di allontanarci ...
di Luigino Bruni (Avvenire, mercoledì 30 ottobre 2019)
- [Foto] Deposizione di Cristo Caravaggio
- Gentile direttore,
- ho letto con interesse l’articolo di Luigino Bruni su “Avvenire” di domenica 27 ottobre. Ho alle spalle una formazione religiosa “meritocratica” ed “espiatoria”, verso la quale in verità, sento una profonda ribellione. Ma mi chiedo: il sacrificio espiatorio del sangue di Cristo «per riconciliare al Padre tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli». (Col 1,20) era necessario?. Se non era necessario, che senso ha, dunque, la Passione? Vorrei invitare il professor Bruni ad aiutarmi a capire. Grazie.
- Maria Carla Pilloni Piasco (Cn)
Cara signora Maria Carla, a proposito della teologia dell’espiazione ho scritto più volte in questi anni su “Avvenire”. In sintesi: nel Nuovo Testamento, compreso Paolo, si usa l’immagine del sangue e del riscatto pagato dal figlio, ma è solo un’immagine e sempre presa in prestito dall’Antico Testamento.
Se guardiamo il messaggio generale che emerge nei Vangeli sulla Passione di Cristo, non abbiamo elementi per pensare che il Padre abbia voluto la morte del Figlio come prezzo della salvezza.
Ormai la maggior parte degli esegeti, soprattutto dopo il Vaticano II è concorde nel leggere la Passione come fedeltà estrema del Figlio al suo compito che lo ha portato a una morte cruenta, non voluta né dal Padre né da Lui, ma accettata come conseguenza dell’incarnazione e della cattiveria degli uomini.
Poi una certa teologia, soprattutto medioevale, e anche alcuni Padri hanno voluto leggere il sacrificio del Cristo (sulla base di testi Neotestamentari, tra cui la lettera agli Ebrei), con le categorie arcaiche del sacrificio del nuovo Agnello etc. Anche la lettera ai Colossesi (che, come saprà, secondo gran parte degli studiosi non sarebbe di Paolo, ma di un suo discepolo) si muove nel passaggio che lei cita in questa stessa tradizione. Anche le preghiere liturgiche, soprattutto quelle della Settimana Santa, risentono di queste letture dell’espiazione, nella versione che ne ha dato Anselmo d’Aosta, la cosiddetta “Satisfactio”: il Padre era così adirato con gli uomini che solo il sangue del Figlio lo poteva soddisfare.
Inoltre, per la parola espiazione, bisogna stare attenti al significato. Quello normale è essere punito per riparare un male e placare l’ira divina. Ma nella Bibbia, quasi sempre il soggetto del verbo espiare è Dio, non il peccatore; ed espiare è praticamente sinonimo di perdonare. È Dio che espia, non l’uomo. Vedi per esempio Rm 3,25: Dio non ha esposto Gesù per espiare cioè punirlo al nostro posto e così placare la sua ira o ricevere soddisfazione, ma Dio è il soggetto che procura espiazione mediante la morte di Gesù, cioè concede il perdono; la Croce è vista come il “luogo” dove Dio dà il perdono, come risposta d’amore all’amore fedele estremo.
Resto convinto che una lettura della Passione come prezzo ci allontana dalla novità del Cristianesimo, ci dà una idea di Dio molto più vicina a Mardok e a Baal che al Dio Amore di Gesù o al Padre Misericordioso delle Parabole e fino a tempi recenti ci ha impedito di comprendere le pagine più belle della Bibbia e dei Vangeli. Grazie a lei per la sua lettera.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO: IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- RENE’ GIRARD INSISTE: DIO NON E’ VIOLENTO. MA CONFONDE IL PADRE NOSTRO (DEUS CHARITAS EST) CON IL DIO DEL CATTOLICISMO PLATONICO-ROMANO DI RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006) E RICADE NELLE BRACCIA DI "MAMMASANTISSIMA".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! - FILANTROPIA E "AGAPE". La teologia corrente del Mediterraneo (di Giuseppe Lorizio).23 ottobre 2019, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. FILANTROPIA... E AMORE di "DIO" ("AGAPE", "CHARITAS") *
Spiritualità.La teologia corrente del Mediterraneo
Dall’esperienza di san Paolo alle riflessioni in musica di Cohen e Dalla: un viaggio per riscoprire l’essenza di un luogo di incontro e di mediazione
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, martedì 22 ottobre 2019)
- [Foto] Il Santuario della Madonna dell’Angelo, nel lido veneziano di Caorle
Perseguo qui il tentativo di mostrare come il Mediterraneo, questo (non nuovo, ma antico e per questo sempre attuale) “luogo teologico”, possa e debba innestarsi nel nostro teologare. Muovo dal Nuovo Testamento e in particolare dall’esperienza di Paolo e dei suoi compagni nell’approdo a Malta. Essi qui sperimentano innanzitutto una «rara umanità». «Una volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un gran fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo» (At 28,1-2).
 Il testo greco la dice lunga e parla di «filantropia», rara e quindi eccezionale, senza la quale forse Paolo non avrebbe potuto raggiungere Roma. Sappiamo bene quanto sia “merce rara” l’umanità, che, in quanto filantropia apparterrebbe ai barbari, ma al tempo stesso dovrebbe essere inclusa nella forma agapica propria del cristianesimo, che deve esprimersi come «amore sconfinato » (R. Penna) e incondizionato, ossia senza e oltre le frontiere, o che comunque pensa la frontiera come luogo di incontro e non di scontro.
Il testo greco la dice lunga e parla di «filantropia», rara e quindi eccezionale, senza la quale forse Paolo non avrebbe potuto raggiungere Roma. Sappiamo bene quanto sia “merce rara” l’umanità, che, in quanto filantropia apparterrebbe ai barbari, ma al tempo stesso dovrebbe essere inclusa nella forma agapica propria del cristianesimo, che deve esprimersi come «amore sconfinato » (R. Penna) e incondizionato, ossia senza e oltre le frontiere, o che comunque pensa la frontiera come luogo di incontro e non di scontro.
 A proposito dell’agàpe, un’annotazione esegetica interessante riguarda la novità semantica che registriamo nei testi neotestamentari, dove il sostantivo ricorre solo diciassette volte (diciannove nella Settanta), mentre per ben centoquarantaquattro (centosessantatré nella Settanta) volte rinveniamo il verbo agapào. E se il verbo esprime - come afferma san Tommaso - una determinazione temporale, allora abbiamo a che fare non con qualcosa di atemporale (ad esempio la mediterraneità), ma con un sostantivo che (attraverso il verbo) deve penetrare nel tempo, nel nostro tempo, e sollecitare non solo la nostra mente, ma anche le nostre passioni. E a tal proposito possiamo leggere metaforicamente l’esperienza maltese/mediterranea di Paolo e dei suoi compagni, davvero carica di “umanità”.
A proposito dell’agàpe, un’annotazione esegetica interessante riguarda la novità semantica che registriamo nei testi neotestamentari, dove il sostantivo ricorre solo diciassette volte (diciannove nella Settanta), mentre per ben centoquarantaquattro (centosessantatré nella Settanta) volte rinveniamo il verbo agapào. E se il verbo esprime - come afferma san Tommaso - una determinazione temporale, allora abbiamo a che fare non con qualcosa di atemporale (ad esempio la mediterraneità), ma con un sostantivo che (attraverso il verbo) deve penetrare nel tempo, nel nostro tempo, e sollecitare non solo la nostra mente, ma anche le nostre passioni. E a tal proposito possiamo leggere metaforicamente l’esperienza maltese/mediterranea di Paolo e dei suoi compagni, davvero carica di “umanità”.
 Se trasferiamo quest’esperienza umana all’esperienza religiosa e credente, il calore di questo fuoco nella pietà popolare (ma anche individuale) degli uomini e delle donne mediterranee si esprime nella forma della “devozione” (il nocciolo duro che ha consentito al “ritorno del sacro” di archiviare la secolarizzazione). In questa prospettiva, mi piace leggere un’indicazione, suscitatami dalla lettura del bellissimo, prezioso e piccolo libro di Fabio Fiori, L’odore del mare. Piccole camminate lungo le rive mediterranee, (Ediciclo editore).
Se trasferiamo quest’esperienza umana all’esperienza religiosa e credente, il calore di questo fuoco nella pietà popolare (ma anche individuale) degli uomini e delle donne mediterranee si esprime nella forma della “devozione” (il nocciolo duro che ha consentito al “ritorno del sacro” di archiviare la secolarizzazione). In questa prospettiva, mi piace leggere un’indicazione, suscitatami dalla lettura del bellissimo, prezioso e piccolo libro di Fabio Fiori, L’odore del mare. Piccole camminate lungo le rive mediterranee, (Ediciclo editore).Karl Barth invitava infatti a leggere la letteratura profana e i giornali per comprendere la Scrittura del Nuovo Testamento: «Nel Mediterraneo - scrive Fiori - non c’è spiaggia che non sia stata teatro di approdi o naufragi, non c’è cala dove non sia stata calata ancora di pietra o di ferro. Lungo la riva il viandante ad ogni passo può incontrare il mito». La religiosità mediterranea assume in primo luogo una forma mitologica, piuttosto che logica.
 Del resto, come più volte affermato da papa Francesco, quella del “popolo” è una «categoria mitica»: «La parola popolo non è una categoria logica, è una categoria mitica», ha detto di ritorno dal Messico. In seguito, intervistato dal suo confratello gesuita Antonio Spadaro, ha voluto precisare: più che “mistica”, ha detto, «nel senso che tutto ciò che fa il popolo sia buono», è meglio dire «mitica»: «Ci vuole un mito per capire il popolo». Attingendo dal già citato Fabio Fiori, un primo spunto riguarda l’ibridazione, non semplicemente declinata secondo la categoria del meticciato: «La sponda mediterranea è il risultato di ibridazioni tra natura e cultura, più di qualsiasi altro luogo ».
Del resto, come più volte affermato da papa Francesco, quella del “popolo” è una «categoria mitica»: «La parola popolo non è una categoria logica, è una categoria mitica», ha detto di ritorno dal Messico. In seguito, intervistato dal suo confratello gesuita Antonio Spadaro, ha voluto precisare: più che “mistica”, ha detto, «nel senso che tutto ciò che fa il popolo sia buono», è meglio dire «mitica»: «Ci vuole un mito per capire il popolo». Attingendo dal già citato Fabio Fiori, un primo spunto riguarda l’ibridazione, non semplicemente declinata secondo la categoria del meticciato: «La sponda mediterranea è il risultato di ibridazioni tra natura e cultura, più di qualsiasi altro luogo ».A livello teologico, più che di ibridazione, possiamo considerare il Mediterraneo come luogo di “mediazione”. Del resto la nostra identità cristiana risiede nella mediazione di Cristo mediatore e si riferisce alle mediazioni partecipate come quella di Maria (mediatrice). In secondo luogo, la necessità di costruire una koinè, ovviamente non solo linguistica, onde non cedere alla tentazione dell’anglismo: «Una koinè da costruirsi ogni giorno, innanzitutto con l’esperienza, camminando e navigando, leggendo e ascoltando, annusando e assaggiando, osservando e chiacchierando», come dovevano certamente chiacchierare, magari esprimendosi con i gesti piuttosto che col greco che i barbari non comprendevano o con l’assistenza di qualche mediatore, intorno al fuoco, i personaggi del testo lucano sopra evocato. In terzo luogo l’identità o appartenenza, tenendo anche conto delle lucide osservazioni di O. Roy, che ci mette in guardia dall’identificare le ricorrenti esibizioni di “identità cristiana” con la fede.
 Tornando a Fiori: «L’appartenenza mediterranea non ha niente a che fare con il passaporto, il luogo di nascita, la nazione. L’appartenenza mediterranea si realizza con la pratica, sporcando il corpo di sale e riempendo i polmoni di salmastro». Con l’appello a realizzare la mediterraneità nel quotidiano, per non cadere nel rischio della retorica. «Noi con Albert Camus “vogliamo ricongiungere la cultura alla vita. Il Mediterraneo, che ci circonda di sorrisi, di sole e di mare, ce lo insegna” ». -Richiamerei, infine, l’invito di Edgar Morin a maternizzare e sacralizzare quella che definisce «l’essenza profana del Mediterraneo».
Tornando a Fiori: «L’appartenenza mediterranea non ha niente a che fare con il passaporto, il luogo di nascita, la nazione. L’appartenenza mediterranea si realizza con la pratica, sporcando il corpo di sale e riempendo i polmoni di salmastro». Con l’appello a realizzare la mediterraneità nel quotidiano, per non cadere nel rischio della retorica. «Noi con Albert Camus “vogliamo ricongiungere la cultura alla vita. Il Mediterraneo, che ci circonda di sorrisi, di sole e di mare, ce lo insegna” ». -Richiamerei, infine, l’invito di Edgar Morin a maternizzare e sacralizzare quella che definisce «l’essenza profana del Mediterraneo».Una teologia mediterranea esprimerà innanzitutto la dimensione storico-escatologica della Rivelazione cristologica. Essa si può rinvenire, con una sorta di pop-theology, nella strofa di una canzone tradotta e interpretata da Fabrizio De André, di Leonard Cohen, intitolata Suzanne, che recita: «E Gesù fu marinaio / finché camminò sull’acqua / e restò per molto tempo / a guardare solitario / dalla sua torre di legno / e poi quando fu sicuro / che soltanto agli annegati / fosse dato di vederlo / disse: Siate marinai finché il mare vi libererà. / E lui stesso fu spezzato / ma più umano abbandonato / nella nostra mente lui non naufragò». Raggiungiamo la dimensione cosmica della Rivelazione evocando il grido etico circa la custodia del creato che dal Mediterraneo (o se si vuole dal mare) ci viene rivolto. Quando non lo impediscano interpretazioni negazioniste e del tutto fuorvianti, il grido ci raggiunge e provoca, insieme alla nostra indignazione, la domanda in noi dei contadini di Fontamara: «che fare?», purché essa non venga metabolizzata e trasformata in triste rassegnazione.
 A tal proposito concludo evocando i versi di Lucio Dalla, nel famoso brano Come è profondo il mare, che non posso non pensare ispirato dai suoi soggiorni nelle isole Tremiti: «È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce e come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare, come è profondo il mare. Certo chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare».
A tal proposito concludo evocando i versi di Lucio Dalla, nel famoso brano Come è profondo il mare, che non posso non pensare ispirato dai suoi soggiorni nelle isole Tremiti: «È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce e come pesce è difficile da bloccare perché lo protegge il mare, come è profondo il mare. Certo chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Fontamara (Ignazio Silone).
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- "LOGOS" E "POLEMOS": LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, NELLA DIMENSIONE CHE ESIGE ERACLITO.22 ottobre 2019, di Federico La Sala
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE. Tracce per una svolta antropologica ... *
HEIDEGGER-FINK, UN SEMINARIO 1966/1967NELLA DIMENSIONE CHE ESIGE ERACLITO
di Federica Montevecchi (su: Alias, 17/07/2010)
Martin Heidegger volle che la sentenza di Eraclito, «il fulmine governa ogni cosa», fosse incisa sull’architrave della porta della sua baita a Todnauberg nella Selva Nera. Le stesse parole, che costituiscono il frammento 64 dell’edizione Diels-Kranz, aprono il celebre colloquio seminariale, su Eraclito appunto, che si svolse nel semestre invernale 1966/67 all’Università di Friburgo fra Martin Heidegger e Eugen Fink. Il testo del seminario fu pubblicato in italiano nel 1992 da Coliseum, nella versione di Mauro Nobile introdotta da Mario Ruggenini, con il titolo Dialogo intorno a Eraclito. A circa venti anni di distanza da questa prima edizione, esaurita da qualche tempo, il colloquio fra Heidegger e Fink è ripresentato - corredato dalle annotazioni di Heidegger - dall’editore Laterza, nella collana «I Libri dell’Ascolto» diretta da Vittorio Tamaro, con il titolo Eraclito (a cura di Adriano Ardovino, pp. 234, € 20,00).
Il seminario, suggerito da Fink, che voleva mettere alla prova la propria interpretazione di Eraclito, fu l’ultima attività didattica di Heidegger e avrebbe dovuto includere, stando al progetto iniziale, anche una lettura dei frammenti di Parmenide. Nei fatti, invece, non fu completata neppure la lettura dei frammenti di Eraclito, tanto che Fink, nel 1970, presentando l’edizione del seminario, affermerà che il testo dato alle stampe è «un torso, un frammento su frammenti».
 Le tredici sessioni in cui si articolò la discussione, alla quale parteciparono tredici persone fra studenti e invitati, vennero trascritte volta per volta, senza l’ausilio di alcun registratore, letteralmente e integralmente.
Le tredici sessioni in cui si articolò la discussione, alla quale parteciparono tredici persone fra studenti e invitati, vennero trascritte volta per volta, senza l’ausilio di alcun registratore, letteralmente e integralmente.
 Il risultato non è tanto un confronto fra due diversi interpreti, ma, dice Heidegger, un ‘parlare con Eraclito’ e, attraverso di lui, con un’intera tradizione che, già dall’antichità, non si è sottratta alla provocazione rappresentata dai Greci. Esempi degli interrogativi di fondo dell’esistenza e dell’enigma riguardante la nascita della ragione, i pensatori greci più antichi - Presocratici o sapienti, a seconda che si voglia adottare le espressioni rispettivamente di Hermann Diels o di Giorgio Colli - sono specchi: quanto più ci avviciniamo a loro tanto più vediamo il nostro riflesso. A seconda della ‘storia razionale’ nella quale li integriamo - e questo accade già a partire da Aristotele - essi assumeranno significati molteplici, restando comunque sempre altro da ciò che di loro possiamo dire: essi costituiscono il momento inaugurale del pensiero della civiltà occidentale, nel quale la ‘verità’ della nostra origine diventa inscindibile dall’origine della nostra ‘verità’, l’ambito del conoscere non facilmente distinguibile dalla sfera del riconoscere, cioè della proiezione retrospettiva.
Il risultato non è tanto un confronto fra due diversi interpreti, ma, dice Heidegger, un ‘parlare con Eraclito’ e, attraverso di lui, con un’intera tradizione che, già dall’antichità, non si è sottratta alla provocazione rappresentata dai Greci. Esempi degli interrogativi di fondo dell’esistenza e dell’enigma riguardante la nascita della ragione, i pensatori greci più antichi - Presocratici o sapienti, a seconda che si voglia adottare le espressioni rispettivamente di Hermann Diels o di Giorgio Colli - sono specchi: quanto più ci avviciniamo a loro tanto più vediamo il nostro riflesso. A seconda della ‘storia razionale’ nella quale li integriamo - e questo accade già a partire da Aristotele - essi assumeranno significati molteplici, restando comunque sempre altro da ciò che di loro possiamo dire: essi costituiscono il momento inaugurale del pensiero della civiltà occidentale, nel quale la ‘verità’ della nostra origine diventa inscindibile dall’origine della nostra ‘verità’, l’ambito del conoscere non facilmente distinguibile dalla sfera del riconoscere, cioè della proiezione retrospettiva.Tutto ciò vale particolarmente per Eraclito le cui parole, stando a Diogene Laerzio, avrebbero fatto dire a Socrate che ci sarebbe voluto un tuffatore delio per poterle riportare alla luce dalle oscure profondità. E su queste parole si sono cimentati, nei secoli, in molti: basti pensare, fra gli altri, a Platone - che nel Sofista annovera Eraclito fra quelle Muse ioniche capaci di mostrare la connessione fra l’uno e i molti -, a Hegel - che nelle Lezioni sulla storia della filosofia afferma: «non c’è proposizione di Eraclito che io non abbia accolto nella mia Logica» -, a Hölderlin - che, attraverso Eraclito, legge l’inscindibilità di unione e separazione -, e ancora, a Nietzsche - che nei frammenti eraclitei vede l’espressione della visione tragica del mondo, del conflitto sotteso a ogni creazione e allo stesso logos.
Va da sé che pure Heidegger e Fink, in sintonia con la tradizione filosofica tedesca, che affronta il pensiero più antico proiettando nella Grecia anzitutto se stessa, la propria specificità filosofica, accolgono la sfida di Eraclito ben prima di questo seminario. L’eco eraclitea, infatti, è costante nell’opera di entrambi e si mostra, ad esempio, nell’idea heideggeriana dell’intermittenza di qualcosa che apparendo come mondo al tempo stesso si nasconde come senso. Se in questa idea è implicita la nota sentenza eraclitea «la natura ama nascondersi», nella metafora di Fink del gioco che gioca con l’uomo e il mondo, ossia con coloro che lo stanno giocando, sono evidentemente sottintese le parole di Eraclito «il tempo è un fanciullo che gioca spostando i dadi: il regno di un fanciullo».
Queste rispettive posizioni filosofiche si riflettono naturalmente nel seminario, dove Heidegger e Fink, tuttavia, cercano di assumere ruoli ben definiti. È lo stesso Fink a caratterizzare il ruolo di Heidegger nei termini di una ‘direzione spirituale’, che si declina in interventi brevi, chiarificatori, interrogativi, ma anche ammonitori rispetto a tutto ciò che potrebbe limitare la possibilità di giungere «nella dimensione che esige Eraclito», come ad esempio approcci di tipo esclusivamente filologico e storiografico, oppure l’uso di termini ritenuti troppo risonanti, quali diradamento e tempo, se non ormai inadeguati, come il temine essere. Fink, invece, assume il compito di presentare una provvisoria interpretazione dei frammenti eraclitei che garantisca una base di discussione e possa essere idonea a collocare i partecipanti al seminario «entro una certa comunione nel linguaggio interrogante». E tuttavia il tentativo di recuperare Eraclito è destinato a fare i conti con una distanza storica e ontologica abissale, come mostrano le frequenti domande di Heidegger - destinate a contenere, nei partecipanti, le cristallizzazioni concettuali, che sono da ricondursi, come viene ricordato, alla filosofia successiva di Aristotele -, oppure l’affermazione che nel seminario si sta presentando un’interpretazione non più metafisica di testi non ancora metafisici: fra il ‘non più’ e il ‘non ancora’ è tuttavia possibile sentire l’eco dell’esperienza di pensiero di Eraclito, che obbliga continuamente a riflettere sui criteri attraverso i quali si è articolato il pensiero occidentale, quindi a considerare la possibilità di pensare in altro modo.
L’andamento del seminario è scandito soprattutto dal tema dell’unità fra opposti, che ricorre in tutti i frammenti eraclitei e rimanda al problema fondamentale dell’appartenenza (Verhältnis) di uno e molti-tutto, en e panta. I numerosi esempi di fenomeni descritti da Eraclito - come pace e guerra, fame e sazietà, giovani e vecchi, mortali e immortali - mostrano a un tempo l’opposizione fra diversi e la loro unità, e cioè il fatto che lo stesso sia anche altro, i molti-tutto siano anche uno: «la difficoltà - dice Heidegger - consiste nello scorgere in che modo lo en mostri all’improvviso un altro carattere», nel capire come Eraclito possa vedere, nell’esperienza comune a tutti basata sull’opposizione e sulla distinzione, sempre l’uno e un unico logos.
 Detto altrimenti, la convivenza degli opposti, che caratterizza l’universo greco più antico già a partire dalle prime cosmologie fino ad arrivare all’opposizione delle proposizioni nell’argomentazione dialettica, rilancia costantemente l’enigma della polarità o, stando al seminario, l’enigma di come il determinato sia ad un tempo «l’unità che riunisce».
Detto altrimenti, la convivenza degli opposti, che caratterizza l’universo greco più antico già a partire dalle prime cosmologie fino ad arrivare all’opposizione delle proposizioni nell’argomentazione dialettica, rilancia costantemente l’enigma della polarità o, stando al seminario, l’enigma di come il determinato sia ad un tempo «l’unità che riunisce».
 La risposta di Heidegger e Fink si concentra sul legame fra l’uno e i molti-tutto, legame che viene inteso appunto come Verhältnis, giustamente tradotto con appartenenza, intendendo con tale termine non una relazione di possesso fra due oggetti né un rapporto di reciprocità, ma il trattenersi dell’uno e dei molti-tutto nella «stabilità dell’apertura», la «tenuta (Verhalt) dell’essere e del mondo». È la stessa cosa infatti che, nella separazione da se stessa, si tiene unita e si custodisce perché - viene precisato nella sessione undicesima - appartenere e tenere «significano in primo luogo il custodire, tenere in serbo e accordare nel senso più ampio»: questo è del resto il logos nel suo significato proprio di raccolta e di presenza di ciò che è stato raccolto. E evidente che tutto ciò permette di aprire lo spazio a un pensare che contrasti la concezione ingenua secondo la quale l’uno viene pensato come un contenitore in cui sono racchiusi i molti-tutto e soprattutto l’idea, che diventerà una delle matrici del pensiero occidentale, secondo la quale il molteplice è un dispiegarsi e un decadere del semplice.
La risposta di Heidegger e Fink si concentra sul legame fra l’uno e i molti-tutto, legame che viene inteso appunto come Verhältnis, giustamente tradotto con appartenenza, intendendo con tale termine non una relazione di possesso fra due oggetti né un rapporto di reciprocità, ma il trattenersi dell’uno e dei molti-tutto nella «stabilità dell’apertura», la «tenuta (Verhalt) dell’essere e del mondo». È la stessa cosa infatti che, nella separazione da se stessa, si tiene unita e si custodisce perché - viene precisato nella sessione undicesima - appartenere e tenere «significano in primo luogo il custodire, tenere in serbo e accordare nel senso più ampio»: questo è del resto il logos nel suo significato proprio di raccolta e di presenza di ciò che è stato raccolto. E evidente che tutto ciò permette di aprire lo spazio a un pensare che contrasti la concezione ingenua secondo la quale l’uno viene pensato come un contenitore in cui sono racchiusi i molti-tutto e soprattutto l’idea, che diventerà una delle matrici del pensiero occidentale, secondo la quale il molteplice è un dispiegarsi e un decadere del semplice.Nell’ultima sessione del seminario Heidegger chiede a Fink qual era il senso dell’affermazione con cui aveva aperto il loro colloquio comune con Eraclito, e cioè che i Greci «significano per noi un’immane provocazione». Fink risponde che si tratta della provocazione «a capovolgere, una buona volta, l’orientamento del nostro pensiero», a disfarsi di tutto l’apparato concettuale costruito sul bisogno, che Hegel ha incarnato in maniera paradigmatica, del pacificante appagamento di ciò che è pensato e conciliato per tornare a pensare, vale a dire a sentire, secondo Heidegger, «l’assillo dell’impensato nel pensato» e, come esorta Periandro di Corinto, ad avere cura del tutto in quanto tutto.
* SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- Eraclito, fr. B 53: "πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους." (Eraclito, fr. B 53).
- Eraclito, fr. B 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi» (Gianfranco Ravasi, La santa violenza, Avvenire, 17.10.2019).
- Eraclito, fr. B 53: "Il conflitto (pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi" (Eraclito, fr. B 53)
COME IL "PADRE" E’ ALL’ORIGINE ("URSPRUNG") DEL BAMBINO, COSI’ IL "POLEMOS" E’ ALL’ORIGINE DI TUTTE LE COSE?!: HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.
Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- "La santa violenza" (di Gianfranco Ravasi).17 ottobre 2019, di Federico La Sala
IL "POLEMOS" DI ERACLITO, "LA SANTA VIOLENZA" DEL CARDINALE RAVASI, E IL "PADRE NOSTRO" ("CHARITAS") DEL MESSAGGIO EVANGELICO....*
- Eraclito nel suo frammento 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi» (Gianfranco Ravasi, La santa violenza, cit. - vedi, qui -sotto)
- Eraclito nel suo frammento 53: "πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους." (Eraclito, fr. 53).
- Eraclito nel suo frammento 53: "Pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi.
Il nuovo libro di Ravasi.
Quando il sacro fa i conti con la violenza
Un orizzonte cupo, segnato da conquiste e lotte, sembra essere il basso continuo della storia umana: la Bibbia non ignora questa realtà, fino al radicale rovesciamento operato da Cristo
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, giovedì 17 ottobre 2019)
- Proponiamo alcuni stralci del nuovo libro del cardinale Gianfranco Ravasi La santa violenza, in uscita oggi per Il Mulino (pagine 168, euro 14,00). Nel volume il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura esplora l’intreccio incandescente fra religione e violenza, dalle “guerre di Dio”, dove la violenza che reca il marchio sacrale al conflitto fra tribù alla guerra santa. Fino alla quasi scomparsa nei Vangeli, alla luce del dirompente messaggio di Cristo.
 Poi è la volta del fondamentalismo, «la lettera che uccide», un fenomeno che oggi riguarda soprattutto l’islam, ma che si inscrive anche nella tradizione ebraico-cristiana.
Poi è la volta del fondamentalismo, «la lettera che uccide», un fenomeno che oggi riguarda soprattutto l’islam, ma che si inscrive anche nella tradizione ebraico-cristiana.
 Infine, tocca il tema, vivo e lacerante ai nostri giorni, del rapporto con lo straniero: un incontro che può generare esclusione e rigetto, come emerge in vari passi biblici nazionalistici o etnocentrici, ma che può diventare anche dialogo, aprendosi all’universalismo della salvezza e all’uguaglianza di tutti gli esseri umani.
Infine, tocca il tema, vivo e lacerante ai nostri giorni, del rapporto con lo straniero: un incontro che può generare esclusione e rigetto, come emerge in vari passi biblici nazionalistici o etnocentrici, ma che può diventare anche dialogo, aprendosi all’universalismo della salvezza e all’uguaglianza di tutti gli esseri umani.
Sembra una ripresa cinematografica; è, invece, la descrizione di un poeta ebreo, il profeta Nahum, che nel 612 a.C. sta “sceneggiando” quasi in presa diretta la caduta di Ninive, la detestata capitale della superpotenza orientale, l’Assiria, sotto l’irruzione congiunta di Ciassare, re dei Medi, e di Nabopolassar, re della dinastia neobabilonese. Ecco la scena affidata a una sequenza impressionistica di azioni militari, costruita sulla secchezza di un elenco: «Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitìo di cavalli, cigolìo di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, s’inciampa nei cadaveri». Le pagine dell’Antico Testamento sono spesso striate dal sangue delle battaglie e si affacciano su rovine e devastazioni causate da eventi bellici. Una lingua lessicalmente povera come l’ebraico classico (5.750 vocaboli in tutto) si mostra sorprendentemente ricca quando deve designare la violenza
 Tanto per esemplificare, ecco la radice hms «fare violenza» (donde hamas «violenza»), o šddhrm «sterminare » (donde herem, la strage sacra), hrg «uccidere», rsh «assassinare», ‘nh «violentare, opprimere», hrs «distruggere », lhm «combattere » (donde milhamah «guerra»), nqm «vendicare», mhs «abbattere, fracassare», šht «mandare in rovina» e altri ancora.
Tanto per esemplificare, ecco la radice hms «fare violenza» (donde hamas «violenza»), o šddhrm «sterminare » (donde herem, la strage sacra), hrg «uccidere», rsh «assassinare», ‘nh «violentare, opprimere», hrs «distruggere », lhm «combattere » (donde milhamah «guerra»), nqm «vendicare», mhs «abbattere, fracassare», šht «mandare in rovina» e altri ancora.
 Un orizzonte cupo, segnato da conquiste e lotte, che per altro sembrano essere il basso continuo della storia umana, come pessimisticamente dichiarava Eraclito nel suo frammento 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi».
Un orizzonte cupo, segnato da conquiste e lotte, che per altro sembrano essere il basso continuo della storia umana, come pessimisticamente dichiarava Eraclito nel suo frammento 53: «La guerra (pólemos) è madre di tutte le cose e di tutte la regina (basiléus). Gli uni rende dèi, gli altri uomini; gli uni fa schiavi, gli altri liberi».
 Anche il Nuovo Testamento, che pure inalbera il vessillo dell’amore ed eredita l’aspirazione messianica biblica allo shalôm «pace», non ignora questa realtà aspra che costella le strade della vita dei popoli.
Anche il Nuovo Testamento, che pure inalbera il vessillo dell’amore ed eredita l’aspirazione messianica biblica allo shalôm «pace», non ignora questa realtà aspra che costella le strade della vita dei popoli.
 Lo stesso Gesù, ad esempio, ricorrerà a un modello di strategia militare applicandolo all’esistenza cristiana da vivere con intelligenza e sapienza: «Quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda un’ambasceria per chiedere pace».
Lo stesso Gesù, ad esempio, ricorrerà a un modello di strategia militare applicandolo all’esistenza cristiana da vivere con intelligenza e sapienza: «Quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda un’ambasceria per chiedere pace».
 La scelta radicale per il Regno di Dio, vero Leitmotiv della predicazione di Cristo, sarà da lui espressa con una dichiarazione paradossale, anche se evidentemente metaforica per indicare la natura “esplosiva” del suo messaggio: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada» [...].
La scelta radicale per il Regno di Dio, vero Leitmotiv della predicazione di Cristo, sarà da lui espressa con una dichiarazione paradossale, anche se evidentemente metaforica per indicare la natura “esplosiva” del suo messaggio: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada» [...].È indubbio che, sia a livello biblico sia nella storia della cristianità, questo intreccio tra guerra e religione è paradossalmente forte. Per stare alla Bibbia, basti solo pensare alle stragi sante - il cosiddetto herem o «sterminio sacro» - che accompagnano la conquista della Terra pro- messa da parte del popolo ebraico, oppure alle centinaia di testi violenti presenti nelle Scritture e alla stessa simbologia bellica usata per rappresentare il «Dio degli eserciti» (che, però, era originariamente un rimando all’armata astrale del Creatore, anche se poi applicata alle battaglie di Israele col palladio dell’Arca santa) [...]. Ci sono alcuni elementi di natura ermeneutica che dovremo costantemente ribadire [...]. Innanzitutto è da sottolineare la qualità storica della Rivelazione ebraico-cristiana, che nella Bibbia si presenta non come un’astratta serie di tesi teologiche speculative ma appunto come una concreta «storia di salvezza». All’interno degli eventi umani, spesso segnati dal peccato, dall’ingiustizia, dalla violenza, dal male, passa la presenza e l’opera di Dio che progressivamente e pazientemente cerca di condurre l’umanità verso un livello più puro, giusto e pacifico di vita. Il vertice è proprio - tenendo conto dell’unità «canonica » (cioè nell’unico Canone cristiano) dei due Testamenti - nella proclamazione: «Beati gli operatori di pace», formulata secondo lo spirito della citata «pace» messianica anticotestamentaria. La stessa tradizione giudaica successiva con rabbì Meir di Gher dichiarerà che «Dio non ha creato nulla di più bello della pace» [...].
Gesù, poi, nella sua proposta procederà fino alla scelta radicale dell’amore per il nemico così da trasformare quasi l’hostis in hospes e da introdurre il principio della non-violenza: «Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano».
 L’apostolo Paolo, in un passo della Lettera agli Efesini, ove elenca una completa attrezzatura militare (cinturone, corazza, calzature, scudo, frecce, elmo, spada), la trasfigura in una simbologia spirituale: «Attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace; afferrando lo scudo della fede col quale si possono spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno, prendendo l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Introduce, dunque, nel cuore dell’apparato militare, evocato già in chiave metaforica, il «vangelo della pace» come meta da raggiungere. Egli parla per due volte della panoplía, cioè dell’«armatura » di Dio che non è aggressiva contro gli altri ma solo contro il male diabolico: «Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo [...]. Prendete l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove».
L’apostolo Paolo, in un passo della Lettera agli Efesini, ove elenca una completa attrezzatura militare (cinturone, corazza, calzature, scudo, frecce, elmo, spada), la trasfigura in una simbologia spirituale: «Attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace; afferrando lo scudo della fede col quale si possono spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno, prendendo l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio». Introduce, dunque, nel cuore dell’apparato militare, evocato già in chiave metaforica, il «vangelo della pace» come meta da raggiungere. Egli parla per due volte della panoplía, cioè dell’«armatura » di Dio che non è aggressiva contro gli altri ma solo contro il male diabolico: «Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo [...]. Prendete l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove».
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
COME IL "PADRE" E’ ALL’ORIGINE ("URSPRUNG") DEL BAMBINO, COSI’ IL "POLEMOS" E’ ALL’ORIGINE DI TUTTE LE COSE: HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- "NON SAPEVO CHE DIO È SPIRITO": "LA MISURA DELLE COSE". In onore e in memoria di Maria Bettetini.17 ottobre 2019, di Federico La Sala
NON SAPEVO CHE DIO È SPIRITO....*
Lutto.
Addio a Maria Bettetini, filosofa e studiosa di sant’Agostino
È morta domenica 13 ottobre a Milano la filosofa Maria Bettetini, docente di Estetica, Retorica e Filosofia delle immagini. Il suo nome è però legato in particolare agli studi agostiniani-
di Francesco Ognibene (Avvenire, lunedì 14 ottobre 2019)
È morta domenica 13 ottobre a Milano la filosofa Maria Bettetini, studiosa di sant’Agostino, docente all’Università Iulm di Milano. 57 anni, milanese, figlia di Gianfranco, che fu pioniere all’Università Cattolica degli studi semiotici in Italia, Maria Bettetini ha insegnato dapprima Storia della filosofia medioevale all’Università Ca’ Foscari di Venezia e poi alla Iulm Estetica, Retorica e Filosofia delle immagini approfondendo in particolare lo statuto della finzione e dell’inganno, studi che hanno dato vita a uno dei suoi libri più noti, “Breve storia della bugia” (Cortina, 2001).
Il suo nome è però legato in particolare agli studi agostiniani, dal classico “Introduzione a Agostino” (Laterza, 2008) a un’edizione delle “Confessioni” da lei curata nel 2000 per Einaudi. Tra gli altri filoni dei quali è stata apprezzata studiosa va ricordato in particolare quello sull’iconoclastia, da “Contro le immagini” (Laterza, 2006) a “Distruggere il passato” (Cortina, 2016).
 Nel 2015 aveva pubblicato un suo omaggio alla filosofia, “La bellezza e il peccato” (Bompiani), una “piccola scuola” - come l’aveva definita - nata da una domanda: “Chi se non la buona filosofia può insegnare a cogliere la bellezza in questo mondo da salvare?”. Con i “Quattro modi dell’amore” (Laterza, 2012) aveva invece proposto un singolare itinerario filosofico e letterario attraverso amicizia, passione, amori folli o ideali e falsi amori.
Nel 2015 aveva pubblicato un suo omaggio alla filosofia, “La bellezza e il peccato” (Bompiani), una “piccola scuola” - come l’aveva definita - nata da una domanda: “Chi se non la buona filosofia può insegnare a cogliere la bellezza in questo mondo da salvare?”. Con i “Quattro modi dell’amore” (Laterza, 2012) aveva invece proposto un singolare itinerario filosofico e letterario attraverso amicizia, passione, amori folli o ideali e falsi amori.La sua intelligenza viva e penetrante, la spontanea disposizione a creare e mantenere relazioni profonde, la libertà di pensiero, la fede sempre intensamente vissuta hanno fatto di lei una figura di pensatrice originale e apprezzata e l’hanno resa naturalmente prossima al pensiero del vescovo di Ippona, del quale è stata instancabile divulgatrice, fino agli ultimi giorni prima di una morte prematura.
*
- "Non sapevo che Dio è spirito" (Agostino, Confessioni, III, 7, 12; cit. in Maria Bettetini, La misura delle cose, pref. di Giulio Giorello, Rusconi editore, Milano, 1994, p. 15).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
FREUD, KANT, E I SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA -- FILOLOGIA E "ARCHEOLOGIA". Considerazioni a margine dell’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò (Lecce).
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- La dea "Hostilina", l’ostia, e l’ospitalità. Chi è effettivamente l’ospite (di Angela Frati e Stefania Iannizzotto).4 ottobre 2019, di Federico La Sala
Chi è effettivamente l’ospite
- Quesito:
- È molta la curiosità dei nostri lettori intorno alla parola ospite: perché in italiano indica sia chi riceve ospitalità sia chi dà ospitalità?
Chi è effettivamente l’ospite
Come si legge in tutti i vocabolari dell’italiano contemporaneo, ospite ha un duplice significato: è sia chi dà ospitalità (un ospite premuroso) sia, più comunemente, chi la riceve (un ospite gradito). Con il primo significato si ritrova soprattutto in contesti formali e letterari (nel GDLI si riscontrano esempi a partire dalla prima metà del XIV secolo fino ad autori quali Foscolo, Manzoni, Pascoli ecc.).
La parola ospite deriva dal latino hospes, -ĭtis, che aveva già il doppio significato di ‘colui che ospita e quindi albergatore’ e di ‘colui che è ospitato e quindi forestiero’, significato - comune alla parola greca xénos - che si è tramandato in quasi tutte le lingue romanze (antico francese (h)oste; francese moderno hôte; occitano e catalano oste; spagnolo huésped; portoghese hóspede). Ed è dunque proprio alla storia della lingua latina che dovremo guardare per rispondere alla curiosità che questa parola suscita.
L’etimologia del termine latino hospes risulta spesso incerta nei più comuni dizionari della lingua italiana e, se vengono date delle spiegazioni, esse risultano parziali e non rispondono pienamente alla nostra domanda. Ad esempio, il Devoto-Oli 2012 e il Sabatini-Coletti 2008 fanno risalire la voce a un più antico *hostipotis, composto da hŏstis ‘straniero’ e pŏtis ‘signore, padrone’, cioè ‘signore dello straniero’, ma non dicono niente di più. Il Vocabolario Treccani scrive sinteticamente che il termine ha “tutti e due i significati fondamentali, in quanto la parola alludeva soprattutto ai reciproci doveri dell’ospitalità”, in accordo con il Dir Dizionario italiano ragionato (D’Anna, 1988).
Tra gli etimologici, il DELI riconosce il doppio significato del termine, ma aggiunge “senza etimologia evidente”. L’etimologico di Nocentini approfondisce invece la questione e rimanda all’indoeuropeo *ghos(ti)-potis ‘signore dello straniero’ cioè il padrone di casa che esercitava il diritto di ospitalità nei confronti del forestiero, composto da *ghostis ‘straniero’ e *potis ‘signore’. A favore di tale ipotesi cita i corrispettivi gospodĭ ‘padrone, signore’ in antico slavo e gospodín ‘signore’ in russo.
Hospesin origine è dunque il “padrone di casa” che dà ospitalità al forestiero; i rapporti che si istauravano tra chi accoglieva e chi era accolto erano così stretti - legati anche al fatto che chi era ospitato si impegnava a sua volta a ricambiare l’ospitalità - che, sin dai tempi più antichi, hospes ha indicato anche la persona accolta in casa d’altri. La reciprocità del patto di ospitalità è dunque all’origine del doppio significato della parola ospite. Riconoscendo questa “squisita umanità degli antichi”, anche Leopardi nello Zibaldone scriveva: “di tal genere è ancora quella tanta ospitalità esercitata dagli antichi con tanto scrupolo, e protetta da tanto severe leggi, opinioni religiose ecc. quei diritti d’ospizio ecc. affinità d’ospizio ecc. Ben diversi in ciò dai moderni” (5 luglio 1827).
Vale la pena soffermarsi un po’ di più sulla parola hostis che, insieme a potis ‘signore’, è all’origine di hospes. Emile Benveniste introduce così la questione:
- Tra i termini comuni al vocabolario preistorico delle lingue dell’Europa, questo ha un interesse particolare: hŏstis del latino corrisponde al gasts del gotico e al gostĭ dell’antico slavo, che presenta inoltre gos-podĭ ‘signore’, formato come hospes. Ma il senso del gotico gasts e dell’antico slavo gostĭ è ‘ospite’, quello del latino hŏstis è ‘nemico’. Per spiegare il rapporto tra ‘ospite’ e ‘nemico’, si ammette di solito che l’uno e l’altro derivino dal senso di ‘straniero’ che è ancora attestato in latino; da cui ‘straniero favorevole → ospite’ e ‘straniero ostile → nemico’.
Benveniste ricorda, infatti, che hostis è usato nella Legge delle XII tavole con il valore arcaico di ‘straniero’, ma riporta anche un’interessante testimonianza di Sesto Pompeo Festo (II secolo d.C.) da cui si ricava che il termine hostis indicava colui a cui erano riconosciuti gli stessi diritti del popolo Romano (quod erant pari iure cum populo Romano). A conferma di ciò Festo ricorda anche che il verbo hostire aveva lo stesso significato di aequare (con valore simile si trovano hostire in Plauto, hostus in Varrone e il nome della dea Hostilina in sant’Agostino). Il legame di hostis con i concetti di uguaglianza e di reciprocità è confermato anche da una parola più conosciuta, hostia, che nel rituale romano indica propriamente ‘la vittima che serve a compensare l’ira degli dei’ (l’offerta è considerata quindi di un valore tale da bilanciare l’offesa), in contrapposizione con il termine meno specifico victima che indica un semplice ‘animale offerto in sacrificio’ (cioè senza nessun intento riparatorio).
Si ricava dunque che il significato originario di hostis non era quello di ‘straniero’ in generale, né tanto meno di ‘nemico’, ma quello di ‘straniero a cui si riconoscono dei diritti uguali a quelli dei cittadini romani’, a differenza del peregrinus che indica invece ‘colui che abita al di fuori del territorio’.
 Il legame di uguaglianza e reciprocità che si stabilisce tra un hostis e un cittadino di Roma conduce alla nozione di ospitalità.
Il legame di uguaglianza e reciprocità che si stabilisce tra un hostis e un cittadino di Roma conduce alla nozione di ospitalità.
 In un dato momento dunque hostis ha indicato ‘colui che è in relazione di compenso’ e di scambio nei confronti del civis e quindi, in ultima analisi, l’ospite. Di questo erano ben consapevoli gli scrittori classici, come scrive Cicerone nel De officiis: “hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus” [infatti i nostri antenati chiamavano hostis quello che noi oggi chiamiamo peregrinus (‘forestiero’)].
In un dato momento dunque hostis ha indicato ‘colui che è in relazione di compenso’ e di scambio nei confronti del civis e quindi, in ultima analisi, l’ospite. Di questo erano ben consapevoli gli scrittori classici, come scrive Cicerone nel De officiis: “hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus” [infatti i nostri antenati chiamavano hostis quello che noi oggi chiamiamo peregrinus (‘forestiero’)].Più tardi, quando alle relazioni di scambio tra clan e clan sono subentrate le relazioni di inclusione o di esclusione dalla civitas, hostis ha assunto un’accezione negativa e ha preso il significato classico di ‘nemico’ (da cui deriva, per esempio, la parola italiana ostile), e in tal senso la storia di hostis riassume il cambiamento che le istituzioni romane hanno attraversato nei secoli.
 In conseguenza del vuoto semantico lasciato da hostis si è dovuto pertanto ricorrere a un nuovo termine per indicare la nozione di ospitalità e si è creato, come già detto, partendo dalla stessa parola hostis, il termine hospes. Hospes dunque eredita e conserva in sé il valore intrinseco di reciprocità e di mutuo scambio: è forse anche per questo che la stessa parola nelle lingue derivate dal latino ha facilmente continuato a indicare sia chi ospita sia chi è ospitato.
In conseguenza del vuoto semantico lasciato da hostis si è dovuto pertanto ricorrere a un nuovo termine per indicare la nozione di ospitalità e si è creato, come già detto, partendo dalla stessa parola hostis, il termine hospes. Hospes dunque eredita e conserva in sé il valore intrinseco di reciprocità e di mutuo scambio: è forse anche per questo che la stessa parola nelle lingue derivate dal latino ha facilmente continuato a indicare sia chi ospita sia chi è ospitato.Un’ultima osservazione. Un lettore, un po’ infastidito dalla polisemia di ospite e preoccupato che nella lingua comune non ci sia una parola per indicare ‘colui che ospita’, propone di usare due termini diversi come nella lingua inglese, che ha host per ‘ospitante’ e guest per ‘ospitato’ (da notare che entrambi i termini derivano dalla stessa radice indoeuropea *ghostis, anche se host passa attraverso il francese antico (h)oste). Ci suggerisce, come sostantivo per indicare chi ospita, il termine ospitante (o addirittura trimalcione). Ma in realtà, come spesso accade nei fatti di lingua, sarà probabilmente l’uso alla fine a trovare da solo la soluzione. E a ben guardare, quando è necessario distinguere tra i due significati di ospite, l’italiano ha già preso delle decisioni e mette a disposizione un ventaglio di scelte. Se per ospite ormai si intende comunemente ‘colui che è ospitato’, per indicare ‘colui che ospita’ invece, in relazione al contesto e al grado di formalità, si può oggi già scegliere tra: il forse troppo letterario ospitatore (cfr. GDLI), il padrone di casa o semplicemente l’amico che mi ospita. Infine, il termine ospitante con il valore di ‘chi dà ospitalità’ esiste già in italiano, ad esempio nelle espressioni squadra ospitante e famiglia ospitante, e può darsi che prima o poi riuscirà a imporsi pienamente sul termine ospite con lo stesso valore.
Per approfondimenti:
 E. Benveniste, Il vocabolario della istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società, I, edizione italiana a cura di Mariantonia Liborio, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-75
E. Benveniste, Il vocabolario della istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società, I, edizione italiana a cura di Mariantonia Liborio, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-75
 Dictionnaire Étymologique de la langue latine, a cura di A. Ernout e A. Meillet, Parigi, Librairie C. Klincksieck, 1967, s.v. hospes
Dictionnaire Étymologique de la langue latine, a cura di A. Ernout e A. Meillet, Parigi, Librairie C. Klincksieck, 1967, s.v. hospes
 E. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, Padova, Tipografia del Seminario, 1771, s.v. hospes
Thesaurus linguae Latinae, Leipzig, Teubner, 1900 e sgg.,.s.v. hospes
E. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, Padova, Tipografia del Seminario, 1771, s.v. hospes
Thesaurus linguae Latinae, Leipzig, Teubner, 1900 e sgg.,.s.v. hospes
 F. Venier, La corrente di Humboldt. Una lettura di La lingua franca di Hugo Schuchardt, Roma, Carocci, 2012
F. Venier, La corrente di Humboldt. Una lettura di La lingua franca di Hugo Schuchardt, Roma, Carocci, 2012*
A cura di Angela Frati e Stefania Iannizzotto
 Redazione Consulenza Linguistica
Redazione Consulenza Linguistica
 Accademia della Crusca (13 luglio 2012).
Accademia della Crusca (13 luglio 2012). -
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di carne (Papa Francesco).19 giugno 2019, di Federico La Sala
Catechesi sugli Atti degli Apostoli: 3. «Lingue come di fuoco» (At 2,3). La Pentecoste e la dynamis dello Spirito che infiamma la parola umana e la rende Vangelo *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, in quel cenacolo che è ormai la loro casa e dove la presenza di Maria, madre del Signore, è l’elemento di coesione, gli Apostoli vivono un evento che supera le loro aspettative. Riuniti in preghiera - la preghiera è il “polmone” che dà respiro ai discepoli di tutti i tempi; senza preghiera non si può essere discepolo di Gesù; senza preghiera noi non possiamo essere cristiani! È l’aria, è il polmone della vita cristiana -, vengono sorpresi dall’irruzione di Dio. Si tratta di un’irruzione che non tollera il chiuso: spalanca le porte attraverso la forza di un vento che ricorda la ruah, il soffio primordiale, e compie la promessa della “forza” fatta dal Risorto prima del suo congedo (cfr At 1,8). Giunge all’improvviso, dall’alto, «un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano» (At 2,2).
Al vento poi si aggiunge il fuoco che richiama il roveto ardente e il Sinai col dono delle dieci parole (cfr Es 19,16-19). Nella tradizione biblica il fuoco accompagna la manifestazione di Dio. Nel fuoco Dio consegna la sua parola viva ed energica (cfr Eb 4,12) che apre al futuro; il fuoco esprime simbolicamente la sua opera di scaldare, illuminare e saggiare i cuori, la sua cura nel provare la resistenza delle opere umane, nel purificarle e rivitalizzarle. Mentre al Sinai si ode la voce di Dio, a Gerusalemme, nella festa di Pentecoste, a parlare è Pietro, la roccia su cui Cristo ha scelto di edificare la sua Chiesa. La sua parola, debole e capace persino di rinnegare il Signore, attraversata dal fuoco dello Spirito acquista forza, diventa capace di trafiggere i cuori e di muovere alla conversione. Dio infatti sceglie ciò che nel mondo è debole per confondere i forti (cfr 1Cor 1,27).
La Chiesa nasce quindi dal fuoco dell’amore e da un “incendio” che divampa a Pentecoste e che manifesta la forza della Parola del Risorto intrisa di Spirito Santo. L’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio che fa nuove tutte le cose e si incide in cuori di carne.
La parola degli Apostoli si impregna dello Spirito del Risorto e diventa una parola nuova, diversa, che però si può comprendere, quasi fosse tradotta simultaneamente in tutte le lingue: infatti «ciascuno li udiva parlare nella propria lingua» (At 2,6). Si tratta del linguaggio della verità e dell’amore, che è la lingua universale: anche gli analfabeti possono capirla. Il linguaggio della verità e dell’amore lo capiscono tutti. Se tu vai con la verità del tuo cuore, con la sincerità, e vai con amore, tutti ti capiranno. Anche se non puoi parlare, ma con una carezza, che sia veritiera e amorevole.
Lo Spirito Santo non solo si manifesta mediante una sinfonia di suoni che unisce e compone armonicamente le diversità ma si presenta come il direttore d’orchestra che fa suonare le partiture delle lodi per le «grandi opere» di Dio. Lo Spirito santo è l’artefice della comunione, è l’artista della riconciliazione che sa rimuovere le barriere tra giudei e greci, tra schiavi e liberi, per farne un solo corpo. Egli edifica la comunità dei credenti armonizzando l’unità del corpo e la molteplicità delle membra. Fa crescere la Chiesa aiutandola ad andare al di là dei limiti umani, dei peccati e di qualsiasi scandalo.
La meraviglia è tanta, e qualcuno si chiede se quegli uomini siano ubriachi. Allora Pietro interviene a nome di tutti gli Apostoli e rilegge quell’evento alla luce di Gioele 3, dove si annuncia una nuova effusione dello Spirito Santo. I seguaci di Gesù non sono ubriachi, ma vivono quella che Sant’Ambrogio definisce «la sobria ebbrezza dello Spirito», che accende in mezzo al popolo di Dio la profezia attraverso sogni e visioni. Questo dono profetico non è riservato solo ad alcuni, ma a tutti coloro che invocano il nome del Signore.
D’ora innanzi, da quel momento, lo Spirito di Dio muove i cuori ad accogliere la salvezza che passa attraverso una Persona, Gesù Cristo, Colui che gli uomini hanno inchiodato al legno della croce e che Dio ha risuscitato dai morti «liberandolo dai dolori della morte (At 2,24). È Lui che ha effuso quello Spirito che orchestra la polifonia di lodi e che tutti possono ascoltare. Come diceva Benedetto XVI, «la Pentecoste è questo: Gesù, e mediante Lui Dio stesso, viene a noi e ci attira dentro di sé» (Omelia, 3 giugno 2006). Lo Spirito opera l’attrazione divina: Dio ci seduce con il suo Amore e così ci coinvolge, per muovere la storia e avviare processi attraverso i quali filtra la vita nuova. Solo lo Spirito di Dio infatti ha il potere di umanizzare e fraternizzare ogni contesto, a partire da coloro che lo accolgono.
Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pentecoste, che dilati i nostri cuori e sintonizzi i nostri sentimenti con quelli di Cristo, così che annunciamo senza vergogna la sua parola trasformante e testimoniamo la potenza dell’amore che richiama alla vita tutto ciò che incontra.
* PAPA FRANCESCO
 UDIENZA GENERALE
UDIENZA GENERALE
 Piazza San Pietro
Piazza San Pietro
 Mercoledì, 19 giugno 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 19 giugno 2019 (ripresa parziale).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?" (Luca 12:54-59). Una nota di Antonio Thellung, da"mosaico di pace"
Federico La Sala
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Quale Trinità quella di Adamo ed Abramo e/o di Giuseppe e Gesù?!17 giugno 2019, di Federico La Sala
LA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA O LA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA?! Al di là della Trintà edipica....*
La Trinità
di José Tolentino Mendonça (Avvenire, domenica 16 giugno 2019)
Come si rappresenta il mistero? Noi ci accostiamo a esso a tastoni, consapevoli che i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre immagini vacillano e arrivano appena a intravvederne, poveramente, la realtà. Ma questo nostro tentativo di approssimazione costituisce comunque un importante patrimonio di fede.
Pensiamo ad Andrej Rublëv: siamo nella seconda metà del XV secolo quando egli crea quella che sarà la più celebre icona della Trinità. Il testo biblico soggiacente (Gen 18,1-15) è quello dell’ospitalità che Abramo offre ai tre personaggi celesti che lo visitano. Nella contemplazione di questa stupenda icona della Trinità, l’orante viene condotto al centro del mistero di Dio.
In effetti, ciò che vien lì focalizzato è il Dio unico, un solo Dio con la stessa natura divina in tre persone. I tratti fisionomici coincidono esattamente, come se fosse la medesima figura mostrata per tre volte, anche se in tre posizioni differenti.
I personaggi hanno lo stesso volto, lo stesso atteggiamento del corpo, le stesse ali. Inoltre, tutti hanno in mano uno scettro e posseggono un’aureola per indicare eguali dignità e regalità.
Ciascun personaggio, però, occupa una posizione differente nello spazio e sono diversi i gesti, i colori degli abiti e il gioco degli sguardi.
Il Padre, da cui proviene ogni benedizione, guarda all’umanità attraverso il Figlio. E il Figlio guarda a noi attraverso lo Spirito Santo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- PROVANDO E RIPROVANDO. LA STELLA E IL NARDO .... Ripartire dalle radici moderne, eu-angeliche e francescane -dal "presepe"!
"NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- Il ""Charis", il Rinnovamento Carismatico Cattolico, in Vaticano, per la solennità di Pentecoste.7 giugno 2019, di Federico La Sala
Santa Sede: nasce Charis per il Rinnovamento Carismatico Cattolico
CHARIS in Vaticano. Il nostro sogno è fare comunione. Ce lo chiede il Papa
I responsabili del Rinnovamento Carismatico Cattolico si incontrano in Vaticano da oggi fino a sabato 8 giugno per pregare insieme in attesa dell’apertura ufficiale di Charis
di Emanuela Campanile (Vatican News, 06 giugno 2019)
Città del Vaticano Si sono dati appuntamento in Vaticano - Aula Paolo VI - e arrivano da tutto il mondo. Sono più di 550 e sono i responsabili del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Vogliono pregare insieme e mettersi all’ascolto dello Spirito Santo in attesa dell’inizio ufficiale di Charis previsto proprio domenica 9 giugno: solennità di Pentecoste. Voluto espressamente da Papa Francesco, Charis (Catholic Charismatic Renewal International Service) segna una nuova tappa per il Rinnovamento Carismatico Cattolico come corrente di grazia nel cuore della Chiesa.
Il Charis
Si tratta di un servizio di comunione tra tutte le realtà del Rinnovamento Carismatico Cattolico che, nel mondo, conta attualmente più di 120 milioni di cattolici che vivono l’esperienza del battesimo nello Spirito in gruppi di preghiera, comunità, scuole di evangelizzazione, reti di comunicazioni e ministeri vari. Quando nella solennità di Pentecoste prenderà ufficialmente il via, l’Iccrs e il Catholic Fraternity cesseranno di esistere.
Rinnovamento come corrente di grazia
"Il nostro sogno è fare ciò che il Papa ci ha chiesto", spiega nell’intervista Jean-Luc Moens, il professore belga nominato moderatore di Charis. "Lui parla del Rinnovamento carismatico come di una corrente di grazia nella Chiesa, riprendendo l’espressione dal cardinale Suenens, il quale voleva sottolineare che il Rinnovamento Carismatico non è un movimento, perché - prosegue il professore - in un movimento c’è un’appartenenza; le persone sono o dentro o fuori. Dunque, c’è una separazione. Una corrente di grazia è un’altra cosa. Il cardinale faceva il paragone con la corrente del Golfo nell’Atlantico che riscalda tutto l’oceano e poi sparisce. Allora, forse posso dire qualcosa di abbastanza strano, ma - conclude - il nostro sogno è quello di sparire quando tutta la Chiesa avrà scoperto il battesimo nello Spirito Santo".
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- "risulta scandaloso vedere operatori di carità che la trasformano in business: parlano tanto della carità ma vivono nel lusso o nella dissipazione" (papa Francesco).28 maggio 2019, di Federico La Sala
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO PROMOSSO DA CARITAS INTERNATIONALIS
 Sala Clementina
Sala Clementina
 Lunedì, 27 maggio 2019
Lunedì, 27 maggio 2019Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle,
sono lieto di avere questa opportunità di incontrarvi in occasione della vostra XXI Assemblea Generale. Ringrazio il Cardinale Tagle per le parole che mi ha indirizzato e rivolgo un cordiale saluto a tutti voi, alla grande famiglia della Caritas e a quanti nei vostri rispettivi Paesi si impegnano nel servizio della carità.
In questi giorni, provenendo da ogni parte del mondo, avete vissuto un momento significativo nella vita della Confederazione, finalizzato non solo ad adempiere ai doveri statutari, ma anche a rafforzare i vincoli di comunione reciproca nell’adesione al Successore di Pietro, a motivo dello speciale legame esistente tra la vostra organizzazione e la Sede Apostolica. Infatti, San Giovanni Paolo II volle conferire a Caritas Internationalis la personalità giuridica canonica pubblica, chiamandovi a condividere la missione stessa della Chiesa nel servizio della carità.
Oggi vorrei soffermarmi a riflettere brevemente con voi su tre parole-chiave: carità, sviluppo integrale e comunione.
Considerata la missione che la Caritas è chiamata a svolgere nella Chiesa, è importante tornare sempre a riflettere assieme sul significato della stessa parola carità. La carità non è una sterile prestazione oppure un semplice obolo da devolvere per mettere a tacere la nostra coscienza. Quello che non dobbiamo mai dimenticare è che la carità ha la sua origine e la sua essenza in Dio stesso (cfr Gv 4,8); la carità è l’abbraccio di Dio nostro Padre ad ogni uomo, in modo particolare agli ultimi e ai sofferenti, i quali occupano nel suo cuore un posto preferenziale. Se guardassimo alla carità come a una prestazione, la Chiesa diventerebbe un’agenzia umanitaria e il servizio della carità un suo “reparto logistico”. Ma la Chiesa non è nulla di tutto questo, è qualcosa di diverso e di molto più grande: è, in Cristo, il segno e lo strumento dell’amore di Dio per l’umanità e per tutto il creato, nostra casa comune.
La seconda parola è sviluppo integrale. Nel servizio della carità è in gioco la visione dell’uomo, la quale non può ridursi a un solo aspetto ma coinvolge tutto l’essere umano in quanto figlio di Dio, creato a sua immagine. I poveri sono anzitutto persone,e nei loro volti si cela quello di Cristo stesso. Essi sono sua carne, segni del suo corpo crocifisso, e noi abbiamo il dovere di raggiungerli anche nelle periferie più estreme e nei sotterranei della storia con la delicatezza e la tenerezza della Madre Chiesa. Dobbiamo puntare alla promozione di tutto l’uomo e di tutti gli uomini affinché siano autori e protagonisti del proprio progresso (cfr S. Paolo VI, Enc. Populorum progressio, 34).
 Il servizio della carità deve, pertanto, scegliere la logica dello sviluppo integrale come antidoto alla cultura dello scarto e dell’indifferenza. E rivolgendomi a voi, che siete la Caritas, voglio ribadire che «la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 200). Voi lo sapete bene: la grandissima parte dei poveri «possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede» (ibid.). Pertanto, come ci insegna anche l’esempio dei Santi e delle Sante della carità, «l’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (ibid.).
Il servizio della carità deve, pertanto, scegliere la logica dello sviluppo integrale come antidoto alla cultura dello scarto e dell’indifferenza. E rivolgendomi a voi, che siete la Caritas, voglio ribadire che «la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 200). Voi lo sapete bene: la grandissima parte dei poveri «possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede» (ibid.). Pertanto, come ci insegna anche l’esempio dei Santi e delle Sante della carità, «l’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (ibid.).La terza parola è comunione, che è centrale nella Chiesa, definisce la sua essenza. La comunione ecclesiale nasce dall’incontro con il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che, mediante l’annuncio della Chiesa, raggiunge gli uomini e crea comunione con Lui stesso e con il Padre e lo Spirito Santo (cfr 1 Gv 1,3). È la comunione in Cristo e nella Chiesa che anima, accompagna, sostiene il servizio della carità sia nelle comunità stesse sia nelle situazioni di emergenza in tutto il mondo. In questo modo, la diakonia della carità diventa strumento visibile di comunione nella Chiesa (cfr Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 4). Per questo, come Confederazione siete accompagnati dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che ringrazio per il lavoro che svolge ordinariamente e, in particolare, per il sostegno alla missione ecclesiale di Caritas Internationalis. Ho detto che siete accompagnati: non siete “sotto”.
Riprendendo questi tre aspetti fondamentali per vivere nella Caritas, ossia la carità, lo sviluppo integrale e la comunione, vorrei esortarvi a viverli con stile di povertà, di gratuità e di umiltà.
Non si può vivere la carità senza avere relazioni interpersonali con i poveri: vivere con i poveri e per i poveri. I poveri non sono numeri ma persone. Perché vivendo con i poveri impariamo a praticare la carità con lo spirito di povertà, impariamo che la carità è condivisione. In realtà, non solo la carità che non arriva alla tasca risulta una falsa carità, ma la carità che non coinvolge il cuore, l’anima e tutto il nostro essere è un’idea di carità ancora non realizzata.
Occorre essere sempre attenti a non cadere nella tentazione di vivere una carità ipocrita o ingannatrice, una carità identificata con l’elemosina, con la beneficienza, oppure come “pillola calmante” per le nostre inquiete coscienze. Ecco perché si deve evitare di assimilare l’operato della carità con l’efficacia filantropica o con l’efficienza pianificatrice oppure con l’esagerata ed effervescente organizzazione.
Essendo la carità la più ambita delle virtù alla quale l’uomo possa aspirare per poter imitare Dio, risulta scandaloso vedere operatori di carità che la trasformano in business: parlano tanto della carità ma vivono nel lusso o nella dissipazione oppure organizzano Forum sulla carità sprecando inutilmente tanto denaro. Fa molto male constatare che alcuni operatori di carità si trasformano in funzionari e burocrati.
Ecco perché vorrei ribadire che la carità non è un’idea o un pio sentimento, ma è l’incontro esperienziale con Cristo; è il voler vivere con il cuore di Dio che non ci chiede di avere verso i poveri un generico amore, affetto, solidarietà, ecc., ma di incontrare in loro Lui stesso (cfr Mt 25,31-46), con lo stile di povertà.
Cari amici, vi ringrazio, a nome di tutta la Chiesa, per quello che fate con e per tanti fratelli e sorelle che fanno fatica, che sono lasciati ai margini, che sono oppressi dalle schiavitù dei nostri giorni, e vi incoraggio ad andare avanti! Possiate tutti voi, in comunione con le comunità ecclesiali a cui appartenete e di cui siete espressione, continuare a dare con gioia il vostro contributo perché cresca nel mondo il Regno di Dio, Regno di giustizia, di amore e di pace. Vi nutra e vi illumini sempre il Vangelo, e vi guidi l’insegnamento e la cura pastorale della madre Chiesa.
Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
-
> LA RISURREZIONE, IL CASO DELLA DONNA DAI SETTE MARITI, IL "FUOCO" DI PASCAL, E IL PROBLEMA DI NICODEMO. Note.19 maggio 2019, di Federico La Sala
NICODEMO 0 DELLA NASCITA: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3). *
- LA RISURREZIONE E IL CASO DELLA DONNA DAI SETTE MARITI. «Gesù rispose: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè, a proposito del roveto, quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui» (Luca, 20, 34-38).
Luca, l’evangelista delle donne (blog di Gianfranco Ravasi, Cardinale arcivescovo e biblista)
Il caso della donna dai sette mariti
di Gianfranco Ravasi (Famiglia Cristiana, 16 maggio 2019)
Siamo in pieno periodo pasquale ed è quindi significativo affrontare un tema connesso con la risurrezione, un argomento che già ai tempi di Gesù era oggetto di dispute con posizioni antitetiche. Noi consideriamo il soggetto secondo un curioso profilo femminile. Si tratta di un caso estremo ipotetico che gli avversari propongono a Gesù per metterlo in difficoltà (l’episodio, citato anche da Matteo e Marco, è da leggere in Luca 20,27-40). Nell’Antico Testamento era codificata una prassi secondo la quale, se un uomo sposato decedeva senza figli, l’eventuale fratello ne doveva sposare la vedova, così da assicurare una discendenza e una memoria al defunto.
Si trattava del cosiddetto “levirato” (dal latino levir, “cognato”), come facilmente si può comprendere da chi era coinvolto in questa normativa (Deuteronomio 25,5-10). Il nostro compito ora è spiegare il caso limite addotto dagli avversari di Gesù appartenenti alla corrente aristocratico-conservatrice dei sadducei a prevalenza sacerdotale. Essi negavano la risurrezione perché tale dottrina, pur presente nella Bibbia (si veda Ezechiele 37), era assente nella Torah (la Legge), ossia nei primi cinque libri della Sacra Scrittura.
Essi puntano a mettere in imbarazzo il rabbì di Nazaret prospettandogli una catena di “levirati” che hanno per protagonista una sola donna: ben sette fratelli subentrano in matrimoni successivi, morendo però tutti prima di aver assicurato una discendenza alla vedova e, quindi, al loro primo fratello defunto. Il paradosso fittizio è introdotto per costringere Gesù a schierarsi con loro contro i farisei - l’altra corrente giudaica avversaria - negando la risurrezione che questi ultimi sostenevano come dottrina di fede. Infatti, sogghignando, alla fine gli domandano: «Alla risurrezione, di quale dei sette la donna sarà moglie?».
Cristo, nella sua risposta, non cade nel tranello e replica volando alto: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio» (Luca 20,34-36). Egli nega, così, una lettura “materialistica” della risurrezione. E aggiunge una motivazione teologica ulteriore, citando un passo dell’incontro di Mosè con il Signore al roveto ardente del Sinai: «Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui» (Luca 20,37-38; cf. Esodo 3,6).
Dio non si lega a cadaveri, ma a esseri viventi ai quali apre un orizzonte di vita oltre la morte secondo categorie differenti rispetto a quelle meramente “carnali”, basate sulla nostra storia che si muove sulla base delle coordinate spazio-temporali. Si tratta di un nuovo ordine di rapporti, di una nuova creazione, di un orizzonte nel quale i vincoli parentali e sociali sono trasfigurati. Queste parole di Gesù avevano conquistato quel grande filosofo e scienziato credente che fu Blaise Pascal. A partire dal 1654 fino alla morte (1662) egli le portò sempre con sé, scritte su un foglio, cucito nella fodera del farsetto, intitolato “Fuoco”, e scoperto alla morte del pensatore da un domestico.
Eccone il testo modulato sulle parole di Gesù, commentate liberamente da Pascal: «Dio d’Abramo, Dio d’Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti. Certezza, certezza. Sentimento. Gioia. Pace. Dio di Gesù Cristo. Dio mio e Dio vostro. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Oblio del mondo e di tutto fuorché di Dio. Egli non si trova se non per le vie indicate dal Vangelo».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "NICODEMO O DELLA NASCITA": HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI).
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
 L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> LA RISURREZIONE, IL CASO DELLA DONNA DAI SETTE MARITI, IL "FUOCO" DI PASCAL, E IL PROBLEMA DI NICODEMO. --- Papa Francesco, Gesù e i Farisei. Discorso ufficiale al Convegno al Pontificio Istituto Biblico.20 maggio 2019, di Federico La Sala
Papa Francesco, Gesù e i Farisei. Discorso ufficiale di Francesco ai partecipanti al Convegno al Pontificio Istituto Biblico sui Farisei.
- Il testo dell’udienza di Francesco in pdf: Udienza papa Francesco ai partecipanti al Convegno sui Farisei, Osservatore Romano 10 5 2019.
 Di seguito, il testo integrale dell’udienza. *
Di seguito, il testo integrale dell’udienza. *
Cari fratelli e sorelle, vi accolgo con piacere in occasione del 110° anniversario del Pontificio Istituto Biblico, e ringrazio il Rettore per le sue cortesi parole. Quando nel 1909 San Pio X fondò il “Biblicum”, affidò ad esso la missione di essere «un centro di alti studi della Sacra Scrittura nella città di Roma, per promuovere il più efficacemente possibile la dottrina biblica e gli studi connessi secondo lo spirito della Chiesa cattolica» (Litt. Ap. Vinea electa, 7 maggio 1909: aas 1 [1909], 447-448).
Da allora, questo Istituto ha lavorato per rimanere fedele alla sua missione, anche in tempi difficili, e ha molto contribuito a promuovere la ricerca accademica e l’insegnamento negli studi biblici e nei campi correlati per studenti e futuri professori che provengono da una settantina di Paesi diversi. Il Card. Augustin Bea, per molto tempo Rettore del “Biblico” prima di essere creato cardinale, è stato il principale promotore della Dichiarazione conciliare Nostra aetate, che ha posto su nuove fondamenta le relazioni interreligiose e in particolare quelle ebraico-cattoliche. Negli ultimi anni l’Istituto ha intensificato la sua collaborazione con studiosi ebrei e protestanti.
Do il benvenuto ai partecipanti al Convegno su “Gesù e i Farisei. Un riesame interdisciplinare”, che intende affrontare una domanda specifica e importante per il nostro tempo e si presenta come un risultato diretto della Dichiarazione Nostra aetate. Esso si propone di capire i racconti, a volte polemici, riguardanti i Farisei nel Nuovo Testamento e in altre fonti antiche. Inoltre, affronta la storia delle interpretazioni erudite e popolari tra ebrei e cristiani. Tra i cristiani e nella società secolare, in diverse lingue la parola “fariseo” spesso significa “persona ipocrita” o “presuntuoso”. Per molti ebrei, tuttavia, i Farisei sono i fondatori del giudaismo rabbinico e quindi i loro antenati spirituali.
La storia dell’interpretazione ha favorito immagini negative dei Farisei, anche senza una base concreta nei resoconti evangelici. E spesso, nel corso del tempo, tale visione è stata attribuita dai cristiani agli ebrei in generale. Nel nostro mondo, tali stereotipi negativi sono diventati purtroppo molto comuni. Uno degli stereotipi più antichi e più dannosi è proprio quello di “fariseo”, specialmente se usato per mettere gli ebrei in una luce negativa.
Recenti studi riconoscono che oggi sappiamo meno dei Farisei di quanto pensassero le generazioni precedenti. Siamo meno certi delle loro origini e di molti dei loro insegnamenti e delle loro pratiche. Pertanto, la ricerca interdisciplinare su questioni letterarie e storiche riguardanti i Farisei affrontate da questo convegno aiuterà ad acquisire una visione più veritiera di questo gruppo religioso, contribuendo anche a combattere l’antisemitismo.
Se prendiamo in considerazione il Nuovo Testamento, vediamo che San Paolo annovera tra quelli che una volta, prima di incontrare il Signore Gesù, erano i suoi motivi di vanto anche il fatto di essere «quanto alla Legge, fariseo» (Fil 3, 5).
Gesù ha avuto molte discussioni con i Farisei su preoccupazioni comuni. Ha condiviso con loro la fede nella risurrezione (cfr. Mc 12, 18-27) e ha accettato altri aspetti della loro interpretazione della Torah. Se il libro degli Atti degli Apostoli asserisce che alcuni Farisei si unirono ai seguaci di Gesù a Gerusalemme (cfr. 15, 5), significa che doveva esserci molto in comune tra Gesù e i Farisei. Lo stesso libro presenta Gamaliele, un leader dei Farisei, che difende Pietro e Giovanni (cfr. 5, 34-39).
Tra i momenti più significativi del Vangelo di Giovanni c’è l’incontro di Gesù con un fariseo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei (cfr. 3, 1). È a Nicodemo che Gesù spiega: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna (3, 16). E Nicodemo difenderà Gesù prima di un’assemblea (cfr. Gv 7, 50-51) e assisterà alla sua sepoltura (cfr. Gv 19, 39). Comunque si consideri Nicodemo, è chiaro che i vari stereotipi sui Farisei non si applicano a lui, né trovano conferma altrove nel Vangelo di Giovanni.
Un altro incontro tra Gesù e i capi religiosi del suo tempo è riportato in modi diversi nei Vangeli sinottici. Ciò riguarda la questione del “grande” o “primo comandamento”. Nel Vangelo di Marco (cfr. 12, 28-34) la domanda viene posta da uno scriba, non diversamente identificato, che instaura un dialogo rispettoso con un insegnante. Secondo Matteo, lo scriba diventa un fariseo che stava cercando di mettere alla prova Gesù (cfr. 22, 34-35). Secondo Marco, Gesù conclude dicendo: «Non sei lontano dal regno di Dio» (12, 34), indicando così l’alta stima che Gesù ha avuto per quei capi religiosi che erano davvero “vicini al regno di Dio”.
Rabbi Aqiba, uno dei rabbini più famosi del secondo secolo, erede dell’insegnamento dei Farisei (S. Eusebii Hieronymi, Commentarii in Isaiam, III, 8: pl 24, 119.), indicava il passo di Lv 19, 18: «amerai il tuo prossimo come te stesso» come un grande principio della Torah (Sifra su Levitico 19, 18; Genesi Rabba 24, 7 su Gen 5, 1). Secondo la tradizione, egli morì come martire con sulle labbra lo Shemà, che include il comandamento di amare il Signore con tutto il cuore, l’anima e la forza (cfr. Dt 6, 4-5. Testo originale e versione italiana in Talmud Babilonese, Trattato Berakhòt, 61 b, Tomo ii, a cura di D. G. Di Segni, Giuntina, Firenze 2017, pp. 326-327). Pertanto, per quanto possiamo sapere, egli sarebbe stato in sostanziale sintonia con Gesù e il suo interlocutore scriba o fariseo. Allo stesso modo, la cosiddetta regola d’oro (cfr. Mt 7, 12), anche se in diverse formulazioni, è attribuita non solo a Gesù, ma anche al suo contemporaneo più anziano Hillel, di solito considerato uno dei principali Farisei del suo tempo. Tale regola è già presente nel libro deuterocanonico di Tobia (cfr. 4, 15).
Quindi, l’amore per il prossimo costituisce un indicatore significativo per riconoscere le affinità tra Gesù e i suoi interlocutori Farisei. Esso costituisce certamente una base importante per qualsiasi dialogo, specialmente tra ebrei e cristiani, anche oggi.
In effetti, per amare meglio i nostri vicini, abbiamo bisogno di conoscerli, e per sapere chi sono spesso dobbiamo trovare il modo di superare antichi pregiudizi. Per questo, il vostro convegno, mettendo in relazione fedi e discipline nel suo intento di giungere a una comprensione più matura e accurata dei Farisei, permetterà di presentarli in modo più appropriato nell’insegnamento e nella predicazione. Sono sicuro che tali studi, e le nuove vie che apriranno, contribuiranno positivamente alle relazioni tra ebrei e cristiani, in vista di un dialogo sempre più profondo e fraterno. Possa trovare un’ampia risonanza dentro e fuori la Chiesa Cattolica, e al vostro lavoro possano essere concesse abbondanti benedizioni dall’Altissimo o, come direbbero molti dei nostri fratelli e sorelle ebrei, da Hashèm. Grazie.
* Fonte: https://www.lapartebuona.it/home/gesu-e-i-farisei-al-pontificio-istituto-biblico-dal-7-al-9-maggio-una-conferenza-internazionale-sui-farisei/ (ripresa parziale).
- Il testo dell’udienza di Francesco in pdf: Udienza papa Francesco ai partecipanti al Convegno sui Farisei, Osservatore Romano 10 5 2019.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- INCONTRO DI PREGHIERA CON IL POPOLO ROM E SINTI. Parole di papa Francesco).10 maggio 2019, di Federico La Sala
INCONTRO DI PREGHIERA CON IL POPOLO ROM E SINTI
PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Sala Regia
Giovedì, 9 maggio 2019 *
Delle cose che ho sentito, tante mi hanno toccato il cuore, ma prendiamone una per incominciare, poi arriveranno le altre.
Questa mamma che ha parlato, mi ha toccato il cuore quando ha detto che lei “leggeva”, “vedeva” la speranza negli occhi dei figli. Ne ha quattro, mi ha detto, e questo va bene, questi sono due. La speranza può deludere se non è vera speranza, ma quando la speranza è concreta, come in questo caso, negli occhi dei figli, mai delude, mai delude!
Quando la speranza è concreta, nel Dio vero, mai delude. Le mamme che leggono la speranza negli occhi dei figli lottano tutti i giorni per la concretezza, non per le cose astratte, no: crescere un figlio, dargli da mangiare, educarlo, inserirlo nella società... Sono cose concrete. E anche le mamme - oserei dire - sono speranza. Una donna che mette al mondo un figlio è speranza, semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza.
In ambedue le testimonianze c’era sempre il dolore amaro della separazione: una cosa che si sente sulla pelle, non con le orecchie. Ti mettono da parte, ti dicono: “Sì, sì, tu passi, ma stai lì, non toccarmi”. [Si rivolge al giovane prete che ha fatto la testimonianza] In seminario, ti domandavano se chiedevi l’elemosina, se andavi a Termini... La società vive delle favole, delle cose... “No, Padre, quella gente è peccatrice!...”. E tu, non sei peccatore? Tutti noi lo siamo, tutti. Tutti facciamo sbagli nella vita, ma io non posso lavarmene le mani, guardando i veri o finti peccati altrui. Io devo guardare i miei peccati, e se l’altro è in peccato, fa una strada sbagliata, avvicinarmi e dargli la mano per aiutarlo ad uscire.
Una cosa che a me fa arrabbiare è che si siamo abituati a parlare della gente con gli aggettivi. Non diciamo: “Questa è una persona, questa è una mamma, questo è un giovane prete”, ma: “Questo è così, questo è così...”. Mettiamo l’aggettivo. E questo distrugge, perché non lascia che emerga la persona. Questa è una persona, questa è un’altra persona, questa è un’altra persona. I bambini sono persone. Tutti. Non possiamo dire: sono così, sono brutti, sono buoni, sono cattivi. L’aggettivo è una delle cose che crea distanze tra la mente e il cuore, come ha detto il Cardinale [Bassetti]. È questo il problema di oggi.
 Se voi mi dite che è un problema politico, un problema sociale, che è un problema culturale, un problema di lingua: sono cose secondarie. Il problema è un problema di distanza tra la mente e il cuore. Questo: è un problema di distanza. “Sì, sì, tu sei una persona, ma lontano da me, lontano dal mio cuore”. I diritti sociali, i servizi sanitari: “Sì, sì, ma faccia la coda... No, prima questo, poi questo”. È vero, ci sono cittadini di seconda classe, è vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente: questi sono di seconda classe, perché non sanno abbracciare. Sempre con l’aggettivo buttano fuori, scartano, e vivono scartando, vivono con la scopa in mano buttando fuori gli altri, o con il chiacchiericcio o con altre cose. Invece la vera strada è quella della fratellanza: “Vieni, poi parliamo, ma vieni, la porta è aperta”. E tutti dobbiamo collaborare.
Se voi mi dite che è un problema politico, un problema sociale, che è un problema culturale, un problema di lingua: sono cose secondarie. Il problema è un problema di distanza tra la mente e il cuore. Questo: è un problema di distanza. “Sì, sì, tu sei una persona, ma lontano da me, lontano dal mio cuore”. I diritti sociali, i servizi sanitari: “Sì, sì, ma faccia la coda... No, prima questo, poi questo”. È vero, ci sono cittadini di seconda classe, è vero. Ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente: questi sono di seconda classe, perché non sanno abbracciare. Sempre con l’aggettivo buttano fuori, scartano, e vivono scartando, vivono con la scopa in mano buttando fuori gli altri, o con il chiacchiericcio o con altre cose. Invece la vera strada è quella della fratellanza: “Vieni, poi parliamo, ma vieni, la porta è aperta”. E tutti dobbiamo collaborare.Voi potete avere un pericolo... - tutti abbiamo sempre un pericolo - una debolezza, diciamo così, la debolezza forse di lasciar crescere il rancore. Si capisce, è umano. Ma vi chiedo, per favore, il cuore più grande, più largo ancora: niente rancore. E andare avanti con la dignità: la dignità della famiglia, la dignità del lavoro, la dignità di guadagnarsi il pane di ogni giorno - è questo che ti fa andare avanti - e la dignità della preghiera. Sempre guardando avanti. E quando viene il rancore, lascia perdere, poi la storia ci farà giustizia. Perché il rancore fa ammalare tutto: fa ammalare il cuore, la testa, tutto. Fa ammalare la famiglia, e non va bene, perché il rancore ti porta alla vendetta: “Tu fai così...”. Ma la vendetta io credo che non l’avete inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta. Voi mi capite bene, no? Un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere nell’omertà: questo è un gruppo di gente delinquente; non la gente che vuole lavorare.
Voi andate avanti con la dignità, con il lavoro... E quando si vedono le difficoltà, guardate in alto e troverete che lì ci stanno guardando. Ti guarda. C’è Uno che ti guarda prima, che ti vuole bene, Uno che ha dovuto vivere ai margini, da bambino, per salvare la vita, nascosto, profugo: Uno che ha sofferto per te, che ha dato la vita sulla croce. È Uno, come abbiamo sentito nella Lettura che tu hai fatto, che va cercando te per consolarti e incoraggiarti ad andare avanti. Per questo vi dico: niente distanza; a voi e a tutti: la mente con il cuore. Niente aggettivi, no: tutte persone, ognuno meriterà il proprio aggettivo, ma non aggettivi generali, secondo la vita che fai. Abbiamo sentito un bel nome, che include le mamme; è un bel nome questo: “mamma”. È una cosa bella.
Vi ringrazio tanto, prego per voi, vi sono vicino. E quando leggo sul giornale qualcosa di brutto, vi dico la verità, soffro. Oggi ho letto qualcosa di brutto e soffro, perché questa non è civiltà, non è civiltà. L’amore è la civiltà, perciò avanti con l’amore.
Il Signore vi benedica. E pregate per me!
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - I seduttori e i maestri: due voci ben diverse (di Ermes Ronchi).).9 maggio 2019, di Federico La Sala
DALLA FIABA, UNA LEZIONE DI PENSIERO COSTITUZIONALE ... *
I seduttori e i maestri: due voci ben diverse
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 9 maggio 2019)
IV Domenica di Pasqua
 Anno C
Anno C- In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge all’orecchio del cuore prima delle cose che dice. È l’esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole.
La voce è il canto amoroso dell’essere: «Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l’amato chiede a sua volta il canto della voce dell’amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce?
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita.
Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l’azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d’umano e di cose che meritano di non morire.
Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie. L’eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.
 (Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30)
(Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30)
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
L’ASTUZIA DEL LUPO E I SETTE CAPRETTI. "APRITE, APRITE": SONO IL VOSTRO "PAPI"!!! LA PAROLA "ITALIA", LA "PASSWORD", CONSEGNATA A UN PARTITO (1994-2011).
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Un canto del cigno triste e inopportuno.15 aprile 2019, di Federico La Sala
A proposito del documento con cui Ratzinger si congeda dalla Chiesa
Un canto del cigno triste e inopportuno
di Marcello Neri (Il Mulino, 15 aprile 2019)
Inadeguato e inopportuno, così è il recente testo di Ratzinger sulla genesi sociale e culturale degli abusi nella Chiesa cattolica. Inadeguato non solo rispetto al tema che si vuole trattare, ma anche alla logica interna che si vorrebbe perseguire. Un affastellarsi di frasi, memorie personali, giudizi, osservazioni, senza un principio argomentativo che renda coerente l’impianto. Inopportuno per i tempi, le maniere, gli esiti prodotti.
Dalla storia, in cui a diritto l’aveva fatto entrare la scelta spirituale delle sue dimissioni da pontefice romano, Ratzinger ha iniziato a uscire quasi subito dopo: troppa devota obbedienza nominale al successore e troppe parole che andavano in altra direzione.
Ratzinger, volente o nolente, ha contribuito ad alimentare il mito di un «doppio» canonicamente e teologicamente mai esistito, reso possibile solo dalla logica mediatica e dalla perfidia di coloro che hanno piegato a essa il lento declino di un uomo che per mezzo secolo ha avuto in mano le sorti della Chiesa cattolica. Fino al punto di dover riconoscere, in un momento di folgorante obbedienza ecclesiale, di non esserne stato all’altezza.
L’ultimo scritto è quello di un uomo solo con i suoi demoni e i suoi conti da regolare, senza un amico che lo consigli saggiamente di tenere per sé le annotazioni su cui è stata costruita una vera e propria campagna di delegittimazione della Chiesa cattolica (dal Vaticano II all’analisi delle ragioni strutturali da parte di Francesco degli abusi sessuali).
Non solo, ma anche lo scritto di un uomo usato da amici privi di quel rispetto e di quella devozione con i quali, come Bibbia e sapienza popolare ci insegnano, dobbiamo circondare il tempo finale dei nostri vecchi. L’ethos uscito dal Sessantotto sarà traballante, finanche scanzonato e ignaro del prezzo che avrebbe fatto pagare alle generazioni future. Ma l’ethos che ha fatto di una «senile» prova di Ratzinger un piano di battaglia per imbrattare i muri del Vaticano II e ostacolare ancora una volta il percorso intrapreso dalla Chiesa sotto la mano severa di Francesco non è altro che il risentimento della rivalsa per il potere perduto.
Entrare nel merito dell’articolo di Ratzinger è quasi imbarazzante. Mi chiedo, d’altro lato, se si possa assistere inermi all’autodistruzione di una mente che ha fatto della propria personale visione del cristianesimo lo schema di base dell’ortodossia cattolica a livello globale.
Agghiacciante la parte che elabora le ragioni della dimissione dallo stato clericale dell’abusatore comprovato. Il crimine lede la fede dogmatica e per questa ragione deve essere perseguito in maniera implacabile. Le vittime nel testo di Ratzinger non esistono, ridotte al silenzio più assordante e alla dimenticanza del non venire nominate neanche en passant. Esse sono solo lo strumento mediante il quale il perpetratore violenta l’innocenza originaria e la perfezione perpetua della fede.
In questo momento, addebitare in toto le ragioni degli abusi nella Chiesa cattolica ai processi sociali e culturali di cambiamento degli assetti relazionali tra le generazioni, le persone, i singoli e le autorità costituite è semplicemente indice di cattivo gusto - anche nel caso uno sia profondamente convinto di ciò. Non si può dire, semplicemente perché si è visto che non è vero.
Distorsioni indebite e legittimazioni improprie del potere che circola nella Chiesa non possono essere ricondotte alla caduta morale di alcuni, neanche di molti dei suoi; si tratta piuttosto - come ha ricordato poco tempo fa monsignor Heiner Wilmer, vescovo di Hildesheim - di qualcosa che appartiene al dna della Chiesa stessa e come tale va trattato.
Non a tutti è concessa una platea globale per il proprio canto del cigno. Quando questo accade si dovrebbe raccogliere presso di sé le poche forze rimaste e prendere congedo con dignità dalla Chiesa che è di tutti. Altro è stato con Ratzinger, che si è lasciato avvincere da ancestrali paure e da una vendicatività di basso profilo, a uso e consumo di una combriccola di filibustieri che non provano un briciolo di sentimento per lui.
Che «un Dio che inizia con noi una storia d’amore e vuole includere in essa tutta la creazione» sia l’orizzonte ultimo da cui prende le mosse questo testo, così come esso si è prodotto e con gli effetti intenzionali che ha messo in circolo, è la piegatura drammatica del canto del cigno di Ratzinger.
-
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- MEMORIA.«La felicità (εὐδαιμονία) è un buon dèmone (δαίμων)» (Marco Aurelio).20 marzo 2019, di Federico La Sala
RICORDARE! Oggi, il 20 marzo è la Giornata Mondiale della Felicità, istituita dall’ONU nel 2012 .....
Se «La felicità (εὐδαιμονία) è un buon dèmone (δαίμων)» (Marco Aurelio, "Pensieri"), l’ Evangelo, composto dalle radici greche εὐ (eu, "buono") e ἄγγελμα (angelma, "novella", "messaggio"), è quindi una buona novella, non un semplice "vangelo" (un "messaggio" con le istruzioni relative alla destinazione - van-gelo)!
Federico La Sala
-
>MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Pregare trasforma in ciò che si contempla (di Ermes Ronchi).16 marzo 2019, di Federico La Sala
«Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Ma come un vitello d’oro di Mammona ("caritas") o come un bambino, figlio dell’Amore ("charitas") di Giuseppe e Maria?! *
Il Vangelo.
Pregare trasforma in ciò che si contempla
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 14 marzo 2019)
 II Domenica di Quaresima
II Domenica di Quaresima
 Anno C
Anno C- In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. [...]
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso l’infinito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti di luce.
 Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l’uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi.
Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l’uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi.
 Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull’abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza.
Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull’abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza.
 Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell’uomo.
Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l’entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell’uomo.
 Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un’altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).
Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce.
Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un’altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).
Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una voce.
 Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull’ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all’ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull’ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all’ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose. (Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36)
(Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1; Luca 9,28-36)
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Corpus demoni. Preti pedofili, j’accuse del vescovo Marx: il Vaticano ha insabbiato. Al Sinodo l’alto prelato tedesco schierato con Bergoglio: «Dossier sulle violenze distrutti o mai creati».24 febbraio 2019, di Federico La Sala
Preti pedofili, j’accuse del vescovo Marx: il Vaticano ha insabbiato
Corpus demoni. Al Sinodo l’alto prelato tedesco schierato con Bergoglio: «Dossier sulle violenze distrutti o mai creati». Scontro con i conservatori
di Luca Kocci (il manifesto, 24.02.2019)
La Chiesa ha messo in atto un’azione sistematica di copertura degli abusi sessuali commessi dal clero per proteggere i preti pedofili, «calpestando» le vittime
La severa accusa alle gerarchie ecclesiastiche è arrivata dal cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco-Frisinga e presidente della Conferenza episcopale tedesca, intervenuto ieri mattina in Vaticano, all’incontro mondiale sulla «Protezione dei minori nella Chiesa». Una relazione, quella di Marx, in sintonia con il grido che, fuori dall’aula del Sinodo dove sono riuniti i 190 presidenti delle conferenze episcopali e superiori generali di tutto il mondo, si è levato dalle vittime degli abusi riunite nel network internazionale Eca global (Ending clerical abuse) le quali, in una marcia da piazza del Popolo a piazza San Pietro, hanno chiesto «tolleranza zero», invocando «la fine dell’impunità e degli insabbiamenti degli abusi da parte della Chiesa». «Gli abusi sessuali nei confronti di bambini e giovani sono dovuti all’abuso di potere», ha detto Marx. L’amministrazione ecclesiastica, ha aggiunto, «non ha compiuto la missione della Chiesa, al contrario, l’ha oscurata, screditata e resa impossibile. I dossier che avrebbero potuto documentare i terribili atti e indicare il nome dei responsabili sono stati distrutti o nemmeno creati. Invece dei colpevoli, a essere riprese sono state le vittime ed è stato imposto loro il silenzio. I procedimenti per perseguire i reati sono stati deliberatamente disattesi, anzi cancellati o scavalcati.
I diritti delle vittime sono stati calpestati». Si riferiva in particolare alle diocesi tedesche, ha precisato in conferenza stampa, sottolineando però che «la Germania non è un caso isolato».
Sono indispensabili «trasparenza e tracciabilità», per chiarire «chi ha fatto cosa, quando, perché e a quale fine, e cosa è stato deciso», ha proseguito l’arcivescovo di Monaco, secondo il quale non ci sono obiezioni che tengano: né rispetto al «segreto pontificio» (non vale per «i reati riguardanti l’abusi di minori») né alla preoccupazione di «rovinare la reputazione di sacerdoti innocenti o del sacerdozio e della Chiesa»: la «presunzione di innocenza», la «tutela dei diritti» e «la necessità di trasparenza non si escludono a vicenda». Anzi «non è la trasparenza a danneggiare la Chiesa, ma gli abusi commessi, la mancanza di trasparenza, l’insabbiamento».
È stata anche la volta delle donne.
Prima la testimonianza (venerdì sera) di una vittima che ha subito abusi da quando aveva undici anni da parte di un prete della sua parrocchia: «Da allora - ha raccontato - io che adoravo i colori e facevo capriole sui prati spensierata non sono più esistita», «restano incise nei miei occhi, nelle orecchie, nel naso, nel corpo, nell’anima tutte le volte in cui lui bloccava me bambina con una forza sovrumana, io mi anestetizzavo, restavo in apnea, uscivo dal mio corpo, cercavo disperatamente con gli occhi una finestra per guardare fuori, in attesa che tutto finisse». «Dobbiamo trovare il coraggio di parlare e denunciare - ha concluso -, pur sapendo che rischiamo di non essere credute o di dover vedere che l’abusatore se la cava con una piccola pena», «non può e non deve essere più così».
Poi la relazione di Veronica Openibo, religiosa nigeriana, superiora della Società del santo bambino Gesù, che ha rimarcato l’esistenza di un fenomeno conosciuto già da qualche anno ma ancora in ombra: la violenza subita dalla suore da parte di preti e religiosi, soprattutto in Africa. La Chiesa sta facendo qualcosa, ma «non è ancora abbastanza», ha aggiunto suor Openibo, che ha indicato alcuni problemi da affrontare, come «l’abuso di potere, il clericalismo, la discriminazione di genere», e alcune prassi da abolire: nascondere «per evitare di portare alla luce uno scandalo e gettare discredito sulla Chiesa»; e «la scusa che si debba rispetto ad alcuni sacerdoti in virtù della loro età avanzata e della loro posizione gerarchica».
Oggi il summit termina, con la messa e l’intervento del papa. Le posizioni sono emerse con chiarezza. I conservatori puntano il dito sull’omosessualità: sarebbe questa la causa degli abusi sessuali (però così non spiegano le violenze sulle donne). La maggioranza filo-Francesco indica invece nel clericalismo e nel potere la radice degli abusi e chiede creazione di strutture di ascolto autonome con il coinvolgimento di laici e donne, collaborazione e denuncia alle autorità civili, riforma del segreto pontificio, rimozione di preti colpevoli e vescovi collusi o complici.
Nemmeno sfiorato il tema del celibato obbligatorio - per molti osservatori il vero nodo del problema -, ma su questo punto anche Francesco è inamovibile. Proposte concrete, però, sono state avanzate. L’incontro non ha valore deliberativo, si tratterà quindi di vedere se ora diventeranno regole scritte. «Non crediamo che solo perché abbiamo iniziato a scambiare qualcosa tra di noi, tutte le difficoltà siano eliminate», ha concluso la giornata, con la celebrazione penitenziale. il vescovo ghanese Philip Naameh.
Il vertice
Il consigliere del Papa: «Distrutti i dossier sugli abusi nella Chiesa»
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 24.02.2019)
- Il cardinale Marx al summit: abolire il segreto pontificio
CITTÀ DEL VATICANO «Ora cerco di concentrarmi sul mio diritto divino di essere vivo». Un giovane cileno che fu abusato da un prete racconta la sua storia, chiude gli occhi e imbraccia il violino, le note di Bach risuonano nel silenzio della Sala Regia e delle gerarchie ecclesiali di tutto il mondo riunite per la «celebrazione penitenziale» guidata da Francesco. Prima del mea culpa del Papa («dobbiamo dire, come il figlio prodigo: Padre, ho peccato») e di cardinali e vescovi («confessiamo che abbiamo protetto dei colpevoli e ridotto al silenzio chi ha subito del male»), il Pontefice ha invitato all’«esame di coscienza» spiegando che «si rendono necessarie azioni concrete per le chiese locali»: l’incontro mondiale sulla protezione dei minori finisce con la messa di oggi ma l’essenziale si vedrà da domani.
La questione centrale è quella che ieri il cardinale Reinhard Marx, uno dei consiglieri più stretti del Papa, ha scandito senza perifrasi: «I dossier che avrebbero potuto documentare i terribili atti e indicare il nome dei responsabili sono stati distrutti o nemmeno creati. Invece dei colpevoli, a essere riprese sono state le vittime ed è stato imposto loro il silenzio. Le procedure e i procedimenti stabiliti per perseguire i reati sono stati deliberatamente disattesi, e anzi cancellati o scavalcati. I diritti delle vittime sono stati di fatto calpestati e lasciati all’arbitrio di singoli individui. Sono tutti eventi in netta contraddizione con ciò che la Chiesa dovrebbe rappresentare». Il cardinale, presidente dei vescovi tedeschi, ha spiegato più tardi che si riferiva in particolare a ciò che la Chiesa tedesca ha scoperto nella ricerca, durata tre anni, sugli abusi nelle sue diocesi. Ma «presumo che la Germania non sia un caso isolato», ha aggiunto.
La denuncia di Marx è la premessa di una serie di riforme, a cominciare dall’abolizione o almeno revisione del «segreto pontificio», definito dal documento «Secreta continere» del 1974.
Il cardinale Marx spiega che la «trasparenza» si deve accompagnare alla «tracciabilità» delle «procedure amministrative», in modo che chiunque possa sempre sapere «chi ha fatto che cosa, quando, perché e a quale fine, e che cosa è stato deciso, respinto o assegnato». E aggiunge: «Ogni obiezione basata sul segreto pontificio sarebbe rilevante solo se si potessero indicare motivi convincenti per cui il segreto pontificio si dovrebbe applicare al perseguimento di reati riguardanti l’abusi di minori. Allo stato attuale, io di questi motivi non ne conosco».
In questi giorni si è parlato di «nuove strutture legali» di controllo - legate ai metropoliti (le diocesi più grandi) e composte anche da laici, donne e uomini - cui i vescovi debbano «rendere conto». E di centri di ascolto per raccogliere denunce in ogni conferenza episcopale e diocesi. Ma soprattutto sono state le donne a scuotere le gerarchie. Dalla canonista Linda Ghisoni alla suora nigeriana Veronica Openibo, che ieri ha parlato di «mediocrità e ipocrisia» e avvertito: «Questa tempesta non passerà. Spero e prego che alla fine di questa conferenza sceglieremo deliberatamente di spezzare ogni cultura del silenzio». Suor Veronica, parlando accanto al Papa, ha evocato il cambio di linea nello scandalo cileno, all’inizio sottovalutato: «La ammiro, fratel Francesco, per essersi preso del tempo, da vero gesuita, per discernere e per essere abbastanza umile da cambiare idea, chiedere scusa e agire: un esempio per tutti noi».
La giornalista messicana Valentina Alazraki non l’ha mandata a dire, a cardinali e vescovi: «Vi aiuteremo a trovare le mele marce e a vincere le resistenze per allontanarle da quelle sane. Ma se voi non vi decidete in modo radicale a stare dalla parte dei bambini, delle mamme, delle famiglie, della società civile, avete ragione ad avere paura di noi, perché noi giornalisti, che vogliamo il bene comune, saremo i vostri peggiori nemici».
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Padre che sei nei cieli. Catechesi sul “Padre nostro” (di Papa francesco).21 febbraio 2019, di Federico La Sala
Catechesi sul “Padre nostro”: 7. Padre che sei nei cieli
di Papa Francesco *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’udienza di oggi si sviluppa in due posti. Prima ho fatto l’incontro con i fedeli di Benevento, che erano in San Pietro, e adesso con voi. E questo è dovuto alla delicatezza della Prefettura della Casa Pontificia che non voleva che voi prendeste freddo: ringraziamo loro, che hanno fatto questo. Grazie.
Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre incomincio il mistero. Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).
Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno; come noi, a nostra volta, non saremo mai genitori, o pastori, perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Per questo a volte le dichiarazioni di amore si tramutano in sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guarda, questi due si amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a morte: questo lo vediamo tutti i giorni! E’ per questo, perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e alle volte escono e fanno del male.
Ecco perché, quando parliamo di Dio come “padre”, mentre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, specialmente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad usare Gesù: è l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo mendicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti!
Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone. La mitologia dice che è figlio di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambivalente dell’amore umano: capace di fiorire e di vivere prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e morire; quello che afferra, gli sfugge sempre via (cfr Platone, Simposio, 203). C’è un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore: «Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce» (6,4). Ecco che cos’è spesso il nostro amore: una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al mattino esce il sole e si porta via la rugiada della notte.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’esperienza: abbiamo amato ma poi quell’amore è caduto o è diventato debole. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre forze: incapaci di mantenere una promessa che nei giorni di grazia ci sembrava facile da realizzare. In fondo anche l’apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire. L’apostolo Pietro non è stato fedele all’amore di Gesù. Sempre c’è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’amore.
Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato - un’ipotesi storica -, c’è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’amore di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16).
 Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.
Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito a conoscere Dio che è padre. La conversione di Sant’Agostino, ad esempio, è transitata per questo crinale: il giovane e brillante retore cercava semplicemente tra le creature qualcosa che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno ebbe il coraggio di alzare lo sguardo. E in quel giorno conobbe Dio. Dio che ama.
L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene.
Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo. Se anche per sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore con lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana: quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te.
*
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE -Aula Paolo VI
 Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale). -
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- Lo sguardo cristiano è capace di dire una parola nuova sulla crisi del mondo contemporaneo?6 febbraio 2019, di Federico La Sala
I cattolici in politica per costruire il futuro
Oggi come 100 anni fa, l’impegno non è rivolto al passato ma riguarda
 la capacità di immaginare una via d’uscita dalla crisi delle società avanzate
la capacità di immaginare una via d’uscita dalla crisi delle società avanzatedi Mauro Magatti (Corriere della Sera, 06.02.2019)
Nelle ultime settimane, in occasione dei cento anni dell’Appello ai liberi e forti di Sturzo, si è riacceso il dibattito sul ruolo dei cattolici in politica (Galli della Loggia e Panebianco sul Corriere ). Comunque la si pensi, il tema è oggi rilevante per almeno due ragioni. In primo luogo perché nell’Italia a pezzi di oggi il variegato mondo cattolico, nonostante la secolarizzazione incalzante, continua a essere - seppur tra mille difficoltà - una delle poche presenze rilevanti. E in secondo luogo perché, nel cambio d’epoca che stiamo attraversando, il rapporto tra politica e religione è tornato centrale. Nel post-2008, in un mondo diventato multipolare, la ricerca di un nuovo equilibrio tra identità cultuali e sviluppo tecno-economico spinge le diverse aree del pianeta a posizionarsi secondo una logica che ricorda da vicino le tesi dello Scontro delle civiltà di Samuel Huntington. Dove la dimensione religiosa è necessariamente tirata in ballo.
Non a caso, in Occidente, le varie forme della nuova destra (da Trump a Orbán a Bolsonaro) sono sostenute dall’ala più conservatrice del mondo cristiano. Un’alleanza teorizzata da Bannon e costruita contro due «nemici»: la cultura progressista (che ha il torto di combinare la fede nella innovazione tecnoscientifica con i diritti individuali); e il mondo islamico, storico avversario oggi accusato di minacciare la cristianità attraverso l’immigrazione e il terrorismo. La «democrazia illiberale» di cui parla Orbán è il prodotto di una nuova «santa alleanza» tra politica e religione - da realizzare su base nazionale - per sconfiggere i due avversari sopra richiamati. La capacità di mobilitare i fermenti identitari di parte del mondo religioso costituisce un elemento importante nella spiegazione dell’avanzata dei nuovi partiti sovranisti. In Italia la presenza di papa Francesco - con i conseguenti orientamenti della Cei - ha finora limitato l’uso da parte di Salvini dei simboli religiosi. Ma sotto la cenere, la brace brucia.
Cento anni fa, col suo appello, Sturzo tentò di radunare le forze cattoliche per evitare la dissoluzione della democrazia, stretta tra le destre emergenti e le sterili convulsioni della sinistra. Oggi in Italia, in Europa, in Occidente, quel bisogno si ripropone: come allora, il disordine mondiale sta risucchiando gli strati popolari su posizioni estremiste. Col consenso di quella parte del mondo religioso che spera in una rivincita nei confronti della secolarizzazione.
Rispetto a 100 anni fa, si possono notare una somiglianza e una differenza. Sturzo fu il prodotto più maturo della lettura che l’Enciclica Rerum Novarum aveva offerto dei grandi cambiamenti prodotti dall’industrializzazione. Come allora, anche oggi il mondo cattolico ha a disposizione un testo (Laudato si’) che per ampiezza e ricchezza è in grado di fornire la cornice di riferimento per l’azione negli ambiti economico, sociale e politico. La differenza è che l’Appello a i liberi e forti arrivò dopo più di 20 anni spesi ad animare la presenza civile dei cattolici. Vero e proprio tirocinio nella carne delle società, che permise a Sturzo di maturare una concezione politica realista e vicina ai problemi reali delle persone.
Per quanto nel Paese ci sia molto di più di quello che emerge nella comunicazione pubblica, e per quanto molto di questo nuovo venga proprio dalla radice cattolica, c’è da domandarsi se sia già il tempo di serrare le fila o se non sia invece il momento di lavorare con più determinazione a innovare i processi dell’economia, della società, dei territori in modo da maturare i termini di una proposta adeguata ai tempi che viviamo.
Inutile cercare si rispondere in astratto a questa domanda. Quello che occorre fare è partire subito e comunque dalla società: ascoltando i bisogni e i sogni del «popolo» (termine caro a papa Francesco) e orientandoli nella direzione indicata dalla Laudato si’. E cercando poi di capire, strada facendo, quale siano i modi e le forme più adatte per contribuire al rilancio del Paese.
Quel che deve essere chiaro è che un impegno dei cattolici in politica, oggi come 100 anni fa, non riguarda la difesa di un’identità o di interessi di parte. Riguarda invece la capacità di questo sguardo sul mondo di immaginare una via d’uscita dalla crisi nella quale le società avanzate si trovano oggi. Nella convinzione che la radice cristiana abbia qualcosa da dire sul futuro e non solo sul passato.
Fu questa la grande sfida di Sturzo, che, nonostante le sue personali traversie politiche, alla fine portò frutti importanti. Il suo lavoro sul campo e la sua ispirazione politica furono infatti decisivi per la nascita dei partiti di ispirazione cristiana che, nel dopoguerra, ebbero un ruolo importante a livello internazionale.
Circa un eventuale ritorno dell’impegno dei cattolici in politica, sarà dunque di questo che si dovrà parlare: lo sguardo cristiano è capace di dire una parola nuova sulla crisi del mondo contemporaneo? Di costruire un consenso, ben al di là dei propri confini identitari, attorno alle linee tracciate dalla Laudato si’? Di essere voce di quei radicamenti concreti (nel mondo dell’impresa, della ricerca, delle professioni, del sociale e così via) da cui trarre anche quella classe dirigente di cui tutti sentono la mancanza?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- “Abbà, Padre!”. Catechesi sul “Padre nostro” (di Papa Francesco).16 gennaio 2019, di Federico La Sala
PAPA FRANCESCO
Catechesi sul “Padre nostro”: 5. “Abbà, Padre!”
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Proseguendo le catechesi sul “Padre nostro”, oggi partiamo dall’osservazione che, nel Nuovo Testamento, la preghiera sembra voler arrivare all’essenziale, fino a concentrarsi in una sola parola: Abbà, Padre.
Abbiamo ascoltato ciò che scrive San Paolo nella Lettera ai Romani: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (8,15). E ai Galati l’Apostolo dice: «E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Padre!”» (Gal 4,6). Ritorna per due volte la stessa invocazione, nella quale si condensa tutta la novità del Vangelo. Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano non considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più paura ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia in Lui: può parlare con il Creatore chiamandolo “Padre”. L’espressione è talmente importante per i cristiani che spesso si è conservata intatta nella sua forma originaria: “Abbà”.
È raro che nel Nuovo Testamento le espressioni aramaiche non vengano tradotte in greco. Dobbiamo immaginare che in queste parole aramaiche sia rimasta come “registrata” la voce di Gesù stesso: hanno rispettato l’idioma di Gesù. Nella prima parola del “Padre nostro” troviamo subito la radicale novità della preghiera cristiana.
Non si tratta solo di usare un simbolo - in questo caso, la figura del padre - da legare al mistero di Dio; si tratta invece di avere, per così dire, tutto il mondo di Gesù travasato nel proprio cuore. Se compiamo questa operazione, possiamo pregare con verità il “Padre nostro”. Dire “Abbà” è qualcosa di molto più intimo, più commovente che semplicemente chiamare Dio “Padre”. Ecco perché qualcuno ha proposto di tradurre questa parola aramaica originaria “Abbà” con “Papà” o “Babbo”. Invece di dire “Padre nostro”, dire “Papà, Babbo”.
 Noi continuiamo a dire “Padre nostro”, ma con il cuore siamo invitati a dire “Papà”, ad avere un rapporto con Dio come quello di un bambino con il suo papà, che dice “papà” e dice “babbo”. Infatti queste espressioni evocano affetto, evocano calore, qualcosa che ci proietta nel contesto dell’età infantile: l’immagine di un bambino completamente avvolto dall’abbraccio di un padre che prova infinita tenerezza per lui. E per questo, cari fratelli e sorelle, per pregare bene, bisogna arrivare ad avere un cuore di bambino. Non un cuore sufficiente: così non si può pregare bene. Come un bambino nelle braccia di suo padre, del suo papà, del suo babbo.
Noi continuiamo a dire “Padre nostro”, ma con il cuore siamo invitati a dire “Papà”, ad avere un rapporto con Dio come quello di un bambino con il suo papà, che dice “papà” e dice “babbo”. Infatti queste espressioni evocano affetto, evocano calore, qualcosa che ci proietta nel contesto dell’età infantile: l’immagine di un bambino completamente avvolto dall’abbraccio di un padre che prova infinita tenerezza per lui. E per questo, cari fratelli e sorelle, per pregare bene, bisogna arrivare ad avere un cuore di bambino. Non un cuore sufficiente: così non si può pregare bene. Come un bambino nelle braccia di suo padre, del suo papà, del suo babbo.Ma sicuramente sono i Vangeli a introdurci meglio nel senso di questa parola. Cosa significa per Gesù, questa parola? Il “Padre nostro” prende senso e colore se impariamo a pregarlo dopo aver letto, per esempio, la parabola del padre misericordioso, nel capitolo 15° di Luca (cfr Lc 15,11-32).
 Immaginiamo questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, dopo aver sperimentato l’abbraccio di suo padre che lo aveva atteso a lungo, un padre che non ricorda le parole offensive che lui gli aveva detto, un padre che adesso gli fa capire semplicemente quanto gli sia mancato. Allora scopriamo come quelle parole prendono vita, prendono forza. E ci chiediamo: è mai possibile che Tu, o Dio, conosca solo amore? Tu non conosci l’odio? No - risponderebbe Dio - io conosco solo amore. Dov’è in Te la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per il tuo onore ferito? E Dio risponderebbe: Io conosco solo amore.
Immaginiamo questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, dopo aver sperimentato l’abbraccio di suo padre che lo aveva atteso a lungo, un padre che non ricorda le parole offensive che lui gli aveva detto, un padre che adesso gli fa capire semplicemente quanto gli sia mancato. Allora scopriamo come quelle parole prendono vita, prendono forza. E ci chiediamo: è mai possibile che Tu, o Dio, conosca solo amore? Tu non conosci l’odio? No - risponderebbe Dio - io conosco solo amore. Dov’è in Te la vendetta, la pretesa di giustizia, la rabbia per il tuo onore ferito? E Dio risponderebbe: Io conosco solo amore.Il padre di quella parabola ha nei suoi modi di fare qualcosa che molto ricorda l’animo di una madre. Sono soprattutto le madri a scusare i figli, a coprirli, a non interrompere l’empatia nei loro confronti, a continuare a voler bene, anche quando questi non meriterebbero più niente.
Basta evocare questa sola espressione - Abbà - perché si sviluppi una preghiera cristiana. E San Paolo, nelle sue lettere, segue questa stessa strada, e non potrebbe essere altrimenti, perché è la strada insegnata da Gesù: in questa invocazione c’è una forza che attira tutto il resto della preghiera.
Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di Lui. Dio scorge in te una bellezza, anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi talenti. Dio è non solo un padre, è come una madre che non smette mai di amare la sua creatura. D’altra parte, c’è una “gestazione” che dura per sempre, ben oltre i nove mesi di quella fisica; è una gestazione che genera un circuito infinito d’amore.
Per un cristiano, pregare è dire semplicemente “Abbà”, dire “Papà”, dire “Babbo”, dire “Padre” ma con la fiducia di un bambino.
Può darsi che anche a noi capiti di camminare su sentieri lontani da Dio, come è successo al figlio prodigo; oppure di precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel mondo; o, ancora, di sbagliare ed essere paralizzati da un senso di colpa. In quei momenti difficili, possiamo trovare ancora la forza di pregare, ricominciando dalla parola “Padre”, ma detta con il senso tenero di un bambino: “Abbà”, “Papà”. Lui non ci nasconderà il suo volto. Ricordate bene: forse qualcuno ha dentro di sé cose brutte, cose che non sa come risolvere, tanta amarezza per avere fatto questo e quest’altro... Lui non nasconderà il suo volto. Lui non si chiuderà nel silenzio. Tu digli “Padre” e Lui ti risponderà. Tu hai un padre. “Sì, ma io sono un delinquente...”. Ma hai un padre che ti ama! Digli “Padre”, incomincia a pregare così, e nel silenzio ci dirà che mai ci ha persi di vista. “Ma, Padre, io ho fatto questo...” - “Mai ti ho perso di vista, ho visto tutto. Ma sono rimasto sempre lì, vicino a te, fedele al mio amore per te”. Quella sarà la risposta. Non dimenticatevi mai di dire “Padre”. Grazie.
PAPA FRANCESCO
 UDIENZA GENERALE
UDIENZA GENERALE
 Aula Paolo VI
Aula Paolo VI
 Mercoledì, 16 gennaio 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 16 gennaio 2019 (ripresa parziale). -
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Restano alla "Caritas" le monete della Fontana di Trevi. Campidoglio in retromarcia.14 gennaio 2019, di Federico La Sala
Roma.
Campidoglio in retromarcia: restano alla Caritas le monete della Fontana di Trevi
Virginia Raggi all’Osservatore Romano: devolveremo anche i 200 mila euro raccolti in altre fontane, è stato un atto della Giunta male interpretato
di Luca Liverani (Avvenire, lunedì 14 gennaio 2019)
- [Foto] Un operaio dell’Acea recupera le monete lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi
Contrordine dal Campidoglio. «La Caritas e tutte le migliaia di persone assistite dai suoi operatori possono stare tranquille. Garantisco io, in prima persona - dice la sindaca di Roma Virginia Raggi all’Osservatore Romano - che non verrà mai meno il contributo di questa amministrazione. Per quanto riguarda le monetine, confermo che resteranno a disposizione delle attività caritatevoli dell’ente diocesano. Nessuno ha mai pensato di privare la Caritas di questi fondi».
Dopo giorni di polemiche e una tempesta di reazioni sui social, il Campidoglio dunque innesta la retromarcia. Le monete lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi continueranno a essere girate alla Caritas di Roma che le investe per i servizi ai più poveri. Il taglio preannunciato a fine anno avrebbe provocato una perdita secca di un milione e mezzo di euro nel bilancio dell’organismo ecclesiale, pari al 15%, la metà dei soldi che la Caritas spende senza nessuna convenzione con enti pubblici.
Il denaro raccolto nella Fontana di Trevi a Roma resterà dunque alla Caritas diocesana. Anzi, anche le monete raccolte nelle altre fontane della Capitale saranno destinate all’organismo caritativo diocesano, per un totale approssimativo di 200 mila euro aggiuntivi. L’Osservatore Romano sulla questione ha intervistato la sindaca di Roma Virginia Raggi: «L’ente diocesano svolge un compito importante per tanti bisognosi e per la città di Roma - dichiara - che vuole continuare a essere la Capitale dell’accoglienza dei più deboli». Tecnicamente, la questione circa la destinazione delle monetine raccolte nella storica fontana della Capitale sarà risolta in questo modo: spetterà all’Acea il compito della raccolta e della quantificazione delle monete, finora svolto gratuitamente dai volontari della Caritas. Sottratto il compenso per questa attività - si calcola circa 2mila euro - in virtù di un apposito protocollo i fondi saranno trasmessi alla Caritas diocesana.
La sindaca questa mattina - riferisce ancora l’Osservatore Romano - ha contattato la presidente di Acea, Michaela Castelli, la quale ha assicurato il suo appoggio a tale soluzione. Si supererà così l’obbligo imposto dalla Ragioneria generale di far transitare l’importo delle monete nel bilancio comunale, che aveva condotto, secondo quanto spiegano dal Campidoglio, alla sospensione della convenzione con la Caritas. «Lo scorso dicembre - afferma Raggi - abbiamo approvato una memoria di Giunta che è stata mal interpretata. Si tratta di un atto amministrativo dovuto alla necessità di raccogliere e quantificare le monetine che i turisti lanciano, non solo nella fontana di Trevi ma anche in altre fontane monumentali di Roma. Un atto amministrativo che ha il fine di portare ordine e trasparenza. Ora, invece, i turisti e cittadini finalmente sapranno quanto viene raccolto e a chi viene destinato. E lo saprà anche la Caritas che potrà programmare più facilmente le proprie attività di beneficenza. Addirittura avrà più fondi».
La sindaca, nell’intervista al giornale vaticano, tiene a ribadire che l’amministrazione intende continuare la collaborazione con tutti gli enti ecclesiali: «Credo che le parrocchie rappresentino un baluardo importante per la tenuta del territorio. Spesso le parrocchie e i centri di volontariato rappresentano le frontiere all’interno della città, il luogo in cui ci si confronta e si cresce insieme. È evidente - aggiunge - che il terzo settore vada tutelato e incoraggiato».
A formalizzare la cessione delle monete lanciate dai turisti nella Fontana di Trevi alle iniziative di solidarietà della Caritas era stato, il Campidoglio nel 2001. Da allora tutte le giunte successive, di qualsiasi colore politico, da Walter Veltroni a Gianni Alemanno a Ignazio Marino avevano conservato questa consuetudine. Con l’arrivo della giunta Raggi l’iniziativa era stata messa in discussione, con l’istituzione di un gruppo di lavoro nell’ottobre 2017. E il processo sembrava arrivato a conclusione: una Determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2018 aveva affermato che dal 1° aprile la Caritas non sarebbe più stata la destinataria delle monete regalate dai turisti nel tradizionale lancio in fontana - dice la tradizione - per propiziare il ritorno a Roma. In concreto, per la Caritas diocesana sarebbe stato un taglio secco di un milione e mezzo di euro. Una decisione che avrebbe costretto la Caritas a ridurre o chiudere molti servizi per i più poveri. Con prevedibili ripercussioni sul clima sociale della città.
Secondo la sindaca Raggi dunque «nessuno ha mai pensato di privare la Caritas di questi fondi». Un’affermazione che sembra parzialmente contraddetta da quanto si legge nella Determinazione dirigenziale del 31 dicembre scorso. A pagina 4 del documento di otto pagine, si leggeva che «il ricavato della raccolta dovrà essere destinato, al netto di quanto necessario alla copertura delle spese dell’addendum contrattuale con la società ACEA s.p.a., in misura prevalente al finanziamento di progetti sociali e per la restante parte alla manutenzione ordinaria del patrimonio culturale».
Oggi dunque la decisa correzione di rotta. Una svolta su cui contava il direttore della Caritas diocesana, don Benoni Ambarus che nei giorni scorsi, nonostante la decisione del Campidoglio, continuava a dirsi «fiducioso» in un ripensamento: «Mi appello - aveva detto - agli amministratori di buona volontà: non mettano fine all’azione sussidiaria e di welfare generativo che moltiplica l’effetto dei fondi disponibili, crea dignità e giustizia sociale. Non parlo per me, ma a nome di tante persone fragili, italiane e non, che a Roma vivono con difficoltà». Una fiducia stavolta ben riposta.
L’Osservatore Romano non risparmia però una critica alla Giunta Raggi. «Dovrebbe dunque chiudersi così una vicenda la cui gestione non è stata certo felice», scrive il quotidiano vaticano: «Sarebbe sicuramente bastata una comunicazione più chiara con la stessa Caritas per fermare sul nascere qualsiasi malinteso».
-
>LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Fontana di Trevi, il Campidoglio toglie le monetine alla "Caritas" (di Rosalia Palermi)..13 gennaio 2019, di Federico La Sala
Fontana di Trevi, il Campidoglio toglie le monetine alla Caritas. "Serviranno a manutenzione vasca"
Diventa operativa da aprile, una decisione assunta dal Comune già lo scorso anno e congelata per le proteste. In ballo un milione e mezzo di euro all’anno
di ROSALIA PALERMI (la Repubblica, 12 gennaio 2019)
I rapporti sono tesi, non è un mistero. Più volte la Curia romana ha punzecchiato l’amministrazione, da ultimo lo ha fatto il Vescovo di Roma Sud, Paolo Lojudice, chiamando alle proprie responsabilità la giunta capitolina in materia di decoro. Sullo sfondo una partita che oltreTevere ha creato parecchi malumori e non solo a livello di vertice.
Riguarda le monetine che i turisti lanciano a Fontana di Trevi. Raccolte da Acea, l’azienda che si occupa della manutenzione della Fontana, finivano nelle mani dei volontari Caritas che le destinavano a scopi sociali. Finivano perché tra qualche mese non sarà più così.
Lo prevede una decisione assunta già l’anno scorso dall’amministrazione capitolina guidata da Virginia Raggi e congelata tra le proteste per altri 12 mesi. Arrivati alla fine dell’anno, i burocrati del Campidoglio hanno notificato alla Caritas che il versamento cesserà dal primo di aprile. In sostanza scadrà la proroga della proroga e oltre non si andrà. Raggi conferma la volontà di incassare le monetine e redistribuirle per finanziare opere di manutenzione, sobbarcandosi anche il costo del conteggio finora svolto gratis dai volontari Caritas.
La partita non è di poco conto: ballano un milione e mezzo di euro, stando al bilancio 2018. Una goccia nel mare del disastrato bilancio capitolino che tuttavia saluta il gettito delle monetine come una provvidenziale boccata d’ossigeno. Una mannaia per la Caritas che stima gli venga a cadere il 15 per cento del proprio bilancio, fatto poi di soldi dell’8 per mille e di decisivi finanziamenti pubblici e solo in minima parte privati. Soldi che finiscono nel circuito dell’assistenza: dall’accoglienza dei senzatetto ai pasti e a iniziative benefiche che sopperiscono ai vuoti del welfare.
Insomma, dove non c’è la mano pubblica a garantire un tetto ai clochard e pasti caldi a chi vive per strada c’è la rete della Caritas. E lo si è visto nel pieno dell’emergenza freddo nella capitale con il circuito del volontariato a fronteggiare una situazione che la rete pubblica dell’assessorato al sociale non è stata in grado di affrontare, tra inadeguatezza, pasticci burocratici e una attività organizzativa partita decisamente in ritardo.
Per questa ragione il malumore crescente nei confronti delle scelte dell’amministrazione è esploso anche su Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale, che senza mezzi termini ha riportato in prima pagina quella che era una felpata polemica affidata al fioretto della diplomazia con un eloquente “Le monetine tolte ai poveri”.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Battesimo del Signore. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio (di Ermes Ronchi).10 gennaio 2019, di Federico La Sala
UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".... *
Il cielo si apre
Siamo tutti figli di Dio nel Figlio
di Ermes Ronchi ( Avvenire, giovedì 10 gennaio 2019)
- Battesimo del Signore - Anno C
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il Battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
«Viene dopo di me colui che è più forte di me". In che cosa consiste la forza di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l’unica che suona in mezzo all’anima. E parla parole di vita. «Lui vi battezzerà...»
 La sua forza è battezzare, che significa immergere l’uomo nell’oceano dell’Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato.
La sua forza è battezzare, che significa immergere l’uomo nell’oceano dell’Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respiro, e diventi figlio: a quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbiano la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E poi mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rinchiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comunicare con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato.E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro.
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amore che anticipa e che prescinde da tutto.
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l’idea di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognuno: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tenerezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicuro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezioso, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.
 (Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22).
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22).
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
- GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- «Pregare Dio come un figlio, non come un pappagallo che parla, parla, parla». Nella prima catechesi del 2019 papa Francesco ritorna sulla preghiera del Padre Nostro.3 gennaio 2019, di Federico La Sala
Udienza generale.
Papa Francesco: dove c’è il Vangelo c’è rivoluzione
Nella prima catechesi del 2019 Francesco ritorna sulla preghiera del Padre Nostro: «Pregare Dio come un figlio, non come un pappagallo che parla, parla, parla»
di Redazione Internet (Avvenire, mercoledì 2 gennaio 2019)
"Dove c’è il Vangelo c’è rivoluzione. Il Vangelo non lascia quieti, ci spinge: è rivoluzionario". Così si è espresso il Papa nella prima udienza generale del 2019, ricordando che il Vangelo di Matteo pone il testo del Padre nostro "in un punto strategico, al centro del discorso della montagna", Francesco ha osservato che con le Beatitudini "Gesù incorona di felicità una serie di categorie di persone che nel suo tempo - ma anche nel nostro! - non erano molto considerate. Beati i poveri, i miti, i misericordiosi, le persone umili di cuore... È la rivoluzione del Vangelo".
"Il grande segreto che sta alla base di tutto il discorso della montagna” è questo, ha aggiunto Francesco, nel corso dell’udienza generale, in aula Paolo VI: "Siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Apparentemente questi capitoli del Vangelo di Matteo sembrano essere un discorso morale, sembrano evocare un’etica così esigente da apparire impraticabile, e invece scopriamo che sono soprattutto un discorso teologico".
È UNO SCANDALO ANDARE IN CHIESA MA ODIARE GLI ALTRI
Il cristiano, ha osservato il Pontefice, “non è uno che si impegna a essere più buono degli altri: sa di essere peccatore come tutti. Il cristiano semplicemente è l’uomo che sosta davanti al nuovo Roveto Ardente, alla rivelazione di un Dio che non porta l’enigma di un nome impronunciabile, ma che chiede ai suoi figli di invocarlo con il nome di ‘Padre’, di lasciarsi rinnovare dalla sua potenza e di riflettere un raggio della sua bontà per questo mondo così assetato di bene, così in attesa di belle notizie". Ecco dunque come Gesù introduce l’insegnamento della preghiera del “Padre nostro”: "Lo fa prendendo le distanze da due gruppi del suo tempo. Anzitutto gli ipocriti: ‘Non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente’. C’è gente che è capace di tessere preghiere atee, senza Dio: lo fanno per essere ammirati dagli uomini". "Quante volte - ha detto a braccio - noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno tutta la giornata lì e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Ma allora è meglio non andare in chiesa". "Se vai in Chiesa devi vivere come figlio e dare buona testimonianza, non una contro testimonianza".
PREGARE NON È PARLARE COME UN PAPPAGALLO, MA RIVOLGERSI A DIO COME UN FIGLIO AL PADRE
La preghiera cristiana, invece, "non ha altro testimone credibile che la propria coscienza, dove si intreccia intensissimo un continuo dialogo con il Padre: ‘Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto’".
"I pagani pensano - ha aggiunto il Papa - che parlando, parlando parlando Dio ascolta”, ma “io penso - ha aggiunto a tanti cristiani che credono che pregare è parlare a Dio come un pappagallo, no pregare si fa dal cuore, da dentro", ha osservato a braccio. "Tu invece - dice Gesù -, quando preghi, rivolgiti a Dio come un figlio a suo padre, il quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora che gliele chieda. Potrebbe essere anche una preghiera silenziosa, il ‘Padre nostro’: basta in fondo mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo è sufficiente per essere esauditi".
"È bello pensare - ha concluso - che il nostro Dio non ha bisogno di sacrifici per conquistare il suo favore! Non ha bisogno di niente, il nostro Dio: nella preghiera chiede solo che noi teniamo aperto un canale di comunicazione con Lui per scoprirci sempre suoi figli amatissimi. E Lui ci ama tanto".
Dopo i saluti ai pellegrini polacchi, una ventata di musica e colore in aula Paolo VI: si sono esibiti, infatti, davanti a un divertito papa Francesco, artisti del circo di Cuba, con danze ed esercizi acrobatici. "Con il loro spettacolo portano bellezza, una bellezza che ci vuole tanto sforzo, allenamento per farlo. La bellezza sempre eleva il cuore, ci fa più buoni a tutti, ci porta alla bontà, ci porta a Dio. Grazie tante" così li ha salutati il Pontefice.
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- «Xenofobia» è parola sbagliata. Quando dire paura non fa vedere l’odio. La parola ’misoxenia’ non è in uso, peccato (di Ferdinando Camon)1 dicembre 2018, di Federico La Sala
«Xenofobia» è parola sbagliata: è «misoxenia».
Quando dire paura non fa vedere l’odio
di Ferdinando Camon (Avvenire, sabato 1 dicembre 2018)
«Ennesimo femminicidio: trovata uccisa con un colpo di pistola alla testa, arrestato l’ex marito»: ma se arrestano l’ex marito, perché lo si chiama ’femminicidio’ e non ’uxoricidio’? L’ex marito l’ammazza in quanto genericamente donna, o in quanto specificamente sua moglie o ex moglie?
 Ho scritto su questo giornale che molti casi di femminicidio, quasi tutti, sono in realtà uxoricidi: si punisce con la morte una donna non perché è donna, ma perché è o è stata moglie, compagna, madre dei nostri figli. Non si punisce la sua vita, ma la spartizione della sua vita con la nostra. È troppo usato il termine ’femminicidio’, e troppo poco il termine ’uxoricidio’. Ma molto spesso il termine ’femminicidio’ è sviante.
Ho scritto su questo giornale che molti casi di femminicidio, quasi tutti, sono in realtà uxoricidi: si punisce con la morte una donna non perché è donna, ma perché è o è stata moglie, compagna, madre dei nostri figli. Non si punisce la sua vita, ma la spartizione della sua vita con la nostra. È troppo usato il termine ’femminicidio’, e troppo poco il termine ’uxoricidio’. Ma molto spesso il termine ’femminicidio’ è sviante.Com’è sviante il termine ’xenofobia’. Etimologicamente, vuol dire ’paura dello straniero’. Ma molto spesso non è paura, è odio. Non è difesa, è aggressione. L’ultimo caso in cui i giornali usano (a sproposito) il termine xenofobia è di questi giorni, e viene dal profondo nord dell’Inghilterra. Accade in ambito scolastico, tra ragazzi di 15-16 anni. Nativi inglesi picchiano e umiliano un coetaneo siriano. E poi mettono in rete un filmato. I telegiornali riportano qualche sequenza: l’inglese sbarra la strada al compagno siriano, allunga una mano sulla sua faccia, il ragazzo siriano cerca di tirar dritto, tiene gli occhi bassi, l’inglese lo scaraventa a terra, quello è menomato, ha un braccio rotto e ingessato, l’altro gli rovescia una bottiglia d’acqua in faccia, dice ’t’annego’, il siriano non vede l’ora di tirarsi su e sgattaiolare via. Certo, in questa scena c’è paura dello straniero, ma ad aver paura è la vittima, che subisce le angherie per più giorni, senza dire niente in casa. I giornali parlano di bullismo più razzismo. È possibile, ma anche nei casi di razzismo non è corretto parlare di xenofobia, anche quello non è paura, è odio.
L’odio vuole più cose: far male e far scappare. Infatti qui il ragazzo siriano non voleva più tornare a scuola, la sua sì che è paura, ed essendo paura di tutti diventa paura dell’ambiente. Il siriano confessa: «Ormai avevo paura anche ad entrare nei negozi». La paura costante scende nell’inconscio, avvelena i sogni: «Mi svegliavo di notte e piangevo». La paura ininterrotta rende impossibile vivere, fa preferire la morte alla vita. Sembra una scelta irrazionale, e lo è, ma nasce da un calcolo del vantaggio, sceglie un male ritenuto minore (morire) per evitare un male ritenuto maggiore (essere umiliato). Qui è la sorella del ragazzo siriano a cercare la morte, tagliandosi le vene con una scheggia di vetro, che come si sa è più affilata di un coltello. I giornali che ho sott’occhio non mi autorizzano a tirar questa conclusione, ma evidentemente qui c’è la persecuzione non di un ragazzo o due ragazzi e non di una famiglia, ma di una (non trovo altro termine) razza. C’è odio.
 Le donne parlano spesso, giustamente, di ’misogenia’ per indicare l’atteggiamento degli uomini che disprezzano, offendono e umiliano le donne: e quel termine non significa ’paura delle donne’, ma ’odio per le donne’.
Le donne parlano spesso, giustamente, di ’misogenia’ per indicare l’atteggiamento degli uomini che disprezzano, offendono e umiliano le donne: e quel termine non significa ’paura delle donne’, ma ’odio per le donne’. Così il concetto ’paura dello straniero’, che ha generato il termine ’xenofobia’, andrebbe sostituito dal concetto di ’odio per lo straniero’. Sparirebbe l’idea giustificatoria di autodifesa che è insita nella paura: hanno paura, perciò si difendono. Ma qui in Inghilterra il persecutore si nascondeva davanti alla scuola del perseguitato, lo aspettava, lo aggrediva d’improvviso. Quello che lo spinge è proprio l’odio per lo straniero.
Così il concetto ’paura dello straniero’, che ha generato il termine ’xenofobia’, andrebbe sostituito dal concetto di ’odio per lo straniero’. Sparirebbe l’idea giustificatoria di autodifesa che è insita nella paura: hanno paura, perciò si difendono. Ma qui in Inghilterra il persecutore si nascondeva davanti alla scuola del perseguitato, lo aspettava, lo aggrediva d’improvviso. Quello che lo spinge è proprio l’odio per lo straniero.
 La parola ’misoxenia’ non è in uso, peccato, perché sarebbe utile.
La parola ’misoxenia’ non è in uso, peccato, perché sarebbe utile. -
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- MEMORIA DEL REGNO. Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve (di Ermes Ronchi)).22 novembre 2018, di Federico La Sala
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA.
IL "PADRE NOSTRO" E IL "CRISTO RE": IL REGNO DI DIO-MAMMONA ("CARITAS") O DI DIO-AMORE ("CHARITAS")!? *
"LE VIE DELLA VERITÀ. [...] per la verifica rinascimentale, analizzare la letteratura dei cristiani offesi, a partire dal Contra hypocritas di Poggio Bracciolini fino all’Isola dei papòmani nel Gargantua di Rabelais. In una lettera del 2 luglio 1497 Savonarola esortò un monaco «all’animosa libertà» contro le parole abbiette, ossia agli ordini ipocriti, pur indorate dalla potestà papale, detta suprema o delle Chiavi. Chi passava dalla collera etica contro la menzogna delle parole [...] alla satira beffarda, si soffermava soprattutto sull’evoluzione del titolo papale di servo dei servi di Dio, per dimostrare che avesse preso senso di signore dei signori, «dominus dominantium»: si legga l’Eremita di Antonio de’ Ferraris detto il Galateo. Anzi era pensiero di Michelangelo che servo dei servi si diviene in croce e perciò quel titolo compete solo a Cristo (Rime, n. 298). Per parte mia sono convinto dell’ironia di Raffaello quando nelle Stanze Vaticane figura Pietro scalzo e i papi Giulio II e Leone X nella pompa della gloria" (cfr. Romeo De Maio, Rinascimento senza toga, Alfredo Guida Editore, Napoli, 1999, p. 18).
Il Vangelo
Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 22 novembre 2018)
Gesù Cristo Re dell’Universo
- Anno B
- In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all’altro; Pilato e il potere inesorabile dell’impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna.
Con Gesù invece arriva un’aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare. Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo?
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re?
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma?
Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato?
E cerca di portare Pilato su di un’altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell’altro. Che è differente, è ad un’altra latitudine del cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un’anima di violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e produce morte. Il mio mondo è quello dell’amore e del servizio che producono vita. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l’essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui che serve.
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il più armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero.
La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto dell’uomo, che è un amore diventato visibile.
 Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos’è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è.
Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos’è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è.
 Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell’uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.
Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell’uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere.Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino.
(Letture: Deuteronomio 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33-37)
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!
- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - iL "PADRE NOSTRO"?! UN "LAMENTO DELLA PACE" DEL 1517 (di Erasmo da Rotterdam).19 novembre 2018, di Federico La Sala
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA ...
iL "PADRE NOSTRO"?! Alcune pagine dalla "Querela pacis" (1517)
di Erasmo *
Pochi anni fa, quando il mondo era travolto a prendere le armi da non so quale peste esiziale, alcuni araldi del Vangelo, frati Minori e Predicatori, dal sacro pulpito davano fiato ai corni di guerra e ancor piú infervoravano chi già propendeva per quella follia. In Inghilterra aizzavano contro i Francesi, in Francia animavano contro gli Inglesi, ovunque spronavano alla guerra. Alla pace non incitava nessuno tranne uno o due, a cui costò quasi la vita l’aver soltanto pronunciato il mio nome.
 Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli.
Prelati consacrati scorrazzavano un po’ dovunque dimentichi della loro dignità e dei loro voti, e inasprivano con la loro opera il morbo universale, istigando ora il pontefice romano Giulio, ora i monarchi ad affrettare la guerra, quasi che non fossero già abbastanza folli per conto loro. Eppure questa patente pazzia noi l’avvolgemmo in splendidi titoli.
 A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza - dovrei dire con sacrilegio - le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.
A tal fine sono da noi distorte con somma impudenza - dovrei dire con sacrilegio - le leggi dei padri, gli scritti di uomini santi, le parole della Sacra Scrittura. Le cose sono giunte a tal punto che risulta sciocco e sacrilego pronunciarsi contro la guerra ed elogiare l’unica cosa elogiata dalla bocca di Cristo. Appare poco sollecito del bene del popolo e tiepido sostenitore del sovrano chi consiglia il massimo dei benefici e scoraggia dalla massima delle pestilenze.Ormai i sacerdoti seguono perfino le armate, i vescovi le comandano, abbandonando le loro chiese per occuparsi degli affari di Bellona. Ormai la guerra produce addirittura sacerdoti, prelati, cardinali ai quali il titolo di legato al campo sembra onorifico e degno dei successori degli Apostoli. Per cui non fa meraviglia se hanno spirito marziale coloro che Marte ha generato. Per rendere poi il male insanabile, coprono un tale sacrilegio col sacro nome della religione. Sugli stendardi sventola la croce.
 Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere.
Armigeri spietati e ingaggiati per poche monete a compiere macelli spaventosi innalzano l’insegna della croce, e simboleggia la guerra il solo simbolo che dalla guerra poteva dissuadere.
 Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. -Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere.
Che hai a che fare con la croce, scellerato armigero? I tuoi sentimenti, i tuoi misfatti convenivano ai draghi, alle tigri, ai lupi. -Quel simbolo appartiene a Colui che non combattendo ma morendo colse la vittoria, salvò e non distrusse; da lí soprattutto potevi imparare quali sono i tuoi nemici, se appena sei cristiano, e con quale tattica devi vincere.
 Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato?
Tu innalzi l’insegna della salvezza mentre corri alla perdizione del fratello, e fai perire con la croce chi dalla croce fu salvato? Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. -Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.
Ma che! Dai sacri e adorabili misteri trascinati anch’essi per gli accampamenti, da queste somme raffigurazioni della concordia cristiana si corre alla mischia, si avventa il ferro spietato nelle viscere del fratello e sotto gli occhi di Cristo si dà spettacolo della piú scellerata delle azioni, la piú gradita ai cuori empi: se pure Cristo si degni di essere là. Colmo poi dell’assurdo, in entrambe le armate, in entrambi gli schieramenti brilla il segno della croce, in entrambe si celebra il sacrificio. -Quale mostruosità è questa? La croce in conflitto con la croce, Cristo in guerra con Cristo. È un simbolo fatto per atterrire i nemici della cristianità: perché adesso combattono quello che adorano? Uomini degni non di quest’unica croce, ma della croce patibolare.Ditemi, come il soldato può recitare il “Padre nostro” durante queste messe? Bocca insensibile, osi invocare il Padre mentre miri alla gola del tuo fratello? “Sia santificato il tuo nome”: come si potrebbe sfregiare il nome di Dio piú che con queste vostre risse? “Venga il tuo regno”: cosí preghi tu che su tanto sangue erigi la tua tirannide? “Sia fatta la tua volontà, come in cielo, cosí anche in terra”: Egli vuole la pace, tu prepari la guerra.
 “Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui?
“Il pane quotidiano” chiedi al Padre comune mentre abbruci le messi del fratello e preferisci che vadano perse anche per te piuttosto che giovare a lui?
 Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?
Infine come puoi pronunciare con la lingua le parole “e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” mentre ti lanci a un fratricidio? Scongiuri il rischio della tentazione mentre con tuo rischio getti nel rischio il fratello. “Dal male” chiedi di essere liberato mentre ti proponi di causare il massimo male al fratello?*
Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 51-55.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? - "NON ABBANDONARCI NELLA TENTAZIONE". La Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del "Messale Romano", a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni.15 novembre 2018, di Federico La Sala
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E "LATINORUM" ...
Assemblea dei vescovi.
La Cei approva la nuova traduzione di Padre nostro e Gloria
Il documento finale dell’Assemblea generale straordinaria. Lotta alla pedofilia, nasce un Servizio nazionale per la tutela dei minori
di Redazione Internet (Avvenire, giovedì 15 novembre 2018)
L’Assemblea generale della Cei ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. In tale arco di tempo, si legge nel comunicato finale dell’Assemblea generale straordinaria della Cei (12-15 novembre), vescovi ed esperti hanno lavorato al miglioramento del testo sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della Presentazione del Messale, che aiuterà non solo a una sua proficua recezione, ma anche a sostenere la pastorale liturgica nel suo insieme.
Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»).
Riconsegnare ai fedeli il Messale Romano con un sussidio
Nell’intento dei vescovi, la pubblicazione della nuova edizione costituisce l’occasione per contribuire al rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica. Di qui la sottolineatura, emersa nei lavori assembleari, relativa alla necessità di un grande impegno formativo. In quest’ottica «si coglie la stonatura di ogni protagonismo individuale, di una creatività che sconfina nell’improvvisazione, come pure di un freddo ritualismo, improntato a un estetismo fine a se stesso». La liturgia, hanno evidenziato i vescovi, coinvolge l’intera assemblea nell’atto di rivolgersi al Signore: «Richiede un’arte celebrativa capace di far emergere il valore sacramentale della Parola di Dio, attingere e alimentare il senso della comunità, promuovendo anche la realtà dei ministeri. Tutta la vita, con i suoi linguaggi, è coinvolta nell’incontro con il Mistero: in modo particolare, si suggerisce di curare la qualità del canto e della musica per le liturgie». Per dare sostanza a questi temi, si è evidenziata l’opportunità di preparare una sorta di «riconsegna al popolo di Dio del Messale Romano» con un sussidio che rilanci l’impegno della pastorale liturgica.
Nasce un Servizio nazionale per la tutela dei minori
Riguardo alla lotta alla pedofilia, dall’Assemblea generale emerge che le Linee guida che la Commissione della Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili sta formulando «chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e anche una comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni». La Commissione - che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione della Commissione per la Tutela dei minori della Santa Sede e soprattutto della Congregazione per la dottrina della fede - ha l’impegno di portare le Linee guida all’approvazione del Consiglio permanente, per arrivare a presentarle alla prossima Assemblea generale.
 Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni.
Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni.I vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concretezza al cammino. È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, con un proprio Statuto, un regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e religiosi esperti saranno a disposizione dei vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di avviare i percorsi e le realtà diocesani - o inter-diocesani o regionali - di formazione e prevenzione. Inoltre, «potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei procedimenti processuali canonici e civili, secondo lo spirito delle norme e degli orientamenti che saranno contenuti nelle nuove Linee guida».
La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. Si tratta di individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un percorso di formazione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto del Centro per la tutela dei minori dell’Università Gregoriana.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" CATTOLICO-ROMANO.
STORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è finito...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO, HENRI DE LUBAC, E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - La rabbia e l’orgoglio dei filologi. A proposito di "La filologia al servizio delle nazioni" di Stefano Rapisarda.24 ottobre 2018, di Federico La Sala
La rabbia e l’orgoglio dei filologi. A proposito di "La filologia al servizio delle nazioni" di Stefano Rapisarda
di Claudio Giunta ("Le parole e le cose", 24.10.2018) *
Chissà se i medici dubitano della medicina, gli ingegneri dell’ingegneria, i parrucchieri della parruccheria con lo stesso zelo con cui gli umanisti di oggi dubitano dell’umanesimo? Probabilmente no: ci saranno sempre tumori da curare, ponti da costruire, capelli da tagliare, sarà sempre abbastanza facile, per loro, rispondere alla domanda «Sì, ma a che cosa servite?». Le discipline umanistiche sono sempre state un po’ meno necessarie, ma c’è la diffusa impressione che il loro credito sia andato diminuendo in fretta negli ultimi decenni, per l’indebolirsi delle culture nazionali, l’impoverimento degli Stati che pagano i professori di ‘umanità’, il prevalere del sapere tecnico-scientifico, internet e le solite altre cose. In questo quadro non roseo, in La filologia al servizio delle nazioni Stefano Rapisarda riflette sulla sorte - anch’essa parrebbe non rosea - di una delle discipline in cui si articola lo studio della letteratura: la filologia, appunto, e la filologia romanza in particolare.
Il libro ha tre parti. Nella prima, Rapisarda constata la crisi degli studi filologici: crisi che non dipende dalla diminuita qualità dei prodotti (anzi, soprattutto in Italia i prodotti di questi studi continuano ad essere eccellenti, e nel novero vanno inclusi quelli dello stesso Rapisarda, che è un medievista insigne) bensì da una sorta di fine del mandato sociale che i filologi un tempo detenevano, non solo nel campo della cultura ma anche in quello, più ristretto, dello studio universitario della letteratura: delle ricerche e dei pareri dei filologi non ci si cura più granché.
Nella seconda parte Rapisarda racconta la storia della filologia romanza negli ultimi due secoli isolando una serie di ‘paradigmi’, cioè di modelli che hanno informato lo studio delle letterature neolatine del Medioevo: un paradigma nazionalistico sviluppatosi soprattutto in Germania e in Francia, vigorosissimo per tutto l’Ottocento e il primo Novecento; un paradigma Curtius, che mira invece al superamento delle moderne frontiere nazionali e cerca l’unità culturale là dove si erano cercati soprattutto i documenti delle distinte identità nazionali; un paradigma della ‘semiotica filologica’, che prova a far dialogare la filologia con lo strutturalismo e le altre scienze umane e sociali (non credo di forzare il pensiero dell’autore se dico che i frutti di questo dialogo gli paiono, come paiono anche a me, praticamente nulli); un paradigma della ‘filologia materiale’, che in vario modo valorizza la materialità dei testimoni manoscritti.
Nella terza parte Rapisarda si domanda «Che fare?», e risponde - più o meno - che la disciplina va reimpostata in chiave davvero comparatistica come Weltphilologie, allargando lo sguardo alle linee di confine, in particolare studiando meglio di come si sia fatto sinora i rapporti tra Europa continentale e Mediterraneo (filologia euro-mediterranea) e i rapporti tra Europa e Oriente (filologia euro-asiatica). Orizzonti tanto vasti non incoraggeranno il dilettantismo? E di fronte alla globalizzazione imposta dall’economia e dai media la missione delle discipline umanistiche, e della filologia in ispecie, non dovrebbe essere proprio quella di distinguere con pazienza, badando alle differenze anziché alle analogie superficiali? Rapisarda oscilla. Da un lato, è un filologo troppo esperto per non vedere che questa neo-Weltphilologie produce spesso studi fragili, velleitari, ideologici in senso deteriore («Atene nera» di Bernal? Davvero?); dall’altro, prova una certa nostalgia per l’Età dell’Impegno, e pur prendendo le distanze dagli eccessi comparatistici, elogia il fatto che anziché di minuzie che non interessano nessuno si parli di cose: «Sotto il profilo probatorio [European Modernity and the Arab Mediterranean di Karla Mallette] è un libro discutibile, e infatti se ne discute e io stesso ne ho discusso. Ma almeno c’è vita, passione, entusiasmo, ardimento intellettuale. Ciò che da molto manca all’algido tecnicismo della filologia europea». Non mi unirei all’elogio.
A unificare le tre parti, infine, un’idea fissa, un motivo ricorrente che è poi anche la tesi fondamentale del libro, e che potremmo definire come un sobrio appello alla militanza: «La filologia non è utile o interessante in assoluto, lo è quando si applica ai temi ideologicamente caldi intorno ai quali è nata [...]. L’auspicio è che le filologie si ridefiniscano intorno ai ‘temi caldi’ di un’epoca, alle passioni politico-ideologiche, ai Grandi Libri sui quali ogni civiltà è costruita, e che esse riannodino i legami con la comunità di cui sono espressione». Vasto programma.
Sono d’accordo su molte delle opinioni che Rapisarda sviluppa nel suo libro, sottoscriverei quasi ogni pagina, anche se quasi nessuna pagina avrei saputo scrivere: perché sono ben lontano dall’avere l’ampiezza d’informazione e di visione che ha lui (ma credo che ben pochi tra gli studiosi in attività sappiano padroneggiare un campo di studi così ampio, che va dai poeti federiciani alla narratologia, dalle ricerche sul folklore alla Postcolonial Theory).
 Sono meno d’accordo sulla sua tesi principale, quella che ispira anche il titolo del libro, e cioè che gli studi filologici, per prosperare, abbiano bisogno di ritagliarsi un ruolo nella battaglia delle idee, di diventare armi da adoperare nel conflitto politico. C’è del vero, ovviamente, in questa opinione, c’è storicamente del vero, e Rapisarda lo documenta bene, ma lo stesso si potrebbe dire della storia, della geografia, della linguistica, della storia letteraria, e insomma di ogni disciplina che - semplifico - faccia centro non sull’oggettività delle cose (da quante carte è formato il tal manoscritto?) ma sulla loro interpretazione (in quale lingua è scritto quel dato documento? Quale popolo si è insediato per primo su quel dato territorio?): cioè appunto quasi tutte le discipline umanistiche.
Sono meno d’accordo sulla sua tesi principale, quella che ispira anche il titolo del libro, e cioè che gli studi filologici, per prosperare, abbiano bisogno di ritagliarsi un ruolo nella battaglia delle idee, di diventare armi da adoperare nel conflitto politico. C’è del vero, ovviamente, in questa opinione, c’è storicamente del vero, e Rapisarda lo documenta bene, ma lo stesso si potrebbe dire della storia, della geografia, della linguistica, della storia letteraria, e insomma di ogni disciplina che - semplifico - faccia centro non sull’oggettività delle cose (da quante carte è formato il tal manoscritto?) ma sulla loro interpretazione (in quale lingua è scritto quel dato documento? Quale popolo si è insediato per primo su quel dato territorio?): cioè appunto quasi tutte le discipline umanistiche.
 Personalmente (ma credo di poter parlare a nome di molti), il mio interesse per la filologia nasce soprattutto dalla sua avalutatività, cioè dal suo tenersi a dati oggettivi - che ci sono: non è tutto interpretazione - sui quali possono convergere studiosi e lettori di indole disparata: il luogo dell’intesa, non quello del conflitto (e basta vedere che cosa è successo negli ultimi decenni in Catalogna, un caso che Rapisarda infatti menziona un po’ di sfuggita, ma su cui conveniva forse indugiare di più: ecco una situazione nella quale le humanities sono state mobilitate per avallare ipotesi storiche quantomeno peregrine; a me non pare una strada da seguire).
Personalmente (ma credo di poter parlare a nome di molti), il mio interesse per la filologia nasce soprattutto dalla sua avalutatività, cioè dal suo tenersi a dati oggettivi - che ci sono: non è tutto interpretazione - sui quali possono convergere studiosi e lettori di indole disparata: il luogo dell’intesa, non quello del conflitto (e basta vedere che cosa è successo negli ultimi decenni in Catalogna, un caso che Rapisarda infatti menziona un po’ di sfuggita, ma su cui conveniva forse indugiare di più: ecco una situazione nella quale le humanities sono state mobilitate per avallare ipotesi storiche quantomeno peregrine; a me non pare una strada da seguire).Qui però sta il problema, che è in fondo anche il problema che ha indotto Rapisarda a scrivere questo libro. Ha ancora senso, oggi, reclutare giovani studiosi e metterli a lavorare per anni, per decenni, alla mappa di un mondo culturale (il Medioevo romanzo) che, oltre ad essere in buona misura già stato mappato, appare così lontano dagli interessi odierni, dalla vita odierna? Può durare, è giusto far durare, finanziandola, la disciplina che produce contributi come «Appunti sulle maiuscole del cod. Hamilton 90», «Tradizioni regionali e tassonomie editoriali dei canzonieri antico-francesi», «Sinalefe e dialefe: appunti per una tipologia degli incontri vocalici interverbali nella versificazione occitana» (gli esempi sono di Rapisarda, che è questa rara avis: un filologo spiritoso)?
Mi pare che le ragioni dell’odierna ‘crisi delle humanities’ - e della più seria e fondativa delle humanities, la filologia - vadano cercate meno nella loro contingente irrilevanza per la battaglia delle idee (così Rapisarda) che nella loro radicale estraneità all’aria del tempo presente. L’epoca eroica delle filologie è il secolo che va dalla metà dell’Ottocento alla metà del Novecento. Prima prevale l’empiria. Dopo, nel tempo presente appunto, cominciano ad affiorare i dubbi, le esitazioni di fronte alla domanda «Sì, ma a che serve?». Anche per questo, in questa età argentea, la filologia e la critica sono state anche troppo propense a salire sul carro del vincitore di turno: il marxismo, Bachtin, lo strutturalismo, gli studi postcoloniali eccetera - tutto il nuovo cemento col quale i filologi hanno sperato di puntellare le proprie rovine.
 Il libro di Rapisarda è, tra le altre cose, un utile promemoria sulle tante scemenze che gli studiosi di letteratura, e purtroppo anche i filologi, hanno preso sul serio nel tentativo di mostrarsi à la page. Qualcuno continua ancora adesso, imperterrito; ma i più hanno capito: le cose vanno meglio oggi che trenta o quarant’anni fa; anche se parliamo continuamente di crisi, la disciplina è in piena salute.
Il libro di Rapisarda è, tra le altre cose, un utile promemoria sulle tante scemenze che gli studiosi di letteratura, e purtroppo anche i filologi, hanno preso sul serio nel tentativo di mostrarsi à la page. Qualcuno continua ancora adesso, imperterrito; ma i più hanno capito: le cose vanno meglio oggi che trenta o quarant’anni fa; anche se parliamo continuamente di crisi, la disciplina è in piena salute.Perché questo nervosismo, allora? Non è tutto semplice? I filologi devono fare bene il loro mestiere: studiare la storia e la tradizione dei testi, allestirne l’edizione, commentarli con erudizione e intelligenza. Solo che è una semplicità difficile a farsi. Nelle università italiana ci sono ancora molte persone, e molti giovani, che fanno esattamente questo, tenendo vivo un habitus che sembra essersi già perso in quasi tutte le altre nazioni occidentali.
 Ma - Rapisarda ha ragione - questo sembra non bastare più: da un lato per la spinta anti-filologica che sempre più forte si avverte all’interno dell’università (parliamo di idee, di diritti, di conflitti, non di varianti manoscritte!); dall’altro per il disinteresse che il vasto mondo che sta al di fuori dell’università sembra nutrire per un sapere umanistico che non sia direttamente spendibile nel dibattito (meglio le scienze sociali di quelle storiche filologiche) o sul mercato culturale (meglio la storia dell’arte, col suo indotto di mostre, della paleografia, che di mostre quasi non ne produce). Perché allora darsi da fare per acquisire un habitus che richiede molto tempo e infinita dedizione, una dedizione tale da escludere quasi qualsiasi altro interesse culturale nonché di vita, se poi la voce di coloro che hanno acquisito questo habitus, i filologi, è così flebile? -Questo poteva non essere un problema un tempo, quando la cultura era un prodotto o un’emanazione della scuola e dell’università; ma è un problema oggi, quando quella cultura non solo è travolta dall’infinita produzione d’idee e di opere d’arte che ignorano il filtro scolastico ma sembra addirittura inadatta a ‘preparare alla vita’, per come la vita è diventata (per non lasciare il discorso nel vago: in tanta concentrazione sui libri del passato, sempre più incombe il rischio di non saper capire quel che succede nel presente, o di voler applicare al presente, sventatamente, i principi di Tucidide o di Dante Alighieri: che è un altro nome della stupidità).
Ma - Rapisarda ha ragione - questo sembra non bastare più: da un lato per la spinta anti-filologica che sempre più forte si avverte all’interno dell’università (parliamo di idee, di diritti, di conflitti, non di varianti manoscritte!); dall’altro per il disinteresse che il vasto mondo che sta al di fuori dell’università sembra nutrire per un sapere umanistico che non sia direttamente spendibile nel dibattito (meglio le scienze sociali di quelle storiche filologiche) o sul mercato culturale (meglio la storia dell’arte, col suo indotto di mostre, della paleografia, che di mostre quasi non ne produce). Perché allora darsi da fare per acquisire un habitus che richiede molto tempo e infinita dedizione, una dedizione tale da escludere quasi qualsiasi altro interesse culturale nonché di vita, se poi la voce di coloro che hanno acquisito questo habitus, i filologi, è così flebile? -Questo poteva non essere un problema un tempo, quando la cultura era un prodotto o un’emanazione della scuola e dell’università; ma è un problema oggi, quando quella cultura non solo è travolta dall’infinita produzione d’idee e di opere d’arte che ignorano il filtro scolastico ma sembra addirittura inadatta a ‘preparare alla vita’, per come la vita è diventata (per non lasciare il discorso nel vago: in tanta concentrazione sui libri del passato, sempre più incombe il rischio di non saper capire quel che succede nel presente, o di voler applicare al presente, sventatamente, i principi di Tucidide o di Dante Alighieri: che è un altro nome della stupidità).Tutto sommato, perciò, sono un po’ più pessimista di Rapisarda. La politica cambia in fretta, le ideologie anche, e alla stasi di un decennio può seguire un’epoca di conflitti (non è quella che viviamo oggi?), un’epoca che potrà essere, per ipotesi, più congeniale a quella seria, metodica critica del passato che è la filologia. Ma l’aria del tempo sfugge alla volontà degli uomini, si orienta verso ciò che è utile più che verso ciò che è giusto; e dura a lungo. Che fare, dunque, da cultori di discipline umanistiche? Andare contro l’aria del tempo, è ovvio.
* Già pubblicato in una versione più breve sul Domenicale del Sole 24 ore del 21 ottobre 2018
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - La rabbia e l’orgoglio dei filologi. A proposito di "La filologia al servizio delle nazioni" di Stefano Rapisarda.25 ottobre 2018, di Federico La Sala
La filologia al servizio delle nazioni. Storia, crisi e prospettive della filologia romanza
di Stefano Rapisarda *
Se un giorno la filologia morisse, la critica morirebbe con lei, la barbarie rinascerebbe, la credulità sarebbe di nuovo padrona del mondo». Così Ernest Renan ne "L’avenir de la science" (1890) tesseva un altissimo elogio della filologia, una delle scienze regine del XIX secolo.
Oggi, al tempo delle fake news e della post-verità, quelle parole ci ricordano che la filologia può essere ancora argine alla barbarie. E ci ricordano che la filologia, quella con aggettivi e quella senza, è intrinsecamente politica. Non è utile o interessante in sé: lo è quando è schierata, militante, "calda", quando tocca interessi, quando serve interessi. Quando è "al servizio" di un Principe o di un partito o di uno Stato o di una visione del mondo.
Ci ricordano insomma che la filologia è anche politica, come sapevano Lorenzo Valla e Baruch Spinoza, Ernest Renan e Ulrich Wilamowitz-Möllendorff, Gaston Paris e Paul Meyer, Eduard Koschwitz e Joseph Bédier, Ernst Robert Curtius e Erich Auerbach, Cesare Segre e Edward Said.
Eppure la filologia, con o senza aggettivi, oggi sa di polvere e di noia. Ciò sollecita varie domande: perché questa antica "scienza del testo" si è ridotta al margine della cultura di oggi? Può tornare al centro dei bisogni intellettuali dell’uomo contemporaneo? Quale tipo di filologia può ancora servire il mondo e servire al mondo?
*
SCHEDA - Academia.Edu
-
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Papa Bergoglio in una situazione eccezionalmente difficile dentro e fuori la Chiesa (di G. E. Rusconi).11 ottobre 2018, di Federico La Sala
La scelta di un papa inquieto
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 11.10.2018)
«L’aborto è come affittare un sicario». E’ un’immagine pesante, non facilmente comprensibile e vagamente diffamatoria quella usata dal Papa. Ma l’aborto viene da lui senz’altro omologato al «disprezzo della vita» quale si esprime nel lungo elenco delle guerre, degli sfruttamenti di ogni genere, di tutti gli abusi per opportunismo. Si tratta di parole gravi che contano, pronunciate da un maestro della comunicazione diretta e coinvolgente come Papa Francesco.
Eppure sulla base della sua esperienza pastorale, il Pontefice dovrebbe sapere che l’aborto non è semplicisticamente riducibile a «un problema per risolvere il quale si fa fuori una vita umana». E’ un’esperienza angosciosa intima .
Soprattutto Bergoglio ignora che «il problema» o «il diritto» all’’interruzione della gravidanza è riconosciuto dalla legge secondo determinate e ben precise condizioni. Essa riguarda «una gravidanza che comporti un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o alla previsione di anomalie o malformazioni del concepito. L’accesso all’intervento abortivo è dalla legge garantito in quelle circostanze, cosicché parlare di libertà di aborto è una forzatura che la legge non consente». Così ha scritto qualche giorno fa su questo giornale Vladimiro Zagrebelsky, augurandosi che non si ritorni a contrapposizioni irragionevoli, aggressive e diffamatorie.
Invece ci risiamo, e proprio per bocca del Papa. Adesso ci manca solo l’intervento di Matteo Salvini.
 E’ triste dover fare questa battuta. Ma ferme restando le ragioni di principio dell’opposizione del Pontefice e del mondo cattolico all’interruzione della gravidanza, è innegabile che essa risenta del mutamento del clima politico e culturale del Paese. E che ci sia la tentazione di approfittarne per riaprire una questione che sembrava risolta nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche.
E’ triste dover fare questa battuta. Ma ferme restando le ragioni di principio dell’opposizione del Pontefice e del mondo cattolico all’interruzione della gravidanza, è innegabile che essa risenta del mutamento del clima politico e culturale del Paese. E che ci sia la tentazione di approfittarne per riaprire una questione che sembrava risolta nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche.Questa tentazione è un segnale importante dell’ avanzare di una democrazia illiberale nel nostro Paese. Si fanno prepotenti i segnali di insofferenza della classe politica al governo per ridurre o condizionare gli spazi di libertà di espressione della stampa. In maniera più pasticciata e subdola vengono alterati i diritti costituzionalmente riconosciuti ai richiedenti asilo, ai profughi, ai migranti. A questo proposito però esiste il consenso detto e non detto della popolazione e dello stesso mondo cattolico - con l’eccezione di pochi gruppi che rischiano però di godere di una visibilità mediatica fine a se stessa.
In tema di migrazione, accoglienza e integrazione dei migranti la stessa voce del Papa così forte, insistente, perentoria e persino provocatoria sino ad un anno fa, sembra in qualche modo ridimensionata. Si è fatta più realistica. Spero che questa mia affermazione non venga maliziosamente fraintesa.
Papa Bergoglio si trova in una situazione eccezionalmente difficile dentro e fuori la Chiesa. Nei suoi contatti e comunicazioni esterne talvolta si ha l’impressione che, senza abbandonare la sua tipica giovialità, sia profondamente turbato.
 Questo turbamento si esprime anche nel suo schietto linguaggio tradizionale che mette continuamente in guardia qui e ora contro la presenza e l’opera del demonio. In fondo è lui il sicario dell’aborto.
Questo turbamento si esprime anche nel suo schietto linguaggio tradizionale che mette continuamente in guardia qui e ora contro la presenza e l’opera del demonio. In fondo è lui il sicario dell’aborto. -
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Gesù e i suoi discepoli; la donna e Paolo; e i dottori della legge. Lo scandalo degli ipocriti.21 settembre 2018, di Federico La Sala
Lo scandalo degli ipocriti
· Messa a Santa Marta · *
- «La Chiesa, quando cammina nella storia, è perseguitata dagli ipocriti: ipocriti da dentro e da fuori» e «il diavolo che è impotente con i peccatori pentiti», è forte proprio con gli ipocriti: «li usa per distruggere la gente, la società, la Chiesa». Con un invito ad affidarsi sempre più alla misericordia e al perdono di Dio, stando alla larga dallo «scandalo degli ipocriti»,
 Papa Francesco ha celebrato, giovedì 20 settembre, la messa a Santa Marta. *
Papa Francesco ha celebrato, giovedì 20 settembre, la messa a Santa Marta. *
«Nelle letture di oggi ci sono tre gruppi di persone: Gesù e i suoi discepoli; la donna e Paolo; e i dottori della legge». Riferendosi al passo evangelico di Luca (7, 36-50) «Gesù è invitato ma ricevuto senza tante cortesie - le cortesie abituali del suo tempo - ma lui fa finta di non accorgersene e va avanti. E appare questa donna. Il Vangelo dice una “peccatrice” - così la qualificavano - una di quelle il cui destino era o essere visitate di nascosto, anche da questi, i farisei, o essere lapidate». Ma «questa donna - ha fatto presente il Pontefice - si fa vedere con amore, con tanto amore verso Gesù, e non nasconde l’essere peccatrice, perché tutti la conoscevano, anche tanti lì a tavola l’avevano visitata».
Accennando poi al brano della prima lettera ai Corinzi (15, 1-11), il Papa ha fatto notare che «Paolo dopo aver parlato di tante cose, anche dei carismi, della Chiesa, va al nocciolo della salvezza: “A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati [...] Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio”».
Dunque, ha rilanciato Francesco, «ambedue cercavano Dio con amore, ma amore “a metà”». Paolo «perché pensava che l’amore fosse una legge e aveva il cuore chiuso alla rivelazione di Gesù Cristo: perseguitava i cristiani, ma per lo zelo della legge, per questo amore non maturo». E «questa donna - ha proseguito il Papa - cercava l’amore, come quell’altra, la samaritana: poverina, tanti mariti e non trovava l’amore, e lo cercava. Il piccolo amore. E Gesù dice: “A questa le è stato perdonato tanto perché ha amato molto”».
«Ma come amare? Queste non sanno amare. Cercano l’amore» ha affermato il Pontefice. E «Gesù, parlando di queste, dice - una volta ha detto - che saranno davanti a noi nel regno dei cieli. “Ma quale scandalo...” - i farisei - “ma questa gente!”». Invece «Gesù guarda il piccolo gesto di amore, il piccolo gesto di buona volontà, e lo prende e lo porta avanti. Questa è la misericordia di Gesù: sempre perdona, sempre riceve».
«Un altro gruppo» ha spiegato Francesco riferendosi al brano odierno del Vangelo, è quello composto da «dottori della legge che guardavano Gesù per vedere se potevano trovarlo in errore tendendogli un tranello». Queste persone, ha aggiunto, «hanno un atteggiamento che soltanto gli ipocriti usano spesso: si scandalizzano. “Ma guarda, quale scandalo! Non si può vivere così! Abbiamo perduto i valori... Adesso tutti hanno il diritto di entrare in chiesa, anche i divorziati, tutti. Ma dove stiamo?”». E questo è «lo scandalo degli ipocriti».
«Questo è il dialogo - ha insistito il Pontefice - tra l’amore grande che perdona tutto, di Gesù, l’amore “a metà” di Paolo e di questa signora, e anche il nostro, che è un amore incompleto perché nessuno di noi è santo canonizzato. Diciamo la verità». E «l’ipocrisia: l’ipocrisia dei “giusti”, dei “puri”, di coloro che si credono salvati per i propri meriti esterni». Ma «Gesù a loro dice - agli ipocriti - “sepolcri imbiancati”. Tutto bello, cimiteri belli, ma dentro putredine e un marciume». Proprio «così è l’anima degli ipocriti».
«La Chiesa, quando cammina nella storia, è perseguitata dagli ipocriti: ipocriti da dentro e da fuori» ha affermato il Papa. «Il diavolo non ha niente da fare con i peccatori pentiti, perché guardano Dio e dicono: “Signore sono peccatore, aiutami”». E se «il diavolo è impotente» con i peccatori pentiti, «è forte con gli ipocriti. È forte, e li usa per distruggere, distruggere la gente, distruggere la società, distruggere la Chiesa». E «il cavallo di battaglia del diavolo è l’ipocrisia, perché lui è un bugiardo: si fa vedere come principe potente, bellissimo, e da dietro è un assassino».
La liturgia, dunque, oggi propone questi «tre gruppi di persone» ha riaffermato Francesco: «Gesù, che perdona, riceve, che è misericordioso, parola tante volte dimenticata quando sparliamo degli altri. Pensate a questo: dobbiamo essere misericordiosi, come Gesù, e non condannare gli altri. Gesù al centro». Poi ci sono «Paolo, peccatore, persecutore, ma con un amore “a metà”» e «questa signora, peccatrice, anch’essa con un amore “incompleto”». Ma «Gesù perdona tutti e due. E incontrano il vero amore: Gesù». Infine ci sono «gli ipocriti, che sono incapaci di incontrare l’amore perché hanno il cuore chiuso, nelle proprie idee, nelle proprie dottrine, nella propria legalità».
«Chiediamo a Gesù - è l’invito di Francesco a conclusione dell’omelia - che protegga sempre la nostra Chiesa, che come madre è santa ma piena di figli peccatori come noi. E che la protegga con la sua misericordia e il suo perdono ognuno di noi».
- «La Chiesa, quando cammina nella storia, è perseguitata dagli ipocriti: ipocriti da dentro e da fuori» e «il diavolo che è impotente con i peccatori pentiti», è forte proprio con gli ipocriti: «li usa per distruggere la gente, la società, la Chiesa». Con un invito ad affidarsi sempre più alla misericordia e al perdono di Dio, stando alla larga dallo «scandalo degli ipocriti»,
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE"19 agosto 2018, di Federico La Sala
AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE". L’*AMORE* Di MARIA E GIUSEPPE E LA "PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018" : .
- Preghiera dei bambini (1870): “Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” (http://www.fondazioneterradotranto.it/2018/07/06/ggimentu-gimmientu-e-ggimintare/#comment-96032)
- Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16).
PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 *
 Dio, nostro Padre,
Dio, nostro Padre,
 Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
 Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
 Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
 Rendici pazienti e gentili,
Rendici pazienti e gentili,
 Amorevoli e generosi,
Amorevoli e generosi,
 Accoglienti con i bisognosi.
Accoglienti con i bisognosi.
 Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
 Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
 Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
 [facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
 persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
 Aumenta la nostra fede,
Aumenta la nostra fede,
 Rendi forte la nostra speranza,
Rendi forte la nostra speranza,
 Conservaci nel tuo amore,
Conservaci nel tuo amore,
 Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
 Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, Amen
Amen Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
 San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
 Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
 San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.*Fonte: https://www.worldmeeting2018.ie/WMOF/media/downloads/prayerA4-IT.pdf
* L’Incontro mondiale. «Famiglia, sfida globale». Ecco il senso dell’incontro di Dublino. L’arcivescovo Martin, primate della Chiesa d’Irlanda: Amoris Laetitia, messaggio di misericordia nella complessità. Uno spazio dedicato anche al soloroso tema degli abusi (di Luciano Moia, Avvenire, venerdì 17 agosto 2018: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/famiglia-sfida-globale-ecco-il-senso-di-dublino).
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala (18.08.2018)
-
>FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE" --- Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima (di Maurizio Fiasco).19 agosto 2018, di Federico La Sala
IL SENNO DI PRIMA ("PROMETEO"), IL SENNO DI POI ("EPIMETEO"), E IL "DISPOSITIVO DI DERIVAZIONE KANTIANA" ...*
- (...) il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può» (Maurizio Fiasco, "Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima", Avvenire, 18.08.2018)).
Il sociologo.
Tutti i disastri «irreparabili» e il senno di prima
Dopo il ragionamento è il solito, col senno di poi: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto?
di Maurizio Fiasco (Avvenire, sabato 18 agosto 2018)
- [Foto] Il balletto delle responsabilità inizia sempre dopo, col senno di poi. Il senno di prima è ignoto (Fotogramma)
Come accadono i disastri? C’è un’espressione, all’apparenza banale ma ricorrente, quando siamo sconcertati per un evento dai costi umani incalcolabili. «Col senno di poi». Che equivale: come è stato possibile che nessuno vedesse e capisse prima dell’irreparabile fatto? Quel che ha condotto al precipitare di una situazione - fisica, come un ponte, oppure comportamentale come una battaglia, un volo, il funzionamento di uno stabilimento industriale - aveva già emesso dei segnali.
 I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.
I disastri - risulta quasi sempre agli investigatori ex post - hanno avuto una incubazione, più o meno lunga. Incubazione tutt’altro che muta, o col bavaglio, anzi spesso visibile per un complesso di segnali. Come ha insegnato, quarant’anni fa un illuminato e inascoltato Barry Turner, non sono prevenuti - ovvero fermati da decisioni pragmatiche - per le patologie della comunicazione tra gli attori di un sistema. Industriale, amministrativo, finanziario, politico: non importa la scala di grandezza. Le incompetenze si strutturano e agiscono come un sistema.I segnali sono sfuggiti a un apparato cognitivo, a una mente capace di connetterli e perciò di abbattere le barriere che inibiscono il giudizio. È mancata la responsabilità di contrastare la universale ottusità dei sistemi, di tutti i sistemi organizzativi. Che squalificano la coscienziosità di chi abbia colto il segnale e si sia posto in modo attivo per spingere al provvedere.
 Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.
Egli finisce per scontrarsi con la gerarchia, con i muri levati su dai rituali dell’organizzazione, per impattare con la squalificazione che si replica davanti all’umile operatore che sta sul terreno e lì ’vede’ qualcosa che non va. Oppure c’è il feticcio della responsabilità di vertice. Chi è in alto - pensa il testimone dei segnali che il disastro sta inviando - lo capirà più e meglio di me.Ma il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
 A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».
A meno che nella persona responsabile in situazione trovino nutrimento valori morali assoluti: che spingono ad assumersi il rischio personale di andare controcorrente, e di superare derisioni e ostracismo, di non farsi influenzare dal dispositivo di derivazione kantiana, «faccio quel che devo, accada quel che può».Insomma, la responsabilità, invece di essere ispirata a valori trascendenti, si attesta alla procedura, al ’di fronte’, a quel che le regole gerarchiche - per esempio il mandato degli azionisti - hanno assegnato. E così si scambia la diversa posizione ricoperta nella piramide organizzativa con la diversità di valori etici e professionali di quanti operano in una struttura complessa: che invece, a rigore, sono unici e universali. Cioè per tutti. Nelle forze armate, dal piantone al generale; nelle autostrade, dall’operaio che passa il bitume all’amministratore delegato della infrastruttura. Unitarietà dei valori e trasparenza della comunicazione sono la speranza del «senno di prima». Potremmo dire l’intelligenza del Buon Samaritano che si prende carico della complessità della situazione e non trascura alcuna variabile.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
IL NATALE DI GESU’: L’INCARNAZIONE SECONDO L’ IMMAGINAZIONE "TEANDRICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO. Gianfranco Ravasi ne ripropone una sintesi e la presenta come "il realismo del nascere nella storia"!!!
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE" --- Abusi, la "Lettera" del Papa: vergogna e pentimento. Tutta la Chiesa se ne faccia carico21 agosto 2018, di Federico La Sala
Lettera.
Abusi, il Papa: vergogna e pentimento. Tutta la Chiesa se ne faccia carico
Francesco ribadisce l’impegno contro il crimine degli abusi. Nella Lettera al popolo di Dio: «Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui»
_***«È imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione».
 Questo uno dei passaggi chiave della “Lettera di Papa Francesco al popolo di Dio” diffusa questa mattina dalla Sala Stampa vaticana. Un testo in cui il Pontefice, all’indomani della pubblicazione del rapporto sui casi di pedofilia nelle diocesi della Pennsylvania (Stati Uniti), esprime a nome dell’intero popolo di Dio «vergogna e pentimento». E sottolinea la necessità della conversione da parte dell’intera comunità ecclesiale.
Questo uno dei passaggi chiave della “Lettera di Papa Francesco al popolo di Dio” diffusa questa mattina dalla Sala Stampa vaticana. Un testo in cui il Pontefice, all’indomani della pubblicazione del rapporto sui casi di pedofilia nelle diocesi della Pennsylvania (Stati Uniti), esprime a nome dell’intero popolo di Dio «vergogna e pentimento». E sottolinea la necessità della conversione da parte dell’intera comunità ecclesiale.Di seguito il testo integrale della lettera.
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AL POPOLO DI DIO
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.
1. Se un membro soffre
Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si descrive l’esperienza di almeno mille persone che sono state vittime di abusi sessuali, di potere e di coscienza per mano di sacerdoti, in un arco di circa settant’anni. Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il passato, tuttavia, col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e constatiamo che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con forza queste atrocità, come pure a concentrare gli sforzi per sradicare questa cultura di morte; le ferite “non vanno mai prescritte”. Il dolore di queste vittime è un lamento che sale al cielo, che tocca l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere. Ma il suo grido è stato più forte di tutte le misure che hanno cercato di farlo tacere o, anche, hanno preteso di risolverlo con decisioni che ne hanno accresciuto la gravità cadendo nella complicità. Grido che il Signore ha ascoltato facendoci vedere, ancora una volta, da che parte vuole stare. Il cantico di Maria non si sbaglia e, come un sottofondo, continua a percorrere la storia perché il Signore si ricorda della promessa che ha fatto ai nostri padri: «Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,51-53), e proviamo vergogna quando ci accorgiamo che il nostro stile di vita ha smentito e smentisce ciò che recitiamo con la nostra voce.
Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli. Faccio mie le parole dell’allora Cardinale Ratzinger quando, nella Via Crucis scritta per il Venerdì Santo del 2005, si unì al grido di dolore di tante vittime e con forza disse: «Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! [...] Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison - Signore, salvaci (cfr Mt 8,25)» (Nona Stazione).
2. Tutte le membra soffrono insieme
La dimensione e la grandezza degli avvenimenti esige di farsi carico di questo fatto in maniera globale e comunitaria. Benché sia importante e necessario in ogni cammino di conversione prendere conoscenza dell’accaduto, questo da sé non basta. Oggi siamo interpellati come Popolo di Dio a farci carico del dolore dei nostri fratelli feriti nella carne e nello spirito. Se in passato l’omissione ha potuto diventare una forma di risposta, oggi vogliamo che la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo ed esigente, diventi il nostro modo di fare la storia presente e futura, in un ambito dove i conflitti, le tensioni e specialmente le vittime di ogni tipo di abuso possano trovare una mano tesa che le protegga e le riscatti dal loro dolore (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tale solidarietà ci chiede, a sua volta, di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l’integrità di qualsiasi persona. Solidarietà che reclama la lotta contro ogni tipo di corruzione, specialmente quella spirituale, «perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché “anche Satana si maschera da angelo della luce” (2 Cor 11,14)» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 165). L’appello di San Paolo a soffrire con chi soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodurre tra di noi le parole di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).
Sono consapevole dello sforzo e del lavoro che si compie in diverse parti del mondo per garantire e realizzare le mediazioni necessarie, che diano sicurezza e proteggano l’integrità dei bambini e degli adulti in stato di vulnerabilità, come pure della diffusione della “tolleranza zero” e dei modi di rendere conto da parte di tutti coloro che compiono o coprono questi delitti. Abbiamo tardato ad applicare queste azioni e sanzioni così necessarie, ma sono fiducioso che esse aiuteranno a garantire una maggiore cultura della protezione nel presente e nel futuro.
Unitamente a questi sforzi, è necessario che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria e ci porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore. Così amava dire San Giovanni Paolo II: «Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi» (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49). Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare dove il Signore vuole che stiamo, a convertire il cuore stando alla sua presenza. Per questo scopo saranno di aiuto la preghiera e la penitenza. Invito tutto il santo Popolo fedele di Dio all’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno secondo il comando del Signore,[1] che risveglia la nostra coscienza, la nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura della protezione e del “mai più” verso ogni tipo e forma di abuso.
E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita.[2] Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l’autorità nella Chiesa - molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza - quale è il clericalismo, quell’atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente»[3]. Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all’abuso significa dire con forza no a qualsiasi forma di clericalismo.
E’ sempre bene ricordare che il Signore, «nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Pertanto, l’unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell’abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione. La dimensione penitenziale di digiuno e preghiera ci aiuterà come Popolo di Dio a metterci davanti al Signore e ai nostri fratelli feriti, come peccatori che implorano il perdono e la grazia della vergogna e della conversione, e così a elaborare azioni che producano dinamismi in sintonia col Vangelo. Perché «ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 11).
E’ imprescindibile che come Chiesa possiamo riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili. Chiediamo perdono per i peccati propri e altrui. La coscienza del peccato ci aiuta a riconoscere gli errori, i delitti e le ferite procurate nel passato e ci permette di aprirci e impegnarci maggiormente nel presente in un cammino di rinnovata conversione.
Al tempo stesso, la penitenza e la preghiera ci aiuteranno a sensibilizzare i nostri occhi e il nostro cuore dinanzi alla sofferenza degli altri e a vincere la bramosia di dominio e di possesso che tante volte diventa radice di questi mali. Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella verità appoggiando tutte le mediazioni giudiziarie che siano necessarie. Un digiuno che ci scuota e ci porti a impegnarci nella verità e nella carità con tutti gli uomini di buona volontà e con la società in generale per lottare contro qualsiasi tipo di abuso sessuale, di potere e di coscienza.
In tal modo potremo manifestare la vocazione a cui siamo stati chiamati di essere «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1).
«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme», ci diceva San Paolo. Mediante l’atteggiamento orante e penitenziale potremo entrare in sintonia personale e comunitaria con questa esortazione, perché crescano tra di noi i doni della compassione, della giustizia, della prevenzione e della riparazione. Maria ha saputo stare ai piedi della croce del suo Figlio. Non l’ha fatto in un modo qualunque, ma è stata saldamente in piedi e accanto ad essa. Con questa posizione esprime il suo modo di stare nella vita. Quando sperimentiamo la desolazione che ci procurano queste piaghe ecclesiali, con Maria ci farà bene “insistere di più nella preghiera” (cfr S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 319), cercando di crescere nell’amore e nella fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima discepola, insegna a tutti noi discepoli come dobbiamo comportarci di fronte alla sofferenza dell’innocente, senza evasioni e pusillanimità. Guardare a Maria vuol dire imparare a scoprire dove e come deve stare il discepolo di Cristo.
Lo Spirito Santo ci dia la grazia della conversione e l’unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con coraggio.
* Fonte: Avvenire, 20.08.2018
- (...) il superiore guarda al consenso e alle conferme di chi siede ancora più in alto di lui. E quest’ultimo rivolge la sua mente al mandato di chi è il supremo detentore di quel bene, di quella situazione, di quel dato potere. E tutto questo complesso di fattori cambia la prospettiva, perché il conformismo è più potente della psicologia della responsabilità.
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.14 agosto 2018, di Federico La Sala
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.
 "PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ... *
"PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ... *- “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Paolo, Galati 3, 25-28).
- "(...) non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente" (Papa Francesco).
PAPA FRANCESCO
ANGELUS
 Piazza San Pietro
Piazza San Pietro
 Domenica, 12 agosto 2018
Domenica, 12 agosto 2018Cari fratelli e sorelle e cari giovani italiani,
buongiorno!
Nella seconda Lettura di oggi, San Paolo ci rivolge un pressante invito: «Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30).
Ma io mi domando: come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti lo abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, quindi, per non rattristare lo Spirito Santo, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del Battesimo, rinnovate nella Cresima. In maniera coerente, non con ipocrisia: non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente. Le promesse del Battesimo hanno due aspetti: rinuncia al male e adesione al bene.
Rinunciare al male significa dire «no» alle tentazioni, al peccato, a satana. Più in concreto significa dire “no” a una cultura della morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa che si esprime nella menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel disprezzo dell’altro. A tutto questo, “no”. La vita nuova che ci è stata data nel Battesimo, e che ha lo Spirito come sorgente, respinge una condotta dominata da sentimenti di divisione e di discordia. Per questo l’Apostolo Paolo esorta a togliere dal proprio cuore «ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità» (v. 31). Così dice Paolo. Questi sei elementi o vizi, che turbano la gioia dello Spirito Santo, avvelenano il cuore e conducono ad imprecazioni contro Dio e contro il prossimo.
Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano; è necessario aderire al bene e fare il bene. Ecco allora che San Paolo continua: «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (v. 32). Tante volte capita di sentire alcuni che dicono: “Io non faccio del male a nessuno”. E si crede di essere un santo. D’accordo, ma il bene lo fai? Quante persone non fanno il male, ma nemmeno il bene, e la loro vita scorre nell’indifferenza, nell’apatia, nella tiepidezza. Questo atteggiamento è contrario al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giovani, che per natura siete dinamici, appassionati e coraggiosi. Ricordate questo - se lo ricordate, possiamo ripeterlo insieme: “E’ buono non fare il male, ma è male non fare il bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado.
Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate il male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. Non basta non odiare, bisogna perdonare; non basta non avere rancore, bisogna pregare per i nemici; non basta non essere causa di divisione, bisogna portare pace dove non c’è; non basta non parlare male degli altri, bisogna interrompere quando sentiamo parlar male di qualcuno: fermare il chiacchiericcio: questo è fare il bene. Se non ci opponiamo al male, lo alimentiamo in modo tacito. È necessario intervenire dove il male si diffonde; perché il male si diffonde dove mancano cristiani audaci che si oppongono con il bene, “camminando nella carità” (cfr 5,2), secondo il monito di San Paolo.
Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto! Perciò siete allenati e posso dirvi: camminate nella carità, camminate nell’amore! E camminiamo insieme verso il prossimo Sinodo dei Vescovi. La Vergine Maria ci sostenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno di noi, ogni giorno, con i fatti, possa dire “no” al male e “sì” al bene.
Dopo l’Angelus
Cari fratelli e sorelle,
rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da tante parti del mondo.
In particolare saluto i giovani delle diocesi italiane, accompagnati dai rispettivi Vescovi, dai loro sacerdoti ed educatori. In questi giorni, avete riversato per le strade di Roma il vostro entusiasmo e la vostra fede. Vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra testimonianza cristiana! E ieri, nel ringraziare, ho dimenticato di dire una parola ai sacerdoti, che sono quelli che vi sono più vicini: ringrazio tanto i sacerdoti, ringrazio per quel lavoro che fanno giorno per giorno, ringrazio per quella pazienza - perché ci vuole pazienza per lavorare con voi! La pazienza dei sacerdoti ... - ringrazio tanto, tanto, tanto. E ho visto anche tante suore che lavorano con voi: anche alle suore, grazie tante.
E la mia gratitudine si estende alla Conferenza Episcopale Italiana - qui rappresentata dal Presidente Cardinale Gualtiero Bassetti - che ha promosso questo incontro dei giovani in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi.
Cari giovani, facendo ritorno nella vostre comunità, testimoniate ai vostri coetanei, e a quanti incontrerete, la gioia della fraternità e della comunione che avete sperimentato in queste giornate di pellegrinaggio e di preghiera.
A tutti auguro una buona domenica. Un buon rientro a casa. E per favore, non dimenticate di pregare per me! Buon pranzo e arrivederci!
* Appunti di commento sul tema, si cfr.:
- PAOLO COME "CRISTO": “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Galati: 3, 25-28).
- CAPO E CORPO "MISTICO" - FORZA "CRISTO"!: "(...) vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Paolo, Ef. 4,15-16)
- "CRISTO", ORDINE SACERDOTALE, E CHIESA: "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- SIMONE WEIL: "L’immagine del
corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza
che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della
nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di
un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato
di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è
Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua
unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognuno di noi, come è tutto intero
nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.
 L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE - Negli Stati Uniti, 70 anni di abusi in Pennsylvania coperti dalla Chiesa.16 agosto 2018, di Federico La Sala
SULLA PEDOFILIA, L’ALLARME DELLA RIVISTA "CONCILIUM" (3/2004) E IL COLPEVOLE SILENZIO DEL VATICANO.
Preti pedofili, 70 anni di abusi in Pennsylvania coperti dalla ChiesaUn Grand giurì ha riconosciuto la colpa di 300 sacerdoti su oltre mille bambini *
Più di 300 sacerdoti sono accusati in Pennsylvania di aver commesso abusi sessuali su oltre mille bambini nel corso di settant’anni, coperti "sistematicamente" dai vertici della Chiesa cattolica. Un Gran giurì americano ha diffuso un rapporto di oltre 1.400 pagine, ritenuto il più articolato e globale pubblicato sinora sulla pedofilia nella Chiesa americana da quando il Boston Globe per la prima volta denunciò il problema in Massachusetts nel 2002, vincendo un premio Pulitzer e ispirando il film ’Spotlight’. Il dossier ha portato all’incriminazione di due preti, ma la maggioranza dei presunti responsabili è ormai morta e la gran parte dei fatti è prescritta.
L’indagine del Gran giurì è durata due anni ed è stata condotta in tutte le diocesi della Pennsylvania, fatta eccezione per due. Cita decine di testimoni e mezzo milione di pagine di informazioni della Chiesa, contenenti "accuse credibili contro oltre 300 preti predatori". Più di mille bambine e bambini che furono vittime di abusi sono identificabili, ma "il vero numero" è in realtà "nell’ordine delle migliaia", secondo il Grand giurì, perché molti bambini hanno avuto paura di denunciare o i loro dati sono andati perduti. Le vittime, afferma il dossier, sono state speso traumatizzate per la vita, finendo per abusare di droga e alcol, o per suicidarsi.
Tra i casi elencati c’è quello di un religioso che ha stuprato una bambina di 7 anni in ospedale, dopo che la piccola aveva subito una tonsillectomia. Un altro bambino bevve un succo di frutta e si svegliò il mattino dopo sanguinante dal retto, senza poter ricordare che cosa gli fosse accaduto. Un prete costrinse un bambino di 9 anni a praticargli sesso orale, poi gli lavò la bocca con l’acqua santa per "purificarlo". Un altro sacerdote abusò di cinque sorelle della stessa famiglia, tra cui una da quando aveva 18 mesi ai 12 anni. Quando una delle bambine lo disse ai genitori nel 1992, la polizia trovò nella casa del prete slip, bustine di plastica contenenti peli pubici, fiale d’urina e fotografie a sfondo sessuale di bambine. La Chiesa ignorò per anni le accuse e il sacerdote morì in attesa di processo, ha dichiarato il procuratore generale della Pennsylvania, Josh Shapiro.
"Lo schema era abuso, negazione e copertura", ha spiegato Shapiro, aggiungendo: "Come diretta conseguenza della sistematica copertura da parte delle alte autorità ecclesiastiche, quasi ogni caso di pedofilia che abbiamo rilevato è troppo datato per un processo". Sinora solo due preti sono stati incriminati per accuse che sono al di fuori della prescrizione: uno è accusato di aver eiaculato nella bocca di un bambino di sette anni e si è dichiarato colpevole, secondo la procura; l’altro ha aggredito due bambini, uno dei quali da quando aveva 8 anni per un periodo di otto anni, sino al 2010.
Il Gran giurì ha chiesto che la prescrizione per i reati di pedofilia sia cancellata, che le vittime abbiano più tempo per presentare denuncia e che sia rafforzata la legge che obbliga a denunciare gli abusi sessuali di cui si viene a conoscenza. "I preti stupravano bambine e bambini piccoli e gli uomini di Dio che erano responsabili per loro non solo non facevano nulla, ma nascondevano tutto. Per decenni", si legge nel rapporto. I religiosi anziani, al contrario, furono promossi e i preti pedofili poterono amministrare per 10, 20 e persino 40 anni dopo che i vertici erano venuti a conoscenza degli abusi e mentre la lista delle vittime si allungava sempre di più, ha detto Shapiro.
Negli Stati Uniti, sono tra 5.700 e 10mila i preti cattolici accusati di abusi sessuali, ma poche centinaia sono stati processati, dichiarati colpevoli e condannati, secondo Bishop Accountability. Da quando il problema della pedofilia nella Chiesa cattolica è diventato noto all’inizio degli anni 2000, la Chiesa americana ha speso più di 3 miliardi di dollari in patteggiamenti, secondo l’osservatorio. Questo ha documentato accordi con 5.679 presunte vittime del clero cattolico, solo un terzo delle 15.235 denunce che i vescovi hanno detto di aver ricevuto fino al 2009. Una stima ipotizza che le vittime negli Usa siano 100mila. Sotto la pressione dell’aumento di denunce nel mondo e delle continue critiche per la insufficiente risposta della Chiesa, papa Francesco nel 2013 ha promesso una nuova legge sulla pedofilia e pedopornografia. Anche in Cile la Chiesa è stata di recente travolta da accuse di vasta copertura di casi di pedofilia durante gli anni Ottanta e Novanta.
* Fonte: La Presse, Martedì 14 Agosto 2018
SULLA PEDOFILIA, L’ALLARME DELLA RIVISTA "CONCILIUM" (3/2004) E IL COLPEVOLE SILENZIO DEL VATICANO.
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - I DUE CRISTIANESIMI, I DUE PAPI, E LA PENA DI MORTE. Fede definita e pena capitale: insieme, ma «con moderazione»?7 agosto 2018, di Federico La Sala
I DUE CRISTIANESIMI, I DUE PAPI, E LA PENA DI MORTE.....
Lupus in pagina
Fede definita e pena capitale: insieme, ma «con moderazione»?
di Gianni Gennari (Avvenire, 07.0 8.2018)
"Life Site News" 3/8: «La liceità della pena di morte è una verità di fede cattolica... de fide tenenda, definita dal Magistero ordinario e universale della Chiesa... Chi afferma che la pena capitale è in se stessa un male cade nell’eresia». Così Roberto De Mattei, con testo dal latino: «Si può esercitare la pena di morte senza peccato mortale, a condizione che la vendetta sia esercitata non per odio ma per giudizio, non in maniera imprudente ma con moderazione».
Ormai contiamo anche «sette accuse» esplicite di «eresia» a papa Francesco, ma qui fa pensare quell’uccidere «con moderazione»: si prenderà esempio dai briganti che nel Vangelo lasciano al Samaritano quel poveraccio «emithanè», solo «mezzo morto»? Quindi, in rete, esemplare chiarezza non solo evangelica ma anche storica con rimando al «Concilio di Trento» parte III, al «Catechismo maggiore di San Pio X», sempre «parte III» e, oltre queste "modernità" esibite, anche alla «lettera del 18 dicembre 1208» di Innocenzo III contro i Valdesi. Se la fede cattolica continua a sopravvivere, insomma, lo dobbiamo a questi professori integerrimi, infrangibili, che sfidano Chiesa e mondo senza tema del ridicolo.
Altri tempi, se avessero incontrato un Galileo Galilei lo avrebbero condannato, e in coerenza con tanto passato, anche "bruciato" - cosa che quei "lassisti" e "modernisti" del 1600 non hanno fatto! - ma con moderazione, accendendo il fuoco a poco a poco, magari con una sigaretta elettronica, perché la loro vera modernità è aperta e immediata.
A proposito, in questi giorni si parla del 50° della Humanae vitae di un Papa che loro non hanno mai gradito del tutto, ma stavolta lo hanno approvato in pieno, con una sola condizione, esplicita e firmata dallo stesso di cui sopra: non va letta alla luce del Concilio e del Vangelo, ma «alla luce della Casti connubii» di Pio XI, del 1930! Sempre in anticipo: la classe non si smentisce mai!
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006). Materiali per riflettere
- NOMADELFIA: IN NOME DELLA FRATERNITA’ EVANGELICA ("CHARITAS"), NON "MAMMONICA" (Benedetto XVI: "Deus caritas est", 2006)! PER LA CHIESA CATTOLICA, LA SOLLECITAZIONE E L’ORA DI UN PROFONDO ESAME DI COSCIENZA!!! "FE’ DU MUCC". FATE DUE MUCCHI": LA LEZIONE DON ZENO SALTINI.
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?".
Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- DUE VOLTI (E DUE NARRAZIONI) DELL’ITALIA - E DELLA CHIESA. Quale avvenire?6 agosto 2018, di Federico La Sala
DUE VOLTI (E DUE NARRAZIONI) DELL’ITALIA - E DELLA CHIESA. Quale avvenire? *
- Questo tempo italiano è specialmente difficile perché ci mette davanti a due volti (e due narrazioni) dell’Italia, che invece o è una o non è. (Marco Tarquinio, 4 agosto 2018).
La deriva della xenofobia
Senza vergogna
di Marco Tarquinio (Avvenire, sabato 4 agosto 2018)
Stiamo attraversando un tempo difficile, duro e bello come ogni tempo difficile, amaro come ogni tempo in cui nel nome di una Legge solo proclamata e di doveri solo parolai, e che ignorano e stritolano i diritti dei più deboli, si mette in questione l’umanità e l’uguaglianza stessa degli esseri umani. Senza vergogna. Ma la fragilità e la dignità della vita, di ogni vita umana, non si riconoscono dal passaporto e non si possono prendere in alcun modo in ostaggio. E le leggi non si applicano solo per stanare e "fermare" lo straniero, ma come ha sottolineato anche la nostra lunga inchiesta sul caporalato per far sì che chi è straniero di origine e italiano di lavoro non venga incluso e integrato soltanto nel (e dal) "lato oscuro" del nostro Paese.
È in tempi proprio come questi che a noi cristiani è chiesto di dare ragione in modo più limpido della nostra speranza. Ma non è un dovere solo nostro. Perché a tutti - ma proprio a tutti - è laicamente chiesto, se vogliamo tener saldo il patto di civile convivenza e la misura comune che contiene le nostre differenze e le compone in armonia, di sentirci impegnati a tener care e preservare le radici (troppo a lungo negate o date per scontate) dell’umanesimo che dà linfa, forza e capacità inclusiva alla nostra civiltà comune.
Questo tempo italiano è specialmente difficile perché ci mette davanti a due volti (e due narrazioni) dell’Italia, che invece o è una o non è.
Perché sarebbe un’Italia umanamente fallita - e del default più sconvolgente: il default della cultura e della fede che l’hanno unita prima di ogni azione politica - quel Paese bifronte che ci si ostina a voler scolpire non nel marmo, ma in grevi nuvolaglie di slogan xenofobi da social network e di parole e atti violenti che si vorrebbe derubricare a «sciocchezze». La «goliardata» che ha sfigurato il viso di Daisy Osakue non è la controprova di un’Italia serena e vaccinata dal razzismo: per rendersene conto, basta leggere ciò che è stato scatenato addosso a questa giovane donna, cittadina italiana di origine nigeriana.
Inqualificabile. Io continuo a vergognarmene. Anche se suo padre, a quanto risulta, non è stato uno stinco di santo e ha pagato il suo debito con la giustizia. E me ne vergogno anche se i tre aggressori a colpi di uova sono "bulli" e non adepti di uno dei manipoli razzisti che sparlano, sputano, menano e sparano (grazie a Dio, quasi sempre a vuoto) in giro per l’Italia.
Non sono l’Italia e non la rappresentano l’Italia. Ma - come ho scritto - ne deturpano i lineamenti, sino a sfigurarli. E allora non si può far finta di niente. Di costoro e per costoro ci dovremmo vergognare tutti, e ancor di più visto che ci viene spiegato e quasi intimato di dire e scrivere che non esistono e che comunque sono la logica reazione alla "violenza portata dagli stranieri". Ma proprio come i poveri, i violenti non hanno passaporto e non hanno patria. Ai poveri patria e passaporto sono negati. Ai violenti interessano solo come arma, e perciò non interessano affatto.
L’Italia non può essere ridotta a un ring di risentimenti etnici. Chi ha responsabilità lavori per evitarlo.
P.S. A quanti in queste settimane hanno ritenuto di ricordarci che i buoni cattolici e i giornali di ispirazione cattolica, prima e invece che delle persone costrette a migrare, dovrebbero preoccuparsi della vita non nata e ancora troppe volte abortita in Italia e in Europa - vita nascente che da appassionati di umanità e di scienza amiamo e rispettiamo sin dal primo istante come testimoniano le pagine del giornale - mi sento di rispondere con parole più grandi di noi: se non siamo capaci di amare e di essere giusti con coloro che vediamo, come potremo mai amare ed essere giusti con coloro che (ancora) non vediamo?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- "MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANO E CRISTIANO" (A. Z.).
 CONTRO LA XENOFOBIA ITALIANA, L’APPELLO E LA DENUNCIA DI PADRE ALEX ZANOTELLI. Non possiamo stare zitti, dobbiamo parlare, gridare, urlare. E’ in ballo il futuro del nostro paese, ma soprattutto è in ballo il futuro dell’umanità anzi della vita stessa
CONTRO LA XENOFOBIA ITALIANA, L’APPELLO E LA DENUNCIA DI PADRE ALEX ZANOTELLI. Non possiamo stare zitti, dobbiamo parlare, gridare, urlare. E’ in ballo il futuro del nostro paese, ma soprattutto è in ballo il futuro dell’umanità anzi della vita stessa
- CRISTIANESIMO E COSTITUZIONE (DELLA CHIESA E DELL’ITALIA). PERDERE LA COSCIENZA DELLA LINGUA ("LOGOS") COSTITUZIONALE ED EVANGELICA GENERA MOSTRI ATEI E DEVOTI ...
 I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?"
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?"
LA COSTITUZIONE ITALIANA, IL CRISTIANESIMO, E LA TRADIZIONE DELLA MENZOGNA CATTOLICO-ROMANA.
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
Federico La Sala
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - "Storie di testi e tradizione classica": Canfora, la filologia è libertà (di Livia Capponi).29 giugno 2018, di Federico La Sala
Canfora, la filologia è libertà
Il volume curato da Rosa Otranto e Massimo Pinto (Edizioni di Storia e Letteratura)
di Livia Capponi (Corriere della Sera, 29.06.2018)
Come lavoravano gli autori greci e latini? Nel suo lungo e intenso magistero, Luciano Canfora, a cui gli allievi Rosa Otranto e Massimo Pinto dedicano il volume collettivo Storie di testi e tradizione classica, ha insegnato ad affrontare ogni testo a partire dalla sua storia, reinventando la filologia come disciplina in grado di leggere non solo i testi giunti fino a noi, ma anche le cicatrici, i tagli, i contorni invisibili di ciò che è stato modellato da un censore, da un copista, dal gusto di un’epoca.
Diversamente da Isocrate, famoso per la sua lentezza nel comporre, e da Pitagora, che preferiva depositare la sua dottrina nei libri più sicuri, cioè nella memoria degli alunni, Canfora, la cui bibliografia conta 843 opere, è più simile a Demostene, che cesellava ogni rigo o a Fozio, patriarca bizantino che salvò il patrimonio letterario antico, aiutato da un’affezionata cerchia di studenti.
Nei contributi qui raccolti, l’erudizione è messa al servizio di una coinvolgente ricerca della verità, intesa come integrità testuale, storica ed etica. Sono toccati i temi prediletti, come l’analisi critica della democrazia, la storia della tolleranza e della libertà di parola, la schiavitù e i perseguitati politici e religiosi da Atene ai giorni nostri, attraverso lo studio di storiografia, archivi, biblioteche e pubblicistica d’ogni epoca. Il tutto condito da empatia e indipendenza di giudizio, in grado di far rivivere gli antichi con grande vivacità: Cesare è ritratto mentre elabora il primo sistema crittografico per l’intelligence romana; Fozio nell’atto di divorare romanzi d’amore greci (per poi censurarli). Coerentemente con la lezione canforiana, lo studio dei classici diventa motivo di apertura mentale perché aiuta a capire il presente e noi stessi.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - FILOLOGIA E LIBERTA’ (L. Canfora). Filologia e “verità” (di Daniele Ruini)30 giugno 2018, di Federico La Sala
Filologia e “verità”
di Daniele Ruini (Nazione Indiana, 01 marzo 2009)
Quale importanza abbia avuto, nella storia dell’umanità, la parola scritta è un fatto difficilmente sottostimabile. Per quanto riguarda, più in particolare, la storia delle religioni, ciò è chiaramente evidente in tutti quei culti che riconoscono autorità sacra a uno o più testi, ritenuti frutto della diretta ispirazione divina, ovvero “parola di Dio”. Dato lo speciale statuto assegnato a tali scritture, ogni operazione volta a definirne con esattezza il dettato testuale acquista un valore particolare; se, da un lato, avvicinarsi il più possibile allo stadio originario di un Testo Sacro significa ridurre la distanza che separa dalla supposta Verità in esso contenuta, dall’altro lato, rimettere ogni volta in discussione la lezione di un’opera di tal fatta non può non avere conseguenze delicate per la comunità religiosa che di essa ha fatto il proprio testo di riferimento. Il rapporto tra Sacre Scritture e filologia (la disciplina finalizzata a ricostruire la veste originaria di un testo attraverso lo studio delle varie fasi della sua trasmissione) è infatti necessariamente contraddittorio: il carattere dogmatico della “parola di Dio” può sopportare il libero esercizio critico della filologia? E soprattutto: fino a che punto saranno disposti ad accettarlo i rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche?
È questo il tema al centro di Filologia e Libertà di Luciano Canfora (Mondadori 2008), nel quale si ripercorre la storia delle resistenze del Vaticano dinnanzi all’applicazione della critica testuale alla Bibbia, dando risalto alle figure dei pochi studiosi che quei divieti tentarono di infrangere. Come sottolinea Canfora, riannodare le fila di questo racconto equivale a narrare la storia «della libertà di pensiero attraverso il faticoso e contrastato dispiegarsi della libertà di critica sui testi che l’autorità e la tradizione hanno preservato».
Benché sia sempre esistita una filologia biblica, le cui origini affondano nel giudaismo ellenistico, la Chiesa Cattolica è venuta progressivamente irrigidendosi, assumendo, di fronte alle possibilità di studiare le Sacre Scritture secondo i principi della critica testuale, un atteggiamento di totale chiusura, cui si accompagnò un’azione di repressione nei confronti dei disobbedienti. Tale fu la posizione espressa nelle disposizioni del Concilio di Trento (1545-1563), colle quali fu sancito il primato della Vulgata, ovvero della versione latina della Bibbia tradotta da San Gerolamo nel IV secolo d.C.
In maniera del tutto illogica e fondandosi sulla supposta ispirazione divina del traduttore, veniva riconosciuta la superiorità di una traduzione rispetto al testo originale (ebraico per l’Antico Testamento, greco per il Nuovo). Si trattava di una risposta alle iniziative dei luterani, che rivendicavano invece l’originale biblico e che quello traducevano per la massa dei fedeli. Tali norme rimasero valide fino al Concilio Vaticano II (1965), quando fu finalmente ammessa, anche da parte cattolica, la possibilità di tradurre le Sacre Scritture nelle lingue moderne, favorendone l’accesso al popolo dei credenti.
E nondimeno, la filologia moderna, sviluppatasi storicamente nel XIX secolo sui classici greci e latini, ebbe le sue prime applicazioni proprio in ambito biblico e, più in particolare, neotestamentario. Alla netta chiusura della Chiesa Cattolica - ma atteggiamento non dissimile ebbero le Chiese riformate - si contrappose l’attività di singoli eruditi che, raccogliendo l’eredità di Erasmo da Rotterdam (1466-1536), si prodigarono nello studio della formazione dell’Antico e del Nuovo Testamento, subendo spesso l’ostracismo delle comunità religiose di appartenenza.
 Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».
Tra le figure ricordate da Canfora vi sono l’ebreo Baruch Spinoza (1632-1677), il giansenista Richard Simon (1627-1704), i protestanti Pierre Bayle (1647-1706), Johann Jacob Wetstein (1694-1745) e Jean Leclerc (1657-1736). Il loro lavoro fu la principale fonte d’ispirazione della critica illuministica delle religioni, della cui efficacia ed attualità rende conto il fatto che «la condanna dell’illuminismo si replica, di papa in papa, di enciclica in enciclica, fino alla recentissima Spe salvi (par. 19) dell’attuale pontefice».Le infrazioni ai divieti cattolici in materia di filologia biblica proseguirono nel XIX secolo per merito di alcuni esponenti dell’Institut Catholique di Parigi, ai quali il Vaticano affibbiò l’etichetta di “modernisti”. Tra di essi, Ernest Renan (1823-1892) - autore di una celebre Vita di Gesù in cui si negava la divinità del Cristo -, Louis Duchesne (1843-1922) e Alfred Loisy (1857-1940), cui si devono due volumi sulla Storia del canone dell’Antico e del Nuovo Testamento.
 La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).
La durissima presa di posizione del cattolicesimo romano fu affidata alle encicliche Providentissum Deus di papa Leone XIII (1893) e Pascendi dominici gregis di papa Pio X (1907). In quest’ultima, in particolare, il pontefice espresse in termini retrogradi l’allarme risentito verso la critica testuale, il cui carattere eversivo risalirebbe alla pretesa di introdurre nell’ambito dei Testi Sacri il concetto di “evoluzione”, «quasi che la stessa religione fosse opera non di Dio ma degli uomini o un qualche ritrovato filosofico che con mezzi umani possa essere perfezionato» (sic).Nessuna posizione ufficiale venne più espressa fino al 1943, quando papa Pio XII compì una svolta inaspettata, ammettendo la legittimità della critica testuale in ambito biblico (enciclica Divino afflante spiritu). Non si trattava, tuttavia, di una netta presa di distanza dalle chiusure del passato; l’enciclica pretende anzi di stabilire una continuità colle dichiarazioni dei pontefici precedenti, disegnando una prospettiva distorta secondo cui la Chiesa avrebbe sempre favorito e appoggiato la critica testuale, ed affermando che il riconoscimento della legittimità dell’indagine filologica sui testi sacri non è in contraddizione coi deliberati tridentini.
 L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
L’apertura di papa Pacelli era in realtà la conseguenza della presa d’atto che alcune significative esperienze filologiche recenti avevano reso del tutto obsoleta e non più sostenibile la condanna vaticana verso la critica testuale; capolavori come l’edizione critica dell’Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea realizzata da Eduard Schwartz (1905-1909), o quella della Bibbia dei Settanta prodotta nel 1935 in ambiente protestante, costituivano una smentita concreta delle preclusioni cattoliche nei confronti della filologia. D’altra parte, pur nella sua apertura di fondo, Pio XII si appella alla cautela degli studiosi; l’enciclica contiene infatti l’invito a produrre nuove edizioni scientifiche del Testo Sacro pur mantenendo nei suoi confronti «somma riverenza».
 Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
Si tratta, come evidenzia Canfora, di una posizione assurda e insensata, dacché inconciliabile colla pur invocata «rigorosa osservanza di tutte le leggi della critica». Ciò equivarrebbe infatti ad ammettere che “un testo affidabile di Platone possano darlo soltanto dei platonici puri e graniticamente fedeli al “verbo” del maestro (ammesso comunque che tale verbo esista già preconfezionato, prima del necessario, lunghissimo, imprevedibile, lavorio critico)”.
 Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».
Questo non-senso nasce dalla convinzione, mai messa in discussione, che i testi inclusi nel canone cattolico - e solo quelli - contengano la verità, una verità «precostituita e testualmente compiuta prima della ricostruzione del testo». L’apparente apertura rivoluzionaria del Vaticano tradisce, quindi, un certo conservatorismo, nell’incapacità di accettare fino in fondo l’idea che «il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della “fede”».Il volume di Canfora costituisce, in conclusione, un elogio della filologia, considerata come un antidoto al dogmatismo e all’oscurantismo e come fondamento della libertà di pensiero.
Per materiali sul tema, nel sito, si cfr.:
LA SAPIENZA E IL MESSAGGIO EVANGELICO. FRANCESCO BACONE E SAN PAOLO PRENDONO LE DISTANZE DALLE ENCICLICHE DI PAPA BENEDETTO XVI. Una "preghiera comune" firmata da Bacone
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Pregare, questione di umiltà. Il modello? È il Padre Nostro. Intervista all’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci.4 giugno 2018, di Federico La Sala
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! .... *
Pregare, questione di umiltà. Il modello? È il Padre Nostro
Castellucci: Il Signore ci insegna la logica del "noi".
L’arcivescovo di Modena-Nonantola: «La preghiera di domanda, con le formule imparate a memoria, non è di serie B rispetto a espressioni più alte della vita dello Spirito»
- [Foto] L’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci, presidente della Commissione episcopale Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio
Intervista di Riccardo Maccioni (Avvenire, domenica 3 giugno 2018)
La preghiera come dialogo d’amore, che non ha bisogno di frasi mirabolanti o immagini di alta poesia, perché cresce nel rapporto cuore a cuore. L’umiltà e la disponibilità come condizioni necessarie per aprirsi all’azione della grazia, per accettare la logica della salvezza che viene da Dio. E si realizza, per così dire è resa possibile, dal rapporto con gli altri. Un atteggiamento di fiducia, di legame filiale tra la creatura e il Creatore che trova semplice e al tempo stesso profonda sintesi nel libretto ”Chi prega si salva”, in cui sono raccolte le preghiere più note della tradizione cristiana. A partire dalla famosa espressione, di sant’Alfonso Maria de’ Liguori scelta come titolo. E che nella sua formulazione completa suona un tantino inquietante: chi prega si salva, chi non prega si danna.
 «Credo che sant’Alfonso non intenda proporre, con questa espressione, una “teoria universale” riguardante la salvezza o la condanna, ma muoversi dentro all’orizzonte del credente - spiega monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e neo presidente della Commissione episcopale Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio -. In altre parole, il suo interesse è concentrato sul cristiano: in questo senso chi prega si salva e chi non prega si danna. Chi prega, cioè, mantiene quell’apertura umile e disponibile al Signore che è il requisito fondamentale per lasciare entrare nel cuore la grazia. Chi non prega, si illude di tenere in mano la propria vita da solo, si chiude ermeticamente all’amore di Dio, crede di salvarsi da solo. Papa Francesco direbbe che cade nel pelagianesimo ».
«Credo che sant’Alfonso non intenda proporre, con questa espressione, una “teoria universale” riguardante la salvezza o la condanna, ma muoversi dentro all’orizzonte del credente - spiega monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e neo presidente della Commissione episcopale Cei per la dottrina della fede, la catechesi e l’annuncio -. In altre parole, il suo interesse è concentrato sul cristiano: in questo senso chi prega si salva e chi non prega si danna. Chi prega, cioè, mantiene quell’apertura umile e disponibile al Signore che è il requisito fondamentale per lasciare entrare nel cuore la grazia. Chi non prega, si illude di tenere in mano la propria vita da solo, si chiude ermeticamente all’amore di Dio, crede di salvarsi da solo. Papa Francesco direbbe che cade nel pelagianesimo ».Nel libretto sono raccolte le preghiere più semplici della vita cristiana, quelle che impariamo da bambini, in famiglia i più fortunati o al catechismo. Perché è importante “frequentarle” anche da adulti?
La memoria orante, come quella liturgica, rappresenta per l’essere umano un punto di riferimento costante nella vita. Tante persone, che poi nemmeno proseguono nella pratica della fede cristiana, continuano quotidianamente a recitare almeno in qualche circostanza le preghiere imparate da bambini. È come il recupero costante di quella dimensione fanciullesca che abita sempre dentro di noi, anche a ottant’anni; e che mantiene viva la condizione posta da Gesù per «entrare nel regno dei cieli»: diventare come bambini. Di nuovo è questione di umiltà e disponibilità.
Quindi la preghiera di domanda, con le formule imparate a memoria, non è di serie B rispetto a espressioni più alte della vita dello Spirito, come l’adorazione o la preghiera del cuore.
Nella preghiera non ci sono le categorie, come nel calcio. Niente serie A, B o C. Piuttosto c’è un modello, al quale ogni preghiera si riconduce: il Padre Nostro, che i padri della Chiesa chiamavano oratio dominica, la preghiera del Signore. In quella breve preghiera, che tutti conoscono a memoria, Gesù suggerisce ben quattro domande: il pane quotidiano, il perdono dei peccati, la custodia dalle tentazioni e la liberazione dal male. Richieste per il corpo, la mente e lo spirito. Queste richieste sono precedute dalla lode, per mettere in evidenza che non sono richieste fatte dagli schiavi al padrone o dai clienti al negoziante, ma dai figli al Padre. Chiedere, quindi, è da figli: purché avvenga nel rispetto della grandezza del Padre. Se siamo figli, dobbiamo chiedere umilmente.
Nella prefazione alla nuova edizione del libro il Papa cita anche una buona preparazione al sacramento della Confessione. Troppe volte abbiamo quasi paura di essere perdonati.
È vero. Forse la difficoltà di prepararci dipende anche dalla sensazione sgradevole che ciascuno di noi prova di fronte ai propri limiti e peccati. Prepararsi significa riflettere, concen-trarsi, calarsi nella propria condizione fragile: e questo dà fastidio. Ma è necessario, se vogliamo sperimentare la misericordia di Dio e correggere i nostri difetti.
Come preparazione al confessionale, che cosa consiglia?
Prima di tutto di ripetere lentamente il “Padre Nostro”, che rappresenta quasi un esame di coscienza: non è infatti la preghiera dell’io, ma la preghiera del noi. «Dacci», «rimetti i nostri debiti », «non ci indurre», «liberaci». È la preghiera di una comunità: mentre dunque chiedo per me, chiedo per noi. E mi interrogo su come io mi rapporto agli altri. Se domando il perdono dei miei debiti, so poi rimetterli ai miei debitori? Se domando il pane per me, so poi condividerlo con gli altri, con quelli che insieme a me formano il “noi” e hanno diritto come me al pane quotidiano?
E per imparare a pregare da dove si comincia?
Si comincia dal cuore, non dalla carta. O meglio, la preghiera scritta e imparata a memoria deve diventare preghiera del cuore, relazione con il Signore. Quando uno si innamora, non si preoccupa di andare a cercare su Internet le frasi giuste da dire. Sarà la relazione a suggerirle. Bastano poche formule - ripeto, Gesù ce ne ha data una esemplare e la Chiesa ce ne offre alcune essenziali - ma occorre molto affetto. Le preghiere stesse incentivano l’affetto, perché l’espressione dell’amore aumenta il grado stesso dell’amore. Se io voglio bene a una persona, ma non glielo dico mai, non scatta la relazione e facilmente quell’amore si raffredda. Così con Dio: non resiste e serve a poco una fede “intellettuale”, fredda, che non si rivolga mai a lui.
Se posso permettermi... c’è una preghiera che lei sente particolarmente “sua’” che la accompagna da sempre?
A questo punto è chiaro che la mia preferita è il Padre Nostro. Dico spesso anche l’Ave Maria. Fin da piccolo ho imparato la preghiera del Rosario, che recito ogni giorno. È come una ripetuta professione d’amore verso la Madre. Quando, insomma, ci si rivolge a Dio come Padre e a Maria come Madre, ci si sente ben custoditi e spronati ad essere paterni e materni verso i fratelli.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?! Un resoconto dell’incontro, con note
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- «Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male (Simone Weil).1 giugno 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, FILOLOGIA, E TEOLOGIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ... *
Il Colle ha fallito? Dipende da noi
«Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male (Simone Weil)»
di Roberta de Monticelli (Il Fatto, 01.06.2018)
Un filosofo è come il matto di corte, lo si può lasciar parlare. C’è chi vuole far processare per alto tradimento il presidente della Repubblica e chi lancia hashtag in suo sostegno. Ci sono giuristi pronti ad affermare che non ha fatto che il suo dovere (Flick) e altri radicalmente critici (Villone e Carlassare), come ce ne sono di molto perplessi (Onida). Ci sono commentatori che in mancanza d’altre idee attribuiscono lo sconquasso al “circo mediatico giudiziario” che ci avrebbe per troppo anni lavato il cervello facendoci credere che in Italia corruzione e impunità siano maggiori che altrove (Panebianco) - ma non vedono che il lavaggio non è bastato, visto che nessuno (neppure il capo dello Stato) s’è fatto un baffo della circostanza che il candidato ministro dell’Economia da ex presidente dell’Impregilo era incorso in inchieste giudiziarie ben motivate dalle intercettazioni, che gli avrebbero sbarrato in ogni altro Paese civile la porta di quel ministero.
C’è chi sostiene con assoluta convinzione che il gesto del Presidente ha salvato la democrazia assediata dai populismi e chi con convinzione altrettanto assoluta sostiene che ha soffocato la domanda democratica di cambiamento, per asservire lo Stato alla tecno-plutocrazia europea, o peggio al diktat tedesco. Nota a margine: non si percepisce traccia di simili congiure e diktat da quassù - il regno del fool è il vuoto celeste, dove le linee aeree franco-canadesi forniscono una massa di giornali nelle principali lingue europee, e neppure un angolino contiene un commento su queste indebite pressioni, nonostante i titoli ridondino di “crisi istituzionale in Italia” e “l’Italia mette a processo l’Europa”.
Ed ecco lo sragionamento del fool, per chi volesse conoscerlo. Che il gesto del presidente della Repubblica sia o non sia stato un tragico errore, dipende da noi. Nel senso che non sarà stato un errore, e forse sarà stato invece uno di quegli attimi che le generazioni future ricorderanno con ammirata gratitudine, solo se d’ora in poi gli uomini e le donne di buona volontà non si daranno tregua a costruire in due mesi la Parte della Speranza Progressista e Civile, per farla trovare pronta alle elezioni, con a capo i migliori cavalieri delle buone cause sconfitte nell’ultimo quinquennio...
 Quanti ce ne sono, e come saranno bravi se somigliano alle idee per cui furono silenziati, in materia di anticorruzione e legalità, di taglio alla spesa, di politica industriale e del lavoro, di lotta alla disuguaglianza, allo scempio dell’ambiente e del paesaggio, di vera politica della scuola, dell’università e della ricerca.
Quanti ce ne sono, e come saranno bravi se somigliano alle idee per cui furono silenziati, in materia di anticorruzione e legalità, di taglio alla spesa, di politica industriale e del lavoro, di lotta alla disuguaglianza, allo scempio dell’ambiente e del paesaggio, di vera politica della scuola, dell’università e della ricerca.
 Non contro ma verso gli Stati Uniti d’Europa. Il programma di questa Parte? Sarà buono se si procederà con infinita attenzione ai veri tagli. “Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male” (Simone Weil).
Non contro ma verso gli Stati Uniti d’Europa. Il programma di questa Parte? Sarà buono se si procederà con infinita attenzione ai veri tagli. “Il vero male non è il male, ma la mescolanza del bene e del male” (Simone Weil).È questo il taglio sottile da operare, o il groviglio da dirimere. Guardate se non torna, lo sragionamento. Tutto il male che ci circonda viene da questo groviglio! Vorresti difendere, certo, la bandiera italiana dal disprezzo di chi ci tratta da gente che non sa stare ai patti, ma poi guardi quelli che la levano ora sulla piazza e ti accorgi che è sporca, lordata dall’uso che ne fece il demagogo lombardo predecessore dell’attuale. Vorresti accorrere, certo, a difesa della Repubblica e del suo presidente, allinearti a quei poveri corazzieri in alta uniforme, ma ti si stringe il cuore solo a guardarli, tanto svilita è l’idea che difendono, che solo il ricordo di quell’adunata di ceffi e mammole che presiedettero all’elezione del precedente presidente al suo secondo mandato ti riempie di vergogna, come quello delle innumerevoli forzature di un governo che da incostituzionalmente eletto si fa costituente senza averlo mai avuto in alcun programma. Vorresti ripetere anche tu, lo stesso, “sto col presidente”, perché dall’altra parte c’è la prepotenza di chi “se ne frega” di qualunque vincolo etico e giuridico in nome di folle senza volto, di chi addirittura non si vergogna a ripetere “chi si ferma è perduto”. E ti accorgi che il solo sostegno al governo del presidente verrà dai responsabili di tutte quelle forzature che hanno svilito l’uniforme dei miei corazzieri, e anche dal ghigno trionfale di un signore politicamente appena riabilitato, ancora prima che si sia quietato l’effetto di rivolta emetica indotto dalle immagini di Sorrentino in Loro 1 e Loro 2...
Il fool nella sua follia si rivolge anche a molti elettori Cinque Stelle: avete lottato - lo so perché ero con voi - per preservare un po’ di bellezza dove interessi biechi la sconciavano. Ma la bellezza non è un valore, è il nome di tutti i valori, compresa la (pari) dignità di tutte le persone. Come potete ora sostenere anche la bruttezza di parole e gesta di chi la nega? Non sta lì il primo nefasto miscuglio?
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IL PADRE NOSTRO E’ AMORE NON MAMMONA. ROBERTA DE MONTICELLI URLA "BASTA" A MONS. GIUSEPPE BETORI, A BAGNASCO, E ALLA CHIESA CATTOLICA. L’abiura di una cristiana laica
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA, NEL REGNO DI "FORZA ITALIA"!!!
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> LA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Un dio chiamato Capitale (di Massimo Cacciari).2 maggio 2018, di Federico La Sala
Due secoli di Marx
Un dio chiamato Capitale
Non è stata l’economia politica il cuore della rivoluzione del grande pensatore. Ma l’Economico come categoria dello spirito. La vera potenza che mette all’opera il mondo
di Massimo Cacciari (l’espresso, 29.04.2018)
Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro, o soltanto di quelli di voi che ne comprendano la grandezza filosofica, anzi: teologico-filosofica. Marx sta tra i pensatori che riflettono sul destino dell’Occidente, tra gli ultimi a osare di affrontarne il senso della storia. In questo è paragonabile forse soltanto a Nietzsche. Ma “Il Capitale”, si dirà? Non è l’economia politica al centro della sua opera? No; è la critica dell’economia politica. Che vuol dire? Che l’Economico vale per Marx come figura dello Spirito, come espressione della nuova potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo. L’Economico è per Marx ciò che sarà la Tecnica per Heidegger: l’energia che informa di sé ogni forma di vita, che determina il Sistema complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un nuovo tipo di uomo. Nessuna struttura cui si aggiungerebbe una sovra-struttura a mo’ di inessenziale complemento - l’Economico è immanente in tutte le forme in cui l’agire e il pensare si determinano; ognuna di esse è parte necessaria dell’intero.
Marx è pensatore del Tutto, perfettamente fedele in questo al suo maestro Hegel. Il Sistema è più delle parti, irriducibile alla loro somma. Chi intende l’Economico come una struttura a sé, autonoma, che determinerebbe meccanicisticamente le altre, non ha capito nulla di Marx. Marx non è pensatore astratto, e cioè non astrae mai l’Economico dall’intero sistema delle relazioni sociali, culturali, politiche.
La sua domanda è: quale potenza oggi governa l’Intero e come concretamente essa si esprime in ogni elemento dell’Intero? L’Economico è infinitamente più che Economico. Esso rappresenta nel contemporaneo la potenza che mette all’opera il mondo.
 Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.
Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.Per Marx è questo il “nuovo mondo” che il sistema di produzione capitalistico crea, non certo dal nulla, ma certo sconvolgendo dalle radici forme di vita e relazioni sociali, insomma: l’ethos dell’Occidente, la “sede” in cui l’Occidente aveva ino ad allora abitato È il mondo dove il Logos della forma-merce si incarna in ogni aspetto della vita, per diventarne la religione stessa. E Marx ne esalta l’impeto rivoluzionario. È questo impeto che per lui va seguito, al suo interno è necessario collocarsi per comprenderne le contraddizioni e prevederne scientificamente l’aporia, e cioè dove la strada che esso ha aperto è destinata a interrompersi - per il salto a un altro mondo. Qui bisogna intendere bene: la contraddizione non viene da fuori, da qualcosa che sia “straniero” al Sistema.
Contraddittorio in sé è il capitalismo stesso. Il capitalismo è crisi, è fatto di crisi. Funziona per salti, che ogni volta mettono inevitabilmente in discussione gli equilibri raggiunti. Non vi è riproduzione senza innovazione. Questo è noto anche agli economisti.
 Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
 È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.
È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.Questa contraddizione muove tutto. E ognuno è imbarcato in essa. L’idea di poterne giudicare “dall’alto” costituisce per l’appunto quella ideologia, che Marx sottopone a critica in dalle prime opere. Se la realtà dell’epoca è contraddizione inscindibilmente economica e politica, ogni interpretazione che la riduca a fatti naturalisticamente analizzabili la mistifica. Non è possibile cogliere la realtà del Sistema che collocandosi in esso, e dunque collocandosi nella contraddizione. Soltanto in questa prospettiva l’Intero è afferrabile. Non si comprende la realtà del presente se non in prospettiva e perciò a partire da un punto di vista determinato. Impossibile oggi un sapere astrattamente neutrale. La pretesa all’avalutatività è falsamente scientifica; l’epoca costringe a prender-parte, all’aut-aut. A porsi in gioco, alla scommessa anche. Il momento, o il kairòs, della decisione politica viene cosi a far parte della stessa potenza dell’Economico, resta immanente in essa.
 È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.
È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.Poiché concepisce la storia dell’Occidente come conflitto, e conflitto determinato dal suo carattere di classe, e poiché intende il presente alla luce dell’intrinseca contraddittorietà della stessa potenza rivoluzionaria del Sistema tecnico-economico, Marx pensa di aver posto saldamente sui piedi il pensiero dialettico dell’idealismo. Le epoche della Fenomenologia hegeliana dello Spirito non trovano conclusione in un Sapere assoluto che tutte accoglie e accorda, in una suprema Conciliazione, ma nella insuperabile contraddizione tra la potenza universale del Lavoro produttivo divenuto cosciente di sé e la sua appropriazione capitalistica. Si tratta di ben altro che di calcoli su valore e plusvalore.
 L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
 Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
 Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
 La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - MEMORIA DI SANT’AMBROGIO: "Nihil charitate dulcius" ("De Officiis ministrorum")21 marzo 2018, di Federico La Sala
IL "LOGOS" E LA "CHARITAS". Sul Vaticano, e su Roma, il "Logo" del Grande Mercante.Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- SANT’AMBROGIO - AMBROSIUS, In Epistolam Beati Pauli Ad Corinthios Primam, Caput XIII, Vers. 4-8:
- "Charitas Deus est" (I Joan. 4,8).
- Ambrosius, De Officiis ministrorum, Liber 2, Caput XXX, 155:
- "Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil charitate dulcius, nihil pace gratius"()
Il motto dello stemma episcopale del Vescovo Ausiliare di Roma, S.E.R. Mons. Angelo De Donatis
- NIHIL CARITATE DULCIUS (Ambrosius “De Officiis ministrorum” Liber 2, Caput XXX, 155)
Le parole scelte da Don Angelo per il proprio motto episcopale sono tratte dal “De officiis ministrorum” di Sant’Ambrogio laddove dice
 “Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”
“Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”
 (“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) *
(“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) **
Fonte: http://www.sanmarcoevangelista.it (ripresa parziale).
Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - Bisanzio brucia nella crociata dimenticata (di Silvia Ronchey)17 marzo 2018, di Federico La Sala
La storia
Bisanzio brucia nella crociata dimenticata
Nel 1204, due secoli prima di cadere in mano turca, Costantinopoli fu presa dai “fratelli” latini. Parte del suo patrimonio di arte e cultura passò a Venezia. Ora nuovi studi ricostruiscono quell’episodio drammatico
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 17.03.2018)
Il 13 aprile 1204, in una fredda giornata di primavera, una colonna di profughi dall’aspetto di fantasmi si incamminò fuori dalla grande città di Costantinopoli. Era “gente vestita di stracci, emaciata dal digiuno, trascolorata, cadaverica, con gli occhi così rossi che parevano colare sangue anziché lacrime”.
Erano stati torturati, depredati delle loro case e dei loro beni, avevano visto rapite le loro mogli, violentate le loro figlie. Non erano stati i turchi a compiere quello scempio, come sarebbe accaduto due secoli e mezzo dopo, nel 1453.
Erano stati i crociati occidentali. E non era contro gli infedeli che lo avevano portato, ma contro i loro correligionari, i bizantini.
La ferocia di quella singolare guerra santa ebbe tra i suoi testimoni oculari il più acuto, spregiudicato e disincantato degli osservatori politici dello Stato più prospero del medioevo: lo storico Niceta Coniata, massimo intellettuale della sua generazione, segretario del basileus fino a poco prima in trono ma anche suo indomabile critico, pensatore indipendente e non certo corifeo del potere, della cui opera è ora stata completata dalla Fondazione Lorenzo Valla l’edizione italiana (Grandezza e catastrofe di Bisanzio - Narrazione cronologica, traduzione di A. e F. Pontani, testo greco a cura di J.-L. van Dieten, introduzione di G. Cavallo, Fondazione Valla Mondadori, tre volumi).
Come ha scritto Steven Runciman, le crociate furono “le ultime invasioni barbariche”. I “barbari”, nelle frasi di Niceta, non sono gli islamici, che anzi i bizantini difesero strenuamente quando fu attaccata la locale moschea, ma quell’“accozzaglia di stirpi oscure e disperse” che erano gli eserciti latini, quei “precursori dell’Anticristo” che “portavano la croce cucita sulle spalle” e che in quei giorni di aprile del 1204 avevano devastato la culla stessa dell’impero romano cristiano, la città che ne custodiva da nove secoli l’identità religiosa oltre che l’eredità artistica, culturale, bibliografica così come la vocazione politica: un modello di Stato multietnico, meritocratico e sostanzialmente egualitario, dotato di una struttura diplomatica rivolta, come l’aquila bicipite, tanto a oriente quanto a occidente.
I profughi che si incamminavano “come una colonia di formiche” stanata dal fuoco avevano assistito al “più grande saccheggio della storia del mondo”, come lo definì lo stesso cronista francese Goffredo di Villehardouin che vi aveva partecipato al seguito di Bonifacio di Monferrato. Le atrocità perpetrate dai cavalieri della quarta crociata sono testimoniate non solo dagli storici bizantini ma anche dai cronisti occidentali, nonché dal papa che l’aveva indetta, Innocenzo III, inorridito nel suo epistolario.
La Città traboccava di capolavori d’arte e di inestimabili libri. Ma ad attrarre gli incolti latini era il fatto che, secondo i loro calcoli, contenesse i due terzi delle ricchezze del mondo conosciuto. Portarono “abominio e desolazione” nel Sacro Palazzo del Boukoleon, coprirono di sterco i marmi policromi della Grande Chiesa di Santa Sofia. Si precipitavano furiosi e urlanti per le strade distruggendo ogni cosa non apparisse trasportabile, fermandosi solo per trucidare gli abitanti e per spalancare le cantine e dissetarsi con il loro vino. Non risparmiarono monasteri, né chiese, né antichi monumenti, lasciarono bruciare gli archivi e le biblioteche. Una parte dei classici greci oggi perduti sarebbe arrivata fino a noi, non fosse stato per quella vandalica insipienza. Nel viaggio degli antichi testi la presa di Costantinopoli del 1204 segnò un naufragio paragonabile all’incendio della biblioteca di Alessandria.
Ciò che i veneziani non portarono a casa i francesi distrussero. I cavalli di bronzo dorato dell’Ippodromo sono oggi noti come Cavalli di San Marco, altre inestimabili opere d’arte formano il ricco bottino oggi conosciuto come Tesoro di San Marco. Ma le altre antiche statue bronzee dell’Ippodromo e quelle del Foro di Costantino furono fatte a pezzi e fuse. Nella stessa Santa Sofia si potevano vedere soldati ubriachi saccheggiare le reliquie, strappare i paramenti, svellere le suppellettili, calpestare i libri sacri e le icone, dilaniare gli arazzi.
L’orrore continuò per giorni, finché la capitale dell’ortodossia fu ridotta, scrivono i testimoni, a un macello. Perfino i saraceni, annotò Niceta, sarebbero stati più misericordiosi: “Dalla gente latina, ora come allora, Cristo è stato di nuovo spogliato e deriso, e le sue vesti sono state spartite, e il fiume del Sangue Divino ha di nuovo inondato la terra”, lamenta alla fine della sua opera.
La presa latina di Costantinopoli del 1204 è l’esempio più notevole di quella cruda verità economica delle crociate di cui, al di là dell’ideologia o della retorica confessionale, un libro dello storico oxfordiano Christopher Tyerman, in uscita in traduzione italiana, spiega in dettaglio mentalità, pragmatismo, finalità materiale e obiettivi strategici (C. Tyerman, Come organizzare una crociata, Utet). Si parla di “deviazione” della Quarta Crociata, quasi fosse stata un’idea repentina e non un preciso piano di conquista, già prospettato da Federico Barbarossa e da Enrico VI. Ben prima di entrare a Costantinopoli gli alleati avevano minuziosamente discusso e patteggiato tra loro, e soprattutto con Venezia, la spartizione dell’impero che avrebbero sostituito a quello bizantino, istituendo anche una gerarchia ecclesiastica cattolica al posto di quella ortodossa e insediando sul soglio patriarcale un veneziano.
L’alleanza della Realpolitik dei papi di Roma con l’Europa dei traffici, del protocapitalismo delle repubbliche mercantili, portò, con il successivo aiuto dei turchi, alla distruzione di una realtà politica che aveva garantito per secoli benessere e pace governando i conflitti fra le diverse etnie in un immenso territorio unificato dalla lingua greca, dalla religione cristiana, dal diritto romano, dominato da un formidabile sistema di pubblica istruzione e di cooptazione nelle burocrazie che assicurava il dinamismo delle élite e il loro costante ricambio sociale.
Per cinque giorni Niceta, la moglie incinta e il loro gruppo di amici dell’intelligencija costantinopolitana rimasero nascosti. Poi anche loro dovettero sfollare strisciando per i vicoli, i bambini piccoli in spalla, il viso delle ragazze mimetizzato col fango, in direzione della Porta d’Oro. Appena superate le sue torri, Niceta si gettò a terra e inveì contro le grandi mura di Teodosio: perché si reggevano ancora dritte in piedi? non vedevano che la civiltà che custodivano era finita? Poi, “gettando lacrime come semi” lungo la loro strada, si incamminarono per ricongiungersi al resto degli esuli e al governo in esilio insediato a Nicea, in Asia Minore.
 Ma quella che Niceta, partito da Costantinopoli con in mano solo il suo manoscritto, pianse come un’irrimediabile fine si rivelò un inizio. Per più di cinquant’anni l’impero di Nicea coltivò non solo la resistenza politica ma anche quella culturale, ricreando un sistema scolastico e universitario, proseguendo la produzione libraria. Quegli intellettuali avevano imparato una lezione: i barbari esistevano. Non erano i popoli che si diceva avessero fatto cadere l’impero romano d’occidente, diversamente da quello d’oriente, che era stato invece capace di assimilarli e accoglierli nella sua classe dirigente.
Ma quella che Niceta, partito da Costantinopoli con in mano solo il suo manoscritto, pianse come un’irrimediabile fine si rivelò un inizio. Per più di cinquant’anni l’impero di Nicea coltivò non solo la resistenza politica ma anche quella culturale, ricreando un sistema scolastico e universitario, proseguendo la produzione libraria. Quegli intellettuali avevano imparato una lezione: i barbari esistevano. Non erano i popoli che si diceva avessero fatto cadere l’impero romano d’occidente, diversamente da quello d’oriente, che era stato invece capace di assimilarli e accoglierli nella sua classe dirigente.
 Erano i figli del feudalesimo, che il sistema statale di Bisanzio aveva sempre combattuto, e di quel “satanico spirito del commercio”, per citare Baudelaire, da sempre incompatibile con la mentalità bizantina, dove la diffidenza dei cittadini verso il mercato e il rifiuto delle premesse etiche della mercatura espresso dagli intellettuali si univa alla condanna teologica del profitto e del lucro.
Erano i figli del feudalesimo, che il sistema statale di Bisanzio aveva sempre combattuto, e di quel “satanico spirito del commercio”, per citare Baudelaire, da sempre incompatibile con la mentalità bizantina, dove la diffidenza dei cittadini verso il mercato e il rifiuto delle premesse etiche della mercatura espresso dagli intellettuali si univa alla condanna teologica del profitto e del lucro.Anche dopo la riconquista del 1261 e l’insediamento della nuova dinastia dei Paleologhi, la guerra tra banchieri - genovesi e veneziani - continuerà a devastare economicamente e militarmente Bisanzio, a scarnificare quell’istmo culturale e strategico tra oriente e occidente. Ma per quanto cieche possano essere le strategie finanziarie e belliche, gli intellettuali possono sempre, discretamente, mobilitarsi.
Sempre di più si affermerà, tra i protagonisti della cosiddetta rinascenza paleologa, la coscienza dell’insopprimibilità di un’arma incruenta: la cultura. Il duello dei governanti, il risentimento delle masse, lo scontro delle chiese saranno trascesi da una simmetrica e inversa, silenziosa e superiore solidarietà tra umanisti orientali e occidentali. Sarà l’inizio di quella sempre più fitta circolazione di maestri e libri, liberamente scambiati dall’internazionale dei dotti, che darà vita a ciò che chiamiamo “il” rinascimento.
 L’antica cultura oltraggiata dai crociati conquisterà la loro stessa patria, la loro stessa curia, la stessa repubblica di Venezia, dove sorgerà, per volere di un umanista bizantino, Bessarione, la prima biblioteca pubblica della storia occidentale moderna. Da Bisanzio verranno e si metteranno all’opera, alacri, i copisti. Nascerà la stampa e non uno ma dieci, cento, mille libri sorgeranno sulle ceneri di quelli distrutti, insieme alle vite dei loro possessori, nella primavera del 1204.
L’antica cultura oltraggiata dai crociati conquisterà la loro stessa patria, la loro stessa curia, la stessa repubblica di Venezia, dove sorgerà, per volere di un umanista bizantino, Bessarione, la prima biblioteca pubblica della storia occidentale moderna. Da Bisanzio verranno e si metteranno all’opera, alacri, i copisti. Nascerà la stampa e non uno ma dieci, cento, mille libri sorgeranno sulle ceneri di quelli distrutti, insieme alle vite dei loro possessori, nella primavera del 1204.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara Santomiero
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara SantomieroFederico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - PURGATORIO DE L’INFERNO. LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI.7 marzo 2018, di Federico La Sala
IL DIO MAMMONA ("CARITAS"), IL DENARO, E "IL GATTO CON GLI STIVALI". LA LEZIONE DI EDOARDO SANGUINETI ... *
PURGATORIO DE L’INFERNO, 10. "Questo è il gatto con gli stivali" *
- Mentre con il figlio osserva un libro illustrato, il poeta sollecita con amore e affetto a guardare le immagini con attenzione e spirito critico, dietro a ogni cosa in esso rappresentata, e a ogni manifestazione della vita, si nasconde l’onnipotenza del ’dio’ denaro.
Questo è il gatto con gli stivali, questa è la pace di Barcellona
fra Carlo V e Clemente VII, è la locomotiva, è il pesco
fiorito, è il cavalluccio marino: ma se volti pagina, Alessandro,
ci vedi il denaro:
questi sono i satelliti di Giove, questa è l’autostrada
del Sole, è la lavagna quadrettata, è il primo volume dei Poetae
Latini Aevi Carolini, sono le scarpe, sono le bugie, è la scuola di Atene, è il burro,
è una cartolina che mi è arrivata oggi dalla Finlandia, è il muscolo massetere,
è il parto: ma se volti foglio, Alessandro, ci vedi
il denaro:
e questo è il denaro,
e questi sono i generali con le loro mitragliatrici, e sono i cimiteri
con le loro tombe, e sono le casse di risparmio con le loro cassette
di sicurezza, e sono i libri di storia con le loro storie:
ma se volti il foglio, Alessandro, non ci vedi niente
*
Edoardo Sanguineti
 La poesia è tratta dalla raccolta Triperuno, dalla sezione Purgatorio de l’Inferno,1964.
La poesia è tratta dalla raccolta Triperuno, dalla sezione Purgatorio de l’Inferno,1964.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- REALTA’ E RAPPRESENTAZIONE. STORIA ("RES GESTAE") E STORIOGRAFIA ("HISTORIA RERUM GESTARUM") ... E INTELLETTUALI.
 I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT
I LIBRI DI "STORIA" E LE "DOMANDE DI UN LETTORE OPERAIO" - DI BERTOLT BRECHT
- PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
- GATTO MAMMONE/(MAMMONA).
- SINODO DEI VESCOVI. L’ANNO DELLA PAROLA DI DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?! Fatto sta che la prima enciclica di Papa Benedetto XVI (Deus caritas est, 2006) è per Mammona.
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Edoardo Sanguineti
Ritratto critico di Edoardo Sanguineti. Prima parte - Seconda parte - Terza parte (di Angelo Petrella, "Belfagor", 2005 - "Nazione Indiana", 2017).
Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! - PAVIA. In S. Pietro in Ciel d’oro il cardinal Ravasi parla di carità (di Maria Grazia Piccaluga)2 marzo 2018, di Federico La Sala
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS")....
In S. Pietro in Ciel d’oro il cardinal Ravasi parla di carità
Mercoledì 28 febbraio la nuova tappa del progetto “L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo” voluto dal rettore Rugge
di MARIA GRAZIA PICCALUGA (la Provincia Pavese, 27 febbraio 2018)
PAVIA. Dopo la Speranza, la Carità. Ma la virtù cantata da San Paolo - paziente e benigna - mostra ancora lo stesso volto agli uomini del nostro secolo? Rappresenta ancora la ricchezza dei poveri e la forza della scienza come riteneva Sant’Agostino? Il progetto “L’Arca delle Virtù: da Agostino al XXI secolo” - concepito e avviato lo scorso anno dal rettore dell’Università di Pavia Fabio Rugge con il sostegno di molte realtà cittadine - la mette al centro della sua seconda edizione.
Mercoledì 28 febbraio alle 20.45, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, la riflessione sarà affidata al cardinale Gianfranco Ravasi (insigne biblista e teologo, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura) e a un dialogo in poesia e musica tra Vivian Lamarque e I Solisti di Pavia. «Pensiamo che questa virtù sia oggi un nervo sensibile della società globalizzata, multietnica, multireligiosa, divisa tra ricchi e poveri» chiarisce il rettore Rugge.
La personificazione della Carità, in una delle 95 statue che adornano l’Arca marmorea del santo, ha il volto di donna. Offre lo stesso seno, con la stessa generosità, a due bambini.
«L’Arca di Agostino è l’esposizione plastica di un programma dottrinario - spiega il rettore dell’Università di Pavia - Questo programma, però, non è per niente un’astrazione. Le “virtù”, in particolare la loro definizione e coltivazione, hanno dato per secoli trama alla società europea. Continuano a farlo, con la sfida intellettuale e spirituale che portano. La carità, ad esempio, ha spesso perso il suo significato di amore, dono, offerta, sacrificio, e ha talvolta acquisito dei connotati negativi. E’ stata contrapposta ai diritti, alla solidarietà civile. Discutere oggi di carità vuol dire anche interrogarsi sulla quotidianità di persone tra le persone».
Fede, speranza, carità, mansuetudine, povertà, prudenza, giustizia, temperanza, fortezza, obbedienza e castità: l’Arca che conserva le spoglie del santo di Ippona parla, come un libro aperto, ai contemporanei.
Agostino, inoltre, è protettore dell’Università di Pavia che, da queste radici passate, ha deciso di proiettarsi verso il futuro promuovendo un progetto che sappia trarre dal tesoro morale del santo spunti per una riflessione sull’etica contemporanea.
L’evento di mercoledì avrà inizio alle 20.45, nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, con una riflessione del cardinale Gianfranco Ravasi sul tema della Carità, dal titolo “Nihil caritate dulcius. Carità, virtù teologica e sociale”. Seguirà un dialogo artistico tra la poesia di Vivian Lamarque e la musica de I Solisti di Pavia: un’esecuzione originale e inedita, che simboleggia il “contagio” della Carità. Il programma prevede la lettura, da parte della poetessa, di versi tratti da “Madre d’inverno” e altre poesie, alternata all’esecuzione di brani di Bach, Mozart, Corelli, Vivaldi.
Del Comitato scientifico che ha elaborato i contenuti fanno parte: Giampaolo Azzoni (Università di Pavia), Cristina Bicchieri (Pennsylvania University), Ian Carter (Università di Pavia), Andrea Moro ( Iuss Pavia), Gianfranco Ravasi (Pontificio Consiglio della Cultura), Salvatore Veca (Iuss Pavia). Mentre al Comitato dei Promotori hanno aderito, oltre al rettore, il priore della basilica di San Pietro Antonio Baldoni, Renata Crotti, il rettore della Scuola Universitaria Superiore Iuss Michele Di Francesco, il sindaco Massimo Depaoli, e il vescovo di Pavia Corrado Sanguineti.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!
- "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (Giovanni Paolo II, 2003)
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- DIVENTÒ UN DIO, IL "PADRE NOSTRO", IL CAPITALE. PAPA FRANCESCO E INTERI MILLENNI DI LABIRINTO26 dicembre 2017, di Federico La Sala
PAPA FRANCESCO, IL "PADRE NOSTRO", E INTERI MILLENNI DI LABIRINTO
DIVENTÒ UN DIO, IL "PADRE NOSTRO", IL CAPITALE ... *
A FURIA DI MERCANTEGGIARE SU TUTTO abbiamo PERSO LA TESTA, fatto del CAPITALE un DIO, il "Padre nostro", e ci siamo fatti allegramente tradurre e "indurre in tentazione"! PER MILLENNI.
CHE BELLO!!! TUTTO è diventato "carissimo", non solo ciò che si produce e si vende (il feticismo delle merci) ma anche noi, gli animali, e l’intera terra con il suo cielo più alto: la CARESTIA si è diffusa su tutta la terra ed è diventa terribile e, come, al solito, i MERCANTI hanno fatto I loro affari e ancora oggi continuano ad accumulare TESORI per i loro "carissimi" eredi, dappertutto, non solo nelle loro case, ma anche nelle Banche e nei Templi (sul tema, cfr. i miei commenti all’art. di Marcello Gaballo, "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò", Fondazione Terra d’Otranto, 38.08.2017). E, ogni giorno, celebrano la LORO benedetta carissima "EU-carestia", la loro "BUONA-carestia" - per conservarla, per tutti i secoli dei secoli.
PER tutti i POVERI "CRISTI", che c’è da augurare?! Che il Natale "sia meno commerciale" e l’anno che viene "meno dozzinale"?!
Dopo duemila anni Papa Francesco finalmente ne ha preso atto:"Dio che ci induce in tentazione non è una buona traduzione".
Era ora!
BUON NATALE, BUON ANNO, BUON 2018
Federico La Sala
* Cfr. Armando Polito, "Natale e Capodanno: che non siano solo belle parole", "Fondazione Terra d’Otranto", 24,12,2017
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- "Dio non ci induce in tentazione"! Come già successo in Francia, papa Francesco vuole cambiare il ’Padre Nostro’: "Traduzione non è buona".8 dicembre 2017, di Federico La Sala
IL PADRE NOSTRO E DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" ...
Papa Francesco vuole cambiare il ’Padre Nostro’: "Traduzione non è buona, Dio non ci induce in tentazione"
Uno dei passaggi più noti potrebbe presto cambiare, come già successo in Francia *
CITTÀ DEL VATICANO - Il testo in italiano della preghiera più nota, il ’Padre Nostro’ , potrebbe presto cambiare. A farlo intendere è lo stesso papa Francesco: "Dio che ci induce in tentazione non è una buona traduzione. Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice ’non mi lasci cadere nella tentazione’. Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito".
Il pontefice lo ha spiegato nella settima puntata del programma ’Padre nostro’, condotto da don Marco Pozza, in onda su Tv2000. Francesco dialoga con il giovane cappellano del carcere di Padova nell’introduzione di ogni puntata. "Quello che ti induce in tentazione - conclude il Papa - è Satana, quello è l’ufficio di Satana".
Della controversia sulla preghiera più nota del cristianesimo - fu insegnata da Gesù stesso ai suoi discepoli che gli chiedevano come dovessero pregare - si è parlato in queste settimane quando in Francia si è detto appunto addio al vecchio ’Padre Nostro’. Dopo anni di discussioni sulla giusta traduzione, la nuova versione francese non include più il passaggio ’ne nous soumets pas à la tentation’ - ’non sottometterci alla tentazione’ -, che è stato sostituito con una versione ritenuta più corretta: ’ne nous laisse pas entrer en tentation’, ’non lasciarci entrare in tentazione’.
Secondo quanto ha scritto Le Figaro, la prima formula - ’non sottometterci’ - ha fatto credere a generazioni di fedeli che Dio potesse tendere in qualche modo una sorta di tranello, chiedendo loro di compiere il bene, li ’sottometteva’ alla tentazione del male. "La frase attuale lasciava supporre che Dio volesse tentare l’essere umano mentre Dio vuole che l’uomo sia un essere libero", ha commentato il vescovo di Grenoble, monsignor Guy de Kerimel, citato dal giornale. Dopo mezzo secolo - la controversa versione venne introdotta il 29 dicembre 1965 - la Conferenza episcopale transalpina ha quindi optato per la nuova traduzione del Notre Père. Per aiutare i fedeli a memorizzarla, la nuova preghiera è stata distribuita in decine di migliaia di copie nelle chiese di Francia. Il cambio ufficiale è avvenuto due giorni fa, domenica 3 dicembre.
Per la verità, anche in Italia, nella versione della Bibbia della Cei (2008), il passo ’et ne nos inducas in tentationem’ è tradotto con ’e non abbandonarci alla tentazione’; l’edizione del Messale Romano in lingua italiana attualmente in uso (1983) non recepisce tuttavia questo cambiamento. Ora però è il Papa a sostenere pubblicamente che si dovrebbe cambiare.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. Una nota di Henri Tincq - con premessa Una nota di Henri Tincq - con premessa
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- Francia. Con l’Avvento arriva il «nuovo» Padre Nostro17 novembre 2017, di Federico La Sala
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" CATTOLICO-ROMANO...
Francia.
Con l’Avvento arriva il «nuovo» Padre Nostro
Nella traduzione approvata dai presuli francesi «non indurci» diventa «non lasciare che entriamo in tentazione»
di Andrea Galli (Avvenire, giovedì 16 novembre 2017)
«Non lasciare che entriamo in tentazione» al posto di «non indurci in tentazione»: è questa la nuova formulazione della sesta richiesta del Padre nostro che i cattolici francesi sono invitati a usare nelle celebrazioni pubbliche a partire dal 3 dicembre prossimo, prima domenica di Avvento, inizio del nuovo anno liturgico. In un incontro con la stampa ieri mattina a Parigi - riporta l’agenzia Sir - il vescovo di Grenoble Guy de Kerimel, che è anche presidente della Commissione episcopale per la liturgia e la pastorale sacramentale, ha spiegato il significato di questa modifica, là dove si chiede a Dio di «essere liberati dalla tentazione che conduce al peccato e a una forma di schiavitù».
La traduzione precedente non era sbagliata dal punto di vista esegetico, ha detto il vescovo, ma rischiava di essere «mal compresa dai fedeli». La modifica sarebbe quindi «un’occasione per i cristiani di riappropriarsi della preghiera che Gesù ha insegnato loro». Per questo i vescovi francesi hanno voluto accompagnare questo passaggio con un volume, «Preghiera del Padre nostro, uno sguardo rinnovato». La nuova formulazione, che è già stata introdotta nella Pentecoste scorsa in alcuni Paesi francofoni come il Belgio e il Benin, sarà utilizzata anche in tutte le celebrazioni ecumeniche, come raccomandato dal Consiglio delle Chiese cristiane in Francia.
Intanto, sempre Oltralpe, continua fra i vescovi la discussione su un tema che ha percorso i lavori della loro assemblea plenaria autunnale si è tenuta a Lourdes dal 3 all’8 novembre. Nell’occasione don Jean-Luc Garin, rettore del Seminario di Lille e responsabile del Consiglio nazionale dei grandi Seminari, ha fornito un quadro aggiornato della situazione vocazionale: in sedici anni, dal 2000 al 2016, i seminaristi in Francia sono passati da 976 a 662: un calo del 30% che non sembra destinato ad arrestarsi, per ora. L’arcivescovo messicano Jorge Carlos Patrón Wong, segretario della Congregazione per il clero, intervenuto nel secondo giorno dei lavori illustrando all’assemblea la «Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis», ovvero le linee guida sulla formazione sacerdotale pubblicate dal dicastero vaticano nel dicembre 2016, ha ricordato che stando al documenti i Seminari, per sussistere o essere aperti, devono avere un numero di vocazioni sufficienti. Un minimo che va «da 17 a 20 persone» ha specificato Wong. Attualmente su 32 Seminari e case di formazione presenti in Francia solo 15 superano la soglia dei 17 seminaristi, per cui dopo l’assemblea plenaria il tema della possibile chiusura di circa la metà degli odierni Seminari è ufficialmente sul tavolo.
Per quanto riguarda i seminaristi diocesani, oggi la metà risiede in soli cinque Seminari: Fréjus-Tolone, Tolosa, Issy-les-Moulineaux, Rennes e Parigi. Un caso non diocesano in forte controtendenza vocazionale - di cui i vescovi hanno discusso, tra coloro che invitano a studiarne l’esempio e altri che manifestano diffidenza - è quello della Comunità di San Martino, associazione di diritto pontificio fondata nel 1976 da monsignor Jean-François Guérin e che ebbe la sua prima approvazione nel 1979 nell’arcidiocesi di Genova, dal cardinale Giuseppe Siri: oggi un seminarista su sei in Francia appartiene a tale comunità.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. Una nota di Henri Tincq - con premessa
DAL "DEUS CARITAS EST" AL "DEUS CHARITAS EST"?
 DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE -- Quella cosa molto seria che si chiama dono (di Luigino Bruni).16 novembre 2017, di Federico La Sala
Quella cosa molto seria che si chiama dono.
di Luigino Bruni *
Una delle povertà più grandi del nostro tempo è quella delle domande generative. Siamo inondati di risposte a domande che non facciamo, a ricette per soluzioni di problemi che non avvertiamo come tali, e al contempo siamo dentro una carestia impressionante di domande grandi, capaci di farci intravvedere orizzonti nuovi, di attivare la nostra creatività individuale e collettiva, di spingerci all’azione per cambiare il mondo, e non solo per gestire l’ordinario business.
Una delle domande non fatte, ma che attraversa tacita l’intera nostra civiltà ha a che fare con una delle parole più abusate e umiliante della nostra generazione: il dono. Dovremmo sempre più tornare ad interrogarci, in un tempo dominato dal consumo e dalla ricerca del piacere che fine ha fatto il dono nella nostra vita, soprattutto nella sfera pubblica. E’ infatti il dono che crea la comunità (cum-munus, dono reciproco), veniamo al mondo e qualcuno ci accoglie con gratuità e la vita si rigenera non per i contratti ma per i doni.
E allora chiediamoci: che cosa diventa il dono quando lo trasformiamo in filantropia, quando finisce per svolgere il ruolo di tappabuchi dello stesso capitalismo? Possiamo ancora chiamare dono le donazioni che le multinazionali dell’azzardo fanno alle associazioni che si occupano delle loro vittime? Che cosa sta allora diventando il dono? E che cosa il mercato?
Domande impegnative, questioni che negli ultimi decenni sono uscite troppo velocemente dall’orizzonte della nostra società, dai temi trattati sui giornali e nei media, dagli argomenti insegnati nei corsi di economia e business. Il mercato nasce come elaborazione del dono. Millenni fa abbiamo iniziato a scambiare con il linguaggio del dono, il contratto è nato dal patto, le monete avevano come effige gli dei, e il primo contratto che troviamo nella Bibbia è l’acquisto di Abramo della terra per la tomba della moglie Sara (Genesi).
Se giungiamo alla modernità, vediamo che il capitalismo nasce come riflessione sul rapporto fra dono (grazia, charis) e mercato. La Riforma protestante è stata decisiva per la natura del capitalismo moderno. Nata dalla ferita di un mercato che era penetrato nel cuore del dono (il mercato delle indulgenze), l’umanesimo luterano e calvinista si è caratterizzato per una netta separazione tra l’ambito del mercato e quello del dono, tra l’economia for-profit intesa come il regno degli interessi e dei contratti e quella non-profit vista come il luogo della gratuità.
L’umanesimo latino-cattolico, invece, non ha mai smesso di mescolare dono e contratto, grazia e mercato, profitto e gratuità, e l’economia cooperativa, l’impresa famigliare e la cosiddetta Economia civile sono comprensibili solo all’interno di un umanesimo meticcio, con le sue tipiche ferite e benedizioni - come ho cercato di dimostrare nel mio ultimo saggio Il mercato e il dono. Gli spiriti del capitalismo, Egea Bocconi 2015. Il nostro tempo sta conoscendo un appiattimento delle differenze regionali, del genius loci dei diversi capitalismi, sotto l’incedere di una ideologia che ci sta convincendo che il capitalismo «buono» è uno solo, quello costruito attorno agli incentivi, all’individuo e all’efficienza, i tipici valori dell’umanesimo protestante, relegando così il dono e i suoi valori in una sfera sempre più angusta e irrilevante.
Il dono è una cosa molto seria. E’ diventato quasi impossibile parlare bene oggi del dono, perché lo abbiamo messo in un angolo, e ridotto a ben poca cosa, soprattutto nella sfera pubblica, civile, economica. L’attacco al dono è comunque cosa antica. Abbiamo iniziato a relegarlo in ambiti molto angusti quando, anche per responsabilità di una certa teologia cristiana, tra l’Umanesimo e la modernità abbiamo iniziato a pensare che la giustizia fosse veramente essenziale per la costruzione di una buona società, e che, invece, la carità fosse un di più. La giustizia - abbiamo pensato e scritto - chiede di dare a ciascuno il suo, la carità di andare oltre il proprio. La giustizia è necessaria, la carità è facoltativa. La giustizia è essenziale, la carità volontaria, quindi inessenziale. La giustizia è importante, la carità superflua.
Il passo verso l’inutilità della carità è stato immediato, e così abbiamo immaginato una giustizia possibile senza agape, e una vita in comune buona senza amore civile. Abbiamo pensato che la carità/agape/amore potesse essere utile in alcuni ambiti specialistici - famiglia, le chiese, un certo non-profit, nella gestione delle emergenze umanitarie ... - ma che per la vita ordinaria pubblica ci bastasse la giustizia, che è già cosa molto ardua. I contratti e gli interessi sono necessari, il dono no: ci viene sempre più presentato come qualcosa di carino, il limoncello alla fine di una cena, che se c ’è fa piacere, ma se non c ’è in fondo nessuno se n ’accorge (tranne, nel lungo periodo, i produttori di limoncello). Il dono nella nostra società finisce per pesare per il 5 o l’8 per mille, e dobbiamo anche scontare l’evasione fiscale.
Il primo colpo, quasi mortale, al dono lo abbiamo allora dato quando, ormai da un po’ di anni, abbiamo ridotto la carità all’elemosina, alle donazioni, alla filantropia, alle offerte in chiesa, alle pesche di beneficienza o (molto più recentemente) ai due euro degli SMS umanitari. Abbiamo così, e nel giro di qualche decennio, annullato quell’operazione mirabile che fecero i cristiani dei primi secoli, quando scelsero di tradurre agape (l’amore gratuito) con charitas.
La caritas (senza h ) era, nel tardo latino, una parola economica - è antico il rapporto tra dono e mercato. Era usata dai mercanti per indicare il valore delle cose: un bene era caro se valeva e costava molto, come diciamo ancora oggi. Ai cristiani, in cerca di una parola latina per tradurre l’amore-agape, una parola diversa da amor (troppo vicino all’eros greco), trovarono in caritas una buona soluzione. Ma volevano differenziarla, almeno un po’, dalla parola economica del loro tempo. E così vi aggiunsero quella ‘h’, che era tutt’altro che muta, perché voleva dirci una cosa importante: charitas traduce le due grandi parole greche su cui si stava fondando la chistianitas (ancora questo ch): agape e charis, amore e gratuità, grazia. In quella charitas c’era praticamente quasi tutto: le vite donate dai martiri del loro tempo, gran parte dell’insegnamento delle lettere di Paolo, il kerigma dei vangeli; ma c ’era soprattutto un messaggio: la persona umana è capace di charitas, perché è capace di amare oltre l’eros e oltre la già grande philia (amicizia). È capace di oltrepassare il registro della condizionalità, persino oltre quel bisogno radicale di reciprocità che muove il mondo, e anche le stelle.
Questo era il dono: agape, charis, charitas. Questo non è più il dono nella nostra società. Cose, parole, realtà, che hanno generato, come ingredienti coessenziali, Notre Dame de Paris, il Duomo di Milano, gli affreschi di Signorelli a Orvieto e quelli di Michelangelo a Roma, la cappella Baglioni a Spello, le prime scuole per le ragazze povere a Viterbo, Barbiana, tante Costituzioni democratiche, le casse rurali che ci hanno salvato dalla miseria dei campi e generato il miracolo economico, una casa e un cuore per i disperati di Calcutta. E questo continua ad essere ancora in alcune periferie della nostra civiltà il dono: una energia straordinaria che continua a far nascere, per motivazioni più grandi del denaro, molte istituzioni, associazioni, cooperative, imprese. Che continua a farci alzare al mattino per andare a lavorare, per soffrire molto quando perdiamo il lavoro, perché smettendo di lavorare smettiamo non solo di percepire un reddito, ma non possiamo più donare la nostra vita lavorando, e ci fa gioire molto quando il lavoro lo ritroviamo. Tutto questo è il dono, ma non lo vediamo più. Se vogliamo veramente cominciare a sognare e costruire una nuova civiltà, prima di prevedere gli incentivi, gli sgravi fiscali e la crescita del PIL, dobbiamo tornare a vedere quella cosa molto seria che si chiama dono.
* Cfr. [DOC] 151028_BCC_Quella cosa molto seria che si chiama dono.docx
 www.consorziofarsiprossimo.org/il-contenuto-della-chiavetta.../14-bruni?...bruni
www.consorziofarsiprossimo.org/il-contenuto-della-chiavetta.../14-bruni?...bruni* Cfr.INTRODUZIONE a Il mercato e il dono. Gli spiriti del capitalismo
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- LA CHIESA DI COSTANTINO, CELESTINO V E IL POSTUMO "RISARCIMENTO" ARALDICO.27 settembre 2017, di Federico La Sala
RICCHEZZA E NOBILTÀ: LA CHIESA DI COSTANTINO, CELESTINO V E IL POSTUMO "RISARCIMENTO" ARALDICO ...
"ORIA. UN CASO DI ARALDICA PONTIFICIA IMMAGINARIA": UN LAVORO MAGISTRALE DI GRANDE INTERESSE. Tra le sue righe una notazione che getta luce sulla intera storia della Chiesa e non solo su Celestino V (la Congregazione dei Celestini, la città di Oria e al Salento), ma anche su papa Bonifacio VIII (Benedetto Caetani), su Benedetto XVI (Joseph A. Ratzinger), papa Francesco (Jorge M. Bergoglio), e, ancora, su DANTE ALIGHIERI (con la sua profetica lezione teologico-politica, cfr. "Monarchia" e "Commedia") e al tempestoso presente storico entro cui ancora oggi (nel III Millemnio d. C.) naviga l’Istituzione nata e cresciuta all’ombra di COSTANTINO, della sua "donazione", del suo "LATINORUM", e della sua "CARITAS" (da non confondere con la "CHARITAS", cfr. i commenti all’art. di Marcello Gaballo, "L’affresco di aant’Agostino nella cattedrale di Nardò", Fondazione Terra d’Otranto):
"Com’è noto, il primo pontefice di cui si possa attestare con certezza l’uso di uno stemma nell’esercizio della sua carica fu Bonifacio VIII (1294-1303), ma è con Clemente VI (1342-1352) che la conformazione dell’arma papale si canonizza nella forma che diventerà classica (...), mantenendosi tale fino al pontificato di Benedetto XVI";
 nota 16: "Com’è noto, Benedetto XVI abolì l’uso della tiara come timbro dello stemma papale, sostituendola con una mitria d’argento ornata da tre fasce d’oro, unite da un palo dello stesso colore. Il suo successore, Francesco, ha mantenuto tale uso" (cfr. Marcello Semeraro, "Oria. Un caso di araldica pontificia immaginaria").
nota 16: "Com’è noto, Benedetto XVI abolì l’uso della tiara come timbro dello stemma papale, sostituendola con una mitria d’argento ornata da tre fasce d’oro, unite da un palo dello stesso colore. Il suo successore, Francesco, ha mantenuto tale uso" (cfr. Marcello Semeraro, "Oria. Un caso di araldica pontificia immaginaria").Federico La Sala
-
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- LA LEZIONE DI SANT’AGOSTONINO, DALL’AFFRESCO DELLA CATTEDRALE DI NARDO’ (LECCE).28 agosto 2017, di Federico La Sala
IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").
"ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS"), DALLA GRAZIA ("gr.: "XAPIS", lat.: "CHARIS") DI DIO AMORE ("CHARITAS"), NON DI DIO MAMMONA ("CARITAS") ...
Lode a Marcello Gaballo per questa bellissima e preziosa nota su "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/#_ftn1) - e il lavoro di De Giorgi: la sua trascrizione della scritta sul cartiglio (ormai scomparsa) "iuste/et cas/te viv/ere et/ xarita(te)" - contrariamente alla protervia che ha portato allo "sproposito maiuscolo" e alla brutta abitudine instauratasi almeno a partire da Ludovico A, Muratori di una "caritas" latina! - conserva ancora la memoria del legame della tradizione dell’evangelo (non: "vangelo"!) con la lingua greca ("charis", "charites"... "charitas").
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. Giambattista Vico ("De constantia iurisprudentis", 1721) giustamente e correttamente e onestamente così pensava e scriveva: "Solo la carità cristiana insegna la prassi del Bene metafisico"("Boni metaphysici praxim una charitas christiana docet"). Sapeva che Gesù ("Christo") aveva cacciato i mercanti FUORI dal tempio, e non aveva autorizzato i sacerdoti a vendere a "caro-prezzo" (lat.: "caritas") la "grazia" (gr.: "Xapis", lat.: "Charis") di Dio (lat.: "Charitas")!!! Due padroni: Dio "Charitas" o dio "Caritas"?!, Dio Amore o dio Mammona?! In questo bivio ("X") ancora siamo, oggi - e ancora non sappiamo sciogliere l’incognita (""x")!
Sul tema, mi sia consentito, si cfr. la seguente nota:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- “La tecnica corre troppo e ci cambierà l’anima” (di Elena Dusi).25 giugno 2017, di Federico La Sala
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi".
IL COLLOQUIO. Parla Monsignor Ravasi: fede e scienza devono allearsi per battere la superficialità del momento“La tecnica corre troppo e ci cambierà l’anima”
di Elena Dusi (la Repubblica, 25.06.2017)
ROMA. «La tecnologia corre e ci propone nuovi mezzi con una velocità che la teologia e gli altri canali della conoscenza umana non riescono a seguire». Il cardinale Gianfranco Ravasi, 74 anni, teologo, biblista, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, non è però uomo che si dia per vinto. Con il “Cortile dei Gentili” e il “Tavolo permanente per il dialogo fra scienza e religione” sta cercando “alleati” fra coloro che hanno ancora fiducia nell’uomo e nel suo pensiero. «Atei, scienziati, persino chi ancora crede nelle ideologie. Non è più tempo di contrapposizioni ma di dialogo». Nell’ultimo incontro del “Tavolo” si è parlato di intelligenza artificiale e del rapporto fra umani e umanoidi.
Perché questo dialogo fra fede e scienza?
«Religione e scienza sono spesso considerati magisteri indipendenti, due rette parallele. E dal punto di vista del metodo è giusto che sia così. Ma condividono lo stesso soggetto e lo stesso oggetto. Non possono non incontrarsi, prima o poi».
Scienza e fede sono due tonalità di una stessa musica?
«La conoscenza del mondo da parte dell’uomo avviene attraverso molti canali: la scienza e la razionalità, ma anche la teologia, l’estetica, l’amore, l’arte, il gioco, il simbolismo, che è poi il primo modo di conoscere che abbiamo da bambini. Perderli o semplificarli vuol dire impoverirsi. E purtroppo è quello che sta avvenendo oggi».
Per colpa della scienza?
«No, per colpa dell’ignoranza. Stiamo vivendo una globalizzazione della cultura contemporanea dominata solo dalla tecnica o dalla pura pratica. C’è, ad esempio, una sovrapproduzione di gadget tecnologici di fronte alla quale non riusciamo a elaborare un atteggiamento critico equilibrato. Ci ritroviamo in un’epoca di bulimia dei mezzi e atrofia dei fini. La formazione scolastica e universitaria si occupa troppo poco degli aspetti relativi all’antropologia generale. Così, l’insegnamento di arte, letteratura, greco e latino, filosofia viene progressivamente ridotto».
Con quali conseguenze?
«Ci ritroviamo spesso appiattiti, schiacciati su un’unica dimensione. Un certo uso della scienza e della tecnologia hanno prodotto in noi un cambiamento che non è solo di superficie. Se imparo a creare robot con qualità umane molto marcate, se sviluppo un’intelligenza artificiale, se intervengo in maniera sostanziale sul sistema nervoso, non sto solo facendo un grande passo avanti tecnologico, in molti casi prezioso a livello terapeutico medico. Sto compiendo anche un vero e proprio salto antropologico, che tocca questioni come libertà, responsabilità, colpa, coscienza e se vogliamo anima».
La scienza corre troppo?
«Non tanto la scienza, quanto la tecnologia: corre e ci propone nuovi mezzi con una velocità che la teologia e gli altri canali della conoscenza umana non riescono a seguire. Per questa via si può finire in una civiltà mediatica e digitale che sta diventando totalizzante. Parliamo di transumanesimo come una delle paure del futuro, ma per certi versi è già iniziato. I nativi digitali sono funzionalmente diversi rispetto agli uomini del passato. Capovolgono spesso sia il rapporto fra reale e virtuale, sia il modo tradizionale di considerare vero e falso. È come se si ritrovassero dentro a un videogioco. Inoltre, l’uomo, che è sempre stato un contemplatore e custode della natura, oggi è diventato una sorta di con-creatore. La biologia sintetica, la creazione di virus e batteri che in natura non esistono sono un’espressione di questa tendenza. Tutte queste operazioni hanno implicazioni etiche e culturali che devono essere considerate».
Scienza e fede come possono collaborare?
«Fra spiritualità e razionalità, tra fede e scienza, può instaurarsi una tensione creativa. Diceva Giovanni Paolo II che la scienza purifica la religione dalla superstizione e la religione purifica la scienza dall’idolatria e dai falsi assoluti».
L’ecologia è un altro terreno di incontro?
«Gli accordi di Parigi sono ora in difficoltà. Anche molti “laici” si riconoscono invece nella Laudato si’ di papa Francesco, che mi pare stia diventando il punto di riferimento della questione ecologica. D’altronde è scritto nei primi passi della Genesi che Dio ha affidato la Terra all’uomo per “coltivarla” ma anche per “custodirla”».
I suoi incontri con i laici ormai proseguono da qualche anno. Qual è il suo bilancio?
«Il fondatore del cristianesimo, Gesù di Nazaret, era un laico, non un sacerdote ebraico. Egli non ha esitato a formulare un principio capitale: “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. La contrapposizione fra clericali e anticlericali ormai è sorpassata. Alcuni aspetti della laicità ci accomunano tutti e la teologia ha smesso da tempo di considerare la filosofia e la scienza solo come sue ancelle. I problemi piuttosto sono altri. Semplificazione, indifferenza, banalità, superficialità, stereotipi, luoghi comuni.
 Una metafora del filosofo Kierkegaard mi sembra adatta ai tempi di oggi: la nave è finita in mano al cuoco di bordo e ciò che dice il comandante con il suo megafono non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. È indispensabile riproporre da parte di credenti e non credenti, i grandi valori culturali, spirituali, etici come shock positivo contro la superficialità ora che stiamo vivendo una svolta antropologica e culturale complessa e problematica, ma sicuramente anche esaltante».
Una metafora del filosofo Kierkegaard mi sembra adatta ai tempi di oggi: la nave è finita in mano al cuoco di bordo e ciò che dice il comandante con il suo megafono non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. È indispensabile riproporre da parte di credenti e non credenti, i grandi valori culturali, spirituali, etici come shock positivo contro la superficialità ora che stiamo vivendo una svolta antropologica e culturale complessa e problematica, ma sicuramente anche esaltante». -
> MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- Nella nuova traduzione del "Padre nostro", «Non c’indurre in tentazione», è cambiata in «Non abbandonarci alla tentazione» (di Luigi Lorenzetti).3 giugno 2017, di Federico La Sala
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
Chiedi al teologo
Non abbandonarci «alla» o «nella» tentazione?
di Luigi Lorenzetti (Famiglia Cristiana, 02/06/2017)
- SERGIO - Nella nuova traduzione del Padre nostro la frase «non abbandonarci alla tentazione» potrebbe far pensare che essere tentati è già un peccato. Non era meglio la preposizione «nella»?
Nella nuova traduzione della Bibbia Cei (2008) la dizione «Non c’indurre in tentazione», è cambiata in «Non abbandonarci alla tentazione». La tentazione mette la libertà-responsabilità della persona di fronte a un bivio: il bene e il male. Ad esempio, aiutare il prossimo o lasciarlo perdere? Per scegliere il bene, è necessario l’aiuto di Dio che, d’altra parte, non lo impone a nessuno. Da qui la consapevolezza d’averne bisogno e di chiederlo fiduciosi nella preghiera. Il significato della nuova dizione è tutto nell’invocazione «Non abbandonarci» alla (traduzione ufficiale) o (il che è lo stesso) nella tentazione. Nell’una come nell’altra versione, è chiara la distinzione tra «essere tentati» e «consentire ». È consolante pensare e credere che Dio è sempre presente alla (o nella) tentazione, così da vincerla, anzi, trasformarla in conferma nella scelta del bene.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- «L’unico estremismo ammesso per un credente è la carità» (Papa Francesco).30 aprile 2017, di Federico La Sala
Il secondo giorno al Cairo
Il Papa: «L’unico estremismo ammesso per un credente è la carità»
Francesco ha concluso il suo viaggio in Egitto con la Messa con 30mila fedeli cattolici allo stadio militare del Cairo e l’incontro con i religiosi: «Siate luce tra profeti di distruzione»
di Redazione Internet *
Il secondo giorno al Cairo di Papa Francesco è dedicato alla piccola comunità cattolica egiziana (lo 0,30% circa della popolazione). Alle 10 è cominciata la Messa (in latino e arabo) nello stadio militare, davanti a circa 30mila tra fedeli cattolici, pellegrini, ma anche ortodossi e musulmani che lo hanno accolto con canti, striscioni di benvenuto, palloncini bianchi e gialli come i colori della bandiera del Vaticano, e con bandiere dell’Egitto. Ad accoglierlo, il patriarca copto cattolico Ibrahim Isaac Sidrak.
"Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l`unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carità! Qualsiasi altro estremismo non viene da Dio e non piace a Lui!". Così papa Francesco durante l’omelia pronunciata nel corso della celebrazione eucaristica all’Air Defense Stadium de Il Cairo.
- Il saluto della folla prima della Messa (Ansa)
"La fede vera - ha aggiunto il Papa - è quella che ci rende più caritatevoli, più misericordiosi, più onesti e più umani; è quella che anima i cuori per portarli ad amare tutti gratuitamente, senza distinzione e senza preferenze; è quella che ci porta a vedere nell`altro non un nemico da sconfiggere, ma un fratello da amare, da servire e da aiutare; è quella che ci porta a diffondere, a difendere e a vivere la cultura dell`incontro, del dialogo, del rispetto e della fratellanza; ci porta al coraggio di perdonare chi ci offende, di dare una mano a chi è caduto; a vestire chi è nudo, a sfamare l`affamato, a visitare il carcerato, ad aiutare l`orfano, a dar da bere all`assetato, a soccorrere l`anziano e il bisognoso. La vera fede è quella che ci porta a proteggere i diritti degli altri, con la stessa forza e con lo stesso entusiasmo con cui difendiamo i nostri. In realtà, più si cresce nella fede e nella conoscenza, più si cresce nell`umiltà e nella consapevolezza di essere piccoli".
- IL TESTO DELL’OMELIA
"Quante volte l’uomo si auto-paralizza, rifiutando di superare la propria idea di Dio, di un Dio creato a immagine e somiglianza dell’uomo! Quante volte si dispera, rifiutando di credere che l’onnipotenza di Dio non è onnipotenza di forza, di autorità, ma è soltanto onnipotenza di amore, di perdono e di vita! - ha detto il Papa nell’omelia, pronunciata in italiano - I discepoli riconobbero Gesù ’nello spezzare il pane’, nell’Eucaristia. Se noi non ci lasciamo spezzare il velo che offusca i nostri occhi, se non ci lasciamo spezzare l’indurimento del nostro cuore e dei nostri pregiudizi, non potremo mai riconoscere il volto di Dio"
- L’arrivo allo stadio militare per la Messa (Ansa)
Perciò, ha continuato, «non serve pregare se la nostra preghiera rivolta a Dio non si trasforma in amore rivolto al fratello: non serve tanta religiosità se non è animata da tanta fede e da tanta carità». «È meglio non credere che essere un falso credente, un ipocrita!».
Lo stadio militare è parte del villaggio dello sport dell’aeronautica, costruito e gestito dal ministero della Difesa per celebrare la difesa aerea egiziana durante la guerra del 1970 contro Israele. Un coro, al passaggio della vettura del Papa ha intonato il Laudato Si’, per ricordare la visita di San Francesco d’Assisi che nel settembre del 1219 visitò il sultano d’Egitto Malik al Kamil per un colloquio storico, avvenuto a Damietta, a pochi chilometri di distanza dal Cairo, che fu il primo grande passo nel dialogo interreligioso con il mondo islamico.
- Al "piccolo gregge" cattolico d’Egitto: costruite ponti
Dopo il pranzo alla Nunziatura apostolica del Cairo con i 15 vescovi copto cattolici, papa Francesco si è trasferito in auto al Seminario patriarcale Al-Maadi, nella periferia sud della capitale egiziana, dove ha incontrato il clero, i religiosi, le religiose e i seminaristi - in tutto 1.500 persone-, ultimo appuntamento della sua visita di due giorni in Egitto.
- IL TESTO COMPLETO
"Sono felice di salutare in voi, sacerdoti, consacrati e consacrate del piccolo gregge cattolico in Egitto, il lievito che Dio prepara per questa Terra benedetta, perché, insieme ai nostri fratelli ortodossi,cresca in essa il suo Regno". "Non abbiate paura del peso del quotidiano, del peso delle circostanze difficili che alcuni di voi devono attraversare". "In mezzo a tanti motivi di scoraggiamento e tra tanti profeti di distruzione e di condanna, in mezzo a tante voci negative e disperate, voi siate una forza positiva, siate luce e sale di questa società; siate il locomotore che traina il treno in avanti, diritto verso la mèta; siate seminatori di speranza, costruttori di ponti e operatori di dialogo e di concordia", ha detto il Papa.
Secondo il Papa, "il Buon pastore ha il dovere di guidare il gregge", e "non può farsi trascinare dalla delusione e dal pessimismo". Inoltre, "è facile accusare sempre gli altri, per le mancanze dei superiori, per le condizioni ecclesiastiche o sociali, per le scarse possibilità", ma il consacrato è colui che "trasforma ogni ostacolo in opportunità, e non ogni difficoltà in scusa!". Francesco ha puntato il dito anche contro il "pericolo serio" del consacrato che "invece di aiutare i piccoli a crescere e a gioire per i successi dei fratelli e delle sorelle, si lascia dominare dall’invidia e diventa uno che ferisce gli altri col pettegolezzo": "L’invidia - ha detto - è un cancro che rovina qualsiasi corpo in poco tempo", e "il pettegolezzo ne è il mezzo e l’arma".
Il Papa ha messo in guardia sacerdoti, religiosi, seminaristi egiziani dal "faraonismo" in cui può cadere chi sceglie l’ordinazione o la consacrazione. Il Papa ha parlato della "tentazione del faraonismo... siamo in Egitto!, cioè dell`indurire il cuore e del chiuderlo al Signore e ai fratelli", la tentazione dell`individualismo" e "la tentazione del camminare senza bussola e senza mèta". "Senza avere un`identità chiara e solida - ha poi specificato - il consacrato cammina senza orientamento e invece di guidare gli altri li disperde".
"L`Egitto ha contribuito ad arricchire la Chiesa con il tesoro inestimabile della vita monastica", ha concluso il Papa salutando sacerdoti, religiosi e seminaristi egiziani. "Vi esorto, pertanto, ad attingere dall`esempio di San Paolo l`eremita, di Sant`Antonio, dei Santi Padri del deserto, dei numerosi monaci, che con la loro vita e il loro esempio hanno aperto le porte del cielo a tanti fratelli e sorelle, e così anche voi potete essere luce e sale, motivo cioè di salvezza per voi stessi e per tutti gli altri, credenti e non, e specialmente per gli ultimi, i bisognosi, gli abbandonati e gli scartati".
Prima di congedarsi al Cairo, ancora un breve incontro con il presidente sl Sisi nella sala d’onore dell’aeroporto. Al din lillah wa al watan lilgiamià, la fede è per Dio, la Patria è per tutti.
* Avvenire, sabato 29 aprile 2017 (ripresa parziale).
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- San Giuseppe, il "disobbediente" che si prese cura di Gesù (di Gianfraqnco Ravasi).20 marzo 2017, di Federico La Sala
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
- PER L’ITALIA, "DUE SOLI".
San Giuseppe, il "disobbediente" che si prese cura di Gesù
Il cardinale e biblista Gianfranco Ravasi ci guida alla scoperta del carpentiere di Nazareth. Che non obbedì alle leggi del suo tempo per abbracciare la volontà divina
di Gianfranco Ravasi (Famiglia Cristiana, 19/03/2017)
I testi biblici relativi a Giuseppe, lo sposo di Maria e padre legale di Gesù, sono piuttosto scarsi, a prima vista quasi lacunosi, e ciò spiega l’abbondanza di letteratura apocrifa sul personaggio, tra cui si segnala in particolare il Protovangelo di Giacomo. Nondimeno, scavando con attenzione nei dati neotestamentari, emerge una figura interessante, capace di interpellare anche il lettore odierno. L’evangelista Marco non parla mai di Giuseppe, ma si limita a riportare quanto dicono i nazareni, allorché affermano che Gesù è il figlio di Maria, e che fa il carpentiere. È invece da Matteo e da Luca che conosciamo il nome del padre legale di Gesù e sposo di Maria. Per quanto riguarda l’attività di Giuseppe, bisogna riferirsi a Matteo 13, 55, versetto in cui Gesù viene definito come “il figlio del carpentiere”. Il termine greco téktôn, che si traduce solitamente con “carpentiere”, corrisponde al latino faber e indica un artigiano che lavora il legno o la pietra. Concretamente si può pensare al lavoro del carraio, o del fabbricante di aratri e di strumenti per l’agricoltura, nonché a uno che tratta genericamente il legno, il classico falegname, o ancora al carpentiere che provvede alle strutture in legno necessarie all’edilizia; questa era in quei tempi assai fiorente nella regione della Galilea, a causa della costruzione di nuove città. Ciò significa che Gesù ha imparato il mestiere da Giuseppe e ne deve aver rilevato l’attività alla sua morte; risulta pertanto il ritratto di una condizione economica dignitosa della famiglia di Giuseppe, anche se non si può definire agiata. Tale condizione permette ad esempio, a Giuseppe e a Maria, di recarsi ogni anno in pellegrinaggio a Gerusalemme, affrontando le spese del viaggio.
Com’era composta la famiglia di Giuseppe
Per quanto riguarda poi la composizione della famiglia di Giuseppe, la questione è difficilmente risolvibile alla luce dei dati a nostra disposizione, poiché si intreccia con il problema della presenza di “fratelli e sorelle” di Gesù, dei quali si parla più volte negli scritti neotestamentari e che non necessariamente vanno intesi come fratelli di sangue veri e propri, ma possono essere semplicemente cugini o anche parenti più lontani. Per vari interpreti si tratterebbe di fratellastri e sorellastre di Gesù, avuti da Giuseppe da un precedente matrimonio; ma la fonte di ciò è il più tardivo apocrifo noto come il Protovangelo di Giacomo e non uno scritto canonico. È Matteo che pone particolare attenzione alla figura dello sposo di Maria, offrendoci un ritratto squisito, indimenticabile, di Giuseppe. Infatti il primo Evangelista ci descrive come egli, dapprima, di fronte all’inattesa gravidanza della promessa sposa, vorrebbe uscire rispettosamente da una storia più grande di lui, senza opprimere con la sua presenza quella giovane donna che egli ama profondamente, e quel misterioso bambino che ella attende: “Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto”.
La giustizia di San Giuseppe è accoglienza della volontà divina
Essendo tuttavia uomo “giusto” - perché disponibile a compiere gioiosamente e fedelmente la volontà divina - subito dopo, obbediente alla parola di Dio, consegna la propria vita a un progetto che lo trascende, con l’accettazione del comando di prendere con sé Maria. Ecco la giustizia di Giuseppe, che non è semplicemente quella derivante dall’osservanza scrupolosa dei comandamenti, ma la giustizia che è ricerca integrale della volontà divina, accolta con obbedienza piena. Attraverso questa obbedienza inizia per Giuseppe una vita nuova, con prospettive assolutamente insospettate, e con la scoperta di un senso più profondo del suo essere sposo e padre. Rimarrà così accanto alla sua donna quale sposo fedele, e a quel bimbo quale figura paterna positiva e responsabile. L’assunzione di questa responsabilità è espressa attraverso il fatto che è Giuseppe - secondo l’ordine angelico - a dare il nome di Gesù al figlio generato da Maria. L’atto del dare il nome significa che egli conferisce a quel bambino la sua identità sociale e che, proprio per questo, Gesù può essere riconosciuto quale vero discendente di Davide, così come esige la natura del Messia atteso. Questo bimbo è dunque consegnato alla responsabilità e all’amore di Giuseppe e, attraverso di lui, Dio consegna alla storia umana il più grande pegno della sua fedeltà, colui che è l’“Emmanuele”, il “Dio-con-noi”, profetizzato da Isaia. Certamente tutto ciò è avvolto nel mistero di Dio, al quale si accede solo con la fede. Ebbene, anche in questa eccelle Giuseppe, definito, proprio per la sua fede, con l’appellativo sobrio e grandioso, di “uomo giusto”.
Uomo "dei sogni", obbediente alla volontà di Dio e capace di prendersi cura
Nel Vangelo matteano dell’infanzia, ogni volta che entra in gioco Giuseppe, la sua figura è caratterizzata da tre aspetti tra loro intrecciati: Giuseppe è l’uomo dei sogni, è l’obbediente che accoglie integralmente la volontà di Dio, è l’uomo che sa “prendere con sé”, cioè sa prendersi davvero cura delle persone affidategli. Attraverso il tema della visione angelica ricevuta nel sogno, l’Evangelista vuole alludere, con un linguaggio tratto dall’Antico Testamento (si pensi qui ai sogni dell’omonimo Giuseppe, nei racconti della Genesi), al mistero dell’irruzione del divino nella vita umana. Ebbene, Giuseppe è l’uomo che accoglie il sogno di Dio, perché in qualche modo sa egli stesso sognare una storia in cui Dio è coinvolto totalmente per la salvezza delle sue creature, così come suggerisce anche il nome di Salvatore-Gesù dato a quel bambino. Agli ordini angelici Giuseppe obbedisce sempre prontamente e ogni volta ricorre un’espressione assai suggestiva circa la sua pronta risposta: “prese con sé”. La prima volta è al termine dell’annunciazione di cui egli è il destinatario: “fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa”. Successivamente, il “prendere con sé” riguarda l’ordine angelico circa il bambino e la madre da far riparare in Egitto; infine la stessa espressione ricorre quando si tratta di ritornare dall’Egitto. In tutto ciò emerge il ritratto di Giuseppe come di un uomo che ha scoperto l’amore divino per questa umanità, e che ha esperimentato la serietà della decisione di Dio di essere l’“Emmanuele”. È da questa evidenza intima che procede la sua forza di prendersi cura e di accogliere con sé Maria e il bambino.
Custodisce e si prende cura di Gesù anche nel pericolo
Ma c’è un particolare che risulta davvero intrigante: quando l’angelo comanda a Giuseppe di rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla minaccia di Erode, il testo evangelico annota che Giuseppe “destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte, e fuggì in Egitto”. Questa “notte” non è soltanto un’indicazione cronologica delle circostanze della fuga precipitosa, ma segnala la prontezza dell’obbedienza di Giuseppe, e assume lo spessore simbolico del tema della notte nei testi biblici. In questo senso Giuseppe emerge davvero come padre di Gesù, non nell’aspetto biologico, ma nel significato più profondo: il padre è infatti colui che custodisce, protegge, apre il cammino. Il genitore è la figura umana che illustra al meglio quello che significa il prendersi cura da parte di Dio della nostra fragilità. Ebbene, Giuseppe è il padre che non soltanto custodisce e provvede al bambino quando è giorno, quando tutto è facile, scontato e solare; egli lo prende con sé nella notte, quando le difficoltà sembrano avere il sopravvento, ed espandersi le tenebre del dubbio, dell’agguato e del terrore. Alla dolcezza della madre e alla debolezza del bambino, egli accompagna la fermezza della sua presenza e dedizione. Giuseppe sa muoversi anche nella notte, mentre tiene fermo il ricordo del giorno, quel giorno che egli ha conosciuto vivendo una vita nella giustizia, cioè in un atteggiamento orante e obbediente davanti a Dio. Giuseppe non ha giocato al ribasso, a tirarsi indietro, a puntare sulle proprie comodità e sicurezze, ma ha preso con sé il bambino e Maria, diventando così per loro come un simbolo concreto, visibile, di quel Padre buono, di quel Dio che ha cura di tutti, di cui Gesù parlerà nell’Evangelo.
Non è un detentore del potere
Nel Vangelo di Luca la maternità verginale di Maria è chiaramente indicata nel contesto dell’annunciazione alla Vergine di Nazaret e non si dice nulla a proposito dell’atteggiamento di Giuseppe di fronte all’avvenimento misterioso che lo coinvolge. Semplicemente, nel prosieguo del racconto, in occasione del viaggio a Betlemme durante il quale Gesù viene alla luce, si mostra come Giuseppe abbia preso con sé Maria, sua sposa, assumendo dunque il carico della situazione creatasi. I successivi racconti dell’infanzia vedono Giuseppe al fianco di Maria, sposo solidale con lei, strettamente unito a lei in tutta la vicenda, dalla nascita alla circoncisione del bambino, fino alla presentazione al santuario di Gerusalemme e al misterioso episodio dello smarrimento e ritrovamento di Gesù dodicenne fra i dottori del tempio. La presenza di Giuseppe a fianco di Maria suggerisce la realtà di una coppia realmente affiatata, tutta protesa alla costruzione di una famiglia al cui centro sta la ricerca della volontà di Dio e dell’obbedienza alla sua legge. Giuseppe è un vero capofamiglia, che non vuole essere il detentore del potere, ma aiutare i membri della famiglia a lui affidata a compiere la propria vocazione. Per questo Luca, che ben conosce l’origine trascendente del Figlio di Maria, non esita a designare per due volte Giuseppe come “padre di Gesù”.
La morte attorniato dai familiari
Gli ultimi fatti evangelici che vedono coinvolto Giuseppe sono quelli riguardanti lo smarrimento di Gesù al tempio e il ritorno alla “normalità” della vita di Nazaret. Il primo episodio è ambientato in un pellegrinaggio a Gerusalemme, per la Pasqua. Giuseppe è coinvolto in un’inaspettata crisi familiare allorché, con Maria, si rende conto che il ragazzo non è nella carovana che sta tornando in Galilea. È una crisi familiare che scoppia in tutta la sua gravità e che chiede di essere ricomposta, consentendo ai membri di uscirne più cresciuti, più maturi. Da una parte vi è l’adolescente Gesù, che si stacca dai suoi genitori, dall’altra costoro che non hanno ancora fatto i conti con tale distacco, pur essendo Maria e Giuseppe! L’Evangelista non dice che la cosa è stata semplice, né per Giuseppe né per Maria; per questo mostra i tre giorni della loro ricerca angosciata (il termine greco designa anche una pena infinita!), finché non ritrovano Gesù al tempio. In qualche modo Giuseppe, con la sposa Maria, prefigura la comunità dei discepoli che dovrà vivere i tre giorni del mistero pasquale, nell’attesa di una luce, di una parola che le dia speranza e superi la notte tremenda che si è abbattuta sul loro discepolato.
Infine la narrazione lucana porta l’attenzione del lettore sugli anni segreti di Gesù a Nazaret, là dove vive nella sottomissione ai suoi genitori. Qui a Nazaret Gesù entra nell’età adulta e riceve un’educazione nella quale il contributo di Giuseppe deve essere stato senza dubbio molto rilevante.
 Anzitutto Giuseppe trasmette a Gesù le conoscenze del proprio mestiere, ma lo introduce pure nella conoscenza della Tôrah, perché nel giudaismo l’educazione religiosa dei figli maschi è eminentemente affidata alla figura paterna. Peraltro è il padre che celebra le principali feste religiose che hanno sempre un’importante componente familiare; sempre Giuseppe, come gli altri padri di famiglia, deve avere condotto Gesù in sinagoga ogni sabato, facendogli acquisire quell’abitudine tipica del giudeo osservante, così come annota il Vangelo di Luca.
Anzitutto Giuseppe trasmette a Gesù le conoscenze del proprio mestiere, ma lo introduce pure nella conoscenza della Tôrah, perché nel giudaismo l’educazione religiosa dei figli maschi è eminentemente affidata alla figura paterna. Peraltro è il padre che celebra le principali feste religiose che hanno sempre un’importante componente familiare; sempre Giuseppe, come gli altri padri di famiglia, deve avere condotto Gesù in sinagoga ogni sabato, facendogli acquisire quell’abitudine tipica del giudeo osservante, così come annota il Vangelo di Luca.
 Sempre a Nazaret scompare la figura evangelica di Giuseppe, che infatti non appare più durante la vita pubblica di Gesù. Da ciò la tradizione deduce una morte di Giuseppe circondato dalla presenza dei suoi, in particolare della sposa Maria e di Gesù. Ed è per questo che egli diventa la figura spirituale del protettore del moribondo cristiano, che affronta il trapasso con tutti i conforti della fede. Testimonia tale attenzione alla figura di Giuseppe - e in particolare alla sua infermità e morte - uno scritto apocrifo cristiano del V secolo, noto come Storia di Giuseppe il falegname.
Sempre a Nazaret scompare la figura evangelica di Giuseppe, che infatti non appare più durante la vita pubblica di Gesù. Da ciò la tradizione deduce una morte di Giuseppe circondato dalla presenza dei suoi, in particolare della sposa Maria e di Gesù. Ed è per questo che egli diventa la figura spirituale del protettore del moribondo cristiano, che affronta il trapasso con tutti i conforti della fede. Testimonia tale attenzione alla figura di Giuseppe - e in particolare alla sua infermità e morte - uno scritto apocrifo cristiano del V secolo, noto come Storia di Giuseppe il falegname. -
> CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- FILOLOGIA E POLITICA. La Casa Bianca toglie la "h" a Theresa May e la fa diventare una star del soft porno27 gennaio 2017, di Federico La Sala
La Casa Bianca toglie la "h" a Theresa May e la fa diventare una star del soft porno *
Nuova gaffe dell’amministrazione Trump in politica estera. Dopo aver confuso il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop per il premier Malcolm Turnbull, l’ufficio stampa della Casa Bianca ha ’dimenticato’ la ’h’ nel nome della premier britannica Theresa May. Risultato: in due documenti l’inquilina di Downing Street è diventata la nota star del soft-porn Teresa May.
L’errore, poi corretto, è stato ripetuto due volte nel comunicato di ieri con il quale la Casa Bianca annunciava l’agenda odierna degli incontri Trump-May e una volta in un comunicato dell’ufficio del vice presidente.
"Nel pomeriggio il presidente parteciperà ad un incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Teresa May", recitava la nota dell’ufficio stampa della Casa Bianca. E qualche riga dopo la ’h’ era di nuovo sparita nel previsto "pranzo di lavoro con Teresa May...".
Ancora una volta, nella nota dell’ufficio di Mike Pence il nome di battesimo di May è diventato quello della star di un video per la canzone Smack My Bitch Up del gruppo The Prodigy.
"È per questo che Donald Trump era eccitato di incontrarla?", commenta ironico il tabloid britannico Mail online riferendosi al previsto colloquio di oggi tra il neo presidente e la premier britannica a Washington. Sempre ieri, ricorda il Mail online, in un altro comunicato la Casa Bianca ha definito il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop il ’primo ministro degli Esteri’ del Paese.
-
>CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?! --- AIL LIBRO COMUNE. LA BIBBIA SI FA IN QUATTRO.23 ottobre 2016, di Federico La Sala
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E UNO "SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
- NEL NOME DI DIO "MAMMONA" ("DEUS CARITAS EST", 2006)!!! UNA VULGATA DEI MERCANTI DEL TERZO MILLENNIO (AVANTI CRISTO). Il 29 maggio [2008] consegnata al Papa la nuova traduzione italiana della Bibbia. Parola di Monsignor Betori.
- MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?!
Il libro comuneLa Bibbia si fa in quattro
La Sacra Scrittura in ebraico masoretico e l’antica versione greca dei Settanta, accompagnate dall’italiano
di Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 23.10.2016)
Forse esagerava ma non aveva del tutto torto Karl Kraus quando nei suoi Detti e contraddetti affermava che «il linguaggio è la madre, non l’ancella del pensiero». E continuava: «Il linguaggio dev’essere la bacchetta del rabdomante che scopre sorgenti di pensiero». Proprio per questo lo studio di una lingua permette di leggere un testo - anche (e soprattutto) sacro - nella sua matrice originaria tematica e culturale, impedendo che - attraverso la versione - accada quello che Cervantes segnalava per ogni traduzione: «è come contemplare un arazzo dal retro». Si spiega, così, il moltiplicarsi di strumenti che favoriscono l’approccio diretto al testo originale, anche attraverso i supporti informatici. Ad esempio, la società texana Silver Mountain Software già dal 1999 ha approntato le Bible Windows che si affacciano su tre orizzonti: l’analisi grammaticale dell’ebraico e del greco biblico; il dizionario ebraico-inglese e greco-inglese; la concordanza dei termini con un filtro grammaticale.
Se, invece, vogliamo fermarci alla carta stampata e a strumenti più “testuali” diretti, dobbiamo segnalare l’impresa messa in cantiere dalle edizioni Dehoniane di Bologna in una collana destinata a coprire tutti i 73 libri di cui si compone la Bibbia e intitolata suggestivamente “Doppio verso”, anche perché si hanno due copertine con testi rispettivamente capovolti. L’uno è riservato all’originale ebraico o greco di un libro biblico nel quale ogni parola ha la sua versione italiana interlineare quasi a ricalco letterale; l’altra sezione del volume offre, invece, una traduzione dello stesso libro biblico in modo continuo secondo la versione della Conferenza Episcopale Italiana (2008), accompagnata dall’apparato di introduzioni e di note desunte dalla ormai famosa “Bibbia di Gerusalemme”. Ad eseguire con pazienza certosina questa impresa è Roberto Reggi, un teologo che ha consacrato anni a questa operazione di fedeltà alla Parola sacra espressa nelle parole umane.
Ora, ha messo in cantiere un nuovo modulo analitico intitolato “La Bibbia quadriforme” e l’ha applicato a due libri biblici tra i più usati nella storia giudaica e cristiana, cioè la Genesi e i Salmi. La tetralogia che regge le doppie pagine di questa opera è facilmente comprensibile: al testo ebraico masoretico (cioè approntato dalla tradizione rabbinica con la vocalizzazione e altri segni di lettura), accompagnato sempre dall’interlineare italiano, si appaia l’antica versione greca detta dei “Settanta”, anch’essa sostenuta dall’interlineare italiano; infine, in calce si offrono la versione latina dei Salmi - secondo la cosiddetta Neovulgata, elaborata sulla base della celebre Vulgata di s. Girolamo, dopo il Concilio Vaticano II - e naturalmente la citata traduzione CEI.
In sintesi, nei bifogli vivono in armonia e, in alcuni casi in contrappunto, i testi ebraico, greco, latino, italiano. È questa una via per venir incontro al desiderio di molti di avere un approccio diretto alle Scritture, scoprendone le matrici primigenie in modo accurato e filologico, un desiderio - e lo affermo per esperienza personale - che sboccia anche in molti “laici” che, pur non considerando la Bibbia un testo “ispirato” da Dio, sono consapevoli della sua realtà di “grande codice” della cultura occidentale.
Ovviamente questi sussidi linguistici sono fondamentali per la teologia e, attraverso essi, si spera di superare quel vuoto indotto da una scuola superiore sempre più incline a soffocare le radici umanistiche classiche, un vuoto che, conseguentemente, si ripercuote sulle stesse scuole teologiche i cui alunni sono spesso estranei al contatto coi testi originali sacri ed ecclesiali. La giovanissima carmelitana s. Teresa di Lisieux (1873-97), in un’epoca in cui gli studi teologici erano preclusi al mondo femminile, confessava: «Se io fossi stata prete, avrei studiato a fondo l’ebraico e il greco così da conoscere il pensiero divino come Dio si degnò di esprimerlo nel nostro linguaggio umano».
Per fortuna ora c’è un manipolo molto fitto e qualificato di teologhe ed esegete che possono, ad esempio, elaborare quel commentario ai quattro Vangeli pubblicato dall’editrice Ancora di Milano lo scorso anno (del quale abbiamo dato conto su queste pagine), accompagnandolo con la battuta “Le donne prendono la Parola” con evidente doppio senso... Inoltre si deve segnalare che paradossalmente questa fedeltà paziente e amorosa alla lettera è un antidoto al fondamentalismo letteralista, quello che san Paolo bollava con la frase lapidaria: «La lettera uccide, lo Spirito invece dà vita» (2 Corinzi 3,6).
Infatti, l’accurata definizione delle singole parole svela non solo la necessità di coordinarle in un contesto, ma ne mostra anche la molteplicità delle iridescenze semantiche che le versioni cercano di recuperare e, quindi, suggeriscono la necessità dell’interpretazione. Questo processo è ignorato dai movimenti fondamentalistici di ogni religione che usano le parole sacre come pietre avulse dal contesto e dalla loro complessità strutturale e le scagliano come aeroliti sacrali contro gli altri (talora anche in senso fisico e non solo metaforico).
Proprio per questo la collana “Doppio verso”, dopo aver puntato l’obiettivo sulle singole parole vedendole come cellule viventi di un textus, cioè di un tessuto di significati specifici che si aprono a un significato globale, propone la versione unitaria commentata, cioè interpretata nella sua totalità. Aveva ragione Victor Hugo quando dichiarava che le mot est un être vivant, una realtà vivente che non può essere scarnificata dal corpo in cui è inserita e non può essere isolata dalla vitalità che sparge attorno a sé. Infine, per stare ancora nell’orizzonte della letteratura francese, dobbiamo riconoscere che on a boulversé la terre avec des mots, come scriveva Alfred de Musset. Sì, attraverso le parole è stata ed è spesso sconvolta la terra e insanguinata la storia, come purtroppo sperimentiamo nella cronaca odierna; ma con la potenza delle parole si è anche trasformata, fecondata, trasfigurata la vicenda di tanti uomini, donne e popoli.
-
>CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE -- AMORE DI DIO ("CHARITY"): SANT’AGOSTINO AMATO DA BOB DYLAN.13 ottobre 2016, di Federico La Sala
-
>DIO E’ AMORE O MAMMONA?! - L’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO: IL MISTERO DEL SACRIFICIO. Così Feuerbach inventò il motto "L’uomo è ciò che mangia" (di Marino Niola)30 agosto 2016, di Federico La Sala
- LUDWIG FEUERBACH (Edgar H. Meyer) --- Se l’essere umano è per l’uomo l’essere sommo anche nella pratica la legge prima e suprema sarà l’amore dell’uomo per l’uomo. "Homo homini deus est": questo è il nuovo punto di vista, il supremo principio pratico che segnerà una svolta decisiva nella storia del mondo. (L’essenza del Cristianesimo).
- CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.
Così Feuerbach inventò il motto "L’uomo è ciò che mangia".
La frase più celebre del padre del materialismo tedesco fu ispirata da un trattato del fisiologo Jakob Moleschott. Che ora viene ripubblicato insieme a un saggio del filosofo in cui replica alle accuse degli idealisti.
di Marino Niola (la Repubblica, 23.08.2016)
«L’uomo è ciò che mangia». È l’aforisma sul cibo più citato di sempre. Al punto da diventare un tormentone. Non solo per noi, che siamo costretti a sorbircelo in tutte le salse e spesso a sproposito. Ma soprattutto per il suo autore, il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach, che passò tutta la vita a struggersi perché della sua poderosa opera non veniva ricordata che questa frase. E per di più al solo scopo di accusarlo di aver leso l’onorabilità del pensiero tedesco. Sporcando le astrazioni dell’idealismo con il suo materialismo che riduceva tutto a pappa e ciccia.
La frase incriminata compare per la prima volta in una recensione che Feuerbach dedica al Trattato dell’alimentazione per il popolo del medico e fisiologo olandese Jakob Moleschott, pubblicato in Germania nel 1850. Un’opera rivoluzionaria, perché fa della nutrizione il principio motore della storia umana. Ponendo il cibo all’origine della società, del pensiero, della religione e persino delle differenze culturali e di classe.
Il Trattato, tradotto in italiano nel 1871 da Giuseppe Bellucci per l’editore Treves di Milano, viene adesso ristampato da Volumnia Editrice (pagg. 171, euro 22) con un utilissimo apparato di testi di antropologi, nutrizionisti, scienziati. E con un bel saggio di Luciano Giacchè che ricostruisce mirabilmente il contesto della vicenda e ne mostra l’attualità, alla luce della cibomania contemporanea.
 Ma la vera chicca dell’edizione Volumnia è la riproposizione del saggio Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia, che Feuerbach scrive nel 1862, dodici anni dopo la sua discussa recensione, per rispondere agli attacchi che gli erano piovuti addosso. Il risultato è una magistrale ricapitolazione del materialismo feuerbachiano.
Ma la vera chicca dell’edizione Volumnia è la riproposizione del saggio Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia, che Feuerbach scrive nel 1862, dodici anni dopo la sua discussa recensione, per rispondere agli attacchi che gli erano piovuti addosso. Il risultato è una magistrale ricapitolazione del materialismo feuerbachiano.La forza dirompente del Trattato per Feuerbach sta nel fatto che fa da supporto a una nuova filosofia, dimostrando scientificamente che il pensiero comincia proprio dalla pancia e poi arriva alla testa. Ma l’autore va ancora più in là. E partendo dall’affermazione, decisamente positivista, di Moleschott secondo cui «senza fosforo non c’è pensiero» ci regala un’altra affermazione passata ormai nel senso comune. «Perché tu introduca qualcosa nella tua testa e nel tuo cuore è necessario che tu abbia messo qualcosa nello stomaco». Un missile contro quella filosofia che ha sempre messo le idee al principio di tutto, dimenticando che a produrle è il corpo. Come dire che è la materia a generare lo spirito e non il contrario.
Ma non si tratta di una semplice disputa filosofica. Quello che hanno a cuore sia il medico che il filosofo è la ricaduta sociale e politica delle loro affermazioni. Entrambi concordano sul fatto che alla base del progresso delle nazioni non sono certo le prediche, che disseminano la vita di principi, ma la giusta distribuzione del carburante. L’operaio inglese, spiegano, è più efficiente perché mangia meglio del popolano napoletano. Fra l’altro vale la pena di ricordare che Moleschott nel 1861 fu chiamato per chiara fama da Francesco De Sanctis, allora ministro della Pubblica istruzione del primo governo Cavour, alla cattedra di Fisiologia all’università di Torino e divenne anche senatore del Regno d’Italia.
Lungi dal tessere l’elogio della gola, i due fanno un discorso radicale che rimette in discussione il dualismo che divide l’uomo dall’altra parte di se stesso. Il corpo e la mente, l’anima e la carne. Per Feuerbach l’unità dell’essere umano sta proprio nell’alimentazione. Che è il trait d’union tra natura e cultura. E questo vale per gli uomini come per gli animali. E d’altra parte il Trattato di Moleschott inizia proprio constatando che se il nutrimento ha trasformato il gatto selvaggio in gatto domestico, da carnivoro a onnivoro, perché dovremmo stupirci se l’alimentazione influenza la natura dell’uomo e delle sue istituzioni? Compresa la religione: gli alimenti che gli uomini, di tutte le fedi, sacrificano da sempre sugli altari ne sono la prova.
Per Feuerbach, l’immortalità degli dei deriva dal fatto che, come racconta Omero, non si nutrono di pane e vino ma di cibi non umani come nettare e ambrosia, ovvero la materia stessa dell’immortalità. Insomma anche Dio è ciò che mangia.
E che mangiare e vivere siano la stessa cosa, per Feuerbach, sta scritto in parole come bios, che in greco antico significava vita, ma anche generi di sopravvivenza. E una traccia di questa familiarità rimane anche nel nostro vitto, dal latino victum, voce del verbo vivere. Ma anche in termini come viveri e vettovaglie, che hanno la stessa radice. Insomma se Feuerbach non avesse assimilato e digerito Moleschott probabilmente il suo pensiero non sarebbe stato lo stesso. Evidentemente anche il filosofo è ciò che mangia.
-
> DIO E’ AMORE O MAMMONA?! - Francesco di Assisi prima di Jobs. Furono i francescani del Medioevo a inventare la politica aziendale adottata oggi dai giganti globali.6 settembre 2016, di Federico La Sala
Pray Different, Francesco precursore di Steve Jobs
Dio e marketing
Francesco prima di Jobs
Furono i francescani del Medioevo a inventare la politica aziendale adottata oggi dai giganti globali
di ALESSANDRO BARBERO (La Stampa, 06.09.2016)
Immaginiamo una grande organizzazione multinazionale, conosciuta in tutto il mondo, fondata grazie allo slancio visionario di un giovane fondatore carismatico, che è diventato un mito già da vivo e ancor più dopo la morte; un’organizzazione riconoscibile anche visivamente per le sue scelte di comunicazione e per il look inconfondibile che la caratterizza.
Sto parlando della Apple e di Steve Jobs? No, sto parlando di san Francesco e dell’ordine francescano. Le analogie tra gli ordini religiosi del Medioevo e le grandi aziende odierne sono così vistose che viene da chiedersi se le strategie e il linguaggio delle multinazionali non si siano ispirati consapevolmente a quell’esperienza.
Oggi non c’è documento di marketing o manuale di comunicazione aziendale che non impieghi a ogni riga le parole vision e mission, che rivelano immediatamente la loro appartenenza al linguaggio dei frati e dei monaci. E d’altra parte, perché le aziende non dovrebbero ispirarsi a un modello di tale successo?
Dieci anni dopo che Francesco ebbe l’intuizione di fondare il suo ordine, i francescani erano già alcune migliaia, il che vuol dire che erano quasi raddoppiati ogni anno; per l’esattezza, si è calcolato un tasso di crescita dell’80% annuo. La conquista di nuovi mercati era gestita con campagne mirate: nati in Italia Centrale, dopo un po’ i francescani decidono di espandersi a Nord, e mandano apposite task force in Lombardia e in Germania, affidate a frati che sanno predicare nelle lingue straniere, «in lombardico et in theutonico».
Nel 1219 Francesco decide di mandare un gruppo di frati in Francia, per diffondere l’Ordine anche in quel regno; ven t’anni dopo sono già fondati qualcosa come 72 conventi.
Non stupisce che Francesco, a un certo punto, abbia aperto gli occhi e si sia accorto di aver creato un mostro: era a capo di una multinazionale, lui che voleva andare in giro scalzo con un gruppetto di amici, parlando di Gesù alla gente e scaricando casse al mercato per mantenersi. Negli ultimi anni di vita Francesco si dimise dalla guida dell’ordine, creando grossissimi problemi ai suoi successori, perché per l’immagine dell’organizzazione e la motivazione dei membri il mito del fondatore è essenziale.
Fra il Novecento e il Duemila i grandi fondatori di aziende, gli Henry Ford, i Bill Gates, gli Steve Jobs sono stati mitizzati in vita, e sono diventati delle leggende dopo la morte, grazie anche all’invenzione di quel peculiare genere letterario, la biografia autorizzata, erede diretto dell’agiografia medievale.
Il caso di Steve Jobs conferma che i visionari del Medioevo avevano ragione quando insistevano sull’importanza del look. La biografia autorizzata di Walter Isaacson ci svela che non era certo un caso se Jobs vestiva sempre uguale, jeans blu senza cintura e maglioncino nero a collo alto. Più volte il fondatore di Apple propose che tutti i dipendenti dell’azienda si vestissero allo stesso modo, ma i lavoratori non apprezzavano l’idea, e Jobs dovette accontentarsi di vestirsi lui così: nell’armadio aveva un centinaio di dolcevita neri, tutti uguali, e previde correttamente che gli sarebbero bastati per tutta la vita.
Francesco, invece, riuscì a imporre ai frati di vestirsi tutti allo stesso modo, con un saio bigio e un cappuccio a punta, da contadino; ma dopo la sua morte i francescani ebbero dei sai larghi e comodi, di ottima stoffa, e il cappuccio diventò ampio e arrotondato, come voleva la moda.
Grazie alle tecnologie moderne gli storici dell’arte hanno scoperto che diverse tavole col ritratto di San Francesco sono state modificate dopo la sua morte, cancellando l’odiato cappuccio a punta e sostituendolo con un cappuccio da giovanotto elegante.
Tutti sapevano che l’immediata riconoscibilità era un ingrediente del successo. Quando il monastero di Cîteaux cominciò a fare concorrenza a quello di Cluny, i cistercensi scoprirono che nella regola benedettina non stava scritto da nessuna parte di che colore doveva essere l’abito; per tradizione era nero, ma loro si vestirono di bianco, perché la gente doveva vedere la differenza.
Il mantello bianco era anche la prerogativa dei Templari, e quando un ordine concorrente, i Teutonici, volle adottarlo, i templari protestarono col papa, perché impedisse quella concorrenza sleale: il copyright era loro! Poi gli ordini militari ebbero il problema, comune a tante aziende, di una crisi di mercato che ridusse la domanda.
Dopo la perdita della Terrasanta e la fine delle crociate non c’era più un gran bisogno di monaci guerrieri. C’erano ben tre ordini militari, i Templari, gli Ospedalieri e i Teutonici, e sempre più voci si levavano contro questi enti inutili, che per la cristianità rappresentavano un passivo netto. Gli ordini reagirono presentando un progetto di fusione: così, argomentò il Gran Maestro del Tempio, si realizzeranno dei grossi risparmi, dove prima c’erano tre poltrone ne rimarrà una sola.
Ma l’antitrust intervenne: i sovrani europei fecero sapere al papa che non avevano nessuna voglia di trovarsi fra i piedi una multinazionale monopolistica e strapotente .
Alla fine, com’è noto, Filippo il Bello risolse a modo suo il problema della ridondanza dei templari; ma i loro rivali , gli Ospedalieri , esistono ancora, col nome di Ordine di Malta. E a questo proposito, ci sono due organizzazioni che recentemente hanno lanciato un progetto chiamato Vision 2050.
Sono progetti che non hanno niente in comune, ma sono stati chiamati nello stesso modo per caso da manager che condividono lo stesso tipo di linguaggio.
Una è il Wbcsd, organizzazione che riunisce circa 200 multinazionali , e che col progetto Vision 2000 si propone di guidare la « global business community» verso un futuro sostenibile. L’altra è appunto l’Ordine di Malta, che col progetto Vision 2000 si propone di reclutare giovani e finanziare iniziative fino alla metà del secolo. Così una potentissima associazione di multinazionali, fondata nel 1992, con sede a Ginevra, e l’Ordine di Malta, il vecchio concorrente dei Templari, che nel suo sito ufficiale dichiara di essere in attività dal 1048, usano lo stesso linguaggio ; ed è molto difficile decidere chi è che sta imitando l’altro.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! -- Benessere o non essere, questo è il problema (Marino Niola)31 luglio 2016, di Federico La Sala
La parola presente /4
BENESSERE. Equilibrio, ricchezza e salute, così è cambiata la "buona vita".
Se la religione dei corpi riduce l’uomo a merce
di Marino Niola (la Repubblica, 25.07.2016)
Well be or not to be. Benessere o non essere, questo è il problema. Il dilemma del nostro tempo che ha sciolto il dubbio amletico e lo ha trasformato in imperativo cosmetico. Estetico, dietetico, terapeutico. Dopo averne fatto a lungo un mantra economico. Ma in entrambi i casi, sia che si tratti della salute del nostro corpo, sia che si tratti della salute delle nostre finanze, resta il fatto che la parola benessere ormai riguarda sempre più l’avere e sempre meno l’essere.
Con un avvitamento della lingua che riflette una metamorfosi del senso comune e dei suoi valori di riferimento. Che prendono un’accezione sempre più materiale, legando la soddisfazione, l’autostima, l’equilibrio personale, la realizzazione di sé, il proprio riconoscimento da parte degli altri, a qualcosa che si possiede. Fino a poco tempo fa era un reddito soddisfacente, adesso è un corpo efficiente. Un passaggio che nell’inglese è scritto a chiare lettere nella stretta parentela tra wealth, ricchezza, e health, salute. Mentre l’italiano chiama entrambe benessere. Con uno slittamento interno del significato che però non affiora alla superficie del vocabolario. Ne è la prova il fatto che non si sente il bisogno di creare due termini distinti.
In realtà il termine benessere finisce per riepilogare i valori, le aspettative, le proiezioni che in ogni epoca compongono gli algoritmi della buona vita. Per gli antichi si tratta di parametri spirituali, che hanno a che fare poco con la ricchezza, un po’ più con la salute, e molto con l’equilibrio. Che è alla base di una buona disposizione dell’animo. Platone la chiama eufrosine, cioè letizia, che è anche il nome di una delle tre Grazie, divinità dispensatrici di splendore, di bellezza e di prosperità. Peraltro il termine grazia è molto imparentato con la gratuità, il disinteresse, l’armonia, la giustizia. Lo dice il nome greco delle Grazie che è Cariti, da charis che significa dono, un concetto storicamente legato alla nostra idea di carità.
E dunque il benessere non dipende dalla ricchezza. Ancor più chiaro in questo senso è Aristotele, che esclude categoricamente il possesso e il successo. Perché lo star bene degli uomini non consiste semplicemente in un soddisfacimento dei desideri e dei bisogni materiali, ma nel controllo razionale delle passioni e delle pulsioni. Che è condizione dell’equilibrio individuale e dell’equità sociale. Ma il filosofo della catarsi si spinge ancora oltre e, con un ragionamento che oggi definiremmo antiutilitaristico, arriva addirittura a separare la crematistica, la scienza che riguarda l’acquisto e la gestione della ricchezza, dall’economia.
Quest’ultima, infatti, insegna come soddisfare i bisogni primari e vivere bene in mezzo agli altri, mentre la crematistica, che mira a quella che adesso chiameremmo l’accumulazione del capitale, è artificiale e in un certo senso antisociale. Insomma, per l’autore dell’Etica Nicomachea, il benessere è di natura essenzialmente relazionale, nel senso che il rapporto con gli altri costituisce un bene in sé. È il fine e non il mezzo dell’economia.
Una posizione declinata al presente da una filosofa come Marta Nussbaum, non a caso definita neoaristotelica. L’autrice di Non per profitto ritiene infatti che una delle cause del declino attuale della democrazia sia l’utilitarismo spinto all’estremo che riduce l’uomo a merce, il sapere a tecnica, la bellezza a dogma, la salute a obbligo. E il benessere a Pil. Che, naturalmente, per mantenersi su livelli elevati ha bisogno di lavoratori in piena forma, di macchine corporee senza difetti. Efficienti, performanti, scintillanti. È l’avvento degli “ultimi uomini”, per dirla con lo Zaratustra di Nietzsche, quelli che credono di avere inventato la felicità, che vivono sempre più a lungo, e per i quali ammalarsi è peccato.
Ed è proprio questo scivolamento della persona verso la risorsa umana, del well-being verso il well-ness, della comunità verso l’immunità, alla base della svolta biopolitica che stiamo vivendo. Dove gli uomini diventano energie rinnovabili e quindi anche rimpiazzabili. Del resto proprio questo vuol dire risorsa, dal francese resortir, nel senso di rinascere, rinnovarsi. È l’umano al servizio dello sviluppo e non lo sviluppo al servizio dell’umano.
Una critica in ipsis verbis di questo pensiero unico della crescita si trova in un apparente lapsus degli studenti della South-Pacific University di Suva, nelle isole Figi, che hanno trascritto in pidgin-english (la lingua franca di alcune aree del Pacifico), il termine development, sviluppo, facendolo diventare develop-men, ovvero piena realizzazione dell’umano. Così quello che sembrava un errore di spelling si rivela invece una straordinaria retroilluminazione della parola. Che fa brillare un altro senso possibile, a condizione di pensare altrimenti.
Oggi l’asse del benessere si è ulteriormente e decisamente spostato. Da richness a fitness. Col risultato di trasformare i nostri stili di vita in religioni del corpo, in idolatrie della longevità, in liturgie alimentari. Con il bio al posto del dio. E la dietetica al posto dell’etica. E, quasi inavvertitamente, siamo entrati nell’era di homo dieteticus, il figlio spaventato di homo oeconomicus. Quest’ultimo, spinto in avanti dal vento del progresso e convinto che le cose sarebbero andate sempre meglio, per sé e per i suoi, investiva sul futuro.
Mentre l’homo dieteticus, in preda a mille insicurezze, personali, ambientali, lavorative, sta facendo della salute il bene rifugio su cui scommettere tutto e subito, il capitale immunitario al quale destinare tempo, cure, energie e risorse. Passione e ossessione. Narcisismo ed esorcismo. Ideologia e ipocondria.
Forse perché non ci è rimasto altro da scambiare e da vendere nel mercato della forza lavoro globale, se non la nostra apparenza e la nostra efficienza. Ridotti come siamo a braccianti multitasking, cottimisti del tardo capitalismo, falangi della mano invisibile.
Così il corpo torna ad essere, come diceva Baudelaire, l’arcano della merce, la forma elementare dell’economia. E il benessere diventa l’algoritmo di una condizione umana ridotta a nuda vita.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
FILOLOGIA, ARTE, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA. "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-16). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettereL’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
-
> CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- "Teste David cum Sibylla": Michelangelo, Mozart, e la "carità".18 luglio 2016, di Federico La Sala
Teste David cum Sibylla
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
MOZART, Requiem (K 626):
DIES IRAE (Coro)
- "Dies irae, dies illa,
 Solvet saeclum in favilla,
Solvet saeclum in favilla,
 Teste David cum Sibylla.
Teste David cum Sibylla.
- Quantus tremor est futurus,
 Quando Judex est venturus,
Quando Judex est venturus,
 Cuncta stricte discussurus!"
Cuncta stricte discussurus!"
- "Giorno d’ira, quel giorno
 distruggerà il mondo in faville,
distruggerà il mondo in faville,
 com’è attestato da Davide e dalla Sibilla.
com’è attestato da Davide e dalla Sibilla.
- Quanto grande sarà il terrore quando verrà il giudice
 a valutare ogni cosa severamente."
a valutare ogni cosa severamente."
MOZART,
(dal "Requiem")
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
-
> CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- «L’Eucaristia è il centro e la forma della vita della Chiesa» (Papa Francesco)28 maggio 2016, di Federico La Sala
«L’Eucaristia è il centro e la forma della vita della Chiesa» Papa Francesco:
L’EUCARISTIA (E LA "CARESTIA" DELLA CHIESA DEL "LATINORUM"): UN DOPPIO SCANDALO.
-
> CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- #Latino e greco (di Gianfranco Ravasi - Breviario)29 maggio 2016, di Federico La Sala
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- CANOVA E IL VATICANO: LE GRAZIE, AMORE E PSICHE Una gerarchia senza Grazie (greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Caritas"). Materiali per riflettere
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. (fls)
Breviario
#Latino e greco
di Gianfranco Ravasi s.j. (Il Sole-24 Ore, Domenica, 29.05.2016
- «Non si impara il latino e il greco per parlarli, per fare i camerieri, gli interpreti, i corrispondenti commerciali. Si impara per conoscere direttamente la civiltà dei due popoli, presupposto necessario della civiltà moderna, cioè per essere se stessi e conoscere se stessi consapevolmente».
Tra le mie varie funzioni presso la Santa Sede c’è quella di tutelare la Pontificia Accademia di Latinità, un’istituzione che coopta i maggiori studiosi di questa lingua. Ho, in tal modo, scoperto quanto forte - soprattutto all’estero - sia la passione per una cultura così alta che continua a vivere proprio attraverso la sua eredità. Agli italiani, e in primis alla scuola che invece la snobba, vorrei semplicemente ricordare le righe sopra citate che non hanno bisogno di commento, ma solo di riflessione. Non le ha scritte un vecchio precettore, ma Antonio Gramsci nel 1932, nei suoi Quaderni dal carcere, per ammonirci che chi non conosce il proprio passato non riesce a vivere il suo presente in modo vero ed efficace.
-
-
> CARDINAL RAVASI --- IL CORTILE DEI GENTILI. Logos e trascendenza nell’Islam, dopo il Discorso di Ratisbona (di Massimo Campanini)23 maggio 2016, di Federico La Sala
- Per l’inizio del dialogo, quello vero (B. Spinelli)
 ITALIA E PAKISTAN: LA DIVINA COMMEDIA (Dante Alighieri) E IL POEMA CELESTE (Muhammad Iqbal). Ri-leggiamo insieme... le due opere e i due Autori!
ITALIA E PAKISTAN: LA DIVINA COMMEDIA (Dante Alighieri) E IL POEMA CELESTE (Muhammad Iqbal). Ri-leggiamo insieme... le due opere e i due Autori!
- IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITA’ E RICONCILIAZIONE. PENSARE UN ALTRO ABRAMO.
Logos e trascendenza nell’Islam, dopo il Discorso di Ratisbona
di Massimo Campanini*.
Cristianesimo e Islam sono religioni che derivano dal medesimo ceppo abramitico. Condividono molti concetti teologici e religiosi, ma anche si differenziano in molti altri. Il confronto comparativo tra le due teologie è un esercizio ermeneutico mai abbastanza praticato. Il controverso discorso di papa Benedetto XVI a Regensburg nel 2006, di cui appunto nel 2016 ricorre il decennale, ha vigorosamente sostenuto la fondazione della teologia cristiana nel Logos, mentre al riguardo l’Islam professa un approccio sostanzialmente divergente, nonostante alcune convergenze. Questo articolo è dedicato a puntualizzare criticamente questa osservazione. Partiamo col considerare un paio di premesse.
La frattura del monoteismo rispetto alle religioni del mondo antico, soprattutto mediterraneo, è consistita in almeno due elementi qualificanti. In primo luogo, nella rivelazione di un Dio persona, liberamente agente e volente, che conferisce all’universo le sue leggi di funzionamento e dirige la storia verso un fine teleologico. In secondo luogo, nel proporre il messaggio religioso attraverso l’invio di profeti, apportatori di libri rivelati.
 L’Islam, ultimo in ordine cronologico dei tre monoteismi, conferma e riafferma comunque questi due pilastri teologici fondativi, ma per quanto riguarda Dio, ne accentua il carattere di sovrano del mondo (Dio è sia malik cioè re, sia mālik cioè padrone dell’universo) e il carattere della trascendenza (tanzīh).
L’Islam, ultimo in ordine cronologico dei tre monoteismi, conferma e riafferma comunque questi due pilastri teologici fondativi, ma per quanto riguarda Dio, ne accentua il carattere di sovrano del mondo (Dio è sia malik cioè re, sia mālik cioè padrone dell’universo) e il carattere della trascendenza (tanzīh).
 Per quanto riguarda la profezia, l’Islam, come l’Ebraismo e il Cristianesimo, riconosce sostanzialmente al profeta un ruolo di testimonianza, di annunciazione di (liete) novelle, di ammonizione. In tal senso, si tratta di una funzione eminentemente dialogica e non è un caso - relativamente all’Islam - che un filosofo come al-Farabi abbia individuato realizzata nel profeta la massima perfezione della facoltà immaginativa utile a persuadere e a guidare le masse. Naturalmente, nell’Ebraismo e nell’Islam il profeta può essere anche apportatore della Legge, qualifica che nel Cristianesimo è andata perduta.
Per quanto riguarda la profezia, l’Islam, come l’Ebraismo e il Cristianesimo, riconosce sostanzialmente al profeta un ruolo di testimonianza, di annunciazione di (liete) novelle, di ammonizione. In tal senso, si tratta di una funzione eminentemente dialogica e non è un caso - relativamente all’Islam - che un filosofo come al-Farabi abbia individuato realizzata nel profeta la massima perfezione della facoltà immaginativa utile a persuadere e a guidare le masse. Naturalmente, nell’Ebraismo e nell’Islam il profeta può essere anche apportatore della Legge, qualifica che nel Cristianesimo è andata perduta.Quanto al concetto di Logos, prima di essere assimilato dalla teologia cristiana, a partire dal famoso incipit del Vangelo di Giovanni, esso è stato formulato nell’ambito della filosofia greca. Anassagora ed Eraclito hanno teorizzato il Nous (o intelletto) e il Logos come principi di ordinamento e organizzazione della realtà cosmica. Socrate ha enfatizzato il carattere dialogico del Logos come strumento di comunicazione, ma anche di educazione degli uomini. Anche Platone ha posto il Logos al centro della sua filosofia, come dialogo umano, nella pluralità delle opinioni e delle idee che si confrontano nell’arena filosofica in uno stile di pensiero aperto e flessibile. Il concetto greco di Logos sembra perciò intersecare aspetti antropologici con aspetti cosmici relativi a una potenziale “mente” o ratio che governa il reale.
Stabilite queste premesse, un discorso comparativo sull’idea di Logos nella teologia cristiana e in quella musulmana può svolgersi su due livelli: il livello dell’esegesi testuale dei libri sacri e il livello dell’elaborazione teologica. Si tratta, dal mio punto di vista, eminentemente di chiarire la posizione musulmana che appare non solo meno nota, ma anche più controversa. [...]
*
Lo speciale “Quel che resta di Ratisbona” è a cura di Gabriele Palasciano.
*Massimo Campanini (1954), orientalista e islamologo italiano, ha studiato filosofia e lingua araba. Ha insegnato nelle Università di Urbino, Milano e Napoli L’Orientale e attualmente è professore associato di studi islamici all’università di Trento. Ha pubblicato oltre 100 articoli e 33 monografie, tra cui cinque sul Corano: la traduzione commentata delle sure 12 e 18, la traduzione delle Perle del Corano di al-Ghazali e in inglese The Qur’an the Basics (Routledge) e The Qur’an: modern muslim interpretations (Routledge).
* IL CORTILE DEI GENTILI. Il dialogo tra credenti e non credenti, 23.05.2016
- Per l’inizio del dialogo, quello vero (B. Spinelli)
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- La sostenibilità cristiana - la «lectio magistralis» in occasione del «Cortile dell’incontro» (di G. Ravasi)3 aprile 2016, di Federico La Sala
Le sfide del nostro tempo
La sostenibilità cristiana
La Bibbia ci insegna che siamo fatti di terra e che la terra è stata data all’uomo perché la coltivasse e la custodisse. Le encicliche di Benedetto XVI e Francesco indicano la strada
di Gianfranco Ravasi s.j. (Il Sole-24 Ore, Domenica, 03.04.16)
- Questo articolo è la «lectio magistralis» che il cardinal Ravasi terrà venerdì 8 aprile all’Università Cattolica di Rio de Janeiro in occasione del «Cortile dell’incontro».
È un vocabolo che è divenuto quasi un’insegna dei nostri giorni, fino a trasformarsi purtroppo in uno stereotipo che riempie le bocche ma lascia indifferenti le mani e, quindi, l’impegno. Stiamo parlando della cosiddetta sostenibilità, un termine spesso ripetuto e declinato in varie forme (indice, codice, bilancio di sostenibilità) e che, però, registra all’opposto un dato talora drammatico, quello dello sfruttamento insensato ed egoistico dei beni che Dio ha destinato universalmente all’umanità e che, invece, vengono o accaparrati solo da alcuni o sprecati insensatamente (si pensi solo all’acqua!) o feriti attraverso l’inquinamento e la devastazione ambientale.
Proprio in apertura alla Bibbia, nelle pagine dedicate alla creazione, ci sono due asserti fondamentali. Il primo è quello che - a differenza della cultura greca - riconosce il rilievo che la materialità ha anche per la creatura umana: «Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e così divenne un essere vivente» (Genesi 2,7). Alla fine della sua esistenza l’uomo «ritorna alla polvere della terra e il soffio vitale ritorna a Dio che lo ha dato» (Qohelet 12,7), «poiché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai» (Genesi 3,19). Tra la terra e l’umanità c’è, dunque, una radicale sororità, una parentela stretta che, però, spesso dimentichiamo e violiamo.
Il secondo asserto indica un altro aspetto che ci distingue dalla materialità. Il Creatore, infatti, impone questo impegno all’uomo e alla donna: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra» (Genesi 1,28). La creatura umana riceve da Dio una dignità di sovranità delegata sul creato. In realtà, i due verbi ebraici usati contengono un significato più sfumato e persino suggestivo: kabash - “soggiogare” originariamente rimanda all’insediamento in un territorio che dev’essere esplorato e conquistato, mentre radah - “dominare” è il verbo del pastore che guida il suo gregge.
Si tratta, certo, di un primato che purtroppo l’uomo spesso ha esercitato in modo tirannico e non come un compito, che è specificato da un ulteriore dettato del Creatore così formulato: «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e custodisse» (Genesi 2,15). È interessante notare anche in questo caso che l’attività propria dell’umanità è espressa con due verbi ebraici - ’abad e shamar - che contengono un duplice significato. Il primo è quello esplicito dell’operare, trasformare, investigare e tutelare le potenzialità della natura attraverso l’attività lavorativa e scientifica. Il secondo aspetto è nel fatto che i due verbi indicano anche il “servire” cultuale e l’“osservare” la legge divina, due componenti fondamentali dell’alleanza tra il Signore e Israele.
C’è, dunque, una sorta di alleanza primaria “naturale” tra il Creatore e l’umanità che si esprime nella tutela e nella trasformazione del creato. Un patto che spesso l’uomo infrange, devastando e occupando brutalmente la terra. È suggestiva una parabola araba che si muove proprio in questa linea. «All’inizio il mondo era un giardino fiorito. Dio, creando l’uomo, gli disse: Ogni volta che compirai un’azione cattiva, io farò cadere sulla terra un granello di sabbia. Gli uomini non ci fecero caso. Che cosa avrebbero significato cento, mille granelli di sabbia in un immenso giardino fiorito? Passarono gli anni e i peccati degli uomini aumentavano; torrenti di sabbia invasero il mondo. Nacquero così i deserti, che di giorno in giorno diventarono sempre più grandi. E Dio continua ancor oggi ad ammonire gli uomini dicendo loro: Non riducete il mio giardino fiorito in un immenso deserto!».
Questa amara parabola dipinge in modo illuminante la crisi del pianeta. Per fortuna, un rigurgito di pentimento e rimorso sta emergendo proprio sotto i termini di ecologia e sostenibilità, temi che sono stati finalmente messi in agenda non solo dalla Chiesa attraverso l’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI e la Laudato si’ di papa Francesco, ma anche dagli Stati, dagli organismi internazionali e dalle stesse strutture economiche. A metà degli anni Settanta, attraverso un rapporto dell’allora Segretario Generale dell’ONU, Dag Hammarskjöld, si iniziò a sottoporre a critica il modello di sviluppo dominante. Fu, però, solo nel 1987 che la “Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo” (nota come “Commissione Brundtland”) definì in modo chiaro e ampio il concetto e il programma di sviluppo sostenibile, come «processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano coerenti coi bisogni futuri e non solo con gli attuali».
In quel testo si introducevano anche elementi etici e sociali per una «effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale e una maggior democrazia a livello di scelte internazionali», così che si potessero «soddisfare i bisogni fondamentali di tutti ed estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni a una vita migliore». In questa linea, nel dicembre 2002, l’assemblea generale dell’ONU proclamò l’arco 2005-2014 come il “Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile”. Fondamentale - a livello socio-culturale generale - è far comprendere che la sostenibilità è uno dei diritti umani capitali. È noto, infatti, che ormai si è soliti elencare quattro “generazioni” di diritti.
I diritti di “prima generazione” sono quelli civili e politici (vita, dignità personale, libertà). Diritti di “seconda generazione” sono quelli economici, sociali, culturali descritti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), come salute, lavoro, istruzione e così via. Di “terza generazione” sono i diritti di solidarietà riguardanti soprattutto i soggetti più vulnerabili: pace, equilibrio ecologico, difesa ambientale e delle risorse nazionali, autodeterminazione dei popoli. Infine, alla “quarta generazione” appartengono i nuovi diritti relativi al campo delle manipolazioni genetiche, della bioetica e delle nuove tecnologie di comunicazione. È, dunque, importante inquadrare la sostenibilità nell’orizzonte più vasto della dignità umana, della morale sociale e degli stessi principi religiosi.
È ciò che è ribadito a più riprese nell’enciclica Laudato si’ che per almeno una dozzina di volta usa la terminologia “sostenibile/sostenibilità”. Papa Francesco lo fa partendo dalla Carta della Terra promulgata a L’Aja il 29 giugno 2000: «Come mai prima d’ora nella storia, il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio [...]. Possa la nostra epoca essere ricordata per il risveglio di una nuova riverenza per la vita, per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità, per l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace, e per la gioiosa celebrazione della vita» (n. 207). Per questo «la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale» (n. 13).
Certo, il Papa è consapevole dei rischi che l’uso scontato e abitudinario del termine “sostenibilità”, come abbiamo già sottolineato in apertura, e lo stesso «discorso della crescita sostenibile possa diventare spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe valori del discorso ecologista all’interno della logica della finanza e della tecnocrazia» (n. 194). Per questo, è necessario sollecitare «una creatività capace di far fiorire nuovamente la nobiltà dell’essere umano, perché è più dignitoso usare l’intelligenza, con audacia e responsabilità, per trovare forme di sviluppo sostenibile ed equo, nel quadro di una concezione più ampia della qualità della vita» (n. 192).
Siamo partiti con la visione genesiaca della creazione; l’abbiamo riletta anche attraverso la concezione musulmana e abbiamo introdotto l’impegno che la Chiesa cattolica propone ai cristiani e anche a tutti gli uomini di buona volontà. Concludiamo questa considerazione essenziale sul nesso tra etica, teologia e sostenibilità, con una parabola moderna che è evocata dal filosofo Martin Heidegger in una delle sue opere più rilevanti, Essere e tempo (1927). Essa è la ricreazione libera di elementi mitici greci. Protagonista è una dea dal nome emblematico di “Cura”, sinonimo del nostro vocabolo “Sostenibilità”.
Attraversando un fiume, essa raccolse il fango della sponda e plasmò una figura umana. Giove le infuse lo spirito e la rese una creatura vivente. Cura e Giove si misero a litigare su chi avesse il diritto di imporre il nome e, quindi, il diritto di proprietà sulla persona umana. A questo punto reclamò il suo potere anche la dea Terra da cui quell’essere era stato tratto. I tre ricorsero a Saturno, il dio giudice che emise questa sentenza: «Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito. Tu, Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma finché la creatura umana vivrà, sarà sotto la tutela e la giurisdizione di Cura». Ecco perché la sostenibilità deve essere una sorta di grande protettrice che veglia sull’umanità, sulla sua storia e sulla sua evoluzione.
-
> SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. -- in Vaticano, Seminario di Confindustria. Fare impresa per creare valori (di Gianfranco Ravasi)..24 febbraio 2016, di Federico La Sala
- CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA. Tutti a scuola in Vaticano, per aggiornamenti. Materiali per approfondire
L’Industria incontra il Santo Padre
Il prossimo 26 febbraio, in Vaticano nel Centro congressi Augustinianum, è in programma il Seminario di Confindustria «Fare insieme»
Fare impresa per creare valori
Il prossimo 26 febbraio, in Vaticano nel Centro congressi Augustinianum, è in programma il Seminario di Confindustria «Fare insieme»
di Gianfranco Ravasii (Il Sole-24 Ore, 24 febbraio 2016)
«Viviamo in un’epoca in cui alla bulimia dei mezzi corrisponde l’atrofia dei fini». Lapidaria ma incontestabile, questa asserzione del filosofo francese Paul Ricoeur delinea uno dei rischi maggiori della società contemporanea. Da un lato, infatti, mai come oggi abbiamo a disposizione un paniere sterminato di informazioni e di dati attraverso la comunicazione digitale. Mai come ora la scienza, accompagnata dalla tecnologia, ci offre una strumentazione efficace nella ricerca fisica, medica, industriale. Mai come in questo tempo la finanza stende una rete, spesso impalpabile, avvolgendo e talora strangolando il nostro globo. Mai come ai nostri giorni le distanze s’accorciano e persino svaniscono, permettendo un rimescolamento di etnie e culture.
D’altro lato, però, a questa indubbia e pur importante “bulimia” operativa corrisponde un’anoressia di valori, di interiorità, di significato, di etica. La massa delle risposte strumentali non riesce a evadere le domande esistenziali che, purtroppo, si affievoliscono nelle coscienze fino a estinguersi. Un altro filosofo, il danese Soeren Kierkegaard, già nell’Ottocento rappresentava simbolicamente questa situazione: «La nave è in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani».
L’apparente ottimismo versato a piene mani dalla scienza e dalla comunicazione di massa non riesce, comunque, a nascondere il groviglio di contraddizioni in cui ci dibattiamo. Il sudario di sangue delle guerre, la disperazione degli esodi di massa, la devastazione ambientale, il colossale divario tra ricchi e poveri, l’anelito dei popoli affamati, le ingiustizie sociali sempre più marcate, l’impennata della disoccupazione, gli squilibri culturali, i fondamentalismi religiosi continuano, infatti, ad artigliare le coscienze e le esistenze personali e comunitarie, distratte e superficiali, e riescono a interpellare tutta la piramide della società, dal vertice politico ed economico fino alla base popolare.
Per questo l’impresa italiana ha voluto consacrare una giornata di studio e di testimonianza nel tentativo di risvegliare e rinvigorire l’impegno comune ad opporsi a questa turbolenza che agita il nostro pianeta sempre più globalizzato eppure altrettanto frazionato. Gli imperativi per edificare un ethos comune che affronti questo orizzonte complesso e complicato sono quelli di sempre ma devono essere declinati con nuovi accenti, liberandoli dagli stereotipi vagamente moraleggianti: la giustizia, la libertà, la dignità della persona, la solidarietà, la conoscenza e l’istruzione, la responsabilità e i diritti individuali e sociali, il lavoro, la fede autentica e la morale. Queste e altre parole di vita sono state annodate sotto un denominatore comune che ha dato il titolo al convegno, il fare insieme.
Ora, questo verbo, che in quasi tutte le civiltà è il più generico per classificare ogni tipologia di azione, nella nostra lingua è basato su una radice indoeuropea che significa “mettere, fondare, posare” e rimanda quindi a una costruzione. Il verbo “fare” è, poi, contenuto in molti altri termini italiani, tra i quali brillano l’“affetto” e il “difetto”.
Sono un po’ i due volti estremi del “fare”, quello luminoso e appassionato della dedizione e quello del limite e dell’imperfezione: le mani che operano possono, infatti, stringersi e procedere “insieme”, ma possono anche rinchiudersi a pugni. Ecco perché è necessario coniugare il verbo “fare” con l’avverbio “insieme” che ha etimologicamente alla base l’aggettivo “simile”. È, quindi, la riscoperta della comune umanità e fraternità, l’essere tutti “figli di Adamo”, prima che essere segnati da altri connotati etnici, storici, culturali e sociali.
Dobbiamo ribadire, come suggeriva un altro filosofo francese, Emmanuel Lévinas, l’importanza del volto, dello sguardo reciproco, del dialogo. Visto da lontano un altro può sembrarci una bestia o un predatore; di fronte rivela, invece, quella costante umanità che tutti ci unisce per cui, come dice un proverbio orientale, il boia non guarda mai negli occhi la sua vittima. Ora, nel “fare”, un aspetto capitale è certamente quello del lavoro. Lo afferma in modo radicale la stessa Bibbia, che è pur sempre “il grande codice” della nostra civiltà occidentale: «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse» (Genesi 2,15).
Certo, come diceva Pavese, «lavorare stanca»: non per nulla il latino labor, da cui deriva il nostro “lavoro”, significa “fatica” e “dolore”, e in francese e spagnolo il “lavoro” è travail e trabajo. Tuttavia l’uomo che è inerte o paralizzato o disoccupato sente una ferita nell’anima. Per questo “fare insieme” è costruire un mondo diverso nella giustizia e nella fraternità ma è anche creare concretamente le condizioni perché tutti possano operare con le loro mani e la mente, “coltivare e custodire” il mondo e sviluppare la loro stessa esistenza personale e sociale. Per questo affidiamo l’ultima considerazione a Primo Levi, uno scrittore che al lavoro operaio ha dedicato un romanzo dal titolo emblematico, La chiave a stella (1978), e che così ci esorta: «Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione della felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti conoscono».
-
>CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? - DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Bibbia e «Lectio Divina»: «Che cosa dobbiamo fare?» (di G. Ravasi)18 gennaio 2016, di Federico La Sala
- EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI")
- EVANGELO ED EVANGELIZZAZIONE. Perché Gesù parlava in parabole? Dietro la domanda, una questione attualissima e gravissima .. CARLO M. MARTINI E IL PROBLEMA DEL "DIRE DIO" OGGI
Bibbia e «Lectio Divina»
Oggi Papa Francesco è in visita alla Sinagoga di Roma. Le Sacre scritture ebraico-cristiane testimoniano la vivacità del dialogo interreligioso
di Gianfranco Ravasii, cardinale (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.01.2016)
- La Sacra Bibbia. Nuova Traduzione CEI con Lectio Divina, Società Biblica Britannica e Forestiera (www.societabiblica.eu), Roma, pagg. 2072, € 50,00
- I libri della Bibbia. Nuovo Testamento. Lectio Divina in famiglia, Fundación Ramón Pané (www.fundacionpane.org), pagg. 528, s.i.p.
In questa domenica in cui - sulla scia di s. Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI - papa Francesco è accolto nella Sinagoga di Roma dalla comunità ebraica romana, e alle soglie della tradizionale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, torniamo a parlare di Bibbia. Se dovessi tener conto di tutti i libri di esegesi, di teologia, di commento e di spiritualità biblica pubblicati dagli editori italiani, sarei costretto a proporre continuamente semplici sillogi con qualche nota, tanto è fitto questo genere di produzione bibliografica.
Eppure ci fu un tempo in cui si introduceva in Italia la Bibbia clandestinamente, come accadeva fino a pochi decenni fa col regime sovietico. Certo, si trattava di edizioni protestanti che partivano da Londra o dalle basi inglesi di Malta e Gibilterra. A capo di questa operazione furtiva c’era la londinese British and Foreign Bible Society , fondata nel 1804. Questa operazione aveva allertato soprattutto lo Stato pontificio che aveva fatto piovere su di essa le sue condanne, a partire dal 1824 fino a un intervento solenne attraverso l’enciclica Inter praecipuas machinationes (e il titolo è emblematico) emanata nel 1844 da papa Gregorio XVI Cappellari, a cui si aggiunse nel 1846 anche Pio IX con un suo divieto.
Questa premessa, che potrebbe essere cronologicamente ben più ampia e che però meriterebbe una corretta contestualizzazione storico-ermeneutica, ci fa comprendere quanto sia significativo il fatto che ora vogliamo presentare. Certo, dopo Porta Pia e il 1870, anche la citata Bible Society era entrata in Italia divenendo, prima la Società Biblica Italiana e poi la Società Biblica Britannica e Forestiera, sostenuta dalla chiesa valdese.
Intanto, però, si celebrava il Concilio Vaticano II e un pastore valdese di grande apertura ecumenica e finezza culturale, Renzo Bertalot (1929?2015) gettava un ponte di collaborazione tra la Società Biblica e la Chiesa cattolica. Così, essa - oltre a pubblicare la famosa Bibbia tradotta dal protestante Giovanni Diodati nel Seicento e rivista da Giovanni Luzzi per adattarla al nuovo linguaggio - proponeva di concerto con l’editrice salesiana Elledici una suggestiva Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente dal successo folgorante.
Ma rimaneva sempre una certa distanza tra le due Chiese, la valdese e la cattolica, per quanto riguardava il testo biblico ufficiale: come è noto, infatti, la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) aveva pubblicato dal 1974 una sua Sacra Bibbia, rielaborata accuratamente nel 2002 e definitivamente proposta in una nuova edizione nel 2007.
Ebbene, ora la Società Biblica Britannica e Forestiera che ha sede a Roma ha deciso di proporre essa stessa proprio questa versione ufficiale della Cei in un volume raffinato ma anche maneggevole e funzionale, accogliendo perciò anche quei sette libri biblici anticotestamentari detti “deuterocanonici” dai cattolici e considerati “apocrifi” dai protestanti.
Si tratta, quindi, di un atto ecumenico molto incisivo perché ribadisce che il cuore dell’incontro tra le diverse confessioni cristiane deve alimentarsi proprio col sangue vivo della Parola divina. Perciò quei cattolici o protestanti, non ancora in possesso di un’edizione della Bibbia che non sia da scaffale ma da tenere tra le mani per la lettura, hanno ora una nuova possibilità comune.
Ma c’è qualcosa di più. Oltre all’integrale testuale a cui opra accennavamo (cioè con l’aggiunta dei sette libri “deuterocanonici” Tobia, Giuditta 1 e 2 Maccabei, Sapienza, Siracide, Baruc) e all’apparato di introduzioni e note, è stata offerta in finale una componente sorprendente, per di più sostenuta da una citazione di papa Francesco. Si tratta di una guida a un particolare approccio alla S. Scrittura, codificato nel Medioevo monastico e caro al mondo cattolico. È la così detta Lectio divina, in pratica una lettura spirituale ed esistenziale della Bibbia.
A elaborarne il metodo fu un monaco del XII secolo, Guigo il Certosino, che lo articolò in quattro tappe o scansioni. Innanzitutto si ha la Lectio vera e propria, cioè la lettura con l’identificazione corretta del messaggio del testo sacro secondo i canoni dell’esegesi. Segue la meditatio, ossia l’incarnazione dell’oggi della parola divina per la vita del credente. Se la prima tappa risponde alla domanda: «Che cosa dice il testo in sé?», nella seconda ci si interroga: «Che cosa dice il testo a noi?». Subentra, così, l’oratio, a cui corrisponde la domanda: «Che cosa dire a Dio», dopo averlo ascoltato? È il momento della risposta orante, personale e comunitaria. Infine, si entra nella contemplatio che è il vertice dell’intero itinerario, in cui si riassume l’esperienza vissuta, intuendo così un nuovo volto di Dio e un nuovo nostro volto interiore. Questo livello potrebbe essere descritto con un passo degli Atti degli apostoli che introducono l’ultima domanda.
Dopo aver ascoltato il discorso di Pentecoste tenuto da s. Pietro, i presenti «si sentirono trafiggere il cuore e dissero: Che cosa dobbiamo fare?» (2,37). Quattro momenti, dunque, segnati da altrettanti interrogativi che rivelano una particolare ermeneutica della Bibbia di natura performativa, destinata cioè a transitare dalla ragione al cuore, dall’ascolto all’agire, dal testo alla vita, dalle parole umane alla Parola divina.
La vasta appendice offerta da questa edizione della Bibbia applica la tetralogia sopra evocata a tutti i 73 libri che compongono le S. Scritture ebraico-cristiane, con indubbia creatività ed efficacia, permettendo così alle comunità cattoliche, protestanti e ortodosse di ritrovarsi insieme in quel crocevia della loro fede che è la Bibbia. In esergo si è, infatti, posta una frase folgorante del libro di Giosuè, il sesto delle S. Scrittura: «Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto; così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo» (1,8).
Accanto a questa importante operazione editoriale ed ecumenica, che ben s’adatta a celebrare i 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II e che s’innesta nella fervida atmosfera di dialogo introdotta da papa Francesco, evochiamo un’esperienza analoga anche se differente sempre di taglio biblico.
La Fondazione Ramon Pané, fondata nel 1994 in ricordo del primo catechista dell’America Latina e con sede a Tegucigalpa (Honduras) e Miami (Usa), ha cercato di rispondere a un quesito che affiora frequentemente: se la Bibbia è composta di più opere, pur essendo ormai compattata in un unico libro, la si può affrontare con una lectio continua, come si faceva in passato, seguendone l’attuale successione canonica, oppure è possibile procedere secondo una trama più libera e coerente con la storia e i temi in essa proposti?
Ebbene, questa Fondazione ha suggerito un inedito e curioso piano di lettura del Nuovo Testamento partendo dalla vicenda germinale di Cristo e della Chiesa narrata da Luca nel suo Vangelo e negli Atti degli apostoli, per proseguire con l’apostolo Paolo che entra con le sue Lettere nelle varie città dell’impero romano e nelle relative comunità cristiane di matrice pagana. Si passa poi alla cristianità di origine giudaica col Vangelo di Matteo, la Lettera agli Ebrei e quella di Giacomo, per rivolgersi poi all’orizzonte della predicazione di s. Pietro col Vangelo di Marco e le due Lettere di Pietro e, così, approdare al corpus giovanneo composto dal Vangelo, dalle Lettere e dall’Apocalisse.
Un copione interessante, reso trasparente e agevole nella lettura anche dall’abolizione della numerazione dei capitoli e dei versetti (una scansione per altro tardiva, perché introdotta solo nel 1528 da Sante Pagnini in una Bibbia pubblicata a Lione). Si offre così, un percorso testuale quasi narrativo continuato, affidato al dettato molto limpido e immediato della citata Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente.
-
>CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Preti o ladri travestiti da samaritani? Lettera aperta (di don Aldo Antonelli)9 gennaio 2016
Preti o ladri travestiti da samaritani? *
- «Mai siano affariste le Chiese». Mai.
 «La redenzione di Dio è gratuita». Sempre.
«La redenzione di Dio è gratuita». Sempre.
 «Noi sappiamo quello che dice Gesù a quelli che sono causa di scandalo: “Meglio essere buttati nel mare”».
«Noi sappiamo quello che dice Gesù a quelli che sono causa di scandalo: “Meglio essere buttati nel mare”».
 Era il 21 Novembre del 2014 quando Papa Francesco diceva queste parole.
Era il 21 Novembre del 2014 quando Papa Francesco diceva queste parole.
 Da allora non solo niente è cambiato tra noi preti, ma alcuni hanno alzato il tiro e.... le pretese!
Da allora non solo niente è cambiato tra noi preti, ma alcuni hanno alzato il tiro e.... le pretese!
- Deluso e ancor più arrabbiato ho scritto al mio vescovo questa lettera aperta.
 Aperta perché si sappia.
Aperta perché si sappia.
 Aperta perché nessuno chiuda gli occhi.
Aperta perché nessuno chiuda gli occhi.
 Aperta perché qualcuno incominci a ribellarsi!
Aperta perché qualcuno incominci a ribellarsi!
Caro Pietro,
scrivo a te, vescovo di questa diocesi di Avezzano, ma è come se gridassi al mondo intero per denunciare pubblicamente lo scandalo.
Non posso continuare a tacere o a glissare o a far finta che!
Il silenzio si configurerebbe come complicità, se non addirittura come correità.
Edotto dai miei maestri di sempre, don Tonino Bello, secondo il quale “delle nostre parole dobbiamo rendere conto agli uomini, ma dei nostri silenzi dobbiamo rendere conto a Dio”, don Mazzolari che amava ripetere che “certi silenzi sono omicidi” e M. L. King il quale confessava: «Non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti», ho deciso di denunciare a Lei e alla pubblica opinione l’impudenza vergognosa di sacerdoti che oltre a farsi pagare puntualmente ogni servizio (messe, matrimoni, funerali, battesimi e benedizioni varie), pretendono, da quelle comunità che dovrebbero “servire”, ulteriori corrispettivi per benzina, luce, gas e cellulare!
Noi già portiamo sulle nostre coscienze il peso di un mensile che viene dallo Stato, attraverso l’8 per mille, e che ci degrada a “stipendiati”. Oltre ciò, la stragrande maggioranza dei preti si fa pagare, profumatamente, sotto il falso nome dell’offerta, ogni prestazione; sarebbe come se un funzionario dello stato, nello svolgere le sue funzioni, prendesse soldi anche dai singoli utenti! Il che ci rende ladri!
Ultimamente, si sta diffondendo il malcostume di parroci che pretendono il “rimborso spese”!
Autodegradandosi ancor di più da ladri a tangentisti e pizzettari.
Oggi, con Papa Francesco, un rinnovato Spirito aleggia sul mare tempestoso della storia come aleggiava agli inizi sul caos primordiale; ma questo Spirito Innovatore sembra trovare tra il clero ottusità refrattarie ad ogni impulso di dignità. Sordi e muti, voraci e venali, impietriti dal potere, dall’abitudine e dal danaro, stanno facendo della chiesa una multinazionale dell’abuso e della corruzione.
A voi vescovi spetta il compito di fare pulizia di questa gente, onde evitare che la Chiesa diventi una spelonca di ladri. Meglio una chiesa vuota di preti che una chiesa infestata da ladri travestiti da samaritani.
Sento già la critiche cui andrò incontro con questa mia pubblica denuncia. Soprattutto mi si rimprovererà di non seguire il consiglio evangelico della correzione fraterna, rivolta in privato e al singolo. Ma qui non siamo di fronte ad un’offesa personale che possa essere risolta in una “trattazione” privata. Qui siamo davanti ad un comportamento pubblico e di “ruolo”, che va pubblicamente denunciato!
Risolvere privatamente problemi pubblici è da mafiosi, non da cristiani!
Don Milani, altro maestro del mio sentire, in una lettera del 5 Luglio 1964 a mons. Capovilla scriveva: «Ho sempre pensato che lo stare in silenzio sia un’elevata funzione ecclesiastica. Mi domando solo se sia giusto seguitare a santificarsi nel silenzio quando sul piano terreno questo non fa che aumentare il già tanto profondo sdegno dei poveri verso la gerarchia ecclesiastica. Fino all’anno scorso pensavo che fosse santità. Da qualche tempo in qua temo che sia correità».
Che Dio ti dia luce e coraggio per il necessario tuo intervento.
Aldo Antonelli (prete)
Post Scriptum
Copia di questa lettera la invio, tramite Raccomandata, anche a Papa Francesco, nella speranza che la legga e la prenda in seria considerazione.
*
Aldo Antonelli (9-gen-2016)
- «Mai siano affariste le Chiese». Mai.
-
>CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Dante e i Papi: Vangelo in poesia (di Gianfranco Ravasi)5 dicembre 2015, di Federico La Sala
Dante e i Papi: Vangelo in poesia
di Gianfranco Ravasi
(Avvenire, 5 dicembre 2015) La Chiesa ha mostrato più volte il vivo e sentito desiderio di onorare degnamente la figura di Dante Alighieri, di tenere nella giusta considerazione la sua opera, considerandola come elemento essenziale del suo patrimonio culturale e religioso, per il profondo rapporto con la fede cristiana e con la riflessione teologica e filosofica sviluppatasi intorno alle verità della fede.
Ricordando i più recenti anniversari danteschi, ci si accorge che i pontefici, a nome di tutta la Chiesa, hanno tributato al sommo poeta uno straordinario, singolare onore, dedicandogli importanti documenti magisteriali. Nell’enciclica In praeclara summorum, rivolta ai professori e alunni degli istituti letterari e di alta cultura del mondo cattolico (30 aprile 1921), Benedetto XV celebrava il VI centenario della morte di Dante. Per l’occasione il pontefice aveva anche promosso il restauro del tempietto ravennate, attiguo alla basilica di San Francesco, che custodisce la tomba di Dante. Con l’enciclica il papa intendeva affermare ed evidenziare «l’intima unione di Dante con la cattedra di Pietro». Nel poema sono espresse le verità fondamentali della Chiesa cattolica, così da renderlo un «compendio delle leggi divine». A riguardo invece dei noti attacchi contro la Chiesa del tempo, papa Benedetto XV giustifica il sommo poeta: «Chi potrebbe negare che in quel tempo vi fossero delle cose da rimproverare al clero?». Per Benedetto XV Dante «conserva la freschezza di un poeta dell’età nostra », anzi egli è molto più moderno di alcuni poeti contemporanei, i quali rievocano «quell’antichità che fu spazzata da Cristo, trionfante sulla croce».
Nella ricorrenza del VII centenario della nascita di Dante, anche Paolo VI con la lettera apostolica Altissimi cantus (7 dicembre 1965), evidenziava il profondo interesse della Chiesa per la figura di Dante. Con tale documento il pontefice istituiva, presso l’Università Cattolica di Milano, una cattedra di studi danteschi. La lettera apostolica completava la serie di iniziative attraverso le quali papa Montini volle esprimere l’ammirazione sua e di tutta la Chiesa per il cantore della Divina Commedia: il 19 settembre dello stesso anno aveva inviato per la tomba del poeta a Ravenna una croce d’oro, come segno della risurrezione che Dante professava, e il 14 novembre era stata incastonata nel battistero di San Giovanni a Firenze un’aurea corona d’alloro. Infine, a conclusione del concilio Vaticano II, il papa aveva donato a tutti i partecipanti una pregiata edizione della Divina Commedia.
«Del Signore dell’altissimo canto...». Già con l’incipit della lettera apostolica si evidenzia la centralità assoluta, in tutta la poesia italiana, del sommo poeta, definito «l’astro più fulgido» della nostra letteratura e ancora «padre della lingua italiana». Così scrivendo, Paolo VI rinnovava la profonda riconoscenza al poeta, e seguendo Benedetto XV lo annoverava tra tutti i grandi poeti cristiani. «Dante è nostro», ribadisce papa Montini, seguendo anche in questo Benedetto XV. «Nostro» nel senso di universale, ma anche nostro nel senso della fede cattolica. Paolo VI afferma che è un dovere della Chiesa riconoscere Dante come proprio, che ha come conseguenza necessaria uno studio accurato della sua opera per scoprirne gli «inestimabili tesori del pensiero e del sentimento cristiano».
Tra il sommo poeta e il pensiero cristiano vi sono numerosissimi elementi di contatto. Tra questi il fine stesso della Commedia, che ha in comune col messaggio cristiano l’intento di cambiare radicalmente l’uomo, di portarlo dalla selva oscura del peccato alla rosa mistica della santità. «Onorate l’altissimo poeta!» è l’invito-appello con cui Paolo VI conclude l’Altissimi cantus, sollecitando il «fermo impegno» soprattutto di coloro che, per vari motivi, si sentono a lui più vicini. La cultura contemporanea deve saper incontrare Dante e chiedere a lui la guida verso la «dritta via», spesso impedita dalla selva oscura, verso quello che egli ci indica come «dilettoso monte/ ch’è principio e cagion di tutta gioia».
Benedetto XVI non è meno legato a Dante dei suoi predecessori e più volte, già da cardinale, ricorda e cita il sommo poeta. Il cardinal Ratzinger, infatti, nel libro Introduzione al cristianesimo, scrivendo dello «scandalo del cristianesimo», cioè di Cristo Figlio di Dio fattosi uomo, e quindi del significato dell’essere che va ricercato non nel mondo delle idee ma nel volto di un uomo, rammenta la concretezza di questo pensiero nella conclusione della Divina Commedia di Dante: «Dentro da sé del suo colore istesso,/ mi parve pinta della nostra effigie,/ per che il mio viso in lei tutto era messo». Dante, «contemplando il mistero di Dio, scorge con estatico rapimento la propria immagine, ossia un volto umano, esattamente in centro all’abbagliante cerchio di fiamme formato da “l’amore che move il sole e l’altre stelle”».
Benedetto XVI riprende questo tema e questi versi per spiegare il significato profondo della sua prima enciclica Deus caritas est. Incontrando i partecipanti a un congresso organizzato dal Pontificio consiglio «Cor unum», il pontefice afferma: «Ancora più sconvolgente di questa rivelazione di Dio come cerchio trinitario di conoscenza e amore è la percezione di un volto umano - il volto di Gesù Cristo - che a Dante appare nel cerchio centrale della Luce. Se da un lato nella visione dantesca viene a galla il nesso tra fede e ragione, tra ricerca dell’uomo e risposta di Dio, dall’altro emerge anche la radicale la novità di un amore che ha spinto Dio ad assumere un volto umano». Nell’enciclica, si ribadisce, il papa voleva «tentare di esprimere per il nostro tempo e per la nostra esistenza qualcosa di quello che Dante nella sua visione ha ricapitolato in modo audace».
Il 4 maggio 2015, quando in Senato si sono celebrati i 750 anni dalla nascita di Dante. ho avuto l’onore di essere latore di un messaggio di Papa Francesco che si accosta ai suoi predecessori nella lode e nell’ammirazione per questo grande poeta e credente. Lo stesso pontefice, per altro, nella sua prima enciclica Lumen fidei, aveva raffigurato la luce della fede, che avvolge e coinvolge l’intera esistenza umana, attraverso un’immagine dantesca, la «favilla,/ che si dilata in fiamma poi vivace/ e come stella in cielo in me scintilla» (Paradiso XXIV, 145-147).
-
>DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- Via Crucis, Gianluigi Nuzzi sui fasti dei cardinali a canone zero: "l’attico di Bertone è la regola, non l’eccezione".5 novembre 2015
Via Crucis, Gianluigi Nuzzi sui fasti dei cardinali a canone zero: "l’attico di Bertone è la regola, non l’eccezione"
di Redazione (L’Huffington Post, 04/11/2015)
Gli sperperi della Curia sostenuti utilizzando i fondi destinati ai bisognosi. I fasti dei cardinali a canone zero, con residenze immense nel centro di Roma riservate a porporati pressoché privi di incarico. Sono solo alcuni degli scandali raccontati in “Via Crucis”, il nuovo libro di Gianluigi Nuzzi edito da Chiarelettere.
- Nel cuore pulsante della Chiesa c’è un buco nero che Francesco scopre dopo molte difficoltà: una malagestione che diventa truffa e raggiro. Grazie alla task force che ha messo in piedi con un colpo di mano senza precedenti, il papa riesce ad accertare che i costi della curia vengono sostenuti impiegando i fondi destinati ai bisognosi. Uno scandalo. I soldi che arrivano in Vaticano, mandati dai cattolici di tutto il mondo per le opere di carità, non finiscono ai poveri ma servono per colmare i buchi finanziari generati da alcuni cardinali e dagli uomini che controllano l’apparato burocratico della Santa sede.
- Jorge Bergoglio aveva scelto il nome di Francesco perché la missione della sua Chiesa doveva essere esattamente quella di san Francesco d’Assisi: aiutare i poveri. Dal primo saluto in piazza San Pietro il papa rifugge qualsiasi orpello indossando spesso abiti dimessi. Invita i senzatetto nella Cappella Sistina e chiede ai responsabili degli istituti religiosi e degli enti che fanno riferimento alla Chiesa di ospitare negli immobili in disuso tutti coloro che ne hanno bisogno: nei palazzi, nei convitti, nelle camerate dei grandi seminari rimasti deserti per la crisi delle vocazioni.
Oltre al rigore e alla trasparenza, povertà e carità sono le parole chiave del suo linguaggio pastorale e del pontificato. Con una sensibilità che cerca di trasmettere e accrescere soprattutto tra sorelle e sacerdoti. A iniziare dalle piccole cose, le più semplici. Come l’utilizzo dell’automobile sul quale si sofferma nell’udienza generale del 6 luglio 2013:
- «A me fa male quando vedo una suora o un prete con la macchina ultimo modello - afferma Francesco - ma non si può... La macchina è necessaria per fare tanto lavoro, spostarsi di qua e di là... ma prendetene una umile. Se ne volete una bella, pensate ai bambini che muoiono di fame... Giustamente a voi fa schifo quando vedete un prete o una suora che non sono coerenti».
Bergoglio è il primo a dare il buon esempio. Quando va a Lampedusa per abbracciare i profughi che arrivano dall’Africa usa una Fiat campagnola messa a disposizione da un cattolico che vive nell’isola, mentre ad Assisi, nella terra di san Francesco, eccolo usare una piccola auto, una Fiat Panda. Perfino «quando un prete veronese gli regala una Renault4, il papa accetta ma la trasferisce al museo delle automobili papali».
- Di fronte a questi discorsi e comportamenti, inconsueti per un papa, sono molti i cardinali curiali che, dopo un iniziale smarrimento, hanno mostrato di allinearsi al nuovo corso. In realtà è una sintonia solo a parole e a larghi sorrisi. La battuta sarcastica che circola tra i loro autisti fa capire il clima: «Hanno lasciato le auto blu, le berline, nel garage, ora vanno in giro con le piccole utilitarie, le 500, le Fiat Panda, ma vivono sempre nelle stesse regge».
I cardinali, infatti, continuano a concedersi lussi di ogni genere, senza badare a spese. L’attico di Bertone - scrive Nuzzi - è la regola, non l’eccezione.
- Basti verificare come e dove vivono i porporati che occupano le posizioni più alte nella gerarchia per capire dove vanno a finire i soldi destinati alla carità: nelle case lussuose del cuore di Roma, realtà inimmaginabili per gran parte dei cattolici, da fare invidia perfino alle star di Hollywood.
- Sui giornali è finita la storia della casa del cardinale Tarcisio Bertone che, unendo due appartamenti situati all’ultimo piano di Palazzo San Carlo in Vaticano, oggi abita in una residenza da 700 metri quadrati. Ma questa è la regola, non l’eccezione. I cardinali di curia risiedono in dimore principesche da 400, 500, anche 600 metri quadrati. Vivono da soli o con qualche suora missionaria come assistente, colf, cuoca e perpetua, meglio se proveniente da un paese in via di sviluppo. Sono appartamenti costituiti da sale di ogni tipo: d’attesa, della televisione, da bagno, dei ricevimenti, da tè, della biblioteca, dell’assistente personale, del segretario, d’archivio, della preghiera. E ancora camere, cucine e dispense. Residenze in edifici da favola, come lo splendido palazzo del Sant’Uffizio, subito dietro il colonnato di piazza San Pietro: risale al Cinquecento e un tempo ospitava il tribunale dell’inquisizione. Qui l’appartamento più grande, ben 445 metri quadrati, è andato al cardinale Velasio De Paolis, ratzingheriano di ferro, classe 1935, presidente emerito della Prefettura degli affari economici della Santa sede. Con una casa da 409 metri quadrati gli fa compagnia il cardinale sloveno Franc Rodé, ottantun anni, già arcivescovo di Lubiana e amico personale di Marcial Maciel Degollado, il fondatore dei Legionari di Cristo sospeso dal ministero per gravissimi atti di pedofilia. È uno dei membri, tra l’altro, del Pontificio consiglio della cultura. Il cardinale Kurt Koch, invece, presidente del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, deve accontentarsi di una casa di 356 metri quadrati.
Un’altra pattuglia di porporati si trova poco distante, al di là di piazza San Pietro, in un bel palazzo a ridosso di via Conciliazione.
- Siamo nel cuore della città eterna. Qui, sfiora i 500 metri quadrati la dimora del canadese Marc Ouellet, classe 1944, prefetto della Congregazione per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina. Il cardinale Sergio Sebastiani, ottantaquattro anni, membro tra l’altro della Congregazione per i vescovi e di quella per le cause dei santi, vive in 424 metri quadrati. Va ricordato che tutti i porporati al di sopra degli ottant’anni conservano un ruolo soprattutto simbolico e non hanno più diritto al voto in conclave per superati limiti di età.
- Lo statunitense Raymond Leo Burke, classe 1948, patrono del sovrano militare ordine di Malta, è a suo agio in 417 metri quadrati, così come il polacco Zenon Grocholewski, classe 1939, dal marzo scorso prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica. A lui una residenza di 405 metri quadrati. A pochi passi, sempre nel quartiere romano di Borgo Pio, una residenza principesca di 524 metri quadrati è abitata dal cardinale americano William Joseph Levada, nato a Long Beach, classe 1936, fedelissimo di Ratzinger, che nel 2005 lo ha voluto suo successore come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Nel 2006 Levada è stato chiamato a testimoniare, a San Francisco, sugli abusi sessuali commessi su minori da alcuni preti dell’arcidiocesi di Portland, dove è stato arcivescovo dal 1986 al 1995. Era l’autorità responsabile dei preti poi risultati colpevoli di abusi. In tutto questo scenario, la stanza 201 di papa Francesco a Santa Marta è quasi una capanna, non arrivando a 50 metri quadrati.
I privilegi dei cardinali però non finiscono qui. I porporati, infatti, non pagano l’affitto ma solo le spese finché ricoprono incarichi all’interno della curia. Dopo viene fissato un canone calmierato di 7-10 euro al metro quadro. Spesso però gli alti porporati mantengono incarichi in qualche dicastero che consentono loro di continuare a godere del benefit “canone zero”.
- Leggi anche: Benvenuti al supermercato vaticano. In un’anticipazione del libro "Avarizia" di Emiliano Fittipaldi il sospetto giro d’affari dei "negozi di Dio": dalla farmacia al tabaccaio, fino al benzinaio, fatturano più dei Musei Vaticani (ESTRATTO)
-
>CARDINAL RAVASI --- Papa Francesco preferisce pastori di strada. Come se arcivescovo di Milano fosse stato nominato don Bepo.29 ottobre 2015, di Federico La Sala
Come se arcivescovo di Milano fosse stato nominato don Bepo
di Redazione (Bergamopost, 28 ottobre 2015)
Richiesto di un parere sul nuovo papa dopo uno dei tanti bagni di folla di Francesco appena eletto, il cardinal Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Consiglio di Coordinamento fra Accademie Pontificie aveva detto che il successo di pubblico non consentiva ancora di capire dove sarebbe andato a parare il cardinal Bergoglio. Si dovevano attendere gli atti di governo. E quello di questi giorni - doppio, con la nomina degli arcivescovi di Bologna e Palermo - è un atto di governo che non lascia dubbi: il papa venuto dalla fine del mondo preferisce pastori di strada.
Lo si poteva intuire già da uno dei primi Angelus, in cui richiamandosi al libro di un suo amico teologo aveva aggiunto: “ma un buon teologo”, per indicare che il titolo accademico in sé non faceva testo. Anzi: poteva addirittura giocare a sfavore del titolato. Nel Discorso ai Partecipanti alle Giornate Dedicate ai Rappresentanti Pontifici (Sala Clementina, 21 giugno 2013) aveva poi detto: «Nel delicato compito di realizzare l’indagine per le nomine episcopali siate attenti che i candidati siano Pastori vicini alla gente: questo è il primo criterio. Pastori vicini alla gente. È un gran teologo, una grande testa: che vada all’Università, dove farà tanto bene! Pastori! Ne abbiamo bisogno! Che siano, padri e fratelli, siano miti, pazienti e misericordiosi; che amino la povertà, interiore come libertà per il Signore e anche esteriore come semplicità e austerità di vita».
Poi c’erano stati altri pronunciamenti terremotanti, come quello - ormai famosissimo - sui pastori che devono avere addosso l’odore delle pecore, o il messaggio alla 68ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, nel maggio di quest’anno, nel quale si legge la devastante frase: «In realtà, i laici che hanno una formazione cristiana autentica, non dovrebbero aver bisogno del Vescovo-pilota, o del monsignore-pilota o di un input clericale per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli, da quello politico a quello sociale, da quello economico a quello legislativo! Hanno invece tutti la necessità del Vescovo Pastore!». Una costruzione linguistica da prendi due paghi uno nella quale vengono passati a fil di spada - e in un solo colpo - sia i laici (che se sentono bisogno dell’input di un vescovo-pilota significa che non sono cristiani maturi) sia i vescovi e monsignori che non li hanno ben formati perché (se non compiamo un’induzione errata) un po’ troppo clericali.
A rileggere a partire da oggi la lettera del cardinal Caffarra pubblicata da Avvenire Bologna Sette nel gennaio 2013, quella che parlava della bambina trovata nel cassonetto e che iniziava «Cara Maria Grazia, sei stata buttata nei rifiuti sotto la mia finestra, vicino alla mia casa...» la distanza fra due stili di discorso e di governo non potrebbe apparire più abissale, al limite del galattico.
Il papa, allora, non ama i teologi? No, non è così: tanto è vero che cita spesso il padre De Lubac, gesuita come lui e cardinale. Solo che vuole che la teologia nasca dalla vita della comunità cristiana, dall’esperienza pastorale e non viceversa. Ha detto alla Riunione della Congregazione per i Vescovi il 27 febbraio 2014: «La Chiesa non ha bisogno di apologeti delle proprie cause né di crociati delle proprie battaglie, ma di seminatori umili e fiduciosi della verità, che sanno che essa è sempre loro di nuovo consegnata e si fidano della sua potenza. Vescovi consapevoli che anche quando sarà notte e la fatica del giorno li troverà stanchi, nel campo le sementi staranno germinando». Vuole, il papa, che i discorsi su Dio (questo significa “teologia”) vengano su come la bruma dai letamai (non dimentichiamo che laetamen - letame - è all’origine di laetitia, gioia. E che i pabula laeta, i pascoli con l’erba bella grassoccia, sono quelli bel concimati. Quelli le cui sementi stanno germinando bene).
Don Corrado Lorefice - che reggerà la diocesi di Palermo - è di Modica, che vuol dire il paesaggio umano del Commissario Montalbano. Famoso per aver scritto un libro su Dossetti e Lercaro: la Chiesa povera e dei poveri. Se fosse stato mandato a Bologna (la città che fu di Dossetti e Lercaro) sarebbe stato uno schiaffo troppo palese per il cardinal Caffarra, che viene sostituito. Meno palese, non meno forte, perché senza bisogno di scriverlo in chiaro il messaggio è comunque chiarissimo.
Nella città emiliana andrà invece monsignor Matteo Maria Zuppi, romano, 60 anni, per anni parroco, assistente spirituale della Comunità di Sant’Egidio oltre che vescovo ausiliare per Roma centro, che viaggia in utilitaria. Chi mai avrebbe immaginato che il parco macchine delle curie arcivescovili avrebbe subito un così radicale rinnovamento in questi anni. Che la FCA l’avrebbe vinta sulla Mercedes. Ma la Chiesa deve cambiare. Deve cambiare sempre, ci è stato ricordato pochi giorni fa.
Cosa possono dunque significare per Bergamo queste nomine? Che se fosse vivo don Bepo ce lo saremmo trovato vescovo. O meglio, secondo lo stile bergogliano: che lui lo avremmo visto insediato a Milano, mentre in Città Alta sarebbe stato mandato un pretino ancora ignoto, le cui virtù sarebbero emerse d’improvviso splendenti al pari di stelle, come si dice dei giusti. E ce ne sono, di questi preti, in giro. Tutto ciò per dire che lo stile di governo bergogliano, in fondo, è semplice. Deriva tutto da un capitolo di Marco che recita:
«In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche».
Oggi avrebbe raccomandato loro di spostarsi in Cinquecento se proprio non potevano usare la moto. Bagagliaio vuoto. Neanche un cambio per spostamenti entro le quarantotto ore. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Perfetto. Come urlavamo da bambini alla fine della conta: «Chi c’è c’è; chi non c’è non c’è». Perché solo quelli che ci sono sono capaci di andare a scovare gli altri, quelli che vorrebbero da tempo unirsi alla compagnia, ma si sono sentiti drammaticamente stupidi a fronte di tanta sapienza e impresentabili a fronte di tanto oro e tante auto. Adesso è il loro turno.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- L’eterno dilemma teologico (di Gianfranco Ravasi).25 ottobre 2015, di Federico La Sala
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
Martin Lutero ed Erasmo da Rotterdam
L’eterno dilemma teologico
Sul tema della libertà o schiavitù del volere umano si è consumato lo scontro epocale tra il rigido riformatore e il raffinato umanista
di Gianfranco Ravasi s.j. (Il Sole-24 Ore, Domenica, 25.10.2015)
- Martin Lutero, Il Padre nostro spiegato ai semplici laici, a cura di Valdo Vinay, Claudiana, Torino, pagg. 86, € 7,50.
- Martin Lutero, Il Piccolo Catechismo, a cura di Fulvio Ferrario, Claudiana, Torino, pagg. 78, € 7,50.
- Lutero e la mistica , a cura di Franzo Buzzi, Dieter Kampen e Paolo Ricca, Claudiana, Torino, pagg. 270, € 34,00. Stefan Zweig, Erasmo , Castelvecchi, Roma, pagg. 134, € 14,50.
Sarà tra due anni, ma in Germania e in molte altre nazioni ci si sta già preparando per celebrare il mezzo millennio di un evento da alcuni giudicato fatale e da altri fatidico: come è noto, il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, cittadina sul fiume Elba, un teologo frate agostiniano trentaquattrenne (era nato il 10 novembre 1483) rendeva pubbliche le celebri “95 Tesi” che avrebbero segnato per i cattolici lo “scisma d’Occidente” e per i protestanti la “Riforma” evangelica per eccellenza. In preparazione a quella commemorazione abbiamo pensato di proporre qualche testo luterano di facile approccio.
Il primo volumetto, destinato «a spiegare ai semplici laici» il Padre nostro, la preghiera-vessillo del cristiano, fiorì da un quaresimale tenuto proprio nel 1517 da un Lutero ancora formalmente cattolico, tant’è vero che quando - anni dopo - il testo, rielaborato e ampliato dall’autore, fu pubblicato anonimo a Venezia in italiano, il censore ecclesiastico cattolico si lasciò andare a questo elogio sorprendente: «Beate le mani che hanno scritto queste cose, beati gli occhi che le vedono, beati i cuori che credono a questo libro e così gridano a Dio». Effettivamente il commento - che procede parola per parola sulla versione dell’orazione offerta dall’evangelista Matteo (6,9-13; Luca 11,2-4 ne presenta un’altra parallela ma non identica) - è segnato da una freschezza, un’essenzialità e una finezza interpretativa da meritare la comparazione che Lutero adotta in apertura quando ricorre alla metafora musicale.
Scrive infatti: «La musica è quando facciamo poche parole, ma con riflessione intensa. Quanto più parca di parole, tanto migliore è la preghiera, quanto più verbosa, tanto peggiore è la preghiera; poche parole e molto senso è cristiano, molte parole e poco senso è pagano... Chi vuole adorare Dio, lo deve adorare in spirito e verità». Questa sobrietà verbale e spirituale riaffiora in un altro scritto celebre di Lutero ormai pienamente “protestante” perché è databile 1529. Si tratta del cosiddetto Piccolo Catechismo che nasce come una sorta di divagazione che il riformatore elabora a margine, mentre sta approntando il ben più ponderoso Catechismo tedesco o Grande Catechismo.
È lui stesso in premessa a spiegare lo stimolo che lo spinge a questa operazione secondaria: visitando le comunità di Sassonia, s’era accorto della «deplorevole, misera situazione» in cui esse versavano, così da vedersi «costretto e obbligato a redigere questo Catechismo in forma breve, sobria e semplice. Buon Dio, quanta miseria ho visto! L’uomo comune non sa nulla della dottrina cristiana, in particolare nei villaggi, e purtroppo molti pastori sono quasi inetti e incapaci di insegnare, e tuttavia tutti si vedono chiamare cristiani, devono essere battezzati e ricevere i santi sacramenti, ma non conoscono il Padre nostro, il Credo, né i Dieci Comandamenti. Vivono come il buon bestiame e le scrofe irragionevoli!». È per questo che egli stila un vivace compendio catechistico attorno ai temi sopra citati.
Così, si ha un altro commento al Padre nostro a domande e risposte («Che cosa significa? Come avviene» e così via). Si passa, poi, ai Dieci Comandamenti, al Credo, ai sacramenti, cioè battesimo, eucaristia, confessione. A proposito di quest’ultima si intuisce un Lutero ancora “cattolico” che esige non solo la confessione del peccato commesso nella sua fattispecie teologico-morale, ma anche una sorta di assoluzione esterna, pronunciata dal ministro in nome di Dio a conferma che la colpa è stata perdonata. L’eucaristia o “sacramento dell’altare” «è il vero corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, che egli stesso ha dato a noi cristiani affinché sia mangiato e bevuto sotto le specie del pane e del vino». Siamo, perciò, ben lontani dalla concezione meramente simbolica sostenuta poi da Zwingli, l’altro riformatore svizzero, ben più radicale.
Nella linea di questo fermento preparatorio alla commemorazione del 2017, possiamo segnalare la nascita, avvenuta nel 2011, dell’Accademia laica ed ecumenica di Studi luterani in Italia (ASLI). Uno dei frutti di questa istituzione è la celebrazione di convegni sul pensiero luterano: segnaliamo, allora, la recente pubblicazione degli atti di un incontro del 2012 dedicato al rapporto tra Lutero e la mistica. È, infatti, indubbia una temperie fortemente spirituale nella fede personale e nella stessa visione teologica del riformatore: emblematiche in questo senso sono sia la sua esegesi delle pagine della Genesi dedicate ad Abramo e alla prova terribile del monte Moria, base anche di quel gioiello che sarà Timore e tremore di Kierkegard, sia la sua ripresa della mistica nuziale che si consuma nell’incontro sponsale tra l’anima redenta e Cristo. In questa luce è interessante anche l’eredità di matrice agostiniana di s. Bonaventura che pervade il pensiero luterano (talora in modo anche critico), movendosi sull’oscillazione tra i due poli dell’amore e della fede.
Ci sembra, alla fine, suggestivo introdurre in una specie di controcanto o di contrappunto con Lutero un’altra imponente figura di quegli anni, Erasmo di Rotterdam. Lo facciamo non tanto con uno dei molti ponderosi saggi dedicati a questo straordinario umanista, bensì con una delle varie biografie romanzate composte dall’ebreo viennese Stefan Zweig, vero e proprio maestro di questo genere letterario. L’opera nasce nell’anno in cui lo scrittore si è stabilito a Londra, il 1934-35, per sfuggire alla barbarie nazista che aveva già messo al rogo le sue opere. Non si era, però, ancora davanti alle ulteriori atrocità hitleriane che spingeranno uno Zweig sconvolto e la sua giovane seconda moglie al suicidio a Rio de Janeiro durante il carnevale del 1942.
Per lo scrittore austriaco è una iattura che «la gloria più alta e più luminosa di quel secolo» sia ora votata all’oblio e che «le sue opere innumerevoli, redatte in una lingua supernazionale ora dimenticata, il latino degli umanisti, dormano indisturbate nelle biblioteche».Ecco, allora, il tentativo di abbozzare un ritratto vivo e raffinato di colui che «è stato il primo europeo cosciente, il primo bellicoso amico della pace, l’avvocato più facondo dell’idealità umanistica». Questi e altri lineamenti della fisionomia di Erasmo non potevano che entrare in collisione con la figura intransigente, spigolosa e rigorosa di Lutero, pur intercorrendo tra i due alcune sintonie, come l’amore per la Parola di Dio da tutelare, anche in sede critico-filologica. Famoso per la dialettica tra i due è già il titolo di quel De libero arbitrio (1524) erasmiano che rivela la sua distanza e l’incompatibilità col riformatore che gli opporrà l’anno dopo un lapidario De servo arbitrio.
Zweig riserva pagine appassionate a questo confronto tra il raffinato umanista, invitato «in tono perentorio a tralasciare ogni discorso caustico, retorico o fiorito», e l’«avversario gigantesco», dotato di una «superiorità combattiva». Ma uno dei nodi capitali dello scontro - continua lo scrittore viennese - è «l’eterno dilemma per la teologia: la questione della libertà o schiavitù del volere umano». Ed Erasmo ribadisce in modo folgorante che «non dobbiamo cercare di evitare la Scilla dell’orgoglio per lasciarci trascinare nella Cariddi del fatalismo». Secondo Zweig, lo studioso di Rotterdam non ebbe il coraggio di abbandonare il suo essere a metà del guado tra i due scogli per compiere la scelta audace di progredire verso la modernità piena.
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Le sconcertanti parole di Gesù. L’invito a mangiare la sua carne, a odiare i genitori, a considerare la sua venuta non come portatrice di pace ma di spada, sono espressioni che hanno sempre scandalizzato i fedeli.13 settembre 2015, di Federico La Sala
- GESU’ E IL CATTOLICESIMO-ROMANO. UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE").
Le sconcertanti parole di Gesù
L’invito a mangiare la sua carne, a odiare i genitori, a considerare la sua venuta non come portatrice di pace ma di spada, sono espressioni che hanno sempre scandalizzato i fedeli
di Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 13.09.2015)
La scena ha come fondale la costa settentrionale del lago di Tiberiade. Là sorgeva un centro importante, Cafarnao, in ebraico «villaggio della consolazione» o «villaggio di Nahum», nome portato anche da un profeta biblico. Di lì passava una strada che conduceva in Siria, un’arteria commerciale di frontiera: è per questo che Cafarnao era dotata di una dogana il cui ufficio era diretto dal funzionario Matteo Levi, il futuro apostolo. Sopra le modeste case del quartiere dei pescatori - ove era situata anche la residenza di un altro discepolo di Cristo, Simon Pietro, messa in luce nel secolo scorso dall’archeologia - si ergeva una sinagoga eretta col contributo di un ufficiale romano filoebreo (Lc 7,4-5).
Gesù, che da poco si è affacciato sul panorama pubblico della Galilea, la regione settentrionale della Terra Santa, la sua predicazione impressionante e coi suoi atti sorprendenti, entra in quella sinagoga e inizia a parlare. Il suo è un discorso sconcertante tanto da generare una reazione ostile da parte non solo della folla che l’ascoltava, ma anche dei suoi primi discepoli. Proviamo anche noi ad accostarci e a raccoglierne l’eco da qualche frase: «Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita ... perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda».
È l’evangelista Giovanni a registrare quel discorso nel capitolo 6 del suo scritto ed è ancora lui a segnalare la sensazione di ribrezzo e di ripugnanza dell’uditorio di fronte a una proposta che sembrava rasentare il cannibalismo, sia pure sacro. Innanzitutto la folla: «I Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare?» (Gv 6,52). Poi è la volta dei discepoli: «Molti dei suoi discepoli, dopo averlo ascoltato, dissero: Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?» (Gv 6,60). Nell’originale greco si usa l’aggettivo sklerós: è un discorso «sclerotico», non solo duro ma anche incomprensibile, recalcitrante a ogni intelligenza normale.
Quegli uomini che l’avevano seguito con entusiasmo voltano ora le spalle a Gesù, escono da quella sinagoga sulla piazzetta antistante. È ancora Giovanni a rappresentare lo sviluppo della scena: «Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui» (6,66). Riprendevano, dunque, le strade dei loro villaggi ove li attendevano forse le barche da pesca che avevano prima con tanto fervore abbandonato, oppure rientravano in quelle magre campagne che avevano coltivato faticosamente. Gesù stesso aveva trovato con un verbo la definizione più adatta ad esprimere il loro stato interiore: «Questo vi scandalizza?» (Gv 6,61).
Il verbo italiano ricalca quello greco del Vangelo, skandalízei: esso letteralmente rimanda alla pietra di inciampo che fa incespicare e cadere una persona che avanza su un viottolo accidentato o su un sentiero di montagna. Questo verbo risuona 29 volte nei Vangeli (15 volte si incontra il sostantivo skándalon) e prevalentemente è collegato all’esperienza di fede: è un rinnegarla, un respingerla, un entrare in crisi o un fare agli altri una sorta di sgambetto così che dalla fede cadano nell’incredulità. Il termine, nella nostra accezione più comune (soprattutto nell’aggettivo «scandaloso»), ha acquistato una connotazione sessuale, evocando l’oscenità, l’indecenza, la sconcezza.
Nel linguaggio neotestamentario questa parola conserva, sì, l’elemento di imbarazzo e di turbamento, si colora di indignazione e di disgusto, ma si orienta quasi sempre allo sconcerto in chiave religiosa. Come scriverà san Paolo, il Cristo crocifisso è scandalo per i Giudei (1 Cor 1,23), è - come usiamo dire noi - «la pietra dello scandalo» che fa perdere fiducia e adesione, introducendo una specie di repulsione e persino di raccapriccio. Ed effettivamente le parole di Cristo sulla sua carne come cibo e sul suo sangue come bevanda avevano suscitato non solo imbarazzo e sconcerto, ma un vero e proprio orrore nell’uditorio di quel discorso nella sinagoga di Cafarnao.
Infatti, come è noto, nella Bibbia il sangue è segno della vita stessa e non è lecito nemmeno toccare un corpo lacerato e sanguinolento, perché si resterebbe contaminati e si diverrebbe impuri e incapaci di compiere ogni atto di culto. Come non ricordare nella parabola del Buon Samaritano il comportamento del sacerdote e del levita che passano «oltre dall’altra parte» della strada ove giaceva quel malcapitato sanguinante e mezzo morto (Lc 10,31-32)? Nell’alleanza primordiale tra Dio e l’umanità, che ha per mediatore Noè, dopo il giudizio del diluvio, si legge questo precetto divino: «Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello» (Gen 9,5).
Per noi l’orrore nei confronti delle parole di Gesù sul cibarsi della sua carne e sul bere il suo sangue sarebbe quello legato all’antropofagia, uno dei tabù dominanti in quasi tutte le civiltà. Evidentemente ben diverso era il senso che intendeva Gesù e che noi ora interpretiamo alla luce dell’eucaristia: il pane e il vino sono segni di una «comunione» di vita col corpo e il sangue, cioè con la persona di Cristo, e quindi con la divinità, in un’intimità piena che genera la «vita eterna», vale a dire la vita divina, come ripete lo stesso Cristo in quel discorso.
Ma perché abbiamo ricostruito questa scena con la reazione allibita dei discepoli? È un episodio che di solito è rievocato ancor oggi dai pellegrini: essi sostano nell’area archeologica di Cafarnao dove sorgeva l’antica sinagoga nella quale Gesù aveva tenuto quel discorso, ora sostituita dai resti di un’altra imponente sinagoga del IV secolo. Là essi leggono appunto il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Abbiamo riproposto quell’evento perché vorremmo invitare a un particolare viaggio testuale nei quattro Vangeli alla ricerca delle parolescandalo, quelle che fanno inciampare il lettore, anche chi è fermamente cristiano. Sono appunto le parole «dure» e difficili, che esigono una speciale interpretazione. Non temiamo di affrontare questo itinerario un po’ arduo e arido, memori di una battuta significativa dello storico inglese, vissuto tra Sei e Settecento, Thomas Fuller, nella sua Gnomologia: «Tutto è difficile prima di essere semplice».
I 140 passi evangelici che presenteremo hanno una diversa gradazione di difficoltà. Alcuni sono chiaramente hard, come vengono definiti in inglese, e creano senza dubbio uno choc. Ad esempio: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre ... e persino la propria vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14,26). Oppure: «Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore» (Mt 5,28). O ancora: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra: sono venuto a portare non pace ma spada!» (Mt 10,34). Infine, tra i tanti altri esempi possibili, ecco un dialogo inquietante tra un aspirante discepolo e Gesù: «“Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre.” “Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti!”» (Mt 8,21-22).
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Vaticano, Papa: Testimoniare unità e carità verso tutti.18 maggio 2015, di Federico La Sala
- QUALE UNITA’, QUALE CARITA’?! MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO.
Vaticano, Papa: Testimoniare unità e carità verso tutti *
"La missione di annunciare Cristo risorto non è un compito individuale, ma è da vivere in modo comunitario, testimoniando l’unità fra di noi e la carità verso tutti". Così papa Francesco, durante l’omelia in occasione della messa in piazza San Pietro per la canonizzazione di quattro suore, di cui due palestinesi. "Questo - ha sottolineato Bergoglio - hanno fatto le quattro sante oggi proclamate. Il loro luminoso esempio interpella anche la nostra vita cristiana: come io sono testimone di Cristo risorto? Come rimango in Lui, come dimoro nel suo amore? Sono capace di ’seminare’ in famiglia, nell’ambiente di lavoro, nella mia comunità, il seme di quella unità che Lui ci ha donato partecipandola a noi dalla vita trinitaria?".
* iL MESSAGGERO, 17.05.2015
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Questioni fondamentali. Il difficile viaggio nella natura umana (di Gianfranco Ravasi)26 aprile 2015, di Federico La Sala
- DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
Questioni fondamentali
Il difficile viaggio nella natura umana
Tramontata la metafisica aristotelica e dissolta la ragione kantiana, si è alla ricerca di un concetto condiviso di “natura” antropologica
di Gianfranco Ravasi s.j. (Il Sole-24 Ore, Domenica. 26.04.2015)
Anche chi non ha una grande assuefazione alla filologia intuisce che il vocabolo «natura» sboccia dal verbo latino nascor: è, quindi, legato a quell’evento radicale che è la nascita. Ora, come osserva Jean-Michel Maldamé, un filosofo della scienza francese ma nato ad Algeri, «in una nascita ci sono due aspetti: il primo è l’inizio della vita, il secondo è che la nascita manifesta un’identità permanente. La nozione di «natura» passa, allora, dalla designazione di un momento della vita iscritto nel tempo [la data di nascita, lo stato anagrafico e civile] a ciò che caratterizza il vivente come tale nella sua identità che trascende il tempo». Questa duplicità si riflette anche nel greco physis che è, sì, la natura essenziale, strutturale, metafisica di un essere, ma che è anche il suo inizio nell’esistenza, dato che la base verbale del termine è phyein, «generare, metter fuori, produrre». Tra l’altro, nelle 14 volte in cui risuona nel Nuovo Testamento il termine physis, entrambi i significati sono attestati, ma a prevalere è la semantica filosofica, quindi, il concetto ontologico di «natura».
Siamo partiti ab ovo - curiosa e pertinente locuzione oraziana che rimanda alle radici storiche della vicenda omerica - perché in questi ultimi tempi attorno a una tale categoria antropologica basilare si è abbattuta una bufera che ne ha scosso le fondamenta: basti solo pensare al «politeismo dei valori» registrato da Weber o al soggettivismo applicato alla nozione di «verità», o anche al puro e semplice pluralismo culturale. Accade, perciò, spesso anche a un uomo di Chiesa come me, proteso al dialogo in quell’ideale «Cortile dei Gentili» ove si confrontano credenti e non credenti, di sentirmi interpellato sulla possibilità o meno di avere una piattaforma comune di incontro. Ritorna, così, il discorso sulla «natura» umana nel senso metafisico sopra accennato, per non rassegnarsi alla mera proceduralità sociale, spoglia però di implicazioni etiche.
La domanda, allora, è questa: è possibile recuperare un concetto condiviso di «natura» antropologica che impedisca di scivolare nelle sabbie mobili del relativismo (so che è sgradito tale termine, ma lo adotto come simbolo di una molteplicità sfaldata e babelica)? Dobbiamo rassegnarci al massimo alla convinzione di Montaigne che nei suoi Saggi considerava la natura come «una poesia enigmatica»? Nella riflessione occidentale su questa categoria possiamo individuare due grandi fiumi ermeneutici, dotati di tante anse, affluenti e ramificazioni ma ben identificabili nel loro percorso. Il primo ha come sorgente ideale il pensiero aristotelico che per formulare il concetto di natura umana ha attinto alla matrice metafisica dell’essere. La base è, perciò, oggettiva, iscritta nella realtà stessa della persona, e funge da stella polare necessaria per l’etica.
Questa concezione dominante per secoli nella filosofia e nella teologia è icasticamente incisa nel motto della Scolastica medievale Agere sequitur esse, il dover essere nasce dall’essere, l’ontologia precede la deontologia. Questa impostazione piuttosto granitica e fondata su un basamento solido ha subìto in epoca moderna una serie di picconate, soprattutto quando - a partire da Cartesio e dal riconoscimento del rilievo della soggettività (cogito, ergo sum) - si è posta al centro la libertà personale. Si è diramato, così, un altro fiume che ha come sorgente il pensiero kantiano: la matrice ora è la ragione pratica del soggetto col suo imperativo categorico, il «tu devi». Al monito della «ragione», della legge morale incisa nella coscienza, si unisce la «pratica», cioè la determinazione concreta dei contenuti etici, guidata da alcune norme generali, come la “regola d’oro” ebraica e cristiana («non fare all’altro ciò che non vuoi sia fatto a te» e «fa’ all’altro ciò che vuoi ti si faccia») o come il principio “laico” del non trattare ogni persona mai come mezzo bensì come fine.
Frantumata da tempo la metafisica aristotelica, si è però assistito nella contemporaneità anche alla dissoluzione della ragione universale kantiana che pure aveva una sua “solidità”. Ci si è trovati, così, su un terreno molle, ove ogni fondamento si è sgretolato, ove il “disincanto” ha fatto svanire ogni discorso sui valori, ove la secolarizzazione ha avviato le scelte morali solo sul consenso sociale e sull’utile per sé o per molti, ove il multiculturalismo ha prodotto non solo un politeismo religioso ma anche un pluralismo etico. Al dover essere che era stampato nell’essere o nel soggetto si è, così, sostituita solo una normativa procedurale o un’adesione ai mores dominanti, cioè ai modelli comuni esistenziali e comportamentali di loro natura mobili.
È possibile reagire a questa deriva che conduce all’attuale delta ramificato dell’etica così da ricomporre un nuovo fenotipo di «natura» che conservi un po’ delle acque dei due fiumi sopra evocati senza le rigidità delle loro mappe ideologiche? Molti ritengono che sia possibile creare un nuovo modello centrato su un altro assoluto, la dignità della persona, còlta nella sua qualità relazionale. Si unirebbero, così, le due componenti dell’oggettività (la dignità) e della soggettività (la persona) legandole tra loro attraverso la relazione all’altro, essendo la natura umana non monadica ma dialogica, non cellulare ma organica, non solipsistica ma comunionale. È questo il progetto della filosofia personalistica (pensiamo ai contributi di Lévinas, Mounier, Ricoeur, Buber).
La natura umana così concepita recupera una serie di categorie etiche classiche che potrebbero dare sostanza al suo realizzarsi. Proviamo a elencarne alcune. Innanzitutto la virtù della giustizia che è strutturalmente ad alterum e che il diritto romano aveva codificato nel principio Suum cuique tribuere (o Unicuique suum): a ogni persona dev’essere riconosciuta una dignità che affermi l’unicità ma anche l’universalità per la sua appartenenza all’umanità. Nella stessa linea procede la cultura ebraico-cristiana col Decalogo che evoca i diritti fondamentali della persona alla libertà religiosa, alla vita, all’amore, all’onore, alla libertà, alla proprietà. Nella stessa prospettiva si colloca la citata “regola d’oro”.
In sintesi, l’imperativo morale fondamentale si dovrebbe ricostruire partendo da un’ontologia personale relazionale, dalla figura universale e cristiana del «prossimo» e dalla logica dell’amore nella sua reciprocità ma anche nella sua gratuità ed eccedenza. Per spiegarci in termini biblici a tutti noti: «Ama il prossimo tuo come te stesso» (reciprocità), ma anche «non c’è amore più grande di chi dà la vita per la persona che ama» (donazione). Inoltre, in senso più completo, nel dialogo «io-tu» è coinvolto - come suggeriva Ricoeur - anche il «terzo», cioè l’umanità intera, anche chi non incontro e non conosco ma che appartiene alla comune realtà umana. Da qui si giustifica anche la funzione della politica dedicata a costruire strutture giuste per l’intera società. La riflessione attorno a questi temi è naturalmente più ampia e complessa e dovrebbe essere declinata secondo molteplici applicazioni, ma potrebbe essere fondata su un dato semplice, ossia sulla nostra più radicale, universale e atemporale identità personale dialogica.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---4 febbraio 2015, di Federico La Sala
Il confessionale
Dalle tette ai neuroni
La “crociatina” di Ravasi
di Daniela Ranieri (il Fatto, 04.02.2015)
Nell’occhio del ciclone-Bergoglio, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio per la cultura, scopre le “culture femminili” (che sono cosa ben diversa dalla cultura tout court) e indìce un’assemblea plenaria per celebrarle.
A fare da testimonial invita l’attrice Nancy Brilli, con la quale incappa nella polemica sulla chirurgia estetica, definita nel documento preparatorio dell’incontro, con un’espressione “pertinente anche se sferzante”, “burqa di carne”.
La Brilli fa notare che se la chirurgia serve a sentirsi meglio non bisogna demonizzarla, e poi lei è moglie di chirurgo estetico “che si occupa prevalentemente di ricostruzione post-cancro”.
IN SOSTANZA potremmo serenamente infischiarcene, se non fosse che la vicenda apre a paradossali considerazioni. Non stupisce che il Vaticano dia spazio alle donne (grazie!) purché corrispondano al ritratto della femminilità che reputa ammissibile - da qui la valorizzazione e la sanzione, l’encomio e i distinguo.
Conta che il raffinato e colto prelato si riferisse alle donne che aderiscono a un “modello estrinseco” di bellezza, essendo egli, come immaginiamo, non tanto interessato al seno femminile (anche se disapprova le diciottenni che se lo gonfiano) quanto alle neuroscienze; infatti, “quando si inizia a intervenire sulla interconnessione neuronale siamo di fronte a ambiti che hanno ridondanze delicate sul piano etico”.
E si sa come funziona, si parte dalle tette e si arriva ai neuroni. A parte che non avremmo niente da ridire sul trapianto cerebrale di molti, questo artificio retorico è un vecchio trucco. Girato per il verso giusto, il discorso rivela la sua piega implicita: la vecchia ossessione della Chiesa per il sesso.
La donna che si “corregge” il corpo che Dio le ha dato lo fa inequivocabilmente per piacere di più agli uomini e quindi accoppiarsi di più. Lo fa perché, a differenza dell’uomo, è incapace di comprendere da sola il valore del corpo femminile autentico e non adulterato, ben chiaro ai detentori del potere biopolitico che per secoli hanno messo le mani negli organi delle donne e oggi le vedono decidere senza il loro permesso.
“Il corpo delle donne”, specie di panda in via di estinzione a causa di una cultura maschilista, diventa così - ma a sua tutela! - oggetto di torsione etica. Come fosse un bene comune, del demanio, un monumento dentro le mura vaticane da proteggere e tutelare, anche a scapito, se occorre, della stessa volontà delle donne.
SAREBBE facile dare torto a quegli oscurantisti di preti, sennonché quella del “burqa di carne” non è una loro invenzione: viene dal mondo “femminista”. Dal movimento Se non ora quando, ad esempio, nel cui film-manifesto Il corpo delle donne una galleria di maschere botulinizzate viene inanellata a illustrazione dei nuovi mostri.
Ai tempi delle intemperanze di Berlusconi, il giudizio sulla chirurgia estetica assurgeva a epitome di una più estesa disapprovazione del modo in cui le donne sono rappresentate sui media e nella società occidentale, ed era severissimo: il ritocco nascondeva il “vero” volto delle ragazze delle Tv e delle case dell’ex premier, le spogliava della loro libertà come fa il burqa, e induceva innocenti adolescenti a imitarle.
Così il “femminismo moralista” disapprova la donna-oggetto anche qualora fosse ella stessa soggetto di questa reificazione, e riconosce dignità solo a una femminilità “vera” e “decente”, in pericolosa consonanza con quella ammessa o imposta dalle destre e dalla morale cattolica.
Colpisce quanto questo giudizio condiviso con la Chiesa contro l’“obbrobrioso mercato delle carni” promuova un’etica della moderazione, della riservatezza se non dell’invisibilità che è molto più affine al fondamentalismo di quanto lo sia l’abuso di botulino.
-
> PER "LA PACE DELLA FEDE": INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Hermes, come sei cristiano.12 dicembre 2014, di Federico La Sala
Hermes, come sei cristiano
Un ampio excursus ricostruisce la vicenda dell’ermetismo e la sua influenza sulla teologia, da Agostino a Ficino
Il tentativo di svelare con la gnosi l’enigma di Dio e dell’uomo
di GIANFRANCO RAVASI *
- Claudio Moreschini, "Storia dell’ermetismo cristiano", Morcelliana, Pagine 408. Lire 45.000
A livello popolare, "ermetico" è sinonimo di "oscuro, chiuso, incomprensibile, enigmatico", nonostante il sotteso rimando a Hermes, il dio greco dell’interpretazione, dell’ermeneutica appunto. A livello più colto "ermetismo" è la corrente poetica sbocciata negli anni Trenta a Firenze sulle riviste Frontespizio e Campo di Marte, che annoverò tra i suoi cultori figure come Ungaretti, Quasimodo, Gatto, Sinisgalli, Luzi, Bigongiari e tra i suoi teorici Carlo Bo e Oreste Macrì.
In realtà l’ermetismo in senso storico-filologico risale a un orizzonte ben più remoto e sorprendente: per dirla con qualche semplificazione, fu un’affascinante e complessa operazione di ermeneutica. I grandi miti teogonici e cosmologici dell’antico Egitto faraonico furono "ellenizzati" e ricollocati in un nuovo linguaggio e in nuove coordinate storico-culturali. Così, il dio egizio Thoth, il rivelatore per eccellenza della sapienza divina, si trasformò nell’Ermete (Hermes) "tre volte grandissimo" (Trismegisto) e i suoi oracoli subirono riletture e ricreazioni sempre più complesse ed esoteriche.
Ma all’avventura ermeneutica del trapasso Egitto-Grecia si aggiunse un altro anello, quello cristiano e latino: la rivelazione pagana si rivestiva di un nuovo manto e diventava un’anticipazione profetica della Rivelazione per eccellenza e della sua inconcussa verità.
Questa vicenda di reinterpretazione delle antiche carte ermetiche non ebbe posa per secoli: passò attraverso Lattanzio, penetrò anche in Agostino, varcò la frontiera del MedioEvo con Abelardo e il platonismo di quell’epoca, approdò fino a Marsilio Ficino e alla filosofia del Rinascimento, attraversando perfino il giudaismo.
A ricostruire questa genealogia ermetica cristiana nelle sue tappe fondamentali è Claudio Moreschini, uno studioso di alto profilo della letteratura greca e latina cristiana. Egli lo fa in un volume suggestivamente ornato da un’immagine del Museo Capitolino che illustra in modo simbolico l’ermeneutica dell’ermetismo: in un rilievo dell’altare di Iside di Campo Marzio a Roma un Hermes chiaramente abbigliato in veste greco-romana e con le sue tipiche insegne ci mostra il volto canino del dio egiziano Anubi.
Naturalmente il trapasso ulteriore che possiamo solo immaginare sarebbe quello di staccare questa testa e sostituirla con un viso profetico cristiano per chiudere il cerchio delle reinterpretazioni. Come in ogni genealogia, il percorso è diacronico. Si parte dalla sorgente, da quel Corpus Hermeticum che fu acutamente studiato dal grande A. J. Festugière e si procede nella serie degli anelli cristiani, oggetto specifico dell’analisi di Moreschini. È un itinerario letterario e teologico di forte suggestione che conosce alcune soste in "slarghi" più ampi. È il caso dell’Asclepius, il più importante testo ermetico cristiano, traduzione latina di un originale greco perduto ma noto e citato da Lattanzio. È un trattato vistosamente destrutturato, affidato com’è alle connessioni per associazioni di parole, forse intenzionalmente impostato sull’impressionismo oracolare e teosofico, destinato a rivelare un mysterium iniziatico. Siamo, quindi, in un contesto di gnosi che ha come scopo quello di svelare la realtà profonda dell’uomo e la sua capacità di penetrare nel mistero divino.
Attraverso questa conoscenza superiore si infrangeranno le catene del carcere del corpo e si volerà verso la parte più pura dell’universo in una salvezza che è intimità perfetta con la divinità spirituale. Giustamente Moreschini - che, per altro, esamina di questo trattato il groviglio dei temi posti sul tappeto (il mondo, il fato, il male, la divinità) - osserva che "la preghiera finale riassume tutto il dialogo: il Trismegisto e i suoi giovani discepoli, possedendo il dono della conoscenza, se ne rallegrano e invocano Dio perché si degni di donare loro l’amore perpetuo per questa conoscenza, che li ha salvati" (p.119). Sono tante le finestre a cui affacciarsi in questo palazzo piuttosto "ermetico" dell’ermetismo cristiano.
Particolarmente interessanti sono quelle che ci permettono di gettare uno sguardo sulla stanza di Marsilio Ficino, il traduttore in latino del Corpus Hermeticum su commissione di Cosimo de’ Medici, oppure di scoprire le carte di quel Ludovico Lazzarelli di San Severino Marche al quale già il famoso P.O. Kristeller aveva dedicato un saggio appassionato. Egli fu l’autore rinascimentale del Crater Hermetis (il "cratere" è un simbolo tipico dell’ermetismo per indicare la formazione di una dottrina segreta) e di altri testi ove dottrina cristiana ed ermetici si miscelano tra loro. O ancora si potrebbe sbirciare negli scritti di Agostino Steuco, vescovo di Gubbio e grande erudito e in quelli di Francesco Patrizi, convinto che l’ermetismo sia alle origini di tutta la filosofia greca e sia per di più del tutto consono coi dogmi della dottrina cristiana.
Una nota finale importante. Il volume di Moreschini offre una vasta appendice sia l’Asclepius di cui sopra si è detto, sia il Crater Hermetis di Ludovico Lazzarelli, sia il poema Prometeus dello stesso autore, entrambi tradotti in italiano da un’allieva di Moreschini, Sara Petri.
*Avvenire-7 OTTOBRE 2000: http://www.swif.uniba.it/lei/rassegna/001007b.htm
-
> PER "LA PACE DELLA FEDE". Hermes, come sei cristiano. -- Rinascimento cristiano. Innovazioni e riforma religiosa nell’Italia del Quindicesimo e Sedicesimo secolo.24 settembre 2017, di Federico La Sala
Claudio Moreschini,
Rinascimento cristiano. Innovazioni e riforma religiosa nell’Italia del Quindicesimo e Sedicesimo secolo,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017 *
- Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo un forte sentimento di crisi colpisce la cultura del Rinascimento italiano in un punto cruciale della sua storia. Oggetto del volume è proprio l’interpretazione di questa crisi, durante la quale si afferma un cristianesimo ermetico, ora piegato soprattutto verso la tradizione antica ora verso la reinterpretazione cristiana della tradizione stessa.
 L’Autore si sofferma su motivi normalmente trascurati nella storia dell’Umanesimo italiano, ma che progressivamente stanno emergendo all’attenzione degli studiosi: le profonde inquietudini e i fermenti religiosi e spirituali che sfuggono a certe presentazioni troppo sistematiche di alcune dottrine filosofiche, come il ‘neoplatonismo del Rinascimento’ o ‘la filosofia dell’amore platonico’.
L’Autore si sofferma su motivi normalmente trascurati nella storia dell’Umanesimo italiano, ma che progressivamente stanno emergendo all’attenzione degli studiosi: le profonde inquietudini e i fermenti religiosi e spirituali che sfuggono a certe presentazioni troppo sistematiche di alcune dottrine filosofiche, come il ‘neoplatonismo del Rinascimento’ o ‘la filosofia dell’amore platonico’.
INDICE DEL VOLUME
Prefazione ................................................................................................ VII
Parteprima
Difesa del Cristianesimo
I. Gianfrancesco Pico della Mirandola tra Savonarola e Giovanni Pico........................3
II. Francesco Zorzi: Teologia e cosmogonia .............................................................71
III. L’autenticità del Corpus Dionysianum: contestazioni e difese........................95
Parte Seconda
Aspetti della poesia cristiana
I. La poesia ermetica e cristiana di Ludovico Lazzarelli: i Fasti Christianae Religionis.....143
II. La poesia di Gian Francesco Pico della Mirandola ........................ 163
III. La riscrittura cristiana di un testo ‘poetico’: Francesco Zorzi e il Cantico dei Cantici..... 219
Parte terza
Le tradizioni teosofiche antiche si inverano nella religione cristiana
I. Cristianesimo e tradizione ermetica .............................................................. 231
II. La tradizione caldaica ..................................................................................265
III. La tradizione (neo)platonica ..........................................................................295
Appendice
Ioannes Francisci Pici Mirandulae domini Concordiaeque Com. Hymnus ad Sanctiss. Trinitatem. Con traduzione a fronte ..... 344
Indice dei nomi .......................................................................................365
* SCHEDA EDITORIALE. - STORIA E LETTERATURA.
- Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo un forte sentimento di crisi colpisce la cultura del Rinascimento italiano in un punto cruciale della sua storia. Oggetto del volume è proprio l’interpretazione di questa crisi, durante la quale si afferma un cristianesimo ermetico, ora piegato soprattutto verso la tradizione antica ora verso la reinterpretazione cristiana della tradizione stessa.
-
>CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ... Papa Francesco a Santa Marta: Dio dona con gratuità, no ai “cattolici ma non troppo”(di Alessandro Gisotti)5 novembre 2014, di Federico La Sala
Papa Francesco \ Messa a Santa Marta
Il Papa: Dio dona con gratuità, no ai “cattolici ma non troppo” *
Nella legge del Regno di Dio il “contraccambio non serve”, perché Lui dona con gratuità. E’ quanto affermato da Papa Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta. Il Pontefice ha avvertito che, a volte, per egoismo o voglia di potere rifiutiamo la festa a cui il Signore ci invita gratuitamente. A volte, ha avvertito, ci fidiamo di Dio “ma non troppo”. Il servizio di Alessandro Gisotti:
Un uomo diede una grande festa, ma gli invitati trovarono delle scuse per non andare. Papa Francesco ha sviluppato la sua omelia partendo dalla parabola narrata da Gesù nel passo del Vangelo odierno. Una parabola, ha detto, che ci fa pensare perché “a tutti piace andare a una festa, piace essere invitati”. Ma in questo banchetto “c’era qualcosa” che a tre invitati, “che sono un esempio di tanti, non piaceva”. Uno dice che deve vedere il suo campo, ha voglia di vederlo per sentirsi “un po’ potente”, “la vanità, l’orgoglio, il potere e preferisce quello piuttosto che rimanere seduto come uno tra tanti”. Un altro ha comprato cinque buoi, quindi è concentrato sugli affari e non vuole “perdere tempo” con altra gente. L’ultimo infine si scusa dicendo di essere sposato e non vuole portare la sposa alla festa. “No - ha detto il Papa - voleva l’affetto per se stesso: l’egoismo”. “Alla fine - ha proseguito - tutti e tre hanno una preferenza per se stessi, non per condividere una festa: non sanno cosa sia una festa”. Sempre, ha ammonito, “c’è l’interesse, c’è quello che Gesù” ha spiegato come “il contraccambio”:
“Se l’invito fosse stato, per esempio: ‘Venite, che ho due o tre amici affaristi che vengono da un altro Paese, possiamo fare qualcosa insieme’, sicuramente nessuno si sarebbe scusato. Ma quello che spaventava loro, era la gratuità. Essere uno come gli altri, lì ... Proprio l’egoismo, essere al centro di tutto ... E’ tanto difficile ascoltare la voce di Gesù, la voce di Dio, quando uno gira intorno a se stesso: non ha orizzonte, perché l’orizzonte è lui stesso. E dietro a questo c’è un’altra cosa, più profonda: c’è la paura della gratuità. Abbiamo paura della gratuità di Dio. E’ tanto grande che ci fa paura”.
Questo, ha detto, avviene “perché le esperienze della vita, tante volte ci hanno fatto soffrire” come succede ai discepoli di Emmaus che si allontanano da Gerusalemme o a Tommaso che vuole toccare per credere. Quando “l’offerta è tanta - ha detto, riprendendo un proverbio popolare - persino il Santo sospetta”, perché “la gratuità è troppa”. “E quando Dio ci offre un banchetto così”, ha affermato, pensiamo sia “meglio non immischiarsi”:
“Siamo più sicuri nei nostri peccati, nei nostri limiti, ma siamo a casa nostra; uscire da casa nostra per andare all’invito di Dio, a casa di Dio, con gli altri? No. Ho paura. E tutti noi cristiani abbiamo questa paura: nascosta, dentro ... ma non troppo. Cattolici, ma non troppo. Fiduciosi nel Signore, ma non troppo. Questo ‘ma non troppo’, segna la nostra vita, ci fa piccoli, no?, ci rimpiccolisce”.
“Una cosa che mi fa pensare - ha soggiunto - è che, quando il servo riferì tutto questo al suo padrone, il padrone” si adirò perché era stato disprezzato. E manda a chiamare tutti i poveri, gli storpi, per le piazze e le vie della città. Il Signore chiede al servo che costringa le persone ad entrare alla festa. “Tante volte - ha commentato - il Signore deve fare con noi lo stesso: con le prove, tante prove”:
“Costringili, ché qui sarà la festa. La gratuità. Costringe quel cuore, quell’anima a credere che c’è gratuità in Dio, che il dono di Dio è gratis, che la salvezza non si compra: è un grande regalo, che l’amore di Dio ... è il regalo più grande! Questa è la gratuità. E noi abbiamo un po’ di paura e per questo pensiamo che la santità si faccia con le cose nostre e alla lunga diventiamo un po’ pelagiani eh! La santità, la salvezza è gratuità”.
Gesù, ha evidenziato, “ha pagato la festa, con la sua umiliazione fino alla morte, morte di Croce. E questa è la grande gratuità”. Quando noi guardiamo il Crocifisso, ha detto ancora, pensiamo che “questa è l’entrata alla festa”: “Sì, Signore, sono peccatore, ho tante cose, ma guardo Te e vado alla festa del Padre. Mi fido. Non rimarrò deluso, perché Tu hai pagato tutto”. Oggi, ha concluso, “la Chiesa ci chiede di non avere paura della gratuità di Dio”. Soltanto, “noi dobbiamo aprire il cuore, fare da parte nostra tutto quello che possiamo; ma la grande festa la farà Lui”.
* RADIO VATICANA. Messa del Papa a Casa Santa Marta - OSS_ROM 04/11/2014 *
-
>CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Un invito alla lettura di "Cristo si è fermato ad Eboli".16 settembre 2014, di Federico La SalaLA "DITTA RENZI" DI TORINO, ALIANO (MATERA), E LA LEZIONE DI LEVI. Un invito alla lettura di "Cristo si è fermato ad Eboli"
 Carlo Levi: "1939 settembre-dicembre. Costretto a fuggire in Francia, è a La Baule, presso St. Nazaire in Bretagna. Qui scrive in compagnia di Vico e della Bibbia, Paura della libertà"
Carlo Levi: "1939 settembre-dicembre. Costretto a fuggire in Francia, è a La Baule, presso St. Nazaire in Bretagna. Qui scrive in compagnia di Vico e della Bibbia, Paura della libertà"
-
>MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- Lo Spirito delle Donne Dalle Erodiadi di Testori agli studi di Simone Weil dalle poesie di Alda Merini alle lettere di Etty Hillesum (di Gianfranco Ravasi)14 settembre 2014, di Federico La Sala
-
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
Sacro al femminileLo Spirito delle Donne
Dalle Erodiadi di Testori agli studi di Simone Weil dalle poesie di Alda Merini alle lettere di Etty Hillesum
di Gianfranco Ravasi s. j. (Il Sole Domenica, 14.09.2014)
Li ho distesi a ventaglio sul mio scrittoio: è impressionante il numero di libri di e su donne che ho ricevuto in questi ultimi mesi. Da questa sorta di arcobaleno ho pensato di estrarre qualche colore, quasi a caso, nella consapevolezza di allestire non una recensione ma solo un bouquet variegato di pagine. Se dovessi escogitare una classificazione sintetica, opterei per il titolo di una bella antologia di passi testoriani, da poco edita, Voci femminili. Ebbi con Giovanni Testori un solo incontro personale nel 1992, un anno prima della sua morte, perché avevo elaborato un saggio da preporre a un suo testo sontuoso di critica d’arte dedicato proprio a una donna speciale, Maria Maddalena, la cui iconografia permetteva allo scrittore di sfoderare uno dei suoi registri tematici più accesi, l’intreccio tra spiritualità e carnalità.
Il femminino testoriano, come appare limpidamente in questa selezione, si àncora infatti alla prorompente corporeità di una Gilda del Mac Mahon, di Erodiade e Cleopatràs, insinuandosi nelle pieghe oscure di Eros ma anche di Thánatos con l’Arialda, ma veleggia anche verso le vette cristalline della madre di Gesù in Factum est o nella lacerata e possente Mater strangosciàs. Attraverso la persona femminile è l’essenza stessa dell’umanità e della vita che Testori vuole illuminare e perlustrare. È su questo terreno che s’incrocia anche una poetessa straordinaria la cui opera fu scritta e orale, quasi al modo degli antichi rapsodi o della Saffo frammentaria. Intendo riferirmi ad Alda Merini, a me legata da un’amicizia intensa e che ho spesso attestato con emozione e commozione.
Della sua poesia, striata da forti pulsioni teologiche insediate nel terreno della carne e del male da cui sbocciavano in modo epifanico ed etereo, scrive con molta finezza ed empatia un giovane studioso di letteratura e teologia, Claudio Cianfaglioni, disegnandone un affascinante ritratto spirituale e poetico. Esso è posto all’insegna di pochi versi prorompenti del Corpo d’amore di Alda: «Se tutto un infinito / ha potuto raccogliersi in un Corpo / come da un corpo / disprigionare non si può l’immenso?». Sul crinale semantico del vocabolo «pro-vocazione», che è chiamata trascendente e sfida immanente, si svolge la dialettica spirituale della Merini il cui linguaggio teologico è appunto sia invocazione sia provocazione, è luce e abisso, è per eccellenza ossimoro capace di stringere in un abbraccio adorazione e blasfemia, spirito e carne.
Un ossimoro che l’intelligenza tagliente e il cuore ardente di Etty Hillesum, l’ebrea olandese consumata dal gas nazista di Auschwitz a soli 29 anni, ha declinato nel suo impressionante diario e nell’epistolario, come accade nelle due lettere composte nella prima stazione di quella «Via crucis» che dal «campo di transito» di Westerbork giungerà al Golgota di Auschwitz. In quel primo girone dell’inferno hitleriano, ove facile è scivolare nella disperazione in mezzo a tanti orrori, Etty impugna invece il vessillo dell’amore e della bellezza. Certo, essa è consapevole dell’orrore: «Me lo sono detta una volta a voce alta in piena notte, costatandolo con una certa lucidità: Ecco ora sono all’inferno». Eppure, man mano che scrive e respira, la paura si dissolve e la fede apre uno squarcio di luce, perché - come attesta una compagna di lager - «noi donne siamo strane creature: basta una piccolezza a salvarci dalla follia. Persino all’inferno. Sì, persino all’inferno».
Alla Hillesum è spontaneo associare un’altra stupefacente figura femminile anch’essa ebrea, seppure pellegrina per alcuni tratti lungo le vie di Cristo, Simone Weil. Oltre alla coraggiosa iniziativa dell’Adelphi di raccogliere i suoi saggi, articoli, traduzioni, appunti relativi alla civiltà ellenica sotto il titolo La rivelazione greca, un vero e proprio giardino letterario, filosofico e spirituale ove intelligenza e passione s’incrociano, possiamo ricorrere per far conoscere Simone a un altro epistolario. È quello che s’intreccia tra la Weil e un poeta paralitico francese, Joë Bousquet, e un contadino anarchico aragonese, Antonio Atarés, mentre la donna soggiorna a Marsiglia tra il 1940 e il 1942, in attesa di imbarcarsi per gli Stati Uniti. Il filo d’oro che percorre e sorregge queste lettere è l’amicizia in tutte le sue iridescenze sentimentali, intellettuali e spirituali. Il sigillo di una simile relazione è nella libertà della donazione: «La necessità è principio di impurità e infanga l’amicizia», così come il desiderio di piacere, perché «i due amici accettano pienamente di essere due creature distinte. È con Dio soltanto che l’uomo ha il diritto di desiderare di essere direttamente unito».
Dopo le lettere di Etty Hillesum e di Simone Weil, un terzo curioso epistolario è quello che tra il 1924 e il 1940 un’altra donna dall’intuizione folgorante, l’argentina bonearense Victoria Ocampo, intesse con una sorta di monumento della cultura indiana, Rabindranath Tagore, Nobel 1913, poeta, artista, guru spirituale, pacifista. A differenza delle lettere di Simone Weil che talora sconfinano nel saggio in miniatura, questi scritti sono essenziali e riflettono una relazione di taglio paterno-filiale tra maestro e discepola, intrisa di quotidianità, segnata da slanci mistici con implicite pulsioni d’amore da parte di Victoria che si firma Vijava: «I giorni sono senza fine da quando ve ne siete andato. Sta venendo il nostro autunno e spero che passi presto. Ma temo che non imparerò mai a essere paziente».
Finora abbiamo visto donne che hanno incontrato uomini forti ma sensibili. E la tradizionale misoginia che ha pure scandito la storia anche cristiana dell’Occidente? In finale vogliamo offrirne uno specimen esemplare da parte di un acuto intellettuale cristiano cartaginese, Tertulliano. Appare, accompagnato da una solida guida di lettura e in una limpida versione del vivace originale latino, il suo pamphlet intitolato De cultu feminarum, «l’eleganza delle donne», una veemente staffilata sul lusso, la moda, la cosmesi che il gentil sesso imbraccia come arma di seduzione per trascinare al peccato il misero maschietto. Già in una deliziosa scenetta del libro biblico dei Proverbi si sceneggiava l’adescamento di un giovane da parte di una prostituta: «incauto la segue, come un bue condotto al macello, come un cervo adescato con un laccio» (si legga 7,6-27). Tertulliano non esita a raccogliere l’armamentario ideologico e moralistico, già allora ben diffuso, che vede la donna come strumento demoniaco per sviluppare un discorso più ampio ove si apre il sipario sull’escatologia considerata imminente.
-
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! --- LA CARESTIA DEI SOGNI E LA BUONA INTERPRETAZIONE: GIUSEPPE E IL FARAONE (di Luigino Bruni - Gli occhi onesti del profeta)7 luglio 2014, di Federico La Sala
NOTA INTRODUTTIVA.
La "buona" interpretazione dei sogni è quella che nasce dalla gratuità ("charitas"), non quella per profitto ("caritas").
- Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
Gli occhi onesti del profetadi Luigino Bruni (Avvenire, 7 luglio 2014
Le carestie sono molte e diverse. Il nostro tempo sta attraversando la più grande carestia di sogni che la storia umana abbia conosciuto. La carestia di sogni prodotta da questo capitalismo individualistico e solitario è una forma molto grave di indigenza, perché mentre la mancanza di pane non estingue la fame, se ci priviamo dei sogni finiamo per non accorgerci più della loro assenza; ci abituiamo a un mondo impoverito di desideri sempre più soffocati dalle merci, e presto diventiamo talmente poveri da non riuscire ad accorgerci di questa povertà. Come è possibile sognare angeli, il paradiso, i grandi fiumi d’Egitto quando ci addormentiamo di fronte alla tv accesa? Per i sogni grandi occorre addormentarsi con una preghiera sulle labbra, o svegliarsi con un libro di poesie aperto sopra il petto, che ha vegliato sul nostro sonno.
Il giovane Giuseppe si ritrovò innocente in una prigione, rigettato di nuovo in fondo a un «pozzo» (Genesi 40,15). Quella prigione divenne, però, anche il luogo della piena fioritura della sua vocazione, quella annunciatagli dai sogni profetici di ragazzo. Quei primi sogni lo avevano fatto arrivare schiavo in Egitto; i sogni che interpreterà nella terra del Nilo saranno la strada che consentirà ai suoi grandi sogni giovanili di avverarsi, e di ritrovare i suoi fratelli-venditori e suo padre.
È in un carcere dove inizia una nuova fase della vita di Giuseppe, quella decisiva per sé e per il suo popolo (non è raro che un "carcere" diventi il luogo di inizio di una vita nuova). In quel «pozzo», da raccontatore dei suoi sogni Giuseppe diventa interprete dei sogni degli altri. Quand’era ragazzo narrava i suoi sogni, ma non li interpretava. Il dolore per essere stato odiato e venduto dai fratelli, la servitù e poi il carcere, lo avevano maturato e gli avevano rivelato se stesso. E nel crogiuolo delle sofferenze e delle ingiustizie scoprì la sua vocazione, divenne servitore dei sogni degli altri.
In quel carcere si trovavano con lui due alti officiali di corte: il coppiere e il panettiere del faraone (40,1). Questi «fecero entrambi un sogno, ciascuno il suo sogno» (40,5). Il mattino «Giuseppe venne da loro e li vide: erano turbati», e chiese loro: «Perché oggi avete una faccia così brutta?». Gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c’è chi ce lo interpreti» (40,7-8). I due funzionari raccontarono i loro sogni a Giuseppe, e lui glieli interpretò.
Solo chi ha sognato e ha avuto il coraggio di raccontare i suoi sogni può diventare ermeneuta dei sogni degli altri. Per una legge paradossale che è al cuore di molte cose alte della vita, i migliori interpreti dei sogni degli altri sono coloro che hanno più sofferto a causa dei propri sogni. Avere dei sogni e non trovare qualcuno che ce li interpreti è una grande causa di infelicità per chi, nonostante la carestia, continua a sognare - ce ne sono ancora molti, soprattutto nei paesi più poveri di Pil e più ricchi di sogni, sogni che presto produrranno anche ricchezza.
I sogni sono sempre cose serie, ma decisivi sono i "sogni a occhi aperti", quelli che chiamiamo progetti, aspirazioni, voglia di riscatto e di giustizia, desideri di futuro e di felicità, quelli che ci fanno intravvedere il nostro posto nel mondo. Ieri e oggi, però, i sogni hanno bisogno di interpreti, di qualcuno che ne sappia decifrare il contenuto, altrimenti quei sogni si spengono. Questi interpreti sono importanti sempre, ma sono fondamentali da giovani, nella stagione dei sogni grandi.
Giuseppe inizia a interpretare i sogni come dono a due compagni di carcere: «Giuseppe disse loro: le interpretazioni non appartengono forse a Dio? Raccontatemi, vi prego» (40,8). La "buona" interpretazione dei sogni è quella che nasce dalla gratuità, non quella per profitto («le interpretazioni non appartengono forse a Dio?»). Sta nel bisogno essenziale di questa gratuità la ragione della scarsità dei buoni ermeneuti dei nostri sogni. Sono un dono raro, ma non rarissimo.
Le "guide spirituali" appartengono a questa preziosa categoria umana, persone che ascoltano e interpretano i nostri sogni e i nostri segni. La buona interpretazione dei sogni è gratuità chiesta e donata. Non è un mestiere, e se diventa mestiere non è buona. Le interpretazioni che Giuseppe dà a quei due sogni sono molto diverse: al capo dei coppieri predice la liberazione, al capo dei panettieri annuncia la morte - come poi accadrà.
Il valore morale di un interprete di sogni si misura dalla sua onestà, cioè dalla capacità e dal coraggio di dirci anche le interpretazioni che non vorremmo sentire. Sono troppi, ieri e oggi, gli interpreti ruffiani che ci dicono soltanto le interpretazioni che ci piace sentire. A volta le interpretazioni sbagliate possono provenire anche da interpreti onesti, che però non hanno abbastanza coraggio e amore - anche se il carisma dell’interpretazione dei sogni si spegne se non lo si custodisce nella sofferenza delle interpretazioni difficili. Ho conosciuto giovani ai quali è stata resa la vita molto difficile, a volte guastata, da cattivi interpreti dei loro sogni, che di fronte ad evidenti segni di vocazione diversa da quella che quel giovane pensava di avere, non hanno avuto né l’onesta né il coraggio della interpretazione vera; e così invece di prendere su di loro il dolore per quella verità costosa, hanno manipolato i sogni e alimentato in quei giovani illusioni, delusioni, frustrazioni, infelicità. Fidarsi di un manipolatore di sogni è più dannoso della morte del sogno per mancanza di interpreti.
Dopo due anni, anche il faraone fece un sogno. «Egli stava presso il Nilo. Ed ecco salire dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse di carne, a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo quelle, altre sette vacche salire dal Nilo, brutte di aspetto e magre di carne ... Ma le vacche brutte di aspetto e magre di carne divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse» (41,1-4). Il faraone si svegliò turbato; si riaddormentò e fece subito un altro sogno: «Sette spighe da un unico fusto, grosse e belle. Ma ecco sette spighe minute e riarse dal vento d’oriente germogliare dopo di quelle. Le spighe minute inghiottirono le sette spighe grosse e piene» (41,5-7). Quei due sogni agitarono l’animo del faraone, che mandò «a chiamare tutti i divinatori e tutti i sapienti d’Egitto. Il faraone raccontò il suo sogno ma non ci fu nessuno che li sapesse interpretare» (41,8).
A questo punto del racconto arriva una svolta narrativa. Quel capo dei coppieri, al quale Giuseppe aveva interpretato il sogno due anni prima, si ricordò di lui. Ne parlò al faraone, che lo mandò a chiamare. Giuseppe gli rivela immediatamente la chiave per comprendere quanto sta per accadere, e la natura del suo operare: «Non io: Dio risponderà per il benessere [shalom] del Faraone» (41,16).
Siamo di fronte a un momento cruciale ed epocale: la fine dell’età dei divinatori, degli aruspici, dei maghi, e l’inizio del tempo della profezia. Qui Giuseppe diventa il primo profeta di Israele. In questa lettura del sogno del faraone vi ritroviamo, infatti, i tratti essenziali che distinguono l’autentica interpretazione profetica dai prodotti dei divinatori e dai falsi profeti di tutti i tempi. Questa interpretazione profetica è dono-gratuità, perché è esercizio di un carisma che il "profeta" riceve, non un suo manufatto né una tecnica appresa in qualche scuola. È un dono che per poter operare deve essere accolto dal suo destinatario, credendoci. E spinge sempre all’azione e al cambiamento.
La nostra società abbonda di consulenti for-profit, è sempre più inondata da maghi e da oroscopi, ma ci mancano troppo i buoni interpreti di sogni - e quei pochi che ci sono non vengono né cercati né ascoltati, e così rischiano di estinguersi per mancanza di domanda.
Quel Faraone, invece, credette all’interpretazione-profezia di Giuseppe, e agì. «Ecco, stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutta la terra di Egitto. Poi, dopo questi, si leveranno sette anni di carestia: si dimenticherà tutta quell’abbondanza nella terra d’Egitto e la carestia consumerà la terra [le vacche-spighe magre che divorano le grasse]» (41,29-30). E quindi Giuseppe continuò: «Il Faraone ravvisi un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sulla terra d’Egitto ... per prelevare il quinto dei prodotti della terra d’Egitto durante i sette anni di abbondanza» (41,33-34).
Le carestie da vacche magre passano. Queste carestie, prima o poi, finiscono naturalmente, anche se a volte con grandi costi. Le carestie di sogni, invece, non terminano da sole. Finiscono soltanto se, a un certo preciso punto, decidiamo di reimparare a sognare. Non è impossibile. Lo abbiamo saputo fare dopo miserie infinite e indicibili: dopo le guerre e le dittature, dopo i fratricidi, dopo le morti dei bambini. Abbiamo voluto, insieme, ricominciare a sognare. Abbiamo così ascoltato i poeti, i santi, gli artisti, che hanno saputo interpretare i nostri nuovi sogni. Abbiamo pregato e pianto insieme, recitato le loro-nostre poesie, cantato le loro-nostre canzoni. Le persone e i popoli rinascono e risorgono veramente soltanto così. «Il faraone si tolse di mano l’anello e lo pose sulla mano di Giuseppe; lo fece rivestire di abiti di lino finissimo e gli mise al collo un monile d’oro» (41,42).
- Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- «C’è bisogno di un’altra visione politica e culturale». La nuova indagine del commissario "Charitos" (di Petros Markaris)24 aprile 2014, di Federico La Sala
«C’è bisogno di un’altra visione politica e culturale»
di Petros Markaris (il manifesto, 18 aprile 2014)
Grecia. Lo scrittore greco Petros Markaris: «Piangere sulla ricchezza passata è inutile, bisogna riabituarsi a lottare». «A pensarci bene, quello che ci ha rovinati è un ascensore troppo rapido». È così che la traiettoria sociale della Grecia è riassunta dal protagonista della fortunata serie noir di Petros Markaris, in Resa dei conti. La nuova indagine del commissario Charitos (Bompiani, 2012), l’ultimo libro uscito in Italia. Le vite segnate dalla crisi e le piccole strategie di resistenza sono molto più che lo sfondo per il mistero del delitto raccontato da Markaris. Sono al centro di una narrazione corale che riscopre legami familiari e solidarietà sociali, fa i conti con l’etica e con gli effetti del suo smarrimento da parte della politica. -Un’intervista telefonica con lo scrittore greco ha aperto il corso “Narratori d’Europa: volti e luoghi dalla crisi”, organizzato dall’Istituto regionale studi europei (Irse) del Friuli Venezia Giulia. Ne riprendiamo qualche estratto.*
Katerina e Adriana, le protagoniste femminili del suo ultimo romanzo, sono simboli della relazione complessa tra giovani e adulti e dei loro differenti modi di agire. In questo particolare momento della nostra vita, come si struttura questa relazione complessa?
Cominciamo a parlare del passato. Uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare con la crisi è quello di come abbiamo cresciuto i nostri figli, i giovani. Uno dei modi in cui lo abbiamo fatto è stato quello di lasciargli credere che la madre Europa avrebbe guarito tutto, e ora che ci rendiamo conto che non è così i giovani si sentono perduti. Oggi i giovani non sono preparati ad affrontare i tempi duri, e il problema è simile in Spagna, Grecia, Italia. La nostra generazione, la mia, è cresciuta lottando per tutto quello che poteva ottenere, quindi i giovani hanno bisogno di tempo per capire che devono lottare e ci sono tre condizioni basilari per questo: leggere, pensare e discutere la realtà. Questo è l’unico modo per affrontare la realtà.
È possibile trasformare la crisi in opportunità di cambiamento?
Penso di sì. È quello che è successo ai due protagonisti del mio libro, Zisis e Charitos, due persone provenienti da mondi molto distanti ma che trovano il modo di connettere le loro differenti personalità. Anche io sono cresciuto in una famiglia con difficoltà economiche, io stesso ne ho avute molte. Mia madre era una casalinga, è stata lei a tenere la famiglia unita, ha sempre trovato una soluzione, un po’ come, nel libro, la figura di Adriana. Tutte queste persone trovano alla fine il modo per sopravvivere, ma trovare il modo di sopravvivere più che una questione economica è un fatto soprattutto culturale, di valori. Piangere sulla passata ricchezza, che per la Grecia è stata più che altro virtuale, non è una soluzione. La soluzione possibile è trovare una ridefinizione del nostro punto di vista sulla vita. Solo in questo modo potremo uscire dalla crisi più forti.
Siamo alla vigilia delle elezioni europee e nessuno in Italia ne parla seriamente. Noi pensiamo che possano essere un’opportunità per chiedere a noi stessi quale Europa vogliamo, quale vita, quale welfare. Lei cosa ne pensa?
Questa è una domanda che mi rende molto triste e le spiego il perché. Credo che le prossime elezioni europee saranno un esperienza molto negativa per gli europei. Siamo convinti che il Sud Europa sia la parte che ha problemi ma se osserviamo bene vediamo che i problemi riguardano gli estremi, l’estrema destra in particolare. È questo il prezzo che stiamo pagando per avere ridotto l’Europa a economia. Voi avete citato Spinelli e Dahrendorf, io voglio citare Jean Monnet che prima di morire disse: «Ho fatto un errore, se dovessi rifare l’Europa dall’inizio punterei su politica e cultura». È vero, ma purtroppo è arrivato tardi. L’Europa ha bisogno di un’altra visione, noi ne abbiamo bisogno, non possiamo sempre dire sarà peggio. Abbiamo bisogno di una visione politica e culturale diversa altrimenti diventeremo dei mostri.
*
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- ANCORA LA CARITA’ "POMPOSA" DI MURATORI?!8 aprile 2014, di Federico La Sala
 "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ...
"PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ...
 VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITA’ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITA’ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! --- E’ il contrario di ciò che ha prezzo (Wasim Salman)4 aprile 2014GRAZIA - AMORE, NEL SENSO EVANGELICO (CHARITAS) : La parola «gratuito» è una parola privilegiata della nostra sensibilità moderna, e designa il contrario di ciò che ha prezzo. Ma nel senso religioso essa deriva dalla grazia in quanto dono gratuito da parte di Dio, che precede ogni opera, sforzo e merito. La grazia rimanda alla priorità dell’amore di Dio, all’inoggettivabile, i cui motivi non si possono spiegare, anche se non siamo nell’ordine dell’arbitrario. Questo gratuito rivela il fallimento delle logiche del mondo, e apre l’orizzonte verso la logica meravigliosa e imprevista dell’amore (Wasim Salman)
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Sotto il cielo di Galileo: le "Lettere copernicane" (di Gianfranco Ravasi)23 marzo 2014, di Federico La Sala
Sotto il cielo di GalileoA 450 anni dalla nascita tornano le splendide lettere copernicane: assai utili oggi per rimarginare vecchie, inutili, ferite
di Gianfranco Ravasi s. j. (Il Sole Domenica, 23.03.2014)
- Galileo Galilei, Lettera a Cristina di Lorena sui rapporti tra l’autorità della Scrittura e la libertà della Scienza; in appendice le Lettere a padre Castelli e a monsignor Dini con una nota di Giovanni Gentile, La Vita Felice, Milano, pagg. 108, € 10,50
«È l’intenzione dello Spirito Santo d’insegnarci come si vadia al cielo e non come vadia il cielo». Chissà quante volte i nostri lettori hanno sentito questa battuta attribuita a Galileo. In realtà, come lo stesso scienziato confessa, si tratta di una citazione: «Io direi quello che intesi da persona ecclesiastica costituita in eminentissimo grado». L’«eminentissimo» in questione era il cardinale Cesare Baronio, nato a Sora nel 1538, legato a s. Filippo Neri, famoso storico della Chiesa, cardinale «bibliotecario di Santa Romana Chiesa», che corse il rischio di essere eletto papa nei due conclavi del 1605, quasi alla soglia della sua morte avvenuta nel 1607 a Roma (per la cronaca divennero, invece, pontefici Leone XI, Alessandro de’ Medici, per un paio di settimane, e poi Paolo V, Camillo Borghese, che regnò fino al 1621).
Ora, questa citazione è presente nella celebre lettera che Galileo indirizzò a Cristina, figlia del duca di Lorena Carlo III e moglie del granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici, appassionata di studi astrofisici. La scadenza dei 450 anni dalla nascita di colui che, con Newton, è considerato il padre della scienza moderna, ha suggerito la necessità (15 febbraio 1564) di una nuova proposta di questo scritto particolarmente significativo dal punto di vista epistemologico per il rapporto tra fede e scienza.
La lettera, molto ampia quasi da renderla simile a un trattatello, datata 1615, fu preceduta da un analogo testo, più breve, che Galileo nel 1613 destinò all’abate del monastero benedettino di Pisa Benedetto Castelli, e fu accompagnata nello stesso anno 1615 da due missive più succinte rivolte a un prelato romano, mons. Piero Dini, di taglio più auto-difensivo.
La nuova edizione delle quattro lettere "copernicane" (dato che il fisico pisano propugna la concezione eliocentrica formulata dal canonico e astronomo polacco Nikolaj Kopernik, morto nel 1543) è accompagnata dalla nota che il filosofo Giovanni Gentile elaborò per tracciare un profilo generale galileiano. L’atto che una ventina d’anni dopo, il mercoledì 22 giugno 1633, si consumò con l’abiura dello scienziato di fronte al tribunale dell’Inquisizione, si trasformerà in una vera e propria icona di un conflitto ritenuto insanabile e di una presunta incompatibilità tra scienza e religione.
Lo stesso Giovanni Paolo II in un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze del 31 ottobre 1992 riconoscerà che «il caso Galileo divenne il simbolo del preteso rifiuto, da parte della Chiesa, del progresso scientifico, oppure dell’oscurantismo "dogmatico" opposto alla libera ricerca della verità».
Togliere questa spina dal fianco della Chiesa è ancor oggi arduo, anche perché essa si è ingrossata con la sua forza infettiva attraverso la dimensione simbolica e fin mitica che il caso assunse nei secoli successivi. Basti solo pensare al dramma Vita di Galileo in 15 scene che Brecht ripetutamente rielaborò mutando di volta in volta il ritratto del protagonista: da combattente indomito della libertà intellettuale (versione del 1938-39) a difensore del proprio quieto vivere (resa del 1945-46), fino alla dura accusa di essere il capostipite degli scienziati atomici servi del potere politico (testo del 1953-55).
Ci sono voluti quasi quattro secoli (e un numero notevole di grandi scienziati ecclesiastici) a riportare la questione del rapporto tra scienza e fede nei suoi termini reali e a riproporre il riconoscimento della legittimità di "magisteri non sovrapponibili". È questa la formula usata dallo scienziato ebreo agnostico americano Stephen Gould (non overlapping magisteria), per designare la necessaria molteplicità degli approcci conoscitivi alla realtà: da quello dedicato alla "scena", al "fenomeno" fisico, appannaggio del metodo scientifico, a quello teso a scoprire il "fondamento" metafisico, compito della filosofia, della teologia, dell’arte.
Ebbene, questo era proprio il succo ermeneutico delle Lettere galileiane. Egli, in verità, non era allora in grado di offrire una prova inconfutabile del movimento della Terra, prova che arrivò solo nel 1740 con la scoperta dell’aberrazione della luce stellare da parte dell’astronomo inglese James Bradley. In questo senso si può anche comprendere l’atteggiamento critico dei suoi giudici di fronte a quella che allora era una mera ipotesi.
L’elemento decisivo offerto da Galileo era, invece, di ordine metodologico: nella scienza e nella teologia due sono gli statuti epistemologici in campo. Essi non possono essere confusi, né l’uno può prevaricare sull’altro, dato che attengono a prospettive diverse, anche se considerano lo stesso oggetto. È ciò che appare in modo nitido in questi scritti per cui egli in realtà sbaragliò i suoi contestatori teologi proprio sul loro terreno più che su quello scientifico.
Tanto per citare un asserto sintetico rispetto a quelli più articolati presenti in questi scritti galileiani, bastino queste righe della lettera all’abate Castelli: «Io crederei che l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto solamente la mira a persuader a gli uomini quegli articoli e proposizioni, che, sendo necessarie per la salute loro e superando ogni umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili, che per bocca dell’istesso Spirito Santo». Questo per quanto riguardava lo statuto epistemologico della teologia. L’astronomo pisano continuava, poi, delineando in parallelo il metodo sperimentale proprio delle scienze fisiche.
Ora, quando il Concilio Vaticano II vorrà formulare - nel testo dedicato alla S. Scrittura, la Dei Verbum - la verità propria che la Bibbia vuole offrire, sia pure esprimendola in categorie legate al loro mondo storico-scientifico, affermerà, proprio nella linea dell’asserto galileiano, che «i libri della S. Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, a causa della nostra salvezza, volle che fosse consegnata nelle Sacre Lettere» (n. 11). Perciò, non è possibile condannare come contraria alla fede una questione di ordine fisico, pena il travalicamento di campo. Allargando il discorso, Galileo sosteneva, comunque, che non era affatto legittimo condannare teologicamente una proposizione, se prima non fosse confutata razionalmente (diremmo "falsificata" per usare un termine popperiano).
In questo senso è curiosa la postilla manoscritta, venata di ironia e consapevole però dei limiti della stessa scienza, che Galileo aggiungerà all’esemplare del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632) ora custodito nella biblioteca del Seminario di Padova: «Avvertite, teologi, che volendo fare materia di fede le proposizioni attenenti al moto ed alla quiete del Sole e della Terra, vi esponete a pericolo di dover forse col tempo condennar d’eresia quelli che asserissero la Terra star ferma e muoversi di luogo il Sole: col tempo, dico, quando sensatamente o necessariamente si fusse dimostrato la Terra muoversi e ’l Sole star fermo».
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi corigerete")?! Una nota di Federico La Sala5 gennaio 2014, di Federico La Sala
Esegesi, etica ed economiaDa Sant’Ambrogio a lezione di equità
C’è una linea che da Elia al vescovo di Milano a Turoldo promuove la giustizia inveendo contro l’avidità dei ricchi
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2014)
Erano gli anni del primo dopoguerra, padre Turoldo predicava ogni domenica alla Messa più frequentata nel Duomo di Milano. Si cominciavano a delineare i primi squilibri sociali, un tema che era congenito e congeniale con la figura del frate servita già molto popolare in Italia. E, così, una domenica nell’omelia egli dette fuoco alle polveri del suo arsenale oratorio, e le sue parole fiammeggianti incendiarono di sdegno alcuni fedeli che si premurarono di raccoglierle e di portarle sul tavolo dell’arcivescovo.
Allora a capo della diocesi ambrosiana c’era un benedettino diafano, segnato dalla semplicità geniale dei santi, il cardinale Ildefonso Schuster. Egli chiamò padre David e lo invitò a essere meno ardente e gli suggerì di scrivere la predica della domenica successiva così da contenere nello stampo freddo di un testo il turgore della sua passione.
Cosa che il frate fece. Quella mattina una folla ancor più numerosa era in attesa sotto le navate del Duomo. Con gesto ieratico, padre Turoldo dispiegò i suoi fogli e col registro della sua voce tonante, da cattedrale appunto, iniziò la lettura.
Ahimè, il testo scritto risultava ancor più rovente del parlato precedente. Siamo in grado di offrire ai nostri lettori alcuni squarci: «Fino a dove, o ricchi, estendete le vostre bestiali cupidigie? Vorrete forse finire ad abitare soltanto voi la terra, rivendicandone solo voi il possesso? La terra fu data in possesso a tutti, ricchi e poveri: perché, allora, vi arrogate il diritto di proprietà esclusiva del suolo?... Il mondo fu creato per tutti e, invece, voi pochi ricchi cercate di appropriarvene. Anzi, volete non solo la proprietà terriera per l’uso di voi soli pochi, ma volete anche il cielo, l’aria, il mare... Le vostre mense si alimentano col sangue dei poveri, i vostri bicchieri grondano del sangue di molti che avete strangolato col cappio... Le vostre donne sono travolte da una smania sfrenata di indossare smeraldi, giacinti, berillio, agata, topazio, ametista, diaspro, sardonice, e pur di soddisfare i loro capricci, spendono metà del loro patrimonio...». Non mancava neppure uno schizzo di sarcasmo: «Ho saputo persino, da fonte attendibile, che un ricco avaro, quando gli veniva servito a tavola un uovo, si rammaricava perché così perdeva la possibilità di avere poi un pulcino».
E concludeva: «Tu, o ricco, quando fai elemosina, non elargisci i tuoi beni al povero, ma semplicemente gli restituisci il suo. Infatti, ciò che giustamente è stato dato in uso a tutti, lo usurpi tu solo. La terra è di tutti, non dei ricchi... Restituite, allora, al povero, pagate il vostro debito a chi è indigente, perché non potete placare in altro modo Dio a causa della vostra malvagità!». Naturalmente, subito quel gruppo zelante di fedeli corse dall’arcivescovo a segnalare con indignazione il nuovo e peggiore misfatto del frate, che fu così riconvocato dal cardinale. Turoldo si presentò e stese davanti a Schuster i fogli con la sua predica.
L’arcivescovo scorse le prime righe e si mise a sorridere, continuò a leggere ed esclamò: «Ma questo è s. Ambrogio!». Si alzò, benedisse il religioso e, com’era suo uso, lo congedò dicendogli un motto che spesso ripeteva: «Faccia bene il bene!». Questo lungo resoconto, con le relative ampie citazioni, è forse il modo migliore per recensire un’opera del grande vescovo milanese del IV secolo intitolata in latino De Nabuthe Jezraelita, composta forse attorno al 395, a poca distanza dalla morte di Ambrogio che avverrà il 4 aprile 397, dopo 22 anni di episcopato.
Col titolo esplicativo Il prepotente e il povero e con l’incisivo testo latino a fronte, questo scritto ambrosiano viene proposto come archetipo della collana intitolata Vetera et nova, che le edizioni San Paolo hanno inaugurato per far conoscere in maniera agile ma efficace le piccole gemme della letteratura cristiana antica e medievale, con particolare attenzione alla loro "attualità" e alla loro capacità di graffiare anche la contemporaneità.
La limpida introduzione di Alberto Grosso chiarisce non solo l’itinerario biografico di Ambrogio, ma anche il nodo tematico che è ben espresso dal titolo apposto. Da un lato, infatti, si ha la prevaricazione del potere e della ricchezza sul povero; d’altro lato, però, si centra un punto capitale dell’autentica concezione dell’economia, la sua strumentalità e non il suo essere il fine a cui tutto sacrificare. Questo vale anche per la proprietà privata che è semplicemente uno dei mezzi per attuare il vero fine, cioè la destinazione universale dei beni creati da Dio e offerti all’intera umanità. Come scrive Grosso, nel testo di Ambrogio «si configura una necessaria prospettiva etica in cui il valore "uomo" viene posto al centro dell’attività economica. L’economia è per l’uomo» e non viceversa.
Per i lettori che non hanno molta assuefazione con la Bibbia vorremmo solo spiegare il titolo originario latino a prima vista un po’ criptico. Protagonista è un contadino di nome Nabot, la cui vicenda è narrata vivacemente nel capitolo 21 del Primo Libro dei Re. Il re di Israele di quel tempo (IX secolo a.C.) è Acab, dominato dall’ambiziosa moglie, una principessa fenicia di nome Gezabele. Egli vorrebbe allargare il parco della sua residenza di campagna a Izreel, nella pianura settentrionale del suo regno.
Ma il proprietario della vigna confinante, che è appunto Nabot, appella al diritto ereditario familiare di proprietà, inalienabile secondo la stessa legislazione ebraica. A questo rifiuto il re non riesce a opporre validi motivi per raggiungere il suo scopo e cade in depressione.
Entra, allora, in scena la regina Gezabele che non ha scrupoli morali e che escogita un piano diabolico. Ricorrendo a testimoni subornati, fa istruire un processo farsa nel quale a Nabot si imputa la falsa accusa di aver maledetto Dio e il re, un delitto gravissimo che prevedeva la pena della lapidazione. Ed è ciò che la magistratura compiacente attua, eliminando così ogni ostacolo al desiderio di Acab.
Ma nel silenzio complice dei sudditi che non osano contestare il potere, si leva forte e solitaria la voce del profeta Elia che, senza attenuanti, denuncia il crimine: «Hai assassinato e ora usurpi! Per questo dice il Signore: Nel punto ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno il tuo sangue!... I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreel!» (1Re 21, 19.23).
La predizione si avvererà anni dopo quando un sanguinoso colpo di Stato eliminerà tragicamente la coppia reale. Le voci di Elia, Ambrogio e Turoldo si intrecceranno, dunque, nell’unico messaggio, quello della vera giustizia che non conosce eccezioni.
 Ambrogio di Milano,
Il prepotente e il povero. La vigna di Nabot
, a cura di Alberto Grosso, San
Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), pagg. 120, € 9,90
Ambrogio di Milano,
Il prepotente e il povero. La vigna di Nabot
, a cura di Alberto Grosso, San
Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), pagg. 120, € 9,90
 Si veda anche, nella stessa collana e dello stesso autore, s. Ambrogio,
Il buon uso del denaro. Il
tesoro di Tobi
, pagg. 160, € 9,90
Si veda anche, nella stessa collana e dello stesso autore, s. Ambrogio,
Il buon uso del denaro. Il
tesoro di Tobi
, pagg. 160, € 9,90 -
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- DANTE, I "DUE SOLI", E L’AMORE ("CHARITAS").2 gennaio 2014, di Federico La SalaDANTE, I "DUE SOLI", E L’AMORE ("CHARITAS"). Il teologo della Chiesa cattolico-romana Gianfranco Ravasi rilegge il canto X del "Paradiso" e continua a sorprendersi che "con una decina di parole Dante riesca a formulare la dottrina cattolica della Trinità"!?! E continua a non chiedersene la ragione
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI.18 dicembre 2013, di Federico La SalaLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI.. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"!
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! --- Donne nella luce dell’amore (di Gianfranco Ravasi}9 dicembre 2013, di Federico La Sala
Donne nella luce dell’amoredi Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 Ore, 8 dicembre 2013)
C’è anche la foto dell’ultimo scritto, una cartolina indirizzata a una sua giovane insegnante e poi amica, Christine van Nooten, una studiosa di letteratura classica che morirà nel 1998: Etty Hillesum il 7 settembre 1943 la getterà dal carro merci che sta conducendo lei e i suoi genitori al lager di Auschwitz, ove tre settimane dopo - il 30 settembre - entrerà nella camera a gas. Scriveva: «Apro a caso la Bibbia e trovo questo: "Il Signore è il mio alto rifugio". Sono seduta sul mio zaino nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Mischa (suo fratello) sono alcuni vagoni più avanti... Abbiamo lasciato il campo (di Westerbork, ove era prima detenuta) cantando... Arrivederci da noi quattro».
Questo "arrivederci" straziante ovviamente non si compirà e la vita di questa donna ebrea olandese, bella, straordinariamente intelligente e dotata di un’anima mistica, delicata e forte, verrà brutalmente spenta dalla bestialità nazista a soli 29 anni. Abbiamo già presentato la riedizione adelphiana del suo Diario; ora vogliamo solo invitare i nostri lettori a non perdere la raccolta delle Lettere, scritte in gran parte dal lager di Westerbork ove Etty (Ester) di sua volontà si era autoreclusa per gettare un seme d’amore e una scintilla di luce nell’"inferno degli altri". La fede, la Bibbia, la poesia (in particolare Rilke), il cielo solare o nuvoloso o stellato saranno il cuore spirituale di quei giorni, umanamente tenebrosi, che avvolgevano gli internati rendendoli cupi, rancorosi e infelici.
Sarà abusata l’immagine, ma Etty è come un angelo che irradia luce, senza però perdere il realismo di un’esistenza umiliata in un campo recintato all’interno di una brughiera sul quale s’abbattono folate di sabbia. Un realismo che conosce i piccoli egoismi delle stesse vittime e la brutalità dei carcerieri, ma anche la gioia di un pacco viveri, dell’arrivo e dell’invio di un biglietto o di un’amicizia che sboccia. Ogni commento a queste lettere della Hillesum o a lei indirizzate, che non sia quello necessario storico-critico (offerto in questa edizione), risulta dissonante e fin sgraziato. La lettura basta a se stessa.
È per questo che non aggiungiamo altro se non una citazione tra le tante possibili. "La miseria che c’è qui è veramente terribile. Eppure, la sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare lungo il filo spinato, e allora dal mio cuore si innalza sempre una voce - non ci posso far niente, è così, è di una forza elementare - e questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande, più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo".
Ad Auschwitz un anno prima, nel 1942, veniva avviata nelle stesse camere a gas un’altra donna di straordinaria intelligenza, un’ebrea tedesca convertitasi al cattolicesimo, Edith Stein, discepola prediletta del filosofo Edmund Husserl. Battezzata a 31 anni nel 1922, entrata nel Carmelo di Colonia nel 1933 col nome di Teresa Benedetta della Croce, verrà proclamata santa da Giovanni Paolo II nel 1997.
Alla vasta bibliografia di lei e su di lei si aggiunge ora un particolare ritratto spirituale disegnato da una sua "consorella" attuale, la carmelitana Cristiana Dobner, che si è da tempo dedicata allo studio di Edith-Teresa Benedetta. Il profilo viene tracciato secondo tre lineamenti, usando altrettante testimonianze che intarsiano tutte le pagine del suo volumetto.
C’è innanzitutto il racconto autobiografico della donna col suo itinerario personale spesso travagliato, segnato da "indici di contrasti", e alla fine collocato all’insegna della luce di Cristo e della tenebra della Shoah. C’è, poi, il filo sia della riflessione filosofica fenomenologica, la prima sua patria ideale (la sua opera maggiore sarà, al riguardo, Endliches und ewiges, l’Essere finito ed eterno"), sia dell’esperienza spirituale, elaborata attraverso scritti di appassionata attestazione mistica (e qui brilla la Kreuzeswissenschaft, una "scienza della croce" che è anche adesione esistenziale).
Infine nelle pagine della Dobner occhieggiano le parole di coloro che hanno incrociato la vita di Edith a diverso titolo e nelle differenti tappe della sua vicenda personale. Suggestiva la testimonianza della nipote, Susanne Batzdorff-Biberstein: «Chi fosse veramente, come abbia vissuto e sia morta, rimarrà per sempre il suo segreto». Tutto converge appunto verso il mistero della morte, soglia apparentemente oscura, in realtà aperta su un roveto ardente di una fiamma divina.
Concludiamo questa recensione al femminile con una vera e propria galleria di ritratti di "tenacemente donne". Sono dodici, molto diverse tra loro, convocate da due giornaliste, la lombarda Alessandra Buzzetti e la siciliana Cristiana Caricato. Che cosa può unire tra loro Clara, la figlia del famoso genetista Lejeune, ascesa al vertice della General Electric France, e l’operaia romagnola part-time Cristina con tre figli e un marito disoccupato? Oppure Jocelyne, comandante delle milizie femminili dell’Esercito libanese, e Nasreen, missionaria francescana in Pakistan? O ancora la giornalista Costanza Miriano con Marcella volontaria in una casa di accoglienza? O Nancy, analista finanziaria della Walt Disney, e una giovane madre romana, Chiara Corbella Petrillo, morta di cancro?
La risposta la si scopre lasciandosi condurre da questi dodici racconti biografici, vere e proprie "storie di vita" nel senso più alto del termine: sfogliando le pagine di questo libro - per usare un’immagine poetica rilkiana - le dita rimarranno segnate dalla polvere di luce dell’amore, come quando si afferrano le ali di una farfalla. L’enfasi della metafora è smitizzata però, dal realismo di queste vicende femminili che si confrontano tutte col respiro di sofferenza, di miseria, di necessità del prossimo, mettendo in gioco successo personale, carriera e la stessa vita. E su tutte sembrano echeggiare le parole pronunciate da Gesù l’ultima sera della vita terrena: «Non c’è amore più grande di colui che dà la vita per gli amici» (Giovanni 15,13).
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- RAVASI E L’ORIZZONTE TEOLOGICO DELLA COMMEDIA DI DANTE (di Franca Giansoldati)13 ottobre 2013, di Federico La Sala
Ravasi e Dante, l’orizzonte teologico della Commedia
di Franca Giansoldati (Il Messaggero, 12 ottobre 2013)
Dante Alighieri? Il sommo, il vate, il cantore di Enea, il maestro, il padre della lingua italiana ma anche (perché no?) il geniale architetto che con le parole progettava e rendeva omaggio alla grandezza di Dio. «L’Amor che move il sole e l’altre stelle». Dante, a modo suo, sembra davvero farsi posto tra i grandi costruttori delle cattedrali medievali dove estetica ed etica hanno coabitato in modo indivisibile, promuovendosi a vicenda, riempiendo di significati e simboli le pagine della Commedia.
Gianfranco Ravasi, ministro della cultura di Papa Francesco ma soprattutto biblista di fama internazionale, ha passato a setaccio tutte le terzine del Vate, scoprendo che la base biblica e teologica della Commedia possiede una struttura profonda, intrisa di esegesi e di riflessioni spirituali. La poetica dantesca, insomma, va a braccetto con le Sacre Scritture, si confonde, si mescola, fino a fondere l’orizzonte con quello della spiritualità.
Tra i tre canti forse il Paradiso più di tutti rimane il luogo poetico e spirituale dove meglio risuona il canto salmico. Ravasi, come se fosse un detective, ricerca ogni indizio teologico ed elenca ben dieci citazioni, incluso un passaggio ispirato all’evangelista Matteo, per un totale di ben 8 salmi del Salterio, uno dei libri anticotestamentari capitali nella tradizione cristiana. Dante è letteralmente conquistato dalla salmodia. Il salmo 51 («Cantando miserere a verso a verso»), il salmo 114 («In exitu Israel de Aegypto»), il 32 («Beati quorum tecta sunt peccata»). Oppure, per esempio, quando dice “Miserere” nel canto I dell’Inferno.
Enrico Malato, il dantista numero uno in Italia, nella prefazione di I salmi nella Divina Commedia (Salerno Editrice, 90 pagine 7,90 euro) a sua volta ha fatto notare che «miserere» nel canto I dell’Inferno è la prima parola che Dante personaggio pronuncia nel poema e sarà anche l’ultima «prima della sua immersione nel tripudio della candida rosa, attraverso una allusione, nel discorso di San Bernardo: «Al cantor che per doglia; del fallo disse, miserere mei».
Ravasi, in questo libro, si spinge addirittura più in là facendo notare che c’è chi ha confrontato l’escatologia dantesca con quella sottesa a opere letterarie e teologiche arabe o addirittura ad un orizzonte ancora più lontano, collocando Dante tra induismo ed eresie medievali. In ogni caso il Vate dimostra di possedere la moneta della fede, «cioè il tesoro prezioso evocato prima da san Pietro», e di averla nella pienezza della sua brillantezza e perfezione («lucida e tonda»), così da non mettere in forse («s’inforsa») in nessun modo la sua piena e totale autenticità («conio»).
Ravasi annota: «Il suo sguardo è sempre stato fisso a quel cielo ove brilla la luce della trascendenza». Dante induce a contemplare l’infinito e l’eterno. Non per altro conclude che l’unicità e la trinità divina, le due Verità, sono simili a «una favilla», a una scintilla di luce «che si dilata in fiamma poi vivace», in un fiammeggiare che rischiara il firmamento dell’anima. Alighieri dimostra di avere una altissima conoscenza delle Sacre Scritture ovvero il suo retroterra culturale e spirituale. Basti solo pensare all’incipit della Commedia tratto da Isaia: «A metà dei miei giorni me ne vado alle porte degli inferi»
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- PRESIEDERE NELLA CARITA’: LA PUNTA DI UN ICEBERG.20 maggio 2013, di Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- «È un culto blasfemo, una degenerazione della religione» (di Pablo Lombo - “Adorare la Sante Muerte è un atto di blasfemia”).10 maggio 2013
“Adorare la Sante Muerte è un atto di blasfemia”
di Pablo Lombo (La Stampa, 10 maggio 2013)
«È un culto blasfemo, una degenerazione della religione». Con queste parole il cardinal Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha condannato l’adorazione della Santa Muerte, diffusa in Messico soprattutto negli ambienti criminali.
Parlando a Città del Messico, a margine di una serie di eventi per il dialogo tra credenti e non credenti, ha denunciato un culto che risale alle tradizioni indigene latino-americane, poi fuso con l’evangelizazzione dei missionari spagnoli: la Santa Muerte, rappresentata come una scheletro di donna riccamente vestito.
I devoti la pregano su altari allestiti in casa, circondati dalle loro offerte: candele, cibi, bevande come la tequila, droghe come la marijuana. Recitano la formula-preghiera per invocarla, le chiedono favori, in genere quelli che gli altri santi non possono offrire. E anche i loro doni sarebbero irricevibili per gli altri santi.
Il cardinal Ravasi ha definito queste pratiche «antireligiose», aggiungendo: «La religione celebra la vita, ma qui c’è solo morte. Non basta prendere le forme di una religione perché ci sia religione. Questa è blasfemia». Anche perché il culto è particolarmente popolare nelle zone del Messico dove più imperversa il cartello della droga.
Per il cardinale è importante che un Paese come il Messico, dove si stima che 70 mila persone siano state uccise negli ultimi sei anni in atti di violenza legati alla droga, mandi un chiaro segnale ai giovani: «La mafia, il traffico di droga e il crimine organizzato non hanno aspetti religiosi, non hanno niente a che vedere con essa, anche se usano l’immagine della Santa Morte».
Non ci sono statistiche sui devoti ma in Messico, così come nelle comunità messicane degli Stati Uniti, spuntano sempre più luoghi di culto. E accadono eventi inquietanti, come quello del marzo 2012, quando due bambini e una donna sono stati uccisi nello stato di Sonora (al confine con gli Stati Uniti) da un gruppo di otto persone che hanno poi ammesso di aver versato il loro sangue sull’«altare» della Santa Muerte per chiedere la sua protezione.
Come tutti i santi, anche questa ha una sua festa, el «Día de Muertos», Ognissanti, il primo novembre. Quel giorno tutti i cimiteri si riempiono di musica, fiori, balli e pietanze per rendere omaggio alla morte dei propri cari (familiari e amici ma anche star del cinema o della musica).
Nonostante i tentativi degli evangelizzatori di sradicare questa tradizione indigena, esse è rimasta viva, pur trasformata nel corso dei secoli. In passato il culto è stato condannato dai parroci e dai vescovi perché legato alla stregoneria popolare ma è sempre sopravvissuto con riti clandestini.
Nel 1992, con la riforma della Legge per le Associazioni religiose e il culto pubblico, la Iscat, la «Iglesia Católica Tradicional Mex-Usa» - vincolata, secondo i suoi seguaci, alla Successione Apostolica della Chiesa Brasiliana - ha acquisito personalità giuridica ed è diventata la dimora della «Santa Muerte».
Ma nel 2007 il Ministero dell’Interno del Paese ha cancellato questo status giuridico. Indifferenti a questi aspetti formali, i narcos, ma anche i membri di gruppi come la Mara Salvatrucha, continuano a pregare la loro «Santa Muerte» e a chiederle potere, protezione, fortuna, amore e pure la felicità.
-
>CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- "LUMEN GENTIUM" o "DOMINUS IESUS"?!17 febbraio 2013, di Federico La Sala
-
> CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- Questo è il problema: l’attuazione del Concilio o il definitivo affossamento!17 febbraio 2013, di Federico La Sala
Se la magia del sacro è sconfitta
di Raniero La Valle (il manifesto, 17 febbraio 2013)
Quasi volesse non farsi rimpiangere, il papa alla fine si è lasciato andare ad una confidenza che ha svelato tutta la difficoltà che sul piano personale egli ha avuto nel vivere il Concilio come una delusione. Nella «chiacchierata» in cui ha raccontato come lui «ha visto» il Vaticano II, c’è forse la chiave per capire come non gli bastassero più le forze per guidare una Chiesa che, come aveva detto nel 2005 nel suo primo discorso alla curia, nel Concilio aveva avuto la sua vera «discontinuità» riconciliandosi con l’età moderna, quella modernità che egli non ha invece ancora accettato e che patisce come «relativismo».
Questo risvolto personale del suo difficile rapporto col Concilio, che già era venuto fuori in un suo discorso estivo, in montagna, al clero del Triveneto, quando aveva negato che dal Concilio potesse scaturire «la grande Chiesa del futuro», è emerso con grande sincerità nel suo discorso di giovedì a un altro clero particolare, quello di Roma. Al presbiterio di cui, come vescovo di Roma, è il capo, Benedetto XVI ha voluto parlare come se fosse uno dei vescovi che aveva partecipato al Concilio, sul filo dei ricordi personali, piuttosto che con «un grande, vero discorso» da papa.
Da questa confidenza risulta che nel vissuto di Ratzinger non c’è stato un solo Concilio, ma ci sono stati diversi concili. Il primo, l’unico che gli sia veramente piaciuto, è stato quello dell’entusiasmo iniziale, quando «speravamo che tutto si rinnovasse, che venisse veramente una nuova Pentecoste». Il secondo è quello soprattutto condotto dall’«alleanza renana», cioè dai vescovi francesi, tedeschi, belgi, olandesi, che vi hanno introdotto i temi «più conflittuali», come quello del rapporto tra papa e vescovi (con quella discussa parola, «collegialità», a cui forse Ratzinger avrebbe preferito «comunione»), la «battaglia» sul rapporto tra scrittura e tradizione, la «lite» sull’esegesi che tenderebbe «a leggere la scrittura fuori della Chiesa, fuori della fede», l’ecumenismo.
Poi c’è stato il terzo Vaticano II, in cui «sono entrati con grande forza nel gioco del Concilio» gli americani degli Stati Uniti e dell’America Latina, l’Africa, l’Asia: ed è stata la fase della responsabilità per il mondo, della libertà religiosa, del dialogo tra le religioni, per cui «sono cresciuti problemi che noi tedeschi all’inizio non avevamo visto»; e sono nate le grandi questioni del rapporto non solo con gli ebrei, ma con l’Islam, il buddismo, l’induismo; e qui la cosa che è ancora «da capire meglio» è il rapporto tra la sola vera religione e le altre di cui un credente non può pensare, secondo il papa, che «siano tutte varianti di un tema», anche se le esperienze religiose portano «una certa luce della creazione». Molti problemi aperti dal Concilio sono dunque ancora «da studiare» e molte applicazioni non sono ancora complete, sono «ancora da fare».
Ma la contraddizione principale che il papa dice di aver vissuto, è stata tra il «vero Concilio», che era quello dei padri e il Concilio dei media. Il primo era un Concilio della fede che si realizzava nella fede, il secondo era il Concilio dei giornalisti che si realizzava non nella fede, ma nelle categorie politiche di una lotta per il potere nella Chiesa. Starebbe nel fatto che il Concilio giunto alla Chiesa, reso accessibile a tutti, fosse quello dei giornalisti e non quello «reale», la vera causa della crisi della Chiesa: «tante calamità, tanti problemi, realmente tante miserie: seminari chiusi, conventi chiusi, liturgia banalizzata»; sarebbe questo Concilio dei media che avrebbe invaso le chiese, profanato la liturgia, negato il culto, trasformato il «popolo di Dio» nella «sovranità popolare», messo fine alla religione del sacro, intesa come «cosa pagana».
Sicché il vero Concilio, l’ultimo, starebbe arrivando ora, dopo 50 anni, che sono i decenni in cui i vescovi se ne sono stati a casa, la Chiesa è stata sottoposta alla robusta cura romana, la controriforma è giunta a buon punto, la liturgia restaurata e i giornalisti, non dovendo più misurarsi con la missione e la fede della Chiesa, sono tornati a fare i «vaticanisti».
È un peccato che su questo punto cruciale dei media il Papa sia male informato e forse, allora, non abbia capito il Concilio. Ed è singolare che oggi si attribuiscano tutti i mali della Chiesa a quelli che, nelle due prime parole del primo documento del Concilio, Inter mirifica , erano definiti «cose meravigliose», cioè appunto i mezzi di comunicazione sociale. È vero invece che si è rischiato che ci fossero due Concili: un Concilio dei padri, e un Concilio dei media.
Ma questo era il progetto della Chiesa preconciliare, che aveva creduto di nascondere il Concilio chiudendone le porte e decretandone il segreto, lasciando ai giornali la sola via dello «scoop»; ma questo finì subito, all’inizio della seconda sessione, quando il segreto fu rotto, e il Concilio irruppe nella coscienza dei fedeli e nel popolo di Dio, che nessuno mai pensò di paragonare al popolo sovrano, come nessuno interpretò le discussioni teologiche sulla sacramentalità dell’episcopato e la successione dei vescovi al collegio degli apostoli come una «lite» o lotta di potere, come ora il papa rivela che per molti sia stato, dicendo addirittura che nel Concilio dei padri «forse qualcuno ha anche pensato al suo potere».
E quello che allora il giovane prof. Ratzinger non vide fu che tra i giornalisti che «fecero» il Concilio c’erano uomini di grandissima fede: per esempio l’abbé Laurentin, mariologo, per Le Figaro , Jean Fesquet e poi Nobécourt per Le Monde , Grootaers per l’Olanda, Juan Arias per El Pais , e tra gli italiani cristiani come Giancarlo Zizola, Ettore Masina, Lamberto Furno, e anche Gianfranco Svidercoschi, che poi addirittura diventò vicedirettore dell’ Osservatore Romano ; e padre Caprile della Civiltà Cattolica ; e padre Roberto Tucci, oggi cardinale, e mons. Clemente Riva, poi vescovo ausiliare di Roma, che ogni giorno informavano i giornalisti italiani dei contenuti, e non solo delle coreografie, dei lavori.
Quanto a me, se è lecito aggiungere ricordi a ricordi, papa Giovanni scrisse sul suo diario, dopo avermi ricevuto una mattina dell’agosto 1961: «Ho ricevuto il giovane (30 anni!) direttore dell’ Avvenire d’Italia , una promessa per la causa cattolica»; e L’Avvenire d’Italia, a spese della Santa Sede, fu mandato a tutti i padri conciliari per tutto il corso del Concilio, e non credo che ciò fosse per spiantare la Chiesa.
Ma io ora sono grato al papa che ci lascia, perché andandosene ci dice che proprio questo è il problema: l’attuazione del Concilio, la fede per l’età moderna, una Chiesa non incapsulata nella magia idolatrica del sacro.
-
-
> CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- DAL "DEUS CARITAS EST" DI BENEDETTO XVI AL "DEUS CHARITAS EST" DEL CARDINALE ANGELO COMASTRI?17 febbraio 2013, di Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Ritrovare insieme la forza degli ideali. L’intervento integrale di Napolitano per il settantesimo compleanno del presidente del Pontificio Consiglio della Cultura9 febbraio 2013, di Federico La Sala
 Ritrovare insieme la forza degli ideali
Ritrovare insieme la forza degli ideali
 Il contributo del Capo dello Stato nel libro dedicato al cardinale Ravasi
Il contributo del Capo dello Stato nel libro dedicato al cardinale Ravasi «Vedo materia di dialogo tra credenti e non credenti»
«Vedo materia di dialogo tra credenti e non credenti» L’intervento integrale di Napolitano per il settantesimo compleanno del presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
L’intervento integrale di Napolitano per il settantesimo compleanno del presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
 Il comunismo venne travolto dal collasso dei regimi che ad esso si ispiravano in Europa e in Urss
Il comunismo venne travolto dal collasso dei regimi che ad esso si ispiravano in Europa e in Urss
 L’ideologia conservatrice ha assunto sempre più le sembianze di un fondamentalismo di mercato *
L’ideologia conservatrice ha assunto sempre più le sembianze di un fondamentalismo di mercato *MI ASSOCIO BEN VOLENTIERI ALL’OMAGGIO CHE VIENE RESO A SUA EMINENZA IL CARDINALE GIANFRANCO RAVASI, FIGURA EMINENTE DELLA CHIESA CATTOLICA E PERSONALITÀ PIÙ GENERALMENTE RICONOSCIUTA DEL MONDO DELLA CULTURA: uomo aperto a ogni dialogo, come ho potuto anche personalmente sperimentare.
Spero dunque che questo mio contributo, senza avere come altri la dimensione e il livello dello «studio in onore» del festeggiato, possa essere accolto come proposta «di ulteriore dialogo», o di riflessione comune, su un tema che ci sollecita entrambi. Il tema, cioè, della «componente ideale» propria di una seria scelta politica.
Parlai, in una mia lezione (all’Università di Bologna) nel gennaio 2012, dell’«appannarsi di determinati moventi dell’impegno politico, inteso come impegno di effettiva e durevole partecipazione» (individuale e collettiva). E indicai, tra i moventi che si sono affievoliti, quella che anche moderni scienziati della politica hanno chiamato «la forza degli ideali».
È un fenomeno che ha accompagnato il mio peraltro fisiologico distacco dall’attività politica o più concretamente partitica e che - nel tirare autobiograficamente le somme della mia lunga esperienza - definii «grave e allarmante». Impoverimento culturale della politica, sua «sfrenata personalizzazione - smania di protagonismo, ossessiva ricerca dell’effetto mediatico» - e nel contempo «perdita, da parte dei partiti, di radicamento sociale e di vita democratica nelle istanze di base», insieme col crescere di «una diffusa spregiudicatezza nella lotta per il potere e nella gestione del potere».
Il visibile impoverimento ideale e culturale della politica ha rappresentato il terreno di coltura del suo inquinamento morale. E non è questa la sede in cui interrogarmi sul futuro, su una possibile, graduale ma netta, inversione di tendenza. Posso tutt’al più ribadire programmaticamente la mia fiducia nella conclusione che Thomas Mann suggeriva ai tedeschi nel pieno della catastrofe provocata dalla degenerazione estrema della politica, quella del barbarico totalitarismo e bellicismo nazista : «la politica non potrà mai spogliarsi del tutto della sua componente ideale e culturale, mai rinnegare completamente la parte etica e umanamente rispettabile della sua natura».
Ma come - ecco quale può essere la materia di un dialogo rinnovato e approfondito - va intesa quella «componente ideale»? Come ha operato politicamente nel passato vissuto dalla mia e da altre generazioni «la forza degli ideali»? Ha operato, si può rispondere, nella forma delle ideologie, di grandi ideologie contrapposte, e oggi invece non è così che si può intendere la rinascita di una «componente ideale» come molla e guida dell’agire politico.
In effetti, non spiega molto, e non ha mai spiegato molto, la formula che a suo tempo diventò di moda: «la fine (o la morte) delle ideologie». Anche perché l’attenzione si concentrò, comprensibilmente, sul crollo di una ideologia: quella comunista, travolta nel collasso dei regimi che ad essa si ispiravano, in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica. Molto più limitata, e sfuggente, rimase ed è rimasta la rivisitazione - e la stessa ri-definizione - dell’ideologia che si era contrapposta a quella comunista: ideologia del libero mercato, ovvero di uno sviluppo capitalistico affidato al libero giuoco delle forze di mercato? O ideologia delle istituzioni liberal-democratiche dell’Occidente come punto d’arrivo della storia?
Comunque, l’ideologia conservatrice è sopravvissuta alla fine del comunismo, assumendo sempre più le sembianze di quel «fondamentalismo di mercato», tradottosi in deregulation e in abdicazione della politica, che solo la crisi finanziaria globale scoppiata nel 2008 avrebbe messo in questione.
Certo, è stato impossibile - se non per piccole cerchie di nostalgici sul piano teoretico e di accaniti estremisti sul piano politico - sfuggire alla certificazione storica non solo del fallimento dei sistemi economici e sociali d’impronta comunista, ma del rovesciamento di quell’utopia rivoluzionaria che conteneva in sé promesse di emancipazione sociale e di liberazione umana e che aveva finito - come, con fulminante espressione, disse Norberto Bobbio - per «capovolgersi», nel convertirsi di fatto nel suo opposto. Anche se può discutersi l’uso - a proposito del movimento comunista e della sua visione - del termine «utopia».
Vale senza dubbio, in riferimento allo svolgimento, sempre più involutivo, di quell’esperienza, il fondamentale avvertimento di Isaiah Berlin, che riconosceva tutto il valore delle utopie, ma aggiungeva che «come guida al comportamento possono rivelarsi letteralmente fatali». In effetti, la dottrina e la prassi comuniste - che pure esprimevano una pretesa di scientificità («l’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza») - avevano proprio la rigidità, onnicomprensività e autosufficienza di una ideologia militante.
Ma non è possibile - ecco ancora un interrogativo attorno al quale varrebbe forse la pena di dialogare - secernere da ideologie contrapposte, riconsiderate nella loro ascesa e nel loro declino, riferimenti positivi per individuare quella irrinunciabile «componente ideale» della politica da cui sono partito in questo mio abbozzo, o proposta, di riflessione?
Non si può confondere, sia chiaro, «la forza degli ideali» o la motivazione ideale che spinge all’agire politico e dovrebbe sorreggerlo, con un approccio fideistico: e invece ritengo - basandomi sulla mia personale esperienza e memoria - che nell’adesione e nell’attaccamento di tanti al Partito Comunista, quale risorse in Italia dopo la liberazione dal fascismo, un elemento di fideismo vi fu, e venne anche dall’alto della sua dirigenza. In un singolare quanto spurio confronto - aggiungo - con il fideismo religioso: non si giunse (da parte comunista) in quegli anni di nuovo inizio, a parlare di «due fedi»? O - in termini già un po’ meno ideologici e più politici - di «due universalismi»?
Ciò di cui parlo è dunque altro: un pieno e limpido, razionale recupero a una visione laica della politica degli ideali della libertà (politica e anche economica), della giustizia, promozione e protezione sociale, della solidarietà come dovere e sentimento individuale e come responsabilità e prassi collettiva, del più ricco sviluppo della persona e della costruzione di un ordinamento fondato su ineludibili diritti e doveri comuni.
Non possono questi ideali, sottratti agli irrigidimenti e alle estremizzazioni di carattere ideologico, essere perseguiti attraverso programmi e indirizzi diversi, nel vivo di una competizione politica e culturale democratica, e costituire al tempo stesso il sostrato comune di un impegno costituzionale, al livello nazionale e al livello europeo? Non si può forse già cogliere un quadro di risposte tanto - per parlare dell’Italia - nell’impianto della Costituzione repubblicana, quanto nelle formulazioni di principio su cui si è fondata e si fonda la costruzione dell’Europa unita?
Vedo in tutto ciò materia di dialogo anche tra credenti e non credenti. Perché i credenti, e segnatamente i cattolici italiani, hanno il loro punto di vista da far valere e il loro contributo da dare. È un fatto che nei principi e negli indirizzi costituzionali sanciti sia in termini nazionali sia in termini europei (tra questi ultimi, quelli riassumibili nell’ancoraggio a una «economica sociale di mercato»), si sono calati valori sentiti come autenticamente cristiani. Quanto l’adesione a questi valori possa essere vissuta in termini di fede e in sintonia con la pratica religiosa, è aspetto non secondario dell’approfondimento e della riflessione comune che sollecito sulla possibile, necessaria rinascita della componente ideale e morale dell’agire politico. Approfondimento, riflessione, cui da pochi può venire un apporto alto e sereno come da Gianfranco Ravasi.
* l’Unità, 09.02.2013
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- (Teologia e) Politica senza visione, è rimasto il vuoto. Intervista a Ganfranco Ravasi (di Gian Guido Vecchi).1 febbraio 2013, di Federico La Sala
«Politica senza visione, è rimasto il vuoto»
di intervista a Gianfranco Ravasi,
a cura di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 01.02.2013)
«Vede, c’è una frase dal Diario di Søren Kierkegaard che amo citare: "La nave è ormai in mano al cuoco di bordo", scrive il filosofo danese, "e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani"». Il cardinale Gianfranco Ravasi abbozza un sorriso un po’ mesto, il presidente del Pontificio consiglio per la cultura ha appena presentato l’assemblea che il dicastero vaticano dedicherà dal 6 al 9 febbraio ai giovani, aperta da un’udienza con Benedetto XVI, e risposto pure alle domande dei ragazzi che gli arrivavano via Twitter, un senso diffuso di estraneità e desolazione, la «tristezza» dei tagli alla cultura, una campagna elettorale che esclude i giovani.
Già il livello del dibattito spesso non aiuta, ma il fatto è che «non possiamo avere una politica che sia esclusivamente di tipo economico, per quanto importanti siano quei temi», sospira il cardinale. «La pólis greca aveva anche la presenza di sapienti. Perché una società ha bisogno di questo respiro, delle grandi prospettive. C’è anche un Pil del benessere, della felicità. E invece ciò che manca alla politica - come peraltro, penso, qualche volta anche alla Chiesa - è proprio la capacità di presentare visioni globali vere e proprie: visioni globali della persona, della società e del mondo».
Manca la classica Weltanschauung, si direbbe, una visione del mondo, e meno male che ci si era rallegrati della morte delle ideologie... «Sì, è vero, ne hanno celebrato i funerali ed erano tutti contenti perché erano state sepolte, le ideologie. Risultato: è rimasta una piattaforma sabbiosa e arida, certe volte il vuoto. Non c’è neppure più l’assenza di qualcosa».
In che senso, eminenza? «Lo scrittore Georges Bernanos distingueva tra vuoto e assenza. Perché parlare di assenza significa almeno avvertire che qualcosa manca. Ma il momento peggiore è questo: quando non ne avverti più neppure il bisogno. L’indifferenza. Tutto uguale, tutto irrilevante».
Il grande biblista ricorda che «otto secoli prima di Cristo, quando vuole esprimere che siamo arrivati al disastro, Isaia dice: "Guardai in giro e non c’era più nessuno da interrogare per avere una risposta". Si dovrà tornare a dare quelle risposte che ormai non risuonano più, nella cultura contemporanea».
Mentre presentava l’assemblea sulle «Culture giovanili emergenti», il cardinale Ravasi ha citato le parole di San Paolo a Timoteo: «Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii tu di esempio...». Bisognerebbe «prestare più attenzione ai giovani anche nella Chiesa, dove dovrebbero poter accedere anche a incarichi di responsabilità», ha spiegato. E ora sorride: «E Timoteo era un vescovo!». Ma il discorso, chiaro, è più ampio e riguarda la società in generale, «la classe dirigente», la politica. Che fa, sostiene la cosiddetta rottamazione? Il «ministro» vaticano della Cultura scuote la testa divertito: «Immaginavo saltasse fuori ma no, la cosa è più complessa.
È necessario dire a quelli che si sono insediati brutalmente che è ora di fare intervenire anche i giovani, aprire a un nuovo vento. E i giovani devono cominciare a prendersi le loro responsabilità e a entrare in scena, tenendo conto però del fatto che non si comincia mai da zero.
La rottamazione, se considerata come demolizione, è pericolosa. È vero quello che Giovanni di Salisbury attribuisce a Bernardo di Chartres, nel XII secolo: "Siamo nani sulle spalle dei giganti". Significa che riusciamo a vedere più lontano perché facciamo tesoro del passato».
Qui sta l’«ingenuità della rottamazione», riflette: «È la pretesa di dire: alziamoci, tocca a noi. Ma per vedere più lontano bisogna avere un passato. E una delle crisi della società contemporanea è di essere smemorata, o di non voler memoria. Chi non ricorda, però, non vive».
Così Ravasi si rivolge ai giovani e alle loro domande, consapevole dello scarto. «Mi sono persino esposto all’ascolto di un cd di Amy Winehouse per averne la prova immediata», ha scherzato.
«Eppure in quei testi così lacerati musicalmente e tematicamente emerge una domanda di senso comune a tutti». Quei ragazzi che sono consapevoli «della media, del grigio, della mucillagine». Ha ragione Pascal, conclude il cardinale: «"L’uomo supera infinitamente l’uomo". Non si accontenta. Lascialo pure così, fallo stupido, consideralo stupido, però alla fine, soprattutto se giovane, andrà oltre».
-
> SI SCRIVE "CARITAS", SI LEGGE ACCENTRAMENTO. BENEDETTO XVI CHIUDE IL CERCHIO.12 dicembre 2012, di Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Ravasi: «Ci sono vescovi che non capiscono il latino» (di Gian Guido Vecchi - Intervista).11 novembre 2012, di Federico La Sala
Ravasi: «Ci sono vescovi che non capiscono il latino»intervista a Gianfranco Ravasi,
a cura di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 11 novembre 2012)
«I giovani preti? Se è per questo pure diversi vescovi fanno fatica, anche all’ultimo sinodo un po’ si rideva, molti hanno una difficoltà quasi strutturale a leggere e comprendere il latino, anche fra gli europei, e dico quello ecclesiastico che è molto più semplice della lingua di Cicerone...». Il cardinale Gianfranco Ravasi sorride con una punta di mestizia, come presidente del Consiglio della Cultura vaticano sarà lui a controllare la nuova «Pontificia Accademia di Latinità» (Pontificia Academia Latinitatis) che Benedetto XVI ha istituito ieri con un motu proprio nel quale scrive (in latino, ovvio) quanto sia «urgente» contrastare «il pericolo di una conoscenza sempre più superficiale». La Chiesa, aggiunge il Papa, è da duemila anni «custode e promotrice» del latino nel mondo.
Eminenza, il Papa parla dei seminari ma in generale dei giovani e del «vasto mondo della cultura». Quale sarà il ruolo dell’Accademia?
«Esistevano già delle istituzioni vaticane come la Latinitas, da ora estinta, però adesso si vuole rivedere tutta la questione in modo diverso. Anzitutto c’è un valore che si considera permanente dell’umanità: il latino - con il greco, naturalmente - è una delle matrici assolute della cultura europea e occidentale. Per questo il Santo Padre ha nominato presidente dell’Accademia un grande latinista come il professor Ivano Dionigi, rettore dell’università di Bologna. Non è solo un problema ecclesiale».
Quindi, come si muoverà?
«Prima di tutto ci si impegnerà nella diffusione della cultura latina alta e dei suoi contenuti, che sono inscindibili dalla conoscenza della lingua. Ogni traduzione è sempre una belle infidèle, come diceva Gilles Ménage, anche se è bella è infedele. Io, per dire, penso che Agostino perda la metà. Pensi alle Confessioni, «Nondum amabam, et amare amabam... quaerebam quid amarem, amans amare...», ma come si fa?, è come tradurre Dante, Agostino sta dicendo che ancora non amava davvero perché non sapeva quale fosse l’oggetto del suo amore e c’è una bellezza musicale nella lingua, lui ne è un cultore raffinato, ci gioca. Così vogliamo recuperare tutto il grande patrimonio culturale latino, classico, patristico e medievale: per il mondo. L’Accademia si amplierà a livello internazionale, con diverse personalità laiche».
Benedetto XVI parla anche dei seminari...
«Certo, il secondo elemento è ad intra. Il latino è stato ed è la lingua ufficiale della Chiesa, in latino sono gli scritti dei Padri, i documenti della tradizione, i testi dei Concili, del magistero dei Papi, i libri liturgici... Ci vuole un impegno maggiore nei seminari, bisogna fare in modo che riescano a capirli!».
Come si è arrivati a questa situazione?
«Non è solo colpa della Chiesa, c’è un problema generale degli studi umanistici. Del resto una volta per studiare teologia nei seminari si doveva venire dal liceo classico e poi non è stato più così, i corsi integrativi non sono bastati, bisogna fare di più. Ma c’è un terzo livello...».
Quale? «Il recupero del latino nella modernità. Oggi c’è il gusto di ritornare alla lingua, lo sa che in Finlandia esiste un quindicinale per ragazzi in latino? Perché il latino ha una funzione formativa. L’inglese parlato - non dico quello alto - è una semplificazione, quasi un "twitteraggio" del pensiero. Mentre il latino ha una forte impronta razionale, la costruzione dei casi, i verbi, la consecutio temporum... Per questo lo si vuole riproporre ai giovani».
C’è chi farà l’equazione latino-Chiesa preconciliare...
«Lo so, purtroppo. Se si vuole c’è un recupero del passato e del suo patrimonio, ma non reazionario né sterile. La bellezza del latino non è alternativa o contrapposta alla Chiesa postconciliare. E poi mi piacerebbe sapere se quelli che partecipano ai riti latini sarebbero in grado di tradurmi gli inni di Sant’Ambrogio, così raffinati e complessi... Anche loro ne hanno bisogno!».
-
> MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012) ---- DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.1 novembre 2012, di Federico La Sala
 MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
-
>DOPO 700 ANNI, IL CARDINALE RAVASI rilegge il canto X del "Paradiso" e continua a sorprendersi che "con una decina di parole Dante riesca a formulare la dottrina cattolica della Trinità"!?! E continua a non chiedersene la ragione.6 novembre 2012, di Federico La Sala
 IL CRISTIANESIMO NON E’ UN CATTOLICISMO. "DIO NON E’ CATTOLICO" (Carlo Maria Martini). E L’AMORE (Deus CHARITAS est) NON E’ MAMMONA ( "Deus caritas est": Benedetto XVI - Enc. 2006)!!!
IL CRISTIANESIMO NON E’ UN CATTOLICISMO. "DIO NON E’ CATTOLICO" (Carlo Maria Martini). E L’AMORE (Deus CHARITAS est) NON E’ MAMMONA ( "Deus caritas est": Benedetto XVI - Enc. 2006)!!!
 DANTE, I "DUE SOLI", E L’AMORE ("CHARITAS"). Il teologo della Chiesa cattolico-romana Gianfranco Ravasi rilegge il canto X del "Paradiso" e continua a sorprendersi che "con una decina di parole Dante riesca a formulare la dottrina cattolica della Trinità"!?! E continua a non chiedersene la ragione
DANTE, I "DUE SOLI", E L’AMORE ("CHARITAS"). Il teologo della Chiesa cattolico-romana Gianfranco Ravasi rilegge il canto X del "Paradiso" e continua a sorprendersi che "con una decina di parole Dante riesca a formulare la dottrina cattolica della Trinità"!?! E continua a non chiedersene la ragione
-
-
> CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- SE IL PAPA SI SBAGLIA, PERCHE’ NON LO AIUTA A CORREGGERSI?!23 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI E ... "IL DIO RADICATO IN TERRA" (di Gianfranco Ravasi)23 settembre 2012, di Federico La Sala
Premessa sul tema. Una nota:
 IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI OGGI (2006-2012) E CIO’ CHE OGNI BUON CATECHISTA INSEGNAVA IERI (2005). Una lezione di don Mauro Agreste - con alcune note
IL MAGISTERO EQUIVOCO DI BENEDETTO XVI OGGI (2006-2012) E CIO’ CHE OGNI BUON CATECHISTA INSEGNAVA IERI (2005). Una lezione di don Mauro Agreste - con alcune note
 SE DIO SI E’ FATTO PAROLA, IO NON POSSO GIOCARE CON LE PAROLE ... IL CATECHISTA NON USA MAI PAROLE EQUIVOCHE: PARLARE DI CARITÀ SIGNIFICA PARLARE DI GRAZIA (Federico LA Sala)
SE DIO SI E’ FATTO PAROLA, IO NON POSSO GIOCARE CON LE PAROLE ... IL CATECHISTA NON USA MAI PAROLE EQUIVOCHE: PARLARE DI CARITÀ SIGNIFICA PARLARE DI GRAZIA (Federico LA Sala)
Un Dio radicato in terra
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore - Domenica, 23 settembre 2012)
«Noi non crediamo più agli dèi lontani/né agli idoli né agli spettri che ci abitano./ La nostra fede è la croce della terra / dov’è crocifisso il figliuolo dell’uomo». Certo, Fortini quando scriveva questi versi in Varsavia 1939 reinterpretava laicamente l’Incarnazione e la Crocifissione cristiane, ma coglieva implicitamente il vero nodo centrale che lega insieme i vari fili tematici del cristianesimo. Il Logos astratto e remoto dei Greci e l’idolo pesante e inerte del paganesimo erano spazzati via e sostituiti da un soggetto unitario, Cristo, che intrecciava in sé divinità e umanità, immanenza e trascendenza, contingente e assoluto, storia ed eternità, crocifissione e risurrezione. Il cristianesimo esige una fede infitta nella ragione, una divinità insediata nella società.
Per questo "Anno della Fede" - indetto da Benedetto XVI a partire dall’11 ottobre (cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II) e che durerà fino al novembre dell’anno prossimo - vorremmo ora suggerire, fra i tanti possibili, alcuni volumi di "contesto". La fede cristiana è, come si diceva, "incarnata" e non alienante, il credere non è un’eterea ascensione estatica, ma un’adesione esistenziale e fiduciale a un Dio personale e alla sua verità. È inevitabile, quindi, l’accamparsi del fedele nella piazza della storia e non solo nell’intimità velata di incenso del tempio. Elencheremo, perciò, alcuni testi che delineano l’orizzonte in cui deve collocarsi il credente con la sua testimonianza.
È naturale che il grembo più vasto è quello della modernità che, da quel Seicento in cui brillò l’«Io» autonomo di Cartesio e si configurò lo statuto indipendente della scienza rispetto alla teologia con Galileo e Newton, si è ora dispersa nella "liquidità" della postmodernità. Il sociologo Sergio Belardinelli preferisce parlare di «tarda modernità» della quale vuole offrire un "sillabario" di quaranta voci, dall’«Aldilà» fino al «Treno». Quest’ultimo lemma piuttosto curioso fa comprendere quanto sia ancor oggi possibile l’allegoria, posta accanto alla "pesantezza" di termini come biopolitica, consumismo, globalizzazione, guerra, laicità, mercato, parlamento, potere e così via. La vivacità del dettato e il respiro sottilmente ottimistico che animano le varie "sillabe" da reimparare nel linguaggio moderno fanno comprendere come non sia legittimo un certo scoramento pessimistico del cristiano.
La destrutturazione e decreazione a cui si è votata la cultura postmoderna può avere come estuario non necessariamente il vuoto e lo spaesamento, ma può essere simile a una piattaforma libera da cui ripartire, recuperando l’eredità apparentemente stinta ed estinta della cristianità e della stessa modernità.
Imbraccia, invece, «l’arco di bronzo» descritto dal Salmista per scagliare le sue frecce «contro gli idoli postmoderni» un teologo raffinato come Pierangelo Sequeri. Tuttavia, il vitello d’oro che egli abbatte non viene brutalmente polverizzato e fatto inghiottire come accade nel celebre racconto biblico, bensì è sottilmente sconfitto attraverso la via dialettica dell’argomentazione, della riflessione e della critica motivata. Sì, perché l’idolo è in realtà solo il segno esteriore di un pensiero, di una concezione esistenziale, di una passione maniacale.
Di questi «idoli di testa» l’autore elenca quattro figure che si compongono quasi a punti cardinali di una mappa della nostra contemporaneità. Ecco, allora, la fissazione della giovinezza, l’ossessione della crescita e dell’accumulazione, il totalitarismo della comunicazione, l’irreligione della secolarizzazione. I vaccini liberatori sono indicati in pagine molto mobili, affidate a un linguaggio spesso evocativo eppure incisivo, ramificato e ammiccante, fieramente critico ma convinto alla fine che ogni vizio è una virtù degenerata e recuperabile, dato che carbone e diamante hanno la stessa base, il carbonio, come ricordava Karl Kraus.
Sequeri elenca il «totalitarismo della comunicazione» tra gli idoli postmoderni ed è difficile dargli torto. Eppure, i nuovi linguaggi informatici sono anche una sorprendente svolta culturale, analoga alla scoperta del fuoco, osava dire il sociologo dei media John P. Barlow. Vale qui, allora, in modo particolare il nesso appena enunciato tra vizio e virtù.
Ed è ciò che fa, in un saggio di straordinaria qualità e godibilità, il gesuita Antonio Spadaro dedicandosi alla "cyberteologia", ossia al come pensare il cristianesimo nel tempo della rete. L’intellectus fidei (l’intelligenza della fede), canone fondamentale della teologia di ogni epoca deve ora esercitarsi nel nuovo terreno digitale con la sua grammatica che privilegia la coordinata incisiva rispetto alla subordinata sillogistica, che si affida all’essenzialità emblematicamente incarnata nei 140 caratteri del tweet, che per comunicare si arresta davanti alla frigidità dello schermo del computer, che si innesta in un sistema nervoso planetario, che alla distesa dell’eco temporale sostituisce l’istantaneità del dato. Ma tra le tante analisi preziose di questo internauta religioso, capace di critica, fondamentale è quella di "connettere" al linguaggio digitale l’antico annuncio fatto di parole proclamate, di sacramenti celebrati, di visioni sistematiche dell’essere e dell’esistere proprie del cristianesimo.
Abbiamo ormai solo lo spazio per una semplice citazione di due incursioni in ambiti particolarmente roventi della modernità, quelli della scienza e della politica. Suggeriamo, allora, di non perdere due testi essenziali. Il primo raccoglie il dialogo di un giornalista con un geniale scienziato e teologo, il sacerdote polacco Michael Heller, interpellato sul tormentato eppur esaltante confronto tra scienza e fede, un incrocio ormai antico che si è consumato attorno a domande capitali per entrambe, come l’origine dell’universo, l’evoluzione della materia e della vita, la genesi dell’uomo, l’approccio conoscitivo sperimentale e teorico, la casualità o l’ordine dell’universo e così via.
Infine, ecco la vexata quaestio, sempre incandescente e mai del tutto risolta nell’esperienza storica, quella del rapporto tra fede e politica. È uno dei migliori teologi italiani, Severino Dianich, ad affrontare il tema non dal punto di vista della sociologia o antropologia religiosa, bensì in sede squisitamente teologica, come capitolo rilevante dell’ecclesiologia. Chiesa e Stato laico sono, quindi, collocati in un confronto che è esaminato stando sul versante ecclesiale, interpellando perciò prima di tutto e sopra tutto la Chiesa nel suo presentarsi e confrontarsi con la società moderna democratica e secolarizzata.
 Sergio Belardinelli, Sillabario per la tarda modernità, Cantagalli, Siena
Sergio Belardinelli, Sillabario per la tarda modernità, Cantagalli, Siena
 Pierangelo Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Lindau, Torino
Pierangelo Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Lindau, Torino
 Antonio Spadaro, Cyberteologia,Vita & Pensiero, Milano
Antonio Spadaro, Cyberteologia,Vita & Pensiero, Milano
 Michael Heller, La scienza e Dio, La Scuola, Brescia
Michael Heller, La scienza e Dio, La Scuola, Brescia
 Severino Dianich, Chiesa e laicità dello Stato, San Paolo, Cinisello Balsamo, MI
Severino Dianich, Chiesa e laicità dello Stato, San Paolo, Cinisello Balsamo, MI
-
-
> CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- A STOCCOLMA. Il cortile dei Gentili a casa dei Nobel - a fare "duetti" (di Armando Torno)10 settembre 2012, di Federico La Sala
Il cortile dei Gentili a casa dei Nobeldi Armando Torno (Corriere della Sera, 10 settembre 2012)
Questa settimana il Cortile dei Gentili - lo spazio di incontri voluto da Bendetto XVI e organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura - riprende a Stoccolma. La capitale svedese ospiterà dibattiti sul tema «Il mondo con o senza Dio?». Sono stati chiamati «duetti», giacché sono dei faccia a faccia tra personalità contrastanti. O forse saranno scontri. E per la bisogna si è messo in campo un argomento chiave che da sempre fa riflettere filosofi e teologi.
Tutto comincerà giovedì 13 settembre all’Accademia reale svedese delle scienze, con i saluti del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e dello scrittore Georg Klein. Poi il primo duetto. Su «Cosa significa credere e non credere?» si contrapporranno Ulf Danielsson (professore di fisica all’Università di Uppsala) e Ingemar Ernberg (biologo, autore del libro Cos’è la vita?); sarà poi la volta dell’incontro «Esiste un mondo non materiale?»: il confronto avverrà tra Antje Jackelén (vescovo della Chiesa di Svezia, diocesi di Lund) e lo scrittore-medico Per Christian Jersild. Tra l’altro, venerdì 14, secondo e ultimo giorno del Cortile svedese, si discuterà «Cosa significa credere e non credere?». Anders Carlberg, scrittore e fondatore del Fryshuset, dibatterà con Linnea Jacobsson, vicepresidente dei Giovani cristiani di sinistra.
Le due giornate svedesi, oltre a evocare una questione sempre aperta, desiderano provocare per meglio far conoscere le ragioni della scienza e le speranze della fede. Inoltre, il Cortile si riunirà in due luoghi simbolo di Stoccolma: l’Accademia, che ha legato il suo nome al Premio Nobel, e il Fryshuset, centro leader di attività sociali, creato per accogliere e soccorrere ragazzi in difficoltà. E tutto questo nell’attesa di Assisi, il 5 e il 6 ottobre, con un Cortile che sarà ricco di sorprese. A Stoccolma non mancheranno scintille parlando di Dio. Ma è bene che sia così. Il cardinale Ravasi ci ha confidato: «A volte la tensione, forse la ferita impediscono la sonnolenza, l’indifferenza, il distacco». Si parla di «ferita» morale. Che, secondo il teologo Ratzinger, genera la bellezza nell’anima.
-
> CARDINALE RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- DARWIN, MARX, E LO STRAFALCIONE DI MONSIGNOR RAVASI (di Telmo Piovani).14 ottobre 2012, di Federico La Sala
- L’IMMAGINARIO MITOLOGICO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA:
 "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
"Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
Lo strafalcione di Monsignor Ravasidi Telmo Pievani *
Sugli ecclesiastici che si cimentano con l’opera di Charles Darwin - e non ne mancano in questo anno del bicentenario - grava ormai una beffarda maledizione. Qualcuno li aiuti, perché spiace vedere cotali intelligenze brancolare nel buio su una materia che evidentemente non padroneggiano. Esordiscono con le migliori intenzioni di “dialogo” - soprattutto se l’interlocutore è un “genetista cattolico” o un “fisico cattolico”, fantastiche chimere da operetta italiana - ma poi inevitabilmente finiscono per gettare la maschera e per attribuire al vecchio naturalista inglese barbuto ogni nefandezza. E’ più forte di loro: va cacciato nell’inferno dei cattivi della storia, insieme a marxismo, eugenetica, razzismo e quanto di peggio. Dopo gli anatemi di Fiorenzo Facchini contro il truce naturalismo (addirittura “lombrosiano”) dei darwinisti italiani, è il turno di un altro illustre esponente della gerarchia, il quale in un articolo del 2 luglio su L’Osservatore Romano ci regala uno scivolone che non sappiamo se giudicare imbarazzante, dal punto di vista di qualsiasi studioso serio della storia del pensiero biologico, o piuttosto disastroso, visto che si tratta del Presidente del Pontificio Consiglio della “Cultura”.
Monsignor Gianfranco Ravasi, in un pezzo dal titolo “Ama intensamente l’intelligenza” (citazione da una lettera di Sant’Agostino), si abbandona a diverse acrobazie fra scienza, filosofia e teologia. Scopriamo per esempio che vi sarebbe stata un’evoluzione “progressiva” dei viventi, e così via. Torna alla memoria l’epocale asserzione dello stesso Ravasi apparsa sul Domenicale del Sole24Ore l’11 febbraio 2007, secondo la quale il “punto dialogico di sintesi” fra scienza e fede andrebbe formulato come segue, citando di nuovo Facchini: “Si può ritenere che la scintilla della coscienza di sé [o, se si vuole, nel linguaggio tradizionale, dell’‘anima’] si sia accesa per un intervento superiore in un ominide il cui organismo ha potuto rappresentare un supporto biologicamente idoneo”. In attesa che i paleoantropologi identifichino questo fantomatico ominide miracolato dalla scintilla divina, ancorché ospitata su “supporto biologicamente idoneo”, torniamo allo strafalcione estivo.
Dopo aver sparato ancora una volta sullo spauracchio esangue del “darwinismo sociale”, il noto biblista cita Karl Marx, il quale, udite, “avrebbe voluto dedicare il suo Capitale proprio a Darwin”. Se così fosse, se ne potrebbe discutere, ma è incredibile come una diceria - la cui falsità è stata svelata e spiegata da più trent’anni dagli storici - possa sopravvivere così a lungo nei meandri dell’ideologia. Marx non chiese affatto a Darwin di potergli dedicare Il Capitale. Gliene inviò una copia autografata, alcuni anni dopo l’uscita. Darwin lo ringraziò con una lettera di cortesia così formale da sembrare imbarazzata. La copia del volume nella biblioteca di Darwin è pressoché intonsa: solo le prime 105 pagine su 822 sono aperte, e non hanno annotazioni. Non sfogliò nemmeno l’indice. Marx, da parte sua, raffreddò ben presto i suoi entusiasmi per l’evoluzione darwiniana quando vi colse quelli che a suo avviso erano i “pregiudizi ideologici” borghesi e maltusiani della libera concorrenza.
Chi chiese a Darwin di potergli dedicare un’opera del 1881 (“The Student’s Darwin”) fu il pensatore socialista e ateo Edward Aveling, compagno della figlia di Marx, Eleanor. La vicenda, e i succosi fraintendimenti che ne seguirono, è ricostruita nei dettagli da Lewis S. Feuer in “Is the ‘Darwin-Marx correspondence’ authentic?”, del 1975 (in Annals of Science, 32, pp. 1-12), da Margaret A. Fay in “Did Marx offer to dedicate Capital to Darwin?”, del 1978 (in Journal of the History of Ideas, 39, pp. 133-146), e da Ralph Colp Jr. in “The myth of the Darwin-Marx letter”, del 1982 (in History of Political Economy, 14(4): 461-482). Si notino gli anni di pubblicazione: è letteratura acquisita da più di trent’anni. Ci permettiamo di consigliarne la lettura a Monsignore, essendo sinceramente dispiaciuti per l’incidente in cui è incorso. La spropositata influenza che esercita in Italia la testata d’Oltretevere dovrebbe suggerire di “amare intensamente” non soltanto l’intelligenza, ma anche il rispetto delle fonti storiografiche e dei fatti. Ve lo immaginate, che spasso, un biologo evoluzionista che cade miseramente sull’interpretazione di un Salmo? Si alzerebbe il coro unanime degli editoriali sulla “scienza arrogante” e qualche dirigente del Partito Democratico detterebbe subito il suo grido di dolore alle agenzie.
Ricordiamo anche come finì la storia. Darwin, fiutando l’opportunismo della richiesta di Aveling (e non di Marx), cortesemente rifiutò, con queste parole di semplice fiducia negli effetti a lungo termine degli avanzamenti della scienza: “Mi pare (a torto o a ragione) che le argomentazioni dirette contro la cristianità e il teismo non producano sul pubblico quasi effetto alcuno; e che la libertà di pensiero sia promossa nel modo migliore dalla graduale illuminazione delle menti umane che fa seguito al progresso della scienza”. La strategia, tuttavia, non pare aver funzionato. L’illuminazione è stata sì molto graduale, anche troppo, visto che dopo un secolo e mezzo - nello spazio ideale che in Italia va dall’Osservatore Romano a Voyager in prima serata sulla tv dei contribuenti - ancora stiamo parlando di salti ontologici, di ominidi miracolati, di rapimenti alieni, di cerchi nel grano. E di leggende storiografiche.
Telmo Pievani
* FONTE: MICROMEGA
- L’IMMAGINARIO MITOLOGICO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA:
-
-
> CARDINAL RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- COME DIRE DIO OGGI?! SECONDO LA LEZIONE DI MARTINI O LA "TRADIZIONE" DI RATZINGER!?1 settembre 2012, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO, SPIRITO CRITICO, E INSEGNAMENTO: CHI INSEGNA A CHI CHE COSA E COME?
(...) quella che affrontiamo non è semplicemente una questione esegetica. La posta in gioco è ben più alta. Dietro la domanda: «Perché Gesù parlava in parabole», sta infatti una questione attualissima e gravissima: quella del «linguaggio religioso», del come parlare adeguatamente di Dio oggi (...)
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- ALLARME TOTALE: "PAROLA A RISCHIO. Risalire gli abissi. La salvezza è per tutti. Alla portata di tutti". Un "urlo" del teologo Giovanni Mazzillo ("mosaico di pace)21 agosto 2012, di Federico La Sala
 OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI BENEDETTO XVI ("DEUS CARITAS EST", 2006). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI BENEDETTO XVI ("DEUS CARITAS EST", 2006). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 ALLARME TOTALE: "PAROLA A RISCHIO. Risalire gli abissi. La salvezza è per tutti. Alla portata di tutti". Un "urlo" del teologo Giovanni Mazzillo (dal "mosaico di pace") - con alcune note
ALLARME TOTALE: "PAROLA A RISCHIO. Risalire gli abissi. La salvezza è per tutti. Alla portata di tutti". Un "urlo" del teologo Giovanni Mazzillo (dal "mosaico di pace") - con alcune note L’annuncio di Gesù, già nella sua venuta in questo nostro mondo, è l’annuncio di una relazionalità umana felicemente riuscita. Nel Vangelo è direttamente collegato alla Grazia (...) Colei che è piena di grazia (kecharitōménē) è invitata a rallegrarsi perché tutto in lei è frutto ed espressione della «grazia» (cháris), cioè di un dono amorevole quanto sorprendente, che sarà presto annuncio di gioia per tutto il popolo e per ogni uomo (...)
L’annuncio di Gesù, già nella sua venuta in questo nostro mondo, è l’annuncio di una relazionalità umana felicemente riuscita. Nel Vangelo è direttamente collegato alla Grazia (...) Colei che è piena di grazia (kecharitōménē) è invitata a rallegrarsi perché tutto in lei è frutto ed espressione della «grazia» (cháris), cioè di un dono amorevole quanto sorprendente, che sarà presto annuncio di gioia per tutto il popolo e per ogni uomo (...) -
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- UN CHIARIMENTO DI GIOVANNI PAOLO II14 agosto 2012, di Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- MA COSA HA STUDIATO "IL GRANDE CODICE" DI MAMMONA?!10 agosto 2012, di Federico La Sala
- Nuovo ordine mondiale: "Dio è valore" ("Deus caritas est"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA.
CATTOLICESIMO (E CRISTIANESIMO) OGGI, 2012: LA CATTEDRA DI SAN PIETRO UNA CATTEDRA DI ECONOMIA POLITICA.
"Chiunque sia sensibile al problema linguistico sa bene sino a che punto leggere una traduzione significhi adattarsi a un ripiego" Cfr. Northrop Frye, Il grande codice. La Bibbia e la letteratura, Einaudi, Torino 1986, p. 22)
- Nuovo ordine mondiale: "Dio è valore" ("Deus caritas est"). Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Dove sta l’originalità del commento del docente dell’Università milanese Vita-Salute San Raffaele? )di Gianfranco Ravasi - La pietà rovesciata)7 agosto 2012, di Federico La Sala
La pietà rovesciata
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 5 agosto 2012)
«Tu, o Compassione, sei la sola virtù! Tutte le altre sono virtù usuraie»: così enfaticamente scriveva lo Jacopo Ortis foscoliano. Ed è proprio da questa esclamazione che parte il noto storico della medicina Giorgio Cosmacini, intrecciandola con l’analoga e altrettanto appassionata dichiarazione del l’Idiota dostoevskijano secondo cui «la compassione è la più importante e forse l’unica legge di vita dell’umanità intera». Ma come declinare oggi questa virtù che può degenerare nella più distaccata commiserazione o compatimento, ma anche allargarsi a ventaglio in un arcobaleno di iridescenze "filantropiche" come la pietà, la misericordia, la pena, la comprensione, la solidarietà, per ascendere sino alla carità, virtù teologale suprema?
Cosmacini ha optato per un antico tracciato di matrice catechetica cristiana, scandito dal celebre settenario delle cosiddette «opere di misericordia corporale», modulate sostanzialmente su un’altrettanto celebre pagina del Vangelo di Matteo ove Cristo si identifica coi miseri della terra: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» e l’elenco comprende affamati, assetati, stranieri, nudi, malati, carcerati (25,31-46). È assente da questa lista solo l’ultima opera misericordiosa o compassionevole, il "seppellire i morti" che naturalmente in questo saggio appare a coronamento del settenario. Dove sta l’originalità del commento del docente dell’Università milanese Vita-Salute San Raffaele?
La singolarità della sua analisi sta nel l’aver adottato quello che l’autore chiama «il rovescio della medaglia» che paradossalmente attualizza le "opere" secondo le coordinate della cultura e della società contemporanea, soffiando via da esse la polvere della retorica morale tradizionale e mostrandone la drammatica necessità anche per quest’era tecnologica. Così il «dar da mangiare agli affamati» non è più soltanto il pur sempre angosciante contrasto - come scriveva nel Settecento Chamfort - tra «quelli che hanno più cibo da mangiare che appetito e quelli che hanno più appetito che cibo da mangiare», ma diventa anche attenzione alla devastazione che l’obesità introduce e, se si vuole, la discesa negli inferi della bulimia (o del suo antipodo speculare, l’anoressia).
Il «dar da bere agli assetati» può trasformarsi nella lotta all’etilismo, nella consapevolezza di quanto scriveva l’alcolizzato Fitzgerald con un irresistibile calembour inglese che non necessita di traduzione: «First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you». E «vestire gli ignudi», come si diceva nell’obsoleto linguaggio del catechismo, che cosa ha nel suo rovescio? È facile pensare a quella moda così invadente e provocante che - per ricorrere ancora a un’auctoritas del passato come l’autore inglese William Hazlitt - conferma sempre più un esito sconcertante: «Coloro per i quali il vestito è la parte più importante della persona finiscono in generale per valere tanto quanto il loro vestito» (così nei suoi Political Essays).
Insomma, sotto il vestito, niente. E talora è già il vestito ad essere un niente anche tessile. Come si vede, nella nostra elencazione abbiamo adottato una costante, il ricorso alla citazione tematica. Lo abbiamo fatto anche per evocare il taglio che rende godibile il testo di Cosmacini. Egli, infatti, intarsia le sue analisi con un caleidoscopio di rimandi storici, letterari, folclorici, documentari, naturalmente approdando anche al registro dell’attualità, convinto comunque che, per dirla con Carlo Levi, «il futuro ha un cuore antico». Proponiamo, allora, gli altri suoi «rovesci della medaglia» relativi alle ultime componenti del settenario delle opere compassionevoli.
«Ospitare i pellegrini» ha la sua rovente immediatezza nel «non respingere gli immigrati». A questo proposito merita di ricordare che non è un comma di una legislazione scandinava questa norma: «Quando uno straniero sarà residente nella vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero residente tra voi lo tratterete come il nativo. Anzi, l’amerai come te stesso». Si tratta, invece, di un asserto del codice ebraico biblico presente nel libro del Levitico (19,33-34). «Visitare gli ammalati» è riproposto non più secondo una tabella di orari o di imbarazzati discorsi al capezzale dell’infermo, bensì secondo la modalità del dialogo, in particolare quello tra medico e paziente, attraverso un’alleanza nella quale tecnica e umanità s’incrocino.
Per finire, le ultime due opere di misericordia o compassione suscitano oggi complesse questioni sociali, giuridiche e morali. I carcerati diventano un appello a «non aggiungere pena a punizione», come purtroppo accade in molte prigioni ove l’affollamento quasi bestiale toglie ogni residuo di dignità al condannato. E «seppellire i morti» oggi apre il capitolo delicatissimo e lacerante del «rispettare la dignità dei morenti». Proprio dall’elenco che abbiamo stilato si evince quanto sia tutt’altro che superata la lezione catechetica antica. Certo, Cosmacini fa intuire in filigrana la sua opzione cristiana, ma il suo discorso conserva il respiro di un’umanità e di una sapienza universale.
In un mondo inginocchiato davanti al gelido idolo della tecnica, un supplemento di pietas, che è calda come la carne umana sofferente, è ancor più necessario. Il ritorno alla compassione è un antidoto all’indifferenza, è un vaccino al morbo dell’isolamento egoistico, è la riscoperta di quella virtù senza la quale non si è né Dio né persona umana, cioè l’amore. Proprio come vantava nell’emblematica The Pity of Love (1922) Yeats: «Una pietà ineffabile si nasconde nel cuore dell’Amore» («A pity beyond any telling / is hid in the heart of Love»).
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- DIPLOMAZIA E VERITA’.10 luglio 2012, di Federico La Sala
Diplomazia e Verità
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24-Ore, 7 luglio 2012)
Tra i pregevoli e a tratti sorprendenti discorsi al Cortile dei Gentili del 26 giugno sul dinamico e inquieto rapporto tra diplomazia e verità, vorrei richiamarne uno in particolare: quello di Hassan Abouyoub, ambasciatore del Marocco presso il Quirinale.
Ciò che egli ha affermato, infatti, dischiude una ricca messe di ragionamenti e proiezioni sul mondo attuale. Riporto alcune brevissime citazioni: «quando si tratta qualcosa con trasparenza - ha detto Abouyoub - c’è progresso»; e ancora: «la negoziazione non ha risolto i problemi del mondo. [...] Lavorare nella cornice del segreto è lavorare fuori della democrazia. [...] Il mondo è cambiato [anche perché, ndr] gli attori non statali giocano un ruolo pari a quello degli Stati sovrani».
Abouyoub ha di fatto introdotto un’idea di superamento dei cosiddetti arcana imperii, che sono sì i segreti di Stato, ma anche un modo antico di intendere l’agire politico secondo ragion di Stato.
Tale superamento, certo, non è irresponsabile e indistinta pubblicità di ogni fatto e rapporto, ma è incidenza del pubblico nei processi collettivi. In altre parole, il pubblico innerva i processi istituzionali spingendoli, per così dire, a cambiare natura.
La parola greca alètheia, che traduce verità , significa letteralmente assenza di nascondimento, dunque, per esteso, assenza di segreto. Come si combina, dunque, la verità come disvelamento con la necessità di riservatezza propria delle pratiche del potere? É questo un tema delicatissimo e fin troppo spesso preso a pretesto per muovere accuse anche viscerali a strutture giuridicamente valide secondo Stato di diritto o, per quanto mi riguarda direttamente, nei confronti dell’azione della Santa Sede.
Ora, se si pensa che tali affermazioni giungono da un importante esponente del mondo mediterraneo a prevalenza religiosa musulmana e culturale araba, da un’area - peraltro - scossa da sussulti sociali stupefacenti che si usa racchiudere nell’espressione “primavera araba” (beninteso, il Marocco non direttamente, e non in modo così prorompente), ebbene, tali dichiarazioni, ponendo l’enfasi sui concetti di “democrazia” e “trasparenza” rappresentano una svolta notevole nel modo di intendere l’azione pratica politica nel contesto attuale e futuro. Quella dell’ambasciatore Abouyoub è, insomma, una lettura descrittiva, cioè sociologica, ma anche filosofico-politica, nel senso che traguarda un orizzonte direi anche teoretico di elaborazione culturale.
Nel mondo arabo-musulmano la religione riveste un ruolo eminente nella configurazione politica, così, essendo ogni religione intimamente relazionata al movimento del concetto di verità, ciò che ha dichiarato l’ambasciatore non rappresenta forse anche un formidabile invito all’Occidente a guardare bene in faccia il profondo cambiamento che oggi riguarda la partecipazione politica?
Così, nel tempo della crisi economico-finanziaria e della evoluzione delle potestà sovranazionali, non è infine un invito a definire una nuova cultura e pratica politica (non ideologica) fondata su un rinnovato rapporto tra politica e religione, dunque in sostanza su una nuova idea di laicità? È una cosa sulla quale dover riflettere pienamente, specie se si guarda alla situazione europea e al movimento delle etnie e delle culture e mentalità nel mondo globalizzato.
-
> CARDINALE RAVASI RAVASI ---- OBBEDIENZA CIECA E VATICANO: CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO17 aprile 2012, di Federico La Sala
 VATICANO: CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione.
VATICANO: CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. Benedetto XVI, il papa teologo, ha gettato via la "pietra" ("charitas") su cui posava l’intera Costruzione.
 OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006). Materiali per riflettere
OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006). Materiali per riflettere
-
> CARDINALE RAVASI RAVASI ---- Il «Cortile dei gentili», nella Catalogna di Salvador Dalì, Antoni Gaudì e Juan Mirò. Intervista a Francesc Torralba Rosellò (di Lorenzo Fazzini).15 maggio 2012, di Federico La Sala
Note introduttive sul tema:
 RIPENSARE L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO E LA DEMOCRAZIA, A PARTIRE DALLA LEGGE DELLA UGUAGLIANZA ("LEY DE IGUALDAD") DEL GOVERNO DI ZAPATERO ...
RIPENSARE L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO E LA DEMOCRAZIA, A PARTIRE DALLA LEGGE DELLA UGUAGLIANZA ("LEY DE IGUALDAD") DEL GOVERNO DI ZAPATERO ...
 CON LA SPAGNA DI "PUERTA DEL SOL", PER LA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO: RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE - E ANDARE OLTRE. (Federico La Sala)
CON LA SPAGNA DI "PUERTA DEL SOL", PER LA DEMOCRAZIA "REALE", SUBITO: RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE - E ANDARE OLTRE. (Federico La Sala)
Laici maestri di sacro
intervista a Francesc Torralba Rosellò,
a cura di Lorenzo Fazzini (Avvenire, 15 maggio 2012)
Nella Catalogna di Salvador Dalì, Antoni Gaudì e Juan Mirò il «Cortile dei gentili» - lo spazio di dialogo tra credenti e ’umanisti’ - non poteva che avere come tema «Arte, bellezza e trascendenza». La nuova tappa del confronto voluto da Benedetto XVI e intrapreso dal cardinal Gianfranco Ravasi per interloquire con «quanti si rivolgono a Dio come Sconosciuto» si sofferma a Barcellona. Giovedì e venerdì si alterneranno riflessioni e scambi in alcune prestigiose sedi: il Museo Nazionale d’Arte della Catalogna, con la prolusione del presidente del Pontificio Consiglio per la cultura, poi l’università di Barcellona e infine la Sagrada Familia.
Francesc Torralba Rosellò, giovane teologo e valente filosofo da qualche mese nominato consultore dello stesso Pontificio Consiglio, vi interviene con una conferenza su «La via dalla bellezza all’amore». Numerosi i suoi scritti recenti: in italiano Qiqajon ha appena pubblicato Volti del silenzio (pp. 200, euro 18); in Spagna sono appena usciti La lógica del don (Khaf) e Vida spiritual en la sociedad digital (Milenio).
 Lei si è concentrato su temi spirituali ma aperti a tutti: silenzio, società digitale, dono. Un’indagine che ricalca molto il «Cortile dei gentili»... Perché quest’approccio?
Lei si è concentrato su temi spirituali ma aperti a tutti: silenzio, società digitale, dono. Un’indagine che ricalca molto il «Cortile dei gentili»... Perché quest’approccio?«La mia ricerca filosofica cerca di essere aperta e ’permeabile’. Ritengo che il mio compito come filosofo sia promuovere il pensiero e la riflessione su queste domande genuinamente umane che ognuno, al di là delle proprie convinzioni spirituali, si formula. La mia funzione è essere alla frontiera perché i confini sono luoghi creativi dove si può imparare dal dialogo condiviso. Ritengo che ogni essere umano abbia una dimensione spirituale che può essere articolata e sviluppata in modi diversi in virtù dei contesti e delle biografie».
 Cosa accomuna credenti e umanisti?
Cosa accomuna credenti e umanisti?«Il senso di nostalgia, il desiderio di felicità, il bisogno di conforto e la paura sono esperienze trasversali che ci fanno fratelli nell’esistenza. Penso che la religione sia sostanzialmente rapporto che trascende il sé, collegando la persona con una realtà totalmente diversa che noi chiamiamo Mistero assoluto».
 Nel suo saggio sul silenzio lei cita varie volte Ludwig Wittgenstein...
Nel suo saggio sul silenzio lei cita varie volte Ludwig Wittgenstein...«Wittgenstein è un pensatore profondamente spirituale. Basta leggere i suoi scritti biografici risalenti alla prima guerra mondiale e il Tractatus logicus-philosophicus. Egli mostra i limiti del linguaggio scientifico e comprende che il silenzio è il migliore atteggiamento davanti al mistero della realtà. Questo attitudine di cautela e cura per ciò che trascende la razionalità scientifica mi pare molto interessante. Wittgenstein riconosce che non si può fare ’scienza’ sul senso della vita, ma la domanda del significato è, a sua volta, la più grave ed emotivamente coinvolgente che un essere umano possa farsi».
 Dunque l’uomo religioso può scoprire un «di più» in chi non lo è?
Dunque l’uomo religioso può scoprire un «di più» in chi non lo è?
«Certo, nel dialogo il credente scopre molti elementi interessanti. Anzitutto si rende conto che i non credenti costituiscono un mondo molto eterogeneo. Ci sono gli indifferenti, ma pure gli ’allontanati’; gli agnostici che cercano, ma anche quelli pieni di risentimento, molto critici con la religione per ragioni biografiche. Nel dialogo con i non credenti, chi crede è costretto ad esprimere ciò che è più essenziale e genuino della sua fede. Inoltre, deve farlo chiaramente e nitidamente, con termini ’laici’, come direbbe Habermas, poiché è l’unico modo per trovare un ambito condiviso».
 Barcellona è una delle regioni più laicizzate d’Europa. Come rendere culturalmente credibile il Vangelo?
Barcellona è una delle regioni più laicizzate d’Europa. Come rendere culturalmente credibile il Vangelo?«Credo si debbano trovare argomenti esistenziali e ragioni pratiche, senza dimenticare i motivi ragionevoli, per diventare cristiano. La persuasione è molto importante, ma il miglior argomento è mostrare che il cristianesimo è una proposta per la felicità del mondo, una comunicazione di esistenza, come disse Kierkegaard: una narrazione di senso che, integrata nella persona, diventa sorgente di tranquillità, serenità e donazione. Il cristiano è credibile quando vive con gioia ciò che ha sperimentato, quando mostra al mondo come il suo incontro personale con Dio e con ciò che Agostino chiama il ’Maestro interiore’ si tramuta in sorgente di pace per l’anima e pacificazione del mondo».
 «La libertà più vera è la gratitudine », scrive nel libro sul dono. Oggi sembra il contrario. Quali gli esempi concreti di questa libertà?
«La libertà più vera è la gratitudine », scrive nel libro sul dono. Oggi sembra il contrario. Quali gli esempi concreti di questa libertà?«La libertà si trova nella liberazione dall’Io, vivendo sotto la sorgente di bontà che esiste nel fondo di ogni essere. Significa essere consegnato agli altri senza calcolo né sperando nulla. La donazione di sé rimane davvero la via della felicità. Quest’ultima non risiede nel possesso né è un esercizio che si concentra sull’ego e la realizzazione dei propri desideri: questo è libertinaggio! Libero è chi vive liberato da pregiudizi e stereotipi, chi non è mosso dalla logica del calcolo e dell’interesse, ma da quella del dono, il dono più grande, che è l’agape. Gesù è il mio modello di libertà umana, ma anche Francesco d’Assisi, Massimiliano Kolbe e Edith Stein hanno vissuto secondo questa prospettiva».
-
>OBBEDIENZA CIECA E VATICANO: CEDIMENTO STRUTTURALE DEL CATTOLICESIMO .... UN CANTO DI SPERANZA. Un racconto orientale, quasi una parabola10 giugno 2012, di Federico La Sala
Un canto di speranza
(...) un racconto orientale, quasi una parabola (...) *
É notte fonda. Le tenebre si distendono su una città del Vicino Oriente. Gli usci delle case sono serrati e all’interno domina il silenzio. Un silenzio che avvolge come in un sudario anche le vie e le piccole piazze. Ma la quiete è squarciata da una serie di ululati che percorrono le strade: un branco di cani randagi e rabbiosi saetta qua e là, aggrappandosi alle porte, rovesciando ciò che incontra, ringhiando ferocemente davanti ai graticci delle finestre. In una di quelle case un uomo è sveglio e col cuore in gola attende che i cani famelici abbandonino il suo uscio. L’ansia è forte e non dà tregua; la notte sembra non finire mai. Allora, prima in modo sommesso, poi in forma sempre più esplicita, egli inizia a cantare, accompagnandosi con una semplice cetra orientale. Il suo è un inno di implorazione che sale verso il cielo oscuro; le sue spirali sonore ripetono la stessa invocazione ma con un’intensità sempre più forte.
La gola non si stanca, la voce vorrebbe sopraffare l’abbaiare dei cani; la paura del buio e della solitudine è sminuita da un suono che echeggia nella stanza come se fosse un coro. Lentamente il tempo si dissolve e, inattesa, si delinea una prima, tenue lama di luce che filtra dalla finestra: è l’aurora che si fa strada nella tenebra. Anche la voce ormai è più squillante; la supplica si è trasformata in cantico gioioso; i cani abbandonano la via e, spaventati dalla luce, si ritirano nel deserto; i loro ululati si fanno sempre più remoti e ovattati; l’alba si è affacciata sulla città e le strade iniziano a popolarsi di gente.
Anche il nostro cantore ha aperto l’uscio e guarda il cielo limpido e luminoso e la sua voce si apre ancora al canto. Con lui ormai cantano anche tutti coloro che hanno avuto il cuore stretto dalla morsa gelida dell’ansia e della tensione. E sulla scena, segnata dalla fosforescenza di un dramma ma aperta a un esito di pace, cala il sipario.
* Cfr.: Gianfranco Ravasi, Un canto di speranza, Il Sole-24 Ore, 21 maggio 2012 (ripresa parziale)
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? -- Il destino di Antonia Pozzi e Piergiorgio Welby non possono essere artificialmente disgiunti (di Marco Politi - Welby, suicida di seconda classe).17 aprile 2012, di Federico La Sala
Welby, suicida di seconda classe
di Marco Politi (il Fatto Quotidiano, 17 aprile 2012)
Capita che un prete celebri messa sulla tomba di un suicida. Non dovrebbe, perché darsi la morte è peccato capitale. Ma una pia bugia, da decenni, ammanta il rito della presunzione che il suicida sia stato “obnubilato” nel momento supremo. Che non sapesse, insomma, cosa stesse facendo e non volesse trasgredire coscientemente un comandamento divino.
Ma Antonia Pozzi, la poetessa, alla cui memoria il cardinale Gianfranco Ravasi celebra stasera una messa nella chiesa parrocchiale di Pasturo, poco distante da Lecco, sapeva bene verso dove andava. Stagione dopo stagione la giovane nata nel 1912, che si ucciderà a soli 26 anni, ha duellato con il pensiero della morte, del vuoto, di Dio e dell’assenza di Dio. “Per troppa vita che ho nel sangue tremo, nel vasto inverno”, scriveva. E quattro anni prima di morire, impigliata nel dolore di vivere, lanciava il suo grido: “Non avere un Dio, non avere una tomba, non avere nulla di fermo - ma solo cose vive che sfuggono - essere senza ieri, essere senza domani, e accecarsi nel nulla - aiuto - per la miseria che non ha fine”.
Al Corriere della Sera il cardinale ha confidato che l’atteggiamento della Chiesa nei confronti dei suicidi oggi “presta molta attenzione alle dimensioni interiori della tragedia”. La Chiesa, ha spiegato, non può accettare superficialità o disprezzo dei valori della vita e in quei casi non può ricordare il morto con una “celebrazione esplicita”, E tuttavia, ha soggiunto, la poetessa porta con sé la storia di una “forte personalità e di intensa ricerca interiore, travolta da una sensibilità estrema”.
RAVASI È UOMO di cultura, anzi attualmente è il “ministro della Cultura” in Vaticano. Suo è il programma di dialogo internazionale tra cattolici, seguaci di altre religioni e personalità esplicitamente agnostiche. L’iniziativa chiamata Cortile dei Gentili, stimolata da un’idea di Benedetto XVI. Ma Ravasi è ancora di più: l’esponente di quella tradizione ambrosiana, nutrita del pensiero di Carlo Maria Martini e del suo successore Dionigi Tettamanzi, tradizione religiosa che ha sempre voluto che la Chiesa si misurasse con la modernità e non rimanesse impigliata nei commi aridi delle leggi ecclesiastiche.
Celebrare messa per Antonia Pozzi, che a lungo esplicitamente ha meditato e scritto di essere “entrata nella strada del morire”, è un gesto di frontiera. O meglio, il gesto delicato di un porporato, che spera di spingere la Chiesa a varcare le frontiere del passato inserendo i suicidi anche ecclesialmente nell’unica dimensione possibile: l’affetto e la misericordia.
Un gesto piccolo o un gesto profetico. Si vedrà. Ma dinanzi alle coscienze degli uomini e delle donne di oggi e - per chi crede - di fronte alla misericordia divina non possono esistere suicidi di prima e di seconda classe.
La tomba di Pergiorgio Welby chiede ancora conto alla Chiesa di Roma della crudele freddezza con cui l’allora presidente della Cei e cardinal Vicario Camillo Ruini negò i funerali religiosi a chi volle accettare con coraggio l’inevitabile morte, rifiutando di restare attaccato degradato ad una macchina. Anche Welby era di una “sensibilità estrema”.
Dal suo letto, paralizzato progressivamente dalla Sla, scrisse al presidente Napolitano: “Morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita, è solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere vive funzioni biologiche”. L’eutanasia, soggiunse, “non è morte dignitosa, ma morte opportuna nelle parole dell’uomo di fede Jacques Pohier. Opportuno è ‘ciò che spinge verso il porto’. Per Plutarco la morte dei giovani è un naufragio, quella dei vecchi un approdare al porto”. Welby era a suo modo poeta. Ma non è questo che conta. Certamente nel suo arrovellarsi sul vivere e il morire e sul non sottomettere la propria inesorabile sofferenza al dominio anonimo della tecnologia seppe trovare accenti da filosofo.
Il destino di Antonia Pozzi e Piergiorgio Welby non possono essere artificialmente disgiunti. Cresce nelle coscienze dei fedeli e nella sensibilità contemporanea l’esigenza che la Chiesa cattolica emerga dallo stato di fossilizzazione in cui è scivolata.
CRESCE nelle coscienze il rifiuto delle ipocrisie. I riti solenni per il credente omosessuale Lucio Dalla mentre continua l’accanimento vaticano nel condannare le unioni omosessuali e nel bloccare ogni legge sulle coppie di fatto etero o gay. L’ipocrisia di una gerarchia che insiste nel negare la comunione ai divorziati risposati e chiude gli occhi quando sempre più parroci ignorano apertamente il divieto. L’ipocrisia nel demonizzare la fecondazione artificiale mentre nessuna clinica cattolica seria si azzarda a usare quel “preservativo bucato”, che per il Vaticano dovrebbe essere l’unico strumento per trasferire il seme del marito alla moglie.
C’è una Chiesa del quotidiano che è molto più avanti della gerarchia istituzionale. Pochi mesi dopo la morte di Welby il cinquantatreenne Giovanni Nuvoli, ex arbitro di calcio anch’egli da tempo immobilizzato per una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica, si lasciò morire rifiutando cibo e bevande. Ad Alghero don Potito Niolu non chiuse la porta della parrocchia. Celebrò pubblicamente il giusto funerale religioso, esclamando che “Giovanni è stato schiodato dalla croce che ha portato per sette anni”. Roma attende ancora che sulla tomba di Welby un cardinale vada a pregare e celebrare messa come chiese invano la madre di Piergiorgio, cattolica di vecchio stampo, ferita gratuitamente nella sua fede.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- IN MEMORIA DI ANTONIA POZZI. Il cardinale e la messa per la poetessa suicida (di Armando Torno)16 aprile 2012, di Federico La Sala
Il cardinale e la messa per la poetessa suicida
di Armando Torno (Corriere della Sera, 16 aprile 2012)
Il cardinale Gianfranco Ravasi domani, alle 18, celebrerà una messa per la poetessa Antonia Pozzi nella chiesa parrocchiale di Pasturo, in provincia di Lecco, ai piedi delle Grigne. Questa donna, che si laureò (tesi su Flaubert) con Antonio Banfi a Milano, morì suicida il 3 dicembre 1938, a 26 anni. Ha lasciato riflessioni struggenti. Il responsabile della cultura del Vaticano ci ha confidato: «Celebro questa messa perché l’atteggiamento che la Chiesa ha attualmente nei confronti dei suicidi presta molta attenzione alle dimensioni interiori della tragedia. Se l’evento drammatico nasce da una superficialità o è causato dal disprezzo dei valori della vita, allora evidentemente non può essere oggetto di una celebrazione esplicita. Ma - e qui Ravasi apre uno spiraglio di luce - la Pozzi rappresenta il caso di una persona dotata di forte spiritualità e di intensa ricerca interiore, travolta da una sensibilità estrema». La Chiesa non accetta il suicidio razionale; tuttavia, per altre situazioni, si fa interprete misericordiosa.
Pasturo è un paese ricordato da Alessandro Manzoni ne I promessi sposi, perché è il luogo di origine di Agnese, la madre di Lucia. Qui Antonia Pozzi trascorse non pochi giorni nella settecentesca casa di villeggiatura della sua famiglia, dove c’era una buona biblioteca; qui, nel piccolo cimitero, è sepolta. Alle 17 sua eminenza visiterà anche la mostra fotografica dedicata alla poetessa. Ravasi ricorda l’inizio di Funerale senza tristezza, una delle poesie più emozionanti che l’allieva di Banfi ha lasciato: «Questo non è esser morti,/ questo è tornare/ al paese, alla culla...». E poi, dopo aver precisato che sta parlando della morte, evoca la parte conclusiva: «...questo tornare degli umani,/ per aerei ponti/di cielo,/ per candide creste di monti/ sognati,/ all’altra riva, ai prati/ del sole». La fine si trasforma in un «ritorno in Dio, nella luce».
Il cardinale la considera una mistica laica, stimata da lettori importanti (Montale ne patrocinò l’ingresso nella collezione di poesia «Lo specchio» di Mondadori); soprattutto evidenzia l’incessante anelito spirituale, sorta di febbre interiore che colpisce chi cerca la fede. Cita ancora dei versi: «Ma tutta l’acqua mi fu bevuta, o Dio, /ed ora dentro il cuore /ho una caverna vuota /cieca di te. /Signore, per tutto il mio pianto /ridammi una stilla di Te, /ch’io riviva». Infine precisa: «Celebrerò la messa anche per essere vicino a tutte quelle persone sensibili che sentono dentro di sé un vuoto e una domanda». Non a caso la Pozzi scrisse: «Io non devo scordare mai che il cielo fu in me». Per Ravasi questa poetessa «è il canto dell’assenza, che è attesa».
Alle 21 di domani, infine, al Teatro della Società di Lecco (con collegamenti esterni) sua eminenza ricorderà anche David Maria Turoldo, spentosi nel 1992. Erano molto vicini, insieme lavorarono. Sceglie una frase del comune amico Carlo Bo per tratteggiarne il profilo: «Padre David ha avuto da Dio due doni: la fede e la poesia. Dandogli la fede, gli ha imposto di cantarla tutti i giorni».
Insomma - e queste sono parole di Ravasi - «furono testimonianze poetiche obbligate, frutto di una fede esistenziale». Non dimentica che Turoldo è stato sovente chiamato «profeta» (lo fece anche il cardinale Carlo Maria Martini, consegnandogli il Premio Lazzati). «Questa definizione - precisa - è da cogliere in senso corretto e non nell’accezione popolare di uomo che prevede il futuro. Il profeta, anche quello biblico, è colui che si interessa del presente cercando di scoprire in esso un senso trascendente, ovvero l’agire segreto di Dio. Per questo si impolvera nelle vicende della storia». E per il medesimo motivo può essere discusso. E discutibile.
Sua eminenza avrà una giornata densa. O meglio, le sue saranno ore in cui vivrà, tra un’emozione e un ricordo, una confidenza che gli fece Julien Green. L’allora monsignore rivolse al drammaturgo e scrittore una domanda particolare, di quel genere che ogni tanto si tenta con le grandi personalità. Quei quesiti che si possono così formulare: «Cos’è per lei il nucleo del Cristianesimo?». Green rispose al futuro cardinale: «Finché si è inquieti, si può stare tranquilli».
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- Vangelo secondo Tommaso (di Gianfranco Ravasi - Così ha parlato Tommaso)15 aprile 2012, di Federico La Sala
Così ha parlato Tommaso
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2012)
La vicenda ha la trama di un giallo. Inverno 1945-46: in un remoto villaggio dell’Alto Egitto, presso la città di Nag Hammadi (l’antica Chenoboskion), alcuni braccianti stanno estraendo dal sottosuolo un fertilizzante naturale. All’improvviso, sotto le pale, ecco apparire un orcio di ceramica sigillato: aperto, si rivela colmo di libri papiracei rilegati in cuoio. Il caposquadra sequestra per sé il tesoro e lo colloca nella sua modesta abitazione ove senza imbarazzo sua madre, quando deve appiccare il fuoco al focolare, non esita a strappare alcuni di quei fogli. Ma un giorno quell’operaio viene coinvolto in una faida di sangue e, costretto alla fuga, si assicura qualche guadagno piazzando quei testi presso alcuni antiquari. Sembra una leggenda, ma uno di questi codici giungerà fino a casa di Jung, sì, lo "psicoanalista" celebre, come dono offertogli per un compleanno!
Fu solo dieci anni dopo la scoperta, nel 1955, che dodici di quei codici furono ricomposti in unità presso il Museo Copto del Cairo perché copta era la lingua in cui erano scritti, mentre bisognerà attendere fino al 1959 per l’editio princeps del testo divenuto più famoso, quel Vangelo secondo Tommaso che ora possiamo leggere e studiare in una raffinata e accurata versione italiana commentata ampiamente, con testo originale a fronte, per merito di un borsista dell’Università di Torino, Matteo Grosso. In verità, ci si era accorti che quei fogli copti contenevano un testo apocrifo parzialmente già noto in greco in tre papiri rinvenuti tra il 1897 e il 1904 nella località di Ossirinco, un centro a 180 km a sud del Cairo, da due studiosi inglesi, Bernard P. Grenfell e Arthur S. Hunt, e databili attorno al 200-250, antichi di oltre 100-150 anni rispetto ai più ampi paralleli copti di Nag Hammadi..
Ma che cosa conteneva questo scritto che solo nel "colofon" finale è definito «Vangelo secondo Tommaso»? Si tratta di 114 lóghia, cioè "detti" di Gesù, alcuni presenti nei Vangeli canonici, altri ignoti ma spesso non privi di una loro attendibilità storica. Ora, da tempo gli esegeti hanno isolato all’interno dei Vangeli di Matteo e Luca una fonte usata da questi evangelisti denominata Q (dal tedesco Quelle, "fonte’) e costituita anch’essa di frasi pronunciate da Gesù. Si trattava, dunque, di qualcosa di parallelo rispetto al Vangelo secondo Tommaso: sappiamo, infatti, che i Vangeli ebbero alcuni "predecessori", orali e scritti, ossia stesure parziali di detti e fatti di Gesù e memorie su di lui. Certo, il nostro apocrifo è di redazione tarda, ma custodisce al suo interno frasi nuove o analoghe e talora identiche a quelle della fonte Q.
Nonostante l’«alone caliginoso» che avvolge il testo di Tommaso - per usare un’espressione di Grosso -, a causa di una sua ipotetica dipendenza dalle mitologie gnostiche, cioè appartenenti a un’ideologia cristiana deviata fiorita soprattutto in Egitto, dipendenza nettamente esclusa dal curatore di questa edizione, l’opera rivela una sua originalità sia contenutistica sia stilistica sia strutturale, acutamente vagliata da una studiosa statunitense, April D. DeConick (The Original Gospel of Thomas, T&T Clark, London - New York 2006).
Il modello di composizione risultante è dinamico, è quello di un rolling corpus che intreccia tradizioni orali e cristallizzazione scritta e che opera «un continuo e progressivo incorporamento di materiale nuovo», destinato a «inframmezzarsi e compenetrarsi con quello precedente, trasfigurandolo nella forma e riorientandone il significato».
Tre sono gli attori che entrano in scena. C’è innanzitutto una voce narrante che introduce i vari lòghia con la formula: «Dice Gesù...». Si ha poi l’apostolo Tommaso che reca anche il nome di Giuda e la resa greca del significato di Thômàs, "gemello", quindi Didimo, termine usato nei suoi confronti anche dal Vangelo di Giovanni (11,16; 20,24; 21,2). Quest’ultimo lo presenta come personaggio centrale in una delle apparizioni di Cristo risorto, sotto lo scorcio simbolico del dubbioso (20,19-29), al contrario di quanto accade nell’apocrifo ove è l’emblema del vero discepolo.
Infine, ecco il protagonista Gesù che sorprendentemente non è mai chiamato né Cristo né Figlio di Dio, ma soprattutto «il Vivente». Infatti, nel testo è di grande rilievo la dialettica tra vita e morte, tesa verso l’orizzonte escatologico per cui il fedele è destinato a «non gustare la morte» in quel paradiso ove gli alberi «non cambiano né d’estate né d’inverno», le cui foglie sono perenni, divenendo così simbolo d’immortalità (n.19). Perciò, sarà «beato colui che sarà saldo all’inizio: egli conoscerà la fine e non gusterà la morte» (n.18).
A questo punto non resta che percorrere i 114 detti di questo stupefacente Vangelo, accompagnati dalla ricca e attenta esegesi di Grosso. Tanto per far pregustare qualche perla di questa collana spirituale, citeremo tre lòghia. Il primo reca il n. 25 ed è un’esaltazione del precetto dell’amore: «Dice Gesù: Ama tuo fratello come la tua anima; custodiscilo come la pupilla del tuo occhio». Il secondo è in realtà l’ultimo della raccolta (n.114) ed è sconcertante per il suo aspro antifemminismo, testimonianza di ambiti estremi del cristianesimo delle origini, ma ricondotto nei suoi termini specifici dal commento di Grosso a cui rimandiamo. Ecco il testo: «Simon Pietro dice loro: Maria deve lasciarci, perché le donne non meritano la vita. Dice Gesù: Ecco, io stesso la attirerò affinché sia fatto maschio, così che possa anche lei diventare uno spirito vivente, maschio simile a voi. Poiché ogni donna che si farà maschio entrerà nel regno dei cieli». In un altro detto, il 22, si aveva invece il superamento della divisione dei sessi, un po’ nella linea di quanto affermava san Paolo: «Non c’è giudeo né greco, non c’è schiavo né libero, non c’è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Galati 3,28).
Infine, un terzo detto che è, invece, senza riscontri diretti nei Vangeli canonici, ma è dotato di una potenza espressiva straordinaria: «Dice Gesù: Mi sono levato in mezzo al mondo e mi sono manifestato loro nella carne; li ho trovati tutti ubriachi e non ho trovato nessuno tra loro assetato. E la mia anima ha sofferto per i figli degli uomini, poiché essi sono ciechi nel loro cuore e non vedono bene; infatti vuoti sono venuti nel mondo e vuoti cercano di uscire dal mondo. Ma in questo momento sono ubriachi; quando scuoteranno via il loro vino, allora si convertiranno» (n.28).
*
Vangelo secondo Tommaso, Matteo Gasso, Carocci, Roma, pagg. 302, € 25,00
-
> MONSIGNOR RAVASI - CARDINALE RAVASI ---- APPELLO DI CONTURSI: SALVATE LA NOSTRA CAPPELLA SISTINA.28 marzo 2012, di Federico La Sala
APPELLO DI CONTURSI: SALVATE LA NOSTRA CAPPELLA SISTINA
(di Margherita Siani, Il Mattino.Salerno, 26.03.2012)
-
>AL CARDINALE RAVASI .... LETTERA APERTA SULLA "CAPPELLA SISTINA" (DI CONTURSI TERME, OPERA DI CARMELITANI ALLA FINE DEL 1500) E’ IN PERICOLO.21 marzo 2012, di Federico La Sala
 BENI CULTURALI.
BENI CULTURALI.
 A CONTURSI TERME, IN PROVINCIA DI SALERNO, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (AD OPERA DEI CARMELITANI, ALLA FINE DEL 1500).
A CONTURSI TERME, IN PROVINCIA DI SALERNO, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (AD OPERA DEI CARMELITANI, ALLA FINE DEL 1500).
 "CAPPELLA SISTINA" IN PERICOLO.
"CAPPELLA SISTINA" IN PERICOLO.
 Lettera aperta al Soprintendente di Salerno, sullo stato della Chiesa "Maria SS. del Carmine" di Contursi Terme
Lettera aperta al Soprintendente di Salerno, sullo stato della Chiesa "Maria SS. del Carmine" di Contursi Terme
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---IL PORPORATO TWITTA. «Porto la Chiesa nel cortile di Twitter». Intervista a Gianfranco Ravasi (di di Cesare Buquicchio Maddalena Loy).29 febbraio 2012, di Federico La Sala
Intervista a Gianfranco Ravasi
«Porto la Chiesa nel cortile di Twitter»
Il cardinale spiega perché la Cattedra di Pietro non deve avere paura del sesto potere: «Ha bisogno di ritrovare la forza del suo linguaggio e, grazie al web, sperimentare rigore, incisività, fulgore e bagliore»
di Cesare Buquicchio Maddalena Loy (l’Unità,29.02.2012)
L’amore che non si rinnova ogni giorno e ogni notte diventa abitudine e lentamente si trasforma in schiavitù. Una frase, una citazione, 140 caratteri possono contenere un fulgore e una profondità che abbaglia. Tra i cinquecento milioni di persone che ogni giorno si misurano con i brevi testi di Twitter c’è anche il cardinal Gianfranco Ravasi e la citazione di Kahlil Gibran è uno dei suoi più recenti tweet insieme con passi dei Vangeli, frasi di Sciascia e John Lennon, Gesualdo Bufalino e Goethe, versetti del Libro di Siracide e delle Lettere ai Corinzi. Il tutto con una logica: tweet laici la mattina, tweet religiosi la sera. È l’attento e meditato esercizio di introdurre complessità e senso nella rigida e, a volte, un po’ svagata, onda dei tweet. E, allo stesso tempo, una risposta al pregiudizio di una chiesa chiusa al progresso. È lo sforzo del presidente del Pontificio consiglio della Cultura, sbarcato sul social network «per curiosità», ma immerso nei 140 caratteri con l’impegno e la profondità degli uomini di Chiesa.
Cardinale, come e quando ha cominciato ad usare Twitter?
«Da migrante digitale, e non da nativo digitale, ho cominciato a percorrere queste strade in maniera molto ingenua e molto curiosa. Ecco, è stata questa curiosità che mi ha spinto cominciare...».
Lei smentisce lo stereotipo di una chiesa chiusa al progresso?
«Il mio compito è nell’ambito di un dicastero vaticano dedicato alla cultura. È, dunque, quello di avere il respiro nel cortile, non tanto nel tempio, più nella piazza che nel palazzo. Questo vale per tutta la cultura, non solo per il Vaticano, perché attualmente non c’è più il concetto aristocratico di cultura, c’è quello antropologico della cultura industriale. Ed è per questo che io sono uscito nel cortile. Ma ritengo che tutta la chiesa debba essere anche sulla piazza e non solo tra gli incensi del tempio». Concetti profondi nella brevità di Twitter: è questa la sfida della chiesa? «Uno degli aspetti più interessanti di Twitter è il vincolo del restare nella gabbia dei 140 caratteri. Questo ti costringe non soltanto all’incisività, al fulgore, al bagliore, ma anche al rigore. E questo va contro una certa tendenza attribuita all’eloquenza sacra, la quale, diceva Voltaire, “è come la spada di Carlo Magno, lunga e piatta...”, perché i predicatori quello che non sanno dare in profondità, cercano di darlo in lunghezza».
Non c’è il rischio di snaturare il messaggio della chiesa?
«Questa è una domanda capitale, perché effettivamente percorrere le arterie di questo nuovo mezzo di comunicazione, non deve far dimenticare che il linguaggio è molto più sontuoso e glorioso, soprattutto quello religioso che ha secoli di elaborazione alle spalle. Per questo non si deve mai abbandonare la subordinata. L’informatica pretende le coordinate, le frasi brevi, mentre la filosofia, la teologia, la grande cultura, prediligono le subordinate, le deduzioni, le ramificazioni. Non usiamo Twitter in modo ingenuo».
Lei ha oltre 13mila follower ma segue solo 32 persone. Segue altri cardinali, direttori di giornali, ma ci è sembrato di vedere solo un politico: Matteo Renzi. È una scelta di campo?
«Per me è una sorpresa, non ci avevo fatto caso. Ma, al di là di Renzi, devo dire che il senso della mia partecipazione a Twitter è rivolta anche verso i non credenti e in particolare verso i polemici... In questi tempi in cui si parla molto di Ici della Chiesa, su Twitter sono stato ininterrottamente bersagliato e devo dire che la palma del tweet più divertente va alla mia follower che ha parafrasato il motto di Sant’Agostino “Oh Signore fammi casto ma non subito” in “Oh Signore fammi catasto ma non subito”». Questa sua familiarità con il web ha trovato delle resistenze nel Vaticano? «Che ci siano delle perplessità è normale, a volte le ho anche io. Spesso c’è una deriva nella comunicazione informatica. E va approfondito l’impatto sulle culture giovanili, perché un ragazzo che sta cinque ore ogni giorno davanti a un computer muta antropologicamente. Ma d’altra parte, stare sul web è necessario perché è una nuova grammatica di linguaggio. E molti vescovi cominciano a frequentare il web: il vescovo di Soissons ha inventato le tweetomelie. Un modo per raggiungere un orizzonte di persone che non metteranno mai piede in una chiesa».
Anche il Santo Padre è sbarcato su Twitter. È stato lei a consigliarlo?
«No, il merito è di monsignor Celli, presidente del Pontificio consiglio delle Comunicazioni sociali e responsabile Vaticano di questo settore. Però recentemente con Benedetto XVI abbiamo a lungo parlato di questi argomenti ed era molto incuriosito dalla decifrazione di quello che io chiamo il “sesto potere”. Un potere che ha veramente una efficacia imperiale. Perché non si tratta più di un aggregato come poteva essere la televisione con l’occhio o il telefono per l’orecchio. È un vero e proprio ambiente in cui siamo immersi anche se non vogliamo esserlo...»
l’Unità 29.2.12Archeologo e biblista conquistato dalla modernità
Comunicare il sacro attraverso le nuove tecnologie. È quello che fa il porporato: scrive sui giornali, naviga e «twitta»
di Roberto Monteforte
Come presentare Gianfranco Ravasi ora cardinale di Santa Romana Chiesa e posto da papa Benedetto XVI a capo del dicastero vaticano della Cultura? Biblista di fama internazionale, già prefetto della prestigiosa biblioteca Ambrosiana, scrittore, saggista, collaboratore anche di «testate» laiche come Il Sole24ore è soprattutto un grande comunicatore del «sacro» che ha il coraggio di porre il problema dell’Assoluto, di Dio, della speranza cristiana nella società contemporanea.
Twitta il porporato. Archeologo e biblista di formazione, in lui la citazione dotta non è sfoggio, ma messa in comune di pillole di saggezza quotidiana, tratte non solo dai sacri testi ma da pensatori e filosofi, poeti e cantanti di ogni epoca, offerti a chi crede e a chi non crede per favorire una riflessione sulla vita e arricchire di umanità la quotidianità. Sono un esempio di come la cultura possa essere messa al servizio dell’uomo e della «buona comunicazione» e di come, nell’indistinto frastuono mediatico, le parole possano ritrovare forza e significato. Con l’obiettivo di umanizzare la comunicazione e costruire relazioni tra le persone, rompendo lo schema chiuso della comunicazione autoreferenziale. Per Ravasi accettare la sfida della comunicazione globale rappresenta una diretta conseguenza della sua «missione»: aiutare la Chiesa a dialogare con l’uomo contemporaneo, cercandolo dove è, anche nel mondo del web. Come un esploratore in perlustrazione in territori sconosciuti, distanti e spesso ostili. Lo fa libero da preconcetti, con l’apertura al confronto dell’uomo di cultura. D’altra parte è sua la responsabilità del progetto del Cortile dei Gentili luogo aperto al confronto esigente con le culture religiose, filosofiche e scientifiche, voluto da papa Benedetto XVI. Il responsabile del Pontificio consiglio della Cultura si fa compagno di strada nella ricerca di senso dell’uomo contemporaneo, inoltrandosi sino alle zone limite, ai punti di confine tra scienza e vita, alle domande etiche fondamentali. Ricercando anche nelle forme dell’arte contemporanea, da quelle figurative al cinema e al teatro, alla musica, alla stessa comunicazione, il riflesso delle ricerca di Assoluto.
È lo sforzo della Chiesa di riannodare i fili di un dialogo con ambienti spesso indifferenti o ostili al suo messaggio. Ma per Ravasi può essere più semplice tessere rapporti con le élite intellettuali che vincere l’indifferenza dell’uomo che vive rassegnato il suo tempo. Far veicolare attraverso Twitter «pillole di saggezza» può rappresentare il tentativo di aprire la mente e il cuore alla riflessione sul senso del vivere.
l’Unità 29.2.12 Cybernauti di fede
Cybernauti di fede
 Presto sul web il pensiero di Papa Benedetto XVI
Presto sul web il pensiero di Papa Benedetto XVINon sarà possibile chattare con Papa Benedetto XVI ma presto chi vuole potrà trovare il suo pensiero veicolato su Twitter. La Chiesa accetta la sfida della comunicazione globale, gran regista è monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio consiglio delle Comunicazioni. Restyling del sito vaticano, sinergia tra il Centro di produzione televisiva, Radio vaticana e l’«Osservatore Romano», tanti siti web. È una rivoluzione culturale. Un esempio? Il cybernauta padre Antonio Spataro direttore di Civiltà Cattolica.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- «Il Cortile allarga i confini». Intervista a Gianfranco Ravasi17 febbraio 2012, di Federico La Sala
Ravasi: «Il Cortile allarga i confini»
intervista a Gianfranco Ravasi
a cura di Lorenzo Fazzini (Avvenire, 17 febbraio 2012)
Dall’illuminista Parigi alla Tirana ex comunista; da Assisi, patria del Poverello, a Bucarest, porta d’Oriente. E, a venire: Barcellona, vetrina della Sagrada Familia, Stoccolma, terra dei Nobel, la Milano sede della Borsa, Marsiglia, patria di Albert Camus. In futuro: Gerusalemme, Washington, Vienna. Il Cortile dei gentili si allarga e abbraccia culture, località, centri accademici diversissimi ma uniti - chiarisce il cardinale Gianfranco Ravasi, regista dell’operazione voluta da Benedetto XVI - dal desiderio di indagare il senso del mistero dell’uomo.
Dall’iniziale intuizione del pontefice (eravamo nel dicembre 2009) affinché la Chiesa aprisse un «nuovo Cortile dei gentili» per dialogare con quanti «sentono la religione come una cosa estranea» ma vogliono avvicinare Dio «almeno come uno Sconosciuto», molto è già stato fatto e altrettanto è in cantiere. Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, confida: «Il problema è tener testa alle tantissime richieste: tutto questo significa che c’è un desiderio comune contrassegnato dalla ricerca di senso». Insomma, da quando il laico "Le Figaro" titolò l’anno scorso «Il Vaticano si invita alla Sorbona» (inaudito negli anni passati, se si pensa alla Francia laicissima), ormai sembra soffiare un’aria nuova tra Chiesa e cultura umanista: Julia Kristeva, Jean Clair, Remo Bodei, Axel Kahn, Giuliano Amato, Jean Luc Marion, Rémi Brague, Jean-Claude Casanova, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Fabrice Hadjadj. Questi solo alcuni dei nomi che hanno punteggiato il primo anno di vita del Cortile. E altri se ne stagliano all’orizzonte.
Eminenza, tempo fa aveva annunciato il confronto con l’ateismo "popolare", quello alla Michel Onfray per intendersi: a che punto siamo?
«Per ora abbiamo escluso - ma non necessariamente - le due ali "estreme" dell’ateismo lasciando da parte l’ateismo "nazional-popolare", di superficie, caustico e sarcastico, quasi aggressivo. Si tratta di una forma antropologica: i suoi sostenitori sembrano alfieri di un’anti-religione. Su questo dobbiamo operare una riflessione perché è un fenomeno molto diffuso, complesso e con una sua letteratura. Tale movimento si inserisce nel più grande ambito dell’indifferenza: questi autori, se lanciano una battuta forte ("l’illusione di Dio", "l’assurdità della religione") suscitano interesse. Prima o poi affronteremo questa atmosfera nebbiosa che rappresenta il frutto estremo della secolarizzazione».
E gli atei devoti? Alcuni, dal mondo cattolico tradizionale, le rimproverano di escluderli...
«Anche questo è un ambito molto variegato. Degli "atei devoti" non ce ne siamo interessati perché in molti casi i suoi esponenti hanno un’implicanza politica. Da queste persone il tema religioso viene affrontato in maniera apologetica, per cui la religione cristiana costituisce solo un grande valore per l’Occidente. Si tratta di una sottolineatura giusta ma che non rappresenta uno scavo profondo. Questi autori non tengono in conto grandi prospettive di indagine. Si accontentano di ripetere la dottrina, e basta. Comunque è vero che queste "ali estreme" chiedono il dialogo: tra gli atei "nazional-popolari" cito Paolo Flores D’Arcais e Piergiorgio Odifreddi; fra gli "atei devoti" Giuliano Ferrara... Ma fino ad ora l’impostazione del Cortile rientra nell’alveo centrale del confronto tra le grandi visioni di interpretazione della realtà mediante un linguaggio comune: il concetto di cultura. Nelle tappe del Cortile di Bologna, Parigi, Firenze, Tirana si sono affrontate tematiche come la cosmologia, il male, il diritto, la laicità, l’arte».
Quale la ragione d’essere del Cortile?
«Ritornare al modello di evangelizzazione di Paolo: l’Apostolo è stato capace di assumere le categorie del pensiero classico a lui contemporaneo per annunciare il cristianesimo. Come evidenzia Jacques Dupont, l’idea della Chiesa come corpo mistico è mutuata dalla concezione stoica dell’anima mundi. Paolo andava in campo "laico" ad attingere concetti e categorie. Mi emoziono sempre a pensare quanto Agostino ha studiato Platone e Plotino per poterli poi "battezzare"».
Gli atei accettano di esser definiti tali?
«Il termine "ateismo" è obsoleto. Il filosofo non credente messicano Guillermo Hurtado, presente all’incontro di Assisi, sull’“Osservatore romano” ha rilevato come l’ateismo non si autodefinisce nemmeno terminologicamente. Le racconto un dettaglio eloquente. Quando il Papa decise di invitare i non credenti ad Assisi, sorse il problema di come definirli: atei è parola desueta e una categoria illuministica, richiama il marchese de Sade. Agnostici? Ma essi ci dicevano: “Allora voi siete gnostici?”. Infatti il cristianesimo ha rifiutato ogni gnosi. Non credenti? Determina solo in senso negativo. Alla fine è prevalsa, dopo un giro di consultazioni, l’idea di Julia Kristeva: umanisti, un termine accettato sia in ambiente francese che in quello anglofono».
Lei tiene un blog, twitta, usa i social network. Che legame esiste tra il web e il Cortile?
«Stiamo pensando a una plenaria del Pontificio Consiglio dedicata alle culture giovanili, alla secolarizzazione e alle indifferenze su vari campi: la musica (un linguaggio fondamentale), l’amicizia (non più quella della nostra generazione), i raduni corali (i concerti), le spiritualità vaghe dell’Oriente. Su questo mi piacerebbe coinvolgere il filosofo Charles Taylor e lo scrittore Claudio Magris».
Quali i risultati già delineati dopo il primo anno di Cortile?
«L’umanesimo "laico" e la fede sono accomunati da un elemento: il ruolo fondamentale della ricerca. È un tema che troviamo in due classici come l’Apologia di Socrate ("una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta") e l’incipit delle Confessioni di Sant’Agostino (il "cuore inquieto"). Su questo vorrei spendere una parola, perché spesso i giornalisti obiettano che comunque la Chiesa, con il Cortile, intende convertire chi non crede. Il problema è intendersi: quando un non credente interviene al Cortile non fa solo opera di informazione. Il suo è un intervento anche performativo, che cerca di convincere l’altro della sua posizione. Basti pensare con quanta passione sono intervenuti il genetista Axel Kahn o la scrittrice Julia Kristeva alla Sorbona. Non lo avrebbero fatto così se non pensassero di convincere i presenti delle loro ragioni. Questo non è negativo. E poi un risultato importante del Cortile c’è già...».
Quale?
«Abbiamo contribuito a elevare il tono del dibattito culturale che spesso risulta abbassato fino alla polvere. Diamo così un contributo alla società deponendo alcuni semi che possono crescere e fruttificare. A Firenze, ad esempio, si è parlato di temi alti (arte e fede, ndr) e la gente è rimasta ad ascoltare per ore. Non è vero che la gente si interessa solo di cibo e festini, o che ascolta unicamente il menù del giorno, per citare Kierkegaard».
Cosa le dice il Papa del Cortile? Le ha dato suggerimenti?
«Anzitutto, va evidenziata una cosa: che l’invito ai "non credenti" ad Assisi è un’idea precisa di Benedetto XVI in persona. Fu lui, in una riunione ristretta con quattro cardinali di Curia, a chiedere questa presenza. E mi sorprese la motivazione di tale invito: rinverdire il modello della teologia patristica, cioè riprendere la capacità dei Padri di entrare in dialogo con le categorie della filosofia del proprio tempo. Se si scorre l’indice di Introduzione al cristianesimo del teologo Joseph Ratzinger, si vedono moltissime citazioni di autori "laici" della cultura tedesca».
In che modo il pontefice si interessa al Cortile?
«Ogni volta che incontro Benedetto XVI, ciò di cui si informa subito (e che considera più importante nel mio lavoro) è il Cortile dei gentili. Una volta mi ha detto: "Le sono particolarmente grato perché con il Cortile lei va dove noi, come Chiesa, non potremmo andare". E infatti nelle varie istituzioni in cui mi invitano io vado sempre come cardinale e rappresentante della Santa Sede».
Ci sarà un giorno un evento del Cortile con Benedetto XVI presente?
«Stiamo pensando a un evento del genere. Lui sa fare molto bene il dialogo "a braccio", specialmente con i giovani. Ma anche con un interlocutore. Vediamo. Potrebbe essere all’interno della plenaria dedicata alle culture giovanili, come dialogo con dei ragazzi e ragazze».
Il Cortile e la cattedra dei non credenti di Milano, inventata dal cardinal Martini: più volte le due iniziative sono state accomunate. Paragone corretto?
«C’è una differenza. Nella Cattedra, per la prima volta, un non credente veniva a parlare a dei credenti dalla cattedra, presentando la sua visione su un certo tema; a Martini spettavano le conclusioni. Nel Cortile invece c’è una dimensione di parità, come se ci fossero due cattedre. Ma posso dire che Martini è molto contento di questa iniziativa perché prosegue, seppur in maniera diversa, quella sua intuizione».
Lei ha un sogno personale sul Cortile? Un dialogo che le piacerebbe vivere?
«Non ci ho mai pensato. Però ... beh, sicuramente la partecipazione diretta di Benedetto XVI sarebbe molto bella. Un sogno sul passato sarebbe stato un dibattito con Albert Camus. Oggi invece mi interessano molto le questioni delle nuove comunicazioni: è venuto a incontrarmi il presidente di Google, Eric Schmidt. E penserei a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Ci sono contatti in corso con lo scrittore Mario Vargas Llosa per un dialogo a due: lo farei molto volentieri».
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- SILENZIO DEI TEOLOGI E MEMORIA DEL PROFETA GIOELE: RIPRENDERE LA PAROLA. Un appello di preti e religiosi alle teologhe e ai teologi.1 gennaio 2012
 Papa e Vescovi, tutta la Gerarchia della Chiesa "cattolico-romana" senza più la Parola evangelica!!!
Papa e Vescovi, tutta la Gerarchia della Chiesa "cattolico-romana" senza più la Parola evangelica!!!
 SILENZIO DEI TEOLOGI E MEMORIA DEL PROFETA GIOELE: RIPRENDERE LA PAROLA. Un appello di preti e religiosi alle teologhe e ai teologi. Una nota di Luca Kocci e il testo della lettera
SILENZIO DEI TEOLOGI E MEMORIA DEL PROFETA GIOELE: RIPRENDERE LA PAROLA. Un appello di preti e religiosi alle teologhe e ai teologi. Una nota di Luca Kocci e il testo della lettera
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- IL CYBERCARDINALE HA ALTRO DA PENSARE. L’omelia via Twitter, 140 battute per parlare a un pubblico immenso (di Armando Torno).9 gennaio 2012, di Federico La Sala
L’omelia via Twitter, 140 battute per parlare a un pubblico immenso
di Armando Torno (Corriere della Sera, 9 gennaio 2012)
Tutti hanno avuto qualcosa da dire sulle prediche o meglio sulle omelie tenute durante le sacre funzioni. I fedeli si sono sovente lagnati per la lunghezza; non pochi esponenti della gerarchia ecclesiastica, di contro, hanno recentemente espresso preoccupazioni per il tono dimesso, gli errori proferiti e, purtroppo, per l’inconsistenza degli argomenti evocati.
Le prediche lunghe stancano, certe altre possono favorire interpretazioni labili delle Scritture. Tanto più che sempre meno sacerdoti conoscono le lingue originali della Bibbia.
Il cardinale Gianfranco Ravasi, ministro vaticano della Cultura, l’ha pensata bella rilanciando la sfida di un vescovo francese, Hervé Giraud: far circolare le omelie attraverso Twitter. Certo, sono 140 battute, ma il pubblico a cui giunge il messaggio è vastissimo e il contenuto è possibile certificarlo. Non c’è la voce che tuona dal pulpito, ma poche parole facili da leggere che ricordano a tutti momenti e messaggi della fede cattolica.
Un tempo la predica si trasformava sovente in cultura. Per fare un esempio tra i molti possibili, basterà citare Giordano da Pisa che, al tempo di Dante, richiamava in Santa Maria Novella mezza Firenze: oggi i suoi vocaboli sono preziosi riferimenti nei dizionari della lingua italiana. Di oratori sacri è piena la nostra letteratura e anche padre Cristoforo - personaggio chiave de I promessi sposi di Manzoni - era un predicatore (venne mandato a piedi a raggiungere i pulpiti di Rimini).
Oggi le parole delle omelie, o anche delle meditazioni per il giorno di festa, si perdono. In televisione il cardinale Ravasi ha un vasto seguito, così come altri predicatori (anche non cattolici) lo hanno trovato, magari grazie alle radio, ma questa via di Twitter va incontro a un pubblico completamente diverso.
Non stupiamoci: sono giovani o anche ragazzi. Per diverse ragioni, molti di loro non hanno mai ascoltato una predica. Twitter li informerà per la prima volta. Con 140 battute. Ma per colpire una sensibilità possono bastare.
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- LA QUESTIONE DELLA "H". La lettera che ’non conta nulla’ e il ... "non capire niente"!!!2 ottobre 2011, di Federico La Sala
LA GRAMMATICA
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, 30.09.2011)
Il rabbí di Gher raccontava: «Da ragazzo non volevo applicarmi allo studio della grammatica perché la consideravo una scienza come tante altre. Più tardi, invece, mi ci sono dedicato con passione perché ho visto che i segreti della Bibbia sono legati ad essa».
Sono stato per anni docente di esegesi biblica; ho passato buona parte della mia vita a studiare le Sacre Scritture e, anche se ora la mia missione è un’altra, considero sempre il santo di oggi, Girolamo, il mio ideale patrono. Non c’è bisogno di spiegare che questo personaggio dal carattere piuttosto rubesto, morto il 30 settembre del 420 nell’aspra solitudine delle grotte di Betlemme, è stato il più famoso traduttore e studioso antico della Bibbia. Io, però, sono ricorso - per commemorarlo - a uno degli apologhi che il filosofo Martin Buber ha raccolto nei suoi Racconti dei Chassidim.
Un maestro ebreo, appartenente a questa corrente mistica mitteleuropea, ammoniva il suo discepolo sulla necessità dello studio della grammatica. Apparentemente essa è arida, è un sistema di regole, è un minuzioso gioco a incastro di elementi variabili secondo le diverse lingue. Eppure, è l’ossatura senza la quale il pensiero si sfalda, la bellezza si scolora, il messaggio si estingue. Un altro scrittore cristiano del VII secolo,
Massimo il Confessore, dichiarava: «Se non conosci le parole [umane] della Scrittura, come potrai raggiungere la Parola [divina]?». Come accade in Cristo che è Verbo divino ma è anche «carne», cioè linguaggio e realtà umana, così è per la Bibbia. Per questo, l’antica tradizione ecclesiale ha sempre esaltato come fondamentale - prima di ogni senso «spirituale» - il senso «letterale», e Lutero ribadiva che il «grammaticale» è il primo dato teologico e non solo letterario. Riflettano quelli che si vantano di letture bibliche solo «spiritualistiche», senza «grammatica»!
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ----- GIUDICARE E VALUTARE. E’ grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso (di Gianfranco Ravasi).,7 luglio 2011, di Federico La Sala
GIUDICARE E VALUTARE
di Gianfranco Ravasi (Avvenire/Il Mattutino, 07/07/2011)
- Il giudizio è la facoltà che acquisiamo più tardi e perdiamo più presto del necessario: i bambini non ne hanno ancora, i vecchi non ne hanno più. Stiamo anche oggi, come abbiamo fatto ieri, nel perimetro della famiglia, ma secondo un angolo di visuale particolare.
Ci affidiamo a questa considerazione del poeta francese ottocentesco Alfred de Vigny che troviamo citata in un saggio dedicato ai trapassi generazionali di questi ultimi decenni. La capacità di giudicare è un po’ come il criterio: ognuno crede di esserne dotato a sufficienza. In realtà, le cose stanno in maniera un po’ diversa, come suggerisce lo scrittore francese. I bambini non l’hanno ancora, i vecchi ormai l’hanno persa con l’annebbiamento delle loro menti e - aggiungiamo noi - gli adulti non la esercitano. Anche all’interno della famiglia è ormai raro ritrovarsi insieme per valutare, vagliare, giudicare appunto le vicende e i comportamenti.
Certo, come insegnava l’Orlando furioso dell’Ariosto, «il giudicio uman spesso erra». Ma è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso, ossia la coscienza morale che ci aiuta a distinguere tra bene e male. È, questo, un esercizio che i genitori e gli educatori dovrebbero insegnare ai ragazzi.
Un altro autore francese che spesso abbiamo citato, Montaigne, nei suoi Saggi non esitava ad affermare che «la cura e la spesa dei nostri padri mirano solo a riempirci la testa di sapere; di giudizio e di virtù, non se ne parla nemmeno!». Pensiamo a quanto si investe giustamente in corsi di nuoto, in scuole di musica, in fitness e altro perché i figli siano addestrati e palestrati. Ma quanto poco si fa per una loro educazione civica, sociale e spirituale!
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI.1 luglio 2011, di Federico La Sala
 L’EUCHARISTIA E IL "DEUS CARITAS" DI BENEDETTO XVI. LA GRAZIA DEL DIO DI GESU’ E’ *BENE COMUNE* DELL’INTERA UMANITA’, MA IL VATICANO LA GESTISCE COME SE FOSSE UNA SUA PROPRIETA’. Una miseria senza fine dell’intera gerarchia vaticana ...
L’EUCHARISTIA E IL "DEUS CARITAS" DI BENEDETTO XVI. LA GRAZIA DEL DIO DI GESU’ E’ *BENE COMUNE* DELL’INTERA UMANITA’, MA IL VATICANO LA GESTISCE COME SE FOSSE UNA SUA PROPRIETA’. Una miseria senza fine dell’intera gerarchia vaticana ...
 FAME NEL MONDO?! CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI. Una nota sull’evento - con appunti sul tema
FAME NEL MONDO?! CIBO MATERIALE E CIBO SPIRITUALE: UNA SOLA GRANDE SPECULAZIONE TEOLOGICO-POLITICA ED ECONOMICA! La Conferenza della Fao e l’intervento di Benedetto XVI. Una nota sull’evento - con appunti sul tema
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- E SMETTERLA DI DARE "ZAMPATE"?! - In ricordo di Michele Do, "La zampata e l’infinito" (di Gianfranco Ravasi - Mattutino).19 maggio 2011, di Federico La Sala
La zampata e l’infinito
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, 19 maggio 2011)
«Quando in un branco un compagno dà una zampata, l’immediato istinto dell’animale è la ritorsione. La prima volta che un animale trattiene la zampata, avverte l’orrore del sangue e non reagisce alla violenza: qui è nato un uomo».
Di lui mi avevano spesso parlato amici comuni, ma anche laici e sacerdoti che accorrevano lassù nel paesino della Val d’Aosta ove aveva trascorso la maggior parte della sua vita, nella purezza assoluta della natura e della sua meditazione e testimonianza. Sto parlando di don Michele Do (1918-2005) e oggi lo rievoco attraverso queste sue righe che vogliono rappresentare simbolicamente quando si compie la vera ominizzazione. Noi passiamo dallo stato bestiale a quello umano nel momento in cui il nostro pugno lascia cadere a terra il sasso di Caino o la spada della vendetta o la zampata dell’assalto, e proviamo nausea e orrore della violenza.
Questo è, certo, il primo grande passo verso la nascita dell’uomo, ossia la scoperta del perdono e dell’amore. Ma don Michele va oltre e continua così, prospettando un’altra tappa fondamentale: «Quando uno degli animali che procede nel branco, alza gli occhi e vede le stelle, quando ne avverte per la prima volta lo stupore, la meraviglia, il mistero, quando - come dice Fogazzaro - sente su di sé, sul proprio cuore, il peso delle stelle: qui è nato l’uomo».
La nostra realtà è, infatti, bidimensionale. Noi non guardiamo solo orizzontalmente, incontrando con gli occhi le altre creature; noi abbiamo un altro sguardo che sale verticalmente, verso l’infinito e il Creatore. È questa l’estrema avventura dell’uomo e della donna, affacciarsi sulle immensità del mistero e cercare di raggiungerle. Siamo un microcosmo che può contenere il cosmo e persino l’infinito, come suggeriva Pascal.
-
> DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! PER IL CARDINALE RAVASI TUTTO FA "BRODO" ..... Agostino amato da Bob Dylan (di Gianfranco Ravasi).10 aprile 2011, di Federico La Sala
Alcune note in premessa:
Federico La Sala
Agostino amato da Bob Dylandi Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 Ore, 10 aprile 2011
Settant’anni fa, il 24 maggio 1941, a Duluth, porto fluviale che s’affaccia sul lago Superiore, il secondo al mondo dopo il Caspio, nel Minnesota, nasceva Bob Dylan (all’anagrafe Robert Zimmermann). Questo cantautore divenuto uno dei miti dell’epopea beat degli anni Sessanta, vagabondo e inquieto fino a ripiegare, nell’ultima fase, all’interno del panorama segreto della sua interiorità attraverso esplorazioni dai contorni ora psichedelici ora mistici, trasformatosi persino in scrittore col non memorabile romanzo Tarantula del 1971, noi ora lo dirottiamo nelle nostre righe per una ragione che sorprenderà molti. Sì, lo coinvolgiamo nientemeno che in una recensione riguardante uno dei massimi Padri della Chiesa, quel sant’Agostino a cui Dylan nell’album John Wesley Harding dedicò nel 1968 una canzone.
Non è che i temi spirituali siano stati alieni a questo personaggio che aveva respirato non solo folk, rock e blues ma anche echi degli spirituals afro-americani: lo ricordo ancora col suo inseparabile cappello mentre cantava e suonava davanti a un (forse perplesso) attento e incuriosito Giovanni Paolo II durante una serata per i giovani in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale il 27 settembre 1997, a Bologna, invitato coraggiosamente dall’allora arcivescovo, il cardinale Giacomo Biffi. Ma ritorniamo alla canzone che inizia così: I dreamed I saw saint Augustine e che ha il suo apice nella ripresa successiva: I dreamed I saw saint Augustine alive with fiery breath! Dunque, Bob aveva sognato di vedere sant’Agostino «in carne e ossa che correva nei nostri quartieri in estrema povertà... e cercava anime che già erano state vendute, gridando forte: Alzatevi, alzatevi! Venite fuori e ascoltate...».
E alla fine, ecco Dylan confessare ancora: «Ho sognato di vedere sant’Agostino, vivo di un respiro di fuoco» per aggiungere in conclusione un apocrifo martirio del santo, in realtà solo un incubo onirico: «Ho sognato di essere tra coloro che lo misero a morte! Oh, mi sono svegliato adirato, solo e terrorizzato..., ho abbassato la testa e ho pianto». Ebbene, proprio questa canzone l’ho ritrovata in apertura a una curiosa e un po’ provocatoria biografia di Agostino di Ippona... per chi non ha tempo, tracciata da un professore di scienze religiose di Lancaster in Pennsylvania, tale Stephen A. Cooper, che si è fatto accompagnare dal cartoonist Ron Hill di Cleveland. Un’americanata, direte. Era un po’ il sospetto che avevo anch’io quando ho sfogliato queste pagine a prima vista irriverenti.
In verità, andando avanti, di capitolo in capitolo, mi sono riconciliato con Cooper e il suo vignettista un po’ esagitato: il ritratto del grande santo e genio dell’umanità è ben abbozzato per un lettore ignaro di temi teologici, anzi, mi è venuto il dubbio che fosse fin troppo impegnativo per «chi non ha tempo» da dedicare a simili argomenti. Certo, l’autore non si inoltra più di tanto nell’oceano testuale agostiniano, ma preferisce attestarsi sulla filigrana delle Confessioni, vera e propria odissea di una conversione e storia di un’anima (giustamente Cooper amerebbe intitolare quell’opera Conversazioni perché, come è noto, il testo è un interrotto dialogo con Dio).
Eppure, il lettore frettoloso - ma non troppo - del volume scopre il profilo intimo di una ricerca che intreccia fede e ragione, Bibbia e Plotino, mistica e autocoscienza, conversione esistenziale e riflessione metafisica. In ultima analisi, aveva ragione Dylan, nel vescovo di Ippona, si incrocia un fiery breath, un ardente respiro di amore, con un alito fresco che proviene dai cieli cristallini della teologia, nella ferma convinzione che «la natura umana manca di unitarietà e la può trovare solo alla luce dell’unitarietà di Dio e questa dote divina è resa a noi disponibile in una forma umana, prima in Cristo e poi nella Chiesa, poiché la Chiesa è la dimensione sociale dell’esistenza cristiana».
Ma a chi ha tempo e vuole inoltrarsi in quel mare di pensieri, di riflessioni, di invocazioni che sostanziano le pagine agostiniane che cosa possiamo suggerire? Arduo è dare un’indicazione perché statisticamente si dice che ogni giorno appare almeno una pubblicazione su o di Agostino. Scegliamo, allora, uno dei suoi gioielli teologici e letterari, quel Commento al Vangelo di Giovanni che la mai a sufficienza lodata collana «Il pensiero occidentale» di Bompiani ci squaderna davanti sia nell’originale latino coi suoi 124 tractatus, sia nella versione italiana accompagnata da un’ampia esegesi di Giovanni Reale. Siamo in presenza di una serie di discorsi distribuiti in tre fasi storiche differenti (nel 406-407, nel 414 e infine degli anni 419-421) e composti con modalità diverse, alcuni in forma orale trascritta dai tachigrafi, altri dettati dal santo stesso; eppure questa eterogeneità non mina la compattezza dell’opera.
Essa, come suggerisce il curatore, rivela nelle sue pagine non solo un anelito straordinario di spiritualità, di comunicazione e di cultura - tant’è vero che è giusto lamentare che l’opera sia nota soltanto ai teologi e ignota agli uomini di cultura -, ma anche una particolare tessitura "a tarsia" allestita attraverso una fitta trama di citazioni ed evocazioni o ammiccamenti biblici. Centrale, ovviamente, è il tema del l’agápe cristiana che trascende e fin capovolge la concezione platonica dell’eros. Un amore che ha la sua sorgente nell’Incarnazione: Deus homo factus est; quid futurus est homo, propter quem Deus factus est homo? («Dio si è fatto uomo, che cosa dovrà diventare l’uomo, se per lui Dio si è fatto uomo?»). E che dire, poi, della "terza navigazione" agostiniana, condotta sul naviglio del lignum crucis, che travalica la celebre "seconda navigazione" (déuteros plous) del Fedone platonico. Lasciamo, allora, al lettore che ama le profondità abissali o i vertici di luce di imbarcarsi in questa avventura della mente e dell’anima.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- IL CORTILE DEI GENTILI ovvero PER UN DIALOGO SENZA ASCOLTO (di Piero Stefani - Dalla cattedra al cortile)3 marzo 2011, di Federico La Sala
Dalla cattedra al cortile
di Piero Stefani (Il pensiero della settimana, 26 febbraio 2011)
Una delle intuizioni più profonde del card. Martini fu di istituire la «cattedra dei non credenti». L’esempio di Milano fu imitato da molti, in modi non sempre felici. Invero, nel succedersi delle edizioni, anche nella diocesi ambrosiana l’iniziativa perse progressivamente di smalto. Assunse, infatti, più l’aspetto di «liturgia culturale» che di vero e proprio confronto. Ciò non toglie la geniale originalità dell’iniziativa.
Il suo fulcro era ben espresso dal titolo scelto. Un vescovo, a cui spetta, per definizione, la cattedra, dava voce a insegnamenti che provengono dall’esterno e giungono fino all’interno. Per comprenderlo occorre aver a mente che l’impostazione degli incontri non si concentrava sul confronto tra persone dotate o sprovviste di fede. Questo aspetto non era escluso, ma non era il più significativo.
La qualifica di «non credente» è spesso riduttiva o addirittura impropria, dominata com’è da una pura negazione. Nella «cattedra» era invece propria; e lo era perché il senso più autentico della proposta stava nell’affermare che le ragioni più serie della non credenza venivano considerate una forma di interlocuzione, esterna e interna, indispensabile perché ci fosse una fede matura. Analogamente la testimonianza di un credente pensoso non era avvertita priva di significato da parte di chi, in virtù della sua riflessione e della sua coscienza, era indotto a negare l’esistenza di una realtà trascendente o, quanto meno, nutriva dubbi al suo riguardo.
Si comprende, allora, sia perché Martini parlasse del dialogo con il non credente che è in noi, sia perché dichiarasse che la vera distinzione non era quella che sussiste tra credenti e non credenti, ma quella che divide le persone pensanti dai non pensanti. Si potrebbe tentare una sintesi: le persone pensanti sono coloro che danno spazio dentro di sé alle ragioni dell’«altro»; lo fanno non per consegnarsi all’incertezza, ma per render più mature le proprie convinzioni. Ciò avviene solo nel caso in cui il confronto sia sincero e alieno tanto da interessi di parte quanto da convenienze reciproche; condizioni queste ultime ormai estremamente rare.
In luogo della «cattedra dei non credenti», la Chiesa universale ora lancia un’iniziativa chiamata «cortile dei gentili». Affidata al Pontificio Consiglio della Cultura (prefetto card. Ravasi), il «cortile» è stato preinaugurato un paio di settimane fa a Bologna; mentre l’avvio ufficiale avverrà a Parigi verso fine marzo.
La scelta dell’espressione è stata spiegata da Benedetto XVI nel suo discorso tenuto alla Curia romana a fine 2009. Si prendono le mosse dal fatto che, sentendo parlare di «nuova evangelizzazione», persone agnostiche o atee (le quali «devono stare a cuore a noi come credenti») forse si spaventano. Tuttavia in loro rimane presente la questione Dio. Come primo passo dell’evangelizzazione bisogna perciò tener desta la loro ricerca di Dio. A tal proposito, aggiunge Ratzinger, vengono in mente le parole di Gesù che, sulla scorta di Isaia, presentano il tempio di Gerusalemme come casa di preghiera per tutti i popoli (Mc 11,17; Is 56,7).
Gesù pensava «al cosiddetto cortile dei gentili, che sgomberò da affari esteriori perché ci fosse lo spazio per i gentili che lì volevano pregare l’unico Dio, anche se non potevano prender parte al mistero, al cui servizio era riservato l’interno del tempio». Si pensava cioè a persone che conoscono Dio solo da lontano: «che desiderano il Puro e il Grande anche se Dio rimane per loro il “Dio ignoto” (cfr. At 17,23)». «Io penso che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorte di “cortile dei gentili” dove gli uomini possano in una qualche maniera agganciarsi a Dio, senza conoscerlo e prima che abbiano trovato l’accesso al suo mistero, al cui servizio sta la vita interna della Chiesa. Al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi il dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che, tuttavia, non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno come Sconosciuto».
È noto che l’esegesi biblica non ha alcun peso nei documenti ufficiali della «Chiesa docente», perciò non val la pena di impegnarsi a mostrare quanto sia inesatta l’interpretazione del passo evangelico qui proposta. Il punto serio è altrove; esso sta nel fatto che, in questa immagine, la Chiesa prende il posto del tempio (e di Israele). La sua cura e generosità sono però tali da aprire una dependance in cui è concessa ospitalità ad alcuni incerti ricercatori di Dio. Nel suo interno, la Chiesa celebra il mistero e nessuna crepa solca il suo levigato seno. In questa prospettiva sarebbe un vero e proprio ossimoro parlare della parte non credente che è in noi e sarebbe addirittura inconcepibile che le ragioni serie del dubbio e della negazione siano meritevoli di ascolto al fine di liberare la propria fede da sovrastrutture improprie.
 In realtà, però, a dover essere purificato
non è solo il cortile, è anche e soprattutto l’interno del tempio.
In realtà, però, a dover essere purificato
non è solo il cortile, è anche e soprattutto l’interno del tempio.In definitiva, il «cortile» che si sta inaugurando presuppone un dialogo senza ascolto. A quanto si può immaginare (e l’impressione è confermata dalla prime avvisaglie), nessuno accederà a essa per mettersi in discussione; dichiaratamente non lo faranno mai i credenti (si può, dunque, già ipotizzare quale sarà la lista degli invitati). Se i fatti confuteranno queste previsioni, saremo ben lieti di ricrederci.
Del resto mettersi in discussione è difficile per tutti. Le drammatiche vicende libiche di queste ore dovrebbero indurre l’Italia a mobilitarsi (ma non ne vediamo tracce consistenti) e ad aprire un profondo ripensamento a proposito della sua storia (in Cirenaica Badoglio e Graziani non si comportarono meglio di quanto faccia Gheddafi nei suoi ultimi giorni di potere), del suo passato prossimo e dei suoi affari presenti. Sono considerazioni che non valgono per la Grecia, Cipro e Malta.
Questi ultimi giorni dimostrano, ancora una volta, che anche ottanta o settanta anni fa i governi e le società erano fatti di uomini esattamente come siamo noi che peraltro siamo, volenti o nolenti, molti più informati di allora. In Libia si compiono stragi e qui ci si preoccupa del prezzo del petrolio e della possibile invasione degli immigrati; mentre, quando si passa ad altro compartimento stagno, si riesce, per esempio, persino a scandalizzarci che alla fine degli anni trenta l’Inghilterra mandataria contingentasse l’immigrazione ebraica in Palestina.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- IL CORTILE DEI GENTILI --- Ravasi: «Per una ragione aperta al sacro» (di Armando Torno)25 marzo 2011, di Federico La Sala
PER UN NUOVO UMANESIMO E UN NUOVO CRISTIANESIMO. Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!!
AL DI LA’ DEL SACRO E DEL PROFANO, RIPENSARE INSIEME IL "CRISTO MORTO" (DI MANTEGNA) E "L’ORIGINE DEL MONDO" (DI COURBET) E ANDARE AL DI LA’ DELL’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE (DI EDIPO) VERSO L’ORDINE SIMBOLICO DI UOMINI E DONNE LIBERE E LIBERI - QUELLO DI MARIA E GIUSEPPE E GESU’:
- Mantegna, Cristo morto (Wikipedia)
 "L’origine du monde" (Wikipedia)
"L’origine du monde" (Wikipedia)
Ravasi: «Per una ragione aperta al sacro»di Armando Torno (Corriere della Sera, 25 marzo 2011)
Il Cortile dei Gentili è cominciato ieri alle 15 nella sala XI dell’Unesco, a Parigi. Dopo il primo incontro di Bologna, che sotto la torre Eiffel qualcuno ha graziosamente definito apéritif, il dialogo tra credenti e non credenti è stato avviato dai saluti delle autorità («la ragione non riesce a fondare la fraternità», ha detto Getachew Engida, direttore generale aggiunto) ma anche dalle parole del cardinale Gianfranco Ravasi. Utilizzando un felice tocco di retorica, il porporato ha scelto una parabola per l’esordio di questo progetto destinato a raggiungere ogni parte del mondo. Ravasi, inoltre, cita Goethe, ricorda le frasi dell’apostolo Paolo per descrivere Gesù nell’antico cortile, utilizza Wittgenstein per parlare dell’indagine e dei confini della nostra conoscenza.
Poi si succedono gli ambasciatori del Marocco, della Repubblica Ceca, del Congo, nonché Giuliano Amato, protagonista di un intervento che fa pensare. Evidenzia lo spostamento dei confini del bene e del male che è in atto, sottolinea che la democrazia non è il regno del relativismo ma è basata su valori assoluti, invita a un’alleanza tra credenti e non credenti per ridare senso ai fondamenti morali del vivere. Merita un plauso, tra gli altri, l’intervento di Fabrice Hadjadj, filosofo e scrittore, che rammenta il bisogno di ognuno di elevarsi al cielo; inoltre, con un affondo, paragona il mistero della Parola alla volontà di potenza, invitando a cercare l’uomo non nell’efficienza ma «nell’epifania del suo volto».
Oggi, invece, dopo le credenziali politiche e diplomatiche, il Cortile dei Gentili avrà una giornata parigina intensissima. Alle 9 si comincia alla Sorbona con personalità quali Jean-Luc Marion, Julia Kristeva e, tra gli altri, il genetista Axel Kahn; alle 15 si passa all’Institut de France, dove gli accademici di Francia (tra loro si chiamano «immortali» ) renderanno onore all’iniziativa: da Gabriel de Broglie a Jean Clair, da Claude Dagens a Jean-Claude Casanova.
Alle 19 si terrà al Collège des Bernardins una tavola rotonda, dove Patrick de Carolis animerà un confronto sul progetto globale del Cortile. Intanto, alle 19.30 comincerà davanti a Notre-Dame un’animazione musicale, che lascerà il posto a una proiezione e alle 21 all’intervento su grande schermo di papa Benedetto XVI. Quindici minuti sono previsti per le parole del pontefice. Poi canti gregoriani, video, una danza sul «Cantico dei Cantici» e altro ancora. Sino al silenzio della notte, accolto nella cattedrale dalle meditazioni dei Fratelli di Taizé.
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- IL CORTILE DEI GENTILI - IL MERCATO DELLA FEDE E DELLA RAGIONE..9 febbraio 2011, di Federico La Sala
MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! Ha dimenticato l’esortazione di Papa Wojtyla ("Se mi sbalio, mi coriggerete")?!:
 ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E TEOLOGICA: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS". ITALIA, NATALE 2010: AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010).
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E TEOLOGICA: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS". ITALIA, NATALE 2010: AL GOVERNO DELLA CHIESA UN PAPA CHE PREDICA CHE GESU’ E’ IL FIGLIO DEL DIO "MAMMONA" ("Deus caritas est") E AL GOVERNO DELL’ **ITALIA** UN PRESIDENTE DI UN PARTITO (che si camuffa da "Presidente della Repubblica"), che canta "Forza Italia" con il suo "Popolo della libertà" (1994-2010).
 ITALIA, NATALE 2010 d. C.: ARCHEOLOGIA EVANGELICA E COSTITUZIONALE. Il buon-messaggio di Giovanni e la preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli.
ITALIA, NATALE 2010 d. C.: ARCHEOLOGIA EVANGELICA E COSTITUZIONALE. Il buon-messaggio di Giovanni e la preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli.
Il «cortile» dove si incontrano fede e ragioneParte da Bologna il dialogo tra atei e credenti ispirato allo spazio per i «gentili» del Tempio di Gerusalemme
di Armando Torno (Corriere della Sera, 09.02.2011)
Nell’antico Tempio di Gerusalemme vi era uno spazio chiamato «Cortile dei Gentili» . Ad esso potevano accedere tutti, non soltanto gli israeliti. Non c’erano vincoli di cultura, lingua o religione. In tal modo, accanto al luogo nel quale Dio aveva fissato la sua presenza, si apriva un’area per i non ebrei, per gli «altri» , o meglio per i non credenti nel Dio unico di Abramo, Isacco e Giacobbe. Un atrio esterno, rappresentato appunto da questo cortile dei gojim, con porticato e colonne, sotto cui sostavano scribi e sacerdoti per dialogare con coloro che chiedevano di conoscere meglio la religione di Israele.
La sua esistenza è attestata a partire da Antioco III (223-187 a. C.) e ad esso si riferisce forse l’Apocalisse: «Ma l’atrio che è fuori del santuario, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balìa dei pagani» (11,2). Giuseppe Flavio nelle sue Antichità Giudaiche (XV, 417) parla dell’iscrizione che proibiva l’ingresso agli stranieri, sotto pena di morte, nella parte riservata al popolo ebraico. Qui si fermò anche Gesù.
Da questa consuetudine, dopo un invito di papa Benedetto XVI alla fine del 2009, è nata l’idea del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, di dare vita a uno spazio di incontro e confronto sulla fede chiamato, appunto, «Cortile dei Gentili» . Un dialogo che non si terrà in un luogo fisso come un tempo usava ma percorrerà le città del mondo, incontrando le diverse culture. Cercherà risposte alle domande della fede, alimenterà una reciproca conoscenza tra credenti e non credenti.
Ravasi invita ogni uomo e punta sul dialogo: affida ad esso le speranze, gli approfondimenti, nonché la creazione di nuovi contesti per meglio comprendere i problemi attuali. Del resto, Platone consegnò ai dialoghi il suo pensiero; ora si guarda con spirito aperto a questa forma di comunicazione per scoprire idee e opinioni condivise, allargare le comuni consapevolezze. Il cardinale nota: «In ogni incontro c’è già un valore».
Non è possibile scrivere in questo momento un programma definitivo del progetto riguardante il «Cortile dei Gentili» , perché le richieste stanno giungendo da ogni parte del mondo. Possiamo soltanto ricordare che codesta odissea di ragione e fede comincerà a Bologna il prossimo 12 febbraio; il 24 e 25 marzo sarà la volta di Parigi, ma già si parla di Tirana, Praga, Stoccolma, Ginevra, Mosca, Chicago, senza contare le richieste che stanno giungendo dall’Asia e dal Sud America.
Perché Bologna? Ravasi chiarisce: «Cominceremo il nostro viaggio nella più antica università d’Europa, con una grande tradizione laica. Sabato prossimo sarà la vera e propria "prolusione"di un itinerario di dialogo e di ricerca dalle tappe molteplici. L’idea nasce quasi in connessione, in concorrenza con l’evento di Parigi, in particolare con la manifestazione della Sorbona» .
Il rettore, Ivano Dionigi, precisa che «un’università pubblica e laica che ospita il confronto tra il credere e l’intelligere non abdica alla propria autonomia, ma assolve la funzione di istituzione vocata, per natura e storia, alla formazione e alla ricerca» . Il suo intervento e quello del cardinale apriranno, poco dopo le 10, i discorsi dei primi quattro «relatori» del «Cortile» : lo scienziato Vincenzo Balzani, il costituzionalista Augusto Barbera, i filosofi Massimo Cacciari e Sergio Givone. Saranno intervallati da letture dell’attrice Anna Bonaiuto (tra l’altro, ha lavorato con Pupi Avati, Liliana Cavani e Nanni Moretti), che farà rivivere brani di Agostino (Confessioni), Pascal (dei Pensieri la parte sulla «Scommessa» ) e Nietzsche (Così parlò Zarathustra).
Sottolinea Ravasi: «L’iniziativa sarà aperta a tutti: studenti, docenti e anche a coloro che desiderano percorrere i sentieri di altura della ricerca sia filosofica sia teologica, sia razionale sia di fede. L’universitas torna a raccogliere ogni disciplina, compresa la teologia, e si rivolge all’agorà, alla comunità, a chi cerca e si interroga» . - per l’eminente uomo di Chiesa questo è il primo di due passi da intraprendere: «Mi sono ora rivolto all’orizzonte alto della cultura ed è auspicabile che sia l’inizio di un percorso di confronto nell’ambito accademico o, se si vuole, in quello del sapere più qualificato e specialistico; il secondo, invece, è delicato, decisamente arduo: sarà un confronto serrato, anche aspro, con la tipologia dominante della non credenza attuale che è quella nazional popolare dell’indifferenza, dell’amoralità, dello sberleffo ateistico» .
Inoltre Ravasi chiarisce i termini del primo incontro: «Il rettore e io non faremo, ovvero non daremo il là; vorrei ribadire che la tonalità del dibattito è lasciata completamente libera. Noi presenteremo soltanto la ragione di indole culturale che esige un simile confronto, perciò non sarà mai la finalità dell’incontro strettamente apologetica o volutamente laica, ma quello che si intende avviare è un dibattito aperto, un dialogo sulle letture differenti delle questioni umane fondamentali» .
Chiediamo degli esempi. In tal caso il cardinale mette in campo parole pesanti, che stanno al centro dell’attenzione di scienza e teologia, oltre che in secolari controversie filosofiche: «Vita, morte, oltrevita, bene e male, amore e dolore, verità e relativismo, trascendenza e immanenza» . Aggiunge: «Ovviamente ci sarà un’attenzione per le questioni bioetiche, in modo da essere sempre attenti ai progressi delle scienze ma al tempo stesso anche alla complessità del valore della vita e della persona, che restano il punto di riferimento sia per la teologia che per la filosofia» .
Il «Cortile dei Gentili» combatte la sonnolenza dello spirito, quel genere di torpore - per fare un esempio- alimentato da quell’editoria che fa notizia ma è inutile alla cultura, cara a coloro che confondono il messaggio con il massaggio. È iniziativa che ribadisce il valore della fede e ricorda con Dostoevskij l’impossibilità di vivere pienamente senza riflettere su Dio.
Ci accomiatiamo da Ravasi chiedendogli cosa si aspetta, come teologo, da questa iniziativa. «Con essa - risponde - attendo, oltre quel dialogo ricordato, un aiuto per coloro che desiderano uscire da una concezione povera del credere. Vorrei invitare il laico a non considerare la teologia un reperto archeologico o mitologico, perché ha una sua dignità "scientifica"; mentre il credente comprenda le ragioni profonde della teologia e non la veda come ostacolo: la intenda come un sussidio, una componente fondamentale per percorrere le strade della fede» .
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- NEMEMNO DA CARDINALE?! --- DIMENTICATI I "DUE SOLI" E LA COSTITUZIONE ITALIANA, IL CARDINALE A SOSTEGNO DEL "COTILE DEI GENTILI" PREDICA DAL PULPITO DEL "SOLE 24 ORE (di Gianfranco Ravasi - Laicità)7 febbraio 2011, di Federico La Sala
 Moneta del potere, genealogia della libertà
Moneta del potere, genealogia della libertà
 LAICITA’
LAICITA’di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2011)
II termine "laico", nonostante l’attuale accezione dominante, ha sostanzialmente una genesi "religiosa" (designava, infatti, il semplice fedele "popolare" - da laós, in greco "popolo" - rispetto alla gerarchia ecclesiastica). Per impostare il discorso sulla laicità è legittimo risalire a una scena evangelica, così nota da diventare proverbiale. È l’unico pronunciamento direttamente politico di Gesù. Egli viene provocato dai suoi avversari a intervenire sulla questione fiscale, ossia sul tributo imperiale da versare da parte dei cittadini dei territori occupati da Roma. La replica di Cristo è lapidaria: «Ta Kaisaros apodote Kaisari kai ta Theou Theo», «rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» (si può leggere l’episodio sia nel Vangelo di Matteo, sia in quello di Marco o di Luca).
Risposta tagliente e a prima vista netta nel tracciare una linea di demarcazione che dovrebbe esorcizzare ogni teocrazia (la shari’a musulmana, per la quale il codice di diritto canonico diventa il codice civile, non è evangelica) e ogni cesaropapismo. Tuttavia, il discorso è più sofisticato e complesso se si tiene conto della parabola in azione che si consuma attorno a quella frase. Cristo, infatti, argomenta tenendo tra le mani simbolicamente una moneta con l’"immagine", l’icona (eikon in greco) dell’imperatore, simbolo evidente della politica e dell’economia, alla quale viene riconosciuta una sua autonomia, un campo di esercizio proprio, una sua capacità e indipendenza normativa.
Ma ai lettori di oggi sfugge l’ammiccamento testuale ulteriore che Gesù introduce per il suo uditorio ebraico: nel libro della Genesi (1, 27) si ha una celebre e suggestiva definizione dell’essere umano come «immagine» (nella versione greca eikon, icona) di Dio. Si delinea, in tal modo, un profilo specifico dell’area «di Dio» distinta da quella «di Cesare». Si tratta della tutela della dignità superiore e inalienabile della persona e della sua natura intrinseca: la libertà, le relazioni, l’amore (nel passo della Genesi si rimanda esplicitamente al «maschio» e alla «femmina» e non al solo maschio come «immagine» divina), i grandi valori etici assoluti della solidarietà, della giustizia, della vita non possono essere meramente funzionalizzati all’interesse politico-finanziario e piegati esclusivamente alle esigenze delle strategie del sistema o del mercato. La missione dei profeti biblici e dello stesso Cristo è stata appunto quella di essere una sentinella sulla frontiera tra Cesare e Dio, proprio nella difesa di questi valori. Memorabile è il «Non ti è lecito!» che Giovanni Battista grida all’arroganza del potere del re Erode Antipa.
È, però, indiscutibile che la questione si aggrovigli quando si procede nella declinazione storica di questa visione di principio, proprio perché entrambi gli attori, Cesare e Dio, ossia lo Stato e la Chiesa o il laico e il credente, si interessano di un soggetto comune, la società fatta di uomini e donne, e quindi i contrappunti e i conflitti di giudizio sono sempre in agguato. Ci si è, così, lasciati spesso tentare dalle scorciatoie. Da un lato, si è configurato il progetto teocratico, talora esplicito oppure solo sognato: «Questo tempio è il mio paese, non ne riconosco altri», proclamava il sommo sacerdote ebreo nella Atalia di Racine. E proprio perché a gestire questo disegno era il clero, prevalente rispetto ai laici, cioè i semplici fedeli, il termine "clericale" ha acquisito una connotazione sospetta o essenzialmente negativa.
D’altro lato, però, prendeva contemporaneamente corpo la spinta opposta, caratterizzata da un atteggiamento di protesta contro il distendersi del manto sacrale, ma anche dallo stizzito desiderio di ridurre alle corde la casta religiosa, espellendola radicalmente dalla polis per relegarla nel ristretto spazio templare, tra le volute degli incensi e i melismi dei canti liturgici. È in questa linea che il termine "laico" acquistava l’accezione ora dominante, spoglia di qualsiasi radice religiosa originaria, e si trasformava nell’orgogliosa affermazione dell’assoluta indipendenza e del primato della politica sulla religione. Lo stesso motto - spesso celebrato come applicazione del citato detto evangelico - della «libera Chiesa in libero Stato» in verità ha sotteso non un concetto di parità ma disubordinazione: è lo Stato che assegna alla Chiesa il diritto di sussistenza, confinandola però nella coscienza dell’individuo o nel perimetro sacrale del culto.
A questo punto, a essere più rigorosi, dobbiamo distinguere tra "laicità" («rendete a Cesare ciò che è di Cesare») e "laicismo" (che elide o reprime il «rendete a Dio ciò che è di Dio»), vocaboli che non sono sinonimi, così come non si devono identificare "secolarità" e "secolarismo" (o "secolarizzazione"), fermo restando che la stessa distinzione vale tra "religiosità" e "teocrazia". La laicità è strutturalmente necessaria anche per una corretta dottrina teologica; il suo mancato rispetto attraverso intromissioni "clericali" esplicite o surrettizie genera disordine e crea tensioni che si riverberano in altri campi paralleli, come sono quelli della scienza e della fede o della ragione e della natura e così via. Il monito di Schelling, rivolto allo storico e al teologo, a «custodire castamente la propria frontiera» è del tutto pertinente, anche se facilmente declassato sotto l’impulso delle questioni aperte che spesso si insediano appunto sulla frontiera di entrambi i campi.
Detto questo e proprio sulla base dell’impostazione ora descritta, è necessario riconoscere in modo parallelo la libertà di parola e di azione all’area di Dio (per usare la distinzione di Cristo, cioè della religione). Questo implica non solo l’esercizio del culto e l’elaborazione del pensiero teologico in senso stretto, bensì anche la funzione di essere coscienza critica nei confronti dei valori personali e sociali della giustizia, del bene comune, della vita, della verità, nella consapevolezza che l’uomo e la donna trascendono il pur legittimo ordinamento economico-politico, dotato di sue norme proprie. Il nodo delicato è precisamente in questa interazione indispensabile, capace di impedire che lo Stato diventi un Moloch e l’economia un Leviatan dominatore e che la Chiesa debordi dal suo orizzonte assumendo forme di integralismo.
Ai nostri giorni la "laicità", però, si sta accendendo sempre più di un costante sdegno, indispettito e insofferente nei confronti di ogni dichiarazione religiosa di indole civile o sociale, senza cercare prima di vagliarne il merito, se etico oppure fondamentalistico. In causa è chiamato soprattutto il cristianesimo che è di sua natura "incarnazione", e quindi non si isola nei cieli mitici e mistici, ma proclama la dignità della "carne", cioè dei grandi valori umani e la lettura del Vangelo ne è un’immediata conferma. La religione cristiana autentica e completa ha nel suo stesso Dna una vocazione "sociale". Chesterton osservava che «tutta l’iconografia cristiana rappresenta i santi con gli occhi aperti sul mondo, mentre l’iconografia buddhista rappresenta ogni essere con gli occhi chiusi nella contemplazione interiore».
Tuttavia, nelle pagine neotestamentarie, giustamente non si ha mai un progetto politico alternativo in senso stretto; san Paolo si colloca all’interno del sistema imperiale romano, come è indicato nel famoso paragrafo della Lettera ai Romani (13, 1-7) dedicato all’etica fiscale da rispettare, così come san Luca negli Atti degli Apostoli riconosce la sostanziale bontà del diritto romano nei confronti dei suoi cittadini (tra i quali è annoverato appunto anche Paolo). Questo, però, non esclude che l’autore dell’Apocalisse promuova una serrata critica nei confronti delle prevaricazioni del potere imperiale, colpendo in questo modo la politica repressiva di Domiziano, né si può ignorare che il cristianesimo abbia esercitato una funzione dirompente all’interno del modello sociale dei primi secoli per accelerare il trapasso a una società segnata dall’uguaglianza e dalla coesione fraterna, demolendo l’impianto tradizionale fondato sulla distinzione castale tra liberi e schiavi, indigeni e stranieri, maschi e femmine («Non c’è più né giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più né uomo né donna, perché voi siete tutti uno in Cristo Gesù», scrive l’Apostolo Paolo ai Galati). Senza, perciò, nasconderci le difficoltà pratiche delle collisioni nell’interazione tra i due ambiti, senza voler essere a tutti i costi concordistici e irenici nell’esorcizzare ogni tentazione integristica, sia essa secolaristica o sacrale, riteniamo che sia sempre importante ribadire i principi che reggono gli statuti propri delle diverse sfere di pensiero e di azione.
"Sacro" e "laico" non sono antitetici, pur essendo in radice differenti. Sbaglia il "sacralismo" clericale quando sogna di "consacrare" il profano ritenendolo in sé negativo, cancellandone l’identità, così come è in errore il "laicismo" secolaristico quando programma l’eliminazione di ogni segno religioso nell’areopago della società come presenza illegittima e indegna e disdegna ogni monito spirituale e morale, considerandolo come un’interferenza inaccettabile.
Il sacro autentico non si oppone né vuole elidere il profano, ma lo chiama a dialogo, lo interpella e ne è interpellato, lo feconda rispettandone le competenze, lo provoca sui valori fondanti e permanenti dell’etica. Interrogarsi reciprocamente scoprendo il terreno di condivisione è il dialogo necessario che allontana il rigetto o la "con-fusione".
L’esito finale positivo potrebbe essere quello che Gandhi delineava in questo suo settenario ideale: «L’uomo si distrugge con la politica senza principi etici, con la ricchezza senza lavoro, con l’intelligenza senza il carattere, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità, con la religione senza la fede, con la solidarietà senza il sacrificio di sé».
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- DAL DUELLO AL DUETTO!?? Credenti e atei, un dialogo per ritrovarsi (da cardinale Gianfranco Ravasi).4 febbraio 2011, di Federico La Sala
Credenti e atei, un dialogo per ritrovarsi
 Anticipiamo un brano dell’intervento su "Jesus" del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del
Anticipiamo un brano dell’intervento su "Jesus" del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del
 Pontificio consiglio della cultura che promuove il "Cortile dei Gentili", dialogo tra credenti e atei.
Pontificio consiglio della cultura che promuove il "Cortile dei Gentili", dialogo tra credenti e atei.
 Il primo incontro sarà a Bologna, organizzato dall’Università, il 12 febbraio
Il primo incontro sarà a Bologna, organizzato dall’Università, il 12 febbraiodi Gianfranco Ravasi (la Repubblica, 4 febbraio 2011)
Credenti e non credenti stanno su territori differenti, ma non si devono rinserrare in un isolazionismo sacrale o laico, ignorandosi o peggio scagliandosi sberleffi o accuse, come vorrebbero i fondamentalisti di entrambi gli schieramenti. Certo, non si devono appiattire le differenze. Ognuno ha i piedi piantati in un "cortile" separato, ma i pensieri e le parole, le opere e le scelte possono confrontarsi e persino incontrarsi.
Ricorrendo a un gioco di parole assonanti (ma non di etimologie), tra Cristiani e Gentili si potrebbe adottare la tecnica del duello (dal latino bellum), in uno scontro all’arma bianca, alla maniera del giansenista e del gesuita del film La Via Lattea di Buñuel. Quello che il progetto denominato "Cortile dei Gentili" vuole proporre è, invece, un duetto (dal latino duo) ove le voci possono appartenere anche agli antipodi sonori eppure riescono a creare armonia, senza per questo rinunciare alla propria identità, cioè, fuor di metafora, senza scolorirsi in un vago sincretismo ideologico.
Da un lato, i "Gentili" devono ritrovare quella nobiltà ideale così com’era espressa dai grandi sistemi "ateistici" (pensiamo a Marx o alla celebre parabola sul Dio morto della Gaia scienza di Nietzsche o ai versi di Heine: «Non sentite la campanella? In ginocchio! Si portano i sacramenti a un Dio che muore»), prima che venissero incapsulati in sistemi politico-ideologici o piombassero nello scetticismo e nell’idolatria delle cose o degenerassero nell’ateismo sprezzante, sarcastico e infantilmente dissacratorio.
D’altro lato, la fede deve ritrovare la sua grandezza, manifestata in secoli di pensiero alto e in una visione compiuta dell’essere e dell’esistere, evitando le scorciatoie del devozionalismo o del fondamentalismo e rivelando che la teologia ha un suo rigoroso statuto metodologico parallelo e specifico rispetto a quello della scienza.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- "IL NOME DELLE COSE": DALLA REGIONE CALABRIA - E DALL’ "AVVENIRE" - UN’INDICAZIONE DECISIVA PER LA CHIESA E PER L’ITALIA!28 gennaio 2011, di Federico La Sala
UNO SPIRITO NUOVO, A PARTIRE DALLA PAROLA:
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- ALEX LANGER, MEMORIA EVANGELICA, E CARITA’ NEL PRECISO SENSO EVANGELICO (di Goffrdedo Fofi).28 gennaio 2011, di Federico La Sala
Langer: fare ponti e «viaggiare leggeri»
di Goffredo Fofi (Avvenire, 28 gennaio 2011)
Se si dovesse chiudere in una formula ciò che Alex Langer ci ha insegnato, essa non potrebbe che essere: piantare la carità nella politica. Proprio piantare, non inserire, trasferire, insediare. E cioè farle metter radici, farla crescere, difenderne la forza, la possibilità di ridare alla politica il valore della responsabilità di uno e di tutti verso «la cosa pubblica», il «bene comune», verso una solidarietà tra gli umani e tra loro e le altre creature secondo il progetto o sogno di chi «tutti in sé confederati estima/ gli uomini, e tutti abbraccia/ con vero amor, porgendo/ valida e pronta ed aspettando aita/ negli ultimi perigli e nelle angosce/ della guerra comun».
Dico carità nel preciso senso evangelico, poiché Alex era un cristiano, dei non molti che cercavano di attenersi agli insegnamenti evangelici che era possibile conoscere in quegli anni nel «movimento» (e oggi sono ancora di meno) e non, come tanti di noi che gli fummo contemporanei e amici, di fragilissime convinzioni «marxiste» oppure, al meglio, mossi confusamente da una visione solo etica del cristianesimo.
La «diversità» di Alex, la sua superiorità sui suoi amici e compagni, gli veniva anche da una storia famigliare più ricca, a cavallo tra lingue e culture, tra Germania e Italia e tra ebraismo e cattolicesimo, ma nessuno vide mai in questo il marchio del privilegio, poiché essa era caratterizzata in lui da una convinzione di umiltà reale e non esibita, non appariscente, dalla propensione all’ascolto degli altri, di tutti, dalla libertà dei collegamenti e dalla scelta di «far da ponte».
Quante volte Alex Langer non ha teorizzato nei suoi testi la funzione e l’imprescindibile necessità dei «ponti»? Ricordava tanti anni fa Piero Calamandrei fondando, a guerra appena conclusa, una rivista che si chiamava Il ponte, il significato metaforico ma anche concreto dei ponti, da riedificare dopo le distruzioni della guerra che si era accanita a distruggerli. Ponti veri, che gli uni o gli altri avevano fatto saltare, e che dovevano mettere di nuovo in comunicazione e in «commercio» persone e città, culture e territori.
Ponti ideali, che potessero permettere ai vinti e ai vincitori, tutti infine perdenti, sopravvissuti ai conflitti e alle stragi e cioè al dominio della morte, di ritrovare nell’incontro e nel dialogo la possibilità di un futuro migliore. (L’attaccamento di Alex alle sue radici regionali e la sua ambizione cosmopolita gli hanno permesso una concretezza precisa, mai parolaia, e una visione ampia, internazionale, nel filone di quell’utopia che era stata per un tempo di una parte del movement americano, quella che diceva di doversi preoccupare ostinatamente di due ambiti da tenere strettamente collegati tra loro: «Il mio villaggio e il mondo».)
Il progetto semplicissimo e immenso di far da ponte tra le parti in lotta, che ad Alex costò infine la vita, è fallito e continua a fallire in un mondo dove le incomprensioni permangono e prosperano gli odi, sollecitati dai diversi poteri e dal peso dei torti ricevuti e fatti, di una memoria di gruppo che, invece di rendere aperti, rende più chiusi alle ragioni degli altri. Poiché troppa memoria può uccidere alla pari della (nostra, italiana) assenza di memoria.
E tuttavia il messaggio di Langer è stato fino all’ultimo chiaro: se anche c’è chi cade, chi non regge più il peso della storia e della solitudine (forse ci si uccide perché ci si sente o si è rimasti soli - ma alcuni, come i vecchi e i malati, perché si è tagliati via dalla vita - più che per l’oggettiva debolezza e insicurezza del genere umano e per la fatica di dover continuamente ricominciare), bisogna imparare dall’esperienza quel che se ne può ricavare, e andare avanti. Non perché «si spera», ma perché «si ama»: e la «carità» è allora il centro di tutto, come voleva san Paolo - più della speranza e più della fede. Alex Langer ha svolto una funzione di ponte in due direzioni prioritarie: quella di accostare popoli e fazioni, di attutirne lo scontro e di promuoverne l’incontro, e quella dell’apertura a un rapporto nuovo tra l’uomo e il suo ambiente naturale.
E se nel primo caso, quello più determinato dalle pesanti contingenze della storia (per Alex, la guerra interna alla ex Jugoslavia), si trattava di far da ponte ma anche da intercapedine, da camera d’aria dove potesse esprimersi un dialogo assai difficile, nel secondo si trattava piuttosto di additare nuovi territori all’azione politica responsabile, allargandone il significato da città a contesto, da polis a natura. Se sul fronte della pace e della convivenza tra umani di diversa etnia o religione o parte politica Alex è stato un continuatore, egli è stato su quel secondo fronte un precursore, uno dei più persuasi pionieri dell’indispensabilità di una visione ecologica dell’agire politico.
Ha visto tra i primi l’arrivo della novità, come lo Zaccheo del Vangelo che si portò nel luogo più avanzato del suo villaggio e nel suo punto più alto per poter vedere per primo l’arrivo del Messia, e cioè della Novità, ed è stato confortato in questo dalla sua conoscenza e vicinanza a uno dei pochi veri profeti dello scorso secolo, il prete e filosofo che si faceva chiamare Ivan Illich. Tra l’antico e l’eterno del messaggio cristiano e la verde novità dell’ecologia, tra le esigenze della pace (gli uomini) e quelle dell’armonia (degli uomini con la natura) tra loro fittamente intrecciate, sempre più interdipendenti, Langer si è mosso quotidianamente, attento al presente ma cosciente del passato e straordinariamente aperto al futuro, al possibile e al doveroso dei compiti della politica (della militanza, della persuasione).
Contro il gioco chiuso del potere. E contro i ricatti paralleli di un’impazienza non meditata e di una lentezza non ipocrita: nell’avvicendarsi che appartiene alla storia delle fasi di stasi e di quelle di febbre, occorre prepararsi nella stasi per saper meglio muoversi nella furia che, prima o poi, si scatenerà.
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ----CHIESA E ARCHITETTURA. Il cardinale Gianfranco Ravasi lancia l’allarme sull’imminente cedimento strutturale19 gennaio 2011, di Federico La Sala
 PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
Questa chiesa val bene una messa?di Giacomo Galeazzi (La Stampa, 19 gennaio 2011)
«Quanto sono inospitali molte chiese moderne!». In una lectio magistralis alla facoltà di Architettura di Roma, il cardinale Gianfranco Ravasi lancia l’allarme: «Un’architettura sacra che non sappia parlare correttamente il linguaggio della luce e non sia portatrice di bellezza e di armonia decade automaticamente dalla sua funzione».
Il ministro vaticano della Cultura stigmatizza «l’inospitalità, la dispersione, l’opacità di tante chiese tirate su senza badare alla voce e al silenzio, alla liturgia e all’assemblea, alla visione e all’ascolto, all’ineffabilità e alla comunione». Chiese nelle quali «ci si trova sperduti come in una sala per congressi, distratti come in un palazzetto dello sport, schiacciati come in uno sferisterio, abbrutiti come in una casa pretenziosa e volgare».
Un degrado inaccettabile e tanto più grave alla luce del «grande contributo offerto in 20 secoli» dalla cultura cristiana all’architettura. «Senza la spiritualità e la liturgia cristiana, la storia dell’architettura sarebbe stata ben più misera - afferma Ravasi -. Pensiamo solo al nitore delle basiliche paleocristiane, alla raffinatezza di quelle bizantine, alla monumentalità del romanico, alla mistica del gotico, alla solarità delle chiese rinascimentali, alla sontuosità di quelle barocche, all’armonia degli edifici sacri settecenteschi, alla neoclassicità dell’Ottocento, per giungere alla sobria purezza di alcune realizzazioni contemporanee».
Nel cristianesimo c’è «una celebrazione costante dello spazio come sede aperta al divino», con il «baricentro teologico» che si sposta dallo spazio al tempo, perché «tra Dio e uomo non è più necessaria nessuna mediazione spaziale: l’incontro è ormai tra persone, si incrocia la vita divina con quella umana in modo diretto».
Per il cristiano, sottolinea Ravasi, la chiesa è «un santuario non estrinseco, materiale e spaziale, bensì esistenziale, un tempio nel tempo». Il tempio architettonico sarà «sempre necessario», ma solo come «segno necessario di una presenza divina nella storia e nella vita dell’umanità». Quindi «non esclude o esorcizza la piazza della vita civile ma ne feconda, trasfigura, purifica l’esistenza, attribuendole un senso ulteriore e trascendente».
Ma nell’episcopato c’è chi di chiese ne ha create una decina. È il vescovo di Livorno, Simone Giusti, breviario e tecnigrafo, allievo di Michelucci, Santi e Savioli, laurea in architettura all’università di Firenze, con disegni sulla scrivania, proiezione computerizzata e rendering digitale. «Entrare in una Chiesa è penetrare in un luogo che i m m e d i a t a m en t e parla alla persona e al suo cuore attraverso un linguaggio simbolico-affettivo», racconta. Un linguaggio (come nella parrocchia di Cecina dedicata alla Sacra Famiglia) che si rivolge all’uomo e alla cultura contemporanea senza però rinnegare la tradizione dell’architettura passata, con evidenti richiami a quella romanica.
Una creatività che necessariamente rifugge ogni banalità. Per il fedele e il semplice visitatore. «L’architettura che vado ricercando è l’architettura della diversità - spiega Giusti, palmare e bluetooth a portata di mano -. Nulla che sia simmetrico: proprio come in natura, dove niente è banale e tutto è diverso ed è da ciò che nasce la voglia di scoprire e di interpretare. Le vetrate non sono un optional o un mero abbellimento. I giochi di luce soffusa e colorata che si susseguono dall’alba al tramonto sono di aiuto ai fedeli che si raccolgono in preghiera». E anche i disegni astratti delle vetrate hanno un loro senso perché «solo ciò che non è pienamente definito può esprimere l’inesprimibile mistero di Dio». Insomma niente va lasciato al caso perché «progettare una chiesa può significare anche edificare le anime».
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- VATICANO E DIRITTI D’AUTORE: CHE SUCCESSO, QUANTI SOLDI CON I DIRITTI DI AUTORE!!!22 dicembre 2010
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- L’ECCLESIOLOGIA: LA CHIESA IN CAMMINO SULLA STRADA DI RATZINGER.10 gennaio 2011, di Federico La Sala
L’ECCLESIOLOGIA, L’ECUMENISMO, E L’ASTUZIA DELLA RAGIONE ’CATTOLICA’: LA CHIESA IN CAMMINO SULLA STRADA DI RATZINGER.
Studia la chiesa, scoprirai umanità
Un dizionario offre la possibilità di capire la ricchezza comunitaria dell’evento religioso e di scoprire le dinamiche comuni alle fedi
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 09.01.2011)
Se siete "laici", non accantonate subito come non a voi pertinente questa segnalazione, convinti al massimo che il termine "Chiesa" valga solo per stare in guardia contro ogni tentazione teocratica, rimodulando e ribadendo la formula di Cavour della «Libera Chiesa in libero Stato» o, più aspramente temendo col Pasolini della Religione del mio tempo che «la Chiesa sia lo spietato cuore dello Stato». No, la categoria sottesa a questo vocabolo di matrice greca, ekklesía, è quella della "convocazione", certo di taglio sacrale e trascendente, ma che rimanda anche a un incontro sociale. Risaliamo, così, alle radici stesse dell’antropologia che non si accontenta di aggregazioni genetiche (famiglia, clan), ma segnala l’anelito a congregazioni di altra impronta, più civile e culturale (popolo, nazione), o corporativa (associazioni, ordini) o infine spirituale e simbolica. Ecco, allora, entrare in scena la Chiesa con le sue sotto-categorie (pensiamo alle comunità monastiche).
Ma non si creda che l’idea sia appannaggio del cristianesimo e in particolare del cattolicesimo. L’umma musulmana è la comunità "materna" (tale è l’etimologia della parola) che raccoglie in unità i fedeli di quella religione e che tende spesso a sovrapporsi alla stessa comunità civile in una sovrimpressione identitaria giuridico-politica.
Persino il buddhismo, a prima vista restio ad accogliere criteri di mutua appartenenza (al massimo c’è la sangha monastica rigidamente istituzionalizzata), ha prodotto forme di comunità nazionale religiosa: come non pensare al Tibet che ha - a partire dal Seicento - nel Dalai Lama l’unificazione dell’identità sacra, civica ed etnica? Il discorso è ancor più evidente per l’ebraismo che ha già nelle Scritture Sacre l’emergere della qahal, l’ekklesía appunto, una "convocazione" divina dai forti connotati istituzionali civili.
È, però, indubbio che la categoria "ecclesiale" sia capitale nel cristianesimo e sia uno dei nodi più intricati dell’odierno dialogo ecumenico, come lo fu in passato nello scontro, non di rado armato, tra le varie Chiese col relativo corteo di scismi, di scomuniche e persino di guerre di religione. Tempo fa, proprio su queste pagine, abbiamo spiegato - sulla scorta di un saggio di Giacomo Canobbio (Nessuna salvezza fuori della Chiesa?, Queriniana) - il senso autentico del celebre motto "inventato" da Origene e Cipriano, Extra Ecclesiam nulla salus, spesso ancor oggi imbracciato come un kalashnikov anti-ecumenico e integralistico.
Si capisce, allora, perché l’apparire di un dizionario di ecclesiologia debba essere segnalato anche ai lettori più diversi e non ai destinatari a prima vista specifici come gli "ecclesiastici" o le comunità "ecdesiali". Certo, quello che ora presentiamo è un manuale che lascia in sordina la prospettiva antropologica (ad esempio, la voce "Appartenenza" è esclusivamente teologica, così come le "società" qui evocate sono soltanto le "Società di vita apostolica").
Tuttavia, nelle 160 voci che compongono questo vasto arazzo tematico ci si imbatte nella trattazione della "Democrazia", della "Promozione umana", dei "Rapporti Chiesa-Stato", di "Arte e Chiesa", ma si lascia pure vasto campo alle mille iridescenze che la categoria "Chiesa" ha assunto nella storia al punto tale da essere applicata a soggetti disparati con reciproco dispiacere degli uni e degli altri. Significativo al riguardo sarebbe rincorrere la sequenza rubricata sotto "Ecclesiologia": ci sono gli anglicani, i congregazionalisti, i luterani, i bizantini medievali, l’occidente medievale, gli ortodossi, i cattolici conciliari e post-conciliari, i riformati, tanto per seguire l’ordine alfabetico.
Ma all’interno s’incunea l’ecclesiologia degli Atti degli apostoli, quella giovannea, delle Lettere pastorali neotestamentarie, la paolina, quella della patristica occidentale e orientale, della comunità cristiana primitiva, l’ecclesiologia sinottica e veterotestamentaria, anche qui per stare alla sequenza alfabetica, fermo restando poi che una decina di voci sono riservate alle specifiche Chiese in cui si è frammentata la cristianità.
L’oscillazione ondeggia, quindi, tra voci che isolano e approfondiscono i fondamenti teologici, come «Concilio, Corpo di Cristo, Dodici, Episcopato, Eucaristia, Evangelizzazione, Infallibilità, Liturgia, Magistero, Ministeri, Missione, Papato, Parola, Popolo di Dio, Presbiterato, Sacramentalità, Scisma, Spirito Santo, Tradizione» e così via, e voci che toccano questioni storiche o pastorali come l’architettura ecclesiale, il Gallicanesimo, le sette e i nuovi movimenti religiosi, la teologia della liberazione, la Scuola di Tubinga e di Roma o lemmi enigmatici ai profani come Subsistit in, sempre per fare qualche esempio. L’oscillazione si ripete - come è ovvio in simili prodotti affidati a una legione di collaboratori - tra impostazioni più sincroniche eapprocci diacronici, tra prospettiva tematica ed evoluzione storico-tematica.
Il Concilio Vaticano II, con la sua costituzione Lumen gentium, ha fatto sì che l’ecclesiologia tornasse al centro dell’interrogazione teologica, ma anche dell’impegno pastorale nel confronto col mondo. Lo ha fatto ribadendo che i suoi confini sono meno "ecclesiastici" di quanto si è soliti ipotizzare anche da parte dei non credenti. Ha riproposto con forza la necessità dell’incontro ecumenico per impedire integralismi e autoreferenzialità. Ha rettificato gli incroci con la società e la politica (Martin Luther King in quegli stessi anni nella sua Forza d’amare affermava che «la Chiesa non è la padrona o la serva dello Stato, è la coscienza dello Stato»). Mi sembra, comunque, significativo concludere con un passo dell’allora cardinale Ratzinger nel suo saggio sulla Chiesa, una comunità sempre in cammino (San Paolo 1991) passo che è posto in apertura a questo dizionario e che noi riproponiamo ai lettori credenti e "laici".
«La Chiesa non è soltanto il piccolo gruppo degli attivisti che si trovano insieme in un certo luogo per dare avvio a una vita comunitaria. La Chiesa non è nemmeno la grande schiera di coloro che alla domenica si radunano insieme per celebrare l’eucaristia. La Chiesa è anche di più che papa, vescovi e preti, di coloro che sono investiti del ministero sacramentale. Di essa fanno parte tutti i santi, a partire da Abele, da Abramo e da tutti i testimoni della speranza... Di essa fanno parte tutti gli sconosciuti e i non nominati, la cui fede nessuno conobbe tranne Dio; di essa fanno parte gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi, il cui cuore si protende, sperando e amando, verso Cristo».
 DIZIONARIO DI ECCLESIOLOGIA
DIZIONARIO DI ECCLESIOLOGIA
 Gianfranco Calabrese, Philip Goyret, Orazio Francesco Piazza edd.
Gianfranco Calabrese, Philip Goyret, Orazio Francesco Piazza edd.
 Città Nuova, Roma
Città Nuova, Roma
 pagg. 1.568 € 140,00.
pagg. 1.568 € 140,00.
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- PER BADARE AGLI AFFARI E TENERE SOTTO CONTROLLO LE PECORE, PERSA LA GIOIA DI DIO E LA CAPACITA’ DI RIDERE!!!26 novembre 2010, di Federico La Sala
Gesù non rideva? Eppure tutto il Vangelo è un inno alla gioia
Gesù ha mai riso? Cristo piange davanti alla tomba dell’amico Lazzaro, di fronte alla città santa, freme e soffre quando s’avvicina la sua ora finale. Conosciamo i suoi sentimenti. I Vangeli ci informano sul suo sdegno, che s’accende fino al punto di fargli impugnare una frusta. In sintesi, Gesù partecipa della natura umana amando, mangiando, provando tristezza e dolore. Ma si può dire che condivida con noi il riso e l’ironia? C’è qualche passo dei Vangeli in cui lo si oda ridere? Certo, partecipava volentieri ai banchetti, ma esiste una menzione del suo sorridere? Oppure il suo era sempre un volto severo come quello che ha rappresentato Pasolini nel suo Vangelo secondo Matteo?
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, 3 ottobre 2010)
«Flevisse lego, risisse numquam» ("Leggo che egli ha pianto, mai che abbia riso"). Così scriveva in modo lapidario un autore medievale, che si celava sotto il nome di Ambrogio, il celebre Padre della Chiesa (lo Pseudo-Ambrogio), negando che le labbra di Cristo siano state sfiorate dal sorriso. Certo, se ci attestiamo sul verbo rigoroso del ridere - in greco gheláo - dobbiamo riconoscere che esso non ha mai come soggetto Gesù.
Ridono, anzi, «deridono» (katagheláo) Gesù solo i lamentatori e le prefiche di professione nella casa di Giairo (Mt 9,24), ironizzando sulla sua dichiarazione nei confronti della figlia del capo-sinagoga («Non è morta, ma dorme»). Ridono anche quelli che ora godono nei piaceri, in attesa che avvenga però il grande ribaltamento dei destini: «Beati voi che ora piangete, perché riderete... Guai a voi che ora ridete perché... piangerete» (Lc 6,21.25). E nella stessa linea si muoverà la Lettera di san Giacomo: «Gemete, peccatori, sulla vostra miseria, fate lutto e piangete; il vostro riso [ghélos] si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza» (4,9). Così stanno le cose se ci fermiamo al puro e semplice verbo «ridere».
Tuttavia si devono fare due osservazioni rilevanti. La prima riguarda i Vangeli che, com’è noto, non sono biografie complete e compiute della figura storica di Gesù di Nazaret, ma sono solo dei profili, illuminati dalla luce della fede. Che manchi qualche tratto dalla fisionomia umana di Cristo non significa automaticamente che esso non sia stato presente durante la sua esistenza terrena. I banchetti, appunto, possono essere una testimonianza indiretta dell’allegria vissuta anche da Gesù, tant’è vero che egli stesso dichiarerà di essere stato accusato di eccessiva libertà in questo senso: «È venuto il Figlio dell’uomo che mangia e beve e dicono: Ecco, è un mangione e un beone, amico di pubblicani e di peccatori» (Mt 11,19). Potremmo supporre che il riso abbia fatto parte dell’esperienza di Gesù, anche perché esso è una componente fondamentale - insieme alle lacrime - dell’essere uomini. L’Incarnazione, infatti, comporta l’assunzione dell’umanità da parte del Figlio di Dio nella sua integralità. C’è, però, una seconda considerazione da fare. Come si suol dire nel linguaggio «tecnico», un orizzonte semantico può essere coperto da più termini che ne descrivono le varie sfumature. Il ridere fa parte, ed è segnale, dell’orizzonte più vasto della gioia il cui molteplice significato può essere espresso con più vocaboli. In questa luce la domanda del nostro interlocutore può ottenere una risposta diversa da quella così categorica che abbiamo citato in apertura.
Particolare attenzione meriterebbe il Vangelo di Luca che uno studioso tedesco, Helmut Gollwitzer, ha idealmente posto in un suo commento sotto il titolo Die Freude Gottes, "La gioia di Dio" (1952). Basterebbe solo cercare i vocaboli della felicità per accorgersi dell’insistita presenza del tema nel terzo Vangelo.
Ci perdonino perciò i lettori, se faremo scorrere i vari termini greci. Il verbo cháiro (gioire, rallegrarsi) e il sostantivo chará (gioia, allegria) echeggiano cumulativamente per venti volte in Luca a partire da quel «Rallègrati» rivolto da Gabriele a Maria e divenuto il nostro «Ave» (1,28). C’è poi l’«esultanza» espressa per quattro volte col verbo agalliáo e col sostantivo agallíasis. È, questa, la felicità messianica di tenore spirituale. Così, quando Gesù pronuncia quella stupenda preghiera, detta appunto «l’inno di gioia», riferita da Luca 10,21-22 («Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli...»), l’evangelista nota in apertura: «In quello stesso istante Gesù esultò [agalliáo] nello Spirito Santo e disse...».
Luca, solo tra tutti gli autori del Nuovo Testamento, usa per tre volte anche il verbo dell’allegria fisica, in greco skirtáo applicandolo al piccolo Giovanni che «danza di gioia» nel grembo di Elisabetta quando incontra Maria (1,41.44) e ai giusti perseguitati che nel giorno del giudizio «si rallegreranno esultanti» perché grande sarà la loro ricompensa nei cieli (6,23). E se si vuole trovare un brano intero che mostri come Gesù proclami la gioia della salvezza - "Vangelo", com’è noto, significa "bella, gioiosa notizia" - basterebbe leggere il capitolo 15 di Luca con le tre celebri parabole della misericordia divina: quelle della pecora, della dracma e del figlio smarriti e ritrovati.
Un esegeta, Bruno Maggioni, ha intitolato quel capitolo «Un invito alla gioia di Dio in Cristo». Non potendo citare per ragioni di spazio tutti i passi, suggeriamo ai nostri lettori di prendere in mano un Vangelo e, nel capitolo 15 di Luca, di leggere i versetti 5, 6, 7, 9, 10, 23, 24, 25, 29, 32. In essi, tra l’altro, c’è un altro verbo greco di gioia: eufráino. Gesù, quindi, esalta il gioire festoso che prende spunto da vicende umane concrete, come il ritrovare un oggetto prezioso smarrito o il riabbracciare dopo tanto tempo una persona cara. Anzi, Luca, che aveva aperto il suo Vangelo col sorriso festoso del natale del Battista e di Gesù, lo conclude con la raffigurazione della Chiesa che conosce l’intensità della gioia: «... dopo averlo adorato tornarono a Gerusalemme con grande gioia [chará] e stavano sempre nel tempio lodando Dio» (24,52-53).
Fermiamo qui la nostra ricerca, che potrebbe essere allargata agli altri Vangeli (e ancor di più all’Antico Testamento, ove appare ampiamente il «ridere» di Dio). Noi vorremmo concludere con le parole che, secondo Giovanni, Gesù pronuncia nell’ultima sera della sua vita terrena: «Queste cose io vi ho detto perché la mia gioia sia con voi e la vostra gioia sia piena» (15,11). Curiosamente Lutero descriverà così la Gerusalemme celeste, sulla scia di un’immagine medievale: «Allora l’uomo giocherà con cielo e terra e sole e con le creature. E tutte le creature proveranno anche un piacere, un amore, una gioia lirica e rideranno con te, o Signore, e tu a tua volta riderai con loro».
Gianfranco Ravasi
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ----- Dio e Platone. Monsignor Gianfranco Ravasi diventa cardinale (di Maurizio Chierici).20 novembre 2010, di Federico La Sala
Dio e Platone
Monsignor Gianfranco Ravasi diventa cardinale
Dall’amore per la filosofia alla Bibbia elettronica
di Maurizio Chierici (il Fatto, 20.11.2010)
La voce di uno dei cardinali che il Papa incorona è il filo che lega Gianfranco Ravasi a milioni di persone. Per vent’anni la sua Bibbia elettronica è entrata in ogni casa: radio e Tv, giornali e conferenze prenotate con lunghe attese. Senza contare i libri per avvicinare i lettori al cammino dei profeti. “Ho scelto la divulgazione attirandomi le critiche di chi non era d’accordo perché la divulgazione è un piano inclinato: può finire nelle sabbie dell’ovvietà. Ma mi ha permesso di realizzarmi come uomo e sacerdote. Se mi fossi chiuso nei libri, sarei ancora molto timido”.
Tempo fa, il monsignore che presiedeva la Biblioteca Ambrosiana raccontava come la vocazione lo avesse raggiunto. Non un innamoramento improvviso. Quando era bambino segue il nonno sulla collina sopra il suo paese della Brianza. Dormono in una baracca per lavorare appena il cielo rischiara. “E al tramonto nella valle passa un treno. Il fischio del treno mi fa capire il senso lacerante e violentissimo della inconsistenza delle cose. Il treno sparisce. Resta la striscia di fumo. Avevo cinque anni, la sensazione mi segue nel tempo; diventa elemento sotterraneo e capitale della vocazione. Il bisogno di scoprire nell’inconsistenza del reale, il senso del fine. Di natura sono pessimista, sento lo sfaldarsi della realtà. Ormai grande ricordo quel fischio e quel treno che se ne andavano come la vita. Emozione che invitava a capire perchè certe cose siano destinate a svanire. Adulto, le ritrovo nella Recherche, Proust e la memoria del passato sulla quale galleggiano foglie morte. Per me è il contrario: diventa l’invito alla permanenza”. Nessun albero degli zoccoli, eppure il nonno e il suo campo riaffiorano in una dimensione fantastica. Si chiamava Giovanni, non era il padre della madre. Solo lo zio. “Ne percepivo il fascino della sicurezza”.
E POI la madre: “Rappresentava la genialità. Non dormiva per sfogliare libri. Ma la cosa che ancora mi accompagna è quel camminare con la mano nella mano del nonno. Non raccontava fiabe. Spiegava cose e persone che incontravamo per strada. Spiegava perché i meno fortunati alla domenica bevono e imbestialiscono e com’è la vita quando si nasce diversi. Spiegava come può presentarsi il potere. Era l’unico a tener testa al signorotto del paese a proposito dell’arroganza sui terreni. Succedeva attorno alla collina chiamata Colle di Brianza; Brianza cattolica e tradizionalista che respirava con distrazione il flusso di Milano”.
La madre era cresciuta nella casa di uno zio senza figli: “Idealmente ceduta”. Monsignore che sorride: civiltà degli affetti contadini. Sposa Paolo Ravasi, antifascista perseguitato, mai un posto vero perché rifiuta la tessera. L’Italia va in guerra, lo mandano in Sicilia a fermare gli americani: prima linea, carne da cannone. Ma il ribelle riempie il fucile di cemento. Non vuole sparare. Diserta e torna camminando. Quando arriva il bambinolorifiuta.Nonsopporta che la vita a tre, con la madre e il nonno, venga turbata dalla presenza di chi non conosce. Comincia la scuola, a Merate, ospite di due zie, maestre alla Gozzano, zitelle molto pie. Ogni tanto torna a casa; solo ogni tanto. Le distanze avevano misure diverse. Quindici chilometri dalla mamma, un’eternità.
Comincia la seconda vocazione, sempre col libro in mano: De Amicis e Cuore e la fantasia di Verne. Le zie influiscono nelle scelte: ginnasio al seminario di Seveso, ambiente che gli sembrava triste. “Quelle relazioni inamidate coi superiori e devozioni richiamate dal suono dei campanelli e nuovi compagni così diversi dagli amici gioiosi della scuola di prima. C’erano anche le ragazze...”.
Al liceo scopre una spiritualità di altro tipo. Primo amore, Platone. Divora i libri che gli suggerisce il professor Cipolla: Gian Franco Contini e l’amore per scrittori stranieri qualche volta proibiti: Camus. Ricorda a memoria brani di Goethe e sei dialoghi di Platone in greco.“Bastava sfogliarli una volta e si fissavano nella memoria. Avevo questa fortuna”.
Divide il tempo con due compagni di corso: Sandro Magister e Umberto Galimberti: “Hanno probabilmente sentito la frattura di un ambiente che non li favoriva e sono usciti”. Magister continua gli studi teologi alla Cattolica; sceglie di fare il giornalista all’Espresso. Galimberti è il filosofo allievo di Severino. Il loro addio al seminario diventa l’allarme sulla possibile frattura tra fede e cultura. “Ma il credere e il mio comprendere andavano di pari passo. Non concepisco l’integralismo religioso; non condivido un cattolicesimo autosufficiente”.
Voleva fare il professore, latino e greco. Colombo (insegnante che diventerà cardinale a Milano) non è dell’ idea: lo indirizza alle scienze bibliche. Comincia l’altra vocazione. Si innamora delle lingue morte, l’ebraico lo incanta. Lingua povera perché esprime la poesia della Bibbia “riuscendo a dire Dio in modo bello con appena 5.750 vocaboli. Il greco classico ne ha 40 mila, l’italiano 150 mila, l’inglese 500 mila”. Dedica una parte importante “all’invito dell’esegesi per andare al di là del versetto e scoprire quanto insegna la tradizione talmudica dove ogni parola ha 70 volti”.
PRIMI passi del giovane prete col talento delle lingue. Ormai ne parla tante: lingue dei nostri giorni, compreso il fiammingo. Si immerge nelle scritture dimenticate: siriaco, aramaico, etiopico, samaritano. Arriva la terza vocazione: raccontare alla gente le emozioni del viaggio tra spirito e parole per evitare il pericolo “di diventare studioso da laboratorio e professore in cattedra”.
Divide il tempo negli incontri con tre tipi di persone: chi lo ascolta per fede, chi discute alla ricerca del piacere letterario, chi contrasta per convinzione atea con il rigore drammatico di una religione negata, ma che sfugge e deve inseguire. Preferisce gli atei (“purtroppo rimasti in pochi...”) agli indifferenti: “Incolori, inodori, insapori. Appagati e non inquieti”.
Il Papa intellettuale gli affida la presentazione del suo Gesù di Nazareth. Lo voleva vescovo ad Assisi, ma i vescovi di Ruini hanno detto no. Lo ha chiamato a governare la cultura della Chiesa e con la rapidità di un lombardo indaffarato Ravasi apre porte trascurate. L’incontro con la modernità, il rapporto con gli artisti, l’elogio della bellezza . Chi ha sempre parlato con la gente non sopporta l’isolamento dei Sacri Palazzi.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ----- E’ ORMAI TEMPO DI SVEGLIARVI DAL SONNO (di Giuseppe casale - Arcivescovo emerito di Foggia-Bovino).8 novembre 2010, di Federico La Sala
È ormai tempo di svegliarvi dal sonno (Rm 13,11)
di Mons. Giuseppe Casale (Adista - Segni nuovi, n. 87, 13 novembre 2010)
Per i cattolici italiani è giunto il tempo di un severo esame di coscienza. Quali responsabilità di fronte ai guasti della vita pubblica che si fanno ogni giorno più gravi? E non parlo solo dei quotidiani scandali che riempiono le pagine di cronaca. Parlo del degrado della vita politica e della tranquilla accettazione di un metodo di governo che promette illusioni e lascia affogare il Paese nella “monnezza”. Non solo a Napoli e a Palermo, ma dovunque si vive di malaffare, di illegalità, di soprusi.
Come hanno reagito i cattolici all’indegno trattamento riservato a migliaia di migranti (tra cui tanti profughi) respinti in veri campi di concentramento? Invece di reagire all’operato del governo, hanno applaudito o tacitamente acconsentito, preferendo difendere il loro risicato benessere, che si fa ogni giorno più precario. Chi ha levato la voce contro una situazione del lavoro che vede disoccupati migliaia di giovani e costringe tanti operai a sopravvivere con la cassa integrazione? Non è sufficiente tenere in regola i conti dello Stato. Questo può farlo qualunque buon ragioniere. È urgente un’azione che ponga fine agli squilibri esistenti tra chi ha molto (in alcuni casi, troppo) e chi non ha niente, tra chi sguazza nel lusso e chi stenta a mettere insieme quanto serve per le quotidiane necessità. Abbiamo detto molte belle parole. Ma non abbiamo avuto il coraggio di denunciare i mali di un capitalismo globalizzato che aumenta i dividendi delle anonime finanziarie (vere centrali di ingiustizia) e tratta gli operai come merce di scambio. Quanti cattolici che si riempiono la bocca di dottrina sociale cristiana sono pronti ad impegnarsi di persona, non per la conquista di un pezzo di potere, ma per un cambiamento che ponga al centro del dibattito i temi della pace, del disarmo, della solidarietà?
È giusto difendere la vita dall’inizio alla sua conclusione. Ma è ancora più urgente difendere la vita di milioni di bambini che muoiono di fame. È ancora più urgente impegnarsi per la pace tra i popoli, scoraggiare i risorgenti nazionalismi. Il governo, invece di far propaganda per innamorare i giovani per la vita militare, li aiuti a inserirsi nel mondo del lavoro, crei tutte le occasioni per non lasciare inoperose migliaia di braccia e di menti, per cui tanto si è speso negli anni della formazione scolastica. Ai cattolici dico: è tempo di agire. Non sognando un nuovo partito cattolico o di cattolici. Non mirando a una fetta di potere. Ma operando in tutti i settori della vita pubblica con una coraggiosa testimonianza di onestà e di competenza.
Ai cristiani di Roma Paolo lanciava un forte monito: “È ormai tempo di svegliarvi dal sonno” (Rm 13,11). Abbiamo dormito troppo. Abbiamo troppo pensato al nostro interesse personale, a una sterile difesa dei diritti della Chiesa. I diritti della Chiesa sono i diritti dei poveri, degli emarginati, degli esclusi, degli oppressi da una società che riesce ad attutire o a spegnere qualunque sussulto di rivolta contro l’imperante conformismo. Di quel perbenismo che concilia il dirsi cattolico e il vivere una vita di immoralità e di menzogna.
È ormai indilazionabile l’impegno a porre a base della nostra vita non la ricerca del potere, ma il servizio, praticando la carità che è la “pienezza della legge” (Rm 13,1). Non c’è legalità se non c’è un forte sussulto di amore, di gratuità, di condivisione.
* Arcivescovo emerito di Foggia-Bovino
-
> MONSIGNOR RAVASI --- I VOCABOLI DEL DESIDERIO E I VOCABOLI DEL DIO PIENO DI GRAZIA ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E MARIA E IL DIO "CARITAS" DI LACAN E DI RATZINGER PIENO DI AFFARI CON "MAMMONA" E "MAMMASANTISSIMA"!!!7 ottobre 2010, di Federico La Sala
RIPARARE IL MONDO. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD.
Sesso e corpo: i vocaboli del desideriodi Gianfranco Ravasi (Corriere della Sera, 06.10.2010)
È suggestivo osservare che il vocabolo ebraico del desiderio sessuale, teshuqah, che nella Genesi rappresentava l’oscura pulsione sessuale («Verso tuo marito sarà la tua teshuqah / desiderio, ed egli ti dominerà», 3,16), nel Cantico viene riproposto come segno di donazione e di comunione totale: «Io sono del mio amato e la sua teshuqah / desiderio è verso di me» (7,10).
Certo, il desiderio non elide la sua componente sessuale ed erotica, come appare nelle stupende rappresentazioni dei corpi dei due innamorati (capitoli 4; 5; 7). Anche Pio XII, in un discorso del 29 ottobre 1951, affermava: «Il Creatore stesso ha stabilito che nella reciproca donazione fisica totale gli sposi provino un piacere e una soddisfazione sia del corpo sia dello spirito. Quindi, gli sposi non commettono nessun male cercando tale piacere e godendone. Accettano quello che il Creatore ha voluto per loro».
La sessualità e l’eros devono però inserirsi nella donazione d’amore che trasforma e trasfigura il desiderio facendolo tendere a quella pienezza, totalità, assolutezza che la donna del Cantico esprime nella sua «professione d’amore»: «Il mio amato è mio e io sono sua. Io sono del mio amato e il mio amato è mio» (2,16; 6,3). La tensione rimane perché la creatura umana è fragile e può contaminare la purezza assoluta della donazione. Questa tensione, però, è anche positiva.
Infatti, il desiderio di sua natura rimane sempre mobile e dinamico, e dev’essere conservato anche in questa sua qualità: essa è ben rappresentata dallo stupore e dalla tenerezza, che brillano soprattutto nello sbocciare dell’amore. Il desiderio dovrebbe saper mantenere continuamente questo clima di dolcezza, questa sorta di «stato nascente» dell’amore che ne rivela la vitalità, ma anche il suo non essere un possesso acquisito.
Come si è già detto, pur nell’abbraccio, la coppia del Cantico sa che sempre deve correre verso «i monti dei balsami» (2,17; 8,14). Si intuisce, così, anche nel desiderio dell’amore umano, quell’ «insoddisfacibilità» che è tensione verso l’assoluto e l’infinito: è l’«inquietudine» agostiniana che può «riposare» solo nella trascendenza e quindi in Dio.
Per questo possiamo parlare di «simbolicità» del desiderio: esso vive nella realtà concreta, presente e temporale, ma al tempo stesso si protende verso l’Altro, l’Oltre, lo Spirito, l’Eterno. Lacan, che al desiderio ha dedicato un’analisi interessante (basata sulla nostalgia del bambino separato dalla madre), connettendosi proprio al linguaggio simbolico, dichiarava: «Se bisogna fondare la nozione dell’Altro con una A maiuscola come il luogo della parola, bisogna affermare che, essendo l’uomo un animale in preda al linguaggio, il suo desiderio è il desiderio dell’Altro».
La storia umana è scandita da grandi desideri che, come il mare è composto da tante gocce, si costruiscono e si sviluppano a partire da singoli desideri personali. Si ha, in tal modo, una tensione universale e costante non solo «verticale» nel procedere oltre che è propria del desiderio, ma anche «orizzontale» fra desideri opposti, negativi e positivi. È quello che è illustrato a livello generale dalla Città di Dio agostiniana ed è anche ciò che, nel microcosmo del singolo, ha descritto sant’Ignazio di Loyola nella sua parabola delle «due bandiere»: esse hanno schiere opposte di seguaci, in marcia verso mete antitetiche, spinti dai loro desideri.
La dinamica della storia universale e di quella personale presuppone, dunque, anche uno scenario tenebroso. Ai figli della luce si accostano e si oppongono i figli delle tenebre, alla tavola luminosa del desiderio dell’amore si allinea in un dittico anche la tavola notturna del desiderio degenerato che tende verso il negativo, l’abisso infernale. Anche la Bibbia raffigura in modo plastico questo desiderio cieco, indomabile e dotato di un suo insaziabile dinamismo, di un’insoddisfazione inestinguibile.
Pensiamo, per esempio, al racconto - straordinario anche a livello psicologico - della passione cieca di Ammon che lo conduce allo stupro di una sua sorellastra, la bellissima Tamar, figlia di suo padre, il re Davide: «Ammon afferrò Tamar e le disse: Dài, unisciti a me, amore mio! E lei: No, fratello mio, non farmi violenza! Non commettere questa infamia! Egli però non ne volle sapere: era più forte di lei e la violentò unendosi a lei. Ma dopo l’atto, Ammon provò verso di lei un odio grandissimo, l’odio che sentiva verso di lei era ben più potente dell’amore con cui l’aveva prima amata» (si legga l’intero testo 2 Sam 13, 1-17).
La brutalità della pulsione insita nel desiderio affiora spesso nelle narrazioni bibliche: le scene di Sodoma (Gen 19) e di Gàbaa, quest’ultima ancor più truculenta (Gdc 19), descrivono le crude e brutali passioni come pure le violente e infami pulsioni degli uomini della steppa che ancor oggi si ripetono nei deserti metropolitani.
E la donna non fu più una cosa
di Armando Torno (Corriere della Sera, 06.10.2010)
Nel libro dell’Esodo (20,17) si legge: «Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa appartenente al tuo prossimo». Un comandamento ribadito in una formulazione successiva nel libro del Deuteronomio (5,21), con alcune varianti.
Se nell’Esodo il primato spetta alla «casa» ( bêt), intesa nella sua dimensione globale che va oltre quella dell’edificio, nel Deuteronomio la donna è estrapolata dall’asse patrimoniale e acquista una posizione autonoma, anzi un primato distintivo: «Non desiderare la moglie del tuo prossimo» precede ed è separato dalla «brama» per le proprietà del capofamiglia. Non a caso l’autore sacro muta il verbo del «desiderio», introducendo la radicale ’wh che denota una maggiore avidità e materialità.
Queste osservazioni, con le varianti linguistiche e i relativi significati, si trovano nell’ultimo saggio di Gianfranco Ravasi che, con Andrea Tagliapietra, ha scritto per Il Mulino (nella serie dedicata ai comandamenti) Non desiderare la donna e la roba d’altri (in libreria domani, 7 ottobre, pp. 160 e 12).
Ravasi, che ha appena pubblicato da Mondadori Questioni di fede. 150 risposte ai perché di chi crede e di chi non crede ( pp. 266, 19) intervenendo sulle domande più spinose e cruciali, nonché su interrogativi insoliti e curiosi, ha intitolato il suo scritto per il libro de Il Mulino Non desidererai la moglie e la casa del tuo prossimo; Tagliapietra, invece, L’ultima delle dieci parole ovvero non desiderare.
Dalla nuova interpretazione del comandamento scritta da Ravasi per l’editrice bolognese offriamo in anteprima un estratto riguardante l’«oggetto del desiderio». Sì, il desiderio. Se per Aristotele nel De anima rappresenta «l’appetizione di ciò che è piacevole», Heidegger in Essere e tempo l’ha connesso ontologicamente alla natura dell’uomo, mentre Spinoza incantò romantici e idealisti con la definizione dell’Etica: «La tristezza che riguarda la mancanza della cosa che amiamo».
Ravasi in Non desidererai la moglie e la casa del tuo prossimo ricorda che il desiderio è una delle componenti capitali e positive della spiritualità biblica, anche se per la fede continua a conservare un’ambiguità.
Del resto, nella Prima Lettera di Giovanni (2,16) si legge il monito contro la bramosia che lo ha trasformato in concupiscenza. Senza la quale, tuttavia, per Oscar Wilde, la vita si riempirebbe di sbadigli. Ha scritto in Lady Windermere’s Fan: «Preferisco le donne con un passato. La loro conversazione è sempre così maledettamente divertente».
-
>I VOCABOLI DEL DESIDERIO E I VOCABOLI DEL DIO PIENO DI GRAZIA ("CHARITAS") ---- "What Do Women Want?" di Daniel Bergner. “Il desiderio femminile è come quello dei maschi” (di Elena Stancanelli).18 luglio 2013
Sessant’anni fa Sigmund Freud scriveva all’amico e biografo Ernest Jones: «La vera domanda alla quale nessuno ha risposto, e alla quale io stesso non so dare una risposta nonostante i miei trent’anni di ricerca nell’animo femminile è: cosa vogliono le donne?»
Daniel Bergner ha raccolto in “What Do Women Want?” gli ultimi studi sul piacere senza tabù e vecchi cliché. Scatenando le polemiche
Il sesso delle donne
“Il desiderio femminile è come quello dei maschi”
di Elena Stancanelli (la Repubblica, 18.07.2013)
- IL SAGGIO: What Do Women Want? di Daniel Bergner (Ecco Pr, pagg. 205 euro 15,80) sarà tradotto in Italia da Einaudi Stile libero
Contrordine: non solo il desiderio femminile esiste, ma è potente almeno quanto quello maschile, non ha una propensione monogamica e, pensa un po’, non è neanche legato all’istinto riproduttivo. Non somiglia per niente a un languore romantico, non necessita di una storia intorno. Esattamente come sapevamo che accade agli uomini e agli altri animali, le donne desiderano punto e basta. Cosa? Sesso. Sono mesi che si gira intorno alla faccenda, le classifiche dei libri sono piene di romanzetti rosa virati hard, che esplorano voglie e vogliette, vizi e vizietti. Persino l’ultimo film di Lars Von Trier, Nymphomaniac (di cui cominciano a girare adesso alcuni spezzoni) ha per protagonista una donna che si concede del tutto al proprio desiderio sessuale, testandone i confini e le implicazioni. Protagonista Charlotte Gainsbourg, a dimostrazione che, forse anche più che per gli uomini, le donne considerano ormai il sesso esplicito un territorio non più proibito, quasi mainstream.
Sessant’anni fa Sigmund Freud scriveva all’amico e biografo Ernest Jones: «La vera domanda alla quale nessuno ha risposto, e alla quale io stesso non so dare una risposta nonostante i miei trent’anni di ricerca nell’animo femminile è: cosa vogliono le donne?». Sessant’anni dopo Daniel Bergner - giornalista delNew York Times, già autore di un saggio sulle parafilie, Il lato oscuro del desiderio- risponde con un libro intitolato appunto What Do Women Want?, che uscirà in Italia, tra qualche mese, per Einaudi Stile libero (come il precedente). E contiene interviste a donne normali, ricerche sugli animali, teorie di psichiatri, scienziate, terapiste sessuali. Gli studi sul desiderio femminile sono in ritardo. Quando sono nate le scienze legate alla sessualità, si è dato per scontato che ci si dovesse occupare di disfunzioni/preoccupazioni/meraviglie dell’organo e dell’orgasmo maschile. Anche soltanto perché entrambi garantiscono la conservazione della specie. E quando Galeno sostenne, nel II secolo d. C., che senza il piacere femminile, mediante il quale immaginava che fosse rilasciato l’uovo da fecondare, non era data appunto fecondazione, fece assai peggio alle donne di quanto una teoria del genere farebbe presupporre.
Secondo Bergner infatti, l’idea imposta dal medico greco che i genitali femminili fossero uguali a quelli maschili ma nascosti e un po’ meno funzionali, ha condizionato la nostra visione del piacere. Questa genitalità femminile oscura e goffa, ha imposto per secoli l’idea che l’orgasmo delle donne, e quindi il desiderio, fossero una robetta insignificante, e soprattutto racchiusa in un istante e in un unico e impervio luogo: la vagina, appunto. Il primo passo per rivalutare instensità e potenza del piacere femminile è stato quindi allargare la zona preposta a un altro paio di robette là intorno, che, ben allertate, garantiscono un gran sollazzo. Tra queste il celeberrimo punto G, scoperto nel 1600 da un medico olandese, ma descritto per la prima volta nel 1950 da Ernst Grafenberg, ginecologo tedesco.
Il primo capitolo del libro di Bergner, uno dei motivi per cui all’uscita negli Stati Uniti e poi in Inghilterra si è scatenato un putiferio, si intitola “animali”. E non soltanto perché le protagoniste degli esperimenti di Meredith Chivers, dell’Università di Ontario, sono le scimmie. Chivers ha studiato a lungo, e raccontato in un documentario, una particolare razza di scimmie chiamate Bonobo, note al mondo per due motivi: la mitezza e la libertà dei costumi sessuali. Le Bonobo fanno sesso continuamente, e quindi soltanto in rari casi per riprodursi, in tutte le combinazioni possibili: maschi, femmine, adulti, anziani, giovani... Ma gli animali che danno il titolo al capitolo non sono le scimmie, bensì le femmine della nostra specie. Selezionate alcune volontarie (etero e omosessuali) la professoressa le prepara applicando nella loro vagina un apparecchietto, “plethysmographry”, che registri turbamenti e movimenti. Poi mostra loro una serie di video pornografici, etero, lesbo e gay - e tra questi anche il documentario che illustra gli allegri accoppiamenti delle scimmie Bonobo. Quindi chiede, alle donne non alle Bonobo, di raccontare che cosa hanno sentito durante la visione, se abbiamo provato eccitazione e per cosa.
Collazionando i risultati ottenuti dalla macchinetta con quanto dichiarato, Meredith Chivers ha scoperto che le donne mentono, mentono moltissimo. Che il loro livello di eccitazione è molto più alto di quello che riescono ad ammettere. Cosa che non accade quando ripete lo stesso esperimento coi maschi. Ne deduce che negli uomini il cervello e i genitali stanno dalla stessa parte, sono alleati, nelle donne spesso no. Cioè le donne si vergognano di quello che provano, o peggio neanche se ne accorgono, talmente sono vincolate a quello che pensano dovrebbero provare. Quindi: il desiderio femminile esiste, è potente animale e vivissimo, ma società e cultura lo osteggiano con forza. Le nostre strutture politiche e di convivenza sono fondate su quel minimo di ordine garantito dalla famiglia, la quale, da un certo punto in poi, ha avuto bisogno di trasformarsi da vincolo utilitario a consesso basato sull’amore.
È lì che, spiega Bergner, ci siamo dovuti inventare un paio di bugie cruciali: che le donne desiderano tutta la vita lo stesso maschio (nonostante la natura gridi il contrario) e che l’unico momento in cui desiderano accoppiarsi è durante il periodo fertile. Qualche anno fa, racconta ancora Bergner, la dottoressa Marta Meana dell’Università del Nevada pubblicò un lungo articolo a proposito delle “fantasie di stupro” o di sottomissione, o di sospensione della volontà. È difficile, spiega la dottoressa, trovare un’espressione che tenga conto del risultato dei miei colloqui, senza offendere nessuno. Alcune donne, spiega, ritennero allora insopportabile l’immagine che lei aveva proposto come esercizio: una donna di spalle, in un vicolo scuro, un uomo che la prende da dietro, uno sconosciuto.
Eppure intorno a quella scena si agita, spesso, il desiderio femminile. Altro che monogamia, altro che riproduzione: sottomissione, cinquanta sfumature di qualsiasi cosa. Un po’ di rischio, la possibilità di non dover scegliere e tanto, tanto testosterone. Di questo si compone il nostro desiderio, il desiderio di uomini e donne. Purtroppo, quando la biochimica si inceppa, la faccenda delle donne si fa più complicata. Un Viagra femminile lo stanno ancora sperimentando. Ma già possiamo dire che in ogni caso si tratterà di un bel frullato di testosterone, dopamina, serotonina... cose così. Non un documentario sul Principe Azzurro.
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- Chiedi, cerca, e ti rarà risposto (di Gianfranco Ravasi - da "Questioni di fede").4 ottobre 2010, di Federico La Sala
Chiedi, cerca e ti sarà risposto
di Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 Ore, 03.10. 2010)
«Le risposte sono capaci di darle tutti, a fare le vere domande ci vuole un genio». Oscar Wilde, raffinato scrittore inglese dell’Ottocento, ma anche fulminante «battutista», coglieva con questa frase un aspetto della conoscenza umana che quasi un secolo prima aveva già intuito un autore moralista francese, il Duca di Lévis, nella sua raccolta di Massime, precetti e riflessioni: «L’ingegno di un uomo si giudica meglio dalle sue domande che dalle sue risposte». Ebbene, questo che il lettore ha tra le mani è soprattutto un libro di domande, non so quanto geniali ma certamente significative, che mi sono state rivolte lungo un ampio arco di anni da persone che non ho quasi mai incontrato direttamente, ma con le quali ho dialogato attraverso i giornali o la televisione proprio accogliendo i loro interrogativi religiosi o filosofici.
L’ars interrogandi. Certo è che alla radice della domanda sta la ricerca di senso che è strutturale allo stesso esistere umano, come diceva il celebre protagonista dell’Apologia di Socrate di Platone: «Una vita senza ricerca non merita di essere vissuta». È proprio per questo che il bambino è implacabile coi suoi «Perché?». In lui pulsa allo stato puro e non è ancora sterilizzato - come accade invece all’adulto superficiale o disincantato o deluso - il desiderio di sapere, l’ansia di capire, la curiosità della scoperta. Tutte le domande serie partecipano di questa esigenza radicale e in qualche modo esprimono l’interrogazione di fondo sul senso ultimo dell’esistenza, sulle scelte decisive, sui valori da ricercare. Senza il fiore delle domande, che sbocciano come tanti petali, non si ha poi il frutto (non sempre automatico e sicuro) delle risposte, che indicano una strada o una meta nell’itinerario della vita.
Proprio per questo la domanda è l’anima della religione, non solo perché la preghiera è supplica, richiesta, invocazione di aiuto o di rivelazione: si pensi ai Salmi biblici o alla prassi arcaica dell’interrogazione oracolare della divinità, anche nel caso di richieste molto concrete, come una guerra da intraprendere (1Sam 14,37) o l’esito di una malattia (2 Re 8,8). C’è un’altra e più profonda motivazione nella domanda religiosa ed è quella di sondare il mistero di Dio, la sua trascendenza e «incomprensibilità».
Straordinario, a questo riguardo, è il libro biblico di Giobbe, che è un’ideale ininterrotta interrogazione lanciata verso un cielo apparentemente muto: «Interrogami pure» dice Giobbe al Signore «e io risponderò, oppure domanderò io e tu ribatterai» (13,22). Alla fine Dio spezza il suo silenzio e ironicamente interpella così il suo interlocutore: «Se sei un uomo valoroso, cingiti i fianchi, io ti interrogherò e tu mi istruirai!» (38,3). E l’approdo sorprendente sarà appunto in un imponente discorso epifanico divino, presente nei capitoli 38 e 39 del libro e paradossalmente costruito su una sequenza di domande che il Signore rivolge a Giobbe e che in sé custodiscono in nuce la risposta attesa.
Talvolta, però, la domanda rivolta a Dio ricade su chi la lancia verso l’alto. Resta, così, come un artiglio - richiamato in qualche modo dal segno grafico occidentale del punto interrogativo - che lacera carne e anima. È il caso tipico delle domande che si levano dai sofferenti e che hanno il loro modello in questo avvio del Salmo 13: «Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri, tristezza nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico?». Sono le domande della sofferenza, del male di vivere, della desolazione e della disperazione che spesso si raggrumano nel semplice e lacerante «Perché?», parallelo al «Fino a quando?», reiterato quattro volte dal Salmista.
L’interrogazione può, dunque, avere connotati esistenziali forti e può allargarsi sino ai fondamenti della propria identità. Significativa, ad esempio, è la domanda che Cristo lascia serpeggiare tra i suoi seguaci: «Ma voi chi dite che io sia?» (Mt 16,15). Un quesito analogo a quello che ciascuno può rivolgere a se stesso - «Ma tu chi sei?» - nell’intimità esclusiva della propria coscienza. Sono, questi, gli interrogativi che possono scompigliare la vita, o spettinare l’ordinata banalità quotidiana, o sommuovere il quieto vivere delle abitudini.
A epilogo della riflessione sul valore alto della domanda, è necessario aggiungere una considerazione che riguarda tutte le scienze, sia tecniche sia umanistiche. È ciò che spiega in modo nitido un altro scrittore, il romanziere francese Honoré de Balzac, nella sua opera La pelle di zigrino (1831): «La chiave di tutte le scienze è indiscutibilmente il punto di domanda.
Dobbiamo la maggior parte delle grandi scoperte al Come? E la saggezza nella vita consiste forse nel chiedersi, a qualunque proposito, Perché?». L’accrescimento del sapere si fonda su una continua interrogazione alla quale subentra una risposta che contiene, a sua volta, la possibilità di un’altra domanda, ed è su questa piramide altissima che si riesce a contemplare spazi sempre più vasti della realtà. È significativo che la stessa tradizione religiosa di Israele si fondi su un continuo «interrogarsi rispondere» delle generazioni, come accade nella celebrazione della Pasqua: «Quando verranno i vostri figli vi interrogheranno: Che significato ha per voi questo rito?, voi direte loro...» (Es 12,26- 27). E la risposta è, certo, commemorativa di un passato, ma è anche la giustificazione di un presente di libertà e l’apertura di uno scenario futuro, verso la piena liberazione messianica. È quello che in ebraico si chiama zikkaron, «memoriale», nel quale il figlio interroga il padre per «ricordare i giorni del tempo antico e meditare gli anni lontani» (Dt 32,7), ma soprattutto per raccogliere un testimone che lo condurrà verso un nuovo orizzonte di comprensione, di speranza e di salvezza.
L’ars respondendi. «L’arte di interrogare non è facile come si pensa. È più arte da maestri che da discepoli. Bisogna già aver imparato molte cose per saper domandare ciò che non si sa». Questa acuta osservazione di Jean-Jacques Rousseau nella sua Nuova Eloisa (1761) riassume il primo movimento della nostra riflessione sull’ars interrogandi, un esercizio della mente e della vita assolutamente necessario per crescere intellettualmente e spiritualmente. Ora, però, dobbiamo scendere anche lungo l’altro versante del dialogo: alla domanda deve succedere la risposta. Anzi, come sopra facevamo sospettare, spesso già nell’interrogativo si cela il germe della soluzione.
È un po’ quello che i nostri maestri ci suggerivano quando ci invitavano, prima di metterci a scrivere il compito d’esame, a leggere accuratamente il titolo del tema o la formulazione del problema o l’enunciato della tesi da dimostrare. Kafka, però, faceva anche intuire che ci sono domande senza risposta: esse, infatti, ci rivelano il nostro limite creaturale, sono una sferzata che fustiga l’arroganza dell’onniscienza o dell’hybris, cioè della sfida all’arbitrio supremo nel decidere bene e male, vero e falso, giusto e ingiusto secondo risposte dettate da convenienza o da mera vanità e superficialità. Tuttavia, c’è un’altra assenza di risposta che ha una genesi più immediata «Guardai» dice il profeta Isaia «ma non c’era nessuno, tra costoro proprio nessuno capace di consigliare, nessuno da interrogare per avere una risposta» (41,28).
La fine dei maestri, come la cosiddetta «morte del padre» e l’estinguersi delle ideologie, ha introdotto nella società contemporanea l’orrore per le risposte nette e definite, lo sberleffo per la certezza, la passione per il relativo. «La verità, qualunque essa sia, non vi farà liberi» affermava la filosofa contemporanea Sandra Harding, ribaltando il celebre detto di Gesù nel Vangelo di Giovanni (8,32). In questa prospettiva non ci sono risposte «vere» ma probabili e, quindi, le domande fondamentali vengono esorcizzate, evitate e persino disprezzate proprio perché esigono repliche basate sulle categorie di un pensiero forte e sostanziale.
C’è, però, anche una più modesta assenza di risposta: essa nasce dall’aumento esponenziale delle persone sgarbate e superficiali che negano ogni approccio serio, che si tuffano nell’ottundimento dei luoghi comuni e che scelgono il rigetto di tutto ciò che inquieta la calma piatta della loro coscienza e della loro mente. «L’uomo sapiente sa quel che dice, mentre lo stupido dice quel che sa» ironizza un aforisma giudaico.
Con questa consapevolezza, che è anche certezza dei propri limiti, la persona saggia offre le risposte che conosce in modo puntuale e completo, essenziale e documentato.
Gianfranco Ravasi, Questioni di fede, Mondadori, €19,50
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- "CARISMA" DA TEOLOGO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA. MONSIGNOR RAVASI PARLA DEL "DIZIONARIO DELLE TEOLOGIE FEMMINISTE" (a c. di Letty M. Russell e J. Shannon Clarkson), "L’EVANGELO DELLE DONNE" (di Lidia Maggi)13 settembre 2010, di Federico La Sala
Carisma da teologa
di Gianfranco Ravasi (Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2010)
Edith Piaf la cantava con la sua voce appassionata e calda nel 1942, proprio quando io nascevo. Ma, cresciuto, l’avevo forse sentita risuonare anche nell’eco screziata e frusciante della radio o del vinile e persino nel canticchiare di mia madre durante il lavoro domestico: La vie en rose è, certo, l’emblema di un’epoca, di un modello esistenziale, di un’atmosfera.
Tuttavia, vedere l’intera vita con lenti rosa alla fine stanca e fin sconcerta. Questa sensazione mi accompagnava mentre percorrevo qua e là le pagine del Dizionario di teologie femministe, curato da due teologhe americane del Connecticut ed edito in italiano dall’alacre Claudiana di Torino con la consulenza di una teologa e di un teologo del nostro paese (in questa materia incandescente è necessario usare sempre il linguaggio "inclusivo").
Intendiamoci, il volume è molto utile e quasi indispensabile per conoscere di prima mano la teologia femminista, sulla quale per altro siamo intervenuti più di una volta su queste pagine, consapevoli che la questione femminile ha registrato una presenza importante nella trama della storia recente del pensiero teologico (e non soltanto nell’orizzonte sociale, psicologico o filosofico).
Non è il caso, infatti, di documentare quanto una concezione maschilistica o patriarcale abbia pesantemente rivestito e condizionato il pensiero religioso del passato, a partire dalle stesse Scritture Sacre, immerse in un contesto "sessista". Tanto per esemplificare, Qohelet non esita a proclamare la donna «amara più della morte, tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia; chi è gradito a Dio la sfugge, ma chi fallisce ne resta catturato...» (7,26). E il suo collega Siracide va anche più avanti, certo com’è che «è meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna» (42,14).
È, quindi, ovvio che una grande e faticosa operazione di rilettura ermeneutica di quelli e di altri testi religiosi, così come una revisione delle prospettive e degli stili pastorali siano necessarie. In questo senso il monito continuo presente nelle voci di questo Dizionario non è da sbeffeggiare o da smitizzare in modo radicale, ma da considerare un po’ come una spina nel fianco delle stesse Chiese. Molto cammino al riguardo è stato compiuto, sia pure nella differente calibratura dottrinale e pastorale delle diverse confessioni cristiane, ma un altro è ancora aperto, anche perché non è con un semplice decreto o con un pronunciamento pur autoritativo che si cancellano concrezioni secolari fatte di ideologia, di prassi e di costumi.
Che c’entra, allora, La vie en rose? C’entra nell’esasperata e parallela unilateralità di certe teologie femministe che colorano tutto di rosa (forse rigettando persino l’assegnazione di questo colore come "esclusivo"), nell’ansia di trasformare una deprecata his-story in una her-story. Così, se prendiamo la prima voce, «Abbà/Padre», è ovvio che bisogna subito "salvare" Gesù, che usava indubbiamente questo appellativo: ma egli lo faceva in un «contesto antipatriarcale», «affermando un significato non-patriarcale» e «rovesciando l’idea stessa per porla al servizio della critica femminista del patriarcato e delle sue divinità». La «Nascita verginale» di Gesù, tanto per proseguire negli esempi, «nelle teologie femministe o è rifiutata in quanto mito cristiano androcentrico che sostiene il patriarcato e denigra le donne» o, al contrario, è «l’inizio della fine dell’ordine patriarcale».
Persino l’apparentemente asettica «Archeologia» non svilupperà la sua vera identità «finché non saranno superati i suoi preconcetti tradizionali ed elitari» che puntano a «esaminare strutture e manufatti pubblici e monumentali, in cui predomina l’impronta maschile... dirigendo la maggior parte delle sue energie verso i prodotti dell’atti vità maschile» e non ai contesti domestici (che, però, si riconosce essere ora fmalmente oggetto di analisi), tuttavia inesorabilmente scoprendo in essi la subordinazione al primato androcentrico.
È scontato che ben più incandescente sia la voce sui «Ministeri ecclesiastici e il culto», molto articolata ma con una netta opzione di principio: «Le femministe stanno mettendo in discussione tutte le forme gerarchiche, i ruoli tradizionali di leadership, la distinzione tra clero e laici, le forme, il linguaggio, le immagini di culto e spiritualità che non siano inclusive. Sono oggetto di critica anche le definizioni della vita familiare e dei ruoli sessuali che stanno alla base dell’educazione religiosa». E qui bisognerebbe invitare il lettore a seguire alcuni temi scottanti connessi - tutti destinatari di un lemma proprio - come famiglia, educazione religiosa, sacramenti, cura pastorale, ministero, liturgia e soprattutto le varie voci dedicate al "genere" (gender), sul quale però si deve registrare una notevole polimorfia di approcci, meno automatici rispetto all’impostazione del celebre asserto «On ne naît pas femme, on le devient» della de Beauvoir, che considerava il sesso come una mera costruzione socio-culturale e non biologico-naturale.
La notevole questione del «Linguaggio inclusivo» a cui sopra accennavamo, pur nell’indiscussa istanza che propone, tende a trascendere verso estremismi che scardinano i concetti e le verità teologiche sottese (è noto che il mezzo linguistico non è mai neutro e inoffensivo rispetto al contenuto). Queste esasperazioni giungono al punto di avanzare perplessità anche nel chiamare Dio «Madre» oltre che «Padre»: «Ci si chiede, infatti, se Madre è sufficiente come unico nome femminile di Dio, dal momento che tale uso implica che le donne sono come Dio solo quando partoriscono e allevano figli».
Ripetiamo: «Numerosi sono i contributi positivi provenienti dall’esegesi, dalla teologia e dall’ermeneutica femminista» (e questa frase è desunta da un documento cattolico ufficiale, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa della Pontificia Commissione Biblica). Soprattutto Giovanni Paolo II ha ribadito la necessità di una conversione della comunità ecclesiale nei confronti della donna e del suo "carisma" (in senso teologico). Ripetiamo pure che questo Dizionario, nella sua qualità fenomenologica, è un sussidio significativo per conoscere il variegato orizzonte delle teologie femministe.
Detto questo, rimane l’impressione di essere di fronte a una sorta di sessuologia teologica che corre il rischio di procedere in modo parallelo all’approccio adottato dal detestato patriarcalismo fallocratico, scivolando in eccessi unilaterali, in parzialità smodate, in visioni che calzano appunto solo occhiali a lenti rosa, cadendo talora in quelle trappole che si denunciano. Ha ragione la pastora battista Lidia Maggi quando scrive, nel suo Evangelo delle donne, un volumetto che esce in contemporanea al Dizionario e che è dedicato a una quarantina di figure femminili neotestamentarie: «La riscoperta della presenza femminile non venga appiattita quale strumento per rivendicare quote rosa all’interno delle Chiese: percorso legittimo, che dà voce all’altra metà del cielo, troppo spesso messa a tacere. Ma la posta in gioco è ben più alta, di tipo teologico: custodire e difendere la rivelazione evangelica nella sua integralità... C’è un’eccedenza dell’evangelo rispetto al nostro desiderio di essere valorizzate da Gesù. Eccedenza non vuol dire che l’evangelo rema contro, ma che va oltre: anche oltre il riconoscimento del ruolo delle donne».
 Letty M. Russell e J. Shannon Clarkson (a cura di), «Dizionario di teologie femministe», edizione italiana a cura di Gabriella Lettini e Gianluigi Gugliermetto, Claudiana, Torino, pagg. 546, € 47,00;
Letty M. Russell e J. Shannon Clarkson (a cura di), «Dizionario di teologie femministe», edizione italiana a cura di Gabriella Lettini e Gianluigi Gugliermetto, Claudiana, Torino, pagg. 546, € 47,00;
 Lidia Maggi, «L’Evangelo delle donne», Claudiana, Torino, pagg. 136, € 12,00.
Lidia Maggi, «L’Evangelo delle donne», Claudiana, Torino, pagg. 136, € 12,00.
Sul tema, nel sito, si cfr.: -
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- "FAMIGLIA CRISTIANA" E "CEI" CRITICANO LA LOGICA DEL "DOMINUS ASSOLUTO" DEL GOVERNO ITALIANO, MA NON DEL "DOMINUS JESUS" DEL GOVERNO VATICANO.5 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> LESSING E NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA!!! Una recensione di Gianfranco Ravasi senza grazia e senza amore (l’"Uno"), che finisce anche con la presa di distanza dal curatore della nuova versione dell’opera, Leo Lestingi3 agosto 2010, di Federico La Sala
 MESSAGGIO DELL’EVANGELO ("DEUS CHARITAS EST": 1 Gv. 4.8), MESSAGGIO DEL POSSESSORE DELL’"ANELLO DEL PESCATORE" ("DEUS CARITAS EST": BENEDETTO XVI, 2006), E TEOLOGIA POLITICA DELL’"UOMO SUPREMO" ("DOMINUS JESUS").
MESSAGGIO DELL’EVANGELO ("DEUS CHARITAS EST": 1 Gv. 4.8), MESSAGGIO DEL POSSESSORE DELL’"ANELLO DEL PESCATORE" ("DEUS CARITAS EST": BENEDETTO XVI, 2006), E TEOLOGIA POLITICA DELL’"UOMO SUPREMO" ("DOMINUS JESUS"). (...) Lestingi è, comunque, convinto che Lessing «non abbia mai voluto sfilarsi di dosso il cristianesimo come una vecchia tunica logorata, ma ha inteso interpretarlo in maniera nuova e ardita facendogli fare un salto in avanti». Un salto, però, piuttosto rischioso che ha sotto di sé anche il vuoto di uno smarrimento della specificità e dell’autenticità teologica.
(...) Lestingi è, comunque, convinto che Lessing «non abbia mai voluto sfilarsi di dosso il cristianesimo come una vecchia tunica logorata, ma ha inteso interpretarlo in maniera nuova e ardita facendogli fare un salto in avanti». Un salto, però, piuttosto rischioso che ha sotto di sé anche il vuoto di uno smarrimento della specificità e dell’autenticità teologica. -
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- SENZA GRAZIA: LA CHIESA NON HA PIU’ PADRI - NE’ MADRI, HA SOLO "MAMMASANTISSIMA" (di Susanna Tamaro)2 agosto 2010, di Federico La Sala
SENZA GRAZIA: LA CHIESA NON HA PIU’ PADRI - NE’ MADRI, HA SOLO "MAMMASANTISSIMA" (di Susanna Tamaro)
L’antropologia come la teologia della "sacra famiglia" della gerarchia vaticana è zoppa e cieca: è quella del ’Figlio’ che prende - accanto alla Madre - il posto del padre "Giuseppe" e dello stesso "Padre Nostro"... e fa il "Padrino"!!!
Se la Chiesa non ha più padri
di Susanna Tamaro (Corriere della Sera, 2 agosto 2010)
Poche settimane fa il Papa ha istituito un nuovo organismo, nella forma di «Pontificio Consiglio», con il compito di promuovere una rinnovata evangelizzazione nei Paesi che stanno vivendo una «progressiva secolarizzazione» e una sorta di «eclissi del senso di Dio». Da cosa, da chi dipende questa «grave crisi del senso della fede cristiana e dell’appartenenza alla Chiesa» di cui parla Benedetto XVI e a cui questo nuovo dicastero vorrebbe porre rimedio?
Da anni mi trovo a vivere in una posizione di confine. Non ho avuto, in famiglia, un’educazione cattolica, anzi, provengo da un ambiente ateo, anticlericale e massone ma avendo una natura inquieta, nel corso della mia vita, ho fatto un lungo cammino spirituale che mi ha riavvicinato al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù Cristo. Non è stato un cammino lineare né sempre luminoso, la via interiore, infatti, è un continuo confronto con il male. Se la mia fede esiste - e resiste - è perché continuo a studiare, a leggere, a interrogarmi e ad accettare anche giorni in cui mi sembra di non credere.
Negli ultimi dieci anni molte altre persone della mia generazione hanno intrapreso un percorso simile, lasciandosi alle spalle ideologie politiche, new age e vari movimenti orientali per tornare alla fede del Vangelo ma, nella maggior parte dei casi, questi figli prodighi non hanno trovato nessun padre ad attenderli. Così, dopo un periodo di grande trasporto, non trovando interlocutori né accoglienza, si sono nuovamente allontanati.
La Chiesa infatti - nonostante i molti dibattiti tra laici e credenti - continua a essere autoreferenziale, a respingere chi è in ricerca e a diffidare profondamente di chi ha fatto un percorso spirituale diverso. Come mi disse un giorno un prete irritato - al quale stavo spiegando il sentito e tardivo riavvicinamento alla fede di un’amica di cui avrebbe dopo poco celebrato il funerale - «gli ultimi mesi non contano niente, bisogna stare da sempre nella Chiesa», dimostrando così un’ammirevole pienezza evangelica.
Malgrado tutti i discorsi sull’apertura, sulla nuova evangelizzazione, la Chiesa continua a essere una struttura solo apparentemente accogliente, accoglie giustamente i poveri, si prodiga con generosità per alleviare le sofferenze degli ultimi, ma spesso, in questa bulimia di buone azioni, si dimentica delle inquietudini delle persone normali. Mancano i padri e le madri spirituali, persone credibili, che abbiano fatto un cammino, che conoscano la complessità e la contraddittorietà della vita e che, con umiltà e pazienza, sappiano accompagnare le persone lungo questa strada, senza giudicare e senza chiedere risultati. Nel padre o nella madre spirituale non c’è niente di nuovo, bensì qualcosa di straordinariamente antico: la sete di un’anima che incontra un’altra anima in grado di aiutarla a cercare l’acqua. Non occorrono nuovi «input», nuovi dicasteri, nuove sfide, nuovi raduni oceanici.
Occorre soltanto ricordarsi che nell’uomo esiste una parte di mistero e che questa parte va nutrita. La natura umana è sempre uguale e, per crescere interiormente, richiede le stesse cose oggi come ai tempi dei padri del deserto. Se così non fosse, non si spiegherebbe il fascino che ancora ha, ad esempio, San Francesco che da più di ottocento anni continua a parlare e a commuoverci con le sue parole e la sua vita. San Francesco infatti era un Santo. E cosa vuol dire Santo? Essere una persona integra, totale, una persona che non ha doppiezze, fraintendimenti, che conosce solo il «sì sì, no no» di evangelica memoria.
Sono così la maggior parte delle persone di Chiesa che ci vengono incontro, che parlano dai pulpiti delle parrocchie, in televisione, sui giornali? Hanno sguardi luminosi? Le loro bocche parlano davvero della pienezza del cuore? Sono forze di santità? E se lo sono, perché non arrivano, perché le loro parole lasciano per lo più indifferenti, se non irritati? Perché non faccio altro che incontrare persone buone, rette, etiche, che si sono allontanate per sempre dalla Chiesa dopo esperienze deteriori con i suoi rappresentanti? Dove «deteriore» non è solo il caso estremo del pedofilo, ma anche quello più semplice del sordido, dell’ignavo, del gretto, comunque del doppio?
Perché, nel cattolicesimo, è concessa questa doppiezza? La bocca si riempie di parole alte, ma la vita, spesso, non le manifesta. La coerenza non sembra essere richiesta. Eppure, dove la coerenza c’è, dove c’è testimonianza della pienezza della vita di fede, le chiese sono piene, i nuovi eremiti sparsi sull’Appennino hanno il problema di gestire il flusso delle persone che ininterrottamente va da loro. Già, perché questi sono tempi di grande inquietudine e di grande ricerca. L’uomo in cammino non si accontenta più di formule, di luoghi comuni, di convenzioni sociali, è molto più esigente, cerca risposte vere e profonde alle domande che ha dentro. Questa sete di verità e bellezza non può venire soddisfatta dalla mediocrità delle vite e delle testimonianze né da una liturgia che ha abbandonato il sacro diventando sempre più simile a una sorta di intrattenimento televisivo.
Se una nuova evangelizzazione ci deve essere, dovrebbe dunque riguardare prima di tutti gli uomini e le donne della Chiesa, responsabili purtroppo - in molti, troppi casi - dell’allontanamento dalla fede di tante persone di valore. Forse è il momento di capire che non è la quantità dei sacerdoti, ma è la qualità a fare la differenza. E la qualità non dipende dalla preparazione teologica, dai convegni, dai master accumulati, ma dalla purezza dell’anima che si arrende alla Grazia. Un’anima arresa è un’anima che converte, che disseta. Un’anima che traffica, organizza, o si assopisce sui suoi privilegi, è un’anima che allontana.
Viene il sospetto che questo nuovo dicastero rischi di diventare soltanto l’ennesimo coperchio messo sulla pentola, per non guardare quello che bolle dentro. Nuove cariche, nuovi poteri, nuovi segretari, nuovi bilanci. C’è davvero bisogno, è questo che avvicinerà la gente? O c’è bisogno piuttosto di una grande cura di umiltà? Cancellare i moralismi, i pregiudizi, la pigrizia, la sete di potere e tutta quella zavorra che nulla ha a che vedere con la fede e appesantisce e rende tanto ostile il cattolicesimo agli uomini contemporanei. I nostri tempi hanno bisogno estremo di santità, come ha detto il Papa di recente all’anno sacerdotale, perché davanti alla cosificazione dell’uomo, è l’unica condizione che lo riporta alla straordinaria grandezza per cui è nato. Santità non è un’inerme arrendevolezza, ma è una forza di pienezza, un essere dell’uomo nella totalità compiuta dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti, capace così di compiere ogni suo atto nella luce dell’amore.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- Sindrome Ipazia per la Chiesa del XXI secolo. Una lezione di Nicla Vassallo.25 aprile 2010, di Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Sul Vaticano, in Piazza san Pietro, il "Logo" del Grande Mercante ... I Pastori mangiano le pecore e gli agnelli, ma non c’è da preoccuparsi: "il fenomeno non è così esteso come si vorrebbe far credere"(Parola Monsignor di Charles J. Scicluna - Intervista di Gianni Cardinale). .13 marzo 2010, di Federico La Sala
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?! ---- Ravasi: «In una Fondazione strutturiamo il confronto». «ll nostro dicastero sta organizzando una Fondazione intitolata "Il cortile dei gentili" che si ispira aldiscorso del Papa alla Curia a dicembre».25 febbraio 2010, di Federico La Sala
intervista a Gianfranco Ravasi
Ravasi: «In una Fondazione strutturiamo il confronto»
a cura di Lorenzo Fazzini (Avvenire, 25 febbraio 2010)
«ll nostro dicastero sta organizzando una Fondazione intitolata "Il cortile dei gentili" che si ispira al discorso del Papa alla Curia a dicembre». L’annuncio è di monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio per la cultura. Una prima concretizzazione dell’auspicio di Benedetto XVI per un rinnovato dialogo con gli uomini e le donne che non credono ma vogliono avvicinare Dio.
Quali gli obiettivi di questo nuovo ente?
«Primo, creare una rete di persone agnostiche o atee che accettino il dialogo e entrino come membri nella Fondazione e quindi del nostro dicastero. Inoltre, vogliamo avviare contatti con organizzazioni atee per avviare un confronto (non certo con l’Uaar italiana, che è folcloristica). Terzo, studiare lo spazio della spiritualità dei senza Dio su cui aveva già indagato la Cattedra dei non credenti del cardinale Martini a Milano. Infine, sviluppare i temi del rapporto tra religione, società, pace e natura. Vorremmo, con questa iniziativa, aiutare tutti ad uscire da una concezione povera del credere, far capire che la teologia ha dignità scientifica e statuto epistemologico. La Fondazione vorrebbe organizzare ogni anno un grande evento per affrontare, di volta in volta, uno di questi temi».
Il debutto?
«Nella seconda metà di quest’anno, probabilmente a Parigi, città molto viva su questi argomenti: abbiamo già avuto la disponibilità di Julia Kristeva (nota linguista e psicanalista, ndr)».
Ma tra i non credenti vi è disponibilità al confronto proprio su Dio?
«Bisogna tener conto dei diversi ateismi, non riducibili ad un unico modello. Da un lato c’è il grande ateismo di Nietzsche e Marx che purtroppo è andato in crisi, costituito da una spiegazione della realtà alternativa a quella credente, ma con un sua etica, una visione seria e coraggiosa, ad esempio nel considerare l’uomo solo nell’universo. Oggi siamo in presenza di un ateismo ironico sarcastico che prende in considerazione aspetti marginali del credere o posizioni fondamentaliste, ad esempio nella lettura della Bibbia. È l’ateismo di Onfray, Dawkins e Hitchens. In terzo luogo vi è un’indifferenza assoluta figlia della secolarizzazione ben sintetizzata dall’esempio che Charles Taylor fa in L’età secolare quando afferma che se Dio venisse in una nostra città, l’unica cosa che succederebbe è che gli chiederebbero i documenti».
Come si conciliano annuncio e dialogo?
«Nell’identità. Come nel dialogo con le religioni, che richiede il mantenimento delle reciproche identità, vi deve essere rigore anche con l’ateismo. Più che una dimostrazione a chi è religiosamente povero, forse bisogna far vedere la ricchezza di quell’oasi che è il credere. Ogni fede non è mai solo informativa ma anche performativa, cioè offre dati sull’uomo ma al tempo stesso li dice con calore. Se presenta in modo ricco la religione, il dialogo adempie al compito di presentare la fede in maniera efficace, senza che si punti su bisogni primari, ad esempio la religione come "farmaco" in una malattia. Lo scambio è già fruttuoso con la scienza: come sostiene Michel Heller, oggi siamo in presenza di una vera e propria "teoria del dialogo" per cui, in alcuni ambienti, scienza e fede, e qui direi ateismo e fede, si incrociano. Basti pensare alla teoria della relatività, che ha bisogno dello spazio e del tempo nel loro significato filosofico, cioè simbolico. Qui c’è lo spazio di un vero dialogo nell’amicizia».
-
> VINCENZO PAGLIA E FRANCO SCAGLIA FACCIA A FACCIA CELEBRANO LA PROPOSTA DI PAPA RATZINGER --- LA CHIESA HA SMARRITO SE STESSA ED E’ TORNATA AL VECCHIO E PRE-EVANGELICO "ATRIO DEI GENTILI"!!!5 marzo 2010, di Federico La Sala
-
> VINCENZO PAGLIA E FRANCO SCAGLIA FACCIA A FACCIA CELEBRANO LA PROPOSTA DI PAPA RATZINGER --- LA CHIESA HA SMARRITO SE STESSA ---- CORRUZIONE E DEVOZIONE (di Francesco Merlo).6 marzo 2010, di Federico La Sala
CORRUZIONE E DEVOZIONE
di Francesco Merlo (la Repubblica, 6 marzo 2010)
A metterli uno appresso all’altro, i crimini italiani, più che fascicoli giudiziari sembrano grani di rosario.
Più che una giurisprudenza compongono una confraternita. Dalla corruzione nello Stato alla mafia, dallo sfruttamento della prostituzione alle scalate dei banchieri devoti, in Italia sembra esserci, tra Cristo e Barabba, lo stretto rapporto che c’è tra asole e bottoni. Questo legame, inquietante per tutti ma offensivo soprattutto per chi davvero ha Fede, è diventato persino grottesco nella terribile inchiesta sulla Protezione civile. Al punto che «la cricca», oltre che agli avvocati, dovrebbe essere affidata ad una squadra di teologi. E proviamo a fare il riassunto senza faziosità laica o, per essere alla moda, laicista: pone Domine custodiam ori meo, poni o Signore una custodia alla mia bocca.
Dov’erano nascosti i fondi neri, il bottino, dell’imprenditore Anemone? In casa del prete, del suo direttore di coscienza don Evaldo Biasini, dietro un quadro sacro. E qual è l’ altissima onorificenza del superfunzionario corrotto Angelo Balducci? Gentiluomo di Sua Santità.
Dove cantava il giovane nigeriano Chinedu Thomas Eihem, prostituto e procacciatore di prostituti? Nel coro di San Pietro.
Dove arriva la telefonata per concordare le prestazioni del cubano, dei due neri, del tedesco, del calciatore e del ballerino? Nel palazzo barocco, realizzato dal Borromini, della Propaganda Fide, e più precisamente nella resi¬denza privata di Sua Eminenza il cardinale...
Cosa risponde il pio Balducci quando gli propongono un incontro bollente? «No. Alle 5 devo vedere Monsignor Paglia». Ma subito ci ripensa: «Possiamo anticipare. Io prima passerei da te e poi vado da Monsignor Paglia. Mezz’ora sola». Monsignor Paglia, certamente ignaro di tutto, è un vescovo molto stimato, presidente della Commissione episcopale sull’ecumenismo: vicina sunt vitia virtutibus, i vizi sono vicini alle virtù.
 E dove lo raggiunge il prostituto per consumare? «In seminario».
E dove lo raggiunge il prostituto per consumare? «In seminario».
 E da dove parte? «Dal Pontificio collegio Pio Brasiliano» che è la celebrata scuola per sacerdoti gesuiti.
E da dove parte? «Dal Pontificio collegio Pio Brasiliano» che è la celebrata scuola per sacerdoti gesuiti.
 Perché è staccato il telefono del bel calabrese? «Gli ho mandato anche un messaggio. Ma non risponde. Forse è a Messa».
Perché è staccato il telefono del bel calabrese? «Gli ho mandato anche un messaggio. Ma non risponde. Forse è a Messa».
 Come fa il lenone a illustrare la qualità della “merce”? «Ci avrà 15 centimetri, occhi azzurri, è un Cristo di due metri».
Come fa il lenone a illustrare la qualità della “merce”? «Ci avrà 15 centimetri, occhi azzurri, è un Cristo di due metri».Ad inquietarci qui non è la solita antica e spesso presunta scostumatezza vaticana né i sentori di una segreta vita debosciata nel cuore della Curia romana. Questa insomma non è letteratura, non è la versione aggiornata dei Sotterranei di Gide, delle scelleratezze dei Borgia, degli eccessi denunziati dalla poesia di Dante Alighieri. Qui c’è qualcosa di diverso e forse di irreversibile. E’ la devozione altissima dei banchieri Fiorani e Fazio, divisi tra il latinorum degli studi su san Tommaso e i furbetti der quartierino; sono gli altarini nei covi dei mafiosi, le madonne di Totò Rina e Bernardo Provenzano; sono i camorristi che pregano e uccidono, i calabresi che a Duisburg baciano il crocifisso e sparano, i finanzieri d’assalto che studiano le Sacre Scritture ed evocano Sodoma e Gomorra. E’ don Livolsi appunto, economo, come ha raccontato ieri Francesco Viviano, della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue di Gesù, gente che porta soldi in Africa e certamente subordina l’etica del danaro al cattolicesimo dei valori, sentendosi probabilmente irreprensibile dal punto di vista della propria morale: vita spartana e custodia delle tangenti, adorazione del Sangue di Cristo e bancomat della corruzione, «dimmi quanto ti serve e li vado a prendere»; riti, evangelizzazione, una coroncina con i grani rossi, le attese dei poveri, le lacrime dei sofferenti, le speranze dei popoli e... il riciclaggio del danaro sporco. Don Livolsi secondo i Pm è il fornitore dei 50mila euro che Balducci avrebbe voluto dare a Bertolaso «senti don Evà, scusa se ti scoccio...». Evidentemente pensa, questo giovane missionario, che Dio sia Italiano, che ami soprattutto i peccatori e, molto più che sulla virtù, punti, per salvare le anime, sul pentimento...
E’ difficile trovare un criminale italiano che non esibisca timor di Dio, che non scriva lettere di perdono, che non frequenti i ministri del culto. Non ho alcuna spiegazione da fornire, non ho intenzioni di lanciarmi in una trattazione storica e teologica, né di citare Manzoni o magari Padre Pio, il Risorgimento e il Concordato o il tempo nel quale si tappavano le vergogne alla Venere del Botticelli. Di sicuro la cronaca non registra criminali che esibiscono con la stessa sfacciataggine una militanza nella morale laica, quella del rigore per le regole collettive e della tolleranza generosa ma severa, la dolorosa libertà di scegliere l’aborto, l’amore tra i gay, il sesso come espressione di un sentimento non eterno, la possibilità di sciogliere una pessima famiglia e ritentare, il difficile rapporto privato con Dio che è tipico di tutti i poveri diavoli del mondo.. .
Alla fine dunque vorrei solo far riflettere sull’incontestabile rapporto che c’è in Italia tra Cristo e Barabba, e sulla coscienza, che immagino disperata in prigione, del gentiluomo di Sua Santità a capo di una associazione a delinquere, abituato a commettere delitti di ogni genere e a invocare il divino perdono nei vestiboli, nei sacrari, nei refettori, nei sentieri tra le celle di un Paese dove la rispettabilità cattolica è garantita dall’ipocrisia.
Come quella della Federcalcio che coltiva lo sport più violento e incivile (e corrotto) del mondo ma squalifica il bestemmiatore sui campi, e ha persino inventato la nuova professione del cacciatore di bestemmie, ispettore autorizzato, apostolico indulto per concessione pontificia, a leggere le labbra, a interpretare le labiali, e dunque a sospendere l’allenatore del Chievo Domenico Di Carlo ma ad assolvere due calciatori che non avrebbero imprecato contro Dio ma contro Dìaz e contro Zio perché sapiens verbis innotescit paucis, l’uomo savio si fa riconoscere da poche parole, come è scritto nella regola benedettina, cara ad ogni Gentiluomo di Sua Santità.
-
> VINCENZO PAGLIA E FRANCO SCAGLIA ..... IN CERCA DELL’ANIMA (di Umberto Galimberti - Se gli italiani perdono l’anima).8 marzo 2010, di Federico La Sala
Se gli italiani perdono l’anima
di Umberto Galimberti (la Repubblica, 8 marzo 2010)
Anche i popoli hanno un’anima, o come dicono i tedeschi un Geist, uno "spirito" che li caratterizza e li rende riconoscibili. "Qual è l’anima degli italiani oggi?" chiede il saggista e romanziere Franco Scaglia al vescovo di Terni Vincenzo Paglia, presidente della Conferenza Episcopale Umbra, nonché consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio.
La domanda percorre l’intero libro-intervista In cerca dell’anima (Piemme, pagg. 290, euro 19), che già nel titolo lascia intendere che gli italiani un’anima, in cui potersi riconoscere come nazione, società e stato, ancora non l’hanno trovata, perché, dopo l’unificazione di storie, culture, società, e soprattutto lingue diverse avvenuta 150 anni orsono, è mancato, come vuole l’espressione di Eugenio Scalfari (che spesso ritorna nelle pagine del libro come interlocutore laico ai discorsi che prendono le mosse da una visione religiosa del mondo), agli italiani è mancato un "federatore". Lo fu Mussolini in modo "approssimativo e superficiale in difesa di valori ingiusti", lo furono la Dc e il Pci "che lavorarono alla rinascita e alla ricostruzione dell’Italia". Dissolte queste due forze, oggi a federare gli italiani è l’"inerzia" quando non addirittura il cupio dissolvi "che ha afferrato le coscienze ancor prima delle menti".
L’inerzia infiacchisce l’anima, che più non si appassiona e non sogna. Non sognano i giovani a cui il futuro non appare più come una promessa ma come una minaccia, non sognano gli adulti che sembrano essersi consegnati a quell’unico generatore simbolico di tutti i valori che è il denaro, non sognano i vecchi a cui è stata allungata la vita solo per riempirla di vuoto. L’inerzia è come un fiume che tutto ingloba e che pigro scorre verso un mare lontano, senza più la spinta della sorgente, le cascate dei dislivelli, i vortici degli affluenti. A rallentare il suo cammino annoiato e triste è solo il suo ristagnare nelle anse sempre più inquinate, paludose e piatte.
Questo infiacchimento spirituale più non conosce ideali forti in grado di affrontare i problemi che la globalizzazione e la tecno-scienza ogni giorno ci propongono: dalla bioetica alla pace, dalla giustizia all’immigrazione, dalla conservazione dell’ambiente alla lealtà fiscale per la costruzione del bene comune. Immersi nel grigio della rassegnazione, gli italiani oggi sono più tristi che felici e, incapaci di guardare il futuro, vivono la "dittatura del presente" dove l’attenzione è rivolta più ai sondaggi che ai movimenti della storia, in un mondo che cambia rapidamente intorno a noi, anche senza la nostra collaborazione, e soprattutto senza che noi lo si sappia interpretare, col rischio che alla fine si cambi in un mondo senza di noi.
Per far emergere il nostro stato di inerzia il libro fa un frequente richiamo al ’68, ricordato dai media con una "sorta di pudore o di fastidio o di lontana e svagata memoria". Senza reticenze nel libro se ne fa una significativa rivalutazione, non tanto per i contenuti, quanto per la passione che esprimeva e che percorreva trasversalmente la società, anche quella ecclesiastica. Allora era difficile parlare di inerzia. C’era una grande voglia di futuro e soprattutto di futuro collettivo, perché a differenza di oggi non c’era chi stava accanto all’altro senza solide relazioni. C’era voglia di comunità e non quelle solitudini di massa, ciascuno col suo ipod nelle orecchie o col video del computer davanti agli occhi per comunicare, dietro una maschera, con altre maschere che nascondono la propria identità.
E tutto questo in un’Italia cattolica che ha il suo centro nella "comunione" che vuol dire comunità, soccorso al prossimo in quelle forme puntualmente elencate nel "Discorso della Montagna" pronunciato da Gesù. Ma già sappiamo che la chiesa del potere non coincide con la chiesa dell’amore, anche se la chiesa dell’amore probabilmente non sopravvivrebbe senza la chiesa del potere. Ma in quest’Italia tutta rifugiata nel privato, senza solidarietà, senza compassione, senza commozione per il proprio simile più svantaggiato, non sarebbe tempo di meno enunciazioni di principio e di più frequenti richiami all’amore del prossimo? Non è questo il grande comandamento del cristianesimo che chiede di scorgere il volto di Dio nel prossimo che non puoi evitare di incontrare lungo la via?
-
> RITORNO ALLE VIRTU’, MA DELL’EVANGELO DELLA GRAZIA ("CHARITAS") O DI DIO MAMMONA E "CARO-PREZZO" ("CARITAS")?! Ogni virtù è un rischio. La lezione di Ravasi (di Giorgio Montefoschi).9 marzo 2010, di Federico La Sala
 Ogni virtù è un rischio
Ogni virtù è un rischio
 La lezione di Ravasi
La lezione di Ravasidi Giorgio Montefoschi (Corriere della Sera, 8 marzo 2010)
Il centro del prezioso libro di Gianfranco Ravasi dedicato alle virtù, Ritorno alle virtù (ora riproposto negli Oscar Mondadori, pp. 129, 9 €) è nei tre capitoli in cui, sinteticamente ma con molta efficacia, l’autore esamina le tre Virtù Teologali: la Fede, la Speranza e la Carità. A sua volta (non deve sembrare spericolato proporlo oggi), il cuore dei tre capitoli è nella zona di penombra che accompagna il corteo di queste tre virtù che risiedono nell’uomo, ma che provengono direttamente da Dio.
Ravasi non ha timore di mettere in evidenza e luce quella zona di penombra: che a volte può essere non sapere, a volte confusione dei sentimenti e dell’intelletto, a volte fragilità e debolezza, a volte oscurità nerissima, a volte rischio. Il momento in cui si accende la grazia nel cuore dell’uomo
 scrive - «è il momento dell’apparire di Dio nella notte dell’anima». Dio non è un sovrano
impassibile e lontano. È Lui che ci cerca. È Lui che «squarcia la nostra solitudine», che bussa alla
nostra porta. Illuminato da questa discesa di luce, l’uomo deve rispondere con la sua adesione. La
sua adesione è la Fede. Però, questa fede, questo abbandonarsi con fiducia, è un qualcosa che
avviene al buio: che contempla una immensa possibilità di rischio. Infatti, affidandoci, noi non
sappiamo a cosa, a quale entità ci affidiamo: perché non la vediamo. Non sappiamo questo
abbandono fiducioso dove ci porterà. Come Abramo che uscì dal suo paese senza sapere dove
andava, ubbidendo al comando, soltanto ci rendiamo disponibili al comando e al cammino.
scrive - «è il momento dell’apparire di Dio nella notte dell’anima». Dio non è un sovrano
impassibile e lontano. È Lui che ci cerca. È Lui che «squarcia la nostra solitudine», che bussa alla
nostra porta. Illuminato da questa discesa di luce, l’uomo deve rispondere con la sua adesione. La
sua adesione è la Fede. Però, questa fede, questo abbandonarsi con fiducia, è un qualcosa che
avviene al buio: che contempla una immensa possibilità di rischio. Infatti, affidandoci, noi non
sappiamo a cosa, a quale entità ci affidiamo: perché non la vediamo. Non sappiamo questo
abbandono fiducioso dove ci porterà. Come Abramo che uscì dal suo paese senza sapere dove
andava, ubbidendo al comando, soltanto ci rendiamo disponibili al comando e al cammino.Ci sarà d’aiuto la ragione, in questo cammino? Ci saranno d’aiuto le opere (il dilemma che tormentò San Paolo)? Non lo sappiamo. E, come leggiamo in Luca (18,8): «Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
Per definire la Speranza, Ravasi sceglie un pensiero di Georges Bernanos: «La speranza è una virtù, anzi virtus, cioè una determinazione eroica dell’anima. La più alta forma della speranza è la disperazione vinta... La speranza è, allora, un rischio da correre. È, addirittura, il rischio dei rischi». Commenta Ravasi: «Contro di essa milita non solo il pessimismo sistematico ma anche l’illusione». È vero. Perché la speranza non è soltanto la virtù che regge e stimola la vita del presente: che ci fa, legittimamente, sperare di migliorare la nostra condizione terrena.
La speranza decisiva è quella che ci spinge a guardare al di là della condizione terrena: al di là dei confini della morte. E chi di noi sa cosa accadrà dopo la morte? Certo, la risurrezione di Cristo - come scrive Ravasi - è il suggello di questa speranza». «Se siamo morti in Cristo - dice San Paolo nella Lettera ai Romani - crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più». Tuttavia, il nostro, per il momento, è un non possesso: è una attesa. E l’attesa «conosce il brivido del timore».
Anche nella Carità, nell’amore, come nella Fede, Dio ci precede. Già lo scendere della Fede è un atto d’amore. Non siamo noi ad amare Dio - non si stanca di ripetere Giovanni - è Dio che ha amato noi; è Dio che ha amato tanto il mondo da mandare il Figlio a sacrificarsi per noi e a salvarlo. È vero. Però noi molte volte non lo riconosciamo, questo amore. Come facciamo a riconoscerlo quando la natura ci devasta, quando i giusti soccombono, quando le creature innocenti muoiono? Dov’è, allora, l’amore di Dio? Insomma: dov’è Dio nei terremoti, dov’era Dio ad Auschwitz? È una vecchia domanda, alla quale forse, al di là del pensiero, può rispondere solo il cuore dell’uomo. Il cuore terreno dell’uomo che sperimenta l’amore, riconosce l’amore, sente proprio nell’amore un mistero che lo trascende. Questo amore misterioso ha il culmine in Gesù uomo. Gli uomini possono riconoscersi in Gesù. Possono dare questa risposta all’amore di un Dio sconosciuto. E, in tal modo, vincere la paura e l’ansia.
-
-
> VINCENZO PAGLIA E FRANCO SCAGLIA ---- IN CERCA DELL’ANIMA. Il dialogo: una cura per l’Italia stretta tra paura e indifferenza (di Giampiero Comolli).16 giugno 2010, di Federico La Sala
Il dialogo: una cura per l’Italia stretta tra paura e indifferenza
di Giampiero Comolli (l’Unità, 16 giugno 2010)
Dialogo: fino a non molto tempo fa pareva un valore accettato volentieri dalle forze politiche, dalle istituzioni religiose, dalla società civile. Dialogo come disponibilità a comprendere le ragioni dell’altro e a discutere assieme per delineare un orizzonte comune, un insieme di regole condivise, destinate a favorire la convivenza e lo sviluppo di un armonico tessuto sociale. Come non essere d’accordo con un simile ideale?
Eppure, da qualche anno a questa parte, la tela di relazioni, intessute proprio dalla pratica del dialogo, pare slabbrata, strappata in più punti. E la parola «dialogo», utilizzata prima da tutti come una moneta corrente, si trova oggi sotto attacco. Si levano infatti da più parti, sempre più aspre per non dire proterve, le voci di coloro che il dialogo non lo vogliono affatto, lo rifiutano in nome di una rivendicazione prepotente e sfacciata dei propri interessi, da difendere senza cedimenti, senza più quelle aperture all’altro che il buon uso del dialogo necessariamente richiede.
Ma come mai è finita la bella primavera di questa parola dalle connotazioni così ospitali? E cosa comporta invece il nuovo autunno della chiusura su di sé, nel quale oggi siamo essere entrati?
Se lo chiedono Vincenzo Paglia e Franco Scaglia in un libro nobile e appassionato, significativamente concepito proprio come un dialogo, una conversazione a due, sui tanti problemi che oggi affliggono il nostro Paese: dalla crisi della politica e della società civile, al dramma della precarietà lavorativa, all’enorme, irrisolta questione dell’immigrazione, fino alle ingiustizie determinate da un mercato sempre più globale e sganciato da ogni prospettiva etica.
Come molti già sapranno, Vincenzo Paglia è vescovo di Terni e consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio; mentre Franco Scaglia è uno scrittore cattolico, autore di saggi, romanzi e reportage, spesso ambientati in Terra Santa. Evidente dunque, anzi dichiarata con franchezza, è l’appartenenza di entrambi alla Chiesa di Roma, così come con passione viene testimoniata dai due autori la fede cristiana e la Parola evangelica, accolta non solo quale scelta di vita ma anche quale visione interpretativa, attraverso cui comprendere lo sconsolante processo di inaridimento che affligge oggi il nostro Paese: un’Italia sempre meno disponibile alle buone usanze del dialogo, ma che proprio per questo ha smarrito se stessa e deve quindi mettersi In cerca dell’anima (come recita il titolo del libro, appena edito da Piemme).
La diagnosi dei due amici scrittori è al tempo stesso severa e accorata. «Inerzia» si chiama «l’epidemia che ha colpito il Belpaese afferrandone le coscienze. Un’inerzia che infiacchisce l’anima nel profondo e offre il terreno alle derive violente»: priva di ambizioni e svuotata del proprio futuro, l’Italia vive una «caduta etica», oscilla fra l’indifferenza e la paura nei confronti degli altri, «chiude gli occhi agli ideali e alla speranza», perché coltiva oggi solo una «parvenza di passione», quella di chi è ripiegato nella difesa del proprio immediato interesse.
Le ragioni di questo generale immiserimento vanno individuate, secondo i due autori, non solo nell’inadeguatezza della nostra politica, ma prima ancora nel processo di una globalizzazione governata dalle pure logiche finanziarie di un mercato a propria volta svincolato dal controllo di una buona politica. Proprio in quanto globale e spietato, il nuovo mercato è divenuto così fonte di spaesamento generale: lungi dall’allargare le coscienze, ha creato precarietà e paure, «ha spinto a rinchiudersi ancor più nel privato, e questo ha prodotto inerzia, immobilità».
Al posto di quella «cultura dell’accoglienza che ha segnato profondamente la nostra storia», si è diffusa allora la propensione perniciosa alla «ricerca del capro espiatorio», di quell’estraneo (per religione, etnia, cultura) su cui scaricare di volta in volta le proprie ansie, le proprie colpe, «il veleno del disprezzo». Immersi come siamo «nel grigio della rassegnazione», abbiamo però di fronte a noi una strada maestra per edificare di nuovo «un paese saldo e robusto».
Questa via di salvezza sta appunto in un’«arte del dialogo», da praticare a ogni livello: fra cattolici e laici, fra religioni diverse, fra fede e scienza, fra italiani e immigrati, tutti chiamati a operare insieme nella ricerca delle nuove regole per una pacifica e fruttifera convivenza. Regole la cui definizione deve appunto risultare dal generoso contributo di tutti: infatti «in questa società nessun ceto e nessuna singola istituzione è addetta o arbitra del bene comune, che deve essere, invece, misura dell’operato di ciascun individuo e di ciascun gruppo. La Chiesa stessa non può arrogarsi il compito della sintesi».
Occorre leggere con attenzione e con favore questo libro che idealmente si rivolge a chiunque, anche a chi cattolico non è. È facile oggi considerare la Chiesa di Roma come un’istituzione chiusa su se stessa, ripiegata nella difesa del proprio ordinamento gerarchico.
Ma la prospettiva aperta da Vincenzo Paglia e Franco Scaglia ci presenta invece il volto di una Chiesa come «comunione dei fedeli», aperta al mondo, schierata innanzitutto dalla parte dei più deboli, dei poveri. Così, se la generosa sollecitazione al dialogo che ci viene dai due autori deve essere accolta con gioia da chiunque abbia a cuore le sorti del nostro Paese, il loro libro si rivela importante anche per un altro motivo: esso ci fa conoscere quello che potremmo forse definire «il volto più bello del cattolicesimo», un volto che in questi tempi di passioni tristi tende a rimanere oscurato.
 Vincenzo Paglia, Franco Scaglia,
Vincenzo Paglia, Franco Scaglia, «In cerca dell’anima- Dialogo su un’Italia che ha smarrito se stessa», Edizioni Piemme, Milano,
2010, pagine. 290, euro 19,00
«In cerca dell’anima- Dialogo su un’Italia che ha smarrito se stessa», Edizioni Piemme, Milano,
2010, pagine. 290, euro 19,00
-
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- Non è “MEGLIO UN UOMO SENZA BENI CHE DEI BENI SENZA UN UOMO!”?! (di Gianfranco Ravasi - dal "Breviario Laico")18 gennaio 2010, di Federico La Sala
“MEGLIO UN UOMO SENZA BENI CHE DEI BENI SENZA UN UOMO!”
A CURA DI CARLO CASTELLINI
“Quando il denaro bussa, Le porte si spalancano....dio regna nei cieli, il denaro sulla terra!”. L’antico aneddoto del consiglio di temistocle ateniese. *
Un ateniese si recò da TEMISTOCLE per un consiglio:”Devo maritare una figlia e devo scegliere tra due pretendenti: uno ricco ma stupido e l’altro onesto e intelligente ma povero”. E TEMISTOCLE:”Meglio un uomo senza beni che dei beni senza un uomo!”. (ANTICO ANEDDOTO).
In verità, ERODOTO riferendosi a questo generale e statista ateniese del VI-V secolo a. C. ci ha lasciato il ritratto caustico di un personaggio avido e ambizioso. A esaltarlo, invece, ci penserà TUCIDIDE, l’altro grande storico greco, e così TEMISTOCLE, diverrà soggetto di parabole esemplari come quella che abbiamo citato. La lezione ha una sua validità anche ai nostri giorni, non ostante non sia più esplicita l’idea del “buon partito” per avere un matrimonio soddisfacente.
Basti infatti pensare alla fatuità con cui si aspira a diventare “VELINE” per impalmare un calciatore e, più genericamente, alla superficialità con cui si approda alle nozze, sulla base di un’esteriorità inconsistente, senza un incontro di coscienze, di esperienze di sentimenti profondi e autentici.
Ma l’apologo ha un valore più generale. Purtroppo da sempre, nella storia L’UOMO SENZA BENI, ma bravo è svantaggiato e penalizzato rispetto a chi è ricco solo per il suo conto in banca e non certo per il suo pensare e agire.
La sapienza popolare si è adattata e ha coniato una serie di proverbi che potrebbero essere l’ideale commento alla parabola citata. Dalla GERMANIA:”QUANDO IL DENARO BUSSA, LE PORTE SI SPALANCANO.........DIO REGNA NEI CIELI, IL DENARO SULLA TERRA”.
DALLA RUSSIA:”QUANDO PARLA IL DENARO, LA VERITA’ TACE”. DALLA CINA:”COL DANARO SI FANNO PARLARE ANCHE I MORTI, SENZA DANARO NON SI FANNO TACERE NEPPURE I MUTI....”. “PERSINO I CIECHI SONO CAPACI DI VEDERE IL DENARO”.
(Dal Breviario Laico - di Gianfranco Ravasi). A CURA DI CARLO CASTELLINI.
* Il Dialogo, Lunedì 18 Gennaio, 2010 Ore: 17:18
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- LA VERGOGNA DI PARLARE SENZA VERGOGNA (di Tullio De Mauro).5 gennaio 2010, di Federico La Sala
PAROLE COME PIETRE
LA VERGOGNA DI PARLARE SENZA VERGOGNA
di Tullio De Mauro (l’Unità, 03.01.2010)
Nella simpatica trasmissione di Corrado Augias, gli ospiti finiscono col parlare delle cose più varie. Nella puntata più recente Umberto Galimberti, già valente studioso di psicologia, è apparso ancora su un terreno suo quando ha cominciato a parlare di vergogna. In effetti si legge ancora utilmente l’articolo “vergogna” che scrisse molti anni fa nel suo bel «Dizionario di psicologia». C’è ancora il sentimento della vergogna? Conduttore e ospite sono scivolati verso la sociologia d’arrembaggio e hanno detto concordi che quel sentimento va scomparendo.
Del vero ci deve essere se in questi anni il francese ha avuto fortuna una nuova parola, riecheggiata in altre lingue: “extimitè”, il contrario di “intimità”, per indicare la propensione a esibire sfacciatamente momenti e atti della propria intimità fisica e sentimentale. E tuttavia vien fatto di osservare che l’esibizione sfacciata ha senso solo perché sfida un persistente senso comune di discrezione. Se l’intero pubblico fosse fatto da svergognati abituali non avrebbero audience trasmissioni che illustrano le recondite fattezze e assai private movenze di qualche grande fratello o sorella (i ladri, diceva Chesterton, sono i più convinti assertori del diritto di proprietà). E colpisce che personalità inclini all’esibizione del loro privato si segnalino per la loro abitudine, quasi un tic irrefrenabile, di gridare ripetutamente in pubblico fino allo spasimo «Vergogna! Vergogna! Vergogna» a interlocutori con cui non concordino. Dunque anche per loro il senso della vergogna non è ancora morto.
Nella trasmissione di Augias lo psicologo e ora filosofo della storia si è avventurato a dire con aria grave: «Del resto, l’etimologia della parola vergogna è “vereo gognam”, temo la gogna». E qui le cose da ricordare sono parecchie.
 La prima, nota anche a studenti di latino diligenti, è che in latino si dice “vereor” e non “vereo” (il verbo è cioè un “deponente”).
La prima, nota anche a studenti di latino diligenti, è che in latino si dice “vereor” e non “vereo” (il verbo è cioè un “deponente”).
 La seconda è che “gogna” non è parola latina, ma italiana moderna.
La seconda è che “gogna” non è parola latina, ma italiana moderna.
 La terza osservazione è che “vergogna” (diversamente da “gogna”) appartiene alle parole di più sicura etimologia ed è la continuazione popolare del vocabolo “verecundia”, un sostantivo latino tratto da “vereri” (come “facundia” era tratto da “fari”, parlare).
La terza osservazione è che “vergogna” (diversamente da “gogna”) appartiene alle parole di più sicura etimologia ed è la continuazione popolare del vocabolo “verecundia”, un sostantivo latino tratto da “vereri” (come “facundia” era tratto da “fari”, parlare).Queste sono cose che si dicono con (appunto) un po’ di vergogna a causa della ovvietà che hanno per chiunque tenga a portata di mano, non diciamo un vocabolario etimologico (chiaro, accessibile, aggiornato è quello di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli), ma un qualsiasi buon vocabolario italiano. Sono cose banali e non è un peccato mortale ignorarle. Ma forse è una piccola vergogna, se si impiega e si dissipa l’autorità guadagnata in altri campi per spacciare notizie etimologiche senza fondamento.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- L’annuncio a Giuseppe - secondo lo spirito dell’amore ("caritas") della tradizionale dottrina cattolico-romana da Papa Ratzinger.20 dicembre 2009, di Federico La Sala
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA"!!!
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. "VA’, RIPARA LA MIA CASA"!!! RESTITUIRE L’ANELLO DEL PESCATORE A GIUSEPPE (come già Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II).
RESTITUIRE L’ANELLO DEL PESCATORE A GIUSEPPE (come già Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II).
Annuncio a Giuseppe
di Gianfranco Ravasi (Il Sole-24 Ore, 20 dicembre 2009)
La melodia di White Christmas può essere anche gradevole, ma il Natale nella sua genesi profonda non potrà mai essere "bianco" a livello etnico; eventualmente potrà esserlo solo a livello climatologico (ho anch’io in mente una Betlemme di molti anni fa tutta innevata). Fino a prova contraria, infatti, i protagonisti di quell’evento erano semiti e non certo ariani, la loro pelle era olivastra, i loro profili somatici erano simili a quelli degli arabi o degli israeliani nati nell’attuale Vicino Oriente.
Ebbene, all’interno di quella famiglia semita vorremmo ora mettere in primo piano colui che nella tradizione è rimasto quasi sempre sullo sfondo, sì, proprio il capofamiglia, Giuseppe, un nome chiaramente ebraico che significa «Dio aggiunga!» o «che egli raduni!». È un nome portato da altri sei personaggi biblici, tra i quali il più celebre è quel figlio di Giacobbe che fece fortuna in Egitto divenendo da schiavo viceré, così da trasformarsi secoli dopo nel protagonista del fluviale romanzo Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann.
La presenza del nostro Giuseppe, il padre legale e non naturale di Gesù, è nei Vangeli esile: affiora nella genealogia di Cristo; appare come il promesso sposo di Maria (Luca 1, 27), sarà menzionato durante la nascita di Gesù a Betlemme (Luca 2,4-5), farà qualche altra fugace apparizione nei primi giorni del neonato, acquisterà rilievo durante la vicenda di clandestino e migrante in Egitto, riemergerà dal silenzio anni dopo quando occhieggerà nelle parole di sua moglie, Maria, in occasione della "fuga" del figlio dodicenne nel tempio di Gerusalemme tra i dottori della Legge («tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo», Luca 2,48), e sarà ricordato con sarcasmo dai suoi concittadini di Nazaret, quando di fronte ai successi del figlio ironizzeranno: «Ma costui non è il figlio di Giuseppe..., il figlio del falegname?» (Luca 4, 22; Matteo 13, 55). Ci sono, però, due scene nelle quali Giuseppe è protagonista. Sono le uniche e riguardano proprio il Natale.
Rievochiamo la prima: è la cosiddetta «annunciazione a Giuseppe» ed è narrata dall’evangelista Matteo (1, 18-25). Leggiamo insieme: «Così fu generato Gesù Cristo: sua Madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta, per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: "Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi". Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù».
Per capire il comportamento iniziale di Giuseppe nei confronti di Maria, dobbiamo entrare, almeno sommariamente, nel mondo delle usanze matrimoniali dell’antico Israele. Il matrimonio comprendeva due fasi ben definite. La prima - denominata qiddushin, cioè «consacrazione», perché la donna veniva «consacrata» al suo sposo - consisteva nel fidanzamento ufficiale tra il giovane e la ragazza che solitamente aveva dodici o tredici anni.
La ratifica di questo primo atto comportava una nuova situazione per la donna: pur continuando a vivere a casa sua all’incirca per un altro anno, essa era chiamata e considerata già «moglie» del suo futuro marito e per questo ogni infedeltà era ritenuta un adulterio. La seconda fase era chiamata nissu’in (dal verbo nasa’, ossia «sollevare, portare») in quanto ricordava il trasferimento processionale della sposa che veniva «portata» nella casa dello sposo, un avvenimento che fa da sfondo alla parabola di Gesù che ha per protagoniste le ancelle di un festoso corteo nuziale notturno (si veda Matteo 25, 1-13). Questo atto suggellava la seconda e definitiva tappa del matrimonio ebraico. Il racconto che abbiamo letto sopra si colloca, allora, nella prima fase, quella del fidanzamento-«consacrazione»: «Prima che andassero a vivere insieme [col trasferimento alla casa di Giuseppe], Maria si trovò incinta».
Giuseppe è di fronte a una scelta drammatica. Il libro biblico del Deuteronomio era chiaro e implacabile: «Se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all’ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a morte, perché ha commesso un’infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre» (22, 20-21). Nel giudaismo successivo, però, aveva preso strada un’altra norma più moderata, quella che imponeva il ripudio. Come si è spiegato, trattandosi già di una vera e propria «moglie», si doveva celebrare un divorzio ufficiale con tutte le conseguenze civili e penali per la donna. È curioso ricordare che a Murabba’at, nei pressi del Mar Morto, è venuto alla luce anni fa un atto di ripudio del 111 d.C., scritto in aramaico e riguardante due sposi che si chiamavano Maria e Giuseppe.
Ma ritorniamo a Giuseppe e alla sua decisione. Egli deve «ripudiare» Maria a causa della legge che lo obbliga a questo; essendo uomo «giusto», cioè obbediente alla legge dei padri, egli si mette su questa strada amara, ma, essendo uomo «giusto», che secondo il linguaggio biblico significa anche mite, misericordioso, buono, lo vuole fare nella forma più delicata e più attenta per lo donna. Sceglie la via «segreta», senza denunzia legale, senza processo e clamore, alla presenza dei soli due testimoni necessari per la validità dell’atto di divorzio, cioè la consegna del cosiddetto «libello di ripudio». Certo, la nostra sensibilità ci fa subite dire: che ne sarebbe stato di Maria? La risposta è purtroppo chiara e inequivocabile: sarebbe stata un’emarginata totale, rifiutata da tutti, accolta forse solo dal clan paterno assieme al figlio illegittimo che avrebbe generato. È nota a tutti, infatti, la triste situazione della donna nell’antico Vicine Oriente. Ma lasciamo da parte questa ipotesi irreale e ritorniamo a Giuseppe e al suo dramma interiore, per altro non lontano da quello vissuto da tante coppie di fidanzati.
La sua oscura tensione è, all’improvviso, squarciata da una luce: l’angelo nella Bibbia è per eccellenza il segno di una rivelazione divina come il sogno (se ne contano cinque nel Vangelo dell’infanzia di Gesù secondo Matteo) è il simbolo della comunicazione di un mistero. «Non temere di portare Maria a casa tua», completando così anche la seconda fase del matrimonio (nissu’in), dice l’angelo a Giuseppe.
Ed è qui che scatta la grande rivelazione del mistero che si sta compiendo in Maria: «Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo». E questa la sorpresa straordinaria che dovrà sconvolgere la vita di Giuseppe, sorpresa molto più forte di quella di avere la propria donna incinta di un altro uomo. Si apre, allora, per Giuseppe una vita nuova e una missione unica. Egli, che è «figlio di Davide» (è l’unica volta nei Vangeli in cui questo titolo non viene applicato a Gesù), dovrà trasmettere la linea ereditaria davidica al figlio di Maria nella qualità di padre legale. Potremmo dire che, come Maria è colei per mezzo della quale Gesù nasce nel mondo come figlio di Dio, Giuseppe è colui per mezzo del quale Gesù nasce nella storia come figlio di Davide.
La paternità legale o «putativa» in Oriente era molto più normale di quanto possiamo immaginare. Esemplare è il caso del «levirato» (dal latino levir, cognato) così formulato nel Deuteronomio: «Quando uno dei fratelli di un clan morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto verrà presa in moglie dal cognato; il primogenito che essa metterà al mondo, andrà sotto il nome del fratello morto perché il nome di questi non si estingua in Israele» (25, 5-6). In altre parole, il padre reale di questo figlio è il cognato, ma il padre legale resta il defunto che attribuisce al neonato tutti i diritti ereditari.
Come padre ufficiale di Gesù, Giuseppe esercita il diritto di imporre il nome riconoscendolo giuridicamente.
Nella Bibbia il nome è il compendio simbolico di una persona, è la sua carta d’identità: perciò, anche se si hanno delle eccezioni (è Eva a chiamare «Set» il suo secondo figlio), è il padre a dichiarare il nome del figlio e Giuseppe sa già che per il figlio di Maria c’è un nome preparato da Dio. «Gesù» è l’equivalente di Giosuè, e a livello di etimologia popolare e immediata significa «Il Signore salva», come è spiegato dall’angelo: «Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Anche san Pietro in un suo discorso registrato dagli Atti degli Apostoli afferma: «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati» (4,12). A un’analisi più filologica «Gesù» significa letteralmente «Il Signore aiuta» o «Il Signore dà la vittoria», un senso abbastanza vicino a quello tradizionale.
Nella narrazione di Matteo c’è un ultimo dato da decifrare. È nella frase finale, quella della nascita di Gesù, che letteralmente suona così: «Giuseppe prese con sé la sua sposa e non la conobbe prima che gli partorisse il figlio». Sappiamo che nella Bibbia il verbo «conoscere» è un eufemismo per alludere all’atto matrimoniale. Sulla frase per secoli si è accesa un’aspra discussione teologica riguardante la verginità perpetua di Maria e la presenza nei Vangeli dei cosiddetti «fratelli e sorelle di Gesù». In realtà il testo di Matteo nel suo tenore originale non affronta la questione, dal momento che in italiano, quando si dice che una cosa non succede «fino a» un certo tempo, si suppone di solito che abbia luogo dopo: Giuseppe non ha avuto rapporti con Maria fino alla nascita di Gesù, ma in seguito avrebbe potuto averli. In greco, invece, e nelle lingue semitiche si vuole mettere l’accento solo su ciò che avviene fino alla scadenza del «finché»: Giuseppe non ebbe rapporti con Maria, eppure nacque Gesù. Il tema fondamentale è, perciò, quello della concezione verginale di Maria. Il Cristo non nasce né da seme umano né da volere della carne, ma solo per lo Spirito di Dio che opera in Maria vergine. Corretta è allora la traduzione che ci propone la Bibbia ufficiale italiana da noi sopra adottata e che risuonerà anche nella liturgia natalizia: «Senza che Giuseppe la conoscesse, Maria partorì un figlio».
Parlavamo prima di due scene in cui Giuseppe è protagonista. Alla seconda - che abbiamo già avuto occasione di presentare in passato proprio su queste pagine - dedichiamo solo un cenno. La famiglia di Gesù si iscrive subito nel lungo elenco che giunge fino ai nostri giorni e che comprende i profughi, i clandestini, i migranti. Ecco, infatti, quando il bambino Gesù ha pochi mesi, Giuseppe in marcia con lui e con la sposa Maria attraverso il deserto di Giuda per riparare in Egitto, lontano dall’incubo del potere sanguinario del re Erode. Anche in questo caso siamo proprio agli antipodi di quel «Natale bianco» assurdamente prospettato da certe attuali ignoranze religiose e da isterie xenofobe. Il Natale cristiano ha, in verità, per protagonisti una famiglia di fuggiaschi e migranti con la loro storia di sventure. «Il cristianesimo - scriveva nei suoi quaderni il filosofo Wittgenstein - non è una dottrina, non è una teoria di ciò che è stato e sarà nell’anima umana, ma la descrizione di un evento reale nella vita dell’uomo».
Vorremmo, allora, far risuonare a suggello di questo «Natale di Giuseppe» le parole - forse un po’ oratorie e magniloquenti ma dalla sostanza inequivocabile - di uno scrittore "scandaloso" come Curzio Malaparte che in un articolo del Natale 1954 ammoniva: «Tra pochi giorni è Natale e già gli uomini si preparano alla suprema ipocrisia... Vorrei che il giorno di Natale il panettone diventasse carne dolente sotto il nostro coltello e il vino diventasse sangue e avessimo tutti per un istante l’orrore del mondo in bocca... Vorrei che la notte di Natale in tutte le chiese del mondo un povero prete si levasse gridando: Via da quella culla, ipocriti, bugiardi, andate a casa vostra a piangere sulle culle dei vostri figli. Se il mondo soffre è anche per colpa vostra, che non osate difendere la giustizia e la bontà e avete paura di essere cristiani fino in fondo. Via da questa culla, ipocriti! Questo bambino, che è nato per salvare il mondo, ha orrore di voi!».
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- Non crediamo al grigiore. Viviamo davvero (di Gianfranco Ravasi).2 gennaio 2010, di Federico La Sala
Non crediamo al grigiore. Viviamo davvero
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, 2 gennaio 2010)
È , questo, l’editoriale più difficile da scrivere, collocato com’è su un crinale da cui si diramano gli orizzonti di due anni. Da un lato, ci si affaccia sulla valle dei giorni ormai finiti, non di rado archiviati col timbro del pessimismo, quasi fossimo sempre in presenza di un annus horribilis.
L’ironico ’Dizionario del diavolo’ dell’americano Ambrose Bierce non aveva esitazioni. Alla voce ’Anno’ recitava: «Periodo fatto di 365 delusioni». D’altro lato, si allarga la pianura dei giorni futuri sui quali cade, invece, la retorica degli auguri che spargono ottimismo e certezza di felicità e prosperità. Su questo crinale mi avventuro anch’io per condividere, però, coi lettori solo poche e semplici riflessioni. Lo spunto della prima me lo offre un cantautore che tutti conoscono, Claudio Baglioni: «A volte più che di un mondo nuovo, c’è bisogno di occhi nuovi per guardare il mondo».
Siamo spesso afflitti da una sorta di daltonismo spirituale; il nostro sguardo non è più abilitato a cogliere la ricchezza dei colori; indossiamo lenti scure che ci mostrano solo l’ombra della storia, immaginandola soltanto sotto il segno del male, della perversione, della negazione. Ignoriamo che, accanto all’egoismo, all’indifferenza e alla vacuità di molti, c’è una folla di persone che si dedicano silenziosamente ai miseri della terra, attraverso un volontariato sempre più generoso. Ci sono chiese e comunità che assumono anche su di sé il carico della crisi che attanaglia tante famiglie. È quel bene - come ha detto Benedetto XVI - sul quale non si puntano mai i riflettori dell’informazione.
C’è un altro pensiero che vorrei condividere coi lettori di Avvenire. Essi hanno ragione di indignarsi nei confronti della corruzione pubblica e privata che anche lo scorso anno si è ben attestata sulla scena mediatica, oppure di sbuffare davanti a una politica così litigiosa e inconcludente.
Certo, speriamo che un ritorno di saggezza si manifesti e si insedi nei palazzi del potere politico ed economico, anche sulla base degli appelli del presidente della Repubblica, di tanti pastori e persone stimate e oneste. C’è, però, un’ulteriore necessità primaria che riguarda quello che potremmo chiamare il ritmo del respiro della vita sociale. «Per compiere grandi passi, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo pianificare, ma anche credere». Era lo scrittore Anatole France a suggerirlo nell’Ottocento, ma l’idea è forse più adatta alla situazione odierna in cui un po’ tutti - e non solo i governanti o i protagonisti della vita pubblica - ci siamo assuefatti al piccolo cabotaggio, all’interesse privato, al vantaggio e alla sicurezza personale o di gruppo. Clint Eastwood in un suo film aveva questa battuta ironica: «Se vuoi una garanzia a tutti i costi, allora comprati un tostapane!».
Nella scuola, nella famiglia e talora persino nella religione ci si accontenta sempre più del minimo comun denominatore. Sappiamo, però, che quando ci si abitua alle piccole cose, si diventa incapaci delle grandi. Ecco, infatti, l’incombere dei luoghi comuni, il rinchiudersi a riccio nella propria cerchia, il timore per gli orizzonti vasti che si aprono, l’assenza degli ideali, la caduta della ricerca della verità e dei valori permanenti. Per essere veramente uomini e donne bisogna coltivare sempre un sogno, un progetto, una fede, non rassegnandosi alla banalità, alla bruttezza, al grigiore, alla sopravvivenza. La stessa cura del creato, generatrice di un’armonia serena, a cui ci ha rimandato ieri il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della pace, partecipa di questo respiro più alto.
Giungiamo, così, a un’ultima riflessione un po’ scontata. Ogni nuovo anno è una porzione di tempo che ci è offerta. E proprio perché il tempo non è ’infinito’ come l’eternità, ha in sé la stimmata della fine e, diciamolo pure (anche se questa parola è oggi esorcizzata), può avere in sé anche la morte. L’augurio che, allora, vogliamo proporre a noi e a tutti è quello che ci ha lasciato un grande pensatore come il cardinal Newman: «Non aver paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che non cominci mai davvero».
-
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? --- il discorso pronunciato ieri dal Papa durante l’udienza ai partecipanti all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio «Cor Unum».14 novembre 2009, di Federico La Sala
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!_________________________________________________________________
Benedetto XVI
«Dal Vangelo l’impegno per la giustizia»
 «Anche nelle società più evolute dal punto di vista sociale, la caritas resta necessaria: il servizio dell’amore non diventa mai superfluo»
«Anche nelle società più evolute dal punto di vista sociale, la caritas resta necessaria: il servizio dell’amore non diventa mai superfluo»Pubblichiamo il discorso pronunciato ieri dal Papa durante l’udienza ai partecipanti all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio «Cor Unum». *
Signori cardinali, venerati fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, sono lieto di salutare ciascuno di voi, membri, consultori e officiali del Pontificio Consiglio « Cor Unum» , qui convenuti per l’Assemblea plenaria, durante la quale viene affrontato il tema «Percorsi formativi per gli operatori della carità». Saluto il cardinale Paul Josef Cordes, presidente del dicastero, e lo ringrazio per le cortesi parole che mi ha rivolto anche a nome vostro. A tutti esprimo la mia riconoscenza per il prezioso servizio che offrite all’attività caritativa della Chiesa. Il mio pensiero, in modo speciale, si rivolge ai numerosi fedeli che, a vario titolo e in ogni parte del mondo, fanno dono, con generosità e dedizione, del loro tempo e delle loro energie per testimoniare l’amore di Cristo, Buon Samaritano, che si china sui bisognosi nel corpo e nello spirito. Poiché, come ho sottolineato nell’enciclica Deus caritas est, «l’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia)» ( cfr n. 25), la carità appartiene alla natura stessa della Chiesa.
Operando in questo ambito della vita ecclesiale, voi svolgete una missione che si colloca in una tensione costante tra due poli: l’annuncio del Vangelo e l’attenzione al cuore dell’uomo e all’ambiente in cui egli vive. Quest’anno due speciali eventi ecclesiali hanno messo in risalto tale aspetto: la pubblicazione dell’enciclica Caritas in veritate e la celebrazione dell’Assemblea speciale per l’Africa del Sinodo dei vescovi sulla riconciliazione, la giustizia e la pace. In prospettive diverse ma convergenti, essi hanno evidenziato come la Chiesa, nel suo annuncio salvifico, non possa prescindere dalle condizioni concrete di vita degli uomini, ai quali è inviata. L’agire per migliorarle concerne la sua stessa vita e la sua missione, poiché la salvezza di Cristo è integrale e riguarda l’uomo in tutte le sue dimensioni: fisica, spirituale, sociale e culturale, terrena e celeste.
Proprio da questa consapevolezza sono nate, nel corso dei secoli, molte opere e strutture ecclesiali finalizzate alla promozione delle persone e dei popoli, che hanno dato e continuano a offrire un contributo insostituibile per la crescita, lo sviluppo armonico e integrale dell’essere umano. Come ho ribadito nell’enciclica Caritas in veritate, «la testimonianza della carità di Cristo attraverso opere di giustizia, pace e sviluppo fa parte della evangelizzazione, perché a Gesù Cristo, che ci ama, sta a cuore tutto l’uomo»(n. 15).
In questa ottica va considerato l’impegno della Chiesa per lo sviluppo di una società più giusta, nella quale siano riconosciuti e rispettati tutti i diritti degli individui e dei popoli ( cfr ibid ., 6). Molti fedeli laici, al riguardo, svolgono una proficua azione nel campo economico, sociale, legislativo e culturale, e promuovono il bene comune. Essi testimoniano il Vangelo, contribuendo a costruire un giusto ordine nella società e partecipando in prima persona alla vita pubblica (cfr Deus caritas est, 28). Non compete certo alla Chiesa intervenire direttamente nella politica degli Stati o nella costruzione di strutture politiche adeguate (cfr n. 9). La Chiesa con l’annuncio del Vangelo apre il cuore per Dio e per il prossimo, e sveglia le coscienze. Con la forza del suo annuncio difende i veri diritti umani e si impegna per la giustizia. La fede è una forza spirituale che purifica la ragione nella ricerca di un ordine giusto, liberandola dal rischio sempre presente di venire « abbagliata » dall’egoismo, dall’interesse e dal potere.
In verità, come l’esperienza dimostra, anche nelle società più evolute dal punto di vista sociale, la caritas resta necessaria: il servizio dell’amore non diventa mai superfluo, non solo perché l’anima umana ha sempre bisogno, oltre che delle cose materiali, dell’amore, ma anche perché permangono situazioni di sofferenza, di solitudine, di necessità, che richiedono dedizione personale ed aiuti concreti. Quando offre amorevole attenzione all’uomo, la Chiesa sente pulsare in se stessa la pienezza di amore suscitata dallo Spirito Santo, il quale, mentre aiuta l’uomo a liberarsi dalle oppressioni materiali, assicura ristoro e sostegno all’anima, liberandola dai mali che l’affliggono. Sorgente di questo amore è Dio stesso, infinita misericordia ed amore eterno. Chiunque, pertanto, presta il suo servizio all’interno degli organismi ecclesiali che gestiscono iniziative e opere di carità, non può che avere questo precipuo obbiettivo: far conoscere e sperimentare il volto misericordioso del Padre celeste, poiché nel cuore di Dio Amore c’è la risposta vera alle attese più intime di ogni cuore umano.
Quanto è necessario per i cristiani mantenere fisso lo sguardo sul volto di Cristo! Solo in Lui, pienamente Dio e pienamente uomo, possiamo contemplare il Padre ( cfr Gv 14,9) e sperimentarne l’infinita misericordia! I cristiani sanno di essere chiamati a servire e ad amare il mondo, pur senza essere « del mondo » ( cfr Gv 15,19); a portare una Parola di salvezza integrale dell’uomo, che non si può racchiudere nell’orizzonte terreno; a rimanere - come Cristo - totalmente fedeli alla volontà del Padre fino al dono supremo di se stessi, per percepire più facilmente quel bisogno di vero amore che c’è in ogni cuore. Ecco dunque il cammino che deve percorrere, se vuole seguire la logica del Vangelo, chiunque voglia testimoniare la carità di Cristo.
Cari amici, è importante che la Chiesa, inserita nelle vicende della storia e della vita degli uomini, si faccia canale della bontà e dell’amore di Dio. Così sia per voi e per quanti operano nel vasto ambito di cui si occupa il vostro Pontificio Consiglio! Con tale auspicio, invoco la materna intercessione di Maria sui vostri lavori e, mentre rinnovo il mio ringraziamento per la vostra presenza e per l’opera che svolgete, ben volentieri imparto a ciascuno di voi e alle vostre famiglie la mia apostolica benedizione.
* Avvenire, 14.11.2009
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- il Papa della Deus caritas est e della Caritas in veritate ... e la parabola del cattolicesimo-romano (di Bruno Forte - La parabola dell’umanesimo ateo)19 agosto 2009, di Federico La Sala
 Una riflessione del teologo Bruno Forte
Una riflessione del teologo Bruno Forte La parabola dell’umanesimo ateo
La parabola dell’umanesimo ateoÈ possibile un’etica che non faccia riferimento a Dio? E allora come si spiega l’esigenza di fare il bene ed evitare il male?
 DI BRUNO FORTE (Avvenire, 19.08.2009) *
DI BRUNO FORTE (Avvenire, 19.08.2009) *Nel dibattito accesosi in questi giorni sulla stampa intorno al concetto di nichilismo e di umanesimo ateo, a partire dalla frase pronunciata da Benedetto XVI nell’Angelus del 9 agosto riguardo ai «lager nazisti, simboli estremi del male, come il nichilismo contemporaneo», vorrei inserirmi concentrandomi su un’unica domanda, quella che dal punto di vista delle conseguenze pratiche mi appare la più decisiva: è possibile un’etica senza Trascendenza? Può esserci un codice morale normativo e condiviso senza il riferimento a Dio, all’«ultimo Dio»? Se sì, dove fondare l’esigenza assoluta di fare il bene e di evitare il male, dal momento che non esisterebbe alcun assoluto a cui ancorarla? O il bene si giustifica da sé e si impone con un’evidenza tale da non richiedere ulteriori motivazioni? E il male? È anch’esso così evidente da non supporre alcun imperativo categorico, rispetto a cui porsi come controcanto, negazione ostinata e perfino beffarda del «cosiddetto bene»? Miriadi di voci in secoli di storia hanno risposto a queste domande in una stessa direzione: il bene c’è ed è assoluto; esso si identifica anzi con l’Assoluto stesso, di cui è il volto attraente, lo splendore irradiante, l’esigenza amabile, il dono perfetto. Il male è la resistenza opposta a questo richiamo, l’appassionato permanere nella negazione, la lotta vissuta in nome di una causa falsa, quella della propria libertà eretta come assoluto contro l’Assoluto. Fra il male e il bene la scelta non sarebbe allora che una: con Dio o contro Dio; per l’Assoluto o per le onnivore fauci del nulla. Dall’ethos classico, alla morale delle Dieci Parole, legate al Grande Codice dell’alleanza con il Dio biblico, dal discorso della montagna alle esigenze di giustizia del diritto romano, è quest’impianto di una morale fondata nella trascendenza che ha retto le sorti della vita personale e collettiva dell’Occidente.
È con l’emergere moderno del valore centrale della soggettività che cambiano anche i termini del problema: dall’eteronomia - in cui si vorrebbe costringere tutto il complesso accennato di un’etica dalla fondazione oggettiva ed assoluta - si intende uscire per passare al mondo dell’autonomia, verso i pascoli di una vita morale emancipata, dove il coraggio di esistere autonomamente sia esteso dal conoscitivo «sapere aude!» - «osa sapere!» al decisionistico «libere age!» - «agisci secondo il codice di un’assoluta libertà!» L’autonomia appare come la sfida irrinunciabile su cui misurare qualsivoglia imperativo morale, per verificare se esso renda più o meno liberi, più o meno umani. Farsi norma a se stessi, essere soggetto e non oggetto del proprio destino, questo appare il progetto da perseguire. L’ebbrezza di questo sogno contagia gli spiriti più diversi, in forme borghesi o rivoluzionarie, di progresso o di conservazione, di freddo calcolo o di passioni emotive. Ben presto, tuttavia, la coscienza dell’impossibilità di un’etica tutta soggettiva si impone alla riflessione dei moderni: che bene sarebbe il bene che fosse tale solo per me? E in nome di quale criterio valido per tutti sarebbe da evitare il male? Non è il confine fra la mia libertà e l’altrui anche il limite di ogni autonomia? E perché se una scelta mi risultasse più vantaggiosa - in termini morali o economici o politici - dovrei seguire un criterio diverso dal semplice profitto e agire in maniera differente?
Se poi un comportamento scorretto è diffuso - giustificato dal «tutti lo fanno!» - in nome di quale valore morale dovrei evitarlo, se la scelta è lasciata all’arbitrio personale? È a partire dal crogiuolo di queste domande - quelle di una modernità ferita, insoddisfatta del passato e inquieta di sé - che si profila come tema veramente urgente quello della fondazione dell’etica, in un’epoca in cui il passaggio dal fenomeno al fondamento appare tanto necessario, quanto spesso evaso. Oltre il tramonto delle pretese assolute di una certa modernità e l’incompiutezza del nichilismo della post-modernità debolista, ritorna in tutta la sua forza il bisogno di un’etica della trascendenza, mancando la quale tutto è permesso. Quattro tesi potranno aiutare a coglierne il senso, che a mio avviso chiarisce e motiva nella maniera più adeguata le parole del Papa. Formulerei così la prima tesi:
non c’è etica senza trascendenza.
Non può esserci agire morale, lì dove non ci sia l’altro, riconosciuto in tutto lo spessore irriducibile della sua alterità. La fondazione dell’etica è inseparabile da questo riconoscimento: chi afferma se stesso al punto da negare consapevolmente o di fatto ogni altro su cui misurarsi, nell’atto stesso di questa affermazione sazia, idolatrica, nega se stesso come soggetto morale, nega anzi la possibilità stessa di una scelta eti- ca fra bene e male, perché annega ogni differenza nell’oceano asfissiante della propria identità. Nessun uomo è un’isola: e chi pensasse o volesse essere tale, nell’atto stesso di pensarsi o volersi così annullerebbe se stesso come soggetto di relazione, e perciò di vita e di storia reale. La negazione dell’altro è negazione di sé; fare dell’altro lo «straniero morale» è farsi stranieri alla verità di se stessi, è rinnegare la più profonda dignità del proprio essere personale e del proprio destino. Non c’è responsabilità e vita morale senza un movimento di esodo da sé per andare verso l’altro, soprattutto se debole, indifeso e senza voce o capacità di far valere i propri diritti. A questa prima tesi si congiunge direttamente la seconda:
non c’è etica senza gratuità e responsabilità.
Questa seconda tesi ricorda come ogni movimento di trascendenza ha un carattere gratuito e potenzialmente infinito: uscire da sé in vista di un ritorno, calcolare con l’altro al fine di un proprio interesse è svuotare di ogni valore la scelta morale, facendone semplicemente un commercio o uno scambio tra pari. Qui la lezione di Kant conserva tutta la sua verità: l’imperativo morale o è categorico, e dunque incondizionato, o non è. O il destinarsi ad altri è un atto gratuito e senza condizioni, da null’altro motivato che dall’esigenza e dall’indigenza dell’altro - «exode de soi sans retour», direbbe Lévinas - , o non è auto-trascendenza, ma riflesso, proiezione di sé fuori di sé in vista dell’egoistico ritorno a sé. In questo carattere gratuito e potenzialmente infinito della trascendenza morale si coglie come l’anima più profonda di essa sia l’amore, il dare senza calcolo e senza misura per la sola forza irradiante del dono. Il bene è ragione a se stesso!
La terza tesi dilata la seconda alle forme dell’oggettività sociale e comunitaria:
non c’è etica senza solidarietà e giustizia.
È nello stesso movimento di auto-trascendenza che si scopre la rete degli altri che circonda l’io come sorgente di un insieme complesso di esigenze etiche: contemperarle in modo che il dono compiuto all’uno non sia ferita o chiusura ad altri è coniugare la morale con la giustizia. Regolare in forma collettiva questa rete di esigenze è misurarsi sul bisogno del diritto: non l’astratta oggettività della norma, né il dispotismo del sovrano fonda l’autorità della legge, ma l’urgenza di contemperare le relazioni etiche perché nessuna sia a vantaggio esclusivo di alcuni e a scapito della dignità di altri. L’etica della solidarietà integra qui la sola etica della responsabilità, strappandola al rischio sempre incombente di un suo stemperarsi nell’assolutismo infecondo della sola intenzione. Il bene comune è misura e norma dell’agire individuale, specialmente nel campo dei doveri civili. Infine, quando si riconosce che il movimento di trascendenza verso l’altro e la rete d’altri in cui siamo posti presentano un carattere di esigenza infinita, sull’orizzonte dell’etica si profila un’altra trascendenza, ultima e nascosta, di cui quella prossima e penultima è traccia e rinvio:
l’etica rimanda alla trascendenza libera e sovrana, ultima e assoluta.
Nel volto d’altri è l’imperativo categorico dell’amore assoluto che mi raggiunge, e nell’assolutezza dell’urgenza della solidarietà con il più debole è un amore infinitamente indigente che mi chiama. Questa trascendenza assoluta, questo assoluto bisogno d’amore sono la soglia che salda l’etica filosofica all’etica teologica: qui l’etica della responsabilità e l’etica della solidarietà appellano all’etica del dono, alla morale della Grazia. Qui l’amore - sovrana esigenza morale - rimanda all’Amore come eterno evento interpersonale dell’unico Dio. Qui, nelle forme dell’essere l’uno- per-l’altro, è il possibile impossibile amore, gratuitamente donato dall’alto, che viene a narrarsi nel tempo: la carità, che «non avrà mai fine» (1 Cor 13,8). Su di essa si misurerà la verità profonda delle nostre scelte: alla sera della vita saremo giudicati sull’amore! Si comprende così come il Papa della Deus caritas est e della Caritas in veritate sia la chiave interpretativa più autentica e illuminante della frase pronunciata all’Angelus del 9 agosto scorso. «Dalle Dieci Parole all’ethos classico e cristiano: l’impianto di una morale fondata nella trascendenza ha retto l’Occidente»
* IL DIBATTITO
Lager e nichilismo, le parole del Papa fanno discutere
Le parole pronunciate da Benedetto XVI all’Angelus del 9 agosto hanno suscitato un dibattito animato sulla stampa italiana. Emanuele Severino sul «Corriere della Sera» e Adriano Sofri su «Repubblica» hanno criticato l’espressione del Papa riguardo ai «lager nazisti, simboli estremi del male, come il nichilismo contemporaneo». A loro ha poi risposto Giovanni Reale su «Liberal»: «Non hanno capito il nichilismo. Non hanno compreso la terribile annunciazione fatta da Nietzsche, il filosofo per eccellenza del nichilismo: la morte di Dio, la trasmutazione di tutti i valori, la fedeltà alla terra come unico principio di realtà». Infine ancora su «Repubblica»,Vito Mancuso pur prendendo le distanze dall’espressione di Ratzinger su lager e nichilismo, ha condiviso la critica all’antropocentrismo moderno e l’impossibilità di un’etica senza trascendenza. Su questo tema pubblichiamo in questa pagina una riflessione di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto.
-
> MONSIGNOR RAVASI, MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? ---- Il vero, il bene ... "il bello non ha etichette né religione (di Alain Elkan)23 novembre 2009, di Federico La Sala
Il bello non ha etichette né religione
di Alain Elkann (La Stampa, 23 novembre 2009)
Caro direttore,
ho letto l’articolo «Noi artisti davanti al Pontefice» pubblicato da La Stampa domenica 22 novembre 2009 a firma Ferdinando Camon. Vorrei dire all’autore che ho trovato nel racconto della cerimonia in certi punti una licenza poetica scherzosa e ironica che faceva assomigliare la solenne giornata di ieri a una sfilata di moda. Io non mi sarei mai permesso di scrivere tali cose data la solennità e la simbologia di tale giornata viste le personalità presenti e la sacralità del luogo prescelto da Benedetto XVI: la Cappella Sistina.
Avrei scritto che ringraziavo Monsignor Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, per aver organizzato con i suoi collaboratori un evento così significativo.
Voglio ringraziare il Santo Padre per aver scelto un luogo così importante, un’icona così unica per coniugare la bellezza - su cui era incentrato il discorso del Pontefice -, la religione, la spiritualità, il talento e la Chiesa, visto che nella medesima Cappella Sistina, come ha ricordato Benedetto XVI con commozione, si tengono i conclavi e proprio lì in quel luogo Lui è stato eletto al Soglio di Pietro. Devo dire che pareva strano vedere arrivare in quella Cappella così famosa architetti, poeti, pensatori, cantanti, cantautori, registi, romanzieri che si stupivano di vedersi lì laici, cristiani, buddisti, ebrei e musulmani credenti e non credenti ma tutti in attesa del Papa. Tutti curiosi di sapere o di provare a capire con quali criteri il Vaticano avesse scelto proprio loro per presentare il mondo dell’arte e della cultura. Il regista Maselli parlando del Papa e del perché era venuto e del perché aveva accettato quell’invito, ha detto: «Comunque non capita ogni giorno di essere invitato da un Capo di Stato».
A un certo punto ci è stato chiesto in italiano e in inglese di spegnere i nostri cellulari, di stare in silenzio, in raccoglimento ad attendere il Padre. Quel silenzio rispettoso dell’attesa era bello perché metteva tutti ad un livello di parità e di rispetto verso il Papa e il suo atteso discorso, poi quando è arrivato c’è stato un applauso e quando ha finito di parlare ce n’è stato un altro lunghissimo che confermava l’ampio consenso verso le parole del Pontefice ma soprattutto verso quell’iniziativa.
Nell’ultima parte dell’articolo di Camon ho letto, a dir poco con stupore, certi propositi tra l’altro accomunando nomi di persone che conosco bene e che so avere pensieri ben diversi, mi riferisco all’amico Lorenzo Mondo, biografo di Pavese e all’amico Ernesto Ferrero, biografo di Primo Levi. C’era scritto: «Sarebbe bello che gli artisti del mondo si ritrovassero ogni 10 anni qui nella Cappella Sistina, ma due giorni, uno ad ascoltare il Papa e uno a confrontarsi tra loro». Sarebbe meglio se fossero solo artisti cristiani (Mondo corregge di area cristiana).
Non credo che persone quali Zaha Hadid, Arnoldo Foà, Daniel Libeskind (architetto che ha realizzato il Museo dell’Olocausto di Berlino) o altri siano stati invitati lì per caso e se ricordo bene nel discorso il Papa si è rivolto a «Cari e illustri artisti, appartenenti a Paesi, culture e religione diverse, forse anche lontani da esperienze religiose, ma desiderosi di mantenere viva una comunicazione con la Chiesa Cattolica...».
Io credo di essere stato invitato in quella giornata in quanto scrittore di lingua italiana, ebreo che ha sempre lavorato per il dialogo interreligioso. Allora quando si legge «solo artisti cristiani» mi viene un brivido «non piacevole» e mi accorgo con tutto il rispetto che abbiamo interpretato in modo assai diverso una grande giornata alla quale sono grato e orgoglioso di aver partecipato con tanti uomini e donne di talento, tutti accomunati, dovunque fossero seduti, innanzitutto uguali, assolutamente uguali, in quella Cappella Sistina che Michelangelo e altri grandi maestri come Perugino, il Ghirlandaio, il Botticelli hanno saputo elevare a capolavoro assoluto dell’arte e patrimonio comune dell’umanità al di sopra di qualsiasi razza o religione.
Ieri nella Cappella Sistina e poi nei lunghi corridoi e nei saloni di Palazzo Vaticano ho sentito che si respirava un clima di soddisfazione, di consenso. La Chiesa aveva deciso in modo solenne dicendo: noi abbiamo bisogno di voi, di gratificare l’arte e gli artisti e questo dal Papa ai Cardinali ai Vescovi fino alle Guardie Svizzere che battevano i tacchi e facevano il saluto al poeta Conte, al poeta Rondoni, all’architetto Botta, allo scrittore Raffaele La Capria e molti altri. L’arte in quel sabato 21 novembre in Vaticano ha ritrovato il suo posto e anche il rispetto dovuto. Si capiva bene che tre grandi Pontefici quali Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in un filo rosso sottile che li univa sentivano che gli artisti nella storia spirituale della Chiesa avevano un ruolo centrale. Del resto l’ispirazione di un artista e la fede sono cose tra loro molto molto vicine. Ma la vera lezione che ho tratto dalla giornata di ieri nella Cappella Sistina è che il bello non ha etichette perché è soltanto bello.
-
> MONSIGNOR RAVASI .... dice sì al film di Moretti sul pontefice che va in analisi (di Gian Guido Vecchi)23 novembre 2009, di Federico La Sala
Fuori programma
Monsignor Ravasi dice sì al film di Moretti sul pontefice che va in analisi
di Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 22.11.09)
CITTÀ DEL VATICANO - Sarà la suggestione, il fatto di sapere che sta preparando un film sulla storia d’un Papa depresso che si rivolge a uno psicanalista - titolo di lavorazione: Habemus Papam - ma quando Nanni Moretti entra nella Sistina, si siede in una fila di mezzo e fissa sugli affreschi e sul pontefice lo sguardo serio, intento e un po’ nevrotico del suo vecchio alter ego Michele Apicella, dà quasi l’impressione d’essere arrivato lì per un sopralluogo. Che abbia preso molto sul serio il suo compito, con buon pace di chi già s’aspetta una commedia «irriverente» o una banale provocazione, lo dimostra del resto il giudizio benevolo e la rivelazione di monsignor Gianfranco Ravasi: «Negli ultimi tempi ci siamo sentiti e visti, Nanni Moretti mi ha fatto leggere la sceneggiatura: un’idea interessante, che non si sofferma sul tema del ’potere’ ma cerca una visione psicologica...».
Quando gli artisti, alla fine, sfilano davanti a Ravasi per ricevere la medaglia commemorativa, è il regista romano, sorridente, a parlare più a lungo con l’arcivescovo. Poi s’allontana, alza la mano davanti ai giornalisti come a dire «non parlo» e sparisce dalla circolazione. Certo è interessante che lui, così riservato sul suo lavoro, desiderasse far conoscere il contenuto del prossimo film al «ministro» vaticano per la cultura. Ma non c’era chi già s’aspettava uno «scandalo » o qualcosa del genere? «Qualcuno magari lo vedrà come una provocazione, vedremo come sarà il film, ma dalla sceneggiatura non mi pare il caso», sorride monsignor Ravasi. «Il testo vuole analizzare la figura di un Papa come persona. È la storia di un uomo che si sente incapace d’essere all’altezza della missione che gli è stata data.
E non c’è polemica, malanimo verso il presunto ’potere’, la sua crisi nasce anzi dallo splendore, dalla grandezza del compito che gli hanno affidato. Tant’è vero che alla fine il Papa chiede di pregare per lui». Viene in mente La messa è finita , le parole di don Giulio davanti alla madre che s’è uccisa: «Ero felice quando uscivo con te, mi sentivo al sicuro da piccolo perché sapevo che c’eri tu. È bello essere bambini, non avere responsabilità, nessuno che ti chiede niente». Soprattutto viene in mente il proposito di «rinnovare l’amicizia della Chiesa con il mondo dell’arte» appena detto da Benedetto XVI. «Adesso si tratta di continuare, la prossima meta sarà la Biennale di Venezia 2011: la Santa Sede, per la prima volta, sarà presente con un proprio padiglione», conferma monsignor Ravasi. E spiega: «Vorrei rivolgermi a sette-otto artisti di altissimo livello e di tutto il mondo, a cominciare dall’Africa. E dare loro come spunto i primi undici capitoli della Genesi, non tanto per rappresentarli ma perché lì si trovano già tutti i temi fondamentali: la creazione, il male, la coppia, l’amore, la violenza familiare e sociale, le decreazione e la rovina - quindi l’ecologia, il diluvio! -, l’oppressione imperialistica di Babele e così via. Così avranno un testo di riferimento, non dei simboli che possono diventare una cosa new age...».
L’importante è proseguire il dialogo e allargare gli orizzonti. «Avevano chiesto di partecipare anche i rappresentanti della moda», allarga le braccia l’arcivescovo. «Si potrà fare un passo verso di loro, magari facendo in modo di strappare l’orizzonte della moda dalla pura provocazione, l’autoreferenzialità, l’esercizio stilistico fine a se stesso, verso una vera rappresentazione artistica: anche i vestiti lo possono essere, pensi all’arte liturgica...».
-
-


