
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
Della Terra, il brillante colore
2013, nov 27*
Della Terra, il brillante colore
Il libro di Federico La Sala offre un punto di vista raro. Quello di un pensiero maschile che osserva e riflette e su alcuni pilastri del pensero filosofico occidentale in modo non neutro ma a partire dal riconoscimento della propria parzialità - di individuo e di genere.
Il libro si compone di più saggi che affondano nel profondo delle nostre radici culturali come “carotaggi” a campione. La sensazione all’inizio spaesante di saltare da un frammento all’altro in campi diversi del sapere e in momenti diversi della storia è ricomposta nel filo conduttore che pian piano si manifesta. Più che un filo conduttore teorico, la tensione etica, intellettuale, di cuore, di un essere umano in ricerca.
Nella prima parte del testo l’autore si spinge in regioni dove la religione cattolica si intreccia con la tradizione ermetica. Incontriamo Ermete Trismegisto e la grande stagione Rinascimentale poi affogata nel rigore censorio della Controriforma. Incontriamo diverse manifestazioni delle Sibille, qui visibili nella riproduzione di xilografie di Filippo Barberi (1481) - una versione inedita. Percorsi incrociati tra Kabbalah, carmelitani e profeti islamici.
Sembra di navigare su un fiume sotterraneo che congiunge Oriente e Occidente. Così arriviamo alle note su Parmenide, Freud, Kant, Rousseau - tra gli altri. L’autore offre spunti e visioni prendendoli da un bagaglio di conoscenze che spazia dalla storia della religione alla filosofia alla psicoanalisi. Si alternano luce solare e lunare. Tra le tante le citazioni, il ritmo conciso e il gesto schietto, senza pose accademiche, rendono la lettura scorrevole. Nella pennellata di Fulvio Papi nell’introduzione, sulla spinta della lettura di questo “testo in piena”:
La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: “guardiamo il nostro ombelico”, riconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire e non i luoghi delle nostre scissioni.
- Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barberi (1481) e la domanda antropologica di Federico La Sala, Edizioni Nuove Scritture, Milano, 2013, 156 p.,15€.
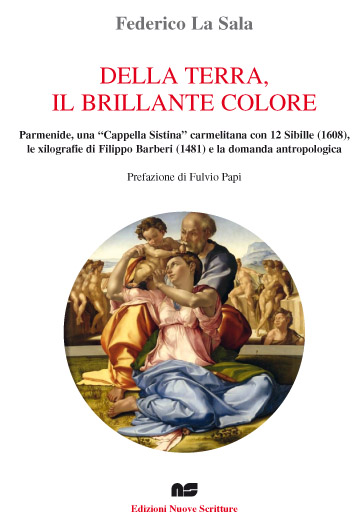
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE...
PREFAZIONE
di Fulvio Papi
Con una immagine non inappropriata, si potrebbe dire che questo libro è una breve composizione sinfonica dove l’autore preleva temi dalla tradizione musicale che orchestra come preludi indispensabili all’apparizione del proprio tema. Nella dimensione letteraria si può dire che è un libro di citazioni dove anche la scrittura dell’autore vi compare come citazione che, più che dire, annuncia. L’insieme, ovviamente, non ha 1e tracce dell’esposizione legale e paterna, ma cerca la risonanza e la suggestione che il lettore deve accogliere come parola che tenta quasi una religiosa seduzione. Tutto questo è conseguenza coerente di una delle possibili strade che si possono prendere dopo il sospetto intorno alle architetture filosofiche che rappresentano con la spada tagliente del concetto una qualsiasi forma dell’essere.
Nel caso di La Sala il pensiero (e questo è il tema saliente del suo lavoro precedente, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica [Antonio Pellicani Editore, Roma 1991]), non deve istituire il giudizio come conseguenza della trasfigurazione simbolica del mondo, ma accogliere nel profondo 1a dimensione terrestre e sensibile della vita. Una voce, avevo pensato leggendo quel libro, che viene da un Nietzsche senza la volontà di potenza, declinato su quel "femminile" che è stato uno degli elementi di riflessione su un "vuoto" strutturale della nostfa tradizione.
E ora, in breve, qualche cenno sul nuovo viaggio testuale. Il luogo di inizio è nella chiesetta di S. Maria del Carmine, a Contursi, dove, a causa di recenti restauri, viene scoperto un poema pittorico (tempera su muro) di un ignoto carmelitano dell’inizio del ‘600. Il testo raffigura le Sibille che annunciano al mondo pagano la prossima nascita del cristianesimo.
Le Sibille di Contursi hanno parentele più celebri nella Cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel Tempio Malatestiano di Rimini, nella Cappella Sistina di Michelangelo. La pittura disegna l’ eclettismo ermetico-cabalistico-neoplatonico rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana in sequenza con il Cristianesimo. Ne deriva un’immagine del mondo come presenza divina nella quale abita l’uomo come unità di corpo e anima.
Tuttavia questa grande sinfonia della sacralità del mondo conduce con sé l’esclusione della donna dal sacro: essa può essere solo portatrice di sacralità. Questa esclusione limita la tradizione e riapre la domanda filosofica con l’estremo Kant della Logica: che cosa è l’uomo? Rispondere a questa domanda, interpretando quello che vuole dire l’autore, significa sottrarci alla nóstra carenza di futuro. Concetto, merce, e definizione della vita sono tre linee che consumano un’unica perdita fatale.
La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: "guardiamo il nostro ombelico", rîconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire non i luoghi delle nostre scissioni. La Sala pensa in termini di speranza e di salvezza e di uomo e donna: non sono sentieri miei. E questo dovrebbe testimoniare proprio alla attenta considerazione del lavoro che deriva dall’essere trasportato senza riserve da un testo, per così dire, in piena.
Fulvio Papi
 Professore ordinario di Filosofia Teoretica
all’Università degli Studi di Pavia.
Professore ordinario di Filosofia Teoretica
all’Università degli Studi di Pavia.
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE...
PARTE INIZIALE DELLA "PREMESSA" DELL’AUTORE *:
Nel 1608, in piena bufera controriformistica, pochi anni prima che in tutta Europa divampassero le guerre di religione e che il filologo Isaac Casaubon (De rebus sacris et eccleslasticis exercitatíones XVI. Ad Cardinalis Baronii prolegomena in Annales, Londra 1614) demolisse “in un sol colpo la costruzione del neoplatonismo rinascimentale con alla base il culto dei prisci teologi principale dei quali era Ermete Trismegisto; [...] la posizione del mago e della magia rinascimentali con il relativo fondamento ermetico- cabalistico; [...] il movimento ermetico cristiano non magico del XVI secolo; [...] la posizione di un ermetico estremista, quale era stato Giordano Bruno; [...] tutti i tentativi di costruire una teologia naturale sull’ermetismo, come quello in cui Campanella aveva riposto le sue speranze”, un ignoto teologo e filosofo carmelitano rimedita nelle linee essenziali il problema e la lezione di Niccolò Cusano, di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e, con l’aiuto di modesti artisti, a Contursi - in provincia di Salerno, nella chiesetta di Maria SS. del Carmine (monastero di padri carmelitani dal 1561 al 1652), scrive il suo poema sulla nascita e sulla pace fidei.
Lo schema della narrazione è lineare e semplicissimo - si parla di un viaggio in cui profetesse pagane (12 Sibille) e profeti ebraici (Elia e Giovanni Battista) mostrano la strada all"iniziato" e lo conducono da Maria, madre di Gesù Cristo, da cui rinasce come figlio e, come Cristo, accede al Regno Celeste - ma le questioni che esso solleva vanno ben al di là del suo tempo e gettano una nuova luce su problemi decisivi del nostro passato come del nostro stesso presente.
Infatti il poema del teologo-filosofo carmelitano presenta una significativa corrispondenza con il viaggio descritto da Parmenide nella sua opera (il cammino all’iniziato è mostrato dalle Figlie del sole e la destinazione è l’incontro con la Dea Giustizia che gli rivela la verità [...]
* Cfr. Federico La Sala, DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri (1481) e la domanda antropologica. Edizioni Nuove Scritture, Milano 2013, pp. 9-10.
 L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, OGGI...
L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, OGGI...
 LE SIBILLE E VICO: L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO. RELAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE CACCIATORE (UNIVERSITA’ DI NAPOLI) SUL LAVORO DI FEDERICO LA SALA
LE SIBILLE E VICO: L’ONDA LUNGA DEL RINASCIMENTO. RELAZIONE DEL PROF. GIUSEPPE CACCIATORE (UNIVERSITA’ DI NAPOLI) SUL LAVORO DI FEDERICO LA SALA
 CONTURSI TERME, 12 AGOSTO 2013: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE".
CONTURSI TERME, 12 AGOSTO 2013: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE".
- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).
- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:
- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
LA CONVERSAZIONE CONOSCITIVA (O IL NUOVO CIRCOLO ERMENEUTICO):
- "IL PROBLEMA CHE RIMANE APERTO DOPO HEGEL è quello di trovare una formula capace di pensare il rapporto tra coscienza individuale e spirito oggettivo: giacché la soluzione prospettata da Hegel, che risolve questo rapporto nella conciliazione suprema dello spirito assoluto, non fa che operare una sintesi dal punto di vista del soggetto. (...) Del resto, la dialettica hegeliana col suo culminare nell’autocoscienza dello spirito, rappresenta proprio lo sforzo che Hegel fa di abbracciare nell’ambito "monologico" del metodo scientifico moderno, la concreta continuità e varietà del dialogo che costituisce la storia" (G. Vattimo, Introduzione, a: H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. IV).
- UNA QUESTIONE DI RICONOSCIMENTO: HEGEL. "La storia propriamente detta, in cui gli uomini (le “classi”) si combattono per il riconoscimento e con il lavoro combattono contro la natura, è chiamata da Marx il «regno della necessità» (Reich der Notwendigkeit); al di là (jenseits) di esso si trova il «regno della libertà» (Reich der Freiheit), in cui gli uomini (riconoscendosi reciprocamente senza riserve) non si combattono più, e lavorano il meno possibile."
- (A. Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel).
- "L’immagine del
corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza
che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della
nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di
un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato
di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è
Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua
unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognu
no di noi, come è tutto intero
nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.
 L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
- "AUT - AUT". “To be, or not to be, that is the question”(W. Shakespeare, "Amleto", III.1): "Voi non potete servire Dio ["Deus charitas est"] e Mammona ["Deus caritas est"] (Luca 16, 13).
- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- UNA DOMANDA SUL TEMA DEL "FIGLIO DELL’UOMO" ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"]: "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).
- FILOLOGIA: ANTROPOLOGIA PIETRINA - 1 PIETRO, 3. 1-7:
- "Ὁμοίως γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν [...] Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ ⸀συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς"
- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- PAOLO DI TARSO E COSTANTINO:"IN HOC SIGNO VINCES"!: «Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.
 Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
- La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo: "Il disegno salvifico di Dio, “il mistero della sua volontà” (Ef 1,9) concernente ogni creatura, è espresso nella Lettera agli Efesini con un termine caratteristico: “ricapitolare” in Cristo tutte le cose, celesti e terrestri (cfr Ef 1,10). L’immagine potrebbe rimandare anche a quell’asta attorno alla quale si avvolgeva il rotolo di pergamena o di papiro del volumen, recante su di sé uno scritto: Cristo conferisce un senso unitario a tutte le sillabe, le parole, le opere della creazione e della storia" (Giovanni Paolo II, Udienza Generale, Mercoledì, 14 febbraio 2001).
- LUCE IRIGARAY, "In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiave per una convivenza universale":
- "[...] «Si tratta di compiere un progresso nel divenire umano, in particolare grazie a una differenziazione più compiuta rispetto all’immediatezza naturale, per la donna ma anche per l’uomo, e anche grazie al #riconoscimento dell’altro come altro e alla pratica di una relazione con lui, o con lei, non sottoposta all’istinto. Senza dominio, dunque, senza possesso [...]».(Baldini Castoldi Dalai, Milano 2006).
- HEGEL E L’AUTOCOSCIENZA - DALLA RELAZIONE DIALETTICA AL DIALOGO: "L’autocoscienza attraversa nella sua formazione o movimento questi tre stadi: 1. quello del desiderio [Begierde], in quanto rivolto ad altre cose; 2. quello della relazione signoria-servitù, nella misura in cui l’autocoscienza si rivolge ad un’altra autocoscienza disuguale da sé; 3. quello dell’autocoscienza in generale, che si riconosce in un’altra autocoscienza uguale a sé" (Hegel).
- SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- Ubuntu: una parola da e per non dimenticare. Una nota a margine della Lettera enciclica di Giovanni Paolo II SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003)
- Trittico di Mérode (1427): L’annunciazione (Adoratrici).
- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).
- MARIA NELLA COMUNITÀ UMANA: «NUOVA EVA»(Domenico Bertetto)
- UNA "PREISTORIA" DI LUNGA DURATA. FREUD, IN UNA NOTA A MARGINE DELLE "CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE", DEL CASO «L’ UOMO DEI TOPI», COSI’ SCRIVE: "Come dice Lichtenberg: «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre». Un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal matriarcato al patriarcato. Le figure preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di un’altra più grande rappresentano appunto la discendenza dal padre, Atena senza madre scaturisce dal capo di Giove. Ancor oggi, in tedesco, il testimone che attesta qualcosa davanti a una corte giudicante si chiama Zeuge [letteralmente "generatore"], per la parte che ha il maschio nell’atto di procreazione; già nei geroglifici troviamo rappresentato il testimone con l’immagine dei genitali maschili." (S. FREUD, "Casi clinici 5. L’uomo dei topi", 1909).
- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:
- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).
- L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- DELLO SPIRITO DI ALEXANDRE KOJÈVE (Mosca 1902 - Parigi 1968). PORTARE LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI "DUE IO" AL DI LA’ DELLE MAGLIE DELLA DIALETTICA
- IN MEMORIA DI FRIEDRICH D. R. SCHLEIERMACHER (1768-1834) E DELLA SUA "ERMENEUTICA". Ordinato pastore della chiesa riformata di Prussia, dal 1796 al 1802, svolse la sua missione di predicatore e di pastore a Berlino presso la chiesa della Charité.
- LA "COMPAGNIA DELLA CHARITA’ dei cortigiani"! Sul tema, cfr. Adriano Prosperi, "Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari", Einaudi, Torino, 1996, tutto il "Capitolo primo. La fede italiana", pp. 16-34.
- Parental control. La riarticolazione della famiglia attraverso le tecniche di PMA (Francesco Piluso, Francesco Pelusi - "La società degli ibridi", No 37, 2023).
- QUESTIONE ANTROPOLOGICA. L’UOMO ("Homo") PER L’UOMO ("homini"), L’ESSENZA DEL GENERE ("GATTUNGSWESEN") UMANO, E IL RAPPORTO MASCHIO ("Vir") E FEMMINA ("Mulier"): LUPO ("Lupus") O DIO ("Deus")?!
- SOLLECITATO DA FUERBACH, MARX (1844) APRE ALLA QUESTIONE "ANDROLOGICA", MA TROPPO "CIVETTANDO" CON LA DIALETTICA DI HEGEL PERDE LA POSSIBILITA’ DI UN LEGAME CON L’ANTROPOLOGIA CRITICA DELL’ETICA DI SPINOZA E DELLA "LOGICA" KANT (1800) E FINISCE PER AUTOLIMITARSI ALLA SOLA "CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA"!
- Karl Marx (1844): "[...] Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie [genere umano].
 Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.
Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.
 In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.
In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.
 In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.
In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.
 La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").
La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").
- HANNAH ARENDT E IL "SELBSTDENKEN" DI LESSING: «La verità è che io non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa d’altro o diversa da quelloche sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come dire che ero un uomo e non una donna - cioè qualcosa di insensato. [...] ho
sempre considerato la mia ebraicità come uno di quei fatti indiscutibili della mia vita, che non ho mai desiderato cambiare o ripudiare. [...] Ciò che ti confonde è che
le mie argomentazioni e il mio metodo sono diversi da quelli cui tu sei abituato; in altre parole, il guaio è che sono indipendente.
 Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa
tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).
Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa
tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).
FLS
|
LE 21 DONNE DELLA COSTITUENTE |
LE DUE META’ DEL CERVELLO (Alfabeta, 1980)

A RAFFAELLA CARRA’ IN MEMORIA (05.07.2021): DISEGNO DI COVINO.
Forum
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- MITO E TRAGEDIA: IL "LETTO DI PROCUSTE" DELLA LUSSUREGGIANTE NATURA E LA NASCITA DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA:4 luglio 2025, di Federico La Sala
IL "CONTADINO" UCCIDE IL "PASTORE" (MITO E TRAGEDIA). IL GIOCO DELLE TRE CARTE, IL "LETTO DI PROCUSTE" DELLA LUSSUREGGIANTE NATURA, E LA NASCITA DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA:
- Una nota a margine di "citazione dalla "Repubblica" ("Politeia") di Platone: Socrate "ipnotizza" Glaucone e lo trasforma in un lavoratore fedele del dio "Fiturgo" (del dio "Piantatore"), il creatore delle forme del cielo e della terra, e, del suo luogotenente panto-cratico Demiurgo...
- "[597 a] - E il fabbricante di letti? Non dicevi poco fa che non costruisce la specie in cui diciamo consistere “ciò che è” letto, ma costruisce un determinato letto? - Lo dicevo, sí. - Se dunque non fa “quello che è” letto, non farà ciò che è, ma un oggetto che è esattamente come ciò che è, ma che non è. E chi asserisse che l’opera del costruttore di letti o di un altro operaio è cosa perfettamente reale, non rischierebbe di dire cose non vere? - Non vere, certamente, rispose; cosí almeno potrà credere chi si occupa di simili argomenti. - Allora non meravigliamoci affatto se anche questa opera è, rispetto [b] alla verità, qualcosa di vago. - No, certo. - Ebbene, ripresi, vuoi che, servendoci di questi medesimi esempi, ricerchiamo chi mai è questo imitatore? - Se vuoi ..., disse. - Questi nostri letti si presentano sotto tre specie.
 Uno è quello che è nella #natura: potremmo dirlo, credo, #creato dal #dio. O da qualcun altro? - Da nessun altro, credo. - Uno poi è quello costruito dal falegname. - Sí, disse. - E uno quello foggiato dal pittore. Non è vero? - Va bene. - Ora, pittore, costruttore di letti, dio sono tre e sovrintendono a tre specie di letti. - Sí, tre. - Ebbene, il dio, sia che non l’abbia voluto [c] sia che qualche necessità l’abbia costretto a non creare nella natura piú di un solo e unico letto, si è limitato comunque a fare, in unico esemplare, quel letto in sé, ossia “ciò che è” letto. Ma due o piú letti di tal genere il dio non li ha prodotti, e non c’è pericolo che li produca mai. - Come?, chiese. - Perché, ripresi, se ne facesse anche due soli, ne riapparirebbe uno di cui ambedue quelli, a loro volta, ripeterebbero la specie. E “ciò che è” letto sarebbe quest’ultimo, anziché quei due. - Giusto, [d] rispose.
Uno è quello che è nella #natura: potremmo dirlo, credo, #creato dal #dio. O da qualcun altro? - Da nessun altro, credo. - Uno poi è quello costruito dal falegname. - Sí, disse. - E uno quello foggiato dal pittore. Non è vero? - Va bene. - Ora, pittore, costruttore di letti, dio sono tre e sovrintendono a tre specie di letti. - Sí, tre. - Ebbene, il dio, sia che non l’abbia voluto [c] sia che qualche necessità l’abbia costretto a non creare nella natura piú di un solo e unico letto, si è limitato comunque a fare, in unico esemplare, quel letto in sé, ossia “ciò che è” letto. Ma due o piú letti di tal genere il dio non li ha prodotti, e non c’è pericolo che li produca mai. - Come?, chiese. - Perché, ripresi, se ne facesse anche due soli, ne riapparirebbe uno di cui ambedue quelli, a loro volta, ripeterebbero la specie. E “ciò che è” letto sarebbe quest’ultimo, anziché quei due. - Giusto, [d] rispose.
 Conscio di questo, credo, il dio ha voluto essere realmente #autore di un letto che realmente è, non di un letto qualsiasi; né ha voluto essere un qualunque fabbricante di letti. E perciò ha prodotto un letto che fosse #unico in #natura. - Può darsi. - Vuoi dunque che lo chiamiamo naturale #creatore di questa cosa, o con un titolo consimile? - È proprio giusto, rispose; perché sia questa sia tutto il resto l’ha fatto in natura. - E il falegname? Non dobbiamo chiamarlo artigiano del letto? - Sí. - E anche il pittore artigiano e autore di questo oggetto? - No, assolutamente. - Ma come lo definirai rispetto al letto? - Secondo me, disse, [e] l’appellativo che piú gli si addice potrebbe essere “imitatore dell’oggetto di cui quegli altri sono artigiani”. - Bene, risposi. Allora chiami tu imitatore chi è artefice della terza generazione di cose a partire dalla natura? - Senza dubbio, rispose. - Tale sarà dunque anche l’autore tragico, se è vero che è un imitatore. Per #natura egli è terzo a partire dal #re e dalla #verità. E tali saranno tutti gli altri imitatori. - Può essere. - Eccoci dunque d’accordo sull’imitatore.
Conscio di questo, credo, il dio ha voluto essere realmente #autore di un letto che realmente è, non di un letto qualsiasi; né ha voluto essere un qualunque fabbricante di letti. E perciò ha prodotto un letto che fosse #unico in #natura. - Può darsi. - Vuoi dunque che lo chiamiamo naturale #creatore di questa cosa, o con un titolo consimile? - È proprio giusto, rispose; perché sia questa sia tutto il resto l’ha fatto in natura. - E il falegname? Non dobbiamo chiamarlo artigiano del letto? - Sí. - E anche il pittore artigiano e autore di questo oggetto? - No, assolutamente. - Ma come lo definirai rispetto al letto? - Secondo me, disse, [e] l’appellativo che piú gli si addice potrebbe essere “imitatore dell’oggetto di cui quegli altri sono artigiani”. - Bene, risposi. Allora chiami tu imitatore chi è artefice della terza generazione di cose a partire dalla natura? - Senza dubbio, rispose. - Tale sarà dunque anche l’autore tragico, se è vero che è un imitatore. Per #natura egli è terzo a partire dal #re e dalla #verità. E tali saranno tutti gli altri imitatori. - Può essere. - Eccoci dunque d’accordo sull’imitatore.
 Ora veniamo al pittore. Dimmi: ti [598 a] sembra che egli cerchi di imitare il singolo oggetto in sé che è nella natura, oppure le opere degli artigiani? - Le opere degli artigiani, rispose. - Quali sono o quali appaiono? Fa ancora questa distinzione. - Come dici?, chiese. - Cosí: un letto, che tu lo guardi di lato o di fronte o in un modo qualsiasi, differisce forse da se stesso? O non c’è nessuna differenza, anche se appare diverso? E analogamente gli altri oggetti? - È cosí, rispose; appare diverso, ma non c’è alcuna differenza. [b] - Esamina ora quest’altro punto. A quale di questi due fini è conformata l’arte pittorica per ciascun oggetto? A imitare ciò che è cosí come è, o a imitare ciò che appare cosí come appare? È imitazione di apparenza o di verità? - Di apparenza, rispose. - Allora l’arte imitativa è lungi dal vero e, come sembra, per questo eseguisce ogni cosa, per il fatto di cogliere una piccola parte di ciascun oggetto, una parte che è una copia. Per esempio, il pittore, diciamo, ci dipingerà un calzolaio, un falegname, gli altri [c] artigiani senza intendersi di alcuna delle loro arti.
Ora veniamo al pittore. Dimmi: ti [598 a] sembra che egli cerchi di imitare il singolo oggetto in sé che è nella natura, oppure le opere degli artigiani? - Le opere degli artigiani, rispose. - Quali sono o quali appaiono? Fa ancora questa distinzione. - Come dici?, chiese. - Cosí: un letto, che tu lo guardi di lato o di fronte o in un modo qualsiasi, differisce forse da se stesso? O non c’è nessuna differenza, anche se appare diverso? E analogamente gli altri oggetti? - È cosí, rispose; appare diverso, ma non c’è alcuna differenza. [b] - Esamina ora quest’altro punto. A quale di questi due fini è conformata l’arte pittorica per ciascun oggetto? A imitare ciò che è cosí come è, o a imitare ciò che appare cosí come appare? È imitazione di apparenza o di verità? - Di apparenza, rispose. - Allora l’arte imitativa è lungi dal vero e, come sembra, per questo eseguisce ogni cosa, per il fatto di cogliere una piccola parte di ciascun oggetto, una parte che è una copia. Per esempio, il pittore, diciamo, ci dipingerà un calzolaio, un falegname, gli altri [c] artigiani senza intendersi di alcuna delle loro arti.
 Tuttavia, se fosse un buon pittore, dipingendo un falegname e facendolo vedere da lontano, potrebbe turlupinare bambini e gente sciocca, illudendoli che si tratti di un vero falegname. - Perché no? - Ma, mio caro, di tutti costoro si deve, credo, pensare cosí. Quando, a proposito di un certo individuo, uno venga ad annunziarci di avere incontrato un uomo che conosce tutti i mestieri e ogni altra nozione propria dei singoli specialisti, e tutto conosce piú [d] esattamente di chiunque altro, a tale persona dovremo replicare che è un sempliciotto e che con ogni probabilità ha incontrato un ciarlatano, un imitatore, da cui è stato turlupinato; e cosí gli è sembrato onnisciente, ma solo perché è lui incapace di vagliare scienza, ignoranza e imitazione. - Verissimo, disse. [...]" (Platone, "Repubblica", 597 a-598 d).
Tuttavia, se fosse un buon pittore, dipingendo un falegname e facendolo vedere da lontano, potrebbe turlupinare bambini e gente sciocca, illudendoli che si tratti di un vero falegname. - Perché no? - Ma, mio caro, di tutti costoro si deve, credo, pensare cosí. Quando, a proposito di un certo individuo, uno venga ad annunziarci di avere incontrato un uomo che conosce tutti i mestieri e ogni altra nozione propria dei singoli specialisti, e tutto conosce piú [d] esattamente di chiunque altro, a tale persona dovremo replicare che è un sempliciotto e che con ogni probabilità ha incontrato un ciarlatano, un imitatore, da cui è stato turlupinato; e cosí gli è sembrato onnisciente, ma solo perché è lui incapace di vagliare scienza, ignoranza e imitazione. - Verissimo, disse. [...]" (Platone, "Repubblica", 597 a-598 d).
IL GIOCO E’ FATTO: ECCO CHI E’ IL LEGISLATORE DEL COSMO (E "QUESTO" E’ LO "SCUDO" DEL NUOVO "ACHILLE" DEL NUOVO "OMERO"). "PLATONE" CODIFICA FINALMENTE LA VITTORIA DELLA LEGGE "APOLLINEA" E "OLIMPICA" CONTRO LA LUSSUREGGIANTE NATURA E AVVIA LA COSTRUZIONE DEL "LETTO DI PROCUSTE" DEL PANTOCRATORE "SO-KRATICO". Platone:La natura ("physis") sembra come stampata nelle progressioni numeriche" ("Epinomide", 90 d). Con la "nascita" della agricoltura (e l’uso dell’aratro e la scoperta della fecondazione maschile), la "numerazione" della Terra e il calcolo del tempo e dello spazio con lo gnomone (Filolao: "Il numero, “mettendo in armonia nell’anima tutte le cose con la percezione, le rende conoscibili e le avvicina in un reciproco accordo secondo la natura dello gnomone, col dar corpo e col distinguere i rapporti delle cose, sia nell’infinito che nel finito”), si gettano le basi pitagoriche e platoniche della persuasione che "il dio è la misura di tutte le cose" e che questo "universale significante" è un cosmoteandrico panto-kratico "Fiturgo": “Il conosciuto viene compreso e abbracciato dal conoscente come un quadrato e abbracciato dal suo gnomone” (A. Boeckh, 1819).
La "instauratio magna" (già) baconiana del "parto maschio del tempo", contro la lussureggiante "lussuria" ("hybris") della "natura" ("physis"), comincia il suo storico cammino. A ben pensare, è un "letto di Procuste", un vero e proprio sofisticatissimo "rasoio teologico-politico" del "Piantatore" ("φυτουργός, phytourgós"), del "Fiturgo" platonico (nient’affatto alla Ockham!). Aveva perfettamente ben compresa la cosa A. N. Whitehead: "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine su Platone". Nel riflettere su "Il problema Socrate", nel "Crepuscolo degli idoli", Nietzsche l’aveva ben capito (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani, editore, Roma 1991).
La "misura" del "Dio" del D(i)ritto impone la sua regola e il suo regolo contro la "Dea" della "torta" - e comincia a camminare "storto" e con #uno solo dei suoi occhi (alla "Polifemo"), a tutti i livelli: "Il torto è una bestia così brutta che nessuno se lo vuol prendere in casa"(Primo Levi). La "caduta" è già accaduta, e la "tragedia" anche. Forse, è proprio il tempo di ripiantare alberi "a volontà" e restituire alla Terra il suo "verde brillante"! Se non ora, quando?!
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CERCARE DI #RINASCERE E ABITARE LA TERRA, #VOLTAIRE "PAGINA" E COLTIVARE IL #GIARDINO (#DANTE - #KANT), NEL #RISPETTO DEL #CERCHIO DELLA #VITA.19 giugno 2025, di Federico La Sala
"TERRA!, TERRA!". LA SALUTE MENTALE: "QUESTA E’ UNA COSA GRANDE", PER USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #TRAGEDIA E CERCARE DI #RINASCERE ...
ABITARE LA TERRA, #VOLTAIRE "PAGINA" E COLTIVARE IL #GIARDINO (#DANTE - #KANT), NEL #RISPETTO DEL #CERCHIO DELLA #VITA.
- Un "#pensiero" e un "#buonconsiglio" a #papa #Leone XIV
"Parigi. Firmata la Dichiarazione sulla Salute Mentale. 31 Paesi per una grande causa" ("Salute mentale", 18 giugno 2025: https://www.salutementale.net/parigi-firmata-la-dichiarazione-sulla-salute-mentale-31-paesi-per-una-grande-causa/ ):
🌟 "CUSTA ’E OSA MANNA" (#PIEROPODDA, #SARDEGNA). Un "invito a occhi aperti, un battito d’ali verso un futuro diverso. L’Europa ha lanciato questo incantesimo, e ora il #coraggio è nelle nostre mani, nel trasformare le parole in azioni concrete." 👏 🙏
#ECOLOGIA E #ANTROPOLOGIA ("#OIKOS" E "#LOGOS": LA "CASA" DELLA "PAROLA", DEL #DIALOGO DEI "#DUESOLI", DELLA INTERA #UmaNITA’ (BENEDETTO, BARUCH #SPINOZA: "#HOMO HOMINI DEUS EST").
- NOTE:
- ANTROPOLOGIA E "PRIMA #RINASCITA": UNA PREMESSA... DI #CIVILTA’. DEL CARDINALE MARTINI (CARLO MARIA MARTINI), LA LEZIONE PIU’ GRANDE: IL #PRESEPE DEL #LAGER NELLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO (#MILANO, 2000) ... A CARLO M. MARTINI E A #ENZO PACI, IN ONORE E MEMORIA.
- STORIA #METASTORIA E #ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA): #NICEA (325-2025). UN "#LETARGO" DI "#VENTICINQUESECOLI" PER #DANTE ALIGHIERI (PAR., XXXIII, 94-95) E UN #SONNO DOGMATICO DI #2025ANNI ATTORNO ALLA "#PISCINA" DEL #MEDITERRANEO.
- Appunti per riflettere: a) Il testo della catechesi di #LeoneXIV. "Il Papa prosegue il ciclo di riflessioni giubilari sulla #speranza e si sofferma sull’episodio della #guarigione del #paralitico. Il cuore di Cristo vera casa della misericordia ("L’Osservatore Romano, #18giugno 2025); e, b) una "sollecitazione" di Martha Zechmeister, ripresa (v. allegato) dal mensile "#Donne #Chiesa #Mondo" (L’Osservatore Romano).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- MEMORIA, FILOLOGIA, SPIRITO SANTO, E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: "ECCO DA DOVE COMINCIA L’ AMORE" (SANT’AGOSTINO).9 giugno 2025, di Federico La Sala
MEMORIA, FILOLOGIA, SPIRITO SANTO, E COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: "ECCO DA DOVE COMINCIA L’ AMORE ("ECCE UNDE INCIPIT #CHARITAS": SANT’#AGOSTINO).
- Un omaggio all’urlo di Francesca Tuscano e alla sua sollecitazione a riflettere e ad "aprire gli occhi", sull’ieri (#8giugno), sull’#oggi (#9giugno), e sul domani (10 giugno):
"Questi referendum sono serviti a contarci. Da questo momento, per quanto mi riguarda, considererò il referendum uno strumento politico importante (com’è stato in passato). Bisogna creare comitati. Fare politica spiegando con grande concretezza cosa in questo paese deve sparire.
 Di roba da abrogare ce n’è ogni giorno di più.
Di roba da abrogare ce n’è ogni giorno di più.
 E verificare numericamente chi in questo paese sia realmente di sinistra è ormai essenziale.
E verificare numericamente chi in questo paese sia realmente di sinistra è ormai essenziale.
 Perché siamo in una situazione politica immonda, e non mi sembra più il caso di zampettare allegramente dietro il pifferaio magico. (Francesca Tuscano, cit.)
Perché siamo in una situazione politica immonda, e non mi sembra più il caso di zampettare allegramente dietro il pifferaio magico. (Francesca Tuscano, cit.)CONCORDO: OTTIMA SOLLECITAZIONE AD APRIRE LE PORTE E LE FINESTRE, USCIRE DAL #LETARGO (#DANTE), E RINGRAZIARE FRANCESCANAMENTE IL "FRATE SOLE". DI QUESTO SI HA PROPRIO BISOGNO, DI UN FORMIDABILE #SATORI, CHE IL SOLE SI LEVI E RENDA POSSIBILE IL #SORGERE DELLA TERRA (#EARTHRISE)!
La #question è quantomeno amletica ("essere, o non essere") e parmenidea: lo "zampettare allegramente dietro il pifferaio magico" è dovuta alla generale e diffusa capacità di #giudizio (#Kant, 1784) che ancora non riesce a distinguere tra #Italia e "Italia", #famiglia e "famiglia", e, #Dio e "Dio"! E, addirittura, tra il "panto-cratore" So-crate di #Platone, e, l’imperatore cosmoteandrico di #Costantino: "Quali pregiudizi, quale cecità (quale malafede) non bisogna avere per osar paragonare il figlio di Sofronisco col figlio di Maria!" (J.-J. #Rousseau, "Emilio").
Chiarissima Francesca Tuscano, proprio ieri, così scrivevo a un mio giovane amico, con fraterna "carità" ("charitas"): «Affinché la gioia sia piena e la festa sia grande, è bene "ri-cordare" (ri-portare al "#cuore" e alla "#mente") la parola che dice appunto dello spirito "cardiaco" (infuocato) dell’amore ("charitas") e non "confonderla" con "#mammona" ("#caritas") e altri interessati motivi. Grazie della tua sollecitazione a ricordare e a riflettere».
- NOTE:
- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E COSTITUZIONE: AL DI LA’ DELLA LOGICA DEL #MENTITORE. CON PARMENIDE DI #ELEA, SUL#PONTE (IL #VIADOTTO) DELLA COSIDDETTA #PORTAROSA PER ANDARE OLTRE IL VICOLO CIECO DELL’ #OPINIONE (cfr. DK 6 B 5: "mortali che nulla sanno vanno errando, gente dalla doppia testa. [...] gente che non sa decidersi, da cui l’essere e il non essere sono ritenuti identici e non identici, per cui di tutte le cose reversibile è il cammino").
- COME UNA #TEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA DEL #MESSAGGIO DELL’ #EVANGELO DIVENTA UNA #COSMOTEANDRIA DEL "VANGELO" DELL’ "IN HOC SIGNO VINCES" DELL’#IMPERATORE #COSTANTINO: UNA #IDEOLOGIA DEL "#CRISTO #PANTOCRATORE". SE il primo Concilio di Nicea (325) tiene ben ferma la "verità" che Gesù Cristo è "vero uomo e vero Dio", filologicamente e hamleticamente, è da dire che la interpretazione della figura del "Figlio dell’Uomo" e del "Figlio di Dio", di #diritto e di #fatto, alla fine, resta (e lo è ancora) "re-cintata" #nicea-mente (come ben denunciava #Nietzsche) nelle mani e nel "palazzo" del "panto-cratico" socratismo platonico e paolino, cattolico-costantiniano. Se questo non è l’orizzonte della #caduta nell’#inferno, cosa è rispetto alla lezione evangelica dello stesso #Galileo e di #Francesco d’#Assisi?! Di cosa si occupava #DanteAlighieri, di quale viaggio ha raccontato, di una preistorica "divina #tragedia"?!
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE.8 giugno 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E FILOLOGIA.
UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS").
STORIA E METASTORIA: AL TEMPO DI DANTE (E DI "AMLETO"), «L’«ENTRÉE D’ESPAGNE», UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).
- "Questo poema è l’opera di gran lunga più importante dell’epica trecentesca d’Italia in lingua francese.. Vigore creativo e spessore culturale ne fanno un monumento letterario autentico, e molto resta ancora da portare alla luce" (A. Limentani).
"[...] Disse Feragu [a Rolando]: «Se mi dimostrate / in modo chiaro come fece Dio / a far nascere suo figlio in una donna/ con carne umana - e ne spiegate il motivo -, / e come sua madre si mantenen vergine / sia prima, sia dopo averlo partorito, / oggi mi battezzerò al sacro fonte» (Anonimo Padovano, "L’Entrée d’Espagne", Interlinea edizioni, Novara 2021, pp. 138-139).
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- APPUNTI SUL "VICISTI, GALILAEE" (KEPLERO A #GALILEO, 1611), SU NICEA (325-2025), E SULLA "COSTITUZIONE" DEL VATICANO II (IGINIO ROGGER, 2012).26 maggio 2025, di Federico La Sala
STORIA E #STORIOGRAFIA D’#EUROPA: "VICISTI, GALILAEE" (PAROLE DI OMAGGIO DI #KEPLERO A #GALILEO GALILEI, 1611) E L’ANNIVERSARIO COSTANTINIANO DEL #PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325-2025).
UNA "RIPRESA" DI UNA "RIFLESSIONE" (2012) A MARGINE DI UNA INTERVISTA SUL "#FATO" E SUL "FATTO" DEL #CONCILIO VATICANO II: IL #MESSAGGIO EVANGELICO E LA #COSTITUZIONE "SACROSANTUM CONCILIUM" NON HANNO NULLA A CHE FARE CON IL "MAGISTERO" della gerarchia cattolico-costantiniana di "#Gesù" come "#Dominus #Iesus" e di Dio come "#ricchezza" (Benedetto XVI, Deus #caritas est, 2006)!
"Bisogna intendersi sul termine sacro: anche l’adorazione del vitello d’oro era sacra!" (Iginio Rogger): Riscoprire l’essenza della Chiesa, intervista a mons. #Iginio #Rogger, a c. di Maria Teresa Pontara Pederiva (“Vita Trentina”, 8 gennaio 2012).
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- APPUNTI PER CERCARE DI NON FARE NAUFRAGIO: DALLA PRIMA ALLA "QUARTA NAVIGAZIONE" ("DIVINA COMMEDIA"), CON IL "GALILEO".25 maggio 2025, di Federico La Sala
CULTURA E DISAGIO DELLA CIVILTÀ E NELLA SOCIETÀ:
FISICA (COSMOLOGIA), METAFISICA (PLATONISMO), E "QUARTA NAVIGAZIONE" ("DIVINA COMMEDIA") CON IL "GALILEO".
- Alcuni appunti per cercare di non fare #naufragio...
Riprendendo il "discorso" sulle "Tre navigazioni" della tradizione filosofico-scientifica occidentale (si cfr. la breve scheda del prof. Ivano Dionigi, [sull’ Avvenire del 7 marzo 2020), forse, è possibile avanzare qualche ipotesi di #ricerca e di riflessione antropologica su una ignorata "quarta navigazione", che ha visto impegnati molti grandi protagonisti della travagliata storia mediterranea, ed, eventualmente, contribuire ad aprire qualche varco che possa portare fuori da una visione sempre più buia della della vita sul #PianetaTerra...
- TRE NAVIGAZIONI. La traversata del mare della vita, così insegna la riflessione classica, può essere compiuta con due diversi tipi di navigazione: la scienza e la filosofia. La “prima navigazione” è quella in cui gli uomini in mare si affidano alla forza naturale dei venti.
 Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.
Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.
 Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).
Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).
A PARTIRE DA SE’, #HAMLETICA-MENTE ("ESSERE, O NON ESSERE"): IL "#GALILEO" (#MESSAGGIOEVANGELICO), LA "DIVINA COMMEDIA" (#DANTEALIGHIERI), E IL "DIALOGO DOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO TOLEMAICO E COPERNICANO" (#GALILEOGALILEI).
SULLA VIA DELLO "SPIRITO PROFETICO" DI GIOACCHINO DA FIORE E, A PARTIRE DALLA "LEZIONE" IN PRIMA PERSONA DI FRANCESCO DI ASSISI, DANTE ALIGHIERI, CON L’AIUTO DI (MARIA, LUCIA, E) "#BEATRICE" E "#VIR_GILIO", REALIZZA IL SUO "VIAGGIO" TERRESTRE E CELESTE, BEN OLTRE LA "#SECONDANAVIGAZIONE" DI PLATONE, E LA "#TERZANAVIGAZIONE" (CON LA #CROCE, IL "LEGNO", LA "NAVE") DI SANT’#AGOSTINO.
Platone, nonostante tutto, è stato chiaro: «Non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità, o scoprirla da sé medesimi, oppure, se ciò è impossibile accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita. A meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio, su una più solida nave, cioè affidandosi a una divina rivelazione» ( Platone, "Fedone", 85c-d).
AFFIDANDOSI ALLA "DIVINA RIVELAZIONE" DI #FRANCESCO DI ASSISI: IL SUO "#PRESEPE" (GRECCIO, 1223), UNA NUOVA #ARCA ("UNA PIU’ SOLIDA NAVE"), QUELLA DELLO STESSO "GALILEO", DANTE ALIGHIERI RITROVA SE’ STESSO E LA #SORGENTE DI TUTTE LE SORGENTI ( "L’ AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE") E RI-DIVENTA ANCH’EGLI UN ALTRO "CRISTO". (Sul tema, mi sia lecito, si cfr.: "La FenomenologiadelloSpirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”).
- NOTE:
- FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPEREAUDE!" (#KANT, 1784). Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi. Una breve nota a margine della sua considerazione .....
- ANTROPOLOGIA #FILOLOGIA E #TEOLOGIA: COME IN #CIELO, COSI’ IN #TERRA. CON LA "DIVINA COMMEDIA" E CON LA "#MONARCHIA" DANTE SI PORTA AL DI LA’ DELLA #COSMOTEANDRIA CELESTE E TERRESTRE DELLA #CHIESA PLATONICO-PAOLINA E COSTANTINIANA E AGOSTINIANA (#NICEA, 325-2025). "Sant’Agostino, la presenza assente nel viaggio di Dante. Sant’Agostino, uno dei più importanti padri della Chiesa, non compare mai come personaggio nella Divina Commedia. Viene, al massimo, solo nominato nell’Empireo del Paradiso. Ma la sua filosofia è presente ovunque, come fonte di ispirazione del Sommo poeta [...]" (cfr. Giovanni Fighera, "La Nuova Bussola Quotidiana"", 11_04_2021).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FISICA E METAFISICA E COSMOLOGIA QUOTIDIANA: LO SPIRITO DI GALILEO E LA RICERCA FILOSOFICO-SCIENTIFICA.24 maggio 2025, di Federico La Sala
FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPERE AUDE!" (#KANT, 1784).
Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi.
 Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:
Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.
 Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.
Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.
 È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.
È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.
 Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.
Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.
 Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.
Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.
 Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.
Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.
 E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).
E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).
***
CULTURA E #SOCIETÀ : #FERMI TUTTI E TUTTE, E, "CUM GRANO SALIS", SI CERCHI (E CERCHIAMO) DI PENSARCI ANCORA E BENE SUL #GALILEO DI CUI SI STA PARLANDO: "VICISTI, GALILAEE" (#KEPLERO, 1611).
La #rivoluzionecopernicana (contro i profeti della "fine della storia"), a mio parere, è solo iniziata, e, la navigazione nell’#oceanoceleste, con la #nave di #GalileoGalilei, se ha oltrepassato Scilla e Cariddi, non è andata affatto oltre le colonne d’Ercole della #cosmoteandria dell #tragedia.
"DIVINA COMMEDIA" (#Dante Alighieri). Non è meglio continuare a rifletterci? Così #EnnioFlaiano, nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, scriveva: “L’amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galilei”. Una forte e bella illuminante idea! Non è bene tenerne conto?
- NOTE:
- ARITMETICA E #ANTROPOLOGIA: #IMPARARE A #CONTARE. UNA #HAMLETICA #DOMANDA TEOLOGICO-POLITICA AI MATEMATICI PER USCIRE DALL’#IMMAGINARIO DELLA #TORREDIBABELE. Come "è stata possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ...
- STORIA #STORIOGRAFIA E #RICERCASCIENTIFICA: A NICCOLO’ #COPERNICO (19 febbraio 1473 - #24MAGGIO 1543). ALLA #LUCE DEL SOLE, CONTRO I PROFETI DI #SVENTURA, DOPO #NEWTON, #KANT ED #EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO "NEW TON": "LA #MENTEACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" (#ANTONIOPELLICANI EDITORE, ROMA 1991) .... UN GRANDE OMAGGIO AL "FRATE #SOLE" E ALLA "SORA NOSTRA MADRE #TERRA"! UN "INVITO" AD ASCOLTARE E AD ASCOLTAR-SI IL "CANTICO DELLE CREATURE" (E IL "CANTICO DEI CANTICI"): UNA SOLLECITAZIONE #SOLARE PER UN #PIANETATERRA ANCORA IMBOZZOLATO NEL " #BUIO" DELLA SUA CAVERNICOLA "#INTELLIGENZA #ARTIFICIALE" E DELLA SUA "PLATONICA" #MATEMATICA COSMOTEANDRICA. UNA "RICOGNIZIONE" STORICO-FILOSOFICA PER RIPRENDERE IL FILO CON LA PRIMA #RINASCITA" (#ERNESTOBUONAIUTI), "L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" (#DANTE ALIGHIERI, Par. XXXIII, 145), E LA "#RIVOLUZIONE COPERNICANA" NELLA #SCIENZA E NELLA #FILOSOFIA.
- STORIA E #METASTORIA D’#EUROPA: OLTRE L’ANTICA #TRAGEDIA, "LA PRIMA #RINASCITA" E LA "#DIVINA COMMEDIA". Storiograficamente, forse, è ora di #capovolgere, il "tempo" proprio dell’#Umanesimo e del #Rinascimento: per la #società e la #cultura del cosiddetto "#MedioEvo" (così dagli "umanisti"), l’epoca (al contrario) "fu sentita - scrive E. #Gilson - come un’età di innovazione in tutti i sensi della cultura, una #modernità in progresso". A mio parere, a ben vedere, Ernesto Buonaiuti aveva ragione: il formidabile processo della "prima #rinascita" cominciò con #GioacchinodaFiore, #Francesco di Assisi, e #Dante Alighieri. Riprendere il filo...
- COSMOLOGIA ED #ECOLOGIA #QUOTIDIANA: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. Per riflettere e approfondire, un libro di #ClaudiaFanti, "A casa nel cosmo. Per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza" (#GabrielliEditori, 2025):
- "DESCRIZIONE [...] Con straordinaria chiarezza e competenza riguardo al mondo della scienza, in particolare dell’astrofisica, della fisica contemporanea, della biologia, l’autrice sviluppa il testo attraverso cinque parole dense di significato che iniziano tutte con la lettera “c”: #casa (il nostro pianeta, ma anche, più in generale, l’intero universo di cui siamo parte), #creatività (il nome della storia cosmica), #coscienza (come possibile fondamento della realtà), #conoscenza (compagna inseparabile del mistero) e #connessione (l’interdipendenza di tutto con tutto come “legge morale” dell’universo). [...] “A ottocento anni dalla morte di #sanFrancesco, questo è un libro che riecheggia in pieno il suo insegnamento di amore per tutto il creato. È una revisione moderna del #CanticodelleCreature.” #MaurizioBusso [...]" (cit.)
- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E "CRISTOLOGIA": L’ "ENTRÉE D’ESPAGNE" E IL BRACCIO DI FERRO FILOSOFICO-SCIENTIFICO E RELIGIOSO TRA DUE CAVALIERI (ROLANDO E FERAGU).22 maggio 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #STORIAELETTERATURA E #FILOLOGIA EUROPEA:
L’ "ENTRÉE D’ESPAGNE" E IL BRACCIO DI FERRO FILOSOFICO-SCIENTIFICO E RELIGIOSO TRA DUE CAVALIERI (ROLANDO E FERAGU) SUL COME NASCE "IL FIGLIO DI DIO".
- Un "invito alla lettura" di un poema epico della prima metà del Trecento sulle imprese di Rolando negli anni precedenti la rotta di Roncisvalle, un’opera straordinaria di Anonimo Padovano, «L’Entrée d’Espagne. Rolando da Pamplona all’Oriente», a cura di Marco Infurna, Carocci editore 2011.
- Nessuno nasce senza ombelico (antico prov. arabo).
"SÀPERE AUDE!" (#KANT). SE L’ESSERE UMANO È "CIO’ CHE MANGIA" (A PARTIRE DAL LATTE MATERNO), COME MAI È COSì DIFFICILE USCIRE DALLO STATO DI MINORITÀ, DALL’AVIDITÀ DEL #CUPIDO (#EROS) SOCRATICO-PLATONICO, ED ENTRARE NELLA MAGGIORE ETÀ, IN UNO STATO DI #GRAZIA ("#CHARIS") E #AMORE ("#CHARITAS") EVANGELICO E COSTITUZIONALE (ART. 3)?!
QUAL E’ LA QUESTIONE (#SHAKESPEARE)?! NON È FORSE QUELLA AMLETICA (DI "#PATERNACARITÀ"), QUELLA ANTROPOLOGICA (#CRISTOLOGICA), QUELLA DELL’ESSERE "FIGLI E FIGLIE DEL RE E DELLA REGINA"?! NON E’ PER CASO UN PROBLEMA DI #INCARNAZIONE, DI "#COMENASCONOIBAMBINI" (ENZO PACI)?!
DISAGIO DELLA CIVILTA E #COSMOTEANDRIA. SE C’È ANCORA CHI SOGNA DI ESSERE UN "BIBLICO" #GOLIA, UN "MITOLOGICO" TITANO, UN "TECNOLOGICO" #SUPERMAN, sia sul piano ateo sia sul piano devoto, rifletta per un secondo su cosa gli è stato dato da mangiare, e su questi temi (a partire dal proprio "#ombelico"), facendo un uso critico della propria facoltà di giudizio, faccia coraggiosamente le sue considerazioni sul duello teologico-politico e militare tra Rolando e Ferragu (cfr. Marco Infurna, «L’episodio di Feragu nell’Entrée d’Espagne », Medioevo romanzo, 33, 2009, p. 73-92) nello "sconosciuto" e "ignorato" capolavoro dell’Anonimo Padovano, "Entrée d’Espagne", realizzato all’incirca una decina di anni dopo la morte di Dante Alighieri (1321)!
"LASCIATE OGNI SPERANZA" (V. HUGO, "Notre-Dame de Paris 1482"). Dante si salverà per miracolo, così come le sue stesse ossa e le sue opere (soprattutto la "Monarchia" con i suoi famosi "Due Soli"), e l’Italia e l’Europa non troveranno più pace. Già dopo la morte di Dante (1321) e di Giotto (1337), a partire dal 1346, la peste nera segnerà la fine dell’ autunno del Medioevo (come scrive Huizinga agli inizi del XX secolo) e darà il via alla stagione "rinascimentale" (invernale e infernale) dell’Europa moderna, promuovendo l’imbozzolamento del messaggio evangelico nella cultura della "dotta ignoranza" (Cusano,1440) e di una "pace della fede" (Cusano, 1453) molto paolina e costantiniana e nient’affatto francescana. La caduta di Costantinopoli (1453) e il via libera alla cacciata dei mori e degli ebrei dalla Spagna e dall’Europa darà la linea teologico-politica del cosiddetto "Rinascimento", a tutti i livelli (Nicea, 325-2025).
RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA. SUL TEMA, MI SIA LECITO, SI CFR.: "#ANATOMIA" (#GIOVANNIVALVERDE, 1560) E #PSICANALISI (2005). "Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo". Una risposta-commento di #LuigiCancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27.
- NOTE:
- RINASCIMENTO. #NASCERE E #RINASCERE: LA "MADONNA DELLE GRAZIE"... #ARTE #STORIOGRAFIA #LETTERATURA E #QUESTIONE ANTROPOLOGICA (#CRISTOLOGIA) - NELL’ANNO DELL’#INCARNAZIONE DEL #NATALE2023 E DELL’ANNIVERSARIO DEL #PRESEPE DI #GRECCIO DEL 1223.....
- ARTE, #FILOLOGIA, E #INTERPRETAZIONE: RIPARTIRE DALLA RISCOPERTA DI #TROIA, DEL #LAOCOONTE (ROMA, 1506), E RIPENSARE LA SACRA #FAMIGLIA (#MICHELANGELO, #TONDODONI E VOLTA DELLA #CAPPELLASISTINA, CON I SUOI #PROFETI E LE SUE #SIBILLE). In memoria della "prima rinascita", dell’ O di #Giotto e del "Tondo Doni" di #Michelangelo....
- NELL’ANNO DELL’#INCARNAZIONE DEL #NATALE2023, A 800 ANNI DAL #PRESEPE DI GRECCIO DEL 1223....
- L’ANTROPOLOGIA, L’ANATOMIA, E LA NASCITA DA #DUESOLI (NON DA "#UNO" SOLO!). #Nessuno nasce senza ombelico (antico prov. arabo): “guardiamo il nostro #ombelico”.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E DI "PRINCIPI DELLA MATEMATICA". UN OMAGGIO A BERTRAND RUSSELL.14 maggio 2025, di Federico La Sala
IL "LOGOS" IN "PRINCIPIO" («Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος»), «DIO NESSUNO L’HA MAI VISTO» (Gv.1,18), E UNA #HAMLETICA #QUESTIONE DI #FILOLOGIA, DI #ANTROPOLOGIA, E DI "#PRINCIPI DELLA #MATEMATICA" (#BERTRAND RUSSELL, 1903).
- Una nota di commento a margine del "vecchio" tentativo di Bertrand Russell, di portarsi sulle ali del "#neutral #monism" ("monismo neutro" ), oltre l’#assolutismo metafisico sia del #materialismo sia dell’#idealismo, e, oltre l’#inferno epistemologico dell’#empirismo, del #razionalismo e, infine, dello stesso #scetticismo.
NELLA "PREFAZIONE" AL SUO LAVORO SULLA "ANALISI DELLA #MENTE" (1921), #Russell così scrive: "Questo libro nasce dal tentativo di armonizzare due diverse tendenze, una in psicologia, l’altra in fisica, con cui mi trovo in sintonia, sebbene a prima vista possano sembrare incoerenti. Da un lato, molti psicologi, soprattutto quelli della scuola comportamentista, tendono ad adottare una posizione essenzialmente materialistica, per una questione di metodo se non di metafisica. Rendono la psicologia sempre più dipendente dalla fisiologia e dall’osservazione esterna, e tendono a pensare alla materia come a qualcosa di molto più solido e indubitabile della mente. Nel frattempo i fisici, soprattutto Einstein e altri esponenti della teoria della relatività, hanno reso la "materia" sempre meno materiale. Il loro mondo è costituito da "eventi", da cui la "materia" deriva da una costruzione logica. Chiunque legga, ad esempio, "Spazio, tempo e gravitazione" del professor Eddington (Cambridge University Press, 1920), si renderà conto che un materialismo antiquato non può ricevere alcun sostegno dalla fisica moderna. Credo che ciò che abbia un valore permanente nella prospettiva dei comportamentisti sia la convinzione che la fisica sia la scienza più fondamentale attualmente esistente. Ma questa posizione non può essere definita materialistica se, come sembra essere il caso, la fisica non presuppone l’esistenza della materia. [...]" (cfr. "L’analisi della mente/Prefazione").
Nonostante le buone intenzioni, Russel mostra di non essere affatto ben disposto a staccarsi "meta-fisica-mente" (andare-oltre) né dall’uno né dall’altro dei "due" e a saper realizzare una visione "neutrale" (da "monismo neutro", come vuole), né nei confronti della psicologia né della fisica, e, anzi, di avere (neopositivisticamente e neoidealisticamente) un punto di vista epistemologicamente e kantianamente del tutto "pre-critico"!
IL PROBLEMA "MATEMATICO-ANTROPOLOGICO" DEL "MENTITORE". In particolare nei confronti di "Einstein e altri esponenti della teoria della relatività" e sul libro «"Spazio, tempo e gravitazione" del professor Eddington (Cambridge University Press, 1920)», Russell mostra di ’guardare’ all’oggetto in esame da un punto di vista molto superficiale, e non neutrale!
Eddington, nella sua "Filosofia della fisica" (1939), mostra decisa consapevolezza critica nel suo sostenere che, "se fosse necessario scegliere una guida tra i filosofi del passato, non ci sarebbe nessun dubbio che la nostra scelta cadrebbe su Kant", e, ancora, che, "come riconoscimento, è giusto dire che Kant anticipò in notevole misura le idee a cui siamo ora spinti dagli sviluppi moderni della fisica" (cfr. Arthur S. Eddington, "Filosofia della fisica", Laterza, Bari 1984).
"#NESSUNO E’ IL MIO NOME" ("Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα"): TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. ANCORA E DI NUOVO, E’ NECESSARIO LASCIARE IL VECCHIO "MONDO" E RIPRENDERE IL VIAGGIO CON OMERO E DANTE ALIGHIERI, OLTRE SCILLA E CARIDDI E LE COLONNE DI ERCOLE DEL "#MATRIARCATO" E DEL "#PATRIARCATO", DELLA "CADUTA" E DELLA "TRAGEDIA" DI "VECCHIE" ALLEANZE E DI COSTITUZIONI DOGMATICHE.
CON LA CRITICA DELLA RAGIONE "PURA" E IL "SÀPERE AUDE!" DI ORAZIO E KANT, E, CON LE "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. #FREUD, 1937), FORSE, E’ POSSIBILE RIPRENDERE IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" DEL #GALILEO (1632) E PORTARSI AL DI LA’ DELLA #DOTTAIGNORANZA E DELL’ASTUZIA (DEL FIDEISMO) DELLA RAGIONE "#UNIVERSALE", NELLA TERRA "ILLUMINATA" DA "DUE SOLI". L’ALBA DELLA MERAVIGLIA: #EARTHRISE...
- Note:
- STORIA E STORIOGRAFIA DELLA #SCIENZA E DELLA #FILOSOFIA. "#Freud, #biologo della #psiche": l’opera di Frank J. #Sulloway (Feltrinelli, Milano, 1982), nella recensione dello psichiatra e psicoanalista #FrancoDeMasi. Una "citazione": -***"Il titolo può anche risultare fuorviante e non sembra rendere giustizia al contenuto di questo libro [...] La tesi centrale è che vi è una continuità nel pensiero di Freud dal periodo del suo stretto interesse biologico a quello dello sviluppo psicoanalitico. L’autore sostiene che, contrariamente a quanto hanno affermato gli studiosi di psicoanalisi, in particolare gli analisti come Jones, che si sono occupati di storia della psicoanalisi e che sottolineano l’importanza dell’autoanalisi per le scoperte psicoanalitiche, Freud, avendo iniziato la sua carriera scientifica come biologo, trovò perfettamente naturale, anche durante gli anni successivi e cruciali delle scoperte analitiche, continuare a collocare l’entità biologica dell’uomo nello stesso cuore del sistema psicoanalitico e che, anche nelle ultime opere, questa fonte di L’ispirazione non venne mai meno anche se non è stata riconosciuta o menzionata." (Rivista di Psicoanalisi).
- STORIA E MEMORIA: #BERTRAND #RUSSELL E #DORA #BLACK.
- Doc.: Una straordinaria donna moderna (#DoraRussel, "#Ipazia e la #guerra tra i #sessi") di Francesca Magni ("Letto fra noi", 29 gennaio 2013):
- Dora Russel (Mrs Bertrand Russell), Ipazia e la guerra tra i sessi (La Tartaruga, 2012, traduzione di Simone Lenzi € 12,00, pp. 100.
- LA #FILOSOFIA E L’#ANTINOMIA ANTROPOLOGICA DEL COSIDDETTO "#PARADOSSO DEL #MENTITORE": "I PRINCIPI DELLA MATEMATICA" (#BERTAND RUSSELL). SCHEDA EDITORALE:
- "Pugnace censore di ogni forma di dogmatismo e fanatismo, è stato uno dei fondatori della filosofia analitica e ha avuto un ruolo di primo piano, con G. E. Moore, nella "rivoluzione" che ha travolto l’idealismo della filosofia anglosassone d’inizio Novecento: rivoluzione di cui i #Principidellamatematica (1903) rappresentano uno dei testi fondativi. "L’opera - scrive #Russell - ha un duplice scopo: primo, provare che tutte le proposizioni della matematica pura sono deducibili da un numero piccolissimo di principi logici fondamentali; [...] secondo, spiegare i concetti fondamentali che la matematica accetta come indefinibili - un compito puramente filosofico, e io non mi illudo di aver fatto altro che indicare un vasto campo di ricerche" (cit.).
- PIANETATERRA E #COSMOTEANDRIA: TRACCIA PER UNA #SECONDA #RIVOLUZIONE COPERNICANA (#KANT, 1724- 2024).
 STORIA DELLA #CIVILTA’ E #FILOLOGIA: COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO (TEOLOGICO E COSMOLOGICO) E’ STATO DECLINATO DALL’#ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE "PRINCIPIO #ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato): "The #Stages of #Man (1510)", by Charles de #Bouelles (c. 1470-1553).
STORIA DELLA #CIVILTA’ E #FILOLOGIA: COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO (TEOLOGICO E COSMOLOGICO) E’ STATO DECLINATO DALL’#ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE "PRINCIPIO #ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato): "The #Stages of #Man (1510)", by Charles de #Bouelles (c. 1470-1553).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" ---ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA: "QUIS UT DEUS?" (" CHI E’ COME DIO?"). UNA NOTA SUL SIGNIFICATO DELLA PAROLA "MICHELE" E SULL’ AUTOGRAFO DI PAPA LEONE XIV A UNA BAMBINA.13 maggio 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA E #TEOLOGIA: "QUIS UT DEUS?" (" CHI E’ COME DIO?"). UNA PRECISAZIONE SU UNA #PAROLA FONDAMENTALE DELLA TRADIZIONE EVANGELICA: "#MICHELE" ("#QUIS UT DEUS?"). Un primo passo oltre la "religione" del #superuomo costantiniano (#Nicea 325-2025).
- Un omaggio alla memoria di Lorenzo Valla...
LA #DIVINA COMMEDIA (#DanteAlighieri) E L’ AUTOGRAFO DI PAPA LEONE XIV A UNA #BAMBINA. A proposito della parola greco-latina #Charitas ("Amore"), da non confondere con la parola latina "#Caritas" (nel senso di "#tesoro", di "#caro" prezzo), una spontanea e straordinaria #sollecitazione a riprendere il cammino della società e della #cultura dalla esatta #comprensione e dalla scrittura precisa del #nome "#Michela" (con #ch) nell’evento della prima firma pubblica di #papa #LeoneXIV, il giorno #8maggio2025.
- NOTE:
- CINEMA #STORIA #LETTERATURA E #FILOSOFIA "OMERICA": "IL MIO #NOME E’ #NESSUNO":
- "[...] Uscito nelle sale italiane il 21 dicembre del 1973, prodotto da #Sergio #Leone e sceneggiato da Ernesto Gastaldi, il #film ebbe un buon successo di pubblico, come già avvenuto negli anni precedenti per numerosi western all’italiana, a partire da Per un pugno di dollari del 1964. Il film giunse al quinto posto tra gli incassi del 1973. [...]" (cit).
- IMMAGINAZIONE SOCIOLOGICA E #FILOLOGIA AZIENDALE: GRANDI #RICCHEZZE E "BUONA" #CARESTIA ("#CARITAS") NELLA #TRADIZIONE DELLA #TEOLOGIA-#POLITICA #ITALIANA ED #EUROPEA [foto allegata].
- LA FINE DELL’ ERA "ICEBERGHIANA" E DEL #DESTINO DELLA #NECESSITA’ ( #ANANKE: VICTOR HUGO): LO SCIOGLIMENTO DELL’ANDROCENTRICO #CORPOMISTICO DEL "RE DELL’UNIVERSO" E L’USCITA DALLA "#PREISTORIA" (K. #MARX) .
- Una breve nota su una metafora "ghiacciata" e "agghiacciante"!
- "MEMORIA DEL #MONDO". In lode di Dante Alighieri, Victor Hugo, Sigmund Freud, e Italo Calvino...
- PSICOANALISI, #ANTROPOLOGIA, ED #ECOLOGIA: SOTTO LA #MONTAGNA (#BERG) DI #GHACCIO (#ICE), COSA C’E’ SE NON SOLO L’ ACQUA "SPORCA" E "RISCALDATA" DELLO STESSO CHIACCIO?
- Continuare ad usare l’ #iceberg, come metafora della coscienza della "specie" umana, non porta fuori dalla "diritta via" e impedisce di conoscere sé e, al contempo, che ciò che "galleggia" sull’oceano è solo la #testa, la #coscienza capovolta del luciferino Signore del #ghiaccio infernale, come aveva ben capito #Dante, nel momento stesso in cui con #Virgilio riesce ad attaccarsi al #vello di #Lucifero e venir fuori dalla #caverna in cui si era smarrito e da cui pensava di non poter più uscire? Non è forse meglio rimettere i piedi a terra (Inf. XXXIV, vv. 88-90: "Io levai li occhi e credetti vedere /Lucifero com’io l’avea lasciato, /e vidili le gambe in sù tenere") e rileggere non solo con Dante e Virgilio, ma anche con Maria Beatrice e Lucia il viaggio di ogni essere umano nello spazio-tempo cosmico in cui si svolge la #Commedia umana, la "divina Commedia"?
- Foto allegata: La "piramide" di #Bovillus (1510). Un omaggio al "#VerdeBrillante" di #StefanoMancuso e #AlessandraViola (Giunti Editore 2011)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- RIPENSANDO AL #GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI PAPA FRANCESCO.26 aprile 2025, di Federico La Sala
RIPENSANDO AL #GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI #SEGNAVIA DELL’#EREDITA’ DI JORGE MARIO #BERGOGLIO E DI #PAPA #FRANCESCO: "QUELLE SCARPE CONSUMATE" E LA "SCELTA" DELLA #BASILICA DI "SANTA MARIA MAGGIORE" (ROMA)
- Una nota a margine di una riflessione di Andrea Arena in omaggio e in memoria di Papa Francesco (26aprile 2025).
ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. "LE SCARPE CONSUMATE, I SORRISI SINCERI, E I DIALOGHI AUTENTICI" INDICANO, A MIO PARERE, IN UNA BREVISSIMA SINTESI ANTROPOLOGICA, I TRATTI ESSENZIALI DEL #VIAGGIO TERRENO E TERRESTRE DELL’#UOMO BERGOGLIO E DEL #PAPA FRANCESCO, DEL SUO #CAMMINARE #SINODALE ("CUM PETRO ET SUB PETRO", 2014), SUL "COME SI VA IN CIELO" (EVANGELICAMENTE), SUL "COME VA IL CIELO" (SCIENTIFICAMENTE ), E, APRENDO STORIOGRAFICAMENTE E FRANCESCANAMENTE MENTE OCCHI E CUORE, SUL COME E DA DOVE RIPARTIRE PER PORTARE AVANTI LA #SECONDA "#RIVOLUZIONECOPERNICANA": "VICISTI, #GALILAEE" (COSì #KEPLERO A #GALILEO, 1611).
FEDE E #SCIENZA: "DUE SOLI" (#DANTEALIGHIERI). LA BASILICA PAPALE DI #SANTAMARIAMAGGIORE E’ UN LUOGO LEGATO NON SOLO ALLA TRADIZIONE RELIGIOSA DEL CATTOLICESIMO-ROMANO E AL FAMOSO MIRACOLO DELLA #NEVE AD AGOSTO, MA ANCHE ALLA TRADIZIONE ARTISTICA E SCIENTIFICA DELL’EUROPA MODERNA, AL "SIDEREUS NUNCIUS" DI #GALILEO GALILEI (1610), E, ALL’OPERA DEL SUO AMICO PITTORE, #LUDOVICOCARDI, DETTO IL CIGOLI: [LA LUNA GALILEIANA, PRESENTE NEL QUADRO DELLA "IMMACOLATA CONCEZIONE CON APOSTOLI E SANTI", NELLA CAPPELLA PAOLINA DI SANTA MARIA MAGGIORE, INFATTI, E’ OPERA SUA.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "SÀPERE AUDE" (ORAZIO): IL FILO DEL "SERPENTE", LA VIA PER USCIRE DALL’INFERNO DELLA DIALETTICA TRAGICA.19 aprile 2025, di Federico La Sala
TEATRO (#STORIA) E #METATEATRO (#METASTORIA): GIUDA E GESU’, E, IL FILO DEL "SERPENTE", LA VIA PER USCIRE DALL’INFERNO DELLA #DIALETTICA TRAGICA (PLATONICO-PAOLINA ED HEGELIANA).
- ARCHEOLOGIA #FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA (#KANT, 1800). "Chi ama, ama al di là del premio e della pena" (Friedrich #Nietzsche, "Così parlò Zarathustra", parte IV: "Fuori servizio" - parole del vecchio papa, "a riposo", 1883-1885).
ALLA #LUCE DELLA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SUL TEMA PROPOSTO IN "Cain and Jesus in Gertrude’s Closet, Hamlet 3.4" (Paul Adrian Fried)), forse, è ora di decidersi ad accogliere coraggiosamente che per #Shakespeare, come per #DanteAlighieri, nel cammino verso la #sorgente stessa della Legge, "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145), l’unica possibilità di raggiungere la meta sta proprio nel pensare insieme (dialogicamente e amorosamente) la identità e la differenza tra i #due "fratelli" (al di là "del "bene e del male") e, così, capire che nel "cuore" di "entrambi" si annida (anagrammatica-mente) un "serpent-e" di #speranza, la modalità stessa del "#Trasumanar" (Par. I.70), di andare oltre l’#androcentrismo (e il "#cristocentrismo") della #cosmoteandria della "tragedia" e della "caduta". Rileggere la #Commedia: "E prima, appresso al fin d’este parole, / ‘#Sperent_in_te’ di sopr’a noi s’udì: a che rispuoser tutte le carole." (Dante Alighieri, Par. XXV, 97-99).
- BUONAPASQUA, #PASQUA2025...
- NOTA:
- ULTIMACENA, #EUCHARISTIA, "#TRADIMENTO" DI #GIUDA, #CROCIFISSIONE: IL "RICHIAMO" DEL "#SERPENTE" DI #MOSE’ ("#CappellaSistina", #Michelangelo - v. foto) E LA "PREPARAZIONE" ALLA #PASQUA DI #GUARIGIONE E #RESURREZIONE (DI OGNI #ESSEREUMANO).
- "SÀPERE AUDE" (ORAZIO): "[...] Dette queste cose, #Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di’, chi è colui a cui si riferisce?». Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a #Giuda #Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, #satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte." (Gv. 13, 21-30).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "ANTROPOLOGIA" E STORIA: DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO COSTANTINIANO E PAOLINO, QUALE IDEA DI EUROPA ANCORA E’ POSSIBILE?!18 aprile 2025, di Federico La Sala
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! DOPO DUEMILA ANNI DI CRISTIANESIMO COSTANTINIANO E PAOLINO, QUALE IDEA DI EUROPA ANCORA E’ POSSIBILE?!:
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- "CONFERIMENTO DEL PREMIO CARLO MAGNO. UNA CITAZIONE DAL "DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO. Sala Regia Venerdì, 6 maggio 2016":
- Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?.
"ANTROPOLOGIA" E STORIA DELLA "EUROPA, MADRE DELLE RIVOLUZIONI". Lo storico Friedrich Heer chiude l’opera così intitolata, appunto "Europa, madre di rivoluzioni" (1964; ed. it., 2 voll. Il Saggiatore, Milano 1968), con il capitolo finale riflettendo su "Il salto", cominciando con il paragrafo "il salto cifra per il XIX-XX secolo, Tutto è in movimento", e, concludendo con l’ultimo paragrafo, a "Marya Sklodowska-Curie", e così scrive: "[...] Marya Sklodowska-Curie appartiene agli uomini di una Nuova Era incipiente, i quali sanno che le battaglie sul fronte dell’uomo - contro la morte, l’assurdo, l’ingiusto, il male, la stupidità - devono essere combattute in nuove forme; richiedono l’intera vita; un pensiero rigoroso, autocritico, un sentimento puro [...]"; e, in nota, aggiunge e "insiste" (in modo "antropologicamente" e linguisticamente "cattolico"): "Nuove battaglie - sul fronte dell’uomo [...] Questo secolo (o per meglio dire: alcuni suoi uomini) ha cominciato a comprendere in modo nuovo, e a far propria, la parola oscura e profonda dell’apostolo Paolo: Noi uomini siamo gli eredi di Dio" (F. Heer, op. cit., II, p. 588 e p. 596).
Federico La Sala
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA "SOLLECITAZIONE" DI#DANTE ALIGHIERI A PAPA #GIOVANNI XXIII, A PORTARSI OLTRE LO SPIRITO DELLA TRAGEDIA.15 aprile 2025, di Federico La Sala
LA STORIA, LA LETTERATURA, I "SEGNI DEI TEMPI", E LA "SOLLECITAZIONE" DI#DANTE ALIGHIERI AD ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, PAPA #GIOVANNI XXIII, A PORTARSI OLTRE LO #SPIRITO DELLA #TRAGEDIA. Alcuni appunti sul tema...
A) - «DANTE E I #PAPI. L’influsso dell’Alighieri sul magistero di Giovanni XXIII: "[...] Dante è una delle fonti del pensiero teologico di Angelo Roncalli. Pertanto indichiamo tre cause, ma anche conseguenze, di questa affermazione: la formazione teologica e spirituale, la scelta del nome Giovanni XXIII, la ri-fondazione della cattedra di Teologia dantesca (a.a. 1961/1962), in coincidenza con la fase preparatoria del concilio. [...]"» (cfr. Gabriella M. Di Paola Dollorenzo, "Una delle fonti del pensiero teologico", L’Osservatore Romano, 14 dicembre 2020)
B) - UNA SVOLTA EPOCALE: DA "GIOVANNI XXII" (Jacques Duèze) A "GIOVANNI XXIII" (Angelo Giuseppe Roncalli ).
C) - I SEGNI DEI TEMPI: "L’espressione segni dei tempi fu usata per la prima volta ufficialmente nella bolla di Giovanni XXIII Humanae salutis (25.12.1961) con cui convocava il Concilio. Nell’enciclica Pacem in terris (11.4.1963) dello stesso Pontefice, diventa una categoria fondamentale. In modo chiaro, vengono in essa indicati #quattro segni dei tempi contemporanei: la socializzazione, l’emancipazione delle classi lavoratrici, l’ingresso della donna nella vita pubblica, la libertà dei popoli oppressi. [...]" (cfr. C. Floristán, "Dizionario sintetico di pastorale").
D) - ANTROPOLOGIA E CRISTIANESIMO, AL DI LÀ DEL PAOLINISMO: #DANTE #ALIGHIERI. «La #FenomenologiadelloSpirito... dei “#DueSoli”. Ipotesi di rilettura della “#DivinaCommedia”» (cfr. Federico La Sala, "IL DIALOGO/Quaderni di teologia", 24 luglio 2007).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION" ("HAMLET, III.1): L’URLO DI "JUDITH SHAKESPEARE". A MEMORIA DI VIRGINIA WOOLF.7 aprile 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (S. FREUD, 1929): L’URLO DI "JUDITH SHAKESPEARE".
A MEMORIA DI VIRGINIA WOOLF, a suo onore e gloria, forse, è bene rimeditare le sue stesse parole, "pronunciate" nella sua conferenza dedicata al tema di "Una stanza tutta per sé": "[...] sarebbe stato impossibile, completamente e interamente impossibile che una #donna scrivesse nell’epoca di Shakespeare le #opere di Shakespeare. Immaginiamo, giacché ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, diciamo." (Virginia Woolf, "Romanzi e Altro", Mondadori, Milano).
"TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION" ("HAMLET, III.1). Se si considera il luogo e la modalità della morte di Virginia Stephen Woolf, con i suoi particolari riferimenti ("appoggia il suo bastone da passeggio sull’argine dell’Ouse e poi si getta nelle acque del fiume"), data la dichiarata "sorellanza" di "Judith" con "William Shakespeare" e la sua urlata domanda amletica sul «Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna?», come non "registrare" (chissà se mai è stato fatto) la forte "consonanza" con il "racconto" della regina Gertrude sulla morte di Ofelia: "C’è un salice che cresce di traverso /a un ruscello e specchia le sue foglie /nella vitrea corrente; qui ella venne [...]" ("Amleto", IV. 7); e, come non sollecitar-si a una riletture delle opere degli "Shakespeare" e a una più ampia e profonda riflessione sulla "tragedia" della questione antropologica?!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- COSMOLOGIA. L’Universo, per il fisico Alan Guth, è «il più grande dei pranzi gratis». Sarà proprio così? (di A. Massarenti).31 marzo 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA ("CHARITAS), E MEMORIA DEL #CORAGGIO DI #ASSAGGIARE ("SÀPERE AUDE") (ORAZIO - KANT):
- L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».
Una lezione di "recupero" di antropologia filosofica di Armando Massarenti ("Il Sole 24 Ore", 24 aprile 2011):
Sicuri che nessun pasto è gratis?
«Nessun pasto è gratis», fu la risposta che un re ebbe dai suoi consiglieri dopo aver a lungo insistito per sapere, in un sola frase, quale fosse il senso della scienza economica. #Michael #Brooks, già autore del best seller "13 cose che non hanno senso", nel volume sulla #Fisica nella collana "Le grandi domande", diretta da #Simon #Blackburn (Edizioni Dedalo) esordisce con queste parole: «La bellezza della fisica si riassume in un fatto semplicissimo: un #bambino può fare domande cui nessun professore può rispondere».
Una di queste è «Perché non esistono pranzi gratis?». Che, in fisica, ci spinge a dare risposte in termini di «energia, entropia e ricerca del moto perpetuo». #LeonardodaVinci fece un’analisi dettagliata di una famosa macchina che pretendeva di generare il moto perpetuo, e spiegò perché non poteva funzionare. «O ricercatori del moto perpetuo», concludeva, «quante idee sconclusionate avete concepito nel corso di questa ricerca. Sareste pronti per andare a fare gli alchimisti». Cioè a sognare altri pranzi gratis. Eppure un pasto gratis sembrerebbe esistere, ed sarebbe niente meno che il nostro stesso Universo.
Per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis», e ciò è dovuto al concetto cosmologico di «inflazione»: «l’Universo e tutta l’energia che contiene si sarebbero sviluppati a partire da un grammo di materiale. Una frazione di secondo dopo il #BigBang, l’Universo era cento miliardi di volte più piccolo di un protone, ma nel giro di 10-34 secondi aveva già raggiunto una dimensione pari a 1025 volte quella di partenza - qualcosa di simile a una biglia» e da lì sì è espanso sempre più fino alle immensità attuali. Nel corso di questo processo l’energia interna dell’Universo è cresciuta di un fattore 1075, il che sembrerebbe violare il principio che impedisce di avere qualcosa in cambio di nulla.
Invece c’è un dettaglio che permette di restare nell’ambito delle leggi fisiche conosciute: una parte dell’energia è negativa, come mostra la teoria della relatività generale. «L’energia associata alla materia è positiva - riassume Brooks -, e la creazione continua di materia fece aumentare l’energia positiva in modo tale da compensare l’aumento dell’energia negativa. In questo modo l’energia totale può rimanere costante. Gli antichi Greci affermavano che nulla può essere creato dal nulla, ma l’inflazione si permette di non essere d’accordo». E di affermare dunque la totale #gratuità dell’Universo.
Sarà proprio così? Di certo, nella nostra vita, ahinoi, continua a vigere la dura legge degli #economisti.
- NOTA:
- UN "SOGNO" DI #TEOCRITO, LE GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE: UNA #DOMANDA DI ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...
- In ricordo di #LorenzoValla e di #GiambattistaVico, una breve nota....
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E MESSAGGIO EVANGELICO: IMPARARE A "SOGNARE".23 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #FILOLOGIA #ARCHEOLOGIA E "#CHARITAS":
IL "TONDO DONI" (#MICHELANGELO #BUONARROTI).
SE SI PENSA, COME SI CREDE ( «I Papi Giovanni XXIII e Francesco “sognatori” come san Giuseppe» ), CHE "secondo le Scritture i “#sognatori” sono «gli unici capaci di far andare avanti la storia», facendola «uscire dai vicoli ciechi creati dagli uomini». E san Giuseppe è il #modello «di ogni credente chiamato a essere un sognatore: uomini e donne che fanno la volontà di Dio; giusti che ascoltano la sua parola» [...]" (cfr. L’Osservatore Romano, 21 marzo 2025), ALLORA NON RESTA CHE "#SOGNARE", FARE IL #SOGNO DI TUTTI I BAMBINI E DI TUTTE LE BAMBINE DEL "MONDO", E, RICONOSCERE E RESTITUIRE A #GIUSEPPE, ACCANTO A #MARIA, E, A MARIA ACCANTO A GIUSEPPE, #DIGNITA’, #ONORE E #GLORIA.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANATOMIA PLATONISMO E CIVILTÀ: UNA NOTA A MARGINE DEL "VASO DI LACAN"21 marzo 2025, di Federico La Sala
PSICOANALISI ANTROPOLOGIA ANATOMIA E FILOSOFIA: "CLAUSTROFILIA" (ELVIO FACHINELLI, 1983) E "MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una svolta_antropologica" (Federico La Sala, 1991).
- In memoria di Enzo #Paci, di Elvio #Fachinelli e di Fulvio #Papi...
Una nota a margine dell’articolo di Gianfranco Ricci - Psicologo sul tema antropologico-psicoanalitico "Il vaso di Lacan" (v. allegato *):
Il "vas [o]" di "Lacan", a ben riflettere sulla "#concezione" lacaniana della donna e della #femminilità, è ancora pieno di memoria tragico-mammonico, di "spirito" #giocastolaio dello storico "compromesso olimpico" (apollineo-platonico-hegeliano e, "cum grano salis", nietzscheano).
PIANETA TERRA. Antropologicamente, e "terronicamente", invece, "uomo" e "donna" ("maschio" e "femmina"), sono, a "#coniugare" bene il discorso di #DanteAlighieri (come #RealdoColombo e #MichelangeloBuonarroti e #GiovanniValverde, e, ancora, di #GiordanoBruno, #GalileoG alilei e Immanuel #Kant), "#dueSoli" in Terra (illuminati) dal terzo "Sole" che è in Cielo. Questo attuale "presente storico", ormai, è, contro ogni evidenza, il tempo della Commedia, della #DivinaCommedia!
Il prossimo #25marzo 2025 è il giorno del #Dantedì, forse, è bene tenerne conto e uscire dal "#letargo" infernale.
- NOTA: COSMOTEANDRIA PLANETARIA. UN ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DI LUNGA DURATA: TUTTI A CENA, AL "SIMPOSIO" DI PLATONE , IN UNA "CAVERNA A LUCI-FERINE ROSSE". TUTTI ACCALCATI NELLA "STANZA DELLA SEGNATURA" A "COPIARE" LA "SCUOLA DI ATENE" (RAFFAELLO, 1509-1511) E, OGNUNO PER SE’, CERCARE DI DIVENTARE "SAPIENTE" (1509-1510) COME BOVILLUS, UN SAGGISSIMO (ATEO E DEVOTO) DELL’ACCADEMIE DEL PIANETA TERRA. Nella «notte in cui tutte le vacche sono nere» o nel «dì in cui tutte le pecore sono bianche», si continua a in-segnare e in-sognare platonicamente, che, «rompendo l’uovo si fa sì l’Homo ma anche l’Hommelette» (Lacan).
*
IL VASO DI LACAN
di Gianfranco Ricci (20 mar 2024)
Jacques Lacan ha dedicato oltre trent’anni della sua vita all’insegnamento pubblico della psicoanalisi: le sue lezioni, raccolte nei celebri “Seminari”, erano un vero e proprio evento nella Parigi degli anni Sessanta e Settanta.
Nella sua ricerca, Lacan faceva riferimento ad altri grandi studiosi, come Jacobson, Sartre, Claude Levi - Strauss, Godel e molti altri.
In particolare, Lacan farà riferimento agli studi antropologici e culturali di Levi - Strauss per introdurre in psicoanalisi i tre registri che, per lo strutturalismo, organizzano la realtà: il simbolico, l’immaginario e il reale.
La prima fase dell’insegnamento di Lacan, gli anni della sua giovinezza, vedono al centro il registro dell’immaginario: sono gli anni della ricerca sulla psicosi e dello stadio dello specchio.
Il “Lacan classico” degli anni Cinquanta e Sessanta invece mette al centro della propria ricerca il primato del Simbolico sugli altri due registri: è il Lacan del “Ritorno a Freud” e dell’“inconscio strutturato come un linguaggio”.
Negli anni Settanta invece l’insegnamento di Lacan mette al centro il registro, criptico ed enigmatico, del Reale. Lacan cercherà in ogni modo di trattare il Reale: come definire il Reale? Lacan cerca di “bordarlo” da diversi versanti: il Reale sarebbe l’impossibile a dirsi, la dimensione del godimento, ciò che sfugge al simbolico, la pulsione, il registro della pulsione di morte.
Per affrontare il Reale, Lacan introdurrà la clinica dei nodi, detta anche “clinica Borromea”, in onore del nodo Borromeo. La clinica dei nodi cerca di superare la concezione classica della clinica psicoanalitica, mettendo al centro il modo unico e singolare in cui i tre registri si “annodano” tra loro nell’esperienza di ciascun paziente.
Abbiamo parlato della passione di Lacan per i nodi in questo articolo.
 Nel corso del Seminario X, dedicato all’angoscia, Lacan introduce una metafora affascinante per descrivere il Reale; lo fa tramite la figura del vaso.
Nel corso del Seminario X, dedicato all’angoscia, Lacan introduce una metafora affascinante per descrivere il Reale; lo fa tramite la figura del vaso.Come è fatto un vaso? Un vaso è un oggetto che “borda”, che circoscrive uno spazio, con vari scopi: metterci dei fiori e del terriccio, oppure dell’acqua o magari nulla!
L’uso che facciamo del vaso lo rende pieno o vuoto. Ma di per sé, al vaso manca qualcosa?
- Dice Lacan:
“Così si dice, per esempio, che il reale è sempre pieno. Fa un certo effetto, ha una certa qual aria che conferisce credito alla cosa, un’arietta come quella che tira dalle nostre parti, quella di un lacanismo di buona lega.
Chi può parlare del reale, se non io? Il guaio è che io non l’ho mai detto.
Il reale formicola di cavità, ci si può persino fare il vuoto.
Io dico una cosa completamente diversa, cioè che al reale non manca nulla.
Ho aggiunto, che se si fanno dei vasetti. anche quando li si fa tutti uguali, è sicuro che siano differenti...
La mia storia dei vasetti continua. Il momento successivo è che la loro identità - ossia ciò che è scambiabile fra i vasetti - è il vuoto attorno al quale un vasetto è fatto.
E il terzo tempo è che l’azione umana ha inizio quando questo vuoto viene barrato per essere riempito con quello che farà il vuoto del vasetto accanto, in altri termini quando per un vasetto essere mezzo-pieno è la stessa cosa che essere mezzo-vuoto.
Sempre che, evidentemente, il vasetto non perde da tutte le parti.
In tutte le culture possiamo essere certi che una civiltà è ormai completa e insediata quando si trovano le prime ceramiche. Talvolta contempo una bellissima collezione di vasi che ho nella mia casa di campagna. Manifestamente per quelle genti, alla loro epoca, come testimoniano molte altre culture, era quello il bene principale.
Anche se non siamo in grado di leggere quanto è magnificamente, lussuosamente dipinto sulla loro superfici, anche se non riusciamo a tradurlo in un linguaggio articolato di riti e miti, c’è una cosa che sappiamo, e cioè che in quel vaso c’è tutto.
Il vaso basta.
Il rapporto dell’uomo con l’oggetto e con il desiderio sta interamente lì, vi è percepibile e lì sopravvive.
È proprio questo a legittimare quel famoso vasetto di senape che ha fatto digrignare i denti ai miei colleghi per più di un anno, a tal punto che io, gentile come sempre, ho finito per riporlo sul ripiano dei vasetti della colla. E dire che mi serviva! Lo portavo come esempio del fatto che a tavola il vasetto di senape è sempre vuoto, come sapete per esperienza.” (Sem X, pag. 201)
 Con il suo stile ironico e canzonatorio, Lacan parla del “vasetto in quanto tale”, al di là della sua funzione e del suo uso: in questo senso, fuori dal simbolico della funzione, il vasetto non manca di nulla.
Con il suo stile ironico e canzonatorio, Lacan parla del “vasetto in quanto tale”, al di là della sua funzione e del suo uso: in questo senso, fuori dal simbolico della funzione, il vasetto non manca di nulla.Il vaso è per Lacan metafora della femminilità: i critici della psicoanalisi accusavano Freud di avere declassato la femminilità, riducendola ad una posizione di inferiorità rispetto al maschile, come se le mancasse qualcosa. Lacan farà ordine, ribadendo la natura simbolica e non reale della castrazione.
- Risponde quindi Lacan:
“Il vaso femminile è vuoto, è pieno? Che importanza ha dato che basta a se stesso, quandanche fosse per consumarsi stupidamente, come si esprime la mia paziente.
Non vi manca niente.
La presenza dell’oggetto è qui, se così possiamo dire, in sovrappiù. Perché? Perché è una presenza che non è legata alla mancanza dell’oggetto causa del desiderio al (-φ), al quale è collegata invece nell’uomo .
L’angoscia dell’uomo è legata alla possibilità di non potere.
Da qui, il mito, tutto maschile, che fa della donna l’equivalente di una delle sue costole. Gli è stata tolta una costola, non sappiamo quale, e del resto non gliene manca nessuna. Ma è chiaro che nel mito della costola si tratta proprio di quell’oggetto perduto.
La donna, per l’uomo, è un oggetto fatto di questo.” (Sem. X, pag. 205)
 Per approfondire:
Per approfondire:
 Jacques Lacan, Il Seminario, Libro X, L’angoscia.
Jacques Lacan, Il Seminario, Libro X, L’angoscia.Anche in Freud troviamo il vaso come oggetto metaforico per descrivere un aspetto della psiche. Ecco qui l’articolo in cui viene approfondito questo aspetto.
Il reale quindi, per Lacan, "non manca di nulla". Questo è un dettaglio decisivo: se l’immaginario si manifesta per la sua inconsistenza e il simbolico per la presenza stessa della mancanza e dell’incompletezza, il reale invece "non mancherebbe di nulla".
Pertanto, il reale segue una logica propria, quella del godimento e della soddisfazione, facendosi beffe dei limiti imposti dal simbolico.
[Gianfranco Ricci, 20 mar 2024.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- IL "TONDO DONI", LA MATEMATICA, E L’ANTROPOLOGIA TERRESTRE. "Quel che è giusto fare" (De officiis"): "Ma poiché vi sono due specie di bellezza, delle quali una è la grazia, l’altra la dignità, dobbiamo considerare la grazia femminile e la dignità maschile" (Cicerone, "De officiiis")..19 marzo 2025, di Federico La Sala
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA: DA #DANTE ALIGHIERI E #MICHELANGELO #BUONARROTI, UNA SOLLECITAZIONE A RIPENSARE L’ UNO (#ONU), AL DI LA’ DEL #PLATONISMO E DEL #PAOLINISMO.
ARTE E ARITMETICA: IL "QUADRATO" DEL "CERCHIO". IL "TONDO DONI" E QUATTRO PROFETI (2+2= 4). Per la "Galleria degli Uffizi" nella cornice, sono "raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti". Ma, per Michelangelo, non è la testa di Gesù Cristo e non sono le teste di due profeti e #due #sibille?!
Non è meglio ri-#contare? Oppure è da ritenersi la punta di un "iceberg", di una questione antropologico-teologica "eterna"?!
Questa la "question" (Shakespeare): una questione antropologica e teologico-politica. Ri-pensare #comenasconoibambini: ri-considerare la #Relazione di "#Giuseppe e #Maria" e ri-meditare la lezione di Michelangelo Buonarroti. Solo così, forse, è possibile capire cosa significa il "ritrovamento" del Laocoonte e, altrettanto, come sia possibile liberare OGNI "UNO", ogni INDIVIDUO ("1") dalla "solitudine" e dall’immaginario bellico ("Homo homini lupus") e uscire dalla polifemica e luciferina "caverna" della #tragedia. (#19marzo 2025).
- NOTE:
- Questione antropologica e #cosmoteandria (#filologia e #cristologia), oggi (#19marzo 2025): "chi è questo figlio dell’#uomo?" (Gv. 12, 34). Come mai il silenzio totale di tutte le Accademie "platoniche" sulla #declinazione antropologica del messaggio evangelico ("Ecce #Homo") in chiave andrologica e costantiniana ("Ecce #Vir")? Non è questo un "meccanismo di rimozione" profondissima (S. #Freud, "Disagio della civiltà", 1929), che ha finito per spezzare le reni alla #Grecia e fatto diventare l’antropologia una #andrologia e, addirittura, il #Logos di #Efeso, il #logo di una #fattoriadeglianimali?! A che gioco giochiamo?! (#Dantedì, #25marzo 2025).
- STORIOGRAFIA #LETTERATURA E #ANTROPOLOGIA TERRESTRE: #DIVINA COMMEDIA. RICORDANDO L’INDICAZIONE DELLA #SOLARE "MONARCHIA" DI #DANTE ... e accogliendo, al contempo, l’invito dello storico #Remi #Brague a rimeditare la #saggezza (#wisdom) della #Romanitas ("IL FUTURO DELL’OCCIDENTE. Nel modello romano la salvezza dell’Europa", 1998), forse, è proprio "ora" e "qui" ("hegelianamente" e "cattolicamente") necessario e opportuno riprendere e portare avanti il filo antropologico-politico della lezione di #Cicerone a suo figlio #Marco:
- "Ma poiché vi sono due specie di bellezza, delle quali una è la grazia, l’altra la dignità, dobbiamo considerare la grazia femminile e la dignità maschile" ("Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero #venustas sit, in altero #dignitas, venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem.": "De officiis", I. 130).
- (#Dantedì, #25marzo 2025).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- CREATIVITÀ, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, E ANTROPOLOGIA. Una nota in memoria di Ester Boserup.14 marzo 2025, di Federico La Sala
SCRITTURA E SOCIETÀ: CREATIVITÀ, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, E ANTROPOLOGIA.
- In memoria di Ester Boserup (1910 -1999)
A PARTIRE DALL’ALFABETO, DALL’#ALFA E DALL’#OMEGA. Se consideriamo che già #Democrito era riuscito (non solo a #ridere, ma anche) a concepire una #cosmologia fondata su atomi-lettere e, quindi, la possibilità di costruire una macchina che potesse "rac-contare" automatica-mente la "storia del cosmo", o, che è lo stesso, che un giorno fosse facile ottenere esatte mappe del cielo del passato, questo ci dice che abbiamo portato avanti un programma "scientifico", imbozzolato nelle coordinate di un vecchio "#storytelling" cosmoteandrico. Aveva ragione #Whitehead (con #BertrandRussell, autore dei "#Principia #Mathematica"): "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine su #Platone".
Se questo è, che fare, oggi, se non andare oltre l’antico programma, codificato nella "macchina" di "scrittura" della #tragedia, e portarsi fuori dal rapporto sociale di produzione "cinematografico" platonico?
La narrazione di un "mondo come volontà e rappresentazione" cosmoteandrica di un #Autore #Sovrano, a tutti i livelli, è finita, e, se non si vuole restare asfissiati nella sua "#caverna", non si può non seguire #DanteAlighieri e cercare di ritrovare la diritta via della #commedia!
LA PRODUZIONE DEL GRANO (ARATURA, SEMINAGIONE, SARCHIATURA, E TREBBIATURA) E IL "RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE" ("PRENDETE E MANGIATE"). Considerato che la nascita dell’#agricoltura e l’invenzione dell’#aratro "camminano insieme" e, ancora, che la stessa "direzione di scrittura dei Greci fu dapprima bustrofedica (cioè con una direzione alterna: una riga da destra verso sinistra e la successiva da sinistra verso destra, come il tracciato che un aratro trascinato da un bue disegna sul campo) e in seguito essa divenne solamente destrorsa, cioè da sinistra verso destra" (cfr. Francesco De Renzo, "Alfabeto", Treccani, 2005), è bene ricordare lo stravolgimento epocale prodotto dall’aratro nella storia dell’eco-nomia e dell’ecologia (nella "#casa" degli esseri umani):
- "Due grandi rivoluzioni: la nascita dell’agricoltura e l’invenzione dell’aratro. [...] L’uomo primitivo usava bastoni per forare il terreno e apporvi il #seme, in seguito modificò lo strumento per creare zappette che erano inefficienti nel garantire la preparazione del #letto di #semina. Pertanto l’invenzione dell’aratro, che ha luogo in Mesopotamia nel IV millennio a.C. ad opera dei Sumeri, è un evento rivoluzionario perché aumenta in modo rilevante la produttività dell’agricoltura consentendo la creazione di quelle eccedenze di cibo che sono alla base della genesi di società complesse basate sulla #divisione del lavoro. L’aratura è una pratica antica, il poeta latino #Virgilio lo considerava “lavoro dell’uomo e dei buoi in grado di rivoltare la #terra” [...]" (SDF Archivio Storico).
- NOTE:
- "SAPERE AUDE!" (KANT): UNA “NOTA” DI “RISCHIARAMENTO” SUI “RAPPORTI SOCIALI DI PRODUZIONE”, SULL’#ECONOMIA POLITICA, SULLA #STORIA, E SULL’ #ANTROPOLOGIA ...
- “Pioniere. #Ester Boserup e il ruolo delle #donne in #agricoltura:
- [...] Nel 1970 pubblica il suo Woman’s role in economic development, quasi un manifesto per ciò che diventerà il programma Women in development (Wid) delle Nazioni Unite. #Boserup descrive per i paesi in via di sviluppo un sistema di produzione agricolo in cui gradualmente le donne passano da sistemi di produzione autogestiti che le vede economicamente indipendenti, a sistemi all’europea in cui finiscono con l’essere alle dipendenze dei coniugi, senza essere retribuite. L’attacco nei confronti dei colonizzatori europei è diretto e senza mezzi termini. [...]” (Marcella Corsi, “inGenere.it”, 02 Agosto 2016).
- AGRICOLTURA, STORIA, E SOCIETA’: "LA CAMPAGNA APPENA IERI". La #sarchiatura del #grano. (Fbook, 11 marzo 2025).
- ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA CRITICA: LA RIVOLUZIONE COPERNICANA, IN #ASTRONOMIA (#COPERNICO, 1543) E IN #ANATOMIA (#VALVERDE, 1560) E IL PERSISTERE DELLA "#AGRICOLTURA" DELLA #TRAGEDIA DELLA TRADIZIONE TEOLOGICO-POLITICA PLATONICO-COSTANTINIANA (NICEA, 325-2025).
- "I TESTICOLI DELLE DONNE: Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]": così inizia il cap.15 dell’Anatomia di #GiovanniValverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli delle donne” (p. 91).
-
> CREATIVITÀ, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, E ANTROPOLOGIA. --- INDIVIDUO E SOCIETA’: LA "ROBINSONATA" DI UN "PLATONISMO" DI MILLENNI:15 marzo 2025, di Federico La Sala
INDIVIDUO E SOCIETA’: COME NASCE LO STATO?
LA "ROBINSONATA" DI UN "PLATONISMO" DI MILLENNI: SOCRATE RISPONDE ALLA DOMANDA SUL COME NASCE LA SOCIETA’, MA NON ANCHE SUL COME NASCE L’INDIVIDUO.
UNA "CITAZIONE" DALL’OPERA DI PLATONE, "REPUBBLICA ["POLITEIA"]" (II, 368-371):
- SOCRATE AD ADIMANTO: "[...] Noi affermiamo che esiste una giustizia del singolo individuo e in certo senso anche quella di uno stato intero, no? - Senza dubbio, ammise. - Ora, uno stato non è maggiore di un individuo? - Maggiore, sí, rispose. - Ebbene, in un àmbito maggiore ci sarà forse piú giustizia e la si noterà piú facilmente. Perciò, se volete, [369 a] cerchiamo prima negli stati che cosa essa sia. Esaminiamola poi con questo metodo anche in ogni individuo e cerchiamo di cogliere nelle caratteristiche del minore la somiglianza con il maggiore. - Cosí va bene, mi sembra, rispose. - Ora, ripresi io, se non di fatto, ma a parole assistessimo al processo di nascita di uno stato, non vedremmo nascere pure la giustizia e l’ingiustizia? - Forse sí, ammise. - E se ciò avviene, non possiamo sperare di scorgere piú agevolmente il nostro obiettivo? - Molto [b] di piú, certo. - Ora, secondo voi, dobbiamo tentar di andare sino in fondo? Non la credo una impresa da poco, e quindi pensateci su! - Ci abbiamo già pensato, disse Adimanto. Via!, fa’ come hai detto.
- Secondo me, ripresi, uno stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso, ma ha molti bisogni. O con quale altro principio credi che si fondi uno stato? - Con nessun altro, rispose. - Cosí per un certo [c] bisogno ci si vale dell’aiuto di uno, per un altro di quello di un altro: il gran numero di questi bisogni fa riunire in un’unica sede molte persone che si associano per darsi aiuto, e a questa coabitazione abbiamo dato il nome di stato. Non è vero? - Senza dubbio. - Quando dunque uno dà una cosa a un altro, se gliela dà, o da lui la riceve, non lo fa perché crede che sia meglio per sé? - Senza dubbio. - Suvvia, feci io, costruiamo a parole uno stato fin dalla sua origine: esso sarà creato, pare, dal nostro bisogno. - Come no? - Ora, il primo e maggiore [d] bisogno è quello di provvedersi il nutrimento per sussistere e vivere. - Senz’altro. - Il secondo quello di provvedersi l’abitazione, il terzo il vestito e simili cose. - Sí, sono questi. - Ebbene, dissi, come potrà bastare lo stato a provvedere tutto questo? Non ci dovranno essere agricoltore, muratore e tessitore? E non vi aggiungeremo pure un calzolaio o qualche altro che con la sua attività soddisfi ai bisogni del corpo? - Senza dubbio. - Il nucleo essenziale dello stato sarà di quattro o cinque [e] persone. - È evidente. - Ebbene, ciascuna di esse deve prestare l’opera sua per tutta la comunità? Cosí, per esempio, l’agricoltore, che è uno, deve forse provvedere cibi per quattro e spendere quadruplo tempo e fatica per fornire il grano e metterlo in comune con gli altri? o deve evitarsi questa briga e produrre per sé soltanto un [370 a] quarto di questo grano in un quarto di tempo? e impiegare gli altri tre quarti del tempo uno a provvedersi l’abitazione, uno il vestito, uno le calzature? e non prendersi per gli altri i fastidi che derivano dai rapporti sociali, ma badare per conto proprio ai fatti suoi? Rispose Adimanto: - Forse, Socrate, la prima soluzione è piú facile della seconda.
 Nulla di strano, per Zeus!, io dissi. Le tue parole mi fanno riflettere che anzitutto ciascuno di noi nasce per natura completamente diverso da ciascun altro, [b] con differente disposizione, chi per un dato compito, chi per un altro. Non ti sembra? - A me sí. - Ancora: agirà meglio uno che eserciti da solo molte arti o quando da solo ne eserciti una sola? - Quando da solo ne eserciti una sola, rispose. - È chiaro d’altra parte, credo, che se uno si lascia sfuggire l’occasione opportuna per una data opera, questa opera è perduta. - È chiaro, sí. - L’opera da compiere non sta ad aspettare, credo, i comodi di chi la compie. E chi la compie deve starle [c] dietro, senza considerarla un semplice passatempo. - Per forza. - Per conseguenza le singole cose riescono piú e meglio con maggiore facilità quando uno faccia una cosa sola, secondo la propria naturale disposizione e a tempo opportuno, senza darsi pensiero delle altre. - Perfettamente.
Nulla di strano, per Zeus!, io dissi. Le tue parole mi fanno riflettere che anzitutto ciascuno di noi nasce per natura completamente diverso da ciascun altro, [b] con differente disposizione, chi per un dato compito, chi per un altro. Non ti sembra? - A me sí. - Ancora: agirà meglio uno che eserciti da solo molte arti o quando da solo ne eserciti una sola? - Quando da solo ne eserciti una sola, rispose. - È chiaro d’altra parte, credo, che se uno si lascia sfuggire l’occasione opportuna per una data opera, questa opera è perduta. - È chiaro, sí. - L’opera da compiere non sta ad aspettare, credo, i comodi di chi la compie. E chi la compie deve starle [c] dietro, senza considerarla un semplice passatempo. - Per forza. - Per conseguenza le singole cose riescono piú e meglio con maggiore facilità quando uno faccia una cosa sola, secondo la propria naturale disposizione e a tempo opportuno, senza darsi pensiero delle altre. - Perfettamente.
 Occorrono dunque, Adimanto, piú di quattro cittadini per provvedere quanto dicevamo: ché l’agricoltore, come sembra, non si costruirà lui stesso da solo l’aratro, se ha da essere un buon aratro, né la zappa né [d] gli altri attrezzi agricoli. Né d’altra parte si costruirà i propri arnesi il muratore: gliene occorrono molti. E cosí il tessitore e il calzolaio. No? - È vero. - Ecco dunque che carpentieri, fabbri e molti altri simili artigiani verranno a far parte del nostro staterello e lo renderanno popoloso. - Senza dubbio. - Ma non sarebbe ancora troppo grande se vi aggiungessimo bovai, pecorai e le altre categorie [e] di pastori: ciò perché gli agricoltori possano avere buoi per l’aratura, e i muratori servirsi, insieme con gli agricoltori, di bestie da tiro per i loro trasporti, e i tessitori e i calzolai disporre di pelli e di lane. - Ma con tutta questa gente, ribatté, non sarebbe neanche piccolo il nostro stato. - D’altra parte, ripresi io, è pressoché impossibile fondarlo in un luogo che renda superflue le importazioni. - Impossibile. - Occorreranno quindi altre persone ancora per portargli da un altro stato la roba che gli abbisogna. - Occorreranno, sí. - E se il nostro agente si presenta a mani vuote senza alcuno dei prodotti occorrenti a chi ci fornisce le merci d’importazione [371 a] necessarie per i nostri cittadini, se ne verrà via a mani vuote, non è vero? - Mi sembra di sí. - La produzione interna deve dunque non solo bastare ai cittadini stessi, ma anche rispondere per qualità e quantità alle esigenze di coloro dei quali i nostri cittadini possono avere bisogno. - Deve, sí. - Al nostro stato occorre perciò un maggiore numero di agricoltori e di altri artigiani. - Sí, un numero maggiore. - E anche di altri agenti, a mio avviso, destinati a importare e ad esportare le singole merci. Sono questi i commercianti, non è vero? - Sí. - Ci abbisogneranno dunque anche i commercianti. - Senza dubbio. - E se poi il commercio si svolge per mare, [b] occorreranno ancora molti altri, pratici del lavoro marittimo. - Molti altri, certo. [...]" (Platone, "Opere complete", 6, Laterza, Bari, 1971, pp. 85-87).
Occorrono dunque, Adimanto, piú di quattro cittadini per provvedere quanto dicevamo: ché l’agricoltore, come sembra, non si costruirà lui stesso da solo l’aratro, se ha da essere un buon aratro, né la zappa né [d] gli altri attrezzi agricoli. Né d’altra parte si costruirà i propri arnesi il muratore: gliene occorrono molti. E cosí il tessitore e il calzolaio. No? - È vero. - Ecco dunque che carpentieri, fabbri e molti altri simili artigiani verranno a far parte del nostro staterello e lo renderanno popoloso. - Senza dubbio. - Ma non sarebbe ancora troppo grande se vi aggiungessimo bovai, pecorai e le altre categorie [e] di pastori: ciò perché gli agricoltori possano avere buoi per l’aratura, e i muratori servirsi, insieme con gli agricoltori, di bestie da tiro per i loro trasporti, e i tessitori e i calzolai disporre di pelli e di lane. - Ma con tutta questa gente, ribatté, non sarebbe neanche piccolo il nostro stato. - D’altra parte, ripresi io, è pressoché impossibile fondarlo in un luogo che renda superflue le importazioni. - Impossibile. - Occorreranno quindi altre persone ancora per portargli da un altro stato la roba che gli abbisogna. - Occorreranno, sí. - E se il nostro agente si presenta a mani vuote senza alcuno dei prodotti occorrenti a chi ci fornisce le merci d’importazione [371 a] necessarie per i nostri cittadini, se ne verrà via a mani vuote, non è vero? - Mi sembra di sí. - La produzione interna deve dunque non solo bastare ai cittadini stessi, ma anche rispondere per qualità e quantità alle esigenze di coloro dei quali i nostri cittadini possono avere bisogno. - Deve, sí. - Al nostro stato occorre perciò un maggiore numero di agricoltori e di altri artigiani. - Sí, un numero maggiore. - E anche di altri agenti, a mio avviso, destinati a importare e ad esportare le singole merci. Sono questi i commercianti, non è vero? - Sí. - Ci abbisogneranno dunque anche i commercianti. - Senza dubbio. - E se poi il commercio si svolge per mare, [b] occorreranno ancora molti altri, pratici del lavoro marittimo. - Molti altri, certo. [...]" (Platone, "Opere complete", 6, Laterza, Bari, 1971, pp. 85-87).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- L’ HAMLETICA QUESTIONE DI UNA ACCA (H), E UNA "SORPRENDENTE" LEZIONE DALLA "GAIA SCIENZA" E DALLA "DIVINA COMMEDIA"..12 marzo 2025, di Federico La Sala
L’EUROPA, L’ HAMLETICA QUESTIONE DI UNA ACCA (H), E UNA "SORPRENDENTE" LEZIONE DALLA #GAIA SCIENZA E DALLA #DIVINA COMMEDIA. Materiali sul tema
- In memoria di #DanteAlighieri, #FriedrichNietzsche, e di #GianniVattimo...
"Sàpere aude!"(#Kant). Siccome, ormai e "finalmente" non solo gli "analfabeti" ma anche i "litterati", tutti e tutte non riescono più a "orientarsi nel pensiero" e nella realtà, nemmeno a capire "un’ acca", o, che è lo stesso, "un’ostia", forse, è il caso di ricominciare dal "principio" (dalla "Alfa") e, possibilmente, cercare di arrivare alla fine (alla "Omega")!
ANTROPOLOGIA INFANZIA STORIA E FILOLOGIA. Come ha scritto in Giorgio #Agamben, in una sua nota su "L’invenzione del nemico" (Quodlibet, 31 maggio 2024), "Se nella religione - con la quale l’Europa si identificava - non credono più nemmeno i preti, anche la politica ha perduto ormai da tempo la capacità di orientare la vita degli individui e dei popoli", significa proprio non riuscire più a distinguere "eu-#carestia" da "eu-#charistia", "dio-mammona" ("#caritas") da "dio-amore" (#charitas), non significa che "Dio è morto", che "non c’è più religione", e che il #nichilismo trionfa e trionferà, alla grande (come ha scritto e chiarito #Nietzsche)?!
Non è meglio rimettersi in cammino e seguire Dante e i suoi "due Soli", il suo "#Virgilio" e la sua "#Beatrice"?! (Dantedì, #25marzo 2025).
- NOTA:
- "AL DI LA’ DEI #CIELI. LA SEDE DEL FILOSOFO TEDESCO #NIETZSCHE": "[...] Le sue parole furono ardite e il suo pensiero grandioso, spaccò in due gli Europei con la spada del suo dire. Nessun compagno trovò alla sua estasi: estatico, lo considerarono pazzo [...]" (#Muhammad #Iqbal, "Il #Poema #celeste" - 1932, Bari 1965).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- RIPENSARE L’UNO, ri-pensare l’ONU - a partire da DUE, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’orizzonte della tragedia.10 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #STORIA D’#EUROPA (#8MARZO 2024 / #10MARZO 2025): RICORDANDO #DANTEALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA,
 RIPENSARE L’#UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia.
RIPENSARE L’#UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia."DIVINA COMMEDIA": CON #DANTE (#25MARZO 2025), OLTRE #VERSAILLES E OLTRE L’ #ANDROCENTRISMO DI NAPOLEONE: LA #FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-#MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO "MAMMONICO" DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "Senza indugio", e il sottotitolo "Con voce di donna. Omelie per l’anno C" sembrano il segno di un cambiamento dei tempi riguardo alla presenza e al ruolo delle donne nella Chiesa (di Laura Destro)1 marzo 2025, di Federico La Sala
“Senza indugio”: le donne e la parola
di Laura Destro (SettimanaNews, 10 febbraio 2025)
Il titolo del libro, "Senza indugio", e il sottotitolo "Con voce di donna. Omelie per l’anno C" sembrano il segno di un cambiamento dei tempi riguardo alla presenza e al ruolo delle donne nella Chiesa.
Anche la data scelta per la presentazione del libro, il 17 gennaio, giorno natale della beata Osanna Andreasi, laica domenicana, e la cornice suggestiva della sua casa, a Mantova, evidenziano un cambio di paradigma. Tutta al femminile è stata l’organizzazione dell’evento, curata dal gruppo diocesano «Donne e Chiesa», che dal 2021 si impegna nella valorizzazione di donne − come la beata Osanna − che hanno segnato il cammino della Chiesa nei secoli e oggi.
Frutto della collaborazione del Coordinamento Teologhe Italiane - associazione che promuove studi di genere in ambito teologico, biblico, patristico, storico - è il libro in questione. Lo presentano la teologa Cristina Simonelli, storica esponente del Coordinamento, e il biblista don Lorenzo Rossi.
Prezioso il contributo delle donne “nell’ascolto e nella narrazione della Parola” - dice il vescovo Marco Busca nella sua introduzione. “La Parola ci supera”; per questo c’è bisogno di una molteplice narrazione e “ognuno, [in quanto] parte di questa comunicazione, la restituisce secondo i propri carismi”.
“Gesù è nato da donna” dice Paolo in Galati, 4,4. Ed è nella casa di Nazareth che Gesù apprende il suo vocabolario, frutto sì della potenza della parola del Padre ma anche di quella di un uomo e di una donna. Di Maria che, “tessitura di carne e di Parola”, è l’uditrice per antonomasia.
Nel mezzo di una festa di nozze (Gv 2,1-11), una figura di donna “si distacca” all’improvviso; è la madre di Gesù, che si accorge che non c’è più vino. Anche noi - scrive ancora mons. Busca - abbiamo bisogno, nella interpretazione delle Sacre Scritture, di una parola “forte”, come il vino buono delle giare. La “sapienza” delle dieci donne autrici delle Tracce per le Omelie, conferisce, con il suo “sapore”, nuova forza alla Parola.
La liturgia e la Parola
Per un credente è fondamentale essere coscienti della centralità della Liturgia e della Parola e a tale scopo fruire di tutte le voci e sensibilità che all’interno di una comunità possono contribuire a estendere all’ Assemblea la portata dell’impianto liturgico e la potenza della Scrittura.
Il termine Tracce, riportato nel sottotitolo, evidenzia il ruolo corale della comunità nello scavo dei passi tratti dal Vangelo di Luca, mentre il titolo descrive l’andare “senza indugio” di Maria da Elisabetta, dei pastori all’annuncio, dei discepoli di Emmaus di nuovo a Gerusalemme.
Condividere degli “orizzonti” di significato è stato il presupposto da cui le studiose del Coordinamento hanno preso le mosse per la stesura delle loro Tracce.
La sensibilità femminile attraversa tutto il libro; tuttavia, da tempo, appartiene all’ordinarietà della procedura, dice Cristina Simonelli - e la sua esperienza di vita in parrocchia lo conferma - costruire le omelie comunitariamente. Anche per don Lorenzo Rossi le riflessioni domenicali sono il frutto di una condivisione; cosa che permette di ridimensionare il protagonismo del presbitero all’ambone e di far emergere il ruolo che la comunità (donne e uomini) svolge nella meditazione della Parola. Omelia è “risposta ecclesiale alla Parola” non “spiegazione”. Ciò che il presbitero offre è più della sua parola, in quanto espressione della comunità.
“Spezzare la Parola” comporta non solo condivisione di orizzonti - dice la teologa Simonelli - ma formazione. Per rimanere aderenti ai testi ed evitare improvvisazioni e forzature funzionali al momento, è necessaria una solida preparazione. Se è importante la voce femminile nell’interpretazione della Parola, la Chiesa deve investire sulla formazione di figure a cui affidare docenze a livello universitario e seminari, come avviene per i maschi.
Don Lorenzo Rossi, rettore del Seminario diocesano, vicedirettore dell’ISSR “San Francesco” di Mantova e docente presso la Facoltà teologica di Milano, dice che la maggior parte degli utenti dell’ISSR mantovano è donna.
“Senza indugio”: la voce delle donne
Le Tracce, pur essendo un contributo individuale, non riportano il nome dell’autrice, facendo del libro il frutto di una coralità, segno distintivo della femminilità.
Il Vangelo di Luca, proclamato nell’anno C, ha spesso come protagoniste le donne, “non perché Luca sia da considerare un femminista ante litteram” - afferma don Lorenzo Rossi − ma per il suo universalismo[1]. La salvezza è per tutti[2], anche per le donne, in quanto “concordi e perseveranti nella preghiera”[3].
Alcune riflessioni presenti nelle Tracce danno conto del diverso rapporto delle donne con Gesù e della particolare sensibilità delle autrici nel rilevarlo.
Maria è prima di tutto madre e la maternità nel passo della nascita[4] si esplica in tutta la sua pienezza. Gli angeli annunciano ai pastori “un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”, ma il loro sguardo coglie solo la seconda parte dell’annuncio, cancellando il gesto della fasciatura e rendendo “invisibile” chi quel gesto l’ha compiuto e chi quel “corpo l’ha lavato e rivestito” prima di adagiarlo nella mangiatoia.
Maria - “teologa silenziosa” - coglie nel silenzio questa parzialità “custodendo e meditando” in profondità “il senso delle cose”.[5]
Maria è anche colei che, rifiutando la logica di una mortifera “ferialità” - così la teologa definisce una quotidianità sbiadita - e sentendo il “desiderio profondo della felicità”, in modo “impertinente”, davanti ad un consesso di uomini, sollecita il figlio con “Non hanno più vino”.
Non possiamo solo “autoconservarci ... esaurendo ... la nostra vitalità” - è il commento - ma vivere con generosità, e fare in modo che anche gli sforzi apparentemente inutili - acqua al posto del vino - siano compiuti alla “presenza vivificante di Dio”[6].
“Rallegrati, o piena di grazia” è questo il saluto dell’angelo a Maria narrato nel Vangelo di Luca e proclamato nel giorno dell’Immacolata. Maria è la “graziosa”, la “gratificata” da Dio; il suo sì alla chiamata non la asservisce ma, serva rinnovata, la fa pronta a corrispondere al disegno divino e, a “collaborare al mistero dell’incarnazione”. In questa capacità di “ricevere e trafficare il dono ricevuto” è insita una santità “costitutiva e originaria”, modello di quella santità a cui Dio ci chiama[7].
“Discepole” vengono definite, a vario titolo, altre figure femminili. È a Maria di Magdala che Gesù risorto si rivela e, affidandole l’incarico di divulgare il Kerygma, da discepola la trasforma in “apostola” di una nuova sequela, quella della “vite e i tralci”[8]. In questa veste, da lei inizia una comunità fondata sulla fede nella Resurrezione, capace di ricevere lo Spirito Santo come suo dono.
Anche la peccatrice, entrata nella casa di Simone il fariseo durante il banchetto fra i cui ospiti c’è Gesù, ha la postura della discepola: “dietro” e “ai suoi piedi”, che ella bagna con le lacrime del pentimento delle sue colpe e che asciuga con i suoi capelli. Ma, mentre Simone, pensandosi “un debitore- base”,” non peggio degli altri”, sta nel banchetto al fianco di Gesù, ritenendo “legittimo” il perdono ricevuto, la postura della donna è “esagerata”, “eclatante”, come è stata la sua vita di peccatrice, che ora, riconoscente, sente che le è stata “condonata”[9].
Nella stessa posizione - “ai piedi di Gesù” - è Maria di Betania.
Il suo atteggiamento non rispetta il “protocollo dell’accoglienza” previsto per le donne e, a differenza della sorella Marta, tutta indaffarata, fa “la sola cosa buona di cui c’è bisogno”. La “scelta, l’ascolto, la messa in discussione della propria identità, la consapevolezza” è tutto questo la parte buona che non le potrà essere tolta, dice Gesù.[10]
A questo particolare sguardo sulle donne e al modo fiero con cui le teologhe ce l’hanno consegnato va la nostra gratitudine.
[1] At. Ap.
[2] Gal 3, 28, “Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo”
[3] At. 1, 12-14
[4] Lc, 2,16-21
[5] Coordinamento Teologhe Italiane (a cura di), Senza indugio − Con voce di donne. Omelie per l’anno C; EDB ed.; Bologna, 2024, 37-39
[6] Ivi, 125-127
[7] Ivi, 279-281
[8] Ivi, 82-83
[9] Ivi, 161-163
[10] Ivi, 182-183
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "Senza indugio. Con voce di donna. Omelie per l’anno C" (EDB 2024). Nota di presentazione di Marco Busca.2 marzo 2025, di Federico La Sala
"Senza indugio. Con voce di donna. Omelie per l’anno C" (EDB 2024).
Ho conosciuto un ragazzo della comunità Bahá’í, appassionato di san Paolo, che durante una conversazione ha usato questa frase: “sono affamato di narratori di Dio”. Dio si lascia raccontare. Celebra in noi e con noi una liturgia di parola e di parole in cui il lettore - che si fa interprete e poi narratore - diventa parte del messaggio, con la sua carne, la sua cultura, la sua età, il suo genere, la sua sensibilità spirituale. Abbiamo bisogno di convergenze e divergenze di risonanze e narrazioni per “balbettare” la Parola che culmina in una liturgia di Silenzio, grembo puro di accoglienza e adorazione. Il mistero che supera tutti ci “ammutolisce”, pur suscitando una continua espressività multiforme di cui abbiamo bisogno.
C’è bisogno di una narrazione di generazioni: risonanze di bambini e di anziani, intuizioni folgoranti dei piccoli e parole misurate, piene di anni di lettura, di sapienti vegliarde e di saggi anziani. La profezia sembra prediligere le labbra degli infanti e dei vecchi: “Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza, a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l’avversario e il vendicatore” (Salmo 8,3); “Uno degli anziani mi disse: Non piangere; ha vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli” (Ap 5,1-14).
Abbiamo bisogno di narrazioni di genere: “non c’è più né uomo né donna”, si legge nella lettera ai Galati che pare relativizzare le “differenze” o, meglio, finalizzarle all’essere una cosa sola in Cristo (cap. 3,28); ma di lì a poche righe, presentando l’identità di Gesù, Paolo afferma che “Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge” (Gal 4,4). Una sottolineatura necessaria non solo ad attestare la storicità dell’incarnazione. L’espressione, infatti, è densa di contenuto antropologico e religioso. Entrambi i significati riassunti nelle due parole “donna” e “legge”.
La grande uditrice della Torà è Maria di Nazareth che ha intessuto con la matassa del suo sangue rosso la carne del Logos divino, come ci è dato di ascoltare negli inni della tradizione siro-palestinese e di vedere nelle icone e negli antichi mosaici. Tessitura di carne e di parole poiché il figlio di Dio è cresciuto in età e sapienza nella casa di Nazareth apprendendo il vocabolario della madre e del padre. Le “parole di grazia” che usciranno dalla bocca del figlio di Giuseppe (cfr. Lc 4,22) non sono solo le cose udite dal Padre che il Figlio ha fatto conoscere a noi (cfr. Gv 15,15), sono anche le parole della Torà udite sulle labbra di un padre e una madre, due pii israeliti, che hanno contribuito a dare parole alla Parola perché un giorno la Parola potesse arrivare alle orecchie e al cuore di quel popolo e della sua cultura. Le loro parole “sante”, risonanze di salmi e profezie, come pure le parole dei lavori quotidiani e il dialetto degli affetti che risuonavano nella casa di Nazareth, hanno contribuito a meritare a Gesù quel complimento ammirato: “Mai un uomo ha parlato come parla quest’uomo!»” (Gv 7,46). Gesù è un Rabbi che insegna “come uno che ha autorità” (Mc 1,22), autorità che gli viene dall’alto in quanto è il Logos che “tutto sostiene con la sua parola potente” (Eb 1,3), ma anche insegnamento efficace che gli deriva dall’autorità della parola umana appresa da Maria e Giuseppe che, con il loro parlare genitoriale, hanno espresso la forma autentica del maschile e del femminile che si è impressa nell’umanità del Figlio dell’uomo ed è risuonata nei suoi approcci salvifici alle donne e alle coppie.
La liturgia della Chiesa celebra tra pochi giorni la seconda domenica del tempo ordinario che proclama la pagina evangelica che Giovanni dedica al primo dei segni compiuti da Gesù a Cana di Galilea (Gv 2,1-11).
Trovo un elogio mariano nel commento proposto dalla professoressa Donata Horak che condivido: “Ma ecco, tra le tante persone invitate alla festa si distacca una figura di donna, una vera credente, l’unica coscienza risvegliata che si accorge che il vino si sta esaurendo: sente che la festa rischia di scivolare nella ferialità delle abitudini e delle consuetudini sociali, che perderà il sapore, l’ebbrezza, il calore” (p. 126). La Chiesa è ancora e sempre la sala nuziale pensata dal Padre per festeggiare con abbondanza di invitati e di vino le nozze del suo Figlio con l’umanità. Non mancano gli assetati e affamati di narrazioni divine. Il rischio anche per noi credenti non è la mancanza del vino buonissimo della Parola ma che si annacqui in narrazioni insipide, incolori, anestetiche, anemiche... Ecco perché abbiamo bisogno di dare voce alla Parola sprigionando tutto il potenziale espressivo di risonanza e di racconto di cui la Chiesa è capace, prestando attenzione anche ai lettori e commentatori di “oltre confine”. Ci sono esegeti “clandestini” e “affabulatori” appassionati della Parola sparsi ovunque. Perché la Bibbia non è un testo “imprigionato”, anzi per sua natura è un tesoro di verità “rischiose” e non facilmente addomesticabili specie quando la Parola è nelle mani e nella lettura del popolo. Grazie di questo strumento di parole a servizio della narrazione della Parola con voce di donna, frutto della gestazione paziente del “Verbo” nel sapere e nel sapore di teologhe e bibliste delle chiese d’Italia, nostre sorelle nello Spirito.
Grazie alla professoressa Cristina Simonelli che ha accolto l’invito a presentare alla comunità mantovana questo testo curato dal coordinamento delle teologhe italiane. La saluto con amicizia e gratitudine per essere la portavoce delle dieci voci femminili autrici del testo. Con lei salutiamo anche don Lorenzo Rossi, biblista della nostra diocesi, esperto della letteratura lucana.
L’evangelista Luca riserva un’attenzione delicata e obiettiva alle donne in rapporto a Gesù. Esse lo seguono e lo servono con i loro beni (Lc 8,2-3), lo seguono fin dalla Galilea sino alla punta più alta del Calvario dove guardano da lontano lo spettacolo della croce (Lc 23,48), per avvicinarsi poi al sepolcro e osservare dove è stato posto il corpo di Gesù così da tornare finalmente il giorno dopo con aromi e oli profumati per un ultimo gesto di omaggio. Ma il giorno dopo non è la naturale successione del precedente. È un giorno nuovo. Il primo giorno della settimana, aurora della nuova creazione che capovolge paradigmi e criteri della nostra condizione naturale, una vera rifusione del maschile e del femminile, nella nascita della Donna-Chiesa Sposa dell’Agnello. Anche le donne sono impreparate e inadeguate alla risurrezione, impaurite e incredule, con il volto chino a terra, devono accogliere l’annuncio di due uomini che vedono presentarsi a loro in abito sfolgorante (cfr. Lc 24,1-10), due rappresentanti di un “altro” mondo, dove non c’è più né maschio né femmina perché tutto ciò che è creato è trasfigurato nella risurrezione. Queste donne, a cui l’evangelista riconosce un nome proprio (Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo) insieme alle altre che erano con loro, sono provocate dall’annuncio pasquale a diventare “teologhe” in quanto “si domandavano che senso avesse tutto questo”, in ordine al loro ri-diventare credenti alla sequela del Maestro amato che ora però chiede il salto di livello della fede nella risurrezione: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. Le donne corrono a raccontare queste cose agli apostoli. Costituite “apostole degli apostoli”, per usare l’espressione felice della liturgia bizantina di Pasqua, hanno il compito non scontato di annunciare il kerigma alle “colonne della chiesa”, pure loro spiazzati e increduli davanti a un annuncio che alle orecchie della carne pare “un vaneggiamento” e sortisce comunque il buon esito di far correre Pietro verso il sepolcro insieme a Giovanni che “vide e credette” (cfr. Gv 20,1-9).
L’originalità - anche di fronte alla Parola - non sta nell’essere donne piuttosto che uomini, ma nell’essere umili discepoli “giudicati degni dell’altro mondo e della risurrezione dai morti”; costoro “non prendono moglie né marito; e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio” (Lc 20,35-36).
Un femminile e un maschile rigenerati dalla Parola possono riprendere in mano la regia del mondo per rigenerarlo nella novità escatologica del Regno. Senza indugio!
-
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- SUL FILO DELLA COMMEDIA E DEL "COMICO" (AL DI LA’ DELLA TRAGEDIA E DEL "TRAGICO"), RIPRENDERE INSIEME LA LEZIONE DI DANTE E DI ECO.20 febbraio 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA: "AMOR, CHE A NULLO AMATO AMAR PERDONA" (#Dante Alighieri, #Inferno, V, 103).
- Un omaggio alla memoria di Rocco Scotellaro e di Umberto Eco
Riflettendo criticamente sulla abitudine "cavernicola" che ancora "abbiamo bisogno di amici e soprattutto di nemici per avere una ragione per vivere!", non è possibile comprendere e condividere la sollecitazione antropologica di Rocco #Scotellaro a finirla con questo "lavoro interminabile" da "infaticabili talpe" di un presente "preistorico" e, finalmente, capire il legame tra il Cielo e la Terra?!
"Pape Sàtan, pape Sàtan aleppe!" (Inf., VII, 1). Forse, #oggi, è proprio il caso e il #tempo di ri-leggere insieme "il #nome della rosa" e la "#divina #commedia", il lavoro di Umberto Eco e l’Opera di Dante Alighieri, e, infine, riconoscer-si come figli e figlie di quello stesso "amor che move il sole e le altre stelle" (#Dante, Par. XXXIII, 145).
#Dantedì, #25marzo 2025.
- NOTA:
- SUL FILO DELLA COMMEDIA E DEL "COMICO" (AL DI LA’ DELLA TRAGEDIA E DEL "TRAGICO"). A teatro, un "invito" al Teatro alla Scala.
 NOTIZIA DEL #19Maggio2023 (Connessi all’Opera): "Il nome della rosa: la nuova opera di Francesco Filidei per la Scala. In scena nel 2025".
NOTIZIA DEL #19Maggio2023 (Connessi all’Opera): "Il nome della rosa: la nuova opera di Francesco Filidei per la Scala. In scena nel 2025".
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE --- DUE OCCHI E UNA SOLA "IDEA" ("VISIONE"): IL "SAPERE AUDE!" DI KANT, IL PROBLEMA DELL’ OCCHIO DI PLATONE, E UNA QUESTIONE DI BELLEZZA..5 febbraio 2025, di Federico La Sala
RICERCA SCIENTIFICA, "MALOCCHIO", PSICOANALISI, E CREATIVITÀ:
IL "SAPERE AUDE!" DI KANT, IL PROBLEMA DELL’ OCCHIO DI PLATONE, E UNA QUESTIONE DI BELLO. UN INVITO A USCIRE DALLA #CAVERNA DI "#POLIFEMO" (CON #DANTE ALIGHIERI).
- In memoria di Immanuel #Kant, Hermann von #Helmholtz, e Marcel #Proust...
RIAPRIRE IL PROGRAMMA-SOCRATICO PLATONICO DELLA "CUPIDITA" ("EROS") DEL VEDERE CON GLI OCCHI E DEL GUARDAR-SI NEGLI OCCHI PER CONOSCER-SI, FORSE, BISOGNA RI-PRENDERE IL CAMMINO PROPRIO DALLA #CRITICA DELLA "RAGIONE PLATONICA". Se è vero, come è vero, che Giorgio Colli inizia il suo cammino di ricerca da una rilettura attenta del "Simposio" e dall’ "Alcibiade primo" e che, poi, giunga a tradurre la "Critica della ragion pura" di Kant (Alfonso M. Iacono, "Giorgio Colli: la dismisura nella misura", "Doppiozero", 04 Febbraio 2025), c’è da pensare che, per realizzare l’antichissimo desiderio «di fare, di due, uno», e così, di «guarire la natura umana» (Platone), probabilmente, si dovesse andare a fondo con Kant e reimpostare la questione.
"CHIUDERE UN OCCHIO" O "APRIRE GLI OCCHI"?! CON FREUD, #OLTRE: CREDO CHE SIA UNA OTTIMA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SUL TEMA, RIPARTENDO da alcune domande poste in "An Inquiry into Beauty" (cfr. Vincent De Luise, Fbook, 02 febbraio 2025).
Chiedersi se "La bellezza è negli occhi di chi guarda? O la bellezza è nel cervello di tutti coloro che la guardano?"; e, al contempo, accogliere come validi i dati disponibili, che "suggeriscono la seconda ipotesi" (cit.), da una parte si richiamano antiche questioni che risalgono almeno a #Platone (appunto, con tutte le conseguenze del caso) e, dall’altra, si rinvia quantomeno a una rilettura del "Manuale di Ottica fisiologica" di un "discepolo" di Kant: Hermann von Helmholtz.
DUE OCCHI E UNA SOLA "IDEA" ("VISIONE"). Helmholtz, nel varco aperto epistemologicamente da Kant, si porta sia al di là della dimensione euclidea dello #spazio e del #tempo (aprendo con #Riemann la via alle geometrie non euclidee e alla fisica di #Mach e #Einstein), e, ancora, sia sulla strada di studi "galileianamente" intesi sulla #fisiologia della #percezione, in #ottica e in #acustica, entro cui si colloca la stessa #neuroestetica.
Già solo capire che #Nietzsche, proprio dalla conoscenza delle ricerche di Helmholtz (mediata dalla lettura dell’opera di Friedrich A. #Lange, "Storia del materialismo e critica del suo significato nel presente"), scrive "Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali" (1881), sollecita a ripensare meglio il suo rapporto non solo con Kant, ma anche con lo stesso Socrate e Platone (il cristianesimo storico e la tradizione illuministica e scientifica) e il "#Crepuscolo degli #idoli".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---UNA QUESTIONE DI "BARBARIE": SCIOGLIERE IL NODO DEL "PARTO MASCHIO" DELLA LEVATRICE "SOCRATE"7 gennaio 2025, di Federico La Sala
FILOSOFIA DEL #DIALOGO E #SCIENZA DELLA #COSTITUZIONE:
LA "BARBARIE" ("MONO-LOGICA" E "CICLOPICA"), IL "SÀPERE AUDE" (ORAZIO), E L’ ANTROPOLOGIA ("DUA-#LOGICA" E "#BINOCULARE") DI IMMANUEL KANT ...
- In memoria di #BertrandRussell e del suo paradosso.
"ORIENTARSI NEL PENSIERO": UNA CAVERNA E UN BARBIERE. «In un villaggio vi è un solo barbiere, un uomo con la barba ["Io, Platone, sono la verità" è l’insegna], che rade tutti e solo gli uomini del villaggio che non sanno radersi da soli. La domanda è: il barbiere non sa farsi la barba da solo?».
#IMMAGINARIO PLATONICO, "BARBE", E "INQUINAMENTO" NEOPOSITIVISTICO E PRAGMATISTICO: "ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO" (#HELMHOLTZ E #PROUST). SE E’ VERO, COME E’ VERO CHE "La verità non nasce e non si trova nella testa di un singolo uomo, essa nasce tra gli uomini, che insieme cercano la verità, nel processo della loro comunione dialogica."(Michail Michajlovič #Bachtin, 1968), ALLORA E’ TEMPO "DI PENSARE A RISOLVERE LA QUESTIONE" (W. V. O. #QUINE, («On "What there is"», 1948) E SCIOGLIERE IL NODO DEL "#PARTO MASCHIO" DELLA #LEVATRICE "SOCRATE" (UN "#DUE IN #UNO", CAPACE DI UN #DIALOGO CON "SE’ STESSO COME UN ALTRO"), LIBERARSI DELLA #CLAUSTROFILIA DELLA TRAGICA "CAVERNA" DELL’ASTUTO ("#METIS -OCRATICO") PLATONE ("ZEUS"), E USCIRE A RIVEDERE LA LUCE DEL SOLE E LE STELLE DEL CIELO.
«ESSERE, O NON-ESSERE» (#SHAKESPEARE), A PARTIRE DA #PARMENIDE, FINO AD ARRIVARE AL "VICOLO CIECO" DELL’ATTUALE STORICO PRESENTE , E’ UNA SOLA GRANDE QUESTIONE FILOSOFICA: E’ QUELLA FONDAMENTALE, QUELLA ONTOLOGICA: "SU «CIO’ CHE VI E’»", CHE NON A CASO TOCCA ANCHE LA "QUESTION" DI "AMLETO".
NOTA - SUL TEMA, PER APPROFONDIMENTO, SI CFR. "LIVELLI DI REALTÀ" ("ALFABETA", 66, 1984, pp. 29-30)), UNA MIA RECENSIONE DEL TESTO RELATIVO AL CONVEGNO (UNA VERA E PROPRIA RIUNIONE DEGLI "STATI GENERALI DEL #REALISMO FILOSOFICO E SCIENTIFICO" - FIRENZE 1978) E AGLI ATTI (PUBBLICATI DA Feltrinelli Editore, MILANO 1984).
- NOTE:
- FILOSOFIA, #COSTITUZIONE, E #LOGICA. BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL #MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO.
- "LA #MEMORIA DEL #MONDO" (#ITALO CALVINO, "#Santiago") E "LA #LETTERATURA E I #LIVELLI DELLA #REALTÀ" (I. #CALVINO, 1978)": #STORIA E #FILOSOFIA E #FILOLOGIA (#Eraclito di #Efeso). Al di là e al di sopra e al di sotto della #guerra (#Polemos), c’è #Armonia (Eraclito): in #principio era il "#Logos" (Eraclito).
- STORIA E LETTERATURA E #MEMORIA E #ANTROPOLOGIA. #Kafka ancora agli inizi del secolo scorso sapeva la differenza tra la #manifestazione epifanica e il #giogo dei "giocastolai" e delle "giocastolaie", e ricordava: "(...) alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (Lettera a Helli Hermann, autunno 1921).
- EPIFANIA (#APPARIZIONE) E #IMMAGINAZIONE ("EPINOIA"), #6GENNAIO 2024. Per "orientarsi nel pensiero" (#Kant) e nella realtà (#Marx), e cercare di non scambiare il gioco dell’illusione (#Schein) con la realtà dell’apparenza (#Erscheinung), ALCUNI APPUNTI PER UNA BUONA #ALIMENTAZIONE ....
- UN’#EPIFANIA STORIOGRAFICA: UN "INVITO" A RILEGGERE "AURORA" (1881) DI #NIETZSCHE E #CAMBIARE #PARADIGMA ANTROPOLOGICO ED EPISTEMOLOGICO...
- "SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784): ALLA #RICERCA SCIENTIFICA DEL "#TEMPO #PERDUTO" (#HELMHOLTZ, 1850). *
- "ECCE HOMO" (NIETZSCHE, 1888): "SENTIRE ALL’UNISONO", L’AFORISMA 142 DI "#AURORA. PENSIERI SUI PREGIUDIZI MORALI", CONTRARIAMENTE A QUANTO PER LO PIU’ SI PENSA, SEGNA L’#INIZIO DI UN PERCORSO NIETZSCHEANO, SEGNATO DA UNO #SPIRITOCRITICO ANTIMETAFISICO E ANTI-DOGMATICO, DI ALLONTANAMENTO DA #SCHOPENHAUER, MEDIATO DAGLI STUDI E DALLE SCOPERTE DI HERMANN VON #HELMOLTZ, E DI AVVICINAMENTO A #KANT (1724-2024)! Quanto "antropomorfismo psicologico", infatti, ci fosse "nelle idee di Platone come nella dialettica immanente al processo universale di Hegel e nella volontà inconscia di Schopenhauer", come ora Nietzsche comincia a capire "illuminato" anche dalla lettura di un opera del fisico J. Robert Mayer, Helmholtz, impegnato già da anni a portare avanti criticamente e pubblicamente a tutti i livelli il cammino kantiano, ne è già ben consapevole.
- *
- STORIA #FILOSOFIA #ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E COSMOLOGIA: "L’ORDINE DEL TEMPO" (ANASSIMANDRO) E "IL PROFUMO DELLA MADELEINE" (#CARLOROVELLI). Una nota in #memoria di #Helmholtz e di Proust, in omaggio a #Carlo Rovelli....
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- ANTROPOLOGIA STORIA ED ECONOMIA: A SCUOLA DI CORAGGIO ("SAPERE AUDE!"), DA "GISELE PELICOT".3 gennaio 2025, di Federico La Sala
FILOLOGIA STORIA E ANTROPOLOGIA:
CON JEAN-JACQUES ROUSSEAU A SCUOLA DI #CORAGGIO ("#SAPERE #AUDE!"), DA "#GISELEPELICOT", PER UN #BUON 2025...
Una nota di commmento all’articolo di Nicoletta Vallorani ("Gisèle Pelicot. Il posto del coraggio", Le parole e le cose, 27 dicembre 2024).
- NOTE:
- QUALE #EUROPA PER UN #BUON 2025?: UNA STORIA DI LUNGA DURATA E UNA ORAZIANA SOLLECITAZIONE SUL "SAPERE AUDE!" (#KANT, #KOENIGSBERG, 1784; #KALININGRAD, 2024) DA RIPRENDERE....
- Critica dell’#economia politica, #storia, e #antropologia: "Pioniere. #Ester Boserup e il ruolo delle #donne in #agricoltura
 [...] Nel 1970 pubblica il suo Woman’s role in economic development, quasi un manifesto per ciò che diventerà il programma Women in development (Wid) delle Nazioni Unite.[3] Boserup descrive per i paesi in via di sviluppo un sistema di produzione agricolo in cui gradualmente le donne passano da sistemi di produzione autogestiti che le vede economicamente indipendenti, a sistemi all’europea in cui finiscono con l’essere alle dipendenze dei coniugi, senza essere retribuite. L’attacco nei confronti dei colonizzatori europei è diretto e senza mezzi termini. [...]" (Marcella Corsi, "inGenere", 02 Agosto 2016).
[...] Nel 1970 pubblica il suo Woman’s role in economic development, quasi un manifesto per ciò che diventerà il programma Women in development (Wid) delle Nazioni Unite.[3] Boserup descrive per i paesi in via di sviluppo un sistema di produzione agricolo in cui gradualmente le donne passano da sistemi di produzione autogestiti che le vede economicamente indipendenti, a sistemi all’europea in cui finiscono con l’essere alle dipendenze dei coniugi, senza essere retribuite. L’attacco nei confronti dei colonizzatori europei è diretto e senza mezzi termini. [...]" (Marcella Corsi, "inGenere", 02 Agosto 2016).
- ANTROPOLOGIA, #LETTERATURA, #ARCHEOLOGIA, E #PSICOANALISI (S. #FREUD, "#DISAGIO DELLA #CIVILTÀ", 1929). A che #giogo si continua ad #aggiogare?! La "#memoria" di una #denuncia della #infamia #originaria" , di un #tradimento strutturale della #fiducia di #lungadurata, "biblico"! (cfr. Lea Melandri).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "SAPERE AUDE! (KANTM 1724-2024): QUALE EUROPA PER UN "BUON 2025"?. UNA STORIA DI LUNGA DURATA.1 gennaio 2025, di Federico La Sala
QUALE EUROPA PER UN "BUON 2025"?: UNA STORIA DI LUNGA DURATA E UNA ORAZIANA SOLLECITAZIONE SUL "SAPERE AUDE!" (KANT, KOENIGSBERG, 1784; KALININGRAD, 2024) DA RIPRENDERE...
RICORDANDO CHE “La guerra non si abolisce coi trattati, ma stimolando la riflessione e la cultura di tutti”, come sosteneva Gino Strada, forse, oggi alla fine del 2024, io renderei omaggio anche alla memoria di Enrico Berlinguer che, il 15 dicembre del 1981, dichiarò la fine della "spinta propulsiva" della rivoluzione sovietica, anticipando sia la svolta di Gorbaciov sia la caduta e la fine del "comunismo" russo, e, con esso, del "muro di Berlino" (1989). Al contempo, e insieme, renderei omaggio allo stesso Michail Gorbaciov (cfr. foto allegata, "Le Monde" 1989) e, ancora, ad Antonio Gramsci (1891-1937).
CULTURA E #SOCIETA’. Alla luce dell’avvio del #Giubileo2025 e delle celebrazioni dell’anniversario del #Primo #Concilio di #Nicea (325), una importante #analogia (carica di #teoria) sulla relazione tra il #cristianesimo e il #paolinismo e il #marxismo e il #leninismo, fatta da Gramsci:
"POSIZIONE DEL #PROBLEMA. [...] Marx è un creatore di Weltanschauung, ma quale è la posizione di Ilici? È puramente subordinata e subalterna? La spiegazione è nello stesso marxismo - scienza e azione -. Il passaggio dall’utopia alla scienza e dalla scienza all’azione (ricordare opuscolo relativo di Carlo Radek). La fondazione di una classe dirigente (cioè di uno Stato) equivale alla creazione di una Weltanschauung. [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7 § 33").
#BUONANNO, #BUON2025!
- NOTE:
- RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE (2005). Una "memoria"
 (...) il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!
(...) il “nuovo mondo” che abbiamo costruito dimostra quanto presto abbiamo dimenticato la ‘lezione’ delle foreste, dei mari, dei deserti, e dei fiumi e delle montagne!!!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "FENOMENOLOGIA DELLO #SPIRITO" (HEGEL) ED "ECCE HOMO" (NIETZSCHE): UNA QUESTIONE AMLETICA. Una nota a margine della "Prima domenica dopo Natale".30 dicembre 2024, di Federico La Sala
TEATRO FILOSOFIA E METASTORIA: EDUCAZIONE "BIBLICA", "INTERPRETAZIONE DEI #SOGNI" (S. FREUD, 1899), "COSTRUZIONI NELL’#ANALISI" (S. #FREUD, 1937), E "CHÂTIMENT DE L’ORGUEIL" (#BAUDELAIRE,1861).
- Una nota a margine dell’amletico lavoro "in progess" di Paul Adrian Fried, "Prima domenica dopo Natale - Gesù della stirpe di re Davide (Serie, parte 5.b.)" - 29 dicembre 2024
"FENOMENOLOGIA DELLO #SPIRITO" (HEGEL) ED "ECCE HOMO" (NIETZSCHE). SE SI CONSIDERA CHE, dalla cosiddetta nascita di Cristo, non solo al tempo di Elisabetta I d’Inghilterra e di #Shakespeare, "Un modo per vedere la storia di Natale è che Giuseppe fu tradito dallo Spirito Santo; sua moglie che gli diede un figlio bastardo del cielo" ("One way to view the #Christmas story is that Joseph was cuckolded by the Holy Spirit; his wife who bore him a bastard son of heaven", cfr. Paul Adrian Fried, "First Sunday After Christmas - Jesus of King David’s Bloodline (Series, Part 5.b.)", cit.), ma anche OGGI, nell’attuale presente storico, fine-anno 2024 secondo il #calendario gregoriano (Gregorio XIII, 1582), si "tramanda" la stessa "storia", vuol dire che non si è ancora ben compresa tutta l’importanza della "silenziosa" costante presenza storica e "legale" (di "Principio", secondo la #Legge, secondo il "Logos") della figura di "Giuseppe" accanto alla figura di "Maria" e della stessa lezione del "#presepe" di #Francesco di #Assisi (Greccio, 1223).
STORIA E LETTERATURA E STORIOGRAFIA: "#DIVINA COMMEDIA" E #COSTITUZIONE DEI "#DUE SOLI" (#DANTE ALIGHIERI) . A mio parere, c’è da pensare che, nonostante le "dicerie sacre" di un Gesù, nato da un altro "Giuseppe" (e secondo una concezione cosmoteandrica "biblica", "platonica" e "plutonica" della donna-#femmina come "Terra - #Vaso", che deve nutrire e far crescere il #seme del "supremo" uomo-#maschio), non si sia ben meditato sul fatto che "la punizione dell’#orgoglio" è già stata evangelicamente ben "scritta" (Baudelaire, "I Fiori del Male", XVI) e, "qui e ora", l’hegeliano "Spirito Santo" di #Mammona (come da enciclica del 2006, "Deus #caritas est") deve solo inginocchiarsi dinanzi a "Giuseppe" e alla stessa "Maria" e chiedere ad entrambi "perdono" e "benedizione". #GiselePelicot insegna...
#Buon2025
- NOTA:
- ARCHEOLOGIA DELL’#ECONOMIA E DELLA TEOLOGIA-POLITICA #DOMESTICA DELLA CIVILTÀ TERRESTRE. Una nota a margine della riflessione di #Nicoletta #Vallorani, "Gisèle Pelicot. Il posto del coraggio" ("Le parole e le cose", 27.12.2024)
- UNA DONNA E UNA MADRE MANDA IN FRANTUMI LA "MITICA" ALLEANZA DELLA "#TRAGEDIA" ("#EDIPO") E DELLA "#AGRICOLTURA" ("#CAINO").
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ARTE DELLA MAIEUTICA E "AGRICOLTURA": SOCRATE E L’APOLOGIA DEL "COMPROMESSO OLIMPICO".17 dicembre 2024, di Federico La Sala
MITOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E CRITICA DELLA "RAGIONE OLIMPICA":
RIPRENDERE IL FILO DA ARTEMIDE E DALLA "APOLOGIA" DI PLATONE DEL SOCRATE "LEVATRICE" E PORTARSI CON #DANTE E #VIRGILIO E #BEATRICE FUORI DALL’INFERNO...
- BUON #NATALE2024 E #BUONANNO 2025.
Una sollecitazione a riflettere (ancora e meglio) sulla teologia-politica della relazione uomini e donne nell’antica Grecia (#Eschilo, #Sofocle, ed #Euripide) e sul tema del #comenasconoibambini (ancora oggi, all’ordine del giorno).
COME ARTEMIDE (DIANA), LA SORELLA DI APOLLO, VENNE "AGGIOGATA" AL CARRO DELL’ANIMA DI UN "APOLLINEO" PLATONE, SOSTENUTO DA UN SOCRATE, CHE "GIOCAVA" A FARE (COME LA MADRE FENARETE, DIVENUTA STERILE, E LA STESSA #VERGINE ARTEMIDE) L’OSTETRICO PER SOLI MASCHI.
ARTE DELLA #MAIEUTICA E "AGRICOLTURA". Nel "Cratilo", Platone, nell’etimologie dei nomi degli dei e delle dee, così scrive:
- "Ἄρτεμις" δὲ ‹διὰ› τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν· ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ καλέσας, τάχα δ’ ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί· ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τιθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ.
- "Ad Artemide poi sembra che il nome sia stato posto per l’artemes (’l’integrità’) per l’ornatezza e per il suo desiderio di verginità. E probabilmente chi le assegnò il nome volle chiamarla esperta di virtù ("aretes histora") o forse anche che detesta l’aratura ("ton aroton misesases") del maschio nella femmina: o per uno di questi motivi oppure per tutti questi insieme le pose questo nome colui che pose il nome alla dea" (406b).
FILOSOFIA E SOCIETA’: "LA NASCITA DELLA TRAGEDIA". * All’altezza dell’anno 2024, e dopo la rivoluzione copernicana e dopo i "maestri del sospetto" (Marx, Nietzsche, e Freud), si continua a concepire la relazione uomo-donna secondo la concezione della tragica #segnatura della "Scuola di Atene" (Raffaello, 1509-1511) e del "#Sapiente" (1510) di #Bovillus, vale a dire come lezione di Platone dal "Teeteto":
- "SOCRATE - E non hai mai osservato [...], che [le levatrici] sono abilissime a combinar matrimoni, esperte come sono a conoscere quale uomo e quale donna si hanno da congiungere insieme per generare i figliuoli migliori? TEETETO - Non sapevo codesto. SOCRATE - E allora sappi che di questa lor arte esse menano piú vanto assai che del taglio dell’ombelico. Pensa un poco: credi tu che sia la medesima arte o siano due arti diverse il raccogliere con ogni cura i frutti della terra, e il riconoscere in quale terra qual pianta vada piantata e qual seme seminato? TEETETO - La medesima arte, credo. SOCRATE - E quanto alla donna, credi tu che altra sia l’arte del seminare e altra quella del raccogliere? TEETETO - No, non mi pare. [...] SOCRATE - Ora, la mia arte di ostetrico, in tutto il rimanente rassomiglia a quella delle levatrici, ma ne differisce in questo, che opera su gli uomini e non su le donne, e provvede alle anime partorienti e non ai corpi. E la piú grande capacità sua è ch’io riesco, per essa, a discernere sicuramente se fantasma e menzogna partorisce l’anima del giovane, oppure se cosa vitale e reale. Poiché questo ho di comune con le levatrici, che anch’io sono sterile ... di sapienza; e il biasimo che già tanti mi hanno fatto, che interrogo sí gli altri, ma non manifesto mai io stesso su nessuna questione il mio pensiero, ignorante come sono, è verissimo biasimo. E la ragione è appunto questa, che il dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi vietò di generare. Io sono dunque, in me, tutt’altro che sapiente [...]" (Platone, "Teeteto", 149d-150d).
SOCRATE E L’APOLOGIA DEL "COMPROMESSO OLIMPICO". Eschilo aveva già chiarito molto bene la "ragione" del volere di Apollo e Atena e dello stesso discorso di Platone nel "Teeteto": «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi").
- * Sul tema, mi sia lecito, si cfr. Federico La Sala, "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991.
- NOTA:
- ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI ("#COSTRUZIONI NELL’#ANALISI, 1937)", E #FILOLOGIA: «GRANDE E’ LA #DIANA DEGLI EFESINI» (S. #FREUD, 1911): #EFESO, LA DEA MADRE, IL DIO FIGLIO, E L’#INTERPRETAZIONE PAOLINA DEL #MESSAGGIOEVANGELICO. Alcuni appunti: *
- In memoria di Eraclito e di Shakespeare e ad omaggio di Eleusis2023...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, MEDICINA, FISICA E METAFISICA: DIALOGO CON UN AMICO IN OCCASIONE DEL SUO ONOMASTICO.4 dicembre 2024, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, MEDICINA, FISICA E METAFISICA:
DIALOGO CON UN AMICO IN OCCASIONE DEL SUO ONOMASTICO NEL GIORNO DELLA MEMORIA DI SAN FRANCESCO SAVERIO:
a) "Messaggio (inoltrato)":
Memoria di san Francesco Saverio, sacerdote della Compagnia di Gesù, evangelizzatore delle Indie, che, nato in Navarra, fu tra i primi compagni di sant’Ignazio. Spinto dall’ardente desiderio di diffondere il #Vangelo, annunciò con impegno Cristo a innumerevoli popolazioni in India, nelle isole Molucche e in altre ancora, in Giappone convertì poi molti alla fede e morì, infine, in Cina nell’isola di Sancian, stremato dalla malattia e dalle fatiche. è il mio onomastico quindi...
b) Risposta:
Ma "Gesù" non aveva nessuna "Compagnia" ... e la compagnia che lo seguiva lo portava là dove si "va-n-gelo". Francesco I, per or-goglio, si richiama a Ignazio di Loyola, è un "gesuita" non un "cristiano" né un "francescano". È tempo di rifare il presepe e restituire a Giuseppe e Maria, il loro ", Bambino...
Molti auguri e buon compleanno, a te e ai tuoi genitori, "Giuseppe e Maria" ... E padre di Andrea, ginecologo.
La X dell’Apostolo Andrea richiama X di "IXTHUS", "Christos", non dell’ "Ictus", così la Caritas, da non confondere con "caritas" ("mammona"). Buona ri-nascita e buon onomastico ... Buona giornata.
- NOTA: XAPITAS - CHARITAS. Caritas, richiama il "caro" del " prezzo" e di Mammona (nel doppio senso di Mamma e di Mammona).
c) Risposta
Dante aspetta ancora. Dalla tragedia "divina" alla "divina" Commedia
d) Messaggio dell’Amico:
La vita dei continui passaggi, per metterla in filosofia, del continuo divenire di Eraclito. Senza la tragedia( il negativo assoluto) non ammireremmo neanche la Bellezza e la Bontà.
e) Risposta:
infatti! Eraclito era di Efeso ed è suo il principio ripreso e rilanciato dall’ Apostolo Giovanni (non dal Paolo, Saulo di Tarso): il Logos. Il Logos, non è il logo di un’azienda, di una setta,o di un partito: è "l’amore che move il sole e le altre stelle" (Dante Alighieri). Della Terra, il brillante colore...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- METAFISICA QUANTISTICA E ANTROPOLOGIA: "L’ORDINE DEL TEMPO" (ANASSIMANDRO) E "IL PROFUMO DELLA MADELEINE" (CARLO ROVELLI).27 novembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #COSMOLOGIA:
"L’ORDINE DEL TEMPO" (ANASSIMANDRO) E "IL PROFUMO DELLA MADELEINE" (CARLO ROVELLI).
- Una nota in memoria di #Helmholtz e di #Proust, in omaggio a Carlo Rovelli...
STRANO, MA VERO: A Carlo Rovelli, PROPRIO NELLA SUA MAGISTRALE INDAGINE SULL’«ORDINE DEL TEMPO» (CITA PROUST E IL PROFUMO DELLA "MADDALENA", APPUNTO), SFUGGE L’IMPORTANZA DELLE RICERCHE DI HELMHOLTZ.
IMMAGINAZIONE #QUANTISTICA: LA"PSICOPATOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA" (S. #FREUD) E IL "RITROVAMENTO" DELL’«#UOMO VITRUVIANO» (LEONARDO). Su questa "dimenticanza", forse, è opportuno interrogarsi, perché, a mio parere, è degna di grande interesse, ai fini sia delle ricerca filosofica sia cosmologica sia antropologica:
- "Ci stiamo avvicinando pericolosamente a noi stessi. Sembra già sentire #Tiresia, nell’#Edipo, che gli dice: «Fermati! O troverai te stesso»... O #Ildegarda di Bingen, che nel XII secolo cerca l’assoluto e finisce per trovare l’«uomo universale» al centro del cosmo" (C. Rovelli, "L’ordine del tempo, cit. , p. 134).
SCIENZA E LETTERATURA. Per riprendere il "discorso", e portare avanti la ricerca, degno di molta attenzione è un articolo del 2003 di #MarcoPiccolino, proprio sul tema di «Un “tempo perduto” tra scienza e letteratura: il "temps perdu" da Hermann von Helmholtz a Marcel Proust», che così inizia:
- "E’ da più di un secolo che Sigmund Freud ci insegna che quello che noi facciamo, pensiamo, ciò di cui abbiamo paura e anche quello che ci accade nel corso della nostra vita quotidiana, a volte in un modo apparentemente casuale e inatteso, può essere connesso a eventi distanti della nostra vita passata, eventi di cui apparentemente non serbiamo alcun ricordo, ma che hanno tuttavia lasciato tracce significative nei territori profondi della nostra personalità. La relazione che esiste tra gli avvenimenti passati e il presente della nostra vita non appare a volte in modo chiaro e ovvio, e sono spesso necessari, perché essa emerga, intensi sforzi da parte dell’ «archeologo» dell’inconscio umano, lo psicanalista. A volte ciò vale per il dominio ristretto dell’esperienza individuale, può essere anche vero per l’ambito più vasto della storia. La relazione tra eventi apparentemente lontani può essere allora rivelata attraverso il lavoro dello storico, che scandaglia le tracce profonde delle epoche passate, consultando antichi libri, manoscritti, che in alcuni casi nessuno ha letto per secoli, spesso situati in luoghi distanti e di difficoltoso accesso. [...]" (cfr. Marco Piccolino, Un “tempo perduto” tra scienza e letteratura: il “temps perdu” da Hermann von Helmholtz a Marcel Proust, Medicina audiologica, 1: 261-270, 2003).
LINGUISTICA E #FILOLOGIA: "MADELEINE", "MADDALENA", E "FISICA QUANTISTICA". L’ordine del tempo, incredibilmente, ha portato alla luce dalle profondità storiche del mare culturale mediterraneo il nesso (#nexus") latente tra la "Madeleine" del parigino #MarcelProust (ma anche il "papà Madeleine" di #Victor Hugo) e la Maddalena, l’isola della #Sardegna, e, infine, la "Maria di Magdala", la "Maria Maddalena" del messaggio evangelico (l’«Apostola degli Apostoli») e, con esso, di una sollecitazione antropologica a svegliarsi dal #sonnodogmatico della tradizione della "dotta ignoranza" platonico-paolina e costantiniana (#Nicea 325-2025).
- Nota:
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CON LA "GUIDA" DEI PROFETI E DELLE SIBILLE, TUTTA UN’ALTRA STORIA E’ POSSIBILE.25 novembre 2024, di Federico La Sala
ARTE #STORIA #ANTROPOLOGIA E #STORIOGRAFIA:
PROFETI E #SIBILLE NEL "REGNO DI #NAPOLI" AGLI INIZI DEL #SEICENTO...
- Una nota a margine della mostra dedicata a Jusepe de #Ribera (conosciuto anche come José de Ribera o con il soprannome #Spagnoletto, ad opera di José Vicente Quirante Rives e l’artista francese Eric #Fontaneau, presso l’Archivio di Stato di Napoli, dal 21 novembre 2024 - al 15 febbraio 2025 (Antonella Cilento).
UNA GRANDE OCCASIONE PER FAR FESTA E, POSSIBILMENTE, FAR CONOSCERE AI #DODICI PROFETI, 12 PROFETI MINORI DI #RIBERA LE 12 SIBILLE DELLA #CHIESA DELLA "MADONNA DEL CARMINE" DI #CONTURSI TERME (#CARMELITANI SCALZI, 1613), CHE, RICOMPARSE DOPO IL TERREMOTO DEL 1980, SONO COSTRETTE A VIVERE ANCORA IN UNO STATO DI DISAGIO (DELLA CIVILTA’), IN GRAN DIFFICOLTA’.
- NOTE
- MEMORIA E STORIA E ARTE: JOSE’ DE RIBERA. "Jusepe de Ribera, conosciuto anche come José de Ribera o con il soprannome Spagnoletto (Xàtiva, 17 febbraio 1591 - Napoli, 2 settembre 1652), è stato un pittore spagnolo, attivo principalmente a Napoli e più in generale per la corte di Spagna.
 Fu uno dei massimi protagonisti della pittura napoletana ed europea del XVII secolo nonché uno dei più rilevanti pittori seguaci del filone del caravaggismo napoletano, da cui generò una peculiare corrente pittorica, il tenebrismo, che si caratterizzava da una esasperata rappresentazione della realtà, violenta e brutale, accentuata da particolari epidermici, anatomici e psichici dei personaggi raffigurati.
Fu uno dei massimi protagonisti della pittura napoletana ed europea del XVII secolo nonché uno dei più rilevanti pittori seguaci del filone del caravaggismo napoletano, da cui generò una peculiare corrente pittorica, il tenebrismo, che si caratterizzava da una esasperata rappresentazione della realtà, violenta e brutale, accentuata da particolari epidermici, anatomici e psichici dei personaggi raffigurati.
 Il suo stile, che nel tempo si evolve influenzato dal classicismo neoveneto, fu modello e punto di riferimento per i pittori partenopei coevi e di generazioni successive, segnando in maniera indelebile tutta la pittura napoletana del Seicento. [...]" (cit.).
Il suo stile, che nel tempo si evolve influenzato dal classicismo neoveneto, fu modello e punto di riferimento per i pittori partenopei coevi e di generazioni successive, segnando in maniera indelebile tutta la pittura napoletana del Seicento. [...]" (cit.).
- STORIA E #GEOGRAFIA: NAPOLI - CONTURSI TERME.
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....Materiali sul tema.
- I "DODICI PROFETI", I "DODICI", I "PROFETI MINORI" DI #RIBERA.
 UNA CITAZIONE DALLA RECENSIONE DELLA MOSTRA DI ANTONELLA CILENTO: "Archivio di Stato i volti dei profeti di Ribera": "[...] Come in alto così in basso: i profeti di Ribera abitano dal Seicento le vele delle lunette sugli archi della chiesa di San Martino, altissimi, quasi invisibili, confusi nella musica barocca della chiesa, che è a sua volta altissima su tutta la città, in volo sulla collina [...]
UNA CITAZIONE DALLA RECENSIONE DELLA MOSTRA DI ANTONELLA CILENTO: "Archivio di Stato i volti dei profeti di Ribera": "[...] Come in alto così in basso: i profeti di Ribera abitano dal Seicento le vele delle lunette sugli archi della chiesa di San Martino, altissimi, quasi invisibili, confusi nella musica barocca della chiesa, che è a sua volta altissima su tutta la città, in volo sulla collina [...]
 È nuovo Fonteneau e antico Ribera, o possiamo cadere nella botola temporale che si crea per i nostri occhi e le nostre anime? Si cammina per le sale dell’Archivio, magnifica installazione del tempo, [...] e si arriva a questi fitti segni, a questi vecchi, a questi antichi. -***Aggeo, Noé, Gioele, Amos, Abdia, Osea, Abacuc, Sofonia, Giona, Daniele, Michele, Ezechiele.
È nuovo Fonteneau e antico Ribera, o possiamo cadere nella botola temporale che si crea per i nostri occhi e le nostre anime? Si cammina per le sale dell’Archivio, magnifica installazione del tempo, [...] e si arriva a questi fitti segni, a questi vecchi, a questi antichi. -***Aggeo, Noé, Gioele, Amos, Abdia, Osea, Abacuc, Sofonia, Giona, Daniele, Michele, Ezechiele.
 Ci sono voluti uno spagnolo, Quirante Rives, benché cittadino onorario di Napoli, e un francese, per mostrare i volti nascosti della Certosa, e questo appare un risarcimento del tempo per Napoli [...]" (cfr. Antonella Cilento, "La Repubblica", 24 novembre 2024).
Ci sono voluti uno spagnolo, Quirante Rives, benché cittadino onorario di Napoli, e un francese, per mostrare i volti nascosti della Certosa, e questo appare un risarcimento del tempo per Napoli [...]" (cfr. Antonella Cilento, "La Repubblica", 24 novembre 2024).
- CON LA "GUIDA" DEI PROFETI E DELLE SIBILLE, UNA VISITA IN "DANIMARCA" DA "AMLETO" (PER RE-SHAKESPEARE NEAPOLITANAMENTE).
- SE è VERO, COME è VERO, CHE lo "spirito santo" soffia dove vuole, e, ancora, che non è da confondere (filologicamente) il "Deus charitas est" (1 Gv., 4.8) con il "caro!" dio "mammona" della "tradizione" paolina-costantiniana della teologia eco-nomica del "Deus caritas est" (del 2006 d. C.), ALLORA è PROPRIO IL CASO DI RIPRENDERE LA QUESTIONE HAMLETICA E RIPROPORSI LA DOMANDA: "ESSERE, O NON ESSERE"? Fare luce sulla indicazione antropologica della "trappola del topo" ("Mousetrap"), non del serpente, e reinterrogar-si con Nicodemo su "come nascono i bambini" (tema su cui rifletteva il filosofo della "Scuola di Milano", Enzo Paci), su come si nasce, su come si rinasce, cercare di cominciare a parlar chiara-mente, sciogliere il "nodo di Ercole" (antropologicamente, non nel modo di Alessandro Magno), e, cominciare a "fare la verità" (Roberto Osculati, Bompiani, Milano 1974). Se non ora, quando?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- OLTRE IL PLATONISMO E IL PAOLINISMO: UN GRANDE SEGNAVIA PER USCIRE DALL’INFERNO, CON #DANTE E #PASOLINI21 novembre 2024, di Federico La Sala
UNA #HAMLETICA #QUESTIONE FILOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA DI #LUNGADURATA E
UN GRANDE SEGNAVIA PER USCIRE DALL’INFERNO, CON #DANTE E #PASOLINI...
- Un omaggio a Emanuela Monini, studentessa magistrale di #Filologia moderna, e alla rivista Insula Europea...
Per Pasolini «chi ama è egoista, e vorrebbe tutta per sé la persona amata» (cfr. Emanuela Monini, "Tu sai che chi ama è egoista", "insula europea", 17 novembre 2024 ); ma, pur avendo capito, come scrive nel sonetto 110, che
- «C’era nel mondo - nessuno lo sapeva - / qualcosa che non aveva prezzo, / ed era unico: non c’era codice né Chiesa / che lo classificasse. Era nel mezzo / della vita e, per confrontarsi, non aveva / che se stesso. Non ebbe, per un pezzo, / nemmeno senso: poi riempì l’intera / mia realtà. Era la tua gaiezza»,
HA difficoltà ad andare oltre sé stesso e riconoscere che "quel qualcosa che non aveva prezzo" è solo la "gaiezza" sua, non della "persona amata".
Il grande #dono della sua vita, forse, sta nel segnalare il "tradizionale" #nodo tragico del non riconoscere alla "persona amata" (gr."#Filomena") la sua #autonomia e la sua #libertà di #amare (gr. "#Filousa").
La sua passione per #DanteAlighieri lo ha portato, oltre la "#ego-logica" di san Paolo, sulla stessa strada e, deposto il suo "vorrebbe", gli ha permesso di giungere a consapevolezza della #dirittavia e a proseguire coraggiosamente il suo viaggio.
A ben distinguere e a ben unire, non è possibile confondere antropologicamente e filologicamente l’amore "prezzolato" (quello con il suo "#caro-prezzo"), la "#caritas", con quell’#amore, quel "qualcosa che non aveva prezzo, / ed era unico: non c’era codice né Chiesa / che lo classificasse", la "#charitas". Un grande segnavia, a mio parere, per uscire con Dante dall’inferno.
- NOTE
- Dante e Pasolini. La #DivinaCommedia e "La #DivinaMimesis: "l’#amor che move il #sole e le altre #stelle" (Par. XXXIII, 145) e il "#Trasumanar e organizar": "un #affetto e la #vita di #PierPaoloPasolini".
- Dante e Pasolini. La #DivinaCommedia e "La #DivinaMimesis: "l’#amor che move il #sole e le altre #stelle" (Par. XXXIII, 145) e il "#Trasumanar e organizar": "un #affetto e la #vita di #PierPaoloPasolini".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- QUALE PRESEPE SI VUOLE CONTINUARE ANCORA A "COSTRUIRE", OGGI?11 novembre 2024, di Federico La Sala
A PARTIRE DA #AMLETO, CON #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO: «TE PIACE ’O PRESEPIO?» DEL #PIANETATERRA?!
- A PARTIRE DAL "#NATALE IN CASA CUPIELLO" (1931), ALCUNE NOTE DI #FILOLOGIA E #ARCHEOLOGIA FILOSOFICA INTORNO AL #CATTOLICESIMO COSTANTINIANO.
INTRODUZIONE. Si racconta che Saulo / Paolo di Tarso, un "cittadino romano"(At. 22, 25-28), sia stato portato fino al terzo cielo (2 Corinzi 12:2): va bene! Da ricordare, però, che #DanteAlighieri ("Io non Enëa, io non Paulo sono") è andato ben oltre i cieli di #Aristotele, come racconta l’astrofisico Carlo Rovelli, una volta uscito dal "buco nero" in cui lucifericamente era caduto!
#METATEATRO E #STORIOGRAFIA: UNA DOMANDA #HAMLETICA PER "RE-SHAKESPEARE" BENE. Antropologicamente (e cristologicamente), c’è da chiedersi, se Paolo ha visto “Gesù Cristo”, come mai - contriamente a quanto visto e insegnato da #Francesco di Assisi con il suo “presepe” (#Greccio, 1223) - non ha notato, accanto a “Cristo” che lo “sgridava” («Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»), “Giuseppe” accanto a “Maria”?! Dov’è finito il "Giuseppe", discendente della "casa del #ReDavide" ("de domo David")?
UNA "#IMITAZIONEDICRISTO" ALLA PAOLO DI TARSO DI LUNGA DURATA: #NICEA (325 -2025). La domanda logico-storica è: come mai alla sua proposta di imitarlo e seguirlo, tutti e tutte si sono sbagliati e sbagliate a tal punto da seguire lui, Saulo (Paolo di Tarso), e non Gesù: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e #capo della #donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?
"ECCE HOMO" (F. #NIETZSCHE, 1888): QUALE #PRESEPE SI VUOLE CONTINUARE ANCORA A "COSTRUIRE", OGGI? Quello di Paolo di Tarso o quello di #FrancescodiAssisi? #Dante, cosa aveva già capito, come anche Shakespeare, e Pirandello e, infine, #Eduardo De Filippo (1931)?
"#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610): QUALE FUTURO PER IL "#DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (#GALILEO GALILEI, 1632)?
- NOTE:
- TEATRO (FILOSOFIA) E #METATEATRO (METAFILOSOFIA): "NATALEINCASACUPIELLO".
- STORIAELETTERATURA #TEATRO, #METATEATRO E #FILOLOGIA: RE-#SHAKESPEARE CHIARA-MENTE, CON #VICTORHUGO, LUIGI #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO.
- In onore e memoria di Victor Hugo e Charles Baudelaire...
- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....
- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....
- Alcuni appunti a margine della presentazione nell’articolo allegato - v. in fondo - di Paola Martino, “Perdere la testa”: a Milano una mostra sulla decapitazione", (#Artuu, 29 Ottobre 2024 ), presso la Galleria BKV Fine Art di #Milano.
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CHE ORA E’? L’OROLOGIO E’ ANCORA FERMO AL TEMPO DI "CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI"?! Una "memoria" di Carlo Levi.6 novembre 2024, di Federico La Sala
CHE ORA E’? L’OROLOGIO E’ ANCORA FERMO AL TEMPO DI "CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI"?!
STORIA E #STORIOGRAFIA DI LUNGA DURATA. UNA #HAMLETICA #DOMANDA ("#QUESTION") DI #CARLOLEVI...
- In #memoria di #DanteAlighieri, #WilliamShakespeare, #GiambattistaVico...
Filologia, Filosofia e #Storia della Carità "Mammonica" ("#Caritas"), senza alcuna tracia di #Grazia ("#Charis"):
"Si usa dire che ci sono due sole strade, due soli principi su cui costruire lo #Stato e la #Società: quello russo e quello americano. Ebbene, ce n’è un terzo, del tutto diverso e ugualmente importante, ed è quello italiano. La via americana sarebbe, dicono, quella della #Libertà, la via russa quella della #Giustizia: ma la via italiana è un’altra, è quella della #Carità.
Naturalmente, questa carità statale, ha certi suoi caratteri speciali: è una carità che si rivolge a se stessa, che riguarda anzitutto e unicamente i componenti dello Stato che su di essa si fonda. Lo Stato è l’incarnazione della Carità, e il suo dispensatore: e la sparge sui propri membri, sui funzionari, sui parenti, sugli amici, su coloro che direttamente o indirettamente ne vivono." (Carlo Levi, "L’Orologio", Einaudi editore, 1950).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- AL DI Là DEL PAOLINISMO E DEL LENINISMO: UN CONTRIBUTO DI GRAMSCI PER "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT) E TENTARE DI RIUSCIRE AD #ABITARE UN #PIANETATERRA COMUNE.31 ottobre 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA E FILOSOFIA: CON KANT A EFESO, IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS...
- UN PARALLELO TRA #CRISTO E SAN #PAOLO, #MARX E #LENIN, E,UNA SOLLECITAZIONE A RITORNARE A #EFESO E A PORTARSI OLTRE I "#LOGO" DEI VARI "CATTOLICISSIMI" #PARTITI ATEI O DEVOTI:
Alcuni appunti a margine di UN CONTRIBUTO DI GRAMSCI PER "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT) E TENTARE DI RIUSCIRE AD #ABITARE UN #PIANETATERRA COMUNE (ERACLITO): RI-PENSARE LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA E #CRISTOLOGICA ("ECCE HOMO") E, AL CONTEMPO, LA #QUESTIONE TEOLOGICO-POLITICA DEL #CORPOMISTICO DELLA #COMUNITA’:
A) - "POSIZIONE DEL PROBLEMA: [...] Marx è un creatore di Weltanschauung, ma quale è la posizione di Ilici? È puramente subordinata e subalterna? La spiegazione è nello stesso marxismo - scienza e azione -. Il passaggio dall’utopia alla scienza e dalla scienza all’azione (ricordare opuscolo relativo di Carlo Radek). La fondazione di una classe dirigente (cioè di uno Stato) equivale alla creazione di una Weltanschauung. [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7, § 33").
B) - PAOLO DI TARSO, IL "CITTADINO ROMANO", DIVENTA "CRISTIANO", E COSTRUISCE LA "WELTANSCHAUUNG" DEL SUO "PARTITO", FA DI #CRISTO IL "RE" DELLA "COSMOTEANDRIA" DELLA SOCIETA’ DEL SUO TEMPO, E COMINCIA A LAVORARE ALLA CONQUISTA DELL’#EGEMONIA SUI VARI "PARTITI" DEGLI APOSTOLI. Alcune note dai testi evangelici:
- a) Dagli "Atti degli Apostoli" (19, 1-7): "Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell’altopiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero.
 Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini." (cfr."La Parola - C.E.I.");
Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini." (cfr."La Parola - C.E.I.");
- b) Dalla "Prima Lettera ai Corinzi" (1-13): "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);
- c) Dalla "Lettera agli Efesini" (4. 1/11-13): "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (cfr. Efesini, 4.1/11-13).
C) "IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS": STUDIANDO LE OPERE DI #SWEDENBORG, CON "I SOGNI DI UN VISIONARIO CHIARITI I SOGNI DELLA METAFISICA" (1766), PUR SE CON UN LAPSUS SIGNIFICATIVO DI "ARISTOTELISMO" RESIDUO, RISCOPRE LA LEZIONE DEL FILOSOFO DEL "LOGOS", #ERACLITO DI #EFESO ("Vegliando, noi abbiamo un mondo comune; ma sognando ciascuno ha il suo mondo") E INIZA A LAVORARE AL SUO PROGRAMMA DI CRITICA DELLA "RAGION "PURA, DELLA "RAGION PRATICA", E DELLA "CAPACITA’ DI GIUDIZIO" E,INFINE A RIFLETTERE SULLA "FINE DI TUTTE LE COSE" ( E SUL COSIDDETTO "CRISTIANESIMO") E, ANCORA, A RIPROPORRE E A RIAPRIRE LA QUESTIONE ANTROPOLOGICa ("LOGICA", 1800).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E STORIA. UN "SOGNO" DI TEOCRITO, LE GRAZIE ("CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI GRATITUDINE30 ottobre 2024, di Federico La Sala
UN "SOGNO" DI #TEOCRITO, LE GRAZIE ("CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE:
- UNA #DOMANDA DI #ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...
- In ricordo di Lorenzo Valla e di Giambattista Vico, una breve nota a margine di una vecchia curiosità...
DELLA #GRAZIA ("#CHARIS - #ΧÁΡΙΣ"), DELLA CARITÀ ("CHARITAS") E DEL "SÀPERE AUDE!" (#KANT): COME MAI OGGI, NELL’ATTUALE PRESENTE STORICO, LE "#GRAZIE" (LE GRECHE "CHARITES = ΧÁΡΙΤΕΣ", LE COSIDDETTE "CARITI") SONO DEL TUTTO ASSENTI DA OGNI #CATTEDRA DI ISTRUZIONE E INFORMAZIONE E LE "#DIS_GRAZIE" HANNO INVASO DEL TUTTO IL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA #CONVIVENZA UMANA? #MEMORIA E #POESIA.
Sul filo di #Virgilio ("Bucoliche") e di #DanteAlighieri, forse, un aiuto a trovare una possibile risposta alla domanda del "cruciverba" può venire da Teocrito (in greco antico: Θεόκριτος, Theókritos; #Siracusa, 315 a.C. - 260 a.C. circa). Egli è stato un poeta siciliano, inventore della poesia bucolica, che in una sua opera, gli "Idilli", in particolare nel XVI, intitolato "Le Grazie, o Ierone", così conclude:
 "Che cosa esiste di amabile per gli esseri umani senza le Grazie? Che io possa restare insieme con le Grazie per sempre
"Che cosa esiste di amabile per gli esseri umani senza le Grazie? Che io possa restare insieme con le Grazie per sempre
 ("[...[τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ’ εἴην.").
("[...[τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπητόν ἀνθρώποις ἀπάνευθεν; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ’ εἴην.").- NOTE:
- ANTROPOLOGIA, MITO STORIA E LETTERATURA: LE CARITI. "Le Cariti (in greco antico: Χάριτες, #Chàrites) sono dee della mitologia greca, corrispondenti nella mitologia romana alle #Grazie (in latino: Gratiae). Sono personificazioni degli aspetti della #Grazia ed erano, probabilmente sin dall’origine, legate al culto della natura e della vegetazione. Sono anche le dee della gioia di vivere ed infondono la gioia della Natura nel cuore degli dèi e dei mortali. [...]"(cit.).
- STORIA E LETTERATURA:VIRGILIO. #TEOCRITO E L’#ARCADIA DELLE "#BUCOLICHE". "[...] La trattazione di temi pastorali non era un elemento di novità per l’ambiente culturale romano del I secolo a.C.; era innovativo invece il fatto che un poeta dedicasse a questo tema un intero libro. All’inizio della sesta egloga, Virgilio scrive: «La nostra Talia, per prima, si degnò di scherzare col verso siracusano / e non si vergognò di frequentare le selve.» [...] allude alla figura di Teocrito [...] Per Virgilio la poesia pastorale non era però semplicemente imitazione di Teocrito o mero esercizio letterario; era qualcosa di strettamente connesso con la sua indole e le sue esperienze. [...] L’Arcadia, che è il locus amoenus dei pastori virgiliani, è carico di significati metaforici: è un luogo di riparo, un luogo dove vivere e cantare l’amore, anche deluso, ed è il luogo della civiltà contrapposta alla barbarie. [...] nella IV egloga, in particolare [...] il poeta celebra l’imminenza del ritorno dei Saturnia Regna, in seguito alla nascita di un “bambino divino”, che avrebbe posto fine al tragico presente per inaugurare una nuova età dell’oro. [...] nella #DivinaCommedia il poeta latino #Stazio dice di essersi convertito al Cristianesimo dopo avere letto la IV #Bucolica (Purgatorio - Canto ventiduesimo, vv. 55-93). Questa tradizione iniziò con un discorso di #CostantinoilGrande, databile tra il 313 e il 325, e riportato da #EusebiodiCesarea in appendice alla sua Vita di Costantino col titolo All’assemblea dei santi. [...]" (cit. )
- GIAMBATTISTA VICO E LA #MEMORIA STORICA DELL’ARCADIA, DELLA "PASTORAL POESIA" DI #TEOCRITO ##VIRGILIO E #SANNAZARO, NELLA "SCIENZA NUOVA" DEL 1744:
- "[...]Tal propietà di pascere tali primi greggi del Mondo dev’essere stata d’Apollo, che truovammo Dio della Luce Civile, o sia della Nobiltà, ove dalla Storia Favolosa ci è narrato Pastore in Anfriso; come fu Pastore Paride, il quale certamente era Reale di Troja: e tal’è ’l Padre di famiglia, che Omero appella Re; il quale con lo scettro comanda, il bue arrosto dividersi a’ mietitori, descritto nello Scudo d’Achille; dove sopra abbiamo fatto vedere la Storia del Mondo, e quivi esser fissa l’Epoca delle Famiglie: perchè de’ nostri pastori non è propio il pascere, ma il guidar’, e guardare gli armenti, e i greggi; non avendosi potuto la Pastoreccia introdurre, che dopo alquanto assicurati i confini delle prime città, per gli ladronecci, che si celebravano a’ tempi eroici: che dev’essere la cagione, perchè la Bucolica, o Pastoral Poesia venne a’ tempi umanissimi egualmente tra’ Greci con Teocrito, tra’ Latini con Virgilio, e tra gl’Italiani con Sannazaro. (Giambattista Vico, "Scienza Nuova" del 1744, L. V, II.).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- ANTROPOLOGIA E STORIA. "BUONENOTIZIE: A ROMA L’ARCHIVIO CARLA LONZI HA TROVATO UNA NUOVA SEDE.28 ottobre 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA ANTROPOLOGIA E GENERE UMANO: CARLA LONZI (1931-1982).
UNA NOTA A COMMENTO DELLE "BUONENOTIZIE: A ROMA L’ARCHIVIO CARLA LONZI HA TROVATO UNA NUOVA SEDE" (*).
MA A CHE #GIOGO SI CONTINUA A #GIOGARE, ANCORA A QUELLO DEL "SAPIENTE" (1510) DEL FILOSOFO #BOVILLUS (Charles de #Bovelles): LA DONNA DEFINITA IN RAPPORTO ALL’UOMO?
- UNA DOMANDA (UNA #QUESTION #HAMLETICA): MA DOVE SONO I FILOSOFI E LE FILOSOFE, LE TEOLOGHE E I TEOLOGI, OGGI!?
Nonostante tutta la sapienza accumulata nei secoli, e, dopo la scoperta dei "#buchineri" e della formidabile ipotesi relativa all’esistenza dei "#buchibianchi", nel pensiero e nelle Istituzioni ancora non si corre ai ripari e non si procede a correggere "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia, 1978). O, per cecità e necessità, si preferisce continuare a vivere come "sapienti e contenti" nella tragica #cosmoteandria platonico-hegeliana?
Forse è bene rileggersi una breve sintesi "storico-poetica" della #fenomenologiadellospirito dal XII al XIX secolo (e oltre) di #Baudelaire e riflettere sulla storia dello “chátiment de l’#orgueil” (“L’orgoglio punito” di “Les Fleurs du Mal”) del poeta e filosofo Charles Baudelaire e portarsi fuori da interi millenni di labirinto. Se non ora, quando?!
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA COSTITUZIONE E MATEMATICA. UNA NOTA PER UNA "RICAPITOLAZIONE" ANTROPOLOGICA, ALLA LUCE DEL SOLE.18 ottobre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOGENESI FILOLOGIA E FILOSOFIA: CHE GRANDE "PREISTORIA" DELL’INTERA #UMANITA’ DEL PIANETA TERRA!
RIPARTIRE DA CAPO, E IMPARARE A #CONTARE, A #CALCOLARE...
INDIVIDUO E SPECIE: "L’ONTOGENESI RICAPITOLA LA FILOGENESI" (ERNST HAECKEL).
MA QUALE "RICAPITOLAZIONE", COME DA #ANTROPOLOGIA COSMICA, QUALE QUELLA DI #DANTE ALIGHIERI ("L’#AMOR CHE MUOVE IL #SOLE E LE ALTRE #STELLE") O COME QUELLA (DELL’ATTUALE #PRESENTE STORICO) DA #ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DA "#CAVERNA" PLATONICA E PAOLINA?!
"SAPERE AUDE!" (#KANT, 1784). NON E’ IL CASO DI CORRERE AI RIPARI E, FINALMENTE, uscire dall’orizzonte della #tragedia e dal #letargo epistemologico e #correggere un’operazione #matematica "sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#Franca Ongaro #Basaglia, 1978)!!!
COSMOTEANDRIA E STORIA. LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO:
 "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).
"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).- NOTE:
- MEMORIA, #STORIA, #SCIENZA, #STORIOGRAFIA E #CRITICA: ERNST HAECKEL. "Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Potsdam, 16 febbraio 1834 - Jena, 9 agosto 1919) è stato un biologo, zoologo, filosofo e artista tedesco.( ...)".
- ELIOCENTRISMO (COPERNICO), "ELIOCENTRISMO" (COSMOTEANDRIA), ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024) E #TEOLOGIA-#POLITICA DEI #DUE SOLI (#DANTEALIGHIERI) ALLA #LUCE DEL #SOLE (NON DEL "RE SOLE")!
- "SÀPERE AUDE" (ORAZIO). Da sempre ogni #essere umano cammina "#insieme" ("#together"( con #sé stesso (come un #altro), ma dopo la lezione minoica-ateniese (di #Arianna e #Teseo) e millenni di #labirinto edipico (e dopo gli innumerevoli tentativi di chiarimenti di tanti esploratori e tante esploratrici) non è ancora tempo di venir fuori dallo "#stato di #minorità" (#Kant, 1784), uscire dall’#inferno, e arrivare alla #Terra Promessa?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA "PAROLA" DI METASTORIA E METAFILOSOFIA: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE".16 ottobre 2024, di Federico La Sala
"IL PRESEPE" (E IL POSSIBILE "CREDO") DI MICHELANGELO BUONARROTI, OGGI (15 OTTOBRE 2024).
UNA #PAROLA DI #METASTORIA E #METAFILOSOFIA: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Ct. 8.6 - trad. di #Giovanni Garbini).
Il Concilio Ecumenico di Costantinopoli, del 381 [del 2024], definì la #divinità dello #SpiritoSanto (#Charitas) con le parole che ancora oggi si ripetono nel "Credo": «Credo nello Spirito Santo ["Deus charitas est": 1 Gv. 4.8], che è Signore [#Logos: Gv.1.1] e dà vita, e procede dal Padre ("#Giuseppe") [e la Madre -"#Maria"] e dal Figlio ["#Gesù"- "#Cristo"]. Con il Padre [e la Madre] e il Figlio, [l’#Amore -"Charitas"] è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei #profeti» [e delle #sibille].
Allegato: #Tondo Doni. Nella cornice non sono "raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti" - come scrivono gli esperti della "Galleria degli Uffizi" - ma chiaramente, e per Michelangelo, #due profeti e due sibille.
- NOTA:
- STORIA E LETTERATURA, STORIOGRAFIA. E #ANTROPOLOGIA: "SAPERE AUDE!" (#ORAZIO - #KANT). Il passato vuole una attenzione nuova, non vuole vivere più nel passato: "In cielo e in terra ci sono più cose, Orazio, di quanto non ne sogni la tua filosofia" (#Shakespeare, #Hamlet, I.5).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---IL "WORLD ANATOMY DAY", LA LEZIONE ANTROPOLOGICA DI MICHELANGELO, E LA "SCOPERTA" DI GIOVANNI VALVERDE..16 ottobre 2024, di Federico La Sala
GIORNATA MONDIALE DELL’#ANATOMIA ("World Anatomy Day"): NON SOLO VESALIO.
- ANTROPOLOGIA, #STORIA, E #STORIOGRAFIA:
GIOVANNI VALVERDE DE AMUSCO E LA "SCOPERTA" DEI "#TESTICOLI DELLE #DONNE" (cfr. allegato: cap. 15 del Libro III dell’ "Anatomia" di #GiovanniValverde, stampata a Roma nel 1560).
COME NASCONO I BAMBINI: #RIVOLUZIONE COPERNICANA (IN #TERRA E IN #CIELO) E #MENSCHWERDUNG. #AL TEMPO DI #FILIPPO II e #TERESA D’AVILA, il medico Giovanni Valverde riconosce alla #donna il ruolo attivo nell’atto del #concepimento e pone le premesse per l’#uguaglianza, per la "#ley de #igualdad".
- NOTE:
- ANATOMIA E RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA (E IN ASTRONOMIA): ANDREA VESALIO.
- IL CAMMINO DELLE SIBILLE E DEI PROFETI E L’ANATOMIA TEOLOGICO-POLITICA DI MICHELANGELO. Prima di #Harvey (1578 - 1657), nel XVI secolo, all’epoca di Ferrante Sanseverino (1507-1568) e di Girolamo #Seripando (1493-1563), la rivoluzione scientifica (in #astronomia e in #medicina) già correva al galoppo (come il #serviziopostale gestito dalla famiglia dei #Tasso, e di #Torquato Tasso), e #Michelangelo Buonarroti ne sa già molto, come l’amico medico #Realdo Colomdo (1516-1559), #GiovanniValverde, #Vesalio (1514-1564), ed #ElGreco (1541-1614). Allegato (foto): omaggio di Giovanni Valverde, nella sua Anatomia" a Michelangelo (e al suo apostolo #Bartolomeo della #Cappella Sistina).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- PEDAGOGIA STORIA LETTERATURA E FILOLOGIA: L’INDICAZIONE DELLA SIBILLA TIBURTINA E LA ESORTAZIONE DELLA DEA "LEVANA".14 ottobre 2024, di Federico La Sala
PEDAGOGIA STORIA LETTERATURA E FILOLOGIA: L’INDICAZIONE DELLA SIBILLA TIBURTINA E LA ESORTAZIONE DELLA DEA "LEVANA" ("CONTEMPLATE CHI E’ PIU’ GRANDE DI VOI!") NELL’ORIZZONTE DELLA "MORTE DI DIO" E DEL NICHILISMO.
Una ipotesi di ricerca... *
A) Nella sua "Legenda Aurea", Jacopo da Varagine scrive: "Narra papa Innocenzo III che il senato voleva adorare come un dio Ottaviano per aver riunito e pacificato tutto il mondo; ma il prudente imperatore non volle usurpare il nome di immortale poiché ben sapeva di essere come uomo, mortale. Insistevano i senatori nel loro proposito onde Ottaviano interrogò la Sibilla per sapere se mai sarebbe nato nel mondo qualcuno più grande di lui.
 Era il giorno della Natività di Cristo e la Sibilla si trovava in una stanza, sola con l’imperatore: ed ecco apparire un cerchio d’oro attorno al sole e in questo cerchio una vergine bellissima con un fanciullo in grembo. La Sibilla mostrò questo portento all’imperatore: mentre costui teneva gli occhi fissi alla visione sentì una voce che diceva: - Questa è l’ara del cielo! -. Esclamò allora la Sibilla: - Questo fanciullo è più grande di te; adoralo -.
Era il giorno della Natività di Cristo e la Sibilla si trovava in una stanza, sola con l’imperatore: ed ecco apparire un cerchio d’oro attorno al sole e in questo cerchio una vergine bellissima con un fanciullo in grembo. La Sibilla mostrò questo portento all’imperatore: mentre costui teneva gli occhi fissi alla visione sentì una voce che diceva: - Questa è l’ara del cielo! -. Esclamò allora la Sibilla: - Questo fanciullo è più grande di te; adoralo -.
 La stanza dove avvenne tale fatto è stata poi consacrata alla Madonna ed ora si chiama Santa Maria Ara Coeli.
Timoteo ci dice di aver trovato negli antichi libri romani lo stesso fatto raccontato in modo diverso: dopo trentacinque anni di regno, Ottaviano salì in Campidoglio e chiese agli dei chi avrebbe retto l’impero dopo di lui. Udì in risposta queste parole: - Un fanciullo celeste, figlio del Dio vivente, nato da una vergine immacolata -. Ottaviano fece allora costruire un altare e vi fece scolpire queste parole: - Questo è l’altare del figlio del Dio vivente - (...)" (Jacopo da Varagine, "Legenda Aurea", Libreria Editrice Fiorentina, p. 52 s.).
La stanza dove avvenne tale fatto è stata poi consacrata alla Madonna ed ora si chiama Santa Maria Ara Coeli.
Timoteo ci dice di aver trovato negli antichi libri romani lo stesso fatto raccontato in modo diverso: dopo trentacinque anni di regno, Ottaviano salì in Campidoglio e chiese agli dei chi avrebbe retto l’impero dopo di lui. Udì in risposta queste parole: - Un fanciullo celeste, figlio del Dio vivente, nato da una vergine immacolata -. Ottaviano fece allora costruire un altare e vi fece scolpire queste parole: - Questo è l’altare del figlio del Dio vivente - (...)" (Jacopo da Varagine, "Legenda Aurea", Libreria Editrice Fiorentina, p. 52 s.).B) Nei "Suspiria de Profundis", a proposito di Levana (e le «Nostre Signore del Dolore»), Thomas De Quincey scrive:
 "Spesso a Oxford vidi nei miei sogni Levana. La riconobbi dai suoi simboli romani. Chi è Levana? Lettore, che sostieni di non aver troppo tempo per erudirti, non ti dispiacerà che te lo spieghi. Levana era la dea romana che esercitava per il neonato il primo ministero di nobilitante benevolenza, tipico, nel suo rituale, di quella grandezza che è dappertutto propria dell’uomo e di quella benignità delle potenze invisibili che anche nel mondo pagano scende talvolta a sostenerla. Al momento stesso della nascita, proprio quando il neonato saggiava per la prima volta l’atmosfera del nostro travagliato pianeta, esso era deposto in terra.
"Spesso a Oxford vidi nei miei sogni Levana. La riconobbi dai suoi simboli romani. Chi è Levana? Lettore, che sostieni di non aver troppo tempo per erudirti, non ti dispiacerà che te lo spieghi. Levana era la dea romana che esercitava per il neonato il primo ministero di nobilitante benevolenza, tipico, nel suo rituale, di quella grandezza che è dappertutto propria dell’uomo e di quella benignità delle potenze invisibili che anche nel mondo pagano scende talvolta a sostenerla. Al momento stesso della nascita, proprio quando il neonato saggiava per la prima volta l’atmosfera del nostro travagliato pianeta, esso era deposto in terra.
 Questo gesto si prestava a diverse interpretazioni. Ma immediatamente, affinché una così nobile creatura non restasse in quell’umile posizione più di un istante, o la mano paterna in rappresentanza di Levana, o un parente prossimo in rappresentanza del padre, lo sollevava in alto, gli ordinava di stare eretto quale sovrano di tutto il mondo e ne volgeva la fronte verso le stelle dicendo, forse in cuor suo: «Ammirate ciò che è più grande di voi!» Questo atto simbolico rappresentava la funzione di Levana. E quella dama misteriosa che non rivelò mai il suo volto (salvo a me in sogno) ma sempre agì per procura, traeva il suo nome dal verbo latino (rimasto tuttora nell’italiano) levare, sollevare verso l’alto.
Questo gesto si prestava a diverse interpretazioni. Ma immediatamente, affinché una così nobile creatura non restasse in quell’umile posizione più di un istante, o la mano paterna in rappresentanza di Levana, o un parente prossimo in rappresentanza del padre, lo sollevava in alto, gli ordinava di stare eretto quale sovrano di tutto il mondo e ne volgeva la fronte verso le stelle dicendo, forse in cuor suo: «Ammirate ciò che è più grande di voi!» Questo atto simbolico rappresentava la funzione di Levana. E quella dama misteriosa che non rivelò mai il suo volto (salvo a me in sogno) ma sempre agì per procura, traeva il suo nome dal verbo latino (rimasto tuttora nell’italiano) levare, sollevare verso l’alto.
 Tale è la spiegazione di Levana. E da ciò è venuto che alcuni intendano per Levana la potenza tutelare che vigila l’educazione nella prima infanzia. Colei che non tollererebbe alla nascita del suo mirabile pupillo nemmeno una sua finta o simbolica degradazione, ancor meno si può ritenere che tollererebbe la vera degradazione inerente al mancato sviluppo delle facoltà che sono in lui. Ella perciò vigila sull’umana educazione. Ora la parola educo, con la penultima breve, è derivata (per un processo che spesso si riscontra nella cristallizzazione delle lingue) dalla parola edùco, con la penultima lunga. Tutto ciò che educe, o sviluppa, educa. Per educazione di Levana si intende, perciò, non il povero meccanismo che è messo in moto da sillabari e da grammatiche, ma il meccanismo che è mosso dal possente sistema di forze interiori nascoste nel profondo della vita umana e che, per mezzo di passioni, lotte, tentazioni, energie della resistenza, agisce continuamente sui fanciulli e non si arresta mai ne giorno né notte, come le stesse ruote possenti del giorno e della notte, i cui istanti, simili a raggi che non hanno sosta, brillano eternamente nel loro ruotare. (cfr. T. De Quincey, "Confessioni di un oppiomane" - con i racconti: "Suspiria de Profundis" e "La diligenza inglese", Garzanti 1987).
Tale è la spiegazione di Levana. E da ciò è venuto che alcuni intendano per Levana la potenza tutelare che vigila l’educazione nella prima infanzia. Colei che non tollererebbe alla nascita del suo mirabile pupillo nemmeno una sua finta o simbolica degradazione, ancor meno si può ritenere che tollererebbe la vera degradazione inerente al mancato sviluppo delle facoltà che sono in lui. Ella perciò vigila sull’umana educazione. Ora la parola educo, con la penultima breve, è derivata (per un processo che spesso si riscontra nella cristallizzazione delle lingue) dalla parola edùco, con la penultima lunga. Tutto ciò che educe, o sviluppa, educa. Per educazione di Levana si intende, perciò, non il povero meccanismo che è messo in moto da sillabari e da grammatiche, ma il meccanismo che è mosso dal possente sistema di forze interiori nascoste nel profondo della vita umana e che, per mezzo di passioni, lotte, tentazioni, energie della resistenza, agisce continuamente sui fanciulli e non si arresta mai ne giorno né notte, come le stesse ruote possenti del giorno e della notte, i cui istanti, simili a raggi che non hanno sosta, brillano eternamente nel loro ruotare. (cfr. T. De Quincey, "Confessioni di un oppiomane" - con i racconti: "Suspiria de Profundis" e "La diligenza inglese", Garzanti 1987).- NOTA:
- MEMORIA POETICA, STORIOGRAFIA, E FILOLOGIA: "IL DANTE D(E)I CAPRONI", "LES FLEURS DU MAL" DI BAUDELAIRE, E WALTER BENJAMIN: "[...] L’intreccio fra Dante, Leopardi, Baudelaire, Caproni, si fonda su un’immagine mentale, su un’icona emozionale: e l’alternativa «Enfer ou Ciel» sintetizza, annullandola immediatamente («qu’importe?»), l’opposizione fra «ire in giù» e «com’altrui piacque» [...].
 Già in Baudelaire d’altronde si era costituita una fondamentale linea tematica di memoria poetante, in cui la Commedia esercita un ruolo che definirei di asse di rotazione. La lirica di chiusura delle Fleurs sembra davvero rileggere come in uno specchio la conclusione della Commedia. Baudelaire dovette avere luminoso negli occhi e nella memoria il fulgore, l’éclair della visione finale di Dante (così rendevano il vocabolo le versioni francesi del poema, e così anche Walter Benjamin tradurrà il verbo aufblitzen traducendo le sue Tesi di filosofia della storia, per indicare «il lampo in cui l’immagine dialettica balena») [...]"(cfr. Corrado Bologna, in «Tutti riceviamo un dono». Giorgio Caproni trent’anni dopo, a cura di Corrado Bologna, EDIZIONI DELLA NORMALE, 2024, pp. 148-149).
Già in Baudelaire d’altronde si era costituita una fondamentale linea tematica di memoria poetante, in cui la Commedia esercita un ruolo che definirei di asse di rotazione. La lirica di chiusura delle Fleurs sembra davvero rileggere come in uno specchio la conclusione della Commedia. Baudelaire dovette avere luminoso negli occhi e nella memoria il fulgore, l’éclair della visione finale di Dante (così rendevano il vocabolo le versioni francesi del poema, e così anche Walter Benjamin tradurrà il verbo aufblitzen traducendo le sue Tesi di filosofia della storia, per indicare «il lampo in cui l’immagine dialettica balena») [...]"(cfr. Corrado Bologna, in «Tutti riceviamo un dono». Giorgio Caproni trent’anni dopo, a cura di Corrado Bologna, EDIZIONI DELLA NORMALE, 2024, pp. 148-149).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- QUALE "PRESEPE"?! "THAT IS THE #QUESTION": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA DI ESSERE O NON ESSERE, ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL PIANETA TERRA.9 ottobre 2024, di Federico La Sala
TEATRO (STORIA) E METATEATRO (METASTORIA).
Psicoanalisi della società contemporanea e "Disagio della civiltà" (1929): un segnavia per oltrepassare "Scilla e Cariddi", le colonne d’Ercole, e non naufragare (Ulisse).
- Sulla "presenza" nell’#Amleto di richiami alla figura della parabola evangelica del "Figliuol #prodigo" e della storia tragica di #Edipo, figlio di Laio e #Giocasta, re e regina di Tebe, una nota a margine del lavoro "archeologico" di Paul Adrian Fried (cfr. "Prodigo è edipico scritto male - Allusioni bibliche come lenti per Amleto"- 08 ottobre 2024).
- In memoria di Omero, Ovidio, Virgilio, Dante, Shakespeare, e Freud...
ARCHEOLOGIA E LETTERATURA: UNA "BIBLICA" TRAGEDIA. Edipo (Mosè e Gesù) e il problema dell’#identificazione con il #Padre (#Re). Se esiste un "complesso di Edipo", dovremmo avere anche un "complesso di Laio" (Paul Adrian Fried, cit.) ... certamente! Si cfr. "Il complesso di Laio. I rapporti famigliari nei disegni dei ragazzi" di Tilde Giani Gallino, Einaudi, 1977).
AL DI LA’ DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO" (J. #BACHOFEN, 1861): OLTRE LA COSMOTEANDRIA. Tuttavia, a mio parere, senza la comprensione antropologica della "scena primaria" (#Otto Rank, 1915) della hamletica #Mousetrap (III.2) non è possibile comprendere tutta l’importanza del programma di "Amleto" ed "#Ofelia" (e dello stesso "sogno" di Freud) di portarsi al di là delle #ombre del "padre" (re) e della "madre" (regina) e di divenire ed essere cittadino-sovrano e cittadina-sovrana dello "stato di Danimarca".
QUALE "PRESEPE"?! "THAT IS THE #QUESTION": UNA #QUESTIONEANTROPOLOGICA, E TEOLOGICO-POLITICA, DI ESSERE O NON ESSERE, NON SOLO DI PSICOLOGIA O SOCIOLOGIA, ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL #PIANETATERRA.
- Nota:
- PSICOANALISI E BIBLIOGRAFIA: IL #FAMILISMO DI #EDIPO, DEL #GIOCASTOLAIO DELLA #TRAGEDIA. "Il complesso di #Laio. I rapporti famigliari nei disegni dei ragazzi" di Tilde Giani Gallino, Einaudi, 1977.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- BRUXELLES. Le parole del Papa sulle donne e l’insolita nota dell’Università Cattolica di Lovanio (di Gianni Cardinale)..29 settembre 2024, di Federico La Sala
Il caso.
Le parole del Papa sulle donne (e l’insolita nota dell’Università di Lovanio)
- Discorso nella sede francofona dell’ateneo. Poi a sorpresa, quando l’incontro è al termine, arriva una nota dell’ateneo non firmata che critica le parole del Papa sul ruolo femminile. Cosa è successo
di Gianni Cardinale, inviato a Bruxelles (Avvenire, sabato 28 settembre 2024)
- [Foto] Il discorso del Papa agli universitari della Cattolica di Lovanio - Ansa
Papa Francesco incontra gli studenti e i docenti dell’Université Catholique di Louvain-la Neuve, la sezione francofona dell’antica Lovanio che nel 1968 dovette lasciare la casa madre in seguito alle proteste dei nazionalisti fiamminghi che ne reclamavano la soppressione. Ma di questa vicenda nessuno ha fatto cenno sia nella visita a Leuven, né a Louvain. Gli argomenti sono altri. Con una sorprendente contestazione dell’ateneo alle parole del Pontefice. Ma andiamo per ordine.
 Il Papa viene accolto dal saluto della rettrice Francoise Smets. E poi gli viene letta una lettera di studenti e professori che prendendo spunto dalla Laudato si’ afferma in modo netto che «l’appello allo sviluppo integrale ci sembra incompatibile con le posizioni sull’omosessualità e sul posto delle donne nella Chiesa cattolica».
Il Papa viene accolto dal saluto della rettrice Francoise Smets. E poi gli viene letta una lettera di studenti e professori che prendendo spunto dalla Laudato si’ afferma in modo netto che «l’appello allo sviluppo integrale ci sembra incompatibile con le posizioni sull’omosessualità e sul posto delle donne nella Chiesa cattolica».Il Papa non risponde direttamente a queste osservazioni, ma nel suo discorso oltre ad affrontare il tema del cristianesimo e l’ecologia («non siamo padroni, siamo ospiti e pellegrini sulla terra») affronta anche tale questione.
 «Pesano qui - spiega - violenze e ingiustizie, insieme a pregiudizi ideologici». Perciò «bisogna ritrovare il punto di partenza: chi è la donna e chi è la Chiesa». La Chiesa «è il popolo di Dio, non un’azienda multinazionale». La donna, «nel popolo di Dio, è figlia, sorella, madre. Come io sono figlio, fratello, padre».
«Pesano qui - spiega - violenze e ingiustizie, insieme a pregiudizi ideologici». Perciò «bisogna ritrovare il punto di partenza: chi è la donna e chi è la Chiesa». La Chiesa «è il popolo di Dio, non un’azienda multinazionale». La donna, «nel popolo di Dio, è figlia, sorella, madre. Come io sono figlio, fratello, padre».
 Per Francesco «ciò che è caratteristico della donna, ciò che è femminile, non viene sancito dal consenso o dalle ideologie». Ma «la dignità è assicurata da una legge originaria, non scritta sulla carta, ma nella carne». La dignità è «un bene inestimabile, una qualità originaria, che nessuna legge umana può dare o togliere».
Per Francesco «ciò che è caratteristico della donna, ciò che è femminile, non viene sancito dal consenso o dalle ideologie». Ma «la dignità è assicurata da una legge originaria, non scritta sulla carta, ma nella carne». La dignità è «un bene inestimabile, una qualità originaria, che nessuna legge umana può dare o togliere».
 A braccio ricorda che «la Chiesa è donna», e poi aggiunge: «La donna è più importante dell’uomo ma è brutto quando vuole fare l’uomo». E infine, sempre a braccio, invita a «non entrare nelle lotte con delle dicotomie ideologiche».
A braccio ricorda che «la Chiesa è donna», e poi aggiunge: «La donna è più importante dell’uomo ma è brutto quando vuole fare l’uomo». E infine, sempre a braccio, invita a «non entrare nelle lotte con delle dicotomie ideologiche». -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DEL "DILEMMA DEI PORCOSPINI", UNA TERAPEUTICA "TRAPPOLA DEL TOPO" (THE MOUSETRAP") PER SCHOPENHAUER.26 settembre 2024, di Federico La Sala
MONDO (ATLANTE), VOLONTA’ (FILOSOFIA), E RAPPRESENTAZIONE (TEATRO): UNA #HAMLETICA TERAPEUTICA "TRAPPOLA DEL TOPO" ("THE MOUSETRAP"), PER SCHOPENHAUER (1788-1860), CHE PENSAVA CHE, "SOGNANDO, CHIUNQUE DIVENTA UNO SHAKESPEARE"!
- Una nota di commento a margine di una riflessione sulla "socievolezza" schopenhaueriana - in memoria di Kant e Freud.
NEI "Parerga e Paralipomena", Arthur Schopenhauer, sicuro del suo punto di vista, scrive: “La socievolezza appartiene alle inclinazioni più pericolose, persino distruttive, poiché ci mette in contatto con esseri la cui grande maggioranza è moralmente cattiva e intellettualmente ottusi o pervertiti”. Questa "superficiale" riflessione, porta a galla (a mio parere) tutta l’incomprensione, da parte di Schopenhauer e del suo "punto di vista", non solo del problema sociologico, ma anche del problema antropologico, sulla "socievolezza" in generale, e sul tema della #interpretazionedeisogni di "un #visionario" e della "#metafisica", già portata avanti da #Kant (a partire dal 1766), e, infine, sulla intera ricerca antropologico-politica e artistica portata avanti da #Shakespeare (all’epoca di #Elisabetta I d’Inghilterra, da non dimenticare).
ANTROPOLOGIA, #TEOLOGIA-POLITICA E #SOCIETA’: "COME NASCONO I BAMBINI" (S. Freud, Analisi terminabile e interminabile", 1937). Nei "Parerga e paralipomena", ancora, scrivendo che «Sognando, chiunque diventa uno Shakespeare», il grande filosofo mette in evidenza tutta la sua grande approssimazione nell’#analisi dei #sogni e, in particolare, delle opere in cui Shakespeare ha prodotto riflessioni importanti e su cui ancor oggi è bene riflettere (con Freud e oltre #Freud), come nell’#Amleto, sulla figura del "#corpomistico" del Re, sulla figura del #Macroantropo, come in "Antonio e Cleopatra", e, in generale, sulla #piramide androcentrica di tutti i teorici della #produzione della "società" della tradizione teologico-politica dell’#Occidente, compreso lo stesso Schopenhauer.
NOTA:
- PER SHAKESPEARE, I #TOPI NON SONO NE’ #SERPENTI NE’ PORCOSPINI. IL "GLOBO" DI #SCHOPENHAUER, INVECE, E’ SEGNATO PARADIGMATICAMENTE DAL "DILEMMA DEI PORCOSPINI":
- “Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero vicini, vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si ripeté quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali. finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.
- Così il bisogno di società, che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia della propria interiorità, spinge gli uomini l’uno verso l’altro; le loro molteplici repellenti qualità e i loro difetti insopportabili, però, li respingono di nuovo l’uno lontano dall’altro. La distanza media, che essi riescono finalmente a trovare e grazie alla quale è possibile una coesistenza, si trova nella cortesia e nelle buone maniere.
- A colui che non mantiene quella distanza, si dice in Inghilterra: keep your distance! − Con essa il bisogno del calore reciproco è soddisfatto in modo incompleto, in compenso però non si soffre delle spine altrui. − Colui, però, che possiede molto calore interno preferisce rinunciare alla società, per non dare né ricevere sensazioni sgradevoli.” (Dilemma, cit.).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- ARTE E LETTERATURA RINASCIMENTALE: LA RAPPRESENTAZIONE IN EUROPA DELLA FIGURA DI "MARIA MADDALENA". Nota a margine delle opere di Federico Barocci, del "Maestro delle Mezze-Figure Femminili", e dello scrittore Paolo Silvio.25 settembre 2024, di Federico La Sala
LA LUNGA ONDA DEL RINASCIMENTO IN EUROPA E LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA DI "MARIA MADDALENA":
ARTE E STORIOGRAFIA NELL’EPOCA DELLA RIFORMA PROTESTANTE E ANGLICANA E DELLA CONTRO-RIFORMA CATTOLICA.
- Una nota a margine della mostra monografica dedicata a Federico Barocci (1535-1612), nel Palazzo Ducale di Urbino.
CONSIDERANDO LE DIFFERENZE DI RAPPRESENTAZIONE ARTISTICHE tra l’Europa del Nord e l’Europa del Sud, con la diversa atmosfera religosa" e politica dell’uno e dell’altro "campo", resta da meglio precisare, storiograficamente e artisticamente, che il rinascimento ha una onda lunga, che va almeno dalla seconda metà del Quattrocento al primo decennio del Seicento (#Shakespeare, #Cervantes, #Garcilaso El Inca de la Vega - 1616). All’interno di questo orizzonte, in cui la figura della #Maddalena (come quella delle #Sibille) è da vedersi quasi una come una cartina di #tornasole teologico-politica di "storia sociale dell’arte" (vedere, sul tema, le #Maria Maddalena del pittore olandese, chiamato "Maestro delle Mezze-Figure Femminili"), forse, è da considerare con attenzione l’opera di Federico Barocci, noto per lo straordinario "#presepe" (con un forte tono "apocalittico") della "Madonna della #gatta", per consonanza, anche il quadro dedicato a "Cristo e la Maddalena (Noli me tangere)", del 1590, e, successivamente, del 1609.
LETTERATURA E #FILOLOGIA. In un periodo storico con forti tensioni teologico-politiche, degna di nota, da associare alla produzione artistica dell’epoca sulla figura di Maria Maddalena, è "La Maddalena penitente" (1599), un’opera di grande successo di Paolo #Silvio (ristampato a cura di Felice Pagnani Raele, nel 2022), un letterato e scrittore originario di #ContursiTerme (e, probabilmente, legato anche a #Fabriano, dove agli inizi del Seicento #Orazio #Gentileschi realizzò un quadro in onore della santa, "#Apostola degli #Apostoli").
- Note:
- STORIA LETTERATURA ED EDITORIA. Paolo Silvio, "La Maddalena penitente", a cura di Felice Pagnani Raele, Ursentum, S. Maria di Castellabate (SA), 2022.
- STORIA DELL’ ARTE. Il "Maestro delle mezze figure femminili".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- FILOLOGIA ANTROPOLOGIA E CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA: "IL CAPITALE NON TRAMONTA MAI" E IL "CERCATE ANCORA" DI CLAUDIO NAPOLEONI.19 settembre 2024, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA MAMMONICA:
IL"CARINO" DI UNO STUDENTE E IL "CERCATE ANCORA" DI CLAUDIO NAPOLEONI (1990)!
- STORIAELETTERATURA: "IL CAPITALE NON TRAMONTA MAI". Una nota a margine della recensione di Alfonso Maurizio Iacono ("Doppiozero", 19 settembre 2024) di "una nuova edizione con una nuova traduzione del I Libro di Il capitale, l’unico che Marx pubblicò (K. Marx, Il capitale, Libro I, Einaudi, Torino 2024, pp. 1287)":
- "Un giorno di tanti anni fa, nella sede della redazione di ‘Pace e Guerra’, la rivista diretta da Luciana Castellina, Stefano Rodotà e Claudio Napoleoni, quest’ultimo, professore di economia politica all’Università di Torino, ci raccontava che un suo studente, che aveva letto Il capitale di Marx e a cui aveva chiesto come l’aveva trovato, aveva risposto: “carino!”. Napoleoni andò su tutte le furie esclamando: “del Capitale non si può dire che è carino! È un libro che o ti sconvolge e ti lasci prendere dal suo argomentare oppure lo respingi!”. Napoleoni aveva ragione. Oggi nessuno osa dire che è carino e tuttavia i tentativi di imbalsamarlo tra i ‘classici’ o di presentarlo come superato e obsoleto non sono poi così diversi dall’affermazione dello studente di Napoleoni. Eppure, ogni qual volta esplode una crisi economico-sociale, Marx e, in particolare Il capitale, ritorna in circolazione. [...]" (cit.).
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ricordando ancora con stima la sollecitazione #critica di Claudio Napoleoni a non addormentarsi nel #sonnodogmatico dominante, mi permetto di #pensare che lo #studente, nella sua risposta, si riferisse al #costo economico del #libro (non al contenuto) e, al contrario, fosse molto pertinente! A ben riflettere, il "carino" avrebbe dovuto allarmare il prof. e fargli #apriregliocchi e le orecchie sulla "#doppiezza" della "#carità" cattolico-paolina, nel suo significato "mercantile" ("#caritas": "caro-prezzo" e "caro-affetto") e #accogliere con #grazia la ironica sottolineatura dello studente!
"SAPERE AUDE!" (KANT, 1784; MICHEL FOUCAULT, 1984))."Da dove iniziare, volendo recuperare, soprattutto ora, il pensiero e l’opera - complessa, molteplice, culturalmente alta - di Claudio Napoleoni?" (cfr. Lelio Demichelis, "Cercare ancora. Il capitalismo, la tecnica, l’ecologia e la sinistra scomparsa. L’attualità di Claudio Napoleoni", Economia&Politica, 26 Aprile 2020).
- NOTE:
- STORIA E FILOSOFIA: "LA MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una #svolta_antropologica" (Federico La Sala, Antonio Pellicani editore, Roma 1991): l’omaggio a Claudio Napoleoni e al suo "Cercate ancora" del 1990 (v. foto della pagina 7 - allegato).
- ANTROPOLOGIA, #ECONOMIA #POLITICA, #TEOLOGIA, E #FILOLOGIA: #CHARITAS (non #Caritas)! "Le #Cariti (in greco antico: #Χάριτες, #Chàrites) sono dee della mitologia greca, corrispondenti nella mitologia romana alle #Grazie (in latino: Gratiae). [...]" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Cariti ).
- STORIA E SOCIETA’. [...] A quanto pare, la "musica" non è proprio cambiata e il "#carino" vale (ancora) sia per il discorso su "Fineschi e i suoi collaboratori" sia su "Il futuro del capitalismo: Crollo o sviluppo?" (di #Colletti e #Napoleoni, dell’editore Laterza del 1970, di ben 687 pagine). Il "circolo filologico" della #critica dell’#economia politica e della #religione "mammonica", a quanto pare, è chiuso e il #capitalismo (con il suo #Capitale) ha "vinto" il suo "e-terno al #lotto".
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- NON C’E’ PIù GRATITUDINE. Una nota a margine di "Un brav’uomo è difficile da trovare" (Flannery O’ Connor).15 settembre 2024, di Federico La Sala
LA "FELINA" TRAGEDIA: ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD, 1937).
- Una nota di commento a margine del racconto di Flannery O’ Connor, "Un brav’uomo è difficile da trovare.
PARTENZA. "La nonna non voleva andare in Florida. Voleva andare a far visita ad alcuni parenti nel Tennessee orientale e si aggrappava a qualsiasi pretesto per far cambiare idea a Bailey. Bailey era il figlio con cui viveva, il suo unico maschio": la #nonna (la protagonista) si porta dietro, in macchina, per un viaggio di "tre giorni", non volendo lasciarlo a #casa da #solo, "il #gatto di #famiglia, #PittySing", e lo "nasconde in un #cestino tra le sue #gambe". Durante il viaggio fa una mossa brusca e fa uscire Pitty Sing dal cestino: il gatto finisce sulle spalle del figlio che sta guidando, che si spaventa, e perde il controllo dell’auto...
"ESSERE, O NON ESSERE": LA VITA (LA MORTE) CONTRO LA MORTE (LA VITA). Ovviamente, siccome è impossibile trovare "un bravo uomo" (così come è altrettanto difficile trovare "una brava donna"), tutto finisce all’#inferno!?
UNA TRINITA’ PERICOLOSA. Dopo poco arrivano #tre #uomini armati: Il figlio cerca di spiegare la situazione in cui si trovano, la nonna fissa l’autista della loro macchina e, subito, lo riconosce avendolo visto in un articolo di giornale, è un evaso noto come #Misfit, e glielo dice davanti a tutti: "Sei tu il Misfit! Ti ho riconosciuto subito". Naturalmente, Misfit risponde: "Sarebbe stato meglio per te se non mi avessi riconosciuto affatto".
"LA FAMIGLIA CHE UCCIDE". La nonna, con la pistola puntata in faccia,non sa più che fare e cerca di trovare compassione e comprensione in Misfit:
- "Ma tu sei uno dei miei bambini. Sei uno dei miei figli! Allungò la mano e gli sfiorò la spalla... [lui] si ritrasse con un balzo come se fosse stato morso da un #serpente e le sparò tre colpi al petto.... Sarebbe stata anche una brava donna, disse, se solo qualcuno le avesse sparato ogni minuto della sua vita".
IL "DISAGIO DELLA CIVILTA’ " (S. FREUD, 1929) E IL "#TROPICALLY" DI "AMLETO", LA "TRAPPOLA PER TOPI". Quale il ruolo e il senso della presenza "nascosta" del gatto nella "macchina" e nel "viaggio" non solo di Flannery O’Connor e QUALE IL SIGNIFICATO (antropologico e teologico-politico) della #Mousetrap nell’#Hamlet di #Shakespeare)?
ARTE E ANTROPOLOGIA: IL "PRESEPE" E LA "MADONNA DELLA GATTA". Federico Barocci (Urbino 1528/1535 - 30 settembre 1612), "Visita di Sant’Elisabetta, con San Giovanni Battista e San Zaccaria, alla Madonna col Bambino e San Giuseppe, detta "Madonna della gatta".
NOTE:
- STORIA E LETTERATURA E FILOLOGIA: LA GATTA E IL SERPENTE. Nella tradizione dell’#immaginario biblico, il "diavolo" è il "serpente" e non il #gatto ( per Shakespeare, la "trappola per topi" di #Amleto e di #Ofelia rimanda ad altre coordinate, alla #vita e al #gattare, e non a quelle del Re-serpente Claudio, fondate caina-mente sul mentire, sull’ingannare, e sull’uccidere. Il problema di #Amleto e #Ofelia, come di #DanteAlighieri, è quello di uscire dall’orizzonte della "caduta" e della "tragedia" e ...scrivere una "felina" #commedia.
- STORIA E LETTERATURA E #CREATIVITA’: "LA FELINA COMMEDIA" ("LA FELINA COMMEDIA DI ELISA BINDA E MATTIA PEREGO ILLUSTRATO DA BEATRICE TINARELLI. PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE).
- A #CINEMA, UNA BELLA LEZIONE DI #ANTROPOLOGIACULTURALE. A #INSEGNARE SONO I #GATTI. Un modo di fare #cinema che è anche una #scuola inedita di #cultura filosofica, antropologica e psicologica.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- L’ANTROPOLOGIA DEI "DUE SOLI" E LA "PSICOANALISI": "COME NASCONO I BAMBINI". Appunti su "Analisi terminabile e interminabile" e "Costruzioni nell’analisi" di Freud..12 settembre 2024, di Federico La Sala
SHAKESPEARE, FREUD, E L’ANTROPOLOGIA DEI "DUE SOLI": LA FILOSOFIA DELLA "MENTE ACCOGLIENTE".
- In memoria di Elvio #Fachinelli (1928-1989).
ALLA RICERCA DEL "TEMPO PERDUTO": IMPARARE A INDOVINARE ("ERRATEN") E AVER IL #CORAGGIO DI ACCOGLIERE ("SÀPERE AUDE!") E "#SPOSARE" ("HEIRATEN") LA IPOTESI "COSTRUITA".
- Una nota a margine della recensione di R. Musella e M. Pappadella della nuova traduzione di “Costruzioni nell’analisi” di S. Freud (Jaca Book ed., 2024):
- "Per apprezzare la nuova traduzione del saggio di Freud (1937a), Costruzioni nell’analisi, ad opera di Francesco Barale e Ingrid Hennemann Barale, è opportuno partire da quella che riteniamo esserne la chiave interpretativa più originale proposta nel saggio introduttivo dello stesso Francesco Barale. Prima di dichiarare le nostre carte, però, dobbiamo fare una premessa che prende le mosse dal lontano 1895. Come è noto, Freud in una lettera a Fliess del 25 maggio 1895, indica tre verbi chiave, necessari per la comprensione della teoria del funzionamento psichico: phantasieren, übersetzen, erraten. Verbi che hanno conosciuto traduzioni diverse e che costituiscono il presupposto indispensabile per la comprensione di quello che l’anno successivo, il 13 febbraio 1896, sempre in una lettera a Fliess, viene denominato lavoro metapsicologico. La triade proposta inizialmente allo storico confidente berlinese, attraverserà tutta l’opera freudiana, fino alle ultime formulazioni contenute in Analisi terminabile e interminabile (Freud, 1937a), nel Compendio di psicoanalisi (Freud, 1938) e, appunto, come rileva Francesco Barale, in Costruzioni nell’analisi (Freud, 1937b).
 [...] La nozione di “costruzione” non è una novità: è un tema già ampiamente trattato da Freud, ma che in questo scritto viene ulteriormente elaborato. Per comprendere a fondo la portata di tale concetto nella sua estensione, è opportuno soffermarsi sul termine chiave che lo introduce: questo “indovinare” (erraten) che è nel cuore del “costruire”, tanto quasi da definirlo. Il termine erraten torna anche nel punto in cui Freud discute quali indizi possano far pensare che l’analista, con la sua costruzione, ci abbia o meno indovinato. [...]"( “Costruzioni nell’analisi” di S. Freud. Recensione di R. Musella e M. Pappa).
[...] La nozione di “costruzione” non è una novità: è un tema già ampiamente trattato da Freud, ma che in questo scritto viene ulteriormente elaborato. Per comprendere a fondo la portata di tale concetto nella sua estensione, è opportuno soffermarsi sul termine chiave che lo introduce: questo “indovinare” (erraten) che è nel cuore del “costruire”, tanto quasi da definirlo. Il termine erraten torna anche nel punto in cui Freud discute quali indizi possano far pensare che l’analista, con la sua costruzione, ci abbia o meno indovinato. [...]"( “Costruzioni nell’analisi” di S. Freud. Recensione di R. Musella e M. Pappa).
***
PSICOANALISI ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA #HAMLETICA: "CHI SONO IO?". Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo #Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The #Mousetrap") e di portarsi oltre il #giogo del "matriarcato" e del "patriarcato".!
"COME NASCONO I BAMBINI" (S. Freud, "Analisi terminabile e interminabile", 4). Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita è come quello di Shakespeare, contribuire a sciogliere il nodo di #Ercole, il nodo del nascere, del #comenasconoibambini, alla base della "nevrosi ossessiva", non solo del "caso" dell’uomo dei topi" (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di Danimarca".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- FILOLOGIA E ANDROCENTRISMO: LA SFINGE CHIESE AD EDIPO, "CHI SEI ?"; EDIPO "PLATONICAMENTE" RISPOSE: "L’#UOMO!".10 settembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFIA E ANDROCENTRISMO: "ECCE HOMO" (NIETZSCHE, 1888).
LA SFINGE CHIESE AD EDIPO, "CHI SEI ?"; EDIPO "PLATONICAMENTE" RISPOSE: "L’#UOMO!" [#ANTHROPOS].
- Un omaggio alla memoria di María Zambrano e al suo lavoro su "La tomba di #Antigone. #Diotima di Mantinea" [1967], La Tartaruga 1995).
STORIA #LETTERATURA E #STORIOGRAFIA. #PILATO INDICO’ #GESU’ ALLA #FOLLA E DISSE: "ECCE HOMO" ( «Ecco l’uomo», «ἰδοὺ ὁ #ἄνθρωπος»).
TEOLOGIA-POLITICA E #COSMOTEANDRIA. LA LEZIONE DI #PAOLODITARSO:
- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).
"PERSONA E DEMOCRAZIA. La storia sacrificale" (M. Zambrano, 1958): "María Zambrano non ha venduto l’anima all’Idea" (Emil M. Cioran, "Esercizi di ammirazione. Saggi e ritratti", Adelphi, 1988).
Sul tema, cfr. "Le parole di Antigone nella riscrittura novecentesca di María Zambrano" (di Camilla Tibaldo, Treccani, 13 gennaio 2020).
- NOTE:
- FILOSOFIA STORIOGRAFIA E ANTROPOLOGIA: DIOTIMA DI MANTINEA E SOCRATE. Una vecchia "foto" da "La mente accogliente", Antonio Pellicani editore, Roma 1991 (v. allegato).
- ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI. "Una tomba per Antigone. Clinica del delirio borderline" (di Pietro Barbetta, Orthotes Editrice 2024).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! L’ALGORITMO DELLA TRAGEDIA (SOCRATE-PLATONE-PAOLO DI TARSO-HEGEL) E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA POSTA DA KANT.9 settembre 2024, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
- SCUOLA E SOCIETA’. Una nota a margine di un nodo non sciolto della #storia delle #idee e dei #sogni... *
L’ALGORITMO DELLA TRAGEDIA (SOCRATE-PLATONE-PAOLO DI TARSO-HEGEL) E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA POSTA DA KANT ("LOGICA", 1800). L’autonomia dello apprendimento e l’#apprendimento dell’autonomia, concepito l’una e l’altro, secondo le indicazioni dell’#illuminismo kantiano (1784), a mio parere, riposa sul #coraggio ("aude") del servirsi della propria intelligenza, sulla propria #capacità e sulla propria #volontà di "mangiare" e "bere" ("#sàpere") da parte dell’alunno e dell’alunna, e non sulla #maieutica di un Socrate che gioca a "sapere di non sapere" con l’alunno-schiavo ("#Menone") a dargli lezioni sul "non sapere di sapere"!
COME NASCONO I BAMBINI (LE IDEE, E I SOGNI): "SAPERE AUDE!". Il "problema Socrate", posto da #Nietzsche e nonostante Nietzsche, è del tutto ignorato e la sollecitazione di Michel Foucault a ripensare il rapporto "illuminismo e critica" (1984) è ancora fuori dall’agenda dei lavori del mondo della "platonica" Accademia e dell’"aristotelico" Liceo: che il trecentesimo anniversario della nascita di Kant (1724-2024) possa essere una buona occasione per cominciare!
- NOTE:
- STORIA E #FILOSOFIA: "ILLUMINISMO E CRITICA" (di Michel Foucault).
- STORIA STORIOGRAFIA E SCUOLA: "INSEGNAMENTO E POTERE" ( di Alfonso Maurizio Iacono, "Doppiozero", #8settembre 2024).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- TEATRO (STORIA) METATEATRO (METASTORIA), E FILOLOGIA ("LOGOS"): SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’.6 settembre 2024, di Federico La Sala
TEATRO (STORIA) METATEATRO (METASTORIA), E FILOLOGIA ("LOGOS"):
SULLA "TERRA PROMESSA" ALL’INTERA UMANITA’ ("EARTHRISE").
- ALCUNI APPUNTI a margine della domanda di Paul Adrian Fried, "How is Hamlet received or avoided in Israel?" - September 05, 2024.
RICORDANDO una riflessione del filosofo Emil L. #Fackenheim sul fatto che la "visione" di Theodor Herzel "non fu abbastanza visionaria: la vecchia lingua che egli considerava morta è rinata" (Emil L. Fackenheim, "Tiqqun. Riparare il mondo", Edizioni Medusa, Milano 2010), ed è rinata grazie al lavoro di Eliezer Ben-Yehuda, FORSE, è bene ricordare anche cosa proprio Ben Yeheuda, il "padre" dell’ebraico moderno) scriveva in una sua "Memoria": “[...] Tante parole nuove dovranno essere inventate, e quando l’Ebraico non basterà, la lingua araba, sorella della nostra, ci fornirà i suoi suggerimenti. Che cos’è infatti un amico, se non quello che ti offre la parola mancante?” (cfr. Massimo Leone, "Alla lingua ebraica. Memoria di Eliezer Ben-Yehuda", 2003).
Plaudendo ("cum grano salis") alla "analogia" storica tra Israele e Palestina con la situazione hamletica dello "stato di Danimarca" e lo "stato di Norvegia", dopo la morte del "Re Amleto", proposta da Paul Adrian Fried, c’è da chiedersi, in riferimento al "presente storico" dell’attuale rapporto tra la "terra" di Israele e la "terra" della Palestina: ma "Hamlet", la "figura" di "Amleto", capace di ricordare la promessa fatta da suo padre "("Ricordati di me!"), riflettere sul da farsi, di mantenere la parola data, e di decidersi a fermare il "gioco", dov’è?!
METASTORICA-MENTE, IERI COME OGGI, IL PROBLEMA E’ UNA #QUESTION LOCALE E GLOBALE DI LUNGA DURATA, TEOLOGICO-POLITICA E ANTROPOLOGICA: UNO=ONU. Bisogna uscire dal "letargo" (#DanteAlighieri) e, hamleticamente, rompere l’ipnosi "millenaria" indotta dalla musica del Re-Pifferaio e restituire alla "parola" il suo legame il "Logos", con la "lingua", la "terra" #comune.
ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA) E "DIVINA COMMEDIA". DA NON DIMENTICARE, a mio parere, che il nodo da sciogliere proposto da Shakespeare, alla intera cultura teologico-politica dell’Europa dell’epoca (egemonizzata dalla tradizione cattolico-spagnola) è legato al doppio filo del problema del "corpo mistico" del Re (#androcentrismo) e della struttura della "Sacra Famiglia": ad Amleto ("Cristo") il "presepe" messo su dallo "zio" - "re" (e dalla madre-regina) non può assolutamente piacere (egli è già "sacrificato" a morte, in partenza) ed è un #presepe che non ha alcuna consonanza né con quello di Francesco di Assisi" né di Dante Alighieri, né di Michelangelo, e nemmeno quello "sognato" da Kafka ("[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" ).
- Nota:
- ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E STORIA: PALESTINA, ISRAELE, E LA LINGUA EBRAICA.
 Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.
Cfr. Gaston Zananiri, "Ben Yehouda" "SENS", I-1978.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- STORIA E FILOLOGIA:COME IL PRINCIPIO ANTROPOLOGICO E’ STATO DECLINATO DALL’ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO, NEI SECOLI DEI SECOLI5 settembre 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA E COSMOTEANDRIA:
TRACCIA PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA (KANT, 1724- 2024).
STORIA DELLA #CIVILTA’ E #FILOLOGIA: COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO (TEOLOGICO E COSMOLOGICO) E’ STATO DECLINATO DALL’ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE PRINCIPIO "ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato).
- The Stages of Man (1510), by Charles de Bouelles (c. 1470-1553):
- "This diagram illustrates as well as any a humanist conception of human virtues. It establishes a series of parallels between incremental states of being in nature, with its correponding verb, and their counterpart in the human condition. Thus simply exist (Est), like a stone, is to be like a sluggard; to merely live (Vivit), like a plant, corresponds to a life of gluttony; to merely feel (Sensit), as a horse can, is to be nothing more than a vain person (Sensualis), to live by the dictates of Luxuria; but to understand (Intellegit), is a human does or ought to, is live as a scholar. The summit of human possibility, in short, is to live the life of the mind. This was the framework for Bouelles study of the human condition, Liber de sapiente, published in 1510."".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- ANATOMIA E ARTE: "SAPERE AUDE!". UNA "RIVOLUZIONE COPERNICANA" IN MEDICINA: MICHELANGELO, REALDO COLOMBO, E JUAN AMUSCO DE vALVERDE.29 agosto 2024, di Federico La Sala
MICHELANGELO, I PROFETI, LE SIBILLE, E LE "STREGHE" DI BENEVENTO: CONTRORIFORMA E CONTRORINASCIMENTO.
- UNA IPOTESI DI "LETTURA" DELLA FIGURA DI SAN #BARTOLOMEO, NEL "GIUDIZIO UNIVERSALE" DELLA "#CAPPELLASISTINA".
ANTROPOLOGIA CULTURALE #ARTE E #STORIA. A lume di #antropologia storica e "#immaginazione sociologica", si può ben pensare che Michelangelo (associandosi al santo patrono di Benevento, all’apostolo Bartolomeo, con la "#sindone" del suo "#autoritratto": ), nel #GiudizioUniversale, protestava "cristianamente", contro la #gerarchia di un #cattolicesimo istituzionalizzato (assetato di potere, all’ombra e al servizio del dio "#Mammona", incapace di accogliere le sollecitazioni della #Riforma Luterana e Anglicana), che aveva rifiutato la proposta di far camminare insieme profeti e sibille, come da chiara indicazione ecumenica e "francescana, nella "Volta" della #CappellaSistina e nel "#presepe" del #TondoDoni) e contro l’equiparazione di #janare e #sibille (come da tradizione "cattolica", delle "streghe", che si riunivano presso l’antico albero di "noce di benevento", per il famoso "concerto" sabbatico.
- NOTE:
- STORIA E STORIOGRAFIA: ROMEO DE MAIO, "#MICHELANGELO E LA #CONTRORIFORMA (Editori Laterza, 1978)
- RIVOLUZIONESCIENTIFICA, MEDICINA, E ARTE: #GIOVANNIVALVERDE. L’omaggio del medico Juan Amusco de Valverde, IN UNA TAVOLA del suo manuale di "ANATOMIA DEL CORPO UMANO" (1560), A "MICHELANGELO - BARTOLOMEO):
 MICHELANGELO COME VALVERDE ERANO ALLIEVI E COLLABORATORI DEL MEDICO, ANATOMISTA E SCIENZIATO, REALDO COLOMBO.
MICHELANGELO COME VALVERDE ERANO ALLIEVI E COLLABORATORI DEL MEDICO, ANATOMISTA E SCIENZIATO, REALDO COLOMBO.
- ANTROPOLOGIA, MEDICINA, E RICERCA SCIENTIFICA: I "TESTICOLI" DELLE #DONNA E LA "COGLIONERIA" DELL’#UOMO, OVVERO ANCHE LE #DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione (v. allegato) di #GiovanniValverde, "#Anatomia" (Roma, 1560).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "SAPERE AUDE!" (KANT, 1724-2024): "IL FEMMINILE E L’UOMO GRECO". Un omaggio e una nota a margine del lavoro di Nicole Loraux (1943-2003).12 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, MITO, STORIA, E LETTERATURA:
"IL FEMMINILE E L’UOMO GRECO" (NICOLE LORAUX). Un omaggio e una nota a margine del lavoro di Nicole Loraux (1943-2003).
- A memoria di William Shakespeare, a Immanuel Kant, a Sigmund Freud, a Franca Ongaro Basaglia, e a Gianni Vattimo...
"SAPERE AUDE!" (KANT, 1724-2024). MUOVENDO dal lavoro della brillantissima Nicole Loraux ("Il femminile e l’uomo greco", Laterza 1991, e, Mimesis Edizioni 2024) e, in particolare, dalla sua indicazione, legata alla figura di Tiresia, che «l’uomo non è mai tanto uomo come quando ha qualcosa della donna dentro di sé», forse, è possibile orientarsi meglio sia sui temi fondamentali della sua ricerca storico-antropologica sia del problema del "chi siamo noi, in realtà" (Nietzsche).
COME IN CIELO ("URANO") COSI’ IN TERRA ("GAIA"): MITO E TRAGEDIA (EDIPO). Riconsiderando, il legame tragico (edipico) codificato giuridicamente e teologicamente già nel (prei)storico "compromesso celeste", a partire dal salvataggio e dalla messa in sicurezza da parte della #Madre-#Regina - #Rea, di "#Zeus", del #Figlio, dalle fauci dello Sposo, il Padre-Re #Crono e, poi, nel "compromesso olimpico", dal "matrimonio" tra il "Padre -Re" (Zeus) e la "Madre -Regina" (#Era), rileggere #Amleto (Shakespeare) e riprendere a tutti i livelli la sollecitazione di #Freud (con le "parole" di Era, relative all’Acheronta movebo, citate all’inizio della "Interpretazione dei sogni", bene in mente) di pensare "l’edipo completo", rianalizzare il suo lavoro relativo a "L’uomo dei topi" (e fare attenzione alle sue riflessioni sul "#matriarcato" e sul "#patriarcato") e capire cosa significa la "trappola per topi" ("The Mousetrap") di Amleto ed Ofelia per il "Padre-Re" e la "Madre-Regina" (Shakespeare). Forse, solo così, è possibile ricominciare a pensare sul #comenasconoibambini e a un’altra "Storia universale della natura e teoria del cielo" (Immanuel Kant, 1755).
NOTE:
- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1800): "IL SOGGETTO E LA MASCHERA. NIETZSCHE E IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE" (GIANNI #VATTIMO, 1974).
- FILOLOGIA CRITICA E "NASCITA DELLA TRAGEDIA": SHAKESPEARE E UNA "CITAZIONE" EVANGELICA. PER AMLETO ("CRISTO"), LA "CASA DEL PADRE" CON LE SUE "MOLTE DIMORE" (Gv. 14, 2) E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (UNA PRIGIONE):
- Hamlet: Denmark’s a prison.
 Rosencrantz: Then is the world one.
Rosencrantz: Then is the world one.
 Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." ("Hamlet", II. 2. 242-245).
Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." ("Hamlet", II. 2. 242-245).
- FREUD CON SHAKESPEARE, ALLA RICERCA DELLA VIA OLTRE IL "MATRIARCATO" E IL "PATRIARCATO". Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo #Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The Mousetrap").
 Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita, come quello di Shakespeare, è stato quello di contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo del#nascere, del #comenasconoibambini, alla base della #nevrosi #ossessiva, non solo del "caso" dell’uomo dei #topi (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di #Danimarca".
Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita, come quello di Shakespeare, è stato quello di contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo del#nascere, del #comenasconoibambini, alla base della #nevrosi #ossessiva, non solo del "caso" dell’uomo dei #topi (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di #Danimarca".
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), ARTE, TEATRO, E PSICOANALISI: "IL TRITTICO DI MERODE", IL "TONDO DONI", E "AMLETO".8 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA) E ARTE: UNA NOTA DI ANTROPOGENESI CHIASMATICA (NEXOLOGIA) E DI STORICHE COSTRUZIONI NELL’ ANALISI (S. FREUD, 1937).
I VEGGENTI E L’ IPOTESI DELLA NASCITA DELL’ESSERE UMANO (E DELLA SUA COSCIENZA) DI MICHELANGELO BUONARROTI.
- A IMMANUEL KANT (1724-1804), IN MEMORIA
IL "MESSAGGIO" DEI SETTE PROFETI E DELLE CINQUE SIBILLE NELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA E DEI "DUE PROFETI" E DELLE "DUE SIBILLE" DELLA SACRA FAMIGLIA DEL "TONDO DONI".
- TEATRO E METATEATRO: LA LEZIONE EVANGELICA DI SHAKESPEARE. IL "RICORDO" DI AMLETO ("REMENBER ME", I.5.91) E LA SUA "ANIMA PROFETICA" ("O MY PROPHETIC SOUL! [...]"). IL "CAMMINO" DELLE #SIBILLE E DEI #PROFETI DI MICHELANGELO (FIN NELLA #CAPPELLA SISTINA) E LA #DOMANDA DI #AMLETO (Che cos’è / Un uomo": IV. 4. 33), PER PORTARSI CON DANTE ALIGHIERI OLTRE L’ORIZZONTE DELLA "CADUTA" E DELLA "TRAGEDIA".
- ARTE TEATRO PSICOANALISI E FEDE: "IN PRINCIPIO ERA L’ AMORE" (JULIA KRISTEVA, 1987). L’#ANNUNCIAZIONE (E L’#INCARNAZIONE) NEL "TRITTICO DI MERODE" (1425) DI ROBERTCAMPIN E "THE MOUSETRAP" NELL’ HAMLET (III. 2. 247) DI SHAKESPEARE. UNA SOLLECITAZIONE A "RIPROBLEMATIZZARE" IL SIGNIFICATO DELLA "TRAPPOLA PER TOPI", NEL SUO CONTESTO (AMLETO CON LA TESTA IN GREMBO ALLA SUA PROMESSA SPOSA, OFELIA), A GUARDARE LO SPETTACOLO SULL’ "ASSASSINIO DI GONZAGO" (NEL TENTATIVO DI SMASCHERARE IL FALSO "RE-PADRE", LO ZIO ("MY UNCLE?") "SERPENTE".
- USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA: PENSARE L’EDIPO COMPLETO (S. FREUD). Tra i moltissimi contributi di Julia Kristeva, uno dei più importanti sul tema, oltre "Teresa, mon amour" dedicato a Teresa d’Avila, c’ è anche «#MelanieKlein. La madre, la follia» (tit. orig.: «Il genio femminile. La follia. Melanie Klein, o del matricidio come dolore e come creatività»). Per andare oltre la antica "alleanza" cosmoteandrica (platonico-apollinea-paolina-costantiniana) di Madre (Gea)-Figlio (Zeus), e, al contempo, uscire dall’orizzonte "infernale" della "caduta" (Dante Alighieri), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) prendere le distanze non solo dal "padre" ( il "parricidio") ma anche dalla "madre" (il "matricidio"). A suo tempo, già Shakespeare aveva mostrato (ben prima di Manzoni e dello stesso Freud) tutte le difficoltà dei "promessi sposi", Amleto e Ofelia, per capire che cosa significa la "trappola per topi" ("The Mousetrap") e cercare di portarsi fuori dalla realtà adulterina e delittuosa della tragica "famiglia che uccide" dello "stato di Danimarca".
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- GEOLOGIA, FILOSOFIA (#KANT2024), E FILOLOGIA (#PARIS2024): LA FOSSA DELLE MARIANNE E LA TORRE DI BABELE, UN "BINOMIO FANTASTICO" (GIANNI RODARI)4 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, GEOLOGIA, FILOSOFIA (#KANT2024), E FILOLOGIA (#PARIS2024):
LA FOSSA DELLE MARIANNE E LA TORRE DI BABELE, UN "BINOMIO FANTASTICO" (GIANNI RODARI).
DUE #SEGNAVIA (COME "DUE SOLI") PER RI-COMINCIARE A RI-PENSARE DA #CAPO E A RI-ESPLORARE "L’#UOMO", IL "#MONDO", E "#DIO".
 >"SÀPERE AUDE" (Orazio). Un omaggio alla #memoria di Immanuel Kant (1724 - 2024)
>"SÀPERE AUDE" (Orazio). Un omaggio alla #memoria di Immanuel Kant (1724 - 2024)A). LA FOSSA DELLE MARIANNE. "La fossa delle Marianne è la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo, localizzata nella zona nord-occidentale dell’Oceano Pacifico a est delle isole Marianne, a 11° 21’ nord di latitudine e 142° 12’ est di longitudine, tra Giappone a nord, Filippine a ovest e Nuova Guinea a sud; il suo punto più profondo, l’abisso Challenger, si trova a 10.994 m sotto il livello del mare. [...]".
B). LA TORRE DI BABELE. "La Torre di Babele: Babilonia tra realtà e mito: [...] La costruzione della Torre di Babele, insieme ai noti e suggestivi riferimenti biblici, ha affascinato l’umanità fin dall’Antichità, essendo divenuta il monumento per eccellenza della città di Babilonia ed espressione del culto del dio Marduk. Il mito della torre di Babele e della sua costruzione, così come è raccontato nel testo biblico, è il soggetto di molte rappresentazioni nel Medioevo, nel Rinascimento, in età moderna ed anche contemporanea e Babilonia e la sua torre sono state spesso considerate un simbolo del mondo antico babilonese. [...]" (Treccani).
NOTE:
- ARTE, MITO, STORIA. La "Torre di Babele" di Pieter Bruegel il Vecchio.
- ANTROPOLOGIA, STORIA E LETTERATURA, E "GRAMMATICA DELLA FANTASIA" (GIANNI RODARI): RIPARTIRE DA "#ADAMO" ED "#EVA" ED USCIRE DALLA #CAVERNA, DALL’#ORIZZONTE BIBLICO DELLA "#CADUTA" E DEL "COMPROMESSO #OLIMPICO" DELLA #TRAGEDIA, SULLE ALI DELL’#AMORE (#CHARITAS) CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE (DANTE ALIGHIERI, "PARADISO", XXXIII, 145).
- ANTROPOLOGIA, #STORIAELETTERATURA E #PEDAGOGIA "PAOLINA" PER L’AZIONE PASTORALE NELLA #CHIESA "CATTOLICA" (#NICEA,325-2025). "Lettera del Santo Padre Francesco sul ruolo della letteratura nella formazione", 04.08.2024: "1. Inizialmente avevo scritto un titolo riferito alla formazione sacerdotale, ma poi ho pensato che, analogamente, queste cose si possono dire circa la formazione di tutti gli agenti pastorali, come pure di qualsiasi cristiano. Mi riferisco al valore della lettura di romanzi e poesie nel cammino di maturazione personale. [...] 43. La potenza spirituale della letteratura richiama, da ultimo, il compito primario affidato da Dio all’#uomo: il compito di “nominare” gli esseri e le cose (cfr.Gn2, 19-20). La missione di #custode del creato, assegnata da Dio ad #Adamo, passa innanzitutto proprio dalla riconoscenza della realtà propria e del senso che ha l’esistenza degli altri esseri. Il #sacerdote è anche investito di questo compito originario di “nominare”, di dare senso, di farsi strumento di comunione tra il creato e la Parola fatta carne e della sua potenza di illuminazione di ogni aspetto della condizione umana. [...]" (Lettera, cit.).
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- SHAKESPEARE E LA DEMISTIFICAZIONE E LA DEMITIZZAZIONE DEL "PRESEPE" DELLO "STATO DI DANIMARCA".24 luglio 2024, di Federico La Sala
TEATRO METATEATRO E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD, 1937):
"IL VANGELO DI AMLETO".
- Una nota in omaggio al lavoro "archeologico" in progress di Paul Adrian Fried (cfr. "Part 55: Ophelia’s Overlapping Biblical allusions and plot echoes" - July 23, 2024) *
AMLETO ("HAMLET") E LA DEMISTIFICAZIONE E LA DEMITIZZAZIONE DEL "#PRESEPE" DELLO "#STATO DI #DANIMARCA". Guardando con gli occhi di #Shakespeare, e di #Elisabetta d’#Inghilterra (dopo il 1588), lo "splendore" delle figure di #TommasoMoro e di #Erasmo da Rotterdam ormai è alquanto oscurato, data la loro "#amicizia" con la visione teologico-politica platonica ("cosmo-te-andrica" e "#golem-antica") della Chiesa cattolico e del Papato dell’epoca, CHIARISSIMO Paul Adrian Fried, a mio parere, il filo del suo lavoro di ricerca, nel rendere sempre più esplicita l’#analogia tra #Amleto e #Gesù, sollecita a guardare a #Ofelia... come a Maria Maddalena, la #donna della tradizione evangelica, legata strettamente alla #vita stessa di Gesù (uno scrittore nato nel mio paese di origine, nel 1564, di nome Paolo Silvio, scrive nel 1599, in coincidenza con un miracolo avvenuto a #Fabriano, un’opera di grandissimo successo dal titola "La Maddalena penitente"). RICORDANDO IL #MATRIMONIO DEL "PAPA DI WITTENBERG", #LUTERO CON #KATHARINAVONBORA, E, DEL RE-PAPA D’INGHILTERRA E DELLA SUA "CHIESA", #ENRICOVIII E ANNA BOLENA, C’E’ DA PENSARE CHE CIO’ A CUI GUARDA SHAKESPEARE E’ LA #CRITICA (#KANT, 1724-2024) "COSTRUZIONE" DI UNA #IDEA TEOLOGICO-POLITICA DI "#CORPOMISTICO" AL DI LA’ DELLA TRAGEDIA (#DANTEALIGHIERI), ANTROPOLOGICAMENTE (E NON EDIPICAMENTE) FONDATA, E, PER UNA ALTRA "DANIMARCA", RESTITUIRE LA SOVRANITA’ A "FORTEBRACCIO"!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E BIOGRAFIA: UNA NOTA SULL’ANALISI DI FREUD DEL RICORDO D’INFANZIA DI LEONARDO DA VINCI (E DEL SUO "UOMO VITRUVIANO").20 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (KANT, 1724-2024), PSICOANALISI E BIOGRAFIA: "ECCE HOMO" (NIETZSCHE, 1888).
"INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (1899) E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (1937):
LEONARDO DA VINCI SUL LETTINO DI FREUD (MA NON DI JUNG NE’ DI LACAN).
- Una nota di commento in omaggio alla sollecitazione di Gianfranco Ricci a riflettere e a discutere sulla "interpretazione" che Sigmund Freud dà di "un ricordo di infanzia di Leonardo" (1910):
- "LEONARDO SUL LETTINO DI FREUD [...] La vita di Leonardo è carica di misteri e di passaggi oscuri: tra gli aspetti che suscitano più interrogativi, abbiamo la vita amorosa di Leonardo e il suo controverso rapporto con la religione.
 In una lettera a Jung del 17 ottobre 1909, al rientro dagli Stati Uniti, Freud scrive di come il carattere di Leonardo “è divenuto improvvisamente trasparente”.
In una lettera a Jung del 17 ottobre 1909, al rientro dagli Stati Uniti, Freud scrive di come il carattere di Leonardo “è divenuto improvvisamente trasparente”.
 Poco dopo, nel 1910, Freud pubblicherà il saggio “Un ricordo di infanzia di Leonardo”. [...]
Poco dopo, nel 1910, Freud pubblicherà il saggio “Un ricordo di infanzia di Leonardo”. [...]
 Freud ricostruisce la storia di Leonardo, sottolineando la centralità del rapporto coi genitori.
Freud ricostruisce la storia di Leonardo, sottolineando la centralità del rapporto coi genitori.
 Il padre di Leonardo è stato spesso assente e lontano; questa esperienza avrebbe segnato il rapporto di Leonardo con le sue opere: proprio come il padre, dopo avere cominciato un’opera, Leonardo era solito abbandonarla per dedicarsi ad altro, iniziando altri progetti. Molte delle opere di Leonardo sono infatti rimaste incompiute, oppure sono stati necessari lunghi anni per completarle.
Il padre di Leonardo è stato spesso assente e lontano; questa esperienza avrebbe segnato il rapporto di Leonardo con le sue opere: proprio come il padre, dopo avere cominciato un’opera, Leonardo era solito abbandonarla per dedicarsi ad altro, iniziando altri progetti. Molte delle opere di Leonardo sono infatti rimaste incompiute, oppure sono stati necessari lunghi anni per completarle.
 Nella vita di Leonardo è stata centrale la madre, Caterina. [...].
Nella vita di Leonardo è stata centrale la madre, Caterina. [...].
 In ogni volto femminile, Leonardo avrebbe ricercato il sorriso della madre. [...].
Freud conclude: “forse Leonardo ha superato con la forza dell’arte l’infelicità della sua vita amorosa, creando queste figure in cui la beata fusione della natura maschile con quella femminile rappresenta l’appagamento dei desideri del fanciullo infatuato della propria madre”
(cit.).
In ogni volto femminile, Leonardo avrebbe ricercato il sorriso della madre. [...].
Freud conclude: “forse Leonardo ha superato con la forza dell’arte l’infelicità della sua vita amorosa, creando queste figure in cui la beata fusione della natura maschile con quella femminile rappresenta l’appagamento dei desideri del fanciullo infatuato della propria madre”
(cit.).
VITA E FILOSOFIA E ILLUMINISMO KANTIANO: "SAPEREAUDE" (Kant, 1784). Freud aveva capito l’essenziale (di sua madre e) della madre di Leonardo da #Vinci, aveva colto il "nucleo di fuoco" (dell’alleanza di fuoco, alla base della sua vita): che la madre era una donna autonoma e indipendente (una "Madonna", non una Signora "Costantiniana", nata dalla costola dell’Adamo "mammonico"), così come di Michelangelo ha intuito il messaggio del "Tondo Doni" e del "Mosè", di essere figlio dell’amore di "Maria e Giuseppe", di diritto e di fatto (Immanuel Kant): in principio era il Logos, non un Logo di un frainteso (antropologicamente) Uomo ("Vir") Supremo "Vitruviano".
NOTA:
- STORIA #ARTE #TEATRO E #FILOSOFIA:
- A #LEONARDO, COME A #MICHELANGELO, COSI’ AD #AMLETO, IL "#QUADRO ANTROPOLOGICO" DEL "#PRESEPE" NELLO "STATO DI DANIMARCA" DA’ DA PENSARE.
- DOPO LA #RIFORMAPROTESTANTE (1517) E DOPO LA #RIFORMA_ANGLICANA (1534) E DOPO IL #CONCILIODITRENTO (1545-1563), A #SHAKESPEARE , IL "PRESEPE" DELL’#EUROPA DEL SEICENTO, SEGNATA DALL’EGEMONIA CATTOLICO-SPAGNOLA, NON PIACE AFFATTO ("O my prophetic soul! My uncle?": #Hamlet, I.5), COSI’ COME A #EDUARDO DE FILIPPO, CON "#NATALE IN #CASA CUPIELLO (1931), IL "#PRESEPIO" NON PIACE PROPRIO.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- LINGUISTICA E PSICOANALISI: UN OMAGGIO A MARIE BONAPARTE. "La grande domanda, alla quale nemmeno io ho saputo rispondere, è questa: che cosa vuole la donna?” (Freud 1933).5 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFIA, PSICOANALISI, E CIVILTA’ (KANT 2024): CRITICA DELLA COSMOTEANDRIA OCCIDENTALE.
RIATTIVARE IL "CIRCUITO DELLA PAROLE". Oltre il lacanismo (e il paolinismo), l’omaggio di Sigmund Freud a Marie Bonaparte:
 "La grande domanda, alla quale nemmeno io ho saputo rispondere, è questa: che cosa vuole la donna?” (Freud 1933). *
"La grande domanda, alla quale nemmeno io ho saputo rispondere, è questa: che cosa vuole la donna?” (Freud 1933). *- Una nota in memoria di Ferdinad de Saussure e a Sigmund Freud, e a Marie Bonaparte*
PIANETA TERRA: ALLA LUCE DEL "CANTICO DEI CANTICI" (è "l’amor che move il sole e le altre stelle"), DOPO MILLENNI DI COLONIZZAZIONE DEL " LOGOS" (DIVENTATO UN "#LOGO"), e, dopo aver gettato in pasto all’algoritmo la "lingua" ("#langue" ) del "Corso di linguistica generale" di Ferdinand de #Saussure, forse, è ora di ri-attivare antropologicamente il "circuito della #parole", e, al contempo, fare chiarezza sulle #ideologie falloforiche nelle loro tragiche pretese androcentriche e platonizzanti e passare alla "commedia" (#DanteAlighieri): almeno dai lavori di #Michelangelo Buonarroti, per riflettere teologicamente sul tema, le Sibille camminano insieme ai #Profeti nella Volta della #CappellaSistina e l’ amore di ogni "Maria" e ogni "Giuseppe" cerca di illuminare non solo il cammino di ogni loro bambino e di ogni loro bambina ("Gesù"), ma anche le loro stesse comunicazioni e le loro stesse relazioni tra di loro e con tutti gli esseri umani (e non solo).
Note:
- Célia Bertin, "Marie Bonaparte. La principessa della psicoanalisi", Introduzione di CesareMusatti, OL - Odoya Library, 2023. Cesare Musatti, con Ernst Jones, nel 1957, incontrò Marie Bonaparte a Parigi e ne ebbe una viva immagine di persona "con libertà di spirito e modernità di vedute".
- Giuliana Proietti, "Marie Bonaparte e lo studio dell’anorgasmia" ("Psicolinea" 30 Marzo 2024).
- Marie Bonaparte, Sigmund Freud,"Correspondance intégrale.1925-1939", Édition de: Rémy Amouroux,Traduction (Allemand): Olivier Mannoni, Flammarion 2022.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E TEATRO. UNA "CITAZIONE" DI SHAKESPEARE: IL PRINCIPE "AMLETO" , LA CASA DEL PADRE - RE, DIVENTATA UNA PRIGIONE, E IL TEMPO FUORI DAI CARDINI.2 luglio 2024, di Federico La Sala
TEATRO E METATEATRO: "REMEMBER ME" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5). MEMORIA STORIA LETTERATURA E FILOLOGIA (2 LUGLIO 2024).
- RI-BILANCIA-RE IL "MONDO": "THE TIME IS OUT OF JOINT" ("IL #TEMPO E’ FUORI DAI CARDINI": (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.5).
PER AMLETO, LA "CASA DEL PADRE" (IL "RE DEL MONDO", L’ AMORE) CON LE SUE "MOLTE DIMORE" (Gv. 14, 2) E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (PRIGIONE):
- "Hamlet: Denmark’s a prison.
 Rosencrantz: Then is the world one.
Rosencrantz: Then is the world one.
 Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).
Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." (II. 2. 242-245).
PSICOANALISI E STORIOGRAFIA. COME IL #LOGOS DEL PRINCIPIO (#ARCHE’) DI #ERACLITO DI EFESO E DELL’APOSTOLO GIOVANNI (Gv. 1.1) DIVENNE UN #LOGO E LE ENCLOSURES (RECINZIONI) SI DIFFUSERO SU TUTTA LA TERRA:
Sigmund Freud, che ha scavato a lungo, e continuò a scavare nei sotterranei della cultura greca, ebraica, e cattolico-romana fino alla morte (Londra, 1939), e conosceva molto bene non solo la "tragedia" di "Edipo Re" (Sofocle), ma anche del principe "Amleto" (Shakespeare), nel 1929, così scrive: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’#amore #universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).
ARTE E TEOLOGIA. Alla luce del sempre più "brillante" presente storico, forse, è bene tenere conto dell’analisi di Freud, rimeditare sulla hamlet-ica "Mousetrap" (III.2) di Shakespeare, e, al contempo, riflettere sulla enigmatica figura del futuro #padre di Gesù, #Giuseppe ("De domo David"), che prepara una "trappola per #topi" nello straordinario "Trittico di Mérode", dedicato al tema dell’#Annunciazione, di Robert Campin.
Nota:
- ANTROPOLOGIA E #COSMOTEANDRIA: L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO:
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CON FREUD E BACHOFEN, OLTRE L’ANDROCENTRISMO "RINASCIMENTALE".23 giugno 2024, di Federico La Sala
STORIA DELL’ARTE, DELLA RELIGIONE, DELLA FILOSOFIA:
FEDE E PROPAGANDA DELL’ANDROCENTRISMO RINASCIMENTALE (PLATONICO-PAOLINO).
- UNA TRAGEDIA DI LUNGA DURATA. Una nota a margine di cinquecento anni di vita europea, all’ombra della #dottaignoranza e della boria delle nazioni...
"DE HOMINIS DIGNITATE" (PICO DELLA MIRANDOLA, 1496). Se la cultura europea (laica e religiosa) continua, ieri come oggi, a orientarsi nel pensiero e nella realtà, secondo l’instaurazione teologico-politica "olimpica" (al seguito di #Apollo e di #Atena), «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi"), e a celebrare acriticamente la tradizione filosofica della "Scuola di Atene" (Raffaello Sanzio, 1509-1511) e la "mappa mentale" del "De Sapiente" (1510) di Charles de Bovelles - Bovillus, come è possibile uscire dall’orizzonte "edipico" della tragedia e, con la sollecitazione e la guida dell’eretico #DanteAlighieri, uscire dallo storico inferno (antropologico ed epistemologico, teologico e politico) "dell’autunno del medioevo" e dell’ uomo del rinascimento?!
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI, E DIRITTO (COSTITUZIONE). Se è vero, come riconosce Sigmund Freud nel 1909 (nell’affrontare il caso dell’«uomo dei topi»), che "un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal #matriarcato al #patriarcato", è altrettanto vero, come aveva già pensato e anticipato Bachofen nel 1861 (nell’anno stesso della Proclamazione del Regno d’Italia e del primo anniversario dell’Unità d’Italia, come da sottolineatura di Eva Cantarella), che, "[...] svincolandosi da ogni zavorra o mistura materiale, il diritto diventa #amore. Proprio l’amore è il diritto supremo, la legge più alta" (J. J. Bachofen, "Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici").
Note:
- ANTROPOLOGIA CULTURALE E STORIA: BACHOFEN E "IL MATRIARCATO".
- ANTROPOLOGIA E CIVILTA’: ANATOMIA E COSTITUZIONE DELL’UOMO E DELLA DONNA. RIPRENDERE IL FILO DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN #MEDICINA E ACCOGLIERE L’AMMISSIONE DI GIOVANNI AMUSCO DE VALVERDE (1560):
"Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap. 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E STORIA: CON SHAKESPEARE E FREUD, OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO.17 giugno 2024, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) ED ENIGMA DELLA SFINGE (EGITTO E GRECIA):
CON SHAKESPEARE E FREUD, OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO.
- Una nota a margine dell’#Amleto e dell’#Uomo dei #topi ...
La #question di Amleto (#Hamlet) è "BIBLICA" E "COSMICA". Si tratta di uscire dalla "preistoria" (#Marx), e di andare oltre la grande instaurazione di Zeus/Apollo/Atena, accettata e sopportata per compromesso "storico-olimpico" da Era/Giunone (Freud pone #Giunone nella "testa" della sua "Interpretazione dei sogni" (1899).
"The #Mousetrap", teatro nel teatro del mondo planetario terrestre, è per fare affiorare alla coscienza (quanto ha già capito Francesco d’Assisi e Dante Alighieri) e andare oltre "#Adamo ed #Eva": #Amleto ("Gesù") è Figlio del Re Amleto ("#Giuseppe") e della Regina Gertrude ("#Maria").
Ciò che dice Freud, in una nota del testo di "L’uomo dei #topi" [*] richiama un problema all’ordine del giorno dell’umanità: comporre in spirito di giustizia e amore la guerra tra #matriacato e #patriarcato, e, riprendere il cammino con tutte le "#sibille" e con tutti i "#profeti" (come da indicazione già di Michelangelo Buonarroti).
- [*] Lichtenberg (1742-1799) "osserva: «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre». Un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal matriarcato al patriarcato. Le figure preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di un’altra più grande rappresentano appunto la discendenza dal padre, Atena senza madre scaturisce dal capo di Giove. Ancor oggi, in tedesco, il testimone che attesta qualcosa davanti a una corte giudicante si chiama #Zeuge [«testimone», letteralmente «generatore»], per la parte che ha il maschio nell’atto di procreazione; già nei geroglifici troviamo rappresentato il testimone con l’immagine dei genitali maschili." (cfr. S. Freud, "Racconti analitici", a cura di Mario Lavagetto, Einaudi 2011).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA QUESTIONE DI PATERNITA’ (COSMOLOGICA): LA "TRAPPOLA PER TOPI" DI "AMLETO" E LA LUNGA RICERCA DEL PADRE DA PARTE DI FREUD.16 giugno 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E DISAGIO DELLA CIVILTA’: COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! *
 Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).
Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).- Un omaggio alla memoria di Mario #Lavagetto.
FREUD (CON SHAKESPEARE), A LONDRA. Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di #Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The #Mousetrap"). Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita è come quello di Shakespeare, contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo della nevrosi ossessiva non solo del caso dell’#uomo dei #topi" (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà" e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di Danimarca":
RIVOLUZIONECOPERNICANA (KANT2024). Sigmund Freud: "Lichtenberg [1742-1799] osserva: «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre». Un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal matriarcato al patriarcato. Le figure preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di un’altra più grande rappresentano appunto la discendenza dal padre, Atena senza madre scaturisce dal capo di Giove. Ancor oggi, in tedesco, il testimone che attesta qualcosa davanti a una corte giudicante si chiama #Zeuge [«testimone», letteralmente «generatore»], per la parte che ha il maschio nell’atto di procreazione; già nei geroglifici troviamo rappresentato il testimone con l’immagine dei genitali maschili." (cfr. S. Freud, "Racconti analitici, a cura di Mario Lavagetto, Einaudi 2011).
* Sul tema, cfr. Federico La Sala, "Cosa succede in casa - nella “camera nuziale”, e cosa succede in Parlamento - nella “camera reale”?! Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud..
NOTE:
- SHAKESPEARE, GERTRUDE ("DE #NIVELLES), E FREUD: TEATRO E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA.
- LO SPIRITO ("GHOST) DI RE - PADRE AMLETO ("RICORDATI DI ME", I.5) E LA TRAPPOLA PER #TOPI DEL PRINCIPE - FIGLIO AMLETO ("THE #MOUSETRAP", III.2): UNA LEZIONE DI STORIA DELL’ARTE (DEL 1427) SULLA "MOUSETRAP" E SULLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) DEL PITTORE FIAMMINGO ROBERT CAMPIN.
- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "CRITICA DELLA RAGION PURA": CON KANT, FREUD, MUSATTI, E FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’ UOMO COL #MAGNETOFONO (J.-J. ABRAHAMS), UNA GENIALE E HAMLETICA "TRAPPOLA PER #TOPI".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- COSMOLOGIA E (DISAGIO DELLA) CIVILTA’: GIACOMO LEOPARDI, NELL’ORIZZONTE COPERNICANO DI KANT E DI FREUD.15 giugno 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, STORIA E LETTERATURA, (E DISAGIO DELLA) CIVILTA’: GIACOMO LEOPARDI, NELL’ORIZZONTE COPERNICANO DI KANT E DI FREUD. Una nota a sua memoria...
RICORDARE che Giacomo Leopardi (Recanati, 29 giugno 1798 - Napoli, 14 giugno 1837 ), a introduzione del testo della "Ginestra o il fiore del deserto" (1836), abbia premesso le parole riprese dall’evangelo di Giovanni (III,19) "Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἂνθρωποι/ μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς ("E gli uomini amarono/ piuttosto le tenebre che la luce" (Giovanni III, 19), è una valutazione radicale di denuncia della scelta fatta.
 Il "giudizio" della "lenta ginestra" sull’umanità che ha amato (v. "ἠγάπησαν") le tenebre e non la luce, dice di una #negazione dell’ ἀγάπη, dello stesso «amore» cristiano, che in qualche modo richiama le considerazioni fatte da Kant nella "Fine di tutte le cose" ) e, al contempo, anche le riflessioni di Freud sulla svolta data da Paolo di Tarso nella "gestione" del messagio evangelico: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).
Il "giudizio" della "lenta ginestra" sull’umanità che ha amato (v. "ἠγάπησαν") le tenebre e non la luce, dice di una #negazione dell’ ἀγάπη, dello stesso «amore» cristiano, che in qualche modo richiama le considerazioni fatte da Kant nella "Fine di tutte le cose" ) e, al contempo, anche le riflessioni di Freud sulla svolta data da Paolo di Tarso nella "gestione" del messagio evangelico: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).NOTE:
- MEMORIA E POESIA: LA GINESTRA. "La ginestra o Il fiore del deserto è la penultima lirica di Giacomo #Leopardi, scritta nella primavera del 1836 a Torre del Greco nella villa Ferrigni e pubblicata postuma nell’edizione dei Canti nel 1845. [...]".
- Storia dell’#astronomia dalle orgini al duemila e oltre (di Leopardi Giacomo, Hack Margherita )
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- ANTROPOLOGIA E COSMOLOGIA: L’ALLEANZA DI FUOCO ("CHARITAS") E UNA NEXOLOGIA CHIASMATICA, PIENA DI GRAZIA ("#CHARIS").4 giugno 2024, di Federico La Sala
GEOCENTRISMO, ELIOCENTRISMO, E COSTITUZIONE DEL "MONDO". SHAKESPEARE, IL NOME DI OFELIA, E SOLO IL SOLE IN CIELO, AL CENTRO.
L’EUROPA ANCORA NELLA CAVERNA DELL’ANDROCENTRISMO PLATONICO E PAOLINO E I POSSIBILI RIMANDI DELL’AMLETO "ELISABETTIANO" AL CONTESTO STORICO-POLITICO DELL’ EUROPA DELL’EPOCA, CARICO DI ATTESE DA PARTE DEL "POPOLO" DEI "SOLARI"...
- TEATRO (ASTRONOMIA), METATEATRO (FILOSOFIA), E COSTITUZIONE DEL "MONDO". Una nota di commento a margine del lavoro in progress di Paul Adrian Fried: "Part 47: Ophelia’s “O” and the Virtues of Nothingness" (May 28, 2024). *
"DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM" (COPERNICO, 1543): GEOCENTRISMO O ELIOCENTRISMO?!
 ACCETTANDO PER IPOTESI CHE IL NOME DI OFELIA ("O-felia" = "Peri-elio", intorno e vicino al Sole) è formalmente vicino al nome di #AFELIO ("A-felio" - lontano dal Sole), non è meglio pensare e collocare la figura dell’amletica Ofelia nell’orizzonte delle discussioni cosmologiche legate alla #centralità del #Sole nell’#Universo (sul filo del lavoro di Copernico, Keplero, e Giordano Bruno) e delle preoccupazioni teologico-politiche legate alla #consonanza con le attese apocalittiche dell’epoca (Tommaso Campanella e "la Città del Sole") e al richiamo diffuso della figura del profeta Elia)?! Se non ora, quando "lo Spaccio della Bestia trionfante" (G. Bruno, 1584)?!
ACCETTANDO PER IPOTESI CHE IL NOME DI OFELIA ("O-felia" = "Peri-elio", intorno e vicino al Sole) è formalmente vicino al nome di #AFELIO ("A-felio" - lontano dal Sole), non è meglio pensare e collocare la figura dell’amletica Ofelia nell’orizzonte delle discussioni cosmologiche legate alla #centralità del #Sole nell’#Universo (sul filo del lavoro di Copernico, Keplero, e Giordano Bruno) e delle preoccupazioni teologico-politiche legate alla #consonanza con le attese apocalittiche dell’epoca (Tommaso Campanella e "la Città del Sole") e al richiamo diffuso della figura del profeta Elia)?! Se non ora, quando "lo Spaccio della Bestia trionfante" (G. Bruno, 1584)?!*
- "OPHELIA: What does the name mean and imply? If the name of Marlowe’s character from Dr. Faustus, Mephistopheles, is said to mean “not-(me-)Faustus-(phisto-)love (pheles),” O-phelia suggests O-love, or Nothingness-love, love of emptiness, openness, humility, endless possibility. [...]" (Paul Adrian Fried).
NOTE:
- ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA, E #COSMOLOGIA: L’#ALLEANZA DI FUOCO ("#CHARITAS"), UNA #NEXOLOGIA CHIASMATICA, PIENA DI #GRAZIA ("#CHARIS", "gr. #XAPIS"). LA #STELLA DEL #CIELO CHE ILLUMINA LA #TERRA. DA #ORSANMICHELE ("L’ORTO DI SAN MICHELE ARCANGELO"-) ALLA "SACRA FAMIGLIA" DI MICHELANGELO BUONARROTI.
- "SÀPERE AUDE" (#ORAZIO - #KANT) E #PSICOANALISI. A partire da "me" con "me" (da "sé" con "sé"), per una #antropologia (al di là della "gioviale" #logica androcentrica, platonico-paolina e costantiniana) e per una chiasmatica e solare #nexologia (con un #nesso liberato dalla "x" dell’incognita del non-sapere, un "#nexus" chiaro, con il gr. "X", "Chi"), forse, non è meglio che in #cielo ci sia solo il #Sole, e si esca dalla #caverna dell’#egocentrismo e dal #geocentrismo tolemaico? Con un #inno alla freudiana "#Freude", senza "freudolenza"?!
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- IL PROGRAMMA "PERDUTO" DELL’UMANESIMO: LE SIBILLE DEL PAVIMENTO DELLA CATTEDRALE DI SIENA.18 maggio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, TEOLOGIA, ARTE E STORIA: IL PROGRAMMA ANTROPOLOGICO E TEOLOGICO DELL’UMANESIMO "PERDUTO":
"Le #Sibille, secondo lo schema varroniano, sono #dieci (cinque per ogni navata) e derivano il loro nome dai luoghi di pertinenza geografica: la Sibilla Persica, l’Ellespontica, l’Eritrea, la Frigia, la Samia, la Delfica per quanto riguarda il mondo orientale e greco; la Libica per l’Africa; e poi quelle occidentali (con riferimento all’Italia): la Cumea o Cimmeria, la Cumana (virgiliana) e la Tiburtina." (https://operaduomo.siena.it/pavimento/).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- TEATRO, METATEATRO, E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI": "AMLETO" E IL "CASO CLINICO DELL’UOMO DEI TOPI".15 maggio 2024, di Federico La Sala
TEATRO, METATEATRO, E COSTRUZIONI NELL’ANALISI: AMLETO ("HAMLET") E "LE GATTE" E I GATTI ("THE MOUSE_TRAPPERS") DI SHAKESPEARE (E SIGMUND FREUD).
- Una nota di commento a margine del lavoro in progress di Paul Adrian Fried ("Part 45: Ophelia’s Terrible Awakening and Liberation", May 13, 2024).
ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA-POLITICA (#CORPOMISTICO): LA DONNA-REGINA E L’UOMO-RE "DEI TOPI". SE E’ VERO, come è vero, che Ofelia e Gertrude si risvegliano dall’ingenuità, non è perché "si liberano dagli aspetti del #patriarcato, Ofelia da suo padre e Gertrude da suo marito", ma perché si svegliano da un epocale tragico "letargo" (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 94) e cominciano a pensare e a giudicare con la propria testa (storicamente ed esemplarmente, come #Elisabetta I d’Inghilterra, "papa e regina") sul come gestire il proprio corpo e il proprio "tesoro" di donne, di persone regali e reali, e, infine, condividendo i sospetti e le analisi dello stesso Amleto (figlio del "valoroso" re Amleto, ucciso dal "nuovo" sposo della stessa madre-regina e dal "falso" padre-re, Claudio), ad "aiutarsi a vicenda con l’esempio".
"LA TRAPPOLA PER TOPI" ("THE MOUSETRAP"). Se è così, allora, per meglio portare avanti l’analisi e il lavoro di interpretazione del "sogno" di Shakespeare, occorre fare più luce sul tema centrale della rappresentazione nella rappresentazione (“The Mousetrap”) e, conseguentemente, capire che all’opera e nell’opera di Shakespeare le vere e proprie collaboratrici della realizzazione del progetto di Amleto sono proprio Ofelia e Gertrude, sono loro le vere "#cacciatrici di topi", le "gatte" ("mousetrappers"), che rendono possibile il successo dell’operazione, rispettare il #patto del vecchio Re Amleto, "ratificato dalla legge e dall’uso cavalleresco" ("Amleto", I,1,), e, infine, "profetizzare" che "l’elezione al trono cadrà su #Fortebraccio" ("Amleto", V. 2): per Shakespeare, evidentemente, la memoria di santa Gertrude di Nivelles, protettrice delle gatte e dei gatti è ancora ben viva.
LINGUAGGIO E #METALINGUAGGIO. IL "CORPO MISTICO" DEL "PAPA-RE" (E DELLA "REGINA-PAPA", ELISABETTA D’INGHILTERRA), SANTA GERTRUDE DE NIVELLES (PROTRETTRICE DELLE GATTE E DEI GATTI), E IL #COMENASCONOIBAMBINI: IL PROBLEMA DEI TOPI E LA PREOCCUPAZIONE DI "GIUSEPPE", LO SPOSO DI "MARIA". Rileggere e rimeditare la lezione dell’Amleto ("Hamlet"), alla luce del singolare "Trittico di Mérode" di Roger de Campin, dedicato proprio al tema dell’#Annunciazione della nascita del Bambino a "Maria e Giuseppe".
- NOTE:
- TEATRO E METATEATRO: DISAGIO DELLA CIVILTA’ (NELLA "DANIMARCA" EUROPEA ALL’EPOCA DELLA REGINA #ELISABETTA I D’#INGHILTERRA) E INTERPRETAZIONE DEL "SOGNO" DI #SHAKESPEARE. Una ulteriore "tappa" del lavoro di Paul Adrian Fried: una sollecitazione a riconsiderare le figure di #Gertrude e #Ofelia nella "#Mousetrap"_ola di #Amleto (#Hamlet), contro "l’uomo dei topi", il Re Claudio, sposo della Regina Gertrude, vedova e madre del principe Amleto. Per orientarsi nel pensiero (#Kant2924), ricordare santa Gertrude di Nivelles, la protrettrice dei gatti e delle gatte.
- LINGUAGGIO E #METALINGUAGGIO: TRAPPER.
- SHAKESPEARE. S.Freud, nelle "Considerazioni teoriche" (1924) sul "caso clinico dell’uomo dei topi" (1909), in una nota di commento, cita " I versi d’amore di Amleto a #Ofelia, che #Polonio legge alla regina #Gertrude (atto 2, scena 2): Doubt thou the stars are flre; Doubt that the sun doth move; Doubt truth to be a liar; But never doubt I love. [Dubita che le stelle siano fuoco; Dubita che il sole giri; Dubita che la verità sia menzogna; Giammai non dubitare del mio amore.]".
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- LO SCIOGLIMENTO DELL’ANDROCENTRICO "CORPO MISTICO" DEL "RE DELL’UNIVERSO" E L’USCITA DALLA "PREISTORIA" (K. #MARX)13 maggio 2024, di Federico La Sala
LA FINE DELL’ ERA "ICEBERGHIANA" E DEL #DESTINO DELLA #NECESSITA’ ( #ANANKE: #VICTORHUGO):
- LO SCIOGLIMENTO DELL’ANDROCENTRICO "CORPO MISTICO" DEL "RE DELL’UNIVERSO" E L’USCITA DALLA "#PREISTORIA" (K. #MARX) .
Una breve nota su una metafora "ghiacciata" e "agghiacciante"!
- "MEMORIA DEL MONDO". In lode di Dante Alighieri, Victor Hugo, Sigmund Freud, e Italo Calvino...
PSICOANALISI, #ANTROPOLOGIA, ED #ECOLOGIA: SOTTO LA #MONTAGNA (#BERG) DI #GHACCIO (#ICE), COSA C’E’ SE NON SOLO L’ ACQUA "SPORCA" E "RISCALDATA" DELLO STESSO CHIACCIO? Continuare ad usare l’ #iceberg, come metafora della coscienza della "specie" umana, non porta fuori dalla "diritta via" e impedisce di conoscere sé e, al contempo, che ciò che "galleggia" sull’oceano è solo la #testa, la #coscienza capovolta del luciferino Signore del #ghiaccio infernale, come aveva ben capito #Dante, nel momento stesso in cui con #Virgilio riesce ad attaccarsi al #vello di #Lucifero e venir fuori dalla #caverna in cui si era smarrito e da cui pensava di non poter più uscire? Non è forse meglio rimettere i piedi a terra (Inf. XXXIV, vv. 88-90: "Io levai li occhi e credetti vedere /Lucifero com’io l’avea lasciato, /e vidili le gambe in sù tenere") e rileggere non solo con Dante e Virgilio, ma anche con Maria Beatrice e Lucia il viaggio di ogni essere umano nello spazio-tempo cosmico in cui si svolge la #Commedia umana, la "divina Commedia"?
- Foto allegata: La "piramide" di Bovillus (1510). Un omaggio al "Verde Brillante" di Stefano Mancuso e Alessandra Viola (Giunti Editore 2011)
NOTA:
- PSICOANALISI, #DISAGIO (DELLA E ) NELLA #CIVILTA’ (#SIGMUNDFREUD), #FILOLOGIA (LORENZOVALLA) E #TEATRO (#MOUSETRAP: #SHAKESPEARE, #HAMLET): A CHE #GIOCO GIOCHIAMO?!
Lacan dice pure la verità (come tutti e tutte), ma "a metà"! Si mette a "spacciare" ("#joyce-#mente") come un grande "pifferaio", in nome dello "#spirito" di #Freud, che il "Nome di «Freud» significa «gioia»" (1956), alla "lettera", "#joy", "#Freude" (cioè, alla #Beethoven e alla #Schiller), e diventa un fedele "niceano" (#Nicea 325, alla costantiniana maniera), sia contro #Kant, contro #Marx, contro #Nietzsche, e, ovviamente, contro lo stesso #Freud!
 DESTINO DELLA #NECESSITA’ ( #ANANKE: #VICTORHUGO). Da "visconte dimezzato", #JacquesLacan come avrebbe potuto prevedere il salire della la temperatura, lo scioglimento dell’io #iceberg _hiano, e il fiorire dei prati a #Maresfield, là dove le cavalle e i cavalli si rincorrono ancora e di nuovo gioiosamente?!
DESTINO DELLA #NECESSITA’ ( #ANANKE: #VICTORHUGO). Da "visconte dimezzato", #JacquesLacan come avrebbe potuto prevedere il salire della la temperatura, lo scioglimento dell’io #iceberg _hiano, e il fiorire dei prati a #Maresfield, là dove le cavalle e i cavalli si rincorrono ancora e di nuovo gioiosamente?!- FILOLOGIA, #ANTROPOLOGIA, E #CATTOLICESIMO ROMANO (#NICEA 325-2025): #GIUBILEO2025. "SPES NON CONFUNDIT". Il testo della Bolla di papa Francesco per il Giubileo Ordinario dell’Anno 2025 (giovedì 9 maggio 2024).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’HAMLETICA QUESTIONE DEL MENTITORE E IL "GLOBO IMPAZZITO" ("DISTRACTED GLOBE"). Un invito a ri-leggere Shakespeare.4 aprile 2024, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, #METATEATRO E #SPIRITO DELL’#EUROPA: L’#HAMLETICA QUESTIONE DEL #MENTITORE ("#SERPENT"), DEL FALSO #RESOCONTO "DELLA GENTE DALLA DOPPIA TESTA" (#PARMENIDE), E IL "GLOBO IMPAZZITO" ("DISTRACTED #GLOBE"). Un invito a ri-leggere #HAMLET (#Shakespeare):
"GHOST [...] Now, Hamlet, hear.
 ’Tis given out that, sleeping in my orchard,
’Tis given out that, sleeping in my orchard,
 A serpent stung me. So the whole ear of Denmark
A serpent stung me. So the whole ear of Denmark
 Is by a forgèd process of my death
Is by a forgèd process of my death
 Rankly abused. But know, thou noble youth,
Rankly abused. But know, thou noble youth,
 The serpent that did sting thy father’s life
The serpent that did sting thy father’s life
 Now wears his crown.
Now wears his crown.
 HAMLET O, my prophetic soul! My uncle!
HAMLET O, my prophetic soul! My uncle!
 GHOST [...] Adieu, adieu, adieu. Remember me. (He exits).
GHOST [...] Adieu, adieu, adieu. Remember me. (He exits).
 HAMLET [...] Remember thee?
HAMLET [...] Remember thee?
 Ay, thou poor ghost, whiles memory holds a seat
Ay, thou poor ghost, whiles memory holds a seat
 In this distracted globe. Remember thee?
In this distracted globe. Remember thee?
 Yea, from the table of my memory
Yea, from the table of my memory
 I’ll wipe away all trivial, fond records,
I’ll wipe away all trivial, fond records,
 All saws of books, all forms, all pressures past,
All saws of books, all forms, all pressures past,
 That youth and observation copied there,
That youth and observation copied there,
 And thy commandment all alone shall live
And thy commandment all alone shall live
 Within the book and volume of my brain,
Within the book and volume of my brain,
 Unmixed with baser matter. Yes, by heaven!
Unmixed with baser matter. Yes, by heaven!
 O most pernicious woman!
O most pernicious woman!
 O villain, villain, smiling, damnèd villain!
O villain, villain, smiling, damnèd villain!
 My tables-meet it is I set it down
My tables-meet it is I set it down
 That one may smile and smile and be a villain.
That one may smile and smile and be a villain.
 At least I am sure it may be so in Denmark.
At least I am sure it may be so in Denmark.
 He writes.
He writes.
 So, uncle, there you are. Now to my word.
So, uncle, there you are. Now to my word.
 It is “adieu, adieu, remember me.”
It is “adieu, adieu, remember me.”
 I have sworn ’t."
I have sworn ’t."
 (W. Shakespeare, Hamlet, I.5).
(W. Shakespeare, Hamlet, I.5)."SPETTRO, [...] E dunque ascolta, Amleto / S’è detto che, mentre dormivo nel mio giardino, / Mi morse un serpente. Così l’orecchio / Dell’intera Danimarca è stato ingannato/ turpemente con un falso resoconto /Della mia morte. Ma tu, nobile giovane, /Sappi che il serpente che morse la vita / Di tuo padre, ora ne indossa la corona.
 AMLETO Oh La mia anima profetica! Mio zio?
AMLETO Oh La mia anima profetica! Mio zio?
 SPETTRO [...] Addio, addio, addio. Ricordati di me!
SPETTRO [...] Addio, addio, addio. Ricordati di me!
 AMLETO [...] Sì, povero spettro, fino a quando / la memoria ha uno spazio in questo glo impazzito / Ricordarmi di te? Ecco, dalla tavola / Della mia memoriascancellerò ogni sciocca / Banale annotazione [...] e il tuo comandamento / Vivrà ds solo nel Libro della mia mente, / Senza essere mischiato a materis più vile. /Sì, per il Cielo. [...] Il mio quaderno... /Conviene mettere per iscritto che uno / Può sorridere, e sorridere, ed essere un criminale / O almeno sono sicuro che può essere così in Danimarca. (scrive) [...]
AMLETO [...] Sì, povero spettro, fino a quando / la memoria ha uno spazio in questo glo impazzito / Ricordarmi di te? Ecco, dalla tavola / Della mia memoriascancellerò ogni sciocca / Banale annotazione [...] e il tuo comandamento / Vivrà ds solo nel Libro della mia mente, / Senza essere mischiato a materis più vile. /Sì, per il Cielo. [...] Il mio quaderno... /Conviene mettere per iscritto che uno / Può sorridere, e sorridere, ed essere un criminale / O almeno sono sicuro che può essere così in Danimarca. (scrive) [...]
 (W. Shakespeare, "Amleto", I.5, trad. Agostino Lombardo, #Feltrinelli).
(W. Shakespeare, "Amleto", I.5, trad. Agostino Lombardo, #Feltrinelli).- NOTA: SE "IL TEMPO E’ FUORI DAI CARDINI" (#Amleto, I. 5), IL #NODO DA SCIOGLIERE (SUL PIANO PERSONALE, POLITICO, E TEOLOGICO) E’ UNA #QUESTION EPOCALITTICA (APOCALITTICA), DI #VITA E DI #MORTE, DI ESSERE E NON-ESSERE...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- EARTHRISE (1968): L’ HAMLETICA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (SHAKESPEARE, 1600; KANT, 1800) E LA "INTRODUZIONE DEL 1857" (K. MARX).16 marzo 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: L’ HAMLETICA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (SHAKESPEARE, 1600; KANT, 1800) E LA "INTRODUZIONE DEL 1857" (K. MARX).
- "VECCHIE" NOTE PER CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA DI MAMMONA... *
Con Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, non solo «Dio è morto» (#Nietzsche) ma anche l’#Uomo (#MichelFoucault) della #tradizione edipico-androcentrica (platonica, paolina, hegeliana, ed heideggeriana):
- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il #capo è Cristo, e capo della #donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «#uomo»], e capo di Cristo è Dio" (Paolo di Tarso, 1 Cor. 11, 1-3).
EARTHRISE (1968). In principio era il Logos (dell’Efeso di #Eraclito e dell’evangelista Giovanni, non il logo dello "apostolo" Paolo di Tarso) e uscire dall’inferno (#Dantedì, #25marzo 2024) è possibile!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---PSICHIATRIA E COSTITUZIONE Una "citazione" in #memoria di FRANCO BASAGLIA E DI FRANCA ONGARO:11 marzo 2024, di Federico La Sala
CREATIVITÀ E SOCIETÀ: ARITMETICA, PSICHIATRIA, PSICOANALISI, E COSTITUZIONE (#Europa2024: #Francia)
- "L’ISTITUZIONE NEGATA" (FRANCO BASAGLIA,1968) E UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI ANTROPOLOGIA (DA PORRE ALL’ORDINE DEL GIORNO, PER EVITARE... UN ARROSSIMENTO GENERALE).
Una "citazione" in #memoria di FRANCO BASAGLIA E DI FRANCA ONGARO:
"un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, "Donna", Enciclopedia, V, Einaudi, Torino 1978).
NOTE:
- "La #clinica dopo #Basaglia: [...] L’#istituzione #negata è una singolare linea di derivazione. Come in #matematica la #singolarità è un punto dove una curva cambia radicalmente e fa nascere l’imprevedibile; oppure in musica, quando si tratta di una variazione repentina - come in alcune composizioni di Schoenberg, o nell’improvvisazione jazz. Se la matematica e la #musica sono all’altezza di gestire la #complessità dei propri contenuti, trasformando i propri limiti in nuove frontiere della #conoscenza - nel primo caso - e in nuove esperienze della sensibilità uditiva e ritmica - nel secondo caso -, perché la società non dovrebbe favorire variazioni esistenziali dello stesso tipo? Se un nuovo teorema e un nuovo brano musicale sono forme della #creazione umana, perché la follia non può esserlo? [...]" (cfr. Pietro Barbetta, "#Doppiozero", 11 Marzo 2024).
- ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #8MARZO2024: RICORDANDO #DANTEALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA, RIPENSARE L’#UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson).
- CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
- RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE E #RIPRODUZIONE: GENITORI E FIGLI. "ALBERTA BASAGLIA: “Non è tardi per parlare di mia #madre #FrancaOngaro e del suo ruolo nella rivoluzione che portò alla chiusura dei manicomi”
 La #psicologa, #figlia dello psichiatra #FrancoBasaglia, racconta nel libro "Contro tutti i muri" (Donzelli editore) il ruolo avuto dalla madre nel processo che portò alla #Legge180: "Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico. Ho il ricordo della presenza contemporanea di entrambi i miei #genitori inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di #cambiare il #mondo" (cfr. EmanueleSalvato, "Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2022).
La #psicologa, #figlia dello psichiatra #FrancoBasaglia, racconta nel libro "Contro tutti i muri" (Donzelli editore) il ruolo avuto dalla madre nel processo che portò alla #Legge180: "Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico. Ho il ricordo della presenza contemporanea di entrambi i miei #genitori inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di #cambiare il #mondo" (cfr. EmanueleSalvato, "Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2022).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- RIPENSARE L’UNO, A PARTIRE DA DUE. Appunti su “The Penelopiad” di Margaret Atwood e la "Divina Commedia" di Dante Alighieri.10 marzo 2024, di Federico La Sala
PENELOPE- IDEA E COMMEDIA: FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Con lo spirito dell’opera “The Penelopiad” di Margaret Atwood e della "Divina Commedia" di Dante Alighieri, un segnavia di uscita dall’orizzonte della tragedia...
STORIA E LETTERATURA. Data la immersione totale di tutta la cultura occidentale nell’immaginario dell’#Odissea, "étudier, très succinctement, la technique d’« écriture féminine » de Margaret Atwood, à travers son ouvrage «The Penelopiad» et plus précisément, à travers l’ironie dans son rapport aux «métamorphoses» apportées au texte de l’Odyssée d’Homère" (cfr. Rebecca Plewinski, "La technique d’«écriture féminine» de Margaret Atwood: l’exemple de The Penelopiad») che con mente "penelope-idea" sa catturare e aggiogare persone e popoli con il proprio "canto" e l’ esperienza tragica della sua "fenomenologia dello #spirito".
L’ALBA DELLA MERAVIGLIA ("Earthrise"). Per #Dante, con l’aiuto del "padre" #Virgilio ("Eneide") su sollecitazione della "#bella e beata" #madre Beatrice (sollecitata a sua volta da Lucia, inviata da Maria, madre di Gesù "Cristo"), la "folle impresa" di uscire dalla "selva oscura" e ritrovare la "diritta via", con il vecchio "Ulisse" e con la vecchia "Penelope" sulle proprie spalle, è possibile: è l’amore che muove il sole e le altre stelle.
- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA: MARGARET ATWOOD, "IL CANTO DI PENELOPE" (Wikipedia).
- ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #8MARZO2024: RICORDANDO #DANTEALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA "MONARCHIA", RIPENSARE L’UNO, ri-pensare l’ONU - a partire da #Due, "almeno due" (#GregoryBateson).
 CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
-
EPOCALISSE: UNA NOTA SULLA TRASVALUTAZIONE STORICA DELLA "VIOLENTA CARITÀ" ("VIOLENTAE CHARITATIS") DI RICCARDO DI SAN VITTORE.6 marzo 2024, di Federico La Sala
EPOCALISSE: "APRIRE GLI OCCHI" (S. #FREUD, 1899), PER #CARITÀ! #FILOLOGIA E #ARCHITETTURA FILOSOFICA E ANTROPOLOGICA (#KANT2024).
#DANTEDI’, 25 MARZO 2024: UNA NOTA SULLA TRASVALUTAZIONE STORICA DELLA "VIOLENTA CARITÀ" ("VIOLENTAE CHARITATIS") DI RICCARDO DI SAN VITTORE.
STORIA E LETTERATURA. Nel bimillenario percorso planetario del #cattolicesimo romano (#Nicea 325-2025), la "#diritta via" (#Dante Alighieri) del filologico legame significante e significato tra il luogo dell’#amore e il luogo dell’#occhio ("Ubi amor, ibi oculus") è stata smarrita insieme con l’#acca ("h").
Incredibilmente, e inauditamente, l’amore, la #charitas dello stesso #Riccardo di San Vittore ("Riccardo /che a considerar fu più che #viro", più che uomo, come scrive Dante nel X del "Paradiso") è diventata la parola-chiave della teologia della ricchezza materiale e spirituale: la "caritas", senza più "h", senza più l’acca, è diventata semplicemente #Mammona, il dio ("#Deus #caritas est") dell’#economia mondiale, garante del "buon-andamento" del #carro delle borse e del #caro-prezzo del #mercato: la religione del #capitalismo, vecchio e nuovo (come aveva capito Karl #Marx, #WalterBenjamin, e, ovviamente, #DanteAlighieri).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" ---SOCIETA’, EDUCAZIONE, E INSEGNAMENTO: IL PROBLEMA DELLA NASCITA E "LA CRISI DELLA ISTRUZIONE" (H. ARENDT).4 marzo 2024, di Federico La Sala
SOCIETA’, EDUCAZIONE, ED INSEGNAMENTO: IL PROBLEMA DELLA NASCITA E "LA CRISI DELLA ISTRUZIONE"
Hannah Arendt, nel suo "Tra passato e futuro" (1961), in riferimento alla "crisi dell’istruzione", forse, è utile #ricordare che, dinanzi a chi non sa, «l’insegnante si qualifica per conoscere il mondo e per essere in grado di #istruire altri in proposito, mentre è autorevole in quanto, di quel mondo, si assume la responsabilità». Di fronte a chi non sa, all’allievo e all’allieva, «è una sorta di rappresentante di tutti i cittadini della terra che indica i particolari dicendo: ecco il nostro #mondo».
CIO’ CHE INTERESSA TUTTI «noi - ella prosegue - e non va quindi delegato alla scienza specialistica, è il rapporto tra adulti e bambini in genere. Si tratta (in termini più generali e corretti) della nostra posizione nei confronti della #nascita degli uomini: del fatto fondamentale che tutti siamo stati "messi al mondo" e che le nuove nascite rinnovano di continuo il mondo stesso. L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo di esseri nuovi, di giovani. Nell’educazione si decide anche se noi amiamo tanto i nostri figli da non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balia di se stessi, tanto da non strappargli di mano la loro occasione d’intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa d’imprevedibile per noi; e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti».
fls
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA NASCITA, LA BILANCIA (DELLA GIUSTIZIA), E IL GIUDIZIO (UNIVERSALE).12 febbraio 2024, di Federico La Sala
LA BILANCIA E LA NASCITA...
DIRITTO, DOVERE, E COSTITUZIONE: UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI ANTROPOLOGIA (DA PORRE ALL’ORDINE DEL GIORNO, PER EVITARE... UN ARROSSIMENTO GENERALE).
La #bilancia della #giustizia e l’urgenza epocale di una #equilibrazione del #rapporto sociale di ri-#produzione: "un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1978).
- Una nota in memoria di Franco Basaglia e di Franca Ongaro Basaglia
#SAPEREAUDE! (#KANT2024). LIBERARE la #Giustizia dalla benda (v. allegato) è un programma di uscita dallo "stato di minorità" (#Kant, 1784), una sollecitazione antropologica a servirsi della propria facoltà di giudizio, di avere il coraggio di #apriregliocchi (ricordare la difficoltà di #Freud, a riguardo) e di non #giudicare né con gli occhi chiusi né con un solo occhio.
Riconoscere l’#identità e la #differenza di sé con sé, di sé con l’altro da sé, di sé con l’altra da sé, l’#uguaglianza e la #diversità, è proprio una questione di "equilibrazione", di bilancia: ne va della nostra stessa #nascita e della nostra stessa #vita.
- Nota:
- LA NASCITA, LA BILANCIA (DELLA GIUSTIZIA), E IL GIUDIZIO (UNIVERSALE): "LA PESATRICE DI PERLE" (JAN #VERMEER).
- "La Pesatrice di perle (o Donna con una bilancia) è un dipinto a olio su tela (40,3x35,6 cm) di #JanVermeer, databile al 1664 [...]. Davanti a lei si vede uno specchio appeso alla parete e sul tavolo un drappo blu [...]. Sulla parete di fondo si vede un dipinto con il #Giudiziouniversale: forse un’allusione moraleggiante a non occuparsi troppo dei beni terreni e a conservare un’anima candida, come quelle che san Michele è solito soppesare con una #bilancia proprio al centro di molti dipinti del Giudizio. Il candore delle perle potrebbe e il tema della bilancia potrebbe simboleggiare la purezza della donna, oppure richiamare il tema della temperanza, ovvero la necessità di soppesare le proprie azioni. Lo stesso specchio di fronte alla donna simboleggerebbe il bisogno, in tale processo, di tenere #coscienza di sé. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Pesatrice_di_perle).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- LA "CLINICA DELLA SINGOLARITÀ", IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ, E L’ANTROPOLOGIA. Note a margine delle "Disforie di genre" (Pietro Barbetta).2 febbraio 2024, di Federico La Sala
L’ESSENZA DEL GENERE UMANO, L’ANTROPOLOGIA, E LA "CLINICA DELLA SINGOLARITÀ":
CON MARX, RIPARTIRE DA DEMOCRITO ("GENDER") E DA EPICURO ("GENRE"), E SEGUIRE DANTE PER USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO.
- Alcune note a margine delle "Disforie di genre" (Pietro Barbetta, "Kaiak. A Philosophical Journey" - 11, 2024):
PSICOLOGIA E LETTERATURA. Nel suo recente ed "euforico" saggio, dal titolo "Disforie di genre" ("Kayak. A Philosophical Journey", 11, 2024), Pietro Barbetta, offre una ottima ricognizione sul tema e sul problema del "genere" (e, con esso, ovviamente, anche della "biblica" questione antropologica, quella del "genere umano" ("gattungswesen"), dell’essere umano, di ogni essere umano...
FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Sembra un passo indietro, ma, a mio parere, è anche una sollecitazione per prendere la rincorsa e saltare meglio: "La traduzione di genere in inglese ha due significanti: genre e gender. [...]. #Genre e #gender sono infatti due visioni opposte dell’essenza: quella ideale, le cui cose materiali non sono che ombre, e quella del motto husserliano “verso le cose stesse”, che ne designa la singolarità e la materialità. Nel primo caso l’accidente è trascurabile, mero aspetto materiale dell’idea, nel secondo l’accidente è linea di fuga dal gender, ciò che, in quanto idiosincrasia, definisce il #clinamen. Il gender è come l’atomo di #Democrito, scende dall’alto verso il basso in modo verticale, senza deviare, il genre è come l’atomo di #Epicuro e Lucrezio, si scontra con altri atomi, deviando costantemente la propria traiettoria" (P. Barbetta, cit.).
STORIA E FILOSOFIA. CONTRARIAMENTE A QUANTO si è per lo più sempre pensato e si continua a pensare nel sonnambulismo cartesiano-hegeliano, il richiamo (non detto) alla tesi di Karl Marx, "La differenza tra la filosofia naturale di Democrito e la filosofia naturale di Epicuro" (1841), non appartiene alla preistoria della "critica dell’economia politica", ma è carica di "radioattività" teorica che può portare fuori dall’#inferno epistemologico della #tragedia platonico-hegeliana e paolina-marxista:
«In Epicuro, quindi, l’atomismo con tutte le sue contraddizioni si è realizzato e completato come scienza naturale dell’autocoscienza. Questa autocoscienza sotto forma di individualità astratta è un principio assoluto. Epicuro ha così portato l’atomismo alla sua conclusione finale, che è la sua dissoluzione e l’opposizione consapevole all’universale. Per Democrito, invece, l’atomo è solo l’espressione oggettiva generale dell’indagine empirica della natura nel suo insieme.» (K. Marx, cit.).
PIANETA TERRA: "LA SCIENZA NATURALE DELL’AUTOCOSCIENZA", DANTE ALIGHIERI, E LA "VECCHIA TALPA" DI SHAKESPEARE ("Amleto", I.5). La mancata chiarezza (claritas) su questa acquisizione e comprensione storiografica e teoretica del giovane Marx ha comportato (e comporta ancora) la "progressiva" incomprensione della lezione di Dante come di Kant (sulla critica della fisica e della metafisica del socratismo, platonismo, paolinismo, ecc.) e la radicale cancellazione della parola "critica" dall’intero discorso dell’economia politica marxiana, fino a fraintendere la stessa dichiarazione "dantesca" (Par. XXXIII, 145) di "Amleto" (II.2) : "Dubita che le stelle siano fuoco, /dubita che si muova il sole, /dubita che la verità sia menzognera, /ma non dubitare mai del mio amore [But never doubt I love]"; e, con il pavimento lastricato di "buone" intenzioni, arrivare a perdere insieme al "paradiso celeste" ("William Blake osserva che coloro che sostengono il bene in generale sono mascalzoni") anche il "paradiso terrestre", e vietare al desiderio stesso della "clinica della singolarità" ogni via di uscita.
Nota:
- DISAGIO DELLA CIVILTÀ (PSICOANALISI) E "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE, IN GENERALE" (ECONOMIA POLITICA E FILOSOFIA):
- "[...] Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie [genere umano].
 Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.
Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.
 In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.
In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.
 In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.
In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.
 La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, "Manoscritti economico-filosofici del 1844").
La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, "Manoscritti economico-filosofici del 1844").
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- STORIA E STORIOGRAGIA E ICONOGRAFIA: PLATONISMO E PAOLINISMO NELL’ARTE E NELLA PROPAGANDA ANDROCENTRICA DELLA FEDE, DELLA SPERANZA, E DELLA CARITA’.26 gennaio 2024, di Federico La Sala
STORIA, IMMAGINARIO, ARTE, ANTROPOLOGIA, PLATONISMO RINASCIMENTALE, E CATTOLICESIMO ROMANO-COSTANTINIANO (PAOLINISMO).
RICORDANDOSI OGGI (25 GENNAIO 2024), UN AVVENIMENTO DECISIVO DELLA VITA DELL’EUROPA (E DELL’INTERO PIANETA), LA "CONVERSIONE DI SANPAOLO,
UN "INVITO" A #RIFLETTERE SULLA FORTE CONNESSIONE FORMALE (CON TUTTE LE SUE VARIE IMPLICAZIONI CULTURALI E TEOLOGICO-POLITICHE: RIFORMA LUTERANA, 1517; RIFORMA #ANGLICANA, 1534),
CON LA FIGURA DI PLATONE DELLA "SCUOLA DI ATENE" (DEL 1509-1511) DI RAFFAELLO,
CON IL "SAN PAOLO" DI PELLEGRINO TIBALBI (1585) DELLA "CAPPELLA BORROMEO" DELLA CHIESA DI "SANTA MARIA DELLE GRAZIE" DI MILANO, (ACQUISTATA E ACQUISITA NEL 2021 NELLE COLLEZIONI DEGLI UFFIZI) : "[...] Secondo gli studi di Allegri, il San Paolo, oltre ad essere un’opera molto importante nell’ambito della pittura della #Controriforma, costituisce anche un tassello cruciale per capire il ruolo del Tibaldi a Milano subito prima della sua partenza per la Spagna (1586), dove era stato chiamato dal re Filippo II per decorare l’#Escurial [...]"(https://www.uffizi.it/news/acquisizione-san-paolo-tibaldi ).
P. S.
PROPAGANDA (#FIDES), SPERANZA (#SPES), E CARITA’ (#CHARITAS). A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est"), Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per il messaggio evangelico (la teologia-politica cattolico-costantiniana, il Paolinismo) sia per l’antropologia, per la filosofia, e l’antropologia culturale : l’essersi "autoproclamato" ("#apostolo"), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del cristianesimo e della storia e della cultura dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad oggi.
- Kant2024
Note:
- RINASCIMENTO PLATONICO: PLATONE NELLA "SCUOLA DI #ATENE" (1509-1511) DI #RAFFAELLO.
- STORIA E MEMORIA DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICO- PAOLINA: CONCILIO DI TRENTO.
- "Il concilio di #Trento o concilio Tridentino fu il XIX concilio ecumenico della Chiesa cattolica, convocato per reagire alla diffusione della riforma protestante in Europa. L’opera svolta dalla Chiesa per porre argine al dilagare della diffusione della dottrina di Martin #Lutero produsse la #controriforma. Il concilio di Trento si svolse in tre momenti separati dal 1545 al 1563 e, durante le sue sessioni, a Roma si succedettero cinque papi (Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio IV). Produsse una serie di affermazioni a sostegno della dottrina cattolica che Lutero contestava. Con questo concilio la Chiesa cattolica rispose alle dottrine del calvinismo e del luteranesimo. L’aggettivo tridentino viene ancora usato per definire alcuni aspetti caratteristici del cattolicesimo ereditati da questo concilio e mantenuti nei secoli successivi sino al concilio Vaticano I ed al concilio Vaticano II. [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Trento).
- STORIA, LETTERATURA E #LETARGO (Par. XXXIII, 94) DA #TRAGEDIA. Ennio Flaiano (da grande "lettore" di #DanteAlighieri, v. "Autobiografia del Blu di Prussia") sapeva benssimo che la #luce era già stata spenta al tempo del #Galileo della #Galilea e del #GalileoGalilei (#Italia, #25gennaio 2024)
- STORIA, LETTERATURA E #LETARGO (Par. XXXIII, 94) DA #TRAGEDIA. Ennio Flaiano (da grande "lettore" di #DanteAlighieri, v. "Autobiografia del Blu di Prussia") sapeva benssimo che la #luce era già stata spenta al tempo del #Galileo della #Galilea e del #GalileoGalilei (#Italia, #25gennaio 2024)
- PROPAGANDA (#FIDES"), SPERANZA (#SPES), E CARITA’ (#CHARITAS). Chiarissimo Vincenzo Santoro, lode al suo eccellente lavoro di ricerca e studio: notevolissima l’immagine stampata a Napoli del "S. Paolo Apostolo"!
 A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est") Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per l’#antropologiaculturale (#ErnestoDeMartino) sia per il #messaggioevangelico (la #teologia cattolico-costantiniana del #Paolinismo), l’essersi "autoproclamato" (#apostolo), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del #cristianesimo e della #storia dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad #oggi.
A mio parere, la "conversione" del "cittadino romano" ( "civis Romanus est") Paolo di Tarso, divenuto "san Paolo", è un problema epocalmente importante (si pensi al prossimo anniversario di #Nicea, 325-2025), dal punto di vista storico e culturale: sia per l’#antropologiaculturale (#ErnestoDeMartino) sia per il #messaggioevangelico (la #teologia cattolico-costantiniana del #Paolinismo), l’essersi "autoproclamato" (#apostolo), e l’essere stato accreditato come tale ha deciso la "qualità" stessa del #cristianesimo e della #storia dell’#Europa (nel male e nel bene), fino ad #oggi.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". --- ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA) E DIVINA COMMEDIA: ACCOGLIERE IL "MORMORIO SOTTILE" DELL’OPERA DI DANTE ALIGHIERI24 gennaio 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA #ARTE #ANTROPOLOGIA E DIVINA COMMEDIA: MEMORIA DELLO "SPOSALIZIO DI GIUSEPPE E MARIA" (#23GENNAIO) E UN "VECCHIO" INVITO AD ACCOGLIERE IL "MORMORIO SOTTILE" DELL’OPERA DI DANTE ALIGHIERI.
STORIA E LETTERATURA: #RICAPITOLAZIONE E #POESIA. Dopo le sollecitazioni "#cosmicomiche" (#ItaloCalvino) di #DanteAlighieri a uscire dal "#letargo" (Par. XXXIII, 94), forse, è proprio il tempo di riaprire la #Commedia e non rinchiuderla per sempre nell’orizzonte del "#Boccaccio" e del "#Petrarca"; e, togliendo le virgolette al "Perché non possiamo non dirci «cristiani»"(Benedetto Croce, 1942), comprendere antropologicamente, che, come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO": e, riprendere proprio quel filo perduto (quel "#paradigma perduto") che collega benevolmente e cosmologicamente il passato e il presente, l’alto e il basso, il sopra e il sotto, e #cielo e la #terra: in principio era il #Logos...
#FILOLOGIA E #AMORE (#CHARITAS), NON #MAMMONA (#CARITAS)! Dante non "cantò i #mosaici" dei "faraoni", ma soprattutto la Legge del "Dio" di Mosè di Elia e di Gesù, del "Dio" dei nostri "Padri" e delle nostre "Madri". L’Amore "che muove il Sole e le altre stelle".
NOTE:
- ARTE,#POESIA, #ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), E #PSICOANALISI: EARTHRISE ( Foto allegata, 1968). Riprendendo e rilanciando (cum grano salis) "il messaggio è: allargate l’area della coscienza” (Allen Ginsberg); è una viva e #critica #sollecitazione a riprendere proprio quel filo perduto (quel "#paradigma perduto") che collega benevolmente il passato e il presente, l’alto e il basso, il sopra e il sotto, e il #cielo e la #terra: in principio era il #Logos (non un #logo).
- CATTOLICESIMO E CRISTIANESIMO: "LA PRIMA #RINASCITA". Storiograficamente, forse, è ora di #capovolgere, il "tempo" proprio dell’#Umanesimo e del #Rinascimento: per la società e la cultura del cosiddetto "#MedioEvo" (così dagli "umanisti"), l’epoca (al contrario) "fu sentita - così scrive E. Gilson - come un’età di innovazione in tutti i sensi della cultura, una #modernità in progresso". A mio parere, a ben vedere, Ernesto #Buonaiuti aveva ragione: il formidabile processo della "prima rinascita" cominciò con Gioacchino da Fiore, Francesco di Assisi, e Dante Alighieri.
- ARTE, STORIA, ANTROPOLOGIA (#CRISTOLOGIA), E #TRADIZIONE DEI #CARMELITANI SCALZI: MARIA E GIUSEPPE E TERESA D’AVILA:
- . Il "Matrimonio mistico di santa #Teresa d’Avila" (di #Francesco del Cairo, 1640-1650, #Parma): Il quadro [...] Raffigura la Vergine e san Giuseppe che appaiono a Santa Teresa d’Avila, inginocchiata in preghiera con le mani incrociate sul petto, nell’atto di ricevere dalla Madonna che si sporge verso di lei una catena d’oro. Santa Teresa, vissuta tra 1515 e 1582, ebbe un ruolo primario nella dell’ordine del Carmelo Scalzo. Ella fu anche particolarmente devota a San #Giuseppe, sposo di #Maria e suo protettore, contribuendo alla diffusione del culto del santo e alla sua rappresentazione nell’arte devozionale. L’episodio raffigura una visione mistica che Teresa aveva avuto il 15 agosto 1561, giorno dell’Assunzione, in cui la Madonna e Giuseppe comparivano insieme ponendole sulle spalle un manto bianco sfolgorante e al collo un ornamento d’oro con appesa una croce, segno dell’approvazione divina al suo progetto di fondazione di un monastero. [...] ".
-
>NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- UNA INDICAZIONE DA GIUBILEO DI PAPA FRANCESCO E UNA PREMESSA FONDAMENTALE A UN’ ANTROPOLOGIA ALL’ALTEZZA DEL "CANTICO DEI CANTICI".18 gennaio 2024, di Federico La Sala
"AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Ct. 8.6):
UNA INDICAZIONE DA GIUBILEO DI PAPA FRANCESCO E UNA PREMESSA FONDAMENTALE A UN’ ANTROPOLOGIA ALL’ALTEZZA DEL "CANTICO DEI CANTICI" (Ct. 8.6).
- "Il Papa, il sesso è dono di Dio e la castità non è astinenza: [...] nella catechesi dedicata al vizio della lussuria.
 Il Papa ha parlato anche della castità che "non va confusa con l’astinenza sessuale". E’ "la volontà di non possedere mai l’altro. Amare è rispettare l’altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un’anima che non sono i nostri, e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori". "Amare è bello", ha sottolineato Papa Francesco. Ma talvolta l’innamoramento "viene deturpato dal demone della lussuria, e questo vizio è particolarmente odioso, almeno per due motivi. Anzitutto perché devasta le relazioni tra le persone. Per documentare una realtà del genere è sufficiente purtroppo la cronaca di tutti giorni. Quante relazioni iniziate nel migliore dei modi si sono poi mutate in relazioni tossiche, di possesso dell’altro, prive di rispetto e del senso del limite?".
Il Papa ha parlato anche della castità che "non va confusa con l’astinenza sessuale". E’ "la volontà di non possedere mai l’altro. Amare è rispettare l’altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un’anima che non sono i nostri, e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori". "Amare è bello", ha sottolineato Papa Francesco. Ma talvolta l’innamoramento "viene deturpato dal demone della lussuria, e questo vizio è particolarmente odioso, almeno per due motivi. Anzitutto perché devasta le relazioni tra le persone. Per documentare una realtà del genere è sufficiente purtroppo la cronaca di tutti giorni. Quante relazioni iniziate nel migliore dei modi si sono poi mutate in relazioni tossiche, di possesso dell’altro, prive di rispetto e del senso del limite?". - Il Pontefice infine ha citato il Cantico dei Cantici, un libro della Bibbia, per ribadire che "nel cristianesimo non c’è una condanna dell’istinto sessuale". (ANSA
AMORE (#CHARITAS) E CASTITA’. L’’indicazione è premessa fondamentale al #riconoscimento giuridico e teologico dei "#dueSoli" (#DanteAlighieri), della #maternità piena di "#Maria" e della #paternità piena di "#Giuseppe" e alla ricostituzione della "FAMIGLIA" umana e divina: al di là del "giocastolaio" #incesto edipico (#SigmundFreud e #ThomasMann), la riconsiderazione (al di là delle pretese imperial-costantiniane e tebane di #SistoIV e di #GiulioII della Rovere) e la riaffermazione antropologica e "cosmicomica" della Relazione d’#Amore ("Charitas") tra #MariaeGiuseppe e #Gesù.
ARTE E "PROPAGANDA FIDE": #TONDODONI. Attenzione: nella cornice "raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti" (Galleria degli Uffizi)? Ma, per Michelangelo, non erano e non sono due #profeti e due #sibille?!
COSMOLOGIA, ANTROPOLOGIA (E #CRISTOLOGIA), E #PSICOANALISI. Con la ripresa dello spirito di Francesco di Assisi, di Giotto, e di Dante Alghieri, e la memoria del "Cantico dei cantici", a mio parere, è possibile comprendere "#Chiara-mente" che le radici della Terra non sono tragico-edipiche, ma "#Cosmicomiche" (come da lezione di Italo Calvino, Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 - Siena, 19 settembre 1985).
- "Il Papa, il sesso è dono di Dio e la castità non è astinenza: [...] nella catechesi dedicata al vizio della lussuria.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- NASCERE E RINASCERE: "NATO DA DONNA, SOTTO LA LEGGE", MA DI QUALE LEGGE?!14 dicembre 2023, di Federico La Sala
NASCERE E RINASCERE: "NATO DA DONNA, SOTTO LA LEGGE", MA DI QUALE LEGGE?!
Ancora quella della tradizione tragica e del paolinismo?
ANTROPOLOGIA FILOLOGIA PREISTORIA, E PSICOANALISI: USCIRE DAL LETARGO E DALL’INFERNO (Dante, Par. XXXIII, 94).
COME NASCONO I BAMBINI, COME NASCONO I GENITORI - OGGI?! Una nota a margine dell’anno dell’Incarnazione del Natale 2023 - e del Presepe di Greccio di Francesco di Assisi dell’anno 1223.
- Due "citazioni" dalle "Lettere" di Paolo di Tarso, sul tema:
- A) «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare coloro che erano sotto la Legge, perché noi ricevessimo l’adozione a figli» (Gal. 4, 4-5);
- B). "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
TRAGEDIA. La difficoltà di "aprire gli occhi" (Freud) sul #fatto antropologico (#Kant) e sociologico (#Marx) che ogni essere umano nasce ed è nato da un essere umano donna ("nato da donna, sotto la Legge"), dice solo della profondità "oceanica" della follia planetaria e della più che millenaria caduta "cosmologica" nell’orizzonte tragico della ragione e religione della cosmoteandria atea (platonico-aristotelica) e devota (paolina)!
COMMEDIA. Non è il caso di rimeditare il significato dell’art. 3 della sana e robusta Costituzione della Repubblica italiana e riprendere il cammino alla luce del Sole e dei "due Soli" (Dante Alighieri)?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- EMERGENZA CULTURALE E SOCIALE. La crisi della matematica è un problema politico: un’ipoteca sui cittadini del futuro (di Raffaele Cariati).1 dicembre 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, EDUCAZIONE CIVICA, E PSICOANALISI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA: UNA QUESTION HAMLETICA E UNA DOMANDA AI MATEMATICI E ALLE MATEMATICHE.
- Come "è stata possibile un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti e uscire dall’orizzonte della tragedia e dall’infernale letargo antropologico ed epistemologico (Dante Alighieri, Par. XXXIII, 94)?!
La crisi della matematica è un problema politico: un’ipoteca sui cittadini del futuro
di RAFFAELE CARIATI (Domani, editoriale, 27 novembre 2023)
- Sia in Francia che in Italia si è parlato negli ultimi anni di “emergenza matematica”, ma le soluzioni per affrontarla sono state inadeguate e miopi. Il sapere matematico non si può ridurre a “fare calcoli” ma cambia il modo in cui capiamo e interpretiamo il mondo
In Francia nel 2019 succede questo: «Emergenza matematica repubblicana», dichiara Emmanuel Macron durante il suo primo quinquennio di presidenza in Francia, riconoscendo il problema dell’esclusione dall’insegnamento-apprendimento della matematica. L’esclusione dall’apprendimento della matematica ha un impatto sulla fiducia in sé stessi, induce senso di inadeguatezza, porta i cittadini a delegare sui ragionamenti complessi e a preferire le semplificazioni e le diffidenze ostacolando la formazione di una cittadinanza consapevole.
Il governo francese di Emmanuel Macron pensa di governare centralmente il problema, di migliorare le sorti dell’apprendimento della matematica e di affidarne la soluzione a uno dei nomi più prestigiosi della matematica, Cedric Villani (medaglia Fields 2010, deputato della Repubblica). Il risultato è il “Rapporto Villani” che propone ventuno “misure”, senza però suscitare grandi entusiasmi: tanti buoni propositi, ma una visione elitaria ha iniziato a farsi strada. Infatti, la riforma dei licei à la carte voluta da Jean-Michel Blanquer, ministro dell’Educazione Nazionale, ha come conseguenza la significativa diminuzione della partecipazione all’insegnamento della matematica.
La matematica non fa più parte delle materie insegnate a tutti gli studenti, può essere scelta solo come materia di indirizzo possedendo certi requisiti di ingresso. Il risultato è l’abbandono dello studio della disciplina, gli studenti dal primo all’ultimo anno del liceo perdono il 20% delle ore di insegnamento della matematica. Le intenzioni di Macron si rovesciano nel loro contrario. ll quotidiano Libération denuncia: «È uno scandalo che non scandalizza nessuno». E Le Monde aggiunge: la riforma ha fatto scendere dal 90% al 59% la percentuale di alunni che seguono un insegnamento di matematica durante l’ultimo anno. Ancora più grave: l’abbandono coinvolge in maniera maggioritaria le studentesse.
Questa breve storia triste si conclude con il riconoscimento da parte di Jean-Michel Blanquer di un errore di calcolo e con il tentativo del suo successore, Pap Ndaye, di invertire la tendenza introducendo un’ora e mezza di matematica nel tronco comune.
Qualcosa di simile avviene anche in Italia. Molti hanno dimenticato che una “emergenza matematica” è stata dichiarata anche nel nostro Paese, e che è si è tentato di gestirla con un metodo molto simile alla strategia Villani. Nel 2007 Giuseppe Fioroni, ministro dell’Istruzione, insedia il Comitato nazionale dei Matematici con il compito di definire le iniziative per contrastare quella che definisce, appunto, “emergenza matematica”. L’opinione pubblica è stata investita da semplificazioni e slogan del tipo «matematica bestia nera degli italiani», «italiani asini in matematica», alimentando le forme più feroci di innatismo, impotenza appresa.
La matematica, dunque, è un problema di tutti. Il Comitato, costituito da trenta esperti e presieduto dall’altissimo profilo di Edoardo Vesentini, rettore della Normale di Pisa, già senatore della Repubblica, studia il problema e indica cosa fare. Ma purtroppo il comitato non va avanti, a causa di un’incapacità collettiva. Resta un’occasione persa insieme alla questione: cosa vuol dire politicamente l’emergenza matematica?
Il tema è stato ben argomentato da Martine Quinio-Benamo nell’articolo “Les mathématiques, c’est politique” apparso su Libération nel febbraio 2022: per fare matematica non si tratta solo di calcolare e ragionare, ma anche di distinguere i punti di vista e di comunicare.
Per esempio: «Dall’inizio del quinquennio di governo Macron il potere di acquisto dei più ricchi è aumentato del 4,1% ed è diminuito dello 0,5% quello dei più poveri. Il potere di acquisto è aumentato in media dell’1,6%». La conclusione sull’aumento medio dell’1,6% è stata ripresa con enfasi dai decisori della comunicazione mass-mediatica, ma si riferisce a una media impossibile da verificare in quanto non riflette l’aumento delle disuguaglianze. Pur supponendo che il potere di acquisto sia aumentato in percentuale (il che è falso per i più poveri), un aumento debole di una o due percentuali si traduce in un incremento salariale bassissimo per le classi medie.
Il tema insomma è l’assenza della formazione a un pensiero-atteggiamento matematico.
I giornali spesso non sono in grado di esaminare i dati numerici avanzati dai politici. E le informazioni che contengono dati numerici corretti possono essere smentite da interlocutori mal formati al ragionamento matematico. Il piano del dibattito diventa «Ci mentono tutti!». Ovviamente, non sono i numeri a mentire, ma una loro interpretazione pigra e decontestualizzata. Secondo la professoressa Quinio-Benamo, si fa strada l’ipotesi per cui «l’incompetenza scientifica prevale sulle cattive intenzioni», e se le decisioni sono assunte anche in nome della realtà e dell’interpretazione dei numeri, allora la matematica è politica e il suo insegnamento-apprendimento è una questione politica.
La matematica è quindi politica nella misura in cui si cerca di rispondere alla domanda: cosa può fare la matematica nella nostra comprensione del mondo? Potrebbe essere “fare politica” gestire l’emergenza matematica non focalizzandosi solo sulle abilità matematiche in chiave professionalizzante, ma anche e soprattutto sul processo educativo che stimoli ad assumere un atteggiamento filosofico che supporti la trasformazione delle informazioni in conoscenze e nella capacità emancipatrice di operare scelte.
In Italia la questione è stata ampiamente affrontata da Bruno D’Amore (professore di Didattica della matematica all’Università di Bologna) che definisce l’educazione matematica come «il sistema sociale complesso ed eterogeneo che, in sinergia con l’epistemologia, la sociologia, la psicologia, la semiotica e la pedagogia include la teoria e lo sviluppo e la pratica relativa all’insegnamento-apprendimento della matematica ed include la didattica della matematica come sottosistema».
L’insegnamento-apprendimento della matematica sembra essere in uno stato di crisi cronica, ma il vero problema non è l’insegnare ad insegnare. All’origine di questo fenomeno ci sono molteplici cause, ma il problema ha a che fare con il ruolo che la matematica recita nella società e la sua influenza sul dibattito pedagogico.
Possiamo allora rovesciare la questione: Guy Brousseau nella Théorie des situations didactiques e la teoria del Contrat didactique analizza cosa determini un mancato apprendimento, studia il fallimento elettivo in matematica determinato dalle abitudini specifiche dell’insegnante attese dall’allievo e i comportamenti dell’allievo attesi dal docente. Queste attese sono dovute a una concezione della scuola percepita come direttiva ed essenzialmente valutativa: anche situazioni didattiche proposte come “libere” vengono elaborate e vissute dall’allievo come un test o come un controllo. Queste attese nascono da concezioni sulla matematica (“in matematica bisogna fare solo calcoli”) e soprattutto alla ripetizione di modalità sociali.
Perdiamo “il corpo umano della matematica”! A causa del “si devono fare i calcoli”, si ritiene che le parole non siano importanti, sia sufficiente usare i dati numerici, anche a caso, per fornire risposte formali. Si perde l’obiettivo culturale della matematica, si smarrisce l’agire matematico che si confonde con le richieste degli insegnanti. Soprattutto: l’unica occasione che hanno gli studenti di entrare in contatto con la matematica è la scuola. Ciò alimenta la credenza diffusa secondo la quale i libri di matematica sono le raccolte stereotipate di esercizi presenti nei libri di testo scolastici.
Secondo Bruno D’Amore, «tutto risale all’ignoranza beota di chi distingue le culture creandone una di serie A e una di serie B, facendosi forza talvolta con lo spirito e le parole di Giovanni Gentile secondo cui l’intrusione delle scienze nel mondo scolastico ha arrecato dannosissimi frutti e la matematica, in particolare, è morta, infeconda, arida come un sasso». Come si può contrastare l’accanimento anti-matematico di matrice gentiliana?
Nel testo Faire l’école, faire la classe, il pedagogista Philippe Meirieu delinea lucidamente un principio su cui istituire la scuola che curi l’educazione matematica: «Per poter costruire uno spazio pubblico orientato alla trasmissione delle conoscenze, la scuola deve sospendere violenza e seduzione, collocando al centro della propria organizzazione le esigenze di esattezza, precisione e verità».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL "PATRIARCATO", IL "COMPROMESSO DORICO" DELLA RAGIONE OLIMPICA, E IL PAOLINISMO.29 novembre 2023, di Federico La Sala
LA TRAGEDIA DEL CD. "PATRIARCATO", OVVERO IL "COMPROMESSO DORICO" DELLA RAGIONE OLIMPICA (ELEUSIS2023).
Una nota a margine della "metafisica concreta" dell’Occidente... *
DOTTA IGNORANZA (CUSANO,1440) CONTRO FILOLOGIA (LORENZO VALLA, 1440):#COME NASCONO I BAMBINI...
- PAROLA DI APOLLO: «[...] non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (ESCHILO, "Orestea")).
- PAROLA DELL’ANDROLOGIA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)
- PAROLA Di FINE SECOLO XX d. C.: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
STORIA #STORIOGRAFIA E #ANTROPOLOGIA. MASSIMO #CACCIARI, a mio parere, sta ancora a difendere, il #compromesso "dorico" della #tragedia tebana di #Giocasta ed #Edipo (e della #caduta biblica): con tutta la stima nei suoi confronti personali, ma la logica della sua metafisica concreta resta tutta dentro l’orizzonte del #paolinismo e della #cosmoteandria atea e devota! (Nicea, 325-2025).
#DANTE2021 #BOVILLUS #COSMICOMICHE (#calvino100)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- FEMMINISMO E PSICOANALISI: "DUE SGUARDI, COMPRESENTI INSEPARABILI, DELLA SUA VITA" E "UN LIBRO ERETICO": «LA PORTA DELLE MADRI» DI MANUELA FRAIRE (di Caterina Venturini).18 novembre 2023, di Federico La Sala
CULTURA
Dentro la relazione dei corpi, tra pratiche e femminismo
- SCAFFALE. «La porta delle madri», l’ultimo libro della psicoanalista Manuela Fraire edito da Cronopio
di Caterina Venturini (il manifesto, 27 settembre 2023)
- [fOTO] Pablo Picasso, «Femme couché e lisant» (1939)
In un momento in cui il dibattito pubblico del nostro Paese, seguendo una tensione diffusa in Occidente, si è polarizzato su opinioni dogmatiche inconciliabili, soprattutto per quanto riguarda le grandi questioni etico-politiche conseguenti al non più ovvio legame tra madre, materno e femminile, esce un libro che partendo da posizioni consolidate non teme di interrogarne i nodi problematici, dovuti alle contraddizioni dei corpi, del desiderio e delle nostre identità sessuali sempre in mutamento.
In una parola: è appena uscito un libro eretico, La porta delle madri (Cronopio, pp. 146, euro 13) e lo ha scritto una grande psicoanalista femminista, Manuela Fraire, che potendo contare su due esperienze di vita ugualmente dense e importanti, una lunga militanza nel femminismo a partire dai gruppi di autocoscienza degli anni 70, e una professione analitica ricca di decenni, non ha avuto esitazione a unire questi due sguardi, compresenti e inseparabili, della sua vita. Sguardi che da sempre la interrogano sui limiti di alcune posizioni dell’una e dell’altra parte, un ancora eccessivo binarismo della psicoanalisi e il pericolo della desessualizzazione dei corpi in funzione del genere dell’ultimo femminismo, spingendola a scrivere quello che a tutti gli effetti si rivela un pamphlet di intenso ragionamento che non solo intreccia fili ed esperienze, ma rilegge anche i propri interventi del passato alla luce dell’attuale.
GIÀ IN UN CONTRIBUTO del 98, Fraire si opponeva «alla maternità come naturale e auspicabile meta della femminilità» credendo «che una decostruzione del paradigma materno da parte delle donne giocava in favore della libertà sia femminile che maschile». All’epoca non si parlava ancora di Gpa (Gestazione per altri) ma a una certa parte di femminismo, che pure aveva attraversato teorie e pratiche della differenza sessuale, era già chiaro come la procreazione non dovesse avere necessariamente come esito la maternità, e come la donna dovesse disgiungersi dalla madre.
Cosa resta allora di quell’enigma del materno che non può che cominciare con Freud, che nel 1932 scrisse che il dottor Breuer cinquant’anni prima aveva in mano la chiave della porta delle madri, ma la lasciò cadere, facendo intendere che quella chiave avrebbe voluto prenderla in mano lui, eppure - ci mostra Fraire - quella chiave non aprirà la porta delle madri fino al nostro secolo quando il femminismo da una parte, la psicoanalisi postfreudiana dall’altra e le nuove famiglie poi, schiuderanno nuovi scenari. Tramontata la famiglia edipica di madre-padre-figlio, c’è stata una riorganizzazione dei ruoli ancora in atto in cui prevalgono come elementi di novità, famiglie monogenitoriali o con due persone dello stesso sesso o in transizione, o che non hanno scelto nessuno dei due. Di questa genitorialità non binaria, non identificata né con un materno né con un paterno, ha senso occuparsi oggi per farsi domande che superino la questione di genere e tornino a occuparsi dei corpi (tutti) dal punto di vista di un sessuale che viene prima di qualsiasi attribuzione.
Tanto più che risulta ormai chiaro che la pulsione dell’infans proviene dalle fantasie che l’adulto (uomo o donna che sia) immette inconsapevolmente nelle cure primarie: fantasie non più asessuali, come voleva Freud ma che contengono la storia sessuale che l’adulto porta con sé (Laplance).
E allora dov’è la differenza tra madri e padri dal momento che chi viene al mondo riconosce molto presto voci diverse e non è solo in simbiosi con la madre? Piera Aulagnier, sempre citata da Fraire, dice che la nascita psichica di un bambino è frutto dell’incontro tra il discorso che gli/le è indirizzato e l’effetto che questo discorso ha sul suo essere/corpo, portando al centro della questione la reale differenza che è quella tra sessuale animale e sessuale umano: ossia il linguaggio che rende la madre biologica sostituibile.
«MADRI SI DIVENTA - dice Fraire - se lo si desidera, a separazione avvenuta tra feto e gestante: la maternità non è legata al corpo più di quanto non lo sia al linguaggio». Parole molto importanti che arrivano dritte al cuore di una questione in cui l’unica differenza tra maschile e femminile risulta, ancora al momento, nel fatto che solo all’interno del corpo delle donne avviene la creazione del vivente. Non a caso, ricorda Fraire, la più grande rivoluzione le donne l’hanno fatta con la depenalizzazione dell’aborto quando hanno affermato una signoria sul loro desiderio di procreare.
Legittimare questa pratica ha portato alla vera liberazione del loro desiderio di maternità, non più vissuta come un destino. Disgiungere definitivamente il femminile dal materno, ha dato anche agli uomini la possibilità di partecipare attivamente alla cura senza necessariamente la supervisione di una donna. Semmai, avverte Fraire, c’è ancora da capire le conseguenze che avrà sull’uomo un’esperienza che implica la totale dipendenza del, e dall’altro, cosa a cui la donna è allenata da secoli.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA. AGOSTINO, PASCAL, HEIDEGGER, SCHELER, E HANNAH ARENDT: UNA FILOSOFICA QUESTIONE D’AMORE (CHARITAS).17 novembre 2023, di Federico La Sala
STORIA DELLA CULTURA EUROPEA:
- FILOLOGIA ARCHEOLOGIA PSICOANALISI ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA.
UNA FILOSOFICA QUESTIONE D’AMORE (CHARITAS).
Una nota sul "disagio della civiltà" (e nella civiltà).
Hannah Arendt, sul "concetto d’#amore in Agostino" (1929), titola il cap. 2 della Parte Prima ("Amor qua appetitus") e della Parte Seconda ("Creator - Creatura"): "Caritas e cupiditas"; ma il Dottore della #Grazia ("Charis") non scrive "Ecce unde incipit Charitas"?
Martin Heidegger, in "Essere e Tempo" (1927), a proposito di Max "Scheler, sotto l’influenza di Agostino e di Pascal", ricorda la frase del’uno e dell’altro, e, cita in nota: "Non intratur in veritatem nisi per charitatem"; "n’entre dans la vérité que par la charité" ("Non si entra nella verità se non con la carità"). Che fare?!
Amore (Charitas") o Mammona ("Caritas"): "Essere, o non essere" (Shakespeare, "Amleto": III,1). Sul "Deus caritas est" non è forse ora di fare chiarezza (claritas)? O, per assurdo, l’amore è "lo zimbello del Tempo" (Shakespeare, Sonetto 116)?!
Non è bene ricordare, filologicamente, che "in principio era il Logos"?! Se non ora, quando?!
*
a) Cfr. Hannah Arendt, "Il concetto d’amore in Agostino", a c. di Laura Boella, SE, 2021.
b) Cfr. Max Scheler, "Ordo amoris", Morcelliana, Brescia.
c) Cfr. S. Freud, "Disagio della civiltà, Bollati Boringhieri, Torino.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA AMLETICA "QUESTION" E UN "PREISTORICO" SIMPOSIO ALL’OMBRA DELLA "EU+CARESTIA"31 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’UMANITÀ (ANTROPOLOGIA), IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE" (ECONOMIA POLITICA) E IL PERSISTERE DI UN "PREISTORICO" SIMPOSIO ALL’OMBRA DELLA "EU+CARESTIA"!!!
- UNA NOTA SU UNA AMLETICA "QUESTION" DI LUNGA DURATA DI FILOLOGIA E TEOLOGIA...
MINIMALISMO ED ESSENZIALISMO: "SÀPERE AUDE" (DECIDERSI A DIVENTARE SAGGIO, AD AS-SAGGIARE, A USCIRE DALLO "STATO DI MINORITÀ" (ORAZIO E KANT). A ben riflettere sulla "essenza del cristianesimo" di Ludwig Feuerbach, e, al contempo, sul problema della "eucharistia", del cibarsi della grazia ("charis") di Dio ("charitas"), forse, si può meglio cominciare a capire la profondità teologico-politica ed economica della sua "banalizzatissima" considerazione che «L’uomo è ciò che mangia»!
IN UN TESTO BRILLANTISSIMO, all’interno di un "presente storico" di secoli, segnato da una grande carestia filologica e logica, così è scritto: "La vita spirituale - di chi «nasce un seconda volta» aderendo a Cristo - poggia sulla preghiera continua e sull’#eucarestia [...]" (cfr. Flavio Piero Cuniberto, "SUL CRISTIANESIMO COME MITO E COME MISTERO). E, proseguendo; si arriva a fare propria la tesi di #RenéGirard: "L’idea che la morte di Cristo sulla croce sia il prezzo del riscatto («redenzione» da «red-imere», «riscattare») non è che una versione cristianizzata della pratica ancestrale del #bouc #émissaire, il #caproespiatorio di Girard. Una versione mitologica del mistero cristiano." (op. cit.).
IL CANTO DEL CAPRO E LA FENOMENOLOGIA DELLA TRAGEDIA: "ECCE HOMO" (PILATO). Accecati dall’astuzia della ragione platonico-hegeliana, invece di fare chiarezza sul "capro espiatorio", si rinnova la confusione e la condanna a morte proprio dell’agnello (dell’#ariete, del montone) che ha portato Ulisse (e Dante) in salvo, fuori dalla caverna e dall’inferno!
 Dopo Nietzsche ("Ecce Homo", 1888), che ha denunciato l’imbroglio storico-antropologico del #paolinismo, a partire dalla morte di Dio, e di Gesù ("Ecce Homo"), chi ha mai più visto sulla Terra un cristiano, una cristiana?
Dopo Nietzsche ("Ecce Homo", 1888), che ha denunciato l’imbroglio storico-antropologico del #paolinismo, a partire dalla morte di Dio, e di Gesù ("Ecce Homo"), chi ha mai più visto sulla Terra un cristiano, una cristiana?
 Nonostante Gioacchino da Fiore, Francesco d’Assisi, Chiara di Assisi, Dante Alighieri, e, addirittura, il lavoro iperstorico ("preistorico" e archeologico) sulle radici "Cosmicomiche" della Terra (Italo Calvino), Diogene di Sinope, definito dalla tradizione "Socrate pazzo", continua ad andare con la sua lanterna accesa, alla luce del sole, per i mercati, a cercare l’uomo ("anthropos") e a sognare il #sorgeredellaterra...
Nonostante Gioacchino da Fiore, Francesco d’Assisi, Chiara di Assisi, Dante Alighieri, e, addirittura, il lavoro iperstorico ("preistorico" e archeologico) sulle radici "Cosmicomiche" della Terra (Italo Calvino), Diogene di Sinope, definito dalla tradizione "Socrate pazzo", continua ad andare con la sua lanterna accesa, alla luce del sole, per i mercati, a cercare l’uomo ("anthropos") e a sognare il #sorgeredellaterra... -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- IL PROBLEMA DEL “MODELLO PATRIARCALE” E L’ITALIA DEL "BENTORNATO MASCHIO" (DI GIANFRANCO pELLEGRINO).29 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’ AMLETICA “QUESTION” DI ELISABETTA I (REGINA D’INGHILTERRA E PAPA DELLA CHIESA ANGLICANA), LA LEZIONE SULLA “VISIBILITA” (“VISIBILITY”) DI ITALO CALVINO, E IL PROBLEMA DEL “MODELLO PATRIARCALE”.
- “C’è un verso di Dante nel Purgatorio (XVII, 25) che dice: «poi piovve dentro a l’alta fantasia»”: una nota in memoria di “Sigismondo di Vindibona” (1856-1939) e di Italo Calvino (1923 -1985). *
A MARGINE E A PROPOSITO DELL’ “USO PERSUASIVO E PROPAGANDISTICO DELLA FAMIGLIA” (DEL “PRESEPE”) E DEGLI ANTROPOMORFISMI MESSI IN LUCE NELLA RIFLESSIONE SUL “BENTORNATO MASCHIO” (Gianfranco Pellegrino, "Le parole e le cose", 26 ottobre 2023), FORSE, non sarebbe male se la sollecitazione a riflettere venisse accolta soprattutto dalle antropologhe, dalle filosofe, dalle psicoanaliste, e dalle teologhe:
- “Alcune autrici hanno proposto una definizione sociale delle donne. Per loro, essere donna significa occupare una specifica posizione sociale, e essere trattate in certi modi, subire certe reazioni, e così via. [...] Semplificando, in questo tipo di visioni, essere una donna o un uomo è un fatto di potere. Sei donna se subisci un certo tipo di potere, quello patriarcale, sei uomo se non lo subisci e lo eserciti.
 L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
 la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
*
VISTO CHE il “modello patriarcale” come strumento di analisi fa acqua da tutte le parti, almeno dal tempo della “dialettica” di Hegel, e, ancor di più, dopo Freud e la sua indicazione a muoversi ad usare il “modello edipico completo”, è più che augurabile fare qualche passo avanti teorico e pensare a un modello “patriarcale-matriarcale” (padrone-serva e padrona-servo), alla luce delle “Lezioni americane” (non solo la quarta, la “Visibilità”) e del “Castello dei destini incrociati” (in particolare, del capitolo della seconda parte, “La taverna dei destini incrociati”, col titolo “Anch’io cerco di dire la mia”).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. - LETTERATURA E PSICOANALISI: “IL CASTELLO DEI #DESTINI INCROCIATI” (ITALO CALVINO). L’INCONTRO CON “SIGISMONDO DI VINDIBONA” [VIENNA] NELLA “TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI”. Una “presentazione” del mito di Edipo con le carte dei Tarocchi:
“ANCH’IO CERCO DI DIRE LA MIA. [...] Tutto questo è come un sogno che la parola porta in sé e che passando attraverso chi scrive si libera e lo libera. Nella scrittura ciò che parla è il represso. E allora Il Papa dalla barba bianca potrebbe essere il gran pastore d’anime e interprete di sogni Sigismondo di Vindobona, e per averne conferma non c’è che verificare se da qualche parte del quadrato dei tarocchi si riesce a leggere la storia che, a quanto insegna la sua dottrina, si nasconde nell’ordito di tutte le storie. [...]” (cfr. I. Calvino, “Anch’io cerco di dire la mia”, “Romanzi e racconti” II, Meridiani, Mondadori, 1992, pp. 592-595).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. 2 - ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, MATEMATICA, E FILOLOGIA...
“Bentornato maschio”( v. sopra) non è solo una chiamata in causa di intellettuali di ogni genere e di ogni specie, ma anche, e prima di tutto, è un segnavia “storico” per ogni cittadino e ogni cittadina per dare alla amletica “question” teologico-politica posta da Shakespeare, in stretto collegamento alla presenza sul trono d’Inghilterra di Elisabetta I, regina e papessa della Chiesa anglicana, una propria risposta all’altezza dell’attuale “presente storico” - è una chiamata ad uscire dall’epocale “stato di minorità”, personale e politico (Immanuel Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984) !
“DUE SOLI” (DANTE ALIGHIERI). Re-interrogarsi alla Kantorowicz sulla “regalità antropocentrica: Dante”, sui “due corpi del re” e, ovviamente, anche sui “due corpi della regina”, forse, può essere una buona occasione per svegliarsi dal sonno dogmatico e portarsi fuori dalla cosmoteandria, atea e devota! Se non ora, quando?!
QUESTIONE MATEMATICA E ANTROPOLOGICA. Per approfondimenti, volendo accogliere alcune indicazioni sul tema, si potrebbe ricominciare a contare da almeno da due o, meglio da “Quattro”, dal poema di Italo Testa (“Le parole e le cose”, 3 Settembre 2021).
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UN’ANTROPOLOGIA CRISTOCENTRICA (NON ANDROCENTRICA). Sul «perché non possiamo non dirci "cristiani"» di Giovanni Paolo II, una testimonianza di Gv. Battista Re (L’Osservatore Romano).20 ottobre 2023, di Federico La Sala
PER UN’ANTROPOLOGIA E UNA TEOLOGIA CRISTIANA, OLTRE L’ANDROCENTRISMO PAOLINO E LA COSMOTEANDRIA "CATTOLICO-COSTANTINIANA" (NICEA 325-2025) *
Il 16 ottobre di 45 anni fa l’elezione di san Giovanni Paolo II
Ha insegnato a non aver paura di dirsi cristiani
[di Giovanni Battista Re (L’Osservatore Romano, 16 ottobre 2023
Il 16 ottobre di 45 anni fa, ero sulla terrazza della Segreteria di Stato quando il cardinale Pericle Felici, dopo la fumata bianca, annunciò il nome del nuovo Papa: Karol Wojtyła. Monsignor Agostino Casaroli (divenuto cardinale l’anno dopo), che era lì con noi, commentò: «Che coraggio hanno avuto i cardinali, scegliendo un arcivescovo di un Paese oltre la “cortina di ferro”! Che coraggio!».
Circondammo tutti monsignor Casaroli, facendogli domande, mentre aspettavamo che il nuovo Papa si affacciasse al balcone della basilica Vaticana.
Ci rispose: è una personalità forte e affascinante per le tante sue doti, ma mai avevo pensato all’eventualità che il nuovo Papa potesse venire da oltre la “cortina di ferro”.
A 45 anni di distanza, il lungo pontificato di Giovanni Paolo II colpisce per la vastità e la grandiosità delle opere realizzate, per il grande numero di eventi e di iniziative, per il consenso ottenuto e per ciò che la sua guida spirituale e morale ha rappresentato per oltre un quarto di secolo.
Papa Wojtyła tuttavia ha stupito non solo per quello che ha fatto, ma anche per l’amore che lo animava e il desiderio che aveva di aiutare tutti nella ricerca di Dio e nel far crescere nel mondo il rispetto dei diritti umani, la fraternità e la solidarietà.
San Giovanni Paolo II è stato una personalità fuori dall’ordinario, un Papa che si è inserito nel solco della tradizione della Chiesa con un innegabile timbro di novità, ma anche di piena fedeltà alla dottrina che viene dagli apostoli.
Non possiamo non riconoscere che la Divina Provvidenza gli ha assegnato grandi compiti nella storia mondiale del suo tempo.
- Uomo di Dio
San Giovanni Paolo II è stato innanzi tutto un grande uomo di Dio, animato da una fede incrollabile.
La prima e fondamentale dimensione del suo pontificato è stata quella religiosa. Il movente dell’intero suo pontificato, il centro ispiratore dei suoi pensieri e di tutte le sue iniziative è stato di natura religiosa: tutti gli sforzi del Papa miravano ad avvicinare gli uomini a Dio e a fare rientrare Dio da protagonista in questo mondo. Voleva che in questo nostro mondo vi fosse ancora posto per Dio.
Il vibrante appello pronunciato nella sua prima celebrazione eucaristica in piazza San Pietro: «Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo», esprimeva bene la linea ispiratrice e il programma di tutto il suo pontificato. Quelle parole manifestavano l’ansia apostolica che lo avrebbe spinto sulle strade del mondo, incontro a popoli di ogni cultura e di ogni razza per annunciare a tutti che solo in Dio, che in Cristo si è fatto a noi vicino, l’umanità può trovare la vera salvezza.
Questa verità egli l’ha proclamata con fedeltà e con un coraggio che nemmeno le due pallottole sparategli contro il 13 maggio 1981 riuscirono a indebolire o a scalfire.
La grandezza del suo lungo pontificato sta soprattutto nell’avere risvegliato nel mondo il senso religioso. Nella società secolarizzata del suo tempo, egli ha aiutato i cristiani a liberarsi dai falsi sensi di inferiorità nei confronti della cultura laicista dominante, e a non avere timore ad essere e a dirsi cristiani. Instancabile fu il suo richiamo a ritornare a Dio, rivolto ad una società che in Occidente lo stava dimenticando e che oltre la “cortina di ferro” lo combatteva.
Ha fatto capire che non si possono limitare a questa terra gli orizzonti di noi, uomini e donne. Ha insegnato che la coscienza, «in cui l’uomo si trova solo con Dio e scopre una legge scritta nel cuore» (Gaudium et spes, 16), conferisce un’altissima dignità all’uomo e alla donna ed ha esortato a rinnovare la società facendole ritrovare la forza del messaggio di Cristo (Cfr. Insegnamenti 1986, i, p. 1379).
Giovanni Paolo II ha avuto fiducia nella forza delle istanze spirituali e morali ed è stato un testimone di eccezionale statura anche per la sua limpida coerenza: in lui non esisteva frattura fra ciò che pensava e ciò che diceva; fra ciò in cui credeva e ciò che egli era. In lui vi era piena unità di fede e di vita.
- Difensore dei diritti umani
Oltre che uomo di Dio, Giovanni Paolo II è stato un appassionato difensore dell’uomo, della dignità, dei diritti e della libertà di ogni persona umana. Fu anche questo un tema caratterizzante il suo insegnamento, che ha aiutato molte persone a scoprire il senso etico della vita. Alla radice di questo impegno per l’uomo si staglia una chiara visione della dignità di ogni persona umana, «unica e irrepetibile», come soleva dire. Ogni attentato contro la dignità di qualsiasi essere umano è un’offesa a Dio, nostro Creatore. I diritti umani erano da lui proclamati e difesi come diritti che Dio ha posto nella natura umana. Si schierò sempre in difesa del carattere inviolabile della vita umana, dal primo istante del concepimento fino al naturale tramonto.
L’uomo e la donna erano da lui visti con gli occhi di Dio e amati col cuore di Dio. La sua era un’antropologia cristocentrica: la creatura umana trova il senso della sua vita al di sopra di sé; lo trova in Dio, che in Cristo si è fatto uomo.
- Uomo di preghiera
Lavorando vicino a Giovanni Paolo II, molte erano le cose che colpivano (impressionavano la sua sicurezza, le sue certezze, la capacità di parlare alle folle... la capacità di veder più lontano degli altri), ma ciò che mi ha sempre stupito di più è stata la profonda intensità della sua preghiera. Non si può comprendere Papa Giovanni Paolo II se si prescinde dal suo rapporto con Dio. È stato un grande uomo di preghiera, animato da una forte spiritualità cristocentrica e mariana. Aveva in sé una tensione spirituale e mistica inconfondibile ed è dalla preghiera che fluivano la sua sicurezza, l’assoluta padronanza di sé e la sua serenità in ogni circostanza.
Colpiva come si abbandonava alla preghiera: si notava in lui un totale coinvolgimento, che lo assorbiva come se non avesse avuto problemi e impegni urgenti che lo chiamavano alla vita attiva. Il suo atteggiamento era raccolto e insieme spontaneamente naturale.
Dal modo con cui pregava si avvertiva come l’unione con Dio era per lui respiro dell’anima e umile ascolto della voce di Dio.
Commuovevano la facilità e la prontezza con le quali passava dal contatto umano con la gente al raccoglimento del colloquio intimo con Dio. Aveva una grande capacità di concentrazione. Quando era raccolto in preghiera, quello che accadeva attorno a lui sembrava non toccarlo e non riguardarlo, tanto si immergeva nell’incontro con Dio.
Durante la giornata, il passaggio da un’occupazione all’altra era sempre segnato da una breve preghiera.
Maturava ogni scelta importante nella preghiera. Prima di ogni decisione significativa Giovanni Paolo II vi pregava sopra a lungo, a volte per più giorni. Sembrava che trattasse con Dio i vari problemi.
Nelle scelte di un certo peso non decideva mai subito. Ai suoi interlocutori che gli chiedevano o proponevano qualcosa, rispondeva che desiderava riflettere prima di dare risposta. In realtà, guadagnava tempo per ascoltare qualche parere, ma soprattutto intendeva pregare per ottenere luce dall’alto prima di decidere.
Ricordo un caso, negli anni in cui ero sostituto della Segreteria di Stato, in cui mi sembrò che il Papa fosse già decisamente a favore di una determinata difficile scelta. Gli chiesi pertanto se si potesse procedere a darne comunicazione. La risposta fu: «Aspettiamo, voglio pregare ancora un po’ prima di decidere».
Nelle decisioni il suo primo interesse era di operare davanti a Dio secondo verità, giustizia ed equità, e non se esse fossero popolari o no. Non gli mancò mai il coraggio necessario.
Quando si stava studiando un problema e non si riusciva a trovare una soluzione giusta e adeguata, il Papa concludeva dicendo: «Dobbiamo pregare ancora, perché il Signore ci venga in aiuto». Si affidava alla preghiera per trovare luce sulla strada da seguire.
Punto forte della sua spiritualità è stata la devozione alla Madonna: la dimensione mariana, espressa nel motto “Totus tuus”, ha contrassegnato l’intera sua esistenza. Era un’eredità lasciatagli dalla mamma scomparsa prematuramente, che poi ha approfondito e sviluppato accompagnato dal padre nel cammino di maturazione spirituale. Karol Wojtyła nacque il 18 maggio 1920, alcuni minuti dopo le ore 17, mentre nella chiesa parrocchiale, vicinissima a casa sua, era in corso la funzione mariana del mese di maggio. Appena il piccolo Karol era venuto alla luce, la mamma, sentendo il canto delle litanie lauretane che giungeva dalla chiesa, disse: «Aprite le finestre, perché voglio che le prime voci ed i primi suoni che il mio bambino ascolta siano i canti della Madonna».
Nel periodo in cui andava a lavorare alla cava di pietra e poi alla fabbrica Solvay, Karol Wojtyła lesse il libro di san Luigi Maria Grignion de Montfort Trattato della vera devozione a Maria, che gli era stato dato da un laico, Jan Tyranowski. Questi aveva creato in parrocchia un gruppo di 15 giovani, fra i quali Karol Wojtyła, che si impegnavano a recitare ognuno una decina del rosario al giorno.
Non è senza significato che due settimane dopo la sua elezione alla sede di Pietro, nel pomeriggio della prima domenica per lui libera, sia andato al santuario della Mentorella per pregare la Madonna, ma anche per parlare della preghiera, affermando che considerava suo primo compito come Papa quello di pregare per la Chiesa e per il mondo e desiderava che la preghiera fosse «il primo annuncio del Papa« (Omelia al santuario della Mentorella, «L’Osservatore Romano», 30-31 ottobre 1978).
La messa era per lui la realtà più alta, più importante e più sacra. In un incontro con i sacerdoti nel 1995 disse: «la messa è in modo assoluto il centro della mia vita e di ogni mia giornata». «Celebrare ogni giorno la messa è per me un bisogno del cuore».
Il mondo intero ha seguito gli ultimi giorni di Papa Giovanni Paolo II. Col suo esempio ci ha insegnato che la vita è un dono che va vissuto fino alla fine con fiducia in Dio e accettando con serenità i disagi della malattia. Ci ha indicato come si percorre il cammino verso il mistero che ci attende, quando anche per ciascuno di noi si apriranno le porte dell’eternità. È stato questo il suo ultimo insegnamento: un insegnamento da Papa.
di Giovanni Battista Re
 Decano del Collegio cardinalizio
Decano del Collegio cardinalizio
NOTA:
Carlo Wojtyla,
 AMORE E RESPONSABILITA’.
AMORE E RESPONSABILITA’.
 Morale sessuale e vita interpersonale,
Morale sessuale e vita interpersonale,
 Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)
Marietti,Casale Monferrato-Torino 1968 (II edizione 1978)fls
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- TERRA! TERRA! IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria".11 ottobre 2023, di Federico La SalaPIANETA TERRA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?, ANCORA, OGGI? AL GIOGO DELLA TERRA PROMESSA?
 TERRA! TERRA! IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria" (2005).
TERRA! TERRA! IL BRASILE DÀ UNA LEZIONE ALL’EUROPA E ALLE SUE RADICI. Una "memoria" (2005).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "DEMOCRAZIA, ULTIMO ATTO?" (CARLO GALLI): QUALI LE PAROLE DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE?6 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’#EUROPA (#GRANADA), #KOENIGSBERG / #KALININGRAD (E #ODESSA), LA "#DEMOCRAZIA" (COME "#STATO DI #MINORITÀ"), E IL PROBLEMA DELLA #TRASPARENZA TEOLOGICO-POLITICA. Alcuni appunti...
Un omaggio alla memoria di Dante Alighieri e William Shakespeare...
LA #TALPA E LA #CIVETTA: LA TRACCIA DI UNA FENOMENOLOGIA DELLO #SPIRITO DI "#DUE #IO" (DI #DUESOLI"). Già per #Shakespeare, ai suoi tempi (1600), Amleto e Ofelia (con il metodo della loro #follia) guardano ben oltre la linea dell’orizzonte teologico-politico di #Erasmo di Rotterdam e #TommasoMoro e lottano per portarsi fuori da un’Europa ormai avviatasi nella "marcia" del tramonto (#Nicea 325/2025).
LE PAROLE DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE. Al centro e al fondo della questione posta da #CarloGalli, nel recente "Democrazia, ultimo atto?"(cfr. estratto: https://www.einaudi.it/.../democrazia-ultimo-atto-carlo.../ ), al di là dei suoi contributi e risultati specifici, vi sono "le idee moderne di libertà, di uguaglianza, di trasparenza, che sono esposte alla contingenza (...) e che meritano ancora una volta di essere il centro intorno a cui ruota la politica".
"DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (#FREUD, 1929). Sul tema, nel suo commento, Francesco Fistetti accoglie con riserva la proposta di variazione e scrive: "[...] Al terzo termine del trinomio #libertà / #eguaglianza / #fraternità Galli sostituisce quello di "trasparenza". Trasparenza nell’accezione già di Bobbio che non devono esserci zone oscure e opacità nell’esercizio del potere e nel governo delle istituzioni, ma il sale della critica e del dibattito razionale. Ma in questo modo, cancellando la fraternità, può cassare senza colpo ferire tutta la storia del socialismo e della lotta per il socialismo come organici alla storia della modernità democratica e dello stesso liberalismo (il liberalsocialismo di un Rosselli e tanti altri). Operata questa amputazione "genealogica’ (almeno per la Modernità) resta una pallida e spettrale idea di liberaldemocrazia. Peraltro, quest’ultima viene declinata come l’ideologia e la pratica di quello che l’autore chiama il "secondo Occidente", quello degli Usa e delle istituzioni dell’Onu: un nuovo Occidente "a guida americana", di cui dalla fine della Seconda Guerra Mondiale "fa parte l’Europa" e la cui "espressione è la Nato" [...]"(cfr. https://www.facebook.com/francesco.fistetti.5/posts/10211262489754567).
"LA SOCIETÀ TRASPARENTE" (GIANNI VATTIMO, 1989), A mio parere, sulla trasparenza, un nodo decisivo legato al problema proprio di una "#societàtrasparente" (#GianniVattimo, 1989) , il dibattito è in alto mare ed è ancora tutto da affrontare, al suo livello antropologico-politico fondamentale, dalla radice (#Marx)!
QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("CRISTOLOGICA") E CULTURA CRITICA. La questione è "metafisica", ma, a quanto pare, nessuno si ricorda più di #Kant e del suo illumiNATO "sàpere".
#PACEPERPETUA, Se non si rende trasparente il nodo antropologico e teologico-politico, non è possibile (come è stato dimostrato storicamente, almeno fino ad oggi, fino alla "tappa" europea di Granada 1492/2023) alcuna fraternità (libertà e uguaglianza) e la "pace perpetua" (Kant) è definitivamente assicurata.
Nota:
#FILOSOFIA #STORIA E#METATEATRO: #METAFOROLOGIA.
"La #civetta e la #talpa. Sistema ed epoca in #Hegel" di #RemoBodei (1975, 2021): "[...] Quale il rapporto fra la civetta della filosofia, che interpreta coscientemente l’epoca, e la talpa dello spirito, che la trasforma inconsciamente con il suo cieco lavorio? A tali interrogativi Remo Bodei cerca una risposta in questo saggio ormai classico, che ha offerto una prospettiva originale della filosofia hegeliana." ( https://www.mulino.it/isbn/9788815291226 ).
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA NUOVA "FILOSOFIA DELL’AVVENIRE". Alcune note su "che cosa ha veramente detto GIANNI VATTIMO".22 settembre 2023, di Federico La Sala
IL SOGGETTO, LA MASCHERA, E LA SOCIETÀ TRASPARENTE.
Alcune note su "che cosa ha veramente detto GIANNI VATTIMO". *
AUTOIRONIA, "Auto-chiarificazione (filosofia critica)", e Charitas: queste poche parole, forse, possono essere dei segnavia per non perdersi l’essenziale (e, in qualche modo, per distinguere prima e unire poi, quanto ritenuto accoglibile) nel mare della ricchissima produzione culturale e professionale di Vattimo.
UNA NUOVA "FILOSOFIA DELL’AVVENIRE". "«L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve». Così Gianni Vattimo, scomparso il 19 settembre scorso, trasformò il celebre motto di Ludwig #Feuerbach, bevendo un calice di rosso della Sila. Di origini calabresi e fama mondiale, il filosofo torinese era autoironico, alleggeriva i discorsi, amava scherzare e porsi con umiltà." (cfr. Emiliano Antonino Morrone, "La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore", Corriere della Calabria, 22.09.2023).
Rimettendo storicamente e antropologicamente accanto all’ironia (della dialettica platonico-socratica), anche l’autoironia di Gianni Vattimo, forse, a omaggio delle sue "AVVENTURE DELLA DIFFERENZA" (1980)", in un mondo dove la lanterna è in mano ai #ciechi, è più che opportuno richiamare alla memoria la figura di Diogene di Sinope.
RIPARTIRE DALLA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA DELL’ATTUALE PRESENTE STORICO. Se nel "processo dell’avvento del valore di scambio come metro di misura totalizzante si nasconde il trionfo dell’homo oeconomicus e della tendenza all’illimitazione del capitalismo", e, ancora, come ricorda Francesco Fistetti, "il recupero del valore d’uso e di un progetto di demercificazione dei mondi vitali va reimpostato a quest’altezza ", come è possibile svegliarsi dal #sonnodogmatico (Kant)?
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. Come mi sembra di capire, non è proprio il caso di re-interrogarsi sul tema del "soggetto e della maschera" (Vattimo, 1974) e riprendere la indicazione kantiana del 1784 (riafferrata per i capelli, da #MichelFoucault nel 1984), della questione antropologica e ripartire dal "#sàpereaude!", "dal coraggio di servirsi della propria intelligenza"? All’ordine del giorno, oggi, per ri-"orientarsi nel pensiero" (Kant) e per una seconda rivoluzione copernicana (Th. W. Adorno), è augurabile che venga ripresa la lettura dello "Spaccio della bestia trionfante" di Giordano Bruno e del "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano" del Galileo Galilei, senza queste opere l’uscita dal letargo claustrofilico e terrapiattistico è impensabile.
IL MATERIALISMO DIALETTICO. Superato Kant dialettica-mente (con la hegeliana astuzia della ragione "mascherata" - già di Platone e Cartesio, sia atea sia devota, sia idealistica sia materialistica), si è perso anche il senso e il sottotitolo stesso del lavoro di Marx sul "Capitale" e, con esso, ogni possibilità di portare avanti la stessa "critica dell’economia politica": si tenga presente che per John Dewey, la rivoluzione di Kant è "un ritorno a un sistema di tipo ultra-tolemaico").
LA "COSCIENZA #MISTICA", IL "SOGNO DI UNA COSA", E "IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE". Paradossalmente, e probabilmente, se avessimo letto di più e meglio sia Giambattista Vico sia Kant a questa ora, in occasione della riflessione sul percorso filosofico di Gianni Vattimo, forse, potremmo capire di più la sua reale vicinanza e consonanza con la "Critica dell’idealismo" della "Critica della Ragion Pura" (1787) e il programma giovanile di Marx, il #sognodiunacosa (1843) : "Sarà chiaro come non si tratti di tirare una linea retta tra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità non incominci un lavoro nuovo, ma venga consapevolmente a capo del suo antico lavoro."("Annali franco-tedeschi"). Uno dei più importanti contributi in tale direzione di Gianni Vattimo, a mio parere, è proprio il saggio del 1974: "Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della liberazione" (Bompiani, 1974). Negli stessi anni, nelle infinite analisi sul rapporto tra il marxismo ed Hegel, correva il ripescaggio del "sapiente" Bovillus e della sua "rinascimentale" antropologia piramidale.
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CON SHAKESPEARE, OLTRE IL SOGNO DEMIURGICO PLATONICO E BACONIANO DEL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO".18 settembre 2023, di Federico La Sala
FILOSOFIA, FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, POLITICA, E RELIGIONE E STORIA E LETTERATURA:
LA DIAGNOSI HAMLETICA DI SHAKESPEARE E LA DIALETTICA "NAPOLEONICA" DELLO SPIRITO DI HEGEL.
Una nota *
Il tramonto della cristianità
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 18 Settembre 2023)
La crisi della Chiesa è sotto gli occhi di tutti. Naturalmente preoccupa soprattutto i cristiani, ma non riguarda soltanto loro perché essa è l’effetto di una crisi sottostante, quella della civiltà cristiana che è la base delle nostre società. Per questo non riguarda soltanto la fede cristiana, ma la società contemporanea nel suo insieme.
In che modo e con quali conseguenze è l’argomento di un breve e interessante saggio della filosofa politica francese Chantal Delsol dal titolo esplicito, La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo (ed. Cantagalli). Il punto di partenza della sua analisi è la constatazione che stiamo assistendo al tramonto della cristianità, la civiltà fondata sul cristianesimo che ha dominato l’Europa e il mondo Occidentale per sedici secoli. Il suo declino è certamente provocato «dal cedimento della base che ne sosteneva l’esistenza: la fede in una verità trascendente, in questo caso quella in un Dio unico venuto nel mondo», tuttavia non comporta necessariamente la fine del cristianesimo. Una religione, infatti, resta viva anche quando raccoglie un piccolo numero di credenti. Quanti e fino a quando, impossibile dirlo e, a questo punto, viene inevitabilmente alla memoria la frase forse più sconcertante pronunciata da Gesù, riportata nel Vangelo di Luca (18,8): «Quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?»
La civiltà cristiana, invece, scrive Delsol, come tutte le costruzioni umane è «effimera, soggetta ai tempi e alle mode, ed eminentemente fragile, mortale». È del tutto ragionevole pensare che possa finire. Il suo inizio è convenzionalmente stabilito dagli storici nel 394 d.C., data della battaglia del fiume Frigido e della definitiva sconfitta del paganesimo. Da quel momento ha preso il sopravvento una civiltà nuova «ispirata, ordinata e guidata dalla Chiesa», con un nuovo «modo di vivere» e una nuova concezione del bene e del male. Il suo declino inizia molti secoli dopo, con il movimento culturale dell’Illuminismo e la Rivoluzione Francese che cercò di fare piazza pulita della Chiesa con abbondante uso della ghigliottina contro chierici e fedeli laici. Poi divenne sempre più rapido, fino ad assomigliare a una vera débâcle culturale a partire dagli anni Sessanta del Novecento, quando i movimenti della contestazione giovanile in tutto il mondo occidentale scompaginarono la società cambiando i costumi e affossando le tradizioni, e gettarono le basi del mondo odierno. Chantal Delsol pensa che quegli anni rappresentino il punto di non ritorno della crisi e che oggi all’orizzonte, a vista d’uomo, sia impossibile immaginare una rinascita della cristianità.
Già nel 1969 Joseph Ratzinger, allora giovane teologo e professore universitario, fece questa previsione sul futuro della Chiesa: «Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi... Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali, ... non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra» e diventerà più spirituale.
Il futuro papa immaginava che un processo lungo e difficile ma positivo l’avrebbe condotta a liberarsi della mondanità, della pomposità e del settarismo permettendole di essere di nuovo, come all’origine, l’assemblea (questo è il significato della parola chiesa) dei ‘piccoli’, termine con cui il linguaggio biblico chiama coloro che non cercano potere, riconoscimenti o ricchezze ma Dio, e a lui si affidano con semplicità e fiducia. Purificata dalla zavorra accumulata lungo i secoli del suo predominio, dopo grandi sommovimenti e una lunga crisi che, a suo parere, era appena cominciata sarebbe rimasta «non la Chiesa del culto politico, che è già morto, ma la Chiesa della fede... Conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte» (Cfr. La profezia dimenticata di Ratzinger sul futuro della Chiesa, reperibile on line o nel libro Faith and Future, Ignatius Press, 2009). Una Chiesa nuova e antica capace di annunciare sempre lo stesso messaggio di speranza affidatole duemila anni fa. Per quale altro scopo se non per conoscerlo la gente dovrebbe avvicinarsi alla Chiesa, si domanda senza tergiversare il filosofo polacco Kolakowski in un breve saggio incompiuto solo ora tradotto in italiano: «Se non è Dio e Gesù che la gente cerca nella Chiesa, la Chiesa non ha alcun compito specifico da realizzare...è Dio che tutti vorrebbero trovare nel cristianesimo», non un’ideologia o una lobby politica (L. Kolakowski, Gesù. Saggio apologetico e scettico, ed. Le Lettere).
Fine del cristianesimo, dunque, fine della morale e trionfo dell’ateismo? Tutt’altro. Se il XXI secolo vedrà la fine della cristianità, scrive Delsol, non vedrà però la fine della moralità, come paventano alcuni cristiani convinti che i principi morali derivino solo dalla religione. Lo dimostrano le società pagane la cui moralità era determinata dai costumi, dalle leggi e dalle tradizioni. Allo stesso modo la società post-cristiana segue una morale che rispecchia i costumi condivisi dalla maggioranza dei cittadini e confermata dalle leggi dello Stato il quale provvede anche alle sanzioni a sua tutela non più affidate alla Chiesa.
Per quanto riguarda l’ateismo, Delsol è certa che non trionferà perché non ha presa sull’animo umano, portato piuttosto a riempire il vuoto provocato dalla fine del trascendente con altre forme di sacro. Le religioni e le filosofie orientali rispondono perfettamente alle nuove esigenze di spiritualità, perché «non brandiscono alcun Dio, alcun dogma, alcun obbligo» e il loro «sforzo per eliminare la sofferenza è molto simile alle sessioni di sviluppo personale, ed è proprio quello che i nostri contemporanei cercano». Anche l’ecologismo è perfetto per l’uomo di oggi. Egli non riconosce più gerarchie e separazioni tra uomo e natura, e nella ricerca di una sacralità senza divinità rigetta ogni monoteismo avvicinandosi piuttosto all’antico animismo; la sua visione è una sorta di cosmo-teismo «preoccupato più dello spazio che del tempo» perché non immagina niente al di sopra del mondo. La fede ecologista, inoltre, bilancia almeno in parte l’individualismo esasperato reintroducendo il concetto di responsabilità personale verso il futuro del pianeta e di chi lo abiterà. Forse, prospetta prendendo a prestito le riflessioni del filosofo tedesco Odo Marquard, dopo il regno di Dio e dopo quello dell’uomo è giunto il regno della natura.
Dall’analisi della Delsol, dalle parole di Ratzinger, dalle considerazioni di Kolakowski emergono pensieri convergenti, non pessimisti, che indicano una via percorribile per il futuro. La Chiesa può sopravvivere tornando all’essenza della sua missione, alla sua originaria ragione d’essere: l’annuncio e la testimonianza del messaggio di Gesù, semplicemente così come lo raccontano i Vangeli. La speranza di un amore che va oltre la morte, oltre le nostre fragilità, gli errori, le mancanze. La consapevolezza di condividere un destino che dovrebbe farci sentire responsabili gli uni degli altri e tutti del mondo. La perdita del potere politico, del riconoscimento sociale, della ricchezza potrebbe essere un beneficio piuttosto che una catastrofe, argomenta Chantal Delsol. Forse non deve essere la cristianità a lasciarci, ma potrebbero essere i cristiani ad abbandonarla rinunciando alla forza e all’ideologizzazione per tornare ad essere quello che devono essere: testimoni. «Non possiamo inventare un altro modo di essere se non quello dell’egemonia? La missione dev’essere necessariamente sinonimo di conquista?» E conclude: «Probabilmente sarebbe meglio se rimanessimo solamente dei testimoni silenziosi e, in fondo, degli agenti segreti di Dio».
*
LA DIAGNOSI HAMLETICA DI SHAKESPEARE E LA DIALETTICA "NAPOLEONICA" DELLO SPIRITO DI HEGEL:
- "[...] Io mi attengo a quest’idea, che lo Spirito del mondo ha dato al tempo l’ordine di avanzare. Tale comando è stato eseguito; questa essenza s’avanza come una compatta falange corazzata, irresistibilmente, ovunque, con un movimento impercettibile come quello del sole. Le muovono contro, l’affiancano, da tutte le parti, innumerevoli truppe leggere, la maggior parte delle quali non sa affatto di che si tratti, e non fa che ricevere colpi sulla testa, come da una mano invisibile. Tutte le millanterie temporeggiatrici o i colpi a vuoto pur tanto celebrati non servono a niente contro di essa. [...] La cosa più sicura (dal punto di vista interno ed esterno) è di non perdere di vista l’avanzata del gigante"[...]" (cfr. G. W. F. Hegel, "Lettere": a Niethammer, 5 luglio 1816; con prefazione di E. Garin - Laterza).
Nonostante Hegel sapesse che "The time is out of joint" (Shakespeare, "Hamlet", I.2), la visione COSMOTEANDRICA di Napoleone a cavallo a Jena (1806) in parte lo accecò e non poté più portarsi fuori dalla DIALETTICA della "strada di Damasco" (e "protestante" e "cattolica"). Con Amleto (e Marx), tuttavia non si può non ripetere: "Ben detto, vecchia talpa!" (I.5).
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, TECNOCRAZIA, E COSMOTEANDRIA: IL"NOVUM ORGANUM" (BACONE). L’ AVANZATA DEL GIGANTE, ormai, con i suoi stivali dalle sette leghe, è diventata inarrestabile: è un "golem-antico" progresso sulla strada aperta dal demiurgico sogno tragico dell’Accademia platonico-socratica, paolina, baconiana-hobbesiana, e schmittiana. "Il parto maschio del tempo ovvero la grande instaurazione del dominio dell’uomo sull’universo" è ormai a "buon" punto.
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PAOLINISMO, CIRCOLO ERMENEUTICO, E USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ - OGGI..16 settembre 2023, di Federico La Sala
ERMENEUTICA, #FILOLOGIA, #ANTROPOLOGIA, #CRISTOLOGIA, E FILOSOFIA (#PADRENOSTRO): "DIO" E’ AMORE ("DEUS #CHARITAS EST": 1 Gv., 4).
- Appunti di "dialogo" con Dante, Michelangelo, Shakespeare, Freud, Gadamer, e la "matematica" #FrancaOngaroBasaglia...
PREMESSO che #Gesù è Gesù e #Cristo è Cristo, e, considerando in tutta la sua radicalità la #question #hamletica ("essere, o non essere"), cosa significa "IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS" e cosa chiarisce il "CIRCOLO ERMENEUTICO" (H. G. #Gadamer, 1900-2002)?
LA BELLA (MARIA -) #BEATRICE, a san Pietro non chiede di verificare se #Dante è uscito dallo "stato di #minorità" e se sa di Chi è figlio, che significa essere "#figliodiDio"?; se Dante sa #comenasconoibambini e se sa chi sono i genitori di Gesù e chi sono i suoi; e Chi è il "Padre Nostro" - il "Padre" di Gesù, di Dante, e di ogni essere umano?!
#STORIAELETTERATURA. Dante, come #Shakespeare, cosa risponde? Non risponde che "In principio era il Logos" (Gv., 1.1); che "L’amore non è lo zimbello del tempo" (Sonetto 116); e, che è "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Pd. XXXIII, 145). Dov’è più il "piccolo" san Paolo che gioca... all’#Edipo "cattolico-romano" con la sua "cara" ("carissima") #mammona?!
#ECONOMIAPOLITICA (J.-J. #ROUSSEAU, 1755), "SAPERE AUDE!" (I. #KANT, 1784), E #PAOLINISMO. "Il disagio della civiltà": "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori [...]" (S. #Freud, 1929).
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. Come "è stata possibile un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia, 1979)?!?
DANTE ALIGHIERI, L’HAMLETICA “QUESTION” CRISTOLOGICA (ANTROPOLOGICA), E LA FILOLOGIA.
Una nota a margine di un articolo di Claudio Giunta (“Inferno. La Commedia di Dante raccontata da Claudio Giunta”):
***
#ANTROPOLOGIA, #LETTERATURA, E #DIVINACOMMEDIA: #LETARGO (Pd. XXXIII, 94) E #SONNODOGMATICO (#Kant).
LA #FEDE DI #DANTE, E DI SAN PIETRO, E LA FEDE DI SAN PAOLO.
A 750 ANNI E OLTRE DALLA NASCITA E A 700 ANNI E OLTRE DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI, UNA “PREMESSA” A UNA ”VECCHIA’ NOTA DI ENNIO ABATE A COMMENTO DI UN ‘VECCHIO’ ARTICOLO DI CLAUDIO GIUNTA (“Dante dopo l’Apocalisse”, Le parole e le cose, 21 maggio 2015):
DANTE ALIGHIERI, L’HAMLETICA “QUESTION” CRISTOLOGICA (ANTROPOLOGICA), E LA #FILOLOGIA:
(LA MADRE, MARIA-) #BEATRICE (Pd. XXIV, 34) chiede al “gran viro”(San Pietro) di verificare se Dante ha capito la differenza tra la fede in “Nostro Signore” Gesù (Ponzio Pilato: Ecce Homo, gr. «idou ho #anthropos») oppure nel “Nostro Signore” (secondo la ‘precisazione’ androcentrica e mammonica) di San Paolo, l’Uomo (#Vir): “sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio” (1 Cor. 11, 1-3).
“DANTE DOPO L’ APOCALISSE” - OGGI (15 settembre 2023):
- “Se ormai possiamo solo insistere col giochino di come avrebbe reagito Dante di fronte ai festeggiamenti del suo 750° compleanno, a me piace immaginarlo non meravigliato ma molto incazzato e pronto a infuriarsi con gli italiani per non aver fatto - dopo ben settecento anni! - le cose che si dovrebbero fare in un Paese già ai tempi suoi ridotto a «bordello».
- Ma Dante oggi è, purtroppo, nelle mani dei dantisti. E ci sarà sempre un Claudio Giunta che, gli riconoscerà la sua genialità (da «marziano», scrisse nel lontano 1999 Pietro Cataldi in « Perché leggere Dante (oggí)?») e lo ringrazierà per aver permesso con la sua opera di lanciare la catena di montaggio della multinazionale Dante & C., quella che produce « articoli, libri, tesi di laurea e di dottorato a centinaia, a migliaia, e quattro o cinque riviste dedicate interamente a lui, e poi spettacoli teatrali, reading, videogiochi, Greenaway, Dan Brown, Gassman, Benigni, un indotto da far impallidire la Fiat...»). Subito dopo, però, appena Dante tirerà fuori la balla che la sua «no, non era solo letteratura», lo azzittirà ricordandogli, appunto, che oggi gli esseri umani (quelli che Giunta frequenta) «se la passano infinitamente meglio di come se la passavano al tempo di Dante».
- (Ennio Abate, 21 maggio 2015, Le parole e le cose).
STORIA E LETARGO STORIOGRAFICO: NON SCAMBIARE DANTE ALIGHIERI CON GIOVANNI BOCCACCIO. Se il “diciottenne” Dante racconta - come scrive Alessandro Barbero - il sogno e la visione di Beatrice nuda “[...] con un tocco così leggero che di solito gli esegeti non lo commentano”, non è meglio interrogarsi su questa dantesca “lezione americana” (alla Italo Calvino) di leggerezza e pensare meglio che Dante abbia ri-visto in sogno la madre “beata e Bella”?!
Non è ancora ora di cambiare registro , e, cominciare a pensare semplicemente che la figlia di Gemma Donati e Dante Alighieri, (Maria-) Antonia, diventata suora, abbia voluto rendere omaggio a Bella, alla sua nonna paterna, e ricordare per tutta la sua vita proprio (Maria-) Beatrice?!
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA "LETTERA AI ROMANI", IL SIMBOLO NICENO, E UNA RAGAZZA BERBERA. La neve in Romania (di G. Agamben).12 settembre 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E TEOLOGIA-POLITICA, OGGI (12 SETTEMBRE 2023).
- Memoria di Paolo di Tarso, del "sapiente" di tutti i "sapienti", per i secoli dei secoli: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- LA FEDE DI UNA RAGAZZA BERBERA, LA PAOLINA "LETTERA AI ROMANI", E IL SIMBOLO NICENO DI COSTANTINO (NICEA 325 d. C.), E "LA NEVE IN ROMANIA".
UN "INVITO ALLA LETTURA" di una breve annotazione di Giorgio Agamben (Quodlibet, 30 agosto 2023) sulla "fede" e sulla "esperienza della parola":
La neve in Romania
di Giorgio Agamben (Quodlibet, 30 agosto 2023)
A che cosa siamo fedeli, che cosa significa aver fede? Credere in un codice di opinioni, in un sistema di idee formulate in un’ideologia o in un «credo» religioso o politico? Se così fosse, fedeltà e fede sarebbero una triste faccenda, nient’altro che il tetro, compiaciuto dovere di eseguire prescrizioni dalle quali per qualche ragione ci sentiamo vincolati e obbligati. Una tale fede non sarebbe qualcosa di vivo, sarebbe lettera morta come quella che il giudice o lo sbirro ritengono di applicare nello svolgimento delle loro funzioni. L’idea che il fedele sia una specie di funzionario della sua fede è così ripugnante, che una ragazza, che aveva sopportato la tortura pur di non rivelare il nome dei suoi compagni, a coloro che elogiavano la sua fedeltà alle proprie idee rispose semplicemente: «non l’ho fatto per questo, l’ho fatto per capriccio».
Che cosa intendeva dire la ragazza, che esperienza della fedeltà voleva esprimere con le sue parole? Una riflessione su quella fede per eccellenza, che fino a qualche decennio fa era ancora considerata la fede religiosa, può fornirci indizi e riscontri per una risposta. Tanto più che proprio in questo ambito la Chiesa a partire dal Simbolo niceno (325 d.C.) ha ritenuto di dover fissare in una serie di dogmi, cioè di proposizioni vere, il contenuto della fede, ogni discordanza rispetto alle quali costituiva un’eresia condannabile. Nella lettera ai Romani Paolo sembra dirci anzi esattamente il contrario. Egli lega innanzitutto la fede alla parola («la fede viene dall’ascolto attraverso la parola di Cristo») e descrive l’esperienza della parola che è in questione nella fede come una immediata vicinanza di bocca e cuore: «Vicina (eggys, letteralmente alla mano) a te è la parola, nella tua bocca e nel tuo cuore, questa è la parola della fede... Col cuore infatti si crede nella giustizia, con la bocca si professa per la salvezza». Paolo riprende qui un passo del Deuteronomio che affermava questa stessa prossimità: «la parola è vicinissima nella tua bocca e nel tuo cuore ed è nelle tue mani attuarla».
L’esperienza della parola che è in questione nella fede non si riferisce al suo carattere denotativo, al suo corrispondere a dei fatti e a delle cose esteriori: è, piuttosto, esperienza di una vicinanza che ha luogo nell’intima corrispondenza tra bocca e cuore. Testimoniare della propria fede non significa fare delle affermazioni fattualmente vere (o false) come si fa in un processo. Non siamo fedeli, come nel credo o nel giuramento, a una serie di enunciati che corrispondono o non corrispondono a dei fatti. Siamo fedeli a un’esperienza della parola che sentiamo così vicina, che non c’è spazio per separarla da ciò che dice.
 La fede è, cioè, innanzitutto un’altra esperienza della parola rispetto a quella di cui crediamo di servirci per comunicare dei messaggi e dei significati ad essa esterni. A questa parola siamo fedeli perché, nella misura in cui non possiamo separare la bocca e il cuore, viviamo in essa e essa vive in noi. È una tale esperienza che doveva avere in mente quella ragazza berbera che, mentre un giorno le chiedevo che cosa la legava così fortemente a un uomo che diceva di aver amato e con il quale era vissuta per un anno in una capanna nelle montagne rumene, rispose: «io non sono fedele a lui, sono fedele alla neve in Romania».
La fede è, cioè, innanzitutto un’altra esperienza della parola rispetto a quella di cui crediamo di servirci per comunicare dei messaggi e dei significati ad essa esterni. A questa parola siamo fedeli perché, nella misura in cui non possiamo separare la bocca e il cuore, viviamo in essa e essa vive in noi. È una tale esperienza che doveva avere in mente quella ragazza berbera che, mentre un giorno le chiedevo che cosa la legava così fortemente a un uomo che diceva di aver amato e con il quale era vissuta per un anno in una capanna nelle montagne rumene, rispose: «io non sono fedele a lui, sono fedele alla neve in Romania».
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA DISCESA NEL REGNO DELLE MADRI. Note sul il filo di M_Arianna, che lega Freud, Virgilio, Milton, Goethe, e Dante Alighieri.3 settembre 2023, di Federico La Sala
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI, DIVINA COMMEDIA, FAUST, ED ELEUSIS 2023: LA DISCESA NEL REGNO DELLE MADRI.
Alcuni appunti per riprendere il filo di M_Arianna, che lega Freud, Virgilio, Milton, Goethe, e Dante Alighieri, e, possibilmente, portarsi fuori dall’orizzonte della tragica "caduta".
A) - LA DISCESA ALL’INFERNO DI FREUD E DI DANTE. "L’Interpretazione dei Sogni" (1899/1900) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di Virgilio e "L’uomo #Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della Divina Commedia (Pg. II, 46-48).
B) - FREUD E MEFISTOFELE: LA DISCESA NEL "REGNO DELLE MADRI". Una chiarificazione sulla fondamentale determinazione "giunonica" da parte di Freud è ben evidente nella sua "scelta" della citazione virgiliana che apre la via alla "Interpretazione deisogni: “Chi è disceso fino alle Madri non ha più nulla da temere.” (J.W. #Goethe, #Faust, II. 2).
C) - FREUD E MILTON. Alla fidanzata Martha, il 7 agosto 1882, #SigmundFreud scrive che, nel "#Paradisoperduto" (#JohnMilton, 1667), «ancora di recente, in un momento in cui non mi sono sentito sicuro del tuo amore, ho trovato consolazione e conforto».
- NOTA.
“ACHERONTA MOVEBO”! MATEMATICA E PSICANALISI: “QUATTRO”, PER RISCRIVERE UN “ROMANZO FAMILIARE” NUOVO... Una "vecchia" nota sul programma di ricerca di Sigmund Freud, a commento di un testo poetico-filosofico di Italo Testa.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---"HIC RHODUS, HIC SALTUS": RI-PARTIRE DA SE’ - DAL PROPRIO OMBELICO.Nota a margine di una riflessione di Alfonso M. Iacono.1 settembre 2023, di Federico La Sala
PIANETATERRA: #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA, E #CRITICA (DELLA #TEOLOGIA ECONOMICA POLITICA PLATONICO E PAOLINA).
RI-PARTIRE DA SE’ - DAL PROPRIO #OMBELICO, PER-RI .#TROVARE L’OMBELICO DEL #MONDO E RI-#PARTECIPARE ALLA #VITA DI UNA #SOCIETA’ #APERTA (NON #CHIUSA).
"HIC RHODUS, HIC SALTUS" ("#Filosofia del #Diritto")! Con #Hegel, #oltre, oltre il #giogo "dialettico" (antinomico) del #Mentitore, "#ora e #qui" ( #now-#here), #31agosto 2023. In memoria di #EnzoPaci e del suo "#Nicodemo o della #nascita" (1944) ...*
- "[...] eppure se, come aveva scritto #Kant nel 1784 e ribadito #Foucault due secoli dopo, l’#illuminismo è l’uscita da uno #stato di minorità e la minorità è l’incapacità di sapere usare il proprio intelletto senza la guida di un altro, forse è venuto il momento di cercare questa uscita autonomamente, senza la guida neoliberista oggi dominante. D’altra parte quando #Marx e #Engels rilevavano che le idee dominanti sono le idee della classe dominante, lo facevano per mostrare ciò che i prigionieri della #caverna di #Platone non vedono e non sanno di non sapere, proprio come la sinistra oggi. Quest’ultima, sul piano delle idee e dell’azione, da che parte intende stare? Certo non si devono semplificare le cose, ma, a volte, come ricordava #PrimoLevi, semplificare è necessario. Basta #sapere che di semplificazione si tratta, utile a togliere alibi e ipocrisie e anche a praticare un #principio della democrazia che è appunto partecipare, cioè prendere parte, meglio prendere partito." (Alfonso Maurizio Iacono, cit.).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- FILOLOGIA, RICERCA § INSEGNAMENTO: UNA QUESTIONE HAMLETICA (DI SALUTE E SALVEZZA) EPOCALE.30 agosto 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, RICERCA § INSEGNAMENTO: UNA QUESTIONE HAMLETICA (DI SALUTE E SALVEZZA) EPOCALE.
 Che cosa significa orientarsi nel pensiero...
Che cosa significa orientarsi nel pensiero...«In verità si è soliti dire che un potere superiore può privarci della libertà di parlare o di scrivere, ma non di pensare. Ma quanto, e quanto correttamente penseremmo, se non pensassimo per così dire in comune con altri a cui comunichiamo i nostri pensieri, e che ci comunicano i loro? Quindi si può ben dire che quel potere esterno che strappa agli uomini la libertà di comunicare pubblicamente i loro pensieri li priva anche della libertà di pensare, cioè dell’unico tesoro rimastoci in mezzo a tutte le imposizioni sociali, il solo che ancora può consentirci di trovare rimedio ai mali di questa condizione». [...]" (I. KANT).
"SÀPERE AUDE!" (Immanuel Kant, Koenigsberg 1784).
 Una nota per un "nuovo" #orientamento nel pensiero e nella realtà.
Una nota per un "nuovo" #orientamento nel pensiero e nella realtà.SENSIBILITÀ E INTELLETTO, OGGI. Per dirla diversamente (generalizzando e utilizzando una "vecchia" idea di #Kant: "I concetti senza le intuizioni sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche"), "la ricerca ha bisogno per ampliare e trovare nuove soluzioni e per non esaurirsi, altrettanto, di un #insegnamento che sappia mantenere aperto il rapporto e il legame tra il sapere acquisito (i risultati delle ricerche compiute) e quello da acquisire proprio in rapporto alla ricerca relativa ai nuovi problemi e alle situazioni inedite. Senza un insegnamento vivo la ricerca muore, così come l’insegnamento senza ricerca viva: solo un circolo virtuoso rende possibile la vita all’uno e all’altra e, al contempo, permette di uscire dall’inferno epistemologico, impedisce di ri-cadere in un claustrofilico circolo vizioso, e, infine, apre la via alla nascita di un insegnamento e di una ricerca all’altezza dell’intera umanità e dell’intero Pianta Terra.
- NOTA.
UNA "MONARCHIA" DI "DUE SOLI" (DANTE ALIGHIERI) E "IL SILENZIO DEI TEOLOGI" (PAOLO PRODI). PER NON PERDERE LA BUSSOLA DEFINITIVAMENTE, FORSE, DATA LA PORTATA DECISIVA DELLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA SU TUTTE LE ALTRE PROBLEMATICHE DELLA INTERA SOCIETÀ, IN ANALOGIA, VALE LA PENA TENER CONTO DI UNA RIFLESSIONE DI PAOLO PRODI SUL RAPPORTO TEOLOGIA E POLITICA: "una politica laica ha bisogno per vivere anche di una teologia che faccia il suo mestiere". (cfr. P. Prodi, "Il silenzio dei teologi", l’Unità, 07.01.2007).
Sul tema, per eventuali approfondimenti, si cfr.:
KANT, FREUD, E LA BANALITA’ DEL MALE
fls
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "INTERPRETAZIONI DEI SOGNI" E "FRECCIA FERMA": UNA NOTA SUL DISAGIO DELLA CIVILTA’.29 agosto 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA. Psicoanalisi, Religione, e Storia:
- Il "Disagio della civiltà" (S. Freud, 1929) e "La freccia ferma" (E. Fachinelli, 1979).
Una nota a margine della notizia relativa al fatto che
- "I talebani hanno vietato alle donne l’accesso a uno dei parchi nazionali più popolari dell’Afghanistan:
- "Il governo dei talebani ha vietato alle donne di visitare il parco nazionale di Band-e-Amir, una delle principali attrazioni dell’Afghanistan, che si trova circa 200 chilometri a ovest della capitale Kabul. La notizia è stata diffusa dal ministero per la Prevenzione dei vizi e la Promozione delle virtù, secondo cui all’interno del parco le donne non rispetterebbero l’obbligo di indossare il velo islamico. Il ministero ha fatto sapere che l’ingresso delle donne sarà vietato finché non verrà trovata una soluzione. (...)" ("IL POST", domenica 27 agosto 2023).*
°°°
"Cum grano salis", e con tutte le differenze implicite ed esplicite. Per quanto possa sembrare strano, a mio parere, siamo di fronte a una pericolosissima e importantissima "freccia ferma" della intera storia umana, quella antropologica: siamo di fronte alla famosa #question sottolineata da #Shakespeare: "The time is out of joint" ("Amleto", I.2).
CULTURA E SOCIETA’. Quanto sta succedendo sul Pianeta Terra , sul piano antropologico e sociologico-politico, non ha niente a che fare con l’indagine #critica di Freud e dei suoi grandi collaboratori (ricordo, in particolare: Theodor Reik) sull’immaginario "biblico" e sulla più che millenaria tradizione tragica (paradigmaticamente indicata dalla figura di Edipo)?
INTERPRETAZIONE DEI SOGNI. Su quanto sta succedendo, in particolare in #Afghanistan, non è da "interpretarsi" come la memoria e l’emergenza del "preistorico" #iceberg di "Adamo ed Eva" e del "mosaico" su cui ha lavorato per tutta la vita lo stesso Sigmund Freud?!
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" E STORIOGRAFIA: 60 ANNI DI «I HAVE A DREAM». La liberazione, un’incompiuta che soffoca ancora (di Alessandro Portelli) )27 agosto 2023, di Federico La Sala
CIVILTÀ DELL’ AMORE E VOLONTÀ DI GUERRA ... *
La liberazione, un’incompiuta che soffoca ancora
60 ANNI DI «I HAVE A DREAM». Ma per la giustizia e i diritti degli afroamericani, è sempre una soffocante estate, in cui - come Eric Garner, strangolato a New York, e come ha ripetuto per un’intera estate il movimento Black Lives Matter, la parola d’ordine è I can’t breathe
- [Foto] A Washington la grande marcia pacifica contro le violenze della polizia dopo la morte di George Floyd nel maggio 2020 - Lapresse
di Alessandro Portelli ([il manifesto, https://ilmanifesto.it/la-liberazione-unincompiuta-che-soffoca-ancora])
Come finisce il discorso di Martin Luther King del 28 febbraio 1963, lo ricordiamo tutti - la perorazione sul sogno, la luminosa visione futura. Quello che ci ricordiamo in pochi è come comincia: con un doppio riferimento alla storia. Le prime parole sono «Five score years ago» (e cioè «Cento anni fa»: score vuol dire venti).
Evocano l’incipit («Four score and seven years ago», 87 anni fa) del discorso del 1863 in cui Abraham Lincoln annunciava l’emancipazione degli schiavi rinviando al 1776 e all’indipendenza. Fin dalle prime parole, King avverte che la liberazione degli afroamericani è il compimento della liberazione del paese; ma questa liberazione è incompiuta, e quindi incompiuto è il paese.
King prosegue con una metafora che sembra quasi preparare l’immaterialità della perorazione conclusiva appoggiandola a una base di rapporti concreti - prepara il volo utopico finale partendo dal linguaggio mercantile, del commercio, del business: gli autori della Costituzione e della Dichiarazione d’Indipendenza, dice, «firmarono una cambiale (a promissory note) che ogni americano avrebbe ereditato. Era la promessa che tutti gli uomini - si, uomini neri come i bianchi - avrebbero goduto dei diritti inalienabili di vita, libertà e ricerca della felicità (...) Invece di onorare questa sacra obbligazione, l’America ha dato ai neri un assegno a vuoto (...) E noi oggi siamo qui per incassare questo assegno».
Ecco, il sogno resta sogno finché la cambiale non è pagata. Se li mettiamo insieme ci rendiamo conto che il sogno non era mero desiderio ma un concreto programma politico, basato sulle fondamenta stesse del paese. La ribellione all’America realmente esistente si legittima con il richiamo all’America nascente idealizzata. Finché questo debito non è saldato, l’America tradisce se stessa.
E continua a farlo. Molti anni prima di King, il poeta afroamericano Langston Hughes domandava: «Che ne è di un sogno rimandato? Avvizzisce come un chicco d’uva al sole, marcisce come una piaga purulenta, puzza come carne marcita, si affloscia come un carico troppo pesante - o esplode?». È esploso molte volte questo sogno differito per una cambiale non pagata - a Harlem, a Watts, a Detroit, a Milwaukee, a East Saint Louis...
Per due volte, King usa una bella parola sonora: sweltering. Vuol dire «soffocante»: «Questa soffocante estate del legittimo scontento nero» ... «il Mississippi, uno stato che soffoca nell’afa dell’ingiustizia». Le rivolte dei ghetti avvengono quasi sempre d’estate. Ma per la giustizia e i diritti degli afroamericani, è sempre una soffocante estate, in cui - come Eric Garner, strangolato a New York, e come ha ripetuto per un’intera estate il movimento Black Lives Matter, la parola d’ordine è I can’t breathe, non respiro.
*
NOTA:
UNA QUESTION HAMLETICA, DI CADUTA "BIBLICA", NELLA CAVERNA "PLATONICA", E UNA MILLENARIA RICAPITOLAZIONE , ATEA E DEVOTA, NELLA LOGICA DEL "SAPIENTE" DI BOVILLUS) : "THE TIME IS OUT OF JOINT" (SHAKESPEARE, "HAMLET", I.2). Non nei millenni passati, la teologa Wilma Gozzini scriveva: “La donna è l’altro dell’ uomo , uguale per diritti e doveri, ma anche diversa [...] L’ altro che sta faccia a faccia è inquietante e scomodo e apre una sola alternativa. O lo si accoglie come unica possibilità data per vivere umanamente la propria storia, o lo si nega, assimilandolo - facendo simile ciò che altro - neutralizzando così l’alterità, non riconoscendogli autorità ma sottomissione, negandogli uguaglianza” ("L’Unità", 1990).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- CULTURA E SOCIETÀ: NICEA (325 - 2025). UNA HAMLETICA "QUESTION" DI LUNGA DURATA. Una nota su una "passeggiata barocca".17 agosto 2023, di Federico La Sala
CULTURA E SOCIETÀ: NICEA (325 - 2025). UNA HAMLETICA "QUESTION" DI LUNGA DURATA
 DI ANTROPOLOGIA, DI FILOSOFIA, DI DIRITTO, E DI STORIA DELLA CHIESA "CATTOLICA".
DI ANTROPOLOGIA, DI FILOSOFIA, DI DIRITTO, E DI STORIA DELLA CHIESA "CATTOLICA".Con malinconia barocca, una nota a margine di una "Passeggiata"...
"[...] ... in segno di stima, plaudo alla grande a questa " terza Passeggiata Barocca di domani, venerdì 18 agosto del più antico e nobile monastero femminile di Scicli" (Ragusa).
STORIOGRAFIA E LETTERATURA. A mio parere, tuttavia, è da dire che la realtà storica (e non solo) è "a doppia faccia": se è vero che la vicenda della comunità religiosa di questo monastero è "molto diversa dall’ idea tradizionale di reclusione e di monacazioni forzate ( penso a Manzoni e a "Storia di una capinera" di Verga )", è altrettanto vero che non si tratta affatto di "un inedito protagonismo femminile da riscoprire": dal 325 al 2025, non mi sembra che la struttura "giuridica" dell’androcentrismo teologico e cristologico della chiesa cattolica sia molto mutato (lode agli sforzi antropologici ed ecumenici di papa Francesco). [...]".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA: VIRGINIA WOOLF E LA "PUPILLA" NELLO SGUARDO DI DI PLATONE.28 luglio 2023, di Federico La Sala
ELEUSIS 2023
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA FILOLOGIA E LETTERATURA:
VIRGINIA WOOLF E LA "PUPILLA" ("KORE", "FANCIULLA", "BAMBOLETTA") NELL’OCCHIO E NELLO SGUARDO DI SOCRATE E DI PLATONE. -Alcuni appunti...
A) VIRGINIA WOOLF: "The eyes of others our prisons; their thoughts our cages" ("Short Stories").
B) PLATONE ("Alcibiade primo", 133 e ss.):
 "SOCRATE: Rifletti anche tu: se [l’iscrizione delfica] avesse rivolto un consiglio al nostro occhio, come se fosse un uomo, e gli avesse detto: «Guarda te stesso», che supposizione avremmo fatto su ciò a cui ci esortava? Non forse a guardare a quella cosa guardando alla quale l’occhio avrebbe visto se stesso?
"SOCRATE: Rifletti anche tu: se [l’iscrizione delfica] avesse rivolto un consiglio al nostro occhio, come se fosse un uomo, e gli avesse detto: «Guarda te stesso», che supposizione avremmo fatto su ciò a cui ci esortava? Non forse a guardare a quella cosa guardando alla quale l’occhio avrebbe visto se stesso?
 ALCIBIADE: è chiaro.
ALCIBIADE: è chiaro.
 SOCRATE: Riflettiamo: guardando a quale degli oggetti esistenti vediamo quello e contemporaneamente anche noi stessi?
SOCRATE: Riflettiamo: guardando a quale degli oggetti esistenti vediamo quello e contemporaneamente anche noi stessi?
 ALCIBIADE: è chiaro, Socrate, che dovremmo guardare a uno specchio o a qualcosa del genere.
ALCIBIADE: è chiaro, Socrate, che dovremmo guardare a uno specchio o a qualcosa del genere.
 SOCRATE: Quel che dici è giusto. Ma nell’occhio col quale guardiamo non c’è qualcosa di questo genere?
SOCRATE: Quel che dici è giusto. Ma nell’occhio col quale guardiamo non c’è qualcosa di questo genere?
 ALCIBIADE: Certamente.
ALCIBIADE: Certamente.
 SOCRATE: Hai notato dunque che quando guarda nell’occhio il volto si riflette nello sguardo di chi si trova di fronte come in uno specchio, cosa che chiamiamo anche pupilla (72 -> "kore", "còre"), dato che è come un immagine di chi guarda?
SOCRATE: Hai notato dunque che quando guarda nell’occhio il volto si riflette nello sguardo di chi si trova di fronte come in uno specchio, cosa che chiamiamo anche pupilla (72 -> "kore", "còre"), dato che è come un immagine di chi guarda?
 ALCIBIADE: Quel che dici è vero.
ALCIBIADE: Quel che dici è vero.
 SOCRATE: Dunque quando un occhio osserva un occhio e guarda in esso ciò che appunto esso ha di più bello, e con cui vede, in tal caso potrebbe vedere se stesso [...]".
SOCRATE: Dunque quando un occhio osserva un occhio e guarda in esso ciò che appunto esso ha di più bello, e con cui vede, in tal caso potrebbe vedere se stesso [...]".C) LA "SORELLA" DI WILLIAM SHAKESPEARE: JUDITH (E LA "INVINCIBILE ARMATA"). Con straordinaria e fulminea eleganza e grande coraggio ("Sàpere aude"), Virginia Woolf prende il nome di Judith ("Una stanza tutta per sé") e taglia definitivamente la testa all’ "Oloferne" della tradizione "mammonica" occidentale e si porta fuori dal tragico e infantile ("stadio dello specchio") dello sguardo socratico-platonico e lacaniano (narcisitico, edipico, golem-antico).
P. S. - QUESTIONE ANTROPOLOGICA E CREATIVITÀ. "Lettere a Virginia Woolf dal XXI secolo". Una raccolta epistolare (a c. di Licia Martella, introduzione di Nadia Fusini) dedicata alla scrittrice:
[LETTERE] Scritte da: Leonetta Bentivoglio, Alessandra Bocchetti, Elisa Bolchi, Maria Grazia Calandrone, Elisa Casseri, Sara De Simone, Viola Di Grado, Donatella Di Pietrantonio, Manuela Fraire, Daniela Gambaro, Cristina Gardumi, Viola Lo Moro, Francesca Mancini, Laura Mazzi, Elena Munafò, Raffaella Musicò, Iolanda Plescia, Galatea Ranzi, Elisabetta Rasy, Maria Serena Sapegno, Carola Susani, Nadia Terranova, Silvia Vegetti Finzi, Sara Ventroni, Maddalena Vianello, Valeria Viganò.
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA-POLITICA: CON DANTE E "AMLETO", RIPRENDERE IL FILO DA "THE BOOK OF SIR THOMAS MORE" DI SHAKESPEARE.21 luglio 2023, di Federico La Sala
TEATRO, METATEATRO, E CRITICA DELLA TEOLOGIA-POLITICA CATTOLICO-SPAGNOLA:
SHAKESPEARE, CON "AMLETO" (E DANTE), CERCA LA VIA D’USCITA PER PORTARSI OLTRE LUTERO E OLTRE ERASMO E TOMMASO MORO.
SOVRANITA’ E OBBEDIENZA. iN "The Book of Sir Thomas More", Shakespeare prende le distanze dalle posizioni teologiche di Tommaso Moro (ed Erasmo) e chiarisce le ragioni antropologiche, politiche e teologiche della Riforma anglicana.
- LEZIONE DELL’APOSTOLO PAOLO:
 1 Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio; e quelle che esistono sono stabilite da Dio.
1 Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se non da Dio; e quelle che esistono sono stabilite da Dio.
 2 Perciò chi resiste all’autorità si oppone all’ordine di Dio; quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna; -3 infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu, non vuoi temere l’autorità? Fa’ il bene e avrai la sua approvazione,
2 Perciò chi resiste all’autorità si oppone all’ordine di Dio; quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna; -3 infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu, non vuoi temere l’autorità? Fa’ il bene e avrai la sua approvazione,
 4 perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male.
4 perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male.
 5 Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza.
5 Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza.
 6 È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.
6 È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.
 7 Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l’imposta a chi è dovuta l’imposta, la tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore; l’onore a chi l’onore."(ROMANI: 13, 1-7).
7 Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l’imposta a chi è dovuta l’imposta, la tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore; l’onore a chi l’onore."(ROMANI: 13, 1-7).
Sir Thomas Moore
da Maria Borio (Nuovi Argomenti, 18 Dic. 2017) *
 The Booke of Sir Thomas Moore è un’opera a più mani pervenutaci in manoscritto in una stesura non definitiva che racconta l’ascesa, il trionfo e la caduta del grande statista e umanista inglese attraverso una serie di episodi secondari o immaginari della sua carriera. Con le sue correzioni e revisioni, il testo ci permette di osservare come lavoravano i drammaturghi del Rinascimento inglese. Il manoscritto contiene le uniche pagine vergate di suo pugno da Shakespeare, il cui contributo è limitato a poche scene del dramma. Una di esse (una parte della Scena 6) è quella qui riprodotta.
The Booke of Sir Thomas Moore è un’opera a più mani pervenutaci in manoscritto in una stesura non definitiva che racconta l’ascesa, il trionfo e la caduta del grande statista e umanista inglese attraverso una serie di episodi secondari o immaginari della sua carriera. Con le sue correzioni e revisioni, il testo ci permette di osservare come lavoravano i drammaturghi del Rinascimento inglese. Il manoscritto contiene le uniche pagine vergate di suo pugno da Shakespeare, il cui contributo è limitato a poche scene del dramma. Una di esse (una parte della Scena 6) è quella qui riprodotta.
 Il contesto della vicenda è il cosiddetto Ill May Day (1517), una rivolta del popolino contro i Lombardi, i potenti mercanti e banchieri stranieri attivi a Londra in quell’epoca. Per placare il delirio xenofobo irrompono alcuni nobili e poi Moro, il quale persuade i ribelli ad arrendersi (il fatto è un’invenzione dei drammaturghi). Come ricompensa, viene nominato cavaliere e membro del Privy Council, mentre i rivoltosi vengono imprigionati.
Il contesto della vicenda è il cosiddetto Ill May Day (1517), una rivolta del popolino contro i Lombardi, i potenti mercanti e banchieri stranieri attivi a Londra in quell’epoca. Per placare il delirio xenofobo irrompono alcuni nobili e poi Moro, il quale persuade i ribelli ad arrendersi (il fatto è un’invenzione dei drammaturghi). Come ricompensa, viene nominato cavaliere e membro del Privy Council, mentre i rivoltosi vengono imprigionati.
 Le parti del testo sottolineate sono quelle cancellate dal censore di stato, Edmund Tilney. In carattere speciale (tipo grassetto) sono invece indicate le annotazioni di una mano diversa da quella dell’autore.
Le parti del testo sottolineate sono quelle cancellate dal censore di stato, Edmund Tilney. In carattere speciale (tipo grassetto) sono invece indicate le annotazioni di una mano diversa da quella dell’autore.- Il testo è tratto da William Shakespeare, Tutte le opere, coordinamento generale di Franco Marenco, Volume terzo, I drammi storici, Bompiani, Milano, 2017.
- Edoardo Zuccato
Il libro di Sir Tommaso Moro
di Anthony Munday e Henry Chettle,
 con revisioni e aggiunte di Thomas Dekker, William Shakespeare e Thomas Heywood
con revisioni e aggiunte di Thomas Dekker, William Shakespeare e Thomas Heywood- Scena 6 Entrano Lincoln, Doll, Clown [Betts], George Betts, Williamson, [Sherwin] e altri: [Cittadini, armati][i]
- [Aggiunta II (Shakespeare)]
LINCOLN
 Silenzio, ascoltatemi! Chi non vuol vedere un’aringa affumicata a quattro centesimi[ii], il burro a undici centesimi alla libbra, la farina a nove scellini allo staio[iii] e il manzo a quattro nobili[iv] per sei chili, mi ascolti[v].
Silenzio, ascoltatemi! Chi non vuol vedere un’aringa affumicata a quattro centesimi[ii], il burro a undici centesimi alla libbra, la farina a nove scellini allo staio[iii] e il manzo a quattro nobili[iv] per sei chili, mi ascolti[v].UN ALTRO GEORGE BETTS
 Arriveremo a tanto se continuiamo a tollerare gli stranieri. Dategli retta.
Arriveremo a tanto se continuiamo a tollerare gli stranieri. Dategli retta.LINCOLN
 Per il cibo il nostro è un grande paese; argo[vi], questi mangiano più da noi che in patria.
Per il cibo il nostro è un grande paese; argo[vi], questi mangiano più da noi che in patria.UN ALTRO CLOWN BETTS
 Almeno una pagnotta da mezzo centesimo al giorno, pesata alla francese[vii].
Almeno una pagnotta da mezzo centesimo al giorno, pesata alla francese[vii].LINCOLN
 Loro importano qui verdure straniere giusto per rovinare i poveri apprendisti: cos’è mai una misera pastinaca rispetto al nostro buon cuore?
Loro importano qui verdure straniere giusto per rovinare i poveri apprendisti: cos’è mai una misera pastinaca rispetto al nostro buon cuore?UN ALTRO WILLIAMSON Schifezze, schifezze! Infiammano gli occhi, e questo basta per impestare la città con un’ondata di paralisi cerebrale[viii].
LINCOLN
 Con quella l’hanno già impestata: queste bastarde piante del letame (lo sapete, no? che crescono nel letame!) ci hanno impestato, e la nostra infezione farà tremare tutta la città, cosa che in parte succede a mangiar pastinache.
Con quella l’hanno già impestata: queste bastarde piante del letame (lo sapete, no? che crescono nel letame!) ci hanno impestato, e la nostra infezione farà tremare tutta la città, cosa che in parte succede a mangiar pastinache.UN ALTRO CLOWN BETTS
 È vero, e anche le zucche.
È vero, e anche le zucche.- Entra [una guardia del corpo del re]
GUARDIA
 Che cosa rispondete alla clemenza del re? La rifiutate?
Che cosa rispondete alla clemenza del re? La rifiutate?LINCOLN
 Vorreste prenderci in contropiede, non è vero? Niente affatto, non la rifiutiamo. Accettiamo la clemenza del re, ma non avremo compassione degli stranieri.
Vorreste prenderci in contropiede, non è vero? Niente affatto, non la rifiutiamo. Accettiamo la clemenza del re, ma non avremo compassione degli stranieri.GUARDIA
 Siete gli esseri più ingenui che si siano mai infilati in un pasticcio del genere.
Siete gli esseri più ingenui che si siano mai infilati in un pasticcio del genere.LINCOLN
 Che ne dite adesso, apprendisti? Apprendisti ingenui? Diamogli una lezione.
Che ne dite adesso, apprendisti? Apprendisti ingenui? Diamogli una lezione.TUTTI
 Apprendisti ingenui? Ingenui noi?
Apprendisti ingenui? Ingenui noi?- Entrano il sindaco, Surrey, Shrewsbury, [Moro, Palmer]
SHREWSBURY SINDACO
 Fermi, in nome del re, fermi!
Fermi, in nome del re, fermi!SURREY
 Amici, maestri, compatrioti...
Amici, maestri, compatrioti...SINDACO
 Silenzio, oh, silenzio! Vi ordino di stare calmi!
Silenzio, oh, silenzio! Vi ordino di stare calmi!SHREWSBURY
 Maestri miei, compatrioti...
Maestri miei, compatrioti...SHERWIN WILLIAMSON
 Il nobile conte di Shrewsbury! Ascoltiamolo!
Il nobile conte di Shrewsbury! Ascoltiamolo!GEORGE BETTS
 Vogliamo sentire il conte di Surrey!
Vogliamo sentire il conte di Surrey!LINCOLN
 Il conte di Shrewsbury!
Il conte di Shrewsbury!GEORGE BETTS
 Vogliamo sentirli tutti e due!
Vogliamo sentirli tutti e due!TUTTI I CITTADINI
 Tutti e due, tutti e due, tutti e due, tutti e due!
Tutti e due, tutti e due, tutti e due, tutti e due!LINCOLN
 Silenzio, vi dico, silenzio! Siete persone assennate o che cosa?
Silenzio, vi dico, silenzio! Siete persone assennate o che cosa?SURREY
 Tutto quel che volete, tranne che persone di buon senso.
Tutto quel che volete, tranne che persone di buon senso.ALCUNI CITTADINI
 Non vogliamo sentire lord Surrey!
Non vogliamo sentire lord Surrey!ALTRI CITTADINI
 No, no, no, no, no! Shrewsbury, Shrewsbury!
No, no, no, no, no! Shrewsbury, Shrewsbury!MORO
 Hanno oltrepassato l’argine dell’obbedienza, e così travolgeranno ogni cosa.
Hanno oltrepassato l’argine dell’obbedienza, e così travolgeranno ogni cosa.LINCOLN
 Parla lo sceriffo[ix] Moro! Vogliamo sentirlo, lo sceriffo Moro?
Parla lo sceriffo[ix] Moro! Vogliamo sentirlo, lo sceriffo Moro?DOLL
 Sentiamolo! Il suo è uno sceriffato[x] generoso, e ha fatto diventare mio fratello, Arthur Watchins, attendente del sergente Safe. Sentiamo lo sceriffo Moro!
Sentiamolo! Il suo è uno sceriffato[x] generoso, e ha fatto diventare mio fratello, Arthur Watchins, attendente del sergente Safe. Sentiamo lo sceriffo Moro!TUTTI I CITTADINI
 Sceriffo Moro, Moro, Moro, sceriffo Moro!
Sceriffo Moro, Moro, Moro, sceriffo Moro!MORO
 Secondo l’autorità in vigore fra di voi, ordinategli di ascoltare in silenzio.
Secondo l’autorità in vigore fra di voi, ordinategli di ascoltare in silenzio.ALCUNI CITTADINI
 Surrey, Surrey!
Surrey, Surrey!ALTRI CITTADINI
 Moro, Moro!
Moro, Moro!LINCOLN e GEORGE BETTS
 Zitti, zitti, silenzio, zitti!
Zitti, zitti, silenzio, zitti!MORO
 Voi che avete autorità e credito presso la folla, ordinategli di fare silenzio.
Voi che avete autorità e credito presso la folla, ordinategli di fare silenzio.LINCOLN
 Gli venga un accidente, non vogliono star zitti. Neanche il diavolo può governarli.
Gli venga un accidente, non vogliono star zitti. Neanche il diavolo può governarli.MORO
 Che incarico spinoso e difficile avete, guidare gente che neanche il diavolo è in grado di governare. Cari maestri, ascoltate le mie parole.
Che incarico spinoso e difficile avete, guidare gente che neanche il diavolo è in grado di governare. Cari maestri, ascoltate le mie parole.DOLL
 Sì, corpo di Cristo, vi ascolteremo, Moro. Siete un buon padrone di casa, e ringrazio vostra altezza per mio fratello Arthur Watchins.
Sì, corpo di Cristo, vi ascolteremo, Moro. Siete un buon padrone di casa, e ringrazio vostra altezza per mio fratello Arthur Watchins.TUTTI GLI ALTRI CITTADINI
 Zitti, pace!
Zitti, pace!MORO
 Attenti, voi offendete proprio quello che invocate, cioè la pace. Nessuno di voi sarebbe qui presente, se quando eravate bambini fossero vissuti dei vostri simili che avessero travolto[xi] la pace come voi volete fare adesso; quella pace in cui finora siete cresciuti vi sarebbe stata tolta, e i tempi sanguinari non vi avrebbero permesso di diventare adulti. Poveri voi! Che cosa otterrete se anche vi concediamo quello che cercate?
Attenti, voi offendete proprio quello che invocate, cioè la pace. Nessuno di voi sarebbe qui presente, se quando eravate bambini fossero vissuti dei vostri simili che avessero travolto[xi] la pace come voi volete fare adesso; quella pace in cui finora siete cresciuti vi sarebbe stata tolta, e i tempi sanguinari non vi avrebbero permesso di diventare adulti. Poveri voi! Che cosa otterrete se anche vi concediamo quello che cercate?GEORGE BETTS
 Per la Madonna, mandar via gli stranieri, cosa che senz’altro porterà grandissimo vantaggio ai poveri artigiani della città.
Per la Madonna, mandar via gli stranieri, cosa che senz’altro porterà grandissimo vantaggio ai poveri artigiani della città.MORO
 Mettiamo che vengano allontanati, e mettiamo che la vostra baraonda abbia soffocato[xii] tutta l’autorità reale dell’Inghilterra. Immaginate di vedere i disgraziati stranieri trascinarsi verso la costa e i porti per imbarcarsi, con i loro miseri bagagli e i bambini dietro[xiii], mentre voi ve ne state a soddisfare i vostri desideri come sovrani, con le autorità ammutolite dal vostro berciare e voi tronfi nella gorgiera della vostra arroganza: che cosa avrete ottenuto? Ve lo dico io: avrete mostrato come la superbia e la forza possono prevalere e come l’ordine può essere distrutto. Ma in questo schema di cose non uno di voi giungerebbe alla vecchiaia, poiché altri furfanti, seguendo le loro ubbie, con identiche mani, identiche ragioni e identico diritto, vi spolperebbero, e gli uomini si divorerebbero fra loro come pesci voraci.
Mettiamo che vengano allontanati, e mettiamo che la vostra baraonda abbia soffocato[xii] tutta l’autorità reale dell’Inghilterra. Immaginate di vedere i disgraziati stranieri trascinarsi verso la costa e i porti per imbarcarsi, con i loro miseri bagagli e i bambini dietro[xiii], mentre voi ve ne state a soddisfare i vostri desideri come sovrani, con le autorità ammutolite dal vostro berciare e voi tronfi nella gorgiera della vostra arroganza: che cosa avrete ottenuto? Ve lo dico io: avrete mostrato come la superbia e la forza possono prevalere e come l’ordine può essere distrutto. Ma in questo schema di cose non uno di voi giungerebbe alla vecchiaia, poiché altri furfanti, seguendo le loro ubbie, con identiche mani, identiche ragioni e identico diritto, vi spolperebbero, e gli uomini si divorerebbero fra loro come pesci voraci.DOLL
 Dio mi sia testimone, questo è vero come il vangelo.
Dio mi sia testimone, questo è vero come il vangelo.GEORGE BETTS LINCOLN
 Sì, questo è uno pieno di buon senso, parola mia. Stiamo attenti a quello che dice.
Sì, questo è uno pieno di buon senso, parola mia. Stiamo attenti a quello che dice.MORO
 Miei cari amici, lasciate che sottoponga un’ipotesi alla vostra riflessione. Se ci pensate bene, vi accorgerete quale forma orribile hanno in sé le vostre novità rivoluzionarie. Anzitutto, è un peccato verso il quale l’Apostolo ci ha ammonito spesso di stare in guardia, raccomandandoci di obbedire alle autorità [xiv: Si riferisce al noto passo di S. Paolo, Romani 13.1-2]; e non sbaglierei se vi dicessi che voi siete insorti contro Dio.
Miei cari amici, lasciate che sottoponga un’ipotesi alla vostra riflessione. Se ci pensate bene, vi accorgerete quale forma orribile hanno in sé le vostre novità rivoluzionarie. Anzitutto, è un peccato verso il quale l’Apostolo ci ha ammonito spesso di stare in guardia, raccomandandoci di obbedire alle autorità [xiv: Si riferisce al noto passo di S. Paolo, Romani 13.1-2]; e non sbaglierei se vi dicessi che voi siete insorti contro Dio.TUTTI I CITTADINI
 Santa Vergine, che Dio non voglia!
Santa Vergine, che Dio non voglia!MORO
 Eppure è così, perché al re Dio prestò il proprio ufficio di terrore, giustizia, potere e comando. A lui ingiunse di governare e volle che voi obbediste. E per aggiungere a questo una più ampia maestà, prestò al re non soltanto la sua figura, il trono e la spada, ma gli diede il suo stesso nome, chiamandolo dio in terra. Che cosa fate dunque voi, ribellandovi contro un uomo insediato da Dio in persona, se non ribellarvi contro Dio? Facendo così, che cosa fate alle vostre anime? Oh sconsiderati, lavate di lacrime le vostre menti corrotte; e le stesse mani che da ribelli levate contro la pace, a favore della pace alzatele, e le vostre ginocchia sacrileghe trasformatele in piedi. Inginocchiarsi per il perdono è la guerra [xv] più sicura che potete fare voi, la cui tattica[xvi] è la ribellione. Su, su, tornate a obbedire! Perfino questa sommossa può proseguire solo con l’obbedienza. Ditemi soltanto: quando una rivolta sta per scoppiare, quale capopopolo è in grado di sedare la turba nel proprio nome? Chi vuole obbedire a un traditore? O quanto bene suonerà l’elezione di qualcuno che come titolo abbia solo quello di ‘ribelle’ per definire un ribelle?
Eppure è così, perché al re Dio prestò il proprio ufficio di terrore, giustizia, potere e comando. A lui ingiunse di governare e volle che voi obbediste. E per aggiungere a questo una più ampia maestà, prestò al re non soltanto la sua figura, il trono e la spada, ma gli diede il suo stesso nome, chiamandolo dio in terra. Che cosa fate dunque voi, ribellandovi contro un uomo insediato da Dio in persona, se non ribellarvi contro Dio? Facendo così, che cosa fate alle vostre anime? Oh sconsiderati, lavate di lacrime le vostre menti corrotte; e le stesse mani che da ribelli levate contro la pace, a favore della pace alzatele, e le vostre ginocchia sacrileghe trasformatele in piedi. Inginocchiarsi per il perdono è la guerra [xv] più sicura che potete fare voi, la cui tattica[xvi] è la ribellione. Su, su, tornate a obbedire! Perfino questa sommossa può proseguire solo con l’obbedienza. Ditemi soltanto: quando una rivolta sta per scoppiare, quale capopopolo è in grado di sedare la turba nel proprio nome? Chi vuole obbedire a un traditore? O quanto bene suonerà l’elezione di qualcuno che come titolo abbia solo quello di ‘ribelle’ per definire un ribelle?
 Voi volete schiacciare gli stranieri, ucciderli, tagliargli la gola, impadronirvi delle loro case e condurre al guinzaglio[xvii] la maestà della legge, per aizzarla come un segugio. Ahimè, ahimè! Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora? Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in Francia o nelle Fiandre, in qualsiasi provincia della Germania, in Spagna o in Portogallo, anzi no, un luogo qualunque diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
Voi volete schiacciare gli stranieri, ucciderli, tagliargli la gola, impadronirvi delle loro case e condurre al guinzaglio[xvii] la maestà della legge, per aizzarla come un segugio. Ahimè, ahimè! Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora? Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in Francia o nelle Fiandre, in qualsiasi provincia della Germania, in Spagna o in Portogallo, anzi no, un luogo qualunque diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
 Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che, in un’esplosione di odiosa violenza, non vi offrisse dimora sulla terra, affilasse i suoi detestabili coltelli sulle vostre gole, vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli, o che gli elementi naturali non fossero stati fatti per il vostro benessere ma riservati per legge esclusivamente a loro? Che cosa pensereste se vi trattassero così? Questa è la condizione degli stranieri, e questa la vostra barbara disumanità.
Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che, in un’esplosione di odiosa violenza, non vi offrisse dimora sulla terra, affilasse i suoi detestabili coltelli sulle vostre gole, vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli, o che gli elementi naturali non fossero stati fatti per il vostro benessere ma riservati per legge esclusivamente a loro? Che cosa pensereste se vi trattassero così? Questa è la condizione degli stranieri, e questa la vostra barbara disumanità.TUTTI I CITTADINI
 In fede, dice la verità. Facciamo agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi stessi.
In fede, dice la verità. Facciamo agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi stessi.TUTTI I CITTADINI LlNCOLN
 Ci faremo governare da voi, mastro Moro, se ci sarete amico e ci procurerete il perdono.
Ci faremo governare da voi, mastro Moro, se ci sarete amico e ci procurerete il perdono.MORO
 Sottomettetevi a questi nobili signori[xviii], implorate la loro mediazione presso il Re, assumete un comportamento ortodosso, obbedite al magistrato, e senza dubbio troverete misericordia, se la cercate in questo modo.
Sottomettetevi a questi nobili signori[xviii], implorate la loro mediazione presso il Re, assumete un comportamento ortodosso, obbedite al magistrato, e senza dubbio troverete misericordia, se la cercate in questo modo.* Fonte: Nuovi Argomenti, Dic 18, 2017 (ripresa parziale, senza le note).
- LEZIONE DELL’APOSTOLO PAOLO:
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA). CON HEGEL, MA A RICOMINCIARE DA .DIOTIMA DI MANTINEA11 luglio 2023, di Federico La Sala
HEGELISMO, PLATONISMO, FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA)*
- "SÀPEREAUDE! (KANT, 1784): "IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, IL PRIMO E L’ULTIMO" (#APOCALISSE, 1.11).
- CON HEGEL, MA A RICOMINCIARE DA DIOTIMA DI MANTINEA, DANTE ALIGHIERI, GALILEO GALILEI, IMMANUEL KANT...
- ELEUSIS 2023.
"MENSCHWERDUNG" ("DIVENTARE UN ESSERE UMANO"). "Dio è amore" ("Deus charitas est"), condivido (è una questione di "h": "Charitas", gr. "Xapitas"). Hegel ha messo il dito nella piaga: "La vita di Dio e il conoscere divino potranno bene venire espressi come un gioco dell’#amore ["ein Spielen der Liebe"] con se stesso; questa idea degrada fino all’edificazione e addirittura all’insipidezza, quando mancano la serietà, il dolore, la pazienza e il travaglio ["Arbeit"] del negativo" ("Fenomenologia dello Spirito", §19).
 A ben "orientarsi nel pensiero" (Kant) e, al contempo, nel sollecitare una ri-considerazione unitaria della "Prefazione" ("Vorrede") della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel e la figura della profetessa di Mantinea, Diotima, a mio parere, emerge chiaramente il #nodo antropologico di fronte a cui Hegel si è trovato e che ha sciolto in modalità tragica, edipica e paolina, con tutta la "socratica" potenza di un #Napoleone (Alessandro Magno); non con lo spirito del #Logos (di Eraclito e dell’evangelista Giovanni) né della #Giustizia di Parmenide, egli ruba "alla #Platone" l’anima a Diotima ("Simposio") e ripropone una demiurgica e demogorgonica #cosmoteandria t(al)ebana: "[...] che il vero sia effettuale solo come sistema o che la sostanza sia essenzialmente soggetto ciò è espresso in quella rappresentazione che enuncia l’#assoluto come #spirito - elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua #religione" (Fenom. d. spir., § 22).
A ben "orientarsi nel pensiero" (Kant) e, al contempo, nel sollecitare una ri-considerazione unitaria della "Prefazione" ("Vorrede") della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel e la figura della profetessa di Mantinea, Diotima, a mio parere, emerge chiaramente il #nodo antropologico di fronte a cui Hegel si è trovato e che ha sciolto in modalità tragica, edipica e paolina, con tutta la "socratica" potenza di un #Napoleone (Alessandro Magno); non con lo spirito del #Logos (di Eraclito e dell’evangelista Giovanni) né della #Giustizia di Parmenide, egli ruba "alla #Platone" l’anima a Diotima ("Simposio") e ripropone una demiurgica e demogorgonica #cosmoteandria t(al)ebana: "[...] che il vero sia effettuale solo come sistema o che la sostanza sia essenzialmente soggetto ciò è espresso in quella rappresentazione che enuncia l’#assoluto come #spirito - elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua #religione" (Fenom. d. spir., § 22).
 A che gioco giochiamo, a che giogo vogliamo continuare a giocare? Non è meglio, forse, riprendere il filo proprio da Diotima e, con Dante Alighieri ("Due Soli") e portarsi fuori dalla tragedia dei "Tempi moderni" (Charlie Chaplin)?
A che gioco giochiamo, a che giogo vogliamo continuare a giocare? Non è meglio, forse, riprendere il filo proprio da Diotima e, con Dante Alighieri ("Due Soli") e portarsi fuori dalla tragedia dei "Tempi moderni" (Charlie Chaplin)?P. S. 1 - «Senza Hegel non sarebbe stato possibile neppure Darwin, afferma Nietzsche, e l’avrebbe potuto dire anche di se stesso; infatti chi si ammali una volta di hegelite - così mordacemente si era espresso un decennio prima - non ne guarirà mai del tutto. E che cosa sarebbe la critica alla religione di Fuerbach e di Marx, o anche quella odierna di Ernst Bloch e Georg Lukács senza Hegel?» (Hans Küng, "Incarnazione di Dio. Introduzione al pensiero teologico di Hegel, prolegomeni ad una futura cristologia", Queriniana, 1972).
P. S. 2 - EUROPA: CRISTIANESIMO CATTOLICESIMO COSTITUZIONE E SPIRITO DI ASSISI (1986). Quando Benedetto Croce pubblicò il suo «Perché non possiamo non dirci "cristiani"» (1942), don Giuseppe De Luca ’confessò’ al Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai: si è "rincristianito per dispetto". Come concordato...!!!
*
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E COSMOLOGIA: UN PIANETA TERRA DA RIPENSARE, ALLA LUCE DEL SOLE.9 luglio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA.
UN PIANETA TERRA DA RIPENSARE E UN IMMAGINARIO DA RISTRUTTURARE: PENSARE L’ EDIPO COMPLETO (S. FREUD). UNA QUESTIONE DI ILLUMINAZIONE (E DI ILLUMINISMO KANTIANO): "NOI ALUNNI DEL SOLE". In memoria di Italo Calvino.
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità" ("Schopenhauer come educatore").
Appunti su un tema del "genere" (il Sole, l’astro del cielo, un dio o una dea?):
A) IL SOLE ("DIE SONNE") DI ZARATHUSTRA (NIETZSCHE):
"Quand’ebbe compiuto il trentesimo anno, Zarathustra lasciò la sua patria e il lago natìo, e si recò su la montagna. Là per dieci anni gioì, senza stancarsene, del suo spirito e della sua solitudine.
 Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
 «Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
«Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
 Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
 Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");
Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");- "Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahr nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, - und eines Morgens stand er mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also:
 “Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
“Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
 Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
B) MITOLOGIA NORRENA ("EDDA DI SNORRI"). LA SIGNORA DEL SOLE ("FRAU SUNNE"):
 "Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);
"Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);C) AMATERASU ("LA DEA DEL SOLE"):
 "Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);
"Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);D) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E PSICOANALISI. L’ESISTENZA DEL "COMPLESSO EDIPICO COMPLETO" (S. FREUD, 1923);
 "[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
"[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
 Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante).
Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante). -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ARCHEOLOGIA FILOLOGIA E MUSICA: PITAGORA, TEANO, E "VIVA VERDI",30 giugno 2023, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, FILOLOGIA, ILLUMINAZIONE E ANTROPOLOGIA: "SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784).
Un omaggio a Flavio Piero Cuniberto e alla sua riflessione sul
- MASCHILE E FEMMINILE, TRA PITAGORA E MARIA MADDALENA.
- (Nell’immagine: Teano, filosofa pitagorica)
- Quando Policrate lo interroga sul numero dei discepoli che formano il «filosofico arengo», la comunità pitagorica di Crotone, il maestro risponde con un piccolo enigma aritmetico: «Ecco, Policrate: c’è una metà che si dedica a fondo a fascinosi problemi di calcolo; un quarto s’affanna sulla natura immortale; d’un settimo, tutta la cura sta nel silenzio totale, nel dialogo interno perenne; t r e s o n o d o n n e, ed eccelle su tutte le altre Teano» (Antologia Palatina, a cura di Filippo Maria Pontani, vol.IV, Einaudi).
- Risolvendo il piccolo enigma (un mezzo + un quarto + un settimo + tre), si scopre che i membri del tiaso sono 28. La Commissione per le Pari Opportunità avrebbe qualcosa da ridire: le donne sono s o l o tre. Ma guardacaso l’unico discepolo nominato nell’epigramma è proprio una donna, Teano, che «eccelle su tutte le altre». (Secondo la tradizione, Teano sarebbe la figlia, o più probabilmente la moglie di Pitagora).
- Considerando che nel Simposio platonico l’iniziatrice di Socrate ai Grandi Misteri è la misteriosa Diotima da Mantinea, si potrebbe concludere che tra Pitagora e Platone le donne filosofe (meglio: le donne «iniziate») sono poche ma buonissime. In fondo è così anche nei primi anni del cristianesimo: quando in apparenza il predominio maschile-patriarcale è schiacciante (gli Apostoli sono tutti maschi), ma la prima a vedere il Risorto è Maria Maddalena. E sul famoso «noli me tangere» che il Risorto le rivolge ci sarebbe molto da dire (è la risposta dovuta a chi ha raggiunto un grado spirituale molto elevato: molto più elevato per esempio dell’apostolo Tommaso, che vuole mettere ottusamente il dito nella piaga del costato, da maschio materialista). (Flavio Piero Cuniberto, Fb., 27 giugno 2023).
***
HAMLETICA: LA PORTA DELLA CAVERNA E LA QUESTIONE DEL NOME. Gloria a Pitagora, e a Teano ("Viva Verdi"), ma non confondiamo la "furbata" di Socrate che, al "Convivio" di Platone, si porta dietro il ricordo (falso e bugiardo) del discorso di Diotima, di cui ribalta tutto il senso sia sul piano materialistico sia idealistico! Dopo interi millenni di labirinto (Nietzsche) e, dopo aver perso l’Italia e la Costituzione, si hanno ancora grandi difficoltà a ricordarsi di M_Arianna, di Maria Maddalena, e di Maria Beatrice (Dante-2021), e si continua a vivere allucinatamente nella illuminata caverna del platonico Mentitore? Tra l’alto dell’Acropoli e il basso dell’Agorà, nella città di Pitagora, come di Parmenide e Zenone, c’è il ponte (un viadotto), non una "Porta Rosa" d’accesso alla fabbrica del "plateale" camuffato Demiurgo acropolitano.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO"): PARMENIDE, PLATONE, IL "CORPO DEL SIGNORE", ED ELEUSI (11 MAGGIO 2023).11 giugno 2023, di Federico La Sala
ARTE, FILOLOGIA, "NASCITA DELLA TRAGEDIA" (NIETZSCHE), E
 QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO", 1888):
QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("ECCE HOMO", 1888):- "CORPUS DOMINI" ED "EU-CHARIS-TIA" (CHARITAS, gr. XAPITAS).
- EUROPA, 11 MAGGIO 2023. Un "invito" a una riflessione filosofica e un omaggio al prof. Flavio Piero Cuniberto e a un suo breve testo, intitolato "CORPUS DOMINI", composto dall’associazione della foto dell’opera di "Jean-Auguste-Dominique Ingres, Madonna dell’Ostia (part.), 1841; Mosca, Museo Pushkin.", e dalla seguente citazione, ripresa da un’opera di Platone, "L’ essere che realmente è, senza colore, senza forma, non apparente [...] occupa questo luogo. [...] e [l’anima] contemplando il vero se ne nutre e ne gode" (Fedro 247 c-d).".
PLATONE E "NOI", OGGI (11MAGGIO 2023). MESSA A MORTE LA #GIUSTIZIA (#DIKE) DI #PARMENIDE, #PLATONE SALE SULL’ACROPOLI E DICHIARA: "IO, PLATONE, SONO LA [DEA DELLA] #VERITÀ". "L’essere che realmente è, senza colore, senza forma, non apparente [...] occupa questo luogo. [...] e [l’anima] contemplando il vero se ne nutre e ne gode" (Fedro 247 c-d).
ELEUSIS_2023. Abbandonata "M_Arianna", interi millenni di labirinto ... nella ’invisibile’ caverna plutonica (ricordando Demetra ed Eleusis).
Dopo #Dante2021, ancora in un profondissimo #letargo (Pd., XXXIII, 94)!
P. S. - Su Platone, oggi, alcuni appunti per una possibile diversa "lettura": nelle Università e nelle Accademie (laiche e devote) si insegna ancora a credere che Aristofane scherzasse su #Socrate!
HAMLETICA: FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), LINGUISTICA, E "COSTRUZIONI NELL’ ANALISI" (FREUD). Un omaggio a Shakespeare, alla "question" di Hamlet (Amleto, e a Ferdinand de #Saussure. In #principio era il #Logos, non un #logo...
*
EUROPA, CRISTIANESIMO E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ": IL "CORPO DEL SIGNORE ("CORPUS DOMINI)" E L’ EUCARISTIA (Eu-charis-tia").
 Due note:
Due note:A) SACRAMENTALISMO. "Il termine #sacramentalismo descrive il sistema concettuale e pratico attraverso il quale in particolare la Chiesa cattolica romana, ma anche il #cristianesimo ortodosso comprende la funzione e l’uso dei #sacramenti come mezzi mediante i quali la #grazia di Dio verrebbe impartita ai fedeli. Esso è strettamente legato alla figura del #sacerdote [...]" (https://it.wikipedia.org/wiki/Sacramentalismo);
B) SACRAMENTARISMO. "Si definisce sacramentismo o #sacramentarismo il movimento di opposizione, sviluppatosi nei Paesi Bassi alla fine del Medioevo, alla tradizionale teologia eucaristica e alle relative pratiche devozionali, consistente nel #rifiuto della dottrina della transustanziazione e della messa intesa come ripetizione del #sacrificio di Cristo, dando alla comunione, la cena del #Signore, un carattere simbolico e commemorativo.
 A definire sacramentisti o sacramentari i seguaci di tale movimento furono le stesse autorità ecclesiastiche, per le quali sacramentarius era chiunque sostenesse che ogni sacramento era soltanto un #segno, senza che nella cerimonia avvenisse alcuna alterazione della materia sacramentale. Anche Lutero, creatore della teoria della consustanziazione, chiamò sacramentari i suoi avversari nella controversia eucaristica che ebbe con Carlostadio, Ecolampadio, Schwenckfeld e Zwingli, quest’ultimo il più autorevole sostenitore del carattere simbolico della comunione. [...]
A definire sacramentisti o sacramentari i seguaci di tale movimento furono le stesse autorità ecclesiastiche, per le quali sacramentarius era chiunque sostenesse che ogni sacramento era soltanto un #segno, senza che nella cerimonia avvenisse alcuna alterazione della materia sacramentale. Anche Lutero, creatore della teoria della consustanziazione, chiamò sacramentari i suoi avversari nella controversia eucaristica che ebbe con Carlostadio, Ecolampadio, Schwenckfeld e Zwingli, quest’ultimo il più autorevole sostenitore del carattere simbolico della comunione. [...]
 Alla crescita del movimento sacramentario fece seguito la reazione dell’Inquisizione. La prima vittima fu Lauken van Moeseken, decapitato nel 1518 a Bruxelles; l’ex-prete Jan de Bakker fu bruciato a L’Aja nel 1525, mentre la prima donna a morire per la sua fede fu Wendelmoet Claesdochter, strangolata e bruciata nel 1527. Negli interrogatori dichiarò che il sacramento dell’altare era « solo pane e farina» e, riferendosi all’estrema unzione, che « l’olio è buono per l’insalata e per lucidare le scarpe». Sul patibolo, rifiutando il crocifisso, dichiarò: «Il mio Dio e Signore non è questo. Il mio Signore è in me e io in lui ».[...]"(https://it.wikipedia.org/wiki/Sacramentarismo).
Alla crescita del movimento sacramentario fece seguito la reazione dell’Inquisizione. La prima vittima fu Lauken van Moeseken, decapitato nel 1518 a Bruxelles; l’ex-prete Jan de Bakker fu bruciato a L’Aja nel 1525, mentre la prima donna a morire per la sua fede fu Wendelmoet Claesdochter, strangolata e bruciata nel 1527. Negli interrogatori dichiarò che il sacramento dell’altare era « solo pane e farina» e, riferendosi all’estrema unzione, che « l’olio è buono per l’insalata e per lucidare le scarpe». Sul patibolo, rifiutando il crocifisso, dichiarò: «Il mio Dio e Signore non è questo. Il mio Signore è in me e io in lui ».[...]"(https://it.wikipedia.org/wiki/Sacramentarismo).Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- STORIA, FILOLOGIA, E PSICOANALISI: LA "PIETAS" DELLA TRADIZIONE DI ROMA E LA "CARITAS ROMANA".9 giugno 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA ANTROPOLOGIA, E PSICOANALISI
LA "PIETAS" DELLA TRADIZIONE DI ROMA E LA "CARITAS ROMANA" NELLA STORIA DELL’ARTE E NELLA LETTERATURA.
ALCUNE NOTE SULLA "PRIMA LEGGE DI NATURA"
- "PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA": In somma da tutto ciò, che si è in quest’Opera ragionato, è da finalmente conchiudersi; che questa Scienza porta indivisibilmente seco lo Studio della Pietà; e che, se non siesi pio, non si può daddovero esser saggio." (Giambattista Vico, 1744).
"CARITAS ROMANA"- In Valerio Massimo (sua è la fonte da cui proviene il racconto, ripreso poi da Giovanni Boccaccio, in "De mulieribus claris", con il titolo "Una Giovanetta Romana"), la figlia allatta la vecchia madre in carcere; nella tradizione artistica diventa invece la figlia che allatta il vecchio padre in carcere.
AMORE (CHARITAS): "COME NASCONO I BAMBINI". Come mai questa sottolineatura rappresentativa della giovane donna che allatta il vecchio padre nell’immaginario culturale europeo che ha quasi cancellata l’altra, quella della figlia che allatta la vecchia madre?! Non è tempo di svegliarsi dal sonno dogmatico (Kant) e avere il coraggio di pensare il "complesso edipico completo" (S. Freud) e imparare ad amare il padre e la madre?:
A) LA PIETAS COME ORIGINE DI TUTTE LE VIRTÙ: "Un pretore consegnò al triumviro una donna di nobile stirpe condannata alla pena capitale presso il suo tribunale affinché fosse uccisa in carcere. Colui che era a capo della custodia, dopo averla presa, mosso da misericordia non la strangolò subito: diede anche il permesso alla figlia di andare da lei, ma diligentemente perquisita affinché non portasse del cibo, ritenendo che sarebbe morta di fame. Poiché trascorsero molti giorni, lui stesso si chiedeva con che cosa mai riuscisse a sostentarsi così a lungo, osservando la figlia con più attenzione si accorse che quella, denudando il petto, placava la fame della madre con l’aiuto del suo latte.
 Di uno spettacolo così straordinario quella novità fu portata da lui stesso al triumviro, dal triumviro al pretore, dal pretore al consiglio dei giudici, e procurò alla donna la remissione della pena.
Di uno spettacolo così straordinario quella novità fu portata da lui stesso al triumviro, dal triumviro al pretore, dal pretore al consiglio dei giudici, e procurò alla donna la remissione della pena.
 A che punto non arriva o cosa non escogita la #pietas, che scoprì un nuovo sistema per salvare una madre dal carcere? Cosa c’è di tanto inusitato, che cosa di tanto inaudito se non che una madre sia nutrita dal petto di sua figlia? Qualcuno potrebbe ritenere questo fatto contro natura, se amare i genitori non fosse la prima legge di natura." ("Factorum et dictorum memorabilium libri IX", cit. da Laura R. Bevilacqua, "UN PANTHEON PER LE VIRTÙ II 13, I QUADERNI DEL RAMO D’ORO ON-LINE n. 10 , 2018).
A che punto non arriva o cosa non escogita la #pietas, che scoprì un nuovo sistema per salvare una madre dal carcere? Cosa c’è di tanto inusitato, che cosa di tanto inaudito se non che una madre sia nutrita dal petto di sua figlia? Qualcuno potrebbe ritenere questo fatto contro natura, se amare i genitori non fosse la prima legge di natura." ("Factorum et dictorum memorabilium libri IX", cit. da Laura R. Bevilacqua, "UN PANTHEON PER LE VIRTÙ II 13, I QUADERNI DEL RAMO D’ORO ON-LINE n. 10 , 2018).B) "LA SCENA PERDUTA" E LA "CARITÀ ROMANA" (ALLA LUCE DELLA PSICOANALISI): "[...] Nell’ultimo romanzo di Abraham B. Yehoshua “La scena perduta”, un anziano regista è invitato ad una retrospettiva dei suoi film, durante la quale gli verrà attribuito un premio. Con sorpresa i film che vengono proiettati sono le sue prime prove cinematografiche e Moses si trova ad assistere alle scene che aveva girato allora, usando come set la casa della propria infanzia: è un ritorno alle origini. [...] La retrospettiva servirà a Moses per ricucire un’antica rottura, la fine della collaborazione con il suo creativo, ispirato, sceneggiatore, colui con cui aveva girato le opere più riuscite della sua carriera. Era successo che, al momento di riprendere la scena finale di un film, frutto della fantasia visionaria dello sceneggiatore, il regista avesse esitato, optando per un’altra conclusione, meno ardita e cruda, tradendo la fiducia nell’intuizione e nelle fonti generose della creatività del collega [...]
 la scena ripudiata riprendeva il tema della Caritas Romana, e raffigura la leggenda meravigliosa di Pero e Cimone, messa per iscritto nel primo secolo d.C. da Valerio Massimo nei suoi Factorum et dictorum memorabilium libri IX . Vi si narra di una giovane donna che allatta il vecchio padre.
la scena ripudiata riprendeva il tema della Caritas Romana, e raffigura la leggenda meravigliosa di Pero e Cimone, messa per iscritto nel primo secolo d.C. da Valerio Massimo nei suoi Factorum et dictorum memorabilium libri IX . Vi si narra di una giovane donna che allatta il vecchio padre.- “Si chiama Cimone ed era stato condannato a morire di fame. Sua figlia andava a fargli visita in segreto e lo allattava perché non morisse. Alla fine i carcerieri la sorpresero in flagrante ma rimasero talmente colpiti dalla sua devozione, audacia e originalità che ebbero pietà del padre e lo lasciarono libero.”
Da Guido Reni a Caravaggio, a Rubens, a Murillo, la storia è stata rappresentata poi da innumerevoli pittori: l’impatto dei dipinti si rivela più forte di quello del #racconto e ogni artista ha cercato di presentare la propria versione. Perfino a #Pompei è riemerso un affresco con questo motivo; a #Budapest esiste una statua in cui la donna che allatta il vecchio sorregge un bambino già sazio, col dito in bocca, quasi pronto per addormentarsi. Nel 1606 #Caravaggio riuscì ad inserire la scena, così scandalosa nella sua carnalità, nella Pala d’altare della chiesa del Pio Monte della #Misericordia di #Napoli, sublimando la sua sensualità nella cornice delle opere di misericordia corporale, “dar da mangiare agli affamati e “visitare i carcerati”.
Allo psicoanalista la “retrospettiva” di Yehoshua evoca subito il termine freudiano di Nachträglickheit, che indica il lavoro psichico che torna a ritroso sul passato, per farlo rivivere in una rinnovata significazione affettiva, ricostruendo ogni volta, insieme al soggetto anche l’oggetto di desiderio. E’ quella ciclica e indispensabile modalità del soggetto di accostarsi alle proprie origini, alle fonti di sé, nel corso delle varie tappe della vita.
La storia di Pero, che col suo latte salva Cimone, incatenato e condannato a morire di fame, può rappresentare una delle diverse e inaspettate forme del ripresentarsi della configurazione edipica e del generoso dono d’amore, Caritas -Agape, all’origine dell’esistenza psichica. Quanto con l’età sarà simbolizzato e acquisterà limite e regola definendo il soggetto (il carcere e le catene di Edipo) all’inizio era unione carnale con la madre, senza confini definiti. Il quadro sconvolgente, che ci parla anche di realtà che a volte si rendono dolorosamente presenti nella crisi della coppia di oggi, mostra come nella figlia riviva la madre, nel vecchio il bambino che era stato.
Nel 1920 la psicoanalista Lou Andreas Salomé, a completamento del concetto di narcisismo primario, ci teneva a ricordare a Freud il valore dell’originario materno e gli proponeva: “Allo stato primario è presente un’identità tra mondo e Io, dove non esistono ricordi”, identità che nell’esperienza di godimento ripresenta “quel non-esser-ancora-Io, quell’esser-tu-e-Io che vigeva all’origine.”
Su questo sentimento di estasi, che Romain Rolland aveva chiamato “sentimento oceanico”, nel 1929 (Il disagio della civiltà) Freud si sarebbe fermato a riflettere, riconoscendo come il senso soggettivo dell’Io sia “soltanto un avvizzito residuo di un sentimento assai più inclusivo, anzi di un sentimento onnicomprensivo che corrispondeva a una comunione quanto mai intima dell’Io con l’ambiente”
Può essere doloroso per l’Io, soprattutto dopo essersi dovuto staccare da un’esperienza così appagante ed aver attraversato con fatica le difficili conquiste che portano alla maturità, alla costituzione dei limiti e della conoscenza, tornare a ripensare all’illimitato e al perturbante rapporto con il femminile originario, per andare nuovamente ad attingere alla fonte della saggezza.
Secondo Luce Irigaray (All’inizio, lei era, 2012), per capire qualcosa del “tra-noi”, sarebbe necessario tornare al mondo e alla filosofia dei presocratici. E’ toccante quello che scrive, e che sembra commentare la scena della Caritas Romana: “All’origine è una lei -natura, donna o Dea- che ispira la verità a un saggio... La totalità del discorso è ancora misteriosamente fondata a partire da lei - natura, donna o Dea - che rimane inaccessibile cosa dalla quale sorgono le parole e alla quale sono rivolte.”
Inoltratosi ormai nella vecchiaia, nel 1935, Freud scriveva a Lou Andreas Salomé: “Quanto buon carattere e umorismo ci vogliono per sopportare l’orribile avanzare dell’età! (...) Il giardino là fuori e i fiori della stanza sono belli, ma la primavera come noi diciamo a Vienna, è una presa in giro. Naturalmente sono sempre affidato alle cure di Anna, proprio come una volta ha osservato Mefistofele (Faust II, 7003): «E si finisce che si dipende dalle creature fatte da noi.»”
- Foto: Mathias Meyvogel Caritas Romana
*Fonte: cfr. Maria Pierri, “Questo è il posto, questa è l’origine”, SpiWeb, 4 marzo 2014 (ripresa parziale).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- OLTRE IL PLATONISMO E IL PAOLINISMO. Una nota a margine dell’articolo "Vedere i concetti" di Alfonso Maurizio Iacono.16 maggio 2023, di Federico La Sala
LA CENA DELLA VITTORIA: PLATONISMO, ILLUMINISMO, E INTERPRETAZIONE DEI SOGNI DEI VISIONARI.
- Una nota a margine dell’articolo "Vedere i concetti" di Alfonso Maurizio Iacono (Doppiozero, 15 maggio 2023). Un invito a cambiare rotta e registro...
ANTROPOLOGIA, ECONOMIA POLITICA E METAFISICA. PREMESSO CHE "Il sapere visuale è una sorta di dannazione della filosofia. Le idee di Platone non sono visibili eppure la radice greca che dà vita alla parola idea ha a che fare con il visibile." (Alfonso M. Iacono), FORSE, è meglio cercare di vedere chi cucina "la cena della vittoria" (B. Brecht), di non affidarsi ai freudolenti "sogni di un visionario", e seguire l’indicazione di Orazio Shakespeare Kant Marx Nietzsche Freud e Foucault: "Sàpere aude!" .
FILOLOGIA E CRITICA: "SÀPERE AUDE!" (ORAZIO/KANT). A ben riflettere, accogliendo l’importante sollecitazione, si tratta di cambiare rotta e registro (oltre il platonismo e il paolinismo) e avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza, di "aprire gli occhi" (Sigmund Freud) sulla lezione evangelica di Gioacchino da Fiore sull’amore ("charitas") e, al contempo, di "sàpere" che cosa "mangiamo" a cena, se "grazia di dio" ("eu-charis-tia") o cibo avvelenato (di una tragica bimillenaria "buona-carestia"). Se non ora, quando?!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA: UNA NOTA SU "LA PASTORALE GENERATIVA" DI "ORIENTAMENTI PASTORALI").24 aprile 2023, di Federico La Sala
GIORNATA DELLA TERRA (2023), MESSAGGIO EVANGELICO E #CONCILIO DI #NICEA (325-2025): #ANTROPOLOGIA, #TEOLOGIA, E #STORIA. Una nota a margine del documento del Centro Orientamento Pastorale (*)
- LA PASTORALE GENERATIVA (INTRODUZIONE AL DOSSIER N. 3/2023 DI ORIENTAMENTI PASTORALI):
- "Nelle nostre prassi pastorali spesso sperimentiamo - non senza sofferenza - il paradosso di una Chiesa che, nata per annunciare e preparare la venuta del Regno, protesa per essenza verso il futuro, venga percepita da molti come relitto malinconico del passato. Vale a dire una realtà che sembra incapace di offrire una parola per l’uomo moderno che vive in ambienti profondamente secolarizzati, in cui è difficile poter incrociare risposte religiose alle proprie domande. Talvolta si ha l’impressione che si stia predicando un vangelo che non è più quello di Gesù, che era capace di penetrare i cuori e toccare l’orizzonte affettivo e progettuale della gente che incontrava. Le sue erano risposte concrete a problemi reali e non preconfezionate o scontate. Le risposte di Gesù erano di un sapore particolare, sapevano di futuro, di un domani sorprendente, capace d’indicare possibilità insperabili. È il «grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa - afferma il papa nella Evangelii gaudium - nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Si sviluppa la psicologia della tomba, che a poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo» (EG, n. 83)." [...]" ("Orientamenti pastorali", 14.04.2023).
- Pastorale: urge un cambio di paradigma: «Occorre un cambiamento di paradigma: dalla trasmissione della fede “a senso unico” alla comune scoperta, in piena sintonia con uno stile sinodale di Chiesa. A ben guardare, non si tratta di un’innovazione, bensì di un ripartire dallo stile di Gesù e dall’esperienza degli inizi del cristianesimo». Pubblichiamo di seguito l’introduzione al Dossier del numero di Orientamenti Pastorali 3/2023 (sommario. La rivista Orientamenti Pastorali è espressione del «Centro di orientamento pastorale» (COP), un’associazione che fedele alla eredità del Concilio Vaticano II contribuisce allo sviluppo della ricerca e dello studio pastorale nella Chiesa italiana, offrendo strumenti di aggiornamento e formazione per le parrocchie e gli operatori pastorali [...]" (cfr. SETTIMANA News, 20.04.2023).
(*)
GIORNATA DELLA TERRA (2023) E MESSAGGIO EVANGELICO (2025).
Pastorale “generativa”? Certissimamente un paradigma interessante per la missione della Chiesa... Ma ad esso, unitamente allo spirito dei profeti, non manca anche e ancora lo spirito delle profetesse, delle sibille!? Non è bene, forse, ri-andare nella Cappella Sistina, guardare in alto, ri-meditare le indicazioni di Michelangelo, e ri-vedere e ri-pensare il “Tondo Doni”, con la sua cornice? Non è bene, dopo 1700 anni da Nicea 325, arrivare al 2025 rinnovando il paradigma e ri-diventare finalmente “bambini”, semplicemente esseri umani, cristiani adulti? Se non ora, quando? (Federico La Sala)
P. S. #COMENASCONOIBAMBINI E #FILOSOFIA (ENZO PACI, "SCUOLA DI MILANO") : "TONDO DONI". #Attenzione - Nella #cornice, è detto che sono"raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti" (Galleria degli Uffizi), ma, per Michelangelo, non sono due profeti e due sibille?!
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE --- ANTROPOLOGIA E "TERRA" DI MARTE: "DANTE 2021" E MISSIONE DI INGENUITY. Note su"Cinquanta voli per l’elicotterino marziano" (di Jacopo Danieli).22 aprile 2023, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E DIVINA COMMEDIA: "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610) E "SAPERE AUDE!"(I. KANT, 1784). Alcuni appunti sul tema dell’antropogenesi (e cristogenesi) nell’opera di Dante...
- FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI ANDROLOGIA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);
- E DELLA SUA COSTRUZIONE DEL "CORPO DI CRISTO": "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (Efesini, 4.1/11-13).
NELL’ANNO DANTE2021, SU MARTE, "INGENUITY" INIZIA LA SUA ATTIVITA’ E LA SUA MISSIONE ESPLORATIVA:
CON ULISSE, OLTRE: VIRTU’ E CONOSCENZA. Ai suoi tempi, Dante ha esplorato con il suo "oudemico" ingegno l’intero "oceano celeste" (Keplero) e, al ritorno, ha raccontato che, trovandosi nel V cielo, quello del Pianeta Marte, rimase colpito da "una melode/ che mi rapiva, sanza intender l’inno (Pd XIV, 101 e 123).
L’INGEGNO, IL GENERE UMANO ("GATTUNGSWESEN"), E LA "TERRA" DI MARTE:
NELL’ANNO 2023, "Lo scorso 13 aprile il piccolo elicottero marziano Ingenuity ha azionato le sue eliche per la 50esima volta, percorrendo 320 metri in poco più di 2 minuti e mezzo, durante i quali ha infranto anche il precedente record di altezza, salendo fino a 18 metri. Ingenuity, che il 19 aprile ha festeggiato i suoi primi due anni su Marte, fu inizialmente concepito come dimostratore tecnologico, un modo cioè per provare che il volo controllato a motore su un altro pianeta fosse possibile. [...]
 Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).
Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).EARTHDAY 2023 #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Il viaggio di Dante e il senso antropologico di sé: "Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine" (Ap., XXII, 13).21 aprile 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, CRISTIANESIMO, ANTROPOLOGIA E LETTERATURA:
- L’ENIGMA DI SAN CRISTOFORO (IL GIGANTE, PORTATORE DEL BAMBINO CRISTO , "CRISTO-FORO" O, ALTRIMENTI, "CRISTO-FARO", "LA LUCE DEL MONDO").
- Una nota in omaggio al lavoro di filologia e storia di Michele Lualdi...
"PSICOLOGIA DELLE MASSE E ANALISI DELL’ IO" (S. FREUD, 1921): DANTE ("Io non Enëa, io non Paulo sono": Inf. II, 32) SA "DOVE METTE CRISTOFORO IL PIEDE" (cfr. Wilhelm Stekel, "Il ’Piccolo Kohn’ ", 1903, tradotto e curato da Michele Lualdi).
"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS", "CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT), E "IDEALE DELL’IO" (S. FREUD). CON GIASONE (OVIDIO) E CON ASTREA (LA "VIRGO" DI VIRGILIO) E MARIA-BEATRICE (LA "VERGINE" DI SAN BERNARDO), DANTE RIPRENDE IL CAMMINO, dall’ INIZIO (dall’Inferno) ma dal PRINCIPIO (Par. XXXIII: "Vergine Madre, figlia del tuo figlio [...] l’amor che move il sole e l’altre stelle") e racconta come è riuscito a ritrovare "LA DIRITTA VIA" e a capire il senso antropologico di sé: "Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine" (Ap., XXII, 13).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MENTE E NATURA: CON BATESON, OLTRE. UNO: RIPARTIRE DA DA DUE, "ALMENO DUE".17 aprile 2023, di Federico La Sala
SPIRITO CRITICO E AMORE CONOSCITIVO: ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA E MATEMATICA:
IMPARARE A #CONTARE. Uscire dall’inferno epistemologico
#UNO: "SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI" (2005). In principio era il Logos (Eraclito, Efeso), non il #logo di una azienda sul cui cancello d’entrata sta scritto "il lavoro rende liberi".
"DUE SOLI" (#DANTE2021). Ri-#pensare l’ONU - a partire da Due, "almeno due" (Gregory Bateson):
- “...per creare una differenza occorrono almeno due cose. Per produrre notizia di una differenza, cioè informazione, occorrono due entità (reali o immaginarie) tali che la differenza tra di esse possa essere immanente alla loro relazione reciproca: e il tutto deve essere tale che la notizia della loro differenza sia rappresentabile come differenza all’interno di una qualche entità elaboratrice di informazioni, ad esempio un cervello, o forse un calcolatore.
 Vi è un problema profondo e insolubile a proposito della natura di quelle ‘almeno due’ cose che tra loro generano la differenza che diventa informazione creando una differenza. È chiaro che ciascuna di esse, da sola, è - per la mente e la percezione - una non-entità, un non-essere. Non è diversa dall’essere e non è diversa dal non-essere: è inconoscibile, una Ding-an-sich, il suono dell’applauso di una mano sola. La materia prima della sensazione, dunque, è una coppia di valori di una qualche variabile, presentati in un certo arco di tempo a un organo di senso la cui risposta dipende dal rapporto tra i due elementi della coppia” (G. Bateson, "Mente e Natura", 1984).
Vi è un problema profondo e insolubile a proposito della natura di quelle ‘almeno due’ cose che tra loro generano la differenza che diventa informazione creando una differenza. È chiaro che ciascuna di esse, da sola, è - per la mente e la percezione - una non-entità, un non-essere. Non è diversa dall’essere e non è diversa dal non-essere: è inconoscibile, una Ding-an-sich, il suono dell’applauso di una mano sola. La materia prima della sensazione, dunque, è una coppia di valori di una qualche variabile, presentati in un certo arco di tempo a un organo di senso la cui risposta dipende dal rapporto tra i due elementi della coppia” (G. Bateson, "Mente e Natura", 1984).
#ELEUSIS2023 #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #EARTHRISE
- “...per creare una differenza occorrono almeno due cose. Per produrre notizia di una differenza, cioè informazione, occorrono due entità (reali o immaginarie) tali che la differenza tra di esse possa essere immanente alla loro relazione reciproca: e il tutto deve essere tale che la notizia della loro differenza sia rappresentabile come differenza all’interno di una qualche entità elaboratrice di informazioni, ad esempio un cervello, o forse un calcolatore.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "L’UOMO È ANTIQUATO": GODOT (BECKETT), CHARLOT (CHAPLIN), E UNA "VECCHIA" INDICAZIONE DI GÜNTHER ANDERS2 aprile 2023, di Federico La Sala
ARTE, CINEMA, ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA E PSICOANALISI: "GÜNTHER ANDERS E LA SCENA ATTUALE".
GODOT (BECKETT) E CHARLOT (CHAPLIN). Tracce per una svolta antropologica: una nota su una "vecchia" indicazione di Günther Anders.
RIPRENDENDO IL DISCORSO DA "ADAMO ED EVA", dalla coppia più famosa della preistoria (laica e devota), sul filo della memoria del lavoro del regista Jim Jarmusch, "Solo gli amanti sopravvivono" ("Only Lovers Left Alive"), un film del 2013, e, al contempo, accogliendo la sollecitazione della rivista "Aut Aut" (397/2023) a riprendere il lavoro di Günther Anders (cfr. "L’uomo è antiquato? Günther Anders e la scena attuale", forse, è opportuno (per "orientarsi nel pensiero") cominciare proprio da "L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’era della seconda rivoluzione industriale" (1956), e, in particolare, dal capitolo intitolato "ESSERE SENZA TEMPO. A proposito di En attendant Godot di Beckett". In questo capitolo, nel "§ 6 Entrano in scena gli antipodi", così è scritto:
- "[...] questi antagonisti si presentano loro [a Estragon e Vladimir] nella coppia Pozzo-Lucky. I tentativi di decifrare questi due personaggi, di scoprire chi siano e che cosa significhino non ha dato meno filo da torcere agli interpreti, che il problema dell’identità di Godot. Ma tutti i tentativi di decifrazione erano mal impostati, perché LA COPPIA STESSA È UNA DECIFRAZIONE. Come sarebbe a dire?
 Beckett, cioè, non ha ridotto a cifra astratta una realtà sensibile, ma si serve di questi due personaggi per trasporre dall’esistenza cifrata e speculativa in quella sensibile, ciò che precedentemente era esistito soltanto in versione concettuale? Che cosa?
Beckett, cioè, non ha ridotto a cifra astratta una realtà sensibile, ma si serve di questi due personaggi per trasporre dall’esistenza cifrata e speculativa in quella sensibile, ciò che precedentemente era esistito soltanto in versione concettuale? Che cosa?
 Sin dall’inizio del decennio 1930-1940, quando in Francia i letterati e i filosofi delle nuove generazioni cominciarono a infervorarsi per la dialettica hegeliana e per la teoria marxista della lotta di classe, la famosa coppia «signore e servo» della Fenomenologia dello spirito si è impressa nella coscienza della generazione nata intorno al 1900, che si può dire senz’altro che oggi ha preso il posto che nel secolo XIX era riservata alla figura di Prometeo; è diventata la pura e semplice immagine dell’uomo [...] Caratteristiche dominanti del nuovo simbolo sono la pluralizzazione e l’antagonismo: ossia il fatto che «l’uomo» è personificato ora da una coppia umana, che il singolo (il quale, selfmade man metafisico, aveva combattuto prometeicamente contro gli dei) è sostituito ora da uomini, precisamente da uomini che si contendono reciprocamente il dominio. [...]. Eppure la commedia di Beckett si differenzia in un punto da quasi tutti quesi documenti nichilistici in cui il presente trova la sua espressione letteraria: nel tono. [...]. Non a caso nessun’altra figura del nostro secolo ha suscitato tanta gratitudine quanto la desolata figura dello Chaplin dei primi film. Sembra che la farsa sia diventata il rifugio dell’amore per il prossimo: la complicità degli sconsolati sia diventata l’ultimo conforto. E se ciò che spunta dal terreno sconsolatamente arido dell’assurdità: il mero tono umano, è un minuscolo conforto; e se il conforto non sa perché conforta e quale Godot promette come conforto - esso dimostra tuttavia che IL CALORE È PIÙ IMPORTANTE DEL SIGNIFICATO; E CHE NON È AL METAFISICO CHE SPETTA L’ULTIMA PAROLA, MA SOLTANTO A COLUI CHE SENTE AMORE PER L’UMANITÀ”.
Sin dall’inizio del decennio 1930-1940, quando in Francia i letterati e i filosofi delle nuove generazioni cominciarono a infervorarsi per la dialettica hegeliana e per la teoria marxista della lotta di classe, la famosa coppia «signore e servo» della Fenomenologia dello spirito si è impressa nella coscienza della generazione nata intorno al 1900, che si può dire senz’altro che oggi ha preso il posto che nel secolo XIX era riservata alla figura di Prometeo; è diventata la pura e semplice immagine dell’uomo [...] Caratteristiche dominanti del nuovo simbolo sono la pluralizzazione e l’antagonismo: ossia il fatto che «l’uomo» è personificato ora da una coppia umana, che il singolo (il quale, selfmade man metafisico, aveva combattuto prometeicamente contro gli dei) è sostituito ora da uomini, precisamente da uomini che si contendono reciprocamente il dominio. [...]. Eppure la commedia di Beckett si differenzia in un punto da quasi tutti quesi documenti nichilistici in cui il presente trova la sua espressione letteraria: nel tono. [...]. Non a caso nessun’altra figura del nostro secolo ha suscitato tanta gratitudine quanto la desolata figura dello Chaplin dei primi film. Sembra che la farsa sia diventata il rifugio dell’amore per il prossimo: la complicità degli sconsolati sia diventata l’ultimo conforto. E se ciò che spunta dal terreno sconsolatamente arido dell’assurdità: il mero tono umano, è un minuscolo conforto; e se il conforto non sa perché conforta e quale Godot promette come conforto - esso dimostra tuttavia che IL CALORE È PIÙ IMPORTANTE DEL SIGNIFICATO; E CHE NON È AL METAFISICO CHE SPETTA L’ULTIMA PAROLA, MA SOLTANTO A COLUI CHE SENTE AMORE PER L’UMANITÀ”.
- P. S. - RICORDANDO OTTO RANK, UNA "NOTA" DI GÜNTHER ANDERS SUL "TRAUMA DELLA NASCITA" DI "PROMETEO": "Dal punto di vista filosofico non si apprezzerà mai abbastanza la scoperta del «trauma della nascita» compiuta da Freud: Che cosa potrebbe toccare di più radicale alla vita, che l’essere strappata dal «fondamento»? Per quanto il linguaggio di Freud sia mascherato dal vocabolario proprio delle scienze naturali dell’epoca, i sentimenti che egli ha messo in evidenza («sentimento oceanico», «impulso di morte») sono assolutamente metafisici. Altrettanto si deve dire del trauma della nascita, in cui egli indicò - mascherato quanto si voglia - lo shock della individuazione. Analogamente alla nostra domanda: «Chi si vergogna?», la domanda che dovrebbe essere posta a proposito di questo trauma sarebbe: «Chi è che subisce lo choc in questo caso?». L’individuo stesso? O non piuttosto, dato che ciò che provoca lo choc è il processo di individuazione, la vita non-ancora-individuata? Non è l’individuo soltanto l’erede di questo spavento, che trascina poi con sè tutta la vita come dolore mai superato di essere individuo? Mi sembra che questa sia stata l’opinione di Freud: Perché il suo «impulso di morte in fondo non è certo altro che la brama del’individuo di liberarsi del tormento di essere individuo" (Cfr. Gunther Anders, "L’uomo è antiquato", cap. "Della vergogna prometeica", nota 32).
#Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "L’UOMO È ANTIQUATO". "L’odierno Prometeo domanda: Chi sono mai?" (Gunther Anders, 11 Marzo 1942).3 aprile 2023, di Federico La Sala
IL "NATUM ESSE", LA "VERGOGNA PROMETEICA", E "IL CONCETTO INESTIRPABILE DELLA DIGNITÀ UMANA"*:
- "L’odierno Prometeo domanda: Chi sono mai?" (Gunther Anders, 11 Marzo 1942).
I. Primo incontro con la vergogna prometeica.
L’odierno Prometeo domanda: Chi sono mai?
Comincio con alcuni appunti di diario presi in California
11 Marzo 1942
Credo di essere capitato sulle tracce di un nuovo pudendum; di un motivo di vergogna che non esisteva in passato. Lo chiamo per il momento, per mio uso, vergogna prometeica, e intendo con ciò "vergogna che si prova di fronte all’umiliante altezza di qualità degli oggetti fatti da noi stessi".
Si è aperta qui un’esposizione tecnica e insieme a T. ho preso parte a una visita guidata. T. si è comportato in modo stranissimo; tanto strano che, da ultimo, osservavo solo lui invece delle macchine esposte. Infatti, non appena uno dei complicatissimi pezzi veniva messo in azione, abbassava gli occhi e ammutoliva. Ancora più curioso il fatto che nascondeva le mani dietro la schiena, come se si vergognasse di aver portato questi suoi arnesi pesanti, goffi e antiquati, all’alto cospetto di apparecchi funzionanti con tanta precisione e raffinatezza. Ma questo "come se si vergognasse" è un’espressione troppo timorosa. Tutto l’insieme del suo comportamento non lasciava adito a dubbi. Gli oggetti di cui conosceva l’esemplarità, la superiorità, l’appartenenza ad una più elevata classe dell’essere, per lui tenevano realmente il posto che per i suoi antenati avevano avuto le autorità o le classi sociali riconosciute superiori. Doversi presentare al cospetto di quei meccanismi perfetti nella sua goffaggine di essere di carne, nella sua imprecisione di creatura, gli era realmente insopportabile; si vergognava davvero.
Se cerco di approfondire questa vergogna prometeica, trovo che il suo oggetto fondamentale, ossia la macchia fondamentale di chi si vergogna, è l’Origine. T. si vergogna di essere divenuto invece di essere stato fatto, di dovere la sua esistenza, a differenza dei prodotti perfetti e calcolati fino nell’ultimo particolare, al processo cieco e non calcolato e antiquatissimo della procreazione e della nascita. La sua onta consiste dunque nel suo natum esse, nei suoi bassi natali; che egli giudica bassi proprio perché sono natali. Ma se egli si vergogna di questa sua origine antiquata, si vergogna naturalmente anche del risultato difettoso e ineluttabile di questa origine: di se stesso. [...]" (cfr. Günther Anders, "L’uomo è antiquato" [1956], cap. "Della vergogna prometeica").
* PER NON PERDERE IL FILO DEL LAVORO DI GÜNTHER ANDERS, RICORDARE QUANTO EGLI SCRIVE NELLA DEDICA ("L’uomo è antiquato", 1956):
- "È passato esattamente mezzo secolo da quando, nel 1906, mio padre William Stern, allora di vent’anni più giovane e di intere generazioni più fiducioso di quanto non sia oggi suo figlio, pubblicò il primo volume della sua opera «Persona e cosa». Non è stato facile fargli perdere la speranza di poter riabilitare «la persona umana» combattendo una psicologia impersonalistica [...]. In memoria di lui, che ha istillato nel figlio il concetto inestirpabile della dignità umana, sono state scritte queste tristi pagine sulla devastazione dell’uomo".
Federico La Sala
- "[...] questi antagonisti si presentano loro [a Estragon e Vladimir] nella coppia Pozzo-Lucky. I tentativi di decifrare questi due personaggi, di scoprire chi siano e che cosa significhino non ha dato meno filo da torcere agli interpreti, che il problema dell’identità di Godot. Ma tutti i tentativi di decifrazione erano mal impostati, perché LA COPPIA STESSA È UNA DECIFRAZIONE. Come sarebbe a dire?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL FALLIMENTO DELLLA "CRISTOLOGIA" DELLA "PACE DELLA FEDE" (1453) E LA COSMOTEANDRIA DEL XXI SECOLO.7 marzo 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA E VITA FUORI DALLA BILANCIA" ("LIFE OUT OF BALANCE").
- APPUNTI PER IL CONGRESSO MONDIALE DI FILOSOFIA ROMA 2024. TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA, PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. In memoria di Immanuel Kant...
COSMOTEANDRIA DEL XXI SECOLO: IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE DELL’UOMO SUPREMO.
 PIANETA TERRA: DOPO 1700 ANNI DAL PRIMO CONCILIO DI NICEA (325), DI "QUALE" ECUMENISMO, LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E L’INTERA EUROPA (LAICA E RELIGIOSA) VUOLE FARE MEMORIA?
PIANETA TERRA: DOPO 1700 ANNI DAL PRIMO CONCILIO DI NICEA (325), DI "QUALE" ECUMENISMO, LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA E L’INTERA EUROPA (LAICA E RELIGIOSA) VUOLE FARE MEMORIA?A) - NICEA 325. "Il concilio di Nicea, tenutosi nel 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano. Venne convocato e presieduto dall’imperatore Costantino I, il quale intendeva ristabilire la pace religiosa e raggiungere l’unità dogmatica, minata da varie dispute, in particolare sull’arianesimo; il suo intento era anche politico, dal momento che i forti contrasti tra i cristiani indebolivano anche la società e, con essa, lo Stato romano. Con queste premesse, il concilio ebbe inizio il 20 maggio del 325. Data la posizione geografica di Nicea, la maggior parte dei vescovi partecipanti proveniva dalla parte orientale dell’Impero (...).
B) STORIA STORIOGRAFIA ED ECUMENISMO: COSTANTINOPOLI E LA "CRISTOLOGIA UMANISTICA". Riprendendo il filo dalla "Dotta Ignoranza" (Niccolò Cusano, 1440), la "Donazione di Costantino" (Lorenzo Valla, 1440, e dalla caduta di Costantinopoli (1453) e il fallimento della proposta "cristologica" del "De pace fidei" (N. Cusano, "La pace della fede", 1453, non è forse tempo di corre ai ripari, di ristrutturare il campo e riequilibrare la bilancia antropologica?!
C) BILANCIA DELLA COSTITUZIONE, BILANCIA DELL’ETICA, E "PACE PERPETUA". Una "foto" per riflettere non solo l’8 marzo 2023, ma anche l’8 marzo 2025...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ECOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E "LINGUAGGIO DEL CAMBIAMENTO".1 marzo 2023, di Federico La Sala
ECOLOGIA DELLA "MENTE ACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA".
Un omaggio al prof. Gianni Vattimo e un augurio di buon lavoro a Elly Schlein.
COME NASCONO I BAMBINI: "LlNGUAGGIO DEL #CAMBIAMENTO. Elementi di comunicazione terapeutica" (Paul Watzlawick): per uscire dalla storica e tragica caverna della cosmoteandria (atea e devota), a mio parere, occorre riprendere il programma di Kant dei "sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica", riaprire la questione antropologica e portare avanti le indicazioni della Scuola di Palo Alto, in particolare, di Paul Watzlawick (1977), e cominciare a pensare con le "due metà del cervello (cfr. Federico La Sala , "Alfabeta" - Rivista, 17, 1980, p.11), sia all’interno e sia all’esterno.
#Metaphysics #Anthropology #Europa2023 #Eleusis2023 #Roma2024
NOTA: L’ITALIA E IL "CORPO MISTICO" DELLA "REGINA" (DELLE PRIMARIE DEL PD, DEL PARTITO DEMOCRATICO).
Cosmoteandria e "disagio della civiltà" (S. Freud, 1929). "Cum grano salis" e. con le dovute proprorzioni, guardando allo #Stato della #Terra (con un #UNO - #ONU - che non esiste ancora), l’evento "Elly Shlein" ha rotto l’incantesimo e ha aperto la porta a un sottile e tuttavia forte vento di sollecitazione antropologica e teologico-politica a ristrutturare il campo e rimettere in sesto i cardini del #tempo (Shakespeare, "Amleto", I.5) e, a svegliarsi dal sonno dogmatico (Kant).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---NELLE "ENCLOSURES", TRACCE DI UN’ALTRA POSSIBILE "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" (ROUSSEAU, BECCARIA, MANZONI, FREUD).28 febbraio 2023, di Federico La Sala
L’ILLUMINISMO LOMBARDO, LA FENOMENOLOGIA "DELLO SPIRITO DELLA FAMIGLIA", E LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA. Un invito a leggere l’opera dell’economista Cesare Beccaria ...
EUROPA2023: STORIA STORIOGRAFIA E FILOLOGIA. Il libro di Cesare Beccaria, "Dei #delitti e delle #pene" (1764), contrariamente a quanto si continua a credere, è un libro tutto da rileggere e da collocare a fianco dell’opera di Jean-Jacques Rousseau, il "DISCORSO SULL’ORIGINE E I FONDAMENTI DELLA DISUGUAGLIANZA FRA GLI UOMINI" (1755):
A) "SOCIETÀ CIVILE" E RECINZIONI ("ENCLOSURES"): «Il primo uomo che, avendo recinto un terreno, ebbe l’idea di proclamare questo è mio, e trovò altri cosí ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile. Quanti #delitti, quante guerre, quanti assassinii, quante miserie, quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i pali o colmando il fosso, avrebbe gridato ai suoi simili: “Guardatevi dall’ascoltare questo impostore; se dimenticherete che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, sarete perduti!”» (J.-J. Rousseau, op. cit.).
B) "DEI DELITTI E DELLE PENE" E IL CAP. XXVI: "DELLO SPIRITO DELLA FAMIGLIA. Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche piú illuminati, ed esercitate dalle repubbliche piú libere, per aver considerato piuttosto la società come un’unione di famiglie che come un’unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l’associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l’associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e nessuno schiavo.
 Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. [...]" (Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", cap. XXVI).
Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. [...]" (Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", cap. XXVI).C) SIGMUND FREUD, LA RECINZIONE DELL’AMORE, E "L’INFELICITÀ NELLA CIVILTÀ" ("Das Ungluck in der Kultur"): "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori [...]" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).
D)PRIMA DI HEGEL E DI MARX, CESARE BECCARIA, E’ GIÀ SULLA STRADA DI UN’ALTRA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" E DÀ AD ALESSANDRO MANZONI UNA TRACCIA FONDAMENTALE PER DISTINGUERE TRA DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", FAMIGLIA E "FAMIGLIA", E ACCOMPAGNARE I "PROMESSI SPOSI" FUORI DALLA PESTE E DALL’INFERNO.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA, ARTE E ITTICA: A NAPOLI, "LA MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO.26 febbraio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E RINASCIMENTO, OGGI (26 FEBBRAIO 2023):
ESSERE, O NON ESSERE? LA DOMANDA DI AMLETO E "LA LEZIONE DI "ABO" (Achille Bonito Oliva).
Una nota a margine ... *
"L’ARTE DA SOLA NON ESISTE. Senza un sistema composto da media, collezionisti, mercato, musei, pubblico, le opere in sé non avrebbero valore". Con questo titolo, di forte tonalità hegeliana e marxista, Achille Bonito Oliva, sul "Robinson" ("la Repubblica" del 18 febbraio 2023), sollecita in qualche modo lodevolmente a ripensare "tutto".
SOCIALITÀ CRITICA. A onore di Bonito Oliva, per non lasciar cadere l’ago nel pagliaio e rischiare di non ritrovarlo, tenendo presente che né la "religione" né la "filosofia", come l’arte, esiste da sola, forse, è opportuno allargare l’area della coscienza del tempo presente e riprendere a cercare di capire meglio la situazione storica attuale, a tutti i livelli.
NAPOLI E "LA MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO. Considerato che «il Pesce puzza dalla testa» (soprattutto se si continua a confondere inconsapevolmente ICTUS con IXTHUS, "I.X.TH.U.S."), a mio parere, solleciterei una urgentissima riflessione antropologica sulla millenaria e moribonda tradizione del “Pensare l’artista come un demiurgo, produttore isolato d’immagini"!
COSMOTEANDRIA. Continuare così, come precisa Achille Bonito Oliva, "vuol dire non riuscire a comprendere l’esistenza di una condizione filosofica dell’arte e dell’artista" e, al di là delle allusioni e delle illusioni dello stesso "ABO" (relative alla "teoria della catastrofe" e allo "spostamento che raccoglie l’esigenza di una struttura edipica uccidendo il padre, ovvero il movimento precedente"), vuol dire interrogarsi radicalmente sulla figura dell’artista e sull’arte stessa, in quanto "produzione linguistica, e dunque, operatività e pratica culturale", al di fuori della logica cosmoteandrica del mondo attuale, che anche il sistema dell’arte ha contribuito a costruire.
NOTA: FILOLOGIA E ITTICA. "Ichthỳs. Antico simbolo cristiano di Cristo; le lettere greche (ΙΧΘΥΣ) che compongono la parola, formano l’acrostico ᾿Ιησοὸς Χριστὸς Θεοῦ υἱὸς Σωτήρ «Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore». (Treccani).
#Earthrise #Metaphysics #Anthropology #Eleusis2023 #Roma2024
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL PRINCIPE AMLETO, IL PRINCIPIO DI INDIVIDUAZIONE, E IL NODO DA SCIOGLIERE: COME NASCONO I BAMBINI.22 febbraio 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA:
- SENZA SHAKESPEARE E SENZA FREUD, NON SI ESCE DAL LABIRINTO DEL "CORPO MISTICO" DEL RE DI TEBE. .***IL PRINCIPE AMLETO, IL PRINCIPIO DI INDIVIDUAZIONE, E IL NODO DA SCIOGLIERE: COME NASCONO I BAMBINI...
METAPHYSICS ANTHROPOLOGY PSYCHOANALITIC. Shakespeare, dopo Lutero e prima di Nietzsche e Freud, con Amleto s’interroga sul come sia possibile andare oltre la vecchia "imitazione di Cristo". Una nota a margine di un programma di ricerca intitolato “Hamlet’s Bible”... *
TEATRO E METATEATRO. La straordinaria ricchezza di Hamlet, a mio parere, sta proprio in questo doppio movimento: "The tension or dissonance between these similarities and differences is an important source of irony" (Paul Adrian Fried). Con questo "gioco" il meta-obiettivo di Shakespeare appare essere proprio quello di indicare una direzione di riflessione che possa portare oltre il proprio #tempo e rendere praticabile l’idea di rimettere i suoi cardini in sesto!
Europa e "Globe Theatre": "Ecce Homo". Dato che la posta (storicamente e teologicamente) è epocale, il "gioco" è ancora più importante: qui, nell’Hamlet, il tema è "ripensare" lo #specchio dell’intera "Danimarca".
P. S.
"ECCE HOMO": NIETZSCHE E LA VOLONTA’ DI POTENZA DI JUNG. Carl Gustav Jung ha fatto un brillantissimo lavoro su «Lo Zarathustra di Nietzsche. Seminario 1934-39» , ma alla fine la sua stessa ombra gli ha impedito di giungere a fondo e a capo dell’enigma di Edipo, della domanda (la "question") di Amleto, della "visione e l’enigma di Zarathustra e, infine, di accogliere il bambino nato dalla metamorfosi del cammello e del leone (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA ... come la filosofia, la teologia, e la politica mondiale, senza più Grazia (gr.: XAPIS, "CHARIS") e senza più Grazie (gr.: XAPITES, "CHARITES") perde la testa e ricade nel sacco.10 febbraio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA: NATURA, INTELLIGENZA ASTUTA, E GRATITUDINE ...
Una sollecitazione a pensare al "mondo divenuto favola" (lezione di Esopo, Fedro, e Nietzsche): come la filosofia, la teologia, e la politica mondiale, senza più Grazia (gr.: XAPIS, "CHARIS") e senza più Grazie (gr.: XAPITES, "CHARITES") perde la testa e ricade nel sacco, nella tradizionale "luminosa" caverna dell’ "homo homini lupus est" ... Dov’è l’etica? E dove la carità (gr. XAPITAS, "CHARITAS") della stessa grazia ("charis")?!
 MEMORIA (E MUSE): "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).
MEMORIA (E MUSE): "L’AMORE NON è LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (W. Shakespeare, Sonetto 116).- Il lupo e il contadino
- Un lupo supplicò un contadino di nasconderlo ma, quando il pericolo fu passato, saltò fuori e volle mangiarsi il suo salvatore. «Non è giusto che tu mangi chi ti ha aiutato!» esclamò il contadino, ma il lupo ribatté: «Nessuno mai ricorda i benefici ricevuti. Perché dovrei essere io il primo a ricordarlo?». «Ti prego, lupo, sentiamo cosa ne pensano i passanti, prima di decidere».
- Si trovava a passare di là un vecchio cane e confermò che il suo padrone, dopo anni di fedele servizio lo trattava, ora che non gli era più utile, con immensa ingratitudine. Giunse anche un cavallo e ammise di aver ricevuto lo stesso trattamento del cane.
- Il contadino oramai disperava di dissuadere il lupo dal mangiarlo e quindi di salvarsi quando, d’improvviso, vide arrivare una volpe e, confidando nella sua astuzia, le fece un cenno d’intesa e rivolgendosi al lupo disse: «Interroghiamo anche quest’ultimo passante, poi farai quello che vorrai». «Volpe cara, questo lupo non vuole essermi grato di averlo nascosto nel sacco dai cacciatori che lo inseguivano. Cosa ne pensi?».
- E la volpe: «Un lupo così grosso in un sacco così piccolo? Non posso crederlo. Fatemi vedere.» Il lupo rientrò nel sacco e subito la volpe aiutò il contadino a chiuderlo ben bene con un grosso nodo. L’uomo prese allora un bastone, riempì di legnate il lupo ch’era dentro il sacco e poi si girò verso la volpe e atterrò anche lei con un gran colpo in testa esclamando poi: «Sai, volpe? A forza di dirmelo hanno convinto anche me che la gratitudine non esiste affatto!».
PSICOANALISI E "DISAGIO NELLA CIVILTÀ" (S. FREUD, 1929): "Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la propria. (Melanie Klein).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL RICORDO DI DIOTIMA (LA SACERDOTESSA DI MANTINEA) E IL PROBLEMA SOCRATE (EUROPA, ELEUSI 2023)..8 febbraio 2023, di Federico La Sala
EUROPA, FILOSOFIA, ED ELEUSIS 2023:
- IL PROBLEMA SOCRATE E IL RICORDO DI DIOTIMA (LA SACERDOTESSA DI MANTINEA).
METAPHYSICS ANTHROPOLOGY PSYCHOANALYS: APRIRE GLI OCCHI SUL SOCRATICO AMORE "CONVIVIALE" (EROS = CUPIDO), SUL DESIDERIO CIECO E VIOLENTO, E PORTARSI CON FREUD, FUORI DAL DISAGIO NELLA CIVILTA’, OLTRE LO STADIO DELLO SPECCHIO DEL TRAGICO PLATONISMO E PAOLINISMO ...
"SAPERE AUDE!". RICORDANDO, CON IL VENOSINO ORAZIO, LE INDICAZIONI DI KANT sul "coraggio di servirsi della propria intelligenza" e sulla necessità di reinterrogarsi sull’intero sapere, ripartendo dalla antropologia, dalla questione antropologica, forse, è il tempo opportuno uscire dal profondissimo letargo (Dante contava XXV secoli di sonno dogmatico) e re-interrogarsi non solo su "come nascono i sogni" e su "come nascono le idee", ma anche, e innanzitutto, come nascono i bambini, e soprattutto non continuare a ripetere vecchi e tragici ritornelli sull’amore di Platone: è una questione di filologia e di teologia-politica (Lorenzo Valla, "La falsa Donazione di Costantino", 1440).
"IL CREPUSCOLO DEGLI IDOLI" (NIETZSCHE). LA ’RISPOSTA’ DI DIOTIMA A SOCRATE: "Caro Socrate, tu sei come Eros - figlio di Ingegno (a sua voìta figlio di Metis. I’intelligenza astuta) e di Povertà - un perfetto #filosofo, perché non sei sapiente come gli dèi né del tutto ignorante come i comuni mortali: sei solo consapevole della tua ignoranza, ma tu sei cieco, cieco e brutto come un ... ciclope. Tu sai che non sai amare e vai in cerca di chi sa amare. Ma tu, caro Socrate. non capisci proprio nulla, né degli uornini, né delle donne. e neppure degli dei: tu sei solo cupìdo (un cieco saettante, avido e vioÌento). Come la rìsposta della Pizia, così la risposta di Diotima: eglì non capisce e va avanti ... a costringere chi ’solo il dio sa’ deve partorire. [...]" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Roma 1991, p. 184).
CADUTA NELLA CAVERNA PLATONICA E COSMOTEANDRIA. Se non ci si sveglia e si continua a contrabbandare l’andrologia tragica di Socrate e Platone per antropologia e, dall’alto della "dotta ignoranza" (Niccolò Cusano,1440) dell’anatomia e della medicina, si spaccia #Vir per #Homo, dove si pensa di andare, se non all’inferno?!
ANATOMIA, ANTROPOLOGIA, E STORIOGRAFIA. Se si vuole ricominciare umana-mente e riprendere il cammino della rivoluzione copernicana e scientifica, bisogna ripartire quantomeno dalla sapienza di Michelangelo (riprendere il cammIno dei profeti e delle sibille del #TondoDoni, rilanciato alla grande nella narrazione della Volta della Cappella Sistina) e, poi, proseguire seguendo le lezioni di anatomia e di medicina di Realdo Colombo e, infine, leggendo il capitolo 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DELLO STADIO DELLO SPECCHIO: A LEZIONE DA KAFKA, WALTER DENJAMIN, E GEORGE GROSZ6 febbraio 2023, di Federico La Sala
LA CRITICA DEL "CAPITALISMO COME RELIGIONE" (FRANZ KAFKA, WALTER BENJAMIN, GEORGE GROSZ).
- CAINO E LO STADIO DELLO SPECCHIO. Una nota a margine di "Caino o Hitler all’inferno" (George Grosz, 1944).
STORIA E MEMORIA. Nel 1944, nello stesso anno dei militari italiani internati nel Lager di Wietzendorf, George Grosz, nel periodo americano, realizza il quadro "Caino o Hitler all’inferno".
ARTE E LETTERATURA. KAFKA, intorno al 1920, nel commentare un volume con i disegni di Grosz, esprime una opinione precisa sui limiti della teoria del rispecchiamento, della rappresentazione artistica: "Il capitalismo è un sistema di dipendenze: dall’interno verso l’esterno, dall’esterno verso l’interno, dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Tutto è dipendente, tutto è concatenato. Il capitalismo è uno stato del mondo e dell’anima." (cfr. G. Janouch, "Colloqui con Kafka", in F. Kafka, «Confessioni e diari», Milano 1972). *
"THE TIME IS OUT OF JOINT" (Shakespeare). Come a dire, ciò di cui "invito" a prendere atto non è tanto il cosiddetto "tramonto dell’#Occidente" (di cui parla Spengler), ma è qualcosa di più radicale, di globale (riguarda tutta la società) ed epocale (riguarda un lungo periodo storico, quasi una "preistoria"); è, per dirla in "sintesi", un orizzonte spazio-temporale che tocca tutto e tutto il genere umano: è un problema biblico, di #caduta.
DISAGIO DELLA CIVILTA’ (S. Freud, 1929). Alla luce della considerazione di Kafka (una traccia di riflessione sul "capitalismo come religione" molto prossima a quella che svilupperà di lì a poco, quasi in contemporanea, Walter Benjamin), l’opera di Grosz del 1944 mostra tutto il suo lato infernale e denuncia il più che millenario #letargo (v. Dante Alighieri) in cui continuiamo a vivere e sognare: il nostro Padre e il nostro Fratello è Caino, il Mentitore, e, Giocasta è la nostra Madre e la nostra Sposa, come Edipo (v. Sigmund Freud).
- Europa 2023: Eleusis 2023).
* La cit. è anche presente nel mio lavoro: si cfr. Federico LA Sala, "Della Terra, brillante colore", 2013, p. 94).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MUSICA DEL PIFFERAIO ALGORITMICO E NOTE DI ARCHEOLOGIA FILOSOFICA28 gennaio 2023, di Federico La Sala
LA FATTORIA DI PLATONE, IL PIFFERAIO ALGORITMICO, E L’ ARCHEOLOGIA FILOSOFICA:
- TRACCE PER UNA SVOLTA_ANTROPOLOGICA.
- Una nota a margine di un lavoro del 1991 (*)
#STORIA E #MEMORIA. Al #tramonto dell’#Occidente e alla #fine della #storia, qualche musicista constata amaramente che oggi la più bella delle arie d’opera viene utilizzata per #pubblicizzare un profumo. Verissimo, ma questo cosa significa? Non è una "bellissima" realizzazione storica dello #Stato sognato dal pitagorico Platone, quello della famosa teoria del #re filosofo (#sofista) e del filosofo (sofista) re?
#FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA. Le #Muse, le #Grazie, le #Sibille, dove sono?! Non sono state rapite come #Persefone da #Plutone e sono tutte rinchiuse nel #Circo (della buon’anima) della #Moira di #Orfeo? Dov’è #Diotima, dove #Arianna? Non è ora di cambiare #musica e uscire dall’Inferno (#Dante2021)?! Se non ora, quando?!
#Eleusis2023 #Earthrise
(*) La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. MEMORIA DI TERESA D’AVILA26 gennaio 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ESTASI, E RINASCIMENTO, OGGI: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA.
- Una nota a margine di un mio lavoro del 1996 e in memoria di Teresa d’Avila (1622-2022): *
CULTURA E SOCIETA’. La vita e l’opera di Teresa d’Avila è ancora una #sfida per la psicoanalisi freudiana, per la psicanalisi lacaniana, per la stessa chiesa cattolica, e per l’intera #cultura laica e devota (oggi, 2023). Nonostante le sollecitazioni generali a portarsi oltre l’orizzonte androcentrico platonico-hegeliano e, in particolare, edipico da parte di psicoanalisiti e psicoanaliste, come Elvio Fachinelli ("La mente estatica", Adelphi,1989) e Julia Kristeva ("Teresa, mon amour. Santa Teresa d’Ávila: l’estasi come un romanzo, Donzelli 2008), il problema del "roveto ardente" di Lacan, "la Cosa di Mosè", resta sempre e "encore" un enigma, quello stesso della Sfinge di Edipo: "L’esperienza mistica - scriveva Fachinelli nel 1988 - è al di là della barriera dell’incesto e in essa si manifesta un aspetto antropologico sinora rifiutato, o temuto, o assimilato tout cort all’impostazione religiosa. E così la gioia eccessiva, che è al cuore dell’esperienza estatica, viene trascurata".
Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo Buonarroti e al suo "Tondo Doni" e al suo Mosè, sollecita a riproblematizzare non solo il rapporto tra #Freud e Lacan, ma anche, e soprattutto, a portarsi oltre la logica cosmoteandrica del "superuomo" del cattolicesimo europeo-costantiniano. Se non ora, quando?!
*http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5195
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MEMORIA E STORIA D’EUROPA: IL "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023), TERESA D’AVILA, E LA PSICOANALISI,.25 gennaio 2023, di Federico La Sala
MEMORIA E STORIA DI LUNGA DURATA. APPUNTI SU PROBLEMI DI PATRIMONIO CULTURALE, ARTE, E ANTROPOLOGIA
- NELL’EUROPA DI IERI (XVI SECOLO) E DI OGGI (XXI SECOLO):
A) SPAGNA: A 700 ANNI DALLA MORTE DI D. GONZALO RUIZ DI TOLEDO, "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023)", UNA BUONA OCCASIONE PER RI-ANALIZZARE L’OPERA DI "EL GRECO" ("LA SEPOLTURA DEL CONTE DI ORGAZ", TOLEDO 1586 -1588) ... E PER RIMEDITARE LO STRAORDINARIO IMPEGNO RIFORMATORE (CARICO DI TEORIA E DI FUTURO) DI TERESA D’AVILA (1515-1582).
B) TERESADAVILA (Avila 1515 - Alba de Tormes 1582): "[...] Teresa (Teresa Sánchez de Cepeda Ávila y Ahumada) nasce in una famiglia ricca; il padre era figlio di un ebreo convertito - dunque tTeresa fu di origini ebree. La madre trasmette alla figlia l’amore per i romanzi cavallereschi, ma muore quando Teresa ha solo 13 anni.
Diventa una donna determinata, affascinante e trascinatrice, estrema nelle sue scelte e insieme capace di amministrare i monasteri e di trattare con diplomazia coi grandi dell’epoca. Da ragazza convince il fratello a fuggire per andare a combattere contro gli infedeli. Sempre col fratello scrive un romanzo cavalleresco; manifesta, insomma, subito due grandi amori della sua vita: la fede e la scrittura.
È l’epoca della grande crisi della Chiesa, che all’apice della propria magnificenza è percorsa da profonde inquietudini, divisa dalla predicazione di #Lutero e Juan de Valdés, una ferita profonda e interna. Teresa ha trent’anni all’epoca del Concilio di Trento (1545-1563), tappa di quella “rifondazione” della chiesa cattolica, che si impegna tanto nella guida delle anime, con la fondazione di nuovi ordini religiosi e la promozione di una rinnovata austerità e spiritualità, quanto nel controllo delle stesse, imponendo nuove e più severe regole monastiche e potenziando i tribunali dell’#Inquisizione. In in Spagna in particolare, dopo il culmine della potenza raggiunto sotto il regno di Carlo V (1500-1558), suo figlio Filippo II (1527-1598) si fa paladino della ortodossia cattolica. [...]" (Cfr. Maria Rosa Panté, "Teresa d’Avila", Enciclopedia delle donne)
C) CARMELITANISCALZI: L’ULTIMA LEZIONE DI TERESA D’AVILA. A CONTURSI TERME, IN PROVINCIA DI SALERNO, NELLA TERRA DEL "PRINCIPE DI EBOLI" (Rui Gomes da Silva), L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (IN STATO DI PROGRESSIVO DEGRADO).
D) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E PSICOANALISI: LA STORIA NON LA FANNO SOLO I PROFETI, MA ANCHE LE SIBILLE. Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo Buonarroti e al suo "Tondo Doni" (e al suo Mosè), sollecita anche a riproblematizzare (Julia Kristeva, "Teresa, mon amour", 2009) il rapporto tra Freud e Lacan ("Encore", 1972-1973) ) e, infine, a portarsi oltre la logica del "superuomo" del cattolicesimo costantiniano!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E CRISTOLOGIA: OLTRE-UOMO O SUPERUOMO?17 gennaio 2023, di Federico La Sala
#QUESTIONEANTROPOLOGICA (#FILOLOGIA E #CRISTOLOGIA ): SHAKESPEARE E NIETZSCHE.
- "TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION" (#AMLETO , III, 1. 56):
- "OLTRE-UOMO" O SUPERUOMO?
La grande eroica ricerca di #Nietzsche è stata quella di rispondere alla domanda già di #Shakespeare , alla #question di Amleto, e portare il discorso oltre #Wittenberg (la #RiformaProtestante ), e chiarirsi e chiarire le idee relative all’ #essere degli esseri umani, figli e figlie del "#Re dei Re", di "Dio", e di andare oltre la tragica #logica del "sapere di non sapere" platonica, del #mentitore, e dell’ #adulterio e dell’#incesto ("Così parlò #Zarathustra ", parte IV). Egli, a mio parere, ha aperto la strada e dato indicazioni per sciogliere il nodo e non nella direzione del #supeuomo cosmoteandrico (cfr. Federico La Sala , "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica ", Roma 1991).
#ANTROPOLOGIA O #ANDROLOGIA? #Gesù, chi era? Quello del "parto maschio del tempo" di san #Paolo e #Costantino (e #Bacone ), o quello del tempo di san #Francesco ("Cantico delle #Creature " o "Cantico di Frate #Sole ") e #DanteAlighieri ("l’amor che muove il sole e le altre stelle") e di ogni #essereumano nato di donna e di uomo nel pianeta Terra?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---FILOLOGIA E MITOLOGIA. Contro millenni di Ci-Viltà e Cosmoteandria (laica e religiosa), il gesto epocale della donna e madre iraniana.15 gennaio 2023, di Federico La Sala
#DIVINACOMMEDIA E #DISAGIODELLACIVILTÀ (#Freud, 1929): #Dante2021.
Per meglio comprendere, a mio parere, la inaudita portata antropologica e teologica della #Monarchia di #Dante, occorre porsi all’altezza del nostro presente storico e sedersi a fianco della "ottantenne (che si) toglie l’hijab" e ascoltare le parole di (Maria) #BEATRICE che, a Dante che le chiede : "#Madonna, mia bisogna / voi conoscete, e ciò ch’ad essa è buono", risponde: "Ed ella a me: "Da tema e da vergogna/voglio che tu omai ti disviluppe,/ sì che non parli più com’om che sogna" (Purg. XXXIII, 26-33 ).
#FILOLOGIA E #MITOLOGIA. #Europa2023: #Eleusis2023 (Memoria di #Demetra e #Persefone). Dopo millenni di #Ci-#Viltà e #Cosmoteandria (laica e religiosa), il gesto della donna e madre iraniana (che #ovviamente si sta rivolgendo non solo agli uomini, ma soprattutto alle donne e alle madri dell’Iran - e non solo!) indica la via della #critica alla ragione olimpica: uscire dal tragico "stato di minorità" (#Kant, #Koenigsberg 1784 - #MichelFoucault, 1984), e, possibilmente, fare qualche passo di coraggiosa chiarezza sulla logica pestilenziale di #Edipo e di #Giocasta - a livello planetario.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (S. FREUD, 1899) DEI NIPOTINI E DELLE NIPOTINE DI PLATONE.11 gennaio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA FILOSOFIA PSICOANALISI
"ABBRACCIATEVI, MOLTITUDINI" (F. SCHILLER, "INNO ALLA GIOIA", 1785): "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (S. FREUD, 1899) DEI NIPOTINI E DELLE NIPOTINE DI PLATONE...
«Che cos’è, o uomini ["anthropoi"], che volete ottenere l’uno dall’altro? [...] Forse è questo che volete: diventare la medesima cosa l’uno con l’altro, in modo che non vi dobbiate lasciare né giorno, né notte? Se è questo che desiderate, io voglio fondervi e unirvi insieme nella medesima cosa, in modo che diventiate da #due che siete #uno solo, e finché vivrete, in quanto venite ad essere in questo modo uno solo viviate insieme la vita, e quando morirete, anche laggiù nell’Ade, invece di due siate ancora uno, uniti insieme anche nella morte. Orsù vedete se è questo che volete e se vi farebbe lieti ottenerlo...» (Platone, Simposio, 192 d-e)
PLATONISMO E TECNOCRAZIA. Dopo interi millenni di letargo, non è meglio svegliarsi e capire che l’intenzione di "Platone" (e di Efesto) è pure lodevole, ma molto, molto artigianale (demiurgica), il suo amore è avido e cieco (Cupìdo) e il suo fare "di due che siete uno solo" sembra voler correggere la divisione fatta da Zeus, ma alla fine fa tutto all’incontrario e fa solo un campo di sterminio, un deserto. All’altezza del 2023, come scriveva Nietzsche, siamo ancora ignoti a noi (stessi e stesse).
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. Forse conviene riprendere il filo da ELEUSI (quest’anno è una delle capitali europee della cultura: Eleusis2023) e cercare di capire il segreto dei misteri eleusini, come nascono i bambini, e, finalmente, scoprire (immergendosi, battesimalmente, nel) l’acqua calda, che ognuno e ognuna è già uno, una, in due; ripartire da sé e riprendere il cammino: "Sàpere aude! (Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984). Ricominciare a contare da due, non da uno (dei due, che fa il furbo): "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia). In principio era il Logos - non il logo di una "fattoria degli animali"!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- ANDARE OLTRE IL “DIO” CONCEPITO SECONDO IL TRAGICO ALGORITMO DELL’ ANDROCENTRISMO26 dicembre 2022, di Federico La Sala
COSMOLOGIA ("MONDO"), TEOLOGIA ("DIO"),
ANTROPOLOGIA ("UOMO")
E
"DISAGIO DELLACIVILTÀ" (S. FREUD, 1929):
The Stages of Man (1510), by Charles de Bouelles (c. 1470-1553).
USCIRE DAL LABIRINTO O DALLA CAVERNA,
E
NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI
“DIO”
CONCEPITO
SECONDO IL TRAGICO ALGORITMO DELL’
ANDROCENTRISMO
COME “UOMO SUPREMO” O "SUPERUOMO".
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). ANTROPOLOGIA SPAZIALE E FILOLOGIA: "CORDONE OMBELICALE" (di Annalisa Teggi - "L’Osservatore Romano").4 dicembre 2022, di Federico La Sala
PIANETA TERRA 2022.
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, ANALFABETISMO, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (FREUD, 1929):
COME NASCONO I BAMBINI? COSA "STA SCRITTO AL CENTRO DELLE NOSTRE PANCE" DI ESSERI UMANI?
***
- "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Nel momento stesso in cui sono cominciati i viaggi extra-terrestri, forse, è possibile cominciare anche a capire l’importanza del cordone ombelicale e preoccuparsi meglio e di più delle condizioni che rendono possibile la vita sul Pianeta Terra.
- TERRA-MADRE (DEMETRA ->ELEUSIS, una delle capitali europee della cultura 2023). Senza cordone ombelicale (il filo "tecnologico", il "pezzo di terra", che assicura condizioni di vita terrestre ad un essere umano) nessuno può avventurarsi fuori dalla Terra (non solo nell’aria o nell’acqua del #Pianeta , ma nemmeno e ancor di più nello spazio planetario o cosmico) e tornare a Casa.
***
CORDONE OMBELICALE
di Annalisa Teggi (L’ Osservatore Romano, 02 dicembre 2022
"Se dovessi scegliere la notizia dell’anno di questo 2022 che si avvia al termine, la tirerei fuori dalle pieghe più silenziose della realtà. Lo scorso maggio a Catania è stato trovato un neonato abbandonato in una cesta con il cordone ombelicale ancora attaccato. Proprio quest’ultimo dettaglio mi è rimasto impresso, quasi fosse un grido. Che grande vulnerabilità esposta in quel cordone, segno di una dipendenza totale. Guai a manifestare una cosa del genere, oggi. I nostri cordoni ombelicali li tagliamo spavaldamente, o piuttosto li nascondiamo con cura (anche noi stessi). Ostentiamo la fierezza di traguardi che ci siamo guadagnati da soli, con le nostre forze. Senza chiedere niente a nessuno - la medaglia da appuntarsi al petto. Ma sarà poi vero?
[...]
«Sono» nasce da un «siamo», e sta scritto al centro delle nostre pance. È un «siamo» che è durato nove mesi dentro il grembo e non sparisce quando siamo creature separate da nostra madre. Restiamo bisognosi di non recisi dal cuore del mondo.
In una lettera datata 8 gennaio 1944 J.R.R. Tolkien scrisse a suo figlio Christopher: «Ma Dio è anche (si fa per dire) dietro di noi, sostenendoci, nutrendoci (dato che siamo creature sue). Quel luminoso punto di potere dove il cordone della vita, il cordone ombelicale dello spirito termina, là è il nostro angelo, che guarda in due direzioni: a Dio dietro di noi, senza che noi possiamo vederlo, e a noi». Ce lo immaginiamo sempre presente, l’angelo custode. Ma un po’ staccato da noi. Magari su un’imprecisata nuvoletta sopra la nostra testa. Solo un genio profondamente intuitivo poteva regalarci quest’istantanea dell’angelo custode che sta a reggere il cordone ombelicale che ci lega fecondamente al Cielo. Verrebbe da attribuirgli tutta l’energia vivace che si vede nei corpi e nei volti di chi fa il tiro alla fune. Solo che non c’è nessuna gara per l’angelo, solo l’inesausto desiderio di non separarci dal vero bene.
E questo «cordone ombelicale dello spirito» non è il filo del burattino che viene manovrato, è una cascata di nutrimento che ci tiene in piedi, per essere davvero liberi. Liberi, perché legati come figli. " (L’Osservatore Romano, 02 dicembre 2022).
***
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CORPO CELESTE. “So questo. Che la Terra è un corpo celeste, che la vita che vi si espande da tempi immemorabili" (di Anna Maria Ortese).).21 novembre 2022, di Federico La Sala
Corpo celeste
di Anna Maria Ortese *
“So questo. Che la Terra è un corpo celeste, che la vita che vi si espande da tempi immemorabili è prima dell’uomo, prima ancora della cultura, e chiede di continuare a essere, e a essere amata, come l’uomo chiede di continuare a essere, e a essere accettato, anche se non immediatamente capito e soprattutto non utile. Tutto è uomo. Io sono dalla parte di quanti credono nell’assoluta santità di un albero e di una bestia, nel diritto dell’albero, della bestia, di vivere serenamente, rispettati, tutto il loro tempo. Sono dalla parte della voce increata che si libera in ogni essere, e della dignità di ogni essere - al di là di tutte le barriere - e sono per il rispetto e l’amore che si deve loro.
C’è un mondo vecchio, fondato sullo sfruttamento della natura madre, sul disordine della natura umana, sulla certezza che di sacro non vi sia nulla. Io rispondo che tutto è divino e intoccabile: e più sacri di ogni cosa sono le sorgenti, le nubi, i boschi e i loro piccoli abitanti. E l’uomo non può trasformare questo splendore in scatolame e merce, ma deve vivere e essere felice con altri sistemi d’intelligenza e di pace, accanto a queste forze celesti. Che queste sono le guerre perdute per pura cupidigia: i paesi senza più boschi e torrenti, e le città senza più bambini amati e vecchi sereni, e donne al di sopra dell’utile. [...] Vivere non significa consumare, e il corpo umano non è un luogo di privilegi.
Tutto è corpo, e ogni corpo deve assolvere un dovere, se non vuole essere nullificato; deve avere una finalità, che si manifesta nell’obbedienza alle grandi leggi del respiro personale, e del respiro di tutti gli altri viventi. E queste leggi, che sono la solidarietà con tutta la vita vivente, non possono essere trascurate. Noi, oggi, temiamo la guerra e l’atomica. Ma chi perde ogni giorno il suo respiro e la sua felicità, per consentire alle grandi maggioranze umane un estremo abuso di respiro e di felicità fondati sulla distruzione planetaria dei muti e dei deboli - che sono tutte le altre specie - può forse temere la fine di tutto? Quando la pace e il diritto non saranno solo per una parte dei viventi, e non vorranno dire solo la felicità e il diritto di una parte, e il consumo spietato di tutto il resto, solo allora, quando anche la pace del fiume e dell’uccello sarà possibile, saranno possibili, facili come un sorriso, anche la pace e la vera sicurezza dell’uomo.”
* Fonte: Quaderno 7 / Corpo Celeste (di Chandra Livia Candiani, Doppiozero, 8 Dicembre 2020)
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ALLA RICERCA DELLA LINGUA D’AMORE. A proposito del "carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West" (di Caterina Venturini)17 novembre 2022, di Federico La Sala
VITA E FILOSOFIA, PSICOANALISI, LETTERATURA, E RICERCA ANTROPOLOGICA. A proposito del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West... *
- Cum grano salis, il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West (“Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio”, Donzelli, 2019) può essere messo accanto al carteggio tra Sigmund Freud e Wilhelm Fliess ("Lettere a Wilhelm Fliess, 1887-1904", Boringhieri, 1986):
- "[...] cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: hashtag#Orlando , il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile [...] La stesura di hashtag#Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno." (Caterina Venturini ).
*
Ti nomino meglio che posso: la lingua d’amore di due donne libere.
Sul carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West
di Caterina Venturini ("femministerie",26 settembre 2019)
“Se questo libro avrà contribuito a mettere ancora una volta in luce la vitalità di Virginia Woolf e, attraverso il legame con Vita, a mostrare il suo amore per il canto del mondo reale e per tutto ciò che vive e respira, avrà raggiunto il suo obiettivo.” Così si augura Elena Munafò nella bella postfazione al carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West “Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio” (Donzelli, 2019) e mi viene da risponderle: certamente.
Ho scoperto in queste lettere molte cose che non sapevo, altre che non ricordavo, infine alcune che non immaginavo affatto. Intanto il tono, vivace, “sbarazzino” addirittura di Virginia e Vita (reso magistralmente dalla traduzione di Nadia Fusini e Sara De Simone), la delicatezza del loro parlato che diventa scritto senza abbandonare certe luminosità del quotidiano; e poi la spregiudicatezza di una società - da una parte gli intellettuali borghesi di Virginia, dall’altra la classe aristocratica di Vita - e di un tempo molto più libero, per certi versi, del nostro. Un viversi sentimentalmente, sperimentare, incrociare persone e situazioni, senza rinunciare mai al rispetto e all’amicizia, qualsiasi cosa accada. E infine la grande cura per i libri, soprattutto di Virginia editrice (anche dei libri di Vita) che trascorre intere giornate a leggere i manoscritti per la Hogarth Press, casa editrice da lei fondata insieme con il marito Leonard Woolf. Una cosa oggi inimmaginabile.
Comincio dunque dal primo contenuto che mi ha appassionato di queste lettere: lo stile, la lingua usata dalle due amanti per esprimere il reciproco affetto, l’ammirazione, l’amore e il sostegno, che mai viene a mancare per tutto il tempo del carteggio che dura fino a due settimane prima della morte di Virginia nel marzo del ’41, in piena Seconda guerra mondiale. La vivacità del tono, che potrebbe essere assimilata a qualcosa di più contemporaneo, si situa invece precisamente nel tempo a cui appartiene per una gentilezza, un’eleganza, un calore che è quello di comunicazioni che vogliono esprimere il più possibile sulla carta, ancora rare le telefonate. Questo tono, dicevo, conserva intatta l’emozione delle due donne nell’inviare e ricevere lettere che al momento sono il loro principale mezzo di comunicazione, anche quando i loro incontri si faranno più radi. Colpisce e quasi turba, se paragonata all’oggi, la ricerca della parola esatta, che lungi dall’essere un inutile sfoggio, diventa invece la prima espressione di cura reciproca, come a dire: ti nomino meglio che posso; al tempo stesso ricorrono epiteti affettuosamente triviali come “somara” e “scandalosa ruffiana”, che non fanno che comporre il quadro di questa relazione con quanti più colori ci sia dato immaginare per l’incontro di due sensibilità in fondo così diverse, ma che riescono a riverberare l’una sull’altra parte del proprio temperamento.
Se finora conoscevamo una Virginia “lunare” e una Vita mondanissima, alla vertiginosa altezza del suo nome, queste lettere ci consentono finalmente di cogliere altri aspetti del loro carattere e delle loro inclinazioni, esaltate dal doppio dell’amica: sono sempre l’una davanti all’altra. Virginia acquista degli aspetti più giocosi e Vita scende nelle profondità d’animo che l’amata la invita a penetrare, anche come scrittrice: sembra infatti esserci qualcosa che non vibra in Vita - dice Virginia - c’è un nucleo freddo in questa nobildonna che sembra muoversi a proprio agio ovunque, ma che rivela in ultimo una cupezza, di cui anche Vita è/diventa più consapevole, scrivendone poi sbalordita al marito Harold Nicolson. Già, perché intorno a queste lettere ce ne sono molte altre (suggerite in alcune note di questa edizione): quelle che Vita e Virginia scrivono ai loro amici, alle amiche, alle amanti e ai rispettivi mariti. Ed è questo un altro aspetto inter e extra testuale che si rivela molto affascinante a una lettura contemporanea: la ricchezza degli affetti e delle relazioni, di cui probabilmente neppure loro stesse sono del tutto consapevoli, ma che al nostro sguardo, risulta tra le più grandi qualità di questa epoca post-vittoriana e modernista in cui la borghesia intellettuale e l’aristocrazia, pur non amandosi tra loro (vedi il sospetto con cui il circolo di Bloomsbury guardava Vita), godono del grande privilegio, anche economico e sociale, di poter costruire forme di rapporto così libero, da essere oggi - nell’epoca dei sacrosanti diritti riconosciuti - considerato quasi stravagante.
- [Foto] Virginia Woolf / Vita Sackville-West
Nelle lettere di Vita e Virginia, vengono raccontati matrimoni che sono in realtà delle amicizie; amicizie che diventano passioni; ménage à trois che si aprono a ulteriori geometrie. Virginia confessa a Vita la sua perplessità, dopo la lettura di Anna Karenina, per “la crescente irrealtà del suo tema principale”, l’adulterio, “che in fondo al cuore non condanniamo più [...] mentre Tolstoj basa tutto il libro su quello. Ma tolto quello, se non mi scandalizza che AK copuli con Vrònskij, che cosa rimane?”.
 Quella di Virginia è una domanda vera, che si pone anche e soprattutto in scrittura: cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: Orlando, il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile, attraversando tre secoli pieni di avventure tra l’Inghilterra e l’Asia, luoghi cari proprio a Vita che seguì il marito ambasciatore fino a Teheran. La stesura di Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno.
Quella di Virginia è una domanda vera, che si pone anche e soprattutto in scrittura: cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: Orlando, il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile, attraversando tre secoli pieni di avventure tra l’Inghilterra e l’Asia, luoghi cari proprio a Vita che seguì il marito ambasciatore fino a Teheran. La stesura di Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno.La sperimentazione est/etica di Orlando, invece, non si configura in quell’assenza di trama, cui ci ha abituato Woolf nei romanzi precedenti, ma proprio nei comportamenti del personaggio, nel suo mettere costantemente alla berlina la tradizione cavalleresca ed eroica della nobile famiglia cui appartiene (si veda a tal proposito L’atto sospeso. Azione e inazione dell’eroe nella tradizione letteraria europea, tesi di dottorato di Sara De Simone). Durante i tre secoli che Orlando attraversa, l’unica sua opera sarà infine un poema ispirato da una quercia a lui cara. Del resto, in letteratura l’eroe che non combatte è l’intellettuale.
Eppure, l’ironia che Woolf esercita nel 1928 sull’epica cavalleresca, al solito, si riferisce più al suo presente e risponde a quella retorica della guerra che tanto si era espressa durante il primo conflitto mondiale e che porterà coerentemente la scrittrice - esattamente dieci anni dopo, nel ’38 - con il pamphlet Le tre ghinee, a condannare radicalmente anche il nuovo incipiente conflitto, legando la guerra e la militarizzazione al patriarcato e individuando nella marginalizzazione della donna, esclusa storicamente dal potere, un’occasione di pensiero non conforme, appunto. Si può notare dunque, come a una non conformità sentimentale ne corrisponda e discenda un’altra di ordine etico e politico, che pone le basi del pensiero divergente dei futuri femminismi.
Tuttavia, e ciò è evidente proprio nel carteggio tra Vita e Virginia, quest’ironia post-vittoriana non distrugge mai l’oggetto, letterario e amoroso; questa leggerezza, sempre dubitante, direi che è anzi il contrario del nostro contemporaneo e progressista pensare di essere sempre migliori di chi ci ha preceduto, e ci ricorda che anche in un’epoca di mancati diritti civili come quella dei primi del Novecento - cui non s’intende certo tornare - si poteva aspirare a un’originalità di costumi oggi rara tra i contemporanei, stretti tra il neo-moralismo dei social che insieme ai prodotti ci vendono modelli di comportamento e pensiero, e apparati tecnologi che ci illudono di poter essere/contenere tutto, togliendoci in cambio molte umane abilità.
Se si guarda alle nuove generazioni, poi, non si può non notare che i legami affettivi e sessuali sono spesso parte integrante di una dimostrazione di successo complessivo della persona, con una gigantesca contraddizione tutta da sciogliere tra una sorta di capitalismo dell’amore, che propone l’accumulo di relazioni e appuntamenti spesso normati dalle app e, dall’altra parte, un nuovo puritanesimo soprattutto dei giovanissimi in cui la coppia (famosa) è sacra e chiunque attenti ad essa, è meritevole di morte. D’altra parte, quelli che diventano famosi soltanto esibendo la loro vita sentimentale (specialmente nei reality), devono costantemente recitare il copione di una vita sessuale morigerata e fedele, pena la disaffezione dei fans che possono adorare/comprare soltanto l’eterna favola a lieto fine.
La nuova tecnologia degli smartphone, d’altra parte, illudendoci di controllare tempi e luoghi della comunicazione con e dell’Altro, non di rado limita, se non annulla, la nostra capacità di attesa e ri/elaborazione del pensiero. Appare oggi difficile, rara, a tratti impensabile, la concentrazione e la profondità del discorso amoroso di Vita e Virginia, che avevano tutto il tempo e i luoghi, appunto, per ri-pensare e ri-significare la loro comunicazione in totale assenza dell’altra. Un’assenza riproducibile forse solo dalle email, alle quali tuttavia manca una serie di imponderabilità che appartenevano invece alle lettere. Cosa resta oggi di quella capacità di ascolto? Cosa resta di quell’assenza, di quella morte apparente del destinatario che ricreava ogni volta il desiderio dell’altro, dell’altra da sé?
 È ancora possibile oggi, salvare qualcosa da altre epoche, pure imperfette quanto e talvolta più della nostra, affinché l’auspicata normalità dei diritti non si traduca sempre di più in una normalizzazione dei comportamenti e dei desideri?
È ancora possibile oggi, salvare qualcosa da altre epoche, pure imperfette quanto e talvolta più della nostra, affinché l’auspicata normalità dei diritti non si traduca sempre di più in una normalizzazione dei comportamenti e dei desideri?
Sul tema nel sito, si cfr.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PARLA EFESTO: NEL 2022, ANCORA NEL’OFFICINA DI PLATONE !9 novembre 2022, di Federico La Sala
IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS ("CHARITAS"): E IL LOGOS SI FECE CARNE... ECCE HOMO!
COME NASCONO I BAMBINI. Al di là della natività edipico platonica... *
***
IN NOME DEL LOGOS ("charitas"). «Egli (Cristo), ha detto: “Io sono la verità” (Gv 14,6); del diavolo invece ha detto: “Non rimase nella verità, poiché in lui non c’è verità” (Gv 8,44). Ora, Cristo è talmente la verità che tutto in Lui è vero: Egli è il vero Verbo, Dio uguale al Padre, vera anima (vera anima), vera carne (vera caro), vero uomo (verus homo), vero Dio; vera è la sua nascita (vera nativitas), vera la sua passione ( vera passio), vera la sua morte (vera mors), vera la sua risurrezione (vera resurrectio). Se neghi una sola di queste verità, entra il marcio nella tua anima, il veleno del diavolo genera i vermi della menzogna e nulla rimarrà integro in te» (Agostino, Joh. Ev. tr. 8, 5-7);
IL FIGLIO. «Quegli che con le sue mani tocca il Verbo può farlo unicamente perché “il Verbo s’è fatto carne e abitò fra noi” (Gv 1,14). Questo Verbo fatto carne sino a potersi toccare con le mani cominciò a essere carne nel seno della Vergine Maria (Hoc autem Ver bum quod caro factum est ut manibus tractaretur coepit esse caro ex Virgine Maria)» (Agostino, In Joh. Ep. 1,1);
MARIA E GIUSEPPE, SPOSI NELLO SPIRITO DEL LOGOS ("CHARITAS"). «L’utero della Vergine fu la stanza (del Verbo), poiché è là che si sono uniti lo sposo e la sposa, il Verbo e la carne (et illius sponsì thalamus fuit uterus Virginis, quia in ilio utero virginali coniuncti sunt duo, sponsus et sponsa, sponsus Verbum et sponsa caro). Poiché sta scritto (Gn 2,24): “E saranno i due una sola carne” (et erunt duo in carne una). E anche il Signore dice nel Vangelo (Mt 19,6): “Dunque non sono due, ma una sola carne” (igitur iam non duo, sed una caro)» (Agostino, In Joh. Ep. 1, 2).
PAROLA DEL "VULCANICO" PLATONE. PARLA EFESTO: "NON PIU’ DUE, MA UN’ANIMA SOLA"!
"ARISTOFANE: [...] queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dirti cosa s’aspettano l’uno dall’altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie dell’amore: non possiamo immaginare che l’attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità e la sola forza che li spinge a vivere fianco a fianco. C’è qualcos’altro: evidentemente la loro anima cerca nell’altro qualcosa che non sa esprimere, ma che intuisce con immediatezza. Se, mentre sono insieme, EFESTO si presentasse davanti a loro con i suoi strumenti di lavoro e chiedesse: "Che cosa volete l’uno dall’altro?", e se, vedendoli in imbarazzo, domandasse ancora: "Il vostro desiderio non è forse di essere una sola persona, tanto quanto è possibile, in modo da non essere costretti a separarvi né di giorno né di notte? Se questo è il vostro desiderio, io posso ben unirvi e fondervi in un solo essere, in modo che da due non siate che uno solo e viviate entrambi come una persona sola. Anche dopo la vostra morte, laggiù nell’Ade, voi non sarete più due, ma uno, e la morte sarà comune. Ecco: è questo che desiderate? è questo che può rendervi felici?" A queste parole nessuno di loro - noi lo sappiamo - dirà di no e nessuno mostrerà di volere qualcos’altro. Ciascuno pensa semplicemente che il dio ha espresso ciò che da lungo tempo senza dubbio desiderava: riunirsi e fondersi con l’altra anima. Non più due, ma un’anima sola.
 La ragione è questa, che la nostra natura originaria è come l`ho descritta. Noi formiamo un tutto: il desiderio di questo tutto e la sua ricerca ha il nome di amore. Allora, come ho detto, eravamo una persona sola; ma adesso, per la nostra colpa, il dio ci ha separati in due persone, come gli Arcadi lo sono stati dagli Spartani. Dobbiamo dunque temere, se non rispettiamo i nostri doveri verso gli dèi, di essere ancora una volta dimezzati, e costretti poi a camminare come i personaggi che si vedono raffigurati nei bassorilievi delle steli, tagliati in due lungo la linea del naso, ridotti come dadi a metà.
La ragione è questa, che la nostra natura originaria è come l`ho descritta. Noi formiamo un tutto: il desiderio di questo tutto e la sua ricerca ha il nome di amore. Allora, come ho detto, eravamo una persona sola; ma adesso, per la nostra colpa, il dio ci ha separati in due persone, come gli Arcadi lo sono stati dagli Spartani. Dobbiamo dunque temere, se non rispettiamo i nostri doveri verso gli dèi, di essere ancora una volta dimezzati, e costretti poi a camminare come i personaggi che si vedono raffigurati nei bassorilievi delle steli, tagliati in due lungo la linea del naso, ridotti come dadi a metà.
 Ecco perché dobbiamo sempre esortare gli uomini al rispetto degli dèi: non solo per fuggire quest’ultimo male, ma anche per ottenere le gioie dell’amore che ci promette EROS, nostra guida e nostro capo. A lui nessuno resista - perché chi resiste all’amore è inviso agli dèi. Se diverremo amici di questo dio, se saremo in pace con lui, allora riusciremo a incontrare e a scoprire l’anima nostra metà, cosa che adesso capita a ben pochi." (Platone, Simposio).
Ecco perché dobbiamo sempre esortare gli uomini al rispetto degli dèi: non solo per fuggire quest’ultimo male, ma anche per ottenere le gioie dell’amore che ci promette EROS, nostra guida e nostro capo. A lui nessuno resista - perché chi resiste all’amore è inviso agli dèi. Se diverremo amici di questo dio, se saremo in pace con lui, allora riusciremo a incontrare e a scoprire l’anima nostra metà, cosa che adesso capita a ben pochi." (Platone, Simposio).***
NEL 2022, ANCORA NEL’OFFICINA DI PLATONE: "ECCE HOMO" (NIETSCHE, 1888)! Chi parla e promette di fare di due un’anima sola, nel racconto di Aristofane, è Efesto (Vulcano), il dio dei fabbri, ed Eros, è il dio dell’amore/desiderio cieco e avido: questi colpisce con le sue frecce e l’altro costruisce le catene per rimettere insieme le due metà! "Disagio della civiltà" (S. Freud, 1929): non è meglio cambiare registro e rileggersi insieme Dante ("Divina Commedia") e Nietzsche ("Crepuscolo degli idoli")?!
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- JEAN STAROBINSKI E GHISLAIN WATERLOT: IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU, OGGI.6 ottobre 2022, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE DI PRINCIPIO (LOGOS): IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU (JEAN STAROBINSKI) *
- Ragione ("Logos") e Amore ("Charitas"). Per la critica dell’economia politica ..... e della teologia "mammonica" ( "Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)
[Intervista]
GHISLAIN WATERLOT.
Rousseau fra Cristo e i Lumi
di Daniele Zappalà (Avvenire, martedì 31 gennaio 2012)
«Jean-Jacques Rousseau resta attuale perché ci ricorda che la dimensione religiosa dell’esistenza è propriamente umana. Non si può accantonarla così facilmente. E quando lo si fa, si compie un gesto violentissimo e dogmatico». Parola del noto studioso francese Ghislain Waterlot, che dal proprio osservatorio privilegiato svizzero all’Università di Ginevra ha scandagliato in profondità l’opera affascinante e controversa del celebre filosofo settecentesco. Moltissimo è stato scritto sul Rousseau padre degli ideali di uguaglianza e tolleranza, riconosciuto non a caso dopo la morte (2 luglio 1778) come uno dei maggiori ispiratori della Rivoluzione francese. Ma l’autentica novità delle commemorazioni di quest’anno, per il tricentenario della nascita (a Ginevra, il 28 giugno 1712), pare l’intensa riscoperta della riflessione religiosa del filosofo. «Essa non parte da Dio, ma dall’uomo, nel quale Rousseau scorge una dimensione d’attesa. Ciò interroga ancora perfettamente la nostra sensibilità», s’infervora Waterlot, che ha già pubblicato fra l’altro in Francia l’importante saggio Rousseau. Religion et politique (Presses Universitaires de France) e darà alle stampe quest’anno una nuova monografia sul pensiero religioso del filosofo.
- Professor Waterlot, come spiega questa riscoperta?
«C’è innanzitutto una ragione politica. Oggi, la laicità torna in discussione e Rousseau è fra i pensatori che hanno giudicato necessaria una religione civile per lo Stato. Non si riferisce alle religioni storiche esistenti, verso le quali resta diffidente o critico. Ma pensa ad una religione per la polis, una religione in cui è presente ciò che egli chiama la religione naturale, a cui aggiunge l’idea di valorizzare la patria. Egli riconosce un Dio per tutti gli uomini che chiede giustizia e pace, ma aggiunge poi che le leggi della comunità politica debbono ritenersi sante. La religione civile rafforza la società, ne preserva l’unità, ma evitando un’eccessiva aggressività verso le nazioni vicine. Al contempo, nella sua concezione della religione naturale, egli si distingue per la grande attenzione riservata a Gesù. Rousseau è un cristiano molto particolare, che non crede nell’Incarnazione e nella Resurrezione. Ma che non cessa di ripetere: “sono cristiano, un cristiano autentico e sincero”».
- In che modo interpreta Gesù?
«Gesù è al di sopra di tutti gli uomini mai esistiti. Confrontando Gesù e Socrate, egli scrive nell’Emilio: “Se la vita e la morte di Socrate sono di un saggio, la vita e la morte di Gesù sono di un Dio”. Egli non dice “di Dio”, ma “di un Dio”. Altri hanno spesso considerato Gesù e Socrate sullo stesso piano, ma non Rousseau. Gesù corrisponde a un’umanità non corrotta dalla realtà sociale e dalla storia umana. Gesù è l’uomo perfetto, per questo particolarmente amato da Dio».
- L’uomo, per Rousseau, può sentire intimamente la presenza di Dio?
«La percezione di Dio è legata a un “istinto divino” che si trova in ciascuno di noi. È un aspetto essenziale. Sentiamo Dio. In proposito, non si deve sottovalutare che Rousseau ha sempre preso cura di una certa vita spirituale, come mostra in particolare Giulia o la nuova Eloisa. Il personaggio di Giulia prova il bisogno di rivolgersi al Grande Essere. In lei, Rousseau valorizza la preghiera, ma quest’ultima non deve mai divorare la vita. La vita deve restare in primo piano, anche se la preghiera permette di porre l’individuo davanti al Creatore, facendogli ritrovare la pace».
- Qual è il suo rapporto con il Vangelo?
«Il Vangelo occupa un posto speciale. Egli lo legge e rilegge. È la guida per chi vuol vivere secondo giustizia e come Dio ha voluto. Egli scrive che è il più bel libro che abbia mai letto. Che se dovesse averne uno solo, sarebbe il prescelto. Ma aggiunge che il Vangelo resta un libro e che non può sostituire la voce della coscienza. È una visione particolare. Inoltre, Rousseau è molto critico verso i miracoli, sostenendo che Gesù non volle farne e che furono i suoi interlocutori a vederne dappertutto. In questo, prende Pascal in contropiede, ritenendo che si può avere la fede solo togliendo i miracoli».
- Rousseau sognava di riformare il cristianesimo senza ammetterlo?
«Penso di sì. Del resto, talora lo confessa quasi. In certe lettere, scrive: “Nella nostra epoca, non c’è più un solo cristiano sulla terra”, probabilmente vedendosi un po’ come l’ultimo, come il vero discepolo di Cristo del tempo. Rousseau nasce nel protestantesimo, poi a 16 passa al cattolicesimo, a Torino. Quindi, nel 1754, torna a Ginevra e alla confessione riformata. Ma i pastori e la città di Ginevra lo respingono dopo la pubblicazione del Contratto sociale e dell’Emilio. Per Rousseau, Dio è creatore e occorre riconoscerlo come centrale, ma non è trinitario. Nella vita, l’essenziale è avere una buona condotta morale, mentre le condotte dogmatiche della Chiesa sono deboli. Egli si posiziona al di là delle confessioni».
- Pur essendo un grande difensore della tolleranza, Rousseau rifiutava l’ateismo. Un paradosso?
«Egli rifiuta l’ateo, innanzitutto, considerandolo alla stregua di un indifferente. In fondo, per Rousseau, è ateo chi ragionando trova argomenti contro l’esistenza di Dio. Al riguardo, Rousseau non nega che tali argomenti esistano, accanto a quelli che tendono a provare l’esistenza di Dio. Ma in fondo, gli atei sono talmente assorbiti dai loro ragionamenti da soffocare la voce della coscienza. Vi è poi una seconda critica, più sociale. L’ateismo è una convinzione dei benestanti, di coloro che snobbano la miseria altrui. Essi dimenticano che il cristianesimo è innanzitutto attento a chi soffre, un punto che per Rousseau è fondamentale».
NOTA:
AL DI LÀ DELLA "DOTTA IGNORANZA": IL PROBLEMA DELLA CARITÀ ("CHARITAS").
 Un problema di filologia ed eco-nomia (teologia e antropologia)!
Un problema di filologia ed eco-nomia (teologia e antropologia)!- "CARITÀ. Il mondo è un beneficio. - L’umanesimo del Rinascimento, incline al sincretismo, ha messo insieme il Dio donatore dea Bibbia ebraica, il demiurgo patonico e il dio benefattore dello stoicismo. Il trattato De beneficiis di Seneca - in cui la questione del dono è tratta in modo esaustivo - vede in Dio l’esempio supremo della benevolenza disinteressata" (cfr. Jean Starobinski, A piene mani. Dono fastoso e dono perverso, Einaudi, Torino 1995, p. 43).
- SOCRATE E IL DONO DI "SE STESSO" (DELL’ALLIEVO AL MAESTRO): "Dal momento che ognuno offriva a Socrate molte cose secondo le proprie possibilità, Eschine, un allievo povero, disse: "Non trovo nulla degno di te che possa darti, e solo per questo motivo mi sento povero. Quindi ti dono l’unica cosa che ho: me stesso. Gradisci questo dono, te ne prego, per quello che può valere, e considera che altri, pur offrendoti molto, hanno tenuto molto di più per se stessi. E Socrate gli rispose: “Perché mai non dovrebbe essere un grande dono quello che mi hai fatto? A meno che tu non abbia poca stima di te stesso! Avrò, quindi, cura di restituirti a te stesso migliore di quando ti ho ricevuto”. Con questo dono Eschine superò l’animo di Alcibiade, che era pari alle sue ricchezze, e tutta la munificenza dei giovani ricchi."(Lucio Anneo Seneca, De beneficiis, I. 8).
- RAPPORTO INDIVIDUO-SOCIETÀ: IL CONTRATTO SOCIALE. "Rousseau ricorre espressamente al verbo donner (dare, donare) quando definisce il contratto fondamentale: «Ognuno dandosi tutto intero»; «Ognuno dandosi a tutti» (J. Starobinski, op. cit., nota 5, p. 45
- ROUSSEAU E SOCRATE (PLATONE). "Il legislatore di Rousseau riprende in parte il ruolo pedagogico tenuto da Socrate nel racconto riportato da Seneca" (J. Starobinski, op. cit., nota 6, p. 45).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- STORIA E MEMORIA. La Chiesa anglicana: la religiosità di Elisabetta, un lascito al suo popolo (di Francesca Sabatinelli)19 settembre 2022, di Federico La Sala
La Chiesa anglicana: la religiosità di Elisabetta, un lascito al suo popolo
Lealtà, servizio e umiltà, le qualità della Regina che hanno toccato i suoi sudditi. La Reverenda Jules Cave Bergquist: nei suoi messaggi parlava della sua fede e del conforto e del sostegno che offriva proprio a lei
di Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano, 09 settembre 2022.
Il mondo anglicano vive il suo profondo dolore per la morte di Elisabetta II, capo della Chiesa d’Inghilterra. Ad esprimerlo, in tutta la sua interezza, è stato ieri nel suo messaggio di cordoglio l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, primate della comunione anglicana. “Abbiamo perso - aveva scritto Welby - una persona la cui lealtà irremovibile, capacità di servizio e umiltà ci ha aiutato a dare un significato a chi siamo attraverso decenni di straordinari cambiamenti nel nostro mondo e nella nostra società”. Lealtà, capacità di servizio e umiltà, doni spirituali che riconosce anche la Reverenda Jules Cave Bergquist, cappellano di Napoli, Bari, Sorrento e Capri e vicario per l’Italia del Vescovo anglicano per l’Europa:
- Ascolta l’intervista con la reverenda Jules Cave Bergquist
Reverenda, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha sottolineato nel suo messaggio di cordoglio per la morte di Elisabetta II, l’incrollabile lealtà, il servizio e l’umiltà della Regina, qualità che hanno segnato profondamente i sudditi, i fedeli del regno ...
Io credo che si possa capire tutto alla luce di qualcosa che la Regina ha detto in occasione del suo 21mo compleanno. Era in Sudafrica con la famiglia e ha parlato alla sua gente dicendo “Dichiaro davanti a voi tutti che tutta la mia vita sia lunga o corta sarà dedicata al servizio vostro e anche al servizio della nostra grande famiglia imperiale, alla quale noi apparteniamo tutti”. E quindi lei, già all’età di 21 anni, sapendo di divenire poi regina, ha dedicato la sua vita al servizio. E ha riferito a questo diversi momenti della sua vita. Trascorsi gli anni l’impero è diventato il Commonwealth, una famiglia di nazioni, molte delle quali sono indipendenti oggigiorno, tutte però con forti legami di una storia insieme, ma con rapporti aggiornati, e la Regina ha saputo gestire questo aggiornamento con intelligenza e spirito di servizio. Poteva fare questo soltanto con i doni spirituali della lealtà, verso la sua gente, dello spirito di servizio e dell’umiltà nel trasformare l’impero in un Commonwealth, una famiglia.
Qual è l’eredità di Elisabetta? Che cosa lascia al mondo anglicano? Quale segno della sua fede cristiana?
Lei è conosciuta per una fede molto forte e molto personale. Andava in chiesa ogni domenica e anche in altri momenti dell’anno, nelle cappelle dei palazzi reali di tutta Gran Bretagna. È anche vero che nei momenti in cui la Regina indirizzava un messaggio alla sua gente, tipo a Natale, oppure in momenti di crisi, non lasciava mai scappare l’opportunità di parlare della fede e del conforto e del sostegno che offriva proprio a lei. E credo anche che la sua eredità sia quella di aver saputo trasmettere l’importanza della fede ai suoi discendenti, e quindi anche a Carlo e a William, il rispetto per la fede e l’importanza dei titoli che loro erediteranno come lei ha ereditato, come quello di Defensor fidei, difensore della fede, o di suprema governatrice della Chiesa anglicana. Sono titoli personali ma devono essere radicati nella realtà dell’essere il responsabile spirituale di una Chiesa.
In molti hanno sottolineato la capacità di Elisabetta II di interpretare un ruolo che lei considerava una missione, lei è d’accordo?
Sì, certo. Come dicevo prima, a proposito del suo 21mo compleanno, è sempre stato importantissimo per Elisabetta. Essere monarca per lei era essere Difensor fidei. Sappiamo tutti che Difensor fidei è stato un titolo dato ad Enrico VIII dal Papa (Papa Leone X ndr) per aver scritto un libro sui sette sacramenti. È un titolo ereditato dalla Regina e poi anche dai re. Molte persone mi chiedono: “Ma la Regina è il capo della vostra Chiesa, della Chiesa di Inghilterra, della Chiesa anglicana?” Il capo della Chiesa nostra è Cristo, come per la Chiesa Cattolica. Il Papa per voi è il vicario di Cristo, per noi la Regina, così come i suoi successori, sono governatori supremi della Chiesa d’Inghilterra, significa che il ruolo comprende l’accertarsi che la sua Chiesa abbia i vescovi per essere governata, significa quindi invitare i vescovi ad assumere le responsabilità per il gregge. La Regina ha saputo aggiornare anche questa missione e tramandarla ai suoi discendenti. Era molto importante per lei, non solo la fede personale, ma anche guardare alla fede come una cosa da tramandare al suo popolo, ai suoi eredi.
Lei l’ha incontrata personalmente? Ne ha un ricordo?
No, non l’ho mai incontrata, ho conosciuto sua sorella, Margaret, anche lei donna di grande fede. Però ho incontrato il principe Carlo (Re Carlo III). Ero responsabile nazionale delle vocazioni e lui veniva ad un seminario anglicano a Oxford, quindi ho avuto l’opportunità di parlargli. È una persona molto interessante, è molto curioso di sapere, di incontrare, di agire per il bene. Perlopiù in Inghilterra è conosciuto come agricoltore biologico, sperimenta da decenni una agricoltura ecosostenibile. È appassionato, instancabile sostenitore dei movimenti per salvaguardare il creato, e credo che in questo andrà molto d’accordo con Papa Francesco, autore della Laudato si’. Però Carlo ha parlato anche del titolo di Difensor fidei, che sapeva un giorno avrebbe ereditato. A lui interessano molto anche le altre Chiese cristiane, così come le altre religioni presenti nel territorio. È conosciuto per avere conoscenza profonda dell’Islam, per esempio. Quindi, credo che nel futuro Carlo saprà salvaguardare la libertà della fede di tutti i suoi sudditi.
 In molti leggeranno come una novità avere un Re che si interessa anche di altre religioni, ma non è vero, e la prova ne è il fatto che il nonno di Carlo, cioè il padre di Elisabetta (Re Giorgio VI, ndr) era ancora imperatore dell’Impero britannico quando fece costruire decenni fa la prima moschea in Inghilterra, a Londra, a St John’s Wood, su di un terreno della casa reale. Fece costruire questa moschea per i suoi sudditi musulmani, quindi già al tempo del padre della Regina la monarchia inglese voleva salvaguardare la possibilità di professare la propria fede e di avere i posti dove farlo. Io sono piena di speranza che la regina abbia saputo tramandare a Re Carlo III l’importanza della fede, nella vita sia della famiglia reale, sia dei suoi sudditi.
In molti leggeranno come una novità avere un Re che si interessa anche di altre religioni, ma non è vero, e la prova ne è il fatto che il nonno di Carlo, cioè il padre di Elisabetta (Re Giorgio VI, ndr) era ancora imperatore dell’Impero britannico quando fece costruire decenni fa la prima moschea in Inghilterra, a Londra, a St John’s Wood, su di un terreno della casa reale. Fece costruire questa moschea per i suoi sudditi musulmani, quindi già al tempo del padre della Regina la monarchia inglese voleva salvaguardare la possibilità di professare la propria fede e di avere i posti dove farlo. Io sono piena di speranza che la regina abbia saputo tramandare a Re Carlo III l’importanza della fede, nella vita sia della famiglia reale, sia dei suoi sudditi. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Nella Chiesa un processo che non potrà essere arrestato, dice Liviana Gazzetta, autrice di “Virgo et Sacerdos” (di Maria Rosaria De Rosa)14 settembre 2022, di Federico La Sala
Nella Chiesa un processo che non potrà essere arrestato, dice Liviana Gazzetta, autrice di “Virgo et Sacerdos”
di Maria Rosaria De Rosa (Il paese delle donne on line - rivista,15 Febbraio 2021
Partiamo dall’attualità in questo incontro con Liviana Gazzetta, studiosa di storia delle donne - si è occupata dei movimenti femminili nell’Italia contemporanea - e autrice del libro appena pubblicato Virgo et Sacerdos. Idee di sacerdozio femminile tra Ottocento e Novecento, Edizioni Storia e Letteratura, Roma 2020.
Per la prima volta una donna parteciperà al Sinodo dei Vescovi non solo con funzioni consultive ma anche con diritto di voto. Il 6 febbraio papa Francesco ha nominato sottosegretaria del Sinodo suor Nathalie Becquart, religiosa saveriana, già direttrice del Servizio Nazionale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza dei Vescovi di Francia. A gennaio, il Papa ha aperto anche formalmente alle donne, nella liturgia cattolica, il Lettorato e l’Accolitato. Infine, per la prima volta, c’è una sottosegretaria di Stato, Francesca di Giovanni. E numerose sono le nomine di laici e di donne laiche in posti chiave, ad esempio la nomina di sei docenti universitarie e manager della finanza nel Consiglio per l’Economia Vaticana.
- Queste novità introdotte da Bergoglio vanno ascritte a un processo irreversibile di apertura alle donne della Chiesa o, piuttosto, alla volontà di papa Francesco di inserire, nel governo della chiesa cattolica, i laici e, tra questi, le donne?
Perdonami se aggiungo al tuo elenco di fatti innovativi anche questo dato, che non è promosso dalla gerarchia, ma mi pare di grande rilievo: nel maggio del 2020 si è avuta la candidatura simbolica della teologa e biblista francese Anne Soupa (fondatrice del “Comité de la Jupe”) al ruolo di arcivescovo di Lione. Poi non dimenticherei l’incisiva lettera “Chiesa, chiedici scusa” firmata da centinaia e centinaia di credenti a vario titolo.
Nel merito della tua domanda, credo che all’interno della chiesa cattolica si sia aperto un processo che non potrà essere arrestato. Un processo che dal punto di vista storico si può leggere anche come riflesso di processi più ampi di crescita della soggettività femminile da cui il mondo cattolico non si difende più, come un tempo, secondo la logica intransigentistica. Dal punto di vista spirituale, poi, direi che questo processo dipende anche dalla ricchezza della ricerca femminile aperta tra teologhe, religiose, donne delle comunità: mentre il femminismo cosiddetto laico, a mio avviso, conosce le secche del materialismo e di una sostanziale mancanza di orizzonti, dentro la chiesa c’è invece una dinamicità intensa, spesso connessa alla contraddizione di fondo tra le grandi finalità universali della fede e le disparità di fatto ancora esistenti tra uomini e donne. Mi pare che, tenendo conto di questo, Bergoglio stia tentando di aprire lentamente, ma progressivamente, la chiesa a questa ricchezza, come parte di un tentativo più generale di riforma delle strutture ecclesiali.
- Che cosa fa veramente ostacolo, anche in un papato rivoluzionario come quello di Bergoglio, al sacerdozio femminile?
In modo sintetico, e forse un po’ provocatorio, si potrebbe dire un po’ tutto e un po’ niente. Dal punto di vista sostanziale è diventato palese che le motivazioni legate all’impedimentum sexus non reggono assolutamente più. Nello stesso tempo pesa tutta la millenaria tradizione, che per il mondo cattolico gioca un ruolo molto importante (a differenza delle chiese evangeliche); pesa la posizione del Magistero, in particolare di papa Giovanni Paolo II con la sua “Ordinatio sacerdotalis”, che è stata presentata come sintesi definitiva (naturalmente negativa) sulla questione; pesa soprattutto il fatto che buona parte del potere effettivo nella chiesa è ancora nelle mani di uomini: la maggior parte dei quali non ha mosso un passo verso la comprensione di queste realtà.
- Nel libro “Virgo et Sacerdos” analizzi un volto inedito del cattolicesimo femminile alle soglie del Ventesimo secolo e parli di un circuito virtuoso che già nel primo’900 poteva crearsi tra una soggettività consapevole di sé e della propria autonomia interiore e il modello della Vergine corredentrice. Come questo ha influito sulla ‘domanda’ femminile di sacerdozio?
Quello che emerge dalla mia ricerca, così come da parallele ricerche di Claude Langlois, è che è esistita una domanda femminile di sacerdozio che si è espressa ben prima del Concilio Vaticano II, presente anche in personalità che pure accettavano in toto la dottrina della chiesa o che addirittura erano su posizioni di intransigente opposizione al mondo moderno. La loro non era infatti una rivendicazione di diritto al ministero ordinato, ma una dedizione totale di sé, una forte vocazione che non trovava riconoscimento. Queste personalità manifestavano una sofferenza sottile ma profonda per la misoginia e il disprezzo che il clero mostrava nei confronti della loro ricerca spirituale. Era quindi l’identificazione con la Vergine, unita a una riflessione sul suo ruolo nel sacerdozio universale di Cristo (per questo l’appellativo di Virgo sacerdos), che consentiva di esprimere quel bisogno non riconosciuto.
- Evidenzi la distinzione tra vocazione e rivendicazione di un diritto nella domanda di accesso al sacerdozio da parte delle donne. Il femminismo ha avuto un ruolo in questa doppia lettura delle richieste delle donne?
La mia tesi è che il femminismo ha influito storicamente su entrambi i piani in cui è stata avanzata la domanda di sacerdozio. Il femminismo ha influito chiaramente sui processi di crescita della soggettività femminile che sono all’origine del piano rivendicativo al sacerdozio; ma ha influito anche indirettamente sul piano della vocazione: costituendo uno stimolo a pensare nuovi e più autonomi modi di vivere la femminilità, il movimento femminista ha per riflesso innescato processi di crescita anche in quelle donne cattoliche che, opponendosi alla domanda di diritti e libertà, finivano per cercare nuovi percorsi oltre i modelli tradizionali.
- Secondo te quali sono, tra le vicende che hai ricostruito nel libro, le esperienze più originali che nella storia della Chiesa hanno visto protagoniste le donne?
Il culto alla Virgo sacerdos (su cui il S. Uffizio pose una sorta di pietra tombale agli inizi del ‘900) ha avuto aspetti di originalità anche perché associata a una ricerca iconografica per accreditare forme di rappresentazione, appunto, sacerdotale della Madonna: una Vergine potente, mediatrice tra Dio e l’umanità, vestita con la pianeta dei preti, una Vergine come non l’abbiamo praticamente mai vista raffigurata nelle nostre chiese. Aggiungo che quasi tutte le famiglie religiose femminili che sono nate o hanno sviluppato una spiritualità legata al sacerdozio di Cristo (e la mia ricerca su questo si può dire solo agli inizi) hanno mostrato una grande consapevolezza delle insufficienze del clero maschile nello svolgimento del proprio ruolo e un’insospettata capacità di rielaborazione della tradizione teologica in un modo più favorevole alle donne.
Vorrei però citare come altrettanto inaspettate le reazioni dei teologi del S. Uffizio alla devozione di cui stiamo parlando: reazioni che mostrano un fastidio, un’insofferenza, una misoginia così profonde da far pensare a quanto poco i valori del cristianesimo dovessero aver permeato le loro vite...
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Il filosofo Simone Regazzoni: «Rimettiamo al centro il Pianeta Blu». Intervista di Maria Tatsos.12 settembre 2022, di Federico La Sala
Il filosofo Simone Regazzoni: «Rimettiamo al centro il Pianeta Blu»
È ora di ripensare la nostra identità e mettere l’Oceano e non la Terra al centro dell’idea di appartenenza. È l’invito del filosofo Simone Regazzoni che ripercorrendo la storia del pensiero vi scopre la chiave del futuro: sentirsi interconnessi agli altri esseri viventi. Dell’intero Universo
di MARIA TATSOS (Corriere della Sera, "Io Donna", 12-09-2022)
Il 24 dicembre del 1972 il New York Times pubblica una foto destinata a entrare nella Storia. È lo scatto realizzato dagli astronauti dell’Apollo 17 in viaggio verso la Luna, che ritrae la Terra. Per la prima volta, l’occhio umano scopre che il pianeta è una sfera blu, in cui è l’acqua - e non la terraferma - a colpirci per vastità.Noi Sapiens con l’Oceano abbiamo avuto un rapporto contraddittorio: ci affascina e ci spaventa, con fare predatorio sfruttiamo le sue ricchezze come se fossero inesauribili e lo inquiniamo come se potesse, per magia, rigenerarsi come l’araba fenice. È giunto il momento di ripensare alla nostra relazione con l’elemento acquoreo intorno a noi. E per farlo abbiamo sentito il filosofo Simone Regazzoni, che insegna presso l’Irpa di Milano (Istituto di Ricerca di Psicanalisi Applicata) e che al tema ha dedicato Oceano. Filosofia del pianeta (Ponte alle Grazie).
- Iniziamo dal nome: è più giusto chiamare il nostro pianeta Terra, o Oceano?
Propongo di chiamarlo Oceano, ma non sono il primo. Sul sito della Nasa è definito Ocean Planet, o Water World (Pianeta Oceano o Pianeta Acquoreo). Da un ventennio, si tende a sottolineare la centralità dell’Oceano per la nostra vita. Definire Terra il nostro pianeta è una visione riduttiva, legata agli umani, e non a tutte le altre specie biologiche che per l’80 per cento vivono nei mari. Cambiare nome non è un vezzo, ma ci consente di prendere consapevolezza di un altro modo di abitare questo mondo, cioè iperconnessi con gli altri viventi, come se fossimo immersi in una grande bolla oceanica in movimento, partecipi di questo grande flusso con tutto ciò che è vita. Uno sguardo differente può aiutarci a cambiare i nostri comportamenti. La natura non è qualcosa di altro da noi.
- Simone Regazzoni: «Nasciamo in un piccolo Oceano»
- Occorre rivalutare il rapporto con gli oceani perché è da lì che veniamo?
Sì, è così. Specie evolute come la nostra hanno mantenuto un tratto legato all’origine della vita. Nasciamo in un mare interiore, una sacca d’acqua che è l’utero materno che, come ha detto lo psicanalista Sándor Ferenczi, è come un piccolo Oceano. Non c’è futuro per il pianeta e per la nostra vita se non ci prendiamo cura delle acque. L’aumento della CO2 comporta un rialzo della temperatura che influisce sulle correnti oceaniche. Basti pensare alla corrente del Golfo, che determina il clima del nord Europa. Sono sufficienti pochi gradi in più e il pianeta diventa invivibile. E anche se abitiamo lontano dagli oceani, il nostro modo di vivere e il nostro futuro dipendono da loro e da come li trattiamo.
- Quando l’umanità si è resa conto dell’esistenza di queste enormi distese d’acqua?
Oceano, in greco “okeanòs”, è parola talmente antica che non è greca. Va a cogliere un tipo di esperienza primigenia che Omero e gli antichi filosofi presocratici hanno descritto molto bene: per loro è un fiume che circola, salendo dal mare verso il cielo e poi ritorna al mare. Noi oggi la chiamiamo idrosfera. Questo dava la consapevolezza di essere immersi in un tutto che ci avvolge, un’immagine che è antica e anche contemporanea: il finale di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick mostra un feto in una sorta di bolla d’acqua di fronte al pianeta Terra, come se si specchiassero l’uno nell’altra. Questa interconnessione gli antichi la conoscevano bene e l’avevano denominata Okeanòs, una figura mitica che non era né maschile, né femminile, più potente di Zeus.
- [Foto] Simone Regazzoni. OCEANO Filosofia del pianeta, Ponte alle Grazie, 224 pagg, 16.00 €
- La visione greca è quindi collegata a cosmogonie più antiche?
Gli egizi parlano di un’origine di tutto a partire dall’Oceano. Dalla Mesopotamia giunge la più antica mappa nota, conservata presso il British Museum, dove il mondo è attorniato da un fiume salato. Le cosmogonie dell’area mediterranea, di provenienza orientale, presentano questo elemento fluido, in divenire, da cui tutto proviene e resta in profonda connessione. Il primo filosofo della Storia, Talete, le conosceva e sosteneva che all’inizio c’è l’acqua, sulla quale la Terra scorrerebbe come sopra una tavola ben levigata. È il primo a evocare quest’immagine, ma già nel mito del diluvio universale c’è un’arca-microcosmo che galleggia. Quest’idea di terra instabile che scorre su qualcosa di fluido viene dimenticata, per poi riemergere in tempi recenti con la teoria della deriva dei continenti. Gli antichi non erano così lontani dalla verità.
- L’Oceano ci appare mostruoso, ci spaventa ma allo stesso tempo ci attrae. Perché?
Perché in una Terra che oggi è quasi interamente mappata rimane per gran parte inesplorato e racchiude forme di vita a noi ancora ignote. È come se fosse una parte intima di noi che al contempo ci è estranea. È uno spazio vicino a noi, ma alieno e la sua forza non si può addomesticare. Pensiamo alle grandi piattaforme petrolifere, progettate per resistere alle correnti: possono naufragare investite da un’onda anomala, fenomeno che non sappiamo spiegare e che incide anche sulla navigazione. Al contempo, ci affascina perché è l’ultimo fronte esplorabile del nostro pianeta. È lo spazio che rimane per l’avventura, come il cielo.
- [Foto] Oceanix, in Corea del Sud la città galleggiante del futuro contro l’innalzamento del livello del mare
- Melville, geniale creatore di Moby Dick, cosa ha voluto rappresentare?
Moby Dick è qualcosa di portentoso, non afferrabile e non controllabile, che ci attira e ci fa paura. È simbolo dell’Oceano che Melville tratteggia a partire da un quadro di Turner, Whalers, dove c’è una balena nera che esce dalle acque. Entrambi avevano visto che lo spazio oceanico rappresenta quel tipo di forza, che è al contempo emblema di pienezza vitale e rischio di distruzione. I surfisti delle grandi onde, quelle di oltre 20 metri, cercano di non contrapporsi alla loro energia, ma di entrare in consonanza. È quella vita che non conosce morte, di cui facciamo esperienza come il massimo dell’intensità, al limite della disgregazione. È una forza vitale immortale. Siamo fatti al 50-60 per cento di acqua.
- Immergersi significa ritornare al nostro elemento primordiale, «entrare in contatto con il pesce che nuota in me», come lei scrive.
Se mettiamo un neonato in piscina, non ha paura. Non a caso il parto in acqua è tra i meno traumatici. Siamo dei pesci modificati: ce lo dice la biologia, e anche il filosofo Empedocle diceva che siamo stati pesci. Nuotare significa riscoprire quella dimensione. D’estate, il contatto con il mare ci permette di scaricare la tensione accumulata nel nostro vivere da terrestri. Nuotare è un modo di pensare: Platone afferma che non saper scrivere è come non saper nuotare. Greci e romani davano al nuoto grande importanza, che nel tempo si è persa. Solo dall’Ottocento la spiaggia diventa luogo-soglia per tornare in contatto con una parte di noi rimossa.
- La presenza di mari su altri pianeti ci dà speranza di trovare anche altre forme di vita?
Questa è fra le scoperte più recenti. Nei nostri oceani, abbiamo visto che c’è possibilità di vita anche senza luce solare e fotosintesi - esistono dei batteri chemioautotrofi, che ricavano energia ossidando l’acido solfidrico - quindi anche su vari pianeti e lune ghiacciati con oceani sotto la crosta potrebbero esserci condizioni adatte. Questo cambia anche la nostra prospettiva del nostro pianeta nel cosmo. La Terra non è al centro dell’universo, anche se mentalmente ci consideriamo ancora tali. Se pensiamo a un pianeta Oceano connesso ad altri significa pensare alla possibilità di un universo biologico anche nel nostro sistema solare.
- Il suo libro è stato concepito a Maupiti, in un atollo corallino della Polinesia francese. Che effetto ha avuto pensare all’Oceano, circondato dalle acque?
Per me la filosofia non è un discorso astratto. Parte da un’esperienza, da un vissuto e da una biografia. Maupiti è un luogo non ancora invaso dai resort turistici, consente l’esperienza della labilità della terraferma: ci si trova su un rialzo di sabbia che si alza di pochi metri sulle acque, è come essere alla deriva in una zattera. Mi sono trovato in mezzo a un brulicare di vita - coralli, pesci - con la percezione che da un momento all’altro quella distesa blu con cui mi sono sentito in consonanza può cancellare ciò che è stabile. È stata l’occasione di una riflessione suscitata da un’esperienza viva e carnale, a partire dalla quale confrontarmi con i testi filosofici.
LEGGI ANCHE
 Verso la generazione Oceano
Verso la generazione Oceano -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO. RIPARTIRE DA SHAKESPEARE20 agosto 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFIA E PSICOANALISI: A TEATRO, A TEATRO! Per "aprire gli occhi" (Freud) e ricomprendere il senso dell’amore di Platone, rileggere il "Simposio" e riascoltare i poeti: ripartire da Shakespeare!
LA "REPUBBLICA" DI PLATONE: "C’È DEL MARCIO IN DANIMARCA"("AMLETO"). A seguire le indicazioni filologiche (più che i manuali di storia della filosofia, forse, si può meglio comprendere il gioco e il giogo di Platone: appropriarsi di "tutta" la "forza" ("sos-kratos") di una figura del "demos" (popolo), il famoso e saggio "So-crate", e restaurare e ripresentare tutta la forza ("sos-kratos") della vecchia aristocrazia terriera come l’arché, il principio, il fondamento dell’intera società ateniese e... di tutta la Terra.
IL "SIMPOSIO", FONDAMENTO DEL PLATONISMO PER IL POPOLO (Nietzsche): "COME VI PIACE". Per ben orientarsi e comprendere il senso del racconto di Diotima narrato da Socrate sulla figura di Eros, l’amore platonico, vale la pena riflettere su quanto già dice Shakespeare circa quattrocento anni fa:
- ROSALINDA. O cugina, cugina cugina, cuginetta mia, se tu sapessi in che profondo m’ha sprofondata l’amore! Non c’è scandaglio che lo sondi. La mia passione ha un fondo ignoto, come la Baia del Portogallo.
- CELIA. Direi piuttosto che è senza fondo, dimodoché più ne versi e più svanisce.
- ROSALINDA. No, quel bastardaccio di Venere, quel figlio della fantasia, concepito dalla tristezza e nato dalla pazzia, quel farabutto moccioso che inganna gli occhi di tutti perché i suoi sono ciechi, venga lui stesso in persona a giudicare quant’è profondo il mio amore.
- ("Come vi piace", IV. 1. 195-205).
"HANG UP PHILOSOPHY"("ROMEO E GIULIETTA", III, 3, 57):"L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO" (Sonetto 116). A commento di "queste parole" pronunciate da Rosalinda, la "donna più arguta", Harold Bloom scrive: "Shakespeare non consente a nulla che assomigli alla suprema intelligenza di Rosalinda di interferire con l’autentico rapimento di Giulietta [...] Shakespeare fa in modo che Giulietta pronunci la più nobile dichiarazione d’amore romantico mai scritta in inglese:
- GIULIETTA. Per essere generosa e potertelo ridare.
- MA io desidero solo quello che già ho.
- La mia generosità è come il mare e non ha confini,
- e il mio amore è altrettanto: ambedue sono infiniti
- e così più do a te più ho per me
- (II. 2. 131-135)
Dobbiamo valutare il resto dell’opera in base a questi cinque versi, mirabili per il loro giusto orgoglio e la loro intensità [...] Credo di non essere il solo a sostenere che l’amore condiviso da Romeo e Giulietta sia la passione più sana e costruttiva regalataci dalla letteratura occidentale" (H. Bloom, "Shakespeare. L’invenzione dell’uomo", Rizzoli, Milano 2001, pp.62-63).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---"IL CANTO DI ULISSE" AD AUSCHWITZ: DANTE ALIGHIERI, PRIMO LEVI, HANNA HARENDT, ED ENZO PACI.17 agosto 2022, di Federico La Sala
MEMORIA E ANTROPOLOGIA E DISAGIO DELLA CIVILTÀ:
DANTE ALIGHIERI, PRIMO LEVI, HANNA HARENDT, ED ENZO PACI.
"IL CANTO DI ULISSE" E IL "PIKOLO" SEGRETO DELLA STORIA...
- Primo Levi a «Pikolo» Jean Samuel:
- «[...] Ecco, attento Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca:
- Considerate la vostra semenza:
- fatti non foste a viver come bruti,
- ma per seguir virtute e conoscenza.
- Come se anch’io lo sentissi per la prima volta: come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono.
- Pikolo mi prega di ripetere. Come è buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse è qualcosa di più: forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle» (Primo Levi, "Se questo è un uomo", Einaudi).
COME UNO SQUILLO DI TROMBA. L’Ulisse di Dante ad Auschwitz svela a Primo Levi il Pikolo segreto della storia "che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie".
HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» [Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21]. La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987).
UN PRESEPIO NEL LAGER. Nel Natale 1944, Enzo Paci con vari militari (tra cui Paul Ricoeur) prigionieri nel Lager di Wietzendorf, riflette su "Nicodemo o della nascita").
Federico La Sala
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E FILOLOGIA: PER UNA CHIESA SINODALE. Memoria di Maria Maddalena (di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo).23 luglio 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA, QUESTIONE CRISTOLOGICA, E FILOLOGIA: DIO E’ CARITÀ (CHARITAS) O MAMMONA (CARITAS)?!
Un intervento di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo su ’L’OSSERVATORE ROMANO, in occasione della "festa liturgica di santa Maria Maddalena", degno di attenzione e riflessione...
- La festa liturgica di santa Maria Maddalena
- PER UNA CHIESA SINODALE.
Oggi celebriamo la festa liturgica di Maria Maddalena, icona di una Chiesa “Maddalena”, dal cuore giovane, capace di accogliere la Pentecoste del Concilio Vaticano II . Questa santa «illumina il cammino che la Chiesa vuole compiere con e per i giovani [...] un cammino di risurrezione che conduce all’annuncio e alla missione. Abitata da un profondo desiderio del Signore, sfidando il buio della notte, la Maddalena corre da Pietro e dall’altro discepolo. Il suo movimento innesca il loro, la sua dedizione femminile anticipa il cammino degli apostoli e apre loro la strada. [...] La sorpresa dell’incontro: Maria ha cercato perché amava, ma trova perché è amata. [...] Il Risorto [...] non è un tesoro da imprigionare, ma un Mistero da condividere. Così ella diventa la prima discepola missionaria, l’apostola degli apostoli. Guarita dalle sue ferite è testimone della risurrezione, è l’immagine della Chiesa giovane che sogniamo» (Sinodo dei giovani, documento finale, 115).
In Oriente Maria Maddalena è definita «portatrice di unguento», «mirofora», in riferimento al corpo di Cristo sepolto. In quella tradizione non ci sono state difficoltà a definirla discepola e apostola, «isoapostola», come gli altri dodici. Gregorio Antiocheno vescovo ( VI secolo) attribuisce a Cristo queste parole per Maria Maddalena: «Proclamate ai miei discepoli i misteri che avete visto. Diventate le prime maestre dei maestri. Pietro, che mi ha negato, deve imparare che io posso anche scegliere donne come apostoli» (Oratio in mulieres unguentiferas, Patrologia Graeca, 88, 11, pag. 1863).
Nella tradizione occidentale san Gregorio Magno nel 591 nella basilica di San Clemente a Roma, durante un sermone, identifica erroneamente Maria Maddalena con altre due donne, la peccatrice di Luca, 7, 36-50 e Maria di Betania sorella di Lazzaro e di Marta: «Crediamo che questa donna che Luca chiama peccatrice e Giovanni chiama Maria sia quella Maria dalla quale - afferma Marco - furono cacciati sette demoni» (Homiliarum in Evangelia, 33, 1, Patrologia Latina, 76, pag. 1239, n. 1592-1593). Non voleva disprezzarla: dobbiamo tenere presente la situazione storica in cui le omelie di Gregorio furono pronunciate e i fedeli ai quali si rivolgeva; più che della storicizzazione era preoccupato per l’attualizzazione del messaggio biblico. Lo stesso san Gregorio in un sermone precedente aveva messo in evidenza la bellezza del primo annuncio che nasce dall’amore: ella mossa dall’amore conobbe il Risorto; fu il suo amore a provocare il Risorto a mostrarsi (Homiliarum in Evangelia, 25, 1-10, Patrologia Latina, 76, pagg. 1188-1196, n. 1544-1553).
L’errore esegetico partito dal pulpito di San Clemente trovò l’humus del pregiudizio maschilista e patriarcale. Sarebbero bastate nozioni elementari di geografia per evitare la sovrapposizione di tre figure diverse: Betania si trova in Giudea e Magdala è una cittadina della Galilea. Inoltre la provenienza della terza donna, la peccatrice, non è chiarita. L’elemento antropologico che caratterizza Maria di Magdala e le altre donne che seguono Gesù mette a dura prova il preconcetto della superiorità e forza maschile di fronte alla debolezza femminile. Davanti alla morte e resurrezione di Cristo i maschi tradiscono, scappano e spergiurano. Le donne sono fedeli, amano e annunciano il Salvatore.
Sarebbe bastato ricordare le parole di san Girolamo sul termine magdal che non designava tanto il paese di provenienza ma il soprannome di questa Maria: in aramaico significa «torre», a indicare l’altezza e la robustezza della fede della donna che vide per prima Gesù risorto, risaltando le qualità di fortezza e grandezza. Egli sottolinea come i cristiani valutano le virtù non dal sesso ma dall’animo: «Posso ridere, lettore forse incredulo, per soffermarmi sulla lode delle donne, e ricordare le sante donne, compagne del Divin Salvatore, che lo assistevano con le loro sostanze, e le tre Marie che stanno davanti alla croce, e Maria Maddalena, la quale per la sua operosità e ardore di fede, ricevette il nome di “turrita” e prima degli apostoli meritò di vedere Cristo risorgere; ci condannerà alla superbia e alla stoltezza, noi che giudichiamo per virtù, non per sesso, ma per l’animo; consideriamo una gloria maggiore della nobiltà e della ricchezza» (Epistola Marcellae viduae epitaphium, 127, 5, Patrologia Latina, 22, pag. 1090, n. 954-955).
Così non fu: si stravolse la figura della santa, che passò da «apostola prima degli apostoli» a «grande peccatrice», modello cristiano della penitenza. Anche nell’arte la sua rappresentazione seguiva uno schema iconografico preciso di stampo maschilista che tanta presa fece nella pietà popolare: la nudità spudorata e seducente, il pianto di espiazione e l’atteggiamento di supplica. Ancora oggi Maria Maddalena rappresenta prevalentemente la peccatrice “penitente”, nonostante l’opera di riforma liturgica del Concilio Vaticano II . In coerenza con i principi teologici e pastorali dell’ecclesiologia le figure dei santi furono sottoposte a esame critico. Paolo VI riscattò questa figura nella revisione del Calendario Romano generale del 1969 rigettando ufficialmente l’identificazione di Maria Maddalena con la peccatrice e con Maria di Betania sorella di Lazzaro e di Marta.
Il Calendarium Romanum generale 1969, nella sezione Commentarius historicus calendarii instaurati, pagg. 97-98, dice: «22 luglio. S. Maria Maddalena. Il Martirologio di Beda fa menzione, il 22 luglio, di Maria Maddalena. Nello stesso giorno la sua festa è celebrata presso i Siriani, i Bizantini e i Copti. Ma il culto di Santa Maria Maddalena in Occidente non è diffuso prima del secolo dodicesimo. Nella liturgia romana riformata non ci sarà più la memoria di Maria di Betania né della donna peccatrice di cui tratta Lc, 7, 36-50, ma soltanto di Maria Maddalena alla quale per prima Cristo apparve dopo la sua risurrezione». Nella sezione Variationes in Calendarium Romanum Inductae ribadisce a pagina 131: «22 luglio. S. Maria Maddalena: nulla cambia per il titolo della memoria di questo giorno, ma si tratta soltanto di S. Maria Maddalena alla quale Cristo apparve dopo la sua resurrezione, ma non della sorella di Santa Marta, né della peccatrice alla quale il Signore ha rimesso i peccati (Lc 7, 36-50)».
Santa Maria Maddalena è come un simbolo. Come è tuttora difficile farla passare da prostituta penitente ad apostola, così sembra ancora difficile che il concilio si faccia strada nella Chiesa. Le donne sono il segno di questo passaggio ecclesiale, per mettere fine, come dice Papa Francesco, alla «perversione della Chiesa oggi [che] è il clericalismo» (La Civiltà Cattolica, 4040 [2018] 105-113). Non a caso il 22 luglio 2016 per volontà dello stesso Pontefice la memoria obbligatoria di Maria Maddalena è stata elevata al grado di festa, al pari degli apostoli.
Questa santa ci può aiutare a sviluppare una spiritualità sinodale. Ecco perché è importante che venga conosciuta nella sua identità di «apostola» nelle Chiese locali. In lei si concretizzano i tre elementi-chiave della comunione, della partecipazione e della missione. Ella è unita a Cristo con le altre donne e con i discepoli, superando ogni pregiudizio e separazione sociale; prende l’iniziativa mossa dall’amore intenso; annuncia la resurrezione del Signore con entusiasmo e parresia, invitando alla speranza del paradiso. La sua figura è pienamente ecumenica, legittimata dai Vangeli, attenzionata sia nelle Chiese orientali sia in quelle riformate. La guerra in Ucraina ha messo a nudo tante ipocrisie nelle comunità cristiane che siamo chiamati a superare per essere credibili: dobbiamo essere coraggiosi, e mostrare al mondo una Chiesa “Maddalena”, una Chiesa sinodale che non dubita e non calcola ma è testimone del bene e della pace e non teme.
di PAOLO SCARAFONI e FILOMENA RIZZO (L’OSSERVATORE ROMANO, 22 LUGLIO 2022).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CULTURA E SOCIETA’: QUEL FREUD E’ PEGGIO DI KAFKA.""Io non mi metterò mai in opposizione alle credenze della chiesa cattolica" (Carl G. Jung).8 luglio 2022, di Federico La Sala
QUEL FREUD E’ PEGGIO DI KAFKA*
LONDRA - Non li divideva soltanto il dissidio ideologico sulla natura ultima dell’ uomo e sulla pratica psicoanalitica. Carl Gustav Jung detestava Sigmund Freud con tutto il cuore, e per lui finì per nutrire soprattutto disprezzo. "Mi dà sui nervi per il suo arido razionalismo", confessa Jung in una lettera ad una devota seguace, la psicologa ungherese Jolande Jacobi. Questa e altre ottantasei missive inedite, sempre con destinataria la Jacobi, saranno messe all’ asta a Londra da Sotheby’ s il 26 maggio e dovrebbero essere vendute ad un prezzo notevole: da sessanta a settantacinque milioni di lire.
Tra i primi e più zelanti discepoli del "padre della psicoanalisi" Freud, Jung ruppe ogni rapporto con l’ autorevole maestro nel 1913 dopo un sodalizio di sei anni: non ne accettava il principio basilare della libido sessuale come motore profondo della personalità. Dalle 87 lettere inedite (56 scritte a mano e 31 a macchina, la prima è del 1928 e l’ ultima del 1961) emerge con lampante chiarezza che le divergenze filosofiche si tramutarono in sprezzante antipatia: "Freud - denuncia ad esempio Jung - è troppo piatto per me. Ha la stessa psicologia di Kafka, che io trovo altrettanto intollerabile". "Freud - si legge in un altra polemica missiva a Iolande - è un dottrinario mentre io non ho dottrine ma descrivo i fatti. Io non insegno come si sviluppa la nevrosi ma descrivo che cosa si trova nelle persone nevrotiche". Pur avendo spesso e volentieri teorizzato e fantasticato sui simboli universali presenti nell’ inconscio collettivo (gli "archetipi"), Jung contesta a Freud anche l’ audace tentativo di una categorizzazione dei sogni e il discutibile metodo della "libera associazione".
L’epistolario non è importante soltanto per la nuova luce che getta sul tormentato rapporto con Freud ma per meglio capire il laborioso sviluppo della teoria psicologica junghiana.
Nato in Svizzera, morto nel 1961 a 86 anni, Jung rivela in una lettera che si guarda bene dal prendere in cura pazienti cattolici: "Io non mi metterò mai in opposizione alle credenze della chiesa cattolica. Rimanderò sempre un cattolico praticante e convinto al suo confessore, non pretendo di mettermi in opposizione al potere guaritore della Chiesa". In una missiva del giugno ’ 33 lo psichiatra elvetico si mostra lungimirante sull’ascesa del nazismo in quel "calderone di gorgoglianti streghe" che è la Germania.
* Fonte: la Repubblica (20 maggio 1994)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "PERCORSI DI CRISTOLOGIA FEMMINISTA": IL RILANCIO DELLE TEOLOGHE. Un doc.umento del Coordinamento delle teologhe italiane (di Vittoria Prisciandaro).12 giugno 2022, di Federico La Sala
Exousia e cristologia femminista al seminario del Cti
Il rilancio delle teologhe
di VITTORIA PRISCIANDARO (L’Osservatore Romano, 04 giugno 2022)
- [Foto] Il rilancio delle teologhe DCM-006
- Ma lei gli replicò
- Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato.
- Marco 7, 24-30
Ci sono anche loro tra le firmatarie della articolata riflessione proposta ai “Fratelli vescovi” come contributo al cammino sinodale. Del documento “Ma lei gli replicò”, che fa riferimento «alla conversione di Gesù dopo lo straordinario dialogo con la donna siro-fenicia», il Coordinamento delle teologhe italiane (Cti) ha parlato anche durante il seminario del 7 maggio scorso, presso l’Antonianum di Roma. Perché partecipazione e autorità, discernere e decidere - i punti su cui è incentrata la riflessione proposta dalla rete sinodale delle donne - sono termini ampiamente risuonati all’incontro su “L’autorità teologica della donne. Pratiche di exousia”, che ha visto la presenza delle fondatrici del Cti, ma anche di giovanissime appassionate di teologia.
«L’autorità delle donne è un tema che viene dal femminismo storico, che si è domandato cosa significa avere una voce autorevole e come tramandarsi la forza di prendere la parola», spiega la presidente del Cti, Lucia Vantini. « La parola exousia esprime il fatto che l’esistenza delle cose e degli esseri viventi viene da fuori. Per i femminismi, questo riconoscimento di dipendenza da altro non è affatto una sottrazione, ma una forza che rende capaci di libertà. Sono i legami, infatti, a dare consistenza ed espressività a un soggetto. In questa prospettiva il potere si trova riconfigurato come potere-di-autorizzare altre e altri in una trama di parole, simboli, gesti e pratiche che mira alla condivisione anche quando inevitabilmente si aprono conflitti». Inoltre, aggiunge Vantini, «nel termine autorità c’è idea di far aumentare, di spingere, di sostenersi tra generazioni. La presenza di giovani teologhe al seminario è stato il segno della grande fecondità della vita teologica della donne. Il futuro passa per questo».
«Ai fratelli vescovi scriviamo che autorizzare deve significare difendere e non abusare del potere, perché nelle Chiese c’è un movimento di esclusione, di chiusure di spazi, casi di epurazione e di licenziamento», dice Cristina Simonelli, che ha tenuto la relazione di apertura del seminario “La teologia delle donne come pratica di autorità”, citando il documento della rete sinodale. «Noi donne abbiamo una memoria, un presente e una consegna di autorità che se esercitata crea stima, empowerment». Il cammino del Cti, nato nel 2003 dall’intuizione di Marinella Perroni - fare un’associazione in prospettiva di genere, ecumenica, pluri e multidisciplinare -, ha percorso strade che hanno portato a numerose pubblicazioni e, negli ultimi anni, alla serie Exousia, con la San Paolo, dove «ciascun volume ri-visita in prospettiva di genere gli ambiti teologici e si propone di attestare possibili circolarità ermeneutiche: tra discipline e temi, tra appartenenze confessionali, tra interessi e posizionamenti».
La serie, spiega Simonelli citando la presentazione che accompagna ogni volume, risponde a una necessità: «La teologia non va semplicemente aggiornata ma completamente riscritta. L’accesso delle donne alla Teologia non ha comportato un semplice aggiornamento degli schedari, ha piuttosto reso evidente l’urgenza di un ripensamento generale dei modelli». Condizione imprescindibile per questa svolta «è quella di accogliere la differenza, vagliando criticamente le prospettive acquisite, introducendo l’esplorazione di campi di indagine inediti, formulando categorie e paradigmi nuovi».
Al centro del seminario, dunque, l’ultimo volume della Collana, Percorsi di cristologia femminista, scritto da Milena Mariani e da Mercedes Navarro Puerto. «I quasi cinquant’anni di decostruzioni e ricostruzioni femministe dimostrano quanto nel discorso cristologico il cambiamento del punto di vista, grazie all’immissione della prospettiva di genere e femminista», ha spiegato nella sua relazione Milena Mariani, «consenta ripensamenti critici e approcci nuovi, illumini aspetti rimossi o prima ignorati dell’identità di Gesù, contribuisca a scongiurare le derive non solo sessiste e misogine, ma anche antigiudaiche, razziste, imperialiste, colonialiste che non appartengono soltanto al passato della tradizione cristologica». Le critiche femministe si sono soffermate, in particolare, su «l’uso strumentale della maschilità di Gesù per ribadire la superiorità del maschio e per rafforzare l’immaginario esclusivamente maschile di Dio». Un secondo nodo è stato indicato, fin dall’inizio, nelle teologie della croce accusate non solo di «veicolare l’immagine di un Dio sadico e indifferente, ma anche di esaltare le idee di sofferenza salvifica, di sacrificio vicario, di obbedienza passiva alla volontà divina, che hanno avuto ricadute storicamente rovinose sulla condizione delle donne e dei più umili nella scala sociale e sulle relazioni intessute dai paesi occidentali, di storia cristiana, con il resto del mondo».
Dalle conclusioni di Mariani viene fuori la centralità della testimonianza e dell’esperienza di fede delle donne, che «richiederebbe il riconoscimento di un’autorità che si trova legittimata sin dal principio dalla traccia pasquale alla base delle narrazioni evangeliche, impensabile senza la loro testimonianza». Un’esperienza che, allora come oggi, «si esprime con parole, idee, sensibilità e gesti propri, la cui piena fecondità e novità nel linguaggio e nella vita delle Chiese cristiane richiederebbe un “discepolato di uguali” che ancora attende di essere davvero realizzato».
 di VITTORIA PRISCIANDARO
di VITTORIA PRISCIANDARO -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Il Giubileo di Platino di Elisabetta II d’Inghilterra e il sogno di Hegel di proporsi come figura di "Re del Mondo".3 giugno 2022, di Federico La Sala
RISALIRE LA CORRENTE. Storia Filosofia, Antropologia, Psicoanalisi, e Costituzione (2 giugno 2022).
Europa e Giubileo di Platino di Elisabetta II d’Inghilterra. Presente storico e storia di lunga durata...
Per riflettere sull’idea di sovranità (e l’individualità dello Stato), oggi, associare (come ha fatto qualcuno) la figura della regina Elisabetta II con il testo della "Filosofia del diritto" (& 279) di Hegel è un ottimo invito a svegliarsi dal sonno dogmatico (Kant) e a riaprire la questione antropologica (e teologico-politica)!
Sollecita a ripensare la storia dell’Europa quanto meno dalla disfatta della Invincibile Armada, da Elisabetta I e da Shakespeare e, ancora, da Trafalgar e da Napoleone e, infine, dal successo di Hegel di proporsi (illuminato da Napoleone a Jena, 1806) come interprete della storia dell’ "anima del mondo", come figura del "Re del mondo"!
EDIPO, TEBE, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (Freud, 1929). La questione antropologica e politica su cui si arrovella Shakespeare con il suo "Amleto" è ancora l’enigma della sfinge: "Che cos’è mai un uomo se del suo tempo non sa far altr’uso che per mangiare e dormire?" (Amleto, Atto IV, Sc. 4).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- STORIA E FILOLOGIA: LA FEDE DI DANTE, E DI SAN PIETRO, NON E’ LA FEDE DI SAN PAOLO (E DI ENEA).29 maggio 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E
AMORE ("CHARITAS"):
LA FEDE DI DANTE, E DI SAN PIETRO,
E
LA FEDE DI SAN PAOLO.
Beatrice (Pd. XXIV, 34) chiede al "gran viro"(San Pietro) di verificare se Dante ha capito
la differenza tra la fede
in "Nostro Segnor" Gesù
(Ponzio Pilato: Ecce Homo, gr. «idou ho anthropos»)
oppure
nel "Nostro Signore" di San Paolo, l’Uomo (Vir):
"sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo,
e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»],
e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- I TEOLOGI, GLI "ATTRIBUTI DI DIO", E LA GUERRA. «Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano»: Le "Capactrici di pace" (di Paolo scarafoni e Filomena Rizzo).).27 maggio 2022, di Federico La Sala
“Capatrici di pace”
Un’analisi dei teologi Scarafoni e Rizzo: «Recuperare l’intreccio ecumenico di sguardi fraterni in Cristo»
di Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo*
Sta per finire l’anno accademico e rimettendo in ordine la nostra biblioteca di casa, ci è capitato fra le mani il bel libro del 2017 «Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano» curato da Assunta Di Sante e Simona Turriziani. Tratta delle artiste, artigiane e imprenditrici che lavorarono «all’ombra del Cupolone contribuendo ad accrescere la bellezza della Basilica Vaticana», svolgendo un ruolo importante nella Fabbrica di San Pietro.
Scrive Paola Torniai: «Nel 1673 Clemente X Altieri commissiona al mosaicista Orazio Manenti il restauro della Navicella, raffigurante Gesù che salva dalla tempesta la nave degli apostoli, realizzata da Giotto per il Cardinale Jacopo Stefaneschi, in occasione del primo giubileo indetto da Bonifacio VIII. Manenti deve risarcire l’opera, originariamente collocata nell’atrio della primitiva San Pietro e danneggiata durante i lavori di ampliamento sotto Paolo V Borghese. ... Manenti recupera ogni più minuta pietruccola, avvalendosi di maestranze femminili». Le «capatrici dell’immondezze de smalti». Esse a mani nude frugavano a terra tra i calcinacci per recuperare smalti vecchi che sarebbero stati rifusi in smalti nuovi. Lavoravano tra «la polvere che inaridisce la pelle e soffoca il respiro, il disagio di prostrarsi per ore alla ricerca di tessere musive, la difficoltà di scavare a mani nude, abrase e ferite, tra calcinacci e materiali ammassati. ... Le capatrici della Navicella ... sono state mani provvidenziali».
Questa storia suggestiva di donne, ci ha fatto riflettere sulle devastazioni che stiamo vivendo in questo momento, e che confermano i moniti di Papa Francesco che da tempo metteva in guardia contro i «venti di guerra». Anche la Chiesa di Cristo, specialmente nelle relazioni ecumeniche e nella riflessione teologica, ha subito forti scossoni come la Navicella di Giotto. Sono cadute tante tessere: fino a pochi mesi fa l’auspicio di molte chiese era che i cristiani tutti insieme fossero parte viva e coraggiosa della società civile, promotori di giustizia, di pace e misericordia per l’umanità. Quell’intreccio ecumenico di sguardi fraterni in Cristo sembra essere crollato in un attimo tra le macerie che le bombe e i missili producono nei territori di guerra.
C’è bisogno di «capatrici di pace». Un lavoro paziente di recupero, in mezzo a quelle rovine, che può essere fatto bene dalle donne, ancora troppo poche nei dialoghi e nelle trattative fra le parti, di fatto assenti ai tavoli dove si decide la guerra. La pace si costruisce recuperando proprio quegli intenti così belli ispirati dallo Spirito santo, come lo scintillio delle tessere musive «capate» che allude «allo splendore della sostanza divina e all’incorrotta chiesa primitiva».
Anche nella riflessione teologica è essenziale valorizzare il contributo delle donne. Abbiamo avuto modo di scrivere già da vari anni che è necessario sviluppare studi sugli «attributi di Dio», specialmente sull’onnipotenza divina, con una maggiore sensibilità nei confronti dei risvolti antropologici. «Lo sforzo della teologia attuale deve essere quello di vincere ogni riferimento individualistico ed egoistico nella presentazione di Dio di fronte alle creature, che possa giustificare una persistenza dell’egoismo e dell’individualismo nelle creature stesse». Dio non è potente al modo umano: «il concetto di potenza è ambiguo perché spesso ha un forte legame con l’egoismo». Nel Vangelo «l’onnipotente che opera con il suo braccio pieno di misericordia e bontà è contrapposto ai potenti, ai ricchi e ai superbi che opprimono i deboli, i poveri e gli umili».
Le bombe mettono in evidenza un Dio egoista e prepotente invocato dai duri di cuore, dai superegoisti privilegiati, per «occupare spazi» e legittimare «strutture di peccato» che fanno sembrare normale ed inevitabile il male inflitto agli ultimi e ai poveri. Disprezzano un Dio debole incapace di difendere le «vittime innocenti».
I teologi devono essere coraggiosi proprio per negare esplicitamente l’egoismo in Dio. «Dire che Dio è buono, benché sia tutt’altro che scontato, non è lo stesso che dire che Dio non è cattivo. Dire che Dio è amore, benché ripete il cuore stesso della rivelazione (cfr. 1Gv 4,8; Gv 3,16), non è lo stesso che negare in Dio l’egoismo». I battezzati che si consacrano a Dio e rinunciano al diavolo, in realtà «come un fiume carsico» nelle difficoltà e nelle prove o per giustificare interessi politici ed economici, sono tentati di affidarsi ad un Dio immaginato come un guerriero, che a suo piacimento riprende l’arco deposto nel cielo, quando ha stabilito l’alleanza della pace.
Se l’uomo non cambia idea su Dio è perché forse non vuole cambiare lui, rimanendo chiuso nel suo egoismo, che giustifica con il meccanismo di proiezione; un gioco sottile e menzognero (al quale si presta talvolta la teologia) di un uomo che sostituisce il Dio vero dell’amore e della libertà con il Dio della guerra. In tal modo rivela come il suo cuore sia chiuso in una autoreferenzialità così insuperabile da crearsi e raccontare per vero un Dio «a sua immagine».
* Don Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo insegnano insieme teologia in Italia e in Africa, ad Addis Abeba. Sono autori di libri e articoli di teologia.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- STURM UND DRANG IN GERMANIA. Quando a lasciare la Chiesa è un vicario generale (di Ludovica Eugenio - Adista).24 maggio 2022, di Federico La Sala
Sturm und drang: quando a lasciare la Chiesa è un vicario generale
di Ludovica Eugenio (21/05/2022) *
41088 SPEYER-ADISTA. Che un vescovo si dimetta non fa molta notizia. Ma che un vicario generale dia le dimissioni per lasciare la Chiesa cattolica ed entrare in un’altra confessione religiosa è invece alquanto singolare. È accaduto in Germania, nella diocesi di Speyer, dove il vicario generale mons. Andreas Sturm, 47 anni, ha rinunciato al suo incarico, dopo un tormento durato un anno e mezzo, secondo quanto ha dichiarato al Mannheimer Morgen (10/5), per aderire alla Chiesa vetero-cattolica come pastore. Il vescovo di Speyer mons. Karl-Heinz Wiesemann ha accettato le dimissioni e ha liberato Sturm da tutti i doveri sacerdotali, e ha nominato al suo posto Markus Magin, rettore del seminario, con effetto immediato.
Sturm, vicario dal 2018 e in questa veste responsabile di migliaia di dipendenti e di un budget di milioni, è stato sempre più il volto di una Chiesa capace di riformarsi, prendendo coraggiosamente posizione su questioni come la benedizione delle relazioni omosessuali e il celibato. Ha rilasciato una dichiarazione personale sulle motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo passo, pubblicata sul sito della diocesi: «Ho perso la speranza e la fiducia nel corso degli anni che la Chiesa cattolica romana possa davvero cambiare», ha affermato in una lettera. «Allo stesso tempo, vedo quanta speranza è riposta nei processi in corso come il Cammino sinodale», ma non si sente più di «annunciare questa speranza e di sostenerla onestamente e sinceramente perché semplicemente non ce l’ho più».
In una lettera alla diocesi, il vescovo Wiesemann afferma di aver accettato «con grande rammarico» le dimissioni del vicario, perché con lui aveva lavorato in «profonda fiducia». «Andreas Sturm ha portato molte cose positive nella nostra diocesi con i suoi modi pragmatici ed entusiasti e il suo impegno appassionato per una Chiesa rinnovata che è stata toccata da Dio ed è vicino alle persone». Il vicario ha guidato la diocesi di Speyer per diversi mesi, durante l’assenza del vescovo per motivi di salute. Nella sua dichiarazione personale, Sturm ha sottolineato di non andarsene con rabbia, «ma con grande speranza per me e per la mia stessa vocazione»; chiede perdono a tutti: «Semplicemente non ne avevo più le forze».
 Il 15 giugno uscirà il suo libro, per le edizioni Herder, intitolato Ich muss raus aus dieser Kirche (“Devo uscire da questa Chiesa”), nel quale mette a nudo se stesso e gli abusi nella Chiesa, facendo un bilancio spietato ma anche un’ammissione di fallimento personale. Il sottotitolo del libro è ancora più espressivo del titolo: Weil ich Mensch bleiben will, “Perché voglio rimanere umano”.
Il 15 giugno uscirà il suo libro, per le edizioni Herder, intitolato Ich muss raus aus dieser Kirche (“Devo uscire da questa Chiesa”), nel quale mette a nudo se stesso e gli abusi nella Chiesa, facendo un bilancio spietato ma anche un’ammissione di fallimento personale. Il sottotitolo del libro è ancora più espressivo del titolo: Weil ich Mensch bleiben will, “Perché voglio rimanere umano”.Sturm è stato parroco nella diocesi per 20 anni e, oltre alla pastorale comunitaria, ha lavorato come guida spirituale della Comunità dei Giovani Cattolici (KjG) e come presidente diocesano della Associazione della Gioventù Cattolica Tedesca (BDKJ).
Perché la scelta di unirsi alla Chiesa veterocattolica? Nata negli anni ‘70 dell’Ottocento in contrasto con le risoluzioni del Concilio Vaticano I (1869-1870) sull’infallibilità e il primato del papa, la diocesi tedesca veterocattolica conta ben 16.000 membri in 60 parrocchie. Negli ultimi anni, ha visto un grande afflusso di membri in precedenza cattolici per la sua apertura rispetto a diversi temi: celibato opzionale e preti sposati, sacerdozio femminile, accoglienza delle persone Lgbtq e matrimonio religioso per le coppie omosessuali.
Motivi profondi
«Gli abusi sono stati un grosso problema», ha affermato Sturm; Il rapporto dello studio MHG nel settembre 2018 «ha infranto» la sua visione del mondo. «Ho sempre pensato che ci fossero abusi nella Chiesa, ma il fatto che la percentuale di casi sia così alta rispetto alla società nel suo insieme, e vedere quanto sia difficile affrontare il problema nella Chiesa è stato determinante». Anche il ruolo delle donne nella Chiesa è stato per lui un punto dolente: «Gesù non ha chiamato solo gli uomini. Noi neghiamo le vocazioni femminili». C’è molta ricerca teologica in questo campo, «noi, invece, continuiamo a ingrandire le parrocchie solo perché pensiamo che possano esserci, come preti, solo uomini non sposati». Questa considerazione porta al terzo tema, il celibato obbligatorio per i preti. «Non possono essere ammessi anche uomini sposati o che vivono con un uomo?», ha chiesto. Lui stesso ha ammesso di aver violato il celibato: «Ma soprattutto ho ferito delle persone, cosa di cui mi dispiace molto». Sturm ha attirato l’attenzione a livello nazionale quando si è opposto al divieto del Vaticano, nel 2021, di celebrare benedizioni delle coppie omosessuali e ha annunciato che avrebbe continuato a benedirle.
Quando, all’inizio di quest’anno, 125 persone queer al servizio nella Chiesa - preti, ex preti, insegnanti, funzionari della Chiesa a vario titolo, volontari - hanno fatto coming out con la campagna #OutInChurch chiedendo di eliminare le «dichiarazioni obsolete della dottrina della Chiesa» sui temi di genere, una benedizione in chiesa per le coppie dello stesso sesso, un cambiamento nella legge sul lavoro della Chiesa, che considera l’omosessualità dei propri dipendenti una violazione della lealtà, e la fine della discriminazione nei confronti dei credenti omosessuali, bisessuali e transgender, Sturm è stato tra coloro che hanno garantito l’assenza di conseguenze sul diritto del lavoro per i dipendenti della Chiesa queer (v. Adista News, 28/1/22).
Sturm ebbe parole di forte critica anche quando il Vaticano, nel 2020, emanò l’Istruzione sulla vita parrocchiale dal titolo “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”, che poneva l’accento sulla centralità della figura sacerdotale (v. Adista Notizie n. 30/20), dicendosi deluso del fatto «che i tentativi delle diocesi di affrontare in modo costruttivo la mancanza di sacerdoti e di trovare nuovi modi di cura pastorale stiano ricevendo così poco supporto da parte della Congregazione per il Clero». Per lui, la corresponsabilità tra clero e laici nelle parrocchie - una possibilità che il Vaticano escludeva chiaramente nella istruzione - non costituiva «una minaccia, ma un’opportunità per le parrocchie e anche per i sacerdoti», e la condivisione degli incarichi tra preti, diaconi, religiosi e laici «rafforzano l’unità in una comunità e arricchiscono la parrocchia di punti di vista differenti».
I commenti
Le dimissioni e l’uscita dalla Chiesa di mons. Sturm hanno suscitato molto scalpore, ma non eccessivo stupore: «La crisi della Chiesa scuote profondamente il popolo di Dio in questo Paese e nel frattempo ha raggiunto anche il livello di leadership» commenta su katholisch.de Christoph Brüwer (17/5). «Eppure questa reazione non sorprende». Di certo, continua, è palpabile «la disillusione e la delusione tra coloro che sperano in riforme nella Chiesa. Per molti Sturm è stato un pioniere che, ad esempio, ha chiesto l’ordinazione delle donne diacono». Le sue dimissioni - questo è il suo timore maggiore - «significano anche una battuta d’arresto per processi di riforma come il percorso sinodale: a quanto pare anche i rappresentanti di alto rango della Chiesa non credono più che le riforme in discussione saranno effettivamente decise e attuate in modo tempestivo, e non possono più annunciare in modo credibile questa speranza. -Alla prossima assemblea sinodale di settembre, i sinodali avranno l’opportunità di contrastare questa sensazione e di prendere decisioni concrete. Resta da vedere quante persone trarranno coraggio e speranza da questo».
* Tratto da: Adista Notizie n° 19 del 28/05/2022
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "HANG UP PHILOSOPHY!". Something is rotten in the state of Denmark...16 maggio 2022, di Federico La Sala
IL SOGNO DI SHAKESPEARE E IL PROGRAMMA DI FRANCESCO BACONE.
"HANG UP PHILOSOPHY!". Something is rotten in the state of Denmark...
RIVOLUZIONE COPERNICANA. "Hang up philosophy!" e disagio della civiltà: "Romeo. Ancora esiliato? - All forca la filosofia! Se non può farmi una Giulietta, se non può cambiare di posto una città, annullare la sentenza di un principe, la filosofia non giova a nulla, non può nulla; non me ne parlare" (Shakespeare, Tutte le opere, a c.di Mario Praz, Sansoni, Firenze, p.313).
SORGERE DELLA TERRA (EARTHRISE). Probabilmente Shakespeare, ancor prima della realizzazione della Bibbia di Re Giacomo, ha già avviato un programma di rilettura e reinterpretazione antropologico-politico dell’immaginario della teologia e filosofia tradizionale... Ricordare il Sonetto 116.
NUOVO CIELO E NUOVA TERRA. Considerato il legame profondo con la cultura italiana (Giordano Bruno, ecc.), non è da escludere la ripresa in grande stile dell’idea già ’lanciata’ da Dante Alighieri di ripensare a trovare la strada per tornare nell’Eden, nel Paradiso Terrestre: da tener presente che la parola d’ordine del programma di Francesco Bacone è già e sarà proprio quella di lavorare al Grande Restaurazione (alla Instauratio Magna).
DANTE 2021: RISORGERE - RINASCERE. Al di là della vecchia filosofia ("Hang up philosophy!"): Shakespeare è sulla strada di Dante Alighieri e Giordano Bruno, e non della andrologia iper-platonica e dello "spirito di carità" paolino ("Il parto maschio del tempo" - "Temporis Partus Masculus", 1602) del teorico della Nuova Atlantide...
Nota: Sul tema, cfr. la preghiera che è inserita nella prefazione della Instauratio magna (1620).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL "COME NASCONO I BAMBINI" E IL MICROCHIMERISMO: CHIMERE, FORSE. UN’ALTRA PROSPETTIVA (Maria Teresa Carbone).12 aprile 2022, di Federico La Sala
Dialoghi con la Chimera /1:
MARIA TERESA CARBONE, MADRE/FIGLIO.
A cura di Laura Pugno (Le parole e le cose, 1 Marzo 2022)
- Nel 2022 si compiono 15 anni dall’inizio della mia personale avventura con l’ibrido, la pubblicazione del mio primo romanzo, Sirene, nel 2007. Da allora, le figure più che umane, oltreumane, si sono moltiplicate, in letteratura e nell’immaginario, intorno a noi, fino a essere in un certo senso ovunque, o forse solo nell’occhio di chi guarda. La parola Chimera, oltre i Canti Orfici e i Dialoghi con Leucò, riecheggia oggi gli ibridi interspecie della scienza contemporanea insieme alla mitologia greca, etrusca ed egizia, e per questo ce ne serviamo qui: il campo delle ibridazioni, come si vedrà, è molto ampio (lp).
L’idea di questa serie di conversazioni mi è venuta a seguito di un nostro dialogo sulle chimere, naturali o artificiali, e in particolare quella particolarissima Chimera che è la combinazione madre-figlio. Quindi questo è il tuo ibrido, in questa intervista. Qual è qui la storia fa raccontare?
Per la verità non so se c’è una storia da raccontare. O forse ce ne sono così tante che non riesco a vederle, smarrita come sono in una foresta di possibilità, anzi in un territorio selvaggio, per citare il titolo del tuo libro sulla poesia come “terzo paesaggio”. Non meno selvaggio, questo territorio - anzi di più - perché è il mio. E allora forse posso cominciare a risponderti con una poesia che ho scritto qualche mese fa:
Che mentre penso
alle persiane rotte e a te che parti
e che penso che sono
me fino in fondo
un’altra me a me inattingibile
mi spinge verso il bagno
che è questa me che regna
sui miei bisogni
sulla vita nuda
che la me a me nota
riveste di pensieri e di intenzioni
Come vedi, qui non c’è la maternità, ma lo spaesamento di fronte a quanto di noi non conosciamo. In fondo, a dispetto delle nostre convinzioni, sappiamo pochissimo di quello che siamo, microscopici puntolini in un universo sconfinato.
E allora, non parto da me, ma dalla parola chimera che deriva dal greco (χίμαιρα) dove inizialmente significava “capra”, anche se molto presto la gentile capretta delle fiabe si è mutata in mostro, testa di leone e coda di drago, “sbuffante terribile fuoco ardente”, come dice Omero. Già in origine, un elemento familiare pronto a trasformarsi e ad atterrirci.
Ti porto due esempi molto contemporanei. Il primo l’ho trovato per caso, cercando l’etimologia del termine “chimera”: nel sito Una parola al giorno, in data 15 febbraio 2012, giusto dieci anni fa, l’anonimo redattore per definire appunto una chimera evocava “la terrifica pandemia annunciata di una qualche influenza animale con zerovirgola casi accertati” - il che, letto oggi, fa una certa impressione. Il secondo è cronaca dei nostri giorni, il recente trapianto del cuore di un maiale in un corpo umano, un intervento che ha prevedibilmente e giustamente aperto un interrogativo cui è difficile rispondere: alleveremo suini (animali cui viene riconosciuta notevole intelligenza, qualsiasi cosa si intenda per “intelligenza”) pur di garantire la sopravvivenza di esseri appartenenti alla nostra specie?
Vedi, il punto per me è che noi stessi - intendo noi umani, ma vale per gli altri animali e le piante e tutto ciò che è vivo - siamo chimere da sempre, frutti di una quantità di incroci avvenuti in ogni fase della nostra storia, ben prima che fossimo o pretendessimo di essere in grado di padroneggiare queste ibridazioni. E torno alla tua domanda, premettendo che le mie conoscenze scientifiche sono limitatissime e quando parlo della “combinazione madre figlio”, come dici tu, mi baso più su sensazioni e sentimenti che su dati certi.
 Chiarisco però che lo spunto che aveva dato origine al nostro dialogo, e quindi a questa conversazione, era un’altra scoperta relativamente recente: la presenza di dna maschile nel corpo, e specificamente nel cervello, di donne anche in età molto avanzata che avevano avuto figli maschi - questo è appunto il microchimerismo, e aggiungo per completezza che se ne sono registrati esempi anche in donne che non hanno partorito e che hanno probabilmente acquisito queste cellule allo stato fetale, da gemelli poi riassorbiti dentro di loro. (Spero, se ci saranno studiosi di queste materie fra i lettori di quanto scrivo, che perdoneranno il mio pressapochismo).
Chiarisco però che lo spunto che aveva dato origine al nostro dialogo, e quindi a questa conversazione, era un’altra scoperta relativamente recente: la presenza di dna maschile nel corpo, e specificamente nel cervello, di donne anche in età molto avanzata che avevano avuto figli maschi - questo è appunto il microchimerismo, e aggiungo per completezza che se ne sono registrati esempi anche in donne che non hanno partorito e che hanno probabilmente acquisito queste cellule allo stato fetale, da gemelli poi riassorbiti dentro di loro. (Spero, se ci saranno studiosi di queste materie fra i lettori di quanto scrivo, che perdoneranno il mio pressapochismo).Della maternità ho diretta esperienza, e inoltre - come sai - è un argomento che sto studiando nella speranza di affrontarlo in modo non “ideologico” (sarà possibile?), ma forse proprio per questo la osservo con la meraviglia che si prova davanti a un mistero, e quindi senza sorprendermi all’idea che delle cellule dei miei figli - due maschi e una femmina - siano incistate dentro di me a più di trent’anni dalla loro nascita. Perché dovrei stupirmi? Se pure in me c’è qualcosa di “non mio”, cioè di non mio alla nascita, questo “non mio” io non lo conosco, né posso o voglio distinguerlo dal “mio” (“mio” geneticamente e “mio” acquisito dal momento in cui esisto) che, ripeto quello che ho detto all’inizio, mi è altrettanto opaco. Tutt’al più posso rallegrarmi al pensiero che nella continua costruzione di quella persona che io chiamo io, non si ritrovino solo tracce dei miei bisnonni o dei cinodonti del Permiano ma anche particelle del futuro, nella forma del dna dei miei figli, maschi o femmine che siano.
Per quanto ci sforziamo di analizzarci (e ricordiamo, a proposito di etimologie, che “analisi” vuol dire “scomposizione”), sono convinta che il tutto, un tutto in continuo divenire, prevale sulle parti, e questo tutto ci sfugge: ci sono sempre zone in ombra, che non vogliamo vedere, che non sappiamo vedere. Una ignoranza, almeno per me, stupenda e salvifica, perché da un lato ci spinge a conoscere di più, a capire meglio, dall’altro ci nasconde quanto siamo piccoli, irrilevanti, caduchi nella nostra individualità, e dunque ci permette di andare avanti, di vivere.
Sarà un caso allora (e torno a parlare non troppo obliquamente di maternità) che oggi che siamo o ci illudiamo di essere meno ignoranti, il tasso di natalità stia calando - in certi casi crollando - ovunque? Certo, le ragioni sono diverse, e alcune sono molto semplici, concrete, in primo luogo politiche sociali insufficienti, che lasciano i giovani genitori quasi soli a destreggiarsi fra lavori molto spesso precari, e per questo ancora più impegnativi, e la necessaria attenzione alla crescita dei loro figli. Ma mi pare che ci sia una tela di fondo, che il nostro (credere di) sapere di più, mettendoci di fronte ai nostri limiti, ci terrorizzi.
Appartenendo alla generazione di donne che ha affermato “l’utero è mio e lo gestisco io”, oggi mi trovo a ripensare a quella frase, che pure continuo a condividere, da un’altra prospettiva: fino a che punto ognuno e ognuna di noi può dire di possedere il proprio corpo, se smettiamo di vederci come individui e ci pensiamo come appartenenti a una specie?
 Oggi si parla tanto delle responsabilità che abbiamo verso chi verrà dopo di noi ed è giusto, giustissimo, ma ho la sensazione che questa responsabilità ci sia troppo gravosa, proprio quando, e forse non è una coincidenza, possiamo (illuderci di) scegliere se/come/quando avere figli.
Oggi si parla tanto delle responsabilità che abbiamo verso chi verrà dopo di noi ed è giusto, giustissimo, ma ho la sensazione che questa responsabilità ci sia troppo gravosa, proprio quando, e forse non è una coincidenza, possiamo (illuderci di) scegliere se/come/quando avere figli.
 Ora che i bambini non li portano più le cicogne, non si trovano più sotto i cavoli, che spavento! Tocca a noi decidere e pensa un po’, in un mondo che va malissimo (non che prima andasse alla grande, ma ci facevamo meno illusioni).
Ora che i bambini non li portano più le cicogne, non si trovano più sotto i cavoli, che spavento! Tocca a noi decidere e pensa un po’, in un mondo che va malissimo (non che prima andasse alla grande, ma ci facevamo meno illusioni).Forse la chimera, e quindi la storia, è questa: fino a quando gli umani (parlo soprattutto da donna) saranno disposti ad accogliere quell’assoluto inatteso che è un figlio, una figlia, ibridi come noi eppure già diversi e lontani, come noi proiettati verso una fine che non conosciamo?
Pensa alla parola totem. C’è qualcosa nel tuo ibrido che ti parla del passato, tuo e di tutti? E il futuro? Pensa alla parola daimon. Il tuo ibrido può accompagnarci nel futuro?
Unisco queste due domande, perché davanti alle parole totem e daimon confesso che dovrei costruirmi alla svelta strumenti di cui non dispongo. Ne conosco superficialmente il significato, ma non le uso, non mi appartengono. Ho avuto invece un’educazione cattolica più approfondita di quanto capitasse, anche quando ero bambina, alle mie coetanee e ai miei coetanei. E anche se dalla religione mi sono discostata tanti anni fa, è ancora quella educazione a determinare in larga parte il mio vocabolario, il mio modo di pensare. Per questo, se rifletto sul tempo (mi pare questo, in sostanza, il senso delle tue domande), non posso non fare riferimento a una frase che, da quando l’ho sentita la prima volta, avrò avuto sette o otto anni, continua a risuonare in me: “Prima che Abramo fosse, io sono” (Giovanni, 8:51-59): l’indicativo presente come rappresentazione dell’eterno dove, come su un unico piano, si trova tutto quello che (nella nostra percezione) è stato e sarà.
Se, come ha detto Werner Herzog in Cave of forgotten dreams, a un certo punto della nostra storia “noi umani siamo diventati prigionieri del tempo” (un’altra frase a cui non so rinunciare), vorrei pensare che di tanto in tanto possiamo liberarci da questa schiavitù e riusciamo ad avere accesso a quell’altra dimensione, magari senza rendercene conto, mentre ci abbandoniamo al sonno, mentre sogniamo. Chimere, forse.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- EUROPA E DISAGIO DELLA CIVILTÀ. "Chi di tremila anni / Non sa darsi conto, / Rimane all’oscuro inesperto, /Vuol vivere così di giorno in giorno" (J.W. Goethe).5 aprile 2022, di Federico La Sala
L’Europa, la guerra, la pace, e il disagio della civiltà...
- IN RICORDO DI KAROL JOZEF WOJTYLA - PAPA GIOVANNI PAOLO II (morto il 2 aprile 2005) E DELL’INCONTRO INTERRELIGIOSO DI ASSISI DEL 27 OTTOBRE 1986, UNA SOLLECITAZIONE A RIPRENDERE IL FILO SPEZZATO DEL DIALOGO, DELL’ECUMENISMO, E DELLA PACE, A TUTTI I LIVELLI...
- "Chi di tremila anni / Non sa darsi conto, / Rimane all’oscuro inesperto, /Vuol vivere così di giorno in giorno" (J. W. Goethe, "Libro del malumore", 1819 ca.).
UNA QUESTIONE DI LUNGA DURATA: INIZIO DELLA FINE DEL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (LORENZO VALLA, 1440), "LA DOTTA IGNORANZA" (NICCOLO’ CUSANO, 1440) E "LA PACE DELLA FEDE" (NICCOLO’ CUSANO, "De Pace Fidei",1454)...
GIORNI FA (IL 25 MARZO 2022: https://www.latinatoday.it/attualita/sermoneta-epigrafe-visita-imperatore-1452.html) E’ STATO DATO CONTO DELLA SCOPERTA DI UNA EPIGRAFE DELLA VISITA, AVVENUTA NEL 1452 A SERMONETA (LATINA), DELL’IMPERATORE DEL SACRO ROMANO IMPERO, FEDERICO III D’ASBURGO (PADRE DI MASSIMILIANO I). DA RICORDARE CHE L’ANNO SUCCESSIVO, NEL 1453, CI FU L’ASSEDIO, LA CADUTA, E LA CONQUISTA DI COSTANTINOPOLI E, NEL 1492, IN SPAGNA, NON CI FU SOLO L’AVVIO DELL’AVVENTUROSA "SCOPERTA DELL’ AMERICA", MA ANCHE E SOPRATTUTTO LA FINE DELLA GUERRA DI GRANADA E DELLA RECONQUISTA...
BRUXELLES, 1477: “[...] Il Molinet paragona l’imperatore Federico [III d’Asburgo] che manda suo figlio Massimiliano a sposare Maria di Borgogna, con Dio Padre che manda suo figlio in terra, e non risparmia termini religiosi per descrivere il viaggio dello sposo. Quando più tardi Federico e Massimiliano entrarono a Bruxelles col giovane Filippo il Bello, i Brussellesi, narra Molinet, avrebbero detto colle lagrime agli occhi: «Veez-ci figure de la Trinité, le Père, le Fil et Sanct Spirit». Il Molinet stesso offre una corona di fiori a Maria di Borgogna, come alla degna immagine della Madonna, «a parte la verginità».
 «Non che io voglia deificare i principi», dice questo arcicortigiano. Può darsi che si tratti effettivamente di vuote frasi più che di venerazione realmente sentita, ma esse attestano ugualmente come l’uso quotidiano di termini sacri finisse per svalutarli. Del resto non sarebbe giusto rimproverare un poetastro di corte, quando un [Jean de] Gerson stesso attribuisce ai principeschi ascoltatori delle sue prediche speciali angeli custodi più elevati in grado di quelli degli altri mortali” (Johan Huizinga, “L’autunno del Medio Evo”, Sansoni Editore, Firenze 1978).
«Non che io voglia deificare i principi», dice questo arcicortigiano. Può darsi che si tratti effettivamente di vuote frasi più che di venerazione realmente sentita, ma esse attestano ugualmente come l’uso quotidiano di termini sacri finisse per svalutarli. Del resto non sarebbe giusto rimproverare un poetastro di corte, quando un [Jean de] Gerson stesso attribuisce ai principeschi ascoltatori delle sue prediche speciali angeli custodi più elevati in grado di quelli degli altri mortali” (Johan Huizinga, “L’autunno del Medio Evo”, Sansoni Editore, Firenze 1978).IL RINASCIMENTO, COME FINE DELL’AUTUNNO DEL MEDIO EVO
Mettendo insieme, con l’aiuto di Raffaello e Michelangelo, gli elementi dell’idea di famiglia di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, il Rinascimento mostra essere un "canto del cigno" dell"autunno del Medio Evo (Johan Huizinga). Il 1517, con le 95 Tesi di Lutero, non è lontano...
Questo, il problema: nonostante la grandezza della concezione teologica ed artistica della sacra famiglia che sta alla base della stessa costruzione della Cappella Sistina (1475/1481) prima e della operazione di Michelangelo dopo (1508-1512), ciò che viene detto e comunicato anche con il riferimento nei disegni dietro i ritratti di Raffaello (Agnolo Doni e Maddalena Strozzi: 1504-1508) è una dottrina fondata sulla dotta ignoranza (Niccolo Cusano, 1440), fiammingamente ispirata, di come nascono i bambini (Diluvio, Deucalione e Pirra): il problema dell’incarnazione e della nascita del Messia è ancora letta dal cardinale Cusano come da teologi e teologhe di oggi secondo la lezione dell’antropologia tebana, del codice della tragedia greca (Socrate, Platone, e Aristotele)!
Che dire? Che fare? Per il Sorgere della Terra, una linea di fuga messianica è proprio nella cornice del Tondo Doni. Dare a Giuseppe ciò che è di Giuseppe e a Maria ciò che è di Maria. La storia non è fatta da quattro profeti, ma due sibille e due profeti...
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DALL’ANDROLOGIA EDIPICA ALL’ANTROPOLOGIA; "AMORE È PIU’ FORTE DI MORTE" (Ct. 8.6).2 aprile 2022, di Federico La Sala
FILOLOGIA STORIA FILOSOFIA TEOLOGIA ARTE PSICOANALISI...
ANTROPOLOGIA O ANDROLOGIA?! In principio era il Logos... o il Logo?!
- CHE FARE? Salire a bordo dell’ Arca di Noè e del Figlio dell’Uomo (Gv. 12,34: υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) o della barca del "Figlio di Dio" di Paolo di Tarso ("Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo (ἀνήρ, ἀνδρός) (1 Cor. 11, 1-3)?
- "AMORE È PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici, 8.6 - trad. di Giovanni Garbini).
QUESTO, IL PROBLEMA...
HOMO HOMINI DEUS EST: ECCE HOMO. Tutto dipende se si pensa in ANTROPOLOGIA o in ANDROLOGIA TEBANA (EDIPO): nel primo caso SIA l’essere umano (uomo/maschio) SIA l’essere umano (donna/femmina) è "come Cristo/Dio", nel secondo caso tutto cambia... e al messaggio evangelico cosa è capitato nel suo viaggio attraverso i secoli dei secoli?
NON "è significativo che l’espressione di Tertulliano: «Il cristiano è un altro Cristo», sia diventata: «Il prete è un altro Cristo»" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010)?!
NON è bene cercare di sapere come e perché "Così parlò Edipo a Cuernavaca" (Franca Ongaro Basaglia, 1982)!?
Non c’è più tempo per nascere a noi stessi e a noi stesse e ammirare il Sorgere della Terra.
È ora di decidersi di salire a bordo...
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DONNE E DIRITTO. 8 MARZO. Una verità antica: le radici del patriarcato vanno in profondità" (di Antonio Guterres - Onu).8 marzo 2022, di Federico La Sala
PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. Per un "cambio di civiltà" - al di là del Regno di "Mammasantissima" (altro che "Patriarcato")!: l’alleanza edipica della Madre con il Figlio, contro il Padre, e contro tutti i fratelli e tutte le sorelle...
- "[...] una verità antica: le radici del patriarcato vanno in profondità. Viviamo in un mondo ancora prevalentemente maschile con una cultura maschilista (Antonio Guterres, 08.03.2022).
- "La disuguaglianza di genere è principalmente una questione di potere. Sradicare secoli di istanze patriarcali richiede un’equa condivisione del potere in ogni istituzione, a tutti i livelli. Nelle Nazioni Unite, abbiamo ottenuto - per la prima volta nella storia dell’organizzazione - la parità di genere ai vertici dirigenziali nei quartier generali e nel mondo" (Antonio Guterres, 08.03.2022).
Otto Marzo.La ripresa c’è se sostantivo femminile e sostenibile
di Antonio Guterres (Avvenire, martedì 8 marzo 2022)
Mentre il mondo celebra la Giornata internazionale della Donna, l’orologio dei diritti delle donne sta andando indietro. Tutti noi ne stiamo pagando il prezzo. Come un effetto domino, le crisi degli ultimi anni e quelle che ci affliggono in questo momento hanno messo in luce quanto una leadership femminile sia di importanza cruciale. Le donne hanno fronteggiato eroicamente la pandemia da Covid-19, come dottoresse, infermiere e impiegate nella sanità pubblica e nell’assistenza sociale. Ma allo stesso tempo, donne e ragazze sono state le prime a perdere il posto di lavoro e a dover rinunciare all’istruzione, con lavori non retribuiti di assistenza e cura e dovendo fronteggiare un aumento vertiginoso dei casi di abuso domestico e di matrimoni infantili. La pandemia ha mostrato ancora di più una verità antica: le radici del patriarcato vanno in profondità. Viviamo in un mondo ancora prevalentemente maschile con una cultura maschilista.
Di conseguenza, sia nel bene che nel male, le donne sono più esposte alla povertà. La loro assistenza sanitaria viene sacrificata, l’istruzione e l’opportunità limitate. E nei Paesi in conflitto - dall’Etiopia all’Afghanistan e all’Ucraina - le donne e le ragazze sono le voci più fragili ma anche le più forti nel chiedere pace. Se guardiamo al futuro, una ripresa sostenibile e uguale per tutti è possibile solo se si tratta di una ripresa femminile - una che metta al centro il progresso per ragazze e donne. Abbiamo bisogno del progresso economico, con investimenti orientati all’istruzione, all’impiego, alla formazione e al lavoro dignitoso delle donne. Le donne dovrebbero essere le prime nella lista dei 400 milioni di posti di lavoro che siamo chiamati a creare entro il 2030. Abbiamo bisogno del progresso sociale, con investimenti in sistemi di protezione sociale e di economia sanitaria.
Essi producono, infatti, molti benefici, creando lavori ecosostenibili e, allo stesso tempo, sostenendo i membri delle nostre società che necessitano assistenza, compresi i bambini, gli anziani e i malati. Abbiamo bisogno del progresso finanziario, per riformare un sistema monetario globale moralmente fallimentare, cosicché tutti i Paesi possano investire in una ripresa economica pensata e realizzata al femminile. Ciò include aiuti economici e sistemi fiscali più favorevoli che trasferiscano a coloro che ne hanno più bisogno gli elevati guadagni del benessere mondiale. Abbiamo bisogno di un’azione urgente e rivoluzionaria per il clima, per invertire l’aumento sregolato di emissioni, e per la disparità di genere, che lascia ancora donne e ragazze eccessivamente vulnerabili. I Paesi sviluppati devono urgentemente mantenere i loro impegni di sostegno finanziario e tecnico per una corretta transizione dai combustibili fossili.
Le economie di successo e stabili del futuro saranno ecosostenibili e inclusive. Abbiamo bisogno di più donne al potere, nel governo e nel commercio, tra i ministri delle finanze e tra i grandi manager privati, che sviluppino e rendano effettive delle politiche ecologiche e sociali progressive che favoriscano tutti. Abbiamo bisogno del progresso politico che attraverso misure mirate assicuri alle donne pari opportunità e rappresentanza a tutti i livelli decisionali, attraverso quote di genere significative.
 La disuguaglianza di genere è principalmente una questione di potere. Sradicare secoli di istanze patriarcali richiede un’equa condivisione del potere in ogni istituzione, a tutti i livelli. Nelle Nazioni Unite, abbiamo ottenuto - per la prima volta nella storia dell’organizzazione - la parità di genere ai vertici dirigenziali nei quartier generali e nel mondo.
La disuguaglianza di genere è principalmente una questione di potere. Sradicare secoli di istanze patriarcali richiede un’equa condivisione del potere in ogni istituzione, a tutti i livelli. Nelle Nazioni Unite, abbiamo ottenuto - per la prima volta nella storia dell’organizzazione - la parità di genere ai vertici dirigenziali nei quartier generali e nel mondo.Questo ha significativamente migliorato la nostra abilità di riflettere e rappresentare al meglio le comunità per le quali lavoriamo. A ogni tappa di questo percorso, possiamo trarre ispirazione dalle donne e dalle ragazze che premono per il progresso in ogni ambito e in ogni angolo del mondo. Le giovani attiviste per il clima sono al centro degli sforzi globali per spingere i governi a mantenere i loro impegni. Le attiviste per i diritti delle donne chiedono coraggiosamente uguaglianza e giustizia, e la costruzione di società più pacifiche in quanto mediatrici, pacificatrici e operatrici umanitarie anche in alcune delle zone più problematiche del mondo.
 Nelle società in cui i movimenti per i diritti delle donne sono in fermento, le democrazie sono più forti. E quando il mondo si impegna per ampliare le opportunità di donne e ragazze, tutta l’umanità ne esce vittoriosa.
Nelle società in cui i movimenti per i diritti delle donne sono in fermento, le democrazie sono più forti. E quando il mondo si impegna per ampliare le opportunità di donne e ragazze, tutta l’umanità ne esce vittoriosa.
 Per una questione di giustizia, uguaglianza, moralità e semplice buon senso, abbiamo bisogno di portare avanti l’orologio sui diritti delle donne. Abbiamo bisogno di una ripresa sostenibile, femminista, che ruoti attorno a - e che sia guidata da - donne e ragazze.
Per una questione di giustizia, uguaglianza, moralità e semplice buon senso, abbiamo bisogno di portare avanti l’orologio sui diritti delle donne. Abbiamo bisogno di una ripresa sostenibile, femminista, che ruoti attorno a - e che sia guidata da - donne e ragazze.Segretario generale delle Nazioni Unite
Sul tema, nell sito, si cfr.:PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO. Rimeditare la lezione di Alessandro Manzoni
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Rimeditare la lezione di Franca Ongaro Basaglia.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA REGALITA’ ANTROPOCENTRICA : DANTE E KANTOROWICZ.5 marzo 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E COSTITUZIONE:
RIPENSARE COSTANTINO E LA TEOLOGIA E LA POLITICA DELL’EUROPA.
Un omaggio a Beatrice Maria e Lucia (8 marzo) e a Dante Alighieri (25 marzo - Dantedì)...
USCIRE A RIVEDERE IL CIELO STELLATO. Non avendo sottratto alla teologia e alla logica dell’ Imperatore Costantino l’opera di Dante Alighieri (ridotto dalla Chiesa Cattolica di Giovanni XXII, prima che da Ugo Foscolo, a "ghibellino fuggiasco"), filosofi e storici hanno finito per banalizzare anche il lavoro di Ernst H. Kantorowicz! Si tenga presente, per capire bene e meglio l’uno e l’altro, che l’ultimo capitolo (l’ottavo) dei "Due corpi del re" è intitolato "La regalità antropocentrica: Dante" e, al contempo, che la regalità antropocentrica è da leggersi in senso antropologico (di ogni essere umano, "ecce homo"), non in senso di una andrologia costantiniana (di ogni essere umano-maschio, "ecce vir")!
COSTITUZIONE. La "Monarchia" dei "due Soli" non dice né della dittatura dell’Imperatore né della dittatura del Papa, ma indica che l’uno e l’altro, semplicemente (la cosa più difficile a farsi), dia a "Dio" (l’amor che muove il sole e le altre stelle) ciò che è di "Dio" e ognuno all’altro (entrambi sovrani - memoria di don Milani) ciò che tocca all’uno e all’altro - nel riconoscimento della sovranità di "Dio" stesso, della Legge dei nostri Padri Costituenti e delle nostre Madri Costituenti. Se in principio era la Costituzione (il Logos), "Quis Ut Deus?" ("Chi è come Dio")?!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA: UNA "MEMORIA" DALLA ANTICA COMMEDIA GRECA.3 marzo 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA E FILOLOGIA.
LA SCOMPARSA DELLA "FANCIULLA STRANIERA" (F. Schiller, 1796) E DELL’AMORE (K. Marx, 1844) E IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ (S. Freud, 1929: "Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità [...]").
Una nota a margine di una memoria dell’antica commedia greca ...
- "[...] «’Ως χαρίεν ἐστ ̓ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ἦι (fr. 707 K.-A.)
- "Quanto è affascinante un essere umano, quando è umano".
- Questa proverbiale frase di Menandro caratterizza probabilmente più di ogni altra cosa la sua arte drammatica: un essere umano non è umano, quando non si comporta con dolcezza, comprensione e bontà, quando non si mette rettamente nel mondo, nella società e nei suoi simili, quando si comporta come onnipotente e onnisciente con arroganza a causa del suo status sociale o della sua ricchezza, quando non riconosce, accetta e confessa i propri errori e non si pente, quando del resto non accetta i colpi del Destino riconoscendo la propria mortalità e che è destino di tutti gli esseri viventi condividere beni e disgrazie, e naturalmente della morte.
- Il γνῶθι σαυτόν «conosci te stesso» è di primaria importanza, come è importante il «conoscere gli altri». Il primo equivale a conoscere la propria situazione e ciò che dovrebbe essere fatto in ogni caso particolare, il secondo perché è molto più utile. La persona che ha queste caratteristiche è l’essere più affascinante, ma quando ne è privo è ἀπάνθρωπος (in-umano).» [...]"
- (cit. dalla relazione di A. Katsouris, "Methods of humanization and sympathy especially in reference to the traditional odd charachters", - per il testo originale, cfr. AA. VV, "Menandro e l’evoluzione della commedia greca"; a c. di Angelo Casanova, Firenze University Press 2014, p. 278 - senza note).
"HOMO HOMINI LUPUS" (Freud, 1929). Formidabile questa riflessione di Andreas Katsouris sulla frase di Menandro! A ben riflettere sulle parole (e, in particolare, sul legame tra la "grazia" ("charis") del χαρίεν ("charien") e "l’anthropos), si dovrebbe tentare di capire su come e quando è stata persa la memoria delle Grazie (greco: Χάριτες - Charites) ed è stata persa anche la traccia di ogni umanità e l’orizzonte culturale dell’Europa (e del Pianeta Terra) è diventato sempre più cosmoteandrico, edipicamente, con la stessa connivenza della filosofia, della filologia, e della psicoanalisi!
CRITICA DELLA VIOLENZA: J.-J. ROUSSEAU, K. MARX, W. BENJAMIN. Una prima traccia della "caduta" è nell’atto logico-storico ("primordiale", che prima di essere materiale è linguistico) della recinzione: "Il primo che, dopo aver recintato un terreno, pensò di dire questo è mio, e trovò altri tanto ingenui da credergli, fu il fondatore della società civile"("Discorso sull’origine della disuguaglianza", 1754"); la seconda è nella denuncia marxiana (nella "Sacra Famiglia") dell’inversione soggetto-predicato (il problema della mele, delle pere, e delle fragole... del Mentitore) e della "fanciulla straniera e la civetta hegeliana" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 190-197)"!
A quando il sorgere della Terra?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA QUESTIONE DI "UNO" (ANTROPOLOGIA O ANDROLOGIA). Note su - La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo" (di Giovanni Paolo II - 2001).25 febbraio 2022, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E QUESTIONE ANTROPOLOGICA: UT UNUM SINT... *
GIOVANNI PAOLO II
UDIENZA GENERALE
Mercoledì, 14 febbraio 2001
La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo *
1. Il disegno salvifico di Dio, “il mistero della sua volontà” (Ef 1,9) concernente ogni creatura, è espresso nella Lettera agli Efesini con un termine caratteristico: “ricapitolare” in Cristo tutte le cose, celesti e terrestri (cfr Ef 1,10). L’immagine potrebbe rimandare anche a quell’asta attorno alla quale si avvolgeva il rotolo di pergamena o di papiro del volumen, recante su di sé uno scritto: Cristo conferisce un senso unitario a tutte le sillabe, le parole, le opere della creazione e della storia.
A cogliere per primo e a sviluppare in modo mirabile questo tema della ‘ricapitolazione’ è sant’Ireneo vescovo di Lione, grande Padre della Chiesa del secondo secolo. Contro ogni frammentazione della storia della salvezza, contro ogni separazione tra Antica e Nuova Alleanza, contro ogni dispersione della rivelazione e dell’azione divina, Ireneo esalta l’unico Signore, Gesù Cristo, che nell’Incarnazione annoda in sé tutta la storia della salvezza, l’umanità e l’intera creazione: “Egli, da re eterno, tutto ricapitola in sé” (Adversus haereses III, 21,9).
2. Ascoltiamo un brano in cui questo Padre della Chiesa commenta le parole dell’Apostolo riguardanti appunto la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose. Nell’espressione “tutte le cose” - afferma Ireneo - è compreso l’uomo, toccato dal mistero dell’Incarnazione, allorché il Figlio di Dio “da invisibile divenne visibile, da incomprensibile comprensibile, da impassibile passibile, da Verbo divenne uomo. Egli ha ricapitolato tutto in se stesso, affinché come il Verbo di Dio ha il primato sugli esseri sopracelesti, spirituali e invisibili, allo stesso modo egli l’abbia sugli esseri visibili e corporei. Assumendo in sé questo primato e donandosi come capo alla Chiesa, egli attira tutto in sé” (Adversus haereses III, 16,6). Questo confluire di tutto l’essere in Cristo, centro del tempo e dello spazio, si compie progressivamente nella storia superando gli ostacoli, le resistenze del peccato e del Maligno.
3. Per illustrare questa tensione, Ireneo ricorre all’opposizione, già presentata da san Paolo, tra Cristo e Adamo (cfr Rm 5,12-21): Cristo è il nuovo Adamo, cioè il Primogenito dell’umanità fedele che accoglie con amore e obbedienza il disegno di redenzione che Dio ha tracciato come anima e meta della storia. Cristo deve, quindi, cancellare l’opera di devastazione, le orribili idolatrie, le violenze e ogni peccato che l’Adamo ribelle ha disseminato nella vicenda secolare dell’umanità e nell’orizzonte del creato. Con la sua piena obbedienza al Padre, Cristo apre l’era della pace con Dio e tra gli uomini, riconciliando in sé l’umanità dispersa (cfr Ef 2,16). Egli ‘ricapitola’ in sé Adamo, nel quale tutta l’umanità si riconosce, lo trasfigura in figlio di Dio, lo riporta alla comunione piena con il Padre. Proprio attraverso la sua fraternità con noi nella carne e nel sangue, nella vita e nella morte Cristo diviene ‘il capo’ dell’umanità salvata. Scrive ancora sant’Ireneo: “Cristo ha ricapitolato in se stesso tutto il sangue effuso da tutti i giusti e da tutti i profeti che sono esistiti dagli inizi” (Adversus haereses V, 14,1; cfr V, 14,2).
4. Bene e male sono, quindi, considerati alla luce dell’opera redentrice di Cristo. Essa, come fa intuire Paolo, coinvolge tutto il creato, nella varietà delle sue componenti (cfr Rm 8,18-30). La stessa natura infatti, come è sottoposta al non senso, al degrado e alla devastazione provocata dal peccato, così partecipa alla gioia della liberazione operata da Cristo nello Spirito Santo.
Si delinea, pertanto, l’attuazione piena del progetto originale del Creatore: quello di una creazione in cui Dio e uomo, uomo e donna, umanità e natura siano in armonia, in dialogo, in comunione. Questo progetto, sconvolto dal peccato, è ripreso in modo più mirabile da Cristo, che lo sta attuando misteriosamente ma efficacemente nella realtà presente, in attesa di portarlo a compimento. Gesù stesso ha dichiarato di essere il fulcro e il punto di convergenza di questo disegno di salvezza quando ha affermato: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32). E l’evangelista Giovanni presenta quest’opera proprio come una specie di ricapitolazione, un “riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52).
5. Quest’opera giungerà a pienezza nel compimento della storia, allorché - è ancora Paolo a ricordarlo - “Dio sarà tutto in tutti” (1Cor 15,28).
L’ultima pagina dell’Apocalisse - che è stata proclamata in apertura del nostro incontro - dipinge a vivi colori questa meta. La Chiesa e lo Spirito attendono e invocano quel momento in cui Cristo “consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza... L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa (Dio) ha posto sotto i piedi” del suo Figlio (1Cor 15,24.26).
Al termine di questa battaglia - cantata in pagine mirabili dall’Apocalisse - Cristo compirà la ‘ricapitolazione’ e coloro che saranno uniti a lui formeranno la comunità dei redenti, che “non sarà più ferita dal peccato, dalle impurità, dall’amor proprio, che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica, nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti, sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione” (CCC, 1045).
La Chiesa, sposa innamorata dell’Agnello, con lo sguardofisso a quel giorno di luce, eleva l’invocazione ardente:“Maranathà” (1Cor 16,22), “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20).
* FONTE: VATICAN.VA, 14 FEBBRAIO 2001 (RIPRESA PARZIALE)
*
NOTA:
PER UNA RICAPITOLAZIONE ANTROPOLOGICAMENTE "INTERA" IN GESU’ ("ECCE HOMO"), NON ANDROLOGICAMENTE "DIMEZZATA" IN PAOLO ("ECCE VIR")!
- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- FILOLOGIA E DIRITTO: LEZIONE DI PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei : "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
- FILOLOGIA E RELIGIONE: LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
DUE SOLI IN TERRA E UNO SOLE IN CIELO. La Monarchia di Dante è una lezione di antropologia prima che di politica: il giardino dell’intera umanità (impero e chiesa) è uno solo - o l’aiuola della guerra o il paradiso terrestre
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E FILOLOGIA. La rinuncia all reciprocità (di Luigino Bruni).20 febbraio 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, COSMOLOGIA, E TEOLOGIA: IL SORGERE DELLA TERRA...
IL RIBALTAMENTO DEL CUORE, LA NASCITA, E LA SCOPERTA DELL’AMORE ("AGAPE", "CHARITAS"). Al di là della reciprocità ("do ut des") della "carità ("caritas")! *
Il segno e la carne /12. La rinuncia alla reciprocità
La rinuncia alla reciprocità
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 19 febbraio 2022)
- L’amore è considerato perfetto se esiste su entrambi i lati: sul lato del giudizio e sul lato opposto della misericordia
- Zohar, n.201
I profeti sono la porta che mette in comunicazione Dio con gli esseri umani e gli uomini e le donne con Dio: a noi donano parole divine, a Dio donano le nostre parole migliori che poi egli usa per parlare con noi, in un dialogo continuo dove noi impariamo la lingua di Dio e diventiamo più umani e Dio diventa più Dio.
Il capitolo undici del rotolo di Osea contiene alcuni dei versi più belli e amati di tutta la Bibbia, è una vetta della profezia. Ma non li comprendiamo se arriviamo a questo capitolo senza aver prima attraversato i moltissimi versi di condanna, di maledizione, di delusione, di tradimento dei capitoli precedenti, senza aver incontrato tutte le parole che Osea ha speso per dirci che l’Alleanza tra YHWH e il suo popolo è spezzata per sempre, che la promessa è svanita per l’infedeltà di Israele. Quei capitoli (4-11) sono veri come è vero il capitolo undici. Come è vero il sepolcro vuoto ed è vero il Golgota, perché la verità del primo giorno dopo il sabato non sarebbe tale senza la verità della croce. La grandezza teologica e antropologica di questo capitolo si svela solo a chi ha percorso la via crucis fino alla fine, è arrivato sul monte e non ha trovato tre tende, ma tre croci. Lì ha voluto stare sotto il patibolo, ha visto morire veramente quel profeta diverso, e ha pensato, veramente, che era finito tutto, che quella speranza stupenda si era infranta contro il no degli uomini che non hanno accolto la luce. E poi ha seguito il cadavere nel terreno di Giuseppe d’Arimatea, ha visto porre la pietra sull’entrata della tomba, e ha sentito che quella pietra chiudeva per sempre anche quella breve stagione straordinaria di salvezza. E solo dopo, soltanto dopo questa verità verissima, ha sentito che il suo nome era chiamato da una voce viva: “Maria”. Non un secondo prima.
Quando invece saltiamo i capitoli difficili e duri della Bibbia, quando schiviamo il Golgota e dalla Domenica delle Palme andiamo subito in Galilea, le risurrezioni diventano finte e non salvano nessuno. Solo chi muore veramente può conoscere una risurrezione vera: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con lacci d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia» (Osea 11,1-4).
YHWH aveva trasformato il giogo degli idoli che opprimevano tutti gli altri popoli in legami d’amore, curando il popolo come un figlio; ma il popolo non aveva voluto sentire nulla, e ha continuato le sue prostituzioni: «Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo» (11,7). La libertà guadagnata, grazie all’allentamento del morso del giogo, era diventata occasione per fuggire in cerca di nuovi amanti, era stata usata per allontanarsi da casa. Perché, lo abbiamo imparato anche noi: i legami d’amore restano lacci, e i figli crescono se riescono a spezzare i loro lacci, persino quelli che avevamo creato solo per amarli. Chiamato a guardare in alto: siamo chiamati a guardare le stelle, solo i sapiens lo sanno fare, gli animali non possono guardare il cielo - forse non c’è definizione più bella della vocazione umana.
Ma mentre Osea ripercorre questa tristissima storia di dolore e di fallimento, ecco che accade l’inatteso, e ci ritroviamo in una delle grandi risurrezioni della Bibbia: «Come potrei abbandonarti, Èfraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboìm? Il mio cuore si capovolge dentro di me, il mio intimo freme di compassione» (11,8). Senza soluzione di continuità, senza nessun preavviso, Osea fa rotolare la pietra del sepolcro e ci accorgiamo, noi e lui, che è vuoto. Quel non-spazio tra quei due versetti contigui crea un tempo infinito che inverte il senso del libro di Osea. Eravamo davvero convinti che YHWH non potesse fare altro che prendere atto della libertà di Efraim e quindi abbandonarlo alla stessa sorte di Adma e Seboìm (città sul Mar Morto, come Sodoma e Gomorra). E invece no: su quella non-speranza irrompe l’impensato, il verso delle cose viene piegato e inizia per Dio il tempo della fedeltà senza reciprocità - la nostra, la sua reciprocità. Non siamo di fronte soltanto a un pentimento di YHWH (come dopo il Diluvio o dopo la punizione per il vitello d’oro); qui c’è una conversione di Dio, come suggerisce il verbo ebraico che parla di un ribaltamento del cuore. YHWH cambia sguardo, inverte la strada, cambia la direzione della sua azione: dunque si converte. E fa qualcosa che non avrebbe dovuto fare, l’opposto di quanto detto finora.
È una vetta della teologia biblica e delle religioni. Qui davvero Osea è maestro di tutti i profeti, di Isaia e di Geremia. Il Dio del capitolo undici di Osea lotta e vince il Dio dei suoi capitoli precedenti. Deus contra Deum: dentro la stessa Bibbia, dentro lo stesso libro, dentro lo stesso profeta. Da questa lotta emerge un Dio inedito. Questa rinuncia alla reciprocità, non ancora conosciuta dagli uomini, ora diventa possibile per Dio: «Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non un uomo» (11,9).
Perché sono Dio e non un uomo: è splendido che la diversità tra Dio e l’uomo stia proprio nel suo essere capace di amare anche senza reciprocità. Come a dirci: “Voi non siete capaci di amare se non siete riamati, io invece non riesco a non amarvi, è per questa incapacità di non amarvi anche se siete ingrati che Io sono Dio”.
 La divinità emerge dallo scarto tra l’amore e la reciprocità, un amore che un giorno chiameremo agape, perché questo amore non era la reciprocità della philìa (amicizia) né il desiderio dell’eros. Quasi a dirci: solo un Dio può amare senza reciprocità: voi, che siete cattivi, non vivete la reciprocità con me, neanche io la vivo con voi e vi amo rinunciando alla reciprocità.
La divinità emerge dallo scarto tra l’amore e la reciprocità, un amore che un giorno chiameremo agape, perché questo amore non era la reciprocità della philìa (amicizia) né il desiderio dell’eros. Quasi a dirci: solo un Dio può amare senza reciprocità: voi, che siete cattivi, non vivete la reciprocità con me, neanche io la vivo con voi e vi amo rinunciando alla reciprocità.Ma poi ci dice anche qualcos’altro. Il Dio di Osea, infatti, da una parte prende le distanze da noi e ci dice parole che non sono ancora le nostre, ma mentre ce le dice ci fa diventare quelle parole diverse, ci sta creando più grandi di come eravamo ieri. Ci mostra una forma di amore che noi non abbiamo ancora, e nel mostrarcela ci rende capaci dell’amore del non-ancora. Meraviglioso.
È così che la parola continua a creare il mondo dicendolo, dicendoci a noi stessi. Noi non siamo il Padre misericordioso che perdona il figliol prodigo prima ancora che gli abbia chiesto perdono, ma ogni volta che ascoltiamo quella parabola di Luca ci nasce il desiderio di somigliarli, vogliamo diventare come lui, diventiamo realmente giorno dopo giorno come lui, finché almeno una volta nella vita ci ritroviamo capaci di accogliere e perdonare un figlio o un amico esattamente come quel padre misericordioso della parabola.
Gli uomini credendo nell’esistenza di Dio hanno detto e dicono molte cose. Una di queste è molto importante: se esiste Dio allora l’uomo non è Dio, quindi non è onnipotente, è limitato e mortale. La Bibbia ha fatto di tutto per tenere viva e operante questa distanza tra il Creatore e noi creature. Ma poi ci ha detto anche un’altra cosa: che siamo stati creati a “immagine di Dio”, e questa parola ha scombinato tutto il rotolo del mondo. Perché se noi siamo immagine di Dio allora ogni volta che Dio ci svela qualcosa di sé ci sta svelando anche qualcosa di noi, qualcosa di diverso, ma anche qualcosa di uguale. Parlandoci della sua giustizia ci parla della nostra giustizia, parlandoci del suo amore ci parla del nostro amore, diverso e simile, e svelandocelo aumenta la somiglianza tra i due amori.
Se guardiamo bene tra le pieghe del mondo, scopriamo ancora qualcosa di entusiasmante. Ci possiamo accorgere che anche le grandi parole umane condividono alcune dimensioni di questa capacità della parola biblica. Scriviamo in una Costituzione, la nostra, che la «Repubblica è fondata sul lavoro» ben sapendo che mentre lo scriviamo la Repubblica non è ancora fondata veramente sul lavoro, perché a fondare la vita sociale c’erano ancora troppi privilegi e ingiustizie. Ma scrivendolo stiamo dicendo, implorando, pregando che la Repubblica possa diventare davvero fondata sul lavoro, vogliamo che quelle parole più grandi di noi abbiano la capacità performativa di cambiare il nostro mondo. Poi scriviamo nei tribunali «La legge è uguale per tutti» ben sapendo che la legge non è ancora davvero uguale per ricchi e poveri, per italiani e stranieri. Ma ogni volta che inauguriamo una nuova aula di tribunale e vi riscriviamo al centro quella frase stupenda stiamo facendo avvicinare il mondo reale a quella parola profetica. Si trova qui una dimensione profetica della terra, quella profezia civile, popolare, cittadina di comunità intere che affidano a poche parole i propri desideri più grandi e i sogni collettivi, che sono autentiche parole-preghiera.
Non sappiamo, infine, come Osea scrisse quel versetto otto del capitalo undici. Forse fu lui il primo a essere tramortito e sconvolto da quanto capì e scrisse. Forse non se lo immaginava, non se lo aspettava, gli arrivò come dono, tutta gratuità, fu risorto da quelle sue parole. O, forse, guardando un giorno un uomo o una donna che era stata capace di amare e di perdonare oltre le infedeltà dell’altro, o ritrovandosi lui stesso capace di amore fedele per sua moglie infedele, Osea intuì che se gli uomini e le donne sono capaci di essere più grandi della loro reciprocità la fonte di questa capacità doveva trovarsi in Dio stesso. O, forse, queste due esperienze sono state una sola, quando Osea nel ricevere quella nuova parola dalla bocca di YHWH, al termine del verso sette gli fiorì un verso differente, vi riconobbe la vita attorno a sé, e finalmente la capì. Una certezza però l’abbiamo: Osea ha incontrato e annunciato una risurrezione perché è arrivato fino in fondo alla crisi sua e della sua comunità. Neanche un centimetro di meno: da dentro la certezza della fine è nata la certezza di un futuro. Troppe volte non risorgiamo perché ci fermiamo alla prima o alla seconda stazione della via crucis, non chiamiamo le crisi col loro nome tremendo, ci consoliamo con piccole risurrezioni e non tocchiamo il fondo degli abissi, dove il piede può tentare un nuovo volo.
*Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IL GIOCO DEL ROCCHETTO E LA NASCITA DELL’ESSERE UMANO. Al di là del gioco di Edipo e Giocasta
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- IL PROBLEMA DELLE "TRE CORONE" E LO "SPACCIO DELLA BESTIA TRIONFANTE" (GIORDANO BRUNO).17 febbraio 2022, di Federico La Sala
DISUGUAGLIANZA, INTOLLERANZA, E PACE PERPETUA...
FINE DELLA STORIA: NON COMPRESA LA LEZIONE DI DANTE ALIGHIERI SUI DUE SOLI E DI GIORDANO BRUNO (17 febbraio1600) SULLE TRE CORONE, DUE CORONE IN TERRA E UNA IN CIELO (“Ultima coelo manet)”, SI VA ANCORA AVANTI CON LE REGOLE DEL GIOCO DELLE TRE CARTE (questa è quella che vince, questa quella che perde, ecc...) e l’espulsione (lo spaccio) dal campo da gioco della BESTIA TRIONFANTE continua ad essere rinviata... USCIRE DAL LETARGO. La Regola, il Logos, non è un "Logo"!
CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA COSMOTEANDRIA. Non sapendo affrontare e non volendo risolvere il problema di Jean Jacques Rousseau (Discorso sull’origine della disuguaglianza: "Il primo uomo che, avendo recinto un terreno, ebbe l’idea di proclamare questo è mio, e trovò altri cosí ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile") come quello di Sigmund Freud (Il disagio della civiltà: "Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comuni tà critiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori"), non ci resta che lavorare ... "PER LA PACEPERPETUA" (KANT, 1795)!!!
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA, ANDROCENTRISMO, E BIENNALE D’ARTE VENEZIA 2022. Riflessioni sul Rinascimento.15 febbraio 2022, di Federico La Sala
LA QUESTIONE DELL’ANTROPOCENTRISMO, IL RINASCIMENTO, E LA BIENNALE D’ARTE VENEZIA 2022...
- "[...] L’antropocentrismo rinascimentale è messo in discussione dalle linee teoriche della Biennale di Cecilia Alemani, come anticipato dalla stessa curatrice.
- Che il meraviglioso, l’ibrido e il fantastico fossero di casa durante il Rinascimento lo testimoniano innanzitutto le opere d’arte: dipinti, sculture, disegni che raffigurano esseri dove il naturale si mescola con l’umano, l’umano con l’animale e il vegetale, il maschile con il femminile etc. etc. Una selva di esseri ibridi provenienti dal paganesimo antico si risvegliano dopo secoli di torpore monoteista. E, se non bastasse la visione diretta delle opere d’arte, che testimoniano in modo inequivocabile l’esplosione dell’immaginazione rinascimentale fatta di centauri, satiri, tritoni, esseri metà uomini e metà cavalli, capre e pesci che si accompagnano a esseri metà arborei e animali ed ermafroditi, abbondano i testi di incomparabile erudizione come La rinascita del paganesimo antico di Aby Warburg o i Misteri pagani nel rinascimento di Edgar Wind. Testi capitali che hanno avuto il compito, nel secolo scorso, di spazzare via la ormai vetusta e inservibile interpretazione che fa del Rinascimento un prodromo dell’Illuminismo, fenomeno figlio della modernità calvinista e iconoclasta, come testimonia James Simpson in Under the Hammer. La difficoltà di classificare un periodo storico come quello rinascimentale deriva dalla difficoltà che molti hanno di dismettere vuote contrapposizioni dicotomiche tipiche della modernità, come razionale vs irrazionale, fantastico vs realista e che dir si voglia. Ciò che tiene insieme artisti come Piero di Cosimo e Piero della Francesca, oppure Leonardo e Michelangelo nella loro diversità e insieme fortissima coesione è la comune appartenenza a un paradigma affatto diverso, tutto all’insegna del potere delle immagini e della loro indipendenza rispetto ad altre forme di pensiero.
- IL PUNTO DI VISTA DI CECILIA ALEMANI. Ecco che quindi fa benissimo la curatrice della nuova Biennale d’Arte, Cecilia Alemani, a inaugurare, nella sua presentazione, la serie delle opere in mostra con i dipinti di Remedios Varo e di Leonor Fini, che, emblematicamente, sono totalmente mutuate da un’iconografia chiaramente rinascimentale. E lo si vede sia nella scatola prospettica dotata di scacchiera albertiana, come in una predella di Paolo Uccello, nell’opera della Varo, oppure nell’acribia del disegno e della sovrapposizione di velature, come in un Cristofano Allori, del dipinto della Fini. Ma anche nell’eccezionale dipinto di Paula Rego si scorge l’organizzazione brunelleschiana dello spazio nella fuga prospettica del pavimento a scacchiera che spinge in avanti verso lo spettatore la grande figura in primo piano.
- È proprio nel tentativo novecentesco di artisti e artiste, come quelle che Alemani ha deciso di porre nuovamente in luce, poste ai margini della linea della modernità ortodossa (quella sì espressione della hubris faustiana e tecnica e quindi fondamentalmente aniconica), le quali ricercavano nell’immagine di matrice rinascimentale la fonte cui abbeverarsi come un antidoto allo strapotere della tecnica, che comprendiamo quanto l’arte del Rinascimento, nella sua irriducibile complessità, sia oggi sempre più che mai attuale e rilevante" (Nicola Verlato, Riflessioni sul Rinascimento in vista della Biennale di Cecilia Alemani, Artribune, 10 febbraio 2022).
ANTROPOLOGIA, STORIA, E FILOLOGIA. Per una messa in discussione critica dell’antropocentrismo rinascimentale (che ha matrici antiche, nella tradizione greco-romana), forse, sarebbe meglio ripartire dalla Trasfigurazione di Cristo del Beato Angelico del 1437-1446, e dall’opera di Lorenzo Valla, "Sulla Donazione di Costantino falsamente attribuita e falsificata" del 1440, e, infine, anche dall’uomo vitruviano (1490) e dal "bambino nel grembo materno" (del 1511) di Leonardo da Vinci.
PER RI-NASCERE, VEDERE DALLO SPAZIO IL SORGERE DELLA TERRA. Alla luce di questo capovolgimento di sguardo, si potrà osservare meglio il cammino della tentazione prometeica e faustiana dello stesso antropocentrismo del Rinascimento, fino ad arrivare alla hubris della tecnica, che si caratteriza per essere più un camuffato androcentrismo tragico (alla Socrate e alla Platone, come ha ben visto Nietzsche) che non un semplice antropocentrismo, antropologicamente fondato.
ARTE E SOCIETÀ. Piero di Cosimo è una figura-chiave del tempo: nel 1481 è a Roma col maestro Cosimo Rosselli, per lavorare nella Cappella Sistina (voluta da papa Sisto IV); e nel 1483 è a Firenze: del 1488 è la Sacra conversazione, ora nella Galleria dello Spedale degli Innocenti ("Era molto amico di Piero lo spedalingo de li Innocenti").
BAMBINI ABBANDONATI E ANDROCENTRISMO. Ricordato che anche Leonardo da Vinci era un figlio naturale e che il "presepe" era stato introdotto nella Firenze del ’400, nell’Ospedale degli Innocenti (l’Ospedale non ha la ruota ma una cappella aperta, il presepe, dove il bimbo veniva deposto tra le immagini di Gesù, nato povero e allevato nella carità), è da dire che il nodo di Ercole, il problema di come nascono i bambini, è ancora sciolto come la cosmoteandria tragica (Eschilo con Platone e Aristotele) comandava e, a metà 1500, con il Concilio di Trento "il matrimonio diventa un’istituzione obbligata, e l’ingresso dell’Ospedale viene chiuso da una grata; da luogo di accoglienza per i meno ricchi diviene rifugio per una sottospecie di infanzia, che nasce sotto il segno di una vergogna ereditata dalla madre" (Adriano Prosperi).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- EARTHRISE (24 DICEMBRE 1968).13 febbraio 2022, di Federico La Sala
Cosmologia, antropologia, cristianesimo e civiltà.
"IL FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGICA...
COSMOLOGIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X”. Così Nietzsche, nel 1886. Ma, per un filosofo nato filologo e, per di più, uno dei grandi maestri del sospetto, contrariamente a quanto si è sempre ripetuto in modo "umano, troppo umano", non è bene tornare a interrogarlo e cercare di avere ulteriori dati sulla destinazione "ignota"?
ANTROPOLOGIA. Nel 1888 pubblica "Ecce homo. Come si diviene ciò che si è": un Urlo contro la paolina religione del "Vir Dei", una critica radicale della cosmoteandria faraonica, e un aut aut epocale.
LA PUNTA DI UN ICEBERG BIMILLENARIO: PUGLIA (12 FEBBRAIO 2022). "Ecce Vir": il "caso serio" del quadro intitolato "Sabinus vir Dei".
Tracce per una seconda rivoluzione copernicana
- AL DI LÀ DELLA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E RINASCIMENTO, OGGI. Una ristrutturazione epocale e lo sgretolamento della cosmoteandria tradizionale (#cosmo, teologia/ #dio e #andrologia/uomo) è già da tempo in atto: la nascita di una antropologia annunciata già da Michelangelo nel suo "Tondo Doni", con le sue due sibille e i suoi due profeti - non "quattro profeti", come vuole la Galleria degli Uffizi, e da Galileo Galilei con il suo "Sidereus Nuncius" (1610), fondata sulla visione del sorgere della Terra, è già in cammino: un capovolgimento e una nuova ricapitolazione, una radicale inversione logico-storica!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Questione antropologica e sorgere della Terra.7 febbraio 2022, di Federico La Sala
Dante 2021: Disagio della civiltà e discorso dei due Soli (del papa della chiesa cattolica e del presidente della repubblica italiana).
Antropologia Filologia e Ricapitolazione. In memoria di Giovanni Garbini, William Shakespeare, Galileo Galilei, Sigmund Freud, Judith-VirginiaWoolf, Joyce 2022...
AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE (Cantico dei cantici, 8.6). L’amore non è lo zimbello del tempo...
QUESTIONE ANTROPOLOGICA: ECCE HOMO. L’ Amore "vince tutto": MA quello antropologico-evangelico di Gesù o quello andrologico di Paolo di Tarso ("di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio": 1 Cor. 11, 1-3)?!
SE DIO è amore ("Deus charitas est"), e "non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù" ("non est Iudaeus neque Graecus, non est servus neque liber, non est masculus et femina; omnes enim vos #unus estis in Christo Iesu" - Galati, 3.28), NON "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il #cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010)?!
A che gioco giochiamo, ancora?!
Non è ora di uscire dal tunnel (Dante Alighieri, Inf. XXXIV, 90)?!
Dopo Tebe, l’enigma della sfinge di Edipo non è stato risolto nemmeno con l’andata di Freud e Jung negli Usa! E l’intera umanità non ha ancora compreso né come nascono i bambini né che cosa significa vedere e aver visto il sorgere della terra!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E LA "MUSICA DELLE SFERE" (GAFFURIO).1 febbraio 2022, di Federico La Sala
DANTE2021
LA MEMORIA DI APOLLO E DELLE MUSE E IL MESSAGGIO SEGRETO DELLA DIVINA COMMEDIA, DEL MUSICO DI LEONARDO, DELLA PRATICA DELLA MUSICA DI GAFFURIO, E DELLA GAIA SCIENZA DI NIETZSCHE...
- DISAGIO DELLA CIVILTÀ (FREUD, 1929). Tenendo ferma la generale non-volontà di sapere di sé e la messa fuori campo della musica dalle accademiche orecchie platoniche (colpite da cecità e zoppia come quelle di Edipo) per le quali già il solo "parlare è suonare il proprio corpo" (Alfred Tomatis), il messaggio di fondo di questi grandi interpreti della tradizione europea è rimasto per lo più "segreto" (esoterico)
A) IL MUSICO. "Il messaggio segreto nel quadro di Leonardo: Un messaggio nascosto, per di più in chiave musicale, all’interno di un quadro: “Il Ritratto di Musico” di Leonardo da Vinci. Lo ha svelato lo storico d’arte e ricercatore siciliano Giuseppe Petix alla Fordham University di New York. [...] Petix ci racconta anche: «Il rebus all’interno del cartiglio è stato trovato grazie alle conoscenze musicali che abbiamo del periodo di Leonardo. Un rebus che se decifrato forma il versetto o meglio il rondò “Oh Re fammi lagnar: Sol l’amore mi fa sollazzar”, che in versione prosaica potrebbe essere visto così “Oh dio, permettermi di lamentarmi, concedimi un lamento da uomo, solo l’amore mi rende felice”». Un inno, quindi, una preghiera, una richiesta di aiuto [...] Questa frase ricorda le lamentazioni presenti nei salmi della bibbia, e di preciso il "dio" del quale si parla potrebbe rappresentare l’anima del Davide Biblico [...]" (Laura Pace , i.Italy, November 25, 2019)
C) LA GAIA SCIENZA (IV, fr. 334). "Si deve #imparare anche l’amore. Si deve imparare ad amare. Ecco quel che ci accade nella musica: si deve prima imparare a udire una sequenza e una melodia in genere, a enuclearla nell’ascolto e a distinguerla isolandola e delimitandola come se avesse una vita propria; quindi bisogna sforzarci e impiegare la nostra buona volontà per sopportarla, malgrado la sua estraneità, bisogna fare un esercizio di pazienza di fronte al suo sguardo e alla sua espressione, considerare con benevolenza quel che c’è di inusitato in essa - finalmente arriva un momento in cui ne abbiamo preso l’abitudine, in cui l’attendiamo, [...] finché non si sia diventati i suoi umili ed estasiati amanti, per cui non v’è più niente di meglio da chiedere al mondo se non la melodia e ancora la #melodia.
Questo ci accade però non soltanto con la #musica: proprio in questo modo abbiamo imparato ad amare tutte le cose che oggi amiamo. In definitiva, siamo sempre ricompensati per la nostra buona volontà, per la nostra pazienza, equità, mitezza d’animo verso una realtà a noi estranea, quando lentamente essa depone il suo velo e si manifesta come una nuova inenarrabile bellezza: è questo il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso, lo avrà appreso per questa strada: non ce ne sono altre. Si deve imparare anche l’amore. (F. Nietzsche).
D) COSMOLOGIA DANTESCA. "L’amor che move il sole e le altre stelle" (Par., XXXIII, 145).
E) DANTE LEONARDO E GAFFURIO: LE TRACCE DI UN PROGRAMMA E DI UNA STRATEGIA CULTURALE CON RADICI PROBABILMENTE GIOACHIMITE E FRANCESCANE...
Il messaggio segreto del Musico di Leonardo e il legame stretto con la Musica delle Sfere ("Theorica Musicae", (1492; "Practica Musicae", 1496) di Franchino Gaffurio (con Apollo, le Grazie, le Muse, il Cielo delle Stelle Fisse e dei Pianeti, e il Serpente) rende possibile una interpretazione e connesione con il viaggio della Divina Commedia: il cammino nel regno dell’Apollo de-caduto (dopo la venuta del nuovo Re, di Cristo), cioè di Lucifero, è finito ed è "ora" che Dante con Virgilio si liberino della loro stessa pelle di serpente e, lasciato Lucifero con" le gambe in sù" (Inf. XXXIV, 90) alle loro spalle, ... mettano i piedi a terra! La strada per il paradiso terrestre e celeste è libera.... sotto il cielo stellato, inizia la "vita nuova"!
- Nota: A proposito di RE, sicuramente legato alla tradizione criptata dell’amore (come in Dante Alighieri), da ricordare (in consonanza) che "L’Adorazione dei Magi" di Leonardo è solo a un primo livello di abbozzo: nel settembre del 1481 stava ancora lavorando al dipinto, ma pochi mesi più tardi lasciò Firenze per recarsi a Milano, alla corte di Ludovico il Moro.
F) LA MUSICA DELLE SFERE, LA DIVINA COMMEDIA, E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA. Nella sua "Mitologia creativa" (Milano 1992), Joseph Campbell, dopo aver premesso che "anche Dante invocò le Muse - all’inizio dell’inferno, nel Canto II - e fu guidato sia attraverso l’Inferno sia sulla cima paradisiaca del Monte del Purgatorio dal pagano Virgilio" (p. 128) e aver analizzato in dettaglio la Figura di «la Musica delle Sfere», "trattada un’opera neoplatonica del quindicesimo secolo, la Pratica musicae di Franchino Gaffurio, pubblicata a Milano nel 1496", scrive che "[...] l’intera Divina Commedia di Dante esprime questa visione pagana di una dimensione spirituale dell’universo", e, al contempo, lo "imbottiglia" (senza resti) nella tradizione cattolico-romana: "[...] Il fatto che, in Dante, il potere di guida dei pagani termini alla sommità del Purgatorio, nel Paradiso Terrestre, si accorda con la formula di san Tommaso secondo cui la ragione può condurre, come fece con gli antichi, fino al vertice delle virtù terrene, ma solo la fede e la grazia soprannaturale (personificata da Beatrice) possono portare oltre la ragione, fino alla sede di Dio". Pur, se con incertezze e difficoltà, continua e finisce paradossalmente col riportare Dante nell’orizzonte della tragedia e dell’antico patto edipico (di "mammasantissima", altro che patriarcale): "Tuttavia, analizzando questo Dio Trinitario che, nella dottrina cristiana delle tre persone divine in un’unica sostanza divina, abbiamo una trasposizione delle tre Grazie e dell’Apollo Iperboreo in un ordine mitologico di maschere escusivamente maschili di Dio, il che si accorda bene con lo spirito patriarcale dell’Antico Testamento, ma sbilancia radicalmente le connotazioni simboliche, e quindi spirituali, non solo del sesso e dei sessi, ma anche dell’intera natura".
Federico La Sala
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- IL SORGERE DELLA TERRA E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, OGGI (2022).20 gennaio 2022, di Federico La Sala
#PIANETA TERRA,
#COSMOTEANDRIA E #ANTROPOLOGIA.
L’#autodeterminazione, la #libertà
di disporre di sé,
è
dell’#uomo come della #donna,
ma l’#Europa pensa come se vivesse
in una #terra piatta, nel suo #mare nostrum.
Non ha ancora visto il #Sorgere della Terra?!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’AUTODETERMINAZIONE, LA LIBERTA’ DI DISPORRE DI SE’, E LA PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO. Un segnale (di Giulia Blasi).20 gennaio 2022, di Federico La Sala
L’elezione di Roberta Metsola è un segnale
Potrà non complicare il voto sui diritti riproduttivi, ma legittima le posizioni antiabortiste in Europa
di Giulia Blasi (La svolta, 19 gennaio 2022)
Per parlare dell’elezione di Roberta Metsola a Presidente del Parlamento Europeo non voglio partire da facili dicotomie buono/cattivo. Di Metsola si sta parlando molto perché oltre a essere una donna (con nome e cognome, non la solita Una Donna che per settimane sembrava dovesse diventare Presidente della Repubblica e adesso, come da copione, è sparita dal radar) è anche la più giovane presidente nella storia del Parlamento Europeo, e solo la terza a rompere la lunga teoria di volti maschili incorniciati nei corridoi dei palazzi di Bruxelles.
 La morte improvvisa di David Sassoli ha solo accelerato un processo che era già in corso da tempo per la ricerca di una figura all’interno delle fila del centrodestra, e Metsola - già presidente a interim e figura che gode di una grande stima fra i colleghi - è stata eletta anche con i voti del gruppo S&D, il gruppo dei socialisti e democratici guidato da Iratxe García Pérez, politica spagnola apertamente femminista. L’elezione di Metsola con i voti dell’S&D è stata frutto di un negoziato, come sempre succede in questi casi: in cambio del loro sostegno, i socialisti hanno chiesto e ottenuto una serie di nomine a cariche importanti.
La morte improvvisa di David Sassoli ha solo accelerato un processo che era già in corso da tempo per la ricerca di una figura all’interno delle fila del centrodestra, e Metsola - già presidente a interim e figura che gode di una grande stima fra i colleghi - è stata eletta anche con i voti del gruppo S&D, il gruppo dei socialisti e democratici guidato da Iratxe García Pérez, politica spagnola apertamente femminista. L’elezione di Metsola con i voti dell’S&D è stata frutto di un negoziato, come sempre succede in questi casi: in cambio del loro sostegno, i socialisti hanno chiesto e ottenuto una serie di nomine a cariche importanti.Tutto regolare, quindi, dal punto di vista della democrazia parlamentare e del suo funzionamento. Il motivo per cui l’elezione di Roberta Metsola sta facendo discutere è un altro: la neopresidente maltese è nota da tempo per le sue posizioni antiabortiste, espresse anche nel corso del suo mandato come europarlamentare, e Malta è l’unico paese dell’Unione europea ad avere reso la procedura abortiva del tutto illegale (l’ultimo intervento sul tema risale al 2005), senza eccezioni. Cosa che - come sempre accade lì dove l’accesso all’aborto è limitato o vietato - spinge le donne ad andare all’estero per poter interrompere una gravidanza. Quelle che non possono farlo cercano di procurarsi un aborto con altri metodi, non sempre sicuri. Il blocco dei voli in ingresso a marzo 2020 ha anche lasciato le donne maltesi sprovviste di contraccettivi, considerati “non essenziali” dal governo.
Non è certo l’elezione di Metsola a ricordarci che opporsi all’autodeterminazione delle donne non è ancora considerato un difetto invalidante per una figura politica di spicco: nel 2013 il rapporto Estrela, che fra le altre cose chiedeva il riconoscimento dell’accesso all’aborto come diritto umano, fu bocciato dal Parlamento Ue anche a causa dell’astensione di alcuni politici di centrosinistra, fra cui spiccano i nomi di Silvia Costa e Patrizia Toia, ma anche del compianto Sassoli. Anche l’ex presidente Antonio Tajani non ha mai fatto mistero delle sue posizioni antiabortiste. Se Metsola viene giudicata con maggiore severità non è perché ha difeso il diritto del governo maltese di ostacolare il diritto delle cittadine di decidere dei loro corpi, e nemmeno perché da una donna ci si aspetta che quel diritto sia disposta a difenderlo anche contro le sue personali convinzioni. Dal canto suo, la nuova presidente ha emanato vaghe rassicurazioni sulla sua intenzione di rispettare la volontà del Parlamento e la missione dell’Europa di proteggere i diritti di tutti, dichiarazioni che la storia ci insegna essere soggette ad ampia interpretazione.
Il problema è più simbolico che pratico, ma sappiamo benissimo quanto i simboli siano determinanti nel definire questioni politicamente delicate come quella dell’aborto. L’ennesima donna bianca, bionda, rassicurante e conservatrice nella stanza dei bottoni ci mostra che la faccia del potere cambia, ma di poco, e non in un modo che possa minacciare l’ordine costituito. Metsola, come tante prima di lei, si presta a fare da scudo con la sua femminilità a un’osservazione ricorrente di chi si batte per i diritti riproduttivi, vale a dire che la sottorappresentazione delle donne in politica rende più difficile il processo di restituire centralità all’esperienza femminile, in tutte le sue varianti. Metsola è una donna: la sua parola sull’aborto conta, perché viene da una persona con un utero, una persona che l’esperienza di vivere in un corpo femminile la fa ogni giorno, e se la sua parola è contro l’aborto, quella parola verrà assunta come finale da chi ritiene che interrompere una gravidanza sia una scelta aberrante, un crimine a cui opporsi con ogni mezzo, e non una decisione che spetta solo a chi quella gravidanza la ospita.
L’elezione di Roberta Metsola potrà non complicare o sbilanciare il voto sulle questioni legate ai diritti riproduttivi, ma è un segnale. Conferisce legittimità all’azione di quei governi che in Europa lavorano per sopprimere le libertà individuali, inclusa quella di scegliere se portare avanti una gravidanza. Perché l’aborto è, e sarà sempre, solo una questione di controllo dei corpi: la vita non c’entra, la natalità non c’entra, c’entra solo la volontà di sottrarre alle donne e alle persone che possono generare la libertà di disporre di sé.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UN PROBLEMA DI DEFINIZIONE E DI SOVRANITÀ. Cantiere Spinoza (di M. Morini).19 gennaio 2022, di Federico La Sala
SPINOZA, UN FIGLIO DEL "DEUS", NON UN FIGLIO DEL "LUPUS", (A FIANCO DI KANT, NON DI HEGEL). *
Questioni teoretiche
Cantiere Spinoza
di Maurizio Morini (Ritiri Filosofici, 16 Gennaio 2022)
Così come per qualsiasi altra occupazione, anche in filosofia sono necessari strumenti adeguati per fare bene il proprio lavoro, tali soprattutto da superare le difficoltà che presto o tardi sempre si dovranno affrontare. In questo senso uno dei suoi strumenti principali è il concetto di definizione, stabilire il quale non è neutrale ed implica delle conseguenze decisive. Chi delle definizioni ha fatto l’essenza del proprio filosofare è stato Spinoza il quale ha costruito l’intero suo edificio proprio grazie al metodo geometrico. Molti però, tra gli stessi filosofi, ne hanno dichiarato l’inutilità o addirittura l’artificiosità. Adorno nelle sue lezioni confessava che, di fronte alle definizioni del filosofo olandese, si trovava «del tutto disorientato, come la mucca di fronte alla porta nuova». Il filosofo della Dialettica dell’Illuminismo finiva poi per dichiarare che in filosofia ci sono dei concetti che non sono passibili di definizione con la conseguenza che la sua ricerca era inutile. Adorno si rifaceva esplicitamente a Kant il quale aveva sostenuto a sua volta una ben precisa critica della definizione così come utilizzata in filosofia. Solo al termine delle sue lezioni, guardando ai risultati della filosofia contemporanea, Adorno (in maniera onesta) sembra spezzare una lancia a favore della definizione e addirittura ritirare la propria tesi.
La definizione in Aristotele e in Kant
Da un punto di vista etimologico, la parola definizione è composta dalla preposizione de e dal nome finis: discorso sul limite. La definizione quindi indica i confini entro i quali è racchiusa l’essenza o il concetto di qualche cosa. Essa pertanto deve cogliere gli aspetti comuni o differenziali di una certa cosa: in altre parole, la definizione si intende secondo il genere e la differenza specifica. Questa impostazione risale ad Aristotele il quale affermava che c’è definizione solo quando il termine significa qualcosa di primario, ovvero quando si parla di cose che non possono essere predicate di altre. Il genere è il primo elemento della definizione (dove per genere si intende il complesso di caratteri di un certo tipo riuniti sotto un certo nome); la differenza specifica invece, ciò invece che caratterizza la cosa che si intende definire rispetto a tutte le altre.
Kant, nella Dottrina trascendentale del metodo, assume un’altra prospettiva, per comprendere la quale è necessario distinguere due usi della ragione: il primo riguarda l’uso della ragione in base a concetti; il secondo l’uso della ragione in base alla costruzione di concetti. Al primo uso viene dato il nome di filosofia; al secondo il nome di matematica. In quest’ultima i concetti sono già determinati a priori dall’intuizione pura, senza che via sia necessario alcun dato empirico; la filosofia invece non può prescindere dall’esperienza in quanto essa sta a fondamento dei concetti. Posto ciò, Kant conclude che la fondatezza della matematica poggia su definizioni, assiomi e dimostrazioni, nei confronti dei quali la filosofia deve fare a meno («come il geometra, usando il suo metodo nella filosofia, non può costruire che castelli in aria, così il filosofo, applicando il proprio nella matematica, non dia luogo che a chiacchiere»). Kant sostiene che in filosofia la definizione non può essere utilizzata proprio perché i concetti empirici, più che essere definiti, andrebbero resi espliciti, chiariti, dichiarati (tutti termini che in tedesco fanno riferimento al termine Aufkärung). Sono fuori strada quindi tutti coloro che utilizzano termini come sostanza, causa, diritto: in altre parole una vera e propria stroncatura della filosofia di Spinoza.
La definizione in Spinoza
Cosa diceva Spinoza in merito? «Se si deve conoscere una cosa attraverso la definizione costituita da genere e differenza - scrive nel Breve Trattato - non possiamo mai perfettamente conoscere il genere supremo, che non ha alcun genere sopra di sé» (KV, I, 9). Piuttosto, bisogna seguire la vera logica, ovvero la divisione della natura in natura naturans e natura naturata.
Ma è in una corrispondenza epistolare, quella intrattenuta con un giovane mercante di Amsterdam, Simone De Vries, che Spinoza chiarisce meglio il suo pensiero. Chiesto su che cosa dovesse intendersi per definizione, egli rispondeva che bisogna distinguere la definizione della cosa in senso reale, in quanto fuori dall’intelletto, e la definizione della cosa in quanto è concepita in senso nominale. Alla prima si chiede di essere vera in quanto ha un oggetto determinato; la seconda si propone invece al solo scopo di ricerca. In altre parole: il primo genere di definizione deve essere necessariamente vero in quanto, se io ad esempio voglio definire l’essenza del tempio di Salomone, devo stabilire una descrizione esatta della cosa (altrimenti si ha una cattiva definizione). Il secondo tipo di definizione implica invece che si esplichi la sua progettualità, non importa che essa sia vera o no: in questo caso la definizione o si concepisce oppure non si concepisce. Chiariamo con un esempio: un conto che io debba definire l’orologio a parete che ho di fronte a me; un’altra è che io debba definire un orologio a parete che devo ancora costruire, in cui ciò che importa è che la sua costruzione non sia autocontraddittoria, tale cioè da renderlo inservibile allo scopo.
Il problema, insiste Spinoza, consiste nel fatto che la definizione tradizionale (quella aristotelica, che distingue genere e differenza specifica) riposa essenzialmente sull’esperienza, la quale però «non ci dà alcuna essenza delle cose», sicché noi dell’esperienza non abbiamo mai bisogno per la definizione. Infatti - si potrebbe dire - come si potrebbe definire una cosa soggetta al continuo divenire? Lo potremmo fare solo fingendo, per esigenze legate a questioni pratiche, come quello di intendersi su ciò di cui si sta discutendo. La prospettiva dunque sembra avvicinarsi a quella kantiana per poi però allontanarsi in modo radicale: se il tedesco sosteneva che l’esperienza è l’unico campo della filosofia (e per questo rinunciava alla definizione), l’olandese sosteneva che, proprio perchè l’esperienza non era l’unico campo della filosofia, la definizione era essenziale.
Un sistema aperto non una cattedrale di ghiaccio
Se il dialogo tra Spinoza e il suo giovane amico non può essere considerato un dialogo tra sordi, non si può non riconoscere però che i due parlano linguaggi diversi. Da esso si ricavano alcune impressioni (vedi le lettere 8, 9 e 10 dell’epistolario), soprattutto in merito all’oggetto della loro discussione, cioè le proposizioni dell’Etica.
La prima è che l’intero dialogo sulla definizione (tema piuttosto acceso nel circolo spinoziano, come ammette De Vries) è fondato sull’intelletto come strumento per accedere alla verità: cosa che oggi è talmente lontana dalla nostra sensibilità filosofica che facciamo difficoltà a seguirlo e a comprenderlo pienamente.
La seconda impressione è che, contro la retorica del “cristallo” e della “cattedrale di ghiaccio”, il sistema di Spinoza (riassunto nell’Etica) si rivela essere un cantiere aperto in cui, oltre alla scelta dei materiali, rimane determinante la capacità di costruire dei costruttori.
Questo conduce ad una terza domanda (da cui nasce l’impressione): le definizioni dell’Etica sono definizioni reali oppure definizioni nominali? Qui l’impressione è che Spinoza mescoli le carte, alternando le une alle altre senza un indice preordinato e dove la risposta sembra lasciata all’intelligenza del lettore, il quale è invitato a prendere parte alla costruzione. Diceva Wolfson che «l’Etica non è una comunicazione al mondo; è la comunicazione di Spinoza con se stesso». Questo non significa che le sue definizioni siano lasciate al relativismo delle interpretazioni o peggio al solipsismo. Tutt’altro: ciò significa che ogni definizione impegna il lettore nella forza del ragionamento, perché solo questo può mostrare la verità o la falsità di un asserto. Nel Trattato sull’emendazione dell’intelletto Spinoza scrive: «ho dimostrato e ancora tendo a dimostrare il buon ragionamento, ragionando bene».
* NOTA.CANTIERE SPINOZA. ETICA, MATEMATICA, E CRITICA DELLA DIALETTICA...
Se è vero, come è vero, che l’Etica di Spinoza è “un sistema aperto non una cattedrale di ghiaccio” e che è necessario sciogliere l’enigma se “le definizioni dell’Etica sono definizioni reali oppure definizioni nominali” (M. Morini, "Cantiere Spinoza", Ritiri Filosofici, 16.01.2022), non si può ricadere nella stesso passo falso dell’analisi del “Discorso del Re” (M. Morini), e portare l’acqua al mulino non di “Amleto” (Shakespeare), ma a quello di Hobbes!
Una interpretazioni riduttiva della “Critica della Ragion pura” e della concezione kantiana della “definizione”, dalla sez. della “Dottrina trascendentale del metodo”, riconduce direttamente e di nuovo il discorso sotto il “principio di Hobbes” (e nell’orizzonte di Hegel e di T. W. Adorno), nell’orizzonte del “Leviatano” (e, al contempo, della dialettica di Hegel e della “dialettica dell’illuminismo” di Adorno), “secondo cui le azioni del sovrano non possono mai essere accusate di ingiustizia dai sudditi e il sovrano non può né essere messo a morte né essere punito dai suoi sudditi” (M. Morini, “ [1]”, Ritiri Filosofici, 02.01.2022).
“HOMO HOMINI LUPUS EST”?! Pur condividendo l’impressione “che Spinoza mescoli le carte, alternando le une alle altre senza un indice preordinato e dove la risposta sembra lasciata all’intelligenza del lettore, il quale è invitato a prendere parte alla costruzione” (M. Morini, cit.), è assolutamente non condisibile una conclusione dell’analisi accogliendo la dichiarazione del “Figlio del Lupo” (“Wolf-son”) e dire davvero con Wolfson che «l’Etica non è una comunicazione al mondo; è la comunicazione di Spinoza con se stesso»! E’ posssibile asservire la “filosofia” (nel senso di Kant) di Spinoza al calcolo e alla matematica di Platone, di Cartesio, di Hobbes, ed Hegel, e dire che questo “significa che ogni definizione impegna il lettore nella forza del ragionamento, perché solo questo può mostrare la verità o la falsità di un asserto” (M. Morini, cit.)?!
Non è il caso di riprendere il discorso dalla figura del “capo”, dal “discorso del re”, e rimeditare la “filosofia” e la “matematica” di Kant?! Se no, come è possibile distinguere tra “essere e non essere”, definire, ragionare e, al contempo, decidere sul “che fare?”, qui ed ora?! Non è meglio uscire dall’inferno della “fenomenologia dello spirito” di Hegel e, con Dante e Virgilio, uscire dalla caverna (Inf. XXXIV, v. 90) e ammirare il “cielo stellato” di Koenigsberg?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ENZO PACI, "NICODEMO O DELLA NASCITA", E IL SUO AUT AUT. Quel gesto fenomenologico che ha fatto cultura (di P. A. Rovatti).11 gennaio 2022, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI. LA CRISI DELLE SCIENZE: ENZO PACI, "AUT AUT", E L’ENIGMA DEL SOGGETTO. *
- Franz Brentano: "La filosofia possiede al massimo grado la dignità di una scienza teoretica, ma perde completamente questo privilegio, quando dall’ambito della sua conoscenza viene esclusa l’esistenza di Dio" ("La prova dell’esistenza di Dio", 1915).
- Enzo Paci: Nicodemo o della nascita.
Quel gesto fenomenologico che ha fatto cultura
di Pier Aldo Rovatti *
Se mi chiedessero di dire in una battuta che cosa ha prodotto il settantennio di vita della rivista “aut aut”, messa al mondo nel 1951 dal filosofo Enzo Paci e oggi tutt’altro che estinta, risponderei senza esitazione: “il gesto fenomenologico”.
A tale atteggiamento o pratica di pensiero è stato dedicato anche il fascicolo della rivista attualmente in circolazione, in cui si guarda tanto al lunghissimo passato quanto a un futuro ancora da realizzare: sì, perché siamo ancora lontani dall’avere ben compreso questo gesto e dall’essere riusciti a metterlo in atto.
Di cosa si tratta? È un tentativo di dar corpo alla parola “critica”, forse più facile da collegare a quella cultura che voleva prendere distanza dai dogmatismi e dagli ideologismi del ventennio fascista di quanto sia riconoscibile oggi in una situazione nella quale tutti ci riempiamo la bocca di un’idea di democrazia alquanto superficiale e di tanti propositi culturali che spesso risultano vuoti e dai piedi di argilla. Parliamo infatti di pensiero critico, di responsabilità e di etica pubblica, ma non sembra proprio che riusciamo a dare troppo peso a quello che diciamo, come se dalla bocca di molti intellettuali uscisse soltanto un esile vapore, un flatus vocis che si disperde subito nell’aria.
Il gesto fenomenologico avrebbe invece la pretesa di tenere i piedi ben piantati sulla terra e di non consumarsi subito in una vacua cortina fumogena, come capita alla gran parte dei prodotti dell’attuale mondo della comunicazione, frettolosi e dunque superficiali. Questo gesto è invece qualcosa che ci coinvolge integralmente: non un semplice pensiero, qualcosa che ci passa per la testa e che comunque si riduce all’ambito del mentale, al contrario riguarda la nostra intera soggettività. È un atteggiamento “concreto” che concentra l’insieme delle nostre facoltà e ci mette completamente in gioco.
Detto altrimenti, questo gesto ci espone agli altri, non è una postura comprimibile nella privatezza, perciò ha sempre una dimensione pubblica, nel senso appunto dell’esposizione e del confronto. Siamo lontani dall’idea di una filosofia come disciplina a sé, dotata di una sua autorevolezza, piuttosto siamo vicini a un impegno di pensiero che ci chiederebbe di uscire dal bozzolo di un “io” separato, vale a dire di tentare di liberarci dalla presa di qualunque egoismo (egologia, egolatria) e dunque anche di sospettare di ogni pervasiva psicologia.
Perciò il gesto fenomenologico, così difficile da mantenere, così facile da inquinare e infrangere, dunque raro, è innanzi tutto un atteggiamento autocritico: ciascuno di noi, ogni “soggetto”, dovrebbe cominciare con il togliersi di dosso la camicia di forza dell’egoismo, tentare almeno di farlo, se vuole che il suo gesto agisca come un gesto critico. Non è certo lo scenario che vediamo ogni giorno perché, invece, abbiamo costantemente davanti una scena opposta in cui non si scorge quasi nessuna traccia di tale necessaria critica di sé stessi.
Ma cosa significa quel parolone, “fenomenologico”, che accompagna la parola “gesto”? Qui compare la specificità filosofica che caratterizza i settant’anni della rivista. È chiaro che il rimando è a Husserl e soprattutto alla sua ultima opera La crisi delle scienze. Si parte da una diagnosi di perdita di senso, cioè appunto di “crisi”, che non investe soltanto il mondo scientifico e la sua tecnicizzazione, come aveva fatto negli anni Trenta lo stesso Heidegger (peraltro, inizialmente discepolo di Husserl), ma investe per intero la cultura poiché riguarda lo stile di vita di ciascuno. Il titolo preciso di quest’opera di Husserl, che davvero ha fatto testo per comprendere un’epoca, certo non ancora conclusa, è: La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (in italiano è stata pubblicata dal Saggiatore, lo stesso editore di “aut aut”).
“Fenomenologia” e in più “trascendentale”? Non è poi così difficile arrivare al nocciolo di una frase che potrebbe giustamente allarmare i non addetti (tra i quali, in questo caso, vorrei potermi collocare a mia volta): quel “trascendentale” è lì per dirci che non dobbiamo confondere fenomenologia con fenomeno (o con qualcosa di semplicemente fenomenico) perché ciò che viene messo in gioco è l’idea di soggetto e di soggettività nella sua concretezza non superficiale.
Per mantenere o ritrovare il suo carattere fenomenologico, questa idea non dovrà essere soltanto la meno idealistica, categoriale, metafisica possibile, perché non basta che la concretezza equivalga a ciò che è empirico, ma dovrebbe riuscire a dar corpo a una soggettività che non è mai fissabile attraverso un’etichetta. Perciò il termine fenomenologia risulta essenziale per mettere in primo piano proprio il problema del soggetto.
Aggiungo, per far capire l’importanza di tale problema, che il soggetto che viene così evocato non è mai traducibile in un concetto chiuso, di cui si possa costruire una scienza comunemente intesa. È piuttosto, come diceva lo stesso Husserl, un “enigma” che non possiamo cessare di sondare e di rilanciare, qualcosa che ha a che fare con l’insieme dei nostri vissuti e con la nostra stessa vita.
Qualcosa che fa tutt’uno con lo stile di vita di ognuno di noi, come ha mostrato con chiarezza Paci nelle pagine del suo personale Diario fenomenologico (ora riedito da Orthotes). E proprio da qui discende l’intero corredo critico di “aut aut”, cioè - per indicarne solo qualche aspetto - l’importanza della “sospensione del giudizio” (la famosa epoché, rilanciata anche da Franco Basaglia nella sua critica alla psichiatria ufficiale), l’importanza di non isolare mai il sapere dall’etica con il rischio di svuotare il “gesto” facendolo diventare unicamente una tecnica di pensiero, o anche l’importanza di conservare a ogni costo l’apertura del dubbio e la possibilità del “sempre di nuovo”.
Perché questo gesto non può essere mai considerato un atteggiamento esclusivamente individuale? La tonalità “politica” della rivista, presente fin dal suo inizio, può ritrovarsi nella risposta a quest’ultima domanda, nel senso che non si dà soggettività senza intersoggettività, cioè che nel vissuto personale è sempre presente e attiva l’esperienza dell’“altro” ed è quindi comunque decisiva un’esperienza del noi.
Senza il compito dello stare assieme in una comunità possibile e necessaria di soggetti, il gesto fenomenologico perde il suo significato, letteralmente si annulla nel suo senso e nei suoi obiettivi. Siamo ancora lontani da questo telos, dall’impegnarci seriamente nella pratica di una simile finalità, e allora si comprende perché il tragitto che “aut aut” ha iniziato fin dal primo fascicolo non sia affatto esaurito.
[articolo uscito in versione ridotta su “La Stampa” il 20 settembre 2021]
*Fonte: Aut Aut, 23/09/2021
NOTA:
L’ENIGMA DEL SOGGETTO E LA PROVA DELL’ESISTENZA DI DIO. Note su un dialoghetto "platonico" diffuso in rete:
- Nel pancione di una mamma c’erano due bambini.
 Uno chiese all’altro: "Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?"
Uno chiese all’altro: "Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?"
 L’altro rispose: "Certo! Deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi". "Sciocchezze" disse il primo "non c’è vita dopo il parto! Che tipo di vita sarebbe quella?"
L’altro rispose: "Certo! Deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi". "Sciocchezze" disse il primo "non c’è vita dopo il parto! Che tipo di vita sarebbe quella?"
 Il secondo riprese: "Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. Forse potremo camminare con le nostre gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora".
Il secondo riprese: "Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. Forse potremo camminare con le nostre gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora".
 Il primo replicò: "Questo è assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale è tutto quello di cui abbiamo bisogno...e poi è troppo corto. La vita dopo il parto è fuori questione".
Il primo replicò: "Questo è assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale è tutto quello di cui abbiamo bisogno...e poi è troppo corto. La vita dopo il parto è fuori questione".
 Il secondo continuò ad insistitere: "Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo".
Il secondo continuò ad insistitere: "Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo".
 Il primo contestó: "Sciocchezze, e inoltre, se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel postparto non c’è nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Il parto non ci porterà da nessuna parte".
Il primo contestó: "Sciocchezze, e inoltre, se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel postparto non c’è nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Il parto non ci porterà da nessuna parte".
 "Beh, io non so" disse il secondo "ma sicuramente troveremo la mamma e lei si prenderà cura di noi".
"Beh, io non so" disse il secondo "ma sicuramente troveremo la mamma e lei si prenderà cura di noi".
 Il primo rispose: "Mamma? Tu credi davvero alla mamma? Questo si che è ridicolo. Se la mamma c’è, allora, dov’è ora?"
Il primo rispose: "Mamma? Tu credi davvero alla mamma? Questo si che è ridicolo. Se la mamma c’è, allora, dov’è ora?"
 Il secondo riprese: "Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere".
Il secondo riprese: "Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere".
 Riprese il primo: "Beh, io non posso vederla, quindi, è logico che lei non esiste".
Riprese il primo: "Beh, io non posso vederla, quindi, è logico che lei non esiste".
 Al che il secondo rispose: "A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri ad ascoltare veramente, si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da lassù".
Al che il secondo rispose: "A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri ad ascoltare veramente, si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da lassù".
 Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l’esistenza di Dio.
Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l’esistenza di Dio.
USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO” (KANT).
COSA PENSANO I due BAMBINI nella pancia della madre "della VITA DOPO IL PARTO"? Ma l’autore "scrittore" di questo "bel" testo (sopra) ha mai sollecitato i "due bambini" a pensare sul come sono ’arrivati’ là dove sono, su come nascono i bambini?, e ha mai visto il Sole? O vive ancora nel pancione della Mamma-Terra, nella caverna di Platone (ama il mondo chiuso e la claustrofilia) e, per il trauma della nascita, si è sempre rifiutato di aprire gli occhi alla luce del Sole e vedere la Terra dalla Luna, dallo spazio?!
"ACHERONTA MOVEBO" (IL "MUOVERE LE ACQUE INFERNALI" DI FREUD) E AFFRONTARE IL TRAUMA DELLA NASCITA (OTTO RANK): SAPERE AUDE! ("IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA" DI KANT) !
Senza la critica di Kant del sogno dell’amore cieco e zoppo della ragion pura (di Socrate/Platone) non si può riconoscere a Diotima piena cittadinanza né nell’Accademia né nella Polis. La logica della tragedia (Edipo) porta davvero la peste!
 La Sibilla Delfica (dell’oracolo di Apollo) a Socrate disse la verità, ma la storiografia ha preferito credere al sogno della nascita del cigno e alla storia di Platone, figlio di Zeus / Apollo!
La Sibilla Delfica (dell’oracolo di Apollo) a Socrate disse la verità, ma la storiografia ha preferito credere al sogno della nascita del cigno e alla storia di Platone, figlio di Zeus / Apollo!
 Nietzsche perché ha scavato nella nascita della tragedia? Freud cosa cercava a Tebe?! Come Edipo, già a partire dal caso Dora, chiarirsi le idee sulla morte e uccisione del padre ("Interpretazione dei sogni") e sul desiderio incestuoso nei confronti della #madre, fare luce su "L’uomo #Mosè" e sull’esistenza di "Dio"! Con Dante e come Dante ha avuto il coraggio di agitare le acque infernali e uscirne: a Londra, è arrivato!
Nietzsche perché ha scavato nella nascita della tragedia? Freud cosa cercava a Tebe?! Come Edipo, già a partire dal caso Dora, chiarirsi le idee sulla morte e uccisione del padre ("Interpretazione dei sogni") e sul desiderio incestuoso nei confronti della #madre, fare luce su "L’uomo #Mosè" e sull’esistenza di "Dio"! Con Dante e come Dante ha avuto il coraggio di agitare le acque infernali e uscirne: a Londra, è arrivato!LA QUESTIONE DEL SOGGETTO, IL TRAUMA DELLA NASCITA, E LA VITA DOPO IL PARTO.
"OTTO RANK, IL DOPPIO E LA PSICOANALISI" (alcune mie note, in "Psicoterapia e Scienze Umane", 4, 1980, pp. 75-79) ). Se Freud osò agitare e rompere le acque infernali ("Acheronta movebo) e riuscì a portare alla luce la psicoanalisi, è da dire, però, che non fu altrettanto attento a riconoscere il trauma della nascita e a portarsi oltre le colonne d’Ercole dell’Edipo.
Andando in America, nel 1909, Freud era ancora fiducioso e ottimista nella possibilità della psicoanalisi di affrontare il diffondersi della peste; ma nel 1924, con la sua parziale comprensione del complesso di Edipo, non riesce ad accogliere la sollecitazione di Otto Rank a riflettere sul trauma della nascita e l’avvenire della sua stessa creatura comincia a oscurarsi.
Elvio Fachinelli (1928-1989) ha saputo vincere la Claustrofilia (1983), si è portato "Sulla spiaggia" (1985), ma l’ Accademia platonica della Filosofia come della Psicoanalisi ha continuato a chiudere un occhio su come nascono i bambini. E il platonismo continua a oscurare il cielo...
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- SIGMUND FREUD, "SULLA SPIAGGIA" (A MARESFIELD), GUARDA COMPIACIUTO IL "CIELO STELLATO".4 gennaio 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA, ANTROPOLOGIA CULTURALE, ARTE E PSICOANALISI...
L’UOMO VITRUVIANO, LA DIGNITÀ DELL’UOMO, E LA DIGNITÀ DELLA DONNA.
In memoria di Franca Ongaro Basaglia e Ida Magli....
Con l’anno nuovo e l’arrivo dei Magi presso la "sacra famiglia", è proprio bene richiamare l’attenzione sulle parole del Salmo (8: 4-8): “Che cos’è l’uomo che tu n’abbia memoria? e il figliuol dell’uomo che tu ne prenda cura! Eppure tu l’hai fatto poco minor di Dio..”; e, lodevolissimamente, sollecitare a riflettere sul tema e sul significato di "uomo" e di "figliuol dell’uomo".
Ma di quale uomo si parla? Si parla solo di andrologia?
Riprendendo "l’uomo vitruviano", Leonardo ha fatto un disegno, ma l’industria "culturale" di ieri e di oggi ne ha fatto un mito, che associato alla generica e generale parola di "uomo" e "figlio dell’uomo" ha guidato e guida ancora l’immaginazione filosofica, teologica, artistica dei "diritti dell’uomo"!
Ma cosa "nasconde" questa mitizzazione e idolatrizzazione dell’ Uomo Vitruviano (dello stesso tempo di Leonardo e Raffaello, vedere l’altra faccia del quadro (1510), quello del Sapiente di Charles de Bouelles.? Semplimente "l’altra metà del cielo" è confinata nello stadio dello specchio, nello stato di minorità.
Luce Irigaray, in occasione dell’ 8 marzo del 2004, sul "Perché il pianeta donna non è stato ancora esplorato a fondo", ricordava: “[...] Mafalda a suo padre che sostiene che “l’occhio di Dio ci vede tutti uguali”: “Ma chi è il suo oculista?” lei gli chiede“.
IL MONDO E’ UNO. Non è più tempo né di conquistatori (il ’vecchio’ gioco di "Freud o Jung?", alla Eduard Glover) né di colonizzati (Cuernavaca). Una antropologia (e una cristologia) al di là dell’orizzonte edipico e della cosmoteandria andrologica (Dante 2021 insegna) è già nata: Giuditta ha tagliato la testa ad Oloferne e la critica della demitizzazione non solo della "nascita dell’eroe" (Otto Rank) ma anche della stessa figura di Freud e delle strutture chiesastiche della psicoanalisi (si vedano le preziose ricerche e il lavoro investigativo di Michele Lualdi) ha aperto porte e finestre sugli infiniti universi...
Dall’alto della mia ignoranza, non è più il tempo di esportazione né di peste né di democrazia! Sigmund Freud da Londra se ne sta "sulla spiaggia" di Maresfield e guarda compiaciuto il cielo stellato (Kant) e sorride: la claustrofilia è finita e ha capito che "la mente estatica" (Elvio Fachinelli) è la via di una formazione cosmica e di un’amicizia stellare...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA: "NEL PRINCIPIO" ("BERESHIT") ERA LA PAROLA ("LOGOS")3 gennaio 2022, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, FILOSOFIA, LOGICA PSICOANALISI E COSTITUZIONE: "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS" (non il Logo di una fattoria).
- La storia delle parole
- Bereshìt. È la prima parola della Torah, in principio. Ma perché c’è la Bet come prima lettera e non l’Aleph? C’è una storiella simpatica nello Zohar: Dio giocò duemila anni con le lettere che presero confidenza con lui. Ognuna di loro chiese di essere la prima. La Tav (l’ultima ed era a forma di croce fenicia inizialmente) iniziò col dire che lei era il sigillo della parola Emet (verità), e si meritava quell’onore. Via via le altre, fino alla Bet che disse che lei indicava il verso giusto del cammino ed era la lettera di Benedizione. A Dio piacque l’idea e scelse Bet. Chiese poi all’Alef perché non avesse cercato di convincerlo e lei rispose "perché non metto in discussione quello che hai già deciso" Dio la osservò e poi le disse "inizierò con Bet, ma tu sarai la prima dell’alfabeto".
DIO E LE LETTERE DELL’ALFABETO. Questa storiella dello Zohar "nasconde" una grande lezione di logica e matematica, antropologia e teologia (e, a mio parere, offre la chiave per meglio capire il senso stesso del riferimento di Baruch Spinoza al detto Homo Homini Deus Est e il messaggio dell’ impresa di Dante Alighieri).
Quando si comincia a contare, da dove bisogna cominciare, per iniziare bene ed essere gà a metà dell’opera?! Chi è che conta e da dove inizia. Perché (come qui, nella storiella dello Zohar) dalla Bet?
Premesso che le lettere dell’alfabeto ebraico sono anche numeri e, quindi, hanno un valore numerico, è opportuno ricordare che alef vale zero (= 0) e che bet vale uno (= 1); e, quando si comincia a contare, si comincia a contare da uno (= 1), appunto, da bet.
Per non perdere la #bussola e, ancor di più, per non lasciarsi sopraffare dalla narcisismica terremotante tentazione di truccare le carte e il conto, però, occorre tenere ben presente che al "Dio" che conta, in un altro testo decisivo della tradizione biblica (Apocalisse di Giovanni), è attribuita la seguente importantissima frase: "Io sono l’alfa e l’omega" (greco koinè: "ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω"). La precisazione è decisiva...
Amore è più forte di Morte (Ct., 8.6). A ben riflettere sull’apocalittica frase, si apre la porta di una chiara #comprensione sul Chi (= X) lega e sa legare "il principio e la fine" (Apocalisse 21:6, 22:13) e, al contempo, sul buon messaggio stesso della "Divina Commedia": "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).
L’alfa (il principio) e l’omega (la fine), e la bet ("la prima lettera dell’alfabeto), la lettera che indica ""il verso giusto del cammino"!
Bet, la lettera di Benedizione ....
LA PIETRA FONDAMENTALE E LA PIETRA ANGOLARE: "ECCE HOMO". Ogni Uno (=1), Ognuno (ogni Eva e ogni Adamo, ogni Maria e ogni Giuseppe), Ogni Essere umano (Everyman, così Dante Alighieri per Ezra Pound), è antropologicamente e linguistica-mente la lettera dell’alfabeto, la Bet, la lettera di Benedizione e Bereshìt, la Parola che sta "Nel Principio": "Nel Principio era il Logos". L’amor che move il sole e le altre stelle....
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LETTERATURA E FILOSOFIA:DANTE 2021. «Dio cammina anche tra le pentole»(Teresa d’Avila).29 dicembre 2021, di Federico La Sala
LETTERATURA E FILOSOFIA...
DANTE 2021: "IL BUON DIO STA NEL DETTAGLIO" (diceva Aby Warburg)!
- "S. Teresa d’Àvila e Cervantes" (Fidel Garcia Martinez).
- [Sancho Panza]: “Non muoia, signor padrone, non muoia. Accetti il mio consiglio e viva molti anni, perché la maggior pazzia che possa fare un uomo in questa vita è quella di lasciarsi morir così senza un motivo, senza che nessuno lo ammazzi, sfinito dai dispiaceri e dall’avvilimento.”
- (Miguel De Cervantes), Don Chisciotte della Mancia.
ANTROPOLOGIA E "MISTICA". All’epoca di Miguel de Cervantes (1547-1616), «Dio cammina anche tra le pentole» (Fondazioni V,8): la cavalleria è finita e comincia l’avventura di una nuova fenomenologia dello spirito (già oltre la logica del Padrone e del Servo di Hegel), quella di Teresa d’Avila (1515-1582): sulle ali di Michelangelo (1475-1564) , ella sollecita a ripensare l’incarnazione e la sacra famiglia e comincia a indicare, con sibille e profeti, un cammino antropologico inedito - al di là della tragedia!
La storia non la fanno i soliti "quattro profeti" (si cfr. la scheda sul "Tondo Doni" della Galleria degli Uffizi e si osservino bene le figure nella cornice del quadro).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA. La traccia di una memorabile lezione carmelitana a Contursi Terme (Salerno).17 dicembre 2021, di Federico La Sala
#DIVINA COMMEDIA (#DANTE 2021):
#MESSAGGIO EVANGELICO
E
#MAGISTERO ANTROPOLOGICO
A #FUTURA MEMORIA.
Per una #Cristologia
non andrologica,
lezione di #Teresa d’Avila,
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- STORIOGRAFIA, ANTROPOLOGIA, E ARCHEOLOGIA. "La preistoria è donna. Una storia dell’invisibilità delle donne". Un lavoro della storica Patou-Mathis (di E. Castagna).17 dicembre 2021, di Federico La Sala
Tendenze.
Riscrivere la preistoria al femminile? Sì, ma volerlo non basta
Secondo la storica Patou-Mathis la lettura standard della società paleolitica rispecchia quella dell’Europa del XIX secolo che la scoprì: una ricerca ancora tutta da costruire
di Edoardo Castagna (Avvenire, giovedì 16 dicembre 2021)
- Ricostruzione di vita quotidiana al tempo dei Cro-Magnon (Paleolitico superiore, circa 25.000 anni fa) - Tips
Come negli studi post-coloniali, anche in quelli che potremmo definire post-maschilisti la pars destruens sembra essere ancora molto più convincente della construens. È senz’altro condivisibile la ricerca di un approccio che in ogni ambito - dalla storia alla sociologia, dall’arte alla filosofia e perfino alla scienza - cerchi di superare pre-giudizi e pre-comprensioni derivanti di un’impostazione “maschiocentrica” (neologismo brutto ma non privo di efficacia), così come lo è, nell’ambito appunto del postcoloniale, l’ambizione di deoccidentalizzare il pensiero. È il grande filone che viene definito, in senso esteso, degli studi subalterni, e che da tempo si sta muovendo in varie direzioni in tutti i campi del sapere.
Inclusa l’archeologia, come ben esemplifica l’ultimo lavoro della storica francese Marylène Patou-Mathis: in La preistoria è donna. Una storia dell’invisibilità delle donne, recentemente pubblicato da Giunti nella collana “i fondamenti” (pagine 290, euro 20,00), la specialista del comportamento dei neandertaliani parte da un assunto difficilmente contestabile: «La preistoria è una scienza giovane, che fa la sua comparsa soltanto a metà dell’Ottocento. È probabile che i ruoli attribuiti ai due sessi nei primi testi di questa nuova disciplina abbiano a che vedere più con la realtà dell’epoca che con quella del tempo delle caverne». Per lungo tempo in effetti è stata data per acquisita una bipartizione dei ruoli, con l’uomo dedito alla caccia e alla guerra e la donna alla cura della famiglia, che proiettava sul Paleolitico esattamente la differenziazione sociale dell’Ottocento occidentale, a sua volta erede di una lunga storia del pensiero. Si tratta di una distorsione prospettica che trova esatti correlativi anche in altre scienze umane; per esempio, sempre nell’Ottocento, era prassi comune interpretare la gerarchia del potere (politico ed economico) allora vigente come un riflesso di un’asimmetrica gerarchia “naturale” dei popoli - naturalmente con i bianchi europei in posizione dominante.
In campo archeologico, il nocciolo dell’argomentazione della Patou-Mathis è che non abbiamo alcuno strumento per attribuire specificamente a uomini o a donne le attività preistoriche di cui siamo a conoscenza grazie ai reperti, dalla caccia alle pitture rupestri. È la convincente pars destruens, appunto: tuttavia, nella pars construens, la ricerca di tracce che possano consentire un pieno ribaltamento di prospettiva appaiono rade e sparse, comunque ancora insufficienti. Se è interessante rimarcare come in alcune pitture rupestri raffiguranti mani in negativo, quelle riconducibili a donne siano almeno quante quelle maschili, oppure rilevare come su alcune ossa femminili compaiano segni di traumi che possono far pensare all’uso di armi, nella maggior parte dei casi i reperti non consentono attribuzioni né a un genere né all’altro. Né convince il ricorso a testimonianze molto più tarde, come quelle celte o scite del V secolo a.C., tentato dalla storica. La Patou-Mathis sembra essere consapevole dei rischi di ideologizzazione che il suo discorso deve affrontare, criticando apertamente alcuni eccessi anche della sua disciplina negli anni del femminismo nascente. Tuttavia, liquida forse un po’ troppo sbrigativamente concetti chiave dell’archeologia del secondo Novecento, come quello della Dea Madre sostenuto con argomentazioni assai forti e convincenti da Marija Gimbutas, come «un’ipotesi tra le altre».
Tuttavia una revisione della nostra comprensione del passato, e del differente ruolo che possono avere avuto le donne nel suo divenire, è più che opportuno, necessario. La ricerca non ha mai un punto di arrivo definitivo, è un pendolo in continua oscillazione. La ricerca di un punto di sintesi o di equilibrio, che rimane sempre provvisorio e parziale, è continua: fino a quando una nuova oscillazione del pendolo non costringa a rimettere tutto in discussione. E questo è il carattere infinito della ricerca.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL QUADRO, LA CORNICE, E LA FILOLOGIA: IL "TONDO DONI" E "QUATTRO PROFETI".23 novembre 2021, di Federico La Sala
#STORIA #ARTE #ARTERAPIA #FILOSOFIA #FILOLOGIA:
IL #QUADRO E LA #CORNICE DEL #TONDO DONI.
UNA #QUESTIONE DI #ANTROPOLOGIA E DI #PRESEPE ...
Ad #Arte? Se nella #cornice del #TondoDoni, "sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di #quattro profeti" (Galleria degli Uffizi), e non quelle di #due profeti e di due #sibille, cosa si può capire dei #due soli di #Dante e del racconto della #Cappella Sistina?:
Michelangelo dipinse questa #SacraFamiglia per #AgnoloDoni, mercante fiorentino il cui prestigioso matrimonio nel 1504 con Maddalena Strozzi avvenne in un periodo cruciale per l’arte a #Firenze di inizio secolo. La compresenza in città di #Leonardo, #Michelangelo e #Raffaello apportò uno scatto di crescita al già vivace ambiente fiorentino, che nel primo decennio del secolo visse una stagione di altissimo fervore culturale.
 (...) La #cornice del #tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la #testa di #Cristo e quelle di #quattro #profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.
(...) La #cornice del #tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la #testa di #Cristo e quelle di #quattro #profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PER UN’ALTRA "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" DI MICHELANGELO E DEL SUO RACCONTO NELLA CAPPELLA SISTINA (di Federico La Sala).11 novembre 2021, di Federico La Sala
"QUATTRO" ... QUATTRO PROFETI? IL "TONDO DONI" E LA TRACCIA PER UN’ALTRA "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" DI MICHELANGELO E DEL SUO RACCONTO NELLA CAPPELLA SISTINA...
di Federico La Sala (Le parole e le cose, 9 novembre 2021)
AL FINE DI UN’INTERPRETAZIONE non riduttiva del "Tondo Doni" di Michelangelo è opportuno fare bene attenzione alla cornice lignea che sta intorno.
NELLA SCHEDA DELLA Galleria degli Uffizi, relativa alla Sacra famiglia, detta “Tondo Doni” di Michelangelo #Buonarroti è scritto:
- "La cornice del tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi." (*).
"QUATTRO PROFETI": MA "COME NASCONO I BAMBINI"?!
Se il tema è quello della nascita di Cristo ("il Figlio dell’Uomo"), il discorso di Michelangelo è semplicemente chiaro e tondo e già anticipa alla grande il programma della Sistina: nella cornice vi sono raffigurate la testa di Cristo (in alto) e ai lati le teste di due profeti e due sibille e, al centro (il fuoco del cammino dell’intero genere umano), Gesù, il "Figlio dell’Uomo" ("Ecce Homo" - ogni essere umano, come da antropologia e filologia), con le figure dei genitori, il "profeta" Giuseppe e la "sibilla" Maria.
L’Uomo non è più un Lupo! L’uomo è per l’uomo un Dio ("Homo homini deus est"), come ricorderà Spinoza nella sua "Etica".
Sacra famiglia, detta “Tondo Doni”
Michelangelo Buonarroti (Caprese 1475 - Roma 1564) *
Michelangelo dipinse questa Sacra Famiglia per Agnolo Doni, mercante fiorentino il cui prestigioso matrimonio nel 1504 con Maddalena Strozzi avvenne in un periodo cruciale per l’arte a Firenze di inizio secolo. La compresenza in città di Leonardo, Michelangelo e Raffaello apportò uno scatto di crescita al già vivace ambiente fiorentino, che nel primo decennio del secolo visse una stagione di altissimo fervore culturale. Agnolo poté quindi celebrare le sue nobili nozze e la nascita della sua primogenita con alcune delle massime espressioni di questa eccezionale fioritura: i ritratti dei due coniugi dipinti da Raffaello, e il tondo di Michelangelo, che è l’unico dipinto certo su tavola del maestro.
Michelangelo aveva da poco studiato le potenzialità del formato circolare, molto apprezzato nel primo Rinascimento per gli arredi devozionali domestici, nei marmi del “Tondo Pitti” (Museo Nazionale del Bargello) e del “Tondo Taddei” (Royal Academy di Londra): in entrambi i casi la Madonna, il Bambino e San Giovannino occupano prepotentemente tutta la superficie del rilievo. Anche il “Tondo Doni” è concepito come una scultura, in cui la composizione piramidale del gruppo si impone su quasi tutta l’altezza e la larghezza della tavola. E’ stato notato che, nella sua compattezza, il gruppo ricorda la struttura di una cupola, tuttavia animata al suo interno dalle torsioni dei corpi e dalla concatenazione dei gesti per il passaggio delicatissimo del Bambino dalle mani di San Giuseppe a quelle della Vergine.
Questa composizione così articolata ed espressiva scaturisce dalla conoscenza e dallo studio da parte di Michelangelo dei grandi marmi del periodo ellenistico (III-I secolo a. C.), contraddistinti da movimenti serpentinati e forte espressività, che stavano emergendo dagli scavi delle ville romane. Alcuni di questi importanti ritrovamenti, come l’Apollo del Belvedere e il Laocoonte scavato nel gennaio 1506, sono citati puntualmente nel quadro fra le figure di nudi in piedi, appoggiati a una balaustra (rispettivamente a sinistra e a destra di San Giuseppe).
La presenza di Laocoonte permette di avanzare per il tondo una datazione che coincide con la nascita di Maria Doni (settembre 1507). I giovani nudi, la cui identificazione è complessa, sembrano rappresentare l’umanità pagana, separata dalla Sacra Famiglia da un basso muretto che rappresenta il peccato originale, oltre il quale c’è anche San Giovannino, che favorirebbe l’interpretazione battesimale del dipinto.
La cornice del tondo, probabilmente su disegno di Michelangelo è stata intagliata da Francesco del Tasso, esponente della più alta tradizione dell’intaglio ligneo fiorentino. Vi sono raffigurate la testa di Cristo e quelle di quattro profeti, circondate da grottesche e racemi, in cui sono nascoste, in alto a sinistra, delle mezze lune, insegne araldiche della famiglia Strozzi.
* GLI UFFIZI, 11.11.2021 (ripresa parziale)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA: "DESIDERIO DI CONOSCERE E DIVIETO DI SAPERE". Quello che sappiamo da sempre: che la conoscenza e il piacere sono legati tra di loro e con la vita (Paul C. Racamier)..2 novembre 2021, di Federico La Sala
DESIDERIO DI CONOSCERE E DIVIETO DI SAPERE ∗
di Paul C. Racamier∗∗
Qualche disturbo di voce mi impedisce purtroppo di presentare direttamente il mio breve lavoro. Mi dispiace anche perché apprezzo molto queste Giornate di Studio. Tuttavia abbiamo la fortuna di ascoltare il mio contributo letto da una voce amica che sarà così gentile da utilizzare la sua voce per ringraziarvi dell’attenzione.
D’altra parte ho solo alcune annotazioni da presentarvi che spero non saranno troppo dispersive. Non stupitevi che questi appunti siano l’eco delle mie preoccupazioni attuali.
Sappiamo bene che il desiderio della conoscenza si alimenta ad una sorgente essenziale, cioè al desiderio di conoscere i segreti della sessualità, partendo da quella dei genitori. Tornerò alla fine sulla questione dei segreti.
Questa curiosità essenziale si origina quindi nella camera dei genitori. Tuttavia la fonte non basta. Essa necessita anche - permettetemi una o due immagini alla mia maniera - di uno spazio e di un letto. Lo spazio consiste in un’area di discrezione che avvolge l’attività sessuale dei genitori in maniera da svolgere una funzione di "para-eccitazione". Senza questa area di discrezione - che é quasi un’area di transizione - non ci sarebbe spazio nel bambino per fabbricare il fantasma e tesserlo; senza questa area di para-eccitazione la sessualità dei genitori sarebbe davvero solo una seduzione invadente, un’effrazione traumatica, come venne descritta da Freud e come la si può incontrare ancora oggi nella pratica clinica.
In tal caso la psiche del bambino viene portata, direi perfino trascinata nel temibile ambito dove il sessuale non psichizzato rimane allo stato grezzo; un ambito dove non rimane spazio per il lavoro dello psichico sul sessuale; un ambito la cui espressione ultima è costituita secondo me dall’incesto e in modo più ampio dall’incestualità, cioé dal corto-circuito e dall’esclusione di qualsiasi elaborazione lipidica, dato che l’incestuale non é altro che il colmo dell’anti-libidinale.
Non anticipiamo troppo. Ma vale la pena di porsi da adesso una domanda: se il desiderio di sapere é per l’uomo un’estensione del desiderio di conoscere i segreti del sesso, bisogna chiedersi a quale condizione tale estensione sia possibile. Come mai questa curiosità si estende ad altri tipi di sapere? Perché ciò avvenga è indispensabile che le sia lasciato lo spazio. Bisogna che quell’area di elaborazione a cui accennavo sia preservata. Ora, l’effrazione genitoriale, se avviene, è traumatica nel senso che invade o distrugge quest’area di discrezione. Perché si sviluppi la voglia di sapere, bisogna prima che il sapere non sia stato piantato come un chiodo nella testa e nel corpo del bambino. Il sapere, per crescere, ha bisogno di essere avvolto da un materasso di silenzio.
Una fonte, dicevo. A questa fonte serve un letto. Questo letto è quello che io chiamo il pensiero delle origini. Mi sembra che questo pensiero giochi una parte essenziale nello sviluppo armonico della vita psichica. Non si limita affatto alla conoscenza o al fantasma delle nostre origini; non consiste nella ricerca delle cause. Rappresenta un’intera modalità del funzionamento psichico e sono tentato di situarla al di sotto dei processi primario e secondario del pensiero senza i quali niente si può apprendere né sapere.
Con "pensiero delle origini" intendo la capacità fondamentale e indelebile di provare, fantasticare, concepire e pensare che ogni cosa, ogni conoscenza, ogni persona, abbiano delle origini che a loro volta hanno altre origini, e così di seguito. L’origine è quello che precede: è a monte. Non ci sono limiti alle origini ma il pensiero delle origini non corrisponde all’onnipotenza perché è riuscito a passare attraverso la strettoia del lutto originario che inaugura la rinuncia all’onnipotenza. E’ lì che inizia il filo della vita e questo filo sarà vissuto come una creazione personale, o piuttosto, secondo il mio vecchio amico Antœdipo, come una coproduzione dei genitori e di se stesso.
Perdonatemi questa escursione in concetti che sembreranno complessi, a meno che vi siano familiari. Tuttavia questa deviazione ci porta a due affermazioni molto semplici.
1. Il bambino o l’adulto che non è riuscito a confezionarsi un pensiero delle origini, che quindi non ha rinunciato alla conoscenza assoluta e alla padronanza onnipotente delle proprie origini e della propria vita, probabilmente non avrà né la voglia di sapere né la disponibilità interiore, area di silenzio di cui bisogna disporre nel proprio mondo interno, necessaria per investire in nuove conoscenze. Tale è il caso dei soggetti con patologia narcisistica grave. Non sopportano di imparare perché in ogni conoscenza nuova vedono meno quello che avrebbero da guadagnare di quello che, essendogli sconosciuto, gli fa difetto e ferisce il loro irresistibile fantasma di onnipotenza e onniscienza. Accettando di imparare sembrerebbe loro di derogare a questo fantasma; tant’è che per imparare bisogna prima ignorare. Ora l’ignoranza non è altro che una vergognosa debolezza quando la si guarda dall’alto di un narcisismo intollerante. I narcisisti più "accesi" hanno una vera anti-voglia di imparare.
2. L’altro punto è più temerario. Non mi sembra azzardato ritenere che l’imparare e il sapere costituiscano già un atto di creazione. Atto modesto, certo, ma fondamentalmente della stessa natura della creazione vera e propria, e che presenta alcune delle sue caratteristiche principali. Se non è una creazione vera e propria, fa parte almeno della stessa famiglia. Ogni cosa appresa ha infatti questo carattere sia personale che universale che nella sua ambiguità, è propria di ogni cosa creata.
 Come ogni creazione nuova, ogni sapere nuovo provoca un ampliamento ed
un’estensione dell’io. Non da ultimo, l’acquisizione del sapere e anche la sua trasmissione, è
creativa nel senso che è il frutto di una coproduzione. Per imparare bisogna prendere e offrire;
non per caso il verbo apprendere (in francese apprendre) può intendersi secondo due modi
diversi: si può insegnare a qualcuno e apprendere da qualcuno; due correnti pulsionali avverse e
complementari che si completano strettamente in questa attività.
Come ogni creazione nuova, ogni sapere nuovo provoca un ampliamento ed
un’estensione dell’io. Non da ultimo, l’acquisizione del sapere e anche la sua trasmissione, è
creativa nel senso che è il frutto di una coproduzione. Per imparare bisogna prendere e offrire;
non per caso il verbo apprendere (in francese apprendre) può intendersi secondo due modi
diversi: si può insegnare a qualcuno e apprendere da qualcuno; due correnti pulsionali avverse e
complementari che si completano strettamente in questa attività.Vediamo qui come le strade si incrociano. Se é vero che l’esistenza di ciascuno di noi è il frutto di una coproduzione, dato che la vita ci è stata data ma non cessa di sgorgare in noi stessi, se quindi questo fantasma di fondazione è il perno delle origini; e se questo pensiero delle origini è realmente il letto del desiderio e della capacità di apprendere; se infine l’atto di apprendere è in se stesso una sorta di creazione, allora si vede bene che i nostri concetti si raggiungono nel sapere.
Se mi dite che la conoscenza di se stesso attraverso la relazione psicoanalitica è in se stessa il frutto di una coproduzione, ne converrò sicuramente. Se dite che all’origine dei disturbi del sapere e, più in generale, all’origine delle occlusioni gravi della vita psichica c’è uno sbarramento di vecchia data sul pensiero delle origini, ne converrò anche.
Ma basta con queste grandi idee. Volevo parlarvi del piacere. E per quello vorrei parlarvi dei segreti. Esistono due tipi di segreti. Vi sono i segreti libidici, come i segreti dell’alcova e i segreti di corridoio, che parlano sempre del piacere e che presentano il felice paradosso di circolare tra le generazioni rimanendo nell’ambito del privato: quei segreti sono dei serbatoi di fantasmi, delle macchine per pensare e degli stimoli del sapere. Il culto della verità naviga nelle stesse acque di quello del sapere. Li sospetto entrambi di trarre una forza considerevole dall’auto-erotismo: è proprio quando la verità, che non si incontra comunemente per strada, diventa un oggetto di piacere che l’io le corre dietro: non è vero tra l’altro che la verità viene descritta solitamente come una signora che, quando esce, va in giro svestita?
Al contrario esistono dei segreti anti-libidici. Essi impediscono l’accesso alla conoscenza, alla comprensione, allo scambio e al pensiero così come alla parola. Sono dei segreti inibitori. Di generazione in generazione esercitano i loro effetti paralizzanti. Li incontrerete dappertutto dove regna l’impero incestuale. Ciò significa che li incontrerete spesso. Il regno del segreto esercita un’influenza della peggiore specie. Si tratta di un divieto molto crudele e molto primitivo che ostacola ogni sapere per impedire la scoperta di alcuni saperi. Questo divieto di dire, questo divieto di sapere, questo divieto di pensare si esercita non tramite l’Io ma direttamente sull’Io, nel cuore stesso dell’Io. Perciò penso che sia molto diverso dal Super Io edipico.
Si potrebbe dire che il Super Io edipico prende l’io da parte e gli ingiunge: "Tu, Io, dirai ai tuoi amichetti, i fantasmi erotici, di tenersi tranquilli e di non fare troppo baccano in fondo alla classe". E l’Io obbedisce più o meno. Ecco come si comporta un Super Io di buona compagnia.
In un regime incestuale e sotto l’impero di un narcisismo abusivo e perforante, come quello che abbiamo visto trasgredire le aeree di transizione e di para-eccitazione di cui l’Io ha bisogno per svilupparsi, succede tutt’altro; sembra che una forza pressante prema l’Io da tutte le parti, gli prenda la testa, gli tappi gli occhi e le orecchie e gli imponga gradualmente un divieto assoluto di imparare, e perfino di pensare. "Se sai, dice, se vuoi sapere, se pensi, allora mi fai morire e muori".
Il Super Io edipico vieta l’incesto ma ne lascia passare il desiderio e il fantasma; lascia anche passare il desiderio di sapere e il piacere di desiderare; all’opposto l’oppressione appena descritta e che chiamerei volentieri, usando un neologismo, un super-anti-io, questa oppressione crudele permette l’incesto ma non lascia spazio al desiderio nonché al sapere, alla conoscenza e al pensiero.
Così viene confermato dal suo contrario quello che sappiamo da sempre: che la conoscenza e il piacere sono legati tra di loro e con la vita. La mia lettrice ed io vi ringraziamo per l’attenzione.
∗ Desiderio di conoscere e divieto di sapere di Paul C. Racamier Gennaio - Giugno 2002. Ringraziamo la Sig.ra Racamier per la gentile concessione alla pubblicazione di questo lavoro e l’Editore del “Bulletin de l’ACIRP” che ha pubblicato gli Atti del Convegno “Envie de savoir, envie d’apprendre”, Besançon, 23 marzo 1996.
∗∗ Traduzione in italiano a cura di Josiane Lots.
Fonte: Quaderno di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (2002) Vol. 15, pp. 11-15. 2
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---- LA FILOLOGIA, LA POLITICA DELL’EUCARESTIA, E L’AGENDA DEL G20,30 ottobre 2021, di Federico La Sala
LA POLITICA DELL’EUCARESTIA ... E "LA QUARTA «P» (QUELLA DELLA «PACE») CHE MANCA ALL’AGENDA DEL G20"
- Francesco-Biden e la diplomazia dell’eucarestia. Il presidente Usa: "Il Papa mi ha detto che posso accedervi". A breve i vescovi americani avrebbero dovuto decidere se negargliela per la sua posizione sull’aborto
- "A pochi giorni dal momento in cui i vescovi americani dovevano decidere se negare la comunione al presidente degli Stati Uniti per la sua posizione su una legge - in questo caso quella sull’aborto - il papa è intervenuto, e ha compiuto un atto primaziale che ha importanti conseguenze ecclesiologiche e politiche: ha detto a Joe Biden di accedere alla eucarestia in pace e gli ha concesso di rendere nota questa parte del loro colloquio [...] Tutto bene anche per i nodi politici, che non sono quelli del clima e dei vaccini che sono ovvia materia G20 [...] Tant’è che alla fine Biden ha elogiato il Papa come «uomo della pace»: la quarta «P» che accanto a People Planet Prosperity manca all’agenda del G20" (di Alberto Melloni, La politica dell’eucarestia, 30 ottobre 2021)
- ALBERTO MELLONI: "Sai qual è la differenza fra uno storico e un grande storico? Uno storico è uno che offre risposte ai problemi storici. Un grande storico è uno che scopre problemi storici" (Arnaldo Momigliano a Massimo Firpo).
#ANTROPOLOGIA #TEOLOGIA #STORIA E #FILOLOGIA. "La #politica dell’#eu-#carestia" - #oggi (la @repubblica , #30ottobre2021) - "segnala" un #problema di #dottrina, di #interpretazione, e di #storiografia di #lungadurata... quello della #Grazia ("#Charis"). O no? Buon lavoro. Grazie.
Federico La Sala
Scheda
MEMORIA DI LORENZO VALLA:
- Presentazione volume - Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019
Lunedì 24 febbraio [2020], alle ore 11.00, verrà presentato il volume Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019.
Interverranno:
Alberto Melloni, Segretario della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
Antonio Manfredi, Scrittore latino della Biblioteca Apostolica Vaticana
Daniele Conti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
Sarà presente la curatrice del volume.
L’incontro - aperto a tutti gli interessati - si terrà nella Sala dei Seminari dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.
* Fonte: INSR. Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 24 febbraio 2020
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT): "METTERE AL MONDO IL MONDO". Stefano Bartezzaghi. Che cosa è la creatività (di G. Marrone).15 ottobre 2021, di Federico La Sala
LA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT): "METTERE AL MONDO IL MONDO".... *
- “La creatività è una mitologia - scrive - perché conferisce connotazioni di prestigio socialmente condivise; ma è una mitologia anche perché riesce a far convivere - sul piano immaginario - aspetti fortemente contraddittori” (Stefano Bartezzaghi, "Mettere al mondo il mondo", Bompiani, 2021).
Stefano Bartezzaghi. Che cosa è la creatività
di Gianfranco Marrone (Doppiozero, 13 ottobre 2021).
Che cos’è la creatività? Che domanda: è come il tempo per Agostino, o l’arte per Croce: tutti sappiamo di che si tratta, fino a quando non ci chiedono di definirla. Allora scattano i guai. Credevamo di avere le idee chiare in proposito: creativo che uno che inventa qualcosa di nuovo, qualcosa che prima non c’era; una specie di nume in miniatura: Dio ha creato il mondo, ab origine, e noi, qui e ora, non facciamo che maldestramente imitarlo: nelle arti, nella scienza, nel lavoro, nei media, nella vita quotidiana. Ma siamo certi che sia proprio così? Che cosa significa esattamente “nuovo”? e “inventare”? e poi, anche, cos’è questo “qualcosa”? Come dire che, in effetti, non erano idee quelle che avevamo sulla creatività, semmai predisposizioni affettive, ideologie, esercizio inconsapevole di etiche e di estetiche. Niente di logico, di preciso, di coerente. La creatività esiste, si dà a vedere, si pratica, a condizione di dimenticare, di rimuovere, di tenere fra parentesi la sua costitutiva indeterminatezza, se non contraddittorietà, il suo essere più passione che ragione, simbolo e non cosa. Il creativo, sostanzialmente, è un esperto senza saperlo, uno che sa fare ma non sa come lo fa, e soprattutto non sa spiegarlo.
Per questo uno come Stefano Bartezzaghi - semiologo, enigmista, opinionista e, soprattutto, ludico e libero pensatore - sulla creatività si spacca la testa da anni, cercando di accerchiarla da più parti, assediandola e corrodendone progressivamente le fondamenta, per offrirne una qualche convincente plausibilità. A questo tema ha dedicato diversi libri, come, per ricordarne solo alcuni, L’Elmo di Don Chisciotte (2009), Il falò delle novità (2013) e, per antifrasi, Banalità (2019); vi dedica densissimi corsi universitari all’Università Iulm di Milano dove insegna, fra l’altro, “Semiotica della creatività”. Il modo in cui Bartezzaghi si accosta alla questione, generalmente di dominio privilegiato dell’estetica, è difatti schiettamente semiotico.
Creatività, dice adesso nel suo nuovo, recente volume (Mettere al mondo il mondo, Bompiani, pp. 302, € 18), non è una disposizione intellettuale, né una prerogativa psicologica o cognitiva, né tantomeno un’innata capacità più o meno genialoide: molto semplicemente, creatività è una parola. L’indagine che Bartezzaghi conduce nel libro non esamina concetti, giudizi o sillogismi ma, più tecnicamente, modi di dire, usi delle parole e relative frequenze, significati legati a espressioni idiomatiche, luoghi comuni, forme discorsive, e dunque i modi di pensare, con quelle parole e quei segni, il loro senso, in tutti i sensi del termine: semantico, percettivo, direzionale.
Del resto, il titolo del libro, esplicitamente ispirato a un’opera di Alighiero Boetti, ha la forma retorica di un chiasma o forse, meglio, di una mise en abyme: mettere al mondo il mondo è al tempo stesso paradossale (si pone quel che c’è già) ed enfatico (addirittura!), che è appunto la natura intrinseca del fatto semiotico e, più ancora, della creatività. Creare è inventare, certo, ma inventare, sappiamo, vuol dire due cose: generare qualcosa di nuovo (mettere al mondo) ma anche, nel senso latino del termine, ritrovare quel che c’è già (il mondo). L’inventio retorica, diceva già Cicerone e prima di lui i sofisti, non inventa proprio nulla, semplicemente (ri)porta in essere quel che stava sullo sfondo.
Fa giocare nel discorso il sostrato culturale su cui si regge il sapere dell’uditorio, dona al pubblico quel che già conosce: i luoghi comuni, appunto. E analogamente i linguaggi, verbali e non verbali, vivono in una dialettica costante fra regole sociali e parlate individuali, come una sorta di lenzuolo troppo corto tirato ora dal lato della codificazione ora da quello dell’espressività: e quando si spinge da quest’ultimo lembo, quando cioè si indeboliscono le regole prestabilite, emerge la novità, che però, per affermarsi, per avere un senso, deve prima o poi essere accettata dalla massa parlante, finendo per diventare regola, elemento del codice. La creatività è dunque un processo, un divenire, e nemmeno tanto semplice: qualcosa che accade, e a determinate condizioni.
Per articolare più finemente tali questioni, Bartezzaghi propone di immaginare una piramide della creatività, dove alla cima sta l’ambito artistico, poi, più in basso, quello conoscitivo, dopo ancora quello produttivo e infine, alla base, quello mediatico. Una scala decrescente quanto a intensità, crescente quanto ad allargamento del campo - e a fumosità. Come dire che l’essere creativo è faccenda più pertinente, e più rara, nella sfera estetica, un po’ meno, e più frequente, in quella del sapere, ancora meno, ma più riconosciuta, in quella lavorativo-produttiva, fino ad arrivare al discorso mediatico, dove la patente - tanto vaga quanto confusa - di creativo non si nega a nessuno, dal ballerino allo sbaraglio al cuoco dilettante che spadella sudaticcio dinnanzi alle telecamere. Si tratta, dice l’autore, del “livello della strada”, che è poi quello dei social network, là dove, se tutti siamo creativi, nessuno lo è.
Il fatto è che, spiega Bartezzaghi, la creatività è in fin dei conti una perfetta mitologia, poiché del mito ha i due caratteri basilari: la notorietà indiscussa e la risoluzione di alcune contrarietà. “La creatività è una mitologia - scrive - perché conferisce connotazioni di prestigio socialmente condivise; ma è una mitologia anche perché riesce a far convivere - sul piano immaginario - aspetti fortemente contraddittori”. Così, da un lato, se il creativo oggi passa per un figo, capiamo che nella storia e nella geografia umane non è stato sempre così: in intere epoche del passato, per esempio il Medioevo, rispettare la parola delle auctoritates era ben più auspicabile che non dire la propria. D’altro lato, nella creatività convivono, malamente ma ci convivono, caratteristiche opposte: quella soggettiva e quella oggettiva, quella dell’abilità e quella dell’azione, quella della puntualità e quella dell’iteratività e così via. Mettere al mondo il mondo, appunto.
Quel che è certo, è comunque che, per quanto nelle varie epoche e culture le sfumature e le valorizzazioni della creatività mutino e anche di parecchio, il nesso con la creazione divina resta sempre, più o meno palesato, più o meno sacralizzato o secolarizzato. Il creativo è un simulacro del creatore per antonomasia, di quella divinità che, sola, secondo il senso comune, ha saputo inventare il mondo dal nulla, senza cioè metterlo al mondo. Se tutti noi, ognuno con la sua scala di suggestione e di mitismo, riusciamo nel migliore dei casi a creare qualcosa, mettendolo al mondo, è perché ci sentiamo dèi, con evidente hybris, o quanto meno ci proviamo, con esiti che possono anche sfiorare il ridicolo.
 Il genio romantico, ad esempio, era abbastanza convinto di essere una sorta di demiurgo, un essere sedicente superiore che mette in gioco quel che Voltaire chiamava “entusiasmo ragionevole” per produrre mondi nuovi, fantastici e no, che le persone comuni possono a mala pena percepire dall’esterno. La sua tracotanza è dunque assai forte, perché non crede d’essere ispirato dalle muse, come a lungo s’è pensato, ma proprio di essere un dio sceso in terra per plasmare il caos in cosmos.
Il genio romantico, ad esempio, era abbastanza convinto di essere una sorta di demiurgo, un essere sedicente superiore che mette in gioco quel che Voltaire chiamava “entusiasmo ragionevole” per produrre mondi nuovi, fantastici e no, che le persone comuni possono a mala pena percepire dall’esterno. La sua tracotanza è dunque assai forte, perché non crede d’essere ispirato dalle muse, come a lungo s’è pensato, ma proprio di essere un dio sceso in terra per plasmare il caos in cosmos.
 Una narrazione elitaria che è durata parecchio (la si ritrova ancora in Harold Bloom), e che, espandendosi democraticamente e progressivamente, ha finito per diventare lo sberleffo di se stessa. Nei media l’arte sparisce, o quanto meno si ritira in buon ordine, lasciando trasparire soltanto il suo fantasma: la creatività appunto, che, l’abbiamo visto, non si nega più a nessuno. Capiamo così la genesi del principio per cui, come si sente ripetere spesso, uno vale uno.
Una narrazione elitaria che è durata parecchio (la si ritrova ancora in Harold Bloom), e che, espandendosi democraticamente e progressivamente, ha finito per diventare lo sberleffo di se stessa. Nei media l’arte sparisce, o quanto meno si ritira in buon ordine, lasciando trasparire soltanto il suo fantasma: la creatività appunto, che, l’abbiamo visto, non si nega più a nessuno. Capiamo così la genesi del principio per cui, come si sente ripetere spesso, uno vale uno.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Paola Azzolini - Diotima (Research group), "Diotima. Mettere al mondo il mondo: oggetto e oggettività alla luce differenza sessuale", (La Tartaruga edizioni, Milano 1990)
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
- “La creatività è una mitologia - scrive - perché conferisce connotazioni di prestigio socialmente condivise; ma è una mitologia anche perché riesce a far convivere - sul piano immaginario - aspetti fortemente contraddittori” (Stefano Bartezzaghi, "Mettere al mondo il mondo", Bompiani, 2021).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PSICOANALISI E FILOSOFIA: RIPARIRE DA "DUE PERSONE CHE DISCORRONO"!7 ottobre 2021, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA.
SU FREUD: RIPARTIRE DAL PRINCIPIO.
Per comprendere meglio Freud e la sua "rivoluzione psicoanalitica" ("Die Frage der Laienanalyse",“Il Problema dell’analisi profana”: «Non succede nulla di strano, i due si parlano. [...] L’analista dà appuntamento al paziente a una certa ora del giorno, lo lascia parlare, lo ascolta, poi gli parla e gli chiede di ascoltare ciò che ha da dirgli»"), c’è solo da salire su una grande nave, scendere nella stiva, e rileggere il "Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano" di Galileo Galilei: a partire da Copernico, da qui (da questa opera) prende il via la navigazione nell’oceano celeste (Keplero) e si apre la strada alla relatività di Einstein (e non al relativismo culturale dell’antropologia culturale e di Gregory Bateson!), alla rivoluzione copernicana di Kant, e alla rivoluzione di Ferdinand de Saussure, proprio da "due persone che discorrono" ("Corso di Linguistica Generale").
Per andare oltre le robinsonate (Marx) e oltre l’edipo (Freud), e uscire dal #terrapiattismo non c’è altra via: con Elvio Fachinelli, superare la claustrofilia (1983), portarsi "sulla spiaggia" (1985), andare oltre le colonne d’Ercole (di Edipo), e non naufragare (come Ulisse), ma uscire dall’inferno (Dante 2021) e rinascere! O no?!.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DANTE E SAUSSURE: UNA SOLA TEORIA, QUELLA DEI "DUE SOLI". Ipotesi di lavoro
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- QUESTIONE CRISTOLOGICA: LO SPIRITO CRITICO, JEAN-LUC NANCY, IL SOFFIO RIVOLUZIONARIO, E I PALLONI IN ARIA.5 ottobre 2021, di Federico La Sala
L’OPPIO DEI POPOLI E LO SPIRITO CRITICO.
JEAN-LUC NANCY, IL SOFFIO RIVOLUZIONARIO, E I PALLONI IN ARIA...
JEAN-LUC NANCY, in un suo ultimo intervento ad un convegno del maggio scorso, dice: "[...] Quando Marx dichiara che la religione è «l’oppio dei popoli, lo spirito di un mondo senza spirito» [Nella sua "Critica della filosofia del diritto di Hegel"] intende dire da un lato che la religione è un povero surrogato dell’oppio con cui i ricchi si stordiscono, ma anche e allo stesso tempo che c’è da qualche parte uno “spirito” riservato a coloro che ne hanno i mezzi. Beninteso, per lui, tutti gli uomini ne hanno i mezzi, tutti possono partecipare al vero Spirito, a condizione d’essere liberi dall’alienazione. Poiché l’alienazione non consiste essenzialmente nell’estorsione del plusvalore - che ne è piuttosto il segno. L’alienazione consiste nel non essere propriamente sé stessi, tanto in quanto individui concreti che in quanto comunità non meno concrete".
E CONTINUA: "Questo spirito soffia come tutti gli spiriti. Marx usa spesso la parola “soffio” (Atem, respirazione). Ci accontenteremo di un esempio: «Il governo prussiano è infastidito dalla resistenza passiva che incontra ovunque. Attraverso l’apparente apatia, percepisce il soffio rivoluzionario»[...]"(Jean-Luc Nancy, "Essere, Soffio / Être soufflé", Le parole e le cose", 4.10.2021).
IL MESSAGGIO EVANGELICO E IL "FIGLIO DELL’UOMO". "Allora la folla gli [a Gesù] rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. CHI è questo Figlio dell’Uomo, CHI il "Gesù Cristo" degli Evangelisti? COME è detto nell’Evangelo di Giovanni di "Gesù Cristo"? Ponzio Pilato disse: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)" (Gv. 19, 4).
QUALE SPIRITO? COME è detto nella Prima Lettera dell’Evangelista Giovanni?: "Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per saggiare se provengono veramente da Dio [...] Dio è amore." (1 Gv. 4, 1-8).
IL PROBLEMA DEL MENTITORE: CHI È IL "GESÙ CRISTO" DI PAOLO DI TARSO?!: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
PSICOANALISI E CRISTOLOGIA: "OEDIPUS AT VERSAILLES" ED "EDIPO A CUERNAVACA". CHE FARE? Rileggere il testo di "Un frammento inedito di Freud del 1931" e dell’articolo di Franca Ongaro Basaglia ("PM", novembre 1982). SapereAude!
IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE (Gv. 3.8). QUANTI PALLONI IN ARIA ...
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "ECCE HOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA, NON ANDROLOGICA.30 settembre 2021, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA (NON ANDROLOGICA): "ECCE HOMO".
LA GIUSTIFICAZIONE PER FEDE E IL PROBLEMA CRISTOLOGICO: CHI E’ GESU’?!? E CHI IL SUO E NOSTRO "PADRE"?!
- ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. IL "FIGLIO DELL’UOMO": "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου"] deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).
- MESSAGGIO EVANGELICO: CHI E’ COME DIO? (QUIS UT DEUS?): "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" ("Carissimi, non prestate fede ad ogni spirito ... Dio è amore" (1 Gv.: 4. 1-16).
- IL PROGRAMMA DI ANTROPOLOGIA ANDRO-LOGICA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- DEUS CHARITAS O DEUS CARITAS?!: LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- PAPA FRANCESCO
 UDIENZA GENERALE
UDIENZA GENERALE
 Mercoledì, 29 settembre 2021
Mercoledì, 29 settembre 2021
Catechesi sulla Lettera ai Galati: 9. La vita nella fede *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel nostro percorso per comprendere meglio l’insegnamento di San Paolo, ci incontriamo oggi con un tema difficile ma importante, quello della giustificazione. Cos’è, la giustificazione? Noi, da peccatori, siamo diventati giusti. Chi ci ha fatto giusti? Questo processo di cambiamento è la giustificazione. Noi, davanti a Dio, siamo giusti. È vero, abbiamo i nostri peccati personali, ma alla base siamo giusti. Questa è la giustificazione. Si è tanto discusso su questo argomento, per trovare l’interpretazione più coerente con il pensiero dell’Apostolo e, come spesso accade, si è giunti anche a contrapporre le posizioni. Nella Lettera ai Galati, come pure in quella ai Romani, Paolo insiste sul fatto che la giustificazione viene dalla fede in Cristo. “Ma, io sono giusto perché compio tutti i comandamenti!”. Sì, ma da lì non ti viene la giustificazione, ti viene prima: qualcuno ti ha giustificato, qualcuno ti ha fatto giusto davanti a Dio. “Sì, ma sono peccatore!”. Sì sei giusto, ma peccatore, ma alla base sei giusto. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Questa è la giustificazione.
Cosa si nasconde dietro la parola “giustificazione”, che è così decisiva per la fede? Non è facile arrivare a una definizione esaustiva, però nell’insieme del pensiero di San Paolo si può dire semplicemente che la giustificazione è la conseguenza della «misericordia di Dio che offre il perdono» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1990). E questo è il nostro Dio, così tanto buono, misericordioso, paziente, pieno di misericordia, che continuamente dà il perdono, continuamente. Lui perdona, e la giustificazione è Dio che perdona dall’inizio ognuno, in Cristo. La misericordia di Dio che dà il perdono. Dio, infatti, attraverso la morte di Gesù - e questo dobbiamo sottolinearlo: attraverso la morte di Gesù - ha distrutto il peccato e ci ha donato in maniera definitiva il perdono e la salvezza. Così giustificati, i peccatori sono accolti da Dio e riconciliati con Lui. È come un ritorno al rapporto originario tra il Creatore e la creatura, prima che intervenisse la disobbedienza del peccato. La giustificazione che Dio opera, pertanto, ci permette di recuperare l’innocenza perduta con il peccato. Come avviene la giustificazione? Rispondere a questo interrogativo equivale a scoprire un’altra novità dell’insegnamento di San Paolo: che la giustificazione avviene per grazia. Solo per grazia: noi siamo stati giustificati per pura grazia. “Ma io non posso, come fa qualcuno, andare dal giudice e pagare perché mi dia giustizia?”. No, in questo non si può pagare, ha pagato uno per tutti noi: Cristo. E da Cristo che è morto per noi viene quella grazia che il Padre dà a tutti: la giustificazione avviene per grazia.
L’Apostolo ha sempre presente l’esperienza che ha cambiato la sua vita: l’incontro con Gesù risorto sulla via di Damasco. Paolo era stato un uomo fiero, religioso, zelante, convinto che nella scrupolosa osservanza dei precetti consistesse la giustizia. Adesso, però, è stato conquistato da Cristo, e la fede in Lui lo ha trasformato nel profondo, permettendogli di scoprire una verità fino ad allora nascosta: non siamo noi con i nostri sforzi che diventiamo giusti, no: non siamo noi; ma è Cristo con la sua grazia a renderci giusti. Allora Paolo, per avere una piena conoscenza del mistero di Gesù, è disposto a rinunciare a tutto ciò di cui prima era ricco (cfr Fil 3,7), perché ha scoperto che solo la grazia di Dio lo ha salvato. Noi siamo stati giustificati, siamo stati salvati per pura grazia, non per i nostri meriti. E questo ci dà una fiducia grande. Siamo peccatori, sì; ma andiamo sulla strada della vita con questa grazia di Dio che ci giustifica ogni volta che noi chiediamo perdono. Ma non in quel momento, giustifica: siamo già giustificati, ma viene a perdonarci un’altra volta.
La fede ha per l’Apostolo un valore onnicomprensivo. Tocca ogni momento e ogni aspetto della vita del credente: dal battesimo fino alla partenza da questo mondo, tutto è impregnato dalla fede nella morte e risurrezione di Gesù, che dona la salvezza. La giustificazione per fede sottolinea la priorità della grazia, che Dio offre a quanti credono nel Figlio suo senza distinzione alcuna.
Perciò non dobbiamo concludere, comunque, che per Paolo la Legge mosaica non abbia più valore; essa, anzi, resta un dono irrevocabile di Dio, è - scrive l’Apostolo - «santa» (Rm 7,12). Pure per la nostra vita spirituale è essenziale osservare i comandamenti, ma anche in questo non possiamo contare sulle nostre forze: è fondamentale la grazia di Dio che riceviamo in Cristo, quella grazia che ci viene dalla giustificazione che ci ha dato Cristo, che ha già pagato per noi. Da Lui riceviamo quell’amore gratuito che ci permette, a nostra volta, di amare in modo concreto.
In questo contesto, è bene ricordare anche l’insegnamento che proviene dall’apostolo Giacomo, il quale scrive: «L’uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede - sembrerebbe il contrario, ma non è il contrario -. [...] Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta» (Gc 2,24.26). La giustificazione, se non fiorisce con le nostre opere, sarà lì, sotto terra, come morta. C’è, ma noi dobbiamo attuarla con il nostro operato. Così le parole di Giacomo integrano l’insegnamento di Paolo. Per entrambi, quindi, la risposta della fede esige di essere attivi nell’amore per Dio e nell’amore per il prossimo. Perché “attivi in quell’amore”? Perché quell’amore ci ha salvato tutti, ci ha giustificati gratuitamente, gratis!
La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti e lo ha fatto per grazia, attraverso il dono di Gesù Cristo, della sua morte e risurrezione. Alcune volte ho detto com’è il modo di agire di Dio, qual è lo stile di Dio, e l’ho detto con tre parole: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Sempre è vicino a noi, è compassionevole e tenero. E la giustificazione è proprio la vicinanza più grande di Dio con noi, uomini e donne, la compassione più grande di Dio verso di noi, uomini e donne, la tenerezza più grande del Padre. La giustificazione è questo dono di Cristo, della morte e risurrezione di Cristo che ci fa liberi. “Ma, Padre, io sono peccatore, ho rubato...”. Sì, ma alla base sei un giusto. Lascia che Cristo attui quella giustificazione. Noi non siamo condannati, alla base, no: siamo giusti. Permettetemi la parola: siamo santi, alla base. Ma poi, con il nostro operato diventiamo peccatori. Ma, alla base, si è santi: lasciamo che la grazia di Cristo venga su e quella giustizia, quella giustificazione ci dia la forza di andare avanti. Così, la luce della fede ci permette di riconoscere quanto sia infinita la misericordia di Dio, la grazia che opera per il nostro bene. Ma la stessa luce ci fa anche vedere la responsabilità che ci è affidata per collaborare con Dio nella sua opera di salvezza. La forza della grazia ha bisogno di coniugarsi con le nostre opere di misericordia, che siamo chiamati a vivere per testimoniare quanto è grande l’amore di Dio. Andiamo avanti con questa fiducia: tutti siamo stati giustificati, siamo giusti in Cristo. Dobbiamo attuare questa giustizia con il nostro operato.
*UDIENZA GENERALE, Mercoledì, 29 settembre 2021 (ripresaparziale).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PSICOANALISI E LOGICA ISTITUZIONALIZZATA DEL MENTITORE. Un ricordo di Ida Magli, l’antropologa scomoda (di Alessandra Pigliaru).25 settembre 2021, di Federico La Sala
CONTRO IL "PADRE NOSTRO", MA CON IL "PADRE NOSTRO": SENZA LA MESSA A FUOCO DELL’ EDIPO COMPLETO (FREUD) NON SI ESCE DALLA TRAPPOLA DEL MENTITORE STORICAMENTE ISTITUZIONALIZZATA ... *
L’antropologa scomoda
Ritratti. È morta a 91 anni Ida Magli. Scrisse testi fondamentali sul matriarcato, la sessualità, l’iconografia della Madonna e la storia laica delle donne religiose. Negli ultimi anni, aveva radicalizzato il suo pensiero, abbracciando posizioni reazionarie
di Alessandra Pigliaru (il manifesto, 23.02.2016)
Figura controversa e complessa del panorama italiano, l’antropologa e scrittrice Ida Magli è scomparsa a Roma all’età di 91 anni. Per chi ne abbia letto i numerosi testi, in particolare quelli pubblicati tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Novanta, dedicati ad argomenti liminari al femminismo - è difficile individuare la ragione che, negli ultimi venti anni, l’ha spinta verso un passo reazionario. Sarebbe tuttavia riduttivo collocarla alla svelta nella deriva antieuropeista che in tempi recenti ha abbracciato anche se, in tutta onestà, potrebbe essere questo uno dei motivi che l’ha resa poco attraente soprattutto alle generazioni di giovani studiose che, con i testi, si confrontano. Ma per capirne il quadro completo e l’eredità che ha lasciato a chi si misura con i senso parlante dei testi, bisogna fare un necessario passo indietro, ne sono convinte in molte che di Magli hanno ascoltato quelle mirabili lezioni di Antropologia culturale alla Sapienza di Roma fino al suo pensionamento nel 1988.
Tra quelle allieve spicca Loredana Lipperini che, quando la notizia della scomparsa della professoressa Magli è stata diffusa, ha affidato ai social network parole tanto affettuose quanto colme di gratitudine per averle insegnato una curvatura dello sguardo ineguagliabile. Ed è forse su questo che ci si potrebbe soffermare, non per espungere i testi dal portato biografico ma per evitare di renderla una intellettuale rubricata semplicisticamente e rapita dalle destre; perché cioè le vada riconosciuto ciò che ha fatto, ovvero individuare alcuni elementi essenziali e spesso scomodi al dibattito antropologico e femminista contemporaneo e che poi hanno retto la parte centrale della sua esistenza.
In realtà, la storia tra Ida Magli e il femminismo è stata piuttosto intermittente, e questo nonostante abbia avuto da sempre il chiaro desiderio di seguirne il passo a giudicare dai passaggi che le sono stati cari.
Basti pensare a volumi come Matriarcato e potere delle donne (1978), in cui compaiono alcuni passi sulle società matriarcali e una inedita traduzione del poderoso testo Das Mutterrecht di Bachofen. Solo due anni prima, aveva fondato la storica rivista dwf.
È del 1982 La femmina dell’uomo e poi c’è lo studio in cui si concentra su Santa Teresa di Lisieux. Una romantica ragazza dell’Ottocento (1994), quello su La Madonna (1987), fino a un’interessante edizione aggiornata, dieci anni dopo, La Madonna, dalla Donna alla Statua; cruciale è stato La sessualità maschile (1989) e il suo studio sulla Storia laica delle donne religiose (1995).
Insieme ai testi forse più conosciuti vi è stato l’impegno costante verso l’antropologia che ha percorso sempre con disinvoltura e originalità di posizioni. È suo il più generale manuale di Introduzione all’antropologia culturale (1983) così come si deve a lei la fondazione e direzione (dal 1989 al 1992) della rivista Antropologia culturale.
Il nodo sessualità-religione è stato per Magli uno dei più frequentati, là dove entrambi i punti sono stati sempre interpretati con una certa ritrosia anche nella discussione politica pubblica.
Ida Magli in realtà, come ricorda Lea Melandri, che abbiamo raggiunto per telefono, è stata precorritrice lucidissima di alcuni snodi fondamentali: «Certo, non si può leggere solo parzialmente, bisogna guardarla nel suo intero e in quanto è stata capace di offrirci alla lettura. È rimasta sempre abbastanza in disparte, ma il femminismo l’ha intersecato; forse non è stata così riconosciuta come avrebbe meritato, e molto ci possono raccontare ancora i suoi libri; vi sono per esempio frammenti folgoranti, coraggiosi che mettono in chiaro alcuni aspetti forti: sessualità, immaginario e fantasie maschili sui corpi delle donne e il grande nodo religioso». Melandri prosegue citando alcuni passaggi cruciali, per esempio quelli che attengono il corpo delle donne, la sessualità e il potere che disciplina i corpi fino a diventare violenza.
Su quest’ultimo punto, infatti, anche la stessa attenzione di Melandri si è soffermata. «Ho letto e riletto alcuni suoi frammenti perché penso ci siano preziosi. Non sono stati mai scontati e andrebbero ascoltati. Ma penso anche alla lezione sulla storia laica delle religiose, un lavoro straordinario che andrebbe accolto con maggiore generosità».
Addio al Padre *
"[...] Abbiamo ricostruito questo percorso per mostrare chiaramente come oggi non vi sia più spazio non soltanto per il cristianesimo, ma per tutti i valori che in questi duemila anni hanno concorso alla formazione e allo sviluppo della civiltà europea. Per quanto forse i credenti cristiani non se ne rendano del tutto conto, non può sussistere una religione fondata su un Dio «Padre» laddove la figura del padre ha perso qualsiasi rilevanza e autorità. Come abbiamo ormai più volte detto, le religioni sono specchio e proiezione di ciò che pensano e che desiderano i popoli. L’immagine di un Dio-Padre è ormai priva di senso.
Non può sussistere una religione fondata sull’importanza del «Figlio» laddove la procreazione è considerata un fatto personale e gravoso e la società provvede gratuitamente ai numerosissimi aborti confermando così che vuole la propria morte. D’altra parte il figlio è ormai inutile per il padre in quanto non gli serve più a garantirne la sopravvivenza. Non serve né per l’al di là né per il di qua. Le dinastie, le successioni, le eredità sono state quasi del tutto abolite, oppure vengono significativamente caricate di tasse. Nessun genitore conta sui figli per la propria vecchiaia. Alla vita nell’aldilà è ormai quasi impossibile credere e di fatto gli uomini in Europa preferiscono non pensarci.
La dichiarazione di «morte cerebrale», i trapianti d’organi hanno tolto concretamente e simbolicamente ogni trascendenza alla morte, di cui il cadavere, fino a questa orrida decisione, sembrava racchiudere il mistero; per non parlare di ciò che il corpo era (o meglio «è», visto che il dogma non è stato abolito) nella teologia cristiana con la fede nella resurrezione dei corpi, inclusa nel Credo, alla quale però nessuno evidentemente pensa più.
Sembra quasi impossibile che vi sia stato un tempo (oggi appare lontanissimo ma in realtà si tratta soltanto di pochi anni fa) in cui gli uomini si toglievano il cappello davanti a un morto a onorarne, appunto, la sacralità. Tutto questo è stato voluto dallo Stato e dalla Chiesa in modo ossessivo, come se la realizzazione dei trapianti d’organi costituisse il centro del loro potere e dei loro desideri.
Ma il trapianto d’organi significa l’annullamento delle specifiche individualità (oltre che il consenso e la legittimazione dell’istinto sempre presente nell’uomo di sopravvivere uccidendo, mangiando l’altro); significa avvicinarsi concretamente a quella nuova forma di uguaglianza che, invece di affermare l’esistenza del singolo, afferma la sua non-forma, la sua mancanza d’identità, la sua integrazione nell’identico. Passaggio indispensabile per giungere ad annullare la differenza posta dalla natura con il Dna maschile e femminile, la differenza di genere, e affermare la «normalità» dell’omosessualità.
Non si può trarne che una sola conclusione: hanno voluto che l’omosessualità vincesse su tutto e su tutti. Ma il primato dell’omosessualità non sarebbe stato proponibile fin quando fosse stato in vigore non soltanto il primato del «padre», dei legami di parentela, dei legami di sangue, ma anche e soprattutto l’assoluta «differenza» del genere maschile e femminile, ossia la differenza per antonomasia. L’interscambiabilità dei corpi l’ha annientata. Dunque: nessun «Genere», nessuna «Paternità», nessun «Figlio», nessuna «Famiglia», nessuna «Società», nessun «Futuro».
Naturalmente questo significa che si vuole la fine non soltanto del cristianesimo, ma di tutta la civiltà e della società europea, la fine dei «bianchi». L’omosessualità è strumentale soltanto a questa fine e il suo primato sparirà insieme ai bianchi".
* Cfr. Ida Magli Dopo l’Occidente, Rizzoli, Milano, 2012.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA "PESTE"!!! LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA E’ ZOPPA E CIECA: IL FIGLIO HA PRESO IL POSTO DEL PADRE "GIUSEPPE" E DELLO STESSO "PADRE NOSTRO" ... E CONTINUA A "GIRARE" IL SUO FILM PRE-EVANGELICO PREFERITO, "IL PADRINO"!!!
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- INTERPRETAZIONE ANDROLOGICA DELLA FIGURA DI CRISTO E STRUTTURA SACRIFICALE DEL CATTOLICESIMO. "Le illusioni di una teologia femminista: chi prenderà il posto della vittima?" (Ida Magli, 1995).25 settembre 2021, di Federico La Sala
Le illusioni di una teologia femminista: chi prenderà il posto della vittima?
di Ida Magli [1995]*
Questa, perciò, è la conclusione. Nessuna teologia femminista è possibile perché la struttura sacrificale che è stata posta alla base del cristianesimo da S. Paolo e, da allora, continuamente ribadita nei duemila anni di storia cristiana, pone alle donne un problema insolubile. Una religione sacrificale obbliga, prima di tutto, ad accettare di possedere una vittima, e subito dopo a stabilire chi debba essere il Sacrificatore e chi la Vittima. La vittima fino ad oggi è stata la Donna (le donne). Naturalmente questo significa anche che colui che ha designato la vittima - il Sacrificatore - è anche colui che detiene il Potere.
Come è chiaro, in queste brevi premesse si delinea la struttura di una società, anche se nel mondo moderno si continua a fare finta che esistano società «laiche»,distinte dalle religioni. Il Protestantesimo è stato un tentativo implicito di scardinare il sistema del Potere legato al sacrificio della vittima. Ma non era ancora ben chiaro in Lutero che la discussione sul grado di realtà della presenza di Cristo nel «sacrificio della Messa» (si tende di solito a dimenticarsi che la Messa è appunto un «sacrificio») non era una polemica fra teologi e fra diverse interpretazioni delle Sacre Scritture, ma una domanda ben diversa: può sussistere una società senza sacrificio?
Interrogativi, questi, irrisolti, malgrado le diverse versioni del cristianesimo che si sono presentate lungo i secoli, perché in realtà, sotto le vesti della téologia, si discuteva(si discute) delle radici di fondazione della vita di gruppo.
Nel Protestantesimo, in teoria, la necessità della vittima è meno forte che nel Cattolicesimo, in quanto si tiene fermo il punto che il sacrificio vero, quello del Salvatore si è compiuto una volta per sempre; e la messa, di conseguenza, viene interpretata come «memoria», come semplice ricordo del sacrificio di Cristo. Nel Cattolicesimo, invece, con la riaffermata «transustanziazione» del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo, il sacrificio è altrettanto reale, si compie nuovamente come sulla Croce.
Di fatto, sia l’una sia l’altra posizione girano intorno al problema irrisolvibile della necessità, o meno, della vittima. Sotto quesro aspetto il cattolicesimo è tragicamente realista. Le chiese cattoliche piene di crocifissi, di corpi di martiri, di scene sanguinanti, lo dicono ad alta voce: vittime, vittime, vittime.
Nel protestantesimo, invece, esistono contraddizioni e ambiguità che, forse, sono ancor più significative. Prima di tutto, la rivendicata continuità con l’Antico Testamento, ossia con la cultura sacrificale per eccellenza.
Il cristianesimo originario, invece, e poi il cattolicesimo, almeno fino a ieri, hanno messo l’accento sulla rottura con l’ebraismo, e benché la polemica violentissima sul non riconoscimento dell’avvento del Salvatore e sull’uccisione del Figlio di Dio da parte degli Ebrei si sia svolta in termini teologici (e nell’antisemitismo concreto), in realtà era dettata dal trauma non cancellabile dell’assoluta novità portata dai Vangeli. Di fatto, però, sia l’una che l’altra Chiesa si basano fondamentalmente su S. Paolo e non su Gesù, cosa che riporta il problema alle sue radici: l’affermazione di Paolo che ogni cristiano è e deve essere, alter Christus e che «senza spargimento di sangue non esiste perdono» (Lettera agli Ebrei, 9, 22). Dunque: la vittima è necessaria.
Se le cose stanno così, nulla di ciò di cui discutono le femministe ha un senso. La richiesta del sacerdozio per le donne, per esempio, non trova che giustificazioni superficiali di parità con gli uomini,se prima non si dice cosa si vuole fare di una religione sacrificale, e se si vuole, oppure no, conservare un’organizzazione di Potere del Sacrificatore. Chiedere il sacerdozio, infatti, significa questo: diventare Sacrificatori.
Nel protestantesimo, il sacerdozio è meno «forte» di quello cattolico a causa della mancanza reale del Sacrifìcio della vittima, ed è per questo che nelle Chiese riformate è stata piu facile l’equiparazione delle donne nell’ufficio di Pastore. Ma il problema si sposta di poco. In realtà (e se ne hanno abbondanti prove nella storia del Calvinismo, del Giansenismo, del Puritanesimo, ecc.) le confessioni riformate sono più rigide e coercitive del cattolicesimo proprio perché, mancando un Potere forte che si assume la «rappresenlanza» del gruppo davanti a Dio, e la valvola di sicurezza del «capro espiatorio», ossia di una vittima delegata al posto di tutti, l’ansia del singolo fedele, affidato soltanto a se stesso nei confronti della giustizia divina, aumenta a dismisura.
Dunque, le donne hanno di fronte a sé un problema irrisolvibile, se continuano a muoversi nelle religioni codificate sperando che siano possibili piccoli o grandi aggiustamenti, mirati in forma analogica sulle strutture maschili già esistenti. Dio è anche Madre, oltre che Padre? Sostituire alla grammatica maschile delle Sacre Scritture e della liturgia una corrispondente grammatica femminile? Oppure,inventare una grammatica «neutra»? Il Figlio è anche Figlia? Gesù non aveva sesso? Celebrare la Messa col miele al posto del vino? Tutte ipotesi, queste, già avanzate, con l’entusiasmo e con la spavalda sicurezza tipica del femminismo, da teologhe soprattutto statunitensi. Ma, come è evidente, prive di senso. Giochi da bambine.
È vero che i teologi hanno continuamente rielaborato, sollecitati dai cambiamenti culturali e sociali che si verificano nella storia, le interpretazioni delle Sacre Scritture, con una disinvoltura stupefacente. Ma oggi si è di fronte ad una trasformazione culturale che non può essere paragonata a nessuna di quelle, sia pure grandissime, che si sono già verificate nell’itinerario storico dell’Occidente. Né l’abolizione della schiavitù, né l’invenzione del metodo scientifico, né l’accelerazione tecnologica, né l’instaurarsi della democrazia hanno messo in luce, travolgendole, le radici della fondazione della cultura e dell’assetto sociale. È questo, invece, che sta avvenendo, mano a mano che saltano i punti fermi della collocazione delle donne. Se la prima organizzazione dei gruppi umani, ìn qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo, è avvenuta attraverso 1o scambio matrimoniale (e su questo non ci sono dubbi da parte di nessun studioso, né biologo, né antropologo, né archeologo, né etnologo, né storico); se, come afferma Lévi-Strauss, la società è nata con la «circolazione» delle donne, è questa radice che oggi, almeno in Occidente, anche in base a quel primo seme gettato da Gesù in questa direzione, sta per essere strappata, divelta. Le donne si rifiutano di «circolare». La messa in crisi dello scambio matrimoniale è molto di più che questo: è messa in crisi (come la storia qui appena traccíata dovrebbe dimostrare) del ruolo assegnato alla «femminilità», prima ancora che alle donne. Ed è sulla «fernminilità» che si gioca il concetto di vittima.
Si ritorna, perciò, al problema di partenza: è necessaria la vittima per la soprawivenza di un gruppo? E, se è necessaria, c’è qualcuno che voglia prendere il posto della vittima che le donne stanno per lasciare?
* Cfr. Ida Magli, Storia laica delle donne religiose, Longanesi, Milano 1995, pp. 312-315.
-
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- EPISTEMOLOGIA "ANDROLOGICA" E PREISTORIA". Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne (di Tiziana Plebani).20 settembre 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA PSICOANALISI E PSICHIATRIA. UNA QUESTIONE DI DIGNITÀ DI LUNGA DURATA.... *
Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne
Violenza maschile. Alla povertà di un gesto, opporre visioni diverse. Non c’è mai una un’unica scelta
- [Foto] Roma, manifestazione contro i femminicidi del movimento "Non una di meno"
di Tiziana Plebani (il manifesto, 17.09.2021)
Una donna uccisa quasi ogni giorno. Ma spostiamo la visuale e guardiamo dall’altra parte: quasi ogni giorno un uomo uccide una donna. Viene da pensare che sia divenuto un gesto imitativo, un modello da seguire, orrendamente, assurdamente, forse inconsapevolmente, ma che, tuttavia, si è imposto nell’immaginario, nel ventaglio di comportamenti e reazioni.
Nel momento della fragilità, della crisi, della necessità di riprogrammarsi, bisogna fare la fatica di trovare una soluzione, una via di uscita. Questa scelta costa. C’è bisogno di silenzio, pena, sofferenza. Cosa fare? Quello che hanno fatto tanti, che ogni giorno viene ripetuto dai media, che è visto di continuo in televisione. È un gesto che si insinua nella testa, e nel momento del bisogno emerge automatico, l’hanno fatto altri. È come se ci fosse una strada maestra di risposta che azzera l’infinità di opzioni a disposizione dell’umano per risolvere un dramma personale.
Ricordo che anni fa, durante la crisi economica del 2008, assistemmo a un’altra di queste associazioni a catena, tragicamente automatiche: più di 1600 imprenditori si tolsero la vita. Cominciò uno di loro a suicidarsi e in poco tempo anche questo gesto venne ripetuto di continuo: una risposta cieca che pure in questo caso si era imposta come l’unica percorribile.
Certo, quegli uomini che ammazzano le donne hanno alle spalle una pratica violenta, tengono armi in casa, hanno coltivato una confidenza con il linguaggio dell’offesa che non si inventa da un giorno all’altro. Sono tutte morti annunciate, come sappiamo.
Che fare dunque? Suggerisco due piani di azione, uno nell’ambito comunicativo, l’altro che riguarda le strategie di prevenzione.
I media ripropongono la sequela di omicidi e purtroppo imprimono e sedimentano questa risposta. Non si tratta ovviamente di tacere questi crimini bensì di accompagnare la notizia con commenti e interpretazioni che innanzitutto smentiscano l’idea che si tratti di raptus, di accecamento istintuale, di rabbia (rimando a questo articolo).
Quasi tutti questi delitti, avvengono dopo episodi di minacce e di brutalità. E soprattutto, come ci insegna la storia delle emozioni, esistono stili di comportamento che emergono rispetto ad altri in alcuni momenti storici, e che in questo caso ci parlano di un deserto e non di un eccesso emozionale, di un analfabetismo dei sentimenti (di cui la nostra società attuale è afflitta), e di un appiattimento delle risorse individuali e collettive ai drammi e alle fatiche della vita.
Televisioni, social media, carta stampata dovrebbero insistere piuttosto sul ventaglio di risposte al disagio, proponendo storie finite in altro modo (che poi sono la stragrande maggioranza). Si deve comunicare la possibilità di uscire da quella che appare in maniera distorta come una strada maestra ma che è invece un vicolo cieco e orrendo.
Opporre alla povertà di un gesto la visione di un paesaggio molteplice e vasto, di scelte multiple, di percorsi attraversati da mille sentieri. Non c’è mai un’unica scelta.
L’altro piano riguarda l’azione preventiva. Si tratta a parer mio di riprendere le modalità con cui si è affrontata la protezione dei testimoni di mafia, ma mutando direzione. Invece che far subire alla donna minacciata e che ha denunciato lo stalking o peggio, l’allontanamento dalla sua casa, dal suo ambiente, dal lavoro e dalle sue reti personali, si vada a trasferire l’uomo violento in un’altra città e almeno in un’altra regione, possibilmente molto distante. E che abbia l’obbligo di firma, come i mafiosi, in modo che si possano controllare i suoi spostamenti.
Perché ciò che non dobbiamo permettere è che le conseguenze di un comportamento violento maschile vengano pagate in qualità di libertà personale femminile. Affinché queste donne non siano viste solo come vittime ma come soggetti autonomi che perseguono le loro scelte di vita.
L’autrice è storica e scrittrice
*
NOTA:
- "Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne" : "Una donna uccisa quasi ogni giorno. Ma spostiamo la visuale e guardiamo dall’altra parte: quasi ogni giorno un uomo uccide una donna (...)" (Tiziana Plebani, il manifesto, 17 settembre 2021).
QUASI OGNI GIORNO UN #UOMO UCCIDE UNA DONNA (ma chi l’addestrò per la vittoria?). Forse non è ora di svegliarsi dal sonno dogmatico e venir fuori dalla edipica tragedia della cosmoteandria e laica e religiosa?!
ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA. Per uscire dal manicomio di una storia segnata (e raccontata, come Brecht ben illustra)) da una andrologia di lunga durata, dall’inferno della tragedia (Edipo), e vedere Lucifero a "gambe in sù" (Inf. XXXIV, 92) o, diversamente, la testa di Oloferne tagliata da Giuditta (Botticelli), oggi, è necessario non solo un radicale capovolgimento di ottica, ma soprattutto prendere coscienza della necessità di uscire da dentro un campo antropologico con la bilancia rotta (tutte le relazioni dell’intera società senza più giustizia)) e smetterla di continuare a fare "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata" (come già denunciato da Franca Ongaro Basaglia). O, contro l’evidenza di Dante Alighieri, ogni speranza è ormai solo un’illusione?! E la storia è finita?!
COSTITUZIONE ("BIBBIA CIVILE") ED EPISTEMOLOGIA "BIBLICA"! . Benché sulla questione antropologica (Kant, "Logica", 1800) abbia richiamato tutta la sua attenzione, l’idealismo materialistico (o il materialismo idealistico) l’ha "conservata e negata" ("superata") nella grande "Scienza della Logica" dello Spirito Assoluto di Hegel (Napoleone). Recentemente, Gregory Bateson, benché (come egli stesso dice in una conferenza del 1979) abbia "all’enima della Sfinge" dedicato "cinquant’anni" della sua "vita di antropologo", non è riuscito a venir fuori dall’orizzonte della tragedia e dalla città di Edipo ed è ritornato sulla strada del "sacro"!
("DIGNITÀ DELL’UOMO". Non per sminuire nessuno, ma per uscire dalla "preistoria" (K. Marx), è bene ricordare che il "Dio" a cui guarda Gregory Bateson, è ancora il dio dell’antico patto, quello dell’andrologia di Paolo di Tarso: il cap. XIII di "Dove gli angeli esitano" (Adelphi,1989) è titolato "Il dio che non si può beffare" e mette in citazione la frase di san Paolo: "Non vi fate illusioni: Dio non lo si può beffare" (Gal., VI, 7)!!!
DIGNITÀ. Che dire?! l’antropologa Ida Magli non ha solo scritto "La femmina dell’uomo" (Laterza, 1982) ma anche scritto il libro "SULLA DIGNITA’ DELLA DONNA"; il sottotitolo è "La violenza sulle donne, il pensiero di Wojtyla". Che dire?! Continuare nello Spirito di Napoleone, Hegel, Bateson, Costantino?! Dopo Dante2021?!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA, MATEMATICA, E PSICOANALIS: "UNA VOCE” FUORI DAL CORO.18 settembre 2021, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MATEMATICA. NOTE PER RISCRIVERE UN “ROMANZO FAMILIARE” NUOVO...
ACHERONTA MOVEBO. “Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo” (Se non potrò piegare gli Dei, muoverò Acheronte: Virgilio, Eneide, VII, 312). A partire da questa citazione virgiliana, volendo, è possibile tentare di "rileggere" l’intero percorso della ricerca di Freud. Ricordando con lo stesso Freud della "Psicopatologia della vita quotidiana" (1901), l’altra importante citazione sempre ripresa dall’Eneide (IV, 625 ) : "Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" (che nasca un giorno dalle mie ceneri un vendicatore), si comincia a capire cosa c’è nel "coraggio degli inizi" (Rubina Giorgi, 1977) e in questa identificazione di Freud con Giunone/Era (non solo la moglie di "Zeus", ma anche la sua stessa madre) con Didone e con Annibale, il grande nemico di Roma.
IL PROBLEMA DEL LIBERATORE. L’esergo dell’Interpretazione "dichiara" semplicemente la "natura" teologico-politica del suo progetto: cercare di fermare il matrimonio di Enea e la nascita della nuova Troia (Roma)! Con la stessa determinazione di Giunone/Era (Virgilio), Freud lavora a portare alla luce della coscienza europea la struttura edipica del sogno del Dio greco e cattolico-romano (di Platone come di Paolo di Tarso), e venir fuori dall’orizzonte della tragedia (come Dante e lo stesso Nietzsche). Con l’aiuto di "Zeus/Giove"" e di "Era/Giunone", pur tra mille difficoltà, egli riesce a venir fuori dall’inferno e a "nascere, di nuovo"! Nel 1938 arriva a Londra e porta a compimento il suo ultimo lavoro "L’uomo Mosè e la religione monoteistica". Un grande respiro di sollievo! Morirà l’anno successivo.
ANTROPOLOGIA, MATEMATICA, E PSICHIATRIA. Pur avendo Freud dato già dal 1907 chiare indicazioni per lavorare congiuntamente a una nuova educazione civica e a una nuova educazione sessuale per una "società sana" (Erich Fromm, 1955), l’Italia (comel’Europa e l’intero Pianeta) naviga ancora in un oceano illuminato da una diffusa cosmoteandria.
"UNA VOCE” FUORI DAL CORO. Come ha scritto Franca Ongaro Basaglia ("Una voce. Riflessioni sulla donna", il Saggiatore, 1982), continuiamo a fare "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" e a leggere per lo più e sempre il vecchio "romanzo familiare", quello edipico! Che dire?! Che fare?! Non è meglio uscire dal "sonnodogmatico"?!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’ HOMO "COSMOTEANDRICUS", "L’EVENEMENT", E LUNGA MARCIA DI UNA CATASTROFE ANTROPOLOGICA IN CORSO.13 settembre 2021, di Federico La Sala
L’ORDINE SIMBOLICO DI MAMMASANTISSIMA: LA LUNGA MARCIA DI UNA CATASTROFE ANTROPOLOGICA IN CORSO.
Senza riandare indietro nel tempo, cosa che ha già fatto una grande tradizione critica (e da cui poco è stato appreso), ipnotizzati da concetti-specchio come patriarcato e matriarcato, ancora non è stato capito che cosa significa Edipo (Freud), tragedia (Dante, Nietzsche), e rapporto sociale di produzione (Marx). C’è solo da accogliere il film “L’événement” (Audrey Diwan, Leone d’oro, Venezia 2021) come una buona sollecitazione a ripensare questi problemi legati a mammane, mammona, cucchiai d’oro e moloch vari e riprendere il filo da quanto successo (in Europa) almeno (non solo a Granada nel 1492, ma anche) su "quel ramo del lago di Como" nel 1628 in un altro modo e in un’altra direzione. E così, possibilmente, buttare via l’acqua sporca e salvare la memoria di chi ha lottato da sempre per non restare all’inferno e vuole ri-nascere. O no?
DANTE 2021: LA DOMANDA ANTROPOLOGICA DI KANT (""Che cos’è l’uomo?": "Logica", 1800), IL "FIGLIO DELL’#UOMO": UNA QUESTIONE DI PAROLA (LOGOS, NON LOGO!).
"Ecce #Homo" (gr. «idou ho #anthropos»): "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo ["Filius hominis", "ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]?»"(Gv. 12,34).
MESSAGGIO EVANGELICO E "DUE CRISTIANESIMI": "SEGUITEMI, VI FARO’ #PESCATORI DI UOMINI [piscatores hominun, ἁλιεῖς ἀνθρώπων] come da parola di Gesù (Mt. 4,19) o come da sollecitazione di Paolo di Tarso:"Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo... sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [lat. vir, gr. ἀνήρ]"(1 Cor. 11, 1-3)?!
11 SETTEMBRE 2011/2021, STORIA, E FILOLOGIA: "ECCE HOMO". Sempre a ripetere le famose parole dell’Ulisse di Dante (Inf. XXVI, 118-120: "Considerate la vostra semenza: /fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza"), ma ancora oggi (2021), dopo Dante e dopo Kant, tutta l’Europa e l’intero Pianeta è immerso in un letargo profondissimo! Alla questione antropologica ("Che cos’è l’uomo?": Kant,1800), si continua a rispondere truccando la Parola (il Logos) e a scambiarla (e a esportarla) come un Logo di un’azienda, proprietà di quegli uomini "più uguali degli altri" della orwelliana "Fattoria degli Animali"!
PREISTORIA (DI "VIRTUS" E "VIRUS"). La parola uomo (gr. anthropos, homo) vale solo come uomo-maschio (gr. anér/andròs, lat. vir/viri) e l’antropologia si coniuga solo al maschile, come andrologia: a tutti i livelli, immersi nel regno dell’Homo cosmo-te-andricus - nella "realtà" di una teologia ("Dio"), di una cosmologia ("Mondo") e di una antropologia "andrologica" ("Uomo"), la cosmoteandria del Pianeta Terra...
METANOIA: CAMBIARE MENTE! A che gioco giochiamo? Non è meglio uscire dall’orizzonte della cosmoteandria e dall’inferno (Inf. XXXIV, 90) e riprendere la navigazione nell’oceano celeste (Keplero a Galilei, 1611)?! O che?!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E "DIVINA COMMEDIA": AL DI LÀ DELLA COSMOTEANDRIA7 settembre 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOLOGIA E DIVINA COMMEDIA: AL DI LÀ DELLA COSMOTEANDRIA
RINASCERE. Beatrice chiede al "gran viro" San Pietro di esaminare Dante (suo figlio!) sulla fede (Par. XXIV, 34-45: " Ed ella: «O luce etterna del gran viro /a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi, /ch’ei portò giù, di questo gaudio miro, /tenta costui di punti lievi e gravi, / come ti piace, intorno de la fede,/ per la qual tu su per lo mare andavi. // S’elli ama bene e bene spera e crede, /non t’è occulto, perché ‘l viso hai quivi /dov’ogne cosa dipinta si vede;/ ma perché questo regno ha fatto civi /per la verace fede, a gloriarla, /di lei parlare è ben ch’a lui arrivi»").
San Pietro chiede: «Di’, buon Cristiano, fatti manifesto: /fede che è?» (52-53). Dante , illuminato dalla Grazia (58: «La Grazia che mi dà ch’io mi confessi»), accetta le parole di San Paolo, risponde: "«Come ’l verace stilo/ ne scrisse, padre, del tuo caro frate/ che mise teco Roma nel buon filo, /fede è sustanza di cose sperate /e argomento de le non parventi; /e questa pare a me sua quiditate»" (61-66), e va oltre!
Con la luce della Grazia (Amore), egli ha ben chiaro che la sua sua strada non è quella né di Enea né di San Paolo, che dell’ "Ecce Homo", della figura di Cristo ha fatto un "vir-o", anzi un superuomo ("Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio": 1 Cor. 11, 1-3), e prosegue!!!
Il viaggio continua, fino a capire che è "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145): "La gloria di Colui che tutto move/ per l’universo penetra, e risplende/ in una parte più e meno altrove. /Nel ciel che più della sua luce prende / fu’ io, e vidi cose che ridire /né sa né può chi di là sù discende: / perché appressando sé al suo Disire, / nostro intelletto si profonda tanto/ che dietro la memoria non può ire" (Par. I, 1-9). E a ri-nascere: aggrappato al "vello" di Lucifero (e... dello stesso San Paolo), con l’aiuto di Virgilio (e Maria e Beatrice e Lucia, Dante ce l’ha fatta! Il suo cammino non sì è interrotto! Dopo 700 anni, come direbbe Raffaella Carrà (in memoria), egli è qui! O no?!
Dante2021: Dante Alighieri non "cantò i mosaici" dei "faraoni" ...
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MARX (CON FEUERBACH) A SCUOLA DA DANTE, PER IMPARARE A LIBERARSI DALLA DIALETTA COSMOTEANDRICA DI PLATONE ED HEGEL.21 agosto 2021, di Federico La Sala
#DANTE2021: CHE #CAPOVOLGIMENTO!
#Vexilla Regis (If. XXXIV, 1):
a "gambe in sù" (90)!
#Marx
a #scuola da
#Dante
per ritrovare la #strada e
#imparare ad
dalla dialettica
dell’#andrologia di
#Platone
e
#Hegel
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- EUTANASIA, FILOLOGIA, E FILOSOFIA DELL’AVVENIRE: LUCIFERO GAMBE ALL’ARIA.21 agosto 2021, di Federico La Sala
EUTANASIA: #FILOLOGIA #COSTITUZIONE E #DIVINACOMMEDIA.
Per una filosofia dell’#avvenire del pianeta (e non solo dell’Italia), sperando in "un clima di #dialogo costruttivo, di rispetto reciproco e non di scontro senza limiti" (Giovanni Maria Flick), forse, è bene
chiarire che
#EUTANASIA ("eu-tanasia") vale letteralmente "buona-morte", come
#EVANGELO ("ev-angelo" -"eu-angelo") vale letteralmente "buon-messaggio"), e non "#vangèlo" ("van-gèlo"), messaggio per andare nel #gèlo ("la ghiaccia") eterno!
Ricordando che il nostro presente storico è quello di #Dante2021 (proprio grazie al signor #DanteAlighieri del 1321 e alla sua #Monarchia dei #duesoli), dopo aver visto #Lucifero con le gambe all’aria (Inf. XXXIV), non è meglio uscire dall’#Inferno e, con l’aiuto di Beatrice (Maria e Lucia) e Virgilio e san #Bernardo (san #Giuseppe) andare avanti, in #Purgatorio e #Paradiso (Par. XXXIII, v. 145)? E uscire dal tragico orizzonte del generale planetario "cosmoteandrismo" laico e religioso?! E ripensare e riformulare (senza trucchi e senza inganni) lo stesso principio di carità?! O no?! Boh e bah!?
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- OLTRE LA COSMOTEANDRIA. Sulla Terra nessuno è straniero (Kant), "perché originariamente nessuno ha più diritto di un altro ad abitare una località della terra". Rec. di STraniero" di U. Curi (di Cristina Morga).20 agosto 2021, di Federico La Sala
GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! AL DI LA’ DELLA COSMOTEANDRIA E DELLA TRAGEDIA.... *
Curi, straniero. La necessità del due
di Cristina Morga (Bene Comune, 1 aprile 2019)
- “Senza il due, la ben rotonda verità dell’uno appare incapace di rendere ragione di ciò che caratterizza l’esperienza degli esseri umani. Il concetto stesso di rappresentazione, in quanto presuppone la distinzione fra due livelli di realtà, rinvia alla molteplicità del due e a tutto ciò che con essa è connessa” (pag. 128)
Il breve saggio intitolato Straniero è un’interessante riflessione sulla figura dello straniero, sul suo ruolo ambivalente di minaccia e di dono, sulla sua ineluttabilità per la definizione della nostra identità.
Il filosofo Umberto Curi non è interessato a sostenere la tesi di quelli a favore dell’accoglienza o di quelli che auspicano la chiusura delle frontiere. Piuttosto, attraverso un’analisi linguistica, filosofica e della letteratura, partendo da molto lontano e arrivando ai nostri giorni, ci invita a confrontarci sull’irriducibile duplicità di quella presenza che è sempre esistita - lo straniero, appunto - ma che oggi ci deve più che mai interrogare per le proporzioni che la mobilità umana sta assumendo.
L’autore dunque non esprime giudizi, ma offre molti spunti per ragionare sul profondo significato del concetto di straniero che oggi, pur in una società globalizzata, sempre più spaventa e sempre meno attrae. Ecco perché un approfondimento culturale sul tema sembra quanto mai urgente.
Curi lo fa a partire dal significato che gli antichi hanno attribuito alla figura dello straniero, elaborando nei secoli molti termini con significati diversi e/o plurimi, a seconda del periodo e del peculiare aspetto che si intendeva sottolineare. E’ proprio analizzando le singole parole della civiltà greca (xenos, barbaros, ecc.) e latina (hostis, ingenuus, perduellis, hospes, ecc.) che ci rendiamo conto delle infinite sfumature e accezioni semantiche che la figura dello straniero acquisiscono nel tempo: straniero come persona estranea, strana; straniero come forestiero, nemico e molto altro ancora. Tuttavia ci sono due elementi che sono onnipresenti: il fatto che si faccia sempre riferimento a una figura altra da noi e il fatto che questa abbia contemporaneamente un rapporto con noi, da cui non possiamo prescindere.
In questo volume tuttavia Curi non si ferma solo all’analisi lessicale che pure sarebbe sufficiente a far comprendere la complessità del tema. Egli si sofferma altresì sul concetto di accoglienza dello straniero, così come è stato interpretato da diversi filosofi, da Platone, a Kant a Freud.
Secondo Platone “non è possibile dire la verità, se non attraverso il confronto con il discorso di chi sia estraneo alla comunità e con essa entri in comunicazione”, mentre Kant sostiene il diritto dello straniero a non essere trattato come un nemico per garantire la pace perpetua. E poi l’autore analizza il pensiero di Freud, a partire dal concetto di unheimlich (malamente tradotto in italiano con il termine di perturbante), che definisce non soltanto l’inquietante, ma anche la scoperta di una duplicità di qualcosa con cui veniamo a contatto, la scoperta che l’ “Io non è unico, ma doppio, scisso in una dualità non ricomponibile, uguale e insieme irriducibilmente diversa rispetto all’immagine riflessa nello specchio, al sosia, all’ombra. Perturbante è la presa di coscienza di una insuperabile ambivalenza, di una unità che non è, non può mai essere, semplice, ma sempre inesorabilmente duplice” (p. 42). Quell’ineffabile e forte sentimento espresso attraverso la parola unheimlisches nasce dal reperimento del due nell’uno e quindi dalla rinuncia a qualsiasi immagine semplificata o rappresentazione univoca.
Infine, Curi, citando diverse opere letterarie, si sofferma sul racconto di Camus, l’Ospite, per sottolineare, fra le altre cose, l’importanza della dualità, che non implica soltanto insolubilità di un problema, ma movimento e mutamento, cioè vita. “Senza il due, la ben rotonda verità dell’uno appare incapace di rendere ragione di ciò che caratterizza l’esperienza degli esseri umani. Il concetto stesso di rappresentazione, in quanto presuppone la distinzione fra due livelli di realtà, rinvia alla molteplicità del due e a tutto ciò che con essa è connessa” (pag. 128).
Insomma, in questo ricco percorso linguistico, letterario e filosofico proposto da Curi, l’ambiguità dello straniero è sempre presente. Tuttavia, la sua natura ambivalente, un nemico da cui proteggersi ma anche un soggetto di cui abbiamo bisogno per definire noi stessi, rappresenta uno stimolo eccezionale per superarci e migliorarci. Nelle antiche carte geografiche, leggiamo nell’introduzione, le terre ignote ed inesplorate dell’Africa e dell’Asia erano descritte con la dicitura “hic sunt leones”, come a dire che quelle terre, per il semplice motivo di essere estranee e sconosciute, rappresentavano una minaccia. “Ma l’attrazione per le risorse e i tesori presenti in quelle zone del mondo indusse a non piegarsi alla paura, intraprendendo i viaggi che avrebbero condotto alla conoscenza dell’ignoto, e dunque alla cancellazione dalle carte di quella iscrizione. Si scoprì così che i doni connessi allo svelamento del mistero, ancorché indissolubili alla minaccia, erano talmente preziosi da risultare irrinunciabili” (p.19).
Forse è giunto il momento storico adatto a nuovi viaggi, allo svelamento di un nuovo mistero. Ritrovare la curiosità di chi ci ha preceduto, superando la paura, ci aiuterà nella comprensione di nuovi doni irrinunciabili? Oltre il confine, dove stanno i leoni, scopriremo forse la necessità del nostro due.
Citazioni
“Lo straniero è ambivalente - è l’ambivalenza. In quanto è thauma, non posso vivere la sua presenza, il suo arrivo, se non come una minaccia. Ma insieme avverto, nel cuore stesso del pathos che è inseparabile dal contatto con lui, che quella pur ineliminabile minaccia è per me feconda, mi conferisce qualcosa che, pur inconsapevolmente, attendevo da tempo e di cui non potrei fare a meno. Posso respingerlo - certamente - in quanto è minaccia. Ma contestualmente, se mi accingo a questo, percepisco anche un mio profondo e irrimediabile depauperamento. Alla sua duplicità dovrei saper rispondere con altrettanta duplicità. Dovrei riuscire a temerlo e a desiderarne l’arrivo, a spalancargli le porte della mia casa, e insieme a tenerlo fuori da essa, a respingerlo con la massima fermezza, e contemporaneamente ad accoglierlo come se si trattasse di una benedizione” (p. 12).
“Rinunciare al dono per allontanare la minaccia, o affrontare il pericolo per acquisire il dono? Un punto resta comunque assodato: di fronte allo straniero cede ogni possibile linguaggio dell’unicità [...] La rassicurante e familiare logica dell’aut-aut deve essere soppiantata da una modalità di ragionamento basata sul ben più impegnativo et-et” (p.13).
“Dell’hostis non possiamo fare a meno - non possiamo “scegliere” se accoglierlo o respingerlo, non più di quanto possiamo scegliere di essere quello che siamo. Egli è legato alla nostra identità non solo perché la fa essere, ma anche perché la fa - potenzialmente - non essere; non solo perché la determina, ma anche perché la minaccia dall’interno” (p.18).
“Unheimlich è quel moto dell’animo che avvertiamo quando ci rendiamo conto che non si dà alcuna possibilità di ricondurre a termini univoci, e a distinzioni nette e irreversibili, la nostra esperienza. Quando scopriamo che la stessa cosa che sembrava poterci rassicurare, proprio quella soprattutto ci inquieta. Quando ci avvediamo - davvero con “timore” e “tremore” - che non si dà alcuna “casa” come luogo privilegiato in cui viga l’assoluta univocità dei significati, degli atti, dei comportamenti e degli eventi, ma che nel cuore stesso di essa si annida la sua negazione, che nell’intimo dello Heim, e non fuori o contro, o comunque distinto rispetto a esso, vi sia l’un-Heim” (p.51).
“Dunque, in origine hostis è una figura alla quale mi lega un rapporto che non è di ostilità, ma di compensazione, nel senso che sono verso di lui in obbligo di contraccambiarlo per qualcosa che ho ricevuto. Mediante il ricambio, all’hostis viene riconosciuta quella piena parità alla quale egli ha diritto” (p.59).
“Il termine xenos compare sia per indicare colui che, provenendo dall’ ‘esterno’, viene ospitato presso la propria casa, sia colui presso la cui casa si riceve ospitalità” (p.63).
“Alla figura dello xenos, che è al centro delle relazioni di reciprocità tra le città che costituiscono il mondo ellenico, si oppone quella di barbaros. I barbari non erano soltanto stranieri, ma erano anche rozzi, crudeli, codardi, ecc. [...]. La natura mostruosa del barbaro fa sì che, propriamente parlando, non si tratti di stranieri, ma di una specie differente di uomini: essi non vengono da un’altra città, come visitatori o residenti, ma da un altro mondo, con cui non c’è possibilità di confronto né di scambio. E’ la loro diversa natura che li pone al di là della cultura ovvero delle possibilità di relazione, intreccio, mescolanza che la costituiscono. Di qui la guerra come modalità naturale di condursi nei confronti di una categoria di uomini con cui non è possibile rapporto, per cui non si possono stabilire quei legami di mutua accoglienza che costituiscono, viceversa, un obbligo sacro nei confronti dello straniero. [...] Il barbaros rappresenta in un certo senso il rovesciamento o la negazione di ciò che - pur nelle differenze - rende simili tutti gli uomini. Ed è solo questo limite, soltanto nei confronti di figure intrinsecamente antiumane, quali sono i barbaroi, che non solo è consentito sottrarsi alle regole dell’ospitalità, ma è addirittura necessario ricorrere alla violenza estrema del polemos” (p.79).
“Se qualcuno è ‘straniero’, è anche, necessariamente, ‘ospite’, non come effetto di una mia scelta facoltativa, per la quale io posso arbitrariamente trattare l’altro come ospite o lasciarlo semplicemente come straniero, ma perché egli si dà a me come figura che mi obbliga all’ospitalità. Né l’ospitalità dà luogo ad alcun processo assimilativo. Lo xenos è sacro proprio nella sua identità e individualità, altra e irriducibile rispetto a quella di chi lo accoglie” (p.80).
“Platone indica che il nostro essere attuale coincide dunque letteralmente con un frammento della tessera hospitalitatis, con una delle due “parti”, la quale esige di essere completata mediante l’incontro con colui che detiene l’altra parte della tessera stessa. Se non vogliamo restare soltanto porzioni di essere, se intendiamo riconquistare la pienezza originaria, se non ci accontentiamo di un’esistenza puramente simbolica, ma aneliamo all’autenticità della plenitudine, dobbiamo ricomporre la nostra metà con colui che è portatore della parte mancante” (p.95).
“Per riuscire a disattivare la guerra non basta, insomma, che la costituzione civile sia conforme allo ius civitatis e allo ius gentium, poiché occorre anche che essa corrisponda allo ius cosmopoliticum, vale a dire a quel diritto che, pur non essendo facilmente traducibile in un apparato di norme positive, riconosce le condizioni dell’ospitalità universale. Con la precisazione davvero fondamentale, introdotta da Kant quasi per rispondere preventivamente a possibili obiezioni e insieme per fugare possibili equivoci, che ‘qui non è in discussione la filantropia, ma il diritto, sicché l’ospitalità coincide con il ‘il diritto di uno straniero a non essere trattato come un nemico’ ” (p. 115).
“Per tornare a Kant [...] il filosofo sottolinea che “fino a quando lo straniero sta pacificamente al suo posto non si deve agire contro di lui in senso ostile perché egli può rivendicare quel diritto di visita che spetta a tutti gli uomini. Ciò perché originariamente nessuno ha più diritto di un altro ad abitare una località della terra” (p. 117).
“Nel racconto di Camus [l’Ospite] il due compare in maniera insistente, quasi ossessiva, per sottolineare, anche attraverso la reiterazione, la centralità di questo tema nell’intera narrazione. Già nell’esordio Daru scorge in lontananza il profilo dei due uomini che si dirigono verso la sua casa - il gendarme e il prigioniero. La corda con cui Balducci tiene l’arabo mostra fino a che punto essi formino una unità che si regge specificamente sulle loro differenze. L’identità di ciascuno di loro non è concepibile senza il riferimento all’altro. Anche lo status dell’uno si spiega soltanto in rapporto alla condizione dell’altro. Se non fosse prigioniero di Balducci, l’arabo semplicemente non avrebbe alcuna presenza nel racconto. Lo stesso vale per il gendarme, la cui ragion sufficiente sta tutta nell’essere il custode del prigioniero” (p. 129).
“Perturbante è ciò che scaturisce - e costantemente si alimenta - dall’inquietudine legata a questo vacillamento dei confini, alla loro mobilità e porosità, attraverso cui l’altro, l’esterno, ma anche lo spettro e la morte penetrano continuamente, intaccando ogni forma di identità a sé: dell’io, delle sue rappresentazioni, dei suoi saperi” (p.149).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA QUESTIONE FILOLOGICA E ANTROPOLOGICA, EPOCALE.6 agosto 2021, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE FILOLOGICA E ANTROPOLOGICA, EPOCALE:
"L’ #Amore non verrà mai meno": un breve video di @Mode_Valdese con una riflessione e un invito a seguirci - con le opportune restrizioni - nelle attività relative al #sinodovaldese e metodista tra il 22 e il 25 agosto, da Torre Pellice (TO).
"L’ #Amore non verrà mai meno" (1 Cor. 13, 8). Domanda, ma quello antropologico-evangelico o quello andrologico-paolino ("di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo (gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»), e capo di Cristo è Dio": 1 Cor. 11, 1-3).)?! Non è bene precisarlo? Grazie.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DESENCUENTRO. Tenochtitlan 13 agosto 1521.C’è ancora tempo per un’altra modalità di relazione con l’alterità? (di Lucia Capuzzi).).5 agosto 2021, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE... *
Tenochtitlan 13 agosto 1521. Conquistadores, la storia di un grande «desencuentro»
Forse quella dell’America non fu né scoperta né conquista, ma incontro mancato. C’è ancora tempo per un’altra modalità di relazione con l’alterità?
di Lucia Capuzzi (Avvenire, giovedì 5 agosto 2021)
- [Foto] “La conquista di Tenochtitlan”, dipinto anonimo del XVII secolo della serie “La conquista del Messico” conservata presso la Biblioteca del Congresso - Library of Congress/WikiCommons
«Il sole si alza dal tuo letto di ossa [...]. L’alba lacera la cortina. Città, pila di parole rotte». Cinquecento anni dopo la sconfitta dell’impero azteca con la caduta di Tenochtitlan, la lacerante attualità dei versi di Octavio Paz vibra nel corpo giunonico di Città del Messico. Un organismo vivente più che una città. La spugnosa carne coloniale copre viscere dell’antica capitale precolombiana, per essere a sua volta ricoperta da una sottile pelle ultra-moderna. Gli strati coesistono, a volte confliggono, sempre si alimentano a vicenda. In questo flusso incessante, la megalopoli palpita, respira, sussiste. Impossibile separarli senza ucciderla. Una consapevolezza che, però, la città è incapace di tradurre in parole, come dimostra la polarizzazione delle narrative per l’anniversario. Perché implica fare i conti con l’evento che l’ha generata. E che, in fondo, ha generato l’America Latina.
Più ancora del 12 ottobre 1492, fu l’entrata a Tenochtitlan dei conquistadores al seguito di Hernán Cortés a segnare la nascita del mondo nuovo. E con esso il principio dell’età moderna. Fu “scoperta” o fu “conquista”? Fu incontro o fu scontro? Di sicuro, come afferma Tzvetan Todorov, fu l’esperienza più radicale, estrema, intensa di «scoprimento dell’altro». A differenza degli africani o degli asiatici, gli indo-americani e la loro esistenza erano del tutto ignorati dagli europei. Il confronto, dunque, fu di forza inedita. Mai come allora, gli uni e gli altri dovettero affrontare dei “simili diversi”.
Quel 13 agosto 1521 diviene, dunque, in un certo senso, il “parto” - per parafrasare Amalia Podetti - del globo, inteso come totalità. E del nostro tempo. Con tutte le sue contraddizioni. Non per niente, secondo Todorov, nel XVI secolo si è perpetrato il più grande genocidio della storia umana. Il massacro fu inaudito, questo è incontestabile. La sua definizione aritmetica, invece, è oggetto di dibattito tra gli studiosi ma tutti parlano di decine di milioni di esseri umani ingoiati in un vortice di violenza, schiavitù, epidemie. Magari una simile proporzione non fu voluta e intenzionale. Magari la leggenda nera anglobritannica - non proprio neutrale e benintenzionata - ha esagerato dettagli e crudeltà. Magari numerosi leader politici hanno cavalcato e cavalcano la strage per opportunismo. In questo, l’enfasi posta dal presidente Andrés Manuel López Obrador sul cinquecentesimo come sconfitta dei «veri messicani» è emblematica. Peccato che il Messico è - nel bene e nel male - è figlio di Cortés quanto di Monteczuma. Non sono, tuttavia, gli intenti, più o meno raffinati, di minimizzazione ad accelerare l’uscita dall’impasse.
Oltre che oggetto di studio, la mattanza d’America è soggetto di una storia di dolore, impressa, tuttora, nella carne e nel sangue dei discendenti dei nativi. Per costoro gli abusi antichi non sono che l’eco di quelli presenti, poiché la discriminazione e il rifiuto non sono terminati con la colonizzazione né con l’indipendenza né con le rivoluzioni e controrivoluzioni del secolo scorso. Per questo, gli occhi degli attuali maya si sono velati di lacrime nell’ascoltare papa Francesco affermare, a San Cristóbal de las Casas, il 15 febbraio 2016: «Perdono, fratelli! Il mondo di oggi, spogliato dalla cultura dello scarto, ha bisogno di voi!». Curiosa, dunque, l’ostinata richiesta di López Obrador nel domandare delle “scuse” già fatte senza alcuna sollecitazione. Farsi carico della memoria ferita è la grande occasione offerta dall’anniversario. Non solo per riconciliare il passato. In fondo, cinque secoli dopo, l’essere umano si trova di fronte ancora l’enigma di Cortés. Esiste l’uguaglianza al di fuori dell’identità? C’è spazio per una differenza che non implichi la subordinazione? La distruzione di Tenochtitlan ci ha mostrato le conseguenze di una risposta negativa, come quella del conquistador.
Forse, più che scoperta o conquista, quella d’America fu un grande desencuentro, un incontro mancato. Eppure non è l’unica alternativa. Desencuentro, intraducibile in italiano come unica parola, contiene in se la dimensione dell’encuentro, l’incontro. Anche questo ci ha mostrato la storia del Continente. Dieci anni dopo la devastazione dell’impero azteca, non lontano dalle ceneri ancora fumanti di Tenochtitlan, a Tepeyac, una Madonna dalle fattezze indigene scelse il nativo Juan Diego come proprio testimone. Nello sguardo non assimilativo della Morenita si intuisce un’altra modalità di relazione possibile con l’alterità.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,11); "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- BUON COMPLEANNO FLEUR JAEGGY: MATEMATICA E COSTITUZIONE.1 agosto 2021, di Federico La Sala
#DANTE2021
#MATEMATICA
E
#COSTITUZIONE
.Se gli esseri umani sono
"fatti della stessa natura del tempo",
e il #tempo avesse l
a forma del coperchio,
la #paura del cielo
direbbe solo del
rifiuto
di uscire dalla
#selva oscura
e
#nascere!
#Fleur Jaeggy!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AUFKLARUNG E GATTUNGSWESEN. I "TRADITIONIS CUSTODES", IL PROBLEMA DEL LATINO, E LA VIA DELLA "CARITAS" O DELLA "CHARITAS"?!28 luglio 2021, di Federico La Sala
#EUROPA:
#QUESTIONE ANTROPOLOGICA
#FILOLOGICA
E
#ARCHEOLOGICA.
#IMPERATIVO CATEGORICO
E
#SONNO DOGMATICO:
E
#GATTUNGSWESEN.
#DIVINA COMMEDIA:
I #TRADITIONIS CUSTODES,
IL #LATINO,
#CARITAS (#KAPITAS)
O DELLA
#CHARITAS (#XAPITAS)?
***
#QUESTIONE ANTROPOLOGICA
#FILOLOGICA
E
#ARCHEOLOGICA:
#EUROPA.
#DIVINA COMMEDIA (#DANTE2021)
E #SONNO DOGMATICO:
IL PROBLEMA DEL #LATINO
E
I #CUSTODI DELLLA #TRADIZIONE CATTOLICO-ROMANA
(#TRADITIONIS CUSTODES),
QUELLA DELLA
#CARITAS (#KAPITAS)
O DELLA
#CHARITAS (#XAPITAS)?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DELLA "TRAGEDIA" E DELLA "DOTTA IGNORANZA" (DI SOCRATE E DI NICCOLO’ CUSANO).10 luglio 2021, di Federico La Sala
#COSTITUZIONE
#EDUCAZIONE CIVICA
#TRAGEDIA
E
#DIVINA COMMEDIA
#oggi.
Dopo #Dante (1321)
e la #rivoluzione delle #sfere celesti
(#Copernico 1543)
e terrestri
(#Giovanni Valverde, #Anatomia 1560),
celebra ancora la
#dotta ignoranza
di
Socrate
e
Niccolò Cusano
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- VITA, FILOSOFIA, E TEOLOGIA: "IL GIOCO DELLA PALLA" (NICCOLO’ CUSANO).10 luglio 2021, di Federico La Sala
"IL GIOCO DELLA PALLA", SECONDO LA LOGICA "ANDROLOGICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO...:
- "Dico che questo gioco esprime il movimento della nostra anima che va dal suo regno al regno della vita in cui è la quiete e la felicità eterna. Nel centro di questo regno siede, come monarca, Gesù Cristo, nostro re, che ci ha donato la vita. In quanto è simile a noi, egli muove la sfera della sua persona in modo da riposare nel centro della vita. Poiché egli ci ha lasciato il suo esempio, facciamo come egli ha fatto. La nostra palla segua la sua, anche se è impossibile che una palla diversa raggiunga la quiete nel medesimo centro di vita in cui riposa la palla di Cristo. Dentro il circolo ci sono, infatti, infiniti luoghi e fermate. La palla di ognuno si ferma nel punto e nell’atomo suo proprio che nessun altro potrà mai raggiungere"(Niccolò Cusano, Opere filosofiche, Torino, Utet, 1972).
#DANTE2021
E
#ANTROPOLOGIA (#HOMO LUDENS):
IL #GIOCO DELLA #PALLA
(#De ludo globi) DI
#NICCOLO’ CUSANO
riguarda «un gioco scoperto da poco che tutti comprendono facilmente e giocano volentieri»
E
LA #DOCTA IGNORANTIA
-
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DELLA "ANDROLOGIA" E DELLA "COSMOTEANDRIA". Note di storiografia e filologia.9 luglio 2021, di Federico La Sala
#ANTROPOLOGIA,
#FILOLOGIA
E
#STORIA.
#PILATO
(#Ecce Homo gr.: «idou ho #anthropos»),
#SAN PAOLO
(1Cor. 11, 3: "di ogni #uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ]"),
#GIUSEPPEFLAVIO
("Egli era il #Cristo")
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DANTE, PONZIO PILATO, E L’ANDROLOGIA DELLA COSTITUZIONE DOGMATICA DI SAN PAOLO.:3 luglio 2021, di Federico La Sala
Accademia della Crusca
#Parola Di Dante
...viro
(Paradiso XXIV, 34)
- «Ed ella: "O luce etterna del gran viro
- a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi,
- ch’ei portò giù, di questo gaudio miro [...]"»
***
#Beatrice chiede al #proboviro
#SanPietro di verificare
se #Dante ha capito la differenza tra
l’#Ecce Homo dell’#antropologia
(#PonzioPilato: gr. «idou ho #anthropos»)
e
il #vir dell’#andrologia di
#SanPaolo
(#capo della #donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ]: 1 Cor 11,1-3).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "VITA ACTIVA": IL MIRACOLO CHE SALVA IL MONDO. Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità.2 luglio 2021, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA. COME NASCONO I BAMBINI...*
- HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» (Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21). La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987, p. 546).
È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo
Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità
di Sergio Belardinelli (il Foglio, 24 apr 2021)
L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nati 404 mila. Un dato agghiacciante nel suo significato sociale e culturale che a me, come una sorta di riflesso condizionato, richiama alla mente uno dei brani filosofici più intensi che abbia mai letto: “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. È in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”.
Con queste parole Hannah Arendt conclude il capitolo di Vita Activa dedicato all’azione. Si tratta di un brano che cito e commento ormai da quarant’anni, nel quale viene messo a tema un nesso, quello tra la libertà e la natalità, tra la libertà e la vita, col quale, che io sappia, soltanto la Arendt ha avuto l’acutezza e il coraggio di cimentarsi e che, a prima vista, può apparire persino paradossale. La vita infatti, almeno immediatamente, sembra richiamare non tanto la libertà, quanto piuttosto il gigantesco, immutabile ripetersi dei cicli naturali, l’ambito di quelli che il grande biologo Adolf Portmann, autore peraltro assai caro alla Arendt, definirebbe i “rapporti preordinati” - il contrario, quindi, di ciò che in genere intendiamo allorché parliamo di libertà. Quanto poi alla vita specificamente umana, essa, è certo impastata di libertà, ma è anche qualcosa che, a diversi livelli, non dipende da noi, qualcosa di cui, nonostante le tecnologie della riproduzione, non possiamo avere il completo controllo: la riceviamo semplicemente; non scegliamo i nostri genitori, né il luogo dove venire al mondo; dobbiamo fare continuamente i conti con gli altri, con le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre inclinazioni, con quel coacervo di natura, ragione, sentimenti, usi e costumi che vanno a costituire appunto il “gran mare” della vita. La vita insomma pone una serie di condizioni e condizionamenti alla libertà che possono renderla persino impossibile. Eppure, rompendo in un certo senso questa grande catena, è proprio la libertà che dà sapore e specificità alla vita umana; solo la libertà impedisce che il mondo si riduca spinozianamente a “sostanza”, a qualcosa di omogeneo, a qualcosa come un continuo fluire; solo la libertà è capace di introdurre nel mondo un elemento di novità, qualcosa di imprevisto.
Pensieri non nuovi, si potrebbe dire. Ma proprio qui si inserisce la fondamentale postilla arendtiana, preziosa per leggere in una chiave forse inusuale ma certo illuminante anche i dati Istat sulla natalità in Italia da cui siamo partiti: è la stessa vita umana, il nostro venire al mondo, la nascita unica e irripetibile di ciascuno di noi, a rappresentare la prima e più immediata forma di novità, il primo scompaginamento, se così si può dire, della routine della vita.
La facoltà dell’azione, dice la Arendt, “è ontologicamente radicata” nel “fatto della natalità”. In entrambe le dimensioni - la libertà e la natalità - ritroviamo non a caso una costitutiva “novità”, un costitutivo essere insieme agli altri (non si nasce, né si agisce da soli), qualcosa che implica l’accettazione della realtà nella quale siamo e insieme fiducia nel futuro. In questo senso ogni bambino che nasce è un segno di speranza nel mondo; è l’irruzione nel mondo di una “novità”, la cui memoria, è il caso di dire, ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe mai.
Novità, pluralità (gli uomini, non l’uomo abitano la terra, ripete spesso Hannah Arendt) e speranza: questo ci schiude direttamente e in modo straordinario il discorso arendtiano sulla libertà radicata nella natalità. Ma indirettamente, specialmente oggi, tale discorso ci schiude molto di più. Ci fa capire, ad esempio, quale tragedia, anche simbolica, si consuma nel momento in cui un paese come l’Italia registra in un anno un saldo passivo tra morti e nuovi nati di 342 mila unità. È un po’ come se il mondo e la nostra libertà perdessero la speranza, ossia ciò che dà loro sapore, ciò che è insieme accettazione della realtà nella quale viviamo e fiducia nel futuro.
È vero, tutto passa. La vita non è altro che un eterno dissolversi nel gigantesco circolo della natura dove, propriamente, non esiste inizio né fine e dove tutte le cose e gli eventi si svolgono in un’immutabile ripetizione: la mors immortalis di cui parlava Lucrezio. Ma la Arendt non accetta questa mestizia, poiché a suo avviso “la nascita e la morte di esseri umani non sono semplici eventi naturali”; avvengono in un mondo dove vivono altri uomini; un mondo che acquista significato grazie alle loro azioni e ai loro discorsi; un mondo che per questo è sempre aperto alla novità.
Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt, “il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo, naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. Di nuovo l’inizio, dunque, diciamo pure, la natalità.
È proprio perché, in quanto uomini, siamo initium, nuovi venuti, iniziatori, per virtù di nascita che secondo la Arendt, siamo indotti ad agire. La definizione che più si addice agli uomini non è quella di “mortali”, ma piuttosto quella di “coloro che nascono”. In questo modo, quasi per una sottile ironia della sorte, la categoria della natalità diventa fondamentale proprio nel pensiero di un’allieva (e anche qualcosa di più) di Martin Heidegger, l’inventore dell’essere per la morte. Non che la Arendt ovviamente trascuri che la morte rappresenta l’ineluttabile fine di ogni vita umana, solo che, a suo avviso, gli uomini, anche se debbono morire, non nascono per questo, bensì per incominciare. E siamo di nuovo al passo da cui siamo partiti: “Il miracolo che salva il mondo....”.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. --- "ESSERE E TEMPO" E FILOLOGIA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- DALL’ASTROLOGIA ALL’ASTRONOMIA E DALL’ANATOMIA ALL’ANTROPOLOGIA: OLTRE LA "COSMOTEANDRIA".30 giugno 2021, di Federico La Sala
#COSMOLOGIA:
L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE
(#Dante).
*
#Storia dell’#astronomia:
"La conoscenza degli effetti e la ignoranza delle cause produsse l’#astrologia"
(#Giacomo Leopardi).
*
#SapereAude! (#Kant):
#Ingenuity
(Pianeta #Marte, 2021).
*
"IAM REDIT ET #VIRGO"
(#Virgilio).
Nell’approssimarsi dell’#alba, un’ottima sollecitazione:
riascoltare la lezione di
#Stazio
su #come nascono i bambini (Purg. XXV, 34-78)
e
riprendere le ricerche dall’#
Anatomia
di #Giovanni Valverde.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA EPOCALE: IL MATRIMONIO FORZATO, OGGI. Report sulla costrizione o induzione al matrimonio in Italia (di Silvia Guzzetti).).29 giugno 2021, di Federico La Sala
Report . Ventiquattro matrimoni forzati in due anni. Un terzo ha coinvolto minorenni
Il Viminale ha pubblicato il primo rapporto sulle donne costrette a un’unione che non vogliono. Nove casi si sono verificati nei soli primi cinque mesi di quest’anno. In tante come Saman Abbas
di Silvia Guzzetti (Avvenire, lunedì 28 giugno 2021)
- [Foto] Saman Abbas la diciottenne di Novellara scomparsa dopo che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato - Ansa
Quante sono le Saman in Italia? Ovvero quante ragazze sono costrette a matrimoni forzati o uccise perché non vogliono accettarli? È questa una delle domande alle quali cerca di rispondere il primo "Report sulla costrizione o induzione al matrimonio in Italia", curato dal Viminale, secondo il quale dal 9 agosto 2019 al 31 maggio 2021 sono 24 i casi di matrimoni forzati registrati nel nostro Paese, 9 dei quali nei soli primi cinque mesi di quest’anno. È proprio al 9 agosto 2019, infatti, che risale l’entrata in vigore del "Codice rosso", che ha introdotto uno specifico reato con lo scopo di contrastare proprio il fenomeno delle "spose bambine",
Dietro la definizione un po’ arida di "matrimonio precoce" come di una "unione formale nella quale viene coinvolto un minorenne, considerato forzato se quest’ultimo non è in grado di esprimere compiutamente e consapevolmente il proprio consenso non solo per le responsabilità che ci si assume con quell’atto ma anche per il fatto che la sua età le impedisce il raggiungimento della piena maturità e capacità di agire", che è contenuta nel rapporto del Viminale, vi sono anche tante storie tragiche simili a quella di Saman Abbas. La diciottenne, di origine pakistana, abitante a Novellara, è scomparsa dalla fine di aprile e gli inquirenti, che stanno indagando per omicidio e occultamento di cadavere il padre e la madre della ragazza, sospettano che sia stata la famiglia a ucciderla e farla scomparire.
LA SCOMPARSA DI SAMAN
Saman è stata vista per l’ultima volta l’11 aprile quando si è allontanta dal centro protetto nei pressi di Bologna dove viveva dallo scorso dicembre. Aveva voluto tornare a casa sua, forse per prendere alcuni documenti, e non ha più fatto ritorno. Agli assistenti sociali che la stavano seguendo e le avevano garantito un rifugio lontano dall’ambiente oppressivo della sua famiglia, aveva raccontato che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato con un cugino residente in Pakistan. Papà e mamma non riuscivano a perdonare alla figlia di volersi costruire un futuro diverso che comprendesse andare a scuola, viaggiare, lavorare. Le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nei pressi dell’azienda in cui lavorava il padre della ragazza mostrano, la sera del 29 aprile, tre persone provviste di un secchio, un sacco nero per la spazzatura e una pala dirigersi verso il campo che circonda l’abitazione di Saman.
CHE COS’E’ IL MATRIMONIO FORZATO
Storie simili vengono suggerite dalle parole usate dal Report del Viminale. "Il fenomeno del matrimonio forzato ha radici storiche, culturali e talvolta religiose. L’emersione di questo reato non è facile perché spesso si consuma tra le mura domestiche e le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, costrette ad abbandonare la scuola, talvolta obbligate a rimanere chiuse in casa nell’impossibilità di denunciare anche per paura di ritorsioni".
È sempre il Report ad ammettere che "i dati, inevitabilmente, fotografano una situazione sottodimensionata rispetto a quella reale".
Insomma le statistiche senz’altro sottostimano l’incidenza di questo reato. Il rapporto, che è stato curato dalla direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, parla di un 85% dei reati, sempre tra agosto di due anni fa e maggio scorso, riguardanti donne. In un terzo dei casi le vittime sono minorenni (il 9% hanno meno di 14 anni e il 27% hanno tra i 14 e i 17 anni). Ci sono poi le straniere, che sono il 59%, in maggioranza pachistane, seguite dalle albanesi mentre per Romania, Nigeria, Croazia, India, Polonia e Bangladesh si registra una sola vittima.
Nel 73% dei casi gli autori del reato sono stati uomini, anche in questo caso più frequentemente pachistani, seguiti da albanesi, bengalesi e bosniaci. Nel 40% dei casi i responsabili erano di età compresa tra 35 e 44 anni mentre il 27% aveva tra 45 e 54 anni. Il 15% aveva tra 25 e 34 anni.
LA PANDEMIA HA PEGGIORATO LA SITUAZIONE
Sempre il Report del Viminale getta anche uno sguardo globale su questo fenomeno, ricordando che, nel 2020, per effetto delle conseguenze economiche della pandemia, per la prima volta, dopo anni di progressi, si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei matrimoni forzati che stanno coinvolgendo molte adolescenti, soprattutto nell’Asia meridionale, nell’Africa centrale e nell’America Latina.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DANTE ALIGHIERI (2021), L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE, E IL "PADRE NOSTRO".28 giugno 2021, di Federico La Sala
Tweet
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza (Mc 12,29-30)
#Questione Antropologica.
La cit. di Mc 12, 29-30 ha un senso andrologico (e cosmo-te-andrico) o antropologico,
come il #Padre di ogni essere umano (#PonzioPilato: #Ecce homo),
quell’#Amore (di #Dante Alighieri),
che muove il #sole e le altre #stelle -
e anche la #Terra?!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DELLA COSMOTEANDRIA: ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E ANDROLOGIA..27 giugno 2021, di Federico La Sala
#ANTROPOLOGIA e #FILOLOGIA:
TRASFIGURAZIONE DI CRISTO (BEATO ANGELICO, 1437-1446).
#PONZIO PILATO
(«#Ecce #homo»: gr. «idou ho #anthropos»),
#PAOLO DI TARSO
("di ogni uomo il capo è Cristo, e
#capo della donna è l’uomo [«uomo»: gr. ἀνήρ, ἀνδρός], e
capo di Cristo è Dio" - 1Cor. 11, 1-3),
e
(LEONARDO DA VINCI).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E ANATOMIA. Salute riproduttiva: "Fertilità femminile" e "Fertilità maschile" (di Ministero della Salute).22 giugno 2021, di Federico La Sala
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA (2008) "NON CLASSIFICATA"!!!
SALUTE RIPRODUTTIVA
Fertilità femminile *
- [Foto] Immagine di una donna con un bambino in braccio
Le cellule riproduttive femminili (ovociti), a differenza di quelle maschili (spermatozoi), vengono prodotte prima della nascita, durante lo sviluppo degli organi genitali.
Nel corso della vita questa "riserva" si riduce poi progressivamente mensilmente fino ad esaurirsi del tutto (menopausa). Ogni donna nasce con 1-2 milioni di follicoli e alla pubertà ne rimangono 500.000. Solo 500 di questi escono dall’ovaio e gli altri si distruggono.
Il sistema riproduttivo femminile dipende dal ciclico reclutamento follicolare, dalla selezione di un unico follicolo dominante, dall’ovulazione e dalla formazione del corpo luteo. Se la fecondazione e di conseguenza l’impianto non avvengono, il corpo luteo scompare, l’endometrio si sfalda e compare la mestruazione.
Dalla pubertà alla menopausa, circa ogni mese, quindi, il corpo femminile si prepara ad un’eventuale gravidanza. Se questa non avviene, compare una nuova mestruazione. Il ciclo mestruale ha una durata variabile tra i 21 e i 35 giorni. Mediamente è di 28 giorni, ma nell’adolescente può essere spesso irregolare.
Dal secondo giorno dall’inizio delle mestruazioni, comincia la cosiddetta fase follicolare: i follicoli che portano a maturazione la cellula uovo si attivano nuovamente, sia per far maturare l’ovocita sia per provvedere alla sintesi degli ormoni (estrogeni e progesterone) necessari per ricostituire l’endometrio.
Intorno al 14° giorno avviene invece l’ovulazione, momento in cui possono avvenire la fecondazione e il concepimento. Il periodo fertile dura circa due giorni (durata in vita della cellula uovo).
Gli spermatozoi sopravvivono invece nel corpo femminile molto di più, anche fino a 4 giorni, per cui un rapporto sessuale avvenuto anche 3 o 4 giorni prima dell’ovulazione può portare alla fecondazione. Per tutto il periodo fertile, quindi, la fecondazione è possibile. Dopo l’uscita della cellula uovo il follicolo si trasforma nel corpo luteo, che produce progesterone, per predisporre l’utero a ricevere l’impianto della cellula uovo fecondata.
Questa fase del ciclo si chiama fase luteale o secretiva. In caso di mancata fecondazione l’uovo viene espulso con la mestruazione. La perfetta sincronia della fisiologia femminile è peraltro continuamente minacciata da insulti o da difetti ad esempio patologie endocrine ovariche od extraovariche che possono ad esempio inficiare l’ovulazione rendendo pertanto la donna infertile o subfertile.
Con l’aumentare dell’età, nella donna si verifica non solo una progressiva riduzione del patrimonio follicolare ma anche un aumento percentuale di ovociti con alterazioni cromosomiche, che mensilmente vengono messi a disposizione dell’ovaio stesso.
Anche l’utero subisce un deterioramento funzionale che riduce la capacità dell’endometrio di interagire con l’embrione e favorisce la possibilità di aborti spontanei; inoltre si registra un incremento dell’incidenza di patologie quali endometriosi e fibromi che ulteriormente riducono la fertilità.
FONTE: [MINISTERO DELLA SALUTE. Data ultimo aggiornamento 17 settembre 2020. (ripresa parziale, senza immagine).
SALUTE RIPRODUTTIVA
Fertilità maschile
- [Foto] Immagine di un uomo con un bambino in braccio
Lo spermatozoo è la cellula riproduttrice dell’uomo, fondamentale per la sua fertilità, in quanto incontrandosi con l’ovocita femminile da origine all’embrione.
La spermatogenesi e la produzione di testosterone sono regolati da un sistema integrato di controllo. L’ipotalamo, attraverso la secrezione pulsatile dell’ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH), controlla la secrezione ipofisaria dell’ormone follicolo-stimolante (FSH) e dell’ormone luteinizzante (LH) i quali a loro volta stimolano il testicolo a produrre rispettivamente gli spermatozoi e il testosterone.
Il testicolo è costituito da due compartimenti distinti, anche per funzioni: quello tubulare dove si trovano le cellule di Sertoli e gli spermatozoi in diversi stadi di maturazione, e quello interstiziale con le cellule di Leydig deputate alla produzione di testosterone. La spermatogenesi è un processo complesso che culmina con la produzione degli spermatozoi maturi e ha una durata di circa 74 giorni.
Le cellule di Sertoli sono importanti per il sostentamento delle cellule della linea seminale e per la loro normale maturazione.
Gli spermatozoi da stadi più immaturi progrediscono dalla base al centro del tubulo seminifero (lume) secondo i diversi stadi di maturazione (spermatogonio, spermatocita, spermatide e spermatozoo).
Gli spermatozoi lasciano i testicoli attraverso un sistema di dotti:
- rete testis
- epididimo
- vaso deferente
e raggiungono le vescichette seminali che, con le loro caratteristiche secrezioni, insieme alla prostata, contribuiscono alla formazione di gran parte del volume finale dell’eiaculato e fungono anche da contenitore tra un’eiaculazione e la successiva. Chiaramente una qualsiasi disfunzione o blocco della spermatogenesi o danno di queste strutture può comportare alterazioni della fertilità.
FONTE: [MINISTERO DELLA SALUTE. Data ultimo aggiornamento 17 settembre 2020. (ripresa parziale, senza immagine).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva....
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
VIVA L’ITALIA!!! Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA (NON "ANDROLOGICA"). “Bibbia e Corano, un confronto. Comincio da una precisazione rilevante: i testi sacri sono in realtà tre” (di Piero Stefani).7 giugno 2021, di Federico La Sala
Intervista - "Letture" *
“Bibbia e Corano, un confronto” di Piero Stefani
Prof. Piero Stefani, Lei è autore del libro Bibbia e Corano, un confronto edito da Carocci: quanto sono simili i due testi sacri?
Comincio da una precisazione rilevante: i testi sacri sono in realtà tre. Occorre infatti distinguere tra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana. Uno stereotipo ancora abbastanza diffuso parla di Bibbia e Vangelo. In realtà, esistono la Bibbia ebraica, e la Bibbia cristiana formata da Antico e Nuovo Testamento. I libri dell’Antico Testamento, salvo alcuni casi particolari, coincidono con quelli della Bibbia ebraica; tuttavia in questo caso si è trattato non di aggiungere alcuni libri a quelli precedenti bensì di creare un insieme da leggere e interpretare in maniera diversa.
La somiglianza più profonda è che Bibbia e Corano sono sacri soltanto a motivo dell’esistenza di tre comunità che li considerano tali, in quanto li ricevono, li leggono nella liturgia, li commentano e li trasmettono. Tutte e tre le comunità religiose condividono la convinzione che, nel corso della storia, Dio abbia fatto giungere agli esseri umani parole destinate in seguito ad assumere una forma scritta. Ciò è avvenuto grazie a specifici mediatori che hanno trascritto nella “lingua degli uomini” la volontà di Dio. Per ricorrere alla classificazione consueta, ebraismo, cristianesimo e islam sono «religioni rivelate». Tra esse ci sono molte e non lievi differenze, ma tutte emergono a partire da questo terreno comune. Le si può paragonare a un bosco in cui ci sono alberi molto differenti tra loro, anzi a volte uno di essi fa ombra a un altro, tutti però condividono lo stesso suolo.
Quali sono i più significativi punti comuni tra Bibbia e Corano?
Il primo, irrinunciabile punto in comune è che Dio è definito creatore. Ciò significa che la realtà nel suo insieme ha avuto inizio a causa di un atto libero di Dio. Per tutte e tre non si tratta di dimostrare l’esistenza di Dio a partire da quanto sperimentiamo in noi e attorno a noi; quanto affermato dalle tre religioni è che in noi e attorno a noi ci sono segni dell’opera creatrice di Dio. Per così dire, il Cantico delle creature di Francesco di Assisi esprime un convincimento comune a ebrei, cristiani e musulmani. Per tutte e tre le tradizioni religiose, specie di età moderna, nasce poi il problema di sapere come confrontarsi con la visione del cosmo e della natura proposta dalla ricerca scientifica. Qui le strategie sono in parte diverse.
Altro punto accomunante è che Dio abbia comunicato agli esseri umani delle leggi (per limitarci a un solo esempio, si pensi ai “Dieci comandamenti”) volte a regolare sia i rapporti interni alle singole comunità religiose sia quelli con le altre persone e società. In questo caso ci si deve confrontare con il problema di quale rapporto esista tra queste leggi credute di origine divina e i tempi storici in cui sono sorte. Nasce poi anche l’interrogativo di quale sia la relazione tra le leggi di natura divina e quelle, fondate su altri principi, che regolano la società civile. La questione è accomunante, le risposte sono invece molteplici e spesso non concordi. Sono tali non soltanto tra ebraismo, cristianesimo ed islam, ma anche tra i vari gruppi o membri interni alle singole comunità religiose.
Le tre grandi religioni monoteiste fondano sulla rivelazione divina la propria dottrina, tanto da meritare l’appellativo di ‘popolo del libro’: come definiscono, i due testi sacri, la comunità dei credenti?
Come accennato in precedenza è vero che tutte e tre le comunità hanno testi sacri, tutt’altro che certo è invece che le si possa chiamare concordemente «popolo del libro». Per limitarmi a un solo esempio, per il cristianesimo la fonte prima della rivelazione è Gesù stesso, di cui i Vangeli sono memoria e testimonianza. Si può affermare che tanto l’ebraismo quanto il cristianesimo definiscono i loro rispettivi testi sacri in modo gerarchizzato.
 La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
La Bibbia ebraica è costituita da tre parti: Torah (Legge, con parola derivata dal greco, detta Pentateuco), Neviim (Profeti) e Ketuvim (Scritti). Il ruolo decisivo è svolto della prima parte; nell’armadio sacro presente in ogni sinagoga è contenuta, non a caso, solo una copia manoscritta della Torah, l’unica che fonda i precetti osservati dagli ebrei.
 Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli.
 Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.
Il Corano ha avuto invece un processo redazionale molto più breve misurabile in qualche decennio. La sua scansione interna è tra sure (capitoli) “fatte scendere” (cioè rivelate) a Mecca e quelle, cosiddette medinesi, risalenti a un periodo successivo all’egira (622 d.C.). I contenuti del Corano si suddividono in annunci, narrazioni e leggi; queste ultime, che incidono maggiormente sulla vita della comunità, risalgono al periodo finale della vita di Muhammad, quando il Profeta esercitava già una forma di governo.L’espressione «comunità dei credenti» calza bene per cristiani e musulmani in quanto l’appartenenza alla Chiesa e all’ Umma (comunità musulmana) presuppone la fede, meno agli ebrei che costituiscono un popolo vero e proprio, non a caso si è ebrei innanzitutto per nascita (secondo una discendenza matrilineare).
Come descrivono Bibbia e Corano l’origine del male?
Vi è una dimensione accomunante che individua l’origine del male nella trasgressione. Come ben compreso da Paolo nella Lettera ai Romani, perché ci sia una trasgressione bisogna che prima ci sia una legge o un comando. Occorre quindi trovare miti fondativi che si muovano in questa direzione; il più noto è quello della proibizione di mangiare l’albero della conoscenza del bene e del male. Non è difficile comprendere il suo valore simbolico incentrato propria sulla connessione tra divieto e violazione. Al pari di prospettive presenti nell’apocalittica tanto giudaica quanto cristiana, il Corano pensa a una violazione antecedente a quella compiuta dalle creature umane. Ecco allora irrompere il peccato angelico, nell’islam connesso alla figura di Iblis, angelo superbo e disobbediente. D’altra parte conviene riflettere sul fatto che una trasgressione c’è eppure non ci dovrebbe essere; in questo senso si vede chiaramente la sua connessione con il male, altra realtà che c’è ma non dovrebbe esserci. Individuare la radice del male nella trasgressione porta con sé però altri problemi: chi spinge a trasgredire? Ecco allora che si “personalizza” il peccato, presentandolo come una forza che induce a compiere atti brutali. Sia per la Bibbia sia per il Corano la storia di Caino rappresenta il simbolo più conosciuto di tutto ciò: quando uccise il fratello, il primo fra i nati da donna non aveva ricevuto il comando di non uccidere.
Aumentare a dismisura la forza del peccato o della tentazione come causa del male rischia però di fa scivolare la visione di insieme verso una forma troppo prossima al dualismo, vale a dire di prospettare l’esistenza di un Dio del male; ecco allora che in alcuni passi sia biblici sia coranici si legge che Dio crea il male (Isaia 45,7). Affermazione che non va assolutizzata ma neppure del tutto accantonata. La presenza del male rappresenta per tutti uno scoglio complesso.
In che modo Bibbia e Corano affrontano il tema della resurrezione dei morti?
Il tema è presentato in maniera per così dire defilata nella Bibbia ebraica, infatti lo si trova con chiarezza solo nel tardo e apocalittico libro di Daniele (che nella Bibbia ebraica non è annoverato neppure tra i libri profetici). La resurrezione dei morti svolge invece un ruolo centrale nel Nuovo Testamento; il motivo è evidente: il kerygma - cioè l’annuncio originario e fondamentale della fede - ha il proprio centro nella «buona novella» di Gesù Cristo morto e risorto. Come stabilito in modo definitivo da Paolo, per la fede cristiana vi è un legame inscindibile tra la risurrezione di Gesù Cristo e quella dei salvati. Anche per questo motivo nel cristianesimo, per quanto sia stato affermato più volte e venga attestato anche da alcuni passi neotestamentari, suscita sempre sconcerto la prospettiva secondo la quale ci sono dei risorti destinati alla dannazione eterna. Nel Corano la resurrezione dei morti è affermata in maniera forte e inequivocabile. Per trovarne il fondamento basta rifarsi alla perenne attività del Dio creatore: Allah, che ha plasmato l’uomo dalla polvere, è ben capace di dare nuova vita a ossa disseccate. La resurrezione è però intrinsecamente legata al giudizio in virtù del quale si è o beati o dannati; una prospettiva tanto presente nell’islam da essere anticipata da una specie di interrogatorio che avviene dentro le tombe.
Piero Stefani, di formazione filosofica, insegna “Bibbia e cultura” presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano e “Diritto ebraico” all’Istituto internazionale di Diritto Canonico e Diritto comparato delle religioni dell’Università della Svizzera Italiana. È segretario generale di Biblia, associazione laica di cultura biblica. Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano Il grande racconto della Bibbia, il Mulino 2017 e per Carocci I volti della misericordia (2015).
* Fonte: Letture.org
Nota:
- "Per il cristianesimo il vertice è invece costituito dai quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi). Essi sono incentrati sulla vita pubblica, morte e resurrezione di Gesù. I Vangeli sono colti come una specie di chiave interpretativa per leggere in modo unitario un libro, la Bibbia, composto da un vasto insieme di testi molto vari per origine e provenienza, sorti in un arco di tempo di parecchi secoli" (Piero Stefani).
Al vertice del "cristianesimo" (cattolicesimo costantiniano), in realtà, non ci sono - come sostiene Piero Stefani - i "quattro Vangeli canonici (nella liturgia cattolica proclamati solo da un sacerdote o da un diacono e ascoltati stando in piedi)", ma - fondamentalmente - ma le lettere (e l’interpretazione "andrologica" della figura di Cristo) di Paolo di Tarso:
 "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).Federico La Sala
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE --- COSMO E ANTROPOLOGIA. Annuncio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’astronauta Samantha Cristoforetti prima donna in Europa a guidare una stazione spaziale.28 maggio 2021, di Federico La Sala
Cristoforetti prima donna in Europa a guidare una stazione spaziale *
Nel 2022 Samantha sarà lanciata verso la "base" dalla Florida: "E’ un onore, coordinerò una squadra eccezionale"
- [Foto] Cristoforetti prima donna in Europa a guidare una stazione spaziale (ansa)
L’astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS). E la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022. Lo annuncia l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
AstroSamantha si dice "onorata" della nomina. "Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore di per sé", afferma l’astronauta. "Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita".
Come membro dell’equipaggio "Crew-4" insieme agli astronauti NASA Kjell Lindgren e Bob Hines, nel 2022 Samantha sarà lanciata verso la Stazione Spaziale dalla Florida, USA, su un veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX. Questa sarà la seconda missione spaziale di Samantha. L’esperienza maturata in questi anni le sarà sicuramente utile per il suo nuovo ruolo.
Il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha spiegato che "la nomina di Samantha al ruolo di comandante della ISS è un’ispirazione per un’intera generazione che sta concorrendo per entrare nel corpo astronauti dell’ESA. Non vedo l’ora di incontrare i candidati finali e colgo l’occasione per incoraggiare ancora una volta le donne a farsi avanti".
* Fonte: la Repubblica, 28 Maggio 2021
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- IL CARDINALE CUSANO, ESCHILO, E DANTE ALIGHIERI.24 maggio 2021, di Federico La Sala
#DIVINACOMMEDIA E
#NiccoloCusano,
per indicare la #via alla "#Visione di Dio" (1454), si serve di
un quadro dell’artista Rogier Van der Wayden,
allievo di Robert #Campin,
autore del #TritticodiMerode
***
Con #Virgilio e #Beatrice (#dueSoli),
#NiccoloCusano,
(«Non è la madre che genera chi è chiamato figlio, ma solo nutrice è del seme gettato in lei»)
non esce dall’orbita
della #tragedia (#Eschilo).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- «Colonizzazione immaginaria dell’inspiegato». Così Stefano Levi Della Torre definisce la religione in un piccolo volume dal titolo lapidario: Dio (di S. Massironi).).7 maggio 2021, di Federico La Sala
LA "DOTTA IGNORANZA" E L’IMMAGINARIO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA.... *
Dio secondo Stefano Levi Della Torre
Dal nostro lato
- [Foto] Cristo Pantocratore (mosaico, Duomo di Monreale, Palermo, 1176,)
di Sergio Massironi *
«Colonizzazione immaginaria dell’inspiegato». Così Stefano Levi Della Torre definisce la religione in un piccolo volume dal titolo lapidario: Dio (Torino, Bollati Boringhieri, 2020, pagine 160, euro 12). Voce di un ebraismo laico, culturalmente ricco e poliedrico, l’autore non va oltre le convinzioni di Feuerbach e, pur muovendosi a suo agio nel Novecento scientifico e filosofico, rimane fermo nell’idea ottocentesca per cui Dio non è che proiezione degli uomini. E solo per questo interessante: «Dio rappresenta una domanda, anche se si vorrebbe fosse una risposta». A chi non provi fastidio per un agnosticismo dogmatico - inconfessato quanto rigoroso - il volume sarà di nutrimento, dal momento che dell’idea di Dio consente un’ampia recensione, lontana dall’inaccessibilità linguistica di molta teologia. Pagine che si divorano, nel dinamismo multidisciplinare con cui attraversano la tradizione occidentale. All’insegna, certo, di un criterio di lettura fermo e coerente, elemento di forza e insieme di debolezza del libro: «Che il mistero esista è una constatazione di cui fa fede la nostra ignoranza. Non l’ignoranza di ciò che ancora non sappiamo, ma che un giorno sapremo, bensì l’ignoranza inamovibile. L’ignoranza del perché del tutto, essendo il perché un interrogativo che si agita ma entro i limiti umani della nostra mente, preoccupata di dare al tutto un senso, cioè un movente e un fine».
Bonhoeffer e con lui la migliore teologia del secolo scorso hanno mostrato lo scarto tra il “Dio tappabuchi”, a cui Levi Della Torre non rileva alternativa, e un Dio al centro del mondo conosciuto, delle cose sapute, della vita vissuta: il Dio che in Cristo sospende le proiezioni umane e dice altrimenti di sé. Non lasciare che Dio parli chiude, prima che inizi, il riflettere “teo-logico”, ma ciò nonostante il volume tocca i nodi della modernità. Quest’ultima ha incorporato, spesso inconsapevolmente, molti effetti della novità cristiana. Primo fra tutti il valore del soggetto, nella sua autonomia e maturità che, per quanto opposte in senso emancipativo a un’idea di legge e a un’esperienza di potere troppo spesso eteronome, hanno una radice biblica. Dove biblica significa trascendente, destabilizzante le proiezioni umane, figlie a loro volta di una cultura e di un immaginario tutt’altro che a noi connaturati. Si tratta, insomma, di spingere più a fondo le intuizioni che legano il nostro autore alla sua genealogia ebraica: «Il Dio della Bibbia sa benissimo che il suo popolo cade a ogni passo nell’idolatria, ingannato dalle varie forme di essa in cui non sa ogni volta riconoscerla, dal fondamentalismo al nazionalismo. Dio sa di essere lui stesso una tentazione idolatrica, per questo dice: non pronunciate il mio Nome». Questa coscienza, che ha statura di conoscenza, oppone alle facili soluzioni agnostiche una via difficile e non idolatrica di incontro con l’Altro. Presente nel libro come un seme nascosto, può dal lettore essere coltivata.
Levi Della Torre offre in tale direzione, quasi suo malgrado, non pochi squarci che motivano e rimettono in cammino. La stima per il Lògos è più decisiva, infatti, delle conclusioni che l’autore presume logiche. Così, chi rifiuti di veder relegata la propria religiosità nei territori dell’irrazionale, apprezzerà e sosterrà il “dia-logo”, almeno interiore, che il volume innesca.
 In effetti, secondo il Salmo 62, «una parola ha detto Elohim, due ne ho ascoltate: l’una è la Parola di Dio, l’altra la parola umana, a reciproca testimonianza». Di qui la complessità di ogni via anti-idolatrica. «Dal “suo lato” (mitisidò, in ebraico), dal lato cioè della sua essenza imperscrutabile, Dio è unico e unitario; dal “nostro lato” (mitsidenu, in ebraico), ci si presenta secondo diversi aspetti, secondo quanto ciascuno sappia intuire e interpretare, mentalmente e in pratica. E quando la voce del Roveto in Esodo 3, 14 dice ehijé asher ehijé e ne cogliamo la forma al futuro, potremmo tradurre “sarò Colui che sarò”. Alla luce di Esodo 15, secondo cui il Dio unico è inteso “dal nostro lato” secondo l’intendimento di ciascuno, potremo allora interpretare: “Sarò quello che tu saprai farmi essere per te”».
In effetti, secondo il Salmo 62, «una parola ha detto Elohim, due ne ho ascoltate: l’una è la Parola di Dio, l’altra la parola umana, a reciproca testimonianza». Di qui la complessità di ogni via anti-idolatrica. «Dal “suo lato” (mitisidò, in ebraico), dal lato cioè della sua essenza imperscrutabile, Dio è unico e unitario; dal “nostro lato” (mitsidenu, in ebraico), ci si presenta secondo diversi aspetti, secondo quanto ciascuno sappia intuire e interpretare, mentalmente e in pratica. E quando la voce del Roveto in Esodo 3, 14 dice ehijé asher ehijé e ne cogliamo la forma al futuro, potremmo tradurre “sarò Colui che sarò”. Alla luce di Esodo 15, secondo cui il Dio unico è inteso “dal nostro lato” secondo l’intendimento di ciascuno, potremo allora interpretare: “Sarò quello che tu saprai farmi essere per te”».
 Questo approccio, che rappresenta una vera e propria postura, un modo rivoluzionario di abitare la realtà, è più fedele al Lògos e alla sua luce di quanto non si sperimenti sul binario morto in cui il volume conclude la sua corsa. L’approccio positivista, infatti, si conferma impossibilitato a tenere insieme ciò che l’autore sino all’ultimo contrappone: i Lumi della conoscenza e il buio dell’ignoranza, i territori sicuri della scienza (e della democrazia) e il caotico abisso che sospingerebbe alla fede. «Il prevalere del paradigma della proporzione tra causa ed effetto ha animato la secolarizzazione moderna. La sua intelligibilità, non solo scientifica, ma anche empirica, ha favorito la democratizzazione del sapere e lo sviluppo della coscienza individuale. [...] Paradossalmente, il paradigma fluido, che sembra quello più attuale a livello scientifico e filosofico, ha risvolti affini al modo antico di percepire il mondo. L’indeterminato, lo smisurato, la sproporzione, ispiravano in antico il senso del sacro, e quindi la religione per sua interpretazione, contenimento e riduzione alla misura umana. Oggi il non sapere, o l’eccesso di informazione in cui l’arbitrio dell’opinione si sente legittimato a prevalere sul sapere, il senso di andar perdendo il controllo cognitivo degli eventi e della propria vita ripropone forse l’inquietudine del sacro e quindi forme religiose e di fede, nuove o tradizionali, a suo rimedio».
Questo approccio, che rappresenta una vera e propria postura, un modo rivoluzionario di abitare la realtà, è più fedele al Lògos e alla sua luce di quanto non si sperimenti sul binario morto in cui il volume conclude la sua corsa. L’approccio positivista, infatti, si conferma impossibilitato a tenere insieme ciò che l’autore sino all’ultimo contrappone: i Lumi della conoscenza e il buio dell’ignoranza, i territori sicuri della scienza (e della democrazia) e il caotico abisso che sospingerebbe alla fede. «Il prevalere del paradigma della proporzione tra causa ed effetto ha animato la secolarizzazione moderna. La sua intelligibilità, non solo scientifica, ma anche empirica, ha favorito la democratizzazione del sapere e lo sviluppo della coscienza individuale. [...] Paradossalmente, il paradigma fluido, che sembra quello più attuale a livello scientifico e filosofico, ha risvolti affini al modo antico di percepire il mondo. L’indeterminato, lo smisurato, la sproporzione, ispiravano in antico il senso del sacro, e quindi la religione per sua interpretazione, contenimento e riduzione alla misura umana. Oggi il non sapere, o l’eccesso di informazione in cui l’arbitrio dell’opinione si sente legittimato a prevalere sul sapere, il senso di andar perdendo il controllo cognitivo degli eventi e della propria vita ripropone forse l’inquietudine del sacro e quindi forme religiose e di fede, nuove o tradizionali, a suo rimedio».E invece la via di Israele è quella di un luminoso conoscere che sospinge alla fede, come emblematicamente colto da un autore (troppo poco) citato: quel Nicolò Cusano che da gigante dell’Umanesimo mise le basi di un’altra modernità, ancora da esplorare. Una modernità che non separa, ma connette, che coglie in Cristo la coincidenza degli opposti e la leggibilità di un universo dai forti tratti d’imponderabilità. La via intravista dal cardinal Cusano, troppo ardita per la sua stessa Chiesa, coltivando approcci multidisciplinari e persino contraddittori radica in Dio dignità e responsabilità di ogni soggetto umano.
 D’altra parte, Stefano Levi Della Torre intuisce come sin dalla prima pagina della Genesi (in ebraico bereshit) il discorso biblico disponga della chiave smarrita dalla moderna illusione di un sapere oggettivo. Seconda lettera dell’alfabeto ebraico, «la beth di bereshit ci avverte che quell’“in principio” non è proprio l’inizio, ma piuttosto un cambiamento di stato. Sottotraccia, è l’esito di una grande battaglia tra l’informe e la forma, tra il disordine e l’ordine, tra il tohu vavohu (massa tenebrosa, vorticosa, caotica) e l’intelletto divino, e quindi di quello umano, che è “a sua immagine e somiglianza”. Una battaglia mai finita; anzi, è sempre in atto, vi siamo immersi». Ecco la chiave che riapre le conclusioni del libro e impedisce di leggerci su un binario morto. Il Dio biblico non sta sul lato della massa tenebrosa e chiama alla sua somiglianza.
D’altra parte, Stefano Levi Della Torre intuisce come sin dalla prima pagina della Genesi (in ebraico bereshit) il discorso biblico disponga della chiave smarrita dalla moderna illusione di un sapere oggettivo. Seconda lettera dell’alfabeto ebraico, «la beth di bereshit ci avverte che quell’“in principio” non è proprio l’inizio, ma piuttosto un cambiamento di stato. Sottotraccia, è l’esito di una grande battaglia tra l’informe e la forma, tra il disordine e l’ordine, tra il tohu vavohu (massa tenebrosa, vorticosa, caotica) e l’intelletto divino, e quindi di quello umano, che è “a sua immagine e somiglianza”. Una battaglia mai finita; anzi, è sempre in atto, vi siamo immersi». Ecco la chiave che riapre le conclusioni del libro e impedisce di leggerci su un binario morto. Il Dio biblico non sta sul lato della massa tenebrosa e chiama alla sua somiglianza.
 La chiave sta in un pronome bistrattato, cui sono legate le sorti della modernità e della stessa rivelazione biblica. «Se la seconda lettera, la beth, non designa un inizio assoluto, la prima lettera, l’alef, in qualità iniziale compare a un certo punto, nel mezzo della narrazione biblica con la parola anokhì, “io”. Una prima volta lo dice Adam di sé in Gen 3, 10; un’altra volta lo dice Dio sul Sinai, in apertura delle “Dieci Parole” [...]. Questo anokhì in cui sia l’uomo sia Dio riconoscono se stessi come soggettività [...] non nasce dall’inerzia, ma dallo sforzo di un distacco e di una nascita della coscienza di se stessi, a confronto con l’altro e col tu». La via difficile implica che “Dio” e “io” vivano solo insieme. In modo ben più serio e vertiginoso dell’essere l’uno illusione o proiezione dell’altro.
La chiave sta in un pronome bistrattato, cui sono legate le sorti della modernità e della stessa rivelazione biblica. «Se la seconda lettera, la beth, non designa un inizio assoluto, la prima lettera, l’alef, in qualità iniziale compare a un certo punto, nel mezzo della narrazione biblica con la parola anokhì, “io”. Una prima volta lo dice Adam di sé in Gen 3, 10; un’altra volta lo dice Dio sul Sinai, in apertura delle “Dieci Parole” [...]. Questo anokhì in cui sia l’uomo sia Dio riconoscono se stessi come soggettività [...] non nasce dall’inerzia, ma dallo sforzo di un distacco e di una nascita della coscienza di se stessi, a confronto con l’altro e col tu». La via difficile implica che “Dio” e “io” vivano solo insieme. In modo ben più serio e vertiginoso dell’essere l’uno illusione o proiezione dell’altro.* Fonte: L’ Osservatore Romano, 04 febbraio 2021
Nota:
L’IMMAGINARIO DELLA CHIESA CATTOLICO-ROMANA:
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, La Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
AL DI LA’ DELLA "DOTTA IGNORANZA" DEL CARDINALE CUSANO E DELLA "TEORIA" DEL "TRITTICO DI MERODE":
#MENSCHWERDUNG. - #Come nascono i bambini: ripartendo dal #sapere di non sapere,
 Niccolò Cusano ricade nella #antropologia zoppa e cieca di #Aristotele
e propone nella #Docta Ignorantia (III, 5) del 1440 la visione (#teoria) del trittico di Merode (1427).
Niccolò Cusano ricade nella #antropologia zoppa e cieca di #Aristotele
e propone nella #Docta Ignorantia (III, 5) del 1440 la visione (#teoria) del trittico di Merode (1427).FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- KANT E WITTGENSTEIN: SAPERE AUDE! "La dignità di un pensiero è data dal suo coraggio e dal coraggio che sa infondere. Il resto è vanità" (di Federico Ferrari).17 aprile 2021, di Federico La Sala
Del coraggio. L’abc di Wittgenstein
di Federico Ferrari *
- “Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri.
- Alcuni costano molto altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri?
- Credo con il coraggio.”
- Ludwig Wittgenstein
Pensare significa avere coraggio. Affrontare le proprie paure, il proprio fondo di inautenticità. Non farsi mai sconti e, indifferenti al quieto vivere, non farli nemmeno agli altri. C’è della crudeltà nel coraggio, una forma di doloroso accanimento. L’impossibilità di tacere, di non dire esattamente quel che va detto, costi quel che costi. Il coraggio si paga. Rovina i rapporti umani. Spinge nella solitudine. Ma il coraggio ci rende un po’ meno pagliacci di quel che naturalmente siamo. Ci offre l’opportunità di diventare uomini e donne decenti - ein anständiger Mensch, scrive Wittgenstein, concependo il pensiero come un impietoso autosmascheramento. Il coraggio e la decenza sono due facce di una medesima medaglia. L’indecenza di ogni tempo nasce dalla mancanza di coraggio. Politici senza coraggio, intellettuali senza coraggio, uomini senza coraggio: la fine di una civiltà.
Poco importa se la lotta coraggiosa per difendere la propria dignità, le proprie idee, la propria esistenza non porterà a nulla, non cambierà il mondo. Il mondo non cambierà mai davvero. Il mondo è solo l’eterno confronto e scontro tra pavidi e coraggiosi. Tra coloro che salgono sul carro dei vincitori, in cerca di consenso, e coloro che percorrono il tempo sempre controvento, in cerca di se stessi. Questo scontro avviene in ogni luogo, in ogni momento e sempre, anche, in noi stessi.
La cosa più difficile non è essere all’altezza del mondo, ma all’altezza di se stessi. E’ abbastanza semplice non deludere gli altri. Molto più complesso non deludere se stessi. Pensare, dire, a volte, tacere coraggiosamente è un modo di darsi dignità, un modo di riconoscere la propria irripetibile unicità.
La dignità di un pensiero è data dal suo coraggio e dal coraggio che sa infondere. Il resto è vanità.
Questo testo è solo un eco (e un ricordo riconoscente) della prefazione di Aldo G. Gargani ai Diari segreti di Ludwig Wittgenstein (Laterza, 1987), letti molti anni fa e mai dimenticati.
* Fonte: Antinomie, 24/11/2020 (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- WITTGENSTEIN E "IL MISTERO PROFONDO": UNA QUESTIONE TUTTA DA RIAPRIRE, SUL FILO DELL’ARCHIVIO RITROVATO.
NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": LA LEZIONE DI DANTE (E NIETZSCHE), OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Ripartire da Cusano, il sapiente che sa di non sapere (di Simone Paliaga).16 aprile 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, MATEMATICA, E IL PROBLEMA DELL’UNO: "DOCTA IGNORANTIA", "COINCIDENTIA OPPOSITITORUM", E NUOVO PRINCIPIO DI CARITÀ (CHARITAS)! *
Maestri.
Ripartire da Cusano, il sapiente che sa di non sapere
Filosofo, teologo, diplomatico, cardinale, vescovo, umanista, un saggio di Massironi lo rilegge come modello di pensiero di fronte allo smarrimento culturale e spirituale del nostro tempo
di Simone Paliaga (Avvenire, giovedì 15 aprile 2021)
- [Foto] Nicola Cusano in un dipinto del XV secolo nell’ospizio per i poveri della natia Bernkastel-Kues - WikiCommons
Tocca in sorte all’epoca attuale fare esperienza della crisi di configurazioni religiose, filosofiche, simboliche, giuridiche che per secoli hanno dato senso e ordine alla realtà circostante. Scollinare da una stagione all’altra non lascia indenni. Il passaggio di epoca comporta lo scacco di una ragione ormai diventata incapace di ritrovare le proprie tracce nel mondo. Il suo naufragio non è però un fenomeno isolato. Fa il paio con la soggettività che se ne faceva interprete, e che ormai fatica a riconoscersi nella realtà che la circonda. Lo spaesamento avviene perché una ragione calamitata dal finito è esposta all’irrompere dell’imprevedibile e l’uomo, alla stregua di una singolarità in costruzione, scopre che essere umano significa non restare identici in rapporto alla Verità.
Sono le sfide da fronteggiare quando a un’epoca di cambiamenti succede il cambiamento di un’epoca. Sembrerebbero questioni più attuali che mai in questo frangente storico. Ma non appartengono esclusivamente al nostro tempo. Lo conferma Sergio Massironi nel suo Il cardinale inquieto. La ripresa di Cusano in Italia come provocazione alla modernità (pagine 228, euro 22) appena pubblicato dalle edizioni Vita e Pensiero e che sarà presentato oggi alle ore 18 in un confronto online che vedrà l’autore discuterne con monsignor Sergio Ubbiali, docente di Teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, e Silvano Petrosino, che insegna Antropologia religiosa e media all’Università Cattolica del Sacro Cuore, moderati da Sara Corna, del Collegio Villoresi di Monza. Il dibattito sarà trasmesso, in diretta, sul canale Youtube e profilo Facebook della casa editrice. Massironi nel suo lavoro mette in dialogo, con gran agio, la biografia intellettuale di Nicola da Cusa con alcune analisi critiche del suo pensiero condotte di recente in Italia.
Pur passando in rassegna le fatiche di Davide Monaco, Giovanni Gusmini, Cesare Catà, Gianluca Cuozzo e Marco Maurizi, lo studioso lombardo non rinuncia al confronto con figure come il filosofo Harald Schwaetzer sullo statuto del soggetto, con il teologo Ingolf U. Dalferth sul problema della ragione e il contributo dell’escatologia e con Jorge Bergoglio sui risvolti ecclesiologici-magisteriali.
Riannodare i fili tra presente e passato è una necessità perché «la crisi della modernità - avverte Massironi - ha provocato nel pensiero del Novecento una ripresa critica della parabola europea. Ciò ha offerto al cristianesimo l’opportunità di ripensarsi e di intervenire nuovamente con la propria proposta a indicare una traiettoria». Nicola da Cusa rappresenta, per usare in maniera impropria un’immagine a lui cara, uno speculum, uno specchio con cui compiere questo passo.
Il Cusano (1401-1464) è uno straordinario modello di riflessione per oggi perché percorre il crinale tra due mondi altrettanto delicato del nostro senza trovarsi impreparato dinanzi alle nuove sfide. Egli è di certo l’ultimo pensatore della stagione medioevale ma anche il primo riformatore nella fase moderna. Lo testimoniano sia la sua opera sia la sua biografia intellettuale. Filosofo, teologo, diplomatico, cardinale, vescovo, umanista, al tempo stesso quindi pastore di anime, politico, teoreta e uomo di fede oltreché grande collezionista di manoscritti, in perfetta sintonia con la passione umanistica delle fonti.
 Nel corso dell’esistenza ha percorso più e più volte l’Europa, dalla natia Kues a Bisanzio, da Basilea a Parigi, da Colonia a Roma. Gli studi condotti a Padova gli hanno permesso di svincolarsi dai dibattiti frustri e desueti vissuti nel corso dei primi anni trascorsi all’università di Heidelberg dove si discuteva ancora della disputa degli universali, quasi un duecentesco déjà vu.
Nel corso dell’esistenza ha percorso più e più volte l’Europa, dalla natia Kues a Bisanzio, da Basilea a Parigi, da Colonia a Roma. Gli studi condotti a Padova gli hanno permesso di svincolarsi dai dibattiti frustri e desueti vissuti nel corso dei primi anni trascorsi all’università di Heidelberg dove si discuteva ancora della disputa degli universali, quasi un duecentesco déjà vu.Ma i tempi erano ormai fuggiti in avanti. Infatti è il soggiorno italiano a consentire a Nicola da Cusa di nutrirsi della grande cultura umanistica che allora soffiava sulla penisola. Frequentare Vittorino da Feltre, Giuliano Cesarini e Lorenzo Valla, interloquire con Tommaso Parentuccelli, il futuro Niccolò V e con Enea Silvio Piccolomini, futuro papa Pio II, o ancora confrontarsi, durante la missione a Bisanzio, con Isidoro di Kiev, Giovanni da Ragusa, il cardinale Bessarione, Gemisto Pletone permettono al Cusano di non rinchiudersi tra le strette gole della scolastica ma di schiudere strategie di pensiero rivolte all’epoca nuova.
Mettendo a frutto il dispositivo della docta ignorantia, Nicola da Cusa comprende che il non sapere è il vero sapere e assume, nel De coniecturis, la natura prospettica della scienza umana che permette di conoscere, senza indulgere in alcun relativismo, la singola cosa come coincidentia oppositorum, un risultato che contrae il tutto in sé, punto nodale dell’intreccio di relazioni del reale, e capace di comprendere in sé il prima e dopo del passaggio d’epoca
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
PER LA PACE E IL DIALOGO, UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESU’ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore" (Agape, Charitas)!!!
UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI: STORIA DELLE IDEE E DELLE IMMAGINI. A CONTURSI TERME (SALERNO), IN EREDITA’, L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE ..... RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MENSCHWERDUNG, "DOCTA IGNORANTIA" (CUSANO), E ANTROPOLOGIA ARISTOTELICA.19 aprile 2021, di Federico La Sala
#MENSCHWERDUNG.
#Come nascono i bambini:
ripartendo dal #saperedinonsapere,
Niccolò Cusano
ricade nella #antropologia zoppa e cieca di #Aristotele
e propone nella #Docta Ignorantia (III, 5) del 1440
la visione (#teoria) del trittico di Merode (1427)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- RIPENSARE L’INCARNAZIONE. Le tre eresie del Cusano (di Maurizio Marini).30 novembre 2021, di Federico La Sala
#DIVINACOMMEDIA (#DANTE2021)!
IL CARDINALE #CUSANO CERCA DI PENSARE L’#INCARNAZIONE MA FA UN PASSO AVANTI E #TRE INDIETRO, VERSO LA #DIALETTTICA COSMOTEANDRICA DELL’#ASSOLUTO DI #HEGEL *
Le tre eresie di Cusano
di Maurizio Morini (Ritiri Filosofici, 21 Novembre 2021)
«Quando entra nel campo del potere-che-è, ossia nel campo dove il potere è in atto, l’intelletto va a caccia di un cibo estremamente nutriente». Con questa promessa, Cusano inizia la descrizione del secondo campo nel quale cercare la sapienza. La linea argomentativa è quella per cui ciò che non può essere, non è: quod esse potest non est. Ne discende una scoperta che Cusano definisce non di poco conto: e cioè che il non essere non è una creatura. In termini parmenidei si direbbe che il nulla non è pensabile e che la domanda “perché l’essere e non il nulla” non ha nemmeno senso perché il nulla non può mai essere. Di fatto, come dirà in altre opere, esiste solo ciò che può essere in quanto ciò che è impossibile non si realizza. Come conseguenza, noi vediamo l’attualità assoluta in virtù della quale le cose che sono in atto sono ciò che esse sono: hinc actualitatem conspicimus. Tutte queste affermazioni implicano uno scontro con le posizioni della tradizione filosofica aristotelico-tomistica.
Nel Possest la coincidenza di possibilità e necessità
Aristotele aveva stabilito il principio secondo cui l’atto è anteriore alla potenza. La potenza infatti, in quanto principio del divenire, non è sufficiente a realizzare il divenire in quanto è necessario che ci sia una causa che trasformi la potenza in atto. Ma questa causa, che Aristotele definisce come causa efficiente, deve necessariamente essere già in atto.
Cusano non accoglie lo schema aristotelico dell’anteriorità dell’atto sulla potenza in quanto né l’attualità né la possibilità possono avere una precedenza: se l’attualità precedesse la possibilità, allora essa non sarebbe più attualità (che attualità sarebbe infatti quella che si risolvesse in una non attualità?); se la possibilità precedesse l’attualità si avrebbe invece un regresso all’infinito (perché ogni attualità richiederebbe sempre una possibilità che la porta all’atto e via di seguito).
La conseguenza di questo ragionamento è quella di ammettere la coincidenza di possibilità e necessità. Tale coincidenza ha bisogno di un nome e Cusano inventa il neologismo possest, termine che nasce dalla composizione di due termini, posse-est, traducibile con l’espressione il poter essere che è. Con questo termine egli indica la coincidenza, nell’assoluto, del poter essere con l’essere in atto. Tutte le cose, nella realtà indicata da questo termine, sono complicate, perché tutto ciò che esiste, per esistere, deve poter esistere, e dunque deve esistere in quello che è il potere allo stato puro. Ma in questo potere assoluto, che è un potere che è, nel quale l’essere coincide con il potere e la possibilità con l’attualità, devono essere incluse (cioè complicate nel linguaggio cusaniano) tutte le cose. Nel termine possest il Cardinale conia un termine che esprime la congiunzione della potenza di divenire e della potenza divenuta. Poter essere è dunque poter essere in atto, per cui siccome questo poter essere è considerato in atto, si dice che questo poter essere è un posse. Si tratta di una conclusione talmente forte che, prima di proseguire, Cusano la nasconde dietro tre affermazioni che, con l’apparenza di essere devote, contengono altrettante eresie le quali, ad altri pensatori, in altri tempi e in altri modi, sono costate la libertà e la vita.
Un Dio glorioso che non compie miracoli
Quello che noi consideriamo come Dio nella nostra tradizione, afferma Cusano, non è altro che la coincidenza dell’atto puro e della potenza pura. Nonostante egli chiami questa coincidenza Dio glorioso, l’affermazione si risolve in una vera e propria eresia rispetto al pensiero ortodosso, perché la potenza pura era da sempre stata considerata il prodotto dell’atto: ad esempio, come applicazione di questo schema, la prima cosa che Dio produce è la materia la quale, nella tradizione scolastica, non ha niente a che vedere con Dio, il quale era considerato piuttosto come una sostanza costituita da un’essenza diversa da quella che possiede la sostanza materia. Cusano cancella un simile quadro teorico perché quello che era un effetto, la materia, lo inserisce nella causa, che egli chiama Dio, considerata simultaneamente come un soggetto di contrari.
Il risultato di questo ragionamento produce una seconda eresia consistente nel rifiuto del concetto di eminenza. Con questo termine la tradizione aveva designato un modo di esistenza in cui, ciò che si dà attualmente nel mondo, è presente in modo diverso nell’idea di Dio. Questo significa che la creatura è contenuta nella mente del creatore in modo qualitativamente diverso rispetto a quello della creatura: in Dio (ad esempio) anche il mio gatto esiste, ma non esiste così come esiste in sé o come esiste nella mia mente: esiste in un modo diverso (diversità intesa come perfezione) in quanto la sua vera natura non è attingibile dalla nostra conoscenza.
Come conseguenza di questo approccio teorico della Scolastica, la potenza di Dio poteva essere concepita contemporaneamente in due modi: potenza assoluta e potenza ordinata. In quanto Dio è Dio, la potenza di Dio è assoluta; se invece si considera la potenza di Dio espressa nel mondo, la potenza ordinata, questa potenza non è assoluta, perché si ritiene che il mondo non sia tutto ciò che Dio poteva creare e che esso sia una tra le creature di Dio. Nel caso del gatto, esso esiste ed è stato creato; ma il gatto non solo non poteva non essere stato creato ma esistono nella mente di Dio tutta una serie di gatti che, trattenuti nella sua mente, non sono stati creati. Si ritiene cioè che non tutto ciò che è nell’intelletto di Dio è stato da lui creato: la sua volontà infatti avrebbe fatto da filtro rispetto all’infinità delle idee che sono in Dio, idee che solo in parte si sono tradotte nel mondo.
Anche in questo caso Cusano liquida la tradizione perché il concetto di Dio coincide con la possibilità attuata in cui non vi è più alcun residuo di possibilità da esplicare. Se la creazione deriva dalla natura di Dio (e non dalla volontà), se questa natura è infinita, anche l’effetto è infinito, e quindi dobbiamo dire che nel mondo c’è la piena e totale espressione della potenza di Dio. Dire ciò significa anche abolire il principio dei miracoli, ovvero che Dio non può, a partire dalla sua volontà, porre in essere qualcosa che prima era nella sua mente.
La materia è parte di Dio
La coincidenza di possibilità e necessità provoca un mutamento anche nel concetto di materia e ciò dà luogo alla terza eresia, sicuramente quella più scandalosa. Nella Dotta ignoranza, Cusano aveva già spiegato che il concetto della possibilità coincideva con quello della materia. Il problema è che la tradizione aristotelica era giunta a quel concetto nella modalità del non sapere, pensandola come possibilità eretta come principio assoluto e che coesisteva con lo stesso Dio (il quale era pensato in termini puramente spirituali). I platonici chiamarono la possibilità assoluta mancanza, in quanto essa manca di ogni forma. Gli aristotelici la definivano “quasi niente”, perché la materia aveva soltanto in minimo grado le qualità della sostanza. Di conseguenza, essi sostenevano che le forme sono presenti nella materia solo allo stato di possibilità. concludendo poi con la tesi che nella possibilità è presente la totalità delle cose. Cusano stabilisce invece che è impossibile che vi sia una possibilità assoluta, non congiunta cioè con l’atto, perché altrimenti bisognerebbe ammettere conseguenze assurde, come riconoscere un’infinità che parte dalla mancanza: cosa del tutto contraria a Dio perché semmai, in lui, l’infinità non può che partire da un’abbondanza.
Nasce il modello della causalità immanente
Come osserva un interlocutore del cardinale, si deve dire che Dio è in tutte le cose in modo tale da non poter essere altro quello che è. Questa, dice Cusano, è una dottrina da sostenere nel modo più fermo perché la coincidenza nell’assoluto di potenza ed atto consente di spiegare altrimenti la sua dottrina della complicatio. Dio infatti è tutte le cose in modo tale da non essere una di esse più di quanto non sia un’altra. Dio è sole ma non secondo il modo di essere del sole, il quale non è tutto ciò che può essere. Se questa prospettiva si può definire panteistica, non si deve dimenticare il modo esatto in cui essa si qualifica. Nel potere-che-è sono complicate tutte le cose e nessun grado di conoscenza riesce a coglierlo. Ma, soprattutto, «il potere, considerato in senso assoluto, è ogni potere. Pertanto se io vedessi che ogni potere è in atto non resterebbe più nulla. Se infatti restasse qualcosa, si tratterebbe pur sempre di qualcosa che potrebbe essere, per cui non resterebbe se prima non fosse già stata compresa nel potere». La conseguenza di questo discorso è che qualcosa, per essere qualcosa, deve avere la potenza di essere ciò che è e quindi, se non c’è il poter essere, non esiste nulla. Così come non si porta un’onda fuori del mare, è necessario che tutte le cose che sono, siano esistite da sempre nell’eternità: ciò che è stato creato è sempre esistito nel poter essere. Tutte le cose che sono e che si muovono, sono e si muovono nel possest.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura della DIVINA COMMEDIA"
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA, CREATIVITÀ E TRADUZIONE. Con gli occhi dell’altro (di Franco Nasi).14 aprile 2021, di Federico La Sala
TRADUZIONE E CREATIVITÀ: NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! Con gli occhi dell’altro...*
- ANTROPOLOGIA E TRADUZIONE. "I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo"(Wittgenstein) e l’arca perduta: la "charitas" della Vulgata, la "caritas" della Neovulgata, e "l’acca in fuga"(GianniRodari).
- Traduzione e creatività: "Sulla scia di Cicerone, Girolamo traduce agape in caritas e attua così un’importante svolta nella conformazione del pensiero occidentale: nasce «qualcosa di nuovo che è stato creato dal movimento del linguaggio»" (A. Fraccacreta, Quando tradurre diventa creatività semantica, Avvenire, 14.04.2021).
Con gli occhi dell’altro
di Franco Nasi (Doppiozero, 18 marzo 2021).
- Stefano Arduini, Con gli occhi dell’altro. Tradurre, Jaca Book, 2020.
- Stefano Arduini, Ilide Carmignani (a cura di), L’arte di esitare. Dodici discorsi sulla traduzione, Marcos y Marcos, 2019.
Che il tradurre testi letterari sia un atto complesso, che richiede competenza e infinita pazienza, umiltà e coraggio, ammirazione per l’opera che si traduce e rispetto per i lettori della traduzione, è cosa ovvia fra chi si occupa di traduzione. Lentezza, pudore, responsabilità, competenza, ascolto inventivo o passività attiva, apertura all’altro, collaborazione, sono tutti termini che ritornano nelle belle riflessioni sul tradurre di una dozzina fra i più autorevoli traduttori italiani, raccolte In L’arte di esitare curato da Stefano Arduini e Ilide Carmignani e pubblicato da Marcos y Marcos. Nell’agile volumetto sono riportati i “discorsi di accettazione” dei vincitori del Premio di traduzione letteraria conferito durante l’ormai canonico appuntamento annuale delle Giornate della traduzione, organizzate dai due curatori dal 2002, prima a Urbino poi a Roma. Il volume si apre con una poesia, I traduttori, scritta in italiano dal poeta spagnolo Juan Vincente Piqueiras, che dice molto bene, con l’economicità e la leggerezza cristallina dei versi, di queste figure spesso dimesse, che stanno dietro le quinte, ma che con passione ci fanno conoscere, a volte amare, mondi che altrimenti ci resterebbero del tutto estranei e sconosciuti:
Sono una tribù strana sparsa per il mondo
perché spostano il mondo.
Portano mondi da una lingua all’altra.
Ecco il loro mestiere.
Fanno nevicare in arabo, cambiano il nome al mare,
portano cammelli in Svezia,
fanno che don Chisciotte cavalchi su Ronzinante
dalla Mancia in Manciuria.
Fanno delle cose strane, pressappoco impossibili.
Dicono nella propria lingua
cose che mai quella lingua aveva detto prima,
cose che non sapeva di poter dire.
Sono nati da un crollo, quello della Torre di Babele,
e da un sogno: che gli uomini, le anime
che vivono agli antipodi,
si conoscano, si capiscano, si amino.
Sono una tribù muta:
danno la loro voce ad altre voci.
Sono diventati invisibili a forza d’umiltà.
Per secoli sono stati anche anonimi.
Loro, che vivono di nomi tra i nomi,
non avevano un nome.
Nella liturgia della letteratura
vengono trattati spesso come chierichetti.
Sono invece i veri pontefici: quelli che fanno i ponti
tra le isole delle lingue lontane, quelli che sanno
che tutte le lingue sono straniere,
che tutto tra di noi è traduzione.
Sono una tribù strana sparsa per il mondo
Perché stanno spostando il mondo,
perché stanno salvando il mondo.
Fra i “pontefici” che raccontano della loro professione e della loro passione, spesso in tono colloquiale e autobiografico, ci sono Giorgio Amitrano, Susanna Basso, Adriana Bottini, Pino Cacucci, Franca Cavagnoli, Renata Colorni, Ena Marchi, Yasmina Melaouah, Anna Ravano, Delfina Vezzoli, Claudia Zonghetti. Senza di loro, è certo, Banana Yoshimoto, Haruki Murakami, Alice Munro, Toni Morrison, Thomas Bernhard, Daniel Pennac, ma anche Freud o Tolstoj, solo per ricordare alcuni autori da loro tradotti, avrebbero una voce diversa da quella che hanno per molti lettori italiani: sarebbero scrittori diversi.
Naturalmente c’è chi pensa che questa antica professione sia un’arte in via di estinzione, e che presto i traduttori non saranno solo dimessi ma proprio dismessi, sostituiti dalle intelligenze artificiali, capaci di processare una infinità di dati in un battito di ciglia e di restituirci finalmente la traduzione perfetta che, come si sa, è un paradosso in termini. Può darsi che succeda, come può darsi che arriveremo ad avere una lingua franca, standardizzata, unica per tutti, che tutti saremo costretti a rispettare come il newspeak nella società distopica di Orwell.
 Per ora, e per fortuna, ci è ancora concesso di usare molte lingue che si muovono, si trasformano, si reinventano; lingue che permettono creazioni di nuove espressioni, ambiguità ed errori, che, come sanno bene i linguisti, sono causa importante delle variazioni e della vitalità del linguaggio. E per ora, grazie anche alla benedizione della caduta della torre di Babele, ci è permesso ancora un dialogo fra le lingue, attraverso il tradurre che non è un atto fondato su mere elaborazioni statistiche di occorrenze di termini, per cui a una parola in una lingua corrisponde una parola in un’altra lingua, a una espressione idiomatica corrisponde una equivalente espressione idiomatica in un’altra lingua ecc., ma un atto ad un tempo rigoroso e creativo, frutto di una relazione produttiva che ha segnato profondamente la storia della cultura, un atto che ha contribuito non solo alla diffusione dei concetti, ma anche alla loro trasformazione.
Per ora, e per fortuna, ci è ancora concesso di usare molte lingue che si muovono, si trasformano, si reinventano; lingue che permettono creazioni di nuove espressioni, ambiguità ed errori, che, come sanno bene i linguisti, sono causa importante delle variazioni e della vitalità del linguaggio. E per ora, grazie anche alla benedizione della caduta della torre di Babele, ci è permesso ancora un dialogo fra le lingue, attraverso il tradurre che non è un atto fondato su mere elaborazioni statistiche di occorrenze di termini, per cui a una parola in una lingua corrisponde una parola in un’altra lingua, a una espressione idiomatica corrisponde una equivalente espressione idiomatica in un’altra lingua ecc., ma un atto ad un tempo rigoroso e creativo, frutto di una relazione produttiva che ha segnato profondamente la storia della cultura, un atto che ha contribuito non solo alla diffusione dei concetti, ma anche alla loro trasformazione.Di questa idea di traduzione parla Stefano Arduini nel volume Con gli occhi dell’altro. Tradurre (Jaca Book, 2020), un libro importante, erudito e nello stesso tempo chiaro e sollecitante anche per chi non è addentro alle questioni di filologia o di linguistica.
Il libro è un saggio scientifico, scritto da un linguista e biblista, impegnato da anni negli studi traduttologici, ma leggendolo si ha l’impressione di trovarsi davanti anche a un testo letterario, sia per la perspicuità ed eleganza dello stile, sia per la struttura “narrativa”. Uso questo termine perché la costruzione del libro ricorda quelle raccolte di racconti a cornice come Il Decameron o Le mille e una notte, dove c’è una storia che ospita al suo interno tante altre storie o novelle, ciascuna a suo modo conchiusa in sé, o bastante in sé, eppure funzionale al discorso generale, alla tesi generale del libro.
 Nel libro di Arduini il filo rosso, che è anche cornice, è dichiarato in apertura e viene iterato ripetutamente all’inizio o alla fine di numerose molte “novelle”: “Una delle idee che sto sviluppando in questi saggi è che i concetti non siano stabili e abbiano invece una struttura dinamica e la traduzione contribuisca a questa dinamicità” (p. 149). Non cento novelle ma dieci, che hanno come protagonisti non dei personaggi ma dei concetti.
Nel libro di Arduini il filo rosso, che è anche cornice, è dichiarato in apertura e viene iterato ripetutamente all’inizio o alla fine di numerose molte “novelle”: “Una delle idee che sto sviluppando in questi saggi è che i concetti non siano stabili e abbiano invece una struttura dinamica e la traduzione contribuisca a questa dinamicità” (p. 149). Non cento novelle ma dieci, che hanno come protagonisti non dei personaggi ma dei concetti.
 Le parole-concetto sono: L’altro, Confini, Tradurre, Parola, Io sono, Verità, Inganno, Amore, Bellezza, l’intraducibile”.
Le parole-concetto sono: L’altro, Confini, Tradurre, Parola, Io sono, Verità, Inganno, Amore, Bellezza, l’intraducibile”.Arduini ci racconta parte della vita, della storia di queste parole-concetto, la parte più lontana da noi, quando transitarono dal sanscrito alla cultura ebraica, greca, latina classica e poi medievale, assumendo nomi diversi nelle varie culture e nelle varie lingue, e cambiando anche almeno un poco il loro carattere, mutando alcune delle loro peculiarità ogni volta che il loro nome veniva “tradotto”, e il concetto introdotto o ricontestualizzato in un’altra lingua, cultura o enciclopedia.
 Arduini ci conduce sulla rotta di quei concetti che, come delle navi che lasciano il porto, prendono il mare, vanno “alla deriva” scrive Arduini, si muovono nel tempo e negli spazi, risignificandosi attraverso le traduzioni, che necessariamente tolgono e aggiungono, conservano e creano. Così, ad esempio, dall’ebraico ahev, per amore, ai greci eros, philia, àgape, al latino amare, diligere e caritas si ripercorre il viaggio di un concetto che muovendosi si trasforma, in quella che potremmo chiamare una storia interlinguistica delle idee.
Arduini ci conduce sulla rotta di quei concetti che, come delle navi che lasciano il porto, prendono il mare, vanno “alla deriva” scrive Arduini, si muovono nel tempo e negli spazi, risignificandosi attraverso le traduzioni, che necessariamente tolgono e aggiungono, conservano e creano. Così, ad esempio, dall’ebraico ahev, per amore, ai greci eros, philia, àgape, al latino amare, diligere e caritas si ripercorre il viaggio di un concetto che muovendosi si trasforma, in quella che potremmo chiamare una storia interlinguistica delle idee.In due di queste “novelle”, quella relativa alla nozioni di tradurre e di intraducibile ci sono poi momenti di particolare importanza per comprendere meglio quel filo rosso che lega tutto il discorso di Arduini; un discorso che non può che essere interdisciplinare o, come ama dire Arduini, transdisciplinare, e che si muove, si deve muovere, fra linguistica, teologia, filosofia, filologia, etica, estetica, storia della religione ecc. in un orizzonte di comprensione aperto alla complessità di quell’atto eminentemente relazionale che è la traduzione, un atto che implica di necessità “un altro”.
“L’altro” è l’argomento del secondo capitolo, e qui troviamo una spiegazione indiretta della prima parte del titolo, Con gli occhi dell’altro. Arduini, dopo aver parlato del concetto di altro riprendendo alcuni autori fondamentali per il suo impianto interpretativo come Benveniste, Ricoeur, Lévinas, arriva al libro La colonna e il fondamento della verità di Pavel Florenskij in cui la riflessione sull’altro porta alla riflessione sull’amicizia.
 Qui incontriamo la citazione da cui viene ripreso il titolo del libro. Scrive Florenskij: “Che cos’è l’amicizia? L’amicizia è la visione di sé con gli occhi dell’altro... L’Io, rispecchiandosi nell’amico, riconosce nel suo Io il proprio alter ego”. E commenta Arduini: “Florenskij propone dunque un’idea di amicizia nella quale la propria soggettività è costruita a partire da tutto ciò che è fuori dal soggetto” (p. 35).
Qui incontriamo la citazione da cui viene ripreso il titolo del libro. Scrive Florenskij: “Che cos’è l’amicizia? L’amicizia è la visione di sé con gli occhi dell’altro... L’Io, rispecchiandosi nell’amico, riconosce nel suo Io il proprio alter ego”. E commenta Arduini: “Florenskij propone dunque un’idea di amicizia nella quale la propria soggettività è costruita a partire da tutto ciò che è fuori dal soggetto” (p. 35).Questo modo di intendere la relazione è fondamentale sia quando si parla di traduzione sia quando ci si interroga su quelle parole-concetto che costituiscono l’ossatura del libro, e che, come mostra Arduini, sono sempre frutto di mediazioni, conflitti e relazioni complesse fra culture e lingue.
Leggendo l’espressione di Florenskij “con gli occhi dell’altro”, mi sono venuti in mente due racconti, che non hanno a che fare con il nostro libro, ma che forse possono esemplificare due atteggiamenti contrari, il rifiuto e l’accettazione dell’altro, di cui parla Arduini.
 Il primo è una novella di Pirandello, Mondo di carta ed esemplifica il rifiuto. Si racconta di uno strano signore, il signor Balicci, amante fanatico di libri. Balicci, come dice Pirandello, “la vita non l’aveva vissuta”, perché l’aveva passata tutta a leggere libri, molti di viaggi e di terre lontane. Ormai anziano perde la vista. Assolda un giovane per riordinare la propria biblioteca. Sapere dove stavano i suoi libri era per lui di grande conforto.
Il primo è una novella di Pirandello, Mondo di carta ed esemplifica il rifiuto. Si racconta di uno strano signore, il signor Balicci, amante fanatico di libri. Balicci, come dice Pirandello, “la vita non l’aveva vissuta”, perché l’aveva passata tutta a leggere libri, molti di viaggi e di terre lontane. Ormai anziano perde la vista. Assolda un giovane per riordinare la propria biblioteca. Sapere dove stavano i suoi libri era per lui di grande conforto.
 Poi assume una giovane esuberante, Tilde Pagliocchini, perché gli “presti gli occhi” e legga per lui i suoi libri. L’esperimento non funziona perché nella voce della ragazza i suoi libri escono stonati, falsi, insopportabilmente diversi da come li aveva in mente, da come li aveva letti lui. Chiede allora alla ragazza di leggerli con “gli occhi soltanto, senza voce”. La ragazza lo fa di malavoglia perché non capisce il senso di questa richiesta; ma poi, di fronte a un libro sulla Norvegia, non resiste, sbuffa; lei che in Norvegia c’era stata dice a Balicci che quello che è scritto nel libro non è vero, non corrisponde alla realtà. Va da sé che Balicci non vuole sentire ragione e caccia in malo modo la ragazza. In questo caso gli occhi dell’altro non sono serviti a nulla, soprattutto perché il Balicci ha rifiutato l’altro, si è chiuso ostinatamente nel suo mondo di carta, un mondo immobile, tautologico e inesistente, statico nel tempo e buio come la morte.
Poi assume una giovane esuberante, Tilde Pagliocchini, perché gli “presti gli occhi” e legga per lui i suoi libri. L’esperimento non funziona perché nella voce della ragazza i suoi libri escono stonati, falsi, insopportabilmente diversi da come li aveva in mente, da come li aveva letti lui. Chiede allora alla ragazza di leggerli con “gli occhi soltanto, senza voce”. La ragazza lo fa di malavoglia perché non capisce il senso di questa richiesta; ma poi, di fronte a un libro sulla Norvegia, non resiste, sbuffa; lei che in Norvegia c’era stata dice a Balicci che quello che è scritto nel libro non è vero, non corrisponde alla realtà. Va da sé che Balicci non vuole sentire ragione e caccia in malo modo la ragazza. In questo caso gli occhi dell’altro non sono serviti a nulla, soprattutto perché il Balicci ha rifiutato l’altro, si è chiuso ostinatamente nel suo mondo di carta, un mondo immobile, tautologico e inesistente, statico nel tempo e buio come la morte.Il secondo racconto ha a che fare invece con l’atteggiamento opposto non di rifiuto ma di accoglienza. Si intitola Cattedrale ed è di Raymond Carver. Qui ci sono tre personaggi. Una coppia, marito e moglie, e un amico della moglie, Robert, ex collega di lavoro, non vedente. Robert va a fare una visita alla donna dopo dieci anni, e così incontra per la prima volta il marito di lei, che però è pieno di pregiudizi nei confronti dell’ospite. All’inizio il marito è distaccato e imbarazzato, non sa come dialogare con Robert, tende piuttosto a evitare di interagire. Poi un po’ alla volta i due familiarizzano. Dopo cena bevono whiskey davanti alla televisione.
 C’è un programma su una cattedrale di Lisbona. Il marito chiede a Robert se ha idea di come sono fatte le cattedrali. Robert risponde di sapere solo alcune cose e chiede al suo ospite di descrivergli quella mostrata nel programma alla tele. Immagina così, attraverso la voce del suo interlocutore, la cattedrale. La vede attraverso le sue parole che però non sono sufficientemente precise. Così Robert, ed è una svolta inattesa nel racconto di Carver, chiede all’uomo di prendere un foglio e una penna e di disegnare insieme una cattedrale.
C’è un programma su una cattedrale di Lisbona. Il marito chiede a Robert se ha idea di come sono fatte le cattedrali. Robert risponde di sapere solo alcune cose e chiede al suo ospite di descrivergli quella mostrata nel programma alla tele. Immagina così, attraverso la voce del suo interlocutore, la cattedrale. La vede attraverso le sue parole che però non sono sufficientemente precise. Così Robert, ed è una svolta inattesa nel racconto di Carver, chiede all’uomo di prendere un foglio e una penna e di disegnare insieme una cattedrale.- “Ha trovato la mia mano, quella con la penna. Ha chiuso la sua mano sulla mia. ‘Coraggio, fratello, disegna’. Ha detto il cieco”.
I due hanno continuato in questo modo. Quando la cattedrale era ormai delineata sul foglio, il cieco invita il marito a chiudere gli occhi e a continuare a disegnare, ma a questo punto è la mano del cieco a guidare quella del marito nel disegno.
- “Le sue dita guidavano le mie mentre la mano passava su tutta la carta. Era una sensazione che non avevo mai provato in vita mia... Tenevo gli occhi ancora chiusi. Ero a casa mia. Lo sapevo. Ma avevo come la sensazione di non stare dentro a niente”.
Ecco, qui scatta qualcosa di opposto a quanto succede nel raccontino di Pirandello. Dal rifiuto di Balicci di leggere il mondo con gli occhi della ragazza, che peraltro aveva avuto esperienza diretta di quel mondo, in Cattedrale nasce un’amicizia, un adeguamento nei confronti dell’altro che non è annessione, ma una relazione che costruisce qualcosa di nuovo, di non visto. È un’amicizia che consente al marito di uscire dalla propria casa pur restando a casa, di uscire dal proprio confine, di vedere la verità e l’inganno, la bellezza, la parola, l’essere e tutti gli altri concetti studiati nella loro dinamicità in Con gli occhi dell’altro.
Scrive Arduini: “Nell’amicizia si misura il vero rapporto con l’alterità dove l’altro non viene rifiutato perché incommensurabilmente lontano, non viene annullato annettendolo al proprio universo culturale e concettuale e, infine, non conduce a rinunciare al sé e alla tradizione in cui il soggetto si è formato, ma viene accolto in un patto di reciprocità che definisce la relazione di amicizia. Una contraddizione, un paradosso, che però non lascia solo il soggetto di fronte all’impenetrabilità dell’altro, ma costituisce un elemento decisivo nella costruzione dell’identità” (p. 44).
Quello dell’amicizia, del rapporto con l’altro, è un concetto chiave per entrare criticamente nell’atto del tradurre, atto relazionale, fertile e complesso come pochi altri, atto che costituisce il fulcro di questo libro centripeto e nello stesso tempo centrifugo, solido ed erudito nella sua documentazione filologica, ma anche suggestivo per le considerazioni originali sulla figura del traduttore, sulle sue esitazioni, psicologiche ed esistenziali, sul senso di perdita che prova confrontando il proprio scritto con il testo originale, e sulla sua capacità di elaborare il lutto di quella perdita ineludibile, grazie alla sua capacità di tenere in vita o di dare nuova vita a quel testo con le sue nuove parole.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
MICHEL SERRES: L’ART DES PONTS. HOMO PONTIFEX. Intervista di Louis De Courcy e Guillaume Goubert. Una forte sollecitazione ad uscire dal "neolitico" e, ripartendo dal nostro presente storico, a ri-attivare l’umana (di tutti e di tutte!!!) capacità di "gettare ponti" e a riprendere il cammino "eu-ropeuo"!!!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL FARISAICO RISPETTO DELLA LEGGE E UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") COSTITUZIONALE4 aprile 2021, di Federico La Sala
PER UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") COSTITUZIONALE ....
- Una nota a margine dell’art. di Sara Nocent e Davide Amato, "Draghi, un messia “tecnico”?", Sinistrainrete, 02 April 2021.
SE E’ VERO CHE, "ANCORA UNA VOLTA, chi trova soluzioni alternative al neoliberismo è bandito dalla stanza dei bottoni", è ALTRETTANTO VERO CHE RIPETERE CON Adorno e Horkheimer, che “la terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura”, porta tutti e tutte ancor di più nel buio dell’inferno.
Si è mai chiarito perché il Marx del "Capitale. Critica dell’economia politica", come il Marx della "Prefazione" a "Per la critica dell’economia politica", richiami Dante (è solo l’eco mnemonico di letture giovanili?) o, ancora, in un "banale" ritornello nei suoi lavori associ alla parola "economia politica" sempre la parola "critica"?! Non è perché il suo discorso ha qualche legame con il lavoro del Kant della "Critica della Ragion Pura", "Critica della Ragion Pratica", "Critica del Giudizio"!?
Se "Oggi tutti sono pazzi per Draghi", forse, c’è qualche motivo - per esempio, un motivo storico-costituzionale di lunga durata: "Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro" (Mario Draghi, discorso al Senato, 17.02.2021)!
DRAGHI, UN MESSIA "TECNICO"?! NON è TEMPO, FORSE, DI CHIARIRSI LE IDEE SU "CHI SIAMO IN REALTà" e, finalmente, riprendere con Marx la via della CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA. O no?!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA (Copernico, 1543), LA LEZIONE DI GIOVANNI VALVERDE (1560), E LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA.2 aprile 2021, di Federico La Sala
LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA, I “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO DI DANTE E LA PRESENTE STORICA CRISI DELLA CULTURA EUROPEA...
- Nota a margine dell’art. di Sergio Benvenuto, “La poca saggezza della filosofia”, "Le parole e le cose", 15 marzo 2021.
CONSIDERATO CHE UN FILOSOFO, “Anche quando sbaglia di grosso, se è un vero filosofo sbaglia con argomenti non banali, fino al punto che, grazie a lui, l’errore brilla della luce convincente della verità” (cf. S. Benvenuto, cit. - su), E VISTO CHE EGLI HA MESSO IL DITO NELLA PIEGA (e nella piaga) della storia della filosofia, nel gioco sofistico di Socrate: «Malgrado lo slogan “so di non sapere”, tutti ci rendiamo conto che Socrate in realtà sapeva tante cose. Ma il suo sapere squisitamente filosofico era proprio quello di non sapere, ovvero, il suo appello all’epistheme come “ricominciare tutto daccapo”» (op. cit. - su), VISTO IL PERSISTERE E, AL CONTEMPO, L’ESAURIRSI DELLA “GRANDE INSTAURAZIONE” ANTROPOLOGICA ED EPISTEMOLOLOGICA apollinea-socratica (su questo, si cfr. la grande analisi di Nietzsche!), forse, è bene e salutare riprendere alla radice (Marx!) la questione e, riaccogliendo l’indicazione di Sofocle, ripensare le «perversioni» di tremila e più anni (come sapeva Dante, meglio di Goethe), rileggere il cap. 15 del manuale di “Anatomia” (Roma, 1560) di Giovani Valverde, e ripensare l’«edipo completo», come voleva Freud e Fachinelli. Altro che continuare a menare la canna per l’aria. O no?!
Sul tema,nel sito, si cfr.:
Antropologia, Storia e Diritto. Donne e Uomini.... PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- VITA E FILOSOFIA: DA CARLO V E GIOVANNI VALVERDE A ENZO PACI E MARIO DRAGHI.31 marzo 2021, di Federico La Sala
#ACHEGIOCOGIOCHIAMO?! #TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA.
#EUROPA #SPAGNA #DUE ANNI DOPO LA MORTE DI #CARLOV nel 1560, in #Italia, a #Roma si pubblica il testo di #Anatomia di #GiovanniValverde: si riconosce il ruolo attivo della donna nella #concezione del problema #comenasconoibambini
La sollecitazione di #Michelangelo (1512), #GiovanniValverde (1560), #LuigiCancrini (2005) e #MarioDraghi (2021) a finirla con "il farisaico rispetto della #legge"
#VITAEFILOSOFIA. #COMENASCONOIBAMBINI (#ENZOPACI). Fermare il #giogo, #uscire dall’orizzonte della #tragedia e imparare a #contare
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DONNE AL FUTURO (di Francesca Rigotti - "Doppiozero").20 marzo 2021, di Federico La Sala
Tweet
*
Controparola/
Donne al futuro
di Francesca Rigotti (Doppiozero, 20 marzo 2021)
Da quando ho scoperto che nella grammatica esistono termini marcati e termini non marcati - me li ha spiegati un illustre linguista amico di tastiera - non dico che non dormo di notte ma quasi. I termini non marcati, se ho capito bene, sono dominanti e includenti: per esempio il termine «giorno», che comprende il giorno e la notte; notte invece è un termine marcato, giacché designa soltanto il tempo dell’oscurità. Non marcato è uomo (ci avviciniamo al tema) in quanto comprende se stesso e anche la donna, la quale invece, guardacaso, è marcata quale «soltanto» donna.
Dovevo ripensare a questa disparità grammaticale nel leggere Donne al futuro, raccolta di saggi di donne che parlano «soltanto» di altre donne, uscito per il Mulino a cura delle amiche di Controparola. Si tratta di un gruppo di scrittrici e giornaliste, nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini, che ha pubblicato diversi libri sulle donne tra i quali Donne del Risorgimento, Donne nella Grande Guerra, nella Repubblica, nel Sessantotto e ora al futuro. Sono Paola Cioni, Eliana Di Caro, Paola Gaglianone, Dina Lauricella, Lia Levi, Dacia Maraini, Cristiana Palazzoni, Maria Serena Palieri, Valeria Papitto, Linda Laura Sabbadini, Francesca Sancin, Cristiana di San Marzano, Mirella Serri, cui si deve Donne al futuro (il Mulino, Bologna 2021). Sempre e soltanto donne. O donne sole, si potrebbe anche dire, che è un’espressione un po’ deprimente ma anche molto divertente, a leggerla con ironia, e con la quale si intendono donne in compagnia di altre donne ma non di uomini. Mentre la dicitura per soli uomini sta per luoghi e/o attività in cui le donne non possono entrare e a cui non devono partecipare (e così è intitolata l’eccellente analisi statistica Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design, appena pubblicata da Codice Edizioni e condotta dalla giornalista Emanuela Griglié e del collega Guido Romeo).
Le donne al futuro di questo libro, soltanto donne marcate nella loro donnità, sono di fatto figure straordinarie, proiettate, come dice il titolo, al futuro o declinate al futuro, visto che siamo partiti dalla grammatica (che innocentemente mi costringe qui a scrivere al maschile benché io sia donna che scrive di donne che scrivono di donne. La lingua sarà anche colpevole ma non nel modo semplificato e a tratti oltraggioso che le attribuiscono le interpretazioni corrive, come spiega puntualmente l’amico linguista il cui nome adesso svelo, Nunzio La Fauci, ma la dice lunga). Donne giovani che lavorano per fabbricare il futuro con l’arte e la musica, l’architettura e l’astrofisica; con l’impegno civile e umanitario (donnitario?), con la ricerca medica, l’economia, la pratica sportiva e l’insegnamento.
 Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.
Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.Non potendo parlare di tutte ho scelto di citarne una sola, l’unica tra l’altro che mi era del tutto ignota, lo confesso e chiedo venia: Sara Gama. Sara Gama, classe 1989, madre triestina e padre congolese, capitana della Nazionale azzurra femminile di calcio nonché vicepresidente dell’Assocalciatori (termine non marcato che comprende anche le calciatrici mentre le calciatrici, marcate dall’essere soltanto donne, non comprendono i calciatori).
 Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
 E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia.
E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- IL COMPORTAMENTO DI UN "UOMO GIUSTO", SAN GIUSEPPE", E UNA FILOLOGIA CIECA E ZOPPA.19 marzo 2021, di Federico La Sala
LA “DIVINA COMMEDIA” E IL CUORE DEL “PADRE NOSTRO”, “L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE”...
- Una nota a margine dell’art. di di Fabrizio Cazzato, "Raffigurazioni di San Giuseppe a Tutino di Tricase", Fondazione Terra d’Otranto, 19.03.2021.
PLAUDENDO ALL’ECCEZIONALE LAVORO DELLA REDAZIONE DELLA FONDAZIONE “TERRA D’OTRANTO”, ANCHE ALLA LUCE DI QUESTO ULTIMO CONTRIBUTO, CREDO CHE OGGI (19 MARZO 2021), ALL’INTERNO DI UN ORIZZONTE STORICO SEGNATO DA UNA PANDEMIA PLANETARIA, SIA OPPORTUNO RIFLETTERE SUL FATTO CHE QUESTO ANNO (2021) è l’anno dedicato all’Anniversario della morte (1321) di Dante Alighieri e che a Lui è stata dedicato come giorno di memoria il 25 marzo, giorno di memoria liturgica anche dell’Annunciazione (vale a dire del concepimento del Bambino).
 Accogliendo la sollecitazione di questa importante connessione, forse, è meglio ripensare a “come nascono i bambini” (antropologicamente, filosoficamente e teologicamente), alla figura dell’uomo Gesù, all’”Ecce Homo”(«Ecco l’uomo», gr. «idou ho anthropos») di Ponzio Pilato, e, ancora, alla lezione di Dante.
Accogliendo la sollecitazione di questa importante connessione, forse, è meglio ripensare a “come nascono i bambini” (antropologicamente, filosoficamente e teologicamente), alla figura dell’uomo Gesù, all’”Ecce Homo”(«Ecco l’uomo», gr. «idou ho anthropos») di Ponzio Pilato, e, ancora, alla lezione di Dante.
 A mio parere, la sua lezione non è solo “poetico-letteraria”, ma è anche teologica e politica: la sua “Monarchia” con l’indicazione relativa ai “due soli” ha, infatti, il suo fondamento teologico e antropologico nell’amore (charitas) del “Cantico dei cantici” (cioè, di Salomone - non di Costantino: rileggere il c. XIV del “Paradiso”) e pone le condizioni per rileggere l’intera figura di san Giuseppe! Egli non è affatto un falegname che prepara la croce per inchiodarci su il bambino che gli è stato affidato, ma lo sposo di Maria, discendente della casa di Davide (“de domo David”: -https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181) che, come Salomone, ha saputo decidere e portare in salvo la madre vera e il bambino vero! O no?!
A mio parere, la sua lezione non è solo “poetico-letteraria”, ma è anche teologica e politica: la sua “Monarchia” con l’indicazione relativa ai “due soli” ha, infatti, il suo fondamento teologico e antropologico nell’amore (charitas) del “Cantico dei cantici” (cioè, di Salomone - non di Costantino: rileggere il c. XIV del “Paradiso”) e pone le condizioni per rileggere l’intera figura di san Giuseppe! Egli non è affatto un falegname che prepara la croce per inchiodarci su il bambino che gli è stato affidato, ma lo sposo di Maria, discendente della casa di Davide (“de domo David”: -https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181) che, come Salomone, ha saputo decidere e portare in salvo la madre vera e il bambino vero! O no?! -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- TRANSIZIONE CULTURALE. Brasile, la profezia di Marielle Franco (di Marielle Frnco).15 marzo 2021, di Federico La Sala
TRANSIZIONE CULTURALE... *
- "Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro (Mario Draghi)
Internazionale
Brasile, la profezia di Marielle Franco
Tre anni dopo. Resta senza mandanti l’omicidio della consigliera di Rio, avvenuto il 14 marzo 2018 per mano di due sicari. Ma alle ultime elezioni voti a valanga per 13 donne afrobrasiliane
di Glória Paiva (il manifesto, 14.03.2021)
Oggi il brutale omicidio della consigliera comunale brasiliana Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes compie tre anni. Militante, femminista, nera, residente a Favela da Maré e quinta consigliera più votata a Rio de Janeiro nel 2016, Marielle è diventata un simbolo mondiale della lotta antirazzista, per i diritti umani e lgbt+.
NONOSTANTE IL TEMPO trascorso, rimangono ancora domande sulle circostanze della sua morte. Perché le autorità locali e quelle nazionali non cooperano nella conduzione del caso? Qual è la conclusione dell’indagine relativa all’uso delle armi della polizia federale nel crimine? Chi ha spento le telecamere della strada in cui transitavano quella sera Marielle e Anderson? C’è stato un tentativo di depistaggio delle indagini? E la principale: chi ha ordinato l’omicidio di Marielle e perché?
Queste e altre questioni sono oggetto di un documento pubblicato dall’Istituto Marielle Franco, un’organizzazione creata dalla famiglia di Marielle per perpetuare la sua memoria. La famiglia chiede in modo costante risposte alle autorità di Rio de Janeiro che conducono le indagini. Tuttavia, si trovano spesso di fronte al silenzio: nell’ultima settimana, ad esempio, hanno cercato di incontrare il governatore dello stato, Cláudio Castro, e il procuratore generale, Luciano Mattos, ma non hanno avuto alcun riscontro, come ha riferito Anielle Franco, la sorella dell’attivista, in una conferenza stampa che si è tenuta venerdì 11 marzo.
FINORA, È NOTO SOLTANTO che Ronnie Lessa, poliziotto in pensione, e Élcio Queiroz, ex poliziotto, hanno aspettato l’auto di Marielle e Anderson nella Rua dos Inválidos, nel centro di Rio, prima di sparare contro il veicolo. Entrambi sono in un carcere di massima sicurezza e saranno sottoposti a un giudizio popolare, un processo in cui 25 cittadini, insieme al giudice, decideranno sulla colpevolezza o meno dell’imputato. L’ipotesi principale è che l’assassinio abbia avuto una motivazione politica e che vi abbiano partecipato delle milizie.
Secondo Jurema Werneck, direttrice esecutiva di Amnesty International in Brasile, i successivi cambiamenti negli organi responsabili delle indagini e la mancanza di trasparenza hanno ostacolato un’inchiesta rapida e imparziale. «In questi tre anni abbiamo avuto tre governatori, due procuratori generali, tre capi di polizia, tre pubblici ministeri. Nella pubblica sicurezza di Rio ci sono stati cinque cambi. Le autorità brasiliane non possono inviare un messaggio di impunità e di tolleranza rispetto alla violenza politica», dice Werneck. Che avverte: «Finché i mandanti sono liberi e sconosciuti, nessuno può sentirsi al sicuro».
«NON POSSIAMO ASPETTARE altri dieci anni prima che le donne nere vengano elette», aveva detto Marielle poche ore prima di essere uccisa. Il suo discorso è diventato una profezia: due anni dopo, nel 2020, alle ultime elezioni amministrative brasiliane, 13 donne nere sono state tra i candidati più votati nelle più grandi città del Brasile. Tra i consiglieri eletti, più di 70 si sono impegnati nella cosiddetta Agenda Marielle, che riunisce progetti di legge con pratiche e linee guida anti-razziste, femministe, lgbt + e popolari ispirate al lavoro svolto dall’attivista.
I politici sintonizzati su questi ideali, tuttavia, sono spesso a rischio. A Rio de Janeiro, le quattro donne nere elette con il Partito socialismo e libertà (Psol) hanno già registrato minacce di natura politica. «È necessario proteggere queste donne e inviare un messaggio a chi vuole mettere a tacere l’eredità di Marielle. Le persone che lottano per la giustizia, i diritti, la dignità devono essere protette perché sono un bene della società», dice Jurema Werneck.
Per il deputato federale Marcelo Freixo (Psol), amico ed ex compagno di lotta di Marielle, l’assassinio ha rivelato un lato brutale del Brasile. A cui il mondo ha reagito: «Le manifestazioni contro la morte di Marielle - osserva - mostrano la forza di ciò che lei ha rappresentato. Questa società capace di uccidere Marielle Franco non è la società che vogliamo»,
*
E Firenze le dedica una terrazza
Il messaggio di Marielle Franco ha fatto il giro del mondo e ha raggiunto anche Firenze. Dal 15 marzo l’attivista sarà la prima donna brasiliana nera ad avere il suo nome in uno spazio pubblico in Italia, sulla terrazza della Biblioteca delle Oblate.
 L’intitolazione è frutto della collaborazione tra la Cgil di Firenze e la Casa do Brasil a Firenze che hanno fatto specifica richiesta al Comune. «Questa terrazza non è uno spazio qualsiasi. Con vista sulla cupola del Brunelleschi, è un luogo simbolo del Rinascimento italiano. Possa la memoria di Marielle rinascere qui e offrire ai giovani la chance di riflettere su giustizia, diritti umani, diversità, tutto ciò che Marielle incarnava», commenta Ana Luiza Oliveira de Souza della Casa do Brasil a Firenze.
L’intitolazione è frutto della collaborazione tra la Cgil di Firenze e la Casa do Brasil a Firenze che hanno fatto specifica richiesta al Comune. «Questa terrazza non è uno spazio qualsiasi. Con vista sulla cupola del Brunelleschi, è un luogo simbolo del Rinascimento italiano. Possa la memoria di Marielle rinascere qui e offrire ai giovani la chance di riflettere su giustizia, diritti umani, diversità, tutto ciò che Marielle incarnava», commenta Ana Luiza Oliveira de Souza della Casa do Brasil a Firenze.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria" del 2004.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- La ricerca di Elvio Fachinelli e di Franco Cassano, al di là dell’antropologia e della logica di Hegel.13 marzo 2021, di Federico La Sala
SULLA SPIAGGIA. DINANZI AL MARE: MEMORIA , STORIA, E RICERCA ANTROPOLOGICA E FILOSOFICA...
- Una nota all’articolo di Stefano Modeo, “Ricordo di Franco Cassano: proseguire Il pensiero meridiano”, Le parole e le cose, 12 marzo 2021.
PER RIPRENDERE E PROSEGUIRE, SE SI VUOLE, IL LAVORO E LA RIFLESSSIONE DI ELVIO FACHINELLI ("LA MENTE ESTATICA", FEBBRAIO 1989) E DI FRANCO CASSANO ("APPROSSIMAZIONE", APRILE 1989), CREDO, SIA OPPORTUNO PARTIRE DALLE LORO OPERE: RISPETTIVAMENTE, dal libro "La mente estatica" di Fachinelli (pubblicato da Adelphi nel febbraio del 1989) e, insieme, dal libro "Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro" di Cassano (pubblicato dalla casa editrice "Il Mulino" nell’aprile del 1989) e, alla luce dei loro particolari programmi di ricerca volti a pensare e a superare "la frontiera", ricordare che la Caduta del Muro di Berlino avviene - senza violenza - nei primi giorni del mese di novembre del 1989.
"DEPORRE L’ELMO". Nel saggio dedicato all’analisi del lavoro di Fachinelli (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1568), contro i vari tentativi di neutralizzare la sua proposta ("Né demonizzare, né omologare"), così annotai :
- "L’espressione è ripresa da quell’interessante e coraggioso libro che «cerca di muoversi nello spazio etico che si trova tra demonizzazione e omologazione sulla base dell’idea che entrambi gli atteggiamenti vivano male la trascendenza dell’altro» di F. Cassano (Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro, Bologna, II Mulino, 1989, p. 8). Il tema centrale della sua riflessione è molto prossimo al tema dell’accogliere: si tratta di «deporre l’elmo» (p. 9) dell’intelligenza astuta e armata, quello di Atena-Metis. L’invito a non demonizzare e a non omologare è rivolto, per quanto riguarda la ricerca di Fachinelli (ma la cosa vale anche per quella di Cassano, come qualcuno ha già fatto), a S. Vegetti Pinzi, che chiude una sua recensione de La mente estatica (cfr. Dalla psicoanalisi all’estasi un viaggio della conoscenza, «Corriere della sera», 30.4.1989) con la seguente considerazione: «Si tratta, come è evidente, di una indagine ad alto rischio dove la psicoanalisi, sganciata dalla pratica clinica e dalla referenza teorica, esplora i territori dell’immaginario e le potenzialità della suggestione»." (Cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma, 1991, nota 26, pp. 146-147).
A distanza di trenta e più anni, non sembrano esserci altre vie, se non quella di deporre l’elmo e uscire dall’orizzonte della dialettica hegeliana, e praticare "esercizi di esperienza dell’altro". O no?!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- MEMORIA DI DANTE (25 MARZO 2021) E "ANNUNCIAZIONE". “L’amore muove il sole e le altre stelle” - e anche la Terra!12 marzo 2021, di Federico La Sala
COME NASCONO I BAMBINI? LA “RISPOSTA” DELLA TRADIZIONE CATTOLICA NELLA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA... *
- Una nota all’articolo di Nicola Fasano, "25 marzo. Annunciazione di Maria Vergine. Una tela a Maruggio" (Fondazione Terra d’Otranto, 25.03.2013).
SOLLECITANDO CON QUESTA “RIPRESA” UNA LODEVOLE E RINNOVATA ATTENZIONE AL TEMA DELLA “ANNUNCIAZIONE” NELLA RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA E RICORDANDO CHE L’EVENTO “rappresenta il momento in cui l’arcangelo Gabriele annuncia a Maria il concepimento di Gesù e la sua incarnazione [...] il 25 marzo, precisamente nove mesi prima della Natività di Cristo”, e, che “Iconograficamente la composizione vede protagonisti la Vergine, la colomba dello Spirito Santo e l’angelo annunciante”, FORSE, è UTILE riconsiderare come nel “corso dei secoli è cambiato il modo di rappresentare il tema” E ANCORA, se si vuole, cominciare a riesaminare con attenzione proprio il “mosaico dell’Annunciazione” di Pietro Cavallini (del 1291 - vedi, sopra: la seconda figura dell’articolo) e, poi, proseguire con le opere specifiche degli artisti “fiamminghi quali Van der Weyden, Campin, i quali dipingono la Vergine colta nella sua quotidianità domestica all’arrivo dell’angelo Gabriele” - e osservare con attenzione, IN PARTICOLARE, l’immagine del pannello centrale della “ANNUNCIAZIONE” (https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Campin#/media/File:Robert_Campin_011.jpg) del “Trittico di Mérode” (1427) di Robert Campin (https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Campin).
Proseguendo e, non dimenticando di riflettere anche sulla rilevanza per gli artisti del lavoro del cardinale Gabriele Paleotti sulle immagini sacre (“Discorso intorno alle immagini sacre e profane”, del 1582), è opportuno arrivare all’attuale presente storico (il prossimo 25 marzo è anche il giorno della prima Giornata dedicata all’opera e alla memoria di Dante - il “Dantedì”) e ricordare quanto “poco fa”, proprio all’inizio del Terzo Millennio dopo Cristo, il CARDINALE CASTRILLON HOYOS (proprio come un artista del 1200 o del 1400) dichiarò alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio” ("la Repubblica" del 17 novembre 2000, p. 35).
Forse, in questo “Anno speciale di San Giuseppe” indetto da papa Francesco (cfr. “DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” .. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-262319), sarà possibile sapere come nascono i bambini e le bambine e sarà possibile avere un’altra rappresentazione artistica della nostra stessa nascita?! Con Dante, non c’è affatto da dubitare: “L’amore muove il sole e le altre stelle” - e anche la Terra!
Buon lavoro...
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA QUESTIONE DI MATEMATICA.Il ommento (del 2005) di Luigi Cancrini al cap. 15 dell’Anatomia (1560) di Giovanni Valverde.10 marzo 2021, di Federico La Sala
MATEMATICA, ANATOMIA, E BAMBINI E BAMBINE. UNA QUESTIONE DI CIVILTÀ..
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
 Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Ovviamente la matematica non procede per voto o alzata di mano, ma per ipotesi e verifiche. Se i nostri politici avessero studiato matematica, e se studiandola l’avessero capita, si comporterebbero diversamente rispetto alle cariche dello Stato che ricoprono perché non agirebbero come singoli, ma come funzioni di un sistema più ampio del loro ego, e soprattutto non si preoccuperebbero delle cose ma delle relazioni tra le cose, dunque sarebbero più cauti nel dare una notizia falsa o non verificata, perché consci di quanto la notizia falsifichi il resto, talvolta il contesto.” (Chiara Valerio, La matematica è politica, Einaudi, Torino, 2020, p. 53).
Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo
risponde Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27)
«Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo».
Così inizia il capitolo 15 dell’Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato «De Testicoli delle donne» (p. 91). Dopo queste timide e tuttavia coraggiose ammissioni, ci vorranno altri secoli di ricerche e di lotte: «(...) fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società prepatriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme» (Françoise D’Eaubonne). Oggi, all’inizio del terzo millennio dopo Cristo, nello scompaginamento della procreazione, favorito dalle biotecnologie, corriamo il rischio di ricadere nel pieno di una nuova preistoria: «l’esistenza autonoma dell’embrione, indipendente dall’uomo e dalla donna che hanno messo a disposizione i gameti e dalla donna che può portarne a termine lo sviluppo» spinge lo Stato (con la Chiesa cattolico-romana - e il Mercato, in una vecchia e diabolica alleanza) ad avanzare la pretesa di padre surrogato che si garantisce il controllo sui figli a venire. Se tuttavia le donne e gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni residui dichiarassero quale destino pare loro preferibile, se un’improbabile adozione, la distruzione o la donazione alla ricerca scientifica, con la clausola che in nessun modo siano scambiati per denaro o ne derivi un profitto, la vita tornerebbe rivendicata alle relazioni umane piuttosto che al controllo delle leggi, ne avrebbe slancio la presa di coscienza dei vincoli che le tecnologie riproduttive impongono e più consenso la difesa della “libertà” di generare.
 Federico La Sala
Federico La SalaHo molto apprezzato la citazione di Valverde soprattutto per un motivo: perché dimostra, con grande chiarezza il modo timido e spaventato con cui da sempre gli uomini di scienza si sono accostati al tema della procreazione. Il problema di quello che era un tempo “l’anima” dell’essere umano, la sua parte più preziosa e più peculiare, quella cui le religioni affidavano il senso della memoria e dell’immortalità è stata sempre monopolio, infatti, dei filosofi e dei teologi che hanno difeso accanitamente le loro teorie (i loro “pregiudizi”: nel senso letterale del termine, di giudizi dati prima, cioè, del momento in cui si sa come stanno le cose) dalle conquiste della scienza. Arrendendosi solo nel momento in cui le verità scientifiche erano troppo evidenti per essere ancora negate e dimenticando in fretta, terribilmente in fretta, i giudizi morali e gli anatemi lanciati fino ad un momento prima della loro resa. Proponendo uno spaccato estremamente interessante del modo in cui il bisogno di credere in una certa verità può spingere, per un certo tempo, a non vedere i fatti che la contraddicono. Come per primo ha dimostrato, scientificamente, Freud.
Ragionevolmente tutto questo si applica, mi pare, alle teorie fra il filosofico e il teologico (come origine: i filosofi e teologi “seri” non entrano in polemiche di questo livello) per cui l’essere umano è tale, e tale compiutamente, dal momento del concepimento. Parlando di diritti dell’embrione tutta una catena ormai di personaggi più o meno qualificati per farlo (da Buttiglione a Schifani, da Ruini a La Russa) si riempiono ormai la bocca di proclami (sulla loro, esibita, profonda, celestiale moralità) e di anatemi (nei confronti dei materialistici biechi di una sinistra senza Dio e senza anima).
In nome dell’embrione sentito come una creatura umana, la cui vita va tutelata, con costi non trascurabili, anche se nessuno accetterà mai di impiantarli in un utero. Mentre milioni di bambini continuano amorire nel mondo e intorno a loro senza destare nessun tipo di preoccupazione in chi, come loro, dovendo predisporre e votare leggi di bilancio, si preoccupa di diminuire la spesa sociale del proprio paese (condannando all’indigenza e alla mancanza di cure i bambini poveri che nascono e/o vivono in Italia) e le spese di sostegno ai piani dell’Onu (mantenendo, con freddezza e cinismo, le posizioni che la destra ha avuto da sempre sui problemi del terzo mondo e dei bambini che in esso hanno la fortuna di nascere).
Si apprende a non stupirsi di nulla, in effetti, facendo il mestiere che faccio io. Quando un paziente di quelli che si lavano continuamente e compulsivamente le mani fino a rovinarle, per esempio, ci dice (e ci dimostra con i suoi vestiti e con i suoi odori) che lava il resto del suo corpo solo quando vi è costretto da cause di forza maggiore, ci si potrebbe stupire, se non si è psichiatri, di questa evidente contraddizione. Quello che capita di capire essendolo, tuttavia, è che i due sintomi obbediscono ad una stessa logica (che è insieme aggressiva e autopunitiva) e che il primo serve di facciata, di schermo all’altro che è il più grave e il più serio. E accade a me di pensare, sentendo Buttiglione e La Russa che parlano di diritti dell’embrione e ignorando nei fatti quelli di tanti bambini già nati, che il problema sia, in fondo, lo stesso. Quello di un sintomo che ne copre un altro. Aiutando a evitare il confronto con la realtà e con i sensi di colpa. All’interno di ragionamenti che dovrebbero essere portati e discussi sul lettino dell’analista, non nelle aule parlamentari.
Così va, tuttavia, il mondo in cui viviamo. Perché quello che accomuna la Chiesa di ieri e tanta destra di oggi, in effetti, è la capacità di far germogliare il potere proprio dalle radici confuse della superficialità e del pregiudizio. Perché essere riconosciuti importanti ed essere votati, spesso, è il risultato di uno sforzo, anch’esso a suo modo assai faticoso, “di volare basso”, di accarezzare le tendenze più povere, le emozioni e i pensieri più confusi di chi non ama pensare. Parlando della necessità di uno Stato che pensi per lui, che decida al suo posto quello che è giusto e quello che non lo è. Liberandolo dal peso della ragione e del libero arbitrio. Come insegnava a Gesù, nella favola immaginata da Dostojevskji, il Grande Inquisitore quando Gesù aveva avuto l’ardire di tornare in terra per dire di nuovo agli uomini che erano uguali e liberi e rischiava di mettere in crisi, facendolo, l’autorità di una Chiesa che per 16 secoli aveva lavorato per lui e agito nel suo nome.
Del tutto inimmaginabile, sulla base di queste riflessioni, mi sembra l’idea che Buttiglione e Ruini, Schifani e La Russa possano accettare oggi l’idea da te riproposta nell’ultima parte della tua lettera per cui «le donne, gli uomini e le coppie che si sentono responsabili degli embrioni» potrebbero/ dovrebbero essere loro a decidere quale destino pare loro preferibile.
Ragionando sui fatti con persone scelte liberamente da loro perché sentite come capaci di dare loro gli elementi necessari per la decisione più corretta. Affermando l’idea per cui gli uomini, le donne e le coppie possono e debbono essere i veri protagonisti di quella procreazione responsabile che è il passaggio più alto, più difficile, più esaltante e più faticoso della vita di tutti gli esseri umani. Quella che più fa paura a tanta parte della Chiesa e della destra, in fondo, è soprattutto la libertà della coscienza critica. Per ragioni, io torno qui sul mio ragionamento iniziale, che andrebbero discusse sul lettino dell’analista, però, non nelle aule parlamentari, sui manifesti o sulle pagine di un giornale.
- LA MATEMATICA È LA COSTITUZIONE, “È una disciplina che non ammette principio di autorità giacché nessuno possiede la verità da solo, le verità sono asserzioni verificabili da chiunque, o se non da chiunque (alcune volte è difficile) almeno da un certo numero di persone. Inoltre, la matematica è un linguaggio, una grammatica. Per discutere di matematica bisogna accettarne le regole. Sicché uno studioso, ma anche uno studente di matematica, è abituato a operare in un mondo di regole comuni, per ridiscutere le quali non si può essere in uno, bisogna essere almeno in due.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MENTE ACOGLIENTE: MEMORIA DEL LAVORO DI ELVIO FACHINELLI E FRANCO CASSANO.6 marzo 2021, di Federico La Sala
Franco Cassano (1943-2021)
di Raffaele Rauty (Il Mulino, 01 marzo 2021)
Sollevare l’elmo * e aprirsi all’altro avendo attraversato il fiume sino alla riva che non è la nostra, mentre l’acqua, l’altro, il confine attraversato, la fronte scoperta segnano una soggettività che affronta un destino incerto ma necessario, che ridefinisce relazioni e futuro. Franco Cassano, autore di questa immagine, a lui molto cara, è stato intellettuale, sociologo, riformatore, cultore di teoria e democrazia, militante non settario: sempre idealmente dalla parte dei deboli, non ha concepito distacco o scissione da un impegno storicamente legato alla trasformazione sociale, in un pensiero non consolatorio e mai concluso.
 Dalla sezione universitaria comunista alla cittadinanza attiva di Città plurale, entrambe di Bari, città simbolo di tante città e di tanti Sud, in una realtà nella quale mezzogiorno, mediterraneo, meridionalismo, hanno assunto identità, significati, legami, consapevolezze, potenzialità diversi dal passato, Cassano ha segnato la strada di una lunga stagione i cui attori di volta in volta ne sono divenuti parte, rispondendo a una chiamata, come la vocazione di Matteo del Caravaggio, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma che Franco, quando poteva, amava visitare, simbolo di un Beruf fissato nella storia. Ma quella chiamata, quel Beruf non si concludevano in sé, ma erano solo l’inizio di una nuova lunga drammatica turbolenza, interiore ed esteriore.
Dalla sezione universitaria comunista alla cittadinanza attiva di Città plurale, entrambe di Bari, città simbolo di tante città e di tanti Sud, in una realtà nella quale mezzogiorno, mediterraneo, meridionalismo, hanno assunto identità, significati, legami, consapevolezze, potenzialità diversi dal passato, Cassano ha segnato la strada di una lunga stagione i cui attori di volta in volta ne sono divenuti parte, rispondendo a una chiamata, come la vocazione di Matteo del Caravaggio, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma che Franco, quando poteva, amava visitare, simbolo di un Beruf fissato nella storia. Ma quella chiamata, quel Beruf non si concludevano in sé, ma erano solo l’inizio di una nuova lunga drammatica turbolenza, interiore ed esteriore.La lettura e le parole dei testi, con i quali lavorava come in una enigmistica continua, erano premessa di analisi libera e ininterrotta, anche se il suo debito con la tradizione sociologica lo aveva pagato appena nell’università con il lavoro su Weber, Mills, Habermas (1971), in una scelta di studio segnata, come dichiarato in un colloquio lontano, dal fatto che Weber era stato ed era per lui verifica continua, «il grande», «quello cui devo tanto e sento sempre di dover tornare».
Franco il suo esame di «ammissione» nella comunità scientifica non lo fece con un concorso universitario, metodo mai amato ma forse necessario di cooptazione, ma con Marxismo e Filosofia (1971) testo ormai dimenticato, di un’editrice meridionale anch’essa dimenticata, la De Donato, che riproponeva testi e discussioni svoltisi sulle pagine di riviste comuniste, di difficile memoria, «Rinascita» e «Il Contemporaneo». E Franco, a trent’anni osò riflettere e confrontarsi con il cuore del marxismo e della politica, aprendo una riflessione, ai limiti dell’eresia per i suoi caratteri, a un retroterra che a Gramsci e Marx sommava anche Della Volpe e Panzieri, e che in quella semplice aggregazione di testi, ristrutturava i termini dell’analisi sociale.
 Fu un esordio silenziosamente fragoroso, compreso, non so quanto condiviso, allora e nel seguito del percorso, da amici con i quali sarebbe rimasto un rapporto di affetto fraterno sempre, di stima reciproca continua, di distanza teorica frequente, Beppe (Vacca), Gino (de Giovanni), Giuseppe (Cotturi), Peppino (Caldarola), Franco (de Felice), tutti parte, individuale e collettiva, della storia del marxismo e della democrazia in Italia.
Fu un esordio silenziosamente fragoroso, compreso, non so quanto condiviso, allora e nel seguito del percorso, da amici con i quali sarebbe rimasto un rapporto di affetto fraterno sempre, di stima reciproca continua, di distanza teorica frequente, Beppe (Vacca), Gino (de Giovanni), Giuseppe (Cotturi), Peppino (Caldarola), Franco (de Felice), tutti parte, individuale e collettiva, della storia del marxismo e della democrazia in Italia.La sua ricerca appassionata, apparente tradimento o addirittura negazione di tradizioni profonde, quasi sacre, iniziava nelle librerie: avendo fatto della interdisciplinarità la madre delle sue categorie, frugava tra i libri con una curiosità che era strategia di costruzione della riflessione, dell’analisi e della comunicazione, dalla narrativa alle scienze sociali, alla letteratura e alla storia, piegando tutto, e raccogliendo, rigo dopo rigo, periodo dopo periodo, suggestioni per l’interpretazione della modernità in un contatto continuo tra senso comune e scienza. È stato un colloquio con autori emblematici del loro mondo, spesso inattesi, Pasolini, Fortini, Camus, Weil, Rossanda, Leopardi, passaggio simbolico il cui antecedente era stato un altro grande marxista a suo modo irregolare, Cesare Luporini, che aveva anche osato dialogare con «il mondo magico» meridionale, e poi altri e altri ancora.
In coerenza con questo, Franco Cassano, pur consapevole del suo ruolo, non amava definirsi sociologo; sentiva questa definizione, forse l’immanenza della disciplina, troppo stretta per la riflessione condotta e per una sensibilità che entrava in rapporto con universi spesso ancora lontani dai mondi più tradizionali che frequentava, il femminismo prima di tutti.
 E i suoi lavori, tutti, dal Teorema democristiano a Senza il vento della storia, sono in qualche modo costruiti in modo non tradizionale, ricchi di notazioni interne al testo, a inseguire il filo centrale del discorso e le sue connessioni a volte appena accennate, spesso tracce di culture lontane ma riconoscibili e da riconoscere. Molto prima della discussione sui migranti le rive del Mediterraneo e i popoli di quelle terre riacquisirono la connotazione di contesti comuni e di fratelli, in una idea di cittadinanza, presenza, partecipazione, che sovrastava ogni limite esclusivo.
E i suoi lavori, tutti, dal Teorema democristiano a Senza il vento della storia, sono in qualche modo costruiti in modo non tradizionale, ricchi di notazioni interne al testo, a inseguire il filo centrale del discorso e le sue connessioni a volte appena accennate, spesso tracce di culture lontane ma riconoscibili e da riconoscere. Molto prima della discussione sui migranti le rive del Mediterraneo e i popoli di quelle terre riacquisirono la connotazione di contesti comuni e di fratelli, in una idea di cittadinanza, presenza, partecipazione, che sovrastava ogni limite esclusivo.Franco Cassano, nelle aule universitarie di Bari, e nelle tante dove è stato chiamato a fare lezione, ha contribuito alla formazione di tanti studenti, in un lavoro mai divenuto consuetudine, e la sua sociologia lo aiutò in una rigorosa direzione de la «Rassegna Italiana di Sociologia», in una fase che, con l’avallo della sua casa editrice, raccolse nella redazione parte dei migliori esponenti della sociologia italiana, in una aggregazione che univa i percorsi teorici di sociologi come Franco Crespi, Margherita Ciacci, Pierpaolo Giglioli, Loredana Sciolla, Chiara Saraceno, con quelli di un gruppo di colleghi più giovani, miscelando esperienze e approcci analitici diversi, scienza, confronti, tutti cementati da stima reciproca, sensibilità, anche affetto.
La riflessione meridiana, centrale nella sua esistenza e nella sua attività, fu così la maturazione di premesse evidenti, in una riacquisizione di centralità e autonomia del Sud, risorsa struggente, carica di orgoglio e di impegno, di speranza e necessità, di opportunità e scelta, consapevole che molti, anche importanti, avevano trovato modo di abdicare a questo e che si trattava di una difficile ma necessaria operazione di riequilibrio, di riconquista di un lessico che aveva visto esaurirsi quello del meridionalismo storico e il suo soggetto politico naturale, di fatto sbiadito, spesso silenzioso, ormai lontano dai luoghi delle necessarie trasformazioni. In tanti volevano conferma che quel lessico e quel soggetto non fossero scomparsi, e che invece si stavano ristrutturando per poter tornare all’altezza dei tempi e delle necessità, in una presenza nuova in grado di raccogliere disponibilità antiche. Uno sguardo, un pensiero quelli di Franco che «andavano oltre», inseguendo l’equilibro drammatico dell’esistenza e da questo colpiti, irregolari rispetto a un senso comune teso alla tranquillità.
Avrebbe potuto essere un intellettuale aristocratico, è stato uomo popolare, amante del calcio, dei cani, del verde, in un rapporto di amore verso gli altri, tutti, forse alcuni in particolare, intoccabili: Bari, la Puglia, il mare, certo; e ancora di più, Luciana, Peppe, e Rossella, Linda, Elisa, tra presente, ricordi e futuro.
* SUL TEMA DEL "DEPORRE L’ELMO", DEL SOLLEVARE L’ELMO, DA NON DIMENTICARE, INSIEME AL LAVORO DI FRANCO CASSANO, "Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro", Il Mulino, Bologna, 1989 (aprile), il lavoro di Elvio Fachinelli, "La mente estatica", Adelphi, Milano, 1989 (febbraio)!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- LA VIA DI UNA NUOVA "COGNAZIONE" ANTROPOLOGICA: L’INDICAZIONE DI DANTE.2 marzo 2021, di Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- UN’INDICAZIONE FILOLOGICA: DALL’ANDROLOGIA ALL’ANTROPOLOGIA.24 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. Un francobollo del Vaticano postale.16 febbraio 2021, di Federico La SalaCRISTIANESIMO E CATTOLICESIMO-ROMANO: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA.
 Per capire l’importanza storica e culturale di un fracobollo
Per capire l’importanza storica e culturale di un fracobollo
 (https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=30331),
(https://www.vaccarinews.it/index.php?_id=30331),
 un brillante lavoro sulla figura di San Giuseppe: "De Domo David"
un brillante lavoro sulla figura di San Giuseppe: "De Domo David"
 (https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/)
(https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LÀ DELLA DIALETTICA HEGELIANA: DUE SOLI, DUE LIBRI, E DUE SOGGETTI. In memoria di Dante e di Galilei.15 febbraio 2021, di Federico La Sala
Tweet
#DANTE2021 A 700 anni dalla #morte di #Dante, ancora non compresi i #due significati (i #duesoli) del "vicisti, #Galilaee". PER #Keplero, come per #Kant, la vittoria di #GalileoGalilei è filosofico-scientifica!
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5061#Mathematics #anthropology #Theology #philosophy In #memoria di #GalileoGalilei (nato il #15febbraio 1564), ricordare i #duesoli (#Dante2021) e i #duelibri di #Galilei e che il #logos non è un #logo
 http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1205FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- NOME E COGNOME: COSTITUZIONE E CODICE CIVILE! La Consulta: "Il cognome del padre è retaggio patriarcale, basta disparità" (Ansa).12 febbraio 2021, di Federico La Sala
La Consulta: "Il cognome del padre è retaggio patriarcale, basta disparità"
"Non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna"
- [Foto] Una coppia con la loro figlia © ANSA
di Redazione ANSA*
ROMA L’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre? Con questo dubbio, la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio. L’ordinanza n. 18 depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano.
L’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli "è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", e di "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna". Lo sottolinea, riprendendo una sua pronuncia del 2006, la Consulta, nell’ordinanza con cui ha sollevato davanti a se’ stessa la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "INTREARSI": CON DANTE, A LEZIONE DA PILATO.9 febbraio 2021, di Federico La Sala
Tweet:
#DANTE2021 #Monarchia, #DueSoli, e "l’#amor ch’a lor s’intrea" (Pd. XIII 57). #Imparare a #contare e a #pensare trinitaria-#mente: #intrearsi. Lezione di #PonzioPilato: #natura del #Figlio dell’#Uomo (#EcceHomo: gr. «idou ho #anthropos») secondo #antropologia (non #andrologia)!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- “Virgo et Sacerdos. Idee femminili di sacerdozio tra Ottocento e Novecento”. Intervista a Liviana Gazzetta (di "Letture").6 febbraio 2021, di Federico La Sala
“Virgo et Sacerdos. Idee femminili di sacerdozio tra Ottocento e Novecento” di Liviana Gazzetta
Intervista *
Dott.ssa Liviana Gazzetta, Lei è autrice del libro Virgo et Sacerdos. Idee femminili di sacerdozio tra Ottocento e Novecento pubblicato dalle Edizioni di Storia e Letteratura: in che modo, a cavallo tra ’800 e ’900, soprattutto in Francia e Italia, si pose il problema del ruolo femminile nel sacerdozio cattolico?
È noto che la questione del diaconato e del sacerdozio femminile si affaccia con chiarezza nella Chiesa della fase conciliare e, ancor più, postconciliare, a partire quindi dagli anni ’60 del XX secolo. Ciò che però emerge da questa ricerca è che anche prima della fase conciliare si è espresso un desiderio, o meglio, un’aspirazione femminile al sacerdozio: è nella devozione alla Vergine Sacerdote (Virgo sacerdos), che si sviluppò in particolare tra le figlie del Cuore di Gesù a cavallo tra ‘800 e ‘900, che si può mostrare l’esistenza di una domanda latente di sacerdozio. Si tratta di una via che definirei di natura cultuale e mariologica al sacerdozio femminile, dove l’aspirazione era espressa sotto il segno della vocazione, e non della rivendicazione, della dedizione e non della pretesa di spazi. E fu questa via a preoccupare la Chiesa ben prima che negli anni ’60 venisse ad essere ufficialmente sollevata la questione dell’ordinazione femminile.
Come si sviluppò la devozione alla «Vierge Prêtre?
La devozione alla «Vierge Prêtre» o «Virgo sacerdos» si sviluppò in special modo (ma non solo) nella congregazione delle figlie del Cuore di Gesù, fondata nel 1872 da Marie Deluil-Martiny e approvata nel 1902 da Leone XIII: un ordine contemplativo, nato all’incontro di complesse matrici spirituali, centrate sull’oblazione eucaristica, la riparazione dei peccati e l’imitazione di Maria al Calvario o -per usare le parole della stessa fondatrice- sullo spirito eucaristico, lo spirito di vittima, lo spirito sacerdotale.
Il titolo di «Virgo Sacerdos» era entrato apertamente nella liturgia cattolica a partire dal 1709, quando presso il seminario di Saint Sulpice si era cominciato ad utilizzare con regolarità, per la festa della Presentazione al tempio, un inno dei Vespri che lo conteneva. Tale festa era qui diventata la celebrazione per eccellenza della spiritualità sacerdotale e della devozione a Maria, costituendo anche il momento della rinnovazione pubblica della professione per i membri della congregazione di San Sulpizio, oltre che festa del seminario. Se nei secoli precedenti Maria era stata al centro soprattutto di una riflessione teologica e filosofica, ora la via al sacerdozio mariano era tutta spirituale e in alcuni casi misticheggiante: Maria era il modello del prete concepito come culmine delle virtù religiose, sempre più interpretata come riferimento contro ogni forma di degenerazione nella vita del clero.
La spiritualità e la devozione alla «Virgo Sacerdos» o «Vierge Prêtre» fu dunque ereditata dalla scuola francese del ‘700. All’interno di una più complessa elaborazione spirituale, l’aspettativa della madre Maria di Gesù (questo il nome assunto in religione dalla Deluil Martiny) era che si realizzasse il tempo in cui i preti avrebbero adempiuto pienamente il loro ministero, nella purezza e nella perfezione di vita che le sembrava mancare attorno a sé; le sue ‘figlie’ dovevano essere come delle vittime che, in analogia a Maria ai piedi della croce e accanto al ‘discepolo amato’, sostenessero i sacerdoti nella loro missione e si immolassero per riparare l’indegnità dei membri del clero.
Nel 1906 le religiose chiesero di poter usare l’appellativo di «Vierge Prêtre» nei riti del proprio istituto e Pio X accolse la richiesta, facendo stendere una preghiera che fu poi arricchita di indulgenze; lo stesso papa concesse nel 1910 che nelle cappelle dell’istituto si potesse aggiungere alle litanie mariane l’invocazione «Virgo Sacerdos, ora pro nobis». Le religiose fecero allora produrre anche delle immagini collegate alla devozione: immagini che raffiguravano la Vergine, abbigliata in vesti sacerdotali, che al di sopra del globo terrestre schiacciava il serpente con le braccia alzate verso il cielo.
Come si è articolata storicamente la riflessione teologica sul tema del sacerdozio di Maria?
Il tema del sacerdozio di Maria percorre un po’ tutta la storia della cristianità. In origine il titolo di «sacerdos» attribuito alla Vergine è attestato nell’ambito della tradizione omiletica: nel contesto, cioè, di un genere letterario, sviluppatosi nella cultura greca tra VII e IX secolo, in cui si usavano metafore e immagini che stabilivano un rapporto tra Maria e l’Eucarestia, o che riconoscevano un ruolo attivo della Madonna nel donare il pane di vita grazie al suo ruolo materno, anche se va detto che gli omelisti usavano idee e suggestioni che difficilmente possono essere ricondotte a concetti: alla base di questa tradizione, ad esempio, stava l’autorità dello Pseudo Epifanio, che attribuiva a Maria il valore di tavola, di altare e di prete.
Nel Medioevo l’idea del sacerdozio della Vergine conosce un significativo sviluppo sul piano teorico. Una delle vie filosofico-teologiche attraverso cui tra Alto e Basso Medioevo è possibile parlare di sacerdozio mariano è costituita dalla diffusione delle idee dello Pseudo Dionigi. Poiché nella prospettiva sincretistico-neoplatonica di questo autore (e dei molti suoi seguaci) la relazione tra i diversi ordini di realtà si pone in chiave gerarchica, ciò induce inevitabilmente a collocare la Vergine in una posizione di primato nei confronti delle gerarchie della Chiesa (e non di rado anche di quelle angeliche). Chi contribuisce in modo determinante in questa direzione è l’autore come lo Pseudo Alberto Magno: il suo Mariale super missus est in più punti sostiene che la pienezza conferita nell’ordinazione sacerdotale appartiene anche a Maria, anche se non la riceve con apposito sacramento, e lascia intendere che non esiste nessuna motivazione - neppure l’inferiorità indiscussa del sesso femminile - per fondare la sua esclusione dal sacerdozio.
In età moderna, oltre e più che la via dottrinale, si è profilata una ‘via al sacerdozio’ della Vergine di natura più propriamente devozionale e spirituale. Questa declinazione si manifesta in un sentimento del legame speciale tra il prete e la Vergine, in un ricorso particolare del sacerdote alla mediazione di Maria nelle funzioni sacramentali: quasi una somiglianza, un’imitazione particolare della Madonna ad opera del prete, che avvia la tradizione delle messe offerte secondo le intenzioni di Maria e la pratica della rinnovazione delle promesse sacerdotali in concomitanza con le feste mariane. Soprattutto all’interno della scuola francese (in primis il seminario di san Sulpizio) si sostiene che Maria ha una sovranità sugli apostoli che non le deriva tanto da una precisa giurisdizione, sempre ritenuta sconveniente al sesso femminile, ma dalla pienezza dello spirito e della grazia: ciò che la rende, dopo l’Ascensione, non il capo dotato di autorità sulla Chiesa, ma il cuore della comunità dei credenti.
Quali vicende segnarono l’indagine inquisitoriale cui fu sottoposto l’ordine delle Figlie del Cuore di Gesù della Deluil Martiny?
Dimostrando di temere soprattutto le conseguenze della devozione sul piano pastorale, per l’associazione tra figura femminile e titolo di sacerdote che essa comportava, il Sant’Uffizio impose una drastica censura alle figlie del Cuore di Gesù e alle loro iniziative. A partire dal 1912 l’ordine venne sottoposto a più riprese all’esame del Sant’Uffizio, che con tre interventi successivi nel 1913, 1916 e 1927 vietò dapprima le immagini, quindi le forme devozionali alla Vergine sacerdotale che vi erano state sviluppate; nel 1927 una lettera del cardinal Merry Del Val, segretario della Suprema, precisò che tale devozione non era approvata e non poteva essere propagata in nessuna forma. Nonostante non riguardassero la dottrina della partecipazione di Maria al sacerdozio in sé, tali interventi hanno quasi oscurato un’intera tradizione teologico-spirituale sul tema del sacerdozio della Vergine, che per secoli ha attraversato cristianesimo e il cattolicesimo occidentali.
Il Sant’Uffizio affermò che, se da un punto di vista dottrinale non si poteva non attribuire a Maria il titolo di mediatrice nella salvezza, e quindi di sacerdote, non era però conveniente farne uso, soprattutto se a farlo erano delle donne. Le conseguenze della devozione considerate più riprovevoli erano quelle che stabilivano un’associazione tra figura femminile e sacerdozio: perché cioè con il culto alla «Vierge Prêtre» le religiose potevano, da una parte, prefigurarsi quasi come delle sacerdotesse (e magari accreditare queste convinzioni presso i fedeli); dall’altra, proporsi come riparatrici degli errori del clero.
Dopo la bufera d’inizio secolo, nel 1989 la famiglia religiosa ha visto concludersi il processo di canonizzazione della fondatrice, proclamata beata da papa Giovanni Paolo II.
In che modo la vicenda del culto alla Virgo sacerdos offre spunti per il dibattito attuale intorno al divieto alle donne all’esercizio del ministero sacro?
Sul piano spirituale emerge il circuito virtuoso che già tra ‘800 e ‘900 poteva crearsi, in determinati settori del cattolicesimo femminile, tra una soggettività consapevole di sé e il modello della Vergine corredentrice: un circuito che può ‘ispirare’ ancor più oggi, a fronte di una crescita esponenziale dell’autonomia e dell’autorevolezza femminile nella vita ecclesiale.
Sul piano storico la vicenda mostra un protagonismo femminile fin qui insospettato, connesso sia all’esigenza di un maggior ruolo nell’accesso al sacro, sia alla richiesta di una profonda riforma ecclesiale. In essa emerge quanto diffusa e radicata fosse la preoccupazione per l’inadeguatezza del clero maschile tra le nuove fondazioni femminili nel primo ‘900, mentre nei procedimenti inquisitoriali emerge un altrettanto diffuso fastidio nei loro confronti. Sul piano storiografico la ricerca indica che la cosiddetta femminilizzazione del cattolicesimo, che interessa l’età contemporanea, porta con sé un’ambivalenza e una conflittualità strutturali. Se dalle spinte per un maggiore coinvolgimento femminile contro i ‘nemici’ della Chiesa si passava all’idea di una comunanza d’azione delle religiose col clero, si usciva dai confini prescritti alle donne e si poteva incorrere nell’interdizione; ed evidentemente lo sconfinamento risultava tanto più grave in quanto veicolato attraverso l’identificazione con Maria corredentrice. In sostanza si evidenzia come all’interno della Chiesa i rapporti tra i sessi non siano meno conflittuali che negli altri ambiti della società, e ciò nonostante la Chiesa si appelli ricorrentemente al contributo o al ‘genio’ femminile.
Nei fenomeni qui ricostruiti, infine, si comprende come la domanda femminile di sacerdozio possa espressa sotto il segno della vocazione e non della rivendicazione di un diritto, della dedizione di sé e non della protesta: un’offerta cui la Chiesa non riesce ancora a rispondere anche perché (si pensi che alla dichiarazione Inter insigniores) si confondono di fatto questi due piani.
Liviana Gazzetta è dottore di ricerca in Storia sociale europea (presso l’Università Cà Foscari di Venezia), socia del Coordinamento Teologhe Italiane e presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento di Padova. I suoi interessi di studio e la sua attività di ricerca si sono sviluppati nell’ambito della storia dei movimenti delle donne in età contemporanea; su questi temi ha pubblicato molti articoli e alcune monografie, l’ultima delle quali è Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia 1865-1925, Roma 2018.
* Fonte: Letture.org.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- SUL TITOLO SACERDOTALE MARIANO (di Daniele Menozzi, storico).6 febbraio 2021, di Federico La Sala
«Ambizioncella muliebre»: sul titolo sacerdotale mariano
di Daniele Menozzi, Storico (Il Regno, Re-blog, 2 Febbraio 2021)
- [Foto]Madonna dei Palafrenieri
La proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione nel 1854 è stata interpretata come un «evento strutturante» nella storia del cattolicesimo contemporaneo. Ha in effetti avuto diverse conseguenze di rilievo. A esse si può ascrivere anche l’avvio della discussione, non ancora conclusa all’interno della Chiesa, sul sacerdozio femminile. Claude Langlois - il noto studioso della femminilizzazione del cattolicesimo ottocentesco, che per primo ha colto il nesso tra la valorizzazione della figura di Maria derivante dalla dichiarazione del suo concepimento senza peccato e la manifestazione del desiderio femminile per il sacerdozio - ha poi mostrato come l’aspirazione al ministero, chiaramente formulata da Teresa di Lisieux nel 1896, fosse condivisa anche da altre personalità del panorama religioso di fine Ottocento. Tra queste indicava Marie Deluil-Martiny, nata nel 1841 a Marsiglia da una famiglia aristocratica, fondatrice nel 1872 della congregazione delle Figlie del Sacro Cuore a Berchem presso Anversa, uccisa nel 1884 da un anarchico che era stato suo giardiniere e beatificata nel 1989 da Giovanni Paolo II.
Avvio della discussione sul sacerdozio femminile
L’attenzione della suora francese al tema è ora analizzata da Liviana Gazzetta, autrice di diverse opere sulla storia del movimento cattolico femminile. Il volume Virgo et sacerdos. Idee di sacerdozio femminile tra Ottocento e Novecento (Edizioni di storia e letteratura, Roma 2020), pur non potendo contare sull’insieme degli scritti di Deluil-Martiny, ancora inaccessibili per il processo di canonizzazione, si è potuto valere, oltre che di quanto già pubblicato, della serie documentaria «Devotiones variae» depositata presso l’Archivio della Congregazione per la dottrina della fede (Virgo et sacerdos. Idee di sacerdozio femminile tra Ottocento e Novecento, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2020). L’opera si presenta, più che sotto forma di una ricostruzione organica, come una serie di affondi successivi che sviluppano e approfondiscono alcune ipotesi di lavoro. Nonostante l’apparente frammentarietà e qualche ripetizione, il libro non solo risulta di straordinario interesse per una questione, il sacerdozio femminile, di bruciante attualità ecclesiale, ma anche del tutto persuasivo nei suoi, per quanto provvisori, esiti conoscitivi.
Il titolo di Virgo sacerdos.
Filo conduttore della ricostruzione è la declinazione tra Ottocento e Novecento del richiamo a Maria col titolo di Virgo sacerdos. Il sintagma, di origine patristica, trova nel Medioevo una duratura sistemazione dottrinale sulla base della pregiudiziale premessa dell’impedimentum sexus per l’accesso al sacerdozio. L’appellativo comporta l’attribuzione alla Vergine non del carattere sacerdotale, che appartiene esclusivamente a chi ha ricevuto l’ordine e detiene quindi il potere di sacrificio; bensì dello spirito sacerdotale. Maria possiede, in grado eminente rispetto a ogni creatura, questo attributo che condivide peraltro con tutti i battezzati in quanto comporta soltanto la capacità di rendersi vittime, ostie immolate per la salvezza del mondo.
In questa chiave la locuzione entra nella liturgia fin dal XVIII secolo, ma nella seconda metà dell’Ottocento diverse opere di ecclesiastici attivi nel prorompente movimento mariano inseriscono la distinzione in una più ampia interpretazione teologica della figura della Vergine. Gli episodi centrali della sua vita - generazione di Cristo, purificazione al Tempio, presenza sotto la croce - sono letti come una compartecipazione all’offerta al Padre della vittima divina che la portano ad assumere, sia pure in grado diverso, i titoli stessi del Figlio: mediatrice, corredentrice e sacerdote. Questa letteratura alimenta la spiritualità di Deluil-Martiny e del gruppo riunito attorno a lei, in particolare di Elise Le Vassor de Sorval, che, succedendole nella direzione della congregazione, la sviluppa con notevolissime capacità organizzative e politiche.
Maria con la dalmatica
Si tratta di una ricezione creativa che si fonda sulla comune adesione all’egemone cultura intransigente. Ne è infatti punto di partenza la prospettiva di riconquista cristiana di una società moderna che si è sottratta alla direzione ecclesiastica. Di fronte alla costatazione dell’inadeguatezza del clero nella lotta in corso per la restaurazione della cristianità, si definisce un carisma specifico dell’istituto religioso: l’offerta vittimale in riparazione degli errori e dell’insufficienza dei sacerdoti. Il riferimento alla Virgo sacerdos ne è la sintesi spirituale, simbolica e devozionale. Lo mostrano i testi delle preghiere in uso nella congregazione; le immagini devozionali in cui Maria, in piedi sul globo, indossa sopra la tunica la dalmatica mentre schiaccia la testa del serpente (all’epoca generalmente identificato con la rivoluzione anticristiana); l’abito delle suore che ripropone la pianeta dei preti.
Aspirazione a un ministero sacerdotale
Nel discorso pubblico delle appartenenti alla congregazione la generale interpretazione della figura di Maria come paradigma esemplare per stabilire il ruolo femminile nella Chiesa si applica anche alla funzione sacerdotale attribuita alla Vergine. Per questa via esse esprimono l’esigenza di un protagonismo ecclesiale della donna che ne affermi la parità senza metterne in questione la diversità. Ma i loro documenti privati lasciano chiaramente trasparire qualcosa di più: l’aspirazione all’esercizio di un ministero sacerdotale che le donne saprebbero svolgere in modo più degno e più adeguato ai bisogni dei tempi. Pur senza una specifica denuncia, il Sant’Uffizio - che aveva preso in esame una prima volta tra il 1838 e il 1842 il tema della Virgo sacerdos, senza assumere in merito alcuna decisione - avverte nelle pratiche dell’istituto un pericolo per l’ortodossia.
Da Roma concessioni poi revocate
Inizialmente Roma era stata larga di concessioni. Dopo il riconoscimento di Leone XIII, nel 1906 la congregazione aveva ottenuto da Pio X di inserire una menzione alla Vierge prêtre nelle preghiere della congregazione, ben presto arricchite di indulgenze. Poi nel 1910 il pontefice aveva concesso che nelle litanie mariane le religiose aggiungessero l’invocazione Virgo sacerdos, ora pro nobis. Provvedimenti assai significativi, perché in quegli stessi anni papa Sarto taglia corto sulle istanze di emancipazione femminile presenti nella comunità ecclesiale, escludendo le donne dal canto sacro e imponendo che non prendano la parola nelle assemblee del movimento cattolico. Ma il Sant’Uffizio, nel 1913 - ma renderà pubblica la decisione tre anni dopo - revoca tutte le precedenti concessioni e vieta l’uso dell’immagine devozionale che aveva avuto anche una traduzione pittorica in un’opera di Silverio Copperoni.
Le preoccupazioni del consultore
Opportunamente Gazzetta pubblica in appendice al libro il parere del consultore, il domenicano Giovanni Lottini, che spiega le motivazioni della decisione. Pur dicendosi sicuro che le religiose non abbiano la pretesa di proclamarsi sacerdotesse, afferma che, qualora non siano per tempo fermate, «mosse da una certa ambizioncella muliebre, queste donne giungeranno a darsi detto titolo ed a chiedere e forse con le loro femminee arti a strappare anche qualche approvazione». Il riconoscimento dell’abilità di chi governa la congregazione nel promuoverne il carisma sul piano istituzionale si traduce nell’individuazione delle misure per bloccarne le iniziative. Il domenicano sostiene quindi che, per quanto storicamente fondato e dottrinalmente irreprensibile, il riferimento alla Virgo sacerdos deve essere interdetto dalle pratiche religiose. Sottolinea in particolare che negli istituti femminili l’infima cultura teologica delle donne - evidentemente ritenute incapaci di distinguere tra ordine e spirito sacerdotale - potrebbe facilmente indurre a costruire su questa devozione pretese al ministero. Suggerisce perciò che la venerazione a Maria venga promossa sotto il titolo di madre, anziché sotto il titolo di sacerdote.
Una rimozione definitiva
Nel 1927 il segretario del Sant’Uffizio, cardinal Merry del Val, in risposta a una domanda apparsa su La Palestra del clero, conferma in una pubblica lettera che attorno al titolo sacerdotale mariano occorre mantenere completo silenzio. Poco dopo una revisione della costituzione delle Figlie del Sacro Cuore ne formalizza la rimozione dalla vita interna dell’istituto. In realtà collegamenti con il tema della Virgo sacerdos riemergono in comunità religiose - in primo luogo i Figli del Cuore sacerdotale di Gesù, oggi noti come padri Venturini dal nome del fondatore - e in pii sodalizi, come le Figlie della Regina degli angeli fondata da Elena da Persico. In effetti la loro spiritualità si alimenta alle stesse fonti dell’istituto franco-belga. In questi casi il richiamo all’imitazione di Maria consente di superare la visione di un mero ruolo oblativo delle donne nella Chiesa, ma non si traduce, almeno a livello delle testimonianze a oggi accessibili, in manifestazioni di aspirazioni ad un ruolo ministeriale.
Gli interventi dei papi nel post-concilio
Nel post-concilio, al momento in cui affiora nuovamente e con più forza, sulla spinta del rinnovamento ecclesiale, la questione del sacerdozio femminile, gli interventi del papato - come mostrano l’esortazione apostolica Marialis cultus emanata da Paolo VI nel 1974 e la lettera apostolica Mulieris dignitatem pubblicata da Giovanni Paolo II nel 1988 - lo hanno nuovamente collegato al ruolo idealtipico di Maria per la definizione della posizione ecclesiale della donna. Il riferimento mariano è stato però utilizzato per ribadire l’impedimentum sexus al sacerdozio femminile. La vicenda della congregazione delle Figlie del Sacro Cuore, oggi restituita alla memoria ecclesiale dalla ricerca storica, per quanto ancora bisognosa di approfondimenti, fornisce un prezioso aiuto per contestualizzare, e quindi relativizzare, questi interventi papali.
Per superare i blocchi alla discussione
Non solo perché essi appaiono ancorati a una mariologia riduttiva rispetto a una tradizione più ricca e articolata, che era stata rimossa dalla vita ecclesiale all’inizio del Novecento in seguito agli evidenti condizionamenti storici che caratterizzavano la visione dei rapporti di genere dei membri del Sant’Uffizio. Soprattutto perché i documenti papali rivelano i limiti di una decisione determinata da un clima ecclesiale in cui si riteneva necessario ribadire la natura teandrica della Chiesa in contrapposizione alla rivendicazione del diritto delle donne ad accedere al ministero. Il contesto ha fatto dimenticare che l’aspirazione al sacerdozio femminile non si era storicamente espressa in termini giuridici e rivendicativi; ma, fondata sull’adeguamento alle necessità dei tempi del tradizionale richiamo al carattere mariotipico della presenza femminile nella Chiesa, si era sviluppata su un terreno vocazionale, spirituale e cultuale. Ricollocare su questa piano la discussione, può aiutarne a superarne i blocchi.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E "NUOVA ALLEANZA".27 gennaio 2021, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E "NUOVA ALLEANZA" DI "MARIA E GIUSEPPE". EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA.... *
- ARTE E "MITOLOGIA GRECO-ROMANA". Trittico di Mérode: L’Annunciazione (1427).
La biblista francese.
Pelletier: «Donne, Chiesa polifonica»
Per la studiosa occorre «ritrovare una struttura consonante a quanto presenta Paolo, cioè la Chiesa come corpo, dove l’istituzione si fonda su doni particolari assegnati agli uni e agli altri»
di Lorenzo Fazzini (Avvenire, mercoledì 27 gennaio 2021)
- [Foto] La biblista francese Anne-Marie Pelletier
Anne-Marie Pelletier non è solo una sagace esegeta e una brillante docente universitaria. Già Premio Ratzinger per la teologia, l’intellettuale francese diventa anche una paladina delle donne, dentro e fuori la Chiesa, quando affronta il tema dell’odierna condizione femminile.
 «Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?
«Un club di uomini anziani, vestiti in modo strano, che dicono alla gente come si deve comportarsi a letto». Con questa sarcastica definizione Timothy Radcliffe illustra come, a suo dire, la gente vede la Chiesa. Perché non viene invece riconosciuto il grande apporto delle donne alla vita della Chiesa?
 Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.
Le parole di Radcliffe sono impietose ma esprimono bene la realtà. La visibilità della Chiesa cattolica resta incontestabilmente quella della sua gerarchia, esclusivamente composta da uomini. E questa visione non è un effetto ottico.
 È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.
È sufficiente aprire la porta di una chiesa durante una celebrazione per constatare che il presbiterio è uno spazio che appartiene agli uomini, in via maggioritaria se non esclusiva. Inoltre, l’autorità viene collegata al sacerdozio ministeriale. E per molti questo tipo di sacerdozio resta la chiave di volta del corpo ecclesiale. Anzi, passa l’idea che ne costituisca l’espressione suprema.
 Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.
Da qui le reiterate denunce di clericalismo da parte di papa Francesco.Cosa va perso in questa visione maschio-centrica?
Il dramma è che la verità della Chiesa viene nascosta. Infatti, la Chiesa non è innanzitutto la sua gerarchia, ma prima di tutto un corpo, che questa gerarchia ha la funzione di servire. Questo corpo è composto da uomini e donne che, nei loro diversi stati di vita, si riconoscono convocati dalla parola di Cristo. Questo popolo di battezzati dona carne e presenza al Vangelo nel mondo, spesso silenziosamente ma in modo autentico. E bisogna ammettere che le donne, in questo corpo, hanno un posto eminente, anzi dominante perché, in molti luoghi e circostanze, sono loro il volto e la mano della Chiesa per i nostri contemporanei. Io perdo un po’ la pazienza quando sento ripetere che ’bisogna fare spazio alle donne’ quando, invece, la prima cosa da fare è riconoscere il posto che esse occupano nelle parrocchie, nella catechesi, nelle missioni. Senza di loro, la Chiesa sarebbe già sparita.
Altrove lei ha sottolineato come l’attenzione della Chiesa con Francesco verso le donne non sia una questione nuova: da 50 anni i Papi prestano un’attenzione crescente al mondo femminile con diversi documenti. Allora è la Chiesa che ha fallito, rispetto all’uguaglianza uomo-donna, se ancora oggi viene percepita come maschile?
Si tratta di un dato impressionante. Dagli anni Sessanta il magistero ha prestato alle donne un’attenzione inedita. Non si era mai visto un elogio tale della donna da parte delle autorità della Chiesa. Eppure, nella Chiesa cattolica, le donne - in gran numero - hanno continuato a sentirsi emarginate, vedendosi assegnate a posti secondari, trattate con accondiscendenza, talvolta disprezzate da un mondo clericale che si arroga ogni decisione. Al punto da far sorgere l’opinione che molte poche cose sarebbero potute cambiare. Il problema di fondo non è semplicemente parlare delle donne, né parlare alle donne, ma lasciarle esistere, farle parlare a nome proprio nella Chiesa, far sì che siano esse a giudicare i problemi della vita e le questioni della fede, di cui hanno esperienza tanto quanto gli uomini.
In un suo testo su ’Vita e Pensiero’ lei scrive: «Il futuro dell’istituzione ecclesiale è intrinsecamente legato, nel cattolicesimo, a una riflessione polifonica ovvero alla condivisione della ricerca della verità, sempre più grande di quanto siamo capaci di cogliere». Può essere una riforma solo ’intellettuale’ sufficiente per far progredire il posto delle donne nella Chiesa? Oppure serve anche una riforma strutturale?
Per me è chiaro che una vera riforma della Chiesa deve incarnarsi nelle strutture della sua vita e nell’organigramma della sua governance. In questo senso non bastano tante belle parole. Il punto focale è che noi, uomini e donne, ci troviamo insieme nella responsabilità verso il Vangelo e nella missione della Chiesa. Rispetto al motu proprio recente, esso ritorna su un testo del 1972 che apriva il lettorato e il servizio di accolitato ai laici, a condizione che fossero uomini: in questo caso il magistero permette di metter fine ad un’aberrazione che squalifica la Chiesa. Resta il fatto che sarebbe troppo poco cercare solo di ridistribuire i poteri in una struttura immutata. Sono convinta che siamo in un momento cruciale in cui l’istituzione ecclesiale deve reinventarsi. Si deve tornare all’ecclesiologia. Non si significa fossilizzarsi su un’attività astrattamente intellettuale. Anzi, qui c’è la leva per un vero cambiamento di fondo. In questo senso mi piace comprendere la messa in guardia di papa Francesco di non attenersi alle semplici ’funzioni’. Per questo, mi trovo a disagio quando si pensa che l’accesso al sacerdozio femminile costituirebbe la soluzione della questione. Piuttosto vi constato un modo per ricondurre e confermare l’intero ordine ecclesiale al primato del sacerdozio ministeriale. Invece, penso che si debba uscire da questo schema per ritrovare una struttura consonante a quanto Paolo presenta, cioè la Chiesa come corpo, dove l’istituzione si fonda su doni particolari assegnati agli uni e agli altri per il servizio di tutti. E così la Chiesa si ridisegna come una comunità di battezzati, dove il sacerdozio battesimale, condiviso da tutti, ritorna ad essere il più importante.
Nel suo libro Una comunione di uomini e donne lei ha parlato di un «machismo diventato il marchio di fabbrica della Russia putiniana e dell’America trumpiana». Perché l’avversione all’emancipazione femminile è così forte nel sovranismo?
Le donne oggi si ritrovano ad essere sotto la minaccia di regimi autoritari che proliferano e che hanno un’aria di dejà vu, i cui leader sono esclusivamente uomini. La Russia vive sotto il comando di un dirigente che esalta la virilità brutale, che mostra mediaticamente i suoi muscoli e che porta avanti una repressione impietosa delle opposizioni: la guerra in Cecenia ne é un sinistro esempio. Non è un caso che una delle maggiori oppositrici di questa ideologia sia una donna, il premio Nobel Svetlana Aleksievic, che ha scritto un libro intitolato La guerra non ha volto di donna. -Quanto al populismo di Donald Trump o Jair Bolsonaro e altri, sappiamo bene come questi uomini disprezzino le donne, sia nei loro discorsi che nella loro vita privata. Non dimentichiamo che le più grandi manifestazioni nella storia degli Usa sono state quelle delle donne che denunciavano il machismo insolente di Donald Trump nel 2016.
I movimenti per l’emancipazione delle donne sono un segno dei tempi. Come far sì che diventino positivi per l’intera società e non restino relegati ad essere - per quanto giuste - solo proteste?
É indubbio che i femminismi, per natura, sono movimenti protestatari e militanti. Come stupirsi che, per denunciare le violenze che pesano di esse e gli asservimenti cui sono costrette, le donne scendano in piazza e brandiscano lo stendardo della rivolta? Ma l’obiettivo dovrebbe essere quello di uscire dalla guerra tra sessi, per arrivare ad un’auspicabile stima reciproca, fino a un’alleanza felice per la pienezza degli uni e delle altre. Non è certo quello che intendono quante oggi riesumano i testi di Valérie Solanas, l’intellettuale americana che sognava l’eliminazione del maschio dall’umanità. Un atteggiamento oltranzista, questo, che non opera per il bene delle donne ostaggio della miseria, delle povertà e del machismo che prospera su questo terreno.
*
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
- GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!!
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
FLS
- ARTE E "MITOLOGIA GRECO-ROMANA". Trittico di Mérode: L’Annunciazione (1427).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- FILOLOGIA, ECOLOGIA, E MESSAGGIO EVANGELICO.18 gennaio 2021, di Federico La Sala
ECOLOGIA DELLA PAROLA: MESSAGGIO EVANGELICO ("AGAPE - CHARITAS") E FILOLOGIA...
Chiave concettuale *
Carità
:É l’amore in senso cristiano (agape-caritas) che costituisce l’essenza stessa del Dio rivelato da Gesù Cristo (cf. 1 Gv 4, 8). Essa consiste nel donare la propria vita (Gv 15,13). La forma perfetta della carità è il dono di sé di Cristo sulla Croce (Gal 2, 20). La Croce è la "cifra" e il simbolo dell’amore: in essa Gesù compie il duplice comandamento dell’amore di Dio e del → prossimo, ripreso dalla Legge antica (Torah) (cf. Mc 12, 28ss; Dt 6, 5; Lv 19,17). Sulla Croce infatti Gesù ama totalmente Dio Padre, affidandosi nelle sue mani (Lc 23,44) e il prossimo, → perdonando i suoi nemici (Lc 23, 36). L’amore vero o carità consiste nell’amare con → gratuità, anche chi non lo merita, il peccatore, il malvagio, il traditore, il nemico (cf. Lc 6, 32; Rm 5,11). Questo amore divino, unico e trascendente non è "utopico" per gli esseri umani. Esso diventa realtà quando è riversato nel cuore degli uomini mediante la potenza dello Spirito Santo, il Dono del Signore risorto (cf. At 2; Rm 5, 5), che rende capaci di conformarsi all’amore di Cristo. Tale è l’esperienza dei santi e dei martiri (cf. At 7, 59-60). La carità è pertanto una virtù teologale, cioè soprannaturale e pneumatologica. San Paolo la considera il più grande dei doni dello Spirito Santo e la descrive così: "La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine" (cf. 1 Cor 13, 4-8). Essa può essere ritenuta opera della → fede (cf. Gal 5, 6). Avere l’amore è segno di una vita nuova che vince la morte: "Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte" (1 Gv 3, 14).
Tutta la tradizione cristiana l’ha venerata come "regina delle virtù". Essa consiste per S. Agostino nell’amore delle cose che devono essere amate (dilectio rerum amandarum) e dona di anteporre le cose comuni a quelle proprie (caritas communia propriis non propria communibus anteponit). La carità è "ordinata": essa fa amare Dio per se stesso; ispira un retto amore di sé (ricordando la propria dignità filiale); stimola ad amare il prossimo in Dio e il nemico a causa di Dio (caritas est amicum diligere in Deo et inimicum diligere propter Deum, S. Gregorio Magno). La carità ama secondo la misura smisurata di Dio (modo sine modo, S. Bernardo). Per san Tommaso soltanto la carità merita veramente il nome di grazia perché è l’unica che renda "graditi a Dio" (nomen gratiae meretur ex hoc quod gratum Deo facit). Essa ha la facoltà di trasformare l’amante nell’amato perché suscita una sorta di "estasi", un uscire da sé per aderire all’amato (caritatis proprium est transformare amantem in amatum, quia ipsa est quae extasim facit).
La carità è il vincolo di comunione della → Chiesa, e trova nell’Eucaristia il suo sacramento. Mediante la carità lo Spirito riunisce i fedeli in un solo corpo: lo Spirito unifica il corpo con la sua presenza, con la sua forza e con la connessione interna delle membra; produce la carità tra i fedeli e li sprona a viverla. Cosicché se un membro soffre, tutti soffrono insieme con lui; e se un membro viene onorato, ne gioiscono insieme anche gli altri (cf. 1 Cor 12, 26; LG 7, 3). La carità non può essere né confusa né tanto meno sostituita con la nozione non peculiarmente cristiana di → solidarietà. Questa consta dell’ordine umano e sociale della fraternità universale. La carità invece è la relazione di comunione propria della → fraternità cristiana. Essa ha una propulsione universale (fino ad abbracciare i nemici), ma è specialmente arricchita dalla reciprocità nella comunità ecclesiale: "questo è il messaggio che avete udito fin da principio: che ci amiamo gli uni gli altri" (1 Gv 3, 11-12); "Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede", (Gal 6,10). Insieme alla → evangelizzazione e all’intercessione (Liturgia), la testimonianza della carità rappresenta la precipua forma cristiana di svolgere la missione che Cristo le ha affidato.
* Fonte: Chiave concettuale - Vatican.va
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO.14 gennaio 2021, di Federico La Sala
TWEET
@UNESCO #LogicDay Uscire dall’#infernoepistemologico: ripartire con #Quine e #Nozick da un nuovo #principiodicarità, ridiscendere nella #nave di #galileogalilei, e riprendere la #navigazione con #Einstein
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA E LINGUISTICA: LA LEZIONE DI DANTE (E SAUSSURE).14 gennaio 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA: SPIRITO CRITICO E AMORE CONOSCITIVO *:
"Per letiziar là sù fulgor s’acquista,
 sì come riso qui; ma giù s’abbuia
sì come riso qui; ma giù s’abbuia
 l’ombra di fuor, come la mente è trista
l’ombra di fuor, come la mente è trista«Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia»,
 diss’io, «beato spirto, sì che nulla
diss’io, «beato spirto, sì che nulla
 voglia di sé a te puot’esser fuia.
voglia di sé a te puot’esser fuia.Dunque la voce tua, che ‘l ciel trastulla
 sempre col canto di quei fuochi pii
sempre col canto di quei fuochi pii
 che di sei ali facen la coculla,
che di sei ali facen la coculla,perché non satisface a’ miei disii?
 Già non attendere’ io tua dimanda,
Già non attendere’ io tua dimanda,
 s’io m’intuassi, come tu t’inmii».
s’io m’intuassi, come tu t’inmii».Dante Alighieri, Paradiso IX, 70-81.
* Sul tema, nel sito, cfr.:
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. CON MARX E FREUD. Una "ipotesi di rilettura della DIVINA COMMEDIA"
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DONNE E CHIESA. Papa Francesco apre a Lettorato e Accolitato, ma non a Sacerdozio.11 gennaio 2021, di Federico La Sala
LO SPIRITO DI ASSISI. LA LEZIONE DI GIOVANNI PAOLO II SULLA DONNA E SULL’UOMO E SU DIO... *
- Karol J. Wojtyla ha compreso il "segreto" delle due persone che gli hanno dato la vita (il padre di religione cattolica e la madre di religione ebraica) e, al di là della loro identità e differenza, ha ritrovato l’Arca dell’Alleanza d’Amore ("Charitas") dei "due cherubini". Per questo ha potuto ri-illuminare il mondo e ri-unificare l’intera umanità intorno a sé, non per altro e non - confondendo Dio-Mammona ("caritas") con Dio-Amore ("charitas") - per negare e uccidere addirittura l’Altro!!! (Federico La Sala, 08.02.2008)
Papa: nuovi ruoli alle donne, apre a Lettorato e Accolitato
’Ma la Chiesa non può conferire loro l’ordinazione sacerdotale’
- FOTO Una giovane legge le preghiere durante la messa del Papa per la giornata della gioventù (archivio)
di Redazione ANSA *
CITTA DEL VATICANO. Papa Francesco ha stabilito con un Motu proprio che i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato siano d’ora in poi aperti anche alle donne, in forma stabile e istituzionalizzata con un apposito mandato. Le donne che leggono la Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche o che svolgono un servizio all’altare in realtà già ci sono con una prassi autorizzata dai vescovi.
Fino ad oggi però tutto ciò avveniva senza un mandato istituzionale vero e proprio.
Aprire ufficialmente le porte alle donne nel Lettorato e nell’Accolitato non significa che potranno diventare sacerdoti. E’ quanto precisa lo stesso Papa facendo proprie le parole di Giovanni Paolo II: "Rispetto ai ministeri ordinati la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale".
* ANSA 11 gennaio 2021 - 19:06 (ripresa parziale).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA. Siamo fili dell’unico arazzo dell’essere (di Ermes Ronchi).2 gennaio 2021, di Federico La Sala
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA.... *
Siamo fili dell’unico arazzo dell’essere
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 31 dicembre 2020)
II Domenica dopo Natale
- In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. [...]
Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte dell’infinito e dell’eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, ma componendo un poema, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo.
In principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci).
Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle cose che sono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui.
«In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti connessi insieme, nell’unico meraviglioso arazzo dell’essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera d’amore.
In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). E la vita era la luce degli uomini.
Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d’ombra e di luce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico a primavera.
Cerchi luce? Ama la vita, amala come l’ama Dio, con i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo.
A quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. L’abbiamo sentito dire così tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l’ha spiegato benissimo papa Francesco nell’omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia».
Non sei inadeguato, non sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce che ti sussurra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri alla vita, come fa Dio. E la domanda ultima sarà: dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno vita?
(Letture: Siracide 24,1-4.12-16; Salmo 147; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica...
 MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours").
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours")."NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E MEMORIA ANTROPOLOGICA: #DANTE2021.28 dicembre 2020, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E MEMORIA ANTROPOLOGICA.
USCIRE DALL’ORIZZZONTE DELLA BIBLICA "CADUTA" ...
DANTE - 2021 E LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI": RISALIRE LA CORRENTE E RITROVARE I PROPRI "GENITORI". Al di là di Caino, la nuova Eva - Maria e Giuseppe, il nuovo Adamo , e Gesù è figlio dell’ amore [charitas] che move il Sole e le altre stelle (Pd. XXXIII, v. 145).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Il "sogno" di Michelangelo, la "Cappella Sistina", e la "Linea della Bellezza e della Grazia”.19 dicembre 2020, di Federico La Sala
Michelangelo e “La Linea della Bellezza e della Grazia”. La "forma serpentinata" ... *
Una macchina teologico-politica
Conversazione con Giovanni Careri in occasione dell’uscita di “Ebrei e cristiani nella Cappella Sistina”.
di Francesco Zucconi *
Francesco Zucconi: Il visitatore dei Musei Vaticani arriva nella Cappella Sistina dopo aver attraversato straordinarie sale e corridoi. Nei pochi minuti che trascorre in questo ambiente immersivo, il suo sguardo è come incantato, si sente preso e sospinto. Ma i turni di visita sono troppo brevi per muovere consapevolmente lo sguardo tra i diversi cicli pittorici.
 Tu hai trascorso molti anni a studiare gli affreschi realizzati da Michelangelo Buonarroti e la tua ricerca fornisce tanto una forma di orientamento nella Sistina quanto una serie di nuovi percorsi interpretativi. Prima di entrare nel merito di questo libro, appena pubblicato da Quodlibet, vorrei chiederti come nasce l’idea di lavorare su questo oggetto straordinario.
Tu hai trascorso molti anni a studiare gli affreschi realizzati da Michelangelo Buonarroti e la tua ricerca fornisce tanto una forma di orientamento nella Sistina quanto una serie di nuovi percorsi interpretativi. Prima di entrare nel merito di questo libro, appena pubblicato da Quodlibet, vorrei chiederti come nasce l’idea di lavorare su questo oggetto straordinario.
Giovanni Careri: Nel 2003 ho coordinato all’EHESS di Parigi un progetto di ricerca sulla temporalità delle immagini con un antropologo (Carlo Severi), uno storico (Jean-Claude Schmitt), e uno specialista della Grecia antica (François Lissarrague). Lo stimolo a occuparmi della Sistina non è arrivato dalla scoperta di nuove fonti o documenti, ma dalla domanda che avevamo posto a tutti i partecipanti al progetto: il rapporto tra le immagini e le temporalità che le attraversano, l’indagine sulle modalità del “tempo visivo” che le immagini stesse producono.
Il mio contributo riguardava il modo in cui il Giudizio Universale di Michelangelo costruisce un tempo dell’attesa e dell’imminenza, imminenza della fine del tempo della storia, ma anche della ricapitolazione e del bilancio della vita di ognuno. Mi sono in particolare interessato ai “libri della vita” che gli angeli aprono al centro dell’affresco per significare che il tempo del giudizio di sé è giunto per i personaggi rappresentati ma anche per lo spettatore.
 Accanto agli angeli si trova un grande dannato, un “disperato” che porta la mano sul volto con un gesto che rinvia inequivocabilmente al dialogo interiore e a quella forma di autobiografia penitenziale che possiamo definire - con Michel Foucault - “soggettivazione”, per articolarla con l’altra determinazione che caratterizza il “soggetto moderno”, quella dell’assoggettamento.
Accanto agli angeli si trova un grande dannato, un “disperato” che porta la mano sul volto con un gesto che rinvia inequivocabilmente al dialogo interiore e a quella forma di autobiografia penitenziale che possiamo definire - con Michel Foucault - “soggettivazione”, per articolarla con l’altra determinazione che caratterizza il “soggetto moderno”, quella dell’assoggettamento.
 Nella postura di questo monumentale personaggio, le due determinazioni coincidono: il disperato ha appena ammesso la sua colpevolezza nel dialogo con sé stesso mentre demoni e serpenti già lo avvolgono nelle loro spire, eseguendo l’ordine del Cristo Giudice. La condanna del “disperato” è esibita nel rapporto tra la sua situazione e quella di Minosse, il giudice infernale avvolto da un serpente che ne inibisce il movimento.
Nella postura di questo monumentale personaggio, le due determinazioni coincidono: il disperato ha appena ammesso la sua colpevolezza nel dialogo con sé stesso mentre demoni e serpenti già lo avvolgono nelle loro spire, eseguendo l’ordine del Cristo Giudice. La condanna del “disperato” è esibita nel rapporto tra la sua situazione e quella di Minosse, il giudice infernale avvolto da un serpente che ne inibisce il movimento.Il punto di partenza di questo mio lavoro sugli affreschi della Sistina è nel confronto tra le due posture, quella del dannato e quella di Minosse. Il dannato sta diventando simile al demonio, tra poco il suo corpo sarà stretto tra le spire del serpente come è già accaduto per il giudice infernale. In questo rapporto tra due figure e nella processualità del divenire Minosse ho ritrovato uno dei fili essenziali delle mie ricerche: quello della “conformazione” ovvero di un’economia mimetica che fonda la sua semiosi sull’assunzione e/o sulla perdita della somiglianza di un’attitudine o di un gesto.
 A partire da tale osservazione, possiamo guardare il Giudizio come a una immensa coreografia: gli eletti e gli angeli si stanno facendo simili al Cristo, imitando e incorporando la sua “forma serpentinata”, mentre i dannati perdono per sempre la somiglianza al figlio di Dio per assumere una somiglianza invertita o “perversa” con Minosse, dove la figura serpentinata che libera il movimento delle figure si muta in un serpente costrittore.
A partire da tale osservazione, possiamo guardare il Giudizio come a una immensa coreografia: gli eletti e gli angeli si stanno facendo simili al Cristo, imitando e incorporando la sua “forma serpentinata”, mentre i dannati perdono per sempre la somiglianza al figlio di Dio per assumere una somiglianza invertita o “perversa” con Minosse, dove la figura serpentinata che libera il movimento delle figure si muta in un serpente costrittore.F.Z.: All’interno della Sistina è sintetizzata in forma visiva l’intera storia spirituale dell’Umanità dal punto di vista cristiano: dalla Creazione al Peccato, dalla Redenzione al Giudizio. Il tuo libro si concentra in modo particolare sul Giudizio Universale e sul ciclo degli Antenati di Cristo. Per quale motivo ti sei interessato a queste parti e quale rapporto intercorre tra di loro?
G.C.: La storia dell’arte ha generalmente separato le tre parti che compongono gli affreschi sistini. Sono opere molto distanti nel tempo, realizzate da artisti di generazioni diverse per tre diversi Papi, ognuno dei quali aveva preoccupazioni e interessi particolari. Nel libro non solo ho voluto considerare le tre parti come un insieme, ma ho anche deciso di cominciare dall’analisi dal Giudizio, che è l’ultimo elemento aggiunto cronologicamente. L’ho fatto per varie ragioni. La principale è che le immagini si rispondono tra di loro se sono messe una accanto all’altra, indipendentemente dalla data della loro realizzazione. Quando il Giudizio viene aggiunto agli affreschi preesistenti si producono nuove relazioni e un nuovo senso, esattamente come quando si aggiunge un oggetto in un’istallazione di arte contemporanea.
Nel caso degli Antenati si può dire che la loro spossatezza era già evidenziata, per contrasto, con i corpi eroici e ispirati delle Sibille e dei Profeti. Ma il contrasto con il Giudizio fa apparire la loro fatica come una categoria dell’ideologia cristiana, in una prospettiva che stringe il nesso tra il tempo delle origini (ebraiche) e quello del compimento. Questa costruzione è coerente con il pensiero di san Paolo, senz’altro il più influente tra coloro che hanno immaginato la fine dei tempi, il quale insiste sul fatto che il senso della storia di un individuo come quello dell’umanità tutta intera si rivela solo a partire dalla fine.
F.Z.: Hai appena menzionato la spossatezza delle figure degli Antenati di Cristo, un tema centrale del tuo libro che porta a esiti sorprendenti.
G.C.: L’incongruità che ha subito attratto la mia attenzione davanti alle lunette degli Antenati è il rapporto tra la degna autorità dei nomi, scritti in lettere capitali e incorniciati in tavole di grandi dimensioni, e le figure che non hanno i tratti regali dei patriarchi e dei sovrani ai quali questi nomi si riferiscono. Vi si vedono giovani donne esauste intente a nutrire e accudire i loro bambini e vecchi padri buttati a terra o persi in melanconica meditazione. Di fronte a questa discrepanza, l’iconologia ha trovato soluzioni ingegnose ma fallimentari, come quella di tradurre in latino i nomi ebraici per poi cercare nella vulgata la presenza di tali nomi in situazioni comparabili a quelle che si vedono nelle lunette.
Considerando la lista dei nomi dal punto di vista dell’antropologia della parentela, sono arrivato alla conclusione che vadano mantenuti separati dalle figure o meglio articolati con esse secondo un principio di inclusione/esclusiva.
 In altre parole, i nomi incorniciati nelle tavole si fanno carico di innestare la storia cristiana in quella degli ebrei e particolarmente in quella prestigiosa stirpe di Abramo alla quale apparteneva Giuseppe, marito di Maria, madre di Gesù.
In altre parole, i nomi incorniciati nelle tavole si fanno carico di innestare la storia cristiana in quella degli ebrei e particolarmente in quella prestigiosa stirpe di Abramo alla quale apparteneva Giuseppe, marito di Maria, madre di Gesù.
 Tuttavia, a questa funzione inclusiva si accompagna una funzione esclusiva della quale si fanno carico le figure stesse che esibiscono i tratti di “carnalità” che san Paolo attribuisce agli ebrei che non si convertono in seguaci di Cristo.
Tuttavia, a questa funzione inclusiva si accompagna una funzione esclusiva della quale si fanno carico le figure stesse che esibiscono i tratti di “carnalità” che san Paolo attribuisce agli ebrei che non si convertono in seguaci di Cristo.
 Tra questi, il più importante è l’ostinato rifiuto della Grazia di cui si possono riconoscere le conseguenze nelle lunette stesse: l’immersione in una vita limitata alle attività di sussistenza, la generazione e la cura dei figli, la pigrizia, l’avidità, l’erranza e persino la follia.
Tra questi, il più importante è l’ostinato rifiuto della Grazia di cui si possono riconoscere le conseguenze nelle lunette stesse: l’immersione in una vita limitata alle attività di sussistenza, la generazione e la cura dei figli, la pigrizia, l’avidità, l’erranza e persino la follia.In breve: mentre i nomi esaltano la continuità tra la storia cristiana e quella degli ebrei, le immagini sono il luogo di produzione della differenza e di un’alterazione che si avvicina alla caricatura, affermando la crisi definitiva alla quale il modello genealogico di trasmissione del sangue da padre in figlio è stato sottoposto dall’inclusione di un figlio che è figlio di Dio e non di suo padre.
 Questa rottura autorizza l’apertura della predicazione a tutte le nazioni, separando il “tempo scaduto” della storia veterotestamentaria da quello nuovo del messianismo cristiano. Si delinea così un paradosso che include la “storia genealogica” e al tempo stesso la esclude denunciandola come ormai superata.
Questa rottura autorizza l’apertura della predicazione a tutte le nazioni, separando il “tempo scaduto” della storia veterotestamentaria da quello nuovo del messianismo cristiano. Si delinea così un paradosso che include la “storia genealogica” e al tempo stesso la esclude denunciandola come ormai superata.F.Z.: Alcuni degli Antenati dipinti da Michelangelo recano i segni della stigmatizzazione antiebraica del XVI secolo. Questo anacronismo è passato inosservato alla storia dell’arte fino a pochi anni fa. Come ti spieghi questa cecità?
G.C.: Nel 2003 la storica dell’arte americana Barbara Wish ha pubblicato un articolo dove rivela la presenza di un segno circolare sulla tunica gialla di uno di personaggi della lunetta che porta il nome di Aminadab. Il restauro che ha reso visibile questo signum si era concluso quasi vent’anni prima e ci si può quindi chiedere cosa ne abbia impedito la visibilità per tutto questo tempo.
Penso che uno dei veli che hanno nascosto la marcatura sia lo statuto di “capolavoro” che la Sistina ha acquisito immediatamente e mai perduto nel corso dei secoli. L’opera di un artista distante da ogni forma di realismo non poteva esibire un tratto “documentario”, la testimonianza di una marcatura infamante. Non si poteva inoltre facilmente ammettere che Michelangelo condividesse con la cultura del suo tempo una precisa forma di antigiudaismo.
Un altro velo è di ordine epistemologico: si trova quello che si cerca. Per dirlo in modo meno meccanico, le domande orientano la ricerca, guidano lo sguardo e, dal dopoguerra fino al 2003, le domande sugli Antenati sono state essenzialmente orientate sul rapporto tra i nomi e le figure. Ho tuttavia incontrato alcuni testi che fanno apparire il carattere semitico delle figure. Tra i più interessanti, quello di Emile Zola che nel suo romanzo Rome (1896) descrive gli Antenati come “la razza punita”, frase che risuona con la sua denuncia dell’antisemitismo francese nell’affaire Dreyfus. Sydney Freedberg, dal canto suo, aveva scritto che in queste figure la dimensione domestica e quella semitica si incontrano e si sovrappongono.
Si trattava, insomma, di cambiare la domanda. Non più “chi sono questi personaggi”? Ma che ruolo assumono nel montaggio della storia che si realizza negli affreschi? Nel libro non pretendo di aver svelato il mistero degli Antenati, ma spero di aver fatto apparire qualcosa che non è spiegabile in rapporto a una fonte scritta: il dialogo che le strane iconografie di queste figure intraprendono con altre iconografie: quella della Santa Famiglia e di Giuseppe in particolare, quella della Madonna del latte, quelle dei cicli dei mesi del Palazzo della Ragione di Padova, quelle, altrettanto “paradigmatiche”, dell’albero di Jesse, ma anche quelle delle stampe antisemite di area germanica.
F.Z.: Negli ultimi anni, la filosofia italiana si è caratterizzata per la capacità di indagare i nessi tra teologia e politica. Penso in particolare ai lavori di Giorgio Agamben e a quelli di Roberto Esposito, citati anche all’interno del tuo libro. Al di là della ricerca filosofica propriamente detta, mi pare che Ebrei e cristiani nella Cappella Sistina ci inviti ad assumere consapevolezza del “pensiero visuale” che trova espressione nelle opere stesse.
G.C.: Perché ancora un libro sulla Sistina? Per le stesse ragioni che spingono Agamben, Esposito e altri studiosi a rileggere le Lettere di san Paolo. Il paradigma teologico enunciato da san Paolo è corporativo, alla fine dei tempi tutti gli uomini giusti saranno incorporati in un unico corpo del quale il Cristo è la testa e i cristiani le membra.
Come nei miei lavori su Bernini e Caravaggio, anche in questo libro si trova la questione dell’efficacia dell’opera sullo spettatore, qui assoggettato dalla “terribilità” dell’affresco ma anche invitato a giudicare sé stesso, soggettivandosi. Si incontra inoltre, di nuovo, il paradigma della “conformazione”, un principio di “somiglianza” che è al fondamento della teoria cristiana dell’immagine ma che è stato quasi completamente ignorato dalla storia dell’arte. Nel suo Giudizio Universale, Michelangelo mostra la penultima tappa di questo processo di incorporazione attraverso l’assunzione di somiglianza.
Il portato politico di questo modello è considerevole e ancora attuale, se si estende la nozione di conformazione al di là del suo senso sacramentale sul piano della vita sociale e politica. L’idea della nazione come corpo è, d’altra parte, ancora oggi ben presente. Basta pensare ai nazionalismi e alle purificazioni etniche dove si tratta precisamente di espellere le impurità da un corpo collettivo omogeneo.
F.Z.: Si potrebbe dire che la tua ricerca porta alla luce le tracce del discorso antiebraico presente nel ciclo di affreschi e correlato al contesto storico del XVI secolo. Allo stesso tempo, mostri le tracce di una presa di distanza da parte di Michelangelo - o meglio di un’adesione al modello figurativo della “vita secondo la carne” - nei confronti del meccanismo teologico-politico che lui stesso ha contribuito a edificare.
G.C.: La condizione degli ebrei che vivono tra i cristiani all’epoca di Michelangelo è molto diversa da quella del XIX e nel XX secolo. Nel libro ho cercato di evitare ogni generalizzazione astorica: la situazione degli ebrei cambia e si aggrava con il papato di Paolo IV Carafa, ma già durante il Papato di Paolo III la conversione forzata degli ebrei viene presa in considerazione. Gli studi di Adriano Prosperi, di Kenneth Stow e di altri storici hanno rivelato che la “purificazione” della cristianità intensa come un corpo collettivo è sorta nell’ambito dei fautori della Riforma prima di essere messa in atto dai conservatori.
Nelle Storie di Mosè e di Cristo degli affreschi del Quattrocento, la posizione degli ebrei è determinata dal paradigma tipologico: le azioni di Mosè prefigurano quelle di Gesù. Nel ciclo degli Antenati, il paradigma tipologico viene abbandonato perché ad essi sono attribuiti i tratti degli ebrei che hanno rifiutato di convertirsi e non hanno dunque più nulla da annunciare. Nel Giudizio, infine, attorno al Cristo risorto si riconoscono figure di sapienti o profeti ebraici perché la conversione degli ebrei è uno dei segni dell’imminenza della fine dei tempi, insieme all’avvento dell’Anticristo. Questo schema deve pero essere “messo a lavoro”, montando tra di loro le varie parti per mostrare come nel passaggio tra l’una e l’altra non solo cambia il modo di raccontare la storia ma si descrive l’esplosione del modello tipologico e della spazialità prospettica.
La posizione di Michelangelo è davvero singolare, nel senso che riguarda direttamente la sua persona o, meglio, la costruzione sperimentale della propria immagine all’interno del grande costrutto storico-teologico degli affreschi. Non penso che l’artista esprima una distanza rispetto a quel costrutto, ma si serve della figura dell’ebreo per denunciare la tiepidezza della propria fede. Confrontando gli affreschi con i poemi penitenziali dove l’artista si attribuisce i tratti di “negligenza” che si ritrovano nelle figure delle lunette, ho avanzato l’ipotesi che si possa riconoscere sulla Volta sistina un’immagine sperimentale di Michelangelo come Antenato. Questa figure di sé come un ebreo - come anche quella che, nel Giudizio, lo mostra come una pelle scuoiata e pendente - esprime un’inquietudine profonda, percepibile se si associano queste due immagini di sé all’idea di una carnalità che non può essere “conformata”. Tuttavia, se leggiamo con attenzione i poemi di Michelangelo capiamo che l’autore desidera di essere conformato almeno quanto lo teme.
F.Z.: Al di là della Sistina, la mia impressione è che la storia e la teoria dell’arte debbano rendersi sensibili ai dibattiti emergenti, mirati a studiare e riflettere criticamente sulle asimmetrie politiche e visuali consolidatesi nei secoli. Anziché ignorare tali dibattiti o aderirvi superficialmente, quanti si occupano di arti e di immagini possono forse fornire (e mettere in discussione) i propri strumenti per fare in modo che il carattere politico delle rappresentazioni emerga in tutta la sua portata.
G.C.: Di che cosa e in che modo una grande opera del passato parla al nostro tempo? Per rispondere a questa difficile domanda, posta allo storico dell’arte da Walter Benjamin, ci vuole un’elaborazione lunga e complessa. Tra i principali motivi per cui è importante continuare a studiare opere del passato è che attraverso la loro analisi e interpretazione si parla anche dell’oggi.
 Personalmente, non sono disposto a rinunciare a questa forma complessa di esegesi, che non ha nulla a che fare con la celebrazione della superiorità dell’Occidente. Tanto è vero che propongo appunto di esporre questo “capolavoro” a uno sguardo antropologico comparatista, sia sul piano del mito che su quello del rito, e pongo al centro dell’analisi la relazione con l’Altro.
Personalmente, non sono disposto a rinunciare a questa forma complessa di esegesi, che non ha nulla a che fare con la celebrazione della superiorità dell’Occidente. Tanto è vero che propongo appunto di esporre questo “capolavoro” a uno sguardo antropologico comparatista, sia sul piano del mito che su quello del rito, e pongo al centro dell’analisi la relazione con l’Altro.Nessuno degli studi sulla Sistina prima del mio aveva considerato gli affreschi come formidabile appropriazione del “passato ebraico” da parte dei cristiani. Una prospettiva di ricerca che è evidentemente informata dai dibattitti contemporanei ai quali ti riferisci. Tuttavia, una volta assunto questo punto di vista, penso che sia importante capire in che modo questa appropriazione si produca tramite il “lavoro delle immagini”, piuttosto che limitarsi a una semplice condanna. L’antropologia si confronta da sempre con fenomeni di appropriazione - più o meno violenti e più o meno riusciti - costitutivi delle dinamiche culturali umane. Il fatto che oggi alcune comunità vogliano farsi carico e riappropriarsi della loro memoria e degli oggetti nei quali essa è depositata fa parte di questa dinamica e ne ridisegna i contorni. È tuttavia importante scongiurare il rischio di una deriva identitaria che, riservando ai soli membri di una comunità il diritto di occuparsi della propria memoria, proietti sugli oggetti culturali del passato un’idea di purezza.
Quanto al sapere depositato nella storia dell’arte, penso che andrebbe profondamente riformulato nel senso che ho indicato prima. Si tratta di mostrare che quel “patrimonio” resta sterile se non si fa apparire ciò che in lui “ci riguarda”. Senza per questo ridurre l’alterità del passato e delle diverse culture che caratterizzano il tempo presente.
* Fonte: Il lavoro culturale, 13 Novembre 2020 (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE": IL "SOGNO" DI MICHELANGELO. Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PROFETI, SIBILLE, E MESSAGGIO EVANGELICO: ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS".16 dicembre 2020, di Federico La Sala
PROFETI, SIBILLE, E MESSAGGIO EVANGELICO: ANTONIO ROSMINI E LA "CHARITAS".
Un invito a ...
Ri-leggere il testo della "BREVE DISSERTAZIONE DI ANTONIO ROSMINI SULLE SIBILLE" (Patricia Salomoni, "Rosmini Studies", 6, 2019). Che Rosmini abbia iniziato il suo percorso riflettendo sulle figure delle Sibille, è da considerarsi un fatto degno della massima attenzione - e, ovviamente, di ulteriore approfondimento!
La riflessione su tale tema, probabilmente, lo ha reso più vigile nel suo cammino e nella sua fedeltà alla lettera e allo spirito della "Charitas". Il "Kant italiano", infatti, iniziando il suo percorso con la tesi di laurea sulle Sibille (1822), non solo non ha perso il suo legame con la Grazia (Charis) e con le Grazie (Charites), ma - coerentemente - ha saputo custodire anche l’«h» della Charitas! E ha cercato di tenere ferma la sua distanza dalla logica economica - sempre più dilagante - della "carità" del "mercato" ("caritas") e, al contempo, dalla politica di sostegno alla diffusione della "eu-carestia" - a tutti i livelli. Ma, alla fine, non è riuscito a coniugare - come voleva, in spirito di verità e carità - - il rapporto tra filosofia (sapienza pagana) e rivelazione (sapienza ebraica).
Già all’inizio del suo percorso, benché partito con buona volontà e - kantianamente ("Sapere aude!") - con gran coraggio, infatti, egli s’inchina all’autorità di sant’Agostino ("De Civitate Dei", XVIII, 47) e - pur rendendosi conto con lo stesso Agostino che "qualsiasi predizione su Cristo poteva essere dichiarata falsa dagli empi e soggiacere al medesimo discredito, sia che si trattasse degli oracoli delle Sibille o delle profezie degli Ebrei" - conclude con un "non è gradito a Lui stesso che, nelle dispute, noi dedichiamo troppe energie più a quelli che a queste" e attribuisce la palma della credibilità solo a "queste .. certissime, luminosissime, custodite dal popolo ebraico a noi assai ostile, e protette da ogni corruzione con incomparabile ed encomiabile cura nel corso di molti secoli" (P. Salomoni, cit, p. 227).
A partire da "queste" premesse (promesse già non mantenute!), ovviamente, accolta solo la parola dei "profeti" non si può che rinarrare e riscrivere la vecchia "storia dell’Amore" di Adamo ed Eva:
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
 La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore.
La prima ragione dell’amore fra tutti gli uomini è l’unità dell’origine. Dio trae la donna dalla carne e dall’osso di Adamo, appunto al fine di indicare che Adamo è il principio unico del genere umano, dal quale non solo i figlioli sono venuti, ma anche la stessa sua moglie. Perciò tutta intera l’umana generazione è un solo corpo con un solo capo, e questo capo è formato da Dio. Da qui l’uomo è chiamato da san Paolo “divina progenie” (Atti 17,28), allegando un verso del poeta greco Arato, il quale ben mostra essersi conservata fra i gentili la tradizione di questa verità. Da dove parte dunque l’unità della stirpe umana, da lì parte anche la prima ragione dell’amicizia. L’una e l’altra da Dio; e l’una e l’altra si può chiamare ragionevolmente cosa divina. Se dunque gli uomini si devono amare per motivo dell’origine, per la stessa ragione devono prima amare Dio, dall’amore del quale come da fonte limpidissima scaturisce il loro proprio amore. - La seconda ragione dell’amore fra gli uomini è nella similitudine della natura. Il divino istitutore della natura umana e dell’amore, nel formare Eva, disse che essa doveva essere ad Adamo un aiuto simile a lui, perché «buona cosa non era che egli stesse solo» (Gn 2, 18). Dio con queste parole faceva il più bello encomio della società umana, nel seno della quale nasciamo tutti, e dalle cui materne sollecitudini siamo educati e sollevati ad una inaspettata e meravigliosa perfezione, e quasi ad una nuova e più eccellente natura. E guai all’uomo solitario che si allontana e rifiuta i benefici della società dei suoi simili, presumendo del proprio giudizio e nutrendosi del proprio affetto individuale! Egli già comincia in quell’ora medesima ad isterilire nei suoi ragionamenti e nei suoi affetti. E appena si potrebbe chiamare ancora uomo, se troppo a lungo tenesse le orecchie chiuse alle amorevoli, alle sagge voci dei suoi simili. Perché i germi di bene più preziosi o starebbero in lui come non fossero, o tralignando porterebbero dei frutti inutili e tristi. Per cui veramente, come dice la Bibbia, «non è bene all’uomo starsene solo [...]».
- La terza ragione assegnata all’amore fu la felicità degli uomini. Gli uomini dovevano trarre vantaggio inestimabile dalla scambievole amicizia. Perciò Eva è nominata da Dio “un aiuto di Adamo”. Essa era aiuto al solitario Adamo allo scopo di rendergli piacevole la vita e permettergli di diffondere e comunicare in lei se stesso. Perché l’umano sentimento, l’uomo stesso, come il bene, cerca di essere diffusivo ed espansivo. Da qui ha origine la dottrina apostolica, che descrive l’uomo quale «immagine e gloria di Dio” e la donna quale “gloria dell’uomo [...]».
- Da tutte queste cose si può pertanto concludere, che nella sacra società coniugale, stabilita da Dio a principio fra gli uomini innocenti e felici, ebbero loro capo e inizio tutte le specie dei legittimi amori. Da lì nasceva l’amore naturale nelle famiglie, da lì l’amore di elezione nelle amicizie, da lì l’amore di vantaggio nell’umano commercio. E come da Dio partivano, così in Dio finivano ugualmente tutti questi affetti, temperati in un unico e sublimissimo affetto (Antonio Rosmini, La storia dell’Amore, "Charitas", 5, maggio 2016, pp. 111-112).
E così, contravvenendo frettolosamente alle regole morali del suo stesso "metodo filosofico", il suo desiderio di lasciarsi guidare "in tutti i suoi passi dall’amore della verità", come dalla carità ("charitas") piena di grazia (charis), resta confinato nell’orizzonte della caduta e della minorità - e la presenza delle Sibille insieme ai Profeti nella Volta della Cappella Sistina è ancora un grosso problema!
Federico La Sala
- L’Amore tra gli uomini nacque da Dio. L’Eden fu sua patria, ed ebbe gemella l’Innocenza. Nella creazione stessa dei progenitori del genere umano si ritrova la divina istituzione dell’amore: e in essa compaiono tutte le ragioni che devono rendere persuasi tutti gli uomini. Ecco quali sono le principali.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "L’OROLOGIO" DI CARLO LEVI E LA "CARITÀ" POMPOSA.7 dicembre 2020, di Federico La Sala
LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.... *
- « L’Italia è il paese classico dell’ospitalità (...). Ma lo spirito evangelico non ha saputo trasformarsi nella forma moderna della solidarietà e dell’organizzazione disinteressata e civile (...). L’assistenza, che è un diritto, diventa un regalo, una umiliante carità, che si può e non si può fare » (A. Gramsci, Odio gli indifferenti, pp.13 e 14).
- "Si usa dire che ci sono due sole strade, due soli principi su cui costruire lo Stato e la Società : quello russo e quello americano. Ebbene, ce n’è un terzo, del tutto diverso e ugualmente importante, ed è quello italiano. La via americana sarebbe, dicono, quella della Libertà, la via russa quella della Giustizia : ma la via italiana è un’altra, è quella della Carità.
 Naturalmente, questa carità statale, ha certi suoi caratteri speciali : è una carità che si rivolge a se stessa, che riguarda anzitutto e unicamente i componenti dello Stato che su di essa si fonda. Lo Stato è l’incarnazione della Carità, e il suo dispensatore : e la sparge sui propri membri, sui funzionari, sui parenti, sugli amici, su coloro che direttamente o indirettamente ne vivono". (Carlo Levi, L’Orologio, Einaudi, 1950)
Naturalmente, questa carità statale, ha certi suoi caratteri speciali : è una carità che si rivolge a se stessa, che riguarda anzitutto e unicamente i componenti dello Stato che su di essa si fonda. Lo Stato è l’incarnazione della Carità, e il suo dispensatore : e la sparge sui propri membri, sui funzionari, sui parenti, sugli amici, su coloro che direttamente o indirettamente ne vivono". (Carlo Levi, L’Orologio, Einaudi, 1950)
Speranze e delusioni in un tornante decisivo del Novecento italiano
L’Orologio di Carlo Levi
di Andrea Mariuzzo (Il Mulino, 02 dicembre 2020])
Il 29 novembre del 1902 nasceva a Torino uno degli intellettuali più brillanti e sottovalutati del Novecento italiano: Carlo Levi. Esponente di quella generazione di figli della buona borghesia del capoluogo piemontese che in tanti casi si sarebbe impegnata nel gruppo cittadino di Giustizia e Libertà sgominato dalla polizia politica fascista nel 1935 a causa della delazione di Dino “Pitigrilli” Segre, Levi fu per tutta la vita attivista politico della sinistra antifascista, ma anche scrittore e giornalista, osservatore con occhio quasi antropologico delle dinamiche sociali piccole e grandi di un Paese, del suo Mezzogiorno più profondo e di una classe politica, e soprattutto pittore molto apprezzato dai suoi contemporanei.
Tuttora, Levi deve la sua fama alle riflessioni nate nel periodo del confino in un villaggio della Lucania, e raccolte in Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato da Einaudi subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e tradotto in tutto il mondo. Ormai quasi dimenticata è, invece, la sua opera letteraria forse più matura, L’Orologio, pubblicato sempre con la casa editrice torinese nel 1950. Eppure, esso rappresenta forse l’unico esempio riuscito, quantomeno tra i pochi applicati a materia relativa all’età repubblicana italiana, di un genere assai raramente praticato nella letteratura italiana, quello del “romanzo politico”.
Riletto oggi, di certo, il libro presenta al pubblico una difficoltà non da poco che pure deve essere affrontata per apprezzarlo, cioè la necessità di immaginarsi come all’epoca e nel contesto della sua stesura un protagonista degli eventi narrati, risalenti a cinque anni prima, potesse rileggerli e guardare criticamente al modo in cui li visse. Vale tuttavia la pena di provarci, per poter godere di una riflessione che ha ancora molto da dirci sull’attualità e sulle sue radici storiche.
L’Orologio, dunque, prende esplicitamente le mosse dalle conclusioni del Cristo si è fermato a Eboli, in alcune pagine citando esplicitamente il libro precedente. Nell’Italia fossilizzata su illusori contrasti all’interno della propria classe dirigente che in realtà celavano la realtà profonda della dialettica di sopraffazione sui “contadini” dei “donluigini”, occorreva ricostruire da zero una comunità nazionale realmente coesa, strutturata attorno a istituzioni davvero al servizio dei cittadini e capaci di accompagnarli nel loro sforzo di elevazione sociale, ma prima di tutto occorreva smantellare fino in fondo gli apparati amministrativi e burocratici dal precedente assetto strutturalmente ineguale. A quegli apparati burocratici i privilegiati di ogni livello, dai grandi imprenditori monopolisti ai piccoli titolari della concessione di una farmacia, erano avvinghiati per ottenere ciò che sanciva in modo inequivocabile la propria condizione di privilegio: una sinecura pubblica, una sovvenzione, una deroga, una norma spudoratamente favorevole.
Su questi rapporti istituzionali e politici malati, che pure lo precedevano di decenni negli interstizi della società italiana, si era retto per vent’anni il regime fascista, e allo smantellamento di questa patologia che era stata una delle basi portanti della dittatura doveva dedicarsi, per completare la sua opera, l’antifascismo vittorioso nel 1945. Era del resto questo l’obiettivo di quella che il Partito d’Azione, allora soggetto politico di riferimento di Carlo Levi nonché interprete più convinto dell’epopea resistenziale, intendeva raggiungere con quella che con un certo understatement era presentata come “riforma della pubblica amministrazione”, ma che in realtà doveva essere una rivoluzione culturale, un lavacro purificatore di tutti i germi socio-culturali alla radice del fascismo. Lavacro purificatore forse utopistico, ragione fondamentale per cui tanta parte delle culture politiche italiane, da quelle raccolte nei partiti di massa della sinistra marxista a quella del cattolicesimo organizzato di governo fino agli opinionisti liberal-conservatori a la Montanelli, avrebbe ricordato il Pda come un partito di anime belle, di illusi sospesi tra il desiderio di crogiolarsi nei loro sogni e la volontà di realizzarli con un colpo di mano giacobino, in definitiva figure storicamente inutili o peggio ancora (per chi guardava da destra) mosche cocchiere per utopie assai meglio armate.
Scrivendo L’Orologio nel 1950, Levi non rinnegava affatto quell’obiettivo ideale, ma in una certa misura ammetteva la necessità di riflettere su quanto esso fosse effettivamente realizzabile, poiché chiariva che esso poteva essere spiegato, e “fatto passare” al pubblico, solo nella forma del romanzo, della scrittura di finzione. Il canovaccio del racconto era però intessuto di fatti reali, poiché l’azione si svolgeva effettivamente tra il 22 e il 24 novembre del 1945, nelle convulse giornate in cui si consumò la crisi del governo guidato da Ferruccio Parri, l’esecutivo in cui gli azionisti avevano riposto le speranze di vedere realizzate le loro istanze di rinnovamento al soffio del “vento del Nord” dell’esperienza resistenziale. Allo stesso modo aveva radici nella realtà anche il ruolo del protagonista e voce narrante, direttore del quotidiano del partito che esprimeva “il Presidente”, proprio come nel novembre 1945 Levi era direttore dell’organo azionista “L’Italia libera”.
In fondo tutto il romanzo è la riflessione su quanto la compagine azionista ed ex-partigiana alla guida del governo chiede troppo a quel “vento del Nord”, per il quale era impossibile soffiare così forte da abbattere abitudini e necessità radicate troppo in profondità nel sentire del Paese, soprattutto delle sue zone più problematiche.
Questa riflessione si dipana, sul piano narrativo, nella forma di due viaggi.
Dapprima il protagonista-narratore si trova a compiere un giro per Roma alla ricerca di esponenti politici più o meno importanti, ma soprattutto alla scoperta di funzionari e impiegati passati dal pre-fascismo al post-fascismo senza mutare di una virgola il loro atteggiamento e il modo di interpretare il loro ruolo. Essi, ai suoi occhi, rappresentavano la vera forza materiale della conservazione, in quanto legati in maniera irremovibile a quei piccoli privilegi che di fatto non permettevano loro null’altro che di galleggiare appena sopra la miseria, ma senza i quali essi non sapevano neppure immaginarsi.
Al protagonista toccò poi compiere un viaggio di andata e ritorno per Napoli che assunse i caratteri di un’odissea tra strade bombardate e paesi ridotti all’inesistenza. Il viaggio di ritorno, in particolare, avverrà in automobile, privilegio che il direttore di un giornale di partito non si sarebbe mai potuto concedere se nel capoluogo campano non avesse ricevuto un passaggio da due esponenti di spicco dei due grandi partiti che si apprestavano a gestire in proprio il governo e il potere: Colombi (figura sotto cui si cela il democratico-cristiano Attilio Piccioni) e Tempesti (il comunista Emilio Sereni).
Proprio nel corso del viaggio due rappresentanti dei grandi partiti di massa, a cui simbolicamente sarebbe passata la responsabilità di guidare il Paese pochi giorni dopo con l’incarico di formare il governo affidato direttamente al leader della Dc Alcide De Gasperi, si rendono protagonisti di un dialogo di cui il protagonista è muto testimone, forse profetico per il dibattito pubblico degli anni successivi: un dialogo in cui moderati e sinistra si confrontano da posizioni opposte, ma portandolo avanti utilizzando le stesse parole e riconoscendo reciprocamente il ruolo l’uno dell’altro. Si manifestava insomma come inevitabile la conclusione che avrebbe condotto all’esito delle elezioni per la Costituente nel giugno 1946, ovvero quella per cui per avere successo nella politica italiana si doveva finire per accettare, e quasi per incorporare e rappresentare, ciò che nel Paese non funzionava, costruendo su tale comune accettazione la collaborazione e il conflitto.
Si chiudeva così la riflessione sul recente passato di Levi, che aveva accompagnato parole e pensieri del protagonista col pensiero ricorrente di un vecchio orologio di famiglia che aveva portato a riparare, ma che non avrebbe più ritirato anche perché nel frattempo gli eventi gliene avevano regalato uno nuovo, come a simboleggiare anche sul piano materiale una netta cesura nel suo percorso esistenziale di attivista politico antifascista che però si stagliava sulla continuità della verità destinata a uscire in modo più evidente dalle pagine del volume: «il nostro [Stato] è una grande organizzazione caritatevole per coloro che ne fanno parte [...]. Qualcuno deve pagare le spese della pubblica carità, le spese di Stato: e questi sono coloro che dello Stato non fanno parte».
Dopo settant’anni queste parole restano allo stesso modo suggestive, anche se l’effettiva partecipazione o meno alla “carità di Stato” si è fatta sempre meno facilmente intuibile.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
LA STORIA DEL FASCISMO E RENZO DE FELICE: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO" !
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Da oscuro oggetto del desiderio a soggetto (di Valeria Finocchiaro).22 novembre 2020, di Federico La Sala
“Ripartire dal desiderio” di Elisa Cuter (Minimum fax)
Da oscuro oggetto del desiderio a soggetto
di Valeria Finocchiaro *
Non è facile, oggi, scrivere che “Il femminile è l’immagine, il volto angelico, del capitalismo più violento, e allo stesso tempo il testimonial del pacifismo fintamente democratico e ipocrita del capitale”.
In una società che vorrebbe raccontare la donna come vittima eterna e agnello sacrificale, sollevandola sostanzialmente da ogni responsabilità e negandole capacità di giudizio, ribaltare esplicitamente l’immagine di donna passiva con quella di donna consapevole e volitiva espone a dei rischi, fra cui quello di scontentare la pletora di commentatori affezionati all’idea che la donna sia qualcosa da tutelare e di cui prendersi cura.
Il libro “Ripartire dal desiderio” di Elisa Cuter (Minimum fax) sceglie di correre qualche rischio nella speranza di introdurre un disordine propedeutico a scompaginare alcuni dogmi, come quello secondo cui “Un mondo più femminilizzato” sarebbe “garanzia di equità, inclusione, libertà o cooperazione”.
Risposte, a dire il vero, Cuter ne dà poche, ed è proprio quando non tenta di risolvere le contraddizioni del reale con facili soluzioni che diventa potente: il femminismo contemporaneo è già sufficientemente balcanizzato da ortodossie inconciliabili da non avere bisogno di ulteriori manuali di condotta. Questo libro sfugge infatti alla tentazione di fornire l’ultima parola, di costituirsi come breviario, di costruire una regola; eppure allo stesso tempo non rimane nel limbo aleatorio di un flusso di coscienza senza direzione: c’è lo sforzo di mantenersi all’altezza delle sfide che il mondo contemporaneo ci offre. Tenendo fede al compito più autentico della critica, che non è mai edificazione, Cuter pone delle domande e inquadra i problemi senza avanzare la pretesa di risolverli con la semplicità cristallina degli assiomi. In certi momenti, a dire il vero, si avverte il bisogno di trarre le fila di un discorso che in alcuni passaggi rimane aporetico, come quando accenna a un argomento piuttosto scivoloso: quello della servitù volontaria, tema cruciale e affatto nuovo che è però rimasto profondamente attuale fin dalla sua prima codificazione a opera di Etienne de la Boetie più di cinquecento anni fa.
Instagram è pieno di donne (e uomini) che mostrano le proprie foto di nudo o seminudo, per compiacere altri utenti e di rimando nutrire il proprio narcisismo, oppure in altri casi per celebrare la bellezza del proprio corpo, più o meno canonico che sia. Come si può riflettere su questo fenomeno da una prospettiva femminista, cercando di restare equidistanti sia dalla critica bigotta e moralistica, sia dall’individualismo liberale? Fino a che punto la spettacolarizzazione della propria sessualità, dell’erotismo e del piacere, è autentica emancipazione, e quando invece introduce lo sfruttamento capitalistico del sé che ogni individuo ha interiorizzato per stare al mondo?
Ancora una volta si pone il problema della libertà: cosa è, cosa ce ne facciamo. E più in particolare, la domanda che ci poniamo oggi dovrebbe consistere nel chiedersi se siamo capaci di riconoscere la libertà dentro un sistema, il capitalismo liberale, che ha camuffato il dominio sugli individui dietro le sembianze allettanti della libertà e della realizzazione individuale. Difficile stabilire se ci spogliamo su internet perché siamo finalmente libere dopo secoli di oppressione sessuale, oppure perché siamo indotte a mettere a profitto il nostro capitale sessuale, - e quindi nient’affatto libere.
Quello che si chiede il libro, dal mio punto di vista, è esattamente questo: esiste un modo di essere libere che non sia quello che il capitalismo ci offre? Siamo ancora in grado di desiderare qualcosa che ci renda felici, oppure questo desiderio è ormai inevitabilmente compromesso con la logica del profitto neoliberale? Come si fa a guardare il nostro corpo (e quello altrui) mettendo da parte il pensiero egemonico della perfezione e del giudizio? Anche perché, come sappiamo, il problema della libertà nel capitalismo è che, a dispetto di ciò che i corifei del sistema raccontano, questa libertà non è affatto alla portata di tutti: solo chi è più bravo a produrre (e solo fintantoché è in grado di farlo) può essere felice, tutti gli altri esclusi.
Dagli anni Ottanta si è imposta infatti una narrazione che impone alle donne - e a ogni individuo in generale - di contribuire al sistema non solo in veste di consumatrici, ma che premia in particolar modo quelle che sono riuscite nell’impresa, tutt’altro che semplice, di mettere a profitto il proprio capitale sessuale, la propria giovinezza: “la vittoria del femminile è la vittoria dello spettacolo” (che però riguarda tutti) e tra le soubrette e le modelle di Instagram la differenza sta nello storytelling: passività nel primo caso, autodeterminazione nel secondo.
Fin qui, niente di nuovo.
L’autrice però va oltre e si chiede: e se fare così ci fosse convenuto (e pure un po’ piaciuto)? Potrebbe essere il caso delle protagoniste del famoso programma televisivo Non è la Rai, andato in onda nei primi anni ’90, dove ragazzine sui quindici anni venivano istruite a mettere in scena una innocenza infantile a cui nessuno credeva, ma che servì a forgiare le fantasie sessuali di una intera generazione. Dice Cuter: “tante di loro, [...] vissero (o sfruttarono) l’esperienza anche come un trampolino ideale per intraprendere una carriera che dura tuttora”. E questo potrebbe valere, ad esempio, anche per le famose Olgettine, giovani donne note alla cronaca per i rapporti sessuali e i ricatti nei confronti di Berlusconi.
D’altronde è evidente che “in un contesto in cui ci viene continuamente imposto di mettere a mercato i nostri corpi e la nostra sfera più intima e individuale, cosa ci sorprende del fatto che qualcuno utilizzi il sesso per acquistare un po’ di potere?”. Nulla, e infatti in questo contesto, “una donna potrebbe volontariamente accettare per ottenere qualcosa in cambio: potrebbe insomma usare il sesso come moneta di scambio. Una pratica a cui le donne, come abbiamo visto, sono ricorse per secoli” (e a cui ricorrono tutt’ora).
Questa tendenza a mettere “volontariamente” a profitto il corpo, e quindi a renderlo “volontariamente” uno strumento passivo, è però una tendenza che non riguarda solo la donna, ma la società intera: quando si parla di femminilizzazione della società, spiega Cuter, bisogna infatti intendere quel processo paradossale per cui ogni individuo è via via portato a farsi oggetto, a diventare passivo almeno in apparenza, per ottenere qualcosa in cambio (dalla gratificazione narcisistica, al denaro, o al potere di esercitare una forma di dominio sugli altri). Si ricava insomma piacere dal fatto di “diventare un oggetto del desiderio (come una donna), ma anche diventare un oggetto nel senso di essere finalmente qualcosa di totalmente passivo, impotente: sollevato da quelle enormi responsabilità (principalmente verso se stessi) a cui si è costretti perfino se non ci si trova in nessuna posizione di potere”.
Anche se, tradizionalmente, è stata sempre la femmina ad avere “desiderato” di essere oggetto (“Essere femmina è essere un oggetto” scrive Cuter citando Andrea Long Chu), come dimostra l’abilità del genere femminile, perfezionata nel corso dei secoli, nell’arte-di-diventare-oggetto per eccellenza, ovvero quella di abbellirsi, oggi questa tendenza riguarda tutti, indipendentemente dal genere: “è in gioco una competizione tra soggetto maschile e femminile per il ruolo di oggetto”.
Ma se ciò che desideriamo, come soggetti, è quello di essere oggetti (di desiderio), stiamo ancora esercitando una libertà? In altri termini, la volontà di regredire al rango di oggetto (sessuale), è qualcosa che ci può rendere libere? Probabilmente sì, ma in che modo?
Il libro non ha la pretesa di risolvere queste domande, che vengono lasciate senza riposta; l’autrice ha però il coraggio di porle - con un gesto di rottura rispetto al conformismo rassicurante di molto femminismo contemporaneo -, sapendo bene di addentrarsi in una selva oscura: ciò che potremmo trovare all’interno potrebbe non piacerci affatto. Come nel film Stalker di Andrej Tarkowskij, siamo noi stesse, nella maggior parte dei casi, ad avere paura dei nostri desideri, perché questi ci obbligano a fare i conti con l’aspetto più oscuro e inquietante del nostro inconscio. “Il sesso [ma il discorso vale anche per il desiderio] non è una passeggiata, è rischioso, imbarazzante e spesso sgradevole. Sicuramente non è qualcosa di rassicurante”.
Un ulteriore punto di merito è il fatto di non peccare di universalismo astratto: quando si parla di femminismo, infatti, il rischio di confondere la propria esperienza specifica di donne occidentali con l’esperienza universale di donna è molto alto. È ovvio infatti che i percorsi di emancipazione delle donne bianche dei paesi sviluppati sono molto diversi, storicamente, da quelli delle donne nere in quegli stessi paesi, o in altri ancora. Mentre, ad esempio, le donne afroamericane si confrontano tutt’ora con un’esperienza di emarginazione razziale oltre che sessuale, le donne bianche dei paesi occidentali, dopo la grande stagione della lotta per i diritti formali, riflettono oggi soprattutto sul significato di quella libertà che il capitalismo si fregia di avere diffuso, mettendone in discussione premesse e risultati. Questo libro è ambientato in uno spazio e in un tempo specifico, l’Occidente, e precisamente in quella fase di decadenza economica che costituisce la cornice del nostro presente, con le sue ombre e i suoi fantasmi ricorrenti.
Fra questi, l’ossessione parossistica per la propria immagine, con tutto il suo portato di sofferenza e frustrazione, segue a quel ritiro nel privato (senza politica) che costituisce la cifra degli ultimi trent’anni. La cura di sé in Occidente ha preso una piega completamente diversa da quella auspicata da Foucault nel ciclo di lezioni che tenne al Collège de France: mentre il suo era un tentativo di formulare, con l’aiuto degli antichi, una forma di resistenza all’assoggettamento biopolitico, la nostra cura del sé ha preso le sembianze di un ingranaggio consumistico, la cui massima soddisfazione coincide con il massimo dell’exploitation.
C’è però un assente in questo libro, ed è l’amore: l’autrice non accenna quasi mai al rapporto, ben presente e sperimentato da ogni individuo, fra desiderio e amore (inteso qui non in senso monogamico né eterosessuale). Certamente davanti al discorso sull’amore ogni persona di buon senso intimidisce: si è frenati dal terrore di essere banali o stucchevoli o di non riuscire a esprimere con parole semplici qualcosa di complesso come l’esperienza amorosa, o viceversa di non trovare parole complesse a sufficienza per descrivere un’esperienza così semplice.
 Eppure, anche se non esplicito, credo che un certo riferimento all’esperienza liberatoria dell’amore sia presente fra le righe, e che agisca in alcuni casi come catalizzatore di quel tipo di desiderio che riesce a fare a meno del dominio (come nel caso del rapporto fra Donna Haraway e il suo cane). Con il desiderio autenticamente liberatorio l’amore condivide il fatto di spezzare quel meccanismo infernale del compiacimento narcisistico illustrato sopra, perché in grado di sospendere la morsa dell’utilitarismo.
Eppure, anche se non esplicito, credo che un certo riferimento all’esperienza liberatoria dell’amore sia presente fra le righe, e che agisca in alcuni casi come catalizzatore di quel tipo di desiderio che riesce a fare a meno del dominio (come nel caso del rapporto fra Donna Haraway e il suo cane). Con il desiderio autenticamente liberatorio l’amore condivide il fatto di spezzare quel meccanismo infernale del compiacimento narcisistico illustrato sopra, perché in grado di sospendere la morsa dell’utilitarismo.L’autrice, naturalmente, non ci dice cosa dobbiamo desiderare per essere persone libere. Né tantomeno le sfugge che il discorso sul desiderio è per sua natura opaco ed equivoco: non basta celebrare la potenza conflittuale del desiderio genericamente inteso - in virtù di un ottimismo deleuziano che funzionava per un’altra stagione politica e per un’altra generazione, ma che oggi si rivela parziale -, per risolvere il problema. Pagine e pagine di letteratura psicanalitica (non solo marxista) ci hanno insegnato che il desiderio senza regole è un’istanza egoica e potenzialmente distruttiva, foriera di squilibri enormi così come il suo pendant moralistico, cioè la repressione puritana.
Dal momento che non esiste alcun desiderio che non sia il prodotto di una serie di condizionamenti culturali e sociali, poiché i “desideri non nascono nel vuoto, [ma] sono frutto della società e delle relazioni in cui viviamo”, ciò su cui è necessario riflettere è fino a che punto, quando crediamo di esercitare un arbitrio, siamo consapevoli del condizionamento che ci deriva dall’essere individui desideranti all’interno di “un contesto in cui tutti, indipendentemente dal loro genere, si percepiscono sempre come merce”, e che quindi al posto di liberare le capacità di ciascun essere umano, le addomestica e le comprime.
Ripartire dal desiderio non significa quindi assecondare ogni desiderio, né tantomeno rifiutare a priori il suo potenziale liberatorio; significa piuttosto tornare a riflettere sul desiderio senza limiti moralistici, come invita a fare questo libro, cioè a metterlo in discussione e interrogarlo in modo radicale. In questo senso, quello di ripartire dal desiderio è compito non soltanto individuale e non soltanto femminista, ma della sinistra intesa come processo collettivo di trasformazione.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Ripensare con cura il linguaggio della antropologia e della teologia. "Il massimo necessario" e le "azioni superogatorie" (di Andrea Grillo).8 novembre 2020, di Federico La Sala
Ripensare con cura il linguaggio della antropologia e della teologia....
Libero e non esigibile, ma dovuto: sull’ultimo libro di Stefano Biancu
di Andrea Grillo *
Con lo stile pacato che abbiamo imparato ad apprezzare nei suoi libri precedenti, e con grande finezza, in questo volume (Il massimo necessario. L’etica alla prova dell’amore, Milano, Mimesis, 2020) Stefano Biancu - che insegna Filosofia morale alla Lumsa di Roma - scandaglia con bella chiarezza un tema “minore” della tradizione della filosofia morale (le “azioni supererogatorie”), portandone alla luce non solo riletture recenti assai promettenti, ma facendolo diventare quasi il luogo di evidenza di una “diversa logica” nel pensare l’agire morale.
Il libro è costruito in modo lineare. Fin dalla Introduzione (“Per iniziare”), è posta la questione centrale: ci sono alcune azioni che la tradizione teologica e filosofica ha riconosciute come “esterne” all’ambito morale e giuridico, e che tuttavia qualificano in modo decisivo l’intelletto d’amore: è ciò che è stato chiamato “supererogatorio”. Così il libro, muovendo da una appassionata ed appassionante “storia del termine” (cap. 1: Il supererogatorio), lo valorizza come chiave di lettura di uno dei temi decisivi della “modernità”: la fraternità (cap. 2). Ciò permette di elaborare, mediante la traduzione della terminologia classica della filosofia morale in nuove categorie, aggiornate nel confronto con il pensiero contemporaneo, una comprensione delle tensioni che il pensiero moderno (etico, giuridico e politico) vive per giustificare non solo la libertà e l’uguaglianza, ma anche la fraternità. Il “massimo necessario” della fraternità non è solo fondato su una libertà ed eguaglianza originaria, ma sta pure all’origine della libertà e della uguaglianza. Questa sfida viene giocata in relazione a tre termini, che definiscono la “fraternità in atto”: l’ospitalità (cap. 3), il perdono (cap. 4) e la misericordia (cap. 5). Una lettura solo etica o giuridica di queste tre categorie è votata al fallimento. Per darne conto, occorre attingere ad una dimensione “previa” - che Biancu chiama “antropologica” - e che costituisce l’orizzonte nel quale il “soggetto di diritto” trova il fondamento della propria dignità.
Nel discorso di Biancu, che resta intenzionalmente e accuratamente un testo di carattere filosofico, appaiono discretamente, ma autoreveolmente, fonti teologiche. D’altra parte, per fare i conti con i temi della fratellanza, della ospitalità, del perdono e della misericordia non è possibile aggirare né il “grande codice” biblico, né la elaborazione che di esso ha fornito la tradizione teologica.
Per questo il libro di Biancu a me pare anche una buona guida per un lavoro esplicitamente teologico, che voglia arricchire la prospettiva di riflessione sulla libertà, sulla eguaglianza e sulla fratellanza, ponendo in luce un presupposto non solo “antropologico”, ma “teologico” delle categorie in gioco. E’ la genealogia del soggetto ad essere qui arricchita e problematizzata, nella sua relazione al prossimo e a Dio come costitutiva della sua identità. La differenza tra ciò che può essere “esigito” e ciò che è doveroso - in altri termini tra i diritti/doveri e i doni - costituisce un guadagno teorico che trova origine in una “esperienza della azione” più complessa di quella a cui siamo abituati.
 Non ci sono solo azioni “imposte, vietate o libere”. Ci sono anche “azioni supererogatorie”, che non sono riducibili a questa “triade”, ma che costituiscono l’orizzonte di fratellanza, di ospitalità, di perdono e di misericordia nel quale ogni soggetto può “venire al mondo”. Sono libere e non esigibili, ma necessarie e dovute. La non contraddittorietà tra queste due affermazioni - sulla libertà e sulla necessità - implica un “cambio di paradigma” che investe non solo la filosofia morale, ma anche la antropologia e la teologia. E il superamento delle “classiche opposizioni” di cui si è nutrita la tradizione filosofica e teologica che ci chiede la comprensione della misericordia - al di qua e al di là delle coppie interiore/esteriore, immanente/trascendente, necessario/possibile, pubblico/privato - dimostrano la bella fecondità della prospettiva assunta.
Non ci sono solo azioni “imposte, vietate o libere”. Ci sono anche “azioni supererogatorie”, che non sono riducibili a questa “triade”, ma che costituiscono l’orizzonte di fratellanza, di ospitalità, di perdono e di misericordia nel quale ogni soggetto può “venire al mondo”. Sono libere e non esigibili, ma necessarie e dovute. La non contraddittorietà tra queste due affermazioni - sulla libertà e sulla necessità - implica un “cambio di paradigma” che investe non solo la filosofia morale, ma anche la antropologia e la teologia. E il superamento delle “classiche opposizioni” di cui si è nutrita la tradizione filosofica e teologica che ci chiede la comprensione della misericordia - al di qua e al di là delle coppie interiore/esteriore, immanente/trascendente, necessario/possibile, pubblico/privato - dimostrano la bella fecondità della prospettiva assunta.In altri termini, per dar conto davvero delle “azioni supererogatorie”, occorre ripensare con cura il linguaggio della antropologia e della teologia. Comprendere davvero fraternità, ospitalità, perdono e misericordia implica una “intelligenza di sé e del mondo” di altra e alta qualità, che impegna il pensiero non solo dei filosofi, ma anche dei teologi.
All’inizio del libro Stefano Biancu ha posto una frase esemplare, tratta dai quaderni di A. Camus, che recita: “Se dovessi scrivere un libro di morale, esso avrebbe cento pagine e 99 sarebbero bianche. Sull’ultima scriverei: conosco un solo dovere ed è quello di amare”. Nel suo bel volume Stefano Biancu propone un serio tentativo di dar voce a quelle 99 pagine .
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’ULTIMO PAPA CEDE IL PASSO A ZARATHUSTRA: "CHI AMA, AMA AL DI LA’ DEL PREMIO E DELLA RIVALSA".
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - L’Europa, il precetto delfico “Gnôthi sautón”, e la sconfitta di Socrate. Letture socratiche (di lavinia Peluso).4 novembre 2020, di Federico La Sala
Recensione a:
- Hannah Arendt, Socrate, Raffaello Cortina, Milano 2015, pp. 124. (Lavinia Peluso) *
Sappiamo che Socrate amava intrattenere conversazioni con i concittadini nell’agorà di Atene, ponendoli ironicamente di fronte a insolite questioni e sollecitandoli a spiegare e giustificare le proprie affermazioni al riguardo. Il filosofo non intendeva insegnare qualcosa ai suoi interlocutori e introiettare in loro una qualche conoscenza dall’esterno, bensì condurli a trovare la verità nascosta in se stessi, portandola alla luce attraverso l’interrogazione e lo sradicamento delle false doxai. Lo scopo era, cioè, quello di aiutare il soggetto a partorire la propria verità, seguendo la celebre metafora della maieutica proposta dallo stesso Socrate. L’obiettivo è realizzabile nel corso di una vita fatta di riflessione, interrogazione continua e messa in discussione dei convincimenti più radicati, poiché proprio dietro la più proclamata sicurezza può nascondersi una subdola ignoranza della verità. Solo a partire dalla conoscenza di se stessi e dal riconoscimento dei propri limiti, risulta possibile dare alla luce la verità. Precisamente in virtù dell’attività socratica, la filosofia inizia a delinearsi come conversazione dialettica e come disciplina caratterizzata da lineamenti precisi.
Non è un caso che la personalità di Socrate attraversi e accompagni la totalità della riflessione di Hannah Arendt, fornendo all’autrice un vivo esempio per la formulazione di tesi che ruotano intorno al controverso rapporto tra filosofia e politica, alla coscienza individuale e al tema del male.
 Il saggio Socrate compare per la prima volta in traduzione italiana nel 2015, figurando in origine come terza e ultima parte di un corso tenuto presso la Notre Dame University nel 1954.
Il saggio Socrate compare per la prima volta in traduzione italiana nel 2015, figurando in origine come terza e ultima parte di un corso tenuto presso la Notre Dame University nel 1954.
 Il testo si apre con un’introduzione a cura di Ilaria Possenti, la quale contestualizza il contributo arendtiano nel contesto della produzione letteraria dell’autrice, e che nelle sue considerazioni prende avvio da una lettera indirizzata da Arendt a Karl Jaspers nell’estate del 1956, dove l’autrice individua nel processo a Socrate il principio del conflitto tra filosofia e politica. Ricostruendo la genesi di questa contrapposizione, Possenti spiega che Arendt non condanna la polis ateniese, bensì chiama in causa Platone, l’allievo di Socrate. Egli avrebbe lasciato in eredità alla storia del pensiero occidentale due convinzioni fondamentali: “che la politica, così come Atene l’aveva intesa, fosse una pericolosa fonte di ingiustizia; e che i criteri per porre rimedio all’ingiustizia dovessero essere trovati altrove, al di fuori e al di sopra della polis” (p. 9). Ciò è evidente se ci rivolgiamo alla Repubblica: la città ideale delineata nel dialogo si regge su un ideale statico di giustizia, definito a priori, che deve la sua realizzazione nel contesto sociale alla reggenza dei filosofi, coloro che, distanti dalla polis, hanno dedicato la loro vita al puro pensiero inteso come noein, come intuizione e contemplazione della verità.
Il testo si apre con un’introduzione a cura di Ilaria Possenti, la quale contestualizza il contributo arendtiano nel contesto della produzione letteraria dell’autrice, e che nelle sue considerazioni prende avvio da una lettera indirizzata da Arendt a Karl Jaspers nell’estate del 1956, dove l’autrice individua nel processo a Socrate il principio del conflitto tra filosofia e politica. Ricostruendo la genesi di questa contrapposizione, Possenti spiega che Arendt non condanna la polis ateniese, bensì chiama in causa Platone, l’allievo di Socrate. Egli avrebbe lasciato in eredità alla storia del pensiero occidentale due convinzioni fondamentali: “che la politica, così come Atene l’aveva intesa, fosse una pericolosa fonte di ingiustizia; e che i criteri per porre rimedio all’ingiustizia dovessero essere trovati altrove, al di fuori e al di sopra della polis” (p. 9). Ciò è evidente se ci rivolgiamo alla Repubblica: la città ideale delineata nel dialogo si regge su un ideale statico di giustizia, definito a priori, che deve la sua realizzazione nel contesto sociale alla reggenza dei filosofi, coloro che, distanti dalla polis, hanno dedicato la loro vita al puro pensiero inteso come noein, come intuizione e contemplazione della verità.
 Secondo Arendt, Platone definì “i termini del conflitto tra filosofia e politica” (p. 10), generando uno iato tra le due, di cui l’autrice lo accusa direttamente. L’allievo fallì così nel cogliere l’eredità del maestro, in cui filosofia e politica risultano invece coessenziali: “così facendo, Platone inaugura la ‘grande tradizione’ rendendo immortale la figura di Socrate e marginale il suo pensiero politico” (p. 11).
Secondo Arendt, Platone definì “i termini del conflitto tra filosofia e politica” (p. 10), generando uno iato tra le due, di cui l’autrice lo accusa direttamente. L’allievo fallì così nel cogliere l’eredità del maestro, in cui filosofia e politica risultano invece coessenziali: “così facendo, Platone inaugura la ‘grande tradizione’ rendendo immortale la figura di Socrate e marginale il suo pensiero politico” (p. 11).Arendt individua, invero, precisamente nella prospettiva socratica un’alternativa a una filosofia ormai esaurita, inserendola peraltro nella sua visione fenomenologica. Nell’ottica arendtiana, l’unica realtà è data dall’apparire e dal mondo comune, lo stesso mondo comune a cui si rivolgeva il filosofo greco. La sua concezione della “condizione umana, in qualche modo intesa come condizione ‘politica’, [...] dovrebbe aiutarci a ripensare da capo il senso della vita della polis [...] e l’oggetto stesso della ‘meraviglia’ filosofica - la pluralità che ci unisce, ci distingue e ci attraversa” (p. 18): è precisamente in ciò che possiamo individuare il fulcro delle riflessioni arendtiane contenute in Socrate.
Il saggio si apre con Il processo di Socrate e la replica di Platone. L’autrice inizia le sue considerazioni partendo dal contesto di appartenenza del filosofo, dominato dall’arte della persuasione, l’arte più elevata e più prettamente politica, che rappresenta ciò in cui fallì Socrate, non riuscendo a persuadere i giudici della sua innocenza. Il filosofo non avrebbe dovuto mirare a far partorire una verità che i giudici non erano disposti ad accogliere, bensì a persuaderli della validità del suo punto di vista.
 Nell’ottica platonica, la causa della sconfitta del maestro è da ricercare nel fatto che Socrate si rivolse ai giudici nello stesso modo in cui era solito conversare con gli Ateniesi, secondo il metodo dialettico, e non retorico: il dialeghesthai, però, risulta possibile solo come dialogo tra due soggetti, mentre peitho si rivolge sempre a una moltitudine, ragione per cui Socrate avrebbe dovuto ricorrere alla persuasione piuttosto che alla dialettica. Ciò condusse Platone a dubitare del valore del peithein e con esso anche della doxa, che il maestro cercava di far esprimere agli interlocutori: “è lo spettacolo di Socrate che sottopone la propria doxa alle opinioni irresponsabili degli Ateniesi, e che viene infine sconfitto da una maggioranza, a spingere Platone al disprezzo delle opinioni e a fare di lui un ardente fautore di criteri assoluti” (pp. 26-27).
Nell’ottica platonica, la causa della sconfitta del maestro è da ricercare nel fatto che Socrate si rivolse ai giudici nello stesso modo in cui era solito conversare con gli Ateniesi, secondo il metodo dialettico, e non retorico: il dialeghesthai, però, risulta possibile solo come dialogo tra due soggetti, mentre peitho si rivolge sempre a una moltitudine, ragione per cui Socrate avrebbe dovuto ricorrere alla persuasione piuttosto che alla dialettica. Ciò condusse Platone a dubitare del valore del peithein e con esso anche della doxa, che il maestro cercava di far esprimere agli interlocutori: “è lo spettacolo di Socrate che sottopone la propria doxa alle opinioni irresponsabili degli Ateniesi, e che viene infine sconfitto da una maggioranza, a spingere Platone al disprezzo delle opinioni e a fare di lui un ardente fautore di criteri assoluti” (pp. 26-27).
 L’adesione platonica a una normatività suprema è, dunque, motivata da Arendt in base alla delusione provata di fronte alla condanna del maestro. A una politica basata sull’opinione plurale, Platone sostituì principi univoci e inequivocabili che non possono essere oggetto di persuasione. Ma egli andò ben oltre la vendetta del maestro affidando il governo ai filosofi, a quei sophoi che per definizione esulano dalla sfera degli affari della città, ribaltando il vecchio aneddoto di Talete deriso dalla servetta perché caduto nel pozzo, in quanto troppo intento a guardare il cielo. Cionondimeno, se Socrate fu il primo filosofo a rivestire un ruolo politico, Platone fu l’ultimo.
L’adesione platonica a una normatività suprema è, dunque, motivata da Arendt in base alla delusione provata di fronte alla condanna del maestro. A una politica basata sull’opinione plurale, Platone sostituì principi univoci e inequivocabili che non possono essere oggetto di persuasione. Ma egli andò ben oltre la vendetta del maestro affidando il governo ai filosofi, a quei sophoi che per definizione esulano dalla sfera degli affari della città, ribaltando il vecchio aneddoto di Talete deriso dalla servetta perché caduto nel pozzo, in quanto troppo intento a guardare il cielo. Cionondimeno, se Socrate fu il primo filosofo a rivestire un ruolo politico, Platone fu l’ultimo.Nella seconda parte del saggio Arendt passa a discutere in maniera sistematica la posizione di Socrate. Nella ricostruzione arendtiana, egli fu indubbiamente il primo a ricorrere al dialeghesthai, ma senza considerarlo la controparte di peitho e della doxa, come arrivò invece a fare l’allievo.
 Nella prospettiva socratica, la doxa corrisponde alla comprensione che ognuno ha del mondo, della maniera in cui la realtà si apre e si mostra al soggetto particolare, a seconda del posto occupato in essa. È lo stesso mondo comune a rivelarsi, presentandosi però a ciascuno in modo diverso. Ciò spiega perché la dialettica socratica prenda avvio da una serie di domande attraverso le quali il filosofo cerca di capire quale sia la posizione del suo interlocutore nella realtà, al fine di aiutarlo poi a portare alla luce la propria verità: “Socrate voleva rendere la città più veritiera facendo partorire a ogni cittadino la propria verità. Il metodo per farlo è il dialeghesthai, ma quest’arte dialettica [...] non distrugge la doxa, l’opinione; al contrario, ne rivela la veridicità” (p. 35).
Nella prospettiva socratica, la doxa corrisponde alla comprensione che ognuno ha del mondo, della maniera in cui la realtà si apre e si mostra al soggetto particolare, a seconda del posto occupato in essa. È lo stesso mondo comune a rivelarsi, presentandosi però a ciascuno in modo diverso. Ciò spiega perché la dialettica socratica prenda avvio da una serie di domande attraverso le quali il filosofo cerca di capire quale sia la posizione del suo interlocutore nella realtà, al fine di aiutarlo poi a portare alla luce la propria verità: “Socrate voleva rendere la città più veritiera facendo partorire a ogni cittadino la propria verità. Il metodo per farlo è il dialeghesthai, ma quest’arte dialettica [...] non distrugge la doxa, l’opinione; al contrario, ne rivela la veridicità” (p. 35).
 La maieutica di Socrate assume dunque i tratti di un’attività politica, che mira a rendere migliori i cittadini, facendo di loro in ultima istanza degli amici, in contrasto con lo spirito agonale regnante nella polis, costituente una minaccia per il bene comune. In particolare, l’aspetto politico dell’amicizia risiede nel fatto che l’amico è capace di comprendere il modo in cui la realtà si apre all’altro, attraverso il dialeghesthai socratico: si tratta della stessa virtù dell’uomo politico, il quale dovrebbe dimostrarsi in grado di comprendere lo spettro più ampio possibile di realtà, al fine di rendere evidente l’essere-in-comune del mondo e formare su tale base una comunità, costruendola sulla comprensione propria degli amici.
La maieutica di Socrate assume dunque i tratti di un’attività politica, che mira a rendere migliori i cittadini, facendo di loro in ultima istanza degli amici, in contrasto con lo spirito agonale regnante nella polis, costituente una minaccia per il bene comune. In particolare, l’aspetto politico dell’amicizia risiede nel fatto che l’amico è capace di comprendere il modo in cui la realtà si apre all’altro, attraverso il dialeghesthai socratico: si tratta della stessa virtù dell’uomo politico, il quale dovrebbe dimostrarsi in grado di comprendere lo spettro più ampio possibile di realtà, al fine di rendere evidente l’essere-in-comune del mondo e formare su tale base una comunità, costruendola sulla comprensione propria degli amici.È sul tema della philia che Arendt struttura la parte più dinamica del saggio, La scoperta del “due-in-uno”. -Premessa indispensabile di questo capitolo è il precetto delfico “Gnôthi sautón”, esemplificato dalla personalità socratica. Nell’ottica arendtiana, l’invito alla conoscenza di se stessi comporta che il principio guida del soggetto deve tradursi nella comprensione veritiera della propria doxa e nell’accordo dell’individuo con se stesso, ossia nella philia interiore. La paura di incorrere in questo genere di contraddizione è giustificata in base al fatto che ognuno di noi può parlare con se stesso: nel pensiero ognuno di noi è due-in-uno, e l’armonia di questa dualità si pone come la condizione imprescindibile per l’accordo con l’altro; la paura della contraddizione, dunque, altro non è che timore della scissione e della perdita della coerenza. La pluralità si rivela così come una condizione ineliminabile della natura umana, dacché è sì possibile l’allontanamento da qualsiasi forma di organizzazione sociale, ma mai dall’altro dentro di noi.
 Ciò implica la convivenza con un testimone di tutte le azioni individuali, con uno spettatore giudicante a cui non è possibile sfuggire: è quel tribunale che la modernità chiamerà coscienza. L’io è così sdoppiato in imputato e testimone, in esecutore e pubblico.
Ciò implica la convivenza con un testimone di tutte le azioni individuali, con uno spettatore giudicante a cui non è possibile sfuggire: è quel tribunale che la modernità chiamerà coscienza. L’io è così sdoppiato in imputato e testimone, in esecutore e pubblico.
 Vista l’impossibilità della separazione da quest’ultimo, per il soggetto è preferibile essere in disaccordo con l’intera società piuttosto che con se stesso, col quale deve sempre convivere: si tratta precisamente della tesi affermata da Socrate nel Gorgia, dove egli dimostra peraltro con forza che è meglio subire un’ingiustizia piuttosto che commetterla (Gorg. 482b). Il compimento di un atto malvagio comporta la convivenza obbligata con un individuo che vorremmo invece evitare e col quale non è possibile essere in armonia, dacché nessuno sceglierebbe di accompagnarsi a un criminale. Ciò costituisce dunque una situazione di disaccordo interiore, accentuata dalla presenza di un testimone che giudica negativamente le nostre azioni malvagie.
La pluralità esterna può anzi distrarci dalla molteplicità più angosciante, rappresentata dal due-in-uno. Nella discussione, inoltre, l’altro ci riconosce come singolo, come una sola voce.
Vista l’impossibilità della separazione da quest’ultimo, per il soggetto è preferibile essere in disaccordo con l’intera società piuttosto che con se stesso, col quale deve sempre convivere: si tratta precisamente della tesi affermata da Socrate nel Gorgia, dove egli dimostra peraltro con forza che è meglio subire un’ingiustizia piuttosto che commetterla (Gorg. 482b). Il compimento di un atto malvagio comporta la convivenza obbligata con un individuo che vorremmo invece evitare e col quale non è possibile essere in armonia, dacché nessuno sceglierebbe di accompagnarsi a un criminale. Ciò costituisce dunque una situazione di disaccordo interiore, accentuata dalla presenza di un testimone che giudica negativamente le nostre azioni malvagie.
La pluralità esterna può anzi distrarci dalla molteplicità più angosciante, rappresentata dal due-in-uno. Nella discussione, inoltre, l’altro ci riconosce come singolo, come una sola voce.
 Poste queste premesse, abbiamo modo di comprendere in che modo le presenti considerazioni si pongano in stretta relazione con quanto affermato relativamente alla philia. Solo chi, vivendo l’esperienza del dialogo interiore, è in accordo con se stesso e una persona affidabile, che in quanto tale può diventare un amico, definito in termini aristotelici come un altro se stesso, secondo a quello che abbiamo dentro di noi. Se, cioè, l’individuo supera il giudizio del tribunale della coscienza presieduto da se medesimo, dimostrandosi un compagno leale, può rapportarsi con l’altro in quanto uno, in qualità di soggetto coerente con se stesso e degno di fiducia.
Poste queste premesse, abbiamo modo di comprendere in che modo le presenti considerazioni si pongano in stretta relazione con quanto affermato relativamente alla philia. Solo chi, vivendo l’esperienza del dialogo interiore, è in accordo con se stesso e una persona affidabile, che in quanto tale può diventare un amico, definito in termini aristotelici come un altro se stesso, secondo a quello che abbiamo dentro di noi. Se, cioè, l’individuo supera il giudizio del tribunale della coscienza presieduto da se medesimo, dimostrandosi un compagno leale, può rapportarsi con l’altro in quanto uno, in qualità di soggetto coerente con se stesso e degno di fiducia.Nella quarta parte, La sconfitta di Socrate, Arendt riflette sulle conseguenze tangibili della visione socratica analizzata nelle pagine precedenti. “Il conflitto tra la filosofia e la politica, tra il filosofo e la polis, esplose dopo che Socrate, più che svolgere un ruolo politico, aveva voluto rendere la filosofia rilevante per la polis” (p. 48): l’opposizione si concluse con la sconfitta della filosofia e determinò la separazione tra pensiero e azione, conducendo la figura del filosofo a disinteressarsi degli affari della polis.
 Nella lettura arendtiana, la filosofia venne così a trovarsi di fronte a un bivio: interpretare l’esperienza filosofica secondo le categorie degli affari umani, oppure giudicare quanto rientra nella sfera politica alla luce della visione filosofica. È in questa seconda direzione che è andato Platone, costruendo una polis retta dai filosofi. Nella parabola della caverna egli condensa la biografia del filosofo, il quale si trova ad attraversare emblematici momenti di ribaltamento del proprio essere.
Nella lettura arendtiana, la filosofia venne così a trovarsi di fronte a un bivio: interpretare l’esperienza filosofica secondo le categorie degli affari umani, oppure giudicare quanto rientra nella sfera politica alla luce della visione filosofica. È in questa seconda direzione che è andato Platone, costruendo una polis retta dai filosofi. Nella parabola della caverna egli condensa la biografia del filosofo, il quale si trova ad attraversare emblematici momenti di ribaltamento del proprio essere.Ma Platone non ci spiega perché il filosofo decida di intraprendere questo percorso. Per risolvere la questione, Arendt richiama quanto si legge nel Teeteto, dove Platone individua l’elemento alla base della nascita della filosofia: “la meraviglia è ciò che appassiona di più il filosofo, poiché non c’è altra origine della filosofia diversa dalla meraviglia” (Thaet. 155d). Ed è proprio con la questione del thaumazein che Arendt chiude questo scritto. A suo avviso, la meraviglia nell’ottica platonica consiste in un pathos, in qualcosa rispetto a cui il soggetto è passivo e che non può trovare espressione nelle parole, ma che consente al soggetto di cogliere l’autentico significato della formula socratica “So di non sapere”. Nel momento in cui l’individuo subisce il thaumazein, capisce cosa significa non sapere. Da tale consapevolezza deriva l’impulso alla filosofia e alla continua interrogazione socratica. Arendt conclude il saggio rivolgendosi ai filosofi contemporanei, i quali, se vorranno raggiungere una nuova filosofia politica in seguito al conflitto con la polis, dovranno “però assumere come oggetto del thaumazein la pluralità degli uomini, dalla quale sorge [...] l’intera sfera degli affari umani” (p. 62).
I due saggi critici di Adriana Cavarero e Simona Forti, in appendice al testo di Arendt, rappresentano un interessante ausilio alla riflessione sul saggio. Cavarero nel suo commento, Il Socrate di Hannah Arendt, si concentra sulla comparsa della personalità socratica in due particolari momenti della riflessione arendtiana, ripercorrendo anche le differenze originarie rispetto allo sviluppo platonico: la prima scena colloca Socrate all’origine di una “pratica filosofica e insieme genuinamente politica” (p. 73), e individua nell’antitesi tra il maestro e l’allievo la scissione della filosofia dalla sfera politica e la conseguente fuga del sophos da tale contesto; l’altra situazione riconosce in Socrate il fondatore di un modello di pensare critico, l’ideatore della coscienza moderna, intesa nei termini di un tribunale interiore in cui il soggetto si interroga e deve rendere conto di sé a se stesso.
 Se, però, nelle sue riflessioni Arendt ci ha convinto a difendere Socrate, Cavarero nel suo commento prende invece le parti di Platone, il quale è messo sotto inchiesta nel saggio arendtiano. Nelle pagine precedenti, infatti, ci siamo imbattuti nella disamina delle colpe metafisiche dell’allievo, che si possono riassumere in ultima analisi nel sacrificio di quella pluralità al cuore dell’insegnamento socratico a favore del totalitarismo dell’Uno, che si pone come l’oggetto supremo della conoscenza muta e contemplativa del filosofo. Cionondimeno, Cavarero ricorda al lettore che l’istante della contemplazione è sì presentato da Platone come la forma più elevata del pensiero, ma il filosofo ammette l’esistenza anche di altre articolazioni del conoscere, tra cui quella del “dialogo senza voce che l’anima fa con se stessa” (Soph. 263e). Tuttavia, Arendt sembra attribuire questo riconoscimento esclusivamente a Socrate, ma risulta evidente la presenza del dialogo silenzioso nell’interiorità dell’individuo anche nel contesto della riflessione platonica. La lezione che indubbiamente è doveroso trarre dall’insegnamento socratico, a discapito dell’allievo, è quella di “ripensare l’umanità, o forse pensarla per la prima volta nei suoi tratti concreti [...] registrare la pluralità che rende ciascun essere umano un essere unico, diverso da ogni altro” (p. 97).
Se, però, nelle sue riflessioni Arendt ci ha convinto a difendere Socrate, Cavarero nel suo commento prende invece le parti di Platone, il quale è messo sotto inchiesta nel saggio arendtiano. Nelle pagine precedenti, infatti, ci siamo imbattuti nella disamina delle colpe metafisiche dell’allievo, che si possono riassumere in ultima analisi nel sacrificio di quella pluralità al cuore dell’insegnamento socratico a favore del totalitarismo dell’Uno, che si pone come l’oggetto supremo della conoscenza muta e contemplativa del filosofo. Cionondimeno, Cavarero ricorda al lettore che l’istante della contemplazione è sì presentato da Platone come la forma più elevata del pensiero, ma il filosofo ammette l’esistenza anche di altre articolazioni del conoscere, tra cui quella del “dialogo senza voce che l’anima fa con se stessa” (Soph. 263e). Tuttavia, Arendt sembra attribuire questo riconoscimento esclusivamente a Socrate, ma risulta evidente la presenza del dialogo silenzioso nell’interiorità dell’individuo anche nel contesto della riflessione platonica. La lezione che indubbiamente è doveroso trarre dall’insegnamento socratico, a discapito dell’allievo, è quella di “ripensare l’umanità, o forse pensarla per la prima volta nei suoi tratti concreti [...] registrare la pluralità che rende ciascun essere umano un essere unico, diverso da ogni altro” (p. 97).Il saggio di Simona Forti, Letture socratiche. Arendt, Foucault, Patočka, è dedicato alle interpretazioni posteriori della figura di Socrate, in particolare, all’analisi dei tratti di quella “grande tribù del socratismo novecentesco della filosofia come forma di vita” (p. 100). Questa corrente individua in Socrate una testimonianza vivente di una condotta “che si singolarizza scegliendo per quanto possibile lo spazio indeterminato della libertà” (p. 100), distaccandosi da un’etica fondata su regole universali che definiscono a priori il bene e il male, delineandosi peraltro come una soggettività immanente che si assume la responsabilità delle azioni individuali di fronte all’altro e al soggetto stesso. In particolare, l’autrice individua un’affinità concettuale tra la prospettiva socratica sul daimon e la parresia e la riflessione di Hannah Arendt, Michel Foucault e Jan Patočka, commentatori novecenteschi del filosofo greco.
Se al centro della riflessione arendtiana vi è la scoperta del due-in-uno, al cuore dell’indagine di Foucault vi è, invece, la parresia, sulla quale Arendt non si sarebbe soffermata, secondo la lettura di Forti. La parresia può dischiudere uno spazio etico nuovo in cui l’interiorità si apre all’altro e alla collettività, delineandosi come una prassi politica in antitesi con l’adulazione e la retorica tipiche delle strutture di potere, dacché assume ad oggetto la verità.
 Per quanto concerne l’altra figura al centro del commento di Forti, Patočka, citato dallo stesso Foucault in un corso tenuto nel 1984, concepisce la cura di sé, dell’anima, come radice della cultura europea, nei termini di una pratica filosofica di continua riflessione e interrogazione del soggetto su se stesso, suscettibile di aprirsi alla prassi e così alla dissidenza nei confronti dei meccanismi di potere.
Per quanto concerne l’altra figura al centro del commento di Forti, Patočka, citato dallo stesso Foucault in un corso tenuto nel 1984, concepisce la cura di sé, dell’anima, come radice della cultura europea, nei termini di una pratica filosofica di continua riflessione e interrogazione del soggetto su se stesso, suscettibile di aprirsi alla prassi e così alla dissidenza nei confronti dei meccanismi di potere.
 In ultima analisi, ciò che unisce i tre volti novecenteschi nel loro confronto con Socrate è “la convinzione che l’azione politica [...] deve essere la manifestazione visibile di un’etica [...] l’effetto collaterale di un ethos, di una postura e di una condotta che si radicano saldamente nelle pieghe del ‘modo di vita’ del singolo” (p. 117). Ritornare a Socrate costituisce, dunque, un richiamo alla possibilità del soggetto di opporre resistenza alla forza delle circostanze, “è il nome della possibilità, del potere di ciascuno di resistere a un altro potere” (p. 123).
In ultima analisi, ciò che unisce i tre volti novecenteschi nel loro confronto con Socrate è “la convinzione che l’azione politica [...] deve essere la manifestazione visibile di un’etica [...] l’effetto collaterale di un ethos, di una postura e di una condotta che si radicano saldamente nelle pieghe del ‘modo di vita’ del singolo” (p. 117). Ritornare a Socrate costituisce, dunque, un richiamo alla possibilità del soggetto di opporre resistenza alla forza delle circostanze, “è il nome della possibilità, del potere di ciascuno di resistere a un altro potere” (p. 123).* Fonte: Discipline Filosofiche.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- OLTRE I CATTOLICISMI E OLTRE HEIDEGGER. «Che la mia opera, per quel tanto o poco che vale, non vada dispersa» (Gianni vattimo). Intervista (di A. Gnoli).26 ottobre 2020, di Federico La Sala
Straparlando
Gianni Vattimo
Ho rottamato il pensiero forte
di Antonio Gnoli (“Robinson - la Repubblica”, 28.12.2019) *
Ora che da un po’ ha superato gli ottant’ anni dice che non se li aspettava così. Dice che essendo stato un giovane brillante - per alcuni perfino un enfant prodige - che ha smosso le acque provinciali in cui di solito navighiamo, forse è un modo di pagare un conticino. A chi? Boh. Non lo sa. Dio e gli uomini hanno un modo strano di esercitare la giustizia: tu fai una cosa bella e ricevi un premio. Ne fai una brutta e paghi pegno.
Questo almeno in teoria. Ma quando sei vecchio, quando, diversamente da altri vecchi, senti il peso della materia che si disgrega, allora ti chiedi perché proprio a me? «Sai, ho fatto un sogno l’ altra notte», dice Gianni Vattimo. «Ho sognato che stavo giocando con la mia vecchiaia e che mi sentivo leggero. E bello come un tempo. Poi quando mi sono svegliato ho pensato: ma ero io quello? Ero proprio io? E se ero io che cazzo mi significava quel sogno?».
Partiamo se vuoi da questo interrogativo chi sei oggi?
«Non lo so, vorrei saperlo. Ci sono vari strati di me. Vari dolori. Alcuni lontani, altri recenti. I dolori raccontano la tua storia, la circoscrivono, a volte. Oppure l’ amplificano. E poi, ci sono i dolori della memoria e quelli del corpo».
Quali prevalgono in questo momento?
«Mi vedi, no? Faccio fatica a camminare. Quattro o cinque anni fa mi hanno diagnosticato un Parkinson. Allora che faccio? Provo a convivere con il signor Parkinson. Gli dico, beh vediamo di non farci troppo male. Io non dò fastidio a te e tu non ne dai a me. Poi scopro che quel signore lì è molto esigente. Paziente ma insidioso. Ti giuro che se fosse stato per me non l’ avrei mai invitato. Si è presentato senza neanche farsi annunciare, senza un biglietto da visita, senza un mazzo di fiori. Capisci?»
Capisco. Però siamo qui, nella tua casa, mentre parliamo e mangiamo quello che è stato apparecchiato a tavola. E non mi sembri così malandato.
«Non lo sono, è vero. Ti piace il risotto?».
Mi piace il risotto. Ma mi piacciono anche altre cose di te.
«Cosa ti piace? Scusa la curiosità».
Beh alcune cose che hai scritto sono state importanti per questo paese. Hai sdoganato Heidegger, ti sei inventato il "pensiero debole", e non hai mai tromboneggiato da accademico.
«Sai è stata la scuola di Luigi Pareyson da cui provengo a formarmi. Rigorosa ma anche molto appartata. Lo scelsi perché era il professore più giovane della facoltà. Esistenzialista e cattolico.
Amico di Karl Jaspers. Io, allora, ero sedotto da Adorno. Dai tedeschi che erano usciti dalla guerra.
Ma se lei vuole studiarli veramente si dedichi a Nietzsche, mi disse Pareyson. Era un personaggio complicato. Bisogna farsi le ossa con i maestri e poi lasciarli andare. Se non lo fai finisci nella gabbia».
Eri molto brillante?
«Credo di sì. Provengo da una famiglia dignitosa ma povera. Padre carabiniere. Madre sartina. Ho frequentato l’ Azione Cattolica. Posso dire che all’ università ero decisamente brillante».
Il tuo cattolicesimo ha conosciuto alti e bassi. Ora dove si colloca?
«Non lo so, onestamente non saprei collocarlo. Adoro questo papa che mi pare sia rimasto il solo anticapitalista in circolazione. Qualche tempo fa gli ho fatto avere il mio ultimo libro Essere e dintorni nella speranza che lo leggesse. Ci sono, infatti, diverse considerazioni sul cristianesimo».
E Francesco l’ ha letto?
«Letto non lo so, certo lo ha sfogliato. Tramite un amico comune, un argentino, Luis Liberman, gli è arrivato il libro. Mi ha telefonato per ringraziarmi del dono. E io gli ho spiegato che era un libro su Heidegger».
La tua ossessione.
«Bisogna pur vivere di qualche passione intellettuale. E poi come lui ha detto: soltanto un Dio ci può salvare».
Ma questo Dio dove lo andiamo a cercare?
«Certo non nelle costruzioni metafisiche e neppure in quelle mitologiche. Dio non può essere ispirato da ragioni teoretiche».
Tu hai scritto che "Essere e Tempo" - l’ opera più importante del primo Heidegger - rispondeva a una domanda storica e non a una esigenza astratta e universale. A questo pensi?
«L’ essere di cui parla Heidegger non è quello di cui discute la metafisica. È l’ evento. Dire evento significa che qualcosa accade. Dove? Nel linguaggio, nella storia, nel mondo. Dell’ evento non puoi dare una spiegazione scientifica, oggettiva. La nascita di Gesù non è dimostrabile. Eppure è un evento che accade nella storia ed è all’ origine della cristianità. Io mi sento tanto cristiano quanto heideggeriano. E tutto questo non ha niente a che vedere con la verità oggettiva. Per cui l’ unica ragione che mi consente di chiamarmi cristiano è perché non credo nell’ oggettività delle cose, non credo, come non crede Heidegger, nella metafisica».
Secondo te papa Francesco ha chiaro in testa questo tuo ragionamento?
«Non lo so e non lo pretendo. Però so che lui ha rimesso la Chiesa al centro di una discussione profonda. Mica facile, perché un corpaccione bimillenario non lo sposti facilmente. Le resistenze che il suo magistero incontra sono pazzesche».
È in corso un forte scontro religioso in seno allo stesso cristianesimo.
«C’ è una posta in gioco altissima. Né la scienza né la filosofia tout court sono in grado di vincere il piatto. Penso che Heidegger fosse consapevole di questo quando nella meditazione degli ultimi anni in maniera drammatica non vedeva soluzione umana al problema della desertificazione del mondo».
E affidava la salvezza a un Dio?
«Proprio così, nella direzione indicata da Lutero, e prima ancora da Paolo, per cui non sono le nostre opere che ci salveranno ma la grazia di Dio».
In questo modo viene meno la responsabilità dell’ atto umano. Puoi essere nazista o decidere di bruciare l’ Amazzonia tanto non dipende dalle tue opere la salvezza.
«Ma è proprio perché ti salvi che le tue opere avranno un senso tutt’ altro che nichilista. Siamo irresponsabili nella misura in cui saremo costretti a restare inautentici. E inautentico è il nostro mondo dominato dalla metafisica, dall’ oggettivazione, dal calcolo, dall’ utilitarismo, dalla tecnologia che tutto divora. Ci sarà un nuovo inizio? È ciò che Heidegger spera, ma non dipenderà dalla decisione dell’ uomo. Del resto, cose in parte analoghe le pensava Wittgenstein, almeno il Wittgenstein che si ribella a Russell e al pensiero anglosassone».
Ci sono due Heidegger come pure due Wittgenstein.
«Mi sono occupato della "svolta" di entrambi. Però Ludwig era certamente più tormentato. La frequentazione dei suoi amici analitici non lo aiutava. Era credente, frocio e pieno di sensi di colpa. Quando cede tutti i suoi beni alle sorelle lo fa anche perché ribolle di turbe mentali».
Tu hai mai avuto sensi di colpa?
«Ma sì, ogni volta che ti scompare una persona che ti è cara ti chiedi cosa hai fatto per essa. E perché gli sopravvivi».
Pensi a qualcuno in particolare?
«Penso ai miei due compagni di vita. Giampiero morto tragicamente di Aids e Sergio per un cancro ai polmoni. Sono stati rapporti bellissimi, importanti. Sergio morì in volo, tornavamo dagli Stati Uniti, aveva espresso il desiderio di vedere il museo di San Francisco. Spirò tra New York e Francoforte. È buffo andarsene mentre sei su un aereo e ho pensato che il cielo in quel caso era la via più breve per il paradiso. Mi chiedevi dei sensi di colpa».
Sì.
«Ho paura di essere diventato un po’ cinico. Se mi raccontano una sciagura il primo impulso è di pensare sì vabbè ma allora io, io che ne ho viste e passate di molto peggio che dovrei dire?».
Ti infastidisce la gente che si lamenta?
«Ma no, la sto ad ascoltare. Però loro che ne sanno della mia stanchezza, della mia vecchiaia che mi ha sorpreso come un ladro nella notte».
Ti viene mai il dubbio che come filosofo avresti potuto dare di più?
«Credo di aver smantellato, decostruito, rottamato buona parte del pensiero forte. Sulla scorta di Nietzsche e di Heidegger mi sono preso la briga di porre un freno alla filosofia come etica del dominio».
Eppure proprio Nietzsche con il superuomo e Heidegger con l’ adesione al nazismo hanno facilitato quel dominio.
«Ma il superuomo di Nietzsche non è volontà di potenza è l’ oltreuomo che libera se stesso e l’ Heidegger nazista si riduce a qualche frase di adesione allo spirito del tempo».
Non sei un po’ riduttivo?
«La giro in un altro modo: se li vuoi trattare come due fanatici sanguinari allora brucia pure le loro opere. Ma è questo che vogliamo? Ho trascorso dei lunghi periodi in Germania, lavorato con Gadamer, penso che la filosofia sia un’ esperienza ermeneutica. Non c’ è verità che non sia interpretazione».
Cosa vuoi dire?
«Che la verità è legata al linguaggio. E che non ci sono fatti ma solo interpretazioni».
Prima accennavi a Pareyson e alla sua scuola.
«Fui fortunato. Venimmo da lì io e Umberto Eco e poco dopo si aggiunsero Mario Perniola e Sergio Givone».
Però ognuno per la sua strada.
«Avevamo la libertà di scegliere. Con Umberto siamo restati amici. Facemmo insieme il concorso in Rai. Ci siamo frequentati fino all’ ultimo. Non so però se l’ ho davvero conosciuto. Per certi versi era imperscrutabile. Io non gli avevo mai rivelato le mie tendenze sessuali. Però una volta ebbi l’ impressione che mi prendesse in giro. Siccome ero con un amico mi disse, forse scherzando, ma allora ti sei deciso. Fu l’ unica volta che sfiorò l’ argomento. Dietro la sua grande estroversione c’ era molto riserbo».
Dovuto a cosa?
«Aveva orrore di dover parlare di sé. Credo che tutta la sua verve barzellettistica discendesse da questa cesura: il comico che uccide o rimuove una parte della vita. Del resto si può leggere perfino Il nome della rosa in questa chiave».
Hai mai avuto la tentazione del romanzo.
«Mi piace leggerli non scriverli».
Meglio la filosofia?
«Chi può dirlo? Se lo chiedi a uno scrittore ti ride dietro».
E tu?
«Non ho messo la mia vita nelle mani della filosofia. Semmai ho messo un po’ di filosofia nella mia vita. Sono obliquo come il volo degli uccelli».
Dove ti vorresti posare con il pensiero?
«Mi piacerebbe scrivere su cristianesimo e heideggerismo. Ho pensato di cominciare con una frase: se non fossi heideggeriano non sarei cristiano, e se non fossi stato cristiano non sarei stato heideggeriano. Ma ogni tanto mi vengono dei dubbi sull’ utilità di un discorso del genere».
Perché?
«A parte il peso o la fatica dell’ argomentazione, a chi interesserebbe? A volte mi metto davanti al computer e sto lì fisso, come un babbeo. La mia vita è fatta ormai di pause. Un sogno ce l’ ho».
Quale?
«Che la mia opera, per quel tanto o poco che vale, non vada dispersa».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DUE CITTADINE, UNITE CIVILMENTE, CON BAMBINO E IL "GRAN RIFIUTO" DI PILATO. Se il miglior interprete dei diritti non è la Corte ma il papa (di Massimo Villone).24 ottobre 2020, di Federico La Sala
Se il miglior interprete dei diritti non è la Corte ma il papa
Diritti. La pronuncia dei giudici costituzionali è pericolosa, perché indebolisce il principio che la Corte è argine ultimo e necessario proprio contro legislatore
di Massimo Villone (il manifesto, 23.10.2020)
È davvero uno scherzo della storia leggere nello stesso giorno di Papa Francesco e della Corte costituzionale. Il Papa apre alle coppie gay, e chiede una legge sulle unioni civili. Non sembra dubbio che, senza toccare il sacramento del matrimonio, dalle sue parole derivi un riconoscimento con pienezza di diritti, inclusa la filiazione. Mentre la Corte quei diritti li amputa.
Il fatto. A una coppia di donne, unita civilmente, nasce in Italia un figlio a seguito di fecondazione eterologa all’estero. La registrazione allo stato civile viene rifiutata. Nel giudizio conseguente viene sollevata dal Tribunale di Venezia una questione di legittimità costituzionale della legge sulle unioni civili e del decreto sugli atti dello stato civile. Il diritto.
La Corte si orienta per l’inammissibilità delle questioni sollevate. Il riconoscimento dello status di genitore alla cd madre intenzionale “non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale”. E dunque il diritto non esiste.
Le secche parole del comunicato chiudono la strada anche a interpretazioni secundum Constitutionem.
Al momento abbiamo solo il comunicato, e vedremo poi in dettaglio le motivazioni. Intanto possiamo dire che la Corte sembra aver sviluppato una allergia per i temi eticamente sensibili, con eccezioni per la fecondazione assistita. Cappato insegna, e certo la Corte sa bene che il rinvio al legislatore può tradursi nell’inerzia del medesimo.
Dobbiamo poi cogliere che oggi la Corte va oltre.
Al rinvio al legislatore si aggiunge la contestuale negazione di un diritto costituzionalmente protetto. Sul tema la Corte ha già balbettato in passato. Nella sentenza 138/2010 lesse nel matrimonio di cui all’articolo 29 della Costituzione la disciplina del codice civile del 1942, che ovviamente conosceva soltanto la coppia formata da due persone di sesso diverso. Ben si poteva invece dare una lettura evolutiva, che tenesse conto del nuovo.
Un recupero parziale è venuto poi dalla sent. 170/2014, sul cosiddetto divorzio automatico o imposto nel caso di cambio di sesso di uno dei coniugi. La Corte ha rinviato al legislatore, dichiarando però la incostituzionalità e affermando il diritto a una piena tutela giuridica della coppia del medesimo sesso.
Quella pronuncia ha avuto poi riscontro nella tormentata legge sulle unioni civili. Ma la Corte tiene oggi a precisare che la coppia omosessuale, pur riconosciuta dalla legge nella forma dell’unione civile, non ha gli stessi diritti della coppia eterosessuale unita in matrimonio. La Costituzione non garantisce che li abbia.
Si faccia una ipotesi di scuola. Una legge che limitasse forzosamente il numero dei figli consentiti nel matrimonio sarebbe incostituzionale. Mentre una legge che ponesse lo stesso limite a una coppia omosessuale unita civilmente potrebbe non esserlo.
Che ne è del nucleo incomprimibile dei diritti, di cui tanto abbiamo letto nella giurisprudenza costituzionale? E della razionalità, intesa come tutela contro distinzioni discriminatorie? Il presidio costituzionale diventa evanescente. Forse la stessa legge sulle unioni civili sarebbe in principio reversibile, se “l’interprete del sentire della comunità nazionale”, e cioè il legislatore maggioritario, maturasse un umore avverso.
L’odierna pronuncia della Corte, magari al di là delle intenzioni, è pericolosa, perché indebolisce il principio che la Corte è argine ultimo e necessario proprio contro il legislatore. E che dunque l’area della political question sottratta al suo scrutinio deve essere il più possibile ristretta.
“Il sentire della collettività” è sempre il pericolo più grande per i diritti e per le libertà, che sono appunto un argine contro quel sentire tradotto in potere politico e legislativo. Bisogna essere estremamente cauti nell’affermare che questa o quella fattispecie sfugge alla protezione costituzionale.
Non è un paese felice quello in cui ci si sente garantiti da un capo religioso piuttosto che dal massimo organo di giustizia costituzionale.
Ma potremmo suggerire che Papa Francesco tenga per i giudici della Corte un seminario di formazione, dal momento che più e meglio di loro si mostra consapevole del senso vero della Costituzione.
#COSTITUZIONE ED #EVANGELO: #DUESOLI. #PapaFrancesco apre la strada a #Dante2021: pagare il tributo a #Cesare «è un #dovere»; ma la #CorteCostituzionale con poco #spirito di #Salomone (di fronte a #due cittadine, unite civilmente, con bambino) fa "per viltade il #granrifiuto".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MATRIMONIO, "NATURA DELLE COSE" E UNIONI CIVILI. Papa Francesco: «Non scherziamo con la verità» (di Lucia Capuzzi).23 ottobre 2020, di Federico La Sala
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!!
- «Matrimonio è un termine che ha una storia. Da sempre, nella storia dell’umanità e non solo della Chiesa, viene celebrato tra un uomo e una donna», afferma Francesco in Dio è un poeta, edito nel nostro Paese da Rizzoli. E aggiunge: «È una cosa che non si può cambiare. È la natura delle cose, è così. Chiamiamole unioni civili. Non scherziamo con la verità» (Cfr. Il punto. Coppie omosessuali, sì alla tutela civile ma niente confusione col matrimonio di Lucia Capuzzi, Avvenire, venerdì 23 ottobre 2020).
Il punto.
Coppie omosessuali, sì alla tutela civile ma niente confusione col matrimonio
Tante reazioni alle parole del Papa nel docufilm “Francesco”. Parla Fernández arcivescovo argentino: Sin da quando era cardinale arcivescovo di Buenos Aires, Bergoglio ha distinto i due piani
di Lucia Capuzzi (Avvenire, venerdì 23 ottobre 2020)
«Ciò che dobbiamo fare è una legge sulla convivenza civile, hanno diritto a una forma di tutela legale. L’ho già sostenuto». Al di là delle forzature mediatiche, l’opinione di Jorge Mario Bergoglio sulle coppie omosessuali non è cambiata negli ultimi dieci anni.
La frase riportata nel documentario di Evgeny Afineevsky ricalca quanto già espresso nel 2010 quando, come arcivescovo di Buenos Aires, si trovò ad affrontare l’infuocato dibattito sulle nozze gay, legge fortemente voluta dal governo dell’allora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ricordarlo non sono solo accreditate fonti giornalistiche di quell’epoca, tra cui il biografo ufficiale Sergio Rubín.
Ieri, in un messaggio su Facebook, monsignor Victor Manuel Fernández, arcivescovo di La Plata, teologo e profondo conoscitore del pensiero bergogliano, ricostruisce la vicenda, sottolineando come per papa Francesco, prima e dopo l’elezione al soglio pontificio, si devono distinguere due piani.
Da una parte c’è il «matrimonio», termine con un significato preciso, applicabile solo a un’unione stabile tra una donna e un uomo, aperta alla vita. «Questa unione è unica, perché implica la differenza tra l’uomo e la donna, uniti da un rapporto di reciprocità e arricchiti da questa differenza, naturalmente capace di generare vita», spiega monsignor Fernández. Qualunque altra unione simile richiede, dunque, una denominazione differente.
Unioni o convivenza civile, appunto. «Jorge Mario Bergoglio ha sempre riconosciuto, pur senza necessità di definirli matrimonio, l’esistenza di legami molto stretti fra persone dello stesso sesso, che vanno al di là del mero piano sessuale, ma sono alleanze intense e stabili. Le persone si conoscono a fondo, condividono lo stesso tetto per molto tempo, si prendono cura e si sacrificano l’uno per l’altro», afferma l’arcivescovo di La Plata. In caso di malattia grave o morte, uno dei due può desiderare i suoi beni all’altro o che sia quest’ultimo ad essere consultato invece di un familiare. «Tutto ciò può essere contemplato da una legge» sulle «unioni civili o normativa di convivenza civile, non matrimonio».
A tal proposito, monsignor Fernández conferma quanto già riportato dai media dieci anni fa. Ovvero che, durante il dibattito sul cosiddetto matrimonio igualitario in Argentina, il cardinal Bergoglio sostenne tale posizione durante un incontro ad hoc con l’episcopato: la maggioranza, però, si oppose. La questione era già emersa subito il conclave del 2013. Da allora, il successore di Pietro ha sempre mostrato sensibilità e attenzione pastorale nei confronti delle persone omosessuali. Certo, nel docu-film di Afineevsky, Francesco torna espressamente sulla questione delle unioni civili e ripropone, da Papa, quanto già affermato dieci anni fa. Nemmeno questo, però, è un inedito assoluto.
Nel libro che raccoglie le conversazioni con il sociologo Dominique Wolton, pubblicato in Francia nel 2017 e in Italia l’anno successivo, c’è già un accenno al riguardo. «Matrimonio è un termine che ha una storia. Da sempre, nella storia dell’umanità e non solo della Chiesa, viene celebrato tra un uomo e una donna», afferma Francesco in Dio è un poeta, edito nel nostro Paese da Rizzoli. E aggiunge: «È una cosa che non si può cambiare. È la natura delle cose, è così. Chiamiamole unioni civili. Non scherziamo con la verità» .
Il documentario Francesco, insignito ieri, nei giardini vaticani, del premio Kinéo, non contiene, dunque, verità sconvolgenti.
Del resto non era questo l’obiettivo dell’autore, ebreo non praticante di origini russe. Attraverso la raccolta di testimonianze e immagini, il regista cerca di narrare le ferite del mondo: le guerre, l’esodo infinito a cui sono costrette migliaia di persone, i muri vecchi e nuovi, fisici e mentali che separano gli uni dagli altri. Il racconto segue il Papa nei suoi viaggi, da Lampedusa a Manila, da Ciudad Juárez a Santiago.
 Il racconto su Francesco, spiega Afineevsky, però, piano piano, si è trasformato in un film «sull’umanità che commette errori, fatta di peccatori...». La chiave è contenuta in una frase di Oscar Wilde cara al Papa e riportata nel filmato: «Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro».
Il racconto su Francesco, spiega Afineevsky, però, piano piano, si è trasformato in un film «sull’umanità che commette errori, fatta di peccatori...». La chiave è contenuta in una frase di Oscar Wilde cara al Papa e riportata nel filmato: «Ogni santo ha un passato e ogni peccatore ha un futuro».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
A FREUD (Freiberg, 6 maggio 1856 - Londra, 23 settembre 1939), GLORIA ETERNA !!! IN DIFESA DELLA PSICOANALISI.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA : VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- OLTRE IL RELATIVISMO ETICO. Io esisto perché tu esisti, per farla finita con il colonialismo (di Andrea Staid).1 ottobre 2020, di Federico La Sala
Io esisto perché tu esisti, per farla finita con il colonialismo
di Andrea Staid *
Come donne e uomini nati o cresciuti nella parte occidentale di questo mondo, quando guardiamo alle pratiche culturali e politiche degli “altri” dobbiamo porre molta attenzione a non comportarci da etnocentrici e pensare che la nostra visone di società, nel mio caso libertaria, sia unica ed esportabile in tutto il mondo. Credo che anche in questo caso, per affinare il nostro sguardo sull’alterità culturale, l’antropologia ci possa venire in aiuto con l’approccio relativista.
Ma cos’è il relativismo? È una teoria formulata a partire dal particolarismo culturale di Franz Boas e dall’antropologo statunitense Melville Jean Herskovits secondo i quali, considerato il carattere universale della cultura e la specificità di ogni ambito culturale, ogni società è unica e diversa da tutte le altre, mentre i costumi hanno sempre una giustificazione nel loro contesto specifico. Questo significa che i bisogni umani universali possono essere soddisfatti con mezzi culturalmente e politicamente diversi. Direi che su questo le lettrici e i lettori di Matrika non dovrebbero avere dubbi.
Quindi l’idea che gli elementi di una cultura debbano essere compresi e analizzati a partire dal contesto in cui agisce la specifica cultura porta alla conclusione che non si può considerare una cultura superiore o inferiore ad un’altra. Anche su questo non dovremmo avere dubbi.
È stato l’antropologo Melville Herskovits ad affermare, sulla scia dei precedenti fondamenti espressi da Franz Boas, che la specificità di ogni ambito culturale non consente analisi di carattere generale sul confronto tra culture.
Questa visione del mondo culturale degli “altri” ci mette in crisi e più che certezze fa nascere dubbi, ma questo non ci deve spaventare; l’importante è far diventare questi dubbi la possibilità di risposte nuove, la creazione di corpi politici ibridi e inediti.
Dobbiamo farla finita con il pericoloso e dannoso sguardo coloniale [1] che ancora ci attanaglia, dobbiamo essere in grado di fare i conti con il colonialismo e liberare i nostri sguardi troppo spesso eurocentrici e giudicanti. Per decostruire i nostri immaginari coloniali ci possono aiutare gli studi (post)coloniali, semplificando, potremmo dire che si raccolgono attorno a tre distinti filoni d’indagine critica: il primo, inaugurato da Orientalism di Edward Said nel 1978 ed ispirato alla teoria del discorso di Michel Foucault, si fonda sulla interpretazione del colonialismo come formazione discorsiva alimentato dalle istituzioni materiali dell’Impero; il secondo filone affonda nel pensiero decostruzionista e, come chiarisce Gayatri C. Spivak nel 1990 in The Post-colonial Critic, definisce il discorso coloniale come il prodotto retorico degli assiomi imperialistici che attengono in particolare alle questioni di razza e di genere; il terzo filone, il cui fondamento va ricercato nella psicoanalisi lacaniana che Homi K. Bhabha rilancia in The Location of Culture del 1994, è caratterizzato da una analisi della formazione del soggetto coloniale e dei processi di ibridazione nei quali colonizzati e colonizzatori sono coinvolti.
Anche le antropologhe e gli antropologi hanno sviluppato pratiche e teorie post-coloniali e non egemoniche, dove l’altro non era più una stranezza culturale da studiare ma un soggetto interlocutore con il quale rapportarsi.
Per questo ancora oggi dal mio punto di vista il concetto di relativismo culturale è imprescindibile sul campo. Trovo fondamentale ricordare che è stata una donna, Margaret Mead, che grazie alla sua attività divulgativa, la cui opera più celebre, L’adolescente in una società primitiva, può essere considerata paradigmatica dell’utilizzo di argomentazioni di carattere relativistico come strumento di critica della società occidentale.
 Il testo è frutto di una ricerca nelle isole Samoa, nella quale l’autrice sosteneva che le difficoltà personali incontrate dalle adolescenti occidentali, non sono universali e necessarie, ma contingenti e generate prevalentemente dalle costrizioni e dalle imposizioni che gli elementi più tradizionalisti e moralistici della cultura occidentale impongono. Le adolescenti samoane, al contrario, sarebbero lasciate libere di giungere alla maturità fisica, identitaria, sessuale, sociale, senza condizionamenti eccessivi e non soffrirebbero delle crisi e delle difficoltà incontrate dalle occidentali. Questo è un caso particolare, ma paradigmatico per capire il concetto relativista.
Il testo è frutto di una ricerca nelle isole Samoa, nella quale l’autrice sosteneva che le difficoltà personali incontrate dalle adolescenti occidentali, non sono universali e necessarie, ma contingenti e generate prevalentemente dalle costrizioni e dalle imposizioni che gli elementi più tradizionalisti e moralistici della cultura occidentale impongono. Le adolescenti samoane, al contrario, sarebbero lasciate libere di giungere alla maturità fisica, identitaria, sessuale, sociale, senza condizionamenti eccessivi e non soffrirebbero delle crisi e delle difficoltà incontrate dalle occidentali. Questo è un caso particolare, ma paradigmatico per capire il concetto relativista.L’impegno dell’antropologia, soprattutto nel periodo che va dai suoi esordi fino alla seconda guerra mondiale produce come conseguenza il superamento dell’antitesi tradizionale tra la superiorità della cultura europea e l’inferiorità degli altri popoli. Sono convinto che il pensiero libertario deve abbandonare completamente un approccio etnocentrico; non può pensarsi unico, giusto ed esportabile tout court nel pianeta, dobbiamo comprendere l’importanza di uno sguardo relativista. Il relativismo culturale è una risposta all’etnocentrismo e nega l’esistenza di un’unità di misura universale per la comprensione dei valori culturali e politici, poiché ogni cultura è portatrice di valori e norme che non hanno validità al di fuori della cultura stessa.
L’emergenza del relativismo culturale ha facilitato una comprensione più profonda e meno superficiale delle culture differenti da quella occidentale. Ma facciamo attenzione, quello che io propongo è un metodo per comprendere l’altro, non una sospensione totale del giudizio e del posizionamento politico dell’individuo. Per questo è molto importante fare una distinzione tra relativismo culturale e relativismo etico; il primo è quello che io propongo per meglio comprendere la cultura e la politica degli “altri”.
Il relativismo culturale (metodologico) va tenuto distinto dal relativismo etico: mentre il primo costituisce un approccio metodologico, indica cioè quale debba essere la metodologia corretta per analizzare i fenomeni culturali, il secondo si riferisce ad un atteggiamento di sospensione del giudizio etico e morale circa usanze, politiche e costumi presenti nelle varie culture.
 Per il relativismo etico, vale il principio di equivalenza di ogni prescrizione morale; se infatti non esiste una verità assoluta di riferimento in base a cui poter distinguere il bene dal male, allora tutto è lecito, affermazione che pretende di porsi a sua volta come una norma assoluta, a dispetto del presunto carattere “non prescrittivo” del relativismo. Non è tutto relativo, al contrario; ma per comprendere gli “altri” dobbiamo relativizzare il nostro sguardo. (Andrea Staid Blog)
Per il relativismo etico, vale il principio di equivalenza di ogni prescrizione morale; se infatti non esiste una verità assoluta di riferimento in base a cui poter distinguere il bene dal male, allora tutto è lecito, affermazione che pretende di porsi a sua volta come una norma assoluta, a dispetto del presunto carattere “non prescrittivo” del relativismo. Non è tutto relativo, al contrario; ma per comprendere gli “altri” dobbiamo relativizzare il nostro sguardo. (Andrea Staid Blog)1 Per colonialismo si intende la politica di conquista, invasione e depredazione di territori e risorse (materiali e umane) attuata dalle potenze europee a partire dal XV secolo. Indica inoltre l’insieme dei principi a sostegno di tale politica e, infine, l’organizzazione del sistema di dominio. Lo sviluppo del colonialismo può essere distinto in due fasi: la prima, che parte dal XV secolo fino alla metà del XIX secolo; la seconda, che parte dagli ultimi decenni del XIX secolo e termina a metà degli anni Settanta del Novecento con il crollo del sistema coloniale portoghese. Purtroppo la mentalità colonialista e i soprusi economici e politici colonialisti delle potenze occidentali sono ancora in atto anche se formalmente e storicamente il periodo coloniale dovrebbe essere concluso.
* Fonte: Matrika.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "RITORNARE" A FREUD E AD ALESSANDRO MANZONI: "SAPERE AUDE!".9 settembre 2020, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI, E POLITICA
ALTRO CHE LACAN, "RITORNARE" A FREUD E AD ALESSANDRO MANZONI...
FORSE è meglio riprendere il filo del discorso dalle riflessioni “fallimentari” di Freud sul “caso clinico di Dora” o, se si vuole e meglio, della “Madonna Sistina”(cfr. S. Freud, “Frammento di un’analisi d’isteria”, 1901/1905) e, rianalizzando la ‘possessione’ di Lacan per “L’origine del mondo” di Courbet, ripartire dalle indicazioni critiche di Alessandro Manzoni sul caso della monaca di Monza e di un’antropologia zoppa e cieca - edipica, appunto - fondata sull’ordine simbolico della madre. Vogliamo o non vogliamo uscire dalla caverna?! O no?! Sapere aude!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Il virus è arrivato del tutto inaspettato. L’amore è lo stesso (di Jeanette Winterson).27 agosto 2020, di Federico La Sala
L’amore ai tempi del coronavirus
di Jeanette Winterson *
- La grande scrittrice inglese ha scritto in esclusiva per «Vanity Fair» questo racconto, che parla della forza dell’amore, dei suoi effetti dirompenti e di come, grazie all’amore, si possa scacciare la paura
Il virus è arrivato del tutto inaspettato. Stavamo vivendo come al solito e, all’improvviso, le nostre esistenze sono cambiate. Ciò su cui avevamo fatto affidamento fino a quel momento era scomparso. Una situazione nuova, strana.
L’amore è lo stesso. Abbiamo le nostre vite in ordine e, poi, compare qualcuno, e il mondo viene messo sottosopra, capovolto. Abbiamo un bambino e niente è più come prima. Perdiamo qualcuno che amiamo e la vita diventa l’ombra di ciò che era.
L’amore ha effetti dirompenti. Quando bruciano le foreste, un metodo per spegnere il fuoco è con il fuoco, contenere l’incendio creandone uno nuovo. Proprio adesso, nel momento in cui le nostre vite sono state interrotte da un nemico che sfugge alla nostra vista, tranne che per gli effetti che determina, possiamo ricordare che anche l’amore è un alleato che sfugge alla nostra vista, non lo possiamo vedere, se non che per gli effetti che determina.
L’amore può arginare la nostra paura. Con l’amore, non siamo soli, isolati o sperduti. Quando troviamo l’amore, in ognuna delle sue forme, non ci preoccupiamo di ciò che interrompe. Con un bambino appena nato non dormiamo, non possiamo più lavorare, fare quello che ci piace. Con qualcuno che amiamo, siamo in grado di pensare solo a quella persona. Un nuovo amico o un nuovo interesse sottrae tempo e attenzione da quello che c’era già, eppure ce la caviamo piuttosto bene. Spesso anche meglio di prima.
L’amore che conosciamo ci rende resilienti. L’amore che c’è in questo momento nelle nostre vite ci dà forza. È il momento di rendere l’amore ancora più grande, di condividerlo con gli altri, così che nessuno sia solo.
Se ti sembra che non tu non stia ricevendo amore, allora dallo tu. E questo comprende dare amore a noi stessi. Pulire la casa può essere un’incombenza o un atto d’amore. Cucinare un pasto può essere un peso o tutto l’amore di cui puoi cibarti. Vestirti bene per te stesso non è suonare la lira mentre Roma brucia, è un atto di rispetto verso noi stessi. C’è una grossa differenza tra amare se stessi ed essere egoisti. Quando ci amiamo nel modo in cui potremmo amare un caro amico, siamo anche più bravi ad amare gli altri.
Sono cresciuta in una famiglia religiosa. C’erano degli svantaggi: una mentalità chiusa, pregiudizi, disinteresse verso i cambiamenti sociali. Ma alcune cose erano comprese meglio di quanto lo siano nel mondo moderno e laico. La Bibbia ci insegna questo: l’amore perfetto scaccia la paura. Significa che l’amore è un antidoto contro la paura. Sappiamo sulla base delle nostre esperienze che quando amiamo qualcuno siamo coraggiosi in suo nome. Facciamo sacrifici e assumiamo rischi. E ci sentiamo protetti dall’amore degli altri. Il vantaggio psicologico che ci dà l’amore non può essere mai sopravvalutato. L’amore ti fa bene. Soprattutto in tempi di paura.
C’era qualcos’altro appeso al muro di casa: l’amore è forte come la morte. È un’affermazione importante. Se la esaminiamo, ci rendiamo conto che l’amore è ciò che sopravvive alla morte fisica degli altri. Continuiamo ad amare qualcuno anche quando se n’è andato. E se scaviamo più a fondo in questa idea, capiamo che l’amore può opporsi al desiderio di morte che tutti, ogni tanto, proviamo. Non parlo di suicidio, ma di auto-sabotaggio, di certi comportamenti distruttivi nei quali ci ritroviamo impigliati. Amarci un po’ meglio, insieme all’amore degli altri che ci protegge, combatte la negatività che può sopraffarci.
Proprio ora dobbiamo liberare amore come colombe sopra la città. Lasciare che l’amore atterri nelle piazze, sui balconi, alle finestre, sulle spalle di tutti. Amore è il messaggero e il messaggio. Fatelo uscire. Portatelo a casa. L’amore è il meglio di noi.
*Jeanette Winterson è una scrittrice inglese, autrice, tra i tanti, di Non ci sono solo le arance (Mondadori, 1999) e Perché essere felice quando puoi essere normale? (Mondadori, 2012), che in Italia hanno avuto grande successo. Il suo ultimo libro si intitola Frankissstein (Mondadori, 2019).
*Fonte: VF, 23 aprile 2020
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA, CRISTOLOGIA ED ECCLESIOLOGIA: "CHI" BATTEZZA "CHI".6 agosto 2020, di Federico La Sala
Papa Francesco: non valido battesimo con formula ’noi battezziamo’
La Congregazione per la Dottrina della Fede interviene per fermare la ’creatività’ di alcuni sacerdoti
di Redazione ANSA *
CITTA DEL VATICANO. La Congregazione per la Dottrina della Fede interviene dunque per fermare la ’creatività’ di alcuni sacerdoti che cambiano le formule dei riti dei sacramenti pensando di migliorarle. "Recentemente vi sono state celebrazioni del Sacramento del Battesimo amministrato con le parole: ’A nome del papà e della mamma, del padrino e della madrina, dei nonni, dei familiari, degli amici, a nome della comunità noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’. A quanto sembra, la deliberata modifica della formula sacramentale - riferisce la Congregazione per la Dottrina della Fede - è stata introdotta per sottolineare il valore comunitario del Battesimo, per esprimere la partecipazione della famiglia e dei presenti e per evitare l’idea della concentrazione di un potere sacrale nel sacerdote a discapito dei genitori e della comunità".
 Ma l’"io", che il sacerdote deve pronunciare ha un valore dottrinale ben preciso: "segno-presenza dell’azione stessa di Cristo". "Nel caso specifico del Sacramento del Battesimo, il ministro non solo non ha l’autorità di disporre a suo piacimento della formula sacramentale, per i motivi di natura cristologica ed ecclesiologica sopra esposti, ma non può nemmeno dichiarare di agire a nome dei genitori, dei padrini, dei familiari o degli amici, e nemmeno a nome della stessa assemblea radunata per la celebrazione", spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede.
Ma l’"io", che il sacerdote deve pronunciare ha un valore dottrinale ben preciso: "segno-presenza dell’azione stessa di Cristo". "Nel caso specifico del Sacramento del Battesimo, il ministro non solo non ha l’autorità di disporre a suo piacimento della formula sacramentale, per i motivi di natura cristologica ed ecclesiologica sopra esposti, ma non può nemmeno dichiarare di agire a nome dei genitori, dei padrini, dei familiari o degli amici, e nemmeno a nome della stessa assemblea radunata per la celebrazione", spiega la Congregazione per la Dottrina della Fede.Ora si apre la questione dei battesimi celebrati con questo rito errato. Al quesito "Coloro per i quali è stato celebrato il Battesimo con la suddetta formula devono essere battezzati in forma assoluta?", la risposta del Vaticano è: "affermativamente". "Negativamente" è la risposta che si dà al quesito principale: "È valido il Battesimo conferito con la formula: ’Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’?".
In pratica i battesimi con la formula ’noi’ è come se non fossero mai stati fatti. Anche se comunque nel Catechismo della Chiesa Cattolica - secondo quanto spiegato da esperti in Vaticano - potrebbe trovarsi una via d’uscita per evitare il ’ripetersi’ del sacramento. Anche perché senza il Battesimo, a cascata non sono validi neanche gli altri sacramenti, dalla Cresima alla Comunione, dal Matrimonio alla Confessione. Nel Catechismo si stabilisce infatti che "Dio ha legato la salvezza al sacramento del Battesimo, tuttavia egli non è legato ai suoi sacramenti". Sempre nel Catechismo ci sono aperture per i non battezzati: "Ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio come la conosce, può essere salvato". (ANSA).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DELLA LOGICA DELL’INCESTO E DEL FEMMINICIDIO. LA LEZIONE DELLA SOCIOLOGA DIANA RUSSELL.30 luglio 2020, di Federico La Sala
È morta Diana Russell, la sociologa e criminologa che coniò il concetto di femminicidio*
Diana E. H. Russell, attivista, studiosa e scrittrice femminista di fama mondiale, è morta il 28 luglio a Oakland, in California. Aveva 81 anni. A lei, sociologa e criminologa, si deve l’invenzione e la diffusione del termine femminicidio, diventato di uso comune negli ultimi anni per identificare chiaramente i crimini contro le donne - una battaglia a cui Russell ha dedicato la sua vita - ma da lei coniato già a metà degli anni Settanta.
Nata il 6 novembre 1938 a Città del Capo, in Sudafrica, Russell è cresciuta in una famiglia di sei figli, con padre sudafricano e madre britannica. Dopo la laurea all’Università di Città del Capo e la specializzazione in sociologia alla London School of Economics di Londra, nel 1961 diventò ricercatrice alla Harvard university dove prima studiò la nozione di rivoluzione, in particolare ispirata dalla sua partecipazione alla lotta contro l’apartheid in Sudafrica, e poi si dedicò alle indagini sociologiche sui crimini sessuali commessi contro le donne. Dal 1970 ha insegnato sociologia delle donne al Mills College di Oakland. Russell nel 1993 ha fondato Women United Against Incest, un’associazione che sostiene le vittime dell’incesto. Ha anche ideato il primo programma televisivo in Sudafrica dove le donne vittime di abusi raccontano le loro esperienze e condotto battaglie contro la pornografia.
E’ stato nel 1976 che Russell ha definito per la prima volta "l’uccisione di femmine da parte dei maschi in quanto femmine" come "femminicidio", mettendo in luce la valenza ’politicà della parola che voleva attirare l’attenzione sulla misoginia alla base dei crimini contro le donne. II termine si affermò all’interno nella campagna per la costruzione di un Tribunale internazionale sui crimini contro le donne, che culminò con un meeting a Bruxelles per la denuncia di tutte le forme di discriminazione e oppressione subite dalle donne nel mondo. E’ del 1992 la sua antologia "Femicide: The Politics of Woman Killing".
Su Facebook e Twitter sono tanti i gruppi femministi e le singole donne a ricordare il suo impegno civile. La ricorda su Facebook anche Valeria Valente, senatrice Pd e presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio : "Diana E. H. Russell, la sociologa femminista che ha coniato la parola "femminicidio", ci ha lasciati martedì all’età di 81 anni, dopo aver dedicato la sua vita intera allo studio dei crimini contro le donne. E’ stata la prima donna a identificare un termine preciso per un fenomeno che era (ed è) così radicato nella nostra società, da essere quasi irriconoscibile. Dare un nome, ha significato riconoscerne l’esistenza. È stato il punto di partenza per iniziare a lottare. E noi, anche con la Commissione di inchiesta del Senato sul fenomeno del femminicidio e della violenza di genere, continueremo la nostra battaglia. Grazie Diana E. H. Russell. Che la terra ti sia lieve".
*la Repubblica, Le Storie, 30.072020 (ripresa parziale).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Uscire dal letargo e dal sonnambulismo delle "nozze di eros e caritas"!6 luglio 2020, di Federico La Sala
Uscire dal letargo "teologico" e "filologico" e dalla notte «in cui tutte le vacche sono nere»! La mistica dell’Amore (Deus charitas est), o quella di "Mammasantissima" e di "Mammona" ("Deus caritas est")?! *
- CHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád.
- Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729)
Spiritualità.
Mistica cristiana: le nozze di eros e caritas
I Meridiani pubblicano il primo di tre volumi dedicati alla mistica cristiana. L’incontro con Dio supera ogni limite, fisico e linguistico, e si configura come esperienza sensibile di un amore totale
di Rosita Copioli (Avvenire, mercoledì 1 luglio 2020)
La Mistica Cristiana (Mondadori, I Meridiani, pagine. LXXXVIII+1624, euro 70,00), è il primo dei tre volumi di una vastissima opera - estesa dalle origini ai nostri giorni - ideata dieci anni fa e curata da Francesco Zambon, su ’impulso’ di Pietro Citati. Questo libro, curato da Zambon con Marco Rizzi, Sabino Chialà, Boghos Levon Zekiyan, comprende la mistica tardogreca e bizantina, siriaca, armena, latina e italiana medievale; il secondo volume presenterà la mistica tedesca e fiamminga, francese, italiana moderna; il terzo la mistica iberica (spagnola, portoghese e catalana), inglese e americana, russa, svedese. Nessun progetto ha avuto la medesima ampiezza, né pari cura filologica e critica: nemmeno i Mistici occidentali curati da Elémire Zolla; e altre pregevoli sillogi sono parziali.
Le radici sono ebraiche - nel Cantico dei Cantici, il testo più ardente e complesso dell’amore umano e divino - e greche: nel Fedro e nel Simposio di Platone, dove la ricerca della conoscenza diviene quella del bene e del bello, l’intelletto sale verso il divino: la mente si unisce allo slancio erotico, la mania che porta all’estasi: invasa da una luce alla quale tenderà tutta la tradizione occidentale fino al Rinascimento, e oltre: da Plotino, per il quale la contemplazione è superiore all’azione poiché permette la visione del vero, a Proclo; da Apuleio a Tasso, i poeti barocchi, i romantici, Yeats, Ungaretti, Luzi, Milosz.
La potenza della vista interiore è previsione e profezia. Lo afferma già Esiodo, e poi Saffo e Platone, seguiti da sant’Agostino e Dante: il poeta sprofonda nella memoria bevendo l’acqua di vita di Oceano, e lascia che il soffio del dio spiri dentro di lui, investendolo del suo nume sconvolgente. «Entra nel petto mio, e spira tue / sì come quando Marsia traesti / de la vagina de le membra sue». È il solo modo per riceverne il barlume, per glorificarlo: «O divina virtù, se mi ti presti / tanto che l’ombra del beato regno / segnata nel mio capo io manifesti».
 Il mistico ricapitola ogni passaggio del Verbo incarnato e dello Spirito Santo che permette - osano i più temerari - di diventare Dio, trascinando con sé l’intera creazione. La trasfigurazione, la passione, la morte sulla croce di Gesù, il suo corpo martoriato sono lo strumento-specchio per rivivere Gesù in anima-spirito-corpo, oltrepassando i ’sensi spirituali’. Francesco nutre nelle viscere il sole - Cristo. Dalle mani e dai piedi spuntano chiodi di carne, sul costato si apre la ferita di Cristo.
Il mistico ricapitola ogni passaggio del Verbo incarnato e dello Spirito Santo che permette - osano i più temerari - di diventare Dio, trascinando con sé l’intera creazione. La trasfigurazione, la passione, la morte sulla croce di Gesù, il suo corpo martoriato sono lo strumento-specchio per rivivere Gesù in anima-spirito-corpo, oltrepassando i ’sensi spirituali’. Francesco nutre nelle viscere il sole - Cristo. Dalle mani e dai piedi spuntano chiodi di carne, sul costato si apre la ferita di Cristo.
 Angela da Foligno aderisce al Crocifisso con i sensi dell’eros totale: «Tu sei me e io sono te». La mente di Iacopone da Todi, «En Cristo trasformata, è quasi Cristo, /cun Deo conionta tutta sta devina». Chi osa tanto, non teme la sintassi, scardina ogni figura e senso. Se fa miracoli, sfida la gravità e si innalza dal suolo, come Doucelina di Digne, altri aboliscono gli intermediari con Dio nel linguaggio, come Caterina Fieschi: «Il mio Mi è Dio, io non conosco altro Mi che esso Dio mio».
Angela da Foligno aderisce al Crocifisso con i sensi dell’eros totale: «Tu sei me e io sono te». La mente di Iacopone da Todi, «En Cristo trasformata, è quasi Cristo, /cun Deo conionta tutta sta devina». Chi osa tanto, non teme la sintassi, scardina ogni figura e senso. Se fa miracoli, sfida la gravità e si innalza dal suolo, come Doucelina di Digne, altri aboliscono gli intermediari con Dio nel linguaggio, come Caterina Fieschi: «Il mio Mi è Dio, io non conosco altro Mi che esso Dio mio».I mistici non hanno paura di niente, né del pudore, né di “ardiri” che il volgo deride: come i patriarchi della Bibbia, variano la metafora del latte della sapienza, con una passione tenerissima. Nel II secolo in Siria, un’Ode di Salomone, e Clemente Alessandrino suggono i seni del Padre e le dolci mammelle di sposa di Gesù; nel X secolo Gregorio di Narek, autore di inni inarrivabili al Cristo glorioso, invoca «comunione che distilla latte»: siamo in Armenia, dove la teologia del sacerdozio di tutti i fedeli - i corpi sono templi e altari - renderà possibile il sacrificio dell’intero popolo: il “Martirio armeno”. Misakh Metzarents (1886-1908) ne è l’ultimo fiore: «Nella notte discende ancora il ruscello di luce, / una goccia di latte della tua santità divenuta un mare; / e vedi, o Madre di Dio, ecco sto diventando bambino».
Come diceva san Tommaso d’Aquino, la mistica è la Cognitio Dei experimentalis, che Jean Gerson esplica: «Theologia mistica est cognitio experimentalis habita de Deo per amoris unitivi complexum». Ma è la più abissale delle imprese gnoseologiche e amorose. Per la “teognosia” dell’ombra, che deriva da Plotino e si distanzia da seguaci di Gesù come Giovanni e Paolo, e Agostino, mai giungeremo a conoscere Dio. La sua trascendenza rispetto a ciò che è, e all’essere stesso, è superessentialis: Dio non può essere conosciuto, descritto, visto, nemmeno dagli angeli e dai santi. Di Dio non si può parlare né in forma positiva, né in forma negativa. Ma la forma negativa si avvicina di più al suo mistero. Lo si contempla tra luce e tenebra.
Scrive Zambon: «Anche nella vita beata, al termine del reditus di tutta la creazione nel seno del Verbo, Dio sarà conoscibile solo attraverso delle mediazioni, delle teofanie (in greco, “manifestazioni, immagini di Dio”)». La teofania segue i gradi della contemplazione, della deificazione (theosis), e coincide con l’unione mistica. Ricorre alle immagini, al loro fantasma, alla fantasia: l’“alta fantasia” di Dante. La docta ignorantia fa apparire Chi è superiore alla Luce come tenebra, caligine, nube: nella “notte oscura” di Giovanni della Croce.
Una rivoluzione accade in pieno XII secolo: Guglielmo di Saint-Thierry, Bernardo di Clairvaux, Aelredo di Rievaulx, Ivo, e Riccardo di San Vittore (di cui Zambon ha curato sapientemente i Trattati d’amore cristiani del XII secolo per Valla Mondadori) mostrano a quale fuoco di trasformazione può accendersi l’intelletto d’amore che guida fino a Dio, intrecciando eros platonico e caritas paolina. Come in Ildegarda di Bingen, il grande impeto d’amore dà le ali. Culminano la poesia della fin’amor dei trovatori, le storie di Tristano e Isotta, il romanzo cortese.
 Con Beatrice davanti alla candida rosa dei beati, Bernardo invita Dante a fissare Dio, nel movimento rapidissimo che imprime al creato e a noi: la metamorfosi dell’anima in Dio, l’excessus mentis, avviene per opera divina in un solo istante: «ma già volgeva il mio disio e ’l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle». Riccardo di San Vittore è il più ardito. Amore terreno e carità hanno la stessa fonte, ma la carità non è mite. Ha la stessa struttura, manifestazioni e gradi della passione violenta. I Quattro gradi della violenta carità gridano in Iacopone da Todi: «Amor de caritate, perché m’ài ssì feruto? / Lo cor tutt’ho partuto, et arde per amore».
Con Beatrice davanti alla candida rosa dei beati, Bernardo invita Dante a fissare Dio, nel movimento rapidissimo che imprime al creato e a noi: la metamorfosi dell’anima in Dio, l’excessus mentis, avviene per opera divina in un solo istante: «ma già volgeva il mio disio e ’l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle». Riccardo di San Vittore è il più ardito. Amore terreno e carità hanno la stessa fonte, ma la carità non è mite. Ha la stessa struttura, manifestazioni e gradi della passione violenta. I Quattro gradi della violenta carità gridano in Iacopone da Todi: «Amor de caritate, perché m’ài ssì feruto? / Lo cor tutt’ho partuto, et arde per amore».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus !!! O, meglio, che progetto!!!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- La ricerca del grande amore si fa ormai soltanto on line? Riprendere la navigazione.1 luglio 2020, di Federico La Sala
AMARE NEL MARE DELLA VITA. Riprendere la navigazione ...
Una nota *
SE è VERO CHE “La ricerca del grande amore si fa ormai soltanto on line” (Laura Vasselli, "InLibertà", 29 giugno 2020), e, al contempo, che “La truffa esiste anche in danno della vita sentimentale” (L. V., "InLibertà", 10 giugno 2020), in una società “liquida” - dove non c’è più né un Giardino per Adamo ed Eva né una Itaca per Ulisse e Penelope - il problema su cui fare chiarezza e “chiudere l’argomento” è : “se è vero che nella vita è necessario amare innanzitutto sé stessi, come si fa a lasciare posto all’amore per qualcun altro ?”.
CONOSCER-SI: IN PRINCIPIO ERA LA “PAROLA” (IL “LOGOS”). RICORDATO CHE “Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima : così profondo è il suo lògos" (Eraclito, fr. 45), E, insieme, RIGUARDATA LA FOTO (vedi sopra: accanto al titolo, sul dito “indice” di “due persone” l’immagine di “due ancore”), RIPARTIRE PROPRIO DA QUI : DAll’ancoraggio di “due navi”, di “DUE PERSONE CHE DISCORRONO” (Ferdinand De Saussure). Mi sembra proprio una (bella riflessione e una) buona indicazione!
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.).
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan -
 LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL CIELO, LA DISTANZA GIUSTA, E IL DILEMMA DEI PORCOSPINI.28 giugno 2020, di Federico La Sala
ANCORA NON ABBIAMO TROVATO "LA GIUSTA DISTANZA" NEMMENO CON NOI STESSI... *
- CIELO STELLATO e LEGGE MORALE (Kant). QUANTO difficile vedersi dallo specchio della distanza celeste!
- “Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima: così profondo è il suo lògos”(Eraclito, fr. 45).
- "Siamo ignoti a noi medesimi, noi uomini della conoscenza, noi stessi a noi stessi: è questo un fatto che ha le sue buone ragioni. Non abbiamo mai cercato noi stessi - come potrebbe mai accadere che ci si possa, un bel giorno trovare? Non a torto è stato detto:«Dove è il vostro tesoro, là è anche il vostro cuore» ; il nostro tesoro è là dove sono gli alveari della nostra conoscenza" (F. Nietzsche, "Genealogia della morale").
- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA (NON "ANDROLOGIA"): "ECCE HOMO!". PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro : "«Ecco l’uomo» (gr. « idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato : "Prendetelo voi e crocifiggetelo ; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
ABITARE LE PAROLE / Distanza.
Vedersi l’un l’altro stagliati nel cielo
DI NUNZIO GALANTINO (Il Sole-24 Ore, Domenica, 28.06.2020)
Distanza. Parola - non la sola, in verità! - che perde un po’ della sua evidenza semantica quando la si trova unita ad attributi particolari. Come capita, per esempio, nelle locuzioni: “distanza sociale”, “fisica”, “interpersonale”. Per coglierne la ricchezza, bisogna anzitutto evitare l’ambiguità - a volte, vera e propria confusione - ereditata dalle locuzioni inglesi social distancing (distanziamento sociale) e social distance (distanza sociale). In sociologia e in psicologia, sono espressioni che descrivono il livello di interazione o di rifiuto tra individui appartenenti a gruppi sociali, economici e culturali diversi. Non è corretto, quindi, ricorrervi per indicare la distanza di sicurezza interpersonale o la distanza necessaria per evitare contagi tra più persone.
Un’intensa considerazione di Rainer Maria Rilke ci aiuta a guardare con occhio diverso la distanza. «Una volta che si è accettato di capire che anche tra gli esseri umani più vicini continuano ad esistere infinite distanze, può crescere un meraviglioso affiatamento, se questi riescono ad amare la distanza che li separa, che rende possibile ad ognuno di vedersi reciprocamente, per intero, stagliati nel cielo».
Qui la parola distanza ha tutt’altro significato rispetto a quello che gli dà F. Nietzsche, quando parla di pathos della distanza. Questa espressione - nel filosofo tedesco e in parte anche nella ripresa di Italo Calvino - indica l’atteggiamento dell’aristocratico che, da una presunta posizione di superiorità, “tiene a distanza” e guarda da lontano quanti non gli sono pari.
 Invece, “la distanza che rende possibile ad ognuno di vedersi reciprocamente, per intero, stagliati nel cielo”, è la “distanza giusta”. Quella che permette di stabilire e coltivare relazioni sane ed equilibrate, grazie alla modulazione e alla misurazione, non esclusivamente fisica, di vicinanza-lontananza, come nel «dilemma dei porcospini», evocato da A. Schopenhauer.
Invece, “la distanza che rende possibile ad ognuno di vedersi reciprocamente, per intero, stagliati nel cielo”, è la “distanza giusta”. Quella che permette di stabilire e coltivare relazioni sane ed equilibrate, grazie alla modulazione e alla misurazione, non esclusivamente fisica, di vicinanza-lontananza, come nel «dilemma dei porcospini», evocato da A. Schopenhauer.
 I porcospini, per ripararsi dal gran freddo, provano a farlo stringendosi l’un l’altro; ma, a causa dei loro aculei, sono costretti ad allontanarsi e a cercare comunque la distanza giusta, per riscaldarsi senza farsi male a vicenda. È, sostiene il filosofo tedesco, la stessa fatica che sono chiamati a far gli uomini. Anche loro hanno bisogno di stabilire tra loro una distanza giusta. Quella che fa passare messaggi e comunicare disposizioni interiori ed emozioni. Una distanza che può persistere, nonostante gesti di grande vicinanza fisica. Chi infatti può davvero decifrare i sentimenti e le autentiche intenzioni che accompagnano le relazioni intime, anche le più belle?
I porcospini, per ripararsi dal gran freddo, provano a farlo stringendosi l’un l’altro; ma, a causa dei loro aculei, sono costretti ad allontanarsi e a cercare comunque la distanza giusta, per riscaldarsi senza farsi male a vicenda. È, sostiene il filosofo tedesco, la stessa fatica che sono chiamati a far gli uomini. Anche loro hanno bisogno di stabilire tra loro una distanza giusta. Quella che fa passare messaggi e comunicare disposizioni interiori ed emozioni. Una distanza che può persistere, nonostante gesti di grande vicinanza fisica. Chi infatti può davvero decifrare i sentimenti e le autentiche intenzioni che accompagnano le relazioni intime, anche le più belle?Lo ha capito bene René Magritte. Con stile surreale, il pittore belga, nelle due versioni (1928) di The Lovers, mostra di non avere dubbi: nonostante i gesti di grande tenerezza, i due amanti non possono guardarsi negli occhi, non possono penetrare la loro intimità. Ad impedirglielo è l’inevitabile distanza, non fisica, esistente tra loro, rappresentata dal telo che ne avvolge il volto.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": LA LEZIONE DI DANTE (E NIETZSCHE), OGGI. CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA, "ANDROLOGIA", E DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE: "UN UOMO, TUTTI GLI UOMINI"?!27 giugno 2020, di Federico La Sala
FILOLOGIA E "ANDROLOGIA". DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE: "UN UOMO, TUTTI GLI UOMINI"?! *
- MEMORIA DI PONZIO PILATO. Nella lingua di Roma (come nella lingua di Atene), L’«ECCE HOMO» ha significato antropologico (non "andrologico" - limitato all’«omuncolo» di qualche "uomo supremo" o “superuomo”!):
- PONZIO PILATO «disse loro : "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro : "«Ecco l’uomo» (gr. « idou ho anthropos », vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi ! Crocifiggi!" Disse loro Pilato : "Prendetelo voi e crocifiggetelo ; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei : "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
La raccolta.
Ivano Dionigi tra parola, vita e smarrimenti
Uno sguardo sul nostro tempo e le sue emergenze partendo dalla lettura dei classici e dei testi biblici. Un estratto dall’ultimo libro di Dionigi che trae linfa dalla rubrica “Tu quis es” per Avvenire
di Ivano Dionigi (Avvenire, giovedì 25 giugno 2020)
- Con la prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi e un’ampia premessa dello stesso autore (dalla quale abbiamo tratto il significativo stralcio che introduce i testi qui anticipati), Raffaello Cortina manda in libreria Parole che allungano la vita. Pensieri per il nostro tempo, il libro di Ivano Dionigi (pagine 112, euro 12,00) che raccoglie, con l’aggiunta di inediti, i brani pubblicati fra gennaio e marzo 2020 su “Avvenire” nella rubrica di prima pagina “Tu quis es”. Uno sguardo sulla quotidianità, nei giorni che in Italia e in Europa hanno aperto la crisi della pandemia, attraverso l’esperienza della classici greci e latini.
La parola, lógos per i Greci, verbum per i Latini, è il miracolo per cui l’uomo da creatura diventa creatore: essa può affascinare (delectare), insegnare (docere), mobilitare le coscienze (movere). La parola può unire e dividere, consolare e affannare, salvare e uccidere. Non solo custodisce e veicola il pensiero, ma lo genera. La Parola divina, quel Logos con cui si aprono l’Antico e il Nuovo Testamento: la Genesi («In principio Dio disse») e il Vangelo di Giovanni («In principio era la Parola»). Il lógos di Eraclito: «così profondo che della sua anima, per quanto tu possa camminare e neppure percorrendo intera la via, mai potresti trovare i confini». La parola che con Gorgia tutto può: «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione ». La parola della “democratica” Atene, che uccise Socrate prima e più della cicuta.
 La parola che, usata male, secondo Platone oltre a essere una cosa brutta in sé fa male anche all’anima. La parola che con Aristotele ci caratterizza come uomini distinguendoci dagli animali. La parola che con Cicerone salva la res publica, se prerogativa degli eloquentes e sapientes; la manda in rovina, se prerogativa dei disertissimi homines, i demagoghi. La parola della ragione di Lucrezio, l’arma più efficace per debellare i nemici interiori della cupido e del timor. La parola terapeutica di Seneca che interiorizza e consola. La parola che con l’apostolo Giacomo ora benedice ora maledice. La parola che con Elias Canetti si fa antidoto alla guerra. La parola che con don Milani diviene «la chiave fatata che apre ogni porta». La parola che con Mario Luzi «vola alta» e profonda, e «tocca nadir e zenith».
La parola che, usata male, secondo Platone oltre a essere una cosa brutta in sé fa male anche all’anima. La parola che con Aristotele ci caratterizza come uomini distinguendoci dagli animali. La parola che con Cicerone salva la res publica, se prerogativa degli eloquentes e sapientes; la manda in rovina, se prerogativa dei disertissimi homines, i demagoghi. La parola della ragione di Lucrezio, l’arma più efficace per debellare i nemici interiori della cupido e del timor. La parola terapeutica di Seneca che interiorizza e consola. La parola che con l’apostolo Giacomo ora benedice ora maledice. La parola che con Elias Canetti si fa antidoto alla guerra. La parola che con don Milani diviene «la chiave fatata che apre ogni porta». La parola che con Mario Luzi «vola alta» e profonda, e «tocca nadir e zenith».
 Questa parola oggi non gode di buona salute: ridotta a chiacchiera e barattata come merce qualunque, ci chiede di abbassare il volume, di ricongiungerla alle cose, di imboccare la strada del rigore. Soprattutto in questo tempo di calamità, in cui ci apprestiamo a un lungo esodo e alla traversata del deserto, le parole note suonano inadeguate se non improprie. -Abbiamo bisogno di parole nuove per nominare questo presente imprevisto, inaudito, alieno. Uguale, eppure così frantumato; estraneo, eppure così invadente attorno a noi e dentro di noi.
Questa parola oggi non gode di buona salute: ridotta a chiacchiera e barattata come merce qualunque, ci chiede di abbassare il volume, di ricongiungerla alle cose, di imboccare la strada del rigore. Soprattutto in questo tempo di calamità, in cui ci apprestiamo a un lungo esodo e alla traversata del deserto, le parole note suonano inadeguate se non improprie. -Abbiamo bisogno di parole nuove per nominare questo presente imprevisto, inaudito, alieno. Uguale, eppure così frantumato; estraneo, eppure così invadente attorno a noi e dentro di noi.Orfeo e Euridice
A Orfeo è concesso di riportare la dolce sposa dall’Ade sulla terra a patto di non girarsi a guardarla. Ma, racconta Virgilio (Georgiche, 4, 485 sgg.), lo sprovveduto amante uscendo dagli Inferi viene preso dalla follia d’amore e viola i patti (rupta foedera): «Quale furia d’amore ha portato me misera, ha portato te Orfeo, alla perdizione? » (4, 494 sg.: Quis et me [...] miseram et te perdidit, Orpheu, / quis tantus furor?), grida Euridice quando Orfeo si volta a guardarla. «Muto e impaziente» Orfeo, «mite nella sua pazienza» Euridice, dirà Rilke. Non è forse vero che non bisogna amarla troppo questa vita per non perderla? Come non è forse vero che non bisogna attaccarsi troppo a una persona per non soffocarla?
 Se non sopportiamo il peso della privazione, il prezzo dell’attesa, il páthos della distanza, perdiamo coloro che amiamo e perdiamo noi stessi. Restiamo agli Inferi: nell’Inferno della nostra identità. Questa favola vale per la scuola come per la vita. -Penso al nostro modo di leggere i classici, oscillante fra due estremi malsani: o non cogliamo le interrogazioni dei testi e li consideriamo come fossili, muti, inanimati, cadaverici, oppure vi sovrapponiamo le nostre domande e li riduciamo a pretesti per le nostre ragioni. Non abbiamo forse pietrificato i classici tutte le volte che, affetti da miopia e incapaci di resistere all’impazienza e all’illusione del possesso, abbiamo anteposto le ragioni della vicinanza e della presenza, incuranti di ogni distanza passata e futura?
Se non sopportiamo il peso della privazione, il prezzo dell’attesa, il páthos della distanza, perdiamo coloro che amiamo e perdiamo noi stessi. Restiamo agli Inferi: nell’Inferno della nostra identità. Questa favola vale per la scuola come per la vita. -Penso al nostro modo di leggere i classici, oscillante fra due estremi malsani: o non cogliamo le interrogazioni dei testi e li consideriamo come fossili, muti, inanimati, cadaverici, oppure vi sovrapponiamo le nostre domande e li riduciamo a pretesti per le nostre ragioni. Non abbiamo forse pietrificato i classici tutte le volte che, affetti da miopia e incapaci di resistere all’impazienza e all’illusione del possesso, abbiamo anteposto le ragioni della vicinanza e della presenza, incuranti di ogni distanza passata e futura?Parole per noi
Negata anche la pietas: non si può abbracciare né chi nasce né chi muore. Catastrofe, inferno, tragedia sono le parole giuste per questi giorni. Va pensata la genesi dopo l’apocalisse: la scienza medica deve curare e guarire, la politica provvedere e prevedere, con l’auspicio che i tanti eurobond siano affiancati da altrettanti neurobond. Avremo bisogno di Mosè, di tanti Mosè che ci guidino nella traversata del deserto. Non è l’ora delle nostre parole che suonano inutili o inopportune. Altro timbro possiedono le parole di coloro che hanno scritto per noi e di noi, che resistono al tempo e alle mode. Ci ricordano con il Prometeo di Eschilo e l’Antigone di Sofocle che l’uomo ha posto rimedio a tutti i mali ma non al suo destino mortale; con il Platone della Repubblica, che non si possono privatizzare i beni materiali ma neppure i sentimenti quali la gioia e il dolore, e che nella città al vertice dell’istruzione deve sedere il migliore; con l’Aristotele della Politica, che l’uomo dotato di norme civili e di senso del giusto è la migliore delle creature; con Lucrezio, che solo la scienza può rimuovere la paura, frutto dell’ignoranza e causa di tutti i mali; con Virgilio, che i vecchi valgono non meno dei giovani; con Seneca, che è cosa diversa vivere (vivere) dallo stare al mondo (esse); con Marco Aurelio, che ognuno di noi vale quanto la causa per cui lotta; con Agostino, che la qualità dei tempi dipende da quella degli uomini (Sermoni, 80, 8: Nos sumus tempora: quales sumus, talia sunt tempora).
Lucrezio lo aveva detto
La storia ama non solo sorprendere ma anche ripetersi. Si vada alla peste di Atene (430 a.C.) descritta da Lucrezio nel finale del suo poema: vi si troveranno consonanze raggelanti con i nostri giorni. Sotto scacco, la medicina allora mostrava tutta la sua incertezza e impotenza: silenziosa e timorosa esitava e balbettava (6, 1179: Mussabat tacito medicina timore). Parimenti disarmata e svilita la religione (vv. 1276-1277: Nec iam religio divum nec numina magni / pendebantur): i templi stipati di cadaveri accatastati (vv. 1272-1273: omnia sancta deum delubra replerat / corporibus mors) e impediti in città perfino i riti della sepoltura (v. 1278: nec mos ille sepulturae remanebat in urbe). Anche la pietà parentale era messa a dura prova: quanti erano accorsi al capezzale dei loro cari, incorrevano nel contagio (v. 1243: Qui fuerant autem praesto, contagibus ibant) e quanti si rifiutavano di portare soccorso morivano soli e abbandonati (vv. 1239 sgg.: Nam quicumque suos fugitabant visere ad aegros / [...] / poenibat [...] / desertos, opis expertis, incuria mactans).
 Con i nostri occhi li abbiamo visti i medici supplire con la compassione alla carenza di terapie; le abbiamo viste le chiese diventate cimiteri, piazza San Pietro deserta e il Papa, solo, a testimoniare non la potenza del rito ma la passione della croce; li abbiamo visti negli ospedali i mariti separati dalle mogli, i fratelli dai fratelli, gli amici dagli amici. E morire senza potere prendersi la mano e neppure salutarsi.
Con i nostri occhi li abbiamo visti i medici supplire con la compassione alla carenza di terapie; le abbiamo viste le chiese diventate cimiteri, piazza San Pietro deserta e il Papa, solo, a testimoniare non la potenza del rito ma la passione della croce; li abbiamo visti negli ospedali i mariti separati dalle mogli, i fratelli dai fratelli, gli amici dagli amici. E morire senza potere prendersi la mano e neppure salutarsi.Un uomo, tutti gli uomini
I rimedi per la ricostruzione del Paese dovranno essere proporzionati ai danni: incalcolabili. Ci vorranno braccia e menti, e una duplice chiamata: da un lato, quella dei migliori cervelli, in seduta permanente in una sorta di “cern” politico, economico, sociale, culturale per progettare il futuro; dall’altro, quella dei ventenni, perché siano i protagonisti della rinascita. Arrivati in un mondo fatto su misura dei loro padri, dovranno ora costruirne uno per i loro figli. A nulla valgono le retoriche consolatorie di questi giorni: il ricorso al patriottismo d’occasione, l’enfasi sull’eroismo dei medici oggi sull’altare e domani di nuovo nella polvere, l’illusione che ne usciremo migliori. I retti saranno ancora retti, gli acuti torneranno acuti, e gli ottusi resteranno ottusi. Più facile prevedere un indurimento degli animi, un ulteriore divario fra chi ha e chi non ha, un ripopolamento di umiliati e gregari che al riconoscimento delle istituzioni e alla rivendicazione dei diritti preferiranno panem et circenses. Avremo imparato che il mondo non è in equilibrio economico, ambientale, sanitario? Che sapere e potere, competenza e politica, cultura e amministrazione sono inseparabili? Che sarà il pronome noi a salvarci? Ce lo ricorda Borges: «Ciò che fa un uomo è come se lo facessero tutti gli uomini. Per questo non è ingiusto che una disobbedienza in un giardino contamini il genere umano; per questo non è ingiusto che la crocifissione di un solo giudeo basti a salvarlo» (La forma della spada).
*
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
- L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE. Da Giovanni Pico della Mirandola* a Herbert Marcuse** e ...
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- IL DESIDERIO E LA CRITICA DEL “SOGNO D’AMORE” DELLA “RAGION PURA”.12 giugno 2020, di Federico La Sala
IL DESIDERIO, IL “SOGNO D’AMORE”, E LA TRAPPOLA DELLA “TRUFFA ROMANTICA”.
PER CHI HA AVUTO L’OPPORTUNITA’ O IL MODO “di venire a conoscenza, se pur in modo fugace e non dettagliato, della vicenda del fantomatico Mark Caltagirone, promesso sposo virtuale della nota showgirl Pamela Prati”, CONSIGLIO UNA LETTURA ATTENTA DELL’ARTICOLO “La truffa esiste anche in danno alla vita sentimentale” (Laura Vasselli, "InLibertà"), TOCCA UNA QUESTIONE FONDAMENTALE DELLA STESSA VITA DI OGNI PERSONA, NON SOLO SUL PIANO DEI RAPPORTI PRIVATI MA ANCHE DEI RAPPORTI PUBBLICI: “[...] credere che la finzione si confonda con la realtà , [...] perdere la lucidità e il senso di realtà”!
QUANTO TALE “PROBLEMA” SIA DEGNO DI ESSERE PENSATO A FONDO (E A TUTTI I LIVELLI) è chiaramente detto - come scrive l’autrice - nella motivazione della Suprema Corte di Cassazione Penale che, con la sentenza n. 25165/2019 in materia di “truffa romantica” ha stabilito che essa “non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo“ (cit.).
CHE DIRE?! E’ UNA SOLLECITAZIONE A SAPERSI CONDURRE CON SENNO SIA NELLE QUESTIONI PRIVATE SIA NELLE QUESTIONI PUBBLICHE E UN INVITO A NON PERDERE IL SENSO DELLA REALTA’ (sul tema, non sembri strano né casuale, si cfr. l’articolo di Italo Mastrolia, su “#iorestoacasa, Forza Italia”). NE VA DELLA NOSTRA STESSA VITA : E’ UN PROBLEMA DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE, A TUTTI I LIVELLI.
***
CALIPSO, PENELOPE, E LA COSTITUZIONE. PER LA CRITICA DEL “SOGNO D’AMORE” DELLA “RAGION PURA”...
SICCOME, E GIUSTAMENTE, va detto che, oggi, “il fenomeno è sommerso nel senso che molte persone sono vittime attive” (Laura Vasselli, cit), e che il problema è un problema di “psicoanalisi della società contemporanea” e di una società “malata” (si cfr. E. Fromm, “The sane society”, 1955), il mio invito - mi sia lecito - vuol essere solo una piccola sollecitazione a meglio contribuire a portare avanti il critico lavoro di “interpretazione dei sogni” (Freud), del “sogno d’amore”, e non perdere quanto messo a fuoco nella riflessione sul caso “Pamela Prati”.
CONSIDERATO CHE “è attraverso la mediazione delle cause interne - come ricordava ai suoi tempi il presidente della Repubblica popolare cinese, Mao Tse Tung - che quelle esterne producono il loro effetto”, e che le possibilità delle tentazioni e degli inganni sono “infiniti”, forse, vale la pena sfogliare l’album della memoria e ricordare quanto BENIAMINO PLACIDO “Agli amici alla vigilia di un cambiamento, un nuovo lavoro, un viaggio, una storia d’amore seria, amava chiedere: «Sai perché Odisseo non ascolta Calipso e non rimane con lei sull’isola felice, pur davanti alla promessa di diventare immortale, bello, sano e innamorato per sempre? Sai perché rinuncia a quella eterna felicità e si rimette in mare tra mostri, tempeste e nemici ferocissimi, umani e divini?». Di fronte allo sguardo perplesso dell’interlocutore, sgranava gli occhi bulbosi, accennava un sorriso malizioso, alzava l’indice da saggio e scandiva «Perché per noi umani l’identità è più importante dell’immortalità, capisci? Sempre!». L’identità era cambiare, studiare, viaggiare, praticare nuovi mestieri, ma senza cambiare il cuore a nessun costo, neanche in cambio dell’immortalità e di una Dea come amante” (si cfr. G. R., “Beniamino Placido (1929-2010) / Beniamino e il segreto di Odisseo”, "Il Sole-24 Ore", 7 gennaio 2010).
Questo, in altre parole, non vuol dire che solo un “sogno d’amore” con gli occhi aperti e la mente sveglia rende possibile l’«odissea» - e “Itaca”? E che per questo è fondamentale e decisivo la necessità e l’urgenza del lavoro della critica del “sogno d’amore” della “ragion pura” (Kant)?! O no?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- “La scienza ha un problema di razzismo”. La rivista scientifica Cell fa mea culpa (di Giulia Belardelli).10 giugno 2020, di Federico La Sala
CULTURE
“La scienza ha un problema di razzismo”. Un altro sasso nella coscienza d’America
La prestigiosa rivista scientifica Cell fa mea culpa e chiama all’azione la comunità degli scienziati: “Sappiamo molto sulla salute dei bianchi perché abbiamo sfruttato i neri. Dai database agli studi clinici, storia di una lunga ingiustizia. Tempo di cambiare”
di Giulia Belardelli *
- [Foto] Da sinistra: Henrietta Lacks; studio sulla sifilide di Tuskegee; tombe di massa nel Bronx per l’emergenza... Wikipedia/getty
“La scienza ha un problema di razzismo. Il compito degli scienziati è risolvere problemi. Quindi andiamo dritti al punto e affrontiamo questo problema”. La chiamata all’azione arriva da Cell, una delle più prestigiose riviste scientifiche americane, che in un editoriale pubblicato oggi fa un excursus, con tanto di mea culpa, su tutti i modi in cui la scienza è complice di un razzismo “manifesto e sistematico” che può “prosperare” grazie alla “epidemia di diniego del ruolo integrale che ogni singolo membro della società gioca nel sostenere lo status quo”. Black Lives Matter, le vite dei neri contano, scandiscono i manifestanti ormai da quasi tre settimane. Ed è ora che contino di più anche per la scienza, in termini di rappresentanza, studi, database scientifici, accesso alle cure.
L’editoriale di Cell parte da una auto-osservazione che diventa auto-critica: “la nostra rivista, impegnata nella pubblicazione e diffusione di entusiasmanti lavori nel campo delle scienze biologiche, è composta da 13 editor scientifici. Nessuno di noi è nero. Ma la sottorappresentazione degli scienziati neri va oltre il nostro team: riguarda i nostri autori, i revisori e il comitato consultivo”. Si potrebbe liquidare il problema sostenendo che “la rivista è un riflesso dell’establishment scientifico”: vero, ma completamente inutile se l’obiettivo è contribuire a eliminare qualche strato di ingiustizia.
Per dirla con De Andrè, è come se da Cell si levasse una chiamata agli scienziati americani e non solo: “Per quanto voi vi crediate assolti / Siete per sempre coinvolti”. “La scienza ha un problema di razzismo”, per vederlo basta guardare alla “storia delle genetica umana, un campo che è stato ripetutamente usato come fondamento scientifico per la definizione di ‘razze’ umane e per sostenere diseguaglianze intrinseche. I propugnatori dell’eugenetica usano gli alleli che portiamo come ragione per dichiarare una superiorità razziale, come se l’espressione di un gene della lattasi avesse a che fare con l’umanità di una persona. La razza non è genetica”.
Un altro modo in cui la scienza è stata - e in molti casi è ancora - razzista è lo sfruttamento dei soggetti neri nella ricerca. Un esempio lampante è “l’enorme mole di ricerca scientifica passata e attuale resa possibile dalle cellule rubate decenni fa a Henrietta Lacks, una donna nera malata di cancro. Oppure lo studio sulla sifilide di Tuskegee, che intenzionalmente ha negato un trattamento adeguato a centinaia di uomini di colore. E ancora: basta pensare - prosegue Cell - al ruolo della razza nelle questioni del consenso, della proprietà e dell’etica medica, e alle relative violazioni.
Ma non è tutto: il razzismo nella scienza si manifesta anche “nell’estrema disparità di database genetici e clinici che gli scienziati hanno costruito”: la stragrande maggioranza dei dati riguarda i bianchi, le cui malattie sono molto più studiate e comprese rispetto a quelle dei neri. Il diritto alla salute, in America come altrove, è minato dal razzismo. Per rendersene conto - prosegue Cell - basta leggere “le statistiche sulle disparità di morbilità e mortalità negli ospedali di tutto il Paese, evidenziata dalla corrente pandemia: chiediamoci perché le donne di colore hanno una probabilità cinque volte maggiore delle donne bianche a morire durante la gravidanza, o perché i bambini neri hanno il doppio delle probabilità di morire rispetto ai bambini bianchi nati negli Stati Uniti. La salute dei neri non è mai stata la priorità”.
Il virus del razzismo infetta la scienza in molti altri modi: “l’establishment scientifico, l’educazione scientifica e la metrica usata per definire il successo scientifico hanno a loro volta un problema di razzismo”. “Gli afroamericani affrontano una montagna di sfide costruite in secoli di razzismo sistemico e strutturale” che compongono “la storia di schiavitù e oppressione razziale degli Stati Uniti d’America”. Finora il mondo accademico e scientifico non ha fatto abbastanza per invertire la rotta: “è giunto il momento di rinnovarsi”.
Nella consapevolezza che non si cambia in un giorno, Cell fa comunque la sua promessa alla comunità scientifica nera. Una promessa articolata in quattro punti: 1) rappresentanza: “ci impegneremo a rappresentare e amplificare la voce degli scienziati neri sulla rivista e sui social media”; 2) educazione: “ci impegneremo a presentare le problematiche più rilevanti per la comunità scientifica nera; 3) diversificazione: “aumenteremo la diversità nel nostro comitato consultivo e nel nostro pool di revisori”; 4) ascolto: “se ci sono modi in cui possiamo usare la nostra voce e la nostra piattaforma per aiutare la comunità di scienziati neri, siamo pronti a imparare”.
Imparare è la parola chiave. “Quasi sicuramente faremo degli errori lungo la strada”, si legge nella conclusione. “Ma il silenzio non è e non sarebbe mai dovuto essere un’opzione. La scienza ha un problema di razzismo. Gli scienziati sono problem solvers. Andiamo dritti al punto”. Un altro sassolino nella coscienza d’America.
* HUFFPOST, 10/06/2020 (ripresa parziale, senza immagini e allegati).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- «La scienza discrimina le donne». Intervista a Francesca Dominici (di Lucia Capuzzi).10 giugno 2020, di Federico La Sala
Coronavirus. Francesca Dominici: «La scienza discrimina le donne»
Cervello in fuga e ai vertici di Harvard, denuncia la situazione delle ricercatrici: «Noi, giudicate per il tailleur. Il Covid? Ci ha costrette a casa. Gli studi a firma femminile sono crollati»
di Lucia Capuzzi (Avvenire, mercoledì 10 giugno 2020)
- [Foto] Francesca Dominici Neolaureate delle facoltà di psicologia, biologia e farmacia manifestano in piazza Duomo, a Milano - Ansa
Ha strappato il velo. E al centro della scena è apparsa una presenza ingombrante, troppo a lungo rimossa dal dibattito pubblico: la discriminazione di genere tuttora vigente nel mondo, in apparenza neutro, della scienza. Perfino nei più prestigiosi centri di ricerca internazionali. «Il Covid ha acceso un potente riflettore sugli ostacoli aggiuntivi che ricercatrici e scienziate devono affrontare per tenere il passo rispetto ai colleghi maschi». Parola di Francesca Dominici, biostatistica di grido nonché direttrice della Data Science Iniziative di Harvard, università dove è arrivata appena 24enne e dove ha trascorso la sua vita accademica, fino ad arrivare ai vertici.
«È stata durissima. E, nonostante mio marito, tra l’altro pure lui scienziato, mi abbia sempre sostenuto, posso dire che non ce l’avrei mai fatta ad allevare mia figlia, che ora ha 14 anni, senza l’aiuto di mia madre. È stata lei ad accompagnarmi nei continui viaggi internazionali in tutto il mondo: teneva la bimba mentre io andavo ai congressi. Non vorrei essere nei panni delle giovani ricercatrici, costrette dal virus a conciliare famiglia e smart working. E non mi meraviglia che la produzione scientifica femminile sia calata negli ultimi mesi». A confermare quest’affermazione, le recenti ricerche di Megan Federickson, studiosa dell’Università di Toronto, e Cassidy Sugimoto, dell’Indiana University Bloomington. Entrambe hanno analizzato i server più utilizzati dalla comunità scientifica per diffondere i cosiddetti preprint, ricerche preliminari ancora da sottoporre alla revisione pre-pubblicazione. Si tratta, al momento, dell’unica fonte disponibile per avere il polso della situazione ancora in corso: per completare l’iter ci vogliono anni. Nei mesi di marzo e aprile, la produttività maschile è cresciuta a una velocità maggiore di diversi punti percentuali - a seconda del portale utilizzato anche il doppio - rispetto a quella delle colleghe. Lo stesso è accaduto nel campo delle ricerche sociali. Come sottolinea Noriko Amano-Patiño, dell’Università di Cambridge, le autrici di lavori sull’impatto del Covid sull’economia sono il 12 per cento del totale: otto punti percentuali in meno della media. «La ragione è intuitiva - sottolinea Dominici -. Sulle donne è gravato il peso maggiore dell’emergenza sanitaria e, soprattutto, delle misure di lockdown messe in atto per contenerla, in primis la chiusura delle scuole e dei centri per l’infanzia».
Ben prima dell’irruzione del virus, le faccende domestiche - il cosiddetto “lavoro non remunerato” - erano in mani femminili: queste vi dedicano una media di quattro ore al giorno secondo l’Ocse, più del doppio rispetto agli uomini. Perché il Covid è stato così importante?
Con la pandemia, le attività di gestione ordinaria sono cresciute enormemente: dalla cura dei figli impegnati nelle lezioni a distanza alle commissioni per i parenti più anziani e, dunque, vulnerabili all’infezione. Nel mentre, il ricorso ad aiuti esterni si è fatto più difficile a causa dell’isolamento. E ad occuparsene sono state le donne. Scienziate incluse. C’è, poi, un’altra questione, legata a una differenza di approccio maschile e femminile. Le ricercatrici tendono ad essere più caute e questo le porta ad essere meno presenti nei media.
In controtendenza lei, invece, è autrice capofila di un’importante ricerca che dimostra la relazione tra inquinamento e tasso di mortalità per il Covid.
Il virus attacca i polmoni. Abbiamo, dunque, analizzato come l’esposizione di questi al particolato sottile ne determini una maggiore vulnerabilità alla malattia. E siamo arrivati alla conclusione che più questa è prolungata maggiore è la capacità del Covid di uccidere. Anche un piccolo incremento del livello di inquinamento determina un incremento della mortalità dell’8 per cento.
- «Paghiamo con l’esclusione l’essere relegate al ruolo della cura. E ai congressi, quando è il turno delle donne, gli uomini ne approfittano per fare la pausa caffè»
Dove, in base alla sua esperienza, c’è più discriminazione di genere, in Italia o negli Usa?
Sono andata via dall’Italia al primo anno di dottorato, proprio a causa delle discriminazione. Ma l’ho ritrovata qui, anche se in forma meno palese. Un pregiudizio strisciante, forse ancor più difficile da individuare e combattere.
Può farmi qualche esempio?
Gliene faccio tre. A volte, per farti un complimento, qualcuno ti dice: «Mi piace molto il tuo tailleur. Peccato che ti copra troppo». Alle riunioni del comitato, tutto al maschile, della Data Science Initiative, di cui sono capo, spesso vengo ancora presentata come «la moglie di un brillante scienziato». Ai congressi, quando è il turno delle ricercatrici donne, gli uomini ne approfittano per fare la pausa caffè. Se ti arrabbi o smetti di parlare, dicono che hai un carattere difficile.
Perfino ad Harvard c’è discriminazione?
Le donne full professor, di cui faccio parte, sono il 15 per cento. Ai livelli iniziali di carriera siamo la metà. Poi, man mano che si va avanti, molte colleghe sono costrette a lasciare perché non riescono a conciliare con la vita familiare.
Che soluzione proporrebbe?
Mettere più donne ai vertici, con un sistema di quote, in modo da cambiare le regole e renderle più eque.
Che consiglio darebbe a un’aspirante ricercatrice?
Se vuole far carriera deve accettare il fatto che sarà criticata. Le direi di non badarci troppo e andare avanti.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DEL "MONOMITO" DELLA RAGIONE E DELLA FEDE. Un omaggio a Joseph Campbell.27 maggio 2020, di Federico La Sala
"CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT) E DEL "MONOMITO" (JAMES JOYCE). UN OMAGGIO A JOSEPH CAMPBELL
LA METAFORA NEL MITO E NELLA RELIGIONE E I PROLEGOMENI AD OGNI FUTURA METAFISICA CHE SI PRESENTERA’ COME SCIENZA.... *
- IL MITO E IL CORPO. [...] I vecchi dèi sono morti o stanno morendo e dappertutto la gente è alla ricerca di qualcosa di nuovo e si chiede: “Quale sarà la nuova mitologia, la mitologia di questa Terra unificata come un unico essere armonioso?”(Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo, i Nottetempo, Milano 2020, p. 23)
- LA COSMOLOGIA E L’IMMAGINAZIONE MITICA. Un’esperienza sorprendente, per me come certo per molti altri spettatori, è stata offerta dalla trasmissione televisiva del viaggio della navicella spaziale Apollo nel momento precedente lo sbarco di Armstrong sulla Luna. Quando dal Centro di controllo di Houston chiesero: «E ora chi è il navigatore?» la risposta che venne dallo spazio fu «Newton!».
 Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
Mi ricordai allora della discussione sullo spazio che Immanuel Kant aveva sostenuto nei suoi Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza quando chiedeva: «Come è possibile che in questo spazio, in questo luogo, noi possiamo farci dei giudizi di cui sappiamo, con apodittica certezza, che saranno validi anche in quello spazio, in quel luogo?».
 Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Il piccolo modulo si trovava dietro la Luna. Questa era la parte di spazio che nessuno aveva mai visitato prima, eppure gli scienziati di Houston sapevano esattamente quanta energia far emettere a quei reattori, e quale direzione far loro prendere al ritorno per riportare indietro il modulo dallo spazio fino a un miglio di distanza da una nave militare che lo aspettava nell’oceano Pacifico" (Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, TEA, Milano 1996, p. 31, senza le note.).
Siamo mito
di Moreno Montanari (Doppiozero, 20 marzo 2020).
“Come fuori, così dentro” si potrebbe riassumere così, parafrasando la celebre massima alchemica, la tesi dell’ultimo libro di Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, Nottetempo, 2020. Si tratta di una raccolta di saggi che amplificano delle conferenze tenute tra il 1981 e il 1984 nello sforzo, consueto per Campbell, di illuminare la transculturalità, ossia gli elementi costanti, nonostante le variabili etnico-culturali, dei miti. Al cuore di ogni narrazione mitologica, che Campbell ha il merito indiscusso di mostrare ancora viva negli aspetti più comuni delle nostre culture, ci sono temi che Adolf Bastian (1826-1905) chiamava “idee elementari” e Carl Gustav Jung (1875-1961) “archetipi” ; si tratta di cristallizzazioni di risposte millenarie che la fantasia e l’immaginazione delle diverse civiltà umane hanno elaborato per affrontare questioni esistenziali che le hanno profondamente interrogate. Naturalmente queste forme archetipiche variano a seconda delle idee etniche che una determinata cultura esprime, ma esiste tra di loro una dialettica che Campbell riassume così : “l’idea elementare è radicata nella psiche ; l’idea etnica attraverso cui si manifesta è radicata nella geografia, nella storia e nella società” (p. 145) ; si accede al punto di vista del mito quando “nelle forme di un ambiente traspare la trascendenza” (p. 28).
Il suo lavoro più celebre sull’universalità del mito è sicuramente quello relativo a L’eroe dai mille volti (1949, tr. it. Lindau, Torino, 2012) figura che, nelle più disparate e diversificate espressioni culturali, lontanissime tra loro nello spazio e nel tempo, passa comunque sempre attraverso i seguenti snodi esistenziali : una nascita misteriosa, una relazione complicata con il padre, ad un certo momento della sua vita sente l’esigenza di ritirarsi dalla società e, in questa condizione, apprende una lezione, o elabora un sapere, che orienterà diversamente la sua vita, poi ritorna alla società per mettere al suo servizio la lezione che ha appreso, molte volte (ma non necessariamente) grazie ad un’arma che solo lui può usare.
In questo libro, invece, l’attenzione si rivolge alle diverse cosmologie e ai miti soteriologici elaborati nel corso dei millenni dalle differenti culture che si sono susseguite, e affiancate, nel nostro pianeta, comprese le attuali, e si organizza intorno alla felice intuizione kantiana che spazio e tempo siano categorie interiori della psiche che vengono applicate alla realtà esterna. Citando Novalis Campbell scrive : “La sede dell’anima è laddove il mondo esterno e il mondo interno s’incontrano”, e aggiunge, “è questo il paese delle meraviglie del mito” (p. 43).
 Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe.
 Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:
Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:- “Le figurazioni mitiche sono metaforiche (...) in due sensi contemporaneamente : in quanto portatrici di connotazioni psicologiche e, allo stesso tempo, metafisiche. Attraverso questa doppia messa a fuoco, le caratteristiche psicologicamente interessanti di ogni ordine sociale locale, di ogni ambiente o di ogni ipotetica storia, possono venire trasformate attraverso il mito in trasparenze rivelatrici di trascendenza.
- Immanuel Kant ci ha fornito una formula straordinariamente semplice per interpretare queste due connotazioni. Compare nei Prologomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza ai paragrafi 57-58. Ci viene offerta una proporzione a quattro termini (a sta a b come c sta a x) che punta non tanto a porre un’imperfetta somiglianza tra due cose, ma definire un’identità perfetta di due rapporti tra cose del tutto dissimili (...). Non “a in qualche modo assomiglia a b”, ma il rapporto tra a e b è perfettamente identico a quello tra c e x, dove x rappresenta una quantità che non è soltanto sconosciuta, ma assolutamente inconoscibile, metafisica” (p. 80).
Mi sembra un esempio realmente illuminante per comprendere il senso di ogni comparazione e di ogni ermeneutica simbolica. Lo ha spiegato bene Jung : il simbolo, centrale in ogni mito, non rimanda a una realtà significata, è esso stesso realtà operante, costituisce la specifica capacità umana di “orientare la coscienza verso ulteriori possibilità di senso”, poiché non è mai del tutto riconducibile ad un significato univoco e definitivo ; per questo non può essere ridotto alla semiotica perché la sua funzione è piuttosto psicagogica, vale cioè per gli effetti che produce nella psiche, per le energie, le immagini, le interpretazioni, i processi psichici che sa evocare, promuovere, mettere in gioco (C. G. Jung, Tipi psicologici, 1921 ; tr. it. Bollati Boringhieri, 1977 e sgg, p. 527). Ecco perché il ricorso a Kant, a quell’x che resta inconoscibile e che apre alla metafisica, a ciò che trascende ogni possibilità di possesso e de-finizione del senso ultimo, appare particolarmente pertinente.
I rapporti che vengono suggestivamente indagati da Campbell, dicevamo, sono quelli che comparano lo spazio interiore e quello esteriore, secondo la celebre analogia tra macrocosmo e microcosmo :
- “la profondità e la sublime maestà della mitologia soppressa può essere apprezzata al meglio attraverso due movimenti a orologeria apparentemente irrelati ; l’uno è il più grande orologio dello spazio esteriore, l’altro appartiene allo spazio interiore. Sono rispettivamente la precessione astronomica degli equinozi e il battito fisiologico del cuore umano” (p. 54).
Attraverso un nutrito numero di calcoli e dati ricavati dagli studi di astronomia, i calendari ideati dalle diverse culture a partire dagli antichi babilonesi, le fonti bibliche, le arcaiche Upanisad induiste e i più remoti testi taoisti, Campbell giunge ad analizzare suggestivi - per un certo tipo di lettore - consonanze tra i cicli biologici del sistema solare (macrocosmo) e quelli dell’individuo (microcosmo). Ma non mi sembra questo il punto cruciale dei suoi sforzi, che consiste piuttosto nel promuovere una diversa prospettiva sul mondo e sulla vita, non più incentrata sulle nostre idee etniche, sui limiti delle nostre culture, ma aperta al riconoscimento di un’unica realtà “il cui centro è ovunque”, della quale dovremmo finalmente farci carico in maniera universale (si pensi agli assurdi sforzi dei singoli stati, in questi difficili giorni, di arginare il coronavirus secondo strategie nazionali, anziché comprenderne la portata globale che richiederebbe interventi condivisi, in tutti i sensi, su scala mondiale e non, addirittura, regionale - per non parlare delle differenti valutazioni a seconda delle fasce di età).
Dopo aver preso in esame i miti cosmologici e soteriologici delle diverse religioni delle nostre principali culture, Campbell giunge a questa conclusione :
- “Il primo passo per partecipare al destino dell’umanità, che non è quello di questo o di quel popolo, ma quello dell’intera popolazione del globo, è riconoscere che ogni immagine locale di un dio non è che una delle molte migliaia, dei milioni, forse anche miliardi di simbolizzazioni limitate di un mistero al di là della vista e del pensiero” (p. 63).
Il pensiero mitologico, quando non viene letteralizzato, promuove dunque un’apertura alla transculturalità, alla trascendenza di ogni appartenenza storico-culturale e si propone, in maniera apparentemente contro intuitiva, come strumento di laicità. Qui incontra l’arte, per la sua capacità di trasformare la coscienza e la visione abitudinarie della realtà in favore di un punto di vista nel quale, “la mente viene fermata e innalzata al di sopra del desiderio e dell’odio” ; sono parole di Joyce che Campbell fa sue e che trova affini all’esperienza ascetica che dovette compiere il Buddha prima di raggiungere l’illuminazione : vincere i tre demoni del desiderio (Kāma), della paura della morte (Māra) e l’identificazione con i vincoli sociali (Dharma), per accedere a una condizione che li sappia trascendere (pp. 201-201).
Un percorso e un’opportunità che, in chiave individuativa, sono poste al centro del lavoro di Giovanna Morelli nel suo Poetica dell’incarnazione. Prospettive mitobiografiche nell’analisi filosofica (Mimesis, 2020). In questo libro - uscito per la collana di Mimesis “Philo-pratiche filosofiche” curata da Claudia Baracchi - l’arte appare lo sfondo dal quale può emergere una rappresentazione mitobiografica della vita di ciascuno di noi, ossia, secondo la lezione di Ernst Bernhard, il modo di riconoscere come ogni singola esistenza si apra, o meglio si riconosca, in alcuni mitologemi (singoli aspetti di un mito) che si prestano a leggerne alcune gesta. Lo sguardo mitobiografico con il quale Morelli invita a osservare la vita, a partire dal racconto della propria, permette di “scoprire e amare l’universale attraverso il particolare, preservando entrambe le dimensioni”, di “narrare la propria vita secondo il disegno di senso che la illumina, la magnifica, la collega a figure universali e pertanto la rende epica, emblematica” (p. 127).
L’arte che indaga l’analista filosofo è dunque quella incarnata, ossia, consapevole che la vita di ciascuno di noi accede al simbolico grazie e attraverso quelle che James Hillman chiamava “metafore radicali” offerte dall’inconscio collettivo, ossia le strutture percettive, gli archetipi, che organizzano l’esperienza umana come già da sempre sovrapersonale.
Lo specifico di ogni vicenda biografica non viene meno se riconosce nel suo sviluppo echi, modalità e variazioni di temi ricorrenti nella storia dell’umanità - di cui la psiche mantiene una traccia in forma, appunto, archetipica - ma procede al contrario verso la sua individuazione, la possibilità di autenticare in modo esclusivo la propria esistenza, “se comunica con se stessa alle più diverse latitudini spazio-temporali, attraverso le tante narrazioni-quadro che si sono avvicendate nella storia” (pp. 38-39).
L’arte è qui poiesis, anzi, mitopoiesi e la vita, vista dall’osservatorio privilegiato della stanza d’analisi, ne costituisce il principale teatro (Giovanna Morelli è anche regista d’opera e critica teatrale), lo spazio in cui s’incontrano e si scontrano le nostre maschere sociali e i nostri doppi impresentabili, ma anche dove si facilita una più profonda espressione di sé che, in una vicenda personale, sa scorgere tracce di qualcosa di universale - il che, osserva Jung, è già di per sé terapeutico :
- “Il mito ha bisogno d’una nuova veste in ogni nuova era, se non vuol perdere la sua virtù terapeutica. (...) gli archetipi inconoscibili sono vivi (...) cambiano nome e veste in una successione infinita, e proprio attraverso questi mutamenti esprimono la loro imperscrutabile essenza” (C. G. Jung, Aion, Ricerche sul simbolismo del Sé, Bollati Boringhieri, Torino, p. 170, cit. in G. Morelli, op.cit., p. 45).
Un’operazione che, in modo diverso, sia Campbell che Morelli, ci invitano a fare per riconoscere nei miti la via maestra alla coltivazione di quella trascendenza che non rimanda a mondi altri e paralleli ma anima l’immanenza, qui ed ora, da sempre.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COME ALL’INTERNO, COSI’ ALL’ESTERNO: "VERE DUO IN CARNE UNA". NOTE SUL PROGRAMMA DI KANT
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaDAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL "CIELO STELLATO" E L’ ANTROPOLOGIA DA RIPENSARE. Non è bene che Dio sia solo (di Luigino Bruni).11 maggio 2020, di Federico La Sala
L’anima e la cetra/7.
Non è bene che Dio sia solo
di Luigino Bruni (Avvenire, domenica 10 maggio 2020)
- E quando miro in cielo arder le stelle; / Dico fra me pensando: / A che tante facelle? / Che fa l’aria infinita, e quel profondo / Infinito Seren? che vuol dir questa / Solitudine immensa? ed io che sono?
- Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
Alcune persone ricordano per tutta la vita il giorno in cui hanno visto per la prima volta il cielo stellato. Lo avevano "visto" altre volte, ma in una benedetta notte è successo qualcosa di speciale e lo hanno visto veramente. Hanno fatto l’esperienza metafisica dell’immensità e, simultaneamente, hanno avvertito tutta la propria piccolezza e fragilità. Si sono, ci siamo, visti infinitamente piccoli. E lì, sotto il firmamento, sono fiorite domande diverse, quelle che quando arrivano segnano una tappa nuova e decisiva della vita: dove sono e cosa sono i miei affari? e i miei problemi? cosa è la mia vita? cosa i miei amori, i miei dolori? E poi è arrivata la domanda più difficile: e io, che sono? È il giorno tremendo e bellissimo; per alcuni segna l’inizio della domanda religiosa, per altri la fine della prima fede e l’inizio dell’ateismo - per poi scoprire, ma solo alla fine, che le due esperienze erano simili, che magari c’era molto mistero nella risposta atea e molta illusione in quella religiosa, ma lì non potevamo saperlo. Non tutti fanno questa esperienza, ma se la desideriamo possiamo provare a uscire di casa in queste notti fatte più calme e nitide dai mesi sabbatici, cercare le stelle, fare silenzio, attendere le domande - che, mi hanno detto, qualche volta arrivano.
Per qualcuno, poi, c’è stato un altro giorno decisivo. Quando quell’infinitamente piccolo ha fatto l’esperienza che quell’«Amor che move il sole e l’altre stelle» si interessava di lui, di lei, lo cercava, gli parlava, la incontrava. Giorno altrettanto decisivo, perché non basta l’esperienza vera del giorno delle stelle perché inizi la vita religiosa. Ci sono molte persone che sentono veramente vibrare lo spirito di Dio nella natura, odono la sua voce risuonare nelle notti stellate e in molti altri luoghi, ma non si sono mai sentite chiamare per nome da quella stessa voce. Come ci sono altri che hanno fatto un autentico incontro personale con la voce dentro, ma che poi non l’hanno mai sentita vivere nell’universo intero, che non si sono mai commossi riconoscendola nell’immensità del cosmo. È l’incontro tra questi due giorni che segna l’inizio della vita spirituale matura, quando l’immensità che ci svela la nostra infinita piccolezza diventa un tu più intimo del nostro nome.
L’autore del Salmo 8 ha fatto, credo, l’esperienza di entrambi questi giorni. Ha riconosciuto la presenza di YHWH nel firmamento infinitamente grande e si è sentito infinitamente piccolo; e poi ha intuito che la voce che gli parlava tra le galassie era la stessa voce che gli parlava nel cuore: «Come splende, YHWH, il tuo nome su tutta la terra: la bellezza tua voglio cantare, essa riempie i cieli immensi... Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, io mi chiedo davanti al creato: e l’uomo che cos’è? perché di lui ti ricordi? Che cosa è mai questo figlio d’uomo perché tu ne abbia una tale cura?» (8, 2-5). Versi meravigliosi. Dovremmo avere il cuore e le stigmate di Francesco per cantarli.
Assistiamo in presa diretta a una esperienza dell’assoluto. Quell’antico poeta ha avvertito l’immensità e la piccolezza, non si è sentito schiacciato, e ha iniziato un nuovo canto. Il canto dell’umiltà (humilitas) vera, perché l’humus ci dice chi siamo veramente solo se riusciamo per un attimo a guardarlo da distanza siderale; l’adamah (terra) svela l’Adam solo se vista dall’alto. È questa la gioia per la verità finalmente rivelatasi, per una nuova ignoranza che non umilia. L’umiltà è l’opposto dell’umiliazione. E si sperimenta una nuova infanzia, una sconfinata giovinezza: «Da fanciullo e lattante balbetto» (8,3).
Al centro del salmo una domanda: cosa è il figlio d’uomo (Ben Adam: espressione cara ai profeti e ai vangeli), di fronte a tanta immensità?! Splendida è la risposta: nonostante la sua insignificanza in rapporto alle stelle e la sua piccolezza nel tempo e nello spazio, tu ti prendi cura dell’uomo, tu ti ricordi di lui. Come a dire: se tu tenessi conto, o Dio, di quello che l’Adam è oggettivamente in rapporto all’universo sterminato, non dovresti occupartene; e invece ti prendi cura di lui, di lei. E quindi la domanda necessaria: ma questa voce che mi parla dentro è proprio la stessa che ha parlato tra le galassie? La risposta del primo giorno può essere soltanto un sì, altrimenti il cammino non incomincia! Col passare del tempo la risposta diventa: forse. Poi arrivano i lunghi anni quando la risposta è: no. Infine ritorna il sì, ma - se e quando ritorna - è un sì detto con un’altra profondità e un’altra umiltà. E qui nasce una nuova meraviglia, trabocca la gratitudine, riaffiora la preghiera degli ultimi tempi.
Sta in questa tensione tra le stelle e il cuore, abitati entrambi dalla stessa presenza, la dignità dell’Adam, dei suoi figli e delle sue figlie, la sua gloria e il suo onore. Ci si perde nelle varie ideologie quando si perde uno di questi due poli. Dobbiamo leggere il Salmo 8 in parallelo con i primi capitoli della Genesi: «E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). Il versetto della Bibbia che, forse, amo di più. L’Adam è posto da Elohim al centro del giardino della creazione perché ne fosse custode e responsabile. Il Salmo ce lo ridice: «Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi» (Salmo 8,7). L’Adam diventa il primo interlocutore di Dio, perché con la sua reciprocità potesse accompagnare anche la solitudine di Dio - «non è bene che l’uomo sia solo» (Gn 2,18) va letto insieme all’altra frase non scritta nella Bibbia ma altrettanto presente: non è bene che Dio sia solo.
Non mi stupirebbe se l’autore di quell’antico salmo mentre cantava avesse sottomano questi versi della Genesi. Forse stava meditando e contemplando "cosa è l’uomo" quando, ad un certo punto, non ha più retto l’emozione e ha composto uno dei versi più belli sull’uomo mai scritti da tutta la letteratura religiosa e laica. Dopo averlo visto sub specie aeternitatis, dopo essere andato con l’anima sulla luna e averlo perso di vista tanta era la sua piccolezza, tornato a quelle parole della Genesi ha rivisto un altro uomo. E ha pronunciato questo capolavoro, che va letto dopo qualche attimo di silenzio: -«Eppure l’hai fatto poco meno di Elohim, di gloria e di onore lo hai coronato» (8,6). Eppure: a volte la Bibbia sa racchiudere in una umile congiunzione tutta la sua profezia. Siamo effimeri, siamo come l’erba ... eppure... «Una voce dice: "Grida", e io rispondo: "Che cosa dovrò gridare?". Ogni uomo è come l’erba. Secca l’erba, il fiore appassisce ... Veramente il popolo è come l’erba» (Isaia 40,6-7).
 Veramente ... eppure. Siamo stati pensati, cercati e amati tra un veramente e un eppure. Veramente effimeri come l’erba, veramente infinitamente piccoli, veramente infedeli e peccatori; eppure poco meno di Dio, eppure sua immagine e somiglianza, eppure amati, curati e attesi come figli.
Veramente ... eppure. Siamo stati pensati, cercati e amati tra un veramente e un eppure. Veramente effimeri come l’erba, veramente infinitamente piccoli, veramente infedeli e peccatori; eppure poco meno di Dio, eppure sua immagine e somiglianza, eppure amati, curati e attesi come figli.Questa è l’immensa antropologia biblica. La letteratura antica conosceva la metafora dell’immagine di Dio applicata all’uomo. Ma era usata per il re, per il faraone. La Bibbia la usa per ciascuno di noi, per ogni uomo e per ogni donna, per te, per me. È l’Adam, ogni Adam, l’immagine e somiglianza di Elohim; e quindi lo siamo anche noi, tutti noi. È questa la magna carta di ogni dichiarazione dei diritti dell’uomo e della donna, dei bambini, delle bambine, della dignità del creato. Il Salmo 8 è un inno a Dio e insieme un inno all’uomo. Esalta la persona dicendoci chi è quel Dio di cui egli è immagine, ed esalta Dio dicendoci chi sono l’uomo e la donna che lo riflettono. Perché se l’uno è immagine dell’altro, più l’Adam diventa bello più dice la bellezza del suo Creatore, e più lasciamo libero Dio di diventare migliore di noi, più abbelliamo noi stessi. Non capiamo l’antropologia biblica se usciamo dalla reciprocità intrinseca al simbolo dell’immagine.
Ma la bellezza e la forza di questo canto esplodono se immaginiamo il salmista cantare quel versetto 6 mentre leggeva anche i capitoli tre e quattro della Genesi: quelli della disobbedienza, della seduzione vincente del serpente, e poi Caino e il sangue di Abele, di cui il salmista sentiva ancora l’odore. È troppo semplice cantare la gloria e l’onore dell’uomo fermandosi al capitolo due. La sfida decisiva è riuscire a continuare il canto mentre i capitoli scorrono e si entra nelle pagine buie e buissime del no, quelle della rottura dell’armonia uomo-donna-creato-Dio, nelle pagine della cacciata da quel giardino meraviglioso, quelle della notte oscura del primo fratricidio della terra. E giunti lì, non smettere il canto. E poi continuarlo con l’urlo tremendo di Lamek l’uccisore di fanciulli, con la ribellione di Babele, con i peccati dei patriarchi, con le bugie e gli inganni di Giacobbe, con l’omicidio dei beniaminiti, fino all’omicidio di Davide, alle infedeltà di Salomone e di quasi tutti i re d’Israele. E non smettere mai di cantare: «Veramente ... Eppure lo hai fatto poco meno di un Dio».
Tutta la forza dell’antropologia biblica si sprigiona quando riusciamo a vincere il dolore e la vergogna e ripetiamo "veramente ... eppure" non solo di fronte al firmamento ma anche nelle carceri, nelle meschinità, nelle violenze, nei bassifondi di Calcutta, nelle via crucis che portano al Golgota. Non c’è condizione umana che non sia racchiusa tra quel veramente e quell’eppure, nessuno resta fuori. La Bibbia non ha avuto paura di narrarci i peccati e le bassezze dei suoi uomini perché credeva veramente all’immagine di Elohim. E ogni volta che nascondiamo nelle nostre storie le pagine più buie abbiamo smesso di credere che siamo immagine.
Caino ha cancellato la sua fraternità e i suoi figli continuano a cancellarla uccidendo ogni giorno Abele. Ma non ha potuto cancellare l’immagine - e se il "segno di Caino" fosse proprio l’immagine di Elohim? «O Dio, Signore nostro, come splende il tuo nome su tutta la terra!» (8,10).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AL DI LA’ DELL’ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA "COSTANTINIANA"! Materiali per il Concilio di Nicea del 2025.3 maggio 2020, di Federico La Sala
COSTANTINO, IL CONCILIO DI NICEA, E LA DICHIARAZIONE DELL’HOMOOUSIOS. *
- CONCILIO DI NICEA I (325) -
BENEDETTO XVI
Il ritorno di Ratzinger: «Nozze gay e aborto segni dell’Anticristo»
L’anticipazione del nuovo libro del papa emerito
di Redazione Online (Corriere della Sera, 3 maggio 2020).
Il Papa emerito Ratzinger parla di crisi della società contemporanea paragonando al «matrimonio omosessuale» e l’«aborto» al «potere spirituale dell’Anticristo», in una nuova biografia scritta dal suo amico giornalista Peter Seewald, «Ein Leben» che esce lunedì, mentre per la versione italiana e inglese occorrerà aspettare l’autunno, con una intervista dal titolo «Le ultime domande a Benedetto XVI» e che, come nel libro di Sarah, propone ai lettori un verbo che scalda gli animi dell’ala conservatrice della Chiesa, quella parte che gli è rimasta fedele anche dopo la rinuncia dell’11 febbraio 2013. Lo anticipa il sito americano conservatore LifeSiteNews, lo stesso che in questi mesi ha diffuso le uscite anti-Francesco dell’ex nunzio a Washington Carlo Maria Viganò, attacca a testa bassa l’’ideologia dominante’ nella società e opponendosi alla quale, spiega, si è scomunicati. Si percepisce, nel suo dire, l’eco del testo di un anno fa dedicato alla pedofilia, con quella condanna delle aperture iniziate nel ‘68, l’incipit a detta sua del decadimento morale della società e di una crisi irreversibile della Chiesa.
Il nemico è sempre il medesimo: la rivoluzione degli anni Sessanta-Settanta. «Cento anni fa - afferma Benedetto - tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale». Mentre oggi, dice, si è scomunicati dalla società se ci si oppone. E lo stesso vale per «l’aborto e la creazione di esseri umani in laboratorio». E ancora: «La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano e se uno si oppone viene punito dalla società con la scomunica. La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale e ha bisogno dell’aiuto delle preghiere da parte della Chiesa universale per resistere».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"NUOVA ALLEANZA" ?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
- IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE. CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA.
- FILIAZIONE DIVINA E "PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA". VICO: "LA MENTE EROICA". Il testo dell’orazione inaugurale del 1732
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA : VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- LIBERARE IL CIELO: IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU E L’ILLUMINISMO, OGGI.22 aprile 2020, di Federico La Sala
EPIDEMIA, POLITICA, E TEOLOGIA: IL PROBLEMA JEAN-JACQUES ROUSSEAU E L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO...
-
GOVERNO POLITICO ED EPIDEMIA: "[...] In una versione più accettabile e aggiornata della sovranità, come quella fornitaci da Jean-Jacques Rousseau, possiamo quindi dire che sovrano è sempre e solo il popolo; ma allo stesso tempo la volontà sovrana del popolo può venire ad esistenza solo nelle vesti di una volontà altra, quella dei governanti che si troveranno di volta in volta a fare esercizio del potere politico legittimo. Ciò che noi chiamiamo “democrazia”, e che senza indugio parafrasiamo come “potere del popolo”, si basa esattamente su questo semplice meccanismo: la posizione della pura immanenza (la volontà generale dei governati) richiede la posizione della pura trascendenza (una volontà particolare che, per dichiarare sovrani coloro che le obbediscono, deve mettere in forma questa loro generalità).
.Perché questo breve passaggio attraverso i classici del pensiero politico moderno? [...] è necessario articolare un campo tanto del sapere quanto delle istituzioni che sia capace di comprendere questo altro che per il momento resta “impossibile” o quantomeno “impensabile”. [...] La sfida, che gli antichi sono riusciti a modo loro a fare propria e che la modernità ha invece rifiutato, è quella di pensare l’unità di due momenti che, come abbiamo visto, il pensiero della democrazia non riesce a tenere fermi perché ci rimbalza all’infinito dall’uno all’altro [....]
 Questo significa anche che il problema della giustizia richiede non che sia data una risposta definitiva, valida per sempre, ma che sussista uno spazio “costituzionale” nel quale si dispieghi un processo di continua mediazione tra la pluralità sempre destabilizzante delle idee sul giusto e l’unità necessaria affinché la società nel suo complesso possa darsi un orientamento comune.
Questo significa anche che il problema della giustizia richiede non che sia data una risposta definitiva, valida per sempre, ma che sussista uno spazio “costituzionale” nel quale si dispieghi un processo di continua mediazione tra la pluralità sempre destabilizzante delle idee sul giusto e l’unità necessaria affinché la società nel suo complesso possa darsi un orientamento comune.
 Mediazione dunque tra la differenza e l’identità, senza cedere a quel gioco di specchi nel quale l’assolutizzazione di una pura differenza (la moltitudine degli individui privi di relazione) si ribalta immediatamente nell’assoluta indifferenza dell’Uno identico a sé (la legge incondizionata di un soggetto assoluto, sia esso Dio, il popolo o perfino un virus). È proprio questo spazio che il pensiero moderno della sovranità e della democrazia ha chiuso, perché assolutizzando la volontà dei cittadini come fondamento esclusivo della legge ha paradossalmente assolutizzato, di contro, l’arbitrio del tutto soggettivo del governante legittimo " (Pierpaolo Cesaroni e Lorenzo Rustighi, "Sul governo politico: riflessioni a partire dall’epidemia", Le parole e le cose, 22.04.2020).
Mediazione dunque tra la differenza e l’identità, senza cedere a quel gioco di specchi nel quale l’assolutizzazione di una pura differenza (la moltitudine degli individui privi di relazione) si ribalta immediatamente nell’assoluta indifferenza dell’Uno identico a sé (la legge incondizionata di un soggetto assoluto, sia esso Dio, il popolo o perfino un virus). È proprio questo spazio che il pensiero moderno della sovranità e della democrazia ha chiuso, perché assolutizzando la volontà dei cittadini come fondamento esclusivo della legge ha paradossalmente assolutizzato, di contro, l’arbitrio del tutto soggettivo del governante legittimo " (Pierpaolo Cesaroni e Lorenzo Rustighi, "Sul governo politico: riflessioni a partire dall’epidemia", Le parole e le cose, 22.04.2020).
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO: "[...] Rousseau cerca in tutti i modi di impostare bene il "trattato le cui condizioni siano eque" (Virgilio, Eneide, XI), ma perde il filo e, alla fine, si ritrova a riproporre la religione dei romani - la "religione civile", contro la "religione romana", cattolica ! Senza volerlo, prepara la strada "cattolico-romana" a Fichte, a Hegel, a Marx, a Gentile e a Lenin.
Kant reimposta il problema e riparte, bene : "tutto proviene dall’esperienza, ma non tutto si risolve nell’esperienza" o, diversamente, tutto viene dalla natura ma non tutto si risolve nella natura ; alla fine egli non riesce a sciogliere il nodo e resta in trappola. Al di là del mare di nebbia non può andare e - per non distruggere i risultati della sua esplorazione - si accampa lì dove è riuscito ad arrivare e decide: Io voglio che Dio esista.
Per Kant, Rousseau e Newton, come Locke, non sono stati affatto cattive guide per il suo viaggio. Il suo cammino è stato lungo, fruttuoso e coraggioso : la Legge morale dentro di me, il Cielo stellato sopra di me ! E, onestamente, rilancia di nuovo la domanda antropologica, quella fondamentale: "Che cosa è l’uomo?". Teniamone conto.
Ciò che essi cercavano di capire e quindi di sciogliere era proprio il nodo che lega il problema "religioso", il legame "sociale", il problema di "Dio", il problema della Legge, non quello o quella dei Faraoni e quella di una Terra concepita come un "campo recintato" o assoggettata alla "Moira" di Orfeo e alla Necessità.
Filosoficamente, è il problema dell’inizio ... e, con esso, dell’origine e dei fondamenti della disuguaglianza tra gli esseri umani. Il problema J.J. Rousseau, dunque: No King, no Bishop! Il problema della Legge - e della Lingua: il problema stesso del principio di ogni parola, la Langue, Essai sur l’origine des langues! Da dove il Logos e la Legge?! E, con queste domande, siamo già all’oggi, agli inizi del ’900 : Ferdinand de Saussure ! Ma ritorniamo al problema politico, della Legge della Polis o, come scrive Rousseau, della Citè. La questione è decisiva ed epocale: ed è al contempo questione antropologica, politica, e "teologica". In generale è la questione del rapporto Uno-Molti - una questione lasciata in eredità da Platone, e riproposta da Rousseau, nei termini del rapporto volontà generale - volontà di tutti o del cosiddetto "uno frazionario", e risolta ancor oggi nell’orizzonte moderno (cartesiano) - dopo Cristo, come dopo Dante, Rousseau e Kant - in modo greco, platonico-aristotelico. Una tragedia, e non solo quella di Nietzsche. In tutti i sensi.
Se continuiamo a truccare le carte e confondiamo l’Uno al numeratore con un "uno" degli "uno" o delle "uno" al denominatore finiremo per cadere sempre nella trappola della dittatura, e nel dominio del "grande fratello". E non riusciremo mai a distinguere tra "Dio" Amore [Charitas], e "Dio" Mammona [Caritas] - tra la "volontà generale" dell’Uno e la "volontà generale" di "uno", camuffato da "Uno". Liberare il cielo, pensare l’ "edipo completo" - come da progetto di Freud.
Vedere solo i molti (gli individui, meglio gli uomini e donne in carne ed ossa, le persone) che agiscono, discutono e lottano, e non vedere l’Uno, che è il Rapporto e il Fondamento di tutti e il Rapporto dell’Uno stesso con tutti i vari sotto-rapporti (economici, politici, religiosi, giuridici, pedagogici, familiari, e, persino, di amicizia) dei molti e tra i molti ... non porta da nessuna parte, se non alla guerra e alla morte. In tale orizzonte (relativistico, scettico e nichilistico), chi vuole guidare chi, che cosa può fare, che cosa può insegnare, che cosa può produrre ... se non il suo stesso "uno" - allo specchio ? Un narcisismo personale e istituzionale, imperialistico e ... desertificante !
È elementare, ma è così - come scriveva l’oscuro di Efeso, Eraclito : "bisogna seguire ciò che è comune : e ciò che è comune è il Logos" - la Costituzione, prima di ogni calcolo, per ragionare bene. La Costituzione è il fondamento, il principio, e la bilancia!!! Questo è il problema : la cima dell’iceberg davanti ai nostri occhi, e il punto più profondo sotto i nostri stessi piedi !!! E se non vogliamo permanere nella "preistoria" e, anzi, vogliamo uscirne, dobbiamo stare attenti e attente e ripensare tutto da capo, dalla radice (Kant, Marx), dalle radici: gli uomini e le donne, i molti, e il Rapporto-Fondamento che li collega e li porta - al di là della natura - nella società, e li fa essere ed esseri umani - dopo il lavoro in generale, il rapporto sociale di produzione in generale è la questione all’ordine del giorno nostro, oggi. [....]" . (Cfr.L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana").
-
GOVERNO POLITICO ED EPIDEMIA: "[...] In una versione più accettabile e aggiornata della sovranità, come quella fornitaci da Jean-Jacques Rousseau, possiamo quindi dire che sovrano è sempre e solo il popolo; ma allo stesso tempo la volontà sovrana del popolo può venire ad esistenza solo nelle vesti di una volontà altra, quella dei governanti che si troveranno di volta in volta a fare esercizio del potere politico legittimo. Ciò che noi chiamiamo “democrazia”, e che senza indugio parafrasiamo come “potere del popolo”, si basa esattamente su questo semplice meccanismo: la posizione della pura immanenza (la volontà generale dei governati) richiede la posizione della pura trascendenza (una volontà particolare che, per dichiarare sovrani coloro che le obbediscono, deve mettere in forma questa loro generalità).
.Perché questo breve passaggio attraverso i classici del pensiero politico moderno? [...] è necessario articolare un campo tanto del sapere quanto delle istituzioni che sia capace di comprendere questo altro che per il momento resta “impossibile” o quantomeno “impensabile”. [...] La sfida, che gli antichi sono riusciti a modo loro a fare propria e che la modernità ha invece rifiutato, è quella di pensare l’unità di due momenti che, come abbiamo visto, il pensiero della democrazia non riesce a tenere fermi perché ci rimbalza all’infinito dall’uno all’altro [....]
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA FINE DI UN MONOTEISMO CIECO E ZOPPO E LA COMUNITA’ CHE VIENE.14 aprile 2020, di Federico La Sala
LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO, LA FEDELTA’ ALL’ AMORE DI HEIDEGGER ED HANNAH ARENDT, LA FINE DI UN MONOTEISMO CIECO E ZOPPO E LA COMUNITA’ CHE VIENE ... *
A) - UNA CASA DI CURA, UN OSPEDALE DA CAMPO: [...] Proprio un totalitarismo apolitico ed economico - fondato su una idea di soggetto come arbitrario e indefinito dispiegamento delle proprie potenzialità - ha impedito sinora di far fronte a tali questioni. Come la pandemia, si tratta di sfide che minano la sopravvivenza. Il virus ha scoperchiato il tetto e ci ha rigettato nella storia. Si può dunque iniziare da qui: dalla condizione storica in cui ci troviamo, che non è regredibile, e che è quella che la biopolitica analizza con acume. Se è vero che il potere sovrano si rivolge sempre più ai corpi, trovando un paradigma nell’oikos o nel campo, allora la “comunità che viene”, costituita da libertà non pure e astratte, ma malate e inchiodate a questi corpi, non potrà che iniziare a costituirsi nella forma di una casa di cura, o di un “ospedale da campo.” ( Francesco Valerio Tommasi, “Curarsi di. Una libertà inchiodata al corpo e alla storia”, Le parole e le cose, 14 aprile 2020);
B) - “UN NUOVO INIZIO”: “[...] Ma rimane altresì vero che ogni fine della storia contiene necessariamente un nuovo inizio; questo inizio è la promessa, l’unico «messaggio» che la fine possa presentare. L’inizio, prima di diventare avvenimento storico, è la suprema capacità dell’uomo; politicamente si identifica con la libertà umana. «Initium ut esset, creatus est homo», dice Agostino. Questo inizio è garantito da ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo” (Hannah Arendt, “Le origini del totalitarismo”, Edizioni di Comunità, Milano 1996);
C) - ANTROPOLOGIA: KANT E LA RISCOPERTA DEL CORPO, LA RICERCA DI ENZO PACI SULLA NASCITA e la “fedeltà all’amore” di HEIDEGGER e ARENDT;
D) - CORONAVIRUS O SOVRANITA’ ( “CORONA VIRTUS”) ?! FILOLOGIA: ECCE HOMO! Ad evitare problemi di un cieco e zoppo monoteismo teologico-politico e biologico e uscire dal letargo e dalla caverna, ricordare che Ponzio Pilato disse: “«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)”;
E) - LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
*
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- USCIRE DAL LETARGO: L’"ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE" COSTANTINIANA, LA "STORIA" DI IPAZIA, E I "DUE SOLI".13 aprile 2020, di Federico La Sala
LA "STORIA" DI IPAZIA, I "DUE SOLI", E L’"ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE" COSTANTINIANA ... *
Ipazia, sedici secoli di bugie
La filosofa di Alessandria d’Egitto fu uccisa nel 415 da un gruppo di fanatici cristiani. E’ passata alla storia come una martire della scienza, versione femminile di Galileo. Ma la sua vicenda nasconde un mistero ancora piu’ inquietante.
di Luisa Muraro ("Giudizio Universale", 11.12.2009)
Ipazia di Alessandria ha un conto aperto con la nostra civilta’ che dobbiamo incominciare a pagare.
Parlo, per chi ancora non conoscesse questo nome, della scienziata e filosofa neoplatonica, maestra nel Museo di Alessandria d’Egitto (non un museo, ma un centro di studi superiori) che, nell’anno 415 dell’era cristiana, venne trucidata da un gruppo organizzato di cristiani fanatici. Il delitto resto’ impunito perche’ l’inviato imperiale non fece il suo dovere.
Da parte di chi ha a cuore la tradizione religiosa cristiana, io mi aspetto un preciso contributo. Posto che le fonti non consentono di attribuire al vescovo di Alessandria, il futuro santo e padre della Chiesa Cirillo, alcuna responsabilita’ diretta nella morte violenta della filosofa, si stabiliscano le innegabili responsabilita’ indirette, nel contesto di una diffusione del cristianesimo che e’ piena di luci e ombre.
Da coloro che hanno a cuore le grandi conquiste della modernita’ (liberta’ di pensiero, pluralismo, liberta’ di ricerca, valore delle scienze sperimentali), mi aspetto che smettano di strumentalizzare la figura della filosofa deformandola in quella di una martire della libera scienza. Le fonti storiche non autorizzano questa rappresentazione che si alimenta da una serie di stereotipi, gia’ confutati, sulla storia delle scienze e la cultura cattolica. Non si faccia di Ipazia un anacronistico pendant femminile di Galileo.
 Lei fu indubbiamente una scienziata di prima grandezza e, come Galileo, si dedico’ all’astronomia con avanzate tecniche di osservazione. L’analogia finisce qui. La famosa vicenda del processo di Galileo riguarda il protagonista di una svolta epocale nell’idea di scienza, che non ha nulla a che fare con l’epoca di Ipazia, il cui tempo fu agitato da una somma di problemi che non riguardavano la concezione della scienza, se non molto indirettamente.
Lei fu indubbiamente una scienziata di prima grandezza e, come Galileo, si dedico’ all’astronomia con avanzate tecniche di osservazione. L’analogia finisce qui. La famosa vicenda del processo di Galileo riguarda il protagonista di una svolta epocale nell’idea di scienza, che non ha nulla a che fare con l’epoca di Ipazia, il cui tempo fu agitato da una somma di problemi che non riguardavano la concezione della scienza, se non molto indirettamente.
 Detto in breve, Galileo e’ il campione e il martire del nuovo che avanza. Ipazia e’ l’esponente di una tradizione secolare (millenaria, se contiamo l’Egitto) e venne schiacciata dal nuovo avanzante, il cristianesimo, che fu anche rivoluzione sociale, non dimentichiamo.
Detto in breve, Galileo e’ il campione e il martire del nuovo che avanza. Ipazia e’ l’esponente di una tradizione secolare (millenaria, se contiamo l’Egitto) e venne schiacciata dal nuovo avanzante, il cristianesimo, che fu anche rivoluzione sociale, non dimentichiamo.Il mio contributo al pagamento del debito che abbiamo verso Ipazia, consistera’ nell’esporre, in forma di racconto basato sulle fonti storiche, le circostanze che portarono alla sua uccisione.
Di Ipazia non abbiamo una data di nascita, possiamo immaginare che fu intorno al 370. Trascorse la sua vita ad Alessandria; non risulta che abbia fatto viaggi fuori dalla sua citta’. Le fonti la ricordano come figlia di Teone, scienziato del Museo; di lui fu allieva, collaboratrice e, in un certo senso, successora. Le fonti dicono che lei lo supero’. Della sua opera non si e’ conservato quasi nulla.
Intorno al 375 nacque ad Alessandria anche Cirillo, che crebbe all’ombra dello zio Teofilo cui succedette sul seggio episcopale nel 412. Come lo zio, era un uomo di grande decisione, al limite della spregiudicatezza.
 Per favorire la Chiesa, Cirillo cerco’ l’alleanza del prefetto imperiale Oreste, un battezzato anche lui ma poco propenso a schierarsi con i cristiani.
Per favorire la Chiesa, Cirillo cerco’ l’alleanza del prefetto imperiale Oreste, un battezzato anche lui ma poco propenso a schierarsi con i cristiani.Scoppiarono incidenti, uno gravissimo nel 415: un gruppo di monaci venuti dal deserto (i cosiddetti parabolani) per servire il vescovo, a che titolo non sappiamo, assaltarono il carro del prefetto e riuscirono a ferirlo con una sassata. Il loro capo fu catturato e duramente punito, Cirillo voleva farne un martire ma i cittadini si opposero, compresi alcuni cristiani. Siamo alla vigilia dell’uccisione di Ipazia.
Bisogna sapere che Oreste era un ammiratore della filosofa e aveva preso l’abitudine di consultarla sui problemi della citta’. All’epoca Alessandria era una citta’ multietnica, abitata da elleni, egizi, ebrei, costellata da vari edifici religiosi: sinagoghe, templi alle divinita’ greche ed egizie, chiese cristiane. Il gruppo dominante e’ costituito dagli elleni (gli abitanti di origine greca), molti dei quali stavano passando al cristianesimo, che era diventato la religione dell’imperatore.
 Ipazia, che apparteneva a questo gruppo sociale, non era cristiana. Fra i suoi allievi aveva tuttavia dei cristiani, come Sinesio, il futuro vescovo di Cirene, che la chiamava "madre" e "patrona", e su di lei ha lasciato una preziosa testimonianza scritta.
Ipazia, che apparteneva a questo gruppo sociale, non era cristiana. Fra i suoi allievi aveva tuttavia dei cristiani, come Sinesio, il futuro vescovo di Cirene, che la chiamava "madre" e "patrona", e su di lei ha lasciato una preziosa testimonianza scritta.Le fonti raccontano che un giorno il vescovo Cirillo si trovo’ a passare nei pressi della casa di Ipazia e noto’ un assembramento di carri, lettighe e guardie.
- "Di chi e’ quella casa? Che cosa sta succedendo?".
- "E’ la casa della filosofa Ipazia - gli rispose uno del seguito - quelli che vedi, sono i curiali del prefetto, lui deve essere venuto con altri a salutarla e ad ascoltarla".
Il vescovo, possiamo immaginare, senti’ una fitta penosa nell’anima. Per certo il nome di quella donna, famosa in citta’, non gli era nuovo. Nuovo fu per lui scoprire che il prefetto si degnasse di farle visita, dopo che aveva rifiutato l’offerta fatta da lui, Cirillo, che era un uomo e un vescovo.
 Le fonti ci autorizzano a immaginare anche il pensiero che segui’ a quel penoso, ma cosi’ umano! sentimento: "Ad Alessandria le cose andrebbero meglio se io e il prefetto fossimo amici. Io e il prefetto non siamo amici per colpa di Ipazia che si e’ messa di mezzo e ha attirato Oreste nella sua orbita".
Le fonti ci autorizzano a immaginare anche il pensiero che segui’ a quel penoso, ma cosi’ umano! sentimento: "Ad Alessandria le cose andrebbero meglio se io e il prefetto fossimo amici. Io e il prefetto non siamo amici per colpa di Ipazia che si e’ messa di mezzo e ha attirato Oreste nella sua orbita".Questo e’ l’antefatto. Il fatto e’ che un giorno del marzo 415 un gruppo di parabolani, guidati da un tale di nome Pietro il lettore, sequestro’ Ipazia, la porto’ in una chiesa e qui, al chiuso, la trucidarono usando strumenti taglienti che non erano coltelli, forse pezzi di vetro o di conchiglia. Poi ne portarono i resti in una localita’, il Cinarone, forse assegnata alla eliminazione di materie di scarto con il fuoco, e qui li bruciarono.
Da questo insieme di fatti risulta che Ipazia, se siamo alla ricerca di un titolo da dare alla sua morte, fu principalmente una martire politica.
Colpita per colpire il prefetto imperiale, e’ la prima supposizione, Ma, se allarghiamo lo scenario storico, le circostanze suggeriscono piuttosto che lei fu eliminata perche’ disturbava, con la sua indipendenza, l’antagonismo fra due poteri, quello imperiale e quello ecclesiastico, che erano anche due uomini, Oreste e Cirillo, e impediva cosi’ che i due poteri e i due uomini arrivassero a trovare un compromesso per una conveniente alleanza.
 A cio’ si aggiunga un senso di rivalita’ del capo della Chiesa alessandrina nei confronti di quella donna che, stando alla testimonianza di Sinesio, aveva l’autorita’ di una sacerdotessa.
A cio’ si aggiunga un senso di rivalita’ del capo della Chiesa alessandrina nei confronti di quella donna che, stando alla testimonianza di Sinesio, aveva l’autorita’ di una sacerdotessa.
 La filosofa e il vescovo erano entrambi sprovvisti del potere della forza; l’efficacia della loro azione dipendeva dall’autorita’ della loro parola e dal credito di cui godevano presso i detentori del potere politico.
La filosofa e il vescovo erano entrambi sprovvisti del potere della forza; l’efficacia della loro azione dipendeva dall’autorita’ della loro parola e dal credito di cui godevano presso i detentori del potere politico.Sicuramente contarono anche altre circostanze, fra cui il conflitto tra la cultura del mondo antico declinante e la nuova religione cristiana, purche’ abbiamo chiaro che il conflitto non si configurava come un antagonismo e che la vittoria del cristianesimo era ormai evidente. Conto’ il fatto che non di un filosofo si trattasse, ma di una filosofa? La domanda va riformulata, considerato che non esistono culture in cui la differenza sessuale sia indifferente. Quanto conto’, nella vicenda di Ipazia? E abbiamo noi modo di stabilirlo? Senza addentrarci, consideriamo che la nascente religione cristiana, a differenza di quella grecoromana e di quella egizia, non rendeva pensabile e accettabile una donna con le prerogative di Ipazia, libera di se’, non subordinata a partiti o fazioni, presente e parlante in luoghi pubblici, sapiente, maestra dotata di una parola autorevole per donne e uomini.
Questa considerazione ci porta ai nostri tempi per costatare che il tipo umano femminile incarnato da una Ipazia non ha corso nella nostra cultura, forse perche’ essa deriva dalla versione cristiana del patriarcato. Il che ci fa capire il perche’ di certi stereotipi laici o laicisti: questi stereotipi resistono e si ripresentano per non poter ammettere che quello che faceva veramente problema ai cristiani di Alessandria, continua a fare problema anche ai nostri giorni, e non solo ai "cristiani"! Voglio dire che gli stereotipi anticlericali con cui si accosta la figura e la vicenda di Ipazia (Chiesa nemica della scienza, della ragione, delle donne) sono fatti per coprire una certa coda di paglia.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- LA "MONARCHIA" DI DANTE, IL GIUSTO AMORE, E IL VATICANO CON IL SUO TRADIZIONALE SOFISMA DELLA "FALLACIA ACCIDENTIS".
- DIO, LINGUA, E SOCIETA’. DANTE E SAUSSURE: UNA SOLA TEORIA, QUELLA DEI "DUE SOLI".
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?"
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA" !!! IL MAGGIORASCATO : L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, -L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
“VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---MILLE ANNI DOPO DAVIDE E GIONATA. Se gli amici fanno le ali della storia (di Luigino Bruni).11 aprile 2020, di Federico La Sala
DOPO I “VENTICINQUE SECOLI” DI DANTE, I "TREMILA ANNI" DI GOETHE, E I "MILLE ANNI DOPO DAVIDE E GIONATA" .. *
- [...] Mille anni dopo Davide e Gionata, un altro amico dell’uomo, fondatore di una comunità di amici («non vi chiamo più servi ma amici»), fu messo su una croce da un’altra mano fratricida. Sotto la croce c’erano le donne, e un amico. Quella volta le donne e l’amico non riuscirono a salvarlo. Ma noi, suoi amici, continuiamo ad attenderlo, in compagnia di Abele e di tutte le vittime della storia. Lo aspettiamo perché ci ha promesso che tornerà, e perché la promessa dell’amico è vera (Luigino Bruni, "Se gli amici fanno le ali della storia", Avvenire, 06.04.2020) .
Idee.
Se gli amici fanno le ali della storia
La philia e l’eros dell’antica Grecia acquistano una diversa ricchezza di significato alla luce dell’agape evangelica. Il libro di Pietro Del Soldà
di Luigino Bruni (Avvenire, giovedì 9 aprile 2020)
Uno degli effetti collaterali del covid19 è la ri-scoperta (o scoperta) della semantica dell’amicizia. Ci stiamo abituando a lezioni online, riunioni di lavoro via zoom, videochiamate, tesi di laurea online con il vestito buono e applauso dei genitori commossi e nascosti dietro la camera; ma ogni volta che terminiamo queste sessioni telematiche ci nasce, troppo spesso, una forte nostalgia per i nostri studenti, per i colleghi, per genitori e amici, per il bar dove andavamo per “consumare” prima la chiacchierata poi il caffé. Gli incontri che stanno continuando ad accadere in questa lunga quarantena non sono solo semplicemente incontri “virtuali” (parola che morirà con la fine della pandemia), sono comunque incontri ai quali mancano alcune dimensioni fondamentali, e tra queste il corpo. Ci sono voluti migliaia di anni per imparare a stare vicini a meno di un metro di distanza, a dare la mano allo sconosciuto per dirgli che su quella mano non c’era un pugnale, e poi ad abbracciare e baciare gli amici.
Ci sono voluti troppi millenni per apprendere l’arte delle distanze brevi per poter pensare di poterle dimenticare in pochi mesi. L’amicizia è l’arte delle distanze brevi. Distanze affettive, ma anche distanze fisiche, geografiche, spaziali. Perché se i verbi dell’amicizia sono quelli del tempo (fedeltà, durata, resilienza), anche i tempi dello spazio sono importanti: se non si va dall’amico o l’amicizia si è indebolita o c’è un ostacolo all’incontro o c’è solo un grande desiderio, come quello immenso che sta crescendo giorno dopo giorno. E mentre le distanze tra di noi sono cresciute, la lotta col virus si gioca sulla capacità di cura di medici e infermieri, che è anche talento delle mani, che devono toccare senza contaminare e contaminarsi.
L’ambivalenza della vita, la danza di communitas e immunitas, che ogni tanto diventa danza macabra. L’amore è uno, ma gli amori sono molti. Amiamo molte persone e molte cose, siamo amati da molti e in modi diversi. Amiamo i genitori, i figli, le fidanzate, le mogli e i mariti, fratelli e sorelle, maestre, colleghi, nonni e cugini, poeti e artisti. E amiamo, moltissimo, gli amici e le amiche.
 Il mondo greco per dire amore aveva due parole principali, eros e philia, due parole che non esaurivano le molte forme dell’amore ma che offrivano un registro semantico più ricco del nostro per declinare questa parola fondamentale della vita. Un lessico che era capace di distinguere il «ti voglio bene» detto alla donna amata dal «ti voglio bene detto» detto a un amico, e allo stesso tempo riconoscere che erano anche uguali. Il cristianesimo, poi, ha aggiunto una terza parola greca per dire un’altra tonalità dello stesso amore, un tono già presente nella Bibbia ebraica e, soprattutto, già presente nella vita.
Il mondo greco per dire amore aveva due parole principali, eros e philia, due parole che non esaurivano le molte forme dell’amore ma che offrivano un registro semantico più ricco del nostro per declinare questa parola fondamentale della vita. Un lessico che era capace di distinguere il «ti voglio bene» detto alla donna amata dal «ti voglio bene detto» detto a un amico, e allo stesso tempo riconoscere che erano anche uguali. Il cristianesimo, poi, ha aggiunto una terza parola greca per dire un’altra tonalità dello stesso amore, un tono già presente nella Bibbia ebraica e, soprattutto, già presente nella vita.Questa terza, stupenda, parola è agape, l’amore che sa amare chi non è desiderabile e il non-amico. Il cristianesimo non ha inventato l’agape lo ha semplicemente visto ed esaltato. Tre dimensioni dell’amore che, spesso, si trovano insieme nei rapporti veri e importanti. Certamente sono tutti presenti nell’amicizia, che non è solo philia. Non dobbiamo, infatti, commettere l’errore di pensare che l’amicizia sia espressa dalla sola parola philia. No. Perché anche nel mondo greco la philia non è mai sola, è la philia la prima ad avere bisogno di amici.
 La philia è sempre accompagnata dal desiderio-passione per l’amico ed è irrorata dall’agape che le consente di poter risorgere da fallimenti e fragilità. La philia poi lega l’eros e l’agape tra di loro e li affratella. In quelle pochissime amicizie che ci accompagnano per lunghi tratti di vita, a volte fino alla fine, la philia racchiude in sé anche i colori e i sapori dell’eros e dell’agape. Sono quegli amici che abbiamo abbracciato, baciato come e diversamente da altri abbracci e da altri baci. Pochi dolori sono più grandi di quello per la morte di un amico - in quel giorno, un pezzo di cuore smette di battere. Non c’è soltanto una lotta radicale tra eros e tanatos; ce n’è un’altra, simile e diversa, tra philia e tanatos.
La philia è sempre accompagnata dal desiderio-passione per l’amico ed è irrorata dall’agape che le consente di poter risorgere da fallimenti e fragilità. La philia poi lega l’eros e l’agape tra di loro e li affratella. In quelle pochissime amicizie che ci accompagnano per lunghi tratti di vita, a volte fino alla fine, la philia racchiude in sé anche i colori e i sapori dell’eros e dell’agape. Sono quegli amici che abbiamo abbracciato, baciato come e diversamente da altri abbracci e da altri baci. Pochi dolori sono più grandi di quello per la morte di un amico - in quel giorno, un pezzo di cuore smette di battere. Non c’è soltanto una lotta radicale tra eros e tanatos; ce n’è un’altra, simile e diversa, tra philia e tanatos.
 Il bel libro di Pietro del Soldà, noto conduttore di Radio3 e filosofo, dal titolo suggestivo Sulle ali degli amici. Una filosofia dell’incontro (Marsilio, pagine 152, euro 16), ci offre una occasione propizia per riflettere, oggi, sull’amicizia. Del Soldà lo fa a partire dalla filosofia e dal mondo greco. Questa mia pagina lo fa prendendo le mosse dalla Bibbia, una seconda radice profonda dell’Umanesimo occidentale. La Bibbia non parla molto di amicizia. Ma ne parla, e in alcuni libri le ha dato un posto centrale.
Il bel libro di Pietro del Soldà, noto conduttore di Radio3 e filosofo, dal titolo suggestivo Sulle ali degli amici. Una filosofia dell’incontro (Marsilio, pagine 152, euro 16), ci offre una occasione propizia per riflettere, oggi, sull’amicizia. Del Soldà lo fa a partire dalla filosofia e dal mondo greco. Questa mia pagina lo fa prendendo le mosse dalla Bibbia, una seconda radice profonda dell’Umanesimo occidentale. La Bibbia non parla molto di amicizia. Ma ne parla, e in alcuni libri le ha dato un posto centrale.A partire dall’Adam, l’essere umano, che è anche amico di Dio, prima di essere amico della donna e degli altri uomini. E non certamente a caso in uno degli ultimi episodi dell’ultimo vangelo, quello di Giovanni, troviamo un bellissimo dialogo sull’amicizia: «Pietro, tu mi ami [agape]? - Sì, Signore, ti amo [philia]. Pietro, tu mi ami [agape]? - Sì, Signore, ti amo [philia]. Pietro, tu mi ami [philia]?» ( Vangelo di Giovanni 21,15-17). Un gioco di parole e di verbi che si perde nelle lingue moderne, ma chiarissimo nell’originale greco.
 Il libro di Giobbe, ad esempio, è composto essenzialmente di dialoghi con i suoi amici: «Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Sofar di Naamà, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Levarono la loro voce e si misero a piangere » (Giobbe 2,11-12).
Il libro di Giobbe, ad esempio, è composto essenzialmente di dialoghi con i suoi amici: «Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano abbattute su di lui. Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Sofar di Naamà, e si accordarono per andare a condividere il suo dolore e a consolarlo. Levarono la loro voce e si misero a piangere » (Giobbe 2,11-12).
 Dal contesto si capisce che questi uomini che si recano presso il mucchio di letame di Giobbe siano amici veri: vengono a sapere della sua sventura, lo vanno a trovare, siedono e piangono con lui. Ma lo sviluppo dei dialoghi di Giobbe ci mostrerà che quei quattro uomini che lo vanno a trovare non sono, in realtà, amici di Giobbe ma difensori di astratte teologie che si riveleranno nemiche dell’uomo e di quel Dio che volevano difendere. Le grandi prove della vita sono anche test che distinguono il grano degli amici dalla zizzania dei finti amici. Ecco perché tra i canti più belli di Giobbe c’è una un’amara e stupenda riflessione sull’amicizia e sull’esistere: «I miei amici sono incostanti come un torrente, come l’alveo dei torrenti che scompaiono: sono torbidi per il disgelo, si gonfiano allo sciogliersi della neve, ma al tempo della siccità svaniscono e all’arsura scompaiono dai loro letti» (6,14-19).
Dal contesto si capisce che questi uomini che si recano presso il mucchio di letame di Giobbe siano amici veri: vengono a sapere della sua sventura, lo vanno a trovare, siedono e piangono con lui. Ma lo sviluppo dei dialoghi di Giobbe ci mostrerà che quei quattro uomini che lo vanno a trovare non sono, in realtà, amici di Giobbe ma difensori di astratte teologie che si riveleranno nemiche dell’uomo e di quel Dio che volevano difendere. Le grandi prove della vita sono anche test che distinguono il grano degli amici dalla zizzania dei finti amici. Ecco perché tra i canti più belli di Giobbe c’è una un’amara e stupenda riflessione sull’amicizia e sull’esistere: «I miei amici sono incostanti come un torrente, come l’alveo dei torrenti che scompaiono: sono torbidi per il disgelo, si gonfiano allo sciogliersi della neve, ma al tempo della siccità svaniscono e all’arsura scompaiono dai loro letti» (6,14-19).Molti amici svaniscono nel tempo della sventura, e svanendo ci dicono che non erano amici. Ma è con Gionata, figlio di re Saul, che l’amicizia fa il suo grande ingresso nella Bibbia. Gionata è principe, è guerriero, ma è soprattutto l’amico. Questa amicizia prende le forme di un patto solenne, forse un “patto di sale”, dove la non corruzione del sale diceva simbolicamente il “per sempre”.
 La Bibbia sa cos’è un patto- Alleanza, e se ricorre a questa parola per parlarci di un’amicizia, allora sta dicendo qualcosa di importante. Nell’Alleanza con Abramo, Dio passò in mezzo agli animali squarciati. Nei grandi patti d’amicizia, Dio passa “in mezzo” agli amici (Matteo 18,20). È quindi un patto che buca spazio e tempo. Coinvolge le nostre discendenze, i nostri figli che abbiamo e che avremo, genitori e nonni. I patti di amicizia, diversamente dai patti nuziali, non vengono in genere celebrati con la parola. Quasi sempre sono patti muti, non vengono pronunciati in pubblico. Qualche volta, però, in una amicizia che matura ci possono essere anche dei patti espliciti, celebrati anche con la parola. Sono, ad esempio, quei patti di amicizia alla base di nuove comunità e movimenti, civili o religiosi, generati da due o più amici che si dicono parole speciali in un momento speciale. Una grande amicizia biblica è quella tra Davide e Gionata, che prende la forma di un patto sacro, di un’alleanza solenne, di una vera e propria fraternità spirituale: la fraternità è una forma di amicizia. Un giorno Gionata, quando ormai infuriava la guerra civile tra suo padre Saul e Davide, aveva detto al suo amico Davide: «Andiamo ai campi» (20,11).
La Bibbia sa cos’è un patto- Alleanza, e se ricorre a questa parola per parlarci di un’amicizia, allora sta dicendo qualcosa di importante. Nell’Alleanza con Abramo, Dio passò in mezzo agli animali squarciati. Nei grandi patti d’amicizia, Dio passa “in mezzo” agli amici (Matteo 18,20). È quindi un patto che buca spazio e tempo. Coinvolge le nostre discendenze, i nostri figli che abbiamo e che avremo, genitori e nonni. I patti di amicizia, diversamente dai patti nuziali, non vengono in genere celebrati con la parola. Quasi sempre sono patti muti, non vengono pronunciati in pubblico. Qualche volta, però, in una amicizia che matura ci possono essere anche dei patti espliciti, celebrati anche con la parola. Sono, ad esempio, quei patti di amicizia alla base di nuove comunità e movimenti, civili o religiosi, generati da due o più amici che si dicono parole speciali in un momento speciale. Una grande amicizia biblica è quella tra Davide e Gionata, che prende la forma di un patto sacro, di un’alleanza solenne, di una vera e propria fraternità spirituale: la fraternità è una forma di amicizia. Un giorno Gionata, quando ormai infuriava la guerra civile tra suo padre Saul e Davide, aveva detto al suo amico Davide: «Andiamo ai campi» (20,11).La Bibbia conosce molto bene questa frase. Era stata quella di Caino (4,8). L’amico è l’anti-Caino, qualcuno che ti invita ad andare nei campi non per ucciderci ma per salvarci. Sulla terra gli inviti di Caino, il fratricida, e quelli di Gionata, l’amico, coesistono, vivono l’uno accanto all’altro, si incrociano. Qualche volta scopriamo che l’altro non è Gionata ma Caino solo quando, arrivati nei campi, vediamo la sua mano diventare diversa. E sono i giorni più tristi. Altre volte scopriamo che chi pensavamo fosse Caino era in realtà Gionata. L’umanità continua la sua storia perché gli inviti di Gionata sono più numerosi degli inviti di Caino, perché le mani degli amici sono di più di quelle degli assassini.
 Mille anni dopo Davide e Gionata, un altro amico dell’uomo, fondatore di una comunità di amici («non vi chiamo più servi ma amici»), fu messo su una croce da un’altra mano fratricida. Sotto la croce c’erano le donne, e un amico. Quella volta le donne e l’amico non riuscirono a salvarlo. Ma noi, suoi amici, continuiamo ad attenderlo, in compagnia di Abele e di tutte le vittime della storia. Lo aspettiamo perché ci ha promesso che tornerà, e perché la promessa dell’amico è vera.
Mille anni dopo Davide e Gionata, un altro amico dell’uomo, fondatore di una comunità di amici («non vi chiamo più servi ma amici»), fu messo su una croce da un’altra mano fratricida. Sotto la croce c’erano le donne, e un amico. Quella volta le donne e l’amico non riuscirono a salvarlo. Ma noi, suoi amici, continuiamo ad attenderlo, in compagnia di Abele e di tutte le vittime della storia. Lo aspettiamo perché ci ha promesso che tornerà, e perché la promessa dell’amico è vera.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
DISTRUGGERE IL CRISTIANESIMO : IL PROGRAMMA "ANTICRISTO" DEL CATTOLICESIMO-ROMANO. LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PANDEMIA E ANTROPOLOGIA. La realtà e i cowboy. A proposito del più grande evento mediatico della storia (di Pierangelo Di Vittorio).).).10 aprile 2020, di Federico La Sala
La realtà e i cowboy. A proposito del più grande evento mediatico della storia
di Pierangelo Di Vittorio ("Aut Aut", 07.04.2020)
Al contrario di altri scenari possibili - nei quali la catastrofe, provocando un blackout tecnologico, consegna la sopravvivenza a vecchie risorse “analogiche” - l’attuale pandemia, costringendoci a un confinamento domestico, ha invece esaltato l’uso delle tecnologie digitali. Collegarsi al computer o allo smartphone è diventata, non solo una necessità, per studiare, lavorare, comunicare, ma anche un’occasione per conservare o magari riscoprire le relazioni sociali. Chi in questi giorni non ha provato almeno una volta il piacere di ritrovarsi a chiacchierare con un gruppo di amici o di colleghi in una videochiamata collettiva? Questo potrebbe essere quindi il momento meno adatto per mettersi a fare le pulci al digitale.
Credo tuttavia che una delle poche riflessioni davvero urgenti in questo periodo riguardi, non tanto il digitale in sé, quanto alcuni effetti legati alla sua capacità di industrializzare e massificare alcune tendenze di più lungo periodo. Mi riferisco in particolare alla mediatizzazione o alla messa in spettacolo della vita quotidiana (che va beninteso di pari passo con la riduzione della realtà a merce-spettacolo). La cosiddetta rivoluzione digitale ha sicuramente introdotto delle novità rispetto all’epoca televisiva. In primo luogo, l’alta tecnologia è diventata “personale” (pc, tablet, smartphone); in secondo luogo, grazie all’accessibilità di tale tecnologia personale e di tutto quello che essa consente di fare, forse per la prima volta nella storia moderna è venuta meno la tradizionale distinzione tra proprietari dei mezzi di produzione e operai, tra produttori e consumatori, tra attori e spettatori. Si tratta quindi di una novità che introduce una discontinuità fondamentale, ma che può essere vista al tempo stesso come un ulteriore giro di vite nel lungo processo di “democratizzazione” delle nostre società, il cui esito, troppo spesso trascurato, è che l’uomo comune si ritrova al centro del sistema come una specie di divinità paradossale - essendo ciò che, per principio, si oppone a ogni forma di unicità, di eccezionalità, di trascendenza.
Ora, forse non ce ne siamo accorti, le priorità sono ben altre, ma quello che stiamo vivendo, anche per le ragioni che dicevo prima, è il più gigantesco evento mediatico della storia dell’umanità. Penso ai comunicati radio e ai cinegiornali durante la Seconda guerra mondiale; al processo contro Adolf Eichmann a Gerusalemme nel 1961; all’allunaggio di Armstrong e compagni nel 1969; alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e agli eventi sportivi di rilevanza mondiale: la pandemia li ha surclassati tutti. Perché?
Per la sua globalità, certo. Per la sua durata, anche. Per la sua gravità, indubbiamente. Ma c’è dell’altro. Credo - e qui veniamo alla novità introdotta dal digitale - che la ragione stia soprattutto nel fatto che tutti, in tutto il mondo, tutti i giorni e per molti giorni, abbiamo contribuito alla “messa in scena” della realtà della catastrofe: dal papa che usa piazza San Pietro deserta come set di un thriller apocalittico alla Dan Brown; ai grandi filosofi che usano il virus come paesaggio su cui stagliare le loro più o meno logore o inopportune teorie; alle autorità governative e sanitarie che tengono messa ogni sera; ai sindaci che se vanno in giro nelle città deserte a fare i giustizieri stile Charles Bronson; all’esercito di politici, esperti, opinionisti, giornalisti che remano come schiavi dietro una prima pagina che non cambia mai; agli uomini e le donne del mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo che si autopromuovono con la scusa di #iorestoacasa; a ciascuno di noi, e siamo la maggior parte, persone comuni che, oltre a riverberare all’infinito le agenzie di cui sopra, offrendo al mondo le nostre quotidiane pillole di saggezza religiosa, filosofica, scientifica, politica ecc., celebriamo noi stessi attraverso l’auto(docu)fiction, i vari diari intimi della pandemia, gli improvvisati spettacolini firmati #iorestoacasa e #celafaremo, le continue valanghe di news e fake news, video, meme e altri contenuti “umoristici” che invadono i social network, saturano le chat di whatsapp ecc.
Sì, celebriamo noi stessi, perché l’uomo comune, non dimentichiamolo, è il centro del sistema, mentre la catastrofe fa da sfondo, come il Colosseo o la Tour Eiffel in tempi “normali”, anche se questo sfondo è fondamentale, trattandosi di “capitale mediatico”, anzi, in questo momento, della soglia mediatica che dà accesso a una condizione di “esistenza” (mediatica e tout court: si può esistere oggi senza passare dalla pandemia, senza parlare del virus, senza mostrarsi con il poster della catastrofe alle spalle?). Il selfie con il virus è diventato lo sport più praticato sul pianeta. Sarà salutare? In ogni caso sembra di assistere al più grande (auto)sciacallaggio mediatico della realtà che sia mai stato compiuto nella storia dell’umanità. Sarà giusto parlarne? O saremo tacciati di disfattismo, di terrorismo? Correremo il rischio. Però chi, in questi giorni, almeno una volta, non ha pensato che la viralità mediatica della pandemia fosse almeno pari a quella biologica del virus stesso? In fondo si tratta di questo. Poi ci sono le priorità. Certo.
A dire il vero, non abbiamo dovuto aspettare la pandemia per assistere all’affermarsi di tale fenomeno: da tempo l’uomo comune è diventato il protagonista del film ininterrotto (e autoprodotto: self-cinema, come si parla di self-publishing ecc.) della propria vita quotidiana. Un film nel quale la realtà stessa è l’unica scenografia, al punto da rendere difficile distinguere dove finisca il primo e dove inizi la seconda. Un film che è solo la mediatizzazione o la messa in spettacolo della realtà più immediata, banale o triviale. Un film che è il reality show della nostra vita quotidiana.
Sarà pure legittimo chiedersi che effetti produce tutto questo sulla nostra relazione con la realtà? E quindi sulla possibilità stessa di costruire delle relazioni - con noi stessi, con gli altri, con il mondo che ci circonda? Perché, attenzione: non si tratta di sostenere, ingenuamente, che la realtà è solo “quella cosa lì” che possiamo toccare, la realtà fisica, materiale, mentre tutto il resto, ossia ciò che chiamiamo genericamente “immateriale”, appartiene al mondo della fantasia. Nulla di tutto questo.
 Si tratta invece di considerare la realtà come il piano delle relazioni “possibili” (in senso kantiano), materiali o immateriali che siano. E le relazioni sono possibili nella misura in cui c’è sempre qualcosa che ci sfugge, nel senso che in esse si apre una dimensione che non ci fa mai essere del tutto a casa nostra, che entra in gioco qualcosa che ha a che fare con l’“altro”.
Si tratta invece di considerare la realtà come il piano delle relazioni “possibili” (in senso kantiano), materiali o immateriali che siano. E le relazioni sono possibili nella misura in cui c’è sempre qualcosa che ci sfugge, nel senso che in esse si apre una dimensione che non ci fa mai essere del tutto a casa nostra, che entra in gioco qualcosa che ha a che fare con l’“altro”.
 La relazione di realtà è quel nesso che ci connette con e attraverso una forma di alterità (a cominciare dal rapporto con noi stessi), e che ci espone quindi a qualcosa che non “padroneggiamo” mai del tutto. La realtà è il non-padroneggiabile e la relazione di realtà è ciò che ci mette in contatto con l’altro, “alterandoci” in questo stesso contatto.
La relazione di realtà è quel nesso che ci connette con e attraverso una forma di alterità (a cominciare dal rapporto con noi stessi), e che ci espone quindi a qualcosa che non “padroneggiamo” mai del tutto. La realtà è il non-padroneggiabile e la relazione di realtà è ciò che ci mette in contatto con l’altro, “alterandoci” in questo stesso contatto.Intuiamo forse quanto la ricchezza, l’ipertrofia della nostra connessione sul piano mediatico (che tende a trasformare l’eterogeneo in omogeneo, l’estraneo in familiare) vada di pari passo con una profonda, galoppante miseria della nostra connessione sul piano della realtà. Il film continuo della nostra vita quotidiana, la sua trasformazione in reality ci dissocia in modo “sistematico”, e perciò drammatico, dalla realtà stessa; ci priva di quella rete di relazioni, rischiose ma creative, che ci fanno entrare in contatto con l’alterità, che ci fanno esperire la realtà stessa come e nella sua alterità; e che attraverso il gioco dei conflitti e delle alleanze, rendono possibile la trasformazione di quello che è in qualcos’altro.
 Che cosa accade invece quando la realtà diventa la scenografia della nostra vita domestica? Quando è “addomesticata” in un dispositivo mediatico del quale siamo noi stessi gli artefici e i protagonisti? Gli eterni e immutabili padroni di casa? -Succede che la vertigine dell’alterità viene meno. E questo vuol dire che ci disconnettiamo dalla realtà come piano delle relazioni possibili, e cominciamo a coltivare l’idea che la realtà stessa sia come il giardino di casa: la pericolosa illusione che, qualsiasi cosa accada, noi siamo sempre in sella e teniamo saldamente le briglie. Che si tratti di migrazioni o di cambiamenti climatici, di crack finanziari o di epidemie, ci proiettiamo e ci vediamo come gagliardi cowboy che scorrazzano nella realtà. Il che, me lo concederete, più che infantile, è idiota.
Che cosa accade invece quando la realtà diventa la scenografia della nostra vita domestica? Quando è “addomesticata” in un dispositivo mediatico del quale siamo noi stessi gli artefici e i protagonisti? Gli eterni e immutabili padroni di casa? -Succede che la vertigine dell’alterità viene meno. E questo vuol dire che ci disconnettiamo dalla realtà come piano delle relazioni possibili, e cominciamo a coltivare l’idea che la realtà stessa sia come il giardino di casa: la pericolosa illusione che, qualsiasi cosa accada, noi siamo sempre in sella e teniamo saldamente le briglie. Che si tratti di migrazioni o di cambiamenti climatici, di crack finanziari o di epidemie, ci proiettiamo e ci vediamo come gagliardi cowboy che scorrazzano nella realtà. Il che, me lo concederete, più che infantile, è idiota.L’idiozia del tizio che fa una rapina e poi si spara un selfie con il bottino in mano all’uscita della banca pubblicandolo immediatamente su facebook - è solo un esempio di fantasia, per ridere, cioè per non piangere citando il caso, realmente accaduto, di quei ragazzi di Manduria che per anni hanno vessato e picchiato un anziano, fino a causarne la morte, e che hanno continuato a filmare e diffondere in rete le loro belle gesta. Effettivamente, in questi casi, la dissociazione - dal rapporto con la realtà e dalle connessioni che il piano della realtà rende possibili - si nota con una certa evidenza. Ma sono casi singoli, si dirà. Eccezioni. Derive. D’accordo. Ma che dire allora del film apocalittico di massa, realizzato in tempo reale e intitolato vox populi “Ai tempi del coronavirus” (circa 1.400.000.000 risultati in 0,41 secondi, appena ho lanciato la ricerca, in italiano, di questa frase su Google: oggi 6 aprile 2020)?
Fare presa sul piano di realtà è sempre importante ma, potremmo chiederci, non diventa addirittura decisivo se la realtà ha un aspetto “catastrofico” - nel senso di un evento che, sottraendoci brutalmente alla nostra routine, ci obbliga a porci almeno il “problema” di come sopravvivere? Nel momento in cui la realtà è più altra e alterante del solito, quando la padroneggiamo meno del solito, o magari non la padroneggiamo affatto, non diventa primordiale costruire una serie di relazioni possibili - come per il naufrago diventa primordiale costruire una zattera con quel poco che ha a disposizione - invece di continuare a fare i cowboy?
Forse passeremo alla storia come i passeggeri di un nuovo Titanic, occupati a farci dei selfie mentre l’iceberg, a fauci spalancate, si avvicinava alle nostre spalle.
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- In che lingua parlava Gesù? La doppia regola dell’incarnazione e dell’universalizzazione del messaggio della salvezza (di Mimmo Muolo)..7 aprile 2020, di Federico La Sala
Pasqua. Aramaico, ebraico, greco, latino... in che lingua Gesù parlò con Pilato?
Oltre l’aramaico, conosceva anche l’ebraico e il greco? E in che lingua avvenne il processo davanti a Pilato? Le ipotesi degli studiosi e l’importanza degli idiomi per l’evangelizzazione
di Mimmo Muolo (Avvenire, martedì 7 aprile 2020).
In che lingua parlava Gesù? E i protagonisti dei grandi eventi che portarono alla sua morte in croce? La questione, da tempo al centro del dibattito tra gli studiosi, può essere assunta proprio nei giorni della Settimana Santa, come filo rosso per comprendere alcune dinamiche fondamentali dell’annuncio della Buona Novella dall’inizio fino a noi.
Le quattro lingue della Palestina
Va detto innanzitutto che al tempo in cui si svolsero gli eventi descritti nei Vangeli quattro erano le lingue parlate in Palestina. Quella ufficiale (ma anche la meno diffusa: usata solo da un ristretto numero di funzionari pubblico) era il latino. Quella religiosa era l’ebraico, parlata nelle sinagoghe, dove si leggevano i testi della Torah, e dai farisei che erano gli ebrei più osservanti. Quella della vita quotidiana era invece l’aramaico, che il popolo aveva adottato dopo il ritorno dall’esilio babilonese (VI sec. a.C.). E infine il greco della koiné, che era un po’ come l’inglese di oggi, parlata ovunque. Ebraico e aramaico erano lingue semitiche, imparentate tra loro come ad esempio l’italiano e il napoletano, dato che l’aramaico (nell’VIII secolo a.C. lingua delle comunicazioni internazionali nella Mesopotamia) era diventata una sorta di dialetto.
Gesù parlava solo l’aramaico?
Tra queste quattro lingue è ormai certo che quella usata da Gesù per la predicazione e per i colloqui con i discepoli fosse l’aramaico. Come ricorda Rinaldo Fabris, nel suo “Gesù il Nazareno” (Cittadella Editrice), sono almeno una ventina i passi dei Vangeli canonici (scritti in greco) in cui vengono citate parole o espressioni aramaiche. Per limitarci a quelle che riguardano la Settimana Santa: “Abba” (Padre), usato da Gesù nel Getsemani; “Eloi Eloi lemà sabachtani” (Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato) cioè le ultime parole di Cristo sulla croce secondo Marco e Matteo; il toponomastico Golgotha (“Luogo del cranio”) per indicare l’altura della crocifissione; e infine l’appellativo “rabbunì” (maestro mio) con cui Maria di Madgala chiama Gesù dopo la risurrezione. E a proposito di vittoria sulla morte, possiamo citare ancora il “talità qum”, (ragazza alzati) con cui Cristo riporta in vita la figlia di Giairo.
Del resto è naturale: cresciuto ed educato in una modesta famiglia della Galilea che abitava a Nazareth, villaggio di poche centinaia di abitanti, Egli certamente aveva come lingua materna l’aramaico occidentale che si parlava nella sua terra. Tra l’altro connotato da accento diverso da quello in uso a Gerusalemme, come attesta il “riconoscimento” di Pietro, nella notte dell’arresto di Gesù (Mt 26,73) proprio a motivo di come parlava.
L’aramaico, scelta di incarnazione
Questo fatto ci dice già una cosa importante. La concretezza dell’incarnazione vale per tutti gli aspetti della vita. Gesù si esprime in un idioma che tutti possono comprendere e poco importa se non è la lingua dei dotti. Anzi proprio questa vicinanza ai “piccoli”, al punto da parlare in “dialetto”, conferma se mai ce ne fosse bisogno la sua “rivoluzione” delle periferie, come direbbe papa Francesco. Il quale, parlando ai genitori dei bambini che stava battezzando nella Cappella Sistina il 7 gennaio 2018, raccomandò: “La trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto, la lingua intima delle coppie. Nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna”. E non è un caso che un grande santo e teologo come Tommaso d’Aquino abbia predicato il quaresimale del 1273 in dialetto napoletano.
Le ipotesi sull’ebraico e il greco
Ciò che resta ancora incerto è se Gesù sapesse parlare nelle altre lingue. Almeno l’ebraico e il greco. Quanto all’ebraico, bisogna registrare un simpatico siparietto durante la visita di papa Francesco in Medio Oriente nel 2014. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante un incontro ufficiale, disse al Pontefice: «Gesù ha vissuto qui, parlava ebraico». «Aramaico», lo corresse Francesco. Al che Netanyahu, immediatamente, precisò: «Parlava aramaico ma conosceva l’ebraico, perché leggeva le Scritture». Al di là dei cordiali sorrisi che chiusero l’episodio, viene da chiedersi: è proprio così?
 Secondo Fabris, “sulla base delle scarne informazioni del Vangeli non si è in grado di dare una risposta categorica alla domanda se Gesù sapesse leggere e scrivere”. E anche l’episodio riferito da san Luca, in cui nella sinagoga di Nazareth Egli prende e legge il rotolo del profeta Isaia, “non può essere addotto come prova che egli è in grado di leggere il testo ebraico della Bibbia”. Probabilmente infatti, argomenta lo studioso, quel racconto è il frutto di una rielaborazione dell’evangelista al quale interessa dire che Gesù è il Messia.
Secondo Fabris, “sulla base delle scarne informazioni del Vangeli non si è in grado di dare una risposta categorica alla domanda se Gesù sapesse leggere e scrivere”. E anche l’episodio riferito da san Luca, in cui nella sinagoga di Nazareth Egli prende e legge il rotolo del profeta Isaia, “non può essere addotto come prova che egli è in grado di leggere il testo ebraico della Bibbia”. Probabilmente infatti, argomenta lo studioso, quel racconto è il frutto di una rielaborazione dell’evangelista al quale interessa dire che Gesù è il Messia.Tuttavia questo punto non è pacifico fra gli esegeti. Stefano Tarocchi, biblista e preside emerito della Facoltà Teologica dell’Italia centrale, nota infatti che “diversi altri racconti dei Vangeli favoriscono la teoria secondo cui Gesù era in grado di servirsi anche dell’ebraico quando la situazione lo richiedeva”. Soprattutto le conversazioni e discussioni con capi religiosi ebrei. “Questi dialoghi di solito avvenivano in ebraico anche tra chi aveva come prima lingua l’aramaico. Per essere credibile come interlocutore, con molta probabilità Gesù usava l’ebraico quando era impegnato in discorsi teologici con i farisei, gli scribi e gli altri capi ebrei”.
Quanto al greco, alcuni esegeti hanno ipotizzato che Gesù potesse conoscerlo, dato che vicino a Nazaret c’erano Sepphoris, capitale della tetrarchia di Erode Antipa, e Tiberiade, centro commerciale di una certa importanza, dove i mercanti greci arrivavano facilmente. Ma Fabris esclude un’ipotesi del genere, così come la possibilità che egli abbia conversato o insegnato in greco.
In che lingua parlarono Pilato e Gesù durante il processo?
Più possibilista è invece Tarocchi, citando la conversazione con il centurione romano di Matteo 8,5-13. “Anche Pilato nel processo - afferma - avrebbe usato il greco, non il latino, come ha invece immaginato Mel Gibson in The Passion. Non è nemmeno ipotizzabile che un governatore romano abbia potuto conoscere ed usare l’aramaico”. Tuttavia il dialogo potrebbe essersi svolto con l’intermediazione di un interprete (anche se nei Vangeli non se ne fa menzione), perché quello a Gesù non era certamente l’unico processo che Pilato fece nella sua carriera e la registrazione di un particolare così scontato può essere stata considerata superflua.
L’importanza del greco per l’evangelizzazione
Il greco però sicuramente entra in scena - e pesantemente - dopo la risurrezione. Soprattutto grazie alle lettere di Paolo, che sono i documenti più antichi del Nuovo Testamento, tutto scritto nell’”inglese” dell’epoca.
A questo punto il cambio di priorità, e dunque di paradigma anche linguistico, appare evidente. Alla logica dell’incarnazione si affianca quella dell’universalità del messaggio evangelico, che essendo destinato a tutti gli uomini, ha bisogno di un veicolo comunicativo il più possibile conosciuto. Il greco, appunto, che diviene così la lingua della “fase due” dell’evangelizzazione, dopo il primo annuncio del Nazareno. A quel punto l’idioma originale parlato da da Gesù diventa secondario, quasi ininfluente.
 "Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio", esclameranno i presenti alla predicazione degli Apostoli, il giorno di Pentecoste. La voce di Cristo raggiunge ognuno nel suo linguaggio, secondo la doppia regola dell’incarnazione e dell’universalizzazione del messaggio della salvezza. E non è un caso che la Bibbia sia oggi il libro tradotto nel maggior numero di lingue al mondo.
"Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio", esclameranno i presenti alla predicazione degli Apostoli, il giorno di Pentecoste. La voce di Cristo raggiunge ognuno nel suo linguaggio, secondo la doppia regola dell’incarnazione e dell’universalizzazione del messaggio della salvezza. E non è un caso che la Bibbia sia oggi il libro tradotto nel maggior numero di lingue al mondo. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- PER UN CAMBIO RADICALE DI PARADIGMA. Un immaginario diverso (di Franco Lorenzoni).7 aprile 2020, di Federico La Sala
Un immaginario diverso
di Franco Lorenzoni *
Trovo profondamente errato e fuorviante il continuo riferimento alla guerra che si fa in queste settimane. Contrastare una pandemia e combattere una guerra sono due azioni che non hanno nulla a che vedere. La guerra, qualsiasi guerra, si fonda sull’assassinio e la soppressione del nemico, il contrasto a un virus letale può contare solo sulla cura, la ricerca scientifica, comportamenti coerenti che fermino il contagio. Inoltre, come ha giustamente notato un ragazzo, “ai nostri nonni e bisnonni, un secolo fa, veniva imposto di partire per il fronte e finire carne da macello in trincea, a noi si chiede solo di stare chiusi in casa su un divano: c’è una bella differenza”.
Di comune c’è solo la presenza di donne e uomini che rischiano la vita, anche se in guerra affrontano il pericolo per uccidere nemici e bombardare innocenti, mentre in ospedale o visitando pazienti, infermieri e medici rischiano prendendosi cura e cercando di salvare più vite possibili.
Questa metafora, sbagliata e abusata, non la dobbiamo tuttavia dimenticare. Quando si dovrà decidere come e cosa ricostruire per uscire da una crisi economica che si annuncia devastante, dovremo ricordare con lucidità che per difenderci da possibili e probabili nuove pandemie, per affrontare le gravissime conseguenze del surriscaldamento globale che provoca già oggi milioni di profughi e vittime per siccità, inondazioni e fame, sarà necessario mettere al centro di ogni rinascita futura la necessità e il valore della cura reciproca, della ricerca scientifica, dell’arte e della cultura intese nel senso più ampio. Dovremo ricordare che le spese militari e i soldi per acquistare armi sono del tutto inutili per affrontare le enormi sfide che abbiamo di fronte, perché delle forze armate abbiamo constatato che le uniche armi utili sono gli ospedali da campo montati dagli alpini e da altri reparti militari.
Ancora una volta è parso evidente che dell’esercito può essere utile solo ciò che non è esercito: infermieri e medici militari che, invece di addestrarsi a usare armi per ferire, si sono formati per curare ferite.
 È tempo di ripensare con radicalità a ciò che davvero ci può difendere, riprendendo le intuizioni di Alexander Langer riguardo alla formazione in Europa di corpi civili di pace. Un solo sommergibile costa più di 5.000 posti letto di terapia intensiva, ha giustamente ricordato Gino Strada, che di guerre e ospedali ne sa qualcosa.
È tempo di ripensare con radicalità a ciò che davvero ci può difendere, riprendendo le intuizioni di Alexander Langer riguardo alla formazione in Europa di corpi civili di pace. Un solo sommergibile costa più di 5.000 posti letto di terapia intensiva, ha giustamente ricordato Gino Strada, che di guerre e ospedali ne sa qualcosa.Abbiamo sicuramente bisogno di più posti letto e ospedali migliori in ogni regione del nostro paese, dunque non potremo più tollerare tagli alla sanità pubblica. Abbiamo bisogno di più scienza e ricerca, quindi migliori università e ricercatori pagati degnamente, abolendo ogni numero chiuso per l’accesso alle facoltà. Abbiamo bisogno di una scuola più ricca, aperta e di qualità, con insegnanti in continua ricerca e formazione per riuscire finalmente a dare a tutte le ragazze e ragazzi la possibilità di terminare con successo i loro studi. Dovremo cercare di aumentare considerevolmente il numero dei laureati, che ha percentuali ridicole nel nostro paese, e affrontare di petto la ferita sociale della dispersione scolastica perché la povertà educativa, che è drammatica fonte di discriminazione sociale, va contrastata con politiche coerenti e l’impegno di ciascuno in ogni campo - dall’educazione alla formazione, all’arte e alla cultura diffusa nel territorio - perché la scuola da sola non ce la può fare (leggi anche il Manifesto dell’educazione diffusa, ndr)..
Lo sconcerto planetario di fronte a una tragedia della pandemia, che sta coinvolgendo miliardi di esseri umani, offre una straordinaria lezione a tutti noi e ci ricorda che l’alternativa è, davvero, tra istruzione e distruzione, tra scienza, conoscenza lungimirante, capacità di cura reciproca e passiva rassegnazione a modi di produrre, accumulare ricchezze, costruire e abitare che portano alla distruzione del territorio e dei fragili equilibri del pianeta che abitiamo. Naomi Klein sostiene che
- “solo una crisi reale o percepita produce un vero cambiamento”. A una condizione, tuttavia: “Quando una crisi si verifica, le azioni che vengono intraprese dipendono dalle idee che circolano”.
E allora è alle idee che circolano che dobbiamo prestare tanta attenzione quanta ne stiamo prestando al virus letale che attenta alle nostre vite. Ciascuno di noi - in particolare chi insegna - dovrebbe fare ogni sforzo per mantenere viva l’attenzione al linguaggio. Possedere un linguaggio per narrare questo tempo straordinario, tanti linguaggi per ragionare e provare a capire ciò che sta accadendo, è il più grande dono che la scuola deve tentare di offrire (anche a distanza) a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi che stanno vivendo momenti che ricorderanno tutta la vita. Questo tempo straordinario non sarà dimenticato, ma non lo si può comprendere davvero senza matematica e statistica, senza intendere qualcosa di biologia e di chimica.
Stiamo assistendo a eventi inimmaginabili e spaventosi e, come tutto ciò che è spaventoso, porta in sé elementi sconcertanti ed eccitanti. Chi ha mai visto le strade di New York deserte? Chi ha mai visto la propria città vuota e silenziosa? E allora cercare e affinare linguaggi che ci permettano di vivere con intensità e pensare con coscienza e profondità questo tempo che stiamo vivendo è più che mai necessario per nutrire la nostra memoria. E la memoria è tutto. Noi siamo la nostra memoria.
Guardarci dalle metafore che informano il nostro sentire ci aiuta non solo a fare esperienza con maggiore consapevolezza, ma anche a provare a immaginare una società capace di contrastare le malattie e catastrofi che ci attendono.
Nessuno avrebbe immaginato, solo due anni fa, che la cocciuta coerenza di una ragazza quindicenne avrebbe potuto scatenare una protesta giovanile mondiale per il clima, che non ha ancora prodotto risultati ma ha scosso le coscienze, ricordandoci quanto sia necessario rivedere la categoria dell’impossibile.
 Solo allargando il nostro immaginario e cimentandoci in un cambio radicale di paradigma possiamo ritrovare le radici della speranza.
Solo allargando il nostro immaginario e cimentandoci in un cambio radicale di paradigma possiamo ritrovare le radici della speranza.* Comune-info, 05 Aprile 2020 (ripresa parziale).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- ANTROPOLOGIA. “L’amore delle donne accompagna la passione di Gesù” (di p. p. Giancarlo Pani S.I., viced. de "La Civiltà Cattolica").").5 aprile 2020, di Federico La Sala
Le note spirituali della Civiltà Cattolica
“L’amore delle donne accompagna la passione di Gesù”.
di p. Giancarlo Pani S.I., vicedirettore de "La Civiltà Cattolica" *
Il Vangelo di Matteo presenta il racconto della passione di Gesù incorniciato tra due episodi che hanno come protagoniste alcune donne. La prima è una donna di Betania, che unge il capo di Gesù con un prezioso olio di nardo (Mt 26,6-13), le altre sono Maria di Magdala e le donne sul Calvario quando Gesù muore (27,55s) e, dopo il sabato, si recano al sepolcro alla prima luce dell’alba (28,1). Sono figure che illuminano il mistero.
Mancavano due giorni alla Pasqua. «Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola» (Mt 26,6s). È un momento di convivialità con la presenza del Signore.
 Ad un certo punto compare una donna: chi sia, non si sa, non ha nome e non dice nemmeno una parola. Compie solo un gesto. Nella sala si spande la fragranza del profumo che suscita sdegno e proteste. Perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!
Ad un certo punto compare una donna: chi sia, non si sa, non ha nome e non dice nemmeno una parola. Compie solo un gesto. Nella sala si spande la fragranza del profumo che suscita sdegno e proteste. Perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri!La donna tace, e Gesù afferma: «Perché infastidite questa donna? Ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura» (vv.10-13). La donna - rivela Gesù - ha preparato il suo corpo per la morte.
Quello che gli apostoli non riescono a comprendere e che Gesù aveva detto più volte, lo ha compreso una donna: i capi dei sacerdoti e gli scribi volevano ucciderlo. In ogni caso, lei è l’unica ad aver capito che la vita di Gesù ha un esito preciso, la morte, e la morte viene perché Gesù ha donato la vita, perché si è fatto tutto a tutti. La donna lo ha veduto, lo ha ascoltato, custodisce le sue parole nel cuore, lo ha amato; e ora vuole essergli vicino con gratitudine. Risponde con amore all’amore di Gesù. Quel profumo è il suo dono, è tutto quello che ha, è tutta la sua vita. Perciò glielo versa fino in fondo, fino all’eccesso, che è la misura dell’amore che si dona senza misura.
La donna ha fatto un’azione buona, dice Gesù; in greco, alla lettera, «un’opera bella». È la bellezza di chi ama e che non bada a nulla per la persona amata. Lei ha compreso che la morte a cui Gesù va incontro è il frutto di un’intera vita donata ai fratelli. E lei, nella sua piccolezza, nella sua povertà, ha voluto esprimerlo con il suo gesto di amore. E Gesù lo accoglie, perché sa accogliere l’amore che gli diamo, che sia poco o tanto. Per lui non conta quello che si dona, ma il cuore con cui lo si dona.
Qui è una donna che dona e la donna sa bene che cosa comporta dare al mondo una vita; lei sa che dando la vita rischia di perdere la propria. Ma è il dono di un amore totale, che non teme il dolore, la sofferenza, la morte. È la profezia di quanto Gesù sta per vivere fino alla croce. La fragranza di quel profumo accompagnerà il Signore nella passione, nella morte, nella resurrezione. È un annuncio di vita e di gioia: è il profumo di Dio, il profumo del Vangelo. «Dovunque sarà annunciato questo Vangelo, nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che lei ha fatto» (v. 13).
***
Sul Calvario, quando Gesù muore, ci sono le donne che lo accompagnano. Sono lì, nel dolore e nel pianto per il Signore che le ha amate e che loro hanno amato. Una presenza e un amore che sono un segno anche per noi. Quando la vita spesa per gli altri ci porta al calvario e alla croce, spesso la luce della risurrezione è talmente lontana da perdere ogni forza confortatrice. La sofferenza può essere così amara e così totalizzante da spingerci in una situazione di disperata solitudine, di fallimento senza rimedio: la forza del Vangelo per il quale abbiamo tentato di vivere ci si vanifica in mano.
Ai piedi della croce - nel Vangelo di Matteo - i discepoli non ci sono. Ai loro occhi Gesù che muore è il segno della fine di tutto, di una speranza delusa, di un drammatico fallimento. Singolare è allora la figura delle donne sotto la croce. Non è pensabile che ai loro occhi potessero esserci prospettive diverse. Anche per loro Gesù muore, anche per loro il domani è nelle tenebre. Ma c’è un amore più forte che, nel buio, le tiene ai piedi della croce: ed è a questo amore semplice ma pieno, piccolo ma autentico, che per primo si rivela la resurrezione di Gesù.
L’amore delle donne è una strada anche per noi: tante volte ci troviamo nel buio, nello sradicamento totale, nell’assurdo, nel silenzio di Dio. Ma come le donne sono rimaste ai piedi di Gesù che muore, così la nostra preghiera insistente e il nostro silenzio fedele di fronte a un Dio che sembra non rispondere, ha in sé il germe di una speranza: anche a noi, come alle donne, si manifesterà la gloria del Signore che risorge.
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CORONAVIRUS E VITA NELLA "CAVERNA": UN SONNAMBULISMO DI LUNGA DURATA.29 marzo 2020, di Federico La Sala
UN SONNAMBULISMO DI LUNGA DURATA: VIVERE NELLA CAVERNA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS....
Nota a margine di "Il virus e l’inconscio. Diario di una quarantena" (di Sergio Benvenuto) *
FINALMENTE, E PIANO PIANO, EMERGE LA RADICALE CONSAPEVOLEZZA CHE “NOI” VIVAMO all’interno della “caverna”, dopo la “caduta”, e che uscire dal “letargo” (cf. Dante) è sempre più urgente. L’immaginario platonico-hegeliano ha esaurito ogni sua risorsa. L’orizzonte “andrologico” adamitico (e “ginecologico” eva-itico!) si va a chiudere, definitivamente:
«Attualmente politici, filosofi, moralisti, giornalisti, ripetono in Italia la stessa cosa: “Questa sarà un’occasione per renderci migliori!” Ricorrente idea consolatoria: pensare che se si attraversano catastrofi, tragedie, guerre, flagelli, poi si sarà migliori. Le traversie temperano il carattere, si diceva un tempo. [...] Attribuire agli umani tutti i mali è l’altra faccia di quella divinizzazione dell’Uomo (che risale a Pascal) che la filosofia più moderna ha denunciato: se si pensa che l’essere umano sia nel fondo potente come Dio, si penserà anche che possa avere la malvagia onnipotenza di Satana. Ma gli uomini non sono né Dio né Satana. »(SERGIO BENVENUTO - "Il virus e l’inconscio", cit., sopra)
SE CONSIDERIAMO CHE LA “SCIENTIFICA” TEO-LOGIA CATTOLICA COSTANTINIANA condivide ancora la “verità rivelata” dal cardinale Dario Castrillon Hoyos: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio” (dichiarazione alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio , “la Repubblica” del 17 novembre 2000, p. 35), -E CHE LEGGIAMO E INTERPRETIAMO l’ antropologico “Ecce Homo” di Ponzio Pilato ancora in temini “andrologici” e” viro-logici” (cf. il saggio “Ecce” di C. Ginzburg, in “Occhiacci di legno”; e il recente lavoro di S. Natoli su “L’uomo dei dolori”), ALLORA è più evidente che viviamo ancora NEL PASSATO, NELLA PREISTORIA, e che LA RISATA DI KANT ha ancora un carico di energia per svegliarci dal letargo, far crollare le pareti della caverna, e portarci fuori da millenni di labirinto (Nietzsche). Ricordiamo, su questo tema, anche la lezione di Elvio Fachinelli. O no?! Boh e bah?!
*
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CORONAVIRUS, PREGHIERA, E INTERCESSIONE. Il Capo supplica Dio, per la nostra vita e per le sue promesse, di non abbandonarci (di P. Sequeri).27 marzo 2020, di Federico La Sala
Lettera aperta a San Cristoforo al tempo del Coronavirus *
Il senso profondo della preghiera.
Con Lui davanti al Dio della vita
di Pierangelo Sequeri (Avvenire, venerdì 27 marzo 2020)
Il Capo se ne sta, dritto e umile, tra Dio e il suo popolo. Non fronteggia l’assemblea degli anziani e la folla dei fedeli, per questa volta. Fronteggia il Signore suo e nostro, il Padre di tutti, il Dio della vita che mille volte già ci ha fatto uscire dalle prigioni della storia, rimettendoci in cammino, perché potessimo celebrare le sue benedizioni e testimoniare la sua misericordia.
Il Capo supplica Dio, per la nostra vita e per le sue promesse, di non abbandonarci. Non siamo stinchi di santi, ma siamo uomini e donne che portano - spesso loro malgrado - i segni della presenza dell’amore di Dio nella storia. Non ne siamo affatto all’altezza: non siamo i migliori che Dio avrebbe potuto trovare, portiamo il tesoro della sua benedizione in vasi di creta, raggiustati più volte, che stanno insieme per miracolo. Però, siamo quelli che Lui si è preso. E abbiamo arrancato per generazioni dietro a Lui: molti hanno perso il passo, molti sono rimasti indietro, molti hanno perso le forze e persino la fiducia. Siamo quello che siamo. Eppure, siamo uomini e donne che tutto vorrebbero, eccetto che essere separati da Lui.
E non abbiamo mai pensato veramente che una creatura umana - chiunque - possa essere abbandonata da Lui. Il Capo, da solo davanti a Dio, rappresenta solennemente tutti noi. E non si sottrae a questo legame profondissimo e struggente. Un vero capo è così. La sua preghiera, in più, ha in serbo una mossa che lo espone direttamente: irresistibile anche per Dio. ’Se tu pensassi di abbandonarli, Signore, con tutto il rispetto, abbandona anche me, perché neppure io potrei seguirti’. Un vero capo arriva a questo. Guardo il papa Francesco nel mezzo di piazza san Pietro, vuota del consueto assembramento, che sta in mezzo fra Dio e il popolo per caricare su di sé il simbolo stesso dell’intercessione, in nome di tutti i credenti e in favore di tutti i viventi. Non posso fare a meno di pensare a quel commovente passaggio della preghiera di Mosè per il popolo, quando osa dire a Dio che non sarebbe un buon segno - per Lui - se abbandonasse il popolo ora, dopo averlo salvato da mali ben peggiori.
Dopo l’episodio del vitello d’oro, infatti, Dio offre a Mosè un nuovo inizio, più o meno in questi termini: ’Facciamola finita con questi, farà di te l’inizio di un nuovo popolo e di una nuova storia’ Mosè, però, respinge l’offerta, supplicando per il popolo: ’Sono quelli ai cui padri e madri hai fatto promesse irrevocabili’ (cfr. Esodo, 32, 10). Il senso profondo della preghiera e dell’atteggiamento dell’intercessione si illumina, qui, di uno splendore emozionante. Così è un vero capo. Nello stesso modo si comporta un vero sacerdote, un vero testimone, un vero credente: ’si mette in mezzo’, esponendosi in prima persona di fronte a Dio stesso, per la vita di ognuno: ’Se li abbandoni, non contare su di me’. Gesù - il Capo reale della Chiesa - ha sigillato l’atto tenero e potente di questa intercessione dalla parte stessa di Dio, iscrivendolo nell’intimità profonda e insondabile del Padre. È il nostro dogma questo, il dogma di tutti i dogmi, capisci? Il Figlio si mette in mezzo, il Figlio intercede, il Figlio non ha nessuna intenzione di abbandonarci, anche quando siamo insopportabilmente inaffidabili.
Nell’orto degli Ulivi, Gesù chiese di essere preso lui soltanto, lasciando i discepoli (Giovanni 18, 7-9). In croce, inchiodato davanti al Padre, chiese di risparmiare i suoi stessi persecutori (Luca 23, 34). Riscoprire il gesto dell’intercessione fino a questa profondità è un miracolo. E nei tempi difficili per il popolo, una grazia insostituibile. Ciascuno di noi è chiamato a riscoprire, anche nel suo forzato isolamento, la benedizione del gesto di intercessione. Ognuno, per gli altri. L’essenza del cristianesimo sta qui, la certezza della redenzione sta qui. L’intercessione comunica un messaggio potente. Non pensate neppure per un istante che i nostri peccati possano indurre Dio ad abbandonarci nella prova. E non scaricate sul vostro prossimo i mali che ci affliggono, sostituendo l’intercessione con l’intimidazione. In momenti di straordinaria angoscia, il semplice e coraggioso gesto dell’intercessione, che supplica di Dio di non abbandonare nessuno, testimoniando che noi stessi non lo faremo, non ha prezzo. È un giuramento di fedeltà che ricompone la comunità: per ciascuno e per tutti. Non ci muoveremo da qui.
*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
NOTE ALLA "Lettera aperta a San Cristoforo al tempo del Coronavirus:
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- UN CAMBIAMENTO DI ROTTA FONDAMENTALE E URGENTE.24 marzo 2020, di Federico La Sala
SAN CRISTOFORO E CORONAVIRUS:
***
UN CAMBIAMENTO DI ROTTA FONDAMENTALE, UNA METANOIA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA URGENTE, PER QUANTI PRETENDONO DI ESSERE "PORTATORI DI CRISTO" DA UNA RIVA ALL’ALTRA DEL FIUME DEL TEMPO... *
Caro don Santino Bove Balestra
Vista la tensione e la passione personali che animano la sua Lettera "a san Cristofaro al tempo del Coronavirus" e, al contempo,sollecitato dalle sue stesse associazioni collegate a questa figura di gigante buono («Ti hanno fatto - forse un po’ abusivamente - diventare il patrono degli automobilisti (dopo essere stato più propriamente il protettore dei facchini): oggi dovresti ispirare chi dall’automobile passa alla bicicletta, al treno o all’uso dei propri piedi!»), il discorso fatto appare essere una forma implicita di autocritica "istituzionale" (cioè, da parte dell’intera Istituzione Chiesa paolina-costantiniana) della propria capacità di "portare Cristo" in giro, di qua e di là, avanti e indietro - e, della totale e più generale cecità antropologica e pedagogica, nei confronti del "Bambino" (che ognuno e ognuna di noi, tutti e tutte, è)!
SE,OGGI, AL TEMPO DEL CORONAVIRUS *, VALE l’esortazione “Restiamo tutti a casa!”, altrettanto sicuramente, domani, vale la consapevolezza che “Nulla sarà più come prima!” e, ancor di più, se vogliamo veramente cambiare rotta, che la “conversione eco-logica” (la ristrutturazione della nostra stessa "casa"!) è già "oggi necessaria", ora e subito! Non c’è alcun tempo da perdere.
Portar-si il "bambino" sulle proprie spalle, «suprema fatica e suprema gioia», è impresa ancora tutta da tentare - e non ha nulla a che fare con il "sacrificio" e con la "messa in croce" di alcun "Bambino"! O no?!
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- La civiltà è Enea che porta Anchise sulle spalle (di Laura Marchetti)24 marzo 2020, di Federico La Sala
La civiltà è Enea che porta Anchise sulle spalle
- [Foto] "Enea, Anchise e Ascanio in fuga da Troia", dipinto di Federico Barocci
di Laura Marchetti (il manifesto, 24.03.2020)
«L’Italia vede decimata la generazione anziana, punto di riferimento per i giovani e per gli affetti». Le parole dette ieri dal presidente della Repubblica italiana, in maniera solenne e commovente, sembrano così voler far scudo contro quell’aberrante e diffusa convinzione, espressa in maniera più o meno sotterranea, che le morti così numerose non siano state poi così importanti perché riguardavano i vecchi, per di più già malati. Mattarella al contrario ci ricorda quale patrimonio siano i vecchi, come siano indispensabili per i bambini, proprio in quanto “rimbambiti”, ovvero anche loro bambini, disposti a giocare, a divagare, a trasgredire.
E come siano importanti per i giovani, per la possibilità che hanno di trasmettere loro antichi saperi, valori vissuti, comunitarie tradizioni, forme diverse di presa dello spazio e di percezione dei tempi. E come, in definitiva, siano importanti per ognuno di noi, perché nel tempo dell’effimero e dell’oblio, di fronte agli spettacoli e ai consumi, mostrano il valore degli affetti teneri, dei ricordi, della memoria e del compianto.
Le parole del presidente sono dunque dense di significato educativo ed esistenziale ma hanno anche un impatto politico radicale perché, per la prima volta, interrompono la filosofia eugenetica che è la pratica e lo spirito di questi insani tempi. Dal documento degli anestesisti spagnoli alla teorizzazione dell’immunità di gregge degli inglesi, fino alla sottrazione forzata dell’assistenza sanitaria accaduta in certi ospedali italiani, si teorizza la necessità, per la “medicina delle catastrofi”, di scegliere fra i vecchi e i giovani, come fra i deboli e i forti. Una scelta dovuta allo stato di eccezione e alla situazione estrema, tesa a sottrarre responsabilità alla coscienza personale, che porta però con sé la traccia indelebile di un giudizio di qualità dato alla vita, come se una vita - la più forte, la più abile - fosse solo per questo degna di essere mantenuta, mentre un’altra con più facilità dovrebbe essere rottamata.
In tale scelta gerarchica - che, perdurando lo stato di eccezione, potrebbe essere estesa anche a tutti i disabili e a tutti i fragili - si conserva il segreto del potere totalitario e della società “tanatologica”, la società di massa del ‘900 che si fonda su un continuo commercio con la morte.
Lo dice Elia Canetti in un libro magnifico e terribile scritto in anni bui e insani quasi come questi (Masse e Potere). In questa società tanatologica, potente diviene sia il capo, che acquisisce potere di morte, sia chi si distingue dalla morte sopravvivendo. La sopravvivenza è di per se stessa acquisizione di potere.
Chi è morto giace, sta per terra; chi sopravvive sta in piedi. Già solo questa collocazione spaziale rende “l’istante del sopravvivere, l’istante della potenza”, anche perché inconsciamente insorge la convinzione di una vera e propria “elezione”, una emozione comparativa che non risparmia nessun rapporto, nemmeno quello più affettivo, nemmeno quello con i figli o i genitori o i fratelli. Su questo senso di elezione si fonda dunque il totalitarismo, secondo Canetti. Ma, potremmo aggiungere, anche il capitalismo in quanto tale trasforma in Pil la sopravvivenza, poiché miglior produttori sono i vivi, cioè gli abili, i giovani, i forti.
C’è nel potere contemporaneo quindi, il persistere di una barbarie di fondo, una inciviltà. La civiltà si fonda invece al contrario e nasce quando Enea in fuga dall’incendio, porta con se il vecchio padre sulle spalle e, per mano, il giovane figlio. La pietà, che è la sua qualità esistenziale e la sua qualità sociale, lo spinge nell’aiutare, includere tutti, curare tutti, anche a scapito della propria sopravvivenza, del proprio potere.
Quella pietà è anche l’intelligenza della specie, in quanto la specie sopravvive, sottolineano i biologi della complessità, non nella lotta ma perché la madre continua ad allattare il figlio e perché gli uomini, anche quando vivono rintanati, non sono topi che si distruggono ma anzi si prestano soccorso.
Noi, nell’agenda delle cose che dobbiamo mettere in campo quando finirà la guerra e vorremmo fare il mondo nuovo, dovremmo mettere in campo la pietà. Fin da ora, in quanto già ora abbiamo due problemi. Il primo è quello di non morire, ma il secondo è quello di vivere civili.
-
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Coronavirus e "8 marzo". Intervista ad Annarosa Buttarelli (di Alessia Ripani).18 marzo 2020, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. RATIONABILITAS: SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ, OGGI.... *
La filosofa Annarosa Buttarelli:
“Coronavirus frutto di forme virili di governo, impotenti e inadeguate”
A Milano un ciclo di lezioni di alta formazione che si apre al pensiero della differenza maschile. La filosofa che lo ha ideato: "La crisi che stiamo affrontando ci dice di festeggiare, oggi 8 marzo, la lungimiranza delle donne"
di ALESSIA RIPANI (la Repubblica, 08 marzo 2020)
"In questi giorni si manifesta ancora una volta, in maniera flagrante, l’impotenza dei potenti e l’inadeguatezza della cultura di origine maschile. Non solo a prevedere le conseguenze catastrofiche dei propri comportamenti ma anche a interloquire con la complessità in cui siamo immersi da sempre. Lo stile generale violento e suicidario delle forme virili di governo, oggi è di nuovo nudo". È così che, in piena tempesta coronavirus, festeggia la "lungimiranza delle donne" la docente e ricercatrice Annarosa Buttarelli, filosofa del pensiero della differenza, autrice di "Sovrane" sull’autorità femminile; pensatrice che ha ispirato anche Stefano Rodotà, con cui stava interloquendo poco prima della morte del giurista.
Ha appena lanciato il secondo corso di perfezionamento della Scuola di alta Formazione Donne di Governo che ha fondato insieme a altre. Ma stavolta, a dispetto della formula, protagonisti a Milano, nella Casa museo Boschi di Stefano, sono gli uomini. Massimo Recalcati e altri tre ’docenti’, ad esempio, chiamati ad approfondire la natura del desiderio maschile e l’inviolabilità del corpo femminile. Ci saranno cinque top manager del Comune guidato da Beppe Sala, che oltre a essere partner, come amministrazione pubblica ha deciso di spedire alcune delle sue dirigenti a scuola di femminismo da Buttarelli e le altre, magistrate, avvocate, funzionarie di polizia, ginecologhe, studiose e scrittrici. Il tema principe è ancora la violenza di genere: dove e perché nasce, come si riconosce e combatte, e, soprattutto, chi è che la fa.
Professoressa Buttarelli, 8 marzo, violenza sulle donne, coronavirus. Come si tiene insieme tutto questo?
"Oggi esiste una grande massa di donne consapevoli, liberate dal vittimismo e dalle rivendicazioni di un femminismo ormai superato; forti del #metoo che ha dato loro una spinta nuova. Sono tante, e possono festeggiare la lungimiranza che hanno avuto nel condannare un sistema di governo del mondo impostato su modelli maschili non più sostenibili. Pensiamo a come è stata gestita l’emergenza coronavirus dai governi, o a come sono state utilizzate le informazioni in Cina o in America, oppure ai tagli fatti alla sanità in Italia, frutto di un modello manageriale di stampo privatistico applicato al settore pubblico".
Uno degli insegnamenti si intitola "Crisi globali e risposte maschili: un passaggio di civiltà per sfidare razzismo, sovranismo e neoliberismo". Perché, però, partire dalla violenza sulle donne?
"E’ sempre la violenza il grande tema. Quella sulle donne porta con sé tutte le altre. Intendiamo per inviolabilità del corpo femminile l’inviolabilità di ogni vivente. Pensiamo a quello che subiscono i migranti, gli altri, i diversi, e guardiamo allo stupro ambientale del pianeta. La riflessione su una nuova forma mentis non può prescindere da una forte istanza ecologista, che combatta l’atteggiamento predatorio nei confronti dell’ambiente. Oggi è un 8 marzo di festa per le donne, le uniche capaci di regalare la visione di un altro futuro possibile".
Da qui il bisogno di guardarsi in faccia, donne e uomini.
"Diciamo che, a differenza di quanto avvenuto nella storia del pensiero femminile e femminista, manca completamente quella che possiamo chiamare autocoscienza maschile, con il riconoscimento da parte degli uomini delle loro responsabilità. È per loro un processo appena cominciato. Ho chiamato con me lo psicanalista Recalcati, ma anche Marco Deriu dell’università di Parma, Stefano Ciccone, sociologo, ricercatore a Genova, Lorenzo Bernini, docente a Verona, ’uomini nuovi, trasformati’, li chiamo. Consapevoli di dover fare la loro parte, appunto".
Lei tiene regolarmente corsi di formazione per alti funzionari dello Stato, personale delle prefetture, degli ospedali, dirigenti di grandi aziende. Quanto bisogno c’è di riflettere sul pensiero della differenza nelle istituzioni e nel mondo del lavoro?
"La narrazione sulla violenza ha finito col concentrarsi tutta sull’oggetto del sopruso, rappresentando sempre le donne come vittime e trascurando la centralità del carnefice. Qualcosa però sta cambiando, e c’è una forte consapevolezza della necessità di ripensare la cultura misogina su cui si basa la nostra società. Vedo un interesse nuovo da parte delle amministrazioni pubbliche, ad esempio, chiamate a intervenire con competenza e sensibilità nei casi di violenza, affinché non si verifichino ulteriori mortificazioni e delegittimazioni nelle corsie degli ospedali, in sede di denuncia davanti alle forze dell’ordine, nei processi per stupro. E c’è un nuovo approccio ai differenti comportamenti femminili in campo aziendale, che valorizza la sapienza femminile come risorsa chiave soprattutto nei momenti di crisi. Il Comune di Milano con cui è nata questa collaborazione ha dimostrato di essere pronto ad affrontare questa sfida, molto avanzata".
LO SPECIALE Gender gap, le donne presentano il conto
In un passaggio del suo libro, scrive che "giunti a questo punto della storia del mondo, pensatori e pensatrici dovrebbero quantomeno riuscire ad allearsi amorosamente con le istanze avanzate dalle donne nei secoli". Servirà questo approccio a eliminare violenza, sopraffazione e gender gap?
"La Scuola ha l’ambizione di portare la riflessione oltre l’individuazione degli strumenti utili all’eliminazione delle disuguaglianze in termini di accesso al lavoro, di posizione nella vita pubblica o remunerazione che già esistono. Si tratta di arrivare però alla radice dei problemi, e chiarire cosa non funziona nella relazione tra i sessi. E su questo terreno gli uomini hanno sì tanta strada a fare".
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. Basta - con la connivenza all’ordine simbolico della madre!!!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ" ! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- La comunità degli abbandonati (di DIVYA DWIVEDI - SHAJ MOHAN - "Antinomie").13 marzo 2020, di Federico La Sala
NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ": LO STATO DI "ECCEZIONE UMANA" ....*
La comunità degli abbandonati
di DIVYA DWIVEDI - SHAJ MOHAN *
- Pubblichiamo in italiano - e in lingua originale a seguire - questo contributo che ci hanno fatto pervenire i due filosofi indiani Divya Dwivedi e Shaj Mohan, venuti a conoscenza del dibattito aperto dall’articolo di Giorgio Agamben e dalla risposta, qui su Antinomie, di Jean-Luc Nancy.
 Ci sembra che in questo momento sia importante condividere i pensieri, far sì che nessuno si senta abbandonato. Detto altrimenti, ci pare sia importante, attraverso una rete globale, far fronte a un evento che, in modo sempre più evidente, mostra come il futuro dell’umanità dipenda dalla capacità di vedere il mondo quale inedita esperienza di una mondializzazione sempre più interconnessa, interdipendente e cosmopolita. Solo la capacità di passare da un pensiero all’altro, da un continente all’altro, da una lingua all’altra, da una specie all’altra potrà forse mutare il destino che sembra aspettarci e nel quale siamo chiamati ad operare. F.F.
Ci sembra che in questo momento sia importante condividere i pensieri, far sì che nessuno si senta abbandonato. Detto altrimenti, ci pare sia importante, attraverso una rete globale, far fronte a un evento che, in modo sempre più evidente, mostra come il futuro dell’umanità dipenda dalla capacità di vedere il mondo quale inedita esperienza di una mondializzazione sempre più interconnessa, interdipendente e cosmopolita. Solo la capacità di passare da un pensiero all’altro, da un continente all’altro, da una lingua all’altra, da una specie all’altra potrà forse mutare il destino che sembra aspettarci e nel quale siamo chiamati ad operare. F.F.
Per molto tempo l’India è stata un paese ricco di gente eccezionale, il che ha svuotato di significato il concetto di ‘stato di eccezione’ o quello della sua ‘estensione’. I bramini sono eccezionali perché solo loro possono presiedere ai rituali che regolano l’ordine sociale e perché non possono essere toccati (meno che mai desiderati) da coloro che appartengono alle caste inferiori per tema di minare la purezza del rituale. In tempi moderni, in alcuni casi, questo prevede servizi igienici separati per loro. A loro volta anche i Dalit, le persone delle caste più basse, non possono essere toccate, e tantomeno desiderate, dalle caste superiori perché ritenute le più ‘impure’. Come si può notare, l’eccezione del bramino è diversa dall’esclusione del Dalit. Una delle caste dei Dalit chiamata ‘paria’ è diventata nell’opera di Arendt un ‘paradigma’, illuminandone tristemente la realtà di sofferenza. Nel 1896, quando la peste bubbonica arrivò a Bombay, l’amministrazione coloniale britannica cercò di contrastare il diffondersi della malattia con l’emanazione dell’Epidemic Diseases Act (legge sulle malattie epidemiche) del 1897. Ma le barriere tra le caste, tra cui la richiesta da parte delle caste più alte di ospedali separati e il rifiuto di ricevere assistenza medica da persone di caste inferiori appartenenti al personale medico, andarono a sommarsi alle cause di morte per più di dieci milioni di indiani.
La diffusione del coronavirus[1], che ha infettato più di 100.000 persone a quanto dicono le cifre ufficiali, porta allo scoperto la domanda che oggi ci poniamo su noi stessi - Vale la pena di salvarci, e a quale costo? Ci sono da un lato le teorie complottistiche, che vanno dalle ‘armi biologiche’ a un presunto progetto globale di frenare le ondate migratorie. Dall’altro, ci sono fastidiosi equivoci, dalla convinzione che il COVID-19 si propaghi attraverso la birra Corona, alle notazioni razziste sui cinesi. Ma ancora più preoccupante è che, in questa con-giuntura di morte di dio e di nascita del dio meccanico, perdura una crisi che riguarda direttamente il ‘valore’ dell’uomo. Si vede nelle reazioni alla crisi climatica, nell’‘esuberanza’ tecnologica, e nel coronavirus.
Prima l’uomo si conquistava il proprio valore tramite svariate teo-tecnologie. Per esempio, ci si poteva immaginare che creatore e creatura fossero la determinazione di qualcosa di precedente, per esempio “l’essere”, dove il primo si dava come infinito e il secondo come finito. In una divisione di questo tipo, si poteva pensare a dio come uomo infinito e all’uomo come dio finito. Nel nome dell’uomo infinito gli dei finiti eleggevano i loro scopi. Oggi, deleghiamo la determinazione degli scopi alla macchina, quindi il suo ambito a questo punto si può definire tecno-teologico.
È in questa con-giuntura particolare che vanno considerate le recenti osservazioni di Giorgio Agamben, secondo il quale le misure di contenimento contro il COVID-19 vengono impiegate come un’“eccezione” volta a permettere un incredibile ampliamento dei poteri dei governi nell’imporre restrizioni straordinarie alle nostre libertà. Cioè, le misure adottate, con notevole ritardo, dalla maggior parte degli stati per prevenire la diffusione di un virus che potenzialmente può uccidere almeno 1% della popolazione, potrebbero condurre al livello successivo di “eccezione”.
 Agamben ci chiede di scegliere tra “l’eccezione” e l’ordinario benché la cosa che lo preoccupi sia che l’eccezione diventi la regola.[2]
Agamben ci chiede di scegliere tra “l’eccezione” e l’ordinario benché la cosa che lo preoccupi sia che l’eccezione diventi la regola.[2]
 Jean-Luc Nancy ha in seguito risposto a questa obiezione osservando che oggi ci sono solo eccezioni, vale a dire, tutto quello che un tempo consideravamo ordinario è ormai infranto.[3]
Jean-Luc Nancy ha in seguito risposto a questa obiezione osservando che oggi ci sono solo eccezioni, vale a dire, tutto quello che un tempo consideravamo ordinario è ormai infranto.[3]
 Nel suo ultimo saggio, Deleuze si riferiva a ciò che ci interpella alla fine di tutti i giochi tra ordinarietà ed eccezioni come a “una vita”[4]; ovvero che si è afferrati dalla responsabilità quando ci si confronta con una vita individuale che è nella presa della morte. Morte e responsabilità vanno insieme.
Nel suo ultimo saggio, Deleuze si riferiva a ciò che ci interpella alla fine di tutti i giochi tra ordinarietà ed eccezioni come a “una vita”[4]; ovvero che si è afferrati dalla responsabilità quando ci si confronta con una vita individuale che è nella presa della morte. Morte e responsabilità vanno insieme.Occupiamoci allora della non-eccezionalità delle eccezioni. Fino alla fine del 1800, negli ospedali molte donne incinte dopo aver partorito morivano di febbre puerperale o di infezioni post-parto. A un certo punto, un medico ungherese, Ignác Semmelweis, si rese conto che ciò succedeva perché le mani degli operatori sanitari veicolavano agenti patogeni passando da un’autopsia a un paziente, o dall’utero di una donna a un’altra, provocando così infezioni e morte. La soluzione proposta da Semmelweis fu di lavarsi le mani dopo ogni contatto. Per questa ragione fu trattato come un’eccezione e messo al bando dalla comunità medica. Morì di setticemia in manicomio, pare contratta dopo essere stato bastonato dalle guardie. In realtà, i sensi delle eccezioni sono infiniti. Nel caso di Semmelweis, la tecnica stessa per combattere le infezioni rappresentava l’eccezione. Nella Politica, Aristotele ha parlato del caso dell’uomo eccezionale, come di colui che sa cantare meglio del coro, che viene messo al bando in quanto dio tra uomini.
Non c’è un unico paradigma per l’eccezione. La via di una patologia microbica è diversa di quella di un’altra. Per esempio, gli stafilococchi vivono all’interno del corpo umano senza arrecare difficoltà, anche se scatenano infezioni quando la risposta del nostro sistema immunitario è “eccessiva”. Al punto estremo dei rapporti non-patogeni, i cloroplasti nelle cellule vegetali e i mitocondri nelle cellule del nostro corpo rappresentano delle convivenze antiche e ben assorbite tra specie differenti. In particolare, virus e batteri non ‘intendono’ uccidere il loro ospite, perché non è sempre nel loro ‘interesse’[5] distruggere l’unico tramite che gli permette di sopravvivere. Sul lungo termine - milioni di anni di tempo della natura - “tutte le cose imparano a vivere insieme” o per lo meno raggiungono un equilibrio reciproco per lunghi periodi. Questo è il senso che ha il biologo della temporalità della natura.
In anni recenti, in parte in seguito a pratiche agricole, microrganismi che vivevano in modo indipendente l’uno dall’altro si sono uniti e hanno cominciato a scambiarsi materiale genetico, a volte solo frammenti di DNA e RNA. Quando questi organismi hanno fatto il “salto” e sono passati agli esseri umani, a volte per noi sono cominciati disastri. Il nostro sistema immunitario percepisce questi nuovi arrivati come uno shock e, sopravvalutandone le risorse, induce infiammazioni e febbre che spesso uccidono noi e anche i microrganismi.
 Etimologicamente il “virus”[6] è legato al veleno. È un veleno nel senso che quando un nuovo virus trova una soluzione negoziata con gli animali umani, noi siamo già morti da un pezzo. Ossia, ogni cosa può essere considerata secondo il modello del pharmakon (che è sia veleno che cura) se ci basiamo sul tempo della natura. Ma la distinzione tra farmaco e veleno per lo più riguarda il tempo dell’uomo, l’animale meraviglioso. Ciò che si definisce ‘biopolitico’ prende posizione partendo dal presupposto di una temporalità della natura, e di conseguenza trascura quello che è un disastro nell’ottica del nostro interesse in - la nostra responsabilità per - “una vita”, cioè la vita di tutti coloro che rischiano di morire per aver contratto il virus.
Etimologicamente il “virus”[6] è legato al veleno. È un veleno nel senso che quando un nuovo virus trova una soluzione negoziata con gli animali umani, noi siamo già morti da un pezzo. Ossia, ogni cosa può essere considerata secondo il modello del pharmakon (che è sia veleno che cura) se ci basiamo sul tempo della natura. Ma la distinzione tra farmaco e veleno per lo più riguarda il tempo dell’uomo, l’animale meraviglioso. Ciò che si definisce ‘biopolitico’ prende posizione partendo dal presupposto di una temporalità della natura, e di conseguenza trascura quello che è un disastro nell’ottica del nostro interesse in - la nostra responsabilità per - “una vita”, cioè la vita di tutti coloro che rischiano di morire per aver contratto il virus.Qui sta il nocciolo della questione: siamo stati in grado di determinare gli ‘interessi’ del nostro sistema immunitario dando luogo a eccezioni in natura, per esempio attraverso il metodo di Semmelweis di lavarsi le mani e attraverso le vaccinazioni. Siamo una specie animale che non ha epoche biologiche a sua disposizione per poter perfezionare ogni intervento. Per cui, anche noi, come la natura, commettiamo errori di codifica e generiamo mutazioni in natura, rispondendo a ogni necessità nei modi migliori che possiamo.
 Come ha fatto notare Nancy, l’uomo come eccezionale artefice di tecnologie e meraviglioso a sé stesso, fu pensato molto tempo fa da Sofocle nella sua ode all’uomo. Analogamente, diversamente dal tempo della natura, gli esseri umani si preoccupano di questo momento, che deve condurre al successivo con la sensazione che noi siamo gli abbandonati: coloro che sono condannati a chiedere “il perché” del loro esistere ma senza avere i mezzi per chiedere. O, come precisava Nancy in una lettera privata, ‘abbandonati da nulla’.
Come ha fatto notare Nancy, l’uomo come eccezionale artefice di tecnologie e meraviglioso a sé stesso, fu pensato molto tempo fa da Sofocle nella sua ode all’uomo. Analogamente, diversamente dal tempo della natura, gli esseri umani si preoccupano di questo momento, che deve condurre al successivo con la sensazione che noi siamo gli abbandonati: coloro che sono condannati a chiedere “il perché” del loro esistere ma senza avere i mezzi per chiedere. O, come precisava Nancy in una lettera privata, ‘abbandonati da nulla’.
 Il potere di questo “essere abbandonati” è diverso dagli abbandoni rappresentati dall’assenza di cose particolari le une rispetto alle altre. Questo essere abbandonati esige, come abbiamo visto in Deleuze, che ci si prenda cura di ogni vita in quanto preziosa, pur sapendo al contempo che nelle comunità degli abbandonati possiamo sperimentare la chiamata della vita individuale abbandonata di cui noi soli possiamo prenderci cura. Altrove abbiamo chiamato l’esperienza di questa chiamata dell’abbandonato, e la possibile nascita della sua comunità dalla metafisica e l’ipofisica, ‘anastasis’[7]
Il potere di questo “essere abbandonati” è diverso dagli abbandoni rappresentati dall’assenza di cose particolari le une rispetto alle altre. Questo essere abbandonati esige, come abbiamo visto in Deleuze, che ci si prenda cura di ogni vita in quanto preziosa, pur sapendo al contempo che nelle comunità degli abbandonati possiamo sperimentare la chiamata della vita individuale abbandonata di cui noi soli possiamo prenderci cura. Altrove abbiamo chiamato l’esperienza di questa chiamata dell’abbandonato, e la possibile nascita della sua comunità dalla metafisica e l’ipofisica, ‘anastasis’[7]Tradotto dall’inglese da Fiorenza Conte. A cura dell’European Journal of Psychoanalysis.
[1] Per pura coincidenza, il nome del virus è ‘corona’, la metonimia della sovranità.
[2] Il che ovviamente è stato percepito come una non-scelta da quasi tutti i governi dopo il 2001 per rendere sicuri tutti i rapporti sociali in nome del terrorismo. La tendenza importante in questi casi è che la securizzazione dello stato è proporzionata alla aziendalizzazione di quasi tutte le funzioni dello stato.
[3] Si veda, Jean-Luc Nancy, L’intruso, Cronopio, 2005.
[4] Si veda, Gilles Deleuze, Immanenza: una vita, Mimesis, 2010.
[5] È assurdo attribuire un interesse a un micro-organismo, e i chiarimenti a questo proposito potrebbero occupare più spazio di quanto concesso per questo intervento. Oggi è altrettanto impossibile determinare l’“interesse dell’uomo”
[6] Da notare che i “virus” esistono sulla linea critica tra vivente e non-vivente.
[7] Shaj Mohan, Divya Dwivedi, Gandhi and Philosophy: On Theological Anti-Politics, prefazione di J.-L. Nancy, Londra, 2019.
* Fonte: "Antinomie", 12/03/2020 (ripresa parziale).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- VERITA’ E VERIDIZIONE: PAROLE PER UNA NUOVA POLITICA. Agamben fa un passo innanzi con Foucault, ma cento passi indietro senza Kant.
NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ" ! DI FRONTE A PONZIO PILATO E NON CAPIRE UN’ACCA ?!
Federico La Sala
- Pubblichiamo in italiano - e in lingua originale a seguire - questo contributo che ci hanno fatto pervenire i due filosofi indiani Divya Dwivedi e Shaj Mohan, venuti a conoscenza del dibattito aperto dall’articolo di Giorgio Agamben e dalla risposta, qui su Antinomie, di Jean-Luc Nancy.
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN.10 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN ...
ALLA LUCE DEL CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO: “ECCE HOMO”(cfr. sopra : https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/#comment-269838), si comprende meglio anche il significato delle parole di Christine de Pizan, l’autrice della “Città delle dame” : «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, “dalla parte del torto”, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
***
ASTREA ! “IAM REDIT ET VIRGO” ...
CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola Rackete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:
- ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A.‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova ; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova ; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛Astraeam‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6 ; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).
Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CHARIDAD. "Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád".8 marzo 2020, di Federico La SalaCHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád ("Diccionario de Autoridades" - Tomo II, 1729).
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Italia. 8 marzo, la protesta si fa diffusa. Flash mob a Roma e S-corteo a Milano. Un’occasione per ripensare un sistema che annulla i legami di solidarietà (di Shendi Veli).7 marzo 2020, di Federico La Sala
Italia
8 marzo, la protesta si fa diffusa
Non Una Di Meno. Cancellate le iniziative che prevedono assembramenti di massa. Si prende parola in forme creative. Flash mob a Roma e S-corteo a Milano. Un’occasione per ripensare un sistema che annulla i legami di solidarietà
di Shendi Veli (il manifesto, 07.03.2020)
La lotta ai tempi del corona virus assume aspetti imprevisti. Non si ferma la marea femminista, ma si riplasma in forme creative per prendere parola intorno alla data dell’8 marzo, momento di mobilitazione a livello globale. Ieri a a Roma la rete Non Una Di Meno insieme ai Fridays For Future ha messo in atto una performance. Un gruppo di persone vestite di tute e bianche e mascherine ha occupato Piazza dell’Esquilino intonando dei cori su una coreografia. Sulla schiena di ogni partecipante c’era un scritta che nominava le varie emergenze letali dei nostri tempi: il virus, certo, ma anche il lavoro, l’inquinamento e la violenza patriarcale.
«In un contesto di emergenza sanitaria abbiamo scelto di annullare tutte quelle iniziative che non garantiscono il rispetto delle norme previste per la salute di tutt*: la responsabilità collettiva è per noi da sempre centrale e sinonimo di cura reciproca» si legge nel comunicato del nodo romano. Ma la decisione è condivisa a livello nazionale, anche se restano le azioni simboliche, che ogni città declinerà a suo modo.
A Milano è stato lanciato per l’ 8 marzo lo «S-corteo», un primo esperimento di manifestazione diffusa «S-corteo è NON rimanere isolat* con la propria paura. S-corteo è un invito, a tutte le persone che l’8 marzo vorranno attraversare la città, a indossare qualcosa di fucsia così da riconoscerci a vicenda» spiegano nell’evento facebook.
A Roma, lo stesso giorno, è previsto un flash mob alle 12 a Piazza di Spagna, le manifestanti annunciano che saranno a distanza ma legate da un nastro fucsia, perché in un momento di crisi si pone l’accento sull’importanza dei legami di cura e solidarietà. Tra i turni estenuanti delle professioni sanitarie e le scuole chiuse, le donne rischiano di essere la valvola di scarico di un sistema non pensato per tutelare la vita.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Coronavirus, il fatto «sociale totale» nel quale specchiarsi (di Filippo Barbera).4 marzo 2020, di Federico La Sala
Coronavirus, il fatto «sociale totale» nel quale specchiarsi
di Filippo Barbera (il manifesto, 04.03.2020)
Un fatto sociale totale - nella definizione del grande antropologo Marcel Mauss - è qualcosa in grado di influenzare e determinare un insieme di fenomeni coinvolgendo la gran parte dei meccanismi di funzionamento della comunità di riferimento. Per Mauss il fatto sociale totale per antonomasia era il dono, in quanto capace di unire le pratiche e le cornici di senso riferibili ad aspetti mitopoietici, economici, politici, espressivi e religiosi. Il fatto sociale totale permetterebbe così di interpretare «pezzi» apparentemente lontani e diversi della stessa società.
Mani pulite, in questo senso, è stato un fatto sociale totale: ha scosso le diverse fondamenta della società italiana e ne ha messo in luce i tratti e le dinamiche politiche, culturali, economiche e simboliche. Oggi, il coronavirus svolge la stessa funzione. Ogni misura sanitaria e di igiene pubblica è intimamente politica, tanto nelle sue cause che nelle sue conseguenze, si intende. Ma le misure decise in occasione della comparsa del coronavirus rivelano - come un reagente chimico - qualcosa di profondo e «totale» sulla società e politica italiane, nonché sulle sue credenze diffuse, modelli culturali e struttura economica. Il coronavirus mostra con ogni possibile forza come la vita politica italiana sia intrappolata - non da oggi - in un’arena hobbesiana, dove la divisione fra amici e nemici si sovrappone ai confini fra gruppi in competizione per il potere e l’influenza. Dove è assente un contesto condiviso (la Costituzione, la Nazione, la Patria, la Repubblica, etc.) che permette a questi gruppi di competere correndo dei rischi politici.
Nelle arene hobbesiane il rischio politico è accuratamente evitato dai gruppi in competizione che utilizzano la logica amico/nemico. La strategia razionale in un contesto come questo è - di fronte a un evento improvviso e in assenza di esperienza pregressa - quella di minimizzare il rischio politico delle decisioni prese. Non poter essere accusati di non «aver fatto tutto il possibile» per le persone contagiate o per bloccare il contagio (a prescindere dalle sue conseguenze), non dover essere obbligati a rifiutare ricoveri in terapia intensiva ad anziani con febbre e polmonite, non diventare oggetto di attacchi e accuse stigmatizzanti.
Consideriamo le misure sanitarie. Quelle previste dal ministero con le tre classi di rischio e misure proporzionate sono intese a contenere i focolai in modo che si esauriscano all’interno e non si allarghino alle aree ancora indenni. Il tutto basato sull’assunzione che il danno di una epidemia diffusa o addirittura di una pandemia sia più alto dei danni sociali ed economici attesi. Questa assunzione sembra eccessiva, dato che per quanto se ne sa finora, la severità delle conseguenze di questa influenza un po’ più grave non sarebbe così alta, soprattutto in una stagione invernale con una influenza vera molto mite.
Ciò che giustifica le assunzioni alla base delle misure prese è la minimizzazione del rischio politico, il non volersi esporre alle accuse che certamente pioverebbero da nemici e falsi ex amici, anche in assenza di una giustificazione basata sul calcolo costi-benefici. La minimizzazione del rischio politico è una metrica ipertrofica che si «mangia» tutte le altre, riducendole a semplici giustificazioni ex post. Dall’assalto ai supermercati, alla speculazione sui prezzi delle mascherine, alle dichiarazioni dei politici, alla crisi dell’export, del polo della logistica e del turismo, il coronavirus è il nostro miglior specchio. Dovremmo avere il coraggio di guardarlo senza abbassare lo sguardo.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DI FRONTE A PONZIO PILATO E NON CAAPIRE UN’ ACCA?!1 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE.
Da Giovanni Pico della Mirandola* a Herbert Marcuse** e ...
CARO ARMANDO, PER IMPARARE "a vivere meglio senza lasciarci condizionare dalla paura della morte, cioè dalla religione, qualunque essa sia", CREDO CHE SIA NECESSARIO riconsiderare il problema di "come nascono i bambini" (a tutti i livelli)! Hai ragione: "Non possiamo permetterci, con le Sibille, Maria Vergine, Cristo come dio, Maometto ed altre favolette l’illusione di un altro Messia"! Ci siamo addormentati nella tradizione cattolico-costantiniana e illuministica acritica (contro Kant), e abbiamo finito per "concepire" noi stessi e noi stesse secondo la bio-logia e l’andro-logia “unidimensionale” dell’omuncolo!
L’«ECCE HOMO» di Ponzio Pilato, al contrario!, ci dice proprio questo - la fine delle "favolette" e di ogni "illusione di un altro Messia". Il discorso è di diritto e di fatto, romanamente universale, vale a dire, antropologico (non limitato all’«omuncolo» di qualche "uomo supremo" o “superuomo”!):
- PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
SE SIAMO ANCORA CAPACI DI LEGGERE, COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA LEZIONE DI PONZIO PILATO?! Non è una lezione critica contro i "sovranisti" laici e religiosi di ieri e di oggi?!
Che vogliamo fare? Continuare a riportare noi stessi e noi stesse davanti a Pilato e ripetere da scemi e da sceme la stessa scena, riascoltare il suo "Ecce Homo" e non capire una "H" (acca)?!
* Discorso sulla dignità dell’uomo.P.S. - RICORDANDO ... GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA “VIA” PER USCIRE DALLA CAVERNA. La lezione di Ponzio Pilato (e di Leonzio Pilato).27 febbraio 2020, di Federico La Sala
L’”ECCE HOMO” (E LA “CORONA DI SPINE”)! Non c’è solo Ponzio Pilato, c’è anche Leonzio Pilato. Non dimentichiamolo... *
DAL PEDUNCOLO ALL’OMUNCOLO: UNA “VIA” PER USCIRE DALLA CAVERNA. Sulla parola “omuncolo”, forse, è utile (cfr. A. Polito, "Dialetti salentini: piticinu", Fondazione Terra d’Otranto) rifletterci un momento: a mio parere, tale parola sollecita a portare alla luce la implicita differenza che veicola in sé. Sorprendentemente, se da una parte dice di un giudizio sul comportamento di una persona di sesso maschile che dovrebbe essere “vir-ile” ma che tale non è, dall’altra, per la sua provenienza etimologica “da una base homo, genitivo hominis, che significa uomo”, veicola e produce una generalizzazione indebita che porta a nascondere la presenza dell’altra metà (il sesso femminile) del “genere umano”.
Come per il greco, la parola “antropologia” vale per ogni persona del “genere umano” (e, per il maschio e per la femmina, abbiamo, rispettivamente, l’andrologia e la ginecologia), così per il latino, la parola “umanità” (da “homo”) vale altrettanto per ogni persona del “genere umano”(e, in italiano, per l’homo-maschio, parliamo di “virile” e, per la homo-femmina, parliamo di “muliebre”).
“ECCE HOMO”. Quando Ponzio Pilato pronunciò la frase «Ecco l’uomo», mostrando alla folla Gesù flagellato cosa disse?! Parlò sì di un “uomo”, ma parlò dell’intero “genere umano”! O NO?! A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! A METTERE ANCORA IN TESTA AL “GENERE UMANO” UNA BELLA “CORONA” DI SPINE?!
*
Sul tema, mi sia consentito, si cfr.:
A) LA GRECIA, LA MEDIAZIONE DELLA CALABRIA, E IL RINASCIMENTO ITALIANO ED EUROPEO. In memoria di Barlaam (Bernardo) e di Leonzio Pilato ... PER BOCCACCIO, UNA GRANDE FESTA IN TUTTA L’ITALIA E L’EUROPA (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5421)
B) PER NON DIVENTARE UN “BOCCALONE”, UNA “BOCCALONE” - PER NON FARE LA FIGURA DEL “FESSO” O DELLA FESSA” (cfr.: https://www.fondazioneterradotranto.it/2017/09/29/fessa-dialetto-salentino-sesso/#comment-63709)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- “ECCE HOMO”: DAL PIEDE ALLA TESTA E DALLA TESTA AL PIEDE.29 febbraio 2020, di Federico La Sala
DAL PIEDE ALLA TESTA E DALLA TESTA AL PIEDE: “ECCE HOMO”! *
CARO ARMANDO, credo che la “generalizzazione che finisce per escludere di fatto la donna”, alla luce del prezioso lavoro realizzato da te e dal dott. Marcello Gaballo su “Santa Maria di Casole a Copertino e le sue Sibille” (cfr.: https://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/24/santa-maria-casole-copertino-le-sue-sibille/), non dipende da generici “millenni di maschilismo”. La riemersione nel nostro presente storico del “piticinu” (“peduncolo”) dell’”ECCE HOMO”, sollecita a riflettere più in profondità sulla nascita dell’uomo Gesù, a reinterrogarci sui suoi genitori e, in particolare, come recentemente e lodevolmente ha fatto la stessa Redazione della Fondazione Terra d’Otranto, su suo padre Giuseppe (cfr. “3 Commenti a De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò”: https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/11/10/de-domo-david-39-autori-per-i-400-anni-della-confraternita-di-san-giuseppe-di-nardo/#comment-257181), e a chiedere lumi alla SIBILLA DELFICA (vale a dire, oggi, alla “buonanima” di Sigmund Freud: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=406) per sapere la ragione del diffondersi della peste nella città di “Tebe”!!! La questione è decisamente antropologica e la situazione storica sollecita ancora e di nuovo a “conoscere sé stessi”, a conoscere sé stesse”, a comprendere finalmente “come nascono i bambini”, “come nascono le bambine”: certamente non da un “omuncolo”(cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2923 )! Ciò che è in gioco è la sopravvivenza della nostra stessa umanità, presente e futura. O no?!
*
-
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- DIRITTO. «Costituente Terra». Un progetto per immaginare gli strumenti politico-giuridici necessari ad affrontare i problemi del nostro tempo.22 febbraio 2020, di Federico La Sala
Politica
«Costituente Terra», la scuola che vuole salvare la specie umana
Diritto. Un progetto per immaginare gli strumenti politico-giuridici necessari ad affrontare i problemi del nostro tempo nella giusta scala
di Giansandro Merli *
«Per la prima volta nella storia esiste un interesse pubblico e generale assai più ampio e vitale di tutti i diversi interessi pubblici del passato: la sopravvivenza dell’umanità e l’abitabilità del pianeta». Luigi Ferrajoli, giurista e filosofo del diritto, pronuncia queste parole in piedi, circondato dai tomi antichi della splendida Biblioteca Vallicelliana, al centro di Roma.
L’occasione è la presentazione della scuola «Costituente Terra», che si è tenuta ieri. Poco prima avevano parlato Paola Paesano, direttrice dell’istituzione ospitante che in un raffinato intervento ha sottolineato le tensioni universalistiche che nel corso della storia hanno attraversato le biblioteche pubbliche, e un altro importante promotore del progetto, Raniero La Valle, giornalista, intellettuale ed ex senatore.
Sostenere l’esigenza di un costituzionalismo globale ai tempi dei rigurgiti sovranisti potrebbe sembrare un’azione fuori fuoco. E invece, sostengono i promotori, sono proprio quelle dinamiche a validare un simile sforzo. Le parole che La Valle e Ferrajoli mettono in fila sono come uno spillo che infrange la bolla di conoscenze acquisite e strumenti interpretativi che trasformano alcune contingenze nella forma del realismo. Lo sguardo è oltre la cronaca, così l’unico realismo diventa la consapevolezza che la politica ancorata agli Stati nazionali è impotente e inadeguata ad affrontare le sfide del nostro tempo.
L’alternativa possibile alle catastrofi cui essa va incontro e anzi produce, però, esiste. Sarà forse politicamente improbabile, almeno per ora, ma si può pensare. A ciò ambisce «Costituente Terra», al fine di revisionare il pensiero che ha portato l’umanità sull’orlo del baratro. Per farlo vuole espandere il costituzionalismo lungo tre direttrici: sovrastatualità; diritto privato; beni fondamentali. A esse corrispondono tre questioni cui occorre trovare risposte su scala planetaria: catastrofe ecologica; guerre; povertà e disuguaglianze. La loro soluzione passa per l’immaginazione politico-giuridica di istituti di garanzia dei diritti fondamentali a livello globale. È questo uno degli obiettivi della scuola, che però sarà anche anti-scuola. «Una scuola trasmette i saperi da una generazione all’altra per riprodurre la società come l’abbiamo ricevuta - dice La Valle - Invece noi dovremmo trasmettere un sapere che ancora non c’è, perché col sapere che c’è la società ricevuta non solo non va bene, ma nemmeno può continuare».
* Fonte: il manifesto, 22.02.2020 (ripresa parziale).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO ED ANTROPOLOGICO. Leader e popolo, una fusione pericolosa (Lea Melandri)..21 febbraio 2020, di Federico La Sala
MENTE ACCOGLIENTE. DUE SOLI (DANTE): USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO, dalla dialettica "tunica di Nesso" ... *
Leader e popolo, una fusione pericolosa
di Lea Melandri **
- Viviamo un tempo nel quale emergono rabbie razziste e sessiste, un individualismo sempre più competitivo, un ripiegamento su identità e leader. Per far crescere una nuova cultura politica, quello che oggi non possiamo smettere di fare, suggerisce Lea Melandri, è cercare nessi tra percorsi, temi, movimenti. Ad esempio, «si potrebbe vedere nel movimento a difesa dell’ambiente e nella rete globale femminista di Non Una Di Meno, oggi protagonisti sulla scena del mondo, la “ripresa” di quella cultura politica che negli anni Settanta ha avviato forme nuove e più libere di convivenza umana...»
- [Foto] Tratta dalla pag. fb di Non una di meno Reggio Emilia
La politica dell’odio comporta inevitabilmente la ricaduta su un capro espiatorio, ma prevede anche che ci sia un abile manovratore che lo riconosca e lo additi come la causa di tutti i mali. Meno visibile, ma determinante è il sentimento che sta a monte, e cioè il rancore, inascoltato e diffuso quanto basta per fare di un capo autoritario l’espressione ritenuta più genuina della volontà di un popolo. Contraddittoriamente, è proprio la perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni che dovrebbero rappresentarli - partiti, sindacati, parlamento, amministrazioni, ecc.- a imprimere alle democrazie una svolta sovranista. La saldatura avviene non a caso attraverso un linguaggio che scambia la politica col senso comune, il ragionamento con le emozioni, la verità con la demagogia, la legge con la vendetta.
Se la mozione degli affetti è smaccatamente l’arma preferita dal cinismo politico di Matteo Salvini, pronto ad agitare, per la cattura del suo pubblico, crocefissi, rosari, bambini violati, il malcontento che ha portato alla presidenza degli Usa inaspettatamente un personaggio come Donald Trump, non è molto diverso da quello che sta all’origine del successo elettorale della Lega. In un libro di una decina di anni fa, Il rancore (Feltrinelli 2008), Aldo Bonomi parlava della comparsa nelle fabbriche di “una forma di sordo rancore quale reazione alla frustrazione di un ruolo sociale perduto”.
“Imprenditore politico della paura”, la Lega - commentava Bonomi - non aveva avuto difficoltà a indirizzare le paure e le insicurezze dei “naufraghi del fordismo” contro la “concorrenza sul mercato del lavoro da parte degli immigrati, l’ingiustizia perpetrata a loro danno con la concessione degli alloggi agli extracomunitari, l’impossibilità della convivenza tra soggetti portatori di culture diverse”. Riflessioni analoghe sul legame tra populismo e sovranismo si trovano nella intervista di Eleonora Capuccilli a Wendy Brown (Il Manifesto 7.1.20):
- “Si è rotto il contratto sociale postbellico che aveva promesso sicurezza e un certo grado di mobilità alle classi medie e operaie bianche (...) La disuguaglianza è cresciuta, quindi, sia a livello di ricchezza sai a livello di quelli che erano stati beni comuni (...) La destra ha brillantemente trasformato questa frustrazione in una rabbia razzista e sessista”.
Nel momento in cui si dissolvono i legami che per un secolo hanno strutturato le relazioni sociali, la partecipazione politica e l’azione collettiva, a venire allo scoperto è una moltitudine di singoli, avviati verso un individualismo sempre più competitivo: l’individualismo proprietario o “il capitale umano”, di cui si parla oggi. Le ricadute della globalizzazione sui luoghi della vita quotidiana, la scomparsa del lavoro in una miriade di impieghi sottopagati o gratuiti, a cui va aggiunta la crisi del patriarcato e dei secolari privilegi del sesso maschile, muovono paure, spaesamento, fanno emergere fragilità insospettate, bisogno di protezione e ripiegamento su identità e appartenenze tradizionali, oltre a violenze di matrice sessista e razzista, nostalgie di regimi autoritari.
Dire che oggi “il re è nudo” significa riconoscere il limite della politica separata, la
- “rovinosa dialettica - come la definiva Elvio Fachinelli - che ha contrapposto corpo e pensiero, biologia e storia, individuo e società; vuol dire fare i conti con il venir meno delle barriere con cui la civiltà ha creduto di poter esiliare come “non politiche” le esperienze più universali dell’umano, la sessualità, la maternità, la nascita, la morte, la relazione tra i sessi”.
Dire che la “psiche individuale” è oggi il campo attraverso cui “passano tensioni politiche di un’epoca sospesa tra rancore, chiusure verso il nuovo che avanza e la prefigurazione di forme comunitarie più libere che in passato” (A. Bonomi), significa rendersi conto - come ha fatto il femminismo - che la figura del cittadino non coincide con la “persona”, vista nella sua interezza, corpo e pensiero, e nella appartenenza a sessi diversi.
Nella “viscere della storia” si può pensare che siano rimasti, non indagati, tesori di cultura, insospettate potenzialità antropologiche, così come pulsioni arcaiche, sogni, pregiudizi: un rimosso inferno infantile che preme per la sua reincarnazione.
- “Nessuna antropologia - scriveva Elvio Fachinelli - che si voglia all’altezza del suo oggetto, potrà in futuro trascurare di esaminare e approfondire queste potenze interne”.
L’uscita dal dualismo si era affacciata alla coscienza storica con i movimenti non autoritari degli anni Settanta, sintomo essi stessi della modificazione dei confini tra privato e pubblico, e, contemporaneamente, prefigurazione di nuove forme dell’agire politico.
- “Si era venuto definendo allora - sono le parole di Fachinelli - un campo pratico-teorico irriducibile ai termini della coppia. (...) il passaggio del bambini da essere biologico a essere inserito nell’universo simbolico proprio dell’uomo“.
- [Foto] Tratta daooa pg. fb di Sardine Roma
Il problema era di cercare nessi, che ci sono sempre stati, tra un polo e l’altro e spingere le analisi politiche verso una “regione bio-psico-sociologica”. Non si poteva immaginare allora che i nuovi percorsi aperti dal ’68 e dal femminismo come riscoperta della politicità del vissuto personale, uscita dalla passività e dalla delega, partecipazione di coloro che sono sempre stati esclusi dal potere, valorizzazione dei sentimenti e dei sogni, sarebbero stati nel giro di alcuni decenni assorbiti dalle tecnologie digitali, ripresi e piegati a finalità opposte dal populismo di destre autoritarie.
 Nell’“acquario Web” si può dire che passano la saldatura tra leader carismatico e popolo, e l’illusione partecipativa. “L’affermazione globale di Internet - si legge nel libro di Alessandro Dal Lago. Populismo digitale (Raffaello Cortina
2017) - rende superflua la distinzione fondamentale tra vita pubblica e vita privata. Chi agisce in rete, come blogger,
come commentatore, acquirente, semplice flaneur o attore politico potenziale, si trova in una situazione privata, perché è a casa sua o comunque isolato, e al tempo stesso pubblica..”.
Nell’“acquario Web” si può dire che passano la saldatura tra leader carismatico e popolo, e l’illusione partecipativa. “L’affermazione globale di Internet - si legge nel libro di Alessandro Dal Lago. Populismo digitale (Raffaello Cortina
2017) - rende superflua la distinzione fondamentale tra vita pubblica e vita privata. Chi agisce in rete, come blogger,
come commentatore, acquirente, semplice flaneur o attore politico potenziale, si trova in una situazione privata, perché è a casa sua o comunque isolato, e al tempo stesso pubblica..”.Tipico del populismo digitale di leader come Trump, Salvini, Grillo, è il coinvolgimento che passa attraverso un linguaggio rozzo, volgarità, sensazionalismo, ammiccamenti ai ceti impoveriti dalla crisi economica, ritorno alle logiche amico-nemico, che si tratti di migranti, omosessuali o femministe. Dell’importanza di un “rapporto emotivo” sembra essersi accorta tardivamente anche la sinistra partitica, oggi all’affannosa ricerca di “un’anima”. Che ci siano movimenti, come quello delle Sardine, a offrirgliene una all’occorrenza, non sembra sufficiente. Si potrebbe invece vedere nel movimento a difesa dell’ambiente e nella rete globale femminista di Non Una Di Meno, oggi protagonisti sulla scena del mondo, la “ripresa” di quella cultura politica che negli anni Settanta ha avviato forme nuove e più libere di convivenza umana.
* *Pubblicato su Il Riformista e qui con l’autorizzazione dell’autrice (Comune-info, 20 Febbraio 2020 (ripresa parziale, senza immagine]).
Non Una di Meno: Appello per la mobilitazione dell’8 marzo e Sciopero femminista e transfemminista del 9 marzo 2020
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LO STRUMENTO ELETTO: LINGUA GRECA, CRISTIANESIMO, E CATTOLICESIMO.18 febbraio 2020, di Federico La Sala
LINGUA GRECA E CRISTIANESIMO: LO STRUMENTO ELETTO E L’EU-CARESTIA... *
GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA GRECA
LO STRUMENTO ELETTO
ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ • VAS ELECTIONIS
Il ruolo della lingua greca nella diffusione del pensiero cristiano
Sabato 8 febbraio 2020, ore 10
Sala conferenze - Palazzo Reale, Piazza Duomo 14, Milano
Interventi
Sua Eminenza Gennadios - Arcivescovo d’Italia e Malta
L’educazione e la cultura sono la via per la pace
Stefano Martinelli Tempesta - Università degli Studi, Milano
Fede cristiana e tradizione classica nei codici della Biblioteca Ambrosiana
Alberto Barzanò - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
La lingua greca: strumento e veicolo di comunicazione tra primo cristianesimo e Impero romano
Emanuela Fogliadini - Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano
Eikōn, “icona”: somiglianza, rappresentazione, rivelazione del prototipo
Gilda Tentorio - Università degli Studi, Milano L’anima senza tempo dell’Athos: scrittori e impressioni di viaggio
Marco Roncalli - Saggista e scrittore
Patristica greca, ortodossia orientale ed ecumenismo in san Giovanni XXIII
Massimo Cazzulo - Presidente Società Filellenica Lombarda
Il lessico liturgico della poesia neogreca del Novecento: l’esempio di To ʼΆξιoν ἐστί di Odisseas Elitis
L’inizio dei lavori sarà preceduto dai saluti delle Autorità di
Filippo Del Corno Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Nikolaos Sakkaris Console onorario della Repubblica di Grecia a Milano,
Dimitri Fessas Presidente della Federazione delle comunità e delle confraternite greche di Italia, Sofia Zafiropoulou Presidente della Comunità ellenica di Milano
* FONTE: LICEO CLASSICO STATALE "TITO LIVIO" - MILANO (27 gennaio 2020)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata... MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
EU-ANGELO, EU-ROPA .... E "SCRITTURA ED EU-CARESTIA"?! LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM".
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- LA BIBBIA, LA FILOLOGIA, E IL "CANTICO DEI CANTICI".11 febbraio 2020, di Federico La Sala
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! ... *
Cantico dei Cantici.
Il corpo delle donne (intimità della Bibbia)
di Luigino Bruni (Avvenire, martedì 11 febbraio 2020)
Sono tra coloro che sono rimasti delusi dalla performance di Roberto Benigni al Festival di Sanremo dedicata al biblico Cantico dei Cantici. Forse perché avevo aspettative alte, grazie al ricordo, vivissimo, delle sue meravigliose letture di Dante, della Costituzione italiana, dei Dieci comandamenti; forse perché Benigni ci ha donato film molto amati per la loro poesia e forza etica.
Ma, forse, in questa delusione c’è anche qualcosa di più. Il corpo delle donne, insieme a quello dei bambini, è il primo bene che una civiltà deve tutelare e proteggere con tutte le sue forze. Quando un uomo, un maschio, parla del corpo della donna, prima deve togliersi i calzari dai piedi perché sta entrando in un territorio sacro, una terra fatta sacra da molto amore e da moltissimo dolore. Da sempre il corpo della donna, prima di essere icona dell’amore, è stato immagine di potere, di violenza, di abusi e di soprusi, di corpo ferito e di eros comprato dai maschi.
 Non si può parlare del corpo delle donne senza avere ben in mente i molti millenni di storia umana in cui le donne hanno vissuto il proprio corpo come luogo da custodire e da preservare dall’uso cattivo dei maschi, un uso sbagliato che ancora troppo spesso è presente e non solo storia.
Non si può parlare del corpo delle donne senza avere ben in mente i molti millenni di storia umana in cui le donne hanno vissuto il proprio corpo come luogo da custodire e da preservare dall’uso cattivo dei maschi, un uso sbagliato che ancora troppo spesso è presente e non solo storia.Ho guardato Benigni insieme a mia mamma e mia sorella. Due donne moderne, laiche, riconciliate con la vita e con i corpi loro, dei figli e dei mariti. Non hanno detto una parola durante lo spettacolo, ma l’aria di casa si è riempita di un pudore mescolato con l’imbarazzo e il disagio.
 Accanto a loro, io ho avuto forte l’impressione di vedere sullo schermo una donna denudata in pubblico da Benigni, senza che lei avesse dato il suo consenso, denudata ai soli fini dello show. Ho visto quella giovane donna medio-orientale, vissuta due millenni e mezzo fa, e in lei ho rivisto le bellissime ragazze delle Mezzaluna fertile (il Cantico mette insieme antichi poemi nuziali babilonesi e cananei).
Accanto a loro, io ho avuto forte l’impressione di vedere sullo schermo una donna denudata in pubblico da Benigni, senza che lei avesse dato il suo consenso, denudata ai soli fini dello show. Ho visto quella giovane donna medio-orientale, vissuta due millenni e mezzo fa, e in lei ho rivisto le bellissime ragazze delle Mezzaluna fertile (il Cantico mette insieme antichi poemi nuziali babilonesi e cananei).Una ragazza ’bruna’ in un mondo di maschi, in una cultura patriarcale che vedeva poco e male le donne, nascoste sotto la tenda, a occuparsi per tutta la vita di bambini e anziani. Quando nella Bibbia si incrocia una donna non è mai un incontro banale. Quelle donne hanno in genere lottato e sofferto molto per entrare in quel racconto, hanno dovuto farsi spazio in una cultura che non glielo dava spontaneamente.
Donne che vivevano poco e male, quasi tutte analfabete, e non di rado morivano per gravidanze non sempre volute e desiderate. Quale eros conosceva quella ragazza del Cantico? Non certamente quello delle fantasie di noi maschi del XXI secolo, né quello che ci ha raccontato Benigni.
 Il Cantico è testo profetico, perché dice ai maschi e alle donne del suo tempo quale fosse il disegno di Dio sulla donna e sull’amore. Non era la descrizione dell’eros che quegli antichi scrittori vedevano attorno a loro, ma l’eros di un mondo futuro sempre desiderato e mai raggiunto.
Il Cantico è testo profetico, perché dice ai maschi e alle donne del suo tempo quale fosse il disegno di Dio sulla donna e sull’amore. Non era la descrizione dell’eros che quegli antichi scrittori vedevano attorno a loro, ma l’eros di un mondo futuro sempre desiderato e mai raggiunto.
 Non dobbiamo infatti dimenticare che il Cantico è un intreccio di presenza e di assenza dell’amato. È anche un canto all’amore non trovato, che fugge, che non si trova:
Non dobbiamo infatti dimenticare che il Cantico è un intreccio di presenza e di assenza dell’amato. È anche un canto all’amore non trovato, che fugge, che non si trova:«Lungo la notte, ho cercato l’amore dell’anima mia; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze; voglio cercare l’amore dell’anima mia. L’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: ’Avete visto l’amore dell’anima mia?’» (Cantico 3,1-3).
Senza questa dimensione di mancanza, di assenza, di limite, non si comprende l’eros che diventa solo gioco o sterile ricerca di piacere. L’eros è insieme pienezza e indigenza, ferita e benedizione. Ferita per tutti, uomini e donne, ma diversamente e di più per le donne (ferita, cioè vulnus).
Non credo che il Cantico sia stato scritto da una donna, e non lo credo per molte ragioni. Ma soprattutto non lo credo perché una donna non avrebbe parlato del proprio corpo e di quello del suo uomo con quelle parole. Le donne hanno altre parole per parlare dell’amore, dell’eros, della philia e dell’agape. Perché dell’eros le donne amano parlare solo due alla volta, nell’intimità di un rapporto d’amore, dove le parole non dette e quelle sussurrate sono importanti almeno quanto il corpo donato, e quando mancano queste poche parole diverse il corpo parla poco e male.
L’unico numero buono dell’eros è il due. E quando dell’eros si parla troppo e si parla in pubblico l’eros diventa altro, ed è bene usare altre parole molto meno nobili. La Bibbia ha da sempre letto quell’antico canto nuziale in modo sapienziale, allegorico e profetico, non per negare l’eros ma per salvarlo, perché l’unico modo per salvare l’eros è custodirlo nella sua intimità e nel suo nascondimento. E quando il Cantico viene letto senza ideologie e manipolazioni, non si fa una esperienza erotica, ma si fa una esperienza spirituale, mistica e soprattutto poetica:
«Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!» (2,10-13).
La poesia è stata infatti la grande assente dalla lettura di Benigni, una poesia mangiata dalla bramosia, molto infantile, di stupire gli spettatori con quell’eros ’nascosto’ dai preti e rabbini finalmente scoperto e liberato. Tutti i giorni i media usano i corpi delle donne per fare spettacolo, per vendere, per fare audience. E ogni giorno di più. La Bibbia non lo ha mai fatto. Parla poco di eros e di sesso, perché ne rispetta il mistero e l’intimità. La Bibbia va portata in tv, va portata ovunque, perché parla solo e sempre di vita. Ma se proviamo a manipolarla si chiude e non ci fa accedere al suo mistero e alla sua bellezza. Come, nonostante le probabili buone intenzioni, è accaduto l’altra sera sul palco di Sanremo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6). Un omaggio a William Shakespeare e a Giovanni Garbini.
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua" ...
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FESTIVAL DI SAN REMO. L’idea di far conoscere e gustare il Cantico è stata davvero stupenda, appropriata, preziosa (di Rosanna Rosanna Virgili).8 febbraio 2020, di Federico La Sala
«Canzonissima della Bibbia».
Il sorprendente dono del Cantico dei Cantici a Sanremo
di Rosanna Virgili (Avvenire, sabato 8 febbraio 2020)
Che gioia il Cantico dei Cantici a Sanremo! Grazie a Roberto Benigni che ha sorpreso e stupito il Festival con quel libretto della Bibbia che la tradizione ebraica e cristiana ha conservato come la canzone più bella, la ’canzonissima’ secondo una suggestione di Gianluigi Prato. Tre sono i trascendentali: verum, bonum e pulchrum. Importante è il bello. L’arte, nelle sue forme più nobili - quali la musica, la pittura, la poesia - è capace di far emergere il divino che si annida nella Parola, più di ogni altro linguaggio.
E allora l’idea di far conoscere e gustare il Cantico è stata davvero stupenda, appropriata, preziosa per un pubblico tanto vasto e popolare come quello del Sanremo in mondovisione (e non può inficiarla neppure la forzata ’licenza interpretativa’ che ha tradotto, tradendolo, l’amore tra amato e amata in altri amori che sono lontani e fuori dal limpido orizzonte biblico).
Del resto i duetti del Cantico, intervallati dalle voci del coro, assomigliano ai testi delle canzoni in gara e anch’essi nascono in un ambiente popolare; quadretti di vita rurale che hanno il sapore delle sere d’estate o del primo autunno quando, dopo la mietitura o la vendemmia, a notte, si faceva festa e gli occhi e le braccia dei ragazzi e delle ragazze si incrociavano, si intrecciavano, si inebriavano al sogno dei baci. Nel Cantico - scrive Guido Ceronetti - non c’è il nome di Dio, perché tutto è puro, quindi tutto è sacro! La forza dell’amore sveglia la primavera sui passi dell’amante che - inverosimilmente - è una donna. È lei a uscire per prima verso chi ancora non ha mai visto, ma è solcato nel suo desiderio profondo, nelle sue cavità vitali. Trasgressiva, testarda è la ’sorella’ del Cantico, si sottrae all’autorità dei fratelli, non cura la sua vigna ma corre verso le ’tende dei pastori’, esce nei deserti, batte la campagna, sfida le guardie alle mura della città, ’malata d’amore’! Una vera anomalia per un mondo in cui le donne non potevano scegliere i loro uomini ma venivano date in spose a scopo di procurare ai mariti una discendenza. Non avevano diritto sul proprio corpo, ma la donna del Cantico lo rapisce e ne fa guida e grammatica del viaggio dell’Amore. C’è un esodo dal sé, un’effrazione del self, per osare gli ignoti sentieri, le rischiose curve, gli anfratti del volto dell’Altro.
L’Amore è un’avventura senza garanzie, una strada senza ritorno, ’forte più della morte’. Irreversibile, fonte di creature nuove, diverse, bagnate di futuro. Amore che azzera i possessivi: ’io sono sua, mentre lui è mio’: l’estasi di un’unione che non risponde alla tentazione di divorare l’altro, rendendolo un cadavere.
Ma è pienezza di ’te’: del consegnarmi a te. Bocca d’infinito, sorso d’eternità, graffio di Vita! Nel testo originario le sue consonanti asciutte, nette, impossibili a essere fraintese. I sensi sono sentinelle e finestre del corpo, teso fuori di sé. ’Una voce, il mio amato’: il primo senso è casto come l’udito. ’Come sei bella, amica mia, come sei bella, le tue labbra una striscia di porpora’. Gli occhi di lui scoprono l’incanto della pelle di lei ’color del miele’, traduce magnificamente Luca Mazzinghi. Il tuo profumo è la quintessenzadi ogni aroma delle piante più squisite d’Oriente; ’c’è latte e miele sotto la tua lingua’; l’olfatto e il gusto si alleano nell’estasi d’Amore dove il tuo nardo è ben più forte di ogni vino drogato. Restituiscono al corpo la sua anima. Un minuto solo dura il tatto ma procura un vero svenimento; com’era per i Greci così nel Cantico, l’Amore è lelymmenos ’scioglitore di membra’. Per fare ’dei due un corpo solo’ direbbe l’Apostolo Paolo.
L’Amore è attesa, fatica, sudore di brama e di timore; esso regala attimi di estasi e anni di deserto, però quegli attimi valgono bene gli anni! L’Amore è corpo nudo, vuoto, puro, come il Santo dei Santi. Per questo il Cantico è il libro dei mistici, Paese sospeso. Dio come in un passaggio, la meghillà di Pasqua. Nel corpo che si perde è il profumo di Dio. Per questo è un gran peccato che la Chiesa abbia impedito per secoli l’accesso a questo piccolo libro, grandissimo tesoro, fonte di salute e salvezza per il corpo e per l’anima. Teniamo sveglio il cuore ora che ’il tempo del canto è tornato’.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- «Genere e Capitale»: Silvia Federici, quello che Marx non ha visto (di Paola Rudan).1 febbraio 2020, di Federico La Sala
Silvia Federici, quello che Marx non ha visto
L’intervista . Parla l’accademica e femminista italiana che vive negli Stati Uniti. Autrice del fortunato «Calibano e la strega», il suo «Genere e Capitale» è di imminente pubblicazione per DeriveApprodi. «Il "Moro" ci dice che il capitalismo gronda sangue, ma porta nel mondo una più alta razionalità. Perciò non pensa la riproduzione, un’attività irriducibile alle macchine»
di Paola Rudan (il manifesto, 30.01.2020)
In occasione dell’imminente uscita di Genere e Capitale. Per una rilettura femminista di Marx (con la casa editrice DeriveApprodi), abbiamo raggiunto l’autrice Silvia Federici per un’intervista. A risaltare è il rapporto conflittuale dell’autrice con il pensiero di Marx, considerato tanto fondamentale per la critica del capitalismo quanto insufficiente a coglierne il carattere distruttivo. Centrale è per Federici la necessità di fare i conti con la complessità delle lotte che contestano il dominio del capitale e di cui le donne - indigene, migranti, proletarie - sono oggi protagoniste in ogni parte del mondo.
Che cosa motiva questo ripensamento di Marx, che oggi sembra più aspro e polemico che in passato?
Una motivazione più immediata è relativa alla necessità di rispondere all’ondata di celebrazioni che si sono fatte in occasione dell’anniversario della pubblicazione del Capitale e poi della nascita di Marx. Bisogna celebrare, ma anche domandarsi dove è necessario andare oltre.
 La seconda motivazione è più profonda: mentre negli anni Settanta la critica a Marx si concentrava sul fatto che non ha visto tutta l’area della riproduzione, quindi il lavoro delle donne, con il passare del tempo ho compreso che questa sottovalutazione è collegata anche a un limite più profondo del suo pensiero, la sopravvalutazione del capitalismo in una visione storica progressista. Marx ci dice che il capitalismo gronda sangue sporco, ma porta nel mondo una razionalità più alta.
La seconda motivazione è più profonda: mentre negli anni Settanta la critica a Marx si concentrava sul fatto che non ha visto tutta l’area della riproduzione, quindi il lavoro delle donne, con il passare del tempo ho compreso che questa sottovalutazione è collegata anche a un limite più profondo del suo pensiero, la sopravvalutazione del capitalismo in una visione storica progressista. Marx ci dice che il capitalismo gronda sangue sporco, ma porta nel mondo una razionalità più alta.
 Questo è forse il peccato originale a causa del quale Marx non pensa la riproduzione, perché è un’attività irriducibile alla meccanizzazione, all’industrializzazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro domestico, l’allevamento dei bambini, la sessualità, l’aspetto emotivo. Il confronto allora non è più aspro, ma più profondo. A motivare questo tipo di critica, infine, è la distruzione ambientale causata dalla tecnologia e specialmente dal digitale. Se guardo a quello che succede in Congo, o in Niger, vedo la distruzione e i massacri che si stanno verificando in gran parte dell’Africa e sono dovuti a espropriazioni massicce e brutali funzionali alle compagnie minerarie e petrolifere.
Questo è forse il peccato originale a causa del quale Marx non pensa la riproduzione, perché è un’attività irriducibile alla meccanizzazione, all’industrializzazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro domestico, l’allevamento dei bambini, la sessualità, l’aspetto emotivo. Il confronto allora non è più aspro, ma più profondo. A motivare questo tipo di critica, infine, è la distruzione ambientale causata dalla tecnologia e specialmente dal digitale. Se guardo a quello che succede in Congo, o in Niger, vedo la distruzione e i massacri che si stanno verificando in gran parte dell’Africa e sono dovuti a espropriazioni massicce e brutali funzionali alle compagnie minerarie e petrolifere.
 Sono stata sempre polemica con l’idea che la lotta più efficace contro il capitalismo si dà ai livelli più alti dello sviluppo tecnologico, e anche con gli accelerazionisti. Che cosa acceleriamo? I massacri, lo spossessamento delle terre? Sviluppo oggi vuol dire violenza, ma in mille luoghi si sta combattendo contro lo sviluppo capitalistico. Se oggi Marx guardasse queste lotte le considererebbe arretrate?
Sono stata sempre polemica con l’idea che la lotta più efficace contro il capitalismo si dà ai livelli più alti dello sviluppo tecnologico, e anche con gli accelerazionisti. Che cosa acceleriamo? I massacri, lo spossessamento delle terre? Sviluppo oggi vuol dire violenza, ma in mille luoghi si sta combattendo contro lo sviluppo capitalistico. Se oggi Marx guardasse queste lotte le considererebbe arretrate?Lei non pensa al salario solo come retribuzione del lavoro, ma come rapporto sociale di dominio, che coinvolge anche chi non svolge un lavoro salariato, come le casalinghe. Parlando delle esperienze contemporanee di organizzazione autonoma comunitaria sembra però che valorizzi politicamente proprio il carattere non retribuito del lavoro che si svolge al loro interno, come una sorta di esteriorità al capitale.
Costruisco i miei discorsi a partire dalle esperienze di lotta. Il discorso sul salario per il lavoro domestico nasceva in un contesto nel quale esistevano grandi movimenti di donne, soprattutto nere, che già parlavano di lavoro domestico in altri termini. Adesso, guardando a queste esperienze della post-globalizzazione, di milioni di persone che sono state dislocate dalle loro terre, che non sono state integrate nel lavoro salariato ma stanno costruendo qualcosa, allora il discorso si è articolato di più. I due obiettivi fondamentali rimangono il rifiuto del lavoro non pagato e il recupero della ricchezza sociale, che comunque vedo anche in esperimenti comunitari come le villas miserias argentine. C’è un momento di riappropriazione della ricchezza non solo per i terreni occupati, ma anche perché si crea un tessuto sociale più solidale che ti permette di affrontare lo Stato in modo da ottenere dei beni materiali. Questa non è un’alternativa al discorso del salario, ma è una maggiore articolazione.
In quest’enfasi sulle esperienze comunitarie non c’è il rischio di un’identificazione delle donne con il lavoro riproduttivo?
È un discorso complicato. Noi femministe degli anni Settanta siamo state le prime a contestare il discorso identitario, abbiamo detto che la femminilità è una cosa costruita e da sempre la mia posizione fondamentale è che non c’è un significato universale dell’essere donne. Che cosa vuol dire essere donne è sempre diverso ed è una lotta continua per stabilire chi sei, chi non sei, che cosa vogliamo essere. Detto questo, rimane anche vero - ed è qui che si possono generare degli equivoci - che guardando all’esperienza che moltissime donne hanno vissuto in America Latina, per esempio, risulta che siccome sono loro che per prime hanno a che fare con i bambini, con le malattie, con il fare da mangiare, sono anche quelle in prima linea contro i progetti estrattivi.
 Le loro però sono esperienze storiche che si collegano all’appropriazione, all’agricoltura, alle sementi, che non riguardano la natura ma la conoscenza. Ci sono conoscenze profonde di che cosa c’è nell’acqua, nella terra, nelle piante, del rapporto con gli animali. Ascoltare queste storie, vedere queste esperienze è quello che alla mia età, dopo aver visto tanto, mi dà coraggio, mi dà forza.
Le loro però sono esperienze storiche che si collegano all’appropriazione, all’agricoltura, alle sementi, che non riguardano la natura ma la conoscenza. Ci sono conoscenze profonde di che cosa c’è nell’acqua, nella terra, nelle piante, del rapporto con gli animali. Ascoltare queste storie, vedere queste esperienze è quello che alla mia età, dopo aver visto tanto, mi dà coraggio, mi dà forza.L’altro problema sul quale insiste è quello del razzismo. Fenomeno che si riconfigura in un contesto globale segnato da movimenti di donne e uomini senza precedenti, e contemporaneamente ridefinisce il lavoro domestico e riproduttivo rispetto al passato.
Per me la lotta delle lavoratrici domestiche migranti è uno dei movimenti di donne più importante di questi anni. Porta in sé tutte le rivendicazioni che riguardano sia il discorso sulla riproduzione e la valorizzazione - loro dicono «senza di noi niente si muove» - sia quello della colonialità e del razzismo. Con questo il movimento femminista non si è ancora rapportato in modo reale e decisivo. Per migrare devi sfondare mille porte, devi avere una comprensione dei rapporti internazionali, delle polizie, delle leggi, delle norme sul lavoro, è quindi un movimento molto ricco di conoscenze e di capacità di rottura.
Nel suo lavoro ha sottolineato come oppressione sessuale e razzismo non siano fattori solo culturali. Perciò si concentra sul lavoro delle donne. Oggi i movimenti delle donne stanno contestando in altro modo la distinzione tra il «culturale» e il «materiale», perché considerano la violenza maschile costitutiva dei rapporti sociali.
È vero anche il fatto che le condizioni materiali generano la violenza. L’indebitamento nella famiglia accresce l’intensità della violenza. L’organizzazione del lavoro negli Stati Uniti genera violenza. È difficilissimo sfuggire alle molestie di chi controlla il posto di lavoro. Le cameriere nei ristoranti devono «vendere il corpo» per ottenere mance perché nella maggior parte dei posti di lavoro non ti danno un salario ma vivi di mance. La mancia ti obbliga a mostrare il décolleté, a sporgere i seni, soprattutto alla fine del mese. Cameriere e proletarie dicono che le attrici che hanno animato il movimento #metoo sono privilegiate. Devono combattere con quelli che le toccano, ma da loro dipende la mancia.
Qual è la sua riflessione sul movimento femminista globale che è cresciuto e si è consolidato negli ultimi anni?
Il tema della violenza ha subito una grande trasformazione, agli inizi si è concentrato sulla violenza domestica, ma ora è messa al centro anche la sua dimensione pubblica. L’iniziativa delle donne di Las Tesis in Cile, che dicono allo Stato «lo stupratore sei tu» è il simbolo di questo cambiamento che riconosce la violenza non solo nelle case ma anche quella istituzionale ed economica. Quando si svalorizza una moneta e da un giorno all’altro migliaia di persone non hanno più niente, o si chiude un’azienda e la gente è sul lastrico, o aumentano gli affitti e la gente dorme in strada, questa è violenza. Oggi il movimento vede come violenza lo stupro, il femminicidio, ma anche l’esproprio dalle terre, l’imposizione della miniera, la gentrificazione che ti costringe a vivere per strada, e ormai capisce che è un rapporto che si dà in forme diverse ma a livello globale. È un momento molto importante, per cui se abbiamo i Bolsonaro e i Trump, abbiamo anche una risposta. Anzi, forse i Trump e i Bolsonaro sono loro la risposta: vedo anche la fascistizzazione come una risposta a un forte movimento dal basso. Si rendono conto che il movimento delle donne sta trainando le lotte. Questo è un momento terribile ma c’è anche una grossa agitazione dal basso. Credo che oggi la gran parte del mondo sappia che il capitalismo è un sistema distruttivo, orrendo. Il problema è come organizzarsi.
La versione integrale di questa intervista è pubblicata su connessioniprecarie.org
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS: CHARITAS.19 gennaio 2020, di Federico La Sala
FILOSOFIA E FILOLOGIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS: CHARITAS....
- LA CARITÀ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia), NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!) *
Tesi di Laurea
IL PRINCIPIO DI CARITÀ [2016]
Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica
a cura di Francesco Gandellini **
- La tesi si preoccupa di analizzare l’origine e il decorso storico del principio di carità o benevolenza, con particolare riferimento alla linea etico-ermeneutica e alla linea logico-ontologica, al fine di metterne in luce gli aspetti significativi che lo identificano e ne caratterizzano l’uso nella storia della filosofia.
SOMMARIO Introduzione .................................................................................................................
 1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
 1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
 1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
 1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
 1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
 1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
 1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
 Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
 2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
 α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
 β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
 2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
 2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
 Conclusione .............................................................................................................. 157
Conclusione .............................................................................................................. 157
 Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163
Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163***
INTRODUZIONE
Il termine “carità” deriva etimologicamente dal latino caritas (acc. caritatem, «benevolenza», «amore», questo da carus, «caro», «costoso», «diletto», «amato»), e a sua volta dal greco χάρις, «grazia». Dal punto di vista dell’etimo, la parola cattura l’idea dell’amore disinteressato ma prezioso verso qualcuno, della benevolenza gratuitamente concessa al destinatario, senza riserve rispetto alla sua condizione.
 Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
 Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
 Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
 La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
 È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
 Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
 Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
 Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.
Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.1 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, il Saggiatore 2008, pag. 35
** UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 Dipartimento Lettere e Filosofia
Dipartimento Lettere e Filosofia
 Corso di Laurea in FILOSOFIA.
Corso di Laurea in FILOSOFIA.
 Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco,
 Laureando: GANDELLINI Francesco.
Laureando: GANDELLINI Francesco.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA QUESTIONE DELLA "H"....SCIENZA E FILOSOFIA. "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia" (di Antonio Rainone)
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "Invariances: The Structure of the Objective World" (R. Nozick). Una metafisica per individui (di R. Casati).8 gennaio 2020, di Federico La Sala
Una metafisica per individui
di Roberto Casati (Il Sole-24 Ore, 19.02.2006)
Nella comunità intellettuale (considerata in senso ampio a includere chi si dedichi a una riflessione esplicita sui fondamenti concettuali e metodologici del proprio lavoro) non c’è un accordo sull’esistenza di fatti oggettivi. Il problema non riguarda soltanto una questione di conoscenza, ovvero del modo in cui potremmo accertarci di un fatto, e neppure riguarda soltanto discipline in cui sembra difficile convergere su ciò che conta come un fatto - come la teoria della letteratura (Manzoni voleva veramente esprimere una concezione del mondo giansenista?), della storia (che cosa ha determinato l’assassinio di Kennedy) o della giurisprudenza (Oswald ha agito davvero senza complici?)
È la nozione stessa di fatto oggettivo, di oggettività, a essere considerata discutibile (e a venire discussa). Le intenzioni degli autori o le cause degli omicidi sono davvero entità oggettive? Certo la discussione soffre di una certa vaghezza dei termini utilizzati. Il termine di contrasto principale è naturalmente con «soggettivo»; ma anche precisando il contrasto oggettivo/soggettivo, sostenere che non esistono fatti oggettivi può significare diverse cose. Per esempio, può significare che tutto è soggettivo nel senso che non ci sarebbero fatti se non ci fossero soggetti in grado di percepire o di pensare a tali fatti, o che c’è una componente soggettiva in ogni asserzione che facciamo sul mondo, o che la rappresentazione della realtà viene filtrata e distorta dai nostri sistemi cognitivi, o che ogni conoscenza inevitabilmente è un’azione, un intervento che modifica la cosa conosciuta, e via dicendo. La nozione di oggettività in gioco in questi diversi casi sarà di volta in volta differente.
Il filosofo Robert Nozick è noto al pubblico italiano per un grande libro di filosofia della politica, Anarchia, Stato e Utopia; e per un testo di filosofia più generale, Spiegazioni Filosofiche. L’ultimo lavoro pubblicato da Nozick prima della morte (avvenuta il 23 gennaio del 2002) è Invariances: The Structure of the Objective World (Harvard University Press, 2001, pp. 416, $ 24.50). Si tratta di un libro molto ambizioso, una summa metafisica che studia filosoficamente la nozione di oggettività alla luce delle trasformazioni della scienza. (Il capitolo introduttivo sul metodo filosofico è online sul sito di Harvard University Press)
Nozick distingue tre possibili ingredienti del modo di considerare l’oggettività. In primo luogo, quello appena menzionato dell’indipendenza dalla soggettività, da opinioni, speranze, misure soggettive. In secondo luogo, l’accesso multiplo: un fatto è oggettivo se vi si può accedere da prospettive differenti - attraverso sensi differenti, da punti di vista differenti, in momenti diversi (per esempio, vedo e sento la conversazione di Marco e Maria, o la vedo oggi e la rivedo in un film girato da un amico domani; o ancora, posso replicare un esperimento in momenti diversi). Infine, l’intersoggettività: un fatto è oggettivo se è possibile che soggetti diversi abbiano un accordo su di esso. Se sia io che voi contiamo i sassi in un mucchio e giungiamo al numero cinque, avremo ragione di pensare che è un fatto oggettivo che ci siano cinque sassi nel mucchio.
Accesso multiplo, intersoggettività e indipendenza sono elementi necessari, presi singolarmente, e sufficienti solo se presi nel loro complesso. Ma Nozick suggerisce che al di sotto di essi un quarto elemento, più profondo, permette di spiegare perché la nozione di oggettività includa proprio gli altri tre. L’elemento più profondo è l’idea di invarianza attraverso trasformazioni.
 Nozick riconosce un debito non solo linguistico ma anche concettuale nei confronti della matematica, della fisica e di altre discipline scientifiche. Il Programma di Erlangen (1872) di Felix Klein (1849-1925) era volto a unificare i diversi tipi di geometria con lo studio dell’invarianza all’interno dei gruppi di trasformazioni ammissibili per le entità geometriche. Per esempio, le rotazioni e le traslazioni nello spazio lasciano invarianti le proprietà metriche delle figure; la proiezione di una figura su un piano che è ad essa parallelo non lascia invarianti le proprietà metriche ma preserva gli angoli. In psicologia la nozione di invarianza viene associata al lavoro di J.J. Gibson (1904-1979), che riteneva che i sistemi percettivi abbiano come funzione l’“estrazione” di elementi invarianti nell’ambiente (un approccio per questa ragione detto “ecologico”). Non ci sembra che una sedia cambi di forma mentre le giriamo intorno: siamo per così dire “sintonizzati” sulla forma invariante della sedia, anche se l’immagine che ne abbiamo a ogni istante muta continuamente. La psicologia della percezione generalizza la nozione, a volte chiamata “costanza”; quello che vale per la forma della sedia vale anche per il suo colore: non ci sembra che la sedia cambi colore in diversi momenti del giorno.
Nozick riconosce un debito non solo linguistico ma anche concettuale nei confronti della matematica, della fisica e di altre discipline scientifiche. Il Programma di Erlangen (1872) di Felix Klein (1849-1925) era volto a unificare i diversi tipi di geometria con lo studio dell’invarianza all’interno dei gruppi di trasformazioni ammissibili per le entità geometriche. Per esempio, le rotazioni e le traslazioni nello spazio lasciano invarianti le proprietà metriche delle figure; la proiezione di una figura su un piano che è ad essa parallelo non lascia invarianti le proprietà metriche ma preserva gli angoli. In psicologia la nozione di invarianza viene associata al lavoro di J.J. Gibson (1904-1979), che riteneva che i sistemi percettivi abbiano come funzione l’“estrazione” di elementi invarianti nell’ambiente (un approccio per questa ragione detto “ecologico”). Non ci sembra che una sedia cambi di forma mentre le giriamo intorno: siamo per così dire “sintonizzati” sulla forma invariante della sedia, anche se l’immagine che ne abbiamo a ogni istante muta continuamente. La psicologia della percezione generalizza la nozione, a volte chiamata “costanza”; quello che vale per la forma della sedia vale anche per il suo colore: non ci sembra che la sedia cambi colore in diversi momenti del giorno.Alcune proprietà vengono conservate attraverso tutte le trasformazioni, altre resistono solo ad alcune trasformazioni. Questo inserisce un ordine di profondità tra le proprietà: le invarianze sono graduate. In geometria le proprietà topologiche sono più profonde di quelle metriche: bisogna alterare in profondità una figura per farle perdere la struttura topologica.
Nozick suggerisce per analogia che una differenza di profondità possa applicarsi alla nozione di oggettività. Ci sono proprietà che resistono a più trasformazioni di altre, e le prime saranno più oggettive delle seconde. La conoscenza di un oggetto si fonda sulla comprensione dell’interazione tra invarianza e la variazione: «Per comprendere qualcosa, non vogliamo soltanto conoscere le trasformazioni sotto le quali è invariante, ma anche quelle sotto le quali varia» (p. 78).
Il lavoro di Nozick tende a mostrare che i problemi metafisici non sono indipendenti dal contesto scientifico che li suscita. La nozione metafisica di oggettività che Nozick suggerisce di adottare non deriva da un’analisi filosofica apriori, ed è tributaria di nozioni che derivano dalle scienze. La metafisica progredisce, e può farlo anche perché la scienza pone problemi inediti ai filosofi e offre a volte strumenti per metterli a fuoco.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
KANT E SAN PAOLO. -- CARITÀ O EMPATIA?!: LA LEZIONE DI QUINE E DI NOZICK: "CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO" (di Antonio Rainone).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL PARADOSSO DELLA RIPETIZIONE "ORIGINALE" E MODI E "MOTI DI IMITAZIONE".8 gennaio 2020, di Federico La Sala
L’IMITAZIONE, L’EMULAZIONE, E IL PARADOSSO DELLA RIPETIZIONE “ORIGINALE” ... *
- UNA NOTA a “Mimetica. L’imitazione in Teoria” di U. Fracassa ("Le parole e le cose", 06.01.2020)
“La mimesi è l’atto di riprodurre il modello secondo le regole. L’emulazione è la spinta dell’anima mossa all’ammirazione” (Dionigi di Alicarnasso, “Sull’imitazione”).
IMITAZIONE E INDIVIDUAZIONE. “Se in campo filosofico il peccato originale dell’imitazione è consistito nella minaccia portata all’idolo del libero arbitrio ovvero all’ego del cogito cartesiano, altrettanto sacrilego risultò in ambito psicoanalitico l’attentato ai fondamenti pulsionali della psiche. Nel pensiero freudiano l’imitazione era confinata alla fase infantile o altrimenti alla psicologia delle masse, mentre nella psicologia analitica di Carl Gustav Jung tale facoltà si trovava a contrastare il fine ultimo di ogni esistenza umana, ovvero l’individuazione: “L’uomo ha una facoltà che per gli intenti collettivi è utilissima, e dannosissima per l’individuazione, quella di imitare”. Nella dichiarazione di Jung risulta comunque superata una concezione volta a relegare l’imitazione ai primi stadi dello sviluppo psichico e, ad onore del vero, lo stesso Freud aveva intuito già nel 1895, in Progetto di una psicologia, il valore imitativo delle percezioni sensoriali sussistere ben oltre l’infanzia. A questa intuizione ancorava le proprie ricerche, a metà degli anni Sessanta, il già citato Eugenio Gaddini grazie al quale è stato infine possibile riconoscere nell’imitazione una struttura permanente, una forma relazionale stabile [..]”.
BIOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Le radici stanno nel fatto - come scrive Aristotele nella “Poetica”, capitolo secondo - che “coloro che imitano imitano persone che agiscono” e - come “Vittorio Gallese, membro del team parmense cui si deve la scoperta dei neuroni specchio, ha avuto modo di ribadire” - che “il meccanismo funzionale alla base di un modello dell’intersoggettività neuroscientificamente fondato consiste nella “simulazione incarnata” (embodied simulation): “Prima e al di sotto della lettura metarappresentazionale della mente si trova l’intercorporeità - la mutua risonanza di comportamenti sensoriali e motori significativi dal punto di vista intenzionale”.
“COME NASCONO I BAMBINI”. SE è VERO, COME è VERO CHE “Al di là delle formidabili oscillazioni del concetto di imitazione e delle sue varianti terminologiche nel corso di secoli di elaborazione dapprima filosofica, poi specificamente estetica e infine teorico letteraria, le teorie della mimesi paiono dispiegare, oltre ad una coerenza non sempre evidente ma di lungo periodo, una spiccata propensione ad oltrepassare i confini disciplinari”, PER NON PERDERSI NEL LABIRINTO delle infinite ramificazioni è bene riprendere il filo delle varie teorie dalla stessa dimensione biologica e antropologica della vita umano-sociale: la NASCITA!
* Sul tema, mi sia consentito, si cfr.:
QUESTIONE ANTROPOLOGICA. E’ lecito e ancora possibile affermare una verità universale sul genere umano? “J’accuse” di René Girard. L’incomprensione della lezione di Freud (Marx e Nietzsche) lo spinge ad un’apologia del cattolicesimo costantiniano
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica.
“CHI” SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A “UNA” DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- AL DI LÀ DELL’ORIZZONTE DELLA IMMAGINAZIONE "COSMOTEANDRICA" IMPERIALE.4 gennaio 2020, di Federico La Sala
"ECCE HOMO": (ANTROPOLOGIA, NON "ANDROPOLOGIA" O "GINECO-LOGIA")!!! USCIRE DALL’ORIZZONTE COSMOTEANDRICO DA "SACRO ROMANO IMPERO"... *
- Dio creò l’uomo ("homo") ... e lo fece maschio ["masculum"] e femmina [" foeminam "] (Genesi, I.27).
- “Chi tene ‘a lingua, va ’n Sardegna" (antico proverbio campano)
La parola può tutto
di Ivano Dionigi (Avvenire, venerdì 3 gennaio 2020)
«Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua». In questa sentenza fulminante di don Lorenzo Milani (Lettera a Ettore Bernabei 1956), ispirata a un deciso afflato di giustizia sociale, trovo il più bel commento al passo in cui Aristotele (Politica 1253 a) riconosce nella parola (logos) la marca che caratterizza l’uomo e lo distingue dagli animali, che ne sono privi (tà zóa á-loga). La parola: il bene più prezioso, la qualità più nobile, il sigillo più intimo. A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti: ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un’occupazione si rimedia, una ferita affettiva si rimargina, ma la mancanza o l’uso ridotto della parola nega l’identità, esclude dalla comunità, confina alla solitudine e quindi riduce allo stato animale. «La parola - continuava il profetico prete di Barbiana - è la chiave fatata che apre ogni porta»; tutto può, come già insegnava la saggezza classica: «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione» (Gorgia, Elogio di Elena 8). Ma essa è di duplice segno, nella vita privata come in quella pubblica: con i cittadini onesti e i governanti illuminati si fa simbolica (syn-bállein), e quindi unisce, consola, salva; confiscata dai cittadini corrotti e dai demagoghi si fa diabolica (dia-bállein), e quindi divide, affanna, uccide.
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua".
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
- OBIEZIONE DI COSCIENZA !!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", 10.11.2019).
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020).
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- TEOLOGIA E ANTROPOLOGIA. QUALE DIO: AMORE O "MAMMONA"? QUALE MADRE: "MARIA-EVA" O "MARIA-MARIA"?!2 gennaio 2020, di Federico La Sala
CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE COSMOTEANDRICA (cosmologia, teologia, e antropo-logia!). QUALE DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")? QUALE MADRE: "MARIA-EVA" O "MARIA-MARIA"?!....*
- "«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]" (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020)
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
SANTA MESSA NELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO
LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
CAPPELLA PAPALE
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica Vaticana
 Mercoledì, 1° gennaio 2020
Mercoledì, 1° gennaio 2020«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana!
Nel primo giorno dell’anno celebriamo queste nozze tra Dio e l’uomo, inaugurate nel grembo di una donna. In Dio ci sarà per sempre la nostra umanità e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. È donna e madre, questo è l’essenziale. Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque non c’è salvezza senza la donna. Lì Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa per la stessa strada: per Maria, donna e madre. Perciò iniziamo l’anno nel segno della Madonna, donna che ha tessuto l’umanità di Dio. Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna.
Nato da donna. La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato; è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore che ci ha salvati! Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri, che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il cuore vuoto di amore.
Nato da donna. Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al culmine della creazione, come il riassunto dell’intero creato. Ella, infatti, racchiude in sé il fine del creato stesso: la generazione e la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. È quello che fa la Madonna nel Vangelo oggi. «Maria - dice il testo - custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (v. 19). Custodiva tutto: la gioia per la nascita di Gesù e la tristezza per l’ospitalità negata a Betlemme; l’amore di Giuseppe e lo stupore dei pastori; le promesse e le incertezze per il futuro. Tutto prendeva a cuore e nel suo cuore tutto metteva a posto, anche le avversità. Perché nel suo cuore sistemava ogni cosa con amore e affidava tutto a Dio.
Nel Vangelo questa azione di Maria ritorna una seconda volta: al termine della vita nascosta di Gesù si dice infatti che «sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore» (v. 51). Questa ripetizione ci fa capire che custodire nel cuore non è un bel gesto che la Madonna faceva ogni tanto, ma la sua abitudine. È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. Solo chi guarda col cuore vede bene, perché sa “vedere dentro”: la persona al di là dei suoi sbagli, il fratello oltre le sue fragilità, la speranza nelle difficoltà; vede Dio in tutto.
Mentre cominciamo il nuovo anno chiediamoci: “So guardare col cuore? So guardare col cuore le persone? Mi sta a cuore la gente con cui vivo, o le distruggo con le chiacchiere? E soprattutto, ho al centro del cuore il Signore? O altri valori, altri interessi, la mia promozione, le ricchezze, il potere?”. Solo se la vita ci sta a cuore sapremo prendercene cura e superare l’indifferenza che ci avvolge. Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prenderci cura degli altri. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna è una conquista per l’umanità intera.
Nato da donna. Gesù, appena nato, si è specchiato negli occhi di una donna, nel volto di sua madre. Da lei ha ricevuto le prime carezze, con lei ha scambiato i primi sorrisi. Con lei ha inaugurato la rivoluzione della tenerezza. La Chiesa, guardando Gesù bambino, è chiamata a continuarla. Anch’ella, infatti, come Maria, è donna e madre, la Chiesa è donna e madre, e nella Madonna ritrova i suoi tratti distintivi. Vede lei, immacolata, e si sente chiamata a dire “no” al peccato e alla mondanità. Vede lei, feconda, e si sente chiamata ad annunciare il Signore, a generarlo nelle vite. Vede lei, madre, e si sente chiamata ad accogliere ogni uomo come un figlio.
Avvicinandosi a Maria la Chiesa si ritrova, ritrova il suo centro, ritrova la sua unità. Il nemico della natura umana, il diavolo, cerca invece di dividerla, mettendo in primo piano le differenze, le ideologie, i pensieri di parte e i partiti. Ma non capiamo la Chiesa se la guardiamo a partire dalle strutture, a partire dai programmi e dalle tendenze, dalle ideologie, dalle funzionalità: coglieremo qualcosa, ma non il cuore della Chiesa. Perché la Chiesa ha un cuore di madre. E noi figli invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a noi l’unità. Donna della salvezza, ti affidiamo quest’anno, custodiscilo nel tuo cuore. Ti acclamiamo: Santa Madre di Dio. Tutti insieme, per tre volte, acclamiamo la Signora, in piedi, la Madonna Santa Madre di Dio: [con l’assemblea] Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio!
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
- IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
Federico La Sala
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Cartoline da un decennio: guardare le cose da un altro punto di vista (di Ida Dominijanni).31 dicembre 2019, di Federico La Sala
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE..... *
Femminismo
Cartoline da un decennio
di Ida Dominijanni, giornalista (Internazionale, 31 dicembre 2019)
All’ingresso negli anni venti del secolo scorso furono le flapper, donne giovani, indipendenti e anticonformiste, a imprimere il segno della gioia di vivere su un decennio che si sarebbe poi colorato di tinte funeree. Finita la grande guerra che le aveva emancipate forzosamente mettendole al lavoro al posto degli uomini spediti al fronte, scorciarono le gonne, si tagliarono i capelli e decisero che era venuto il momento di invadere la città e di godersi la vita, a costo di scandalizzare tutti i benpensanti dell’occidente che con quel termine, flapper, le stigmatizzavano come ragazzine di troppo facili costumi. Cominciava così, fra il gioco e la necessità, quella mutazione della specie che avrebbe smantellato il monopolio maschile della felicità pubblica e che da allora in poi non si è mai arrestata, dilagando dall’occidente a tutte le latitudini del pianeta.
Un secolo dopo delle flapper non c’è più bisogno: le cattive ragazze sono dappertutto, con gli orli e i capelli corti o lunghi, con desideri espliciti e ambizioni autorizzate, anche se la specie non ha ancora fatto i conti con questa mutazione e non manca di resisterle. Eppure sono di nuovo le donne a dare il segno del mutamento e della felicità pubblica a un passaggio di decennio per lo più marcato dall’incertezza e da passioni tristi.
I decenni, si sa, sono come il bicchiere del proverbio: li si può vedere mezzi vuoti o mezzi pieni. Di quello che sta per chiudersi è più facile enumerare i vuoti che i pieni, i moti retrogradi che gli sprazzi di futuro, i capovolgimenti inattesi che le promesse mantenute. Anche stavolta, intanto, c’è stata una grande guerra, non militare ma economica, con il suo corredo di morti, feriti, azzoppati, declassati, impoveriti, illividiti; qui in Europa non ne siamo ancora fuori, tanto meno in Italia, ed è pressoché certo che qui le cose non torneranno mai più com’erano prima e altrove chissà, se alla crisi economica aggiungiamo quella ambientale che toglie il respiro anche a quelle parti della terra dove il motore della crescita gira vorticosamente.
- La crisi ci ha aperto gli occhi, trasformando la disillusione non sempre in rancore, paura e nostalgia ma anche in rivolta
C’è una crisi demografica, che precipita l’Europa in una vecchiaia senza ritorno a meno che non apra ai popoli che vengono dal sud quelle porte che oggi si ostina a tenere chiuse.
 C’è una crisi democratica, che capovolge in rancore l’illusione che la democrazia avrebbe messo tutto il mondo a regime e ne scombina tutti i piani, con capi impresentabili che spuntano ovunque e popoli gregari che ne inseguono false promesse e velleità di potenza. C’è una crisi tecnologica, anche qui con un rovesciamento del miraggio egualitario della rete nella presa d’atto dei suoi dispositivi gerarchici di sorveglianza, controllo, estrazione di lavoro e di valore.
C’è una crisi democratica, che capovolge in rancore l’illusione che la democrazia avrebbe messo tutto il mondo a regime e ne scombina tutti i piani, con capi impresentabili che spuntano ovunque e popoli gregari che ne inseguono false promesse e velleità di potenza. C’è una crisi tecnologica, anche qui con un rovesciamento del miraggio egualitario della rete nella presa d’atto dei suoi dispositivi gerarchici di sorveglianza, controllo, estrazione di lavoro e di valore.
 C’è una crisi, perfino, epistemologica, con l’appannarsi del confine fra vero e falso, informazione e fake news, lumi della ragione e buio delle credenze, che erode il nocciolo stesso dell’autodeterminazione e ci mette tutti nella condizione dell’angelo di Benjamin, con il futuro alle spalle e il progresso ridotto a una montagna di macerie. E potremmo chiuderla qui, con l’immagine di un decennio avvolto nella parola “crisi” variamente declinata ma riassumibile sotto il nome di crisi del neoliberalismo, e senza che se ne vedano le soluzioni o l’uscita.
C’è una crisi, perfino, epistemologica, con l’appannarsi del confine fra vero e falso, informazione e fake news, lumi della ragione e buio delle credenze, che erode il nocciolo stesso dell’autodeterminazione e ci mette tutti nella condizione dell’angelo di Benjamin, con il futuro alle spalle e il progresso ridotto a una montagna di macerie. E potremmo chiuderla qui, con l’immagine di un decennio avvolto nella parola “crisi” variamente declinata ma riassumibile sotto il nome di crisi del neoliberalismo, e senza che se ne vedano le soluzioni o l’uscita.Eppure, il bicchiere si può rovesciare, come fa Rebecca Solnit sul Guardian, invitandoci a guardare le cose da un’altra prospettiva. Perché proprio questa infilata di crisi ci ha aperto gli occhi, trasformando la disillusione non sempre in rancore, paura e nostalgia ma anche in rivolta, resistenza, immaginazione del futuro. Guardato da questa prospettiva, il decennio è attraversato da un filo rosso di movimenti che non smettono di ripresentarsi da ogni parte del mondo: Occupy Wall street, le primavere arabe, Black lives matter, il movimento sul cambiamento climatico dall’Artico all’Equatore, le piazze gremite degli ultimi mesi in America Latina, i gilet gialli in Francia. E il femminismo di ultima generazione dappertutto, dal Cile al Messico, dal Giappone alla Corea del Sud, dall’Europa all’India, dal Pakistan al Kenia, e da Hollywood alle periferie più sofferenti: una rivolta dentro la rivolta, come da sempre il femminismo si presenta, ad ammonire che non c’è ribellione contro la finanza, contro il capitalismo delle piattaforme, contro i dittatori, contro le polizie, contro i fondamentalismi, contro il razzismo, contro lo sfruttamento mortifero della natura, che non passi per lo smantellamento delle strutture profonde del dominio sessuale e per la tessitura di una diversa trama dell’io, del noi, delle relazioni umane.
 Non c’è uscita dalla razionalità neoliberale, che ha ridisegnato l’antropologia politica del mondo mettendo sul trono un individuo tanto proprietario, narcisista e competitivo quanto deprivato, isolato e infelice, senza ritessere la trama delle alleanze intersezionali fra quante e quanti in quell’individuo non si riconoscono.
Non c’è uscita dalla razionalità neoliberale, che ha ridisegnato l’antropologia politica del mondo mettendo sul trono un individuo tanto proprietario, narcisista e competitivo quanto deprivato, isolato e infelice, senza ritessere la trama delle alleanze intersezionali fra quante e quanti in quell’individuo non si riconoscono.Conosciamo le obiezioni: questi movimenti spuntano e passano, non vincono, sono poca cosa rispetto alle torsioni verso destra dei popoli e degli elettorati. Ma i movimenti non vincono le elezioni, cambiano la testa e il cuore di chi li fa e di chi ne è contagiato; scavano in profondità, aprono l’immaginazione del presente e del futuro, rimettono al mondo la felicità pubblica dove imperano le passioni tristi; rilanciano il desiderio di politica dove la politica costituita agonizza; modificano, appunto, la prospettiva. Sotto questa prospettiva, la visione del decennio cambia: l’infilata delle crisi diventa un generatore imprevedibile di soggettività, e l’icona che meglio la condensa è quella di un maschio bianco impaurito che pretende di tornare sovrano erigendo barriere e confini circondato da una moltitudine di donne che glielo impediscono. Trump e il Metoo, Salvini e Carola Rackete, Putin e Olga Misik, i potenti della terra e Greta: cartoline da un decennio niente male.
Oggetto privilegiato di addomesticamento del neoliberalismo, le donne ne sono diventate la principale spina nel fianco, le frontwomen di una rivolta che i media mainstream riducono alla conta delle presidenze e delle onorificenze femminili ma che ha per posta in gioco un cambio di civiltà. Non ci sono tetti di cristallo da rompere ma basi sociali da ricostruire. Il gioco, nel decennio che verrà, si farà certamente più duro se non tragico come un secolo fa, ma giocato dalla parte giusta si annuncia anche gravido di buone promesse.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "La gioia dell’amore": la lettera del sindaco di Milano e i "divorziati e l’eucarestia". Note.30 dicembre 2019, di Federico La Sala
COSTITUZIONE, MESSAGGIO EVANGELICO, CATTOLICESIMO ROMANO, E FILOLOGIA... *
- SE LA "CARISSIMA" EU-CARESTIA è figlia DELLA CARITA’ ("CARITAS") è e resta SEMPRE una ELEMOSINA, E L’EU-CHARIS-TIA è e resta sempre una CARITA’ ("Caritas") senza GRAZIA ("CHARItaS"):
- AMORIS LAETITIA [La gioia dell’amore]: "296. Il Sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. Al riguardo, desidero qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di sbagliare strada: «due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare [...]. La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione [...]. La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero [...]. Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!».[326] Pertanto, «sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione».[327]" (ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE di Papa Francesco SULL’AMORE NELLA FAMIGLIA, 19 marzo 2016).
- "Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!».[326]": "Nam, vera caritas semper immerita interminataque et gratuita est! [326]" (cfr.: "Homilia in Eucharistia cum Cardinalibus nuper electis celebrata habita, 15 februarii 2015)"
Sala: “La fede mi guida. Ma da divorziato soffro senza la comunione”
La lettera del sindaco di Milano. Riflessione sul rapporto con la religione: “Mi aiuta nell’impegno a favore dei più deboli. Altrimenti la parola di Dio rimane scritta solo nei libri e non nei nostri cuori”
di GIUSEPPE SALA (la Repubblica, 24 dicembre 2019)
Caro direttore, sono un uomo fortunato perché la fede è per me qualcosa di irrinunciabile. È un dono fondamentale che apprezzo ancor di più adesso, dopo i sessant’anni, con tanta vita alle spalle. Ho avuto momenti di stanchezza, ho vissuto dubbi e contraddizioni ma non ho mai smesso di ricercare il Signore. Tra tante vicende della vita sento di non potere fare a meno del confronto con il Mistero e, in definitiva, con me stesso.
Ed è proprio da questa esperienza che conosco i miei limiti. Non mi sono mai sentito così profondo da potermi nutrire solo di fede, di farmi “bastare” l’intima relazione con Dio. Penso spesso che la mia fede non reggerebbe senza la pratica, senza la possibilità di entrare in un luogo di culto, senza la Messa della domenica. Ho bisogno della Messa, di sentire la voce, più o meno ispirata, di un pastore e di misurarmi con Gesù e con il suo Vangelo. Pur nella consapevolezza dell’ineluttabilità del confronto che nasce in me e ritorna in me.
La Messa della domenica è un momento di pace e di verità. Mi fa star bene, mi aiuta a sentire la mia umanità, i miei dolori, la mia essenza. La gratitudine e la precarietà. Sono solo a disagio rispetto al momento della comunione, essendo divorziato e in uno stato che non mi consente di accostarmi al Sacramento. Amo stare insieme agli altri, condividere quel senso di solitudine e, allo stesso tempo, di comunione che la Messa ti dà. La liturgia ci insegna l’umiltà di essere come (e peggio) degli altri, di condividere la speranza, di far ammenda delle nostre miserie.
Si deve essere popolo anche fuori dalle porte della Chiesa. Tra tante urla, la ricerca della verità e della giustizia è l’impegno che dà senso alla mia fede, quella fede che mi dà l’energia giorno per giorno per rendere concreto il mio cammino sulla via dell’equità, del rispetto e dell’accoglienza soprattutto verso i più deboli e i più abbandonati. Altrimenti la parola di Dio rischia di rimanere scritta solo nei libri e non nei nostri cuori.
Per tutto ciò amo parlare di religione, ma ne aborro l’ostentazione. Sorrido pensando che ne sto scrivendo, ma è come se stessi parlando a me stesso.
I divorziati e l’eucarestia.
La lettera del sindaco Sala e le risposte che dà la Chiesa
È raro che un politico parli della sua vita di fede. Il primo cittadino di Milano lo ha fatto rivelando un’adesione di fede e una ferita
di Luciano Moia (Avvenire, sabato 28 dicembre 2019)
- [Foto] Giuseppe Sala, sindaco di Milano
È raro che un politico parli della sua vita di fede. Il sindaco Beppe Sala lo ha fatto rivelando un’adesione e una ferita. Un atto di coraggio e di chiarezza. Che non può che essere apprezzato da chi, come noi, da anni è impegnato a divulgare e promuovere la svolta pastorale voluta da papa Francesco all’insegna dell’accoglienza e della misericordia. Nella confessione spirituale che ha affidato, la vigilia di Natale, alle pagine de "la Repubblica", il sindaco di Milano rivela «di non poter fare a meno del confronto con il Mistero» e di partecipare regolarmente alla Messa domenicale, ma di sentirsi «a disagio rispetto al momento della Comunione, essendo divorziato e in uno stato che non mi consente di accostarmi al Sacramento».
Se una persona seria e preparata come Sala, è costretta ad ammettere un disorientamento spirituale per la sua condizione di divorziato risposato, significa che la strada per trasformare in consapevolezza diffusa le indicazioni uscite dal doppio Sinodo sulla famiglia (2014 e 2015) voluto da papa Francesco e poi dall’esortazione apostolica Amoris laetitia, è ancora lunga.
In quel testo il Papa scrive in modo esplicito che nessuno deve sentirsi condannato per sempre e che la Chiesa è chiamata ad offrire a tutti, compresi i divorziati risposati a cui è dedicato un intero capitolo - l’VIII - la possibilità di vivere pienamente il proprio cammino di fede. In questo cammino si può comprendere anche l’aiuto dei sacramenti (nota 351).
Non è un’opinione. È quanto emerso da un cammino sinodale proseguito per oltre tre anni che il Papa ha sancito con la sua parola. Poi, di fronte alle critiche e ai distinguo, Francesco ha voluto che l’interpretazione da lui considerata più efficace, quella dei vescovi della regione di Buenos Aires, fosse inserita nei cosiddetti Acta apostolica sedis - gli atti ufficiali della Santa Sede - a ribadire che indietro non si torna e che tutte le diocesi del mondo devono incamminarsi lungo quella strada.
Milano non fa eccezione. Inutile far riferimento al rito ambrosiano e alle aperture del cardinale Carlo Maria Martini, che su questi aspetti non ci sono state, in quanto scelte che non si potevano e non si possono pretendere da una singola Chiesa locale.
Francesco, come detto, ha ritenuto necessarie due assemblee mondiali dei vescovi per gettare i semi del cambiamento. Una persona divorziata e risposata che desidera riaccostarsi alla Comunione - spiega il Papa - può chiedere l’aiuto di un sacerdote preparato per avviare un serio esame di coscienza sulle proprie scelte esistenziali.
Sei, in rapidissima sintesi, i punti da non trascurare: quali sforzi sono stati fatti per salvare il precedente matrimonio e ci sono stati tentativi di riconciliazione? La separazione è stata voluta o subita? Che rapporto c’è con il precedente coniuge? Quale comportamento verso i figli? Quali ripercussioni ha avuto la nuova unione sul resto della famiglia? E sulla comunità? Domande spesso laceranti e risposte non codificabili, che possono richiedere anche lunghi tempi di elaborazione e da cui non derivano conseguenze uguali per tutti. Ma anche modalità pastorali efficaci per metterle in pratica.
Trovare e attuare queste buone prassi è faticoso e Sala, con le sue parole, ha dato voce a un disagio e una sofferenza spirituale, ma anche a una speranza, che condivide con tanti altri credenti, divorziati e risposati.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE.
FLS
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Rompere il muro della diseguaglianza fra donne e uomini nella Chiesa (di Gianni Cardinale)28 dicembre 2019, di Federico La Sala
La rivista.
«Rompere il muro della diseguaglianza tra donna e uomo nella Chiesa»
Il numero di dicembre di "Donna Chiesa Mondo", supplemento dell’Osservatore Romano, dedicato al rapporto di papa Francesco con il mondo femminile
di Gianni Cardinale (Avvenire, sabato 28 dicembre 2019)
- [Foto] Papa Francesco con una giovane donna nell’udienza del 30 gennaio 2019 - Ansa
“Le donne e Francesco”. È questo il titolo dell’ultimo numero di “Donna Chiesa Mondo”, il supplemento mensile dell’Osservatore Romano coordinato da Rita Pinci interamente dedicato all’universo rosa. Il fascicolo, in uscita oggi in allegato al quotidiano diretto da Andrea Monda, ospita interventi di donne - laiche e consacrate - che “dicono ciò che pensano di papa Francesco in rapporto alla questione femminile nella Chiesa”. E lo dicono in piena libertà. Numerosi i contributi, dal contenuto a volte pungente.
Stefania Falasca di Avvenire sottolinea che “al di là della formazione personale, la sollecitudine con la quale papa Francesco, fin dalla sua elezione, si è dedicato alla questione delle donne, del loro ruolo e accesso alle responsabilità ecclesiali, evidenzia l’urgenza di affrontare una realtà che riguarda la visione della Chiesa stessa e investe la sua natura gerarchica e comunionale”. È tale visione infatti “che spinge il Papa a percepire il monocolore maschile come un difetto, uno squilibrio, una minorazione della Chiesa considerato che senza le donne essa risulta deficitaria nell’annuncio e nella testimonianza e che dunque compromette la sua missione”.
Alla luce del recente Sinodo sull’Amazzonia la teologa Serena Noceti da parte sua ricorda che “nel quadro della visione del ministero ordinato consegnata dal concilio Vaticano II, la teologia sistematica è interpellata oggi per valutare la possibilità di ordinare donne diacono”. Così “sessanta anni dopo il votum di mons. de Uriarte Bengoa, ancora una volta dall’Amazzonia, la richiesta di donne diacono - come voce profetica? - raggiunge la chiesa intera e sollecita la teologia a ‘pensare in novità’”.
Mentre la “filosofa femminista” Luisa Muraro lamenta che anche la volontà di cambiamento di papa Francesco sarebbe però "un’eccezione" al livello "alto" della Chiesa dove prevale ancora "la preoccupazione di andare d’accordo con una tradizione che ha, fatalmente, l’impronta del tra-uomini di potere".
Tra i temi affrontati nel fascicolo anche lo spinoso problema della violenza contro le suore, sessuale e sotto forma di abuso di potere, da parte degli stessi uomini della Chiesa. "Il pontefice ha rotto il silenzio sulla violenza - sottolinea suor Jolanta Kafka, la nuova presidente della Uisg, Unione Internazionale Superiore Generali, che riunisce 1900 congregazioni per oltre 450.000 consacrate - e questo ci dà la possibilità di parlare, di essere, anche come Uisg, un luogo di ascolto e di aiuto non solo nei confronti della violenza sessuale, ma di ogni abuso di potere".
Da segnalare poi un appello al Papa a firma di Marinella Perroni, teologa e biblista al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo: "Date l’esempio al mondo, anche quello che si ritiene ’civilizzato’ e che invece fa ancora tanta fatica ad accettare che, tra uomo e donna, non c’è uno che è soggetto (anche di parola) e l’altra che è oggetto (anche di parola), ma che, ormai, la soggettualità non può che essere condivisa. E ognuno parli di sé. Abbiamo gran bisogno di ascoltare uomini che parlano di maschilità. Anche nella Chiesa".
Il supplemento si chiude con una paginetta dal titolo forte: “Rompere il muro della diseguaglianza”. In essa tre fondatrici dell’Associazione Donne in Vaticano - Romilda Ferrauto, Adriana Masotti, Gudrun Sailer - sostengono che "anche in Vaticano le donne sono a volte viste, da uomini, ma anche da altre donne, come persone di minor valore intellettuale e professionale, sempre disponibili al servizio, sempre docili ai comandi superiori". Di qui l’urgenza appunto di "rompere il muro della diseguaglianza fra donne e uomini nella Chiesa".
Sulla scia dell’insegnamento di Papa Francesco, per cui “l’alleanza dell’uomo e della donna è chiamata a prendere nelle sue mani la regia dell’intera società”. Con un invito “alla responsabilità per il mondo... e anche nella Chiesa”.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- «Perché la storia continui». Appello per una Costituzione della Terra (di Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, Raffaele Nogaro, Paolo Maddalena, Mariarosaria Guglielmi, Riccardo Petrella).27 dicembre 2019, di Federico La Sala
«Perché la storia continui». Appello per una Costituzione della Terra
Proposte. Appello per un nuovo costituzionalismo globale, una bussola etica e politica per salvare il mondo e i suoi abitanti dalla distruzione.
di Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, Raffaele Nogaro, Paolo Maddalena, Mariarosaria Guglielmi, Riccardo Petrella (il manifesto, 26.12.2019)
Nel pieno della crisi globale, nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, il vescovo Nogaro, Riccardo Petrella e molti altri lanciano il progetto politico di una Costituzione per la Terra e promuovono una Scuola, «Costituente Terra», che ne elabori il pensiero e prefiguri una nuova soggettività politica del popolo della Terra, «perché la storia continui». Pubblichiamo le parti essenziali del documento che esce domani, in data 27 dicembre 2019.
L’Amazzonia brucia e anche l’Africa, e non solo di fuoco, la democrazia è a pezzi, le armi crescono, il diritto è rotto in tutto il mondo. «Terra! Terra!» è il grido dei naufraghi all’avvistare la sponda, ma spesso la terra li respinge, dice loro: «i porti sono chiusi, avete voluto prendere il mare, fatene la vostra tomba, oppure tornate ai vostri inferni». Ma «Terra» è anche la parola oggi più amata e perduta dai popoli che ne sono scacciati in forza di un possesso non condiviso; dai profughi in fuga per la temperatura che aumenta e il deserto che avanza; dalle città e dalle isole destinate ad essere sommerse al rompersi del chiavistello delle acque, quando la Groenlandia si scioglie, i mari son previsti salire di sette metri sull’asciutto, e a Venezia già lo fanno di un metro e ottantasette. «Che si salvi la Terra» dicono le donne e gli uomini tutti che assistono spaventati e impotenti alla morte annunciata dell’ambiente che da millenni ne ospita la vita.
Ci sono per fortuna pensieri e azioni alternative, si diffonde una coscienza ambientale, il venerdì si manifesta per il futuro, donne coraggiose da Greta Thunberg a Carola Rackete fanno risuonare milioni di voci, anche le sardine prendono la parola, ma questo non basta. Se nei prossimi anni non ci sarà un’iniziativa politica di massa per cambiare il corso delle cose, se le si lascerà in balia del mercato della tecnologia o del destino, se in Italia, in Europa e nelle Case Bianche di tutti i continenti il fascismo occulto che vi serpeggia verrà alla luce e al potere, perderemo il controllo del clima e della società e si affacceranno scenari da fine del mondo, non quella raccontata nelle Apocalissi, ma quella prevista e monitorata dagli scienziati.
Il cambiamento è possibile
L’inversione del corso delle cose è possibile. Essa ha un nome: Costituzione della terra. Il costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra.
La Costituzione del mondo non è il governo del mondo, ma la regola d’ingaggio e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo. Nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, ad opera di un soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una Costituzione della Terra è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, ma l’unità umana che giunga ad esistenza politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità e la eserciti ai fini di far continuare la storia e salvare la Terra.
Salvare la Terra non vuol dire solo mantenere in vita «questa bella d’erbe famiglia e d’animali», cantata dai nostri poeti, ma anche rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone umane.
 Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».
Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».È chiaro che in queste condizioni i diritti proclamati sono rimasti sulla carta, come promesse non mantenute. Riprendere oggi il processo politico per una Costituzione della Terra vuol dire tornare a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant’anni fa e i diritti in esso stabiliti. E poiché quei diritti appartengono al diritto internazionale vigente, la loro tutela e attuazione non è soltanto un’urgente opzione politica, ma anche un obbligo giuridico in capo alla comunità internazionale e a tutti noi che ne facciamo parte.
Qui c’è un’obiezione formulata a partire dalla tesi di vecchi giuristi secondo la quale una Costituzione è l’espressione dell’«unità politica di un popolo»; niente popolo, niente Costituzione. E giustamente si dice che un popolo della Terra non c’è; infatti non c’era ieri e fino ad ora non c’è.
La novità è che adesso può esserci, può essere istituito; lo reclama la scena del mondo, dove lo stato di natura delle sovranità in lotta tra loro non solo toglie la «buona vita», ma non permette più neanche la nuda vita; lo reclama l’oceano di sofferenza in cui tutti siamo immersi; lo rende possibile oggi la vetta ermeneutica raggiunta da papa Francesco e da altre religioni con lui, grazie alla quale non può esserci più un dio a pretesto della divisione tra i popoli: «Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno» - hanno detto ad Abu Dhabi - non vuole essere causa di terrore per nessuno, mentre lo stesso «pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani»; non c’è più un Dio geloso e la Terra stessa non è una sfera, ma un poliedro di differenze armoniose.
Per molti motivi perciò è realistico oggi porsi l’obiettivo di mettere in campo una Costituente della Terra, prima ideale e poi anche reale, di cui tutte le persone del pianeta siano i Padri e le Madri costituenti.
Una politica dalla parte della Terra
Di per sé l’istanza di una Costituzione della Terra dovrebbe essere perseguita da quello strumento privilegiato dell’azione politica che, almeno nelle democrazie, è il partito - nazionale o transnazionale che sia - ossia un artefice collettivo che, pur sotto nomi diversi, agisca nella forma partito. Oggi questo nome è in agonia perché evoca non sempre felici ricordi, ma soprattutto perché i grandi poteri che si arrogano il dominio del mondo non vogliono essere intralciati dal controllo e dalla critica dei popoli, e quindi cercano di disarmarli spingendoli a estirpare le radici della politica e dei partiti fin nel loro cuore. È infatti per la disaffezione nei confronti della politica a cui l’intera società è stata persuasa che si scende in piazza senza colori; ma la politica non si sospende, e ciò a cui comunque oggi siamo chiamati è a prendere partito, a prendere partito non per una Nazione, non per una classe, non “prima per noi”, ma a prendere partito per la Terra, dalla parte della Terra.
Ma ancor più che la riluttanza all’uso di strumenti già noti, ciò che impedisce l’avvio di questo processo costituente, è la mancanza di un pensiero politico comune che ne faccia emergere l’esigenza e ne ispiri modalità e contenuti.
Non manca certamente l’elaborazione teorica di un costituzionalismo globale che vada oltre il modello dello Stato nazionale, il solo nel quale finora è stata concepita e attuata la democrazia, né mancano grandi maestri che lo propugnino; ma non è diventato patrimonio comune, non è entrato nelle vene del popolo un pensiero che pensi e promuova una Costituzione della Terra, una unità politica dell’intera comunità umana, il passaggio a una nuova e rassicurante fase della storia degli esseri umani sulla Terra.
Eppure le cose vanno così: il pensiero dà forma alla realtà, ma è la sfida della realtà che causa il pensiero. Una “politica interna del mondo” non può nascere senza una scuola di pensiero che la elabori, e un pensiero non può attivare una politica per il mondo senza che dei soggetti politici ne facciano oggetto della loro lotta. Però la cosa è tale che non può darsi prima la politica e poi la scuola, né prima la scuola e poi la politica. Devono nascere insieme, perciò quello che proponiamo è di dar vita a una Scuola che produca un nuovo pensiero della Terra e fermenti causando nuove soggettività politiche per un costituzionalismo della Terra. Perciò questa Scuola si chiamerà «Costituente Terra».
«Costituente Terra»: una Scuola per un nuovo pensiero
Certamente questa Scuola non può essere pensata al modo delle Accademie o dei consueti Istituti scolastici, ma come una Scuola disseminata e diffusa, telematica e stanziale, una rete di scuole con aule reali e virtuali. Se il suo scopo è di indurre a una mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni casa dovrebbe diventare una scuola e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il suo fine potrebbe perfino spingersi oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano cambiare le lance in falci e le spade in aratri e si aspettavano che i popoli non avrebbero più imparato l’arte della guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in natura: per farla, bisognava prima impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così bene che per prima cosa dovremmo disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe addestrarci, a disimparare l’arte della guerra, per imparare invece l’arte di custodire il mondo e fare la pace.
Molte sarebbero in tale scuola le aree tematiche da perlustrare:
1) le nuove frontiere del diritto, il nuovo costituzionalismo e la rifondazione del potere;
2) il neo-liberismo e la crescente minaccia dell’anomia;
3) la critica delle culture ricevute e i nuovi nomi da dare a eventi e fasi della storia passata;
4) il lavoro e il Sabato, un lavoro non ridotto a merce, non oggetto di dominio e alienato dal tempo della vita;
5) la «Laudato sì» e l’ecologia integrale;
6) il principio femminile, come categoria rigeneratrice del diritto, dal mito di Antigone alla coesistenza dei volti di Levinas, al legame tra donna e natura fino alla metafora della madre-terra;
7) l’Intelligenza artificiale (il Führer artificiale?) e l’ultimo uomo;
8) come passare dalle culture di dominio e di guerra alle culture della liberazione e della pace;
9) come uscire dalla dialettica degli opposti, dalla contraddizione servo-signore e amico-nemico per assumere invece la logica dell’ et-et, della condivisione, dell’armonia delle differenze, dell’ «essere per l’altro», dell’ «essere l’altro»;
10) il congedo del cristianesimo dal regime costantiniano, nel suo arco «da Costantino ad Hitler», e la riapertura nella modernità della questione di Dio;
11) il «caso Bergoglio», preannuncio di una nuova fase della storia religiosa e secolare del mondo.
Naturalmente molti altri temi potranno essere affrontati, nell’ottica di una cultura per la Terra alla quale nulla è estraneo d’umano. Tutto ciò però come ricerca non impassibile e fuori del tempo, ma situata tra due kairòs, tra New Delhi ed Abu Dhabi, due opportunità, una non trattenuta e non colta, la proposta di Gorbaciov e Rajiv Gandhi del novembre 1986 per un mondo libero dalle armi nucleari e non violento, e l’altra che ora si presenta di una nuova fraternità umana per la convivenza comune e la salvezza della Terra, preconizzata nel documento islamo-cristiano del 4 febbraio 2019 e nel successivo Comitato di attuazione integrato anche dagli Ebrei, entrato ora in rapporto con l’ONU per organizzare un Summit mondiale della Fratellanza umana e fare del 4 febbraio la Giornata mondiale che la celebri.
Partecipare al processo costituente iscriversi al Comitato promotore
Pertanto i firmatari di questo appello propongono di istituire una Scuola denominata «Costituente Terra» che prenda partito per la Terra, e a questo scopo hanno costituito un’associazione denominata «Comitato promotore partito della Terra». Si chiama così perché in via di principio non era stata esclusa all’inizio l’idea di un partito, e in futuro chissà. Il compito è oggi di dare inizio a una Scuola, «dalla parte della Terra», alle sue attività e ai suoi siti web, e insieme con la Scuola ad ogni azione utile al fine «che la storia continui»; e ciò senza dimenticare gli obiettivi più urgenti, il risanamento del territorio, la rifondazione del lavoro, l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, la firma anche da parte dell’Italia del Trattato dell’ONU per l’interdizione delle armi nucleari e così via.
I firmatari propongono che persone di buona volontà e di non perdute speranze, che esponenti di associazioni, aggregazioni o istituzioni già impegnate per l’ecologia e i diritti, si uniscano a questa impresa e, se ne condividono in linea generale l’ispirazione, si iscrivano al Comitato promotore di tale iniziativa all’indirizzo progettopartitodellaterra@gmail.com versando la relativa quota sul conto BNL intestato a “Comitato promotore del partito della Terra”,
 IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR).
IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR).La quota annua di iscrizione, al Comitato e alla Scuola stessa, è libera, e sarà comunque gradita. Per i meno poveri, per quanti convengano di essere tra i promotori che contribuiscono a finanziare la Scuola, eventuali borse di studio e il processo costituente, la quota è stata fissata dal Comitato stesso nella misura significativa di 100 euro, con l’intenzione di sottolineare che la politica, sia a pensarla che a farla, è cosa tanto degna da meritare da chi vi si impegna che ne sostenga i costi, contro ogni tornaconto e corruzione, ciò che per molti del resto è giunto fino all’offerta della vita. Naturalmente però si è inteso che ognuno, a cominciare dai giovani, sia libero di pagare la quota che crede, minore o maggiore che sia, con modalità diverse, secondo le possibilità e le decisioni di ciascuno.
Nel caso che l’iniziativa non riuscisse, le risorse finanziarie mancassero e il processo avviato non andasse a buon fine, l’associazione sarà sciolta e i fondi eventualmente residui saranno devoluti alle ONG che si occupano dei salvataggi dei fuggiaschi e dei naufraghi nel Mediterraneo.
Un’assemblea degli iscritti al Comitato sarà convocata non appena sarà raggiunto un congruo numero di soci, per l’approvazione dello Statuto dell’associazione, la formazione ed elezione degli organi statutari e l’impostazione dei programmi e dell’attività della Scuola.
Roma, 27 dicembre 2019, 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.
PROPONENTI E PRIMI ISCRITTI. Raniero La Valle, giornalista (Roma), Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto (Roma), Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, Raffaele Nogaro, ex vescovo di Caserta, Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, Mariarosaria Guglielmi, Segretaria generale di Magistratura Democratica, Riccardo Petrella, ecologo, promotore del Manifesto dell’acqua e dell’identità di “Abitante della Terra”, Domenico Gallo, magistrato, Francesco Carchedi, sociologo (Roma), Francesco Di Matteo, Comitati Dossetti per la Costituzione, Anna Falcone. avvocata, Roma, Pippo Civati, Politico, Piero Basso (Milano), Gianpietro Losapio, cooperatore sociale, direttore del Consorzio NOVA, Giacomo Pollastri, studente in Legge (Roma), Francesco Comina, giornalista (Bolzano), Roberto Mancini, filosofo (Macerata), Francesca Landini, informatica (Roma), Giancarlo Piccinni e la Fondazione don Tonino Bello (Alessano), Grazia Tuzi, antropologa, autrice di “Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della comunità del porcellino” (Roma), Guido Innocenzo Gargano osb cam., monaco (Roma), Felice Scalia, s. J, (Messina), Marina Graziosi, docente (Roma), Agata Cancelliere, insegnante, (Roma), Raul Mordenti, storico della critica letteraria, Politico (Roma), Salvatore Maira, scrittore (Roma), Marco Malagola, francescano, missionario, (Torino), Norma Lupi (Roma), Andrea Cantaluppi, sindacalista (Roma), Enrico Peyretti (Torino), Nino Mantineo, università di Catanzaro, Giacoma Cannizzo, già sindaca di Partinico, Filippo Grillo, artista (Palermo), Nicola Colaianni, già magistrato e docente all’Università di Bari, Stefania Limiti, giornalista (Roma), Domenico Basile (Merate, Lecco), Maria Chiara Zoffoli (Merate), Luigi Gallo (Bolzano), Antonio Vermigli, giornalista (Quarrata, Pistoia), Renata Finocchiaro, ingegnere (Catania), Liana D’Alessio (Roma), Lia Fava, ordinaria di letteratura (Roma), Paolo Pollastri, musicista (Roma), Fiorella Coppola, sociologa (Napoli), Dario Cimaglia, editore, (Roma), Luigi Spina, insegnante, ricercatore (Biella), Marco Campedelli, Boris Ulianich, storico, Università Federico II, Napoli, Gustavo Gagliardi, Roma, Paolo Scandaletti, scrittore di storia, Roma, Pierluigi Sorti, economista, Roma, Vittorio Bellavite, coordinatore di “Noi siamo Chiesa”, Agnés Deshormes, cooperatrice internazionale, Parigi, Anna Sabatini Scalmati, psicoterapeuta, Roma, Francesco Piva, Roma, Sergio Tanzarella, storico del cristianesimo, Tina Palmisano, Il Giardino Terapeutico sullo Stretto, Messina, Luisa Marchini, segretaria di “Salviamo la Costituzione”, Bologna, Maurizio Chierici, giornalista. Angelo Cifatte, formatore, Genova, Marco Tiberi, sceneggiatore, Roma, Achille Rossi e l’altrapagina, Città di Castello, Antonio Pileggi, ex Provveditore agli studi e dir. gen. INVALSI, Giovanni Palombarini, magistrato, Vezio Ruggieri, psicofisiologo (Roma) Bernardetta Forcella (insegnante (Roma), Luigi Narducci (Roma), Laura Nanni (Albano), Giuseppe Salmè, magistrato, Giovanni Bianco, giurista, Roma.
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO E DALLA CAVERNA "COSMO-TE-ANDRICA" PLATONICA. Veder le stelle con gli occhi di Dante.18 dicembre 2019, di Federico La Sala
USCIRE DALLA CAVERNA E DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE COSMO-TE-ANDRICA PLATONICA. Materiali sul tema... *
Letteratura.Veder le stelle con gli occhi di Dante
Fisici, cosmologi, poeti, scrittori, teologi e mistici sono da sempre affascinati dalla “scienza stellare” dantesca: lo ricorda l’inglesista Tracy Daugherty in un nuovo saggio
di Gianni Vacchelli (Avvenire, mercoledì 18 dicembre 2019)
- [Foto] «E quindi uscimmo a riveder le stelle» (XXXIV, 139), in un’antica miniatura
Dante ci sorprende sempre e ci spiazza, anche quando crediamo di averlo incasellato, almeno su un aspetto. Così potremmo pensare che la sua astronomia sia realmente irricevibile e superata. Ad esempio per il grande poeta Thomas Eliot, anche acuto dantista, come tutti sappiamo, «non è essenziale che la quasi inintelligibile astronomia di Dante sia capita ». Eppure non è così. E se forse l’accademia riserva in genere una rispettosa ma un po’ distaccata attenzione alla “scienza stellare” dantesca, fisici, cosmologi, oltre che poeti, scrittori, teologi e mistici ne sono da sempre affascinati. Soprattutto oggi gli uomini di scienza. Ce lo ricorda anche l’americano Tracy Daugherty, professore emerito di Inglese all’Oregon State University, nonché romanziere, nel suo recente e interessante saggio Dante and the Early Astronomer [Dante e la Prima Astronoma] ( Yale University Press).
 In verità il libro di Daugherty, come si evince anche dal sottotitolo “Scienza, avventura e una donna vittoriana che aprì i cieli”, è sì dedicato a Dante ma insieme all’astronoma Mary Acworth Evershed (conosciuta pure come M.A. Orr, col cognome da nubile, prima di sposare John Evershed, importante astronomo lui stesso).
In verità il libro di Daugherty, come si evince anche dal sottotitolo “Scienza, avventura e una donna vittoriana che aprì i cieli”, è sì dedicato a Dante ma insieme all’astronoma Mary Acworth Evershed (conosciuta pure come M.A. Orr, col cognome da nubile, prima di sposare John Evershed, importante astronomo lui stesso).Mary è una donna inglese, nata nel 1867. Amava la poesia e il cielo stellato, e un viaggio in Italia all’età di 20 anni, a Firenze e a Ravenna, fu fondativo per la sua ricerca: decise così di studiare attentamente tutti i riferimenti astronomici nella Commedia di Dante, che arriverà a leggere in italiano. E nel 1913 Mary, con il cognome di Orr, pubblicò il suo importante studio Dante and the Early Astronomers, troppo presto dimenticato e che sarebbe utile riscoprire e tradurre in italiano. Nonostante il modello tolemaico di Dante fosse totalmente superato, Mary ammirò «la fedeltà dantesca agli insegnamenti dell’astronomia come l’aveva imparata dai suoi maestri», «la fantastica precisione dentro una struttura chiara» nel descrivere i fenomeni celesti. Per lei «il Poeta possedeva l’istinto e le attitudini di un ricercatore scientifico: una mente irrequieta, un abito di attenta osservazione».
Studiosa dei crateri lunari e delle macchie del sole, che «Dante aveva riconosciuto tre secoli prima che venissero scientificamente rilevate», Mary rimase affascinata anche da come Galileo, che stava aprendo all’umanità una nuova immagine di universo, rimanesse fedele alla retorica, all’immaginazione, ai ritmi danteschi. Le sue descrizioni del sole nelle Lettere sulle macchie solari echeggiavano le discussioni astronomiche di Beatrice in Paradiso II, sulle macchie lunari. Per la Evershed «Galileo considerò sempre Dante un pari, e la sua maestria artistica un modello... per lui la Commedia non era un cimitero di teorie astronomiche scartate, ma un prologo poetico a future scoperte». Allo stesso modo anche lei «seguì le tracce dell’universo di Dante, afferrò l’uso da parte di Galileo dell’arte di Dante per far avanzare le sue nozioni scientifiche e partecipò alla rivoluzione mentale che espanse l’esistenza e la conoscenza nel modo in cui Einstein - e Dante - predissero che sarebbe accaduto».
E in effetti il libro di Daugherty accenna in più parti ad una seconda e in qualche modo diversa linea di ricezione delle idee astronomiche del Poeta. Se la Evershed, con Galileo prima di lei, ha ammirato la coerenza e l’accuratezza “scientifica” del dettato dantesco, pur nel paradigma tolemaico non più accettabile, oggi molti «scrittori come il matematico Mark A. Peterson, lo storico della scienza Edward Grant e lo storico William Egginton hanno sostenuto in modo persuasivo che le concezioni medievali di Dante sulla forma dell’universo sembrano agli astronomi contemporanei sorprendentemente preveggenti». Dante insomma avrebbe «inventato un nuovo spazio topologico, la 3-sfera, o ipersfera», come scrive il citato Peterson in una sua analisi del 1979. In qualunque caso, una cosa è certa: la rappresentazione grafica del cosmo dantesco, ancora largamente accettata e quasi onnipresente su tutte le antologie scolastiche, con la terra al centro, i nove cieli intorno e l’Empireo sopra tutti, per lo più rappresentato come una sorta di “buffo cappellino” all’intero universo dantesco, è inaccettabile, testo di Dante alla mano.
Basta rileggere due complessi ma splendidi passi paradisiaci. In Paradiso XXVII, 106ss., Dante spiega la natura del Primo Mobile, la prima e più esterna delle sfere cosmiche ruotanti attorno alla Terra in base al modello geocentrico dell’universo, da cui trarrebbero origine il moto e il tempo. E scrive: «Luce e amor d’un cerchio lui comprende, / sì come questo li altri; e quel precinto / colui che ’l cinge solamente intende» (Pd XVVII, 112-114). Qui il Poeta sembrerebbe descrivere l’Empireo come un’ultima realtà capace di cingere il Primo Mobile e tutti gli altri cieli a seguire. Eppure nel canto successivo, Paradiso XXVIII, 16ss., avviene qualcosa di straordinario: Dante vede al centro dell’universo non la terra bensì un punto luminosissimo, il cui splendore non può essere sostenuto da occhi umani: «un punto vidi che raggiava lume / acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume» (Pd XXVIII, 16-18). Il mistero divino è adesso centro dell’universo, «da quel punto / depende il cielo e tutta la natura» (vv.41-42), ed è come se il Poeta scorgesse «un altro universo», rovesciato e fatto, ugualmente, di nove cerchi concentrici, sede delle gerarchie angeliche ruotanti intorno a Dio.
È a partire da questi passi danteschi che il fisico rumeno Roman Patapievici, nel suo prezioso e oggi introvabile libretto Gli occhi di Beatrice ( Bruno Mondadori 2006), scrive: «L’immagine allo specchio è simile a quella reale, solo che è invertita. Il mondo invisibile diventa allora un calco rovesciato del mondo visibile: l’Empireo è Dio-centrico mentre la Terra è diavolo-centrica... l’invisibile obbedisce a norme opposte rispetto al visibile. Per spiegare queste simmetrie non resta che concepire l’universo visibile (con al centro la Terra) e l’Empireo (con al centro Dio) come due sfere che hanno in comune la superficie, cioè il “Primo Mobile”: il che equivale appunto a una ipersfera, oggetto della geometria di Riemann adottato da Einstein per descrivere l’universo nella relatività generale ». Su questa intuizione tornano recentemente anche due fisici italiani, Marco Bersanelli, nel suo Il grande spettacolo del cielo (Sperling & Kupfer 2016) e Carlo Rovelli in Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza ( Corriere della Sera 2018), che loda la «straordinaria intelligenza, anche matematico-scientifica» di Dante.
Questa ipotesi in verità ha una storia lunga e viene fatta risalire al matematico svizzero Andreas Speiser, che ne scrisse nel 1925, ripreso appunto poi da Mark Peterson, dall’astrofisico svizzero Bruno Binggeli e infine da Patapievici. Per altro già nel 1922 Pavel Florenskji in un breve e densissimo scritto, Gli immaginari in geometria, aveva sostenuto, a partire dalla “piroetta” effettuata dal Dante-personaggio in If XXXIV al centro della terra, che la concezione dello spazio della Commedia è abbordabile solo con il sostegno teorico della relatività einsteiniana e della geometria non-euclidea. Per concludere sorprendentemente: «Squarciando il tempo, dunque, la Divina Commedia finisce inaspettatamente per trovarsi non indietro, ma avanti rispetto alla scienza nostra contemporanea ».
 Eppure forse il punto è un altro, anche se le riletture della fisica e della matematica contemporanee sono importanti, e certo da approfondire in uno studio esaustivo. Perché Dante ragiona da un mythos diverso dal nostro e le sue “preveggenze” gli vengono da una visione mistica dell’esistente. Ecco allora che il mistero divino sarà insieme imprendibile sfera e centro concentrico della realtà, contenente e contenuto, trascendente e immanente, come recitava un folgorante aforisma del medievale Libro dei XXIV filosofi: «Dio è una sfera infinita, il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo».
Eppure forse il punto è un altro, anche se le riletture della fisica e della matematica contemporanee sono importanti, e certo da approfondire in uno studio esaustivo. Perché Dante ragiona da un mythos diverso dal nostro e le sue “preveggenze” gli vengono da una visione mistica dell’esistente. Ecco allora che il mistero divino sarà insieme imprendibile sfera e centro concentrico della realtà, contenente e contenuto, trascendente e immanente, come recitava un folgorante aforisma del medievale Libro dei XXIV filosofi: «Dio è una sfera infinita, il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo».La fisica contemporanea vi intravede un’iper-sfera. Sia. Per Dante la posta in gioco però è forse ancora più complessa: non solo ravvisare in tutto ciò il mistero divino, ma comprendere come la trinità Dio(Mistero)-Uomo-Cosmo sia in una relazione costitutiva e rappresenti tutta la realtà: non Dio, l’Uomo o il Cosmo da soli.
 Potremmo ricordarci allora l’intuizione cosmoteandrica (cosmo-dio-mondo) del filosofo e teologo indocatalano Raimon Panikkar, che parlava anche di teofisica, «non tanto come “fisica di Dio”, ma come “del Dio della Fisica”, del Dio creatore del mondo, dove il mondo non è sentito in quanto autonomo, indipendente e diviso da Dio, ma costitutivamente connesso a Lui». L’ardore di Dante è stato quello di provare a tenere insieme queste dimensioni della realtà - misteriosa, umana e materiale - con tutti i saperi che aveva a disposizione, anche fallaci, limitati, scientificamente. È questo che ci attende oggi: mantenere viva e prolungare la tensione dantesca, aggiornandola all’altezza dei tempi. E le potenti preveggenze del Poeta sembrano guidarci, perché «poca favilla gran fiamma seconda».
Potremmo ricordarci allora l’intuizione cosmoteandrica (cosmo-dio-mondo) del filosofo e teologo indocatalano Raimon Panikkar, che parlava anche di teofisica, «non tanto come “fisica di Dio”, ma come “del Dio della Fisica”, del Dio creatore del mondo, dove il mondo non è sentito in quanto autonomo, indipendente e diviso da Dio, ma costitutivamente connesso a Lui». L’ardore di Dante è stato quello di provare a tenere insieme queste dimensioni della realtà - misteriosa, umana e materiale - con tutti i saperi che aveva a disposizione, anche fallaci, limitati, scientificamente. È questo che ci attende oggi: mantenere viva e prolungare la tensione dantesca, aggiornandola all’altezza dei tempi. E le potenti preveggenze del Poeta sembrano guidarci, perché «poca favilla gran fiamma seconda».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’INCARNAZIONE AL DI LA’ DELL’ IMMAGINAZIONE "TE-ANDRICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO: DANTE ALIGHIERI (1265-1321)!!! LA LINGUA D’AMORE: UNA NUOVA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. Ipotesi di rilettura della "Divina Commedia".
- LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
FLS
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA LEZIONE DI QUINE E DI NOZICK: "CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO" (di Antonio Rainone).17 dicembre 2019, di Federico La Sala
USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO. Amore (Charitas) o Mammona (Caritas)?! Il "principle of charity", il «principio di carità» ("caritas"!), un assunzione di tipo «imperialistico» (Robert Nozick, "The Nature of Rationality", 1993) *
CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO.
di Antonio Rainone *
- 3.Linguaggio ed empatia in W. V. Quine
Carità o empatia?
Esiste una tematica nella filosofia del linguaggio e nell’epistemologia di W. V. Quine che può apparire per molti versi atipica o sorprendente a chi abbia del celebre filosofo statunitense un’immagine limitata alle sue concezioni fisicalistiche e comportamentistiche, per non dire “scientistiche”, non di rado considerate le più caratteristiche della sua produzione filosofica. Si tratta della tematica dell’empatia, cioè della capacità di avanzare spiegazioni o interpretazioni del comportamento (linguistico e non) di altri soggetti “mettendosi nei loro panni” o “simulandone” la situazione cognitiva o, ancora, assumendone immaginativamente il ruolo.
 L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.
L’empatia - anche indipendentemente
da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione
nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a
un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con
la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori
sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione
a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object
(1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione
più tarda.A partire dagli anni Settanta, ma più esplicitamente negli anni Novanta, Quine ha considerato il metodo dell’empatia come il metodo fondamentale di traduzione nel celebre Gedankenexperiment della traduzione radicale (ovvero la traduzione di una lingua completamente sconosciuta), ma anche come una capacità naturale ai fini dell’acquisizione del linguaggio e dell’attribuzione di stati mentali intenzionali (ossia percezioni, credenze, desideri ecc.) ad altri. In effetti, l’empatia ha acquisito un rilievo così crescente in Quine che nei suoi due ultimi lavori sistematici, Pursuit of Truth (1992) e From Stimulus to Science (1995), essa appare come un nucleo centrale della sua filosofia del linguaggio e della mente.
È stato del resto lo stesso Quine a sottolineare la rilevanza dell’empatia nella sua filosofia del linguaggio, “retrodatandone”, per così dire, la teorizzazione agli anni Cinquanta. Così Quine si esprime in uno dei suoi ultimi interventi sulla questione:
- Il mio uso della parola “empatia” è piuttosto recente ed è stato notato, ma io avevo già riconosciuto che l’approccio del traduttore radicale è di tipo empatico in Word and Object e, in realtà, già nove anni prima. «Il lessicografo - avevo scritto - dipende [...] da una proiezione di sé stesso, con la sua Weltanschauung indo-europea, nei sandali del suo informatore Kalaba» (Quine, 2000, p. 410).
Il brano qui citato da Quine, ripreso dall’importante The Problem of Meaning in Linguistics (1951b, p. 63) - una notevole anticipazione della problematica della traduzione radicale - non è privo di una certa ambiguità, prestandosi a una duplice lettura. È forse vero che in Word and Object alcune affermazioni di Quine potrebbero essere interpretate come la proposta di un metodo empatico, sostenuto comunque in modo non del tutto esplicito (cfr. Rainone, 1995), ma possono essere avanzati dei dubbi circa la difesa di tale metodo nel saggio del 1951. Se da un lato il concetto di proiezione sembra proporre il metodo dell’empatia nell’attività di traduzione di una lingua completamente sconosciuta da parte di un etnolinguista, dall’altro sembra in effetti riferirsi non tanto al metodo empatico, quanto, piuttosto, a quello che, grazie allo stesso Quine, e in seguito a Donald Davidson (cfr. Davidson, 1984), sarebbe diventato noto come «principio di carità» (principle of charity). Il linguista - asseriva infatti Quine - proietta sé stesso con la sua Weltanschauung nei panni del nativo che usa una lingua sconosciuta, presupponendo (o ipotizzando) così che il suo informatore si conformi ai suoi principi logici e abbia le sue stesse credenze (ritenute vere) riguardo alla realtà (sono questi, grosso modo, i principali tenet del principio di carità, che presuppone una comune natura razionale tra interprete/ traduttore e interpretato/parlante).
In Word and Object Quine avrebbe esplicitamente utilizzato - e teorizzato - il principio di carità riguardo alla traduzione dei connettivi logici e degli enunciati “ovvi”. L’esempio più pertinente, in merito, è rappresentato dal «caso estremo» di qualche nativo che accetti come veri enunciati traducibili nella forma “p e non-p” (per esempio, “piove e non piove”), una forma enunciativa che, violando il principio di non contraddizione, deporrebbe per Quine non a favore dell’irrazionalità dei parlanti - come riteneva Lévy-Bruhl con la sua teoria della «mentalità prelogica» - ma contro la correttezza della traduzione (Quine, 1960, p. 58).
Il medesimo argomento varrebbe inoltre per la traduzione di enunciati ovvi: una risposta negativa da parte del nativo alla domanda (nella lingua nativa) “sta piovendo?” fatta sotto la pioggia costituirebbe una prova di cattiva traduzione nella lingua nativa, non del fatto che il nativo non condivida con il traduttore la credenza in qualcosa di così evidente. In generale, nota Quine in un famoso passo di Word and Object, «quanto più assurde o esotiche sono le credenze attribuite a una persona tanto più sospetti abbiamo il diritto di essere nei confronti delle traduzioni; il mito dei popoli prelogici segna solo il caso estremo» (ivi, p. 68).
Difficilmente, pertanto, la «proiezione» del linguista nei «sandali» del nativo di cui Quine parlava nel saggio del 1951 potrebbe apparire come una forma di metodo empatico, dal momento che essa “imporrebbe” al nativo uno «schema concettuale» (quello del linguista) che, per quanto il linguista può saperne, potrebbe essergli del tutto estraneo. Questo è, in fondo, il problema sottostante a tutto il celebre secondo capitolo di Word and Object3. Non vi sarebbe alcuna garanzia, infatti, secondo Quine, che i nativi condividano lo stesso schema concettuale (la stessa Weltanschauung) del linguista. Ma il linguista non può, d’altro canto, che fare affidamento sul proprio linguaggio (o schema concettuale), data la scarsa evidenza empirica di cui dispone nel tradurre la lingua sconosciuta. Basarsi sul proprio schema concettuale, proiettandolo sul «linguaggio della giungla», è una necessità pratica, che - asseriva Quine in Word and Object - investirebbe soprattutto l’elaborazione delle «ipotesi analitiche», ovvero le ipotetiche correlazioni tra le emissioni verbali olofrastiche dei nativi e le loro possibili traduzioni mediante cui il linguista deve stabilire quali frammenti di enunciati andranno considerati termini (singolari e generali), quali congiunzioni, quali articoli, quali desinenze per il plurale e quali pronomi, sulla cui base individuare un insieme plausibile di credenze ontologiche ed epistemiche. La scelta delle ipotesi analitiche, infatti, non è altro che un modo di «catapultarsi nel linguaggio della giungla utilizzando i propri modelli linguistici » (ivi, p. 70).
 Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.
Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione
del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative
bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili
sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa
a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i
nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare
i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.Utilizzare i modelli del proprio linguaggio per tradurre un linguaggio alieno non equivale quindi ad applicare un metodo empatico di comprensione, trattandosi al massimo di un’ulteriore e più ampia applicazione del principio di carità. L’empatia sembra in realtà qualcosa di diverso dalla carità: a differenza di quest’ultima, l’empatia non presuppone necessariamente una condivisione di significati e stati cognitivi (credenze). Forse l’assunzione di un’analogia di stati cognitivi tra interprete e interpretato - il «ritrovamento dell’io nel tu», secondo la celebre formula di Wilhelm Dilthey (1927, trad. it. p. 293) - può apparire inevitabile ed efficace riguardo alle risposte verbali fenomenologiche direttamente connesse a stimolazioni elementari provenienti da eventi osservativi intersoggettivi del mondo esterno (la pioggia, il colore rosso, il caldo e il freddo ecc.): ci si aspetta infatti che i nativi, che presentano una conformazione neurofisiologica e neuropsicologica analoga alla nostra, non abbiano percezioni di tipo diverso dalle nostre, rispondendo linguisticamente a tali percezioni in modo analogo a come risponderemmo noi; in tal caso l’empatia sembrerebbe indistinguibile dalla carità interpretativa, in quanto fondata sull’assunzione dell’esistenza di meccanismi percettivi comuni ai soggetti coinvolti. Ma difficilmente tale analogia potrebbe essere presupposta allorché si tratti di tradurre il linguaggio o spiegare il comportamento di soggetti appartenenti a una cultura del tutto estranea a quella dell’interprete. In questo caso l’interprete dovrà in qualche modo “entrare”, per così dire, nella “mente” dei soggetti da interpretare per comprendere il loro peculiare punto di vista, le loro credenze sulla realtà e i significati delle loro parole.
In definitiva, la differenza tra carità ed empatia può essere intesa come la differenza tra imporre il proprio punto di vista all’altro e assumere il punto di vista dell’altro. La differenza è particolarmente rilevante nei casi di interpretazione di soggetti appartenenti a “mondi” radicalmente diversi da quello dell’interprete. Se così non fosse, difficilmente gli etnoantropologi avrebbero potuto attribuire credenze animistiche o culti religiosi atipici (come i celebri cargo cults) alle popolazioni studiate (in entrambi i casi si dovrebbe trattare, secondo un’interpretazione caritatevole, di errori di traduzione o interpretazione).
Non dovrebbe costituire motivo di sorpresa, allora, che David K. Lewis, in un saggio dedicato alla problematica davidsoniana dell’«interpretazione radicale», avesse dato una definizione del principio di carità che ingloba, per così dire, anche il procedimento empatico: un soggetto di interpretazione, asseriva Lewis, «dovrebbe credere ciò che crediamo noi, o forse ciò che avremmo creduto noi al suo posto; e dovrebbe desiderare ciò che desideriamo noi, o forse ciò che avremmo desiderato noi al suo posto» (Lewis, 1974, p. 336; corsivi aggiunti). In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.
Ma forse c’è ancora qualcosa da dire: mentre la carità impone dei vincoli normativi sulla razionalità dei soggetti da interpretare - vincoli a priori basati sui principi logici e sulle norme di razionalità epistemica e pratica dell’interprete, ritenuti universali 4 -, l’empatia sembrerebbe invece un metodo descrittivo ed empirico, essendo subordinata all’acquisizione di un’ampia gamma di informazioni relative alle credenze, alla cultura e alle esperienze passate dei soggetti da interpretare (inutile aggiungere che non c’è accordo su quest’ultimo punto).
4. Si può ricordare, riguardo a questa presunta universalità, che Robert Nozick ha contestato il principio di carità in quanto assunzione di tipo «imperialistico», conferendo tale principio «un peso indebito alla posizione che accade di occupare a noi, alle nostre credenze e alle nostre preferenze» (Nozick, 1993, p. 153). Giustamente, Nozick fa notare che difficilmente questa sarebbe l’assunzione di un antropologo relativamente alle cosiddette società “primitive” (ivi, p. 154).
* Cfr. Antonio Rainone, "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia", Carocci editore, Roma, 2019, pp. 55-59, ripresa parziale.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA LEZIONE DI NOZICK. Trovo più congeniali Nozick e quei tentativi «bayesiani» di ricondurre il fenomeno dell’empatia in un ambito empirico e razionale (A. Pagnini).26 gennaio 2020, di Federico La Sala
EMPATIA. Cosa significa adottare il punto di vista altrui? Due approcci complementari ce lo spiegano
METTETEVI UN PO’ NEI MIEI PANNI
di Alessandro Pagnini *
- Laura Boella, «Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia», Cortina, Milano, 2006, pagg. 120, euro 11,50.
- Antonio Rainone, «La riscoperta dell’empatia», Bibliopolis, Napoli, 2006, pagg. 236, euro 24.
Due libri sull’empatia usciti quasi contemporaneamente, di Laura Boella e Antonio Rainone, testimoniano quella che i due autori considerano una vera e propria attuale rinascita di interesse per il tema. L’empatia è una forma di comprensione, come indicava Dilthey, fondata sull’affinità ontologica e psicologica di soggetto e oggetto, che avviene in una sorta di immedesimazione, di proiezione immaginativa, in cui «io» e «tu» entrano in un sottile gioco di condivisione, anche emotiva, di esperienze e di idee.
Il significato del termine non è mai stato univoco, per cui ha ragione Boella ad avvertirci di non confondere l’empatia con l’amore, con la compassione, con la simpatia, mentre sembra più proficuo riportarla nell’alveo naturale del suo battesimo «tecnico»: da una parte, quello del «dibattito sul metodo» in psicologia e in ambito storicistico (su cui insiste di più Rainone), dall’altra, quello del «sentire l’altro» in un’etica che sia sensibile alla lezione della fenomenologia di Heidegger e di Levinas (Boella).
Rainone, da parte sua, dà maggior risalto al modo del tutto peculiare in cui il dibattito sul verstehen è penetrato nel neopositivismo e nella filosofia analitica, fino a leggere originalmente la «riscoperta» dell’empatia dove meno è trasparente: nella tesi del «comportamentista» Quine su come concepire le attribuzioni intenzionali (le attribuzioni ad altri di credenze e desideri) e su come risolvere il problema della «traduzione radicale» di un linguaggio alieno; e quindi nelle tesi, particolarmente rilevanti, di Putnam e Nozick, tra chiarimenti intorno al cosiddetto «principio di carità» e teorie del contenuto concettuale e della razionalità nell’azione.
 Alla fine, Rainone condivide l’interesse di molti filosofi anche per alcune teorie sperimentali sullo sviluppo ontogenetico della psicologia ingenua dette del mindreading ; dove alla «teoria della teoria», che postula il possesso da parte degli esseri umani di una "teoria" implicita (su basi innatistiche) che ci consente di interpretare il comportamento e il linguaggio altrui (noi congetturiamo su quello che vuol dire e fare l’altro esattamente come lo scienziato predice l’occorrenza di un evento), si contrappone la «teoria della simulazione», che postula la simulazione, talora letta in chiave di inferenza analogica, come procedimento di base che soddisfa quella funzione.
Alla fine, Rainone condivide l’interesse di molti filosofi anche per alcune teorie sperimentali sullo sviluppo ontogenetico della psicologia ingenua dette del mindreading ; dove alla «teoria della teoria», che postula il possesso da parte degli esseri umani di una "teoria" implicita (su basi innatistiche) che ci consente di interpretare il comportamento e il linguaggio altrui (noi congetturiamo su quello che vuol dire e fare l’altro esattamente come lo scienziato predice l’occorrenza di un evento), si contrappone la «teoria della simulazione», che postula la simulazione, talora letta in chiave di inferenza analogica, come procedimento di base che soddisfa quella funzione.La storia che ci racconta Rainone parte da Dilthey e Collingwood per arrivare a Davidson, ai neowittgensteiniani e ai dibattiti più recenti in filosofia della mente e in epistemologia (soprattutto quella «affidabilista» e quella ingaggiata nei problemi controversi di una sua «naturalizzazione»). La storia che richiama Boella, per approdare a considerazioni soprattutto etiche, parte invece da quell’empatia che Husserl definiva un «enigma... oscuro e... tormentoso», e passa poi per Scheler e soprattutto per la Edith Stein (filosofi cari all’autrice), con la quale è condiviso il senso della necessaria attenzione per l’empatia: «Osservare e descrivere il fondamento originario del nostro esistere insieme agli altri».
Le due trattazioni sono palesemente molto diverse, al punto di non avere, assai sorprendentemente, neppure un minimo di riferimenti bibliografici in comune. La trattazione di Rainone informa in dettaglio, con una opportuna attenzione alla sequenza storica delle posizioni, sui contenuti di un dibattito che si è andato trasformando nel tempo soprattutto per la sua spesso essenziale contiguità con gli esiti delle scienze (da quelle psicologiche cognitive a quelle biologico-evoluzionistiche e neurofisiologiche), fino a cogliere la rilevanza della recente scoperta dei «neuroni specchio» per la teoria della simulazione (i «processi simulativi sarebbero una sorta di software attivato a livello cerebrale»). La trattazione della Boella è invece più improntata a descrizione fenomenologica a partire dalla nostra esperienza quotidiana, più attenta alle modulazioni dei rapporti vissuti tra corpo, emozioni e mente, ed è più concentrata sul significato morale del "praticare" l’empatia. Boella, con una scrittura adatta a cogliere la grana fine dell’esperienza concreta, creativa nelle metafore e nelle suggestioni, mutua più dalla letteratura (preziosa alleata sin dalle epigrafi) che non dalla scienza. Era stato Milan Kundera, del resto, a cogliere opportunamente come la letteratura (il romanzo) avesse nella modernità ereditato quella «passione del conoscere» di cui parlava Husserl, scrutando la vita concreta dell’uomo, tenendo il «mondo della vita» sotto una luce perpetua, senza incorrere nell’«oblio dell’essere».
Sono anch’io convinto, senza condividere quelle premesse filosofiche, che la letteratura ci insegni molto, soprattutto sull’empatia. Sicuramente più di quanto la più fantasiosa delle filosofie contempli (basterebbero le pagine strordinarie, recentemente rilette da Sebald nel suo Passeggiatore solitario, in cui Robert Walser "empatizza" con un lapis, o con la cenere, per lo sconcerto di qualsiasi teoria, sia essa epistemologica o relativa alla scoperta dei valori etici). Ma personalmente non inclino alle filosofie che rivaleggiano con la letteratura (preferisco la letteratura), prediligo (pace Heidegger) le filosofie "rigorose" a quelle "serie", non amo quelle che indulgono agli enigmi o alle magiche congiunzioni di anime.
 E così, in tutto il materiale che questi due bei libri ci mettono a disposizione, trovo più congeniali Nozick e quei tentativi «bayesiani» di ricondurre il fenomeno dell’empatia in un ambito empirico e razionale (tentativo altrove riuscito anche per quella particolare forma di empatia che è, per certi versi, l’abduzione, o l’«occhio clinico», o la metis rivista in chiave di abilità «indiziaria»). Raccomandando però, con sincero spirito bipartisan, la lettura di tutt’e due.
E così, in tutto il materiale che questi due bei libri ci mettono a disposizione, trovo più congeniali Nozick e quei tentativi «bayesiani» di ricondurre il fenomeno dell’empatia in un ambito empirico e razionale (tentativo altrove riuscito anche per quella particolare forma di empatia che è, per certi versi, l’abduzione, o l’«occhio clinico», o la metis rivista in chiave di abilità «indiziaria»). Raccomandando però, con sincero spirito bipartisan, la lettura di tutt’e due.*Il Sole-24 Ore, 09.07.2006 (ripresa parziale - senza foto).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- STORIA E PROFEZIA. La parola della profetessa Hulda e i "vestiti dell’Imperatore": «Dì all’uomo che ti ha mandato a me».9 dicembre 2019, di Federico La Sala
Profezia è storia /27.
È uomo il nome del re
di Luigino Bruni (Avvenire, sabato 7 dicembre 2019)
- Ma come può Giosia ignorare Geremia e inviare emissari a Hulda? I saggi risposero: Perché le donne sono più compassionevoli, e quindi sperava che ciò che avrebbe detto loro non sarebbe stato eccessivamente duro
 Talmud Megillah14b
Talmud Megillah14b
Un padre giusto e un grande miracolo non sono una garanzia che i figli continueranno a scrivere una storia giusta e buona. Dopo Ezechia, re buono e fedele che salvò Gerusalemme per la sua fede in Dio, in Giuda si susseguono due re malvagi, Manasse e Amon (2 Re 21), che riedificano gli altari agli dèi stranieri, riprendono e riattivano gli antichi culti popolari cananei che non si erano mai spenti tra la gente. Dopo la bella parentesi di Ezechia, ritorna l’idolatria, l’antica malattia di Israele - e di tutti gli uomini, che sono costruttori infaticabili di idoli per divenirne adoratori: siamo consumatori di molte merci, ma prima e sopra tutto siamo consumatori di idoli.
Nel ciclo dell’alternanza del bene e del male, dopo Amon arriva Giosia, il nuovo Davide, amatissimo dalla Bibbia almeno quanto il suo avo Ezechia: «Quando divenne re, Giosia aveva otto anni; regnò trentun anni a Gerusalemme... Fece ciò che è retto agli occhi di YHWH» (2 Re 22, 1-2).
 Giosia si presenta come un restauratore del tempio. Il testo descrive i lavori con parole molto simili a quelle che il capitolo 12 aveva utilizzato per i restauri del re Ioas. Di nuovo l’argento, raccolto dai "custodi della soglia" viene fuso, trasformato in monete e consegnato ai carpentieri e ai muratori. La descrizione della fabbrica del tempio si chiude con le stesse parole usate per il restauro di Ioas: «Non si controlli il denaro consegnato nelle loro mani, perché lavorano con onestà» (22, 7). -Le parole buone sull’onestà e sulla lealtà dei lavoratori non si devono mai tacere, soprattutto quando le incontriamo nella Bibbia; e soprattutto oggi, quando prima dei posti di lavoro abbiamo bisogno di parole buone sui lavoratori, di benedizioni del lavoro, senza le quali i posti di lavoro non ci sono o sono cattivi.
Giosia si presenta come un restauratore del tempio. Il testo descrive i lavori con parole molto simili a quelle che il capitolo 12 aveva utilizzato per i restauri del re Ioas. Di nuovo l’argento, raccolto dai "custodi della soglia" viene fuso, trasformato in monete e consegnato ai carpentieri e ai muratori. La descrizione della fabbrica del tempio si chiude con le stesse parole usate per il restauro di Ioas: «Non si controlli il denaro consegnato nelle loro mani, perché lavorano con onestà» (22, 7). -Le parole buone sull’onestà e sulla lealtà dei lavoratori non si devono mai tacere, soprattutto quando le incontriamo nella Bibbia; e soprattutto oggi, quando prima dei posti di lavoro abbiamo bisogno di parole buone sui lavoratori, di benedizioni del lavoro, senza le quali i posti di lavoro non ci sono o sono cattivi.I lavori di restauro producono uno degli eventi più importanti della Bibbia: da quel cantiere emerge un libro: «Il sommo sacerdote Chelkia disse allo scriba Safan: "Ho trovato nel tempio di YHWH il libro della Legge (Sefer hat Torà)"» (22, 8). Un ritrovamento eccezionale. Non sappiamo quanto ci sia di storico in questa scoperta, essendo comune nella letteratura antica coeva poggiare una riforma religiosa sul ritrovamento di un testo, reale o immaginario, che diventava mito fondativo della nuova età. Si è scritto molto su questo ritrovamento. Per alcuni storici quel libro era una prima versione di quello oggi conosciuto come libro del Deuteronomio, o di quella sua parte che contiene la Legge di Mosè (Torà). Un muratore, o forse un gruppo di teologi, ritrovò nel tempio o nel mito una fondazione più antica della loro fede, su cui un gruppo di riformatori, in un tempo di corruzione religiosa fondò la sua riforma.
Non è raro che la minoranza profetica che vuole una riforma radicale basi la sua azione su qualcosa di più antico, perché in quell’antico c’è qualcosa di puro e genuino che nel tempo si è contaminato ed è decaduto. Qualche volta questo "qualcosa" è una tradizione dimenticata, alcune parole del fondatore cancellate dal tempo; altre volte è un testo, un libro, una lettera, un "vangelo" smarrito o considerato dai più apocrifo, che invece, per i riformatori, conteneva un messaggio autentico.
 Nel mondo antico, inclusa la Bibbia, ciò che era più antico era anche più vero. In quella cultura c’era la convinzione che l’inizio contenesse il principio ideale, che lì vi fosse la promessa prima che arrivassero i nostri compromessi, il patto prima delle nostre infedeltà. C’era la certezza che per uscire dalla crisi del presente la principale e forse unica risorsa fosse un passato diverso, quella terra incontaminata e ancora fertile per generare futuro - «in principio non era così». Come quando, precipitati dentro un orizzonte accorciato e abbuiato, sentiamo che per ridonare nuova vita al nostro rapporto dobbiamo tornare ai giorni del primo amore, a quelle parole diverse capaci di pronunciare una speranza infinita. Capiamo che dobbiamo provare a rivedere il cuore dell’altro e il nostro come lo abbiamo conosciuto in quel primo patto, e poi fare in modo che quel passato risusciti il presente che appare morto.
Nel mondo antico, inclusa la Bibbia, ciò che era più antico era anche più vero. In quella cultura c’era la convinzione che l’inizio contenesse il principio ideale, che lì vi fosse la promessa prima che arrivassero i nostri compromessi, il patto prima delle nostre infedeltà. C’era la certezza che per uscire dalla crisi del presente la principale e forse unica risorsa fosse un passato diverso, quella terra incontaminata e ancora fertile per generare futuro - «in principio non era così». Come quando, precipitati dentro un orizzonte accorciato e abbuiato, sentiamo che per ridonare nuova vita al nostro rapporto dobbiamo tornare ai giorni del primo amore, a quelle parole diverse capaci di pronunciare una speranza infinita. Capiamo che dobbiamo provare a rivedere il cuore dell’altro e il nostro come lo abbiamo conosciuto in quel primo patto, e poi fare in modo che quel passato risusciti il presente che appare morto.
 Non è nostalgia, è il suo opposto: nella Bibbia si chiama memoria. In questi atti non si guarda indietro, si guarda solo avanti. Come Mosè, che dal Monte Nebo non guardava l’Egitto ma il Giordano. A volte quel testo antico lo si ritrova davvero dentro un "restauro" di un’opera, emerge come dono da un lavoro sulle fondamenta. Altre volte il libro si "crea’", nasce dall’ascolto del dolore della gente. La storia può essere "prodotta" oggi da un amore più grande, perché il libro può essere generato dalla carne e dal sangue di chi crede che quell’origine non sia persa per sempre e può risorgere. Le identità, individuali e collettive, sono sempre creazioni del presente, anche quando partono dal passato.
Non è nostalgia, è il suo opposto: nella Bibbia si chiama memoria. In questi atti non si guarda indietro, si guarda solo avanti. Come Mosè, che dal Monte Nebo non guardava l’Egitto ma il Giordano. A volte quel testo antico lo si ritrova davvero dentro un "restauro" di un’opera, emerge come dono da un lavoro sulle fondamenta. Altre volte il libro si "crea’", nasce dall’ascolto del dolore della gente. La storia può essere "prodotta" oggi da un amore più grande, perché il libro può essere generato dalla carne e dal sangue di chi crede che quell’origine non sia persa per sempre e può risorgere. Le identità, individuali e collettive, sono sempre creazioni del presente, anche quando partono dal passato.Il re giusto Giosia partì dal ritrovamento di un libro antico, e riformò il culto: distrusse gli altari pagani che popolavano la sua regione, eliminò dal tempio i prostituti sacri, cacciò i sacerdoti cananei, distrusse anche l’antico altare sacro di Betel (23, 4-14). Inoltre «Giosia rese impuro il Tofet, che si trovava nella valle di Ben-Innòm, perché nessuno vi facesse passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco in onore di Moloc» (23, 10). Ogni buona riforma comincia non uccidendo più i bambini, smettendo di passarli per il fuoco per offrirli ai vari Moloc.
La riforma di Giosia fu un passaggio essenziale nella storia della salvezza. Perché segnò il passaggio dal tempio al libro, che divenne centro e "luogo" della fede. Un’operazione che si rivelò decisiva per il tempo dell’esilio che presto sarebbe arrivato. Israele riuscì a sopravvivere settant’anni senza tempio, perché Giosia e quella scuola di scribi e sacerdoti avevano spostato l’asse dal tempio al libro.
 La Torà divenne il tempio mobile, la nuova Arca dell’alleanza che seguiva la carovana nel mondo e nel tempo, nelle mille diaspore e distruzioni. Quella distruzione di Giosia divenne la possibilità di conservare la fede dentro altre distruzioni devastanti e totali.
La Torà divenne il tempio mobile, la nuova Arca dell’alleanza che seguiva la carovana nel mondo e nel tempo, nelle mille diaspore e distruzioni. Quella distruzione di Giosia divenne la possibilità di conservare la fede dentro altre distruzioni devastanti e totali.Colpisce in questi versetti la forza della distruzione creatrice di Giosia: «Il re comandò... di portare fuori dal tempio tutti gli oggetti fatti in onore di Baal, di Asera e di tutto l’esercito del cielo... Destituì i sacerdoti creati dai re di Giuda per offrire incenso sulle alture... e quanti offrivano incenso a Baal, al sole e alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l’esercito del cielo» (23, 4-5). Senza il coraggio della distruzione non si porta a termine nessuna riforma seria, perché la corruzione consiste quasi sempre nell’accumulo - progressivo, continuo, non intenzionale - di cose, idee-ideologie-idoli, pratiche, tradizioni, che entrano poco a poco nel "tempio" della città e dell’anima; e così quel luogo nel quale all’inizio c’era "soltanto una voce", quella nudità parlante di infinito dove avevamo un giorno toccato il cielo, viene riempita di manufatti, fino a rendere impercettibile il suono della prima voce. Ma lo sgombero dei locali è molto costoso - noi e i nostri amici ci affezioniamo troppo ai manufatti sacri -, e così quasi tutte le riforme falliscono per l’incapacità di sostenere il dolore della distruzione. Perché la riforma è l’operazione di svuotamento per tornare al nudo tempio, e poi pregare e sperare che la voce torni a parlare. Non sempre la voce torna, perché il tempo delle voci è spesso quello della giovinezza; ma è preferibile un tempio vuoto e muto a un tempio pieno con voci finte, perché finché lo spazio resta disabitato possiamo sempre sperare di udire in quel silenzio una voce diversa, fosse anche la voce dell’ultimo angelo.
Importante, poi, in questo capitolo fondamentale, è l’entrata in scena di una delle profetesse nominate esplicitamente nella Bibbia: Hulda (o Culda). Giosia rimane scioccato dalle parole del libro ritrovato (quelle dove si annunciano le sventure del popolo dovute alle sue infedeltà), e vuole una prova dell’autenticità di quel libro. Nella Bibbia i "certificatori" della parola vera di YHWH erano i profeti: «Il sacerdote Chelkia, insieme con Achikàm, Acbor, Safan e Asaià, si recò dalla profetessa Culda, moglie di Sallum...; essi parlarono con lei» (22, 14).
 La profetessa Hulda convalida quella parola come parola di YHWH, e profetizza che Giosia verrà risparmiato dalla distruzione di Gerusalemme. Hulda profetizza con parole molto simili a quelle di Geremia, che invece qui non viene nominato, sebbene in quel periodo (attorno al 620-622) fosse già attivo in città.
La profetessa Hulda convalida quella parola come parola di YHWH, e profetizza che Giosia verrà risparmiato dalla distruzione di Gerusalemme. Hulda profetizza con parole molto simili a quelle di Geremia, che invece qui non viene nominato, sebbene in quel periodo (attorno al 620-622) fosse già attivo in città.Perché viene consultata una profetessa, una donna, e per un parere di estrema importanza? Una domanda che si sono fatti in molti, già nei tempi antichi, ipotizzando qualche risposta. Non abbiamo dalla Bibbia molti altri elementi su Hulda. Da Ezechiele sappiamo dell’attività di profetesse in Gerusalemme, da lui condannate per aver «disonorato YHWH» (Ez 13, 19). Secondo alcuni studiosi è possibile che in quel tempo difficile del pre-esilio e poi dell’esilio vi fosse un conflitto tra profeti, e Hulda fosse stata esclusa dalla narrazione ufficiale in quanto sconfitta da profeti più potenti e famosi. -Secondo un recente e controverso studio di Preston Kavanagh (Huldah: The Prophet Who Wrote Hebrew Scripture, 2012), Hulda fu invece una figura fondamentale nella Bibbia (addirittura scrisse o influenzò un terzo delle scritture ebraiche). Il suo nome, anagrammato, comparirebbe 1.773 volte nella Bibbia, poiché, secondo Kavanagh, gli «scrittori biblici usavano l’anagramma come gli scrittori moderni usano il corsivo per sottolineare un punto» (p.12). Una tesi estrema, difficilmente difendibile (es: i nomi biblici che nella Bibbia si possono formare come anagramma di Huldah sono molti), che comunque ci ricorda l’importanza delle profetesse e delle donne nell’umanesimo biblico; un’importanza che fu maggiore di quello, già notevole, che la Bibbia attesta. Perché tutti sappiamo che c’è una grande affinità tra donna e profezia.
Hulda in ebraico significa donnola (o martora), nome che, secondo il Talmud, si meritò per avere osato chiamare il re semplicemente "uomo" («Dì all’uomo che ti ha mandato a me»; 22, 15).
 Le profetesse riescono a chiamare i re per nome. Le donne, più dei maschi, sanno che i potenti sono uomini, come tutti. Lo ricordano a loro, lo ricordano a noi, a partire dalle mure domestiche. È questo un dono immenso per i potenti e per tutti. Dono delle donne, dono delle profetesse, dono della profezia. Senza profezia i capi fanno i re sempre e ovunque. Non sperimentano mai la reciprocità tra uguali, quindi non conoscono la felicità. Vivono tristi nella loro solitudine dorata, circondati da adulatori e ruffiani. E alla lunga, non riuscendo a essere uomini come tutti, diventano disumani. Anche per questo la profezia è risorsa essenziale della terra.
Le profetesse riescono a chiamare i re per nome. Le donne, più dei maschi, sanno che i potenti sono uomini, come tutti. Lo ricordano a loro, lo ricordano a noi, a partire dalle mure domestiche. È questo un dono immenso per i potenti e per tutti. Dono delle donne, dono delle profetesse, dono della profezia. Senza profezia i capi fanno i re sempre e ovunque. Non sperimentano mai la reciprocità tra uguali, quindi non conoscono la felicità. Vivono tristi nella loro solitudine dorata, circondati da adulatori e ruffiani. E alla lunga, non riuscendo a essere uomini come tutti, diventano disumani. Anche per questo la profezia è risorsa essenziale della terra. - Ma come può Giosia ignorare Geremia e inviare emissari a Hulda? I saggi risposero: Perché le donne sono più compassionevoli, e quindi sperava che ciò che avrebbe detto loro non sarebbe stato eccessivamente duro
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?!6 dicembre 2019, di Federico La Sala
VERSO "BARI 2020", "NICEA 2025": MESSAGGIO EVANGELICO, FILOLOGIA, ED ECUMENISMO. Quale "carità" (Kapitas o Xapitas, caritas o charitas)?! *
Nicola. Protettore del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente
di Matteo Liut (Avvenire, giovedì 6 dicembre 2018)
La carità è il "miracolo" più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313.
Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
 Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
Altri santi. Santa Asella di Roma, vergine (IV sec.); san Pietro Pascasio, vescovo e martire (1227-1300).
 Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Letture. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
 Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
Ambrosiano. Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12.
*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
Commenti a Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE, OGGI: INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA", IL FEMMINISMO, E LA "SCONFITTA" DELLA PSICOANALISI.3 dicembre 2019, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA": L’ ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO...
Psicoanalisi e femminismodi Luisa Muraro e Lucetta Scaraffia *
Su Sette Corriere della sera del 22 novembre 2019 è apparso un articolo di Lucetta Scaraffia, Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi, chiarissimo in quello che dice. Potete leggerlo qui di seguito. È un testo di notevole interesse perché attira l’attenzione e fa luce sulla parte avuta dalla psicoanalisi nella rivoluzione femminista del ventesimo secolo. L’autrice finisce con un punto di domanda, giustamente, e invita così ad approfondire l’argomento.
Per parte mia ci tengo a dire che la “sconfitta” della psicoanalisi avviene su un antico campo di battaglia, quello dell’autorità della parola, autorità negata alle donne dal regime patriarcale, e campo di battaglia dalle donne tenacemente tenuto aperto attraverso i secoli. Parlo dell’isteria. Dedicandosi alla cura dell’isteria, Freud ha avuto il merito innegabile di essere entrato nel campo di battaglia e di sbagliare, sì, ma in un modo significativo: è il suo inconscio che lo fa sbagliare e lui finisce che se ne accorge. Se possiamo fare festa per la fine del discredito patriarcale e l’affermarsi di autorità femminile nella vita pubblica, qualcosa dobbiamo anche a lui. A sua volta, lui deve qualcosa, o molto, all’umanità femminile. (Luisa Muraro)
Corriere della sera - Sette, 22 novembre 2019
Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi
di Lucetta Scaraffia *
Quando Ida ha acconsentito alla richiesta del padre, che voleva far curare da Freud i suoi strani disturbi (afonia, svenimenti, tosse continua), la ragazza sperava che il dottore avrebbe creduto alle sue parole, convincendo così anche suo padre che l’amico di famiglia Hanss Zellenka l’aveva molestata con insistenza e pesantemente, per mesi, suscitandole profondo turbamento e paura. Le molestie erano cominciate quando aveva solo tredici anni, e lei si era trovata invischiata in una situazione angosciosa: le vacanze con la famiglia Zellenka sul lago di Garda - dove la madre Pepina l’aveva accolta con un affetto e una simpatia che le mancavano in casa - nascondevano un segreto imbarazzante.
Pepina era in realtà l’amante del padre di Ida, un ricco industriale, che si era portato in vacanza la figlia per mascherare la relazione. E proprio mentre la ragazza cominciava ad accorgersene, diveniva oggetto di corteggiamenti e molestie da parte di Hanss, il marito di Pepina. È questa situazione difficile all’origine dei suoi disturbi di salute ma, come quasi tutte le giovani donne in casi analoghi, Ida ha paura di parlarne e si sente confusamente colpevole, finché un episodio più grave non la induce a raccontare tutto alla madre. Il padre, prontamente informato, convoca Hanss, il quale non solo nega indignato ma ritorce su Ida le accuse, consigliando di mandarla in cura da Freud.
Ferita dall’incomprensione paterna, Ida lo sarà ancor più dolorosamente da Freud che, dopo averla spinta a parlare, comprensivo - finalmente qualcuno la prendeva sul serio! - le aveva spiegato la sua complicata interpretazione dell’episodio. Secondo Freud le parole della ragazza rivelavano un suo amore edipico verso il padre, spostato poi su Hanss, e di conseguenza «lei non aveva affatto paura del signor Zellenka ma piuttosto di se stessa, e più precisamente della tentazione di cedere al signor Zellenka».
Ida reagisce a questa nuova cocente delusione interrompendo la cura con Freud, e proseguendo, sia pure con fatica, nella sua vita di donna che si sarebbe sposata, avrebbe avuto un figlio, avrebbe lavoratoe sarebbe scampata alla persecuzione nazista fuggendo prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, dal figlio. Una vita dura e drammatica, che racconta alla nipote, autrice della bella biografia a lei dedicata. La vita di una donna che dal rifiuto dell’interpretazione di Freud ha tratto forza e coraggio. Una posizione totalmente diversa da quella che lo stesso Freud rivela concludendo la narrazione dell’analisi: «Promisi comunque di perdonarla per avermi privato della soddisfazione di guarirla radicalmente». E se invece Ida si fosse guarita da sola rifiutando l’interpretazione di chi non considerava vere le sue parole?
Ida è Dora, la protagonista del primo caso clinico di Freud, che su questo ha costruito la sua ipotesi sulle cause dell’isteria, considerando il caso come prova chiara e convincente della sua teoria del complesso di Edipo.
Agli occhi di una donna di oggi, invece, la vicenda di Ida appare solo come la drammatica storia di una ragazza molestata che non viene creduta dagli uomini ai quali si rivolge per avere aiuto. Il padre, probabilmente anche perché segnato da sensi di colpa nei confronti di Hanss, crede a questi piuttosto che alla figlia, mentre Freud dà credito al padre, e si lascia influenzare dal desiderio di trovare nei desideri edipici rimossi la causa dell’isteria. Le malattie di Ida, invece, rivelano piuttosto la sofferenza di una donna le cui parole non vengono ascoltate né rispettate. Una donna che non viene presa sul serio, proprio come tante altre sue contemporanee - ma anche molte più vicine a noi - che non hanno visto riconosciuto il valore delle loro parole.
La biografia di Ida (scritta dalla pronipote Katharina Adler, Ida, Sellerio 2019) rovescia la storia raccontata da Freud: non si tratta della prima paziente alla quale è stata diagnosticata e curata l’isteria, ma una delle tante - troppe - donne che hanno subito due forme di violenza, quella sessuale e quella contro la loro identità perché le loro parole non vengono credute. È la storia narrata dal punto di vista delle donne, che vedono le cose molto diversamente dagli uomini, ma non sono ascoltate.
C’è voluta una lunga battaglia, combattuta dalle donne, perché le parole delle vittime venissero ascoltate e prese seriamente in considerazione, perché le vittime stesse non fossero sempre considerate possibili complici della violenza - Ida aveva forse provocato, magari anche inconsapevolmente, come insinua Freud, il violento? - e venissero invece aiutate a superare il trauma, e risarcite.
Nell’ordinamento giuridico italiano gli articoli del codice Rocco, vigenti fino al 1996, punivano ogni tipo di violenza o molestia sessuale - sia sulle donne che sui minori - come «delitto contro la morale pubblica e il buoncostume». Tutelavano cioè quello che veniva considerato un bene collettivo e non la vittima. È stato solo nel 1996, grazie alle pressioni del movimento femminista, che viene promulgata la nuova legge per cui lo stupro diventa reato contro la persona, e di conseguenza l’attività sessuale riconosciuta come frutto di una libera scelta perché rientra nel diritto proprio dell’individuo.
Mentre nella fase precedente si collocava al primo posto la condizione di vita della comunità, che per il legislatore costituiva il massimo valore, oggi a essere valorizzata è invece la dimensione individuale di chi subisce il reato, divenuta il bene giuridico protetto dalla legge. Rivendicando la loro posizione di vittime della violenza, le donne capovolgono la situazione di debolezza in cui si trovavano, s’impadroniscono del potere di accusa, le loro parole si caricano di valore, e hanno finalmente diritto di essere ascoltate.
Oggi Ida troverebbe ascolto, Hanss verrebbe punito per molestie su una minore, e Freud non avrebbe più la possibilità di elaborare la sua teoria sull’isteria. Un caso in cui la psicanalisi, elemento fondamentale della nostra modernità, viene forse sconfitta dalla realtà che sta nelle parole delle donne?
(www.libreriadelledonne.it, 29 novembre 2019)
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". La crisi epocale dell’ordine simbolico di "mammasantissima" ("patriarcato": alleanza Madre-Figlio).
DONNE, UOMINI, E DISORDINE SIMBOLICO
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA “CROCE” DI SANT’ANDREA, DI SAN PIETRO, E DI CRISTO, E LA "BIBLIA PAUPERUM".1 dicembre 2019, di Federico La Sala
LA “CROCE” (“X”) DELL’APOSTOLO ANDREA E LA “BIBLIA PAUPERUM”. A GLORIA DI PRESICCE E IN MEMORIA DEL SUO PATRONO.... *
RICORDANDO CHE “lo storico Eusebio di Cesarea (ca. 265-340) scrive che Andrea predica il Vangelo in Asia Minore e nella Russia meridionale. Poi, passato in Grecia, guida i cristiani di Patrasso. E qui subisce il martirio per crocifissione: appeso con funi a testa in giù, secondo una tradizione, a una croce in forma di X; quella detta poi “croce di Sant’Andrea”. Questo accade intorno all’anno 60, un 30 novembre” (cfr. : Sant’ Andrea Apostolo), solleciterei storici e storiche, filologi e filologhe, filosofi e filosofe, a riflettere - visto che Gesù Cristo (dal greco Χριστός, Christós) è morto sulla “croce” - sulla differenza tra la “croce” (“X”) dell’apostolo Andrea e, unitariamente, la “croce” latina dell’apostolo Pietro (“Crocifissione di San Pietro” di Michelangelo Merisi), sia sul piano del significato del simbolismo della figura sia sul significato della lettera dell’alfabeto greco e dell’alfabeto latino.
Al buon-intenditore (del “buon-messaggio” - dell’ “ev-angelo”) poche parole....
Complimenti e buon lavoro
Federico La Sala
* Cfr.: Presicce, il suo patrono Sant’Andrea e la tela del suo martirio, opera del Catalano di Andrea Erroi, Fondazione Terra d’Otranto, 30.12.2018.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Al di là delle colonne di Ercole e di Zeus! La lezione di Ovidio: la "storia" di Cenis (di Alba Subrizio).25 novembre 2019, di Federico La Sala
Antichi Ritorni
Cenis/Ceneo, quando uno stupro cancella l’identità
Oltraggiata dal dio Poseidone la fanciulla chiede di diventare uomo
di Alba Subrizio (il Mattino di Puglia e Basilicata, 10/09/2017)
La prima trasformazione female-to-male ma soprattutto il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita. Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Per cancellare quel dolore, Cenis ha bisogno di ripudiare se stessa, divenendo altro...
Lungi da me l’idea di fare politica, non posso tacere in merito agli stupri perpetrati nelle ultime settimane in tutta Italia e allo scempio mediatico a cui le vittime sono state sottoposte. In una società come la nostra, quasi assuefatta ai crimini della peggior specie (sic!), sembra che il ‘delitto’ commesso passi in secondo piano, il dolore, la vergogna subita, sono cose che non vogliamo vedere o che forse non ci interessano; ciò che invece interessa è sapere chi ha compiuto il misfatto: l’immigrato, l’italiano, il carabiniere finanche...
Soprattutto sui social network - ormai divenuti sempre più luogo di sfogo di personali frustrazioni da parte di individui che diversamente non saprebbero come esistere - leggo commenti insulsi, a dir poco da far accapponare la pelle: dopo i fatti di Firenze c’è chi inneggiava che a commettere l’abominio fossero stati esponenti dell’Arma (inneggiare sì, come se fosse una bella cosa, l’importante è che non fossero ancora una volta accusati cittadini extracomunitari); d’altra parte in seguito ai fatti di Rimini leggo gente “tutta contenta” utilizzare gli avvenimenti a sostegno delle loro teorie xenofobe... e poi numeri e numeri. Come se tutto ciò fosse un gioco: un gioco a calcolare quale ‘parte’ in gara ha compiuto più stupri.
Da questo quadro emerge solo un dato di fatto: il popolo italiano, di qualunque colore politico, ha perso ormai il senno. Ahinoi, non possiamo dire che i nostri antenati latini fossero poi così diversi; basti rileggere i miti antichi per accorgersi da quanti stupri e violenze sono disseminate queste storie: piccoli particolari senza valore all’interno di Storie ben più grandi, ben più importanti.
A convalida di ciò, si pensi solo a Zeus ed Apollo (i campioni dello stupro) per non parlare di altre divinità. Eh già, perché nell’antica Grecia i maggiori artefici di violenze erano gli dèi, proprio quelli che avrebbero dovuto proteggere gli uomini. Tra i tanti miti me ne viene in mente uno che, sebbene sconosciuto ai più, mi ha attratto per la forza delle immagini.
C’era una volta Cenis, una delle donne più belle di tutta la Tessaglia; nonostante decine e decine fossero i suoi pretendenti, lei non voleva concedersi e preferiva godere spensierata della sua fanciullezza. Ma un giorno, mentre passeggiava sulle rive del mare, il dio Poseidone, desiderandola, le usò violenza.
Dopo aver goduto di lei - così narra il poeta latino Ovidio nelle sue “Metamorfosi” - le disse che avrebbe realizzato per Cenis ogni suo desiderio. Così ella rispose: «L’ingiuria che ho patito provoca in me un desiderio grande: quello di non dover subire mai più alcunché di simile. Se farai in modo che io non sia più donna, mi avrai completamente accontentato». Fu così che il dio del mare trasformò Cenis in Ceneo.
Il mito non è una semplice metamorfosi come le altre: innanzitutto è la prima volta nella letteratura mondiale che leggiamo di una donna che diventa uomo (la prima trasformazione female-to-male), ma soprattutto è il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita.
Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Scioccamente (da buon maschione) il dio crede di rimediare offrendo un dono, ma nulla può cancellare ciò che è stato. Lo sa bene Cenis, che pertanto, per cancellare quel dolore, ha bisogno di cancellare e ripudiare se stessa, divenendo altro.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Walter Benjamin e il culto del capitalismo. Quando il denaro si sostituisce a Dio. Note.22 novembre 2019, di Federico La Sala
Il libro.
Fermiamo il culto del capitalismo. Quando il denaro si sostituisce a Dio
L’autore del saggio lancia un grido di allarme: la cultura dominante del profitto e del consumismo è ormai diventata una forma di idolatria
di Luigino Bruni (Avvenire, mercoledì 20 novembre 2019)
- Anticipiamo una parte del capitolo iniziale di Il capitalismo e il sacro di Luigino Bruni (pagine 128,euro 13,00, in libreria dal 21 novembre), nuovo volume della collana “Pagine prime”, realizzata da Vita e Pensiero in collaborazione con “Avvenire”. In questo pamphlet Bruni - professore di Economia politica alla Lumsa di Roma e opinionista fra i più seguiti del nostro quotidiano - propone un’analisi originale e provocatoria sulle origini della mentalità attuale. Attingendo al pensiero di autori quali Benjamin, Florenskij, Nietzsche, Marx, Agamben e Boltanski, Il capitalismo e il sacro invita a contrastare la pretesa idolatrica della prassi economica contemporanea, in nome di una rinnovata prospettiva di condivisione.
Pochi anni dopo Marx, nel 1905 Max Weber pubblica i suoi lavori sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo, dove una idea chiave è la de-sacralizzazione del mondo occidentale. Passano pochi anni e il 1921 diventa un anno decisivo per la cosiddetta “teologia economica”. Il filosofo tedesco Walter Benjamin scrive un breve e densissimo testo, oggi noto come Il Capitalismo come religione, e contemporaneamente il teologo e filosofo russo Pavel Florenskij, in un contesto culturale molto diverso, tiene tra l’agosto e l’ottobre del 1921 un corso di lezioni all’Accademia Teologica di Mosca sulla dimensione sacra del capitalismo.
Weber annunciava un mondo de-sacralizzato, Benjamin e a modo suo anche Florenskij dicono invece qualcosa di opposto: il capitalismo non ha eliminato il sacro dal mondo perché è diventato esso stesso un culto, una religione. Due autori vicini anche nella morte: Benjamin muore suicida nel 1940 mentre tenta di fuggire ai nazisti sui Pirenei, Florenskij viene fucilato nel 1937 in un gulag nei pressi di Stalingrado.
Il saggio di Benjamin è stato a lungo trascurato, sebbene contenga un’analisi ancora insuperata del rapporto tra l’economia capitalistica e la religione. Benjamin, anche per le sua cultura ebraica, aveva posto il tema del messianismo al centro della sua riflessione filosofica. Il capitalismo gli appare come una (falsa) risposta alla domanda di salvezza che nell’umanesimo ebraico-cristiano aveva fondato l’Europa. Per Benjamin, allora, «nel capitalismo va individuata una religione; il capitalismo, cioè, serve essenzialmente all’appagamento delle stesse preoccupazioni, tormenti, inquietudini a cui in passato davano risposta le cosiddette religioni».
Questo incipit di Benjamin è chiaro e potente: il capitalismo non nasce soltanto, come diceva Weber, da uno spirito religioso; per Benjamin il capitalismo è una religione: «non solo, come ritiene Weber, in quanto costruzione determinata in senso religioso, bensì in quanto fenomeno essenzialmente religioso».
E quindi sintetizza: «In Occidente il capitalismo - come deve essere dimostrato non solo nel caso del calvinismo, ma anche degli altri orientamenti cristiani ortodossi - si è sviluppato parassitariamente sul cristianesimo, tanto che, alla fine, la storia di quest’ultimo è in sostanza quella del suo parassita, il capitalismo». E poco dopo aggiunge: «Il cristianesimo nell’età della Riforma non ha agevolato il sorgere del capitalismo, ma si è tramutato nel capitalismo».
Molto forte e particolarmente efficace è la metafora biologica del parassita: il capitalismo dal cristianesimo non ha preso solo lo spirito, ha la sostanza ed è cresciuto al punto da assorbirlo interamente. Il capitalismo è un cristianesimo fagocitato e trasformato, una metamorfosi del bruco in farfalla - e le farfalle non ricordano di essere state bruco.
Inoltre, Benjamin rettifica ancora Weber estendendo la metamorfosi dal protestantesimo all’intero cristianesimo, anticipando in questo di qualche anno Amintore Fanfani e le sue analisi sullo spirito “cattolico” e medioevale del capitalismo, un tema sviluppato anche da Giuseppe Toniolo, sebbene avanzando una tesi diversa da quella di Fanfani. È questa la grande e potente tesi di quel piccolo opuscolo del 1921, dove però troviamo molte altre intuizioni di grande valore. Vi è contenuta anche una sorta di profezia: «In seguito, tuttavia, ne avremo una visione d’insieme».
Benjamin conosceva troppo bene Marx per usare la parola “struttura” in senso generico. Per lui la religione, il cristianesimo in particolare, è la struttura del capitalismo, e quindi l’economia capitalistica, che dovrebbe essere la struttura della società capitalistica, è a sua volta una sorta di sovrastruttura di una struttura religiosa più radicale. Noi vediamo economia, ma sotto, nascosta «dall’involucro delle cose », c’è la religione: quale religione? Quali sono i tratti della farfalla-capitalismo nata dal bruco-cristianesimo?
Scriveva Benjamin: «Tre tratti di questa struttura religiosa sono però riconoscibili già nel presente. In primo luogo il capitalismo è una religione puramente cultuale, la più estrema forse che mai sia stata data. Tutto, in esso, ha significato soltanto in rapporto immediato con il culto; non conosce nessuna particolare dogmatica, nessuna teologia. L’utilitarismo acquisisce così la sua coloritura religiosa ».
Tesi forti e dense, e tutte ancora da esplorare, oggi più di ieri. Innanzitutto il capitalismo è definito dal filosofo tedesco come una «religione puramente cultuale», di puro culto, senza teologia, senza dogmi. Benjamin era ebreo, era filosofo, ed era tedesco - la Germania della sua generazione ( Taubes, Buber, Bonhoeffer, Bloch, e molti altri) fu un luogo straordinario e ineguagliato per le riflessioni sull’anima collettiva dell’Europa, per il destino e “tramonto” dell’Occidente e del capitalismo.
Benjamin sapeva quindi che le religioni di puro culto, senza dogmi né teologia, avevano nella Bibbia un nome preciso: idolatrie. Quei culti contro i quali il popolo ebraico, in Caanan e in Babilonia e ancor prima in Egitto, aveva ingaggiato una lotta campale, la lotta più radicale e estesa di tutta la Bibbia.
E che cosa significa, oggi, una religione/idolatria di puro culto? Pavel Florenskij, il grande filosofo e teologo russo, ha scritto cose importanti sul capitalismo come religione/idolatria di puro culto. Sempre nel 1921, anche Florenskij dedicava una specifica attenzione al rapporto tra il capitalismo, il sacro e il culto. Il suo resta un testo di enorme interesse per le intuizioni che vi sono contenute sulla natura sacrale del capitalismo. Scriveva il teologo ortodosso: «La stessa teoria del sacro dice che all’origine dell’economia, così come dell’ideologia, c’è il culto».
Il culto, per Florenskij, è «una sorta di prius. Viene prima il culto, e in seguito gli strumenti e i concetti». E poi aggiunge: «Il punto di partenza della cultura è il culto», giocando anche sulla comune radice delle parole cultura e culto: «In suo favore si pone anche l’analisi filologica». Per questo aggiunge: «È sbagliato pensare che la teoria del sacro sia perduta per sempre. Essa è legata alla coscienza medioevale. Nella vita storica ci sono periodi di laicizzazione e, al contrario, periodi in cui tutta la vita è introdotta nell’alveo del culto».
Il capitalismo è dunque per Benjamin e Florenskij una religione di solo culto, di sola prassi - in realtà, oggi noi sappiamo che nel secolo che è passato dallo scritto di Benjamin la religione capitalistica si è sofisticata e ha prodotto alcuni dogmi e una sua teologia, offerta in buona parte dalla teoria economica e da quella manageriale. Ed è per la necessità di avere un culto per poter creare una cultura che il capitalismo è diventato la vera cultura (o religione) popolare di questo secolo.
La forza culturale del capitalismo sta proprio nel suo essere diventato una esperienza globale, olistica, onnicomprensiva e onniavvolgente - il primo populismo moderno lo ha inventato il capitalismo. È nella sua dimensione di sola prassi quotidiana che, novello Anteo, il capitalismo trae la sua forza.
Il capitalismo crea e rafforza la sua cultura alimentandosi nel culto feriale di miliardi di persone. Ecco perché è diventato il culto universale e globale, che può solo crescere e rafforzarsi nei prossimi decenni - finché altri culti e altre culture non ne prenderanno il posto: speriamo solo che non siano le antiche arti della guerra! Ma da qui deriva anche un corollario interessante: per superare l’idolatria capitalistica occorrono nuove prassi, nuove esperienze.
Non basta scrivere teorie, perché ogni cultura nasce dal culto e dal pane quotidiano. Siamo immersi in pratiche quotidiane, ripetute, reiterate di culti di acquisto, vendita, investimenti. Anche nelle imprese, che nel Novecento erano in genere pensate e vissute sul modello della comunità, sta crescendo la stessa cultura commerciale.
Dal modello comunitario tipico del XIX e XX secolo siamo passati progressivamente all’impresa-mercato, che oggi domina indisturbata la scena. Fino a pochi decenni fa, soprattutto (ma non solo) in Europa, il registro relazionale che fondava imprese e/o cooperative era quello del patto non quello del contratto; anche il “contratto” di lavoro era soprattutto un patto, dove il do-ut-des era solo una delle componenti di quel rapporto fondamentale che fondava il lavoratore e la sua famiglia (il lavoro non era una merce perché quel contratto era essenzialmente un patto).
E invece oggi la cultura che si respira nelle imprese, nei loro culti e nelle loro liturgie, è la stessa cultura che si respira nei grandi centri commerciali, nelle banche, e sempre più anche nei social media. Ed è in questi culti e in queste pratiche, molto più che nelle business school e nelle università, dove si alimenta la cultura-religione- idolatria del capitalismo.
Perché, sempre secondo Florenskij, «il contenuto mistico-religioso dei concetti non si rivela nel pensiero astratto ma nell’esperienza ». Per il pensatore russo, dunque, all’inizio c’è la prassi del culto e da questa prassi nascono i concetti astratti (la cultura): «Tutte le concezioni scientifiche - economiche e simili - si sviluppano attraverso la secolarizzazione: da una parte si definiscono i concetti utilitaristici, dall’altra quelli scientifici».
Per questa stessa ragione, «il mito nasce dal culto... Il mito è il tentativo teorico di spiegare un determinato culto». Infatti, la «realtà originaria, nella religione, non sono i dogmi e nemmeno i miti, ma il culto, ovvero una realtà concreta. Mito e dogma sono astrazioni, teorie».
L’analogia storica più vicina alla cultura capitalista è per Florenskij la christianitas medievale: «Può essere convincente per noi soltanto l’idea medioevale di unità ecclesiale, di penetrazione di tutta la cultura da parte del principio sacrale... Non c’era fenomeno che non abbia un chiaro aspetto ecclesiale. Tutti i fenomeni, in positivo o in negativo, sono orientati all’ecclesialità».
Prassi era il cristianesimo pre-moderno in Europa, prassi è il nostro capitalismo: qui la loro forza, qui la loro vicinanza. Queste di Florenskij sono parole importanti. Per questa sua natura pratico-cultuale, ad esempio, che i filosofi e i teologi fanno molta fatica a comprendere il capitalismo del nostro tempo. Il secondo tratto del capitalismo, legato al primo (religione di puro culto), è per W. Benjamin «la durata permanente del culto».
Cento anni fa non esistevano ancora i negozi 24h7d, né lo shopping online, ma il filosofo ebreo aveva, profeticamente (la grande filosofia ha una dimensione profetica intrinseca e spesso non intenzionale) intuito una dimensione che nel tempo ha mostrato tutta la sua forza: «Il capitalismo è la celebrazione di un culto “senza tregua e senza pietà”. Non ci sono “giorni feriali”; non c’è giorno che non sia festivo, nel senso spaventoso del dispiegamento di ogni pompa sacrale, dello sforzo estremo del venerante».
Il conflitto tra il capitalismo e la domenica (possibile giorno dei negozi chiusi) non va infatti letto solo sul piano pragmatico del business ma su quello religioso dello scontro tra culti. Anche per questa ragione ha un suo senso, se ben inteso, rivendicare per i cristiani la domenica come giorno del Signore e quindi proteggerlo dal culto capitalistico, anche se la battaglia è troppo impari.
L’ebraismo potrà salvarsi da questo capitalismo (che in parte è suo figlio) se continuerà ad essere fedele allo shabbat. C’è poi quello che per Benjamin è il terzo tratto del capitalismo-culto, quello che ha ottenuto più attenzione dagli studiosi (da Giorgio Agamben in particolare): «Questo culto è colpevolizzante. Il capitalismo è presumibilmente il primo caso di un culto che non consente espiazione, bensì produce colpa». Una tesi forte e sempre suggestiva, che apre discorsi appassionanti e rilevanti.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
La domenica di Ratzinger e la "domenica della vita" di Hegel. Una nota di Gianni Vattimo
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MUTAMENTI SEMANTICI E NUOVA DENOMINAZIONE DELL’ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. "Motu Proprio" di Papa Francesco.14 novembre 2019, di Federico La Sala
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
PER IL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
DA
- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
AD
- ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO *
L’esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a volte necessari.
Anche l’Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell’ingente e rilevante patrimonio documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali inevitabili condizionamenti.
Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta Bibliotheca secreta) fra il primo e secondo decennio del XVII secolo, l’Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto (Archivum Secretum Vaticanum) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte dell’Europa e del mondo. Se è vero che l’apertura ufficiale dell’Archivio ai ricercatori di ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte opere erudite si poterono pubblicare con l’ausilio di copie documentarie fedeli o autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell’Archivio Segreto Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo modo l’Archivio centrale dell’Europa (quod quodam modo totius Europae commune Archivum censeri debet).
Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all’Archivio Segreto Vaticano stima e riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione delle progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato di Pio XII), sia in ragione dell’aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi all’Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche.
Tale meritorio servizio ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei prefetti pro tempore, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal modo si è provveduto alla graduale crescita della struttura dell’Archivio stesso per il suo sempre più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici.
Vi è tuttavia un aspetto che penso possa essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione dell’Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell’istituto: Archivio Segreto Vaticano.
Nato, come accennato, dalla Bibliotheca secreta del Romano Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto la giurisdizione diretta del Papa, l’Archivio si intitolò dapprima semplicemente Archivum novum, poi Archivum Apostolicum, quindi Archivum Secretum (le prime attestazioni del termine risalgono al 1646 circa).
Il termine Secretum, entrato a formare la denominazione propria dell’istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l’archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente secreti.
Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di Archivum Secretum. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine Secretum accostato all’Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine secretum e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l’accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l’Archivio Segreto Vaticano, che - come disse il mio santo predecessore Paolo VI - conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia (Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, p. 614). E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!» (Discorso agli Officiali dell’Archivio Segreto Vaticano, 4 marzo 2019: L’Osservatore Romano, 4-5 marzo 2019, p. 6).
Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che:
da ora in poi l’attuale Archivio Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, sia denominato Archivio Apostolico Vaticano.
Riaffermando la fattiva volontà di servizio alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame della Sede romana con l’Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al tempo stesso ne sottolinea l’immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato.
Francesco
* Fonte: http://w2.vatican.va/
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- Uno dei testi che ha saputo innescare una radicale critica al presente su scala globale è "Il racconto dell’ancella" di Margaret Atwood (Cristina Gamberi).26 ottobre 2019, di Federico La Sala
Margaret Atwood
La vincitrice del Booker Prize 2019 insieme a Bernardine Evaristo
di Cristina Gamberi (il Mulino, 21 ottobre 2019)
Può un libro cambiare il mondo? Nonostante le illusioni di molti, la risposta è chiaramente no. Eppure esistono libri a cui è stato riservato il curioso destino di, se non proprio cambiare il mondo, farsi strumento del cambiamento politico. Sono libri che hanno il potere di offrire un vocabolario e degli strumenti teorici, ma soprattutto narrazioni e immagini che aiutano a comprendere una realtà fino a quel momento sommersa o taciuta, adottando prospettive inconsuete e denunciando la condizione di oppressione in cui vivono le persone. In questo senso, sono libri rivoluzionari.
Uno dei testi che ha saputo innescare una radicale critica al presente su scala globale è Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, la scrittrice canadese che è appena stata insignita del più prestigioso premio letterario britannico, il Man Booker Prize, per il romanzo The Testaments. Edito in Italia da Ponte alle Grazie, I testamenti è l’attesissimo sequel della distopia ambientata nella Repubblica di Galaad, di cui non sappiamo se condividerà lo stesso destino del romanzo originale. Di sicuro, però, sappiamo che si tratta già di un successo editoriale che si colloca al culmine della parabola letteraria di un’autrice che all’età di ottant’anni ha alle spalle una carriera di scrittrice molto letta, molto premiata e saldamente insediata nell’establishment letterario mondiale.
 Fin dagli esordi, negli anni Sessanta, Atwood si è infatti misurata con una molteplicità di linguaggi ed eterogeneità di generi letterari, iniziando a scrivere poesie e pubblicando successivamente romanzi, storie per bambini, graphic novel, libretti per opera da camera, saggi critici e contribuendo attivamente all’adattamento delle sue opere in serie televisive, film e documentari.
Fin dagli esordi, negli anni Sessanta, Atwood si è infatti misurata con una molteplicità di linguaggi ed eterogeneità di generi letterari, iniziando a scrivere poesie e pubblicando successivamente romanzi, storie per bambini, graphic novel, libretti per opera da camera, saggi critici e contribuendo attivamente all’adattamento delle sue opere in serie televisive, film e documentari.Una solida formazione accademica - iniziata a Toronto con il teorico della letteratura Northrop Frye e proseguita al Radcliffe College di Harvard - ha fatto di lei una scrittrice colta. Il misurarsi con i grandi classici della tradizione occidentale è infatti uno degli aspetti principali della sua opera.
 Succede in The Penelopiad (2005) riscrittura dell’Odissea dal punto di vista di Penelope; nel romanzo Hag-Seed ispirato alla Tempesta di Shakespeare (2016); in Morning in the Burned House (1995) in cui Elena e Cressida prendono parola; e nel Racconto dell’ancella (1985) che trae ispirazione da un versetto biblico del della Genesi. Si tratta di una poetica profondamente intrecciata a quella che Adrienne Rich chiamò re-vision, ovvero il necessario confronto che le scrittrici devono compiere con la tradizione letteraria del passato per rileggere e riscrivere l’immaginario profondamente cristalizzato dal punto di vista del genere con l’obiettivo di entrare nei testi con uno sguardo nuovo: lo sguardo di donna.
Succede in The Penelopiad (2005) riscrittura dell’Odissea dal punto di vista di Penelope; nel romanzo Hag-Seed ispirato alla Tempesta di Shakespeare (2016); in Morning in the Burned House (1995) in cui Elena e Cressida prendono parola; e nel Racconto dell’ancella (1985) che trae ispirazione da un versetto biblico del della Genesi. Si tratta di una poetica profondamente intrecciata a quella che Adrienne Rich chiamò re-vision, ovvero il necessario confronto che le scrittrici devono compiere con la tradizione letteraria del passato per rileggere e riscrivere l’immaginario profondamente cristalizzato dal punto di vista del genere con l’obiettivo di entrare nei testi con uno sguardo nuovo: lo sguardo di donna.
Sono infatti la centralità della narrazione al femminile e l’indagine dell’autrice intorno alla soggettività delle donne a costituire il secondo aspetto saliente della scrittura di Atwood. Fin dal primo romanzo The Edible Woman (1969), la sua opera si intreccia con i temi, le rivendicazioni e i desideri espressi dalla seconda ondata del movimento femminista nord-americano, di cui è sempre stata reticente a definirsi parte attiva.
 La stessa Atwood ha tuttavia riconosciuto come il movimento delle donne abbia contribuito a espandere i territori a disposizione della scrittura, fornendo un’analisi lucida dei meccanismi di potere che operano nelle relazioni fra i generi e permettendo di esplorare aspetti dell’esperienza delle donne che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.
La stessa Atwood ha tuttavia riconosciuto come il movimento delle donne abbia contribuito a espandere i territori a disposizione della scrittura, fornendo un’analisi lucida dei meccanismi di potere che operano nelle relazioni fra i generi e permettendo di esplorare aspetti dell’esperienza delle donne che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.Il legame fra le istanze femministe e la narrativa di Atwood è tuttavia da ricercare nell’uso del genere distopico, scelto dall’autrice perché maggiormente libero dai vincoli imposti dal realismo e quale luogo ideale per esplorare (e far esplodere) la costruzione dei ruoli di genere e gli assetti sociali considerati "naturali". Come era successo prima di lei in Katharine Burdekin e Octavia E. Butler, nel Racconto dell’ancella Atwood usa la distopia come spazio letterario privilegiato in cui la riappropriazione della sessualità e dei corpi femminili è mezzo cruciale per ridefinire l’agency e la soggettività delle donne.
 Il disturbante racconto dell’ancella Difred, la donna-schiava che vive asservita all’uomo per scopi riproduttivi in un regime teocratico di ispirazione biblica in un futuro non tanto lontano dal nostro, rappresenta infatti una critica radicale al patriarcato e al totalitarismo. Il suo racconto diventa narrazione capace di rivelare l’indissolubile legame fra il culto della virilità, i regimi totalitari, il controllo della sessualità femminile e la violenza sul corpo delle donne.
Il disturbante racconto dell’ancella Difred, la donna-schiava che vive asservita all’uomo per scopi riproduttivi in un regime teocratico di ispirazione biblica in un futuro non tanto lontano dal nostro, rappresenta infatti una critica radicale al patriarcato e al totalitarismo. Il suo racconto diventa narrazione capace di rivelare l’indissolubile legame fra il culto della virilità, i regimi totalitari, il controllo della sessualità femminile e la violenza sul corpo delle donne.Il curioso destino di questo libro non è solo che a distanza di trent’anni il suo messaggio è diventato politicamente urgente, ma è anche che ha prodotto effetti di realtà imprevisti. La narrazione distopica di Atwood ha infatti innescato inaspettate pratiche di soggettivazione radicate nei corpi delle donne. Nel 2017, quando viene trasmessa la prima serie televisiva ispirata al romanzo, nel clima politico seguito all’elezione di Donald Trump e in concomitanza con il dilagare del movimento #MeToo e #TimesUp, l’Ancella da finzione si è trasformata in realtà. La sua iconografia, contraddistinta da una lunga tunica rossa e dal capo coperto da una cuffia bianca, è infatti diventata il simbolo di un movimento vero e proprio e da allora è stata usata dalle donne di tutto il mondo per denunciare le forme di controllo sui propri corpi e la propria sessualità.
Il perché il romanzo sia ritornato oggi così attuale può essere spiegato con le continue violazioni dei diritti riproduttivi e con l’aumento delle forme di violenza contro le donne. Ma ciò che ha permesso alla narrazione di travalicare i confini del successo letterario è stato un doppio movimento. Da una parte il cruciale passaggio dal testo romanzesco alla serie televisiva. Dall’altra il processo dal basso che ha portato alla riappropriazione dell’immaginario distopico dell’ancella come forma di soggettivazione politica femminista e che l’ha trasformata in un potente strumento di critica delle forme di subordinazione non solo sessuale, ma anche economica e sociale del presente.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---- «Se ora dunque mi riperete la domanda perché l’uomo ha due occhi, io vi risponderò così» (Ernst Mach)..13 ottobre 2019, di Federico La Sala
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico...
- PERCHÉ L’UOMO HA DUE OCCHI?: «Se ora dunque mi riperete la domanda perché l’uomo ha due occhi, io vi risponderò così. Perché possa osservare attentamente la natura, e comprenda che egli stesso con le sue opioni vere o false con la sua alta ideologia, non è altro che un piccolo e fugace fenomeno della natura. E che, per dirla con Mefistofele, non è che "una parte di una parte". E che è cosa assai assurda "che l’uomo, piccola parodia del mondo,/ si illuda di essere un mondo egli stesso" (Goethe)»(Ernst Mach: cfr. Carlo Rovelli, "In principio c’era Ernst Mach", Corriere della Sera - La Lettura, 13.10.2019, pp. 14-15).
- CREATIVITÀ: «Cominciamo da noi stessi, esseri umani dotati di due mani, di due piedi, due occhi, due orecchi, una testa (con due emisferi cerebrali), una bocca ...
- Limitiamoci a considerare la questione partendo dagli organi della vista, dagli occhi. E’ esperienza comune vedere, ma non è affatto comune - né nella vita culturale né nella vita quotidiana degli esseri umani - pensare nel pieno senso della parola che noi vediamo ciò che vediamo grazie all’azione unitaria e combinata di tutti e due gli occhi; e continuiamo a vedere e a pensare come se - avendo una sola testa (e una sola bocca) - avessimo un solo occhio (un solo orecchio, una sola mano e un solo piede)!» (cfr. Federico La Sala, Creatività: Kant e la critica della società dell’uomo a "una" dimensione. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico).
SCHEDA EDITORIALE*
Ernst Mach
Perché l’uomo ha due occhi?
Nella seconda metà dell’Ottocento, il grande fisico e filosofo Ernst Mach, allora giovane professore alle università di Graz e Praga, organizza una serie di lezioni di «scienza popolare» rivolte a un pubblico non specialistico né accademico, perlopiù femminile.
Tra i temi proposti, spiccano per interesse e originalità le riflessioni sui concetti di simmetria, armonia e prospettiva, considerati secondo una lettura epistemologica in cui le intuizioni filosofiche si confrontano con l’osservazione empirica dei processi naturali. Attraverso esempi presi non solo dall’arte, dalle scienze e dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana, Mach riesce a spiegare con ragionamenti scorrevoli e un linguaggio chiaro e diretto questioni classiche della tradizione filosofica e scientifica legate alla percezione visiva e all’esperienza spazio-temporale.
L’uomo, insegna Mach, deve tendere a una comprensione razionale della realtà che lo circonda, senza mai perdere la consapevolezza, però, di essere una piccola parte del tutto.
Ernst Mach
 (Brno-Chrlice, 1838 - Monaco di Baviera, 1916) Fisico e filosofo, insegna prima a Graz e a Praga per poi trasferirsi a Vienna, dove sarà docente di Filosofia della scienza fino al ritiro nel 1901. Sostenitore di un’indagine storico-critica delle idee scientifiche, sviluppa una filosofia empirica in cui i concetti servono a dare ordine ai dati dell’esperienza. La sua critica allo spazio assoluto di Newton ha anticipato la teoria della relatività di Einstein. Ha influenzato un’intera generazione di filosofi e scienziati, e le sue teorie sono state oggetto della tesi di laurea di Robert Musil.
(Brno-Chrlice, 1838 - Monaco di Baviera, 1916) Fisico e filosofo, insegna prima a Graz e a Praga per poi trasferirsi a Vienna, dove sarà docente di Filosofia della scienza fino al ritiro nel 1901. Sostenitore di un’indagine storico-critica delle idee scientifiche, sviluppa una filosofia empirica in cui i concetti servono a dare ordine ai dati dell’esperienza. La sua critica allo spazio assoluto di Newton ha anticipato la teoria della relatività di Einstein. Ha influenzato un’intera generazione di filosofi e scienziati, e le sue teorie sono state oggetto della tesi di laurea di Robert Musil. Prezzo 8.5
Prezzo 8.5
 Anno 2016
Anno 2016
 Pagine 64
Pagine 64* CASTELVECCHI EDITORE
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Il legame di uguaglianza e reciprocità e "la dea Hostilina in sant’Agostino". Chi è effettivamente l’ospite (di Angela Frati e Stefania Iannizzotto).4 ottobre 2019, di Federico La Sala
Chi è effettivamente l’ospite *
- Quesito:
- È molta la curiosità dei nostri lettori intorno alla parola ospite: perché in italiano indica sia chi riceve ospitalità sia chi dà ospitalità?
- Chi è effettivamente l’ospite
Come si legge in tutti i vocabolari dell’italiano contemporaneo, ospite ha un duplice significato: è sia chi dà ospitalità (un ospite premuroso) sia, più comunemente, chi la riceve (un ospite gradito). Con il primo significato si ritrova soprattutto in contesti formali e letterari (nel GDLI si riscontrano esempi a partire dalla prima metà del XIV secolo fino ad autori quali Foscolo, Manzoni, Pascoli ecc.).
La parola ospite deriva dal latino hospes, -ĭtis, che aveva già il doppio significato di ‘colui che ospita e quindi albergatore’ e di ‘colui che è ospitato e quindi forestiero’, significato - comune alla parola greca xénos - che si è tramandato in quasi tutte le lingue romanze (antico francese (h)oste; francese moderno hôte; occitano e catalano oste; spagnolo huésped; portoghese hóspede). Ed è dunque proprio alla storia della lingua latina che dovremo guardare per rispondere alla curiosità che questa parola suscita.
L’etimologia del termine latino hospes risulta spesso incerta nei più comuni dizionari della lingua italiana e, se vengono date delle spiegazioni, esse risultano parziali e non rispondono pienamente alla nostra domanda. Ad esempio, il Devoto-Oli 2012 e il Sabatini-Coletti 2008 fanno risalire la voce a un più antico *hostipotis, composto da hŏstis ‘straniero’ e pŏtis ‘signore, padrone’, cioè ‘signore dello straniero’, ma non dicono niente di più. Il Vocabolario Treccani scrive sinteticamente che il termine ha “tutti e due i significati fondamentali, in quanto la parola alludeva soprattutto ai reciproci doveri dell’ospitalità”, in accordo con il Dir Dizionario italiano ragionato (D’Anna, 1988).
Tra gli etimologici, il DELI riconosce il doppio significato del termine, ma aggiunge “senza etimologia evidente”. L’etimologico di Nocentini approfondisce invece la questione e rimanda all’indoeuropeo *ghos(ti)-potis ‘signore dello straniero’ cioè il padrone di casa che esercitava il diritto di ospitalità nei confronti del forestiero, composto da *ghostis ‘straniero’ e *potis ‘signore’. A favore di tale ipotesi cita i corrispettivi gospodĭ ‘padrone, signore’ in antico slavo e gospodín ‘signore’ in russo.
Hospesin origine è dunque il “padrone di casa” che dà ospitalità al forestiero; i rapporti che si istauravano tra chi accoglieva e chi era accolto erano così stretti - legati anche al fatto che chi era ospitato si impegnava a sua volta a ricambiare l’ospitalità - che, sin dai tempi più antichi, hospes ha indicato anche la persona accolta in casa d’altri. La reciprocità del patto di ospitalità è dunque all’origine del doppio significato della parola ospite. Riconoscendo questa “squisita umanità degli antichi”, anche Leopardi nello Zibaldone scriveva: “di tal genere è ancora quella tanta ospitalità esercitata dagli antichi con tanto scrupolo, e protetta da tanto severe leggi, opinioni religiose ecc. quei diritti d’ospizio ecc. affinità d’ospizio ecc. Ben diversi in ciò dai moderni” (5 luglio 1827).
Vale la pena soffermarsi un po’ di più sulla parola hostis che, insieme a potis ‘signore’, è all’origine di hospes. Emile Benveniste introduce così la questione:
- Tra i termini comuni al vocabolario preistorico delle lingue dell’Europa, questo ha un interesse particolare: hŏstis del latino corrisponde al gasts del gotico e al gostĭ dell’antico slavo, che presenta inoltre gos-podĭ ‘signore’, formato come hospes. Ma il senso del gotico gasts e dell’antico slavo gostĭ è ‘ospite’, quello del latino hŏstis è ‘nemico’. Per spiegare il rapporto tra ‘ospite’ e ‘nemico’, si ammette di solito che l’uno e l’altro derivino dal senso di ‘straniero’ che è ancora attestato in latino; da cui ‘straniero favorevole → ospite’ e ‘straniero ostile → nemico’.
Benveniste ricorda, infatti, che hostis è usato nella Legge delle XII tavole con il valore arcaico di ‘straniero’, ma riporta anche un’interessante testimonianza di Sesto Pompeo Festo (II secolo d.C.) da cui si ricava che il termine hostis indicava colui a cui erano riconosciuti gli stessi diritti del popolo Romano (quod erant pari iure cum populo Romano). A conferma di ciò Festo ricorda anche che il verbo hostire aveva lo stesso significato di aequare (con valore simile si trovano hostire in Plauto, hostus in Varrone e il nome della dea Hostilina in sant’Agostino). Il legame di hostis con i concetti di uguaglianza e di reciprocità è confermato anche da una parola più conosciuta, hostia, che nel rituale romano indica propriamente ‘la vittima che serve a compensare l’ira degli dei’ (l’offerta è considerata quindi di un valore tale da bilanciare l’offesa), in contrapposizione con il termine meno specifico victima che indica un semplice ‘animale offerto in sacrificio’ (cioè senza nessun intento riparatorio).
Si ricava dunque che il significato originario di hostis non era quello di ‘straniero’ in generale, né tanto meno di ‘nemico’, ma quello di ‘straniero a cui si riconoscono dei diritti uguali a quelli dei cittadini romani’, a differenza del peregrinus che indica invece ‘colui che abita al di fuori del territorio’.
 Il legame di uguaglianza e reciprocità che si stabilisce tra un hostis e un cittadino di Roma conduce alla nozione di ospitalità.
Il legame di uguaglianza e reciprocità che si stabilisce tra un hostis e un cittadino di Roma conduce alla nozione di ospitalità.
 In un dato momento dunque hostis ha indicato ‘colui che è in relazione di compenso’ e di scambio nei confronti del civis e quindi, in ultima analisi, l’ospite. Di questo erano ben consapevoli gli scrittori classici, come scrive Cicerone nel De officiis: “hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus” [infatti i nostri antenati chiamavano hostis quello che noi oggi chiamiamo peregrinus (‘forestiero’)].
In un dato momento dunque hostis ha indicato ‘colui che è in relazione di compenso’ e di scambio nei confronti del civis e quindi, in ultima analisi, l’ospite. Di questo erano ben consapevoli gli scrittori classici, come scrive Cicerone nel De officiis: “hostis enim apud maiores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus” [infatti i nostri antenati chiamavano hostis quello che noi oggi chiamiamo peregrinus (‘forestiero’)].Più tardi, quando alle relazioni di scambio tra clan e clan sono subentrate le relazioni di inclusione o di esclusione dalla civitas, hostis ha assunto un’accezione negativa e ha preso il significato classico di ‘nemico’ (da cui deriva, per esempio, la parola italiana ostile), e in tal senso la storia di hostis riassume il cambiamento che le istituzioni romane hanno attraversato nei secoli.
 In conseguenza del vuoto semantico lasciato da hostis si è dovuto pertanto ricorrere a un nuovo termine per indicare la nozione di ospitalità e si è creato, come già detto, partendo dalla stessa parola hostis, il termine hospes. Hospes dunque eredita e conserva in sé il valore intrinseco di reciprocità e di mutuo scambio: è forse anche per questo che la stessa parola nelle lingue derivate dal latino ha facilmente continuato a indicare sia chi ospita sia chi è ospitato.
In conseguenza del vuoto semantico lasciato da hostis si è dovuto pertanto ricorrere a un nuovo termine per indicare la nozione di ospitalità e si è creato, come già detto, partendo dalla stessa parola hostis, il termine hospes. Hospes dunque eredita e conserva in sé il valore intrinseco di reciprocità e di mutuo scambio: è forse anche per questo che la stessa parola nelle lingue derivate dal latino ha facilmente continuato a indicare sia chi ospita sia chi è ospitato.Un’ultima osservazione. Un lettore, un po’ infastidito dalla polisemia di ospite e preoccupato che nella lingua comune non ci sia una parola per indicare ‘colui che ospita’, propone di usare due termini diversi come nella lingua inglese, che ha host per ‘ospitante’ e guest per ‘ospitato’ (da notare che entrambi i termini derivano dalla stessa radice indoeuropea *ghostis, anche se host passa attraverso il francese antico (h)oste). Ci suggerisce, come sostantivo per indicare chi ospita, il termine ospitante (o addirittura trimalcione). Ma in realtà, come spesso accade nei fatti di lingua, sarà probabilmente l’uso alla fine a trovare da solo la soluzione. E a ben guardare, quando è necessario distinguere tra i due significati di ospite, l’italiano ha già preso delle decisioni e mette a disposizione un ventaglio di scelte. Se per ospite ormai si intende comunemente ‘colui che è ospitato’, per indicare ‘colui che ospita’ invece, in relazione al contesto e al grado di formalità, si può oggi già scegliere tra: il forse troppo letterario ospitatore (cfr. GDLI), il padrone di casa o semplicemente l’amico che mi ospita. Infine, il termine ospitante con il valore di ‘chi dà ospitalità’ esiste già in italiano, ad esempio nelle espressioni squadra ospitante e famiglia ospitante, e può darsi che prima o poi riuscirà a imporsi pienamente sul termine ospite con lo stesso valore.
Per approfondimenti:
 E. Benveniste, Il vocabolario della istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società, I, edizione italiana a cura di Mariantonia Liborio, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-75
E. Benveniste, Il vocabolario della istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società, I, edizione italiana a cura di Mariantonia Liborio, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-75
 Dictionnaire Étymologique de la langue latine, a cura di A. Ernout e A. Meillet, Parigi, Librairie C. Klincksieck, 1967, s.v. hospes
Dictionnaire Étymologique de la langue latine, a cura di A. Ernout e A. Meillet, Parigi, Librairie C. Klincksieck, 1967, s.v. hospes
 E. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, Padova, Tipografia del Seminario, 1771, s.v. hospes
Thesaurus linguae Latinae, Leipzig, Teubner, 1900 e sgg.,.s.v. hospes
E. Forcellini, Lexicon Totius Latinitatis, Padova, Tipografia del Seminario, 1771, s.v. hospes
Thesaurus linguae Latinae, Leipzig, Teubner, 1900 e sgg.,.s.v. hospes
 F. Venier, La corrente di Humboldt. Una lettura di La lingua franca di Hugo Schuchardt, Roma, Carocci, 2012
F. Venier, La corrente di Humboldt. Una lettura di La lingua franca di Hugo Schuchardt, Roma, Carocci, 2012*
A cura di Angela Frati e Stefania Iannizzotto
 Redazione Consulenza Linguistica
Redazione Consulenza Linguistica
 Accademia della Crusca (13 luglio 2012).
Accademia della Crusca (13 luglio 2012). -
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "SCRITTURA ED EU-CARESTIA"?! L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI.3 ottobre 2019, di Federico La SalaEU-ANGELO, EU-ROPA .... "SCRITTURA ED EU-CARESTIA"?!
 LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
LA CHIESA DI COSTANTINO, L’AMORE ("CHARITAS") E LA NASCITA DELLA DEMOCRAZIA DEI MODERNI. LA "CHARTA CHARITATIS" (1115), LA "MAGNA CHARTA" (1215) E LA FALSA "CARTA" DELLA "DEUS CARITAS EST" (2006).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- «Ogni buona conversazione presuppone il piacere della differenza». Una verità che disturba (di Padre Timothy).29 settembre 2019, di Federico La Sala
EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ... *
Spiritualità.
Radcliffe: «Credere significa porsi in dialogo»
Cosa significa credere al tempo dei fondamentalismi? In un libro le riflessioni del domenicano: «Ogni buona conversazione presuppone il piacere della differenza E prende direzioni inaspettate»
di Timothy Radcliffe (Avvenire, giovedì 26 settembre 2019)
- [Foto] Padre Timothy Radcliffe (Christian Penocchio)
- Pubblichiamo un passaggio del nuovo libro di Timothy Radcliffe, teologo di Oxford, già Maestro generale dell’Ordine dei predicatori (domenicani), Una verità che disturba. Credere al tempo dei fondamentalismi (Emi, pp. 144, euro 15, in libreria da oggi). In questo saggio Radcliffe, indaga il rapporto tra la fede e la cultura attuale attraverso alcune tematiche (la parola di Dio, la vita religiosa, la speranza, i populismi) e alcune grandi figure della Chiesa, come Oscar Romero, san Domenico, Bartolomé de Las Casas, Marie-Dominique Chenu. In occasione della pubblicazione del libro, Radcliffe tiene alcuni incontri in Italia. Domani interviene a Torino Spiritualità (Chiesa di Gesù Nazareno, ore 21) sul tema «Perché la notte appartiene agli amanti»; sabato, sempre a Torino, svolge una lectio all’Università del Dialogo del Sermig (ore 18); domenica parla al Festival Francescano di Bologna (piazza Maggiore, ore 16) su «Il dialogo creativo: conversazioni tra cristiani e non credenti». «La gioia del dialogo con i non credenti» è il titolo del suo intervento martedì a Modena, presente il vescovo Erio Castellucci (Chiesa di S. Agostino, ore 20.45). Info su www.emi.it.
Ascoltare la parola di Dio non significa assorbirla passivamente. Secondo la Dei Verbum, vuol dire impegnarsi nel dialogo di Dio con l’umanità. «Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (n. 2). Nella Verbum Domini, papa Benedetto ha scritto: «La novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che Dio si fa conoscere nel dialogo che desidera avere con noi» (n. 6). La vita di Dio è un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio nello Spirito. La Rivelazione è l’invito che Dio ci rivolge a sentirci sempre a casa, in quell’eterna e amorevole conversazione, non è ricevere messaggi dallo spazio con gli esegeti che disperatamente cercano di decifrare strani segnali come faceva il matematico Alan Turing a Bletchley Park. La Rivelazione comporta di essere assorbiti in quell’eterno dialogo che è la vita di Dio. È quindi estremamente calzante affermare che la parola di Dio si fa carne nel dialogo con l’uomo. Il Vangelo di Giovanni, per esempio, è un succedersi di conversazioni - dal dialogo di Giovanni Battista con i sacerdoti e i leviti, fino alla conversazione finale di Gesù con Pietro sulla riva del lago. La notte prima di morire, si tenne quello che siamo soliti chiamare il «discorso d’addio », ma in realtà è l’ultimo dialogo che Gesù ha con i suoi amici. È Pilato a chiudere la conversazione con un «che cos’è la verità? ». La Parola viene silenziata. Ma la conversazione riprende quando Maria di Magdala incontra Gesù nel giardino. Non è una coincidenza che i primi documenti cristiani non fossero libri o professioni di fede, ma le lettere di san Paolo: l’altra metà delle sue conversazioni con le persone.
 Leggere Paolo è come ascoltare qualcuno che parla al telefono e cercare di immaginare che cosa l’interlocutore stia dicendo all’altro capo del filo.
Leggere Paolo è come ascoltare qualcuno che parla al telefono e cercare di immaginare che cosa l’interlocutore stia dicendo all’altro capo del filo.Perciò la parola di Dio non si rivolge a noi con una purezza immacolata che precede le nostre interpretazioni. Non possiamo risalire agli autori biblici alla ricerca della cruda verità, di una parola nuda. I sostenitori della Riforma dicevano: «Lasciate perdere, abbandonate la tradizione che la corrotta Chiesa cattolica ha aggiunto, tornate alla pura parola della Bibbia!». Poi, nel XIX secolo gli studiosi iniziarono a dire: «Attenetevi alla Bibbia, al falegname di Galilea... Attenetevi a Paolo che ha inventato il cristianesimo ». State agli evangelisti: ognuno ha la propria agenda. Tornate al puro messaggio, prima che venga distorto dalle nostre risposte. Ma in questo modo ciascuno ha trovato il Gesù che amava trovare. Lo storico ebreo Geza Vermes ci ha fatto tornare a un Gesù che era un rabbino ebreo. Teologi militanti latinoamericani scoprirono che era stato un politico rivoluzionario. I professori di Oxford vi riconobbero un altro professore che, come loro, avrebbe sicuramente apprezzato un bicchiere di sherry prima dell’Ultima Cena. I californiani invece scoprirono un hippy gentile, carino con tutti, che probabilmente avrebbe preferito la marijuana allo sherry. C’è poi il Gesù gay, il Gesù infatuato della Maddalena, il Gesù simil-Gandhi nonviolento... qualsiasi Gesù ti garbi! In realtà, se ti metti a pelare i vari strati della cipolla via via fino al centro, troverai sicuramente un Gesù che assomiglia giusto a te! Allora, invece di sbucciare la cipolla, dialoghiamo. Entriamo in dialogo con la parola di Dio e lasciamocene sconvolgere. Dialoghiamo con la tradizione. Gli uni con gli altri. La conversazione porta alla conversione.
 La chiave di tutto ciò che papa Francesco sta facendo è lo sforzo di riportare il dialogo nel cuore della chiesa. Ha nominato un consiglio dei cardinali, con i quali si incontra regolarmente per discutere delle questioni della chiesa. Sta cercando di trasformare il sinodo in una vera conversazione, invece di avere delle persone che s’incontrano semplicemente per leggere dei testi che avevano scritto prima di arrivare a Roma. Io sono stato a tre sinodi, e vi assicuro che possono essere lunghi momenti estremamente noiosi. Lui invece vuole che si instauri il dialogo nel cuore di ogni parrocchia, di ogni diocesi. Ma il fondamento di tutto è il nostro dialogo con Dio.
La chiave di tutto ciò che papa Francesco sta facendo è lo sforzo di riportare il dialogo nel cuore della chiesa. Ha nominato un consiglio dei cardinali, con i quali si incontra regolarmente per discutere delle questioni della chiesa. Sta cercando di trasformare il sinodo in una vera conversazione, invece di avere delle persone che s’incontrano semplicemente per leggere dei testi che avevano scritto prima di arrivare a Roma. Io sono stato a tre sinodi, e vi assicuro che possono essere lunghi momenti estremamente noiosi. Lui invece vuole che si instauri il dialogo nel cuore di ogni parrocchia, di ogni diocesi. Ma il fondamento di tutto è il nostro dialogo con Dio.La Dei Verbum cita sant’Ambrogio (IV secolo): «Quando preghiamo, parliamo con lui; lui ascoltiamo, quando leggiamo gli oracoli divini». Ogni buona conversazione presuppone il piacere della differenza. Non ha senso avere un dialogo con chi la pensa esattamente come te. È così noioso! Una buona conversazione prende direzioni inaspettate. Non può essere controllata. E la Bibbia è piena di dialoghi. Nell’Antico Testamento ci sono conversazioni litigiose tra i profeti e i re; e c’è un dialogo tra l’Antico e il Nuovo Testamento.
 Il Nuovo Testamento abbraccia le differenze con un entusiasmo temerario. Al suo centro sta il dialogo tra i quattro Vangeli. Come ha scritto il teologo Francis Watson: «È emerso lentamente un consenso sul fatto che i quattro Vangeli debbano essere letti l’uno accanto all’altro e che a nessun altro Vangelo debba essere permesso di condividere la loro conversazione intratestuale». Quattro Vangeli che non vanno d’accordo tra loro. Nel II secolo, la chiesa si oppose fermamente a quei timorosi che volevano ridurli a una singola e coerente narrazione. La nostra interpretazione della morte di Gesù è un dialogo senza fine, da una parte con i racconti di Marco e Matteo che parlano di un uomo che grida che Dio l’ha abbandonato, e dall’altra con le narrazioni dei più sereni Luca e Giovanni, nelle quali egli confida e si abbandona allo Spirito. È una conversazione che continuerà fino a che non avremo scoperto la verità di Dio che resta al di là di ogni parola.
Il Nuovo Testamento abbraccia le differenze con un entusiasmo temerario. Al suo centro sta il dialogo tra i quattro Vangeli. Come ha scritto il teologo Francis Watson: «È emerso lentamente un consenso sul fatto che i quattro Vangeli debbano essere letti l’uno accanto all’altro e che a nessun altro Vangelo debba essere permesso di condividere la loro conversazione intratestuale». Quattro Vangeli che non vanno d’accordo tra loro. Nel II secolo, la chiesa si oppose fermamente a quei timorosi che volevano ridurli a una singola e coerente narrazione. La nostra interpretazione della morte di Gesù è un dialogo senza fine, da una parte con i racconti di Marco e Matteo che parlano di un uomo che grida che Dio l’ha abbandonato, e dall’altra con le narrazioni dei più sereni Luca e Giovanni, nelle quali egli confida e si abbandona allo Spirito. È una conversazione che continuerà fino a che non avremo scoperto la verità di Dio che resta al di là di ogni parola.Ci poniamo in ascolto di questa conversazione e troviamo il coraggio di intervenire, come bambini che osano intromettersi nelle conversazioni degli adulti. E così, lentamente, essa ci trasforma. Smonta uno per uno i nostri pregiudizi, ci cura dalla violenza. Da una generazione all’altra, come il lievito nella chiesa. Ci sono voluti migliaia di anni prima che il Dio violento dei testi più antichi diventasse il Dio misericordioso, padre del figliol prodigo. Pensate solo alla schiavitù.
 Paolo scriveva che in Cristo «non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Ma nella sua Lettera a Filemone egli sembra tollerare la schiavitù. Considera Onesimo suo figlio, e vorrebbe che fosse trattato come un diletto fratello, ma non mette mai in discussione l’istituzione della schiavitù. Questa era universale all’epoca, non si sarebbe potuto immaginare una società senza di essa.
Paolo scriveva che in Cristo «non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Ma nella sua Lettera a Filemone egli sembra tollerare la schiavitù. Considera Onesimo suo figlio, e vorrebbe che fosse trattato come un diletto fratello, ma non mette mai in discussione l’istituzione della schiavitù. Questa era universale all’epoca, non si sarebbe potuto immaginare una società senza di essa.
 Solo con Bartolomé de Las Casas - come visto sopra - l’idea stessa di schiavitù iniziò ad essere ripudiata. I domenicani spagnoli riuscirono a persuadere il papa a denunciarla nell’enciclica Sublimis Deus del 1537. Spesso dimentichiamo che per secoli il papato ha denunciato qualsiasi forma di schiavitù. Ma abbiamo ancora molta strada da fare. Nel XIX secolo riconoscemmo la schiavitù dei lavoratori incatenati alle loro macchine. Oggi assistiamo alla riduzione in schiavitù delle donne dovuta alla tratta sessuale. Nonostante la Parola sia stata pronunciata da Gesù una volta per tutte e per sempre, la sua eco continua ad interrogarci, a sfidarci, a incalzarci ad andare oltre.
Solo con Bartolomé de Las Casas - come visto sopra - l’idea stessa di schiavitù iniziò ad essere ripudiata. I domenicani spagnoli riuscirono a persuadere il papa a denunciarla nell’enciclica Sublimis Deus del 1537. Spesso dimentichiamo che per secoli il papato ha denunciato qualsiasi forma di schiavitù. Ma abbiamo ancora molta strada da fare. Nel XIX secolo riconoscemmo la schiavitù dei lavoratori incatenati alle loro macchine. Oggi assistiamo alla riduzione in schiavitù delle donne dovuta alla tratta sessuale. Nonostante la Parola sia stata pronunciata da Gesù una volta per tutte e per sempre, la sua eco continua ad interrogarci, a sfidarci, a incalzarci ad andare oltre.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SINODO DEI VESCOVI 2008. L’ANNO DELLA PAROLA DI DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
LA PAROLA DI DIO, IL SINODO DEI VESCOVI, E UN OMAGGIO AI FRATELLI MAGGIORI E A SIGMUND FREUD. Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, dopo due anni, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! E che confusione spirituale di lunga durata!!!
Federico La Sala
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Per una "società più accogliente", appuntamento il 20 maggio 2020. Umanità più fraterna, il Papa invita i Grandi per un nuovo patto educativo.12 settembre 2019, di Federico La Sala
Messaggio.
Umanità più fraterna, il Papa invita i Grandi per un nuovo patto educativo *
L’appuntamento il 20 maggio nell’Aula Paolo VI per una "società più accogliente". L’annuncio della Congregazione per l’educazione cattolica. Francesco: dialoghiamo su come costruire il futuro
Il Papa convoca a Roma per il 14 maggio 2020 personalità di tutto il mondo insieme ai giovani per una serie di iniziative, dibattiti, tavole rotonde per una "società più accogliente". La Congregazione per l’Educazione Cattolica spiega il motivo di questo evento mondiale che si svolgerà in Vaticano nell’Aula Paolo VI: "Sono invitate a prendere parte all’iniziativa proposta le personalità più significative del mondo politico, culturale e religioso, ed in particolare i giovani ai quali appartiene il futuro. L’obiettivo è di suscitare una presa di coscienza e un’ondata di responsabilità per il bene comune dell’umanità, partendo dai giovani e raggiungendo tutti gli uomini di buona volontà".
"L’iniziativa - spiega ancora la Congregazione per l’Educazione Cattolica in una nota - è la risposta ad una richiesta. In occasione di incontri con alcune personalità di varie culture e appartenenze religiose è stata manifestata la precisa volontà di realizzare una iniziativa speciale con il Santo Padre, considerato una delle più influenti personalità a livello mondiale e, tra i temi più rilevanti, è stato da subito individuato quello del Patto educativo, richiamato più volte dal Papa nei suoi documenti e discorsi. Il quinto anniversario dell’enciclica Laudato sì, con il richiamo all’ecologia integrale e culturale, si offre come piattaforma ideale per tale evento".
In un messaggio il Pontefice rinnova "l’invito a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente". Ricorda ancora Bergoglio che "in un percorso di ecologia integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni creatura, in relazione con le persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che respinga la cultura dello scarto. Un altro passo è il coraggio di investire le migliori energie con creatività e responsabilità".
Sul tema, bel sito, si cfr.:
Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
- "AVREMMO BISOGNO DI DIECI FRANCESCO DI ASSISI". LA RIVOLUZIONE EVANGELICA, LA RIVOLUZIONE RUSSA, E L’ "AVVENIRE" DELL’UNIONE SOVIETICA E DELLA CHIESA CATTOLICA. Le ultime riflessioni di Lenin raccolte da Viktor Bede
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Un governo per difendere la Costituzione (di Luigi Ferrajoli).7 settembre 2019, di Federico La Sala
Un governo per difendere la Costituzione
M5S-Lega. Il dovere delle forze democratiche è quello di dar vita a un governo che ripari i guasti prodotti proprio da chi quelle politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone ha praticato e intende riproporre con più forza ove vincesse le elezioni
di Luigi Ferrajoli (il manifesto, 25.08.2019)
C’è una ragione di fondo che impone alla sinistra la formazione di un governo giallo-rosso: la necessità, prima di porre termine alla legislatura, di disintossicare la società italiana dai veleni in essa immessi da oltre un anno di politiche ferocemente disumane contro i migranti. La Lega di Salvini intende «capitalizzare il consenso» ottenuto a tali politiche pretendendo nuove elezioni e chiedendo al popolo «pieni poteri».
L’idea elementare della democrazia sottostante a questa pretesa - poco importa se per analfabetismo istituzionale o per programmatico disprezzo delle regole - è la concezione anticostituzionale dell’assenza di limiti alla volontà popolare incarnata dalla maggioranza e, di fatto, dal suo capo: dunque, l’esatto contrario di quanto voluto dalla Costituzione, cioè la negazione del sistema di vincoli, di controlli e contrappesi da essa istituito a garanzia dei diritti fondamentali delle persone e contro il pericolo di poteri assoluti e selvaggi.
Non dimentichiamo quanto scrisse Hans Kelsen contro questa tentazione del governo degli uomini, e di fatto di un capo, in alternativa al governo delle leggi: «la democrazia», egli scrisse, «è un regime senza capi», essendo l’idea del capo al tempo stesso non rappresentativa della complessità sociale e del pluralismo politico, e anti-costituzionale perché in contrasto con la soggezione alla legge e alla Costituzione di qualunque titolare di pubblici poteri.
Di fronte a queste pretese, il dovere delle forze democratiche - di tutte quelle che si riconoscono non già nell’idea dell’onnipotenza delle maggioranze ma in quella dei limiti e dei vincoli ad esse imposte dalla Costituzione - è quello di dar vita a un governo che ripari i guasti prodotti proprio da chi quelle politiche velenose contro la vita e la dignità delle persone ha praticato e intende riproporre con più forza ove vincesse le elezioni.
Dunque un governo di disintossicazione dall’immoralità di massa generata dalla paura, dal rancore e dall’accanimento - esibito, ostentato - contro i più deboli e indifesi.
Non un governo istituzionale o di transizione, che si presterebbe all’accusa di essere un governo delle poltrone, ma al contrario un governo di esplicita e dichiarata difesa della Costituzione che ristabilisca i fondamenti elementari della nostra democrazia costituzionale: la pari dignità delle persone, senza differenze di etnia o di nazionalità o di religione, il diritto alla vita, il rispetto delle regole del diritto internazionale, prima tra tutte il dovere di salvare le vite umane in mare, il valore dei diritti umani e della solidarietà, il rifiuto della logica del nemico, come sempre identificato con i diversi e i dissenzienti e immancabilmente accompagnato dal fastidio per la libera stampa e per i controlli della magistratura sull’esercizio illegale dei poteri.
Su questa base non ha nessun senso condizionare il governo di svolta a un no a un Conte-bis o alla riduzione del numero dei parlamentari.
L’alternativa possibile è un governo Salvini, preceduta dalla riduzione dei parlamentari ad opera di una rinnovata alleanza giallo-verde, e poi chissà quante altre e ben più gravi riforme in tema di giustizia, di diritti e di assetto costituzionale.
Una probabile maggioranza verde-nera eleggerebbe il proprio capo dello Stato e magari promuoverebbe la riforma della nostra repubblica parlamentare in una repubblica presidenziale. Di fronte a questi pericoli non c’è spazio per calcoli o interessi di partito.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Sonny, il protagonista artificiale del famoso film "Io robot" e il «Nuovo umanesimo».2 settembre 2019, di Federico La Sala
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI... *
Dopo il discorso di Conte.
«Nuovo umanesimo» in politica: è tempo di dirlo e di farlo
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, domenica 1 settembre 2019)
«Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un nuovo umanesimo. Non ho mai pensato che fosse lo slogan di un governo. Ho sempre pensato che fosse l’orizzonte ideale per un intero Paese». Questa frase, pronunziata giovedì al Quirinale da Giuseppe Conte nel discorso con cui ha accettato di verificare la possibilità di formare un nuovo esecutivo, è stata ripresa dai media in modo spesso superficiale e talvolta in maniera irridente, in alcuni casi come esclusivo supporto alla cultura dell’accoglienza, soprattutto verso i migranti, e tuttavia, ha bisogno di essere ulteriormente pensata e approfondita.
Non bisogna dimenticare che la Chiesa italiana, nel suo V convegno nazionale, celebrato a Firenze nel 2015, è stata chiamata a riflettere sul tema del ’nuovo umanesimo’ nel suo radicamento cristologico. Il titolo di quell’evento recitava ’In Cristo il nuovo umanesimo’. E papa Francesco nella riflessione che ha proposto ai vescovi italiani nell’Assemblea generale del maggio scorso ha richiamato, in particolare con riferimento alla sinodalità, il discorso che aveva pronunziato in quell’occasione.
 Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
 Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).
Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).Richiamando la Costituzione, si è fatto riferimento al ’primato della persona’, come radice antropologica di ogni azione sociale, politica, culturale. Come tutti sanno, o dovrebbero sapere - e qui il rammarico per averlo troppo spesso tralasciato e dimenticato -, la nozione di ’persona’, nella sua pregnanza ontologica, è stata consegnata (o, meglio, donata) all’Occidente dalle vicende delle dispute cristologiche e trinitarie dei primi secoli, messe in atto in ambito cristiano. Si è pensato l’umano a partire dall’identità di Cristo e dal mistero di Dio.
 Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
 Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
 Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.
Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.In questa prospettiva vanno letti gli autorevoli inviti - in particolare quello del presidente della Cei Gualtiero Bassetti - a fondare un’autentica prospettiva politica non su dei semplici contratti, spesso frutto di miopi compromessi, che prima o poi esplodono, determinando la catastrofe del rapporto, ma su una visione programmatica, basata appunto su vere e proprie alleanze.
Non possiamo non ricordare che la prospettiva rosminana si rifà alla definizione di Giovanni Duns Scoto, che a sua volta radicalizza la visione di Riccardo di San Vittore (per il quale la persona è intellectualis naturae incommunicabilis existentia) fino a definirla ultima solitudo. Il Roveretano infatti afferma che la persona è una sostanza spirituale dotata di un principio incomunicabile. Così possiamo cogliere la caratteristica fondamentale della persona, ossia la sua unicità.
Sonny, il protagonista artificiale del famoso film Io robot, allorché si scopre ’quasi umano’ e ne prende coscienza, afferma con stupore: «Io sono unico». La macchina si produce, la persona si genera. Questa unicità rende preziosa ogni persona e determina un’etica della sua salvaguardia a qualsiasi classe, cultura, religione, regione, cultura appartenga.
Ma, oltre che unicità, la persona dice anche ulteriorità. Un aforisma che ci giunge dall’antica sapienza (Seneca, Naturales quaestiones) recita: «Oh quam contempta res est homo, nisi supra humana surrexerit», che cosa misera è l’umanità se non si sa elevare oltre l’umano... In questa breve espressione si sintetizza in maniera mirabile l’ulteriorità della condizione umana, espressa peraltro col verbo (surrexerit) che fa riferimento alla risurrezione. Quell’«essere della lontananza » che è l’uomo, infatti, proprio a partire dalla sua distanza originaria e dal suo oltrepassamento realizza la più piena prossimità alle cose (Martin Heidegger). E da questo senso della ’trascendenza’ dell’umano il pensiero credente non è certo assente, anzi lo afferma, per esempio in un famoso frammento di Blaise Pascal, che viene a stemperare il facile ottimismo di un progresso ideologicamente mitizzato - allorché afferma che «La natura dell’uomo non è di avanzare sempre; ha i suoi alti e bassi» (fr. 318 ed. Brunschvicg) - e a mettere in guardia da una possibile deriva spiritualistica dell’antropologia: «L’uomo non è né angelo né bestia, e disgrazia vuole che chi vuol fare l’angelo fa la bestia» (fr. 325 ed. Brunschvicg).
Il nuovo umanesimo, che non intenda esprimersi nella forma di un acritico antropocentrismo, chiede così di declinarsi e di realizzarsi attraverso autentiche alleanze, spesso purtroppo infrante, fra uomo e natura, fra i generi, fra le generazioni, fra il cittadino e le istituzioni, fra emozione e ragione, fra popoli e religioni. Una saggia fatica che certo non può essere il risultato di un programma di Governo, ma quel quel programma può ben ispirare e illuminare. E che richiede una visione culturale e antropologica alla quale i cristiani possono efficacemente contribuire.
Teologo, Pontificia Università Lateranense
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO"
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Duemila anni di storia. Una nuova scommessa per la Chiesa di oggi (di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti).25 agosto 2019, di Federico La Sala
Riflessione.
Una nuova scommessa per la Chiesa di oggi
di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti (Avvenire, giovedì 22 agosto 2019)
- Duemila anni di storia, un miliardo e 300 milioni di fedeli in continua crescita nei paesi del Sud del mondo. Eppure la Chiesa cattolica appare invecchiata e impacciata, soprattutto in Europa dove per la maggior parte dei trentenni la «questione Dio» ha scarsa rilevanza, e gli scandali finanziari e sessuali hanno nuociuto alla sua reputazione. Partendo da questo stato delle cose Chiara Giaccardi e Mauro Magatti hanno scritto un saggio - La scommessa cattolica (il Mulino, pagine 200, euro 15, da oggi in libreria, dal quale anticipiamo alcuni stralci dell’introduzione). Quale scommessa? I due autori si chiedono - come recita il sottotitolo - se «c’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?». Che futuro per un mondo che recide completamente il dialogo con la religione?
Duemila anni di storia, un miliardo e trecento milioni di fedeli in continua crescita grazie alla spinta demografica dei paesi del Sud del mondo. Da un certo punto di vista, la Chiesa cattolica gode di ottima salute. Eppure, dietro la facciata rassicurante dei numeri, si odono scricchiolii allarmanti che non possono essere sottovalutati. Crollo della partecipazione religiosa nelle società più avanzate; difficoltà particolarmente forti tra i giovani e i ceti più istruiti; sensibile riduzione delle vocazioni. Sintomi eloquenti, ai quali si aggiunge la perdita di reputazione causata dagli scandali finanziari e dagli abusi sessuali.
Lo spostamento del baricentro in aree economicamente, politicamente e socialmente più arretrate è dunque una buona notizia solo a metà. In quei paesi - dove il livello istituzionale è meno evoluto e il rapporto con le persone più diretto - la Chiesa gioca su un terreno che le è più congeniale. Ma il timore è che le cose siano destinate a cambiare rapidamente anche in quei contesti. Difficile immaginare un futuro se la Chiesa rinuncia a dialogare con la parte più avanzata del mondo.
Almeno in Europa la Chiesa si trova di fronte a uno snodo generazionale senza precedenti: nella popolazione che ha meno di 30 anni, coloro che non credono semplicemente perché si sentono del tutto indifferenti e apatici rispetto alla «questione Dio» (i cosiddetti nones) sono netta maggioranza. Come se la cosa non li riguardasse, come se non riuscissero neppure a cogliere il senso della domanda: credi tu? Di Dio sembra proprio non sentirsi la necessità.
Oggetto di un discorso ormai superato, residuo di tradizioni che sconfinano nella superstizione o bandiera di fondamentalismi che sfociano nella violenza: è questo il registro in cui la questione della fede viene oggi rubricata in Europa da buona parte della popolazione, specie giovanile. Quando la generazione di chi oggi ha 70 anni e più passerà, la Chiesa europea, già assottigliata, si ritroverà con un numero assai esiguo di fedeli. C’è una questione organizzativa: la struttura della Chiesa - burocratizzata e gerarchica - appare inadatta a stare al passo con un mondo diventato veloce e plurale. Manca la consapevolezza che non è più possibile parlare dell’esperienza religiosa oggi usando lo stesso discorso di quando la fede era un’evidenza sociale.
Occorrerebbero, piuttosto, parole in cammino, che cerchino di dare voce e forma al diffuso senso di precarietà. Parole capaci di trasmettere l’esperienza della fede dove, con Michel de Certeau, «la sola stabilità è spingere il pellegrinaggio più in là», alla ricerca di nuove vie di presenza e narrazione. Ma sembra difficile, quasi impossibile, trovarle. C’è ancora spazio per la «buona novella» cristiana nel mondo di oggi? Ci può essere ancora una domanda che non trova risposta in ciò che già c’è, o nelle promesse di un progresso della scienza, della tecnica, dell’economia nel quale si ripongono ormai tutte le speranze di salvezza?
Facciamo un passo indietro. Se il messaggio del Vangelo, la buona notizia dell’amore che salva e vince la morte, è arrivato fino a noi è perché ha saputo parlare al profondo del cuore degli uomini e delle donne lungo i venti secoli che ci hanno preceduti. Riuscendo così a ispirare il modo di pensare e di vivere di intere società. Questa forza che ha attraversato la storia si è fondata su almeno tre pilastri, che sono però oggi tutti soggetti a una profonda erosione, sotto la spinta di cambiamenti storico-culturali di enorme portata.
Il primo pilastro ha a che fare con lo spinosissimo nodo dell’onnipotenza. Prendendo le distanze dalle religioni che l’avevano preceduta - nelle quali la potenza del sacro si manifestava al di là di qualunque limite -, quella cristiana è sempre stata molto attenta a evitare di farsi schiacciare dall’onnipotenza di Dio. In questo modo, essa ha potuto garantire una scansione tra ordine religioso e ordine politico, aprendo una dialettica che nel corso della storia si è rivelata straordinariamente fruttuosa. È per il fatto impensabile di essere una religione in cui è Dio che si sacrifica per l’uomo - e non viceversa - che quella cristiana ha potuto essere grembo per l’affermazione della soggettività moderna. Persino Nietzsche ha riconosciuto che proprio «grazie al cristianesimo l’individuo acquistò un’importanza così grande, fu posto in modo così assoluto, che non lo si poté più sacrificare».
E tuttavia, come in altre epoche, anche oggi - dentro e fuori la Chiesa - questo «scandalo» evangelico fatica a trovare ascolto: come far capire all’uomo contemporaneo - affascinato dai miti dell’efficienza, della performance, della (onni) potenza tecnica o all’opposto attratto da una divinità a cui semplicemente sottomettersi - il significato liberatorio di un Dio che, con le parole di Hölderlin, «crea l’uomo come il mare la terra: ritirandosi»?
E che mostra la propria «potenza» incarnandosi in un bambino e facendosi appendere a una croce? Il secondo pilastro riguarda la salvezza personale, tema essenziale per ogni grande religione. Dio salva la vita di ciascuno. Nella storia del cristianesimo ci sono state, come è naturale, molte oscillazioni attorno a questo tema, in una continua tensione fra terra e cielo, corpo e anima. Con la modernità, come sappiamo, sul piano culturale il baricentro si è spostato dalla salvezza eterna al successo mondano, dalla cura dell’anima al benessere materiale. Di quale salvezza si può dunque parlare oggi, quando la tecnica arriva addirittura a immaginare di poter promettere l’«immortalità»? Il terzo pilastro tocca il tema della universalità.
La Chiesa ha sempre riconosciuto e coltivato la propria vocazione universale, consapevole della necessità di parlare a tutti. Condizione per essere chiesa, appunto, anziché setta, piccolo gruppo di duri e puri ripiegati su sé stessi e separati dal resto del mondo. Sappiamo che la relazione tra fede e ragione, ereditata dalla tradizione greca e latina, è stata di enorme importanza. Sin dall’inizio la Chiesa ha intuito che il proprio destino sarebbe stato legato a quello della ragione. Ma il problema è che nel corso degli ultimi secoli si sono modificati i termini stessi della questione. Da una parte, il restringimento alla sola dimensione strumentale (vero è ciò che è certo, e dunque ciò che funziona e realizza rapidamente le promesse) ha di molto diminuito la capacità della ragione di essere guida sicura all’agire umano. Diventata tecnica, l’ambito principio in cui la ragione sembra applicarsi è il problem solving e il suo obiettivo il superamento del limite, di ogni limite.
Così, ciò che oggi sembra unificare il mondo è il grande sistema tecno/economico che, con la sua neutralità etica e le sue pretese di controllo, vorrebbe rendere superflua la stessa questione religiosa. Ma è realistico un tale progetto? Dall’altra parte, se oggi, come dicono le stime dell’autorevole Pew Research Institute, su dieci abitanti della terra tre sono cristiani, cosa vuol dire pensarsi come «universali »? In un pianeta diventato piccolo, senza più terre da esplorare, ma dove le diverse tradizioni religiose - che pure si delocalizzano e si innestano un po’ dappertutto - hanno sedimenti ormai consolidati, come sviluppare il dialogo interreligioso?
Questione che a maggior ragione investe l’ecumenismo: quale ruolo il cattolicesimo romano può e deve giocare rispetto alle altre confessioni cristiane, numericamente più deboli ma custodi di ricchezze da rimettere in gioco, a vantaggio dei cattolici stessi e del mondo intero? In questa cornice, all’inizio del XXI secolo, la scommessa cattolica non è allora né quella di rincorrere qualcosa che starebbe davanti - la piena affermazione della modernità, con tutti i suoi successi - né di inseguire un sogno di restaurazione e rinnovata centralità - cullandosi nella nostalgia di un passato ormai perduto. Si tratta, piuttosto, di muovere i primi passi di una via nuova, recuperando la consapevolezza di avere qualcosa di inaudito da dire. Qualcosa che manca a questo tempo. Qualcosa di prezioso per il nostro futuro comune.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’ORA. QUASI UN MINIMO PROGRAMMA DI GOVERNO.Finisca il tempo dell’odio e della follia (di "La nonviolenza e’ in cammino").22 agosto 2019, di Federico La Sala
L’ORA. QUASI UN MINIMO PROGRAMMA DI GOVERNO (UN DISCORSO QUESTA MATTINA IN PIAZZA, RIASSUNTO IN POCHE PAROLE)
I. Finisca il tempo dell’odio
Finisca il tempo dell’odio e della follia
 non mangino piu’ carne umana i ministri della repubblica
non mangino piu’ carne umana i ministri della repubblicasiano soccorsi tutti i naufraghi
 siano liberati e portati in salvo tutti i prigionieri dei lager libici
siano liberati e portati in salvo tutti i prigionieri dei lager libici
 sia dato aiuto e asilo a chi fugge dalle guerre e dalla fame
sia dato aiuto e asilo a chi fugge dalle guerre e dalla fame
 sia dato aiuto e asilo a chi fugge da dittature e schiavitu’
sia dato aiuto e asilo a chi fugge da dittature e schiavitu’torni l’Italia alla civilta’
 siano abrogate tutte le antileggi hitleriane
siano abrogate tutte le antileggi hitleriane
 sia ripristinato il dovere di soccorrere chi e’ in pericolo
sia ripristinato il dovere di soccorrere chi e’ in pericolo
 si condivida il pane tra sorelle e fratelli
si condivida il pane tra sorelle e fratelliogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereII. Rinuncino a commettere ulteriori crimini
Rinuncino a commettere ulteriori crimini altri ebbri abominii
 i ministri gia’ decaduti
i ministri gia’ decadutiin questi pochi giorni d’interregno
 s’attengano finalmente al rispetto della Costituzione
s’attengano finalmente al rispetto della Costituzionegia’ tanti delitti hanno commesso per cui saranno giudicati in tribunale
 non aggiungano in guisa di colpo di coda finale altri orrori
non aggiungano in guisa di colpo di coda finale altri orrorisi ricordino almeno ora
 della loro umanita’
della loro umanita’
 dell’umanita’ di tutti gli esseri umani
dell’umanita’ di tutti gli esseri umaniogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereIII. Con la forza della verita’
Con la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 si riconquista il bene comune
si riconquista il bene comunecon la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 l’umanita’ intera torna interamente umana
l’umanita’ intera torna interamente umanacon la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 si abbattono i regimi totalitari
si abbattono i regimi totalitaricon la forza della verita’ con la scelta della nonviolenza
 si salvano tutte le vite
si salvano tutte le viteogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereIV. Qui e adesso
Qui e adesso occorre che ogni persona di volonta’ buona
 insorga per salvare tutte le vite
insorga per salvare tutte le vitequi e adesso occorre che la repubblica
 torni ad essere una repubblica
torni ad essere una repubblicaqui e adesso valga finalmente
 la legge che salva tutte le vite
la legge che salva tutte le vitequi e adesso
 si riconoscano uguali io e tu
si riconoscano uguali io e tu
 si facciano noi
si facciano noi
 vale per tutti dinanzi a ogni ingiustizia
vale per tutti dinanzi a ogni ingiustizia
 il motto del resistente je me revolte donc nous sommes
il motto del resistente je me revolte donc nous sommesogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovereV. E quasi un minimo programma di governo
1. abrogare immediatamente tutte le misure razziste e persecutorie imposte dal governo razzista teste’ caduto (ma anche le altre imposte dai governi precedenti che hanno aperto la strada all’inabissamento nella brutalita’ di quest’ultimo anno);
 2. ripristinare l’adempimento del dovere di soccorrere chi e’ in pericolo;
2. ripristinare l’adempimento del dovere di soccorrere chi e’ in pericolo;
 3. escludere da ogni incarico di governo chi e’ stato complice dell’esecutivo razzista ora caduto;
3. escludere da ogni incarico di governo chi e’ stato complice dell’esecutivo razzista ora caduto;
 4. ripristinare la legalita’ costituzionale che il governo della disumanita’ ha infranto;
4. ripristinare la legalita’ costituzionale che il governo della disumanita’ ha infranto;
 5. riconoscere il diritto di voto e tutti gli altri diritti sociali, civili e politici a tutte le persone che vivono in Italia, facendo cessare l’effettuale regime di apartheid e di schiavitu’ di cui sono vittima milioni di nostri effettivi conterranei.
5. riconoscere il diritto di voto e tutti gli altri diritti sociali, civili e politici a tutte le persone che vivono in Italia, facendo cessare l’effettuale regime di apartheid e di schiavitu’ di cui sono vittima milioni di nostri effettivi conterranei.Ogni essere umano ha diritto alla vita alla dignita’ alla solidarieta’
 siamo una sola umanita’ in quest’unico mondo vivente casa comune dell’umanita’ intera
siamo una sola umanita’ in quest’unico mondo vivente casa comune dell’umanita’ intera
 il razzismo e’ un crimine contro l’umanita’
il razzismo e’ un crimine contro l’umanita’
 ogni vittima ha il volto di Abele
ogni vittima ha il volto di Abele
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo doveresalvare le vite e’ il primo dovere
 chi salva una vita salva il mondo
chi salva una vita salva il mondo
 sii tu il buon samaritano
sii tu il buon samaritano
 sii tu l’umanita’ come dovrebbe essere
sii tu l’umanita’ come dovrebbe essereogni essere umano ha diritto alla vita
 salvare le vite e’ il primo dovere
salvare le vite e’ il primo dovere* FONTE: "LA NONVIOLENZA CONTRO IL RAZZISMO. Supplemento de "La nonviolenza e’ in cammino" (anno XX). Numero 303 del 22 agosto 2019.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- “SOCRATE E ARISTOFANE" - E LA LEZIONE DI NIETZSCHE E DIOTIMA. Note.14 luglio 2019, di Federico La Sala
L’EUROPA, “SOCRATE E ARISTOFANE", E “LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE ... *
Leo Strauss, i classici greci per capire il rapporto tra filosofia e politica
di Matteo Moca (Alfabeta-2, 14.07.2019)
- Leo Strauss, Socrate e Aristofane, cura e introduzione di Marco Menon, ETS, pp. 336 euro 30.
«La nostra Grande Tradizione include la filosofia politica e perciò sembra garantirne la possibilità e la necessità. Secondo la medesima tradizione, la filosofia politica è stata fondata da Socrate. Dal momento che Socrate non ha scritto libri o discorsi, la nostra conoscenza delle circostanze in cui, o delle ragioni per cui, la filosofia politica è stata fondata, dipende interamente dai resoconti di altri uomini». Così, squadernando una questione di grande importanza e difficile soluzione, si apre l’introduzione che Leo Strauss scrisse per il suo Socrate e Aristofane, pubblicato adesso come primo volume - curato e introdotto da Marco Menon - della nuova importante collana “Straussiana” delle Edizioni ETS, diretta da Carlo Altini, Raimondo Cubeddu e Giovanni Giorgini, una collana che si propone, anche scorrendo i titoli che risultano in preparazione, di dare un nuovo e maggiore spazio editoriale a uno dei pensatori più importanti del Novecento. Socrate e Aristofane rappresenta certamente una summa del pensiero filosofico di Strauss, e dunque una privilegiata porta di accesso alla sua filosofia, per molteplici motivi: innanzitutto per l’andamento e la forma precisa e minuziosa dell’interrogazione del testo antico, che pare assecondare quel dialogo con gli autori che deve precedere la lettura dell’opera, ma anche perché l’analisi del testo di Aristofane mette in gioco i temi principali della sua riflessione, ovviamente riscontrabili nelle altre sue opere, come la relazione tra la filosofia e la politica, l’analisi della religione e il rapporto tra la politica e l’arte.
L’interesse per Aristofane e per i classici greci nell’orizzonte della ricerca sulla filosofia politica, come ricostruisce precisamente nella prefazione Marco Menon, diventa per Strauss sostanzioso a partire dalla fine degli anni Trenta: questa attenzione prende la direzione dell’analisi del rapporto tra Aristofane, Senofonte e Platone, come testimonia chiaramente una lettera di Strauss del 1947 che fa bene intendere su cosa si stia assestando la sua ricerca: «Sto studiando ancora la Repubblica. Penso che la querelle tra filosofia e poesia possa essere intesa nei termini di Platone; filosofia significa la ricerca della verità; [...] poesia significa qualcos’altro, ad esempio, nel migliore dei casi, la ricerca di un tipo particolare di verità». All’interno di questa discussione emerge la centralità della figura di Aristofane, perché Strauss rintraccia come il suo attacco a Socrate, rintracciabile non solo nelle Nuvole ma in molte delle sue commedie, si concentri proprio sulla questione della superiorità della filosofia o della poesia. Tentare di comprendere la centralità di Socrate nella filosofia politica, come emerge anche dal passo dell’Introduzione precedentemente citato, implica la lettura di Aristofane: via privilegiata per comprendere la vera natura di Socrate sarà il confronto tra il ritratto platonico e quello aristofaneo, l’autore del Simposio ammirava Socrate, Aristofane no, (l’attenzione di Strauss si concentra anche su Senofonte, che insieme a Platone e Aristofane conobbe Socrate di persona): si tratta però di uno studio che sottende un discorso al presente e non si limita solo allo studio dell’antichità. Su questo punto è preciso Strauss quando scrive di come, dopo gli attacchi di Nietzsche a Platone e a Socrate, il suo ritorno alle origini «è diventato necessario a causa della radicale messa in discussione di quella tradizione».
Socrate e Aristofane viene concluso da Strauss, dopo una lunga fase preparatoria e di studio, nel 1965, ma la sua pubblicazione è accolta con freddezza anche da parte dei suoi corrispondenti più stretti (Karl Löwith per esempio, a cui Strauss scriverà dopo aver ricevuto uno stringato commento: «La sua frase sul mio capitolo sulle Nuvole mi ha rallegrato molto: è quasi l’unica parola di incoraggiamento che ho sentito da molti anni! Ma non vorrebbe leggere anche gli altri capitoli?»), nonostante questo testo si concentri, come sottolinea Menon, sulla questione fondamentale della differenza tra physis e nomos, «che riveste un ruolo costruttivo per la filosofia stessa» e trascenda ben presto, pur nell’organicità della lettura, i testi di Aristofane per addentrarsi tra i sentieri speculativi a lui più cari, come la natura del teatro drammatico e il suo ruolo edificante, la dualità tra illuminismo e tradizionalismo, la vita nella città o l’imprescindibile ruolo della politica. -Strauss espone come le fonti platoniche e aristofanee su Socrate siano divergenti (Senofonte è invece considerato da Strauss come un testimone più solido in quanto continuatore delle storie di Tucidide): nei dialoghi del primo, Socrate è idealizzato ed è molto difficile distinguere nettamente ciò che Socrate ha pensato e quello che gli viene attribuito da Platone, utilizzando invece le Nuvole di Aristofane è possibile conoscere il Socrate presocratico, e cioè analizzare il passaggio dalla filosofia stricto sensu alla filosofia politica e dunque, ancora, andare a ricercare nei territori che sono alla base della disciplina filosofica.
 La lettura di Strauss si articola in numerosi capitoli, ognuno dedicato a una delle commedie di Aristofane: attraverso una lettura filologica, in queste testi emergono alcuni temi centrali della filosofia di Strauss, come il discorso sugli dei, già precedentemente evocato, nella lettura di Uccelli, Rane e Pluto, dove Aristofane solleva problematiche centrali per la definizione della divinità, oppure la riflessione sul rapporto tra Atene e Gerusalemme, nome di uno dei suoi libri più importanti ma soprattutto metafora della scelta tra filosofia e Bibbia, tra due città sacre.
La lettura di Strauss si articola in numerosi capitoli, ognuno dedicato a una delle commedie di Aristofane: attraverso una lettura filologica, in queste testi emergono alcuni temi centrali della filosofia di Strauss, come il discorso sugli dei, già precedentemente evocato, nella lettura di Uccelli, Rane e Pluto, dove Aristofane solleva problematiche centrali per la definizione della divinità, oppure la riflessione sul rapporto tra Atene e Gerusalemme, nome di uno dei suoi libri più importanti ma soprattutto metafora della scelta tra filosofia e Bibbia, tra due città sacre.
 Lo spazio maggiore è dedicato a Nuvole, nonostante comunque ognuna delle commedie venga messa in relazione da Strauss con le altre, costruendo un vero e proprio studio organico sull’opera di Aristofane, perché Nuvole rappresenta il luogo centrale per l’indagine sul giudizio aristofaneo su Socrate. Attraverso questa dettagliata analisi, Strauss arriva alla conclusione, se di giudizi definitivi si può in questi casi parlare, che Aristofane si credeva superiore a Socrate, «in virtù della sua conoscenza di sé e della sua prudenza»: infatti, scrive Strauss, «se da una parte Socrate è totalmente indifferente nei confronti della città che lo mantiene, dall’altra Aristofane si occupa molto della città» e, ancora, se Socrate «non rispetta le necessità fondamentali della città, o non vi si attiene, dall’altra Aristofane lo fa».
Lo spazio maggiore è dedicato a Nuvole, nonostante comunque ognuna delle commedie venga messa in relazione da Strauss con le altre, costruendo un vero e proprio studio organico sull’opera di Aristofane, perché Nuvole rappresenta il luogo centrale per l’indagine sul giudizio aristofaneo su Socrate. Attraverso questa dettagliata analisi, Strauss arriva alla conclusione, se di giudizi definitivi si può in questi casi parlare, che Aristofane si credeva superiore a Socrate, «in virtù della sua conoscenza di sé e della sua prudenza»: infatti, scrive Strauss, «se da una parte Socrate è totalmente indifferente nei confronti della città che lo mantiene, dall’altra Aristofane si occupa molto della città» e, ancora, se Socrate «non rispetta le necessità fondamentali della città, o non vi si attiene, dall’altra Aristofane lo fa».La saggezza di Aristofane assume la sua forma attraverso la parola del poeta, sia esso comico o tragico: le sue commedie sono «il vero Discorso Giusto» che tratta le cose comicamente (questa la chiave utilizzata da Strauss, che anche in un lettera a Kojéve scrive di come il suo libro potesse divertire un filosofo: «Ho appena finito di dettare un libro, Socrate e Aristofane. Credo che qua e là le strapperà un sorriso, e non solo per le battute di Aristofane e le mie parafrasi vittoriane») e che, «presentando come ridicoli non solo gli ingiusti ma anche i giusti, riesce a far sì che la sua commedia sia totale». Solo in questa maniera e attraverso questo filtro a lui congeniale, è possibile tratteggiare ciò che altrimenti sfuggirebbe o trascenderebbe ogni possibilità.
* NOTA
LA LEZIONE DI NIETZSCHE - E DI DIOTIMA. Con Socrate ha inizio l’avventura dell’Occidente! Leo Strauss condivide con Nietzsche l’analisi, ma non riesce a portarsi oltre e a risalire la corrente! E la filosofia è ancora immersa, come denunciava Kant, nel suo profondo “sonno dogmatico” (cfr. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN)!
“NeÌla sua cecità e protervia, l’uomo Platone è l’incarnazione più propria del sogno “diabolico” di Adamo e della sua donna Eva: diventare “come Dio”. contro Dio stesso. I Greci sapevano. Platone sa di ciò che è avvenuto in tempi remotissimi, ma non ha la mente come da una sua battuta contro il grande Diogene di Sinope per comprendere (...) Il racconto è di Aristofane, nel Simposio, e, come si può vedere, ricalca abbastanza fedelmente il racconto biblico relativamente al prima e al dopo del peccato originale, e indica anche la via ... per restaurare I’antica natura. L’indicazione del Commediografo è più che chiara e non è affatto (non fraintenderlo, “non volgerlo al comico”, egli ripete a chi ascolta il suo discorso - noi abbiamo sempre sottovalutato le sue Nuvole, ma egli aveva visto molto bene che cosa Socrate stava preparando) una boutade. Platone non comprende nulla, stravolge e continua, con il suo Eros (avido, cieco e saettante) e con lasua filosofia, sulla strada del padre. Titanicamente, come Zeus, spaccato tutto in due, tenterà di rimettere insieme i cocci, con la forza - una storia di steminata e “incurabile” follia. Aristofane parla della nostra mente, della nostra anima e della nostra vita e Platone taglia e ricuce - a specchio, “divinamente” (...) (Cfr. L’EUROPA, LE “REGOLE DEL GIOCO” DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- GINECOLOGIA, ANDROLOGIA, E INVERNO DENOGRAFICO. Ecco la vera crisi che non si affronta.25 giugno 2019, di Federico La Sala
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA [2008[ "NON CLASSIFICATA"!!! *
Demografia.L’Europa è unita dalle culle vuote: ecco la vera crisi che non si affronta
I tassi di fecondità sono molto diversi tra Paese e Paese, tuttavia a partire dal 2008 il crollo delle nascite è diventata una tendenza che riguarda tutte le età e tutti i livelli di reddito
di Massimo Calvi (Avvenire, sabato 22 giugno 2019)
La recessione demografica che colpisce l’Italia, e che insieme al debito pubblico rappresenta uno dei maggiori elementi di preoccupazione per gli anni a venire, non è un fenomeno limitato ai confini nazionali. Nel lanciare l’ennesimo allarme, alla presentazione del rapporto annuale Istat, il presidente dell’istituto di statistica Giancarlo Blangiardo ha fatto un paragone con il crollo della popolazione registrato negli anni 1917-1918, quelli segnati dalla Grande Guerra oltre che dagli effetti dell’epidemia di Spagnola. Eppure il male italiano è anche un grande problema europeo. «L’inverno demografico che stiamo vivendo in Europa», di cui ha parlato anche papa Francesco a gennaio nell’Udienza generale per il viaggio a Panama in occasione della Giornata mondiale della gioventù 2019, merita di essere preso più seriamente di quanto la politica e le istituzioni non stiano facendo: l’immagine choc della Guerra non è così lontana dagli effetti che il Continente può dover sperimentare nei prossimi anni.
In Europa, i tassi di fecondità sono molto diversi tra Paese e Paese, tuttavia a partire più o meno dal 2008 il crollo delle nascite è diventata una tendenza strutturale comune, che riguarda un po’ tutte le età e tutti i livelli di reddito. Paesi come la Francia sono passati da tassi superiori ai 2 figli per donna a 1,87 nel 2018, la "mitica" Svezia è scesa a 1,75 (era a 1,91 nel 2008), la Gran Bretagna è arrivata al record negativo da 10 anni a 1,76, la Spagna è crollata a 1,25 figli (da 1,44 nel 2008), persino in Finlandia gli allarmi si ripropongono anno dopo anno perché si ritarda sempre di più la messa al mondo del primo figlio e nascono sempre meno secondi e terzi. L’Italia ha un tasso di fecondità oggi di 1,32, ma aggravato dal fatto che il calo delle nascite dura da molti più anni rispetto ad altri Paesi, e questo ha ormai compromesso le possibilità di compensare con nuove nascite l’emorragia della popolazione.
Il primo problema all’origine dell’inverno demografico ovunque in Europa è proprio il calo del numero di donne in età riproduttiva, fenomeno che ha origine attorno agli anni 90. Meno donne che mettono al mondo meno figli è il "dato grezzo" della questione. In realtà, lo choc del 2008 sembra aver tracciato una linea netta oltre la quale è entrato probabilmente in gioco un cambiamento di mentalità delle nuove generazioni, unita al venire meno di molte certezze su lavoro, abitazione, prospettive e soprattutto sulla possibilità di migliorare la propria situazione rispetto alla generazione precedente. Non è una mancanza di desiderio di famiglia, ma più di condizioni da soddisfare in un contesto di politiche pubbliche che tende a premiare comportamenti individualistici e a scoraggiare la formazione di una famiglia. È vero in Italia, ma lo si incomincia a registrare un po’ ovunque nelle politiche di bilancio.
Il cambio della composizione demografica porta infatti con sé anche decisioni di spesa che rischiano di accentuare il problema della denatalità. In un recente saggio pubblicato sulla rivista Population & Avenir, il demografo francese Gerard-Francois Dumont ha dimostrato come salvo rarissime eccezioni i Paesi che più spendono per sostenere la natalità registrano anche i maggiori tassi di fecondità. Tuttavia, oggi l’aumento della popolazione anziana e il calo di quella in età da lavoro sta spingendo gli Stati ad aumentare le risorse a favore della componente più rilevante anche elettoralmente per mantenere gli standard di welfare, inteso come sanità e pensioni.
Secondo un recente rapporto della Fondazione Leone Moressa l’Italia avrà il 17% in meno di popolazione tra 32 anni, e oltre il 35% dei cittadini con più di 65 anni. Altre previsioni che riguardano invece l’Europa indicano che entro il 2060 le persone tra i 15-64 anni caleranno dal 67% attuale al 56%, gli "anziani" saliranno invece dal 18 al 30%. Da 4 persone in età attiva per ogni over-65 si passerà a sole 2.
Guardando avanti, in un Continente che oggi conta poco più di 510 milioni di persone, e che dovrebbe incominciare a conoscere un calo di popolazione dal 2035, si può immaginare un gruppo di Paesi che continuerà ad avere un saldo naturale positivo della popolazione: Francia, Gran Bretagna, Svezia, Irlanda, Danimarca...; un altro caratterizzato da un deciso declino demografico: Portogallo, Spagna, Grecia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia...; l’Italia e la Germania presentano invece prospettive molto negative nel bilancio nati-morti, ma la possibilità di tenuta dei livelli resta appesa alla capacità di continuare ad attrarre popolazione giovane.
Culle vuote e migrazioni mal gestite sono una bomba a orologeria per il Vecchio Continente. L’Europa ha bisogno disperatamente di più bambini e di più persone al lavoro che possano sostenere gli anziani a riposo o bisognosi di cure. Crudamente, ha bisogno di far venire alla luce nuove risorse e di attrarne di già disponibili. Spendere e investire per favorire le nascite purtroppo è una scelta che non piace ai governi in virtù di un banale calcolo statistico, considerato che proprio la tendenza demografica declinante richiede sempre maggiori risorse a favore della parte elettoralmente più rilevante della popolazione. Ma la tentazione della rendita è di per sé un indicatore evidente di declino e sconfitta.
Il fatto è che la recessione demografica porta con sé anche recessione economica, problemi sul debito e sulla sostenibilità dei servizi, maggiori difficoltà di spesa per sostenere le aree depresse.
Tutti gli studi sull’effetto dello choc demografico indicano che per Paesi del Centro e dell’Est-Europa, per la Germania Orientale, l’Italia del Sud, il Nord della Spagna e la Grecia, la prospettiva è quella di un futuro fatto di poche nascite, invecchiamento, emigrazione. E’ un circolo vizioso, insomma. Esattamente come quello che chiama in causa la questione delle migrazioni. I Paesi che riusciranno a tenere la posizione saranno quelli in grado di garantire due tipi di condizioni: uno sviluppo così elevato in termini di qualità della vita, del lavoro, delle retribuzioni, degli incentivi, della sicurezza e della sostenibilità futura, in grado di sostenere il desiderio di figli e famiglia; la capacità di offrire alle persone che emigrano lavoro, integrazione, educazione e un ambiente favorevole e dignitoso.
Non è una partita semplice perché l’inverno demografico è già qui e le tensioni che comporta questa trasformazione sono in atto e ben visibili. Di certo se la sfida è anche culturale, la soluzione non è più individualismo, ma migliore capacità di interpretare la solidarietà tra le generazioni e tra i popoli.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA - 2008 - "NON CLASSIFICATA"!!!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "VERITATIS GAUDIUM": IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE.22 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
- Intervento del Santo Padre Francesco all’Incontro sul tema: “La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli, 20-21 giugno 2019), 21.06.2019
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
- "Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- ANTROPOLOGIA, ANDROLOGIA E GINECOLOGIA. "Margini della filosofia" (Jacques Derrida).13 giugno 2019, di Federico La Sala
MARGINI della filosofia. Intervento libero. In memoria di Jacques Derrida...
Siccome orientarsi nell’infinito è un problema meta-fisico e costituzionale, e - dopo Kant e la sua "rivoluzione copernicana" - non sappiamo ancora distinguere "dewey"anamente tra "prima di Cristo" e "dopo Cristo", tra Tolomeo e Copernico, tra il tutto e la parte, tra antropologia e andrologia - e ginecologia, tra Italia e "Italia", tra Costituzione e Partito, tra forza Italia e "Forza Italia", mi è sembrato opportuno fornire un piccolo banale (comune!) elemento per uscire dal sonnambulismo e dalla confusione! Siamo o non siamo "Dopo Dewey" !? O no?!
P. S. - SUL TEMA, MI SIA CONSENTITO, SI CFR.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- DA "CAPO". "Quando tutto sembra perduto bisogna / mettersi tranquillamente all’opera / ricominciando dall’inizio" (A. Gramsci).10 giugno 2019, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA (E DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO DELL’ "UOMO SUPREMO"): INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI...
LE PAROLE, LE COSE, E LE PERSONE: "Identità. Poche settimane fa l’europarlamentare Eleonora Forenza (area di Rifondazione di Potere al Popolo) ha scatenato una piccola bagarre nel minuscolo stagno della sinistra italiana. Forenza ha bollato, su Twitter, la Brexit come “pasticcio di maschi”, non negando una certa solidarietà ‘femminista’ a Theresa May e alla gatta da pelare che i colleghi “maschi” le avrebbero rifilato. L’uscita infelice di Forenza non è cosa nuova (ma preoccupa che venga da una gramsciana). È parte integrante di un certo orientamento della sinistra diritto-civilista e culturalista, cioè di quella sinistra che, pur non escludendo le questioni legate al mondo del lavoro e della produzione, individua ormai nei diritti civili la principale chiave d’intervento sociale e, proprio a causa di tale scelta, si ritrova fatalmente irretita all’interno di un uso distorto del concetto di “identità”. Tale posizionamento (largamente maggioritario anche nel Partito Democratico) è stato spesso già portato a critica". Così inizia la riflessione di Mimmo Cangiano su “Intersezionalità, identità e comunità: a che punto siamo a sinistra” ("Le parole e le cose", 10 giugno 2019).
CONSIDERATO CHE ORA COME ORA proprio perché, come scrive l’autore,
- "Stiamo ora guardando in faccia, ed è sicuramente un progresso, il nostro capitalismo. Senza identità e senza comunità siamo al centro delle sue disconnessioni, ostili l’uno all’altro, alienati l’uno dall’altro. Senza valori comuni, collettivi, sovrapersonali, l’identità viene a coincidere con noi stessi, urla a gran voce la propria libertà, il proprio diritto a essere ciò che si vuole, mutevoli e fluidi quanto ci aggrada, libertà di godimento e desideri, finché la conformazione sociale in cui siamo comunque inseriti non torna a battere alla porta ricordandoci che i desideri hanno il volto sofferente dei bisogni, e il nostro godere (cioè il nostro far valere la nostra identità, anche quando fluida) non vive separato dalle regole sociali" (Mimmo Cangiano, “Intersezionalità, identità e comunità: a che punto siamo a sinistra”, cit.),
nel condividere e nell’accogliere l’invito gramsciano citato in esergo (“quando tutto sembra perduto bisogna / mettersi tranquillamente all’opera / ricominciando dall’inizio”) e, INSIEME, nel RICORDARE che FORENZA è VICINO ad ACERENZA, in BASILICATA (là dove fu confinato l’Autore di "Cristo si è fermato ad Eboli"),
sul problema di lunga durata del nostro presente storico, IO CONSIGLIEREI DI RIPRENDERE IL DISCORSO proprio da "CAPO", da GRAMSCI.
FORSE è TEMPO di interrogarci un po’ più radicalmente! La sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico è già "vecchia" ed uscire da uno "stato di minorità" in cui versiamo da millenni, intrappolati come siamo in una logica adamitica ("Adamo ed Eva"!) di un cieco, cainico, teologico-dialettico, edipico, molochiano, capitalistico "familismo amorale" non è un gioco da "ragazzi"!
Bisogna aprire gli occhi (non "chiudere un occhio"!) su "«chi» siamo noi in realtà e, nello stesso tempo, saper sognare il sogno di una cosa. Forse non è (ancora!) possibile?! Boh e bah...
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- ANCHE A CHI non sia un cultore di Freud è evidente come ciò che ci identifica non è il nostro cervello, bensì ciò che facciamo della nostra esistenza (Francesca Borrelli)..6 giugno 2019, di Federico La Sala
Solo alla psicoanalisi sta a cuore il senso della sofferenza mentale
CONVEGNI. L’efficacia incompresa dell’orientamento psicodinamico. «L’efficacia della psicoterapia psicoanalitica nei contesti di cura»: il 7 a Roma
di Francesca Borrelli (il manifesto, 06.06.2019)
Da anni, ormai, della sofferenza mentale si è impossessato un ingegnoso mercato, che punta sulla idealizzazione delle neuroscienze e sugli effetti delle terapie cognitiviste, entrambe perfettamente sintonizzate con l’individualismo contemporaneo e il tempo della fretta. La cacciata in esilio del senso ha colonizzato il senso comune: non è un gioco di parole, è precisamente quanto è avvenuto in coincidenza con ciò che Alain Ehrenberg chiama, nel suo ultimo libro - La meccanica delle passioni (Einaudi, 2019) - l’avvento di un uomo nuovo: «l’uomo neurale».
ANCHE A CHI non sia un cultore di Freud è evidente come ciò che ci identifica non è il nostro cervello, bensì ciò che facciamo della nostra esistenza. In questo contesto, notava nel 2015 Miguel Benasayag, quel che spesso si nasconde dietro gli attacchi alla psicoanalisi non è ascrivibile alle sue lacune, ma è piuttosto frutto delle sue virtù: sembra che a venire soprattutto rifiutata sia infatti, la «dimensione tragica» della cura analitica, quel contatto del singolo con il mondo in cui risuona l’eco hegeliana di una teoria della storia secondo la quale gli individui, pur dedicandosi alle loro attività e perseguendo fini egoistici servono, sebbene inconsciamente, un comune disegno di emancipazione. L’universo dell’uomo contemporaneo - scrive ancora lo psichiatra argentino - si ferma invece ai confini del corpo. Eppure, nemmeno quando si limita a un fenomeno fisico, il dolore si esaurisce, in realtà, in un impulso nervoso: la sua percezione dipende, infatti, dalla diversa griglia interpretativa che ha in dotazione ciascun individuo. Detto altrimenti, non esiste dolore che preceda il senso.
A dispetto di questa evidenza, Anna Maria Nicolò, attuale presidente della Spi, introdurrà il convegno L’efficacia della psicoterapia psicoanalitica nei contesti di cura (promosso dalla Società Psicoanalitica Italiana, dalla Associazione Italiana Psicologia Analitica, e da Soci Italiani European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) il 7 giugno all’Università La Sapienza di Roma, sottolineando come «la psicoterapia sta praticamente sparendo dalle istituzioni e l’approccio psicodinamico, che aveva tanto bene orientato la prevenzione, la diagnosi e la cura nei consultori, nelle équipe mediche psicopedagogiche delle scuole, nei centri di salute mentale e negli ospedali, viene relegato a settori o a operatori rari e isolati».
ORMAI ALMENO due generazioni di psichiatri sono stati allenati a ignorare la ricorsività intrinseca a giochi linguistici che, se interpretati, potrebbero aiutare sensibilmente molti dei loro pazienti, trattati invece farmacologicamente sulla base di un investimento di interessi sul cervello piuttosto che sulla psiche.
Nel denunciare la illusoria prassi di sbarazzarsi dei sintomi schizofrenici trasferendoli sui farmaci, il grande psicoanalista inglese Christopher Bollas ha parlato di «incarcerazione psicotropa», identificando nella medicalizzazione vigente una minaccia alla dimensione umana. Per molti aspetti, infatti, sintomo e persona sono tutt’uno. «Di fatto - scrive Bollas - l’idea che i disturbi mentali possano essere risolti tramite un intervento neurologico è un errore categoriale ridicolo quanto lo è confondere un programma radiofonico con la radio stessa».
Da che la ricerca empirica ha ormai dimostrato l’efficacia dei trattamenti analitici, ciò che è in gioco - dirà Antonello Correale al convegno - è «capire come e per chi il trattamento analitico funziona e chiarire quali siano i fattori terapeutici realmente attivi». La psicoterapia a orientamento dinamico ha rivelato la sua particolare efficacia nel trattamento della depressione, «inesorabile contropartita dell’uomo che si pretende sovrano» ha scritto Ehrenberg, in un saggio ormai famoso, La fatica di essere se stessi, che analizza questa «malattia della responsabilità» come tipica di dinamiche sociali dove il conflitto non è più fra ciò che è permesso e ciò che è vietato, bensì tra ciò che è possibile, ovvero alla nostra portata, e ciò che è inaccessibile, sebbene propagandato come dipendente dalle nostre capacità autoimprenditoriali.
AL CONVEGNO che avrà inizio venerdì, Antonello Colli si incaricherà di riassumere le critiche più frequenti alle terapie psicoanalitiche: «non sono validate empiricamente; laddove esistano prove empiriche l’efficacia delle terapie psicoanalitiche è modesta se paragonata ad altre terapie evidence based; sono eccessivamente e inutilmente lunghe e costose». Ma «mettere in atto una valutazione psicodinamica in età evolutiva, significa - farà notare Mirella Galeota - sostare senza fretta a osservare e interrogarsi sulla persona intera del paziente, non solo sul disturbo o sull’organo o la singola funzione... Valutare psicodinamicamente un minore significa utilizzare il metodo psicoanalitico che è il solo che consente di stare con propria mente in relazione con la mente dell’altro».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- SCIENZA E STORIA: “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. NOTE A MARGINE DELLA LETTERA "Al CNR la storia è una scienza?".6 giugno 2019, di Federico La Sala
PER UN NUOVO CNR ....
NOTE A MARGINE DELLA LETTERA "Al CNR la storia è una scienza? Una risposta all’intervento di Gilberto Corbellini"
- Recensendo un volume dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa. [...] (ALFABETA-2, 26 MAGGIO 2019)
1. PER LA STORIA DELLLA SCIENZA E PER LA SCIENZA DELLA STORIA, FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE IL LAVORO GALILEANO DELLA CONVERSAZIONE E DELLA CONOSCENZA 29 Maggio 2019 :
- «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. (..)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.» (Galileo Galilei, “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”, 1632 - Salviati, giornata II)
2. STORIA, SCIENZA, ED ECLISSI. Da Galileo Galilei ad Albert Einstein 30 maggio 2019...
Al di là delle pretese “mitideologiche” (atee e devote) del “post-positivismo” contemporaneo (Paolo Fabbri) di dare il via a un’ epoca in cui la storia del mondo dev’essere riscritta secondo l’indicazione rosenberghiana!), ricordiamo che il 29 maggio 1919 Arthur Eddington provò sperimentalmente la teoria della relatività (cfr. : Franco Gabici, “Cento anni fa l’eclissi che diede ragione a Einstein” - https://www.avvenire.it/agora/pagine/cento-anni-fa-leclissi-che-diede-ragione-a-einstein). Buon lavoro!
3. COSTITUZIONE E CNR. UN PROBLEMA STORIOGRAFICO (SCIENTIFICO) DI LUNGA DURATA 31 Maggio 2019...
CONDIVIDO LA PREOCCUPAZIONE E, AL CONTEMPO, LA CONSAPEVOLEZZA dei firmatari della lettera. La “provocazione” - da parte di chi dirige il Dipartimento del CNR, “al cui interno operano decine di storici, storici della filosofia, giuristi e altri ricercatori nel campo delle scienze umane e sociali” - evidenzia il sintomo non tanto e non solo “di un profondo problema culturale e scientifico”, ma anche e soprattutto di un problema politico-filosofico (metafisico), costituzionale, di CRITICA della “ragion pura” (di questo parla il “principio della relatività galileiana”, condensato nel “Rinserratevi” del “Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano”)!,
DOPO GALILEI, DOPO KANT, DOPO EINSTEIN, DOPO LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA... UNA “PROVOCAZIONE” al CNR DA ACCOGLIERE!
Strana “coincidenza”, oggi!:
- A) Il 9 Aprile 2019, in una nota (dal titolo
“CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!: https://www.alfabeta2.it/2019/03/31/marcel-detienne-memorie-felici-e-concetti-indelebili/#comment-639227), così scrivevo:
 “La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
“La totale incomprensione del “relazionismo” proposto da Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius (e non solo!) di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4790)”.
- B) Il 12 maggio 2019, “recensendo un volume - come scrivono gli studiosi e le studiose del CNR - dell’epistemologo statunitense Alex Rosenberg, in un articolo dal titolo Questa storia è davvero molto falsa apparso sul supplemento domenicale del “Sole - 24 ore” il 12 maggio scorso, il professor Gilberto Corbellini ne ha preso spunto per asserire, in polemica con un recente appello in difesa dell’insegnamento della storia, l’assenza di scientificità e di utilità sociale della disciplina stessa”.
Prima che sia troppo tardi, che fare?! Alle studiose e alle studiose di scienze umane e sociali (del CNR e non solo), consiglierei (mi sia permesso) la ri-lettura del “Dialogo sopra i due massimi sistemi iolemaico e copernicano” di Galileo Galilei, la ri-lettura dei “Sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica” di Immanuel Kant, e, infine, la rilettura dei “Principi” della Costituzione della Repubblica Italiana - e, alla luce della “ferocissima” provocazione, ri-prendere il lavoro storiografico-scientifico con più grande entusiamo e responsabilità di prima!
VIVA IL CNR,
VIVA L’ITALIA!
4. PER UN NUOVO CNR! ALL’INSEGNA DI ERMES: “IO VORREI PENSARE CON IL CERVELLO INTERO”. IN MEMORIA DI ENRICO FILIPPINI E DI MICHEL SERRES 3 Giugno 2019 ...
“[...] all’insegna di Ermes, che per me è il simbolo della scienza contemporanea”.
 In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
In che senso? “Nel senso che Mercurio, a cui ho dedicato ben cinque libri, è il dio della comunicazione. A differenza di quanto pensavano i marxisti, io ritenevo che il problema della comunicazione fosse più importante di quello della produzione, e che l’ economia stessa fosse più una questione di comunicazione che di produzione. Sono fiero di quell’ assunto, mi scusi la superbia: infatti, i paesi che hanno scommesso in questo senso, per esempio il Giappone, hanno evitato la crisi”.
 Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
Ma comunicazione che vuol dire? “All’ inizio, all’ epoca dello strutturalismo, davo del termine “struttura” un’ interpretazione algebrica, esatta. Poi, studiando il XIX secolo, la fisica ottocentesca, e cioè essenzialmente la termodinamica, finii per attribuire un ruolo centrale alla teoria dell’ informazione. In fondo, se del mio lavoro dovessi tracciare un profilo, ecco: per tutta la vita ho cercato di tenermi al corrente, da filosofo, del sapere scientifico (il che in Francia ø raro), e insieme di non dimenticare la tradizione letteraria: ho scritto su Zola e su Jules Verne. Ecco, ho cercato di tenere unite, con le due mani, la scienza e la letteratura, di passare dall’ una all’ altra. E’ quello che chiamo, nel quinto volume dedicato a Mercurio, il Passaggio a Nord-Ovest: passaggio difficile, pericoloso, tempestoso, ma passaggio. Per me la filosofia è questa alleanza. In Italia ciò dovrebbe essere comprensibile”.
 In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
In Italia c’ è stata una forte tradizione idealista e marxista. L’ interesse per la scienza tende a diventare scientismo. “Come nel mondo anglosassone. Ma il fatto è che nella letteratura c’ è spesso più rigore che nella scienza. In Tito Livio c’ è più epistemologia che in Popper. Il mio sogno è di scrivere un’ opera che compia la riconciliazione enciclopedica, proprio alla maniera di Diderot e di D’ Alembert, ma non solo nel senso storico (per cui si pensa sempre soltanto nel solco della propria tradizione), anche nel senso del concetto: quello è il campo che si percorre e che si deve percorrere. La filosofia ha perduto troppo non sapendo nulla di scienza, ma oggi che ne sa qualcosa, ha perduto la dimensione culturale. E’ come un cervello tagliato in due. Io vorrei pensare col cervello intero”.
 Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
Ora sta scrivendo qualche cosa? “Un libro sui cinque sensi, e, appunto, in una forma letteraria, anche se sono partito da un sistema rigorosamente formale. E’ un tentativo di alleanza tra le due forme di sapere, è anche il tentativo di ritrovare, come diceva Edmund Husserl, le radici profonde della cultura europea. Lei conosce La crisi delle scienze europee?”.
 L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
L’ ho tradotta in italiano da studente. Ma Husserl parlava appunto di “crisi” di quell’ idea e di quella tradizione. C’ è il problema della tecnicizzazione della scienza. E poi c’ è la difficoltà della estrema specializzazione dei settori scientifici [...]
 (cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).
(cfr. ENRICO FILIPPINI, “Il mio amico Mercurio”, “la Repubblica”, 15 giugno 1984: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/06/15/il-mio-amico-mercurio.html).5. STORIA E SCIENZA: “VICISTI, GALILAEE” (KEPLERO, 1611) 5 Giugno 2019.
La rotazione della Terra rimescola le acque del lago di Garda ... http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2019/06/05/la-rotazione-della-terra-rimescola-le-acque-del-lago-di-garda-_8cbe9d78-1459-4088-a0a4-12016cd675b9.html.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- PER LA FILOSOFIA DI UN ALTRO SOCRATE. IN MEMORIA DI MICHEL SERRES.3 giugno 2019, di Federico La Sala
"Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986)
IN MEMORIA DI MICHEL SERRES *. UNA CONFESSIONE (DA "IL MANCINO ZOPPO"):
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
PER LA FILOSOFIA DI UN ALTRO SOCRATE. AL DI LA’ DI EDIPO...:
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
a) IL PUNTO DI SVOLTA. L’INDICAZIONE DI FACHINELLI E LA SUA IMPORTANZA.
b) LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
c) CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
d) CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
*
Morto Michel Serres, il filosofo della scienza che amava l’Italia
Grande figura dell’epistemologia e fra i primi a pensare in modo sistematico la necessità di un nuovo approccio alla questione ecologica, aveva 88 anni. «I miei miglior amici sono italiani»
di Daniele Zappalà (Avvenire, sabato 1 giugno 2019)
Parigi. Era uno dei pensatori più ammirati a livello internazionale, oltre a rappresentare una figura centrale del mondo intellettuale francese. Il filosofo Michel Serres, grande figura dell’epistemologia e fra i primi a pensare in modo sistematico la necessità di un nuovo approccio alla questione ecologica, si è spento ieri a 88 anni. Accademico di Francia fin dal 1990, aveva insegnato a lungo negli Stati Uniti, all’Università di Stanford, oltre che in vari atenei transalpini. Autore di una cinquantina di volumi e di opere fondamentali sull’origine del pensiero scientifico, come Le origini della geometria (Feltrinelli) o Lucrezio e l’origine della fisica (Sellerio), aveva pure interpretato, nella lontana scia di Leibniz, la pregnanza della comunicazione nel mondo contemporaneo, come nei 5 volumi della serie Hermès (1969-1980).
Figura estremamente originale, aveva scelto come proprio motto «pensare significa anticipare», prevedendo e interpretando nei propri libri diverse rivoluzioni del nostro tempo. Una costante della sua riflessione è stata pure la grande attenzione alla tradizione culturale cristiana, come in La ricerca delle parole. Corpo, scrittura e messaggio evangelico (EDB), o in Darwin, Napoleone e il samaritano. Una filosofia della storia (Bollati Boringhieri).
Fra i volumi di Serres più citati, si può ricordare Il contratto naturale (Feltrinelli), all’origine di una riflessione sull’ambiente approdata poi a volumi più personali, come Biogea. Il racconto della terra (Asterios). Di recente, aveva pubblicato pure dei pamphlet con cui aveva riscosso un notevole successo, come Non è un mondo per vecchi. Perché i ragazzi rivoluzionano il sapere, o ancora Contro i bei tempi andati, entrambi tradotti da Bollati Boringhieri.
«Tutti i miei migliori amici sono italiani», ci aveva raccontato nella sua ultima intervista ad Avvenire, da grande innamorato del Belpaese. In proposito, aveva anche dedicato un volume a Carpaccio, edito in Italia da Hopefulmonster. Fra gli altri tratti della tradizione italiana reinterpretati a livello filosofico, spicca la figura di Arlecchino, nel volume Il mantello di Arlecchino (Marsilio). Profondamente segnato dal dramma della guerra, ha lasciato anche importanti riflessioni di stampo pacifista.
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- La riforma del diritto di famiglia: 19 maggio 1975 (di Raffaella Sarti).20 maggio 2019, di Federico La Sala
IL LETARGO DI SECOLI E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI... *
La riforma del diritto di famiglia
19 maggio 1975
di Raffaella Sarti (Il Mulino, 17 maggio 2019)
“Storica riforma del diritto di famiglia: diventa assoluta la parità tra i coniugi”, titolava un articolo su “La Stampa” del 23 aprile 1975, commentando l’approvazione, il giorno prima, di quella che sarebbe divenuta la Legge 19 maggio 1975, n. 151. Dopo un iter di quasi nove anni, la riforma arrivava in porto. Senza dubbio, per molti versi la legge rappresentava una “rivoluzione in famiglia”, come recitava un altro articolo sullo stesso giornale. “Le famiglie italiane diventeranno più moderne e più libere”. “Ad essere ‘liberati’ saranno le donne e i figli, spiegava il giornalista: “l’‘oppressore’ del quale vengono limitati i diritti e i poteri, è il padre, finora capo famiglia assoluto”. La famiglia “non è più vista come piramide, che ha al vertice il marito, ‘capo’ e monarca assoluto”, gli faceva eco un articolo su “l’Unità”. In effetti, la legge cancellava quasi completamente il ruolo di capofamiglia, erede per tanti versi della figura plurimillenaria del paterfamilias del diritto romano.
La riforma modificava molti articoli del codice civile del 1942, e - a ventisette anni dalla sua entrata in vigore - faceva un deciso passo verso l’attuazione dell’art. 29 della Costituzione, secondo il quale “il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Fino ad allora le leggi, più che tale principio, avevano attuato quanto previsto nella parte finale dell’articolo che subordinava l’uguaglianza alla “garanzia dell’unità familiare”, prevedendo a tali fine limiti di legge. E i limiti, per decenni, erano stati molti e pesanti. Sino alla riforma, infatti, il marito-padre era “il capo della famiglia”: “la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”, recitava l’art. 144 del codice civile.
Con la riforma, l’obbligo di coabitazione tra coniugi non veniva meno. Si stabiliva, tuttavia, che la residenza della famiglia e l’indirizzo della vita familiare fossero decisi insieme da moglie e marito. Non solo: i coniugi avrebbero potuto avere ciascuno un proprio domicilio nella “sede principale dei propri affari o interessi” (nuovo art. 45 del codice civile). Insomma, si passava da una legislazione che aveva mantenuto una forte preminenza del marito a leggi che garantivano maggior parità tra i coniugi. Non era, però, una parità assoluta. Certo la riforma stabiliva che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” (nuovo art. 143). Ma permanevano delle asimmetrie. Ad esempio, ora la moglie poteva mantenere il suo cognome. Doveva però aggiungervi quello del marito (art. 143-bis) mentre per il marito non era previsto nulla di simile. Né era previsto che i figli nati in seno al matrimonio potessero avere il cognome della madre. Senza dubbio, comunque, la legge rendeva la moglie meno dipendente dal coniuge: ad esempio, la donna che sposava uno straniero ora non perdeva più la cittadinanza italiana (art. 143-ter).
La riforma metteva i coniugi su un piano di maggiore parità anche grazie alle disposizioni economiche. Il codice del 1942 aveva stabilito che il marito avesse il dovere di “proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze”. La moglie doveva contribuire al mantenimento del marito solo se questi non aveva “ha mezzi sufficienti” (art. 145). In base alla riforma, invece, entrambi i coniugi erano “tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” (nuovo art. 143). Un’altra norma che appariva “rivoluzionaria” riguardava il regime patrimoniale. Fino ad allora era stata in vigore la separazione dei beni tra marito e moglie, mentre la nuova legge introduceva la comunione dei beni, a meno di diversa scelta da parte dei coniugi. Coerentemente, aboliva la dote che, seppur in disuso, per secoli aveva condizionato la vita delle ragazze e delle loro famiglie. Per quanto riguarda gli aspetti economici, la riforma riconosceva inoltre i diritti, fino ad allora disconosciuti, di moglie, figli e altri parenti che lavoravano stabilmente in famiglia o nell’impresa familiare: anzitutto il diritto al “mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia” e poi quello a partecipare “agli utili dell’impresa familiare”. Con una virata in senso democratico, prevedeva anche che le decisioni fossero “adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa”. E ridimensionava le gerarchie di genere: “il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo”, recitava l’art. 230-bis.
La tendenza a smussare le gerarchie di genere e generazionali riguardava anche il rapporto tra genitori e figli. La potestà esercitata dal padre veniva sostituita da una potestà “esercitata di comune accordo da entrambi i genitori” (nuovo art. 316). E i genitori non avevano più solo l’obbligo “di mantenere, istruire ed educare la prole”, ma dovevano farlo anche “tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (nuovo art. 147). D’altra parte, se permaneva l’obbligo, per la prole, di rispettare padre e madre, veniva meno quello di onorarli. Era poi previsto che i figli contribuissero “in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia” finché avessero convissuto con essa.
“Finiscono le crudeli discriminazioni tra bambini”, sosteneva uno degli articoli apparsi il 23 aprile 1975 su “l’Unità”. Un aspetto importante della legge riguardava, in effetti, le differenze tra figli legittimi e illegittimi, di cui ora si parlava solo come di figli “naturali”. L’art. 30 della Costituzione aveva stabilito che la legge dovesse assicurare “ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale”, ma aveva circoscritto la portata del principio alla tutela “compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”, prevedendo anche limiti per la ricerca della paternità.
 Di fatto, profonde differenze avevano continuato a caratterizzare la condizione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio. La riforma le avrebbe ridotte, non cancellate. Sino ad allora un genitore sposato non poteva riconoscere i figli nati da un rapporto adulterino; ora il riconoscimento era possibile (nuovo art. 252). Prima della riforma, i nati fuori del matrimonio che non potevano essere riconosciuti non avevano il diritto di sapere di chi fossero figli. A parte i casi di incesto, la nuova legge permetteva la ricerca della paternità e della maternità (nuovi artt. 269, 270, 278). Infine, la riforma cancellava molte delle discriminazioni, quanto a diritti successori, dei figli naturali, pur senza equipararli completamente ai figli legittimi.
Di fatto, profonde differenze avevano continuato a caratterizzare la condizione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio. La riforma le avrebbe ridotte, non cancellate. Sino ad allora un genitore sposato non poteva riconoscere i figli nati da un rapporto adulterino; ora il riconoscimento era possibile (nuovo art. 252). Prima della riforma, i nati fuori del matrimonio che non potevano essere riconosciuti non avevano il diritto di sapere di chi fossero figli. A parte i casi di incesto, la nuova legge permetteva la ricerca della paternità e della maternità (nuovi artt. 269, 270, 278). Infine, la riforma cancellava molte delle discriminazioni, quanto a diritti successori, dei figli naturali, pur senza equipararli completamente ai figli legittimi.Il nuovo diritto di famiglia, che interveniva su molti altri aspetti della vita familiare, recepiva l’orientamento favorevole alla democratizzazione dei rapporti di genere e generazionali di una parte crescente della società italiana. Per molti versi rappresentava davvero una discontinuità. Nelle pieghe della legge, tuttavia, si annidavano elementi di continuità. In base al nuovo art. 316, ad esempio, “se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili”. Insomma, “l’ultima parola spetta sempre al padre”, notava Danielle Turone sulla rivista femminista “Effe” già nel 1973, analizzando il progetto della legge in un articolo intitolato, significativamente, Dopo anni di gestazione nasce già vecchio il nuovo diritto di famiglia. Cacciato dalla porta, il capofamiglia rientrava, in alcune occasioni, dalla finestra.
Peraltro restava aperto il rapporto tra leggi e più vaste trasformazioni sociali e culturali. “Non basta togliere dal codice la parola ‘patria-potestà’ lasciando integro concetto, o concedere alla donna di mantenere il proprio cognome ‘aggiungendo quello del marito’, per credere di aver dato alle donne la parità”, continuava Danielle Turone. A suo avviso, la donna avrebbe potuto raggiungere la parità “solo quando, oltre ai rapporti inter-familiari, muterà tutta l’organizzazione sociale, quando le sue possibilità di studio, di lavoro saranno uguali a quelle degli uomini, quando il ‘costo’ di una maternità non verrà addebitato al solo nucleo familiare ma diverrà un costo ‘sociale’, quando alloggi, servizi sociali ed assistenziali organizzati, toglieranno la donna dal ghetto delle quattro mura domestiche”. “La nuova legge sulla famiglia dà alle donne nuovi diritti”, ammetteva. “Ma la parità è ancora lontana”. Era il 1973. Da allora le leggi hanno riconosciuto alle donne italiane numerosi altri diritti, importantissimi. Ma molti dei problemi che Turone elencava restano drammaticamente attuali e la parità resta, anch’essa, ancora lontana.
Sul tema, nel sito, si cfr.:- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
DANTE, IL LETARGO DI SECOLI, E LA CRISI DELL’EUROPA - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- UN NUOVO VAGITO. Marx per ripensare l’alternativa oggi (di Luciana Castellina).19 maggio 2019, di Federico La Sala
Commenti
Marx per ripensare l’alternativa oggi
Marxismo. Gli argomenti che più hanno appassionato i partecipanti, perché per molti versi i più nuovi, quello dell’Ecologia e quello di Genere
di Luciana Castellina (il manifesto, 19.05.2019)
La sala più grande di Pisa, quella del Polo didattico Carmignani, a Piazza dei Cavalieri, proprio alle spalle della leggendaria Normale, è gremita già prima dell’inizio. “Esagerati”, avevano detto tutti a Marcello Musto, grande artefice dell’evento, che aveva insistito per quella localizzazione.
E invece c’è persino gente in piedi. Tutti lì per Carlo Marx a 201 anni dalla sua nascita: e se si trattasse di un nuovo vagito della sinistra? Potrebbe persino darsi, perché sono restati tutti tutti e tre i giorni in cui al microfono si sono susseguiti 25 relatori, provenienti da 14 paesi di quattro continenti.
I lavori aperti da una non programmata ragazzina che, a nome degli studenti, si felicita per questa occasione di confronto ( che - dice - ormai non c’è più nell’università) e poi attacca diretta il presidente della regione Enrico Rossi - lì per inaugurare la conferenza - perché ha finanziato un convegno di quelli delle famiglie e invece lesina i soldi per l’istruzione.
Un giusto inizio perché questa conferenza su Marx pur ad alto livello marxologo (salvo me e Landini) non è stata affatto un evento accademico. Il titolo, del resto, lo aveva annunciato: “Ripensare l’alternativa”. E cioè: andiamo a scovare quello che il nostro vecchio compagno di Treviri ha detto e si è spesso perso per strada e solo ora, grazie a Mega ( la strepitosa edizione che fin dai tempi della Germania est - è in corso a Berlino, in cui compaiono una quantità di sconosciuti inediti) viene fuori e vediamo a cosa ci può ancora servire. Insomma:non siamo qui per interesse archeologico ma per trovare argomenti per il che fare di oggi.
E in effetti da tanti inediti che i relatori ci hanno fatto conoscere è emerso un Marx solo sospettato, molto più ricco e vicino alle nostre attuali problematiche di quanto sia stato quello un po’ rozzo tramandatoci dalla vulgata del movimento operaio. Soprattutto un Marx molto politico. Non per caso fra i relatori c’è anche Maurizio Landini, accolto da tutti con grande entusiasmo, che ci legge Marx nel presente del lavoro, di cui fa una impietosa disanima.”Ho incontrato lo sfruttamento prima di avere incontrato Marx” - esordisce.
Non cercherò neppure di entrare nel merito di quanto è stato detto, sarebbe impossibile in un articolo di quotidiano. E però voglio riportare i titoli e almeno un concetto delle diverse sezioni in cui la conferenza si è articolata per dare un’idea dell’attualità della riflessione:
Dopo una prima seduta inaugurale che ha affrontato il tema generale “Capitalismo”, con Landini, appunto, e poi - prima oratrice - Silvia Federici (Hofstra University, Usa), che ha offerto il primo contributo da una prospettiva femminista; Bob Jessop (Lancaster University, UK) “Il capitale come relazione sociale: dall’analisi alla lotta di classe”, e cioè il rapporto fra persone viene mediato dalle cose, che lo nascondono ; e, infine, una preziosa relazione di Maurizio Iacono (Università di Pisa ma anche fra i fondatori de Il manifesto), intitolata “La merce entra in scena nel teatro del postmoderno”, in cui, richiamando i “tavoli danzanti” di Flaubert, ha ripercorso il processo che dal legno arriva al tavolo, e poi però nessuno cerca il loro autore come avrebbe fatto Pirandello, ma anzi nasconde il lavoro sociale collettivo che è servito a crearli, lo rende invisibile, merce separata. che incorpora lavoro transitato dalla soggezione al dispotismo aziendale a quello mascherato della merce.depurata dal lavoro nella camera oscura.
La seconda giornata è cominciata con tre contributi sul tema “nazionalismo” : di George Comninel (York University Toronto), il nostro Alberto Burgio (Università di Bologna, ex deputato di RC, autore fra i tanti di un libro su Gramsci dedicato a Lucio Magri): “Gli operai non hanno patria”, nazionalismi e internazionalismo tra XX e XXI secolo, una lucida e impietosa descrizione di come e perché sia andato emergendo l’attuale sovranismo. ( “Mentre il mercato globale si espande, si soffia sul fuoco dei particolarismi, nascondendone la gerarchia”).
Stesso tema - “Il nazionalismo nel 18 brumaio di Luigi Bonaparte. Il primo contrattacco contro il socialismo”- trattato da un relatore un po’ speciale, perché il solo proveniente dall’est Europa e proprio da uno dei paesi oggi portabandiera del nuovo nazionalismo, l’Ungheria, dove insegna alla Central European University:Gaspar Tamàs. (“Il soggetto, individuale o collettivo, è sempre in sé plurale, contiene contraddittorietà ineliminabili; solo che oggi questo è più dirompente perché si è affievolita la coscienza di classe”).
A seguire “Democrazia”, con Mauro Buccheri, un ormai anziano siciliano da 50 anni alla York University di Toronto;Terrel Carver (University of Bristol,UK) e Michael Brie (Fondazione Rosa Luxemburg), alle prese con il complicato tema del rapporto democrazia e socialismo, “il filo del rasoio”, come l’ha definito Carver, o, più pessimisticamente Brie,“un compito irrisolto”. Molto ricco di narrazioni ( e considerazioni ) il tema della Migrazione, dove Davud Smith, (Kansas Uniuversity Usa) ha riferito del pensiero di Marx su accumulazione e migrazione forzata quale appare nel Capitale ma soprattutto nei suoi ultimi manoscritti; Piero Basso (università di Ca’Foscari) sull’esercito di riserva, le migrazioni forzate iniziate con la tratta degli schiavi, la necessità oggi di battersi per il diritto a non dover emigrare, più che per quello di emigrare. E Ranabir Samaddar (gruppo di ricerca di Calcutta) , che ci ha parlato del passato e del presente: le migrazioni nell’era del globalismo.
E ancora il Lavoro, dove ho avuto l’onore di tenere anche io una relazione che ho intitolato “il becchino frantumato”, ma dove soprattutto è stato analizzato il lavoro moderno quale risulta essere quello di due paesi del Sud, le Filippine ( Sarah Raymundo, Dillman University Manila) e Ricardo Antunes (Unversità Campinas Brasile), che ha affrontato il tema del lavoro immateriale ( che, ha detto fra l’altro, presuppone quello materialissimo dei minatori che estraggono la materia prima con cui si fanno i nostri apparecchi digitali) caratterizzato in realtà da un modo di estrazione del plus valore del tutto simile a quello delle epoche più antiche. Anche in questo caso molte osservazioni di Marx su quanto oggi chiamiamo post-industria, che continua a produrre plus valore.
Oltre a due interessanti contributi sul tema Religione, uno di Stefano Petrucciani (Sapienza) e uno di Michael Loewy (Centre de la recherche scientifique, Francia) su aspetti del feticismo in Marx, ma anche su quello attualissimo della Teologia della Liberazione , la grande preziosa corrente della Chiesa sudamericana.
Gli argomenti che più hanno appassionato i partecipanti, perché per molti versi i più nuovi, quello dell’Ecologia e quello di Genere.
Sul primo hanno parlato tre relatori venuti ciascuno da una diversa parte del mondo: Kohei Saito dal Giappone (Osaka University), Gregory Claeys (Royal Holloway University UK), Razmig Keucheyan ( nome palesemente armeno ma Università di Bordeaux). Tutti e tre hanno in qualche modo affrontato il tema dal lato dei bisogni, citando gli scritti dei due principali teorici dell’argomento, André Gorz e Agnes Heller, ma mettendoli in rapporto con le tantissime e quasi sempre ignorate riflessioni di Marx sulla rapina della natura, così come sulla liberazione del tempo (Manoscritti del ’44, Ideologia tedesca, Critica alla filosofia del diritto di Hegel, Grundrisse,lo stesso Capitale).
E dunque insistendo sul fatto che occorre sottrarsi al consumismo imposto dal modo di produzione capitalista ( l’imbroglio del capitalismo) e invece qualificare i propri bisogni ,non moltiplicarli. Un mutamento possibile tuttavia solo se si libera tempo dal lavoro per lo sviluppo della creatività, proprio quello che il capitale nega. Greta è stata naturalmente molto citata, e però come ha detto Claeys, dobbiamo risponderle in fretta, ma non abbiamo ancora elaborato le linee della rivoluzione necessaria ad affrontare il problema.
L’ultimo round è stato per il Genere con Humani Bannerji (indiana ma York University Toronto) e di Elvira Concheiro (Unam,Mexico). Nel riprendere il più recente dibattito femminista molto si è insistito su quello che è stato definito “incontro possibile con Marx”, e cioè sulla connessione della battaglia delle donne con quella anticapitalista. E per questo molto si è parlato del lavoro non pagato di riproduzione e di cura.
Per questo più volte citato il nuovo manifesto femminista americano scritto da Nancy Fraser e Cinzia Arruzza ( giovane siciliana ma docente universitaria a new York), intitolato “Patriarcato e capitale, alleanza criminale”.
Il discorso di chiusura ha rappresentato un evento eccezionale. A pronunciarlo è stato Alvaro Garcia Linera, vicepresidente della Bolivia dal 2006, il paese altissimo sulle Ande presieduto dal leggendario indio Morales. Linera ha una storia diversa, è un raffinato intellettuale marxista, che ha trascorso come tanti nel suo continente molti anni in prigione. Ha tenuto una relazione lunga, argomentata e colta, spiegando come stanno provando a fare un socialismo diverso da quello che abbiamo chiamato “reale”.
Insistendo sulle necessarie forme di democrazia e sulla socializzazione dei beni (il famoso bencomunismo) al posto delle statalizzazioni. Non provo neppure a darne una traccia, ma spero si sarà in grado di pubblicarlo al più presto. Linera è venuto apposta a Pisa, per poche ore, fra un impegno a Barcellona e uno a Parigi. Voleva esserci, e noi della sua partecipazione siamo stati orgogliosi e commossi .(Particolarmente io perché mi ha parlato subito de Il Manifesto ).
Ringraziando tutti a nome dell’Università di Pisa a conclusione della Conferenza Maurizio Iacono ha detto: “Ricucire, pur mantenendo la necessaria tensione dialettica, tempo lungo della ricerca, della storia e dell’immaginazione, e tempo breve dell’azione civile, politica e della vita quotidiana, nella consapevolezza che non ci può essere libero sviluppo delle facoltà individuali senza la fine dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, dell’uomo sulla donna, dell’uomo sulla natura.E’ questo che abbiamo imparato da Marx e che deve presupporre ogni tentativo di ripensare l’alternativa e ogni lotta per la dignità e l’uguaglianza.”
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - Sé come un altro ovvero “resa e cattura”: la prospettiva di Kurt Wolff (di Roberto Cipriani).11 maggio 2019, di Federico La Sala
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff:
- Sé come un altro ovvero “resa e cattura”: la prospettiva di Kurt Wolff di Roberto Cipriani.
UNA METODOLOGIA PER L’ANALISI QUALITATIVA: RESA E CATTURA DI WOLFF (di ROBERTO CIPRIANI)
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- La "diade" (madre-figlio) e il Congresso Mondiale delle Famiglie. Appello (di Luisa Muraro)..31 marzo 2019, di Federico La Sala
NEL REGNO DI EDIPO: "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE", L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO... *
Appello di una femminista alle donne cristiane che sono contro il Congresso mondiale delle famiglie
di Luisa Muraro (Libreria delle donne, 29 Marzo 2019)
Care amiche, vorrei sottoscrivere il vostro Appello contro il Congresso delle famiglie a Verona. Sono d’accordo con quello che dite, in primo luogo che la famiglia non è un’entità naturale ma un’istituzione culturale, che quasi sempre mostra una forte impronta patriarcale.
A me e a voi, suppongo, è chiaro che prima della famiglia, comunque intesa, c’è la diade formata da una donna e dalla creatura che lei ha concepito e portato al mondo. È un rapporto molto speciale, che precede i dualismi tipici della cultura maschile: la donna che accetta di entrare nella relazione materna, alla sua creatura dà la vita e insegna a parlare, le due cose insieme. Ed è un “insieme” che si tende, come un ponte insostituibile, sopra l’abisso della schizofrenia umana.
Vorrei ma non posso sottoscrivere il vostro Appello perché, nella difesa delle nuove forme familiari, non c’è una critica di quelle che si costituiscono da coppie che, sfortunatamente o naturalmente sterili, invece di adottare, si fanno fare la creatura a pagamento.
Da donne cristiane, mi aspettavo una calorosa difesa dell’adozione e un’energica richiesta della sua estensione a persone e coppie finora escluse dalla legge. Ma, ancor più, essendo voi donne, mi aspettavo una difesa della relazione materna libera e responsabile così come oggi è diventata possibile. Invece, parlate solo di genitorialità, usate cioè una parola tipica del linguaggio neutro-maschile. E a voi che parlate del corpo femminile come luogo di spiritualità incarnata, chiedo: che famiglia è mai quella che nasce con il programma esplicito, messo nero su bianco, di cancellare la relazione materna che si sviluppa con la gestazione in un intimo scambio biologico e affettivo?
Voi, a differenza di tanti cattolici, leggete la Bibbia e sapete che la cosiddetta gravidanza per altri, ossia la donna che partorisce senza diventare madre, corrisponde pari pari ad antiche usanze del patriarcato, usanze che sembravano superate. Le ultime pagine del Contratto sessuale di Carole Pateman, parlano proprio di questo sostanziale arretramento. Detto alla buona, ci sono “nuove” famiglie che di nuovo hanno solo la tecnologia.
A proposito: che cosa pensano di tutto questo gli uomini vicini a voi, i vostri compagni di fede e d’impegno politico? Perché non compaiono nel vostro Appello? Mi è venuto un sospetto, di ritrovarmi davanti a quel noto comportamento maschile che è di nascondersi dietro a una o più donne quando si vuol far passare pubblicamente qualcosa che è contro le donne. Devo portare degli esempi? Ma, se questo non fosse vero, scusatemi.
(www.libreriadelledonne.it, 28 marzo 2019)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. COME NASCONO I BAMBINI? - E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!
Cultura e civiltà. L’ordine simbolico della madre.....
 NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima"
NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima""L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": L’ALLEANZA CATTOLICO-"EDIPICA" DEL FIGLIO CON LA MADRE!!!
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’Italia e il Congresso mondiale delle famiglie. Intervista a Chiara Saraceno: «Non difendono le donne, vogliono solo chiuderle in casa»28 marzo 2019, di Federico La Sala
Politica
«Non difendono le donne, vogliono solo chiuderle in casa»
Chiara Saraceno. «Oggi il linguaggio omofobo della politica autorizza chiunque a offendere il papà o la mamma di un bambino»
di Carlo Lania (il manifesto, 26.03.2019)
«Questi gruppi esistono da sempre, oggi gli diamo tutta questa attenzione perché si riuniscono a Verona ma sono gli stessi delle Sentinelle in piedi o del Family day. Sono quelli che pensano che ogni diritto riconosciuto a qualcun altro sia un diritto tolto a loro. Da qui la difesa della famiglia naturale, come se poi davvero esistesse, fatta come se fosse sotto attacco la famiglia fondata sulla coppia eterosessuale. E’ un po’ come un tempo si definivano alcuni bambini illegittimi per difendere la famiglia legittima».
Sociologa, Chiara Saraceno guarda con preoccupazione al Congresso mondiale delle famiglie che si apre venerdì a Verona.
«Sarebbe quasi da non prenderli in considerazione, se non fosse che ultimamente queste posizioni hanno un grande ascolto e popolarità nei governi più reazionari. Sono molto amati non tanto e solo da chi è contrario alle coppie omosessuali, ma da chi è contrario a ogni diritto civile, di libertà, di opinione».
Colpisce che questi gruppi abbiano per la prima volta un palcoscenico così visibile.
Ma glielo abbiamo dato noi, perché fino a quando hanno fatto le loro cose in Ungheria o in Moldavia non si è saputo. Invece sulla loro pagina web dicono di essere stati invitati dal vicepremier Salvini. Non so se sia vero o no, comunque nessuno li ha smentiti. In più c’è stata la vicenda della sponsorizzazione della presidenza del consiglio che pare sia stata ritirata. Preoccupa l’avallo politico dato da una parte del governo che, pur essendo minoritaria, è quella che comanda, al punto da aver imposto un proprio ministro per la famiglia il quale è un grande sponsor del congresso. In più stanno sempre lì che difendono la famiglia naturale ma li vedessi mai fare qualche proposta seria di sostegno alle famiglie. Niente. L’unica cosa che gli viene in mente è che bisogna aiutare le mamme a stare a casa.
La famiglia tradizionale è sempre stata un cavallo di battaglia esclusivo della destra. E’ stato anche questo un errore della sinistra?
Questo era vero fino a dieci, quindici anni fa. Quando io ho cominciato a occuparmi di questi temi dicevo che in Italia c’era stato una specie di patto di Yalta, per cui del lavoro si occupava la sinistra e della famiglia si occupava la destra. Già negli anni ’70, un po’ sotto lo stimolo del movimento delle donne, la sinistra ha dovuto abbozzare alcune proposte. Poi sicuramente quando è stata ministro per gli Affari sociali Fernanda Contri con il governo Ciampi alcune politiche sono state fatte anche se mai abbastanza, perché arrivavano sempre di rimessa. E poi naturalmente c’è stata tutta la stagione dei diritti civili. Anche recente. Quello che imputo alla sinistra è che non ha mai fatto davvero delle serie politiche per la famiglia, salvo la breve stagione quando ministro fu Livia Turco che raccattò un po’ di finanziamenti per gli asili nido.
Dagli anni ’70 a oggi le trasformazioni della famiglia sono state notevoli, ne cito solo alcune: divorzio, unioni civili e poi le famiglie arcobaleno.
Ma le trasformazioni ci sono state anche all’interno della stessa famiglia, basti pensare che oggi la maggioranza dei bambini in età prescolare ha una mamma che lavora, oppure al fatto che molti padri, soprattutto se giovani, non pensano più che la cura dei bambini non li riguardi. Non parliamo poi dell’invecchiamento delle parentele, altro argomento su cui la politica ha riflettuto poco. Si parla sempre del fatto che l’invecchiamento della popolazione uccide il welfare, ma non si considera che sta anche sovraccaricando le reti familiari.
Le conquiste degli anni passati oggi però vengono messe in discussione.
Vengono messe in discussione da questi signori che si trovano a Verona e sicuramente anche dal nostro ministro degli Interni e dal nostro ministro della Famiglia. Non credo però che avranno il coraggio di cancellare delle leggi. Semplicemente fermeranno il percorso, lo renderanno più difficile, e questo anche con il linguaggio . Oggi una parte della popolazione si sente autorizzata a offendere il papà o la mamma di un bambino solo perché certe espressioni omofobe fanno ormai parte del discorso pubblico.
Gli organizzatori del congresso si difendono dalle critiche affermando che loro vogliono solo parlare di politiche per la donna.
Già quando uno parla della donna al singolare mi fa venire un po’ di rabbia. Presuppone l’idea che le donne abbiano tutte gli stessi desideri o gli stessi doveri e che se venissero aiutate starebbero volentieri a casa loro a curare i bambini.
E infatti viene proposto un reddito di maternità.
Sono meccanismi che rischiano di impoverire le donne. I figli stanno a casa a lungo ma non hanno bisogno di essere curati a oltranza. Allora chi è rimasta a casa, magari sostenuta da un reddito, che possibilità avrà di ritornare sul mercato del lavoro o di avere una pensione adeguata? Nessuna. E per di più produrrà ulteriore diseguaglianza, perché le donne con un’istruzione non rinunceranno a lavorare, mentre le altre invece di essere incoraggiate a formarsi vengono spinte a stare a casa, sempre più dipendenti da un uomo che spesso, dal punto di vista economico, non ce la fa neanche lui. Il risultato è che nel medio lungo termine, quando quel reddito sarà finito, le famiglie impoveriranno.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "Muri e Mari". Se la poesia guarda ai migranti per indagare l’ignoto dentro e fuori di noi (di27 marzo 2019, di Federico La Sala
Cultura
Se la poesia guarda ai migranti per indagare l’ignoto dentro e fuori di noi
Scaffale. "Muri e Mari" di Marco Cinque per le edizioni Ensemble. Una raccolta, introdotta da Jack Hirschman e illustrata da Mauro Biani, in cui la tensione poetica è drammaticamente sospesa, mai fine a se stessa, fino a diventare intento, forza che spinge ed attira verso la conoscenza dell’"altro": il migrante, uomo, donna, bambino, in mare, a Roma o in ogni altro posto, è il Giusto, l’essere che in sé porta la Salvezza
di Raffaele K. Salinari (il manifesto, 27.03.2019)
Per Anatole France il vero significato della parola «viaggiare» era quello del cambiare opinioni e pregiudizi. Per Osip Mandel’stam invece che, una volta, chi non aveva viaggiato non osava scrivere. In questa raccolta di poesie, di cronache in versi, di immagini che si fissano nelle pieghe dell’anima, traspaiono esperienze vissute e condivise: chi scrive non solo ha viaggiato, ma accolto in sé l’altro, il diverso per eccellenza, l’alieno che viene dal nostro stesso altrove: il migrante.
Ma chi è il migrante per Marco Cinque? Chi è questo totaliter aliter che, alla fine, sostanzia la parte più profonda di noi e ci invita a ri-guardarci alla luce interrogativa che ogni esperienza vitale suscita e accende? Qui, in queste pagine di Muri e Mari (edizioni Ensemble) con l’introduzione di Jack Hirschman, «poeta laureato emerito», come si definisce nella prefazione, e l’evocativa copertina di Mauro Biani, la tensione poetica è drammaticamente sospesa, mai fine a se stessa, una tensione che così diventa intento, in-tensio, forza che spinge ed attira verso la conoscenza dell’ignoto dentro e fuori di noi: il migrante, uomo, donna, bambino, in mare, a Roma o in ogni altro posto, è il Giusto, l’essere che in sé porta la Salvezza.
Ad un certo punto del folgorante saggio sull’opera di Nikolaj Leskov, Walter Benjamin ci introduce alla sua originalissima idea di apocatastasi: la Salvezza universale attraverso il ritorno di tutti gli esseri alla pienezza originaria. Il sentiero che invita a percorrere da quel momento è, come spesso nel suo stile, notturno e sotterraneo: pieno di oscure analogie e necriche metafore che però, alla fine, seguendo la mappa tracciata dal suo immaginario messianico, ci portano al cospetto di una splendente verità.
Come guida naturale del tortuoso cammino verso la verità del nostro essere nel Mondo, del nostro esserci, Benjamin staglia dai racconti di Leskov questa particolarissima figura che egli chiama «il Giusto». Incarnazione complessa perché estremamente sfaccettata, maschera di volta in volta diversa, il viaggiatore, il pellegrino, il nomade, l’apolide, come i personaggi delle poesie di Marco Cinque, sono tra le sue incarnazioni più frequenti. In tutte queste versioni, che nel nostro tempo costituiscono il prisma della complessa figura migrante, il giusto mostra la sua essenza costante che si trasmette, di sfaccettatura in sfaccettatura, come in quelle Pathosformel che Warburg cercò di incasellare nel suo favoloso atlante Mnemosyne.
E non è Memoria questa raccolta di poesie? Benjamin parte da Bloch, citandone l’interpretazione del mito di Filemone e Bauci, nel quale si descrive la figura del Giusto come colui, «favolosamente scampato alla follia del mondo» e che, proprio mercé questa sua caratteristica, è in grado, attraverso i suoi racconti, di portare un annuncio di Salvezza, di apocatastasi appunto. Ecco perché queste poesie, tra l’altro splendidamente tradotte in inglese da Alessandra Bava, queste cronache, questi insight, che Marco Cinque ci offre, non parlano solo di vita, di salvezza fisica, di accoglienza, ma, purtroppo, anche di morte, di abbandono, di una tremenda ingiustizia egoista, della nostra indifferenza.
Molte pagine sembrano stagliare la figura migrante come talmente fragile che l’idea stessa che da questa possa venire un annuncio di Salvezza attraverso la loro stessa salvezza, sembra assolutamente incoerente. Ma, se ci pensiamo bene, se rimaniamo il tempo necessario nell’atmosfera di ogni pagina, della visione che ogni verso vorrebbe trasmetterci, non ci sovveniamo, ancora una volta che il pensiero dell’eternità ha sempre avuto la sua fonte principale nella morte?
Per attivare questa operazione favolosa che trasmuta i racconti di morte nella tensione massima verso la vita, l’autore, forse inconsciamente, o forse come forma della sua stessa esperienza esistenziale, potrebbe fare suo il motto di Johann Peter Hebel, quando dice che la morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare e aggiunge, «dalla morte egli attinge la sua autorità. O, in altre parole, è la storia naturale in cui si situano le sue storie». La morte come fonte di rinascita dunque è l’origine del racconto, la matrice della sua eternità. Come non vedere in questa affermazione la sanzione di queste pagine, la loro sottile fascinazione?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- MITO E FILOSOFIA: L’ARAZZO DI ATENA E L’ARAZZO DI ARACNE E FILOMELA.12 marzo 2019, di Federico La Sala
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA...
LA LUNA (“LA SCIANA”), IL DESIDERIO (“LU SPILU”), E IL FILO DI ARACNE.
Quanti millenari pregiudizi ... *
CONSIDERATO CHE “SCIANA”, sinonimo di “umore”, «è in uso in locuzioni del tipo “osce sto ti sciana” (oggi “sto di umore giusto”, ho voglia di fare) ma anche in unione all’aggettivo che ne definisce esplicitamente il valore positivo (“sto ti bona sciana”) o negativo (“sto ti malesciana”). Il derivato “scianaru” (prevalentemente e, come dirò, non a caso, usato al femminile “scianara”) come sinonimo di “volubile” [...]» (cfr. Armando Polito, “Dialetti salentini: sciàna”, Fondazione Terra d’Otranto, 10.03.2019); E CHE “SCIANA” è «deformazione dell’italiano “Diana”, dea della luna e della prima luce del mattino oltre che della caccia, dal latino “Diàna(m)”, da dius=divino, connesso con dies=giorno e con Iùppiter=Giove [da Iovis=Giove (a sua volta dal greco Zeus/Diòs)+pater=padre]» (cfr. Armando Polito, “Lu spilu e la sciàna”, Fondazione Terra d’Otranto, 16.12.2011).
E’ BENE RICORDARE CHE «Diana, com’è noto era gemella di Apollo, entrambi figli di Zeus e Latona ...» (op. cit.).
MILLENARI PREGIUDIZI. Per non scivolare nel “terreno viscido” e perdersi nell’aria nebulosa di ingegnosi labirinti e, al contempo, riuscire a districarsi tra millenarie “incrostazioni irrazionali” , forse, è opportuno tenere ben aperti gli occhi dinanzi ai bagliori emessi “dalla rete dell’oro” del SOLE dell’OLIMPO (“Dalla rete dell’oro pendono - così epigrammaticamente Salvatore Quasimodo - ragni ripugnanti”). e riguardare con attenzione gli ARAZZI tessuti da Atena, da Aracne, e da Filomela (cfr. Ovidio, “Metamorfosi”: La tela di Aracne apre il libro sesto, la storia di Filomela lo chiude ... Prima che la dea adirata Atena (Minerva) stracci la stoffa tessuta da Aracne, la tessitrice, donna mortale, racconta su di essa una storia molto particolare).
FORSE solo così si potrà uscire dal labirinto, senza perdere il filo, senza abbandonare Arianna, e tornare ad Atene con le vele bianche - non nere!
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- IL MIO DECALOGO CONTRO OGNI FORMA DI POTERE. Credo di una donna (Robin Morgan con sette femministe di vari paesi).10 marzo 2019, di Federico La SalaIL MIO DECALOGO CONTRO OGNI FORMA DI POTERE. Noi, esseri umani e donne, siamo la maggioranza della specie, ma abbiamo abitato nell’ombra. Noi le invisibili, le analfabete, le sfruttate, le profughe, le povere. E noi votiamo: mai più. Sospese sull’orlo del nuovo millennio, abbiamo alle spalle la rovina, davanti nessuna mappa, il sapore della paura acuto sulle nostre lingue.
 Eppure faremo il salto.
Noi siamo la continuità, intessiamo il futuro col passato, la logica con la poesia. Noi siamo le donne la cui anima nessuna gabbia fondamentalista può contenere. Noi siamo le donne che rifiutano di permettere che si semini morte nei nostri giardini, nell’ aria, nei fiumi, nei mari. Siamo stanche di enumerare le nostre sofferenze. Abbiamo fame d’ azione, dignità, gioia. Intendiamo fare di meglio che resistere e sopravvivere. Hanno tentato di negarci, definirci, piegarci, denunciarci. Ci hanno ridotte in schiavitù, esiliate, picchiate, stuprate, seppellite - e ci hanno annoiato. Noi siamo la bambina dello Zambia, la nonna della Birmania, le donne del Salvador e dell’ Afghanistan, della Finlandia...
Eppure faremo il salto.
Noi siamo la continuità, intessiamo il futuro col passato, la logica con la poesia. Noi siamo le donne la cui anima nessuna gabbia fondamentalista può contenere. Noi siamo le donne che rifiutano di permettere che si semini morte nei nostri giardini, nell’ aria, nei fiumi, nei mari. Siamo stanche di enumerare le nostre sofferenze. Abbiamo fame d’ azione, dignità, gioia. Intendiamo fare di meglio che resistere e sopravvivere. Hanno tentato di negarci, definirci, piegarci, denunciarci. Ci hanno ridotte in schiavitù, esiliate, picchiate, stuprate, seppellite - e ci hanno annoiato. Noi siamo la bambina dello Zambia, la nonna della Birmania, le donne del Salvador e dell’ Afghanistan, della Finlandia...
 (da ’Credo di una donna’ scritto da Robin Morgan con sette femministe di vari paesi’ -
(da ’Credo di una donna’ scritto da Robin Morgan con sette femministe di vari paesi’ -
 Laura Lilli, "Femministe europee siete arroganti", la Repubblica, 17.09.1996).
Laura Lilli, "Femministe europee siete arroganti", la Repubblica, 17.09.1996).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- CON IL "DIO DI AMORE" DI OVIDIO E BRUNETTO LATINI AL"L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" DI DANTE20 febbraio 2019, di Federico La Sala
IL "DIO DI AMORE" DI (OVIDIO E) BRUNETTO LATINI E "L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" DI DANTE.... *
Su Brunetto Latini, “Poesie”, a cura di Stefano Carrai
di Claudio Giunta (Domenicale del Sole 24 ore, 20 marzo 2016)
- Brunetto Latini, Poesie, a cura di Stefano Carrai, Torino, Einaudi 2016, euro 15.
Il Tesoretto di Brunetto Latini non è certamente quel misconosciuto «capolavoro della letteratura allegorica» che diceva Jauss (ma come mai lo abbiamo preso sul serio?), ma è un modo eccellente per avvicinarsi alla poesia dei primi secoli; e questa nuova edizione a cura di Stefano Carrai è un modo eccellente per avvicinarsi al Tesoretto.
Si tratta di un poemetto, 2944 versi in tutto, scritto da Brunetto Latini al principio degli anni Settanta del Duecento. È uno strano ibrido. Comincia come un racconto di viaggio (il poeta-protagonista si trova a Roncisvalle, e qui incontra uno studente bolognese che gli comunica la sconfitta dei guelfi a Montaperti), prosegue come un trattato didascalico (la Natura personificata illustra al poeta l’ordinamento del cielo e della terra), poi come un trattato morale (il poeta incontra in successione le virtù, il dio d’Amore, il poeta Ovidio), e finisce con una bizzarra ‘Penitenza’, circa 500 versi in cui Brunetto riflette sulla caducità delle cose umane ed esorta un amico a cambiare vita come lui l’ha cambiata («che sai che sén tenuti», scrive, «un poco mondanetti»); dopodiché il racconto riprende e il protagonista si trova sul monte Olimpo, dove incontra il grande Tolomeo, «maestro di storlomia». Qui il testo s’interrompe di colpo.
Al di là però del contenuto, né originale né profondo, e al di là dello stile, senza veneri (anche perché imprigionato in una gabbia metrica da filastrocca: coppie di settenari a rima baciata), il Tesoretto è un testo interessantissimo perché è davvero un repertorio di topoi immaginativi, un campione di medievalità: c’è il viaggio nella foresta, c’è un mondo fantastico all’interno del quale il personaggio-poeta può dialogare via via con la Natura, con Ovidio o con Tolomeo, ci sono le ipostasi delle virtù e delle percezioni, che pescano dall’identico immaginario da cui hanno pescato gli sceneggiatori di Inside Out (Desianza=Joy, Paura=Fear): «Desïanza ... sforza malamente / d’aver presentemente / la cosa disïata / ed è sì disvïata / che non cura d’onore / né morte né romore, / se non che la Paura / la tira ciascun’ora, / sì che non osa gire / né solo un motto dire».
Il commento di Carrai è un commento esatto e intelligente. Sembra poco, ma è tantissimo, perché i commenti alla poesia (e soprattutto alla poesia antica) sono spesso un po’ stupidi. Chi ha studiato per anni un autore o un testo non si rassegna facilmente a farsi da parte, cioè a tacere una volta chiarito ciò che nel testo c’è da chiarire, ed eventualmente a far riflettere il lettore su ciò che il testo può dire sul suo autore o sulla mentalità dell’epoca in cui venne scritto: non si rassegna, gli viene, come diceva il dottor Johnson, «la fregola di dire qualcosa anche quando non c’è nulla da dire», o peggio - e la cosa è specialmente frequente nel campo della medievistica - gli viene la fregola di trovare verità nascoste, di sciogliere gli enigmi, il che porta spesso a postulare enigmi là dove non ce ne sono, onde una ridda di ipotesi e contro-ipotesi da stancare un causidico. E poi, a riempire le pagine, valanghe di ‘riscontri intertestuali’, come se importasse qualcosa che il poeta X ha preso quella parola dal poeta Y o dal poeta Z. Carrai invece non scaraventa sul lettore tutto il contenuto delle sue schede, spiega il testo dove occorre, e dove non riesce a spiegare prospetta delle ipotesi d’interpretazione, appoggiandosi - per consentire o per dissentire - a chi del Tesoretto si è occupato prima di lui.
Al Tesoretto Carrai fa seguire, com’è consuetudine, il Favolello, che è un altro breve poemetto in settenari baciati, più pedestre nel contenuto (è uno scialbo trattatello sull’amicizia), ma interessante soprattutto perché cita come amici-destinatari due rimatori contemporanei, Rustico Filippi e Palamidesse di Bellindote. E al Favolello segue, nel volume (che appunto per questo s’intitola Poesie: è l’opera omnia in volgare italiano di Brunetto), l’unica canzone di Brunetto che ci venga tramandata dai manoscritti, S’eo son distretto, strana poesia d’amore e devozione che alcuni hanno interpretato come un documento dell’omosessualità dell’autore (con ovvi riflessi sull’interpretazione di Inferno XV) e altri, direi più plausibilmente, come canto nostalgico per la patria, Firenze, dal quale il guelfo Brunetto viene bandito dopo Montaperti.
Manca, e avrebbe invece dovuto esserci, la canzone responsiva di Bondie Dietaiuti (così, nel Medioevo, si dissolvevano le tenzoni poetiche: gli scribi copiavano i corpora personali degli autori obliterando i testi missivi e responsivi dei loro corrispondenti, che in questo modo si disperdevano; ma in un’edizione moderna non si vede perché le tenzoni non debbano essere date nella loro integrità).
Il discorso sul Tesoretto e sul Favolello non è chiuso. Sono testi facili solo all’apparenza, specie a causa delle contorsioni che il metro e lo schema delle rime impongono all’autore. Di certi hapax resta poco chiaro, nonostante lo sforzo degli interpreti, il significato. Altri termini sono ambigui (per esempio non parafraserei con ‘verità’, con Contini e Carrai, il drittura di Favolello 7 «e fàllati drittura»: ‘giustizia’, che è il senso che drittura ha usualmente, mi pare più aderente al contesto). E certi passi dovranno forse essere riconsiderati in una futura edizione critica. Per esempio, ai vv. 1275-79 tutti gli editori postulano un (credo inattestato altrove) ablativo assoluto: «E vidi ne la corte, / là dentro, fra le porte, / quattro donne reali / che corte principali / tenean ragione ed uso». Dove «corte principali» vorrebbe dire ‘nella prima corte’. Ma dato che le «donne» di cui si parla sono virtù, e che principales è l’aggettivo che nel Medioevo spesso si predica delle virtù, in genere le cardinali, ci si deve domandare se la lezione corretta non sia piuttosto, con minimo emendamento, «come principali», cioè ‘come signore, regine di quella corte di giustizia’ (e sarebbe un altro errore d’archetipo, da aggiungere a quelli registrati da Pozzi e Contini nei Poeti del Duecento).
Forse potremmo chiudere, invece, il discorso sui rapporti tra Brunetto e Dante, salvo che non saltino fuori nuovi testi che permettano di riconsiderare sotto nuova luce la questione. Questione che è nota ad ogni studente liceale: Dante mette Brunetto all’Inferno, tra i sodomiti, ma non dice nulla della sua colpa (il che sorprende fino a un certo punto, dato che non sempre Dante lo fa), né di questa colpa si parla nelle fonti che non dipendono da Dante (il che non sorprende per niente: ci si aspetta che l’omicidio o la simonia lascino traccia nelle cronache, non necessariamente le inclinazioni sessuali).
Sodomia va allora inteso figuratamente, come ‘peccato contro la propria lingua materna’ (perché Brunetto, fiorentino, ha scritto il suo Tresor in francese)? Oppure come peccato politico (perché Brunetto non avrebbe «riconosciuto la sacra autorità dell’Impero»)? Mi sembra che la soluzione proposta da Zanato e ora da Carrai resti la più sensata: dato che Brunetto ci appare in compagnia di «Prisciano, Francesco Accursio e Andrea de’ Mozzi, [cioè] del gruppo di intellettuali, perlopiù pedagoghi ed ecclesiastici, che si sono resi colpevoli di pratiche omosessuali», non c’è ragione di pensare che lui non si sia macchiato dello stesso - non metaforico - peccato.
Non andrei oltre; né speculerei, per le ragioni che ho già accennato, sulla ‘memoria’ della poesia brunettiana nel canto XV. Il poeta Brunetto non aveva niente da insegnare a Dante, perché il peggior Dante (per esempio quello un po’ lezioso di Inferno IV: «Venimmo al piè d’un nobile castello, / sette volte cerchiato d’alte mura, / difeso intorno d’un bel fiumicello...») è migliore del migliore Brunetto. E l’idea che quando Dante mette in scena un altro poeta si serva - attraverso accorte allusioni - delle parole che quel poeta ha adoperato nelle sue opere mi sembra davvero un’idea tutta nostra, un’idea da filologi moderni, che mettiamo a forza nella testa di scrittori molto meno sottili di noi.
E questo vale anche per la testimonianza che molti (anche Carrai) considerano più probante: l’avvio del canto XV, «Ora cen porta l’un de’ duri margini...», nel quale si condenserebbero «gli echi di mosse identiche del Tesoretto, vv. 1183-84 “Or va mastro Burnetto / per un sentiero stretto”, e 2181-82 “Or si ne va il maestro / per lo camino a destro”». Ma direi di no: è una formula di transizione che si trova molte volte nella poesia narrativa francese, per esempio nel Girart de Rossillon («Ere s’en vait Girarz egal solel / per un estreit sender...» (l’identica immagine del sentiero stretto che si trova in Brunetto Latini), nella chanson de toile Gaiete et Oriour («Or s’an vat Oriour stinte et marrie»), nel Macaire franco-veneto, «Ora se voit sor un corant destrer». Langue, insomma, non parole, come nella poesia medievale capita non dico sempre, ma quasi.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI". DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "DUE SOLI": PER UNA NUOVA "BUSSOLA TEOLOGICA". L’indicazione di Dante.19 febbraio 2019, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELLA "MENTE ASTUTA". PER UNA NUOVA "BUSSOLA TEOLOGICA" .... *
Classici.
Più fede nella politica, la lezione di Dante
La vicenda biografica e intellettuale del grande fiorentino si rivela di grande attualità ancora oggi, specie per quanto riguarda l’impegno dei credenti a favore del bene comune
di Gabriella M.Di Paola Dollorenzo (Avvenire, 17 febbraio 2019)
- [Foto] La visione del «Paradiso» dantesco in un’incisione di Gustave Doré
L’intervista al cardinale Gualtiero Bassetti (Avvenire, 9 dicembre 2018) ha riportato la nostra attenzione «sull’impegno concreto e responsabile dei cattolici in politica». Già nell’inchiesta del mensile Jesus sul «tempo del rammendo » (ottobre 2018), il presidente della Cei aveva rimarcato l’urgenza di ricostruire una presenza laicale che guardasse alla politica come a un’avventura positiva, nella necessità di una classe dirigente in grado di opporre alla sfiducia popolare un forte senso di concretezza e di responsabilità. Queste virtù o, per meglio dire, questi talenti ci permettono di richiamare la coerenza del pensiero politico di Dante così come ebbe a svilupparsi, sia negli anni di politica attiva sia dopo l’esilio e parallelamente allo svolgersi del suo pensiero teologico nella Commedia. Considerare l’architettura del suo pensiero, il rapporto tra teoria e prassi, l’utilizzo anzi l’interazione delle fonti (Sacre Scritture, autori grecolatini, testi arabi) può essere utile per individuare l’archetipo del cristiano impegnato nella realtà politica del proprio tempo, con l’ambizione di tradurre l’imitatio Christi nel concreto operare all’interno della res publica.
La vicenda umana del Poeta incardinato nella realtà politica del suo tempo, specialmente negli anni che vanno dalla morte di Beatrice (1290) alla condanna all’esilio (1302), ci permette di riflettere sul rapporto teologia- politica, così come fu duramente ma appassionatamente vissuto, in «un crescendo di temerarietà e di coerenza» (Giorgio Petrocchi, Vita di Dante, 1993) e, nello stesso tempo, avendo ben salda la «coscienza della storia», quell’habitus morale in base al quale «gli avvenimenti non si confondono caoticamente nella memoria, ma sono collegati dalla coscienza della causa e dell’effetto, dell’iniziativa e della responsabilità» (Romano Guardini, Dante, 2008). Se accogliamo l’approccio euristico di Jürgen Moltmann (si veda in particolare Dio nel progetto del mondo moderno, edito da Queriniana nel 1999), possiamo capire in che senso la teologia può “binarizzarsi” con la politica determinando le scelte tra il bene e il male, nel concreto avvicendarsi della storia di una città, di una nazione, di un popolo. Non è un caso che la formazione filosofico-teologica di Dante preceda cronologicamente l’attività politica, anzi ne sia quasi il trampolino di lancio: «Io che cercava di consolarme, trovai non solamente a le mie lagrime rimedio, ma vocaboli d’autori e di scienze e di libri: li quali considerando, giudicava bene che la filosofia, che era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, fosse somma cosa. E da questo imaginare cominciai ad andare là dov’ella si dimostrava veracemente, cioè ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de li filosofanti » ( Convivio, II, xii, 5-7).
Dopo aver approfondito l’Etica Nicomachea e la Politica di Aristotele (nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke e col commento di Tommaso d’Aquino), nel libro II del Convivio si rivendica il primato della morale. Dante va oltre Tommaso d’Aquino: se la metafisica è la scienza di Dio, l’uomo potrà cercare lo status felicitatis in questa vita e, dato che l’uomo è un animale sociale, in una politica regolata dalla morale. Pertanto non è conforme alla morale rinchiudersi nella contemplazione dell’intelligibile, quando l’odio e la violenza di parte sconvolgono la comunità in cui si vive.
Nel 1294, anno dell’elezione e successiva abdicazione di Celestino V, nonché dell’ascesa al papato di Bonifacio VIII, Dante ha un ruolo diplomatico- culturale di primo piano nella delegazione dei cavalieri destinati dal Comune al seguito dell’imperatore Carlo Martello. In seguito, con la stesura del Paradiso, Dante potrà immaginare un incontro con Carlo al cospetto di Dio; il dialogo tra i due, con esplicito richiamo alla Politica di Aristotele, ma anche al De Anima, ha una precisa connotazione teologica: «“Vuo’ tu che questo ver più ti s’imbianchi?”. /E io: “Non già; ché impossibil veggio / che la natura, in quel ch’è uopo, stanchi”. / Ond’ elli ancora: “Or dì: sarebbe il peggio /per l’omo in terra, se non fosse cive?”. / “Sì”, rispuos’ io; “e qui ragion non cheggio”. / “E puot’ elli esser, se giù non si vive /diversamente per diversi offici? / Non, se ’l maestro vostro ben vi scrive”» ( Paradiso, VIII, 113-120).
Sarebbe un male per l’uomo sulla terra se non facesse parte di un ordine civile, di un organismo sociale? E può esistere un’organizzazione civile se i suoi membri non siano ordinati a vivere esercitando diverse funzioni? E Dante risponde “sì” alla prima domanda e “no” alla seconda. La naturale politicità dell’uomo si accompagna alla necessità di distinguere gli offici poiché Nihil frustra natura facit (Politica I, 2).
Il quinquennio successivo al 1294 segnerà intensamente la vita e l’opera di Dante proprio perché continuo sarà lo scambio tra teoria e prassi, una prassi in toga candida: dalla riflessione filosofica riguardo al primato della morale alla traduzione di ciò nella vita della polis, una sorta di ragion pratica kantiana ante litteram: impegno civile, riflessione morale, tenace inseguimento della giustizia.
Proprio quando Firenze è dilaniata da lotte sociali interne e lo stesso papato non è immune dalla brama di potere che assale i partiti politici, Dante tiene ben ferma la barra del suo operare cristiano, perché è fermamente convinto di agire nella direzione indicata dalla bussola teologica. In questo atteggiamento riconosciamo l’attualità del suo pensiero politico e del suo agire politico. Dopo la condanna, negli anni dell’esilio, Dante consegnerà alle pagine del Convivio, della Commedia, ma soprattutto del trattato Monarchia, la riflessione teorica frutto della sua esperienza politica. È un progetto in fieri perché dovrà fare i conti col divenire della storia, è un progetto politico voluto da Dio per il bene dell’umanità.
Dopo la fine del potere temporale dei Papi, la Chiesa, a partire dall’enciclica In praeclara summorum (1921) di Benedetto XV, fino al Messaggio al presidente del Pontificio Consiglio della cultura in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (2015) di papa Francesco, ha pienamente rivendicato, si pensi alla mirabile Altissimi cantus, la lettera apostolica di Paolo VI, l’appartenenza di Dante alla Chiesa cattolica e alla fede di Cristo, proprio considerando la sua battaglia di cristiano impegnato nella vita politica del suo tempo e nella sua somma opera teologica.
Oggi l’umanesimo cristiano di Dante può essere una traccia da seguire nella comunicazione religiosa e laica che stiamo vivendo. Per la preparazione del laicato cattolico alla vita politica, il pensiero di Dante può diventare una “bussola teologica”. Il rapporto tra fede, morale e politica, vissuto alla luce dei valori cristiani, che fece di Dante il segno di contraddizione della sua epoca, oggi fa di lui un nostro contemporaneo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Platone, Ippocrate, e i medici senza frontiere (di Roberto Mussapi).18 gennaio 2019, di Federico La Sala
I medici nascono senza frontiere
di Roberto Mussapi (Avvenire, venerdì 18 gennaio 2019)
«In quante case io entri mai, vi giungerò per il giovamento dei pazienti tenendomi fuori da ogni ingiustizia e da ogni altro guasto, particolarmente da atti sessuali sulle persone sia di donne che di uomini, sia liberi sia schiavi». Siamo all’inizio di uno scritto che segna una tappa fondamentale della civiltà: il Giuramento di Ippocrate, il medico che fonda il compito e traccia le basi della sua arte. «Io giuro su Apollo medico e Asclepio e Igieia e Panacea, e su tutti gli dei e le dee, prendendoli a miei testimoni...».
Il giuramento di Ippocrate, su cui si fonda la medicina, è fatto agli dèi, il compito del medico non riguarda esclusivamente il mondo della polis, ma è vincolato a quello sacro del divino. Studi recenti datano il giuramento intorno al V secolo a. C, il secolo che vede nascere la tragedia come genere teatrale di poesia, e la filosofia, pensiero come logos. Alle spalle il rito dionisiaco tragico, e il pensiero dei presocratici, i baldi e travolgenti scienziati-poeti. Prodigioso momento di creazione dei Greci che fondano l’Occidente.
Cittadini di una democrazia, non servi di un Re come gli Egizi o i Persiani. Ma civiltà non ancora compiuta. Le donne non godono di diritti civili, né considerazione, meno ancora degli schiavi. Insomma molestare una donna, o uno schiavo, non è, per il greco del tempo, così grave. Non sono cittadini, maschi.
Per Ippocrate invece è la stessa cosa. Supera i limiti della sua civiltà. Va oltre: giuro di non fare violenza a nessuno, perché tutti, comprese donne e schiavi, sono, siamo uguali. Supera i pensatori del suo tempo. È un medico. I medici nascono senza frontiere.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Marx, i "Manoscritti" del ’44, e l’alienazione. A proposito dell’ultimo numero di «La società degli individui».11 gennaio 2019, di Federico La Sala
MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".... *
L’alienazione come concetto da ridiscutere
A proposito dell’ultimo numero di «La società degli individui», a cura di Ferruccio Andolfi e Giovanni Sgro’
di Marco Gatto (il manifesto, 11.01.2019)
Il quadrimestrale di filosofia e teoria sociale La società degli individui dedica il suo ultimo numero a una rilettura del tema dell’alienazione depositato in quel testo tanto importante quanto discusso che è la raccolta dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Karl Marx. Ferruccio Andolfi e Giovanni Sgro’, nelle pagine introduttive, spiegano perché sia necessario ripensare adeguatamente il Marx umanista, dopo una lunga stagione che, da più versanti, ha inteso ribadire la centralità del Marx scienziato dell’economia, allestendo così una scissione assai problematica nell’opera del Moro che è alla base anche del più recente dibattito storiografico e filosofico.
Per i curatori, che si riallacciano a una più generale ripresa del concetto di alienazione proveniente da pensatori quali Axel Honneth e Rahel Jaeggi, ma che ne considerano la problematicità sia nel suo crinale critico-negativo, sia in quello propositivo di ripensamento della centralità individuale, gli attuali «fenomeni di spossessamento del sé continuano ad attirare l’attenzione anche dopo il superamento delle ingenuità utopico-essenzialiste» ormai date per scontate nel cammino riflessivo di Marx.
DEL RESTO, se è vero che il capitalismo contemporaneo produce forme di vita devote alla superficie o a uno sradicamento del concreto verso i registri distorsivi dell’astratto, che sovente sposano l’interezza delle retoriche neoliberali sul lavoro, una riflessione sulle nuove modalità di estraneazione sembra farsi all’ordine del giorno. Quelle oggi concepite come patologie sociali possono comunque definirsi attraverso concetti che rappresentano una dislocazione, una dissociazione dell’individuo dall’ambiente sociale, e dunque un suo autonomizzarsi dai legami; nello stesso tempo, questo distacco presuppone, per alcuni, una positiva esperienza critica e dunque l’apertura a una nuova modalità di conoscenza ed esperienza: una doppia accezione, insomma, che rende problematico il quadro filosofico legato al concetto di alienazione.
IL NUMERO è assai denso; i contributi - a firma di Mario Cingoli, Marcella D’Abbiero, Enrico Donaggio, Roberto Fineschi, Paulo Denisar Fraga, Stéphane Haber, Stefano Petrucciani, Eleonora Piromalli, Yvon Quiniou, Emmanuel Renault e Massimiliano Tomba - problematizzano le questioni rilevandone diversi gradi di prospettiva; non manca una riflessione, allestita da Sgro’, sull’interpretazione che dei Manoscritti avevano offerto Herbert Marcuse ed Erich Fromm, dei quali il numero presenta due scritti sul materialismo storico e sul socialismo. È ovviamente legata a questa riconsiderazione critica del Marx umanistico la proposta, messa in campo ancora da Andolfi e Sgro’, di una nuova edizione commentata dei Manoscritti, appena uscita presso l’editore Orthotes, e calibrata sulla nuova Marx-Engels-Gesamtausgabe, con un testo di accompagnamento assai puntuale che guida la lettura passo dopo passo.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CON MARX, OLTRE. "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)
COSMOLOGIA E CIVILTÀ. "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA
 KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI.
KARL MARX RISPONDE A SALVATORE VECA, PRENDE LE DISTANZE DA ENGELS E RENDE OMAGGIO A FULVIO PAPI."PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ...
 VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".11 gennaio 2019, di Federico La Sala
UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".... *
Una ribellione diversa
di Lea Melandri *
Sabato 12 gennaio si terrà a Milano, nella Casa della donne, l’assemblea di “Non una di meno” in preparazione dello “sciopero delle donne dell’8 marzo“.
Una giornata di sciopero delle donne ha un evidente significato forte per diversi motivi.
Sovverte un ordine che, dato come “naturale”, ha permesso di protrarre per secoli il dominio di un sesso sull’altro, la consegna delle donne al ruolo di madri, mogli, figlie, sorelle “di”, custodi della famiglia e della continuità della specie; la cura e il lavoro domestico possono finalmente essere visti per quello che sono sempre stati: “un grande aggregato dell’economia” (per dirla con Antonella Picchio), il sostegno materiale, psicologico, affettivo all’impegno “civile” dell’uomo.
“Per secoli - come scrive Virginia Woolf - le donne sono state gli specchi magici in cui si rifletteva la figura dell’uomo raddoppiata. Senza questa facoltà, la terra probabilmente sarebbe ancora palude e giungla”. Questi specchi sono stati “indispensabili ad ogni azione violenta ed eroica”.
Favorisce la presa di coscienza che “vivere per l’altro e attraverso l’altro” è stata la conseguenza dell’espropriazione di esistenza propria che le donne hanno subito, asservimento dei loro corpi e dei loro pensieri, cancellazione del loro tempo, confuso con l’immobilità delle leggi naturali.
Afferma visibilmente, con migliaia di presenze nelle strade e nelle piazze, che le “porte di casa”, le solitudini “private”, si aprono solo attraverso la costruzione di una socialità inedita tra donne, fatta di amicizia, amore, azione, intelligenza di sé e del mondo sottratta a modelli imposti e interiorizzati;
Lo sciopero delle donne, inoltre, porta allo scoperto la cultura e le pratiche politiche che fanno del femminismo la “rivoluzione più lunga”, ma anche la più “radicale” nello svelamento del sessismo - eterosessismo, superiorità maschile, ecc.- come fondamento di tutte le forme di dominio, servitù, violenza, disuguaglianza, che la storia ha conosciuto finora.
Denunciare, infine, la violenza maschile contro le donne in tutte le sue forme manifeste o invisibili, non deve impedirci di fare dell’8 marzo 2019 una giornata di lotta “creativa”.
Per tutte queste ragioni, mi sembra importante che ci poniamo alcune domande.
Su che posto riusciamo a dare nel nostro agire politico alla soggettività - l’esperienza, il vissuto delle singole donne (ragioni, ma anche sentimenti, sogni, pregiudizi, ecc.) - senza la quale è difficile avviare processi di identificazione necessari all’allargamento della rete e della sua azione.
Su come riprendere, in quella giornata, alcuni punti essenziali del Piano contro la violenza, in modo particolare per quanto riguarda la violenza in ambito domestico e il rapporto della cultura femminista con la scuola.
Su come evitare la sorte toccata ad altri movimenti, quando hanno creato un linguaggio e modalità di militanza chiusi e comprensibili a poche attivisti, finendo per diventare “fortezze nel deserto”.
Su come mantenere e approfondire i collegamenti internazionali senza perdere la specificità della situazione italiana.
* Insegnante, giornalista, scrittrice e saggista, riferimento per il movimento delle donne italiano. Tra i suoi libri: L’infamia originaria; Come nasce il sogno d’amore; Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia; La perdita; Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà. Altri suoi articoli sono leggibili qui.
* Comune Info, 10 gennaio 2019 (riproduzione parziale - senza immagini).
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO ---- UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- L’INDICAZIONE DI FACHINELLI. Cura di sé e cura del mondo (di Lea Melandri).25 dicembre 2018, di Federico La Sala
Cura di sé e cura del mondo
di Lea Melandri (Comune-info, 24 dicembre 2018)
L’odio e i veleni che l’Occidente ha sparso nel mondo, i suoi stessi “valori” - denaro, competizione -, gli ritornano indietro ingigantiti e lo mostrano per quello che realmente è: già contaminato da quella “barbarie” che ha contribuito a far crescere respingendola fuori di sé, fingendosi un’innocenza mai conosciuta. Per una specie di “contrappasso”, la parte del mondo che si è pensata dispensatrice di “progresso” e di civiltà, si trova oggi costretta a contare sul proprio territorio le piaghe che ha inflitto ad altri, con le sue industrie, le sue bombe, i suoi consumi illimitati.
C’è una parte del mondo dove la morte ha nome, storia, leggenda, e un’altra, la più estesa, dove è solo numero. La malattia mortale della Terra unifica la famiglia umana, costringe popoli di cultura e condizioni diverse a ragionare su una sorte comune, ad affrontare per la prima volta un pericolo di sopravvivenza che alla lunga non risparmierà nessuno. Ma, insieme alla scoperta di parentele, escono vistose dal silenzio e dall’invisibilità anche le disuguaglianze, le responsabilità e, sia pure tra molte opposizioni, alternative di sviluppo e di convivenza. Fornire insistentemente numeri e previsioni può diventare allora un modo inconsapevole per adombrare l’ansia e l’infelicità legate inevitabilmente all’uso distruttivo dei beni che produciamo o che troviamo in natura.
Accanto alle altre “catastrofi” si assiste oggi anche al declino dell’antica dialettica che ha diviso e contrapposto natura e cultura, donna e uomo, individuo e società. Cadono barriere millenarie e consolidate costruzioni di senso: così, paradossalmente, sono le cose, alienate dai nostri “consumi forzati”, è la natura, ferita nel suo equilibrio, sono le donne, i bambini, i poveri, i malati, a dire il dolore e la distruttività nascosti dietro la facciata di un mondo che si è creduto “civile”.
Nell’articolo pubblicato sul Manifesto (22/23 gennaio 1989) l’anno della sua morte - Freud, Rilke e la caducità -, Elvio Fachinelli così concludeva:
“Questo è il rovesciamento radicale dell’antica e ben nota posizione in cui la natura, madre divina, era chiamata a salvarci. Ora siamo noi sollecitati a salvarla. In Rilke questo rovesciamento, ottenuto passando attraverso la più dolorosa identificazione con l’effimero, si fa vivo come compito particolare dell’arte e della poesia (dire la Terra, farla diventare invisibile), che è nello stesso tempo un atteggiamento etico religioso. Ma entrambi presuppongono qualcosa di più ampio e indistinto, l’accettazione piena di una figura che comprende in sé e salva le creature, prima che sia troppo tardi: «un cuore», per usare le parole del poeta, in cui scaturisca un «innumerabile esistere».
Forse sta qui una delle chiavi anche per noi, oggi. Forse non di un lutto abbiamo bisogno, come pensava Freud, né anticipato né post rem. Ma di questo accoglimento, di questa capacità di immedesimazione in cui noi, feriti, diventeremmo madre di creature ferite. È un passo difficile - al limite, impossibile: troppo tardi. Eppure esso ci viene da ogni parte e sempre più spesso «sollecitato». E in questo compito potrebbe trovarsi una gracile felicità: non un’«ascesa», un apice o culmine come si pensa di solito, ma piuttosto, come ci dice la Decima elegia, una «caduta», simile alla «pioggia che cade su terra scura a primavera».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
 CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI.
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- SANTA TERESA AD ALTA DEFINIZIONE: "TERESA, MON AMOUR". Un libro di Julia Kristeva su Santa Teresa d’Avila (di Nadia Fusini).30 novembre 2018, di Federico La Sala
In principio era l’amore (charitas - non caritas!!!): pensare l’ "edipo completo"(Freud) *
Un libro su Santa Teresa d’Avila, una serenata in forma di fiction
Lacan e Kristeva come godono i santi
Un’analisi dedicata alla beata spagnola e alla sua estasi. Come interpretare questa forma sublime di rapimento? Perché il sesso non spiega tutto
di NADIA FUSINI (la Repubblica, 27.01.2009) *
Teresa, mon amour è non solo il titolo dell’ultimo libro di Julia Kristeva (tradotto da Alessia Piovanello per Donzelli Editore, pagg.628, euro 35,00); è il ritornello che l’attraversa, quasi il libro tutto fosse una canzone, una lunghissima serenata che l’autrice dedica alla santa spagnola, alla sua estasi. In copertina, of course, la Transverberazione di Santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini. Subito comprendiamo che lacaniano sarà il corteggiamento, debitore al medesimo fremito barocco che scioglie perfino il marmo della famosa scultura.
 E non a caso Jacques Lacan sceglieva lo stesso gruppo marmoreo a copertina del suo seminario Encore dell’anno accademico 1972-73. Dove nel capitolo sesto a chi volesse intendere l’amore divino e il godimento mistico si raccomandava di andare a Roma a contemplare la statua del Bernini. Guardatela e vedrete, affermava Lacan, vedrete che lei gode! Non c’è dubbio. E di che cosa gode? Di che cosa godono i mistici, le mistiche? Fino al secolo scorso, fino a Charcot, fino a Freud si sarebbe detto che era una faccenda puramente sessuale, energia libidica repressa, e così via.
E non a caso Jacques Lacan sceglieva lo stesso gruppo marmoreo a copertina del suo seminario Encore dell’anno accademico 1972-73. Dove nel capitolo sesto a chi volesse intendere l’amore divino e il godimento mistico si raccomandava di andare a Roma a contemplare la statua del Bernini. Guardatela e vedrete, affermava Lacan, vedrete che lei gode! Non c’è dubbio. E di che cosa gode? Di che cosa godono i mistici, le mistiche? Fino al secolo scorso, fino a Charcot, fino a Freud si sarebbe detto che era una faccenda puramente sessuale, energia libidica repressa, e così via.No, dice Lacan, non è una questione di fottere, o meno. C’è di più. In quell’attacco c’è un vero e proprio passaggio all’ ex-sistenza, un passaggio in quell’"ex", in quel "fuori" che fa da prefisso alla parola ex-stasi.
In mille variazioni Julia Kristeva riprende il motivo lacaniano, intrecciando il delirio mistico alla dimensione immaginativa e alla scrittura, e in quest’ultima versione, in quanto scrittrice, fa "sua" la santa. Letteralmente se ne appropria. Si identifica. Una volta adottata questa chiave - la vera estasi è la scrittura - non ci vuole molto a stabilire una stretta affinità tra la santa e la scrittrice. Tanto più che Teresa, oltre che santa e scrittrice e fondatrice, fu interprete e analista dell’anima.
A dare più brio alla serenata, l’inno a Teresa viene affidato a un alter ego, tale Sylvia Leclercq, psicoterapeuta, ossessionata, invasata dalla santa, intorno alla quale monta la sua fiction; fiction postmoderna, più che letteratura vera e propria, perché solo nel registro di una bulimica assimilazione, che procede per scorci temporali e incroci spaziali, pare a Sylvia di riuscire ad afferrare la vita della santa. Se Sylvia legge con passione le opere di Teresa, è per comprendere se stessa, le donne di oggi che incontra in terapia. E si esalta a certe affinità che intravvede. E’ meno sensibile alle differenze.
Il termine fiction piace alla dotta dottoressa di Linguistica e Semiotica Julia Kristeva, che in questa sua opera si sforza al massimo di rendere contemporaneo il suo soggetto anche grazie a una scrittura che si vuole veloce, gergale. E si concede vezzi modaioli che per via di slang ci presentano Teresa come "un big-bang fatto donna" (p.588); mentre per descrivere la sua religiosa confidenza con Dio si ricorre all’ espressione: "fare una Tac al mistero del Signore (p.274). Abbondano allusioni all’idea della rete. Internet, default sono termini che tornano. E i corsi di Derrida e di Kristeva alla Columbia University vengono citati come occasioni uniche per i pochi privilegiati che li frequentarono per penetrare, o meglio decostruire i misteri della rete che per l’appunto connetterebbe i mistici e i kamikaze.
 La nebulosa mistica si espande così in nebbia religiosa, e si aprono a ventaglio nel libro scottanti temi di attualità, tra cui sovrani i problemi del fanatismo e della fede: con Teresa sempre al centro, al crocevia di pensieri e concezioni di sé e del mondo che cambiano, che la vedono accanto a Montaigne, a Spinoza, a Cervantes. Teresa esponente sublime del Siglo de Oro. E ragazza d’oggi, runaway girl. Come Louise Bourgeois. Come Julia Kristeva. Tutte donne capaci di darsi un altro padre, un’altra patria. E di farsi un nome!
La nebulosa mistica si espande così in nebbia religiosa, e si aprono a ventaglio nel libro scottanti temi di attualità, tra cui sovrani i problemi del fanatismo e della fede: con Teresa sempre al centro, al crocevia di pensieri e concezioni di sé e del mondo che cambiano, che la vedono accanto a Montaigne, a Spinoza, a Cervantes. Teresa esponente sublime del Siglo de Oro. E ragazza d’oggi, runaway girl. Come Louise Bourgeois. Come Julia Kristeva. Tutte donne capaci di darsi un altro padre, un’altra patria. E di farsi un nome!In questo senso, Teresa mon amour è una "installazione" (p.577). E forse proprio tale termine meglio descrive questo strano libro troppo lungo, interessante quando si presenta come "una avventura nel cuore del credere" (p.565). Meno, quando riduce quell’avventura a una spiegazione della vita umana tutta - sia barocca sia contemporanea sia mistica sia mondana - in chiave di parafrasi attualizzante tradotta in termini psicoanalitici della vita medesima. A proposito della scrittura teresiana Kristeva parla di "una scrittura fuori genere, perché li mescola tutti" (p.311). Così fa lei qui; trasportata non dall’estasi, ma da una specie di hybris intellettuale che di certo non le manca, si fa una e trina: autrice, narratrice, protagonista del racconto, che è insieme una biografia, una autobiografia, un saggio, una fiction; alla fine, un monumento alla diva Julia.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Ana De Mendoza, Principessa di Eboli: Santa Teresa in alta definizione
In principio era l’amore (charitas - non caritas!!!): pensare l’ "edipo completo"(Freud)
 INTERVISTA A JULIA KRISTEVA. Anche chi non crede in Dio, crede nell’amore e ciò mi pare oggi il più grande elemento di persistenza della nostra civiltà cristiana. Ma, detto questo, la studiosa ri-cade nelle braccia dell’autorità paterna (della versione cattolico-romana del cristianesimo ... ancora edipica)
INTERVISTA A JULIA KRISTEVA. Anche chi non crede in Dio, crede nell’amore e ciò mi pare oggi il più grande elemento di persistenza della nostra civiltà cristiana. Ma, detto questo, la studiosa ri-cade nelle braccia dell’autorità paterna (della versione cattolico-romana del cristianesimo ... ancora edipica)Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE. La storia della Luna e del Sole (di Paola Zanca)25 novembre 2018, di Federico La Sala
EDUCARE AL GENERE UMANO. La "storia" della Luna e del Sole...
- "DUE SOLI" IN TERRA, E UN SOLO SOLE IN CIELO: "TRE SOLI". GENERE UMANO: I SOGGETTI SONO DUE, E TUTTO E’ DA RIPENSARE!!! NON SOLO SUL PIANO TEOLOGICO-POLITICO, MA ANCHE ... ANTROPOLOGICO!!!
Maschi/femmine. La parità (non) si insegna a scuola
di Paola Zanca (Il Fatto, 25.11.2018)
La storia della Luna e del Sole è in un sussidiario di quarta elementare. Un mito della tradizione orale africana che diversi editori hanno inserito nei libri di testo della scuola pubblica italiana. Il racconto spiega come mai la Luna e il Sole, marito e moglie, non stiano mai insieme in cielo: hanno litigato perché lei non gli ha fatto trovare la cena pronta. Una “infame pigraccia” che si è perfino permessa di mangiare la polenta che il marito si era poi cucinato da sé. Il lieto fine: il Sole lancia il tagliere con la cena bollente in faccia alla Luna che “dolorante e vergognosa corse a nascondersi”.
La “dimensione di genere”,spiega bene Cristina Gamberi in Educare al genere (Carocci), influisce sulle nostre vite “da quando nasciamo fino alla terza età, e specie nell’adolescenza, quando si gettano le basi del divenire uomini e donne”.
Secondo il rapporto Eurydice, tutti i Paesi europei hanno messo in atto politiche di educazione di genere in ambito didattico: tutti tranne Estonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. E Italia. “Nella società italiana - notano le associazioni delle Donne in Rete contro la violenza - gli stereotipi e pregiudizi di genere, i ruoli tradizionali assegnati a uomo e donna, sono riprodotti sin dai primi testi scolastici”.
E se “l’educazione è sessista”, per parafrasare il titolo della ricerca di Irene Biemmi sugli stereotipi di genere nei libri delle elementari, c’è poco da stupirsi se, per la metà degli intervistati da Ipsos per conto del dipartimento Pari Opportunità, le donne non dovrebbero lavorare a tempo pieno se hanno figli piccoli, sono le principali responsabili della cura della famiglia e si sono avvalse del proprio aspetto fisico per la loro realizzazione professionale.
È l’humus in cui nasce e prolifera la mentalità che è alla base della violenza. Ecco perché - spiega Biemmi, ricercatrice all’università di Firenze - è “scorretto associare l’educazione di genere alle misure di contrasto alla violenza” perché, piuttosto, l’educazione è lo strumento attraverso cui “costruire dinamiche relazionali sane e paritetiche tra maschi e femmine”. Quelle, quindi, in cui la violenza - né esercitata né subìta - ha diritto di cittadinanza.
Uscire dalla “logica emergenziale” è il passo fondamentale. E solo dalla scuola si può provare a farlo: con la formazione obbligatoria degli insegnanti e con un intervento sui libri di testo che escano dai “binari rosa/azzurro” - spiega Biemmi -. “La femmina buona e mansueta, il maschio brillante anche se vivace”.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PER L’ITALIA, "DUE SOLI". Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni"...
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva di Federico La Sala Studio europeo nelle scuole, ma il Ministro "censura" la domanda sui metodi contraccettivi (la Repubblica/Salute, 14.02.2008, p. 19).
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- POMPEI. L’eros senza maschio di Leda e il cigno (di Silvia Ronchey).21 novembre 2018, di Federico La Sala
AL DI LA’ DEL PARTO MASCHIO (O FEMMINA) DEL TEMPO. La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica... *
- L’EROS SENZA "FEMMINA" DI SOCRATE: "Si narra che Socrate abbia sognato di avere sulle ginocchia un piccolo cigno che subito mise le ali e volò via e dolcemente cantò e che il giorno dopo, presentatosi a lui Platone come alunno, abbia detto ch e il piccolo uccello era appunto lui" (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III 5, cfr.: Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma, 1991, pp.182-183)
- Leda e il cigno, Pompei a luci rosse
- ESCLUSIVA ANSA/ Osanna, "Ritrovamento eccezionale e unico"
Mitologia
L’eros senza maschio di Leda e il cigno
Il dipinto ripropone il simbolo della donna che dall’antichità ai grandi artisti del Rinascimento afferma la propria indipendenza
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 20.11.2018)
Ed ecco che a Pompei la sempre imponderabile cabala dei crolli e dei controlli fa riemergere una variante ancora più antica, pittorica, di un episodio amoroso da sempre simbolo, nella storia della pittura e della letteratura, dell’autoerotismo femminile: del piacere che la donna può darsi senza la cooperazione del maschio, anzi, di alcun umano. Nella scultura adrianea, copia di un originale ellenistico, il corpo di Leda, completamente nudo, è contratto nell’amplesso, la mano celata nel grembo premuto alle piume, stretto fra le unghie di un onirico cigno dotato di doppio fallo, dove quello proteso nel lungo collo, cui le labbra si accostano in un’appena dissimulata fellatio, prevale sull’altro che si insinua fra le cosce tremanti - per citare i versi di Yeats - della ragazza che è in piedi e barcolla. Nell’altrettanto esplicito erotismo dell’affresco pompeiano, Leda, i drappeggi dell’abito appena scostati, ancora cinta di diadema e calzari, è abbandonata su una sedia ed è al seno scoperto che si protende il becco del bianco fantasma erotico avvinghiato alle sue cosce.
Nelle grandi Lede della storia dell’arte successiva c’è sempre qualcosa di ineffabile dipinto sul viso della donna da cui non a caso nascerà Elena, e con lei la guerra di Troia, e dunque Roma, con la fuga di Enea. Perfino il sorriso leonardesco del dipinto della Galleria Borghese è solo uno dei tanti misteriosi, allusivi, indecifrabili sorrisi che Leda, moltiplicata nel suo sogno in infinite immagini pittoriche, regala prima, durante o spesso dopo l’amplesso all’empatia dei pittori.
Del resto, della meno censurata tra le Lede dei grandi maestri, quella di Michelangelo, non sopravvive l’esecuzione finale, smarrita o censurata in un giro di corti che dalla committenza estense si arenerà in quella di Francia, ma la copia di Rosso Fiorentino della National Gallery dà un’idea di quanto meno pudica della Leda post coitum di Leonardo fosse l’idea che Michelangelo aveva di quell’amplesso.
Il cigno non è una bestia. È la figurazione simbolica dei desideri repressi e insieme delle paure erotiche femminili. Tutta l’imponderabilità e irrefrenabilità dell’erezione maschile è richiusa e dischiusa in quelle grandi ali frementi, che nell’iconografia assumono, come sempre le immagini dei sogni, proporzioni vertiginosamente variabili, ora ridotte alla sensualità del passer della Lesbia di Catullo, ora talmente gigantesche da far intravedere nel corpo a corpo erotico delle Lede avviluppate nelle loro piume qualcosa di simile alla lotta di Giacobbe con l’angelo. In effetti, se a qualcosa la loro tradizione iconografica può essere accostata, è quella di una vertigine del volo - pensiamo allo slancio di Icaro - che il mondo greco, attingendo alla tradizione orientale, consegnerà all’angelologia cristiana e islamica.
Che siano di chimera, di fenice o di cigno, che richiamino Eros o Ermes dal piede alato, e con lui la natura stessa del sogno, le ali, tipico oggetto di fobia sessuale femminile, sono un altro potente simbolo di hybris fallica. Creato dalla fantasia, dalla forza del sogno, dall’urgenza del simbolo, il cigno di Leda è quanto di più lontano da una concreta presenza animale.
Nulla a che fare con gli accoppiamenti bestiali della mitologia greca, come quello di Pasifae col nero, potente toro dall’immenso membro, che non a caso farà sorgere alle fondamenta dell’edificio psicologico greco una creatura - il Minotauro - che simboleggia nella mitologia l’assoluto irrazionale, la parte bestiale che è in noi, tanto avida quanto sapiente, tenuta a guardia del grande labirinto dell’inconscio.
Ma neanche quel figlio, per i greci, è il male, anzi. Sarà la sua uccisione da parte dell’infido eroe Teseo a produrre la combinazione di eventi che porterà a un’ancora più potente compensazione simbolica: a consegnare Arianna, sorella del Minotauro e suo esatto contrario, sacerdotessa della razionalità della dea Atena, a farsi sposa, abbandonata a Nasso, di Dioniso, il dio della natura scatenata e dell’ebbrezza.
Il prodotto dell’accoppiamento di Leda non sarà meno inquietante. Elena incarnerà la femminilità più potente di tutto il mito greco, quella cui non si resiste, capace di addormentare con il suo nepente il cuore degli uomini, di scatenare le loro guerre, di disseminare, con la sua forza di donna creata dal puro piacere di una donna, il massimo disorientamento nel mondo dei maschi. Elena dalle bianche braccia, candida e onirica come "il bianco tumulto" che la fa nascere, sarà la femme fatale per eccellenza, la splendida strega capace di scardinare ognuno degli aspetti dell’egemonia maschile.
Il mito di Leda è dunque il mito d’origine dell’autonomia femminile, del suo desiderio sessuale emancipato dal maschio, delle sue non solo erotiche ma anche concrete paure - poiché certo essere ingravidate da un sogno è da sempre nelle donne uno dei più irrazionali e archetipi timori, non a caso esorcizzato nelle storie di maghe e di streghe. È forse questo solo, nel mito di Leda, l’intervento di Zeus.
 Per una volta assolviamolo dalla sua fama di stupratore. Quello di Leda è il contrario di uno stupro. E la vasta fortuna della sua iconografia è uno dei tanti segni nascosti, sotterranei, carsici che la psiche femminile ha lasciato, indecifrati dai molti, còlti dagli artisti e dai poeti, serbati e sussurrati nel segreto delle corti, della sua indipendenza e della sua libertà.
Per una volta assolviamolo dalla sua fama di stupratore. Quello di Leda è il contrario di uno stupro. E la vasta fortuna della sua iconografia è uno dei tanti segni nascosti, sotterranei, carsici che la psiche femminile ha lasciato, indecifrati dai molti, còlti dagli artisti e dai poeti, serbati e sussurrati nel segreto delle corti, della sua indipendenza e della sua libertà.
*
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
"PARTORIRE CON LA TESTA. Alle origini della maieutica" (Dorella Cianci, Marsilio, Venezia, 2018).
SOCRATE, "LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- NONUNA DI MENO. Se il capitale diventa una seconda natura (di Lea Melandri).17 novembre 2018, di Federico La Sala
Se il capitale diventa una seconda natura
Non Una Di Meno. Si è aperta una breccia nell’economicismo della vulgata marxista, che ha resistito al movimento delle donne e alla progressiva femminilizzazione del lavoro. La garanzia di poter contare su un tempo liberato dall’aziendalismo potrà venire da quello che oggi Non Una di Meno ha definito un «reddito di auto-determinazione»
di Lea Melandri (il manifesto, 16.11.2018)
Una volta che si riconosce che l’economia si è imposta in tutte le sfere dell’agire e del pensiero umano, che cosa significa parlare di forza lavoro come «facoltà che appartiene agli individui», espressione di libertà e autodeterminazione di uomini e donne, che lavorino o non lavorino? «La forza lavoro - scrive Roberto Ciccarelli nel suo Capitale Disumano (manifestolibri, 2018) - diventa una merce a seguito della sua vendita. Ma - prosegue - resta comunque una facoltà del suo possessore». E aggiunge che, in quanto tale, «è universale e comune». Difficile non vedere l’analogia con la definizione marxiana della «passione dell’uomo», intesa come il bisogno di una «totalità di manifestazione di vita umana» di ogni vivente.
VIENE immediata l’osservazione che, finché resta una potenza indipendente dalle offerte di mercato che risuona nel fondo di ogni vita come semplice diritto all’esistenza la forza lavoro così distinta dalla sua oggettivazione in merce, assomiglia allo stato di natura di Rousseau, e al concetto di inesistenza delle donne, da cui è partito il femminismo degli anni Settanta: in entrambi questi casi, si era evidentemente ritenuto necessario restituire all’individuo la consapevolezza che, dietro le imposizioni e i modelli, a cui ha dovuto assoggettarsi, non si era mai eclissata la possibilità di esercitare le diverse funzioni del corpo, della ragione, dell’immaginazione.
VERREBBE da dire che finalmente, anche nell’analisi del lavoro, si è aperta una breccia nell’ombra lunga dell’economicismo che ha segnato la vulgata marxista, resistendo all’urto della rivoluzione culturale e politica del movimento delle donne e, in tempi più recenti, alla progressiva femminilizzazione del lavoro. Forse non è un caso che lo scarto, rispetto a una critica dell’economia catturata dal suo stesso oggetto, avvenga in un momento in cui è saltata la divisione tra il lavoro produttivo e tutta la somma di vita che, riduttivamente, impropriamente, è stata così a lungo collocata sotto la voce «riproduzione», nel senso che Marx stesso gli ha dato, e cioè come riproduzione della forza lavoro in quanto merce. Assenti le donne e la materialità di esperienze corporee e intellettuali ritenute «naturali» del genere femminile.
LA CADUTA dei confini, che hanno tenuto separate e in guerra tra loro la «potenza dell’amore» e la «coercizione al lavoro» (Freud), non ha segnato solo la femminilizzazione della sfera pubblica - la vita in quanto tale messa a produrre valori economici, sociali, cognitivi, attività di cura malpagate o gratuite, l’economia che diventa oikonomia, economia domestica -, ma un passaggio più inquietante a quel perverso connubio di autoimprenditorialità e autosfruttamento che ha preso corpo, pur nella sua astrazione, nel figura del capitale umano». In corrispondenza con la crisi del lavoro da tempo si moltiplicano gli inviti a diventare imprenditori di noi stessi. Il nuovo imperativo è pensare la vita come se fossimo tutti manager.
L’IO DIVENTA, al medesimo tempo, datore di lavoro e lavoratore di se stesso, viene a ricoprire un doppio ruolo: quello di chi comanda e di chi obbedisce. La libera scelta diventa la manifestazione di una subordinazione.
Con questo ultimo cambiamento nei rapporti che ci sono sempre stati tra sfere tra loro divise e contrapposte, il divoramento avviene su un versante e sull’altro: il capitale ingurgita la forza lavoro separandola dal vivente, ma il vivente, a sua volta, incorpora il capitale e le sue leggi, si fa oggetto e attore della propria alienazione.
SE IL FEMMINISMO degli anni Settanta aveva messo a tema le problematiche del corpo e contrastato l’economicismo dominante nella sinistra extraparlamentare, con l’idea che si dovessero cercare o nessi tra sessualità e politica, sessualità e economia, oggi la naturalizzazione del sistema capitalistico, neoliberista, è avanzata a tal punto da assomigliare alla sorte toccata nel corso di secoli alla donna: l’interiorizzazione, sia pure forzata e inconsapevole, della rappresentazione maschile del mondo, e compresa, per usare le parole di Sibilla Aleramo, «solo per virtù di analisi».
QUANDO i rapporti di potere toccano la vita intima - intreccio, confusione, sovrapposizione-, entrano fatalmente nella vita psichica. È accaduto per le donne, legate a un dominatore che era anche figlio, marito, padre, fratello, amante, piegate per ragioni di sopravvivenza o per amore al sacrificio di sé, alla dedizione all’altro, costrette a considerare malattia, colpa, inadeguatezza propria gli effetti della colonizzazione del loro sesso. Oggi, pur con qualche differenza, può toccare a chi è spinto, fin dagli anni della scuola, a interiorizzare la dialettica servo-padrone, a reinventare la subordinazione, che non trova nella società, come fatto psicologico. Non molto diversa è la richiesta che è fatta alle donne - e che le donne stesse sono tentate di vedere come un riconoscimento e una occasione di far valere la loro «differenza»- di investire le loro «risorse», i loro «talenti» per rivitalizzare un’economia in crisi. Non vittime, ma soggetti che oggettivizzano il loro corpi, come corpi erotici corpi materni.
CONTRO un’emancipazione che vuole oggi uomini e donne attori del loro asservimento, e li ritiene responsabili quando falliscono, non resta che aprire la strada a quella ricerca di autonomia e libertà, su cui si erano incamminati il movimento non autoritario nella scuola e il femminismo. La garanzia di poter contare su un tempo liberato dall’aziendalismo potrà venire da quello che oggi Non Una di Meno ha definito un «reddito di auto-determinazione». Per scostarsi da una illusoria onnipotenza figlia dello sfruttamento capitalistico, ci vorranno comunque modi nuovi e più incisivi dell’agire politico.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - MEMORIA DELLA LIBERTA’: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!8 novembre 2018, di Federico La Sala
LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"! .... *
- NOTERELLE SUL MACHIAVELLI (1932-34): "Il Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume" (A. Gramsci, Quaderni del carcere)
- "IN OGNI MODO OCCORRE STUDIARE KANT E RIVEDERE I SUOI CONCETTI ESATTAMENTE" (A. Gramsci, Quaderni del carcere)
La scoperta della libertà
di Maurizio Viroli Il Fatto, 18 aprile 2017
Per molti della mia generazione la lettura degli scritti di Antonio Gramsci ha avuto l’effetto di una liberazione dal marxismo-leninismo banale e dogmatico che teneva banco, alla fine degli anni Sessanta, fra i movimenti della sinistra extraparlamentare. Non ho prove storiche da offrire, ma credo che molti giovani si siano avvicinati al Pci anche perché quel partito si proclamava erede di Gramsci e si impegnava attivamente a farne conoscere gli scritti.
Nel 1975 esce infatti per Einaudi, sotto l’egida dell’Istituto Gramsci, la prima edizione critica dei Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana. Su quei quattro volumi furono promosse molte iniziative e si aprì un importante dibattito culturale e politico sul concetto di egemonia, sul rapporto fra democrazia e socialismo, sul ruolo e la natura del partito, sulla Rivoluzione d’Ottobre, sugli intellettuali, sulla storia d’Italia, sulla questione meridionale.
A Gramsci va riconosciuto il merito storico di aver avviato nel mondo comunista la consapevolezza che non era possibile in Italia seguire la via della Rivoluzione d’Ottobre. Lo ha fatto con l’unico argomento che poteva essere efficace, vale a dire la considerazione realistica delle condizioni storiche.
Sarebbe sbagliato sostenere che Gramsci aveva capito che la trasformazione socialista della società deve avvenire soltanto nel pieno rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche. Ma una volta dichiarato che la via sovietica non poteva essere percorsa, che il proletariato “può e deve essere dirigente [vale a dire ottenere il consenso degli altri gruppi sociali] già prima di conquistare il potere governativo”, e che deve continuare a essere dirigente anche dopo la conquista del potere, restava aperta, di fatto, soltanto la via democratica.
L’intuizione più felice di Gramsci è, a mio giudizio, l’idea della “riforma intellettuale e morale”. In un passo delle Noterelle sul Machiavelli, la descrive come “elevamento civile degli strati depressi della società”, simile, per la sua capacità di coinvolgere ampi strati delle classi subalterne, alla Riforma protestante e all’Illuminismo, ma capace di conservare e rielaborare “i caratteri di classicità della cultura greca e del Rinascimento italiano”.
E giustamente sottolinea che la riforma intellettuale e morale “non può non essere legata a un programma di riforma economica, anzi, il programma di riforma economica è appunto il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e morale”.
“Banditore” della riforma intellettuale morale doveva essere per Gramsci, il “moderno Principe”, il partito comunista, che diventa, nella sua visione, non più un’avanguardia volta esclusivamente al lavoro di agitazione e organizzazione in vista della conquista del potere politico, ma un partito educatore e formatore di coscienze, una vera e propria scuola dove gli elementi migliori delle classi subalterne imparano a dirigere il complesso della vita sociale alla luce di ideali di emancipazione.
Il limite dell’idea gramsciana della riforma intellettuale e morale non risiede nella sua concezione del partito politico come educatore e formatore di coscienze, ma nella sua convinzione che il partito della classe operaia debba essere il punto di riferimento del giudizio morale e politico: “Il moderno Principe sviluppandosi sconvolge tutto il sistema dei rapporti intellettuali e morali in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni atto viene concepito come utile o dannoso, come virtuoso e scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno principe stesso e serve a incrementare il suo potere o a contrastarlo”.
Il Principe , conclude Gramsci, “prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico” (Quaderni del carcere, vol. III, p. 1561). Ma la coscienza personale è e deve rimanere rigorosamente individuale: può accogliere l’imperativo morale o la divinità, ma mai lasciare entrare come sua guida suprema un soggetto collettivo, non importa se è lo Stato, o il partito o una chiesa. Se la coscienza personale accetta la guida o l’autorità di un soggetto collettivo non è più pienamente libera e non può costruire né uno Stato né una società liberi.
In quegli stessi anni, nel confino di Lipari, Carlo Rosselli scriveva su Socialismo liberale: “Non esistono fini della società che non siano, al tempo stesso, fini dell’individuo, in quanto personalità morale; anzi questi fini non hanno vita se non quando siano profondamente vissuti nell’intimo delle coscienze. [...] Uno Stato libero vuole prima e soprattutto uomini liberi. E uno Stato socialista spiriti socialisti. Io non esito a dichiarare che la rivoluzione socialista sarà tale, in ultima analisi, solo in quanto la trasformazione della organizzazione sociale si accompagnerà a una rivoluzione morale, cioè alla conquista, perpetuamente rinnovantesi, di una umanità qualitativamente migliore, più buona, più giusta, più spirituale”. Carlo Rosselli partiva da Giuseppe Mazzini; Gramsci da Karl Marx e da Lenin.
Per arrivare all’idea del socialismo come trasformazione sociale sorretta da una riforma intellettuale e morale capace di realizzare l’elevamento civile delle classi subalterne, aveva percorso una lunga strada grazie alla libertà morale e intellettuale che gli diede la forza di andare contro le idee prevalenti nel suo stesso partito, senza paura di affrontare, anche nelle terribili condizioni del carcere, l’ostilità degli stessi compagni comunisti che lo giudicavano un traditore della causa. La sua è una testimonianza di libertà, per tutti i tempi.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
- UNA LEZIONE TEOLOGICO-POLITICA DI BAGET BOZZO SU OGNI PROGETTO DI "RIFONDAZIONE COMUNISTA" FUTURA CHE SI VUOLE COME PARTITO. Avanti o popolo alla riscossa. Il populismo trionferà
ANTONIO GRAMSCI, SULLA "ZATTERA DELLA MEDUSA". Una lettera dal carcere
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- FILOSOFIA DEL DIALOGO. E già nel 1942 Guido Calogero smontava Heidegger (di A. Berardinelli).5 novembre 2018, di Federico La Sala
E già nel 1942 Guido Calogero smontava Heidegger
di Alfonso Berardinelli (Avvenire, venerdì 12 gennaio 2018)
Buone notizie, secondo me, dal numero di “MicroMega” intitolato “Gli intellettuali giudicano la religione”. La sezione su tale tema richiederebbe un resoconto critico per il quale non basterebbero una ventina di pagine. Vi è riportato un questionario del 1950 che l’americana “Partisan review” propose a scrittori, filosofi, critici e studiosi. “MicroMega” pubblica le risposte del grande poeta e saggista Auden (credente) e del filosofo analitico Ayer (non credente): due punti di vista opposti sui quali si potrebbe ragionare a lungo.
Ma quella che in particolare ho considerato subito la buona, ottima notizia è un’altra. È un saggio di Guido Calogero (1904-1986), studioso di storia della logica e della dialettica dai Presocratici al Novecento, filosofo del dialogo come strumento insuperabile del pensiero, teorico e animatore con Aldo Capitini del movimento liberal-socialista e tra i fondatori del Partito d’Azione.
In questo scritto del 1942, Calogero offriva una tempestiva, precoce analisi critica del pensiero e del linguaggio di Martin Heidegger, filosofo vicino al nazismo (mai esplicitamente rinnegato) che ha esercitato un’influenza magnetica su filosofi francesi e italiani di fine Novecento tuttora in attività. Benché Heidegger sia stato notoriamente discusso, criticato, demolito già da Adorno, Löwith e Anders, i nostri heideggeriani, per evitarsi dei fastidi, non hanno mai voluto prendere in considerazione i loro argomenti. Calogero (filosofo a sua volta oggi ciecamente trascurato) in questo scritto di settant’anni fa notava subito il punto debole della filosofia di Heidegger: la sovrapposizione, l’identificazione impropria e arbitraria fra il problema della conoscenza (gnoseologia) e il problema dell’essere (ontologia). Heidegger usa un linguaggio metafisico lì dove dovrebbe usare un linguaggio logico e metodologico.
Dire “essere” e dire “ente”, ripetere queste parole come una giaculatoria o un mantra, non significa dire qualcosa della cui realtà si possa dare conoscenza e discorso, poiché si tratta di una terminologia arcaica ormai priva di contenuto determinato e determinabile, un “modo di dire” generico e vuoto la cui pensabilità è nulla. Provate a pensare l’essere e vedrete che equivale a pensare il nulla, cosa altrettanto impensabile. Il linguaggio di Heidegger è una disonesta parodia verbalistica dell’esperienza mistica. Teologizza la filosofia, evitando il problema della religione.
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
PAURA DELLA LIBERTA’... FASCISMO, STORIOGRAFIA, E COSTITUZIONE: "Vi fu chi accondiscese al giuramento, tra questi Guido Calogero e Luigi Einaudi, seguendo l’invito di Benedetto Croce, «per continuare il filo dell’insegnamento secondo l’idea di libertà»".
- POLITICA E LINGUAGGIO. IL SENZA-NOME: LE FIGURE DI NESSUNO. Roberto Esposito riavvia il discorso sulla "Terza Persona" ... e apre la strada a una comprensione antropologica inedita della Prima (e Quarta) "Persona" del "Tetragramma" divino e dello stesso "Logos"
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
I POLITICI SI SONO FATTI TEOLOGI E LA TEOLOGIA, IN SENSO PROPRIO, NON PARLA PIU’. Una riflessione di Paolo Prodi.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "Non c’è fede che tenga". Essere laici significa, per Cinzia Sciuto, “non invocare nessuna tradizione per giustificare una limitazione, se non addirittura una violazione, dell’autonomia e della libertà di ciascun essere umano” (di Marco Aime).31 ottobre 2018, di Federico La Sala
Non c’è fede che tenga
Manifesto contro il multiculturalismo
di Marco Aime (Doppiozero, 31.10.2018) *
Un libro coraggioso quello di Cinzia Sciuto, tagliente e spigoloso, che non fa sconti e mette il dito nella piaga di un atteggiamento sempre più diffuso, l’elogio del multiculturalismo, che però nasconde un dono avvelenato, che lo porta ad assomigliare a una forma di razzismo capovolto, seppure animato da lodevoli intenzioni. La critica dell’autrice parte dalla necessità di esercitare sempre e in modo coerente una determinata laicità, che conduca a prestare sempre più attenzione ai diritti degli individui, piuttosto che a quelli dei gruppi, di qualunque specie essi siano: etnici, religiosi, politici, ecc. Laicità come fondamento della democrazia, laicità che non si oppone alla/le religione/i, ma che rifiuti ogni principio di autorità e di ingerenza e non solo quelli religiosi. Essere laici significa, per Sciuto, “non invocare nessuna tradizione per giustificare una limitazione, se non addirittura una violazione, dell’autonomia e della libertà di ciascun essere umano”.
Nei paesi come la Gran Bretagna, dove da decenni si segue la linea del multiculturalismo, sono venute a formarsi comunità etniche o religiose che vivono una accanto all’altra, ciascuna secondo dei dettami della sua tradizione. Questo ha fatto sì che, per esempio, siano nate scuole confessionali, dove si insegna la tradizione islamica o induista e solo quelle. Questo, ci avverte l’autrice, porta a chiusure reciproche e non alla costruzione di una reale società, capace di contenere delle differenze. Ogni tradizione poi, e qui a volte Sciuto sembra essere un po’ eccessiva, finisce per limitare le possibilità di scelta del singolo individuo, pena l’esclusione o la marginalizzazione della società. Se poi lo Stato agisce nei confronti delle comunità culturali in quanto tali, finisce che l’attenzione si sposta dalle persone al gruppo, per cui un individuo diventa degno di protezione o di qualche altra azione solo in quanto appartenente a tale gruppo.
Ampio spazio è dedicato alla questione del velo a proposito della quale Sciuto è molto critica anche sulla possibile libera scelta per una donna di indossarlo, in quanto ogni scelta è condizionata da una tradizione culturale e da un senso di appartenenza. In parte è vero, ma è vero che anche la laicità, che condivido pienamente, è il prodotto di una tradizione culturale, la nostra. L’autrice però, giustamente, afferma che se “loro” vivono qui, non sono più “loro” ma parte di “noi”. Forse il paragone tra il velo e le mutilazioni genitali femminili appare un po’ eccessivo, ma pone il giusto problema del limite di accettazione che ogni comunità può sopportare e soprattutto di chi stabilisce questo limite.
Ovviamente questo discorso implica anche una riflessione sul concetto di identità, che pervade gran parte del dibattito politico-culturale attuale e su come tale identità venga sempre più spesso rappresentata in modo essenzialista e fissista, per poi essere strumentalizzata politicamente. Riprendendo una distinzione proposta da Seyla Benhabib tra ethnos e demos si sottolinea come debba essere il secondo a prevalere, cioè una comunità a cui si sceglie di appartenere e non a cui si “deve” appartenere secondo una logica di discendenza o in nome di una tradizione. La critica non risparmia neppure una certa sinistra, che sempre più spesso si è dedicata al riconoscimento dei diritti di gruppi particolari, dimenticando la sua vocazione universalista.
Tutto il percorso di Cinzia Sciuto è teso al raggiungimento si una società laica, che riconosca i diritti agli individui per ciò che sono e non perché appartenenti a una comunità di qualche tipo. Un percorso che serva a elaborare urgentemente “una prospettiva solidale, laica, libertaria e universalista: perché i diritti, se non sono universali, si chiamano privilegi”.
*
C. Sciuto, Non c’è fede che tenga. Manifesto contro il multiculturalismo, Feltrinelli, 2018.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "Nonostante Platone": "Platone", il pensiero politico nei saggi di Adriana Cavarero (di Donatella Di Cesare).29 ottobre 2018, di Federico La Sala
Platone, il pensiero politico nei saggi di Adriana Cavarero
La raccolta pubblicata da Raffaello Cortina si concentra sui dialoghi del pensatore che affrontano il delicato rapporto tra filosofia e polis
di DONATELLA DI CESARE (Corriere della Sera, 29 ottobre 2018)
Nel femminismo italiano non c’è forse libro che ha fatto epoca come Nonostante Platone di Adriana Cavarero. Uscito nel 1990 per Editori Riuniti (quindi pubblicato in inglese dalla prestigiosa Polity Press nel 1995), richiamava l’attenzione sulla parte dimenticata della filosofia, quella femminile, che veniva rivendicata con intelligenza, finezza e decisione già a partire dagli esordi greci. Tra le figure considerate spicca quella di Diotima di Mantinea, la «straniera», a cui nel celebre dialogo Simposio viene attribuita la parte di protagonista. Il che non sorprende: dalla passione per la sapienza alla maieutica, l’arte della levatrice, il femminile permea la filosofia. E in fondo Socrate lo riconosce.
- Adriana Cavarero, «Platone» (Raffaello Cortina, pagine 199, euro 19)
Il capitolo su Diotima di quel fortunato volume viene ora riproposto in una raccolta pubblicata in questi giorni da Raffaello Cortina e intitolata semplicemente Platone (pagine 199, e 19). Si tratta di saggi che coprono un arco di tempo di quarantacinque anni e vanno dal primo testo giovanile Platone e la democrazia, del 1973, all’ultimo che è il testo di una conferenza tenuta a Brighton nel 2017 Per un’archeologia della post-verità. È insomma il libro non scritto di Cavarero su Platone che vede finalmente la luce grazie a Olivia Guaraldo che ha curato la raccolta consentendo così di risalire quasi il percorso filosofico di una delle voci più interessanti della filosofia italiana. Platone nel pro e nel contro. Impossibile articolare il pensiero della differenza sessuale se non partendo dai dialoghi, quei testi classici che nessun filosofo e nessuna filosofa dovrebbero mai aggirare. Si può dire che Platone sia il punto di riferimento costante per Adriana Cavarero che va esemplarmente acquisendo originalità di riflessione in un confronto serrato con il «padre» della filosofia.
Nella raccolta emerge soprattutto la dimensione politica del suo pensiero. Preziosa interlocutrice diventa allora Hannah Arendt che, com’è noto, a sua volta è tornata sempre alle fonti greche. La questione sollevata in alcuni saggi è quella incandescente del rapporto tra filosofia e politica, in particolare nei termini in cui Platone lo delinea nella Repubblica. Quale ruolo spetta nella polis alla filosofia, dopo le innumerevoli sconfitte, la condanna a morte di Socrate, ma anche la tragica avventura di Platone a Siracusa? Se, malgrado tutto, l’una ha bisogno dell’altra, in che modo è possibile recuperare il rapporto tra lo sguardo teoretico dei filosofi e l’agire politico? La pista aperta da Arendt non porta Cavarero verso l’utopia, bensì verso la possibilità di una plurale condivisione della teoria. Se non si può fuggire dalla politica, come ha fatto Platone - è l’accusa di Arendt - non si può neppure fare a meno di quel peculiare «vedere» filosofico.
Si intuisce perché l’interesse di Cavarero, come mostra anche l’ultimo saggio della raccolta, quello sulla post-verità, si concentri sul tema attualissimo della democrazia, sul suo significato, sul suo valore. Impossibile non riprendere da Platone e dalla sua critica a quel regime politico che causa corruzione, manipola l’opinione, provoca demagogia.
Ecco la lezione della filosofia: non dare nulla per scontato. Forse la prossima tappa di Cavarero sarà allora un saggio su questo tema dove ormai all’interno della filosofia si fa sempre più chiaro lo iato tra chi auspica una democratizzazione della democrazia (questa sembra anche la via verso cui s’incammina la filosofa) e chi invece si dispone a una critica più radicale.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- La scelta di un papa inquieto: «L’aborto è come affittare un sicario» (di Gian Enrico Rusconi).11 ottobre 2018, di Federico La Sala
La scelta di un papa inquieto
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 11.10.2018)
«L’aborto è come affittare un sicario». E’ un’immagine pesante, non facilmente comprensibile e vagamente diffamatoria quella usata dal Papa. Ma l’aborto viene da lui senz’altro omologato al «disprezzo della vita» quale si esprime nel lungo elenco delle guerre, degli sfruttamenti di ogni genere, di tutti gli abusi per opportunismo. Si tratta di parole gravi che contano, pronunciate da un maestro della comunicazione diretta e coinvolgente come Papa Francesco.
Eppure sulla base della sua esperienza pastorale, il Pontefice dovrebbe sapere che l’aborto non è semplicisticamente riducibile a «un problema per risolvere il quale si fa fuori una vita umana». E’ un’esperienza angosciosa intima .
Soprattutto Bergoglio ignora che «il problema» o «il diritto» all’’interruzione della gravidanza è riconosciuto dalla legge secondo determinate e ben precise condizioni. Essa riguarda «una gravidanza che comporti un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o alla previsione di anomalie o malformazioni del concepito. L’accesso all’intervento abortivo è dalla legge garantito in quelle circostanze, cosicché parlare di libertà di aborto è una forzatura che la legge non consente». Così ha scritto qualche giorno fa su questo giornale Vladimiro Zagrebelsky, augurandosi che non si ritorni a contrapposizioni irragionevoli, aggressive e diffamatorie.
Invece ci risiamo, e proprio per bocca del Papa. Adesso ci manca solo l’intervento di Matteo Salvini.
 E’ triste dover fare questa battuta. Ma ferme restando le ragioni di principio dell’opposizione del Pontefice e del mondo cattolico all’interruzione della gravidanza, è innegabile che essa risenta del mutamento del clima politico e culturale del Paese. E che ci sia la tentazione di approfittarne per riaprire una questione che sembrava risolta nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche.
E’ triste dover fare questa battuta. Ma ferme restando le ragioni di principio dell’opposizione del Pontefice e del mondo cattolico all’interruzione della gravidanza, è innegabile che essa risenta del mutamento del clima politico e culturale del Paese. E che ci sia la tentazione di approfittarne per riaprire una questione che sembrava risolta nel rispetto reciproco delle convinzioni etiche.Questa tentazione è un segnale importante dell’ avanzare di una democrazia illiberale nel nostro Paese. Si fanno prepotenti i segnali di insofferenza della classe politica al governo per ridurre o condizionare gli spazi di libertà di espressione della stampa. In maniera più pasticciata e subdola vengono alterati i diritti costituzionalmente riconosciuti ai richiedenti asilo, ai profughi, ai migranti. A questo proposito però esiste il consenso detto e non detto della popolazione e dello stesso mondo cattolico - con l’eccezione di pochi gruppi che rischiano però di godere di una visibilità mediatica fine a se stessa.
In tema di migrazione, accoglienza e integrazione dei migranti la stessa voce del Papa così forte, insistente, perentoria e persino provocatoria sino ad un anno fa, sembra in qualche modo ridimensionata. Si è fatta più realistica. Spero che questa mia affermazione non venga maliziosamente fraintesa.
Papa Bergoglio si trova in una situazione eccezionalmente difficile dentro e fuori la Chiesa. Nei suoi contatti e comunicazioni esterne talvolta si ha l’impressione che, senza abbandonare la sua tipica giovialità, sia profondamente turbato.
 Questo turbamento si esprime anche nel suo schietto linguaggio tradizionale che mette continuamente in guardia qui e ora contro la presenza e l’opera del demonio. In fondo è lui il sicario dell’aborto.
Questo turbamento si esprime anche nel suo schietto linguaggio tradizionale che mette continuamente in guardia qui e ora contro la presenza e l’opera del demonio. In fondo è lui il sicario dell’aborto. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Legge 194. Quarant’anni fa veniva legalizzato l’aborto in Italia6 ottobre 2018, di Federico La Sala
Legge 194
Quarant’anni fa veniva legalizzato l’aborto in Italia
di Flavia Amabile (La Stampa, 06.10.2018)
Era il 22 maggio 1978 quando , dopo anni di aspre battaglie fu approvata la legge 194 che riconosce alle donne il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza. Prima l’aborto era considerato un reato, le donne che avevano necessità di non portare avanti una gravidanza dovevano rivolgersi a strutture clandestine, con seri rischi per la propria vita.
Quarant’anni dopo la legge ha raggiunto alcuni dei suoi obiettivi. Le interruzioni volontarie di gravidanza, sono più che dimezzate. Ma è aumentata la pressione dei movimenti antiabortisti, il numero di medici obiettori che ha raggiunto la cifra record del 70% rendendo del tutto impossibile in alcune regioni esercitare il diritto di effettuare un aborto. La legge 194 si presenta quindi sempre meno applicata e sta di nuovo aumentando la richiesta di aborti clandestini.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO. Se nella Chiesa c’è chi fa muto Dio (di Marina Corradi)16 settembre 2018, di Federico La Sala
"LA CHIESA, CORPO DI CRISTO", LA PAROLA DEL PAPA, E LA NECESSITA’ DI UNA "UMILTA’ NUOVA". IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.... *
- "L’immagine del corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognu no di noi, come è tutto intero nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo. L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante sentirsi membro del co rpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici, che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
Pedofilia: la parola profonda e tagliente del Papa.
Se nella Chiesa c’è chi fa muto Dio
di Marina Corradi (Avvenire, sabato 15 settembre 2018)
C’è fra alcuni di noi una stanchezza. Gli episodi di pedofilia nella Chiesa emergono dal passato molto più numerosi di quanto li avremmo mai creduti. Si delinea un male sotterraneo, taciuto, e quasi, in certi ambienti, tollerato. È un’onda fangosa quella che si solleva dall’Irlanda, dagli Usa, dall’Australia e da altrove. Fa scandalo, come è giusto, e fa molto rumore. E appunto alcuni credenti, pure avviliti e addolorati, cominciano a avere una reazione tuttavia di insofferenza: non si sente parlare che di pedofilia, obiettano, non c’è solo questo, la Chiesa è ben altro. La Chiesa, dicono, è piena uomini e donne che fanno del bene senza fare rumore, è fatta anche di missionarie e missionari coraggiosi, di bravi parroci, di suore che curano i figli dei poveri, di laici generosi. È fatta la Chiesa, anche di sconosciuti santi, e di martiri.
Ed è tutto assolutamente vero. Eppure, il Papa giovedì scorso a dei vescovi di recente nomina, tornando sul dramma della pedofilia fra consacrati, ha detto parole drammatiche. Ha detto che le nostre risposte «saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non metteranno a nudo il vuoto esistenziale che esse hanno alimentato. Se non riveleranno - ha proseguito - perché mai Dio è stato così reso muto, così messo a tacere, così rimosso da un certo modo di vivere, come se non ci fosse».
Dio reso muto. Dio messo a tacere, come se non esistesse. Etsi non daretur. E hanno vissuto, e vivono, così persone consacrate. Taglia come un rasoio questa parola del Papa. Come il bisturi del chirurgo che, aprendo il petto di un paziente, scopre che è ampio, il male da asportare. Non minimizza il Papa, non si consola pensando a tutto il bene fatto dalla Chiesa. Sembra dirci che occorre prendere coscienza del male, tutto intero, di quanto profondo sia stato - tanto da ammutolire Dio.
Francesco ci fa stare davanti al peccato che ha intaccato la Chiesa, senza scappatoie. Un peccato che, nel dolore delle vittime, nel loro scandalo, riguarda anche noi. Coloro che parlavano a dei bambini di Dio erano gli stessi che ne abusavano: ingenerando in loro il pensiero che né degli uomini, né di Dio ci si può fidare. Pensiero che annienta, colpo di scure su giovani piante.
Dio reso muto, Dio rimosso, proprio da chi doveva insegnare ad amarlo. Il dito del Papa non smette di indicarci ciò che è stato. Noi, forse, avremmo la tentazione di dimenticarcene. D’accordo, lo sappiamo, basta adesso. Perché abbiamo il vizio di pensare che gli uomini e le istituzioni siano "buoni", oppure "cattivi". La Chiesa è "buona", e dunque non tolleriamo di constatare quanti abbiano potuto tradire, e nel modo peggiore, con dei bambini. Ci umilia troppo il ricordarlo.
Ma la Chiesa, corpo di Cristo, è fatta da uomini. Contiene in sé, come il cuore di ogni uomo, possibilità di luce e di buio, di generosità fedele e silenziosa, di eroismo, ma anche di diserzione vigliacca, sotto a ordinate apparenze. E chi conosce il labirinto del suo cuore, e a una certa età almeno bisognerebbe conoscerlo, può guadare allo scandalo che il Papa continua a indicarci, senza domandare che si parli d’altro.
Si può stare a viso aperto davanti a tanto male compiuto in mezzo a noi, solo se non ci si sente orgogliosamente "buoni", "onesti", intoccabili dalla miseria umana. Nessuno è buono, ci ha insegnato Gesù Cristo. Siamo tutti poveri, dei miserabili che mendicano la grazia di Dio. È quella grazia, domandata ogni mattina, che ci permette di fare del bene, che ci allontana dalla attrazione del male. Non un nostro essere "bravi".
«Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore» era la litania dei monaci della tradizione greco-bizantina, ripetuta come un respiro, come una domanda inesausta. In questa coscienza di mendicanti possiamo stare di fronte alle parole del Papa, al tragico Dio muto che ha evocato, e non perdere il coraggio. In un travaglio che potrebbe portarci a una umiltà nuova.
 Nessuno è buono, e c’è in ciascuno di noi la possibilità del male. Bisogna ostinatamente domandare. Il peccato dentro la Chiesa che si leva alto come un’onda non ci travolge, se non lo censuriamo; ma, più coscienti del nostro e altrui male, ci ricordiamo che l’autentica santità, come ha concluso l’altro giorno Francesco, «è quella che Dio compie in noi».
Nessuno è buono, e c’è in ciascuno di noi la possibilità del male. Bisogna ostinatamente domandare. Il peccato dentro la Chiesa che si leva alto come un’onda non ci travolge, se non lo censuriamo; ma, più coscienti del nostro e altrui male, ci ricordiamo che l’autentica santità, come ha concluso l’altro giorno Francesco, «è quella che Dio compie in noi».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA "PESTE"!!! Caro Benedetto XVI ... DIFENDIAMO LA FAMIGLIA!? MA QUALE FAMIGLIA - QUELLA DI GESU’ (Maria - e Giuseppe!!!) O QUELLA DI EDIPO (Laio e Giocasta)?!
- IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO. L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- UNA DOMANDA CAPOVOLTA. Non più «perché?», ma «per chi?». La relazione figli-genitori - e la felicità (di Marina Corradi)20 settembre 2018, di Federico La Sala
LA DOMANDA CAPOVOLTA: QUANDO TUTTO SI ROVESCIA. La relazione figli-genitori.... *
Dare onore oltre ogni merito.
La relazione figli-genitori nell’insegnamento del Papa
di Marina Corradi (Avvenire, 20 settembre 2018)
Onora il padre e la madre. La parola del Quarto comandamento risuona da migliaia di anni, ma da altrettanto tempo generazioni di figli si sono domandate perché onorare quei genitori che magari li hanno abbandonati, o maltrattati, o fatti soffrire. “Onora il padre e la madre”, dice il Decalogo, come prescindendo dall’infelicità di certe famiglie di ieri come di oggi.
Onora tuo padre che non ti ha riconosciuto, che picchia tua madre, che se ne è andato? Un simile “onore” potrebbe apparire un’astratta, esteriore formalità. Ma questo onore, cos’è? Il Papa in Udienza ieri ha spiegato che il termine ebraico indica il «peso», la consistenza di una realtà. Non è questione di forme esteriori, ha aggiunto Francesco, «ma di verità». Cioè questo onore ha a che fare con il riconoscimento di un dato oggettivo. Tua madre e tuo padre ti hanno dato la vita.
A prescindere da cosa sia successo poi, l’«onore» che devi loro è legato a questa incontrovertibile verità. Il Quarto comandamento, ha spiegato papa Francesco, «Non parla della bontà dei genitori, non richiede che i padri e le madri siano perfetti. Parla di un atto dei figli, a prescindere dai meriti dei genitori, e dice una cosa straordinaria e liberante: anche se non tutti i genitori sono buoni e non tutte le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici, perché il raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta riconoscenza verso chi ci ha messo al mondo».
Perché quel comandamento si conclude con una parola ben nota, certo, ai religiosi e ai biblisti, meno alla gente comune e meno ancora ai ragazzi di oggi, una generazione che in ampie proporzioni viene ormai da famiglie divise e sofferenti. Onora il padre e la madre, dunque, si legge nel Deuteronomio, «perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà». Annota Francesco: «La parola “felicità” nel Decalogo compare solo legata alla relazione con i genitori».
Dieci comandamenti, ma, singolare, solo in uno si fa esplicito riferimento alla felicità. Quell’«onore» dovuto riguarda una riconoscenza per il fatto di essere stati dati alla luce, e ha poi a che fare, in ultimo, con la felicità. Anche qui, certo, molti figli potrebbero umanamente recriminare che la vita data, e poi da quei genitori ferita o abbandonata, non è così bella da meritare tanta gratitudine. Spesso chi ne è protagonista trascorre l’esistenza a domandarsi “perché”, perché a me questa famiglia, perché a me, questa infanzia. Ma è una domanda sbagliata.
La domanda giusta, ha detto il Papa, non è «perché» ma «per chi» mi è successo questo, e ha spiegato: «In vista di quale opera Dio mi ha forgiato attraverso la mia storia? Qui tutto si rovescia, tutto diventa prezioso, tutto diventa costruttivo». In questo sguardo rovesciato le ferite dei figli possono diventare luoghi fecondi dell’anima. I silenzi e le parole, le assenze, i litigi, tutto ciò che segretamente ha fatto male, e perfino gli abbandoni e le violenze: di tutto questo dovremmo non chiederci più «perché», ma «per chi».
A quale disegno si è stati chiamati dentro alla incapacità o alla fragilità dei padri. Perché l’infanzia, come ha ricordato Francesco, è scritta «con inchiostro indelebile». Non ci si chiede di dimenticare, ma di andare oltre: a cosa serviva la sofferenza attraversata, e a che cosa ci chiama la forma, il “cuore” che con esso ci è stato dato.
 Dentro a questo sguardo la vita ricevuta è davvero un dono. Dentro a questo sguardo l’onore dovuto ai genitori è anche, ha concluso Francesco, «misericordiosa accoglienza dei loro limiti». (Quasi fossimo noi, ora, madri e padri pietosi, e loro i figli). Quanta libertà e speranza in questa prospettiva.
Dentro a questo sguardo la vita ricevuta è davvero un dono. Dentro a questo sguardo l’onore dovuto ai genitori è anche, ha concluso Francesco, «misericordiosa accoglienza dei loro limiti». (Quasi fossimo noi, ora, madri e padri pietosi, e loro i figli). Quanta libertà e speranza in questa prospettiva.I cristiani di una certa età vengono da tempi in cui ai bambini al catechismo veniva detto spesso «Onora il padre e la madre», e basta, come dando per scontate famiglie unite e perfette, come non prevedendo le sofferenze e i torti che pure allora c’erano. Oggi, con tanti figli che fin da piccoli vedono la famiglia spezzarsi, e con questa il loro stesso mondo, la “seconda parte” del Quarto comandamento ricordata dal Papa è una parola fondante. Non c’è solo il rancore, la tristezza, la depressione come reazione a certe infanzie, e nemmeno solo le psicoterapie, che analizzano, sezionano i ricordi, ma alla fine non curano la memoria. C’è anche questa domanda inconsueta, capovolta, posta da Francesco. Non più «perché», ma «per chi».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA VITA, L’ETICA E LA VERITA’ E IL LORO FONDAMENTO NASCOSTO, L’AMORE (DEUS CHARITAS). Come un "padre" diventa "figlio del suo figlio" - e il figlio "padre del suo padre"
"DUE SOLI". Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò i mosaici" dei "faraoni", ma soprattutto la Legge del "Dio" di Mosè di Elia e di Gesù, del "Dio" dei nostri "Padri" e delle nostre "Madri". L’Amore che muove il Sole e le altre stelle
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Nelle “viscere della storia” non c’è solo la barbarie o la disumanità. Ci sono anche “prospettive impensate”, “tesori di cultura” (di Lea Melandri).14 settembre 2018, di Federico La Sala
Nelle viscere della storia
di Lea Melandri*
Nelle “viscere della storia” non c’è solo la barbarie o la disumanità. Ci sono anche “prospettive impensate”, “tesori di cultura”. Basta cercarli. È questa la lezione della rivista “L’erba voglio”.
Il pericolo che molti vedono incombere sulla democrazia nel nostro Paese raramente viene associato alla crisi, più generale e più datata della politica: la modificazione lenta ma inarrestabile dei confini che per secoli hanno circoscritto e confuso lo spazio pubblico con il suo governo, le sue istituzioni, le sue leggi, i suoi linguaggi, e, prima ancora, con il dominio di un sesso solo.
Se la nostra cultura non si fosse dimostrata finora così ottusamente refrattaria ad accogliere analisi attente ai nessi tra corpo e politica, tra virilità e costruzione storica della sfera pubblica, risulterebbe evidente che la norma e la trasgressione, l’ordine e la perdita di controllo, la legge e la sua sistematica violazione, il bene collettivo e l’egoismo individuale, la civiltà e la barbarie, non hanno mai smesso di affrontarsi e confondersi nello spazio pubblico, sotto la spinta di contesti economici e politici mutevoli, ma ubbidendo nel medesimo tempo a quella “invariante” della storia che è l’identificazione dell’umano perfetto con la maschilità, e tutte le contrapposizioni che ha prodotto tra l’amico e il nemico, il cittadino e lo straniero
L’irruzione del “femminile” nella vita pubblica - inteso non solo come presenza quantitativa delle donne nel luogo da cui sono state tradizionalmente escluse, ma come protagonismo e rivalsa di tutto ciò che è stato identificato col “sesso debole” - non poteva non intaccare i fondamenti della politica, mettere in discussione i concetti di libertà, democrazia, uguaglianza, fraternità, diritto, ridefinire in modo meno astratto la figura del cittadino.
Se l’occasione di portare al centro della responsabilità collettiva la vita nella sua interezza si sta trasformando in “antipolitica” - rovesciamento dei rapporti tra ordine e caos, realtà e immaginario, ragione e sentimenti - è perché si continuano ad ignorare i percorsi di liberazione e di allargamento dell’impegno politico aperti dalle culture alternative degli anni Settanta, in particolare dal femminismo, e oggi dalle associazioni di uomini che si interrogano sulla storia dal punto di vista del sesso che ne è stato protagonista.
Quello che molti di noi scoprirono allora, come insegnanti, operatori sociali, studenti, operai, nel momento in cui si abbandonavano gli strumenti tradizionali del controllo e della repressione, avrebbe dovuto allarmare molto più delle forze conservatrici che ci fecero guerra.
Le pratiche non autoritarie nella scuola, negli asili autogestiti, nelle assemblee autonome sorte all’interno delle fabbriche, che generalmente vengono additate da destra e da sinistra come la causa remota del degrado attuale, sono state, al contrario, il primo svelamento della massificazione precoce, la denuncia del caos che si cela dietro i sistemi istituzionali di controllo e sicurezza.
- “Eludendo la figura dell’adulto - annotava Elvio Fachinelli in Masse a tre anni (L’erba voglio, Einaudi, 1971) -, astrattamente considerata ‘autoritaria’, si vede sorgere una gerarchia di ferro, basata sulla forza e la prepotenza, che impronta di sé i rapporti dei bambini tra loro (...) sembra di trovarsi in una società violenta, tra il fascista e il mafioso”.
Erano segnali piccoli ma inequivocabili, portati allo scoperto dalla consapevolezza delle mutilazioni che si era inflitta la politica, e dall’idea che bisognasse partire da lì, da quei corpi che arrivano all’asilo “già rattrappiti e coartati”, per trovare nuove forme d’amore e di convivenza umana.
La crisi dell’autorità paterna nell’ambito famigliare, e il declino delle istituzioni della vita pubblica, avrebbero poi subìto un’accelerazione imprevista sotto l’urto della società dei consumi, della sua potenza invasiva e divorante, della sua indifferenza per norme e limiti di ogni specie. Così è accaduto che, quando ancora le donne muovevano i primi passi da cittadine sotto tutti gli effetti, a farla da vincitore fosse il “femminile” costruito dall’uomo, la visceralità che la storia si è portata dietro e che insidia da sempre il suo processo di incivilimento.
Oggi si scopre che l’inconscio collettivo, che si è espresso “democraticamente” nel voto della maggioranza, è reazionario. Non era poi così difficile da immaginare: tutto ciò che è stato sepolto nella zona più oscura della vita dei singoli, identificato con la natura o con la parola rivelata di un Dio, per potersi modificare ha bisogno innanzi tutto di essere riconosciuto, narrato e analizzato, restituito alla cultura e alla politica con cui è sempre stato in rapporto, sia pure un rapporto alienato, strumentale, distruttivo della politica stessa e delle sue conquiste democratiche.
L’“immensa esperienza negativa” che si è accumulata nelle “viscere della storia” nel corso dell’ultimo secolo, come conseguenza del fatto che sono stati considerati condizione quasi esclusiva del cambiamento i rapporti di produzione, oggi esce allo scoperto attraverso la retorica populista delle destre occidentali. Ma, se non ne abbiamo paura e, soprattutto se non abbiamo fretta di cancellarla o imitarla, forse è l’occasione per dare finalmente cittadinanza a “esperienze essenziali del vivere umano”.
L’esperienza della rivista “L’erba voglio” ha significato fare cultura attraverso tutto ciò che la cultura tradizionale considera “rifiuti”, “scarti”, “tabù”, prendere distanza dalla continuità del “noto”, dal rapporto ottimistico che la cultura occidentale ha intrattenuto con le sue mete tecno scientifiche, non aver paura di addentrarsi nel “caotico mondo dell’antiragione”, aprirsi a “prospettive impensate”.
Prima che la barbarie, come ritorno a forme arcaiche di violenza, prenda il sopravvento, dovremmo tentare - come è stata per la generazione “imprevista” di giovani e donne nel Sessantotto -, a farci noi “barbari”, estranei e creativi, rispetto a una civiltà esaurita e sempre più disumanizzante.
*Insegnante, giornalista, scrittrice e saggista, riferimento per il movimento delle donne italiano. Tra i suoi libri: L’infamia originaria; Come nasce il sogno d’amore; Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia; La perdita; Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà. Altri suoi articoli sono leggibili qui.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- La cooperazione come terzo principio fondamentale dell’evoluzione (Vittorio Lingiardi)..12 settembre 2018, di Federico La Sala
I dialoghi. Vittorio Lingiardi e Benedetto Farina
Dottor Freud aiutaci a cooperare
La psicoterapia è una forma di cooperazione e la cooperazione è una forma di psicoterapia
di Vittorio Lingiardi (la Repubblica, 12.09.2018)
- Vittorio Lingiardi è uno psichiatra e psicoanalista italiano, professore ordinario di psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. Wikipedia
La psicoterapia è una forma di cooperazione e la cooperazione è una forma di psicoterapia. Sono giunto a questa conclusione dialogando con un collega che ha una formazione diversa dalla mia. Non che parlare di "scuole" abbia sempre senso, ma la mia educazione, psicoanalitica, e quella del mio interlocutore cognitivista Benedetto Farina, docente all’Università Europea di Roma e allievo di Giovanni Liotti, uno dei padri del cognitivismo italiano, sono oggettivamente diverse. Cose importanti però ci uniscono: siamo entrambi clinici e ricercatori. Benedetto fa ricerca soprattutto da una prospettiva neuroscientifica; io parto dai trascritti delle sedute di psicoterapia per valutare la qualità dell’alleanza terapeutica: rotture, riparazioni, negoziazioni...
Entrambi siamo cresciuti studiando la teoria dell’attaccamento di Bowlby, che pone basi etologiche e motivazionali all’origine delle relazioni e dello sviluppo della personalità. Forse l’unica teoria che ha saputo raccogliere attorno a sé, mettendole in dialogo, discipline tra loro diverse e litigiose. «Oggi - dice Farina - potremmo metterla così: la tua psicoanalisi e il mio cognitivismo considerano la relazione con il paziente il principale strumento terapeutico. Ma non è forse questo il fattore comune che secondo la ricerca spiega l’efficacia di tutti i trattamenti?».
Vittorio Lingiardi: Sì, l’esito di una terapia è in gran parte associato alla qualità della relazione che si stabilisce tra paziente e terapeuta. Detto questo, le variabili in gioco sono molte. Anche perché molte sono le psicoanalisi e molti i cognitivismi. Nonostante il marchio di fabbrica, un paziente in cerca di terapia non sa mai esattamente quello che trova. E poi ci sono le diverse tipologie, anche caratteriali, di terapeuta. Un terapeuta riservato e uno espansivo funzionano nello stesso modo? Con tutti i pazienti? Per tornare alla relazione come fattore terapeutico, mi domando se è più in gioco l’accudimento o la cooperazione, pur sapendo che il bravo clinico sa dosare il loro contributo.
Benedetto Farina: È un tema che appassionava Liotti, il quale ha sempre sostenuto che è più efficace impostare la terapia sul piano cooperativo, soprattutto con pazienti gravi che hanno alle spalle un’infanzia traumatica. Stimolare troppo il sistema dell’attaccamento è rischioso, può riattivare memorie traumatiche di accudimenti mancati o distorti. Molte ricerche dimostrano che la promozione di un clima di cooperazione favorisce invece la capacità di provare empatia, di sintonizzarsi con i pensieri degli altri, di comprendere il funzionamento della mente propria e altrui e di lavorare sugli aspetti che portano a soffrire.
VL: È quello che in psicologia viene chiamato mentalizzare, una funzione che inizia a svilupparsi nei primi anni e ci accompagna tutta la vita. Ed è il pane quotidiano di molte terapie. La sua complessità sta nel riuscire a "tenere in mente" i nostri stati mentali e quelli degli altri. Sofisticate tecniche di registrazione simultanea dell’attività cerebrale di due individui che interagiscono mostrano che l’attività elettrica dei loro cervelli, nelle aree evolutivamente più recenti come la corteccia frontale, si sincronizza quando devono compiere azioni coordinate e cooperative.
BF: Molte discipline indicano che l’eccezionale espansione del cervello e lo sviluppo delle funzioni cognitive e culturali di cui l’uomo è capace sono il risultato di una traiettoria evolutiva finalizzata alla relazione e alla cooperazione. La spinta motivazionale alla cooperazione ha richiesto lo sviluppo di capacità cognitive sempre più sofisticate come il linguaggio, l’empatia, la condivisione di scopi e decisioni, l’insegnamento.
VL: E dunque delle strutture cerebrali per sostenerle. Ma se la capacità di instaurare legami cooperativi è così fondata sul piano etologico e biologico, come può essere tanto in disgrazia sul piano sociale? Il discorso va affrontato sul piano dell’evoluzione. Proprio Liotti ci insegnava a non perdere di vista la tripartizione evolutiva e gerarchica del nostro cervello e dei nostri sistemi motivazionali. Il livello più arcaico presiede le condotte non-sociali legate alla regolazione delle funzioni fisiologiche, alla difesa dai pericoli, al controllo del territorio, ecc. Quando è molto attivato può avere la meglio. Il secondo livello corrisponde all’attività delle reti neurali che definiscono le condotte di attaccamento, accudimento, richiesta/offerta di cura, ecc. Il terzo livello, prerogativa della specie umana, è nella neo-corteccia e riguarda le dimensioni cognitive dell’intersoggettività e della costruzione di significati. Regola i livelli più arcaici ed è influenzato dalla cultura di appartenenza.
BF: Ed è proprio qui che poggia il sistema cooperativo paritetico. La spinta a cooperare non solo ha promosso le nostre capacità empatiche e intellettuali, ma ha anche favorito la nascita della cultura. Il vantaggio di condividere ciò che si è appreso dall’esperienza individuale è alla base delle capacità culturali che caratterizzano la nostra specie.
VL: Ha dunque ragione l’antropologo Robert Boyd quando sostiene che il nostro successo nell’adattamento è dovuto alla capacità di imparare dagli altri, una capacità che ci permette di accumulare informazioni tra le generazioni e sviluppare strumenti, credenze e pratiche che sarebbe troppo complesso per il singolo individuo concepire durante l’arco della vita. La cosiddetta social brain hypothesis ci spiega infatti che, nei primati, l’espansione del cervello è avvenuta per gestire rapporti sociali sempre più complessi e cooperare al meglio. Un fatto che ci aiuta a capire lo sviluppo di tutte quelle relazioni non finalizzate alla riproduzione, "cognitivamente" impegnative e specificamente umane, come quella psicoterapeutica. Se la mente umana si è sviluppata per cooperare non sorprende che, quando si ammala o soffre, la sua cura non possa che basarsi su una relazione cooperativa.
 L’aspetto più "miracoloso" dell’evoluzione è forse proprio l’abilità di generare cooperazione in un mondo competitivo. Al punto che c’è chi sostiene che, alla mutazione e alla selezione naturale, andrebbe aggiunta la cooperazione come terzo principio fondamentale dell’evoluzione.
L’aspetto più "miracoloso" dell’evoluzione è forse proprio l’abilità di generare cooperazione in un mondo competitivo. Al punto che c’è chi sostiene che, alla mutazione e alla selezione naturale, andrebbe aggiunta la cooperazione come terzo principio fondamentale dell’evoluzione. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- COSMOLOGIA E CIVILTA’. L’astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell e lo "scippo" del Nobel.12 settembre 2018, di Federico La Sala
CULTURE
Scoprì le stelle pulsar ma il Nobel andò al suo professore: 44 anni dopo, l’astrofisica si prende la sua rivincita
Jocelyn Bell Burnell era solo una studentessa di Cambridge negli anni ’70 e, per di più, donna. Come "risarcimento" riceverà un premio da 3 milioni di dollari
di Huffington Post (07.09.2018)
Per la scoperta delle stelle pulsar - merito suo - l’astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell non ricevette alcun premio. Anzi, il Nobel per la Fisica, che le spettava, invece che a lei andò al suo professore. D’altronde lei era solo una studentessa di Cambridge, giovane e per di più donna. Oggi, però, la scienziata si è presa una rivincita: in USA le è stato assegnato lo "Special Breaktrough Prize", un premio finanziato dai miliardari della Silicon Valley, del valore di 3 milioni di dollari.
Basterà questo risarcimento tardivo a compensare lo "scippo" del Nobel? "Sono rimasta assolutamente senza parole", ha affermato Jocelyn ai media dopo aver appreso la notizia, "e chiunque mi conosce sa che non sono mai senza parole. Non era mai entrato neppure nei miei sogni più bizzarri".
- [Foto] Acclaimed Northern Irish astrophysicist Jocelyn Bell Burnell, pictured at the Edinburgh International Book Festival where she talked about her work which included the discovery of the pulsar. The three-week event is the world’s biggest literary festival and is held during the annual Edinburgh Festival. The 2011 event featured talks and presentations by more than 500 authors from around the world. (Photo by Colin McPherson/Corbis via Getty Images)
Jocelyn Bell Burnell fu autrice di una delle maggiori conquiste scientifiche del XX secolo. Nata nel 1943 in Irlanda del Nord, Jocelyn era arrivata all’università di Cambridge per un dottorato. Fu proprio durante il periodo di studio, precisamente nel 1967, che fece l’importante scoperta: mentre esaminava i dati provenienti da un radiotelescopio che aveva aiutato a costruire, si accorse di un segnale insolito, onde radio che pulsavano a intervalli regolari. "Me ne sono accorta perché ero molto attenta, molto precisa, a causa della ’sindrome dell’impostore’", ha raccontato al Guardian. Il riferimento è a quella sensazione di essere sempre in errore: Jocelyn dubitava delle proprie capacità e temeva di poter essere cacciata da Cambridge.
Fu il professore il primo a "smontarla": le disse che quel segnale era semplicemente un’interferenza, di origine umana.
Lei non si arrese: raccolse ulteriori dati e rilevò tre diversi impulsi radio provenienti da diverse parti della galassia. Questi provenivano da stelle pulsar, le quali, quando ruotano su se stesse, emettono onde radio che si diffondono nello spazio come da un faro cosmico.
La scoperta fu talmente sensazionale da guadagnarsi il Nobel, che però non andò a Jocelyn ma al suo professore. "Ero soltanto una studentessa", commenta oggi la scienziata. Come per riscattare il torto subito, l’astrofisica donerà i 3 milioni vinti per finanziare gli studi scientifici delle giovani donne.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- GENOVA 2018. AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE"18 agosto 2018, di Federico La Sala
AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE". L’*AMORE* Di MARIA E GIUSEPPE E LA "PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018" :
- Preghiera dei bambini (1870): “Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” (http://www.fondazioneterradotranto.it/2018/07/06/ggimentu-gimmientu-e-ggimintare/#comment-96032)
- Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16).
PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 *
 Dio, nostro Padre,
Dio, nostro Padre,
 Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
 Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
 Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
 Rendici pazienti e gentili,
Rendici pazienti e gentili,
 Amorevoli e generosi,
Amorevoli e generosi,
 Accoglienti con i bisognosi.
Accoglienti con i bisognosi.
 Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
 Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
 Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
 [facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
 persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
 Aumenta la nostra fede,
Aumenta la nostra fede,
 Rendi forte la nostra speranza,
Rendi forte la nostra speranza,
 Conservaci nel tuo amore,
Conservaci nel tuo amore,
 Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
 Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, Amen
Amen Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
 San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
 Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
 San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.*Fonte: https://www.worldmeeting2018.ie/WMOF/media/downloads/prayerA4-IT.pdf
* L’Incontro mondiale. «Famiglia, sfida globale». Ecco il senso dell’incontro di Dublino. L’arcivescovo Martin, primate della Chiesa d’Irlanda: Amoris Laetitia, messaggio di misericordia nella complessità. Uno spazio dedicato anche al soloroso tema degli abusi (di Luciano Moia, Avvenire, venerdì 17 agosto 2018: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/famiglia-sfida-globale-ecco-il-senso-di-dublino).
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala (18.08.2018)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- MARIA E GIUSEPPE A DUBLINO. "Risorsa famiglia. Così lo sguardo femminile può cambiare l’economia" (di Luigino Bruni).23 agosto 2018
CREATIVITÀ E CARITÀ ("CHARITAS"). ADAMO ED EVA, MARIA E GIUSEPPE UGUALI DAVANTI A DIO. Il cattolicismo "andropologico" romano è finito...*
Risorsa famiglia.
Così lo sguardo femminile può cambiare l’economia
di Luigino Bruni (Avvenire, giovedì 23 agosto 2018)
- Il testo che segue è parte della relazione che l’economista Luigino Bruni ha tenuto ieri nella seconda giornata dell’Incontro mondiale delle famiglie in corso a Dublino.
Economia è una parola greca che rimanda direttamente alla casa ( oikos nomos, regole per gestire la casa), quindi alla famiglia. Eppure l’economia moderna, e ancor più quella contemporanea, si è pensata come un ambito retto da principi diversi, distinti e per molti versi opposti ai principi e ai valori che hanno sempre retto e continuano a reggere la famiglia. Un principio fondante la famiglia, forse il primo e quello sottostante gli altri, è quello di gratuità, che è quanto è di più distante dall’economia capitalistica, che conosce surrogati della gratuità (sconti, filantropia, saldi) che svolgono al funzione di immunizzare i mercati dalla gratuità vera.
La famiglia, infatti, è il principale luogo dove apprendiamo, per tutta la vita e in un modo tutto speciale da bambini, quella che Pavel Florensky chiamava ’l’arte della gratuità’. E lì che soprattutto da bambini impariamo anche a lavorare, perché non c’è lavoro ben fatto senza gratuità. La nostra cultura, però, associata la gratuità al gratis, al gadget, allo sconto, alla mezza ora in più al lavoro non remunerata, al prezzo zero (San Francesco ci ha invece detto che la gratuità è un prezzo infinito: non si può né comprare né vendere perché è impagabile).
In realtà la gratuità è qualcosa di molto serio, come ci ha spiegato con estrema chiarezza anche la Caritas in veritate, che rivendica alla gratuità anche lo statuto di principio economico. Gratuità è charis, grazia, ma è anche l’agape, come ben sapevano i primi cristiani, che traducevano la parola greca agape con l’espressione latina charitas (con l’h), proprio ad indicare che quella parola latina traduceva ad un tempo l’agape ma anche la charis, e per questo quell’amore diverso non era né solo eros né solo philia (amicizia). La gratuità, questa gratuità, allora, è un modo di agire e uno stile di vita che consiste nell’accostarsi agli altri, a se stesso, alla natura, a Dio, alle cose non per usarli utilitaristicamente a proprio vantaggio, ma per riconoscerli nella loro alterità e nel loro mistero, rispettarli e servirli.
Dire gratuità significa dunque riconoscere che un comportamento va fatto perché è buono, e non per la sua ricompensa o sanzione. La gratuità ci salva così dalla tendenza predatoria che c’è in ogni persona, ci impedisce di mangiare gli altri e noi stessi. E’ ciò che distingue la preghiera dalla magia, la fede dall’idolatria, che ci salva dal narcisismo, che è la grande malattia di massa del nostro tempo, per assenza di gratuità.
Se la famiglia vuole, e deve, coltivare l’arte della gratuità, deve fare molta attenzione a non importare dentro casa la logica dell’incentivo che oggi vige ovunque. Guai, ad esempio, ad usare la logica dell’incentivo all’interno delle dinamiche familiari. Il denaro in famiglia, soprattutto nei confronti dei bambini e dei ragazzi (ma con tutti), va usato molto poco, e se usato deve essere usato come un premio o riconoscimento dell’azione ben fatta per ragioni intrinseche, e mai usato come prezzo. Uno dei compiti tipici della famiglia è proprio formare nelle persone l’etica del lavoro ben fatto, un’etica che nasce proprio dal principio di gratuità. Se, invece, si inizia a praticare anche in famiglia la logica e la cultura dell’incentivo, e quindi il denaro diventa il ’perché’ si fanno e non si fanno compiti e lavoretti di casa, quei bambini da adulti difficilmente saranno dei buoni lavoratori, perché il lavoro ben fatto di domani poggia sempre su questa gratuità che si apprende soprattutto nei primi anni di vita, e soprattutto a casa.
L’assenza del principio di gratuità nell’economia dipende anche, e molto, dall’assenza dello sguardo femminile. La casa, l’oikos, è sempre stato il luogo abitato e governato dalle donne. Ma , paradossalmente, l’economia è stata, e continua ad essere, una faccenda tutta giocata sul registro maschile. Anche i maschi hanno sempre avuto a che fare con la casa, e molto. Il loro sguardo si è però concentrato sul provvedere i mezzi per il sostentamento, sul lavoro esterno, sui beni, sul denaro. E quando l’economia è uscita dalla vita domestica ed è diventata politica, sociale e civile, lo sguardo e il genio femminile è rimasto dentro casa, e quello maschile è rimasta la sola prospettiva della prassi e soprattutto della teoria economica e manageriale.
Le donne guardano alla casa e all’economia vedendo prima di tutto il nesso di rapporti umani che si svolge in esse. I primi beni che vedono sono quelli relazionali e i beni comuni, e dentro a questi vedono anche i beni economici. Non è certo un caso che l’Economia di comunione sia nata da uno sguardo di una donna (Chiara Lubich), né che la prima teorica dei beni comuni è stata Katherine Coman (nel 1911), e che Elinor Ostrom sia stata insignita (unica donna finora) del premio Nobel in economia proprio per il suo lavoro sui beni comuni. E ci sono due donne (Martha Nussbaum e Carol Uhlaner) all’origine della teoria dei beni relazionali. Quando manca lo sguardo femminile sull’economia, le sole relazioni viste sono quelle strumentali, dove non è la relazione ad essere il bene, ma dove i rapporti umani e con la natura sono mezzi usati per procurarsi i beni.
Se lo sguardo e il genio femminile della oikoscasa fossero stati presenti nella fondazione teorica dell’economia moderna, avremmo avuto una economia più attenta alle relazioni, alla redistribuzione del reddito, all’ambiente e forse alla comunione. È, infatti, la comunione una grande parola che dalla famiglia può passare all’economia di oggi. E qui si apre un discorso specifico per i cristiani.
 La chiesa oggi è chiamata ad essere sempre più profezia, se vuole salvarsi e salvare. La profezia è anche una parola della famiglia. La maggior parte dei profeti biblici erano sposati, e molte parole e gesti profetici della bibbia sono parole di donne. Isaia chiamò suo figlio Seariasùb, che significa ’un resto tornerà’, che uno dei grandi messaggi della sua profezia.
La chiesa oggi è chiamata ad essere sempre più profezia, se vuole salvarsi e salvare. La profezia è anche una parola della famiglia. La maggior parte dei profeti biblici erano sposati, e molte parole e gesti profetici della bibbia sono parole di donne. Isaia chiamò suo figlio Seariasùb, che significa ’un resto tornerà’, che uno dei grandi messaggi della sua profezia.Non trovò modo migliore per lanciare quel suo messaggio profetico di farlo diventare il nome del figlio. Ogni figlio è un messaggio profetico, perché dice con il solo suo esserci che la terra avrà ancora un futuro, e che potrà essere migliore del presente. La profezia della famiglia oggi, per essere credibile, deve prendere la forma dei figli e la forma dell’economia, e quindi della condivisione, dell’accoglienza e della comunione. Perché sia i figli che l’economia non sono altro che la vita ordinaria di tutti e di ciascuno, che è il solo luogo dove la profezia si nutre e cresce.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
PER RATZINGER, PER IL PAPA E I CARDINALI, UNA LEZIONE DI GIANNI RODARI. L’Acca in fuga
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
ESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.14 agosto 2018, di Federico La Sala
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA.
 "PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ...
"PERCHE’ NON POSSIAMO NON DIRCI CRISTIANI", 0GGI.. In memoria di (Benedetto Croce), alcune note a margine del discorso di Papa Francesco, all’Angelus del 12 agosto 2018 d. C. ...- “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Paolo, Galati 3, 25-28).
- "(...) non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente" (Papa Francesco).
PAPA FRANCESCO
ANGELUS
 Piazza San Pietro
Piazza San Pietro
 Domenica, 12 agosto 2018
Domenica, 12 agosto 2018Cari fratelli e sorelle e cari giovani italiani,
buongiorno!
Nella seconda Lettura di oggi, San Paolo ci rivolge un pressante invito: «Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30).
Ma io mi domando: come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti lo abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, quindi, per non rattristare lo Spirito Santo, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del Battesimo, rinnovate nella Cresima. In maniera coerente, non con ipocrisia: non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente. Le promesse del Battesimo hanno due aspetti: rinuncia al male e adesione al bene.
Rinunciare al male significa dire «no» alle tentazioni, al peccato, a satana. Più in concreto significa dire “no” a una cultura della morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa che si esprime nella menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel disprezzo dell’altro. A tutto questo, “no”. La vita nuova che ci è stata data nel Battesimo, e che ha lo Spirito come sorgente, respinge una condotta dominata da sentimenti di divisione e di discordia. Per questo l’Apostolo Paolo esorta a togliere dal proprio cuore «ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità» (v. 31). Così dice Paolo. Questi sei elementi o vizi, che turbano la gioia dello Spirito Santo, avvelenano il cuore e conducono ad imprecazioni contro Dio e contro il prossimo.
Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano; è necessario aderire al bene e fare il bene. Ecco allora che San Paolo continua: «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (v. 32). Tante volte capita di sentire alcuni che dicono: “Io non faccio del male a nessuno”. E si crede di essere un santo. D’accordo, ma il bene lo fai? Quante persone non fanno il male, ma nemmeno il bene, e la loro vita scorre nell’indifferenza, nell’apatia, nella tiepidezza. Questo atteggiamento è contrario al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giovani, che per natura siete dinamici, appassionati e coraggiosi. Ricordate questo - se lo ricordate, possiamo ripeterlo insieme: “E’ buono non fare il male, ma è male non fare il bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado.
Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate il male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. Non basta non odiare, bisogna perdonare; non basta non avere rancore, bisogna pregare per i nemici; non basta non essere causa di divisione, bisogna portare pace dove non c’è; non basta non parlare male degli altri, bisogna interrompere quando sentiamo parlar male di qualcuno: fermare il chiacchiericcio: questo è fare il bene. Se non ci opponiamo al male, lo alimentiamo in modo tacito. È necessario intervenire dove il male si diffonde; perché il male si diffonde dove mancano cristiani audaci che si oppongono con il bene, “camminando nella carità” (cfr 5,2), secondo il monito di San Paolo.
Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto! Perciò siete allenati e posso dirvi: camminate nella carità, camminate nell’amore! E camminiamo insieme verso il prossimo Sinodo dei Vescovi. La Vergine Maria ci sostenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno di noi, ogni giorno, con i fatti, possa dire “no” al male e “sì” al bene.
Dopo l’Angelus
Cari fratelli e sorelle,
rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da tante parti del mondo.
In particolare saluto i giovani delle diocesi italiane, accompagnati dai rispettivi Vescovi, dai loro sacerdoti ed educatori. In questi giorni, avete riversato per le strade di Roma il vostro entusiasmo e la vostra fede. Vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra testimonianza cristiana! E ieri, nel ringraziare, ho dimenticato di dire una parola ai sacerdoti, che sono quelli che vi sono più vicini: ringrazio tanto i sacerdoti, ringrazio per quel lavoro che fanno giorno per giorno, ringrazio per quella pazienza - perché ci vuole pazienza per lavorare con voi! La pazienza dei sacerdoti ... - ringrazio tanto, tanto, tanto. E ho visto anche tante suore che lavorano con voi: anche alle suore, grazie tante.
E la mia gratitudine si estende alla Conferenza Episcopale Italiana - qui rappresentata dal Presidente Cardinale Gualtiero Bassetti - che ha promosso questo incontro dei giovani in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi.
Cari giovani, facendo ritorno nella vostre comunità, testimoniate ai vostri coetanei, e a quanti incontrerete, la gioia della fraternità e della comunione che avete sperimentato in queste giornate di pellegrinaggio e di preghiera.
A tutti auguro una buona domenica. Un buon rientro a casa. E per favore, non dimenticate di pregare per me! Buon pranzo e arrivederci!
* Appunti di commento sul tema, si cfr.:
- PAOLO COME "CRISTO": “(...) noi non siamo più sotto un pedagogo. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Galati: 3, 25-28).
- CAPO E CORPO "MISTICO" - FORZA "CRISTO"!: "(...) vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Paolo, Ef. 4,15-16)
- "CRISTO", ORDINE SACERDOTALE, E CHIESA: "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" (Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010.)
- SIMONE WEIL: "L’immagine del
corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza
che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della
nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di
un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato
di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è
Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua
unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognuno di noi, come è tutto intero
nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo.
 L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i
cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. certo inebriante
sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici,
che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a
mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"
LA LEZIONE CRITICA DI KANT. Alcune luminose pagine da "La fine di tutte le cose"GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Con "l’Arcisenso", al di là della "Dialettica della solitudine".10 agosto 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA.
- L’Arcisenso. Dialettica della solitudine
La solitudine come humus del bisogno di comunicare
di Giorgio Agnisola («Avvenire», 24 luglio 2018)
I1 titolo, peraltro suggestivo, dell’ultimo libro di Aldo Masullo, L’Arcisenso, può far supporre una disamina attorno ai disperanti sensi dell’incomunicabilità. In realtà il novantaseienne filosofo italiano declina nella sua opera una differente definizione della solitudine, essendo al centro della sua riflessione i concetti di relazione e intersoggettività, da sempre suoi luoghi di approfondita indagine. Nello specifico il libro raccoglie scritti di epoche differenti opportunamente rivisti, puntando l’autore, in definitiva, a una sintesi del suo pensiero.
In principio Masullo pone il significato di "paticità". Essa muove, secondo il filosofo, ogni atto e sentire umani. «Nulla si compie, nulla avviene nella coscienza se non nel segno del patire». In questo senso gioia e dolore sono facce di una stessa essenza umana; «sicché questo patire, diciamo sentire profondamente implicato col sentirsi, con il sensus sui, è unico e inviolabile. Io posso dire al mio simile ciò che penso, posso spiegarmi e spiegare, posso in sostanza comunicare, ma non posso trasmettere a chi mi ascolta, pur desiderandolo, il mio personale sentire». «Toccare un altro non è toccarlo ma sentirsi mentre lo si tocca».
 In sostanza non si esiste, scrive Masullo, se non si sente di esistere, ma il sentire dell’altro mai io posso sentirlo. Il mio sentire resta incomunicabile, ostinatamente e imprescindibilmente legato al mio sé: dunque «Il sentir-si, l’Arcisenso, è l’Intoccabile».
In sostanza non si esiste, scrive Masullo, se non si sente di esistere, ma il sentire dell’altro mai io posso sentirlo. Il mio sentire resta incomunicabile, ostinatamente e imprescindibilmente legato al mio sé: dunque «Il sentir-si, l’Arcisenso, è l’Intoccabile».Da qui la solitudine di leopardiana memoria (a Leopardi l’autore dedica un affascinante capitolo), il sentire la solitudine del sentirsi. Che non è dunque solo una condizione dello spirito, ma anche un’esperienza del corpo. L’attitudine morale e lo stesso valore della politica, afferma Masullo, derivano da questo principio. Ora questa solitudine può condurre al male, può corrompersi nell’odio e cedere alla castrante paura dell’intimità. Ma può essere una preziosa chance.
 La solitudine infatti, scrive ancora il filosofo, può dirsi in definitiva una condizione positiva della natura umana, giacché dalla solitudine deriva il bisogno di comunicare, di cercare strategie di convivenza, di operare nel sociale, di condividere.
La solitudine infatti, scrive ancora il filosofo, può dirsi in definitiva una condizione positiva della natura umana, giacché dalla solitudine deriva il bisogno di comunicare, di cercare strategie di convivenza, di operare nel sociale, di condividere.
 Con questa premessa Masullo rilegge temi fondanti della filosofia contemporanea, come il relativismo, a cui assegna un valore politico. Il relativismo, afferma il filosofo, viene sovente letto in termini negativi. Viceversa «è proprio dalla certezza del relativo che può nascere la volontà, il bisogno di una strategia di adattamento e di mediazione».
Con questa premessa Masullo rilegge temi fondanti della filosofia contemporanea, come il relativismo, a cui assegna un valore politico. Il relativismo, afferma il filosofo, viene sovente letto in termini negativi. Viceversa «è proprio dalla certezza del relativo che può nascere la volontà, il bisogno di una strategia di adattamento e di mediazione».Il conclusivo capitolo del libro dal titolo «Nei labirinti della soggettività» ha un valore emblematico. In esso il filosofo recupera la storia della sua ricerca in una prospettiva autobiografica. Sembrerebbe un capitolo eccentrico rispetto al contesto dell’opera. In realtà scorrendolo si comprende che esso fa da legante al testo, in qualche misura ne spiega i nessi, tra tema e tema, e li riassume nel profondo della straordinaria storia umana del maestro.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Questione antropologica
 IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA"."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
- L’Arcisenso. Dialettica della solitudine
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Razzismo e noismo - le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro: la sistematica di Linneo.9 agosto 2018, di Federico La Sala
PSICHIATRIA E RAZZISMI
 Storie e documenti
Storie e documentiLa sistematica di Linneo
di Luigi Benevelli (POL.IT, 14 gennaio, 2014)
- Luigi Luca Cavalli Sforza, Daniela Padoan, Razzismo e noismo - le declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro, Einaudi, Torino, 2013, pp. 72-75, passim.
Il pensiero occidentale è contrassegnato dalla prepotenza. Il grande sviluppo della sistematica ebbe pienamente luogo solo nel Settecento, con il botanico Carl Nilsson Linnaeus (1707-1778), che cominciò a organizzare le specie raggruppandole in generi, e quindi raggruppando i generi in una serie di categorie superiori basandosi sulle somiglianze morfologiche e anatomiche.
 Da quando nel 1735 venne introdotta la sua nomenclatura binomiale - basata sul modello aristotelico di «genere prossimo» e di «differenza specifica» - si è iniziato a declinare in latino il genere e la specie degli organismi.
Da quando nel 1735 venne introdotta la sua nomenclatura binomiale - basata sul modello aristotelico di «genere prossimo» e di «differenza specifica» - si è iniziato a declinare in latino il genere e la specie degli organismi.Linneo ha teorizzato un sistema di classificazione in cui il genere HOMO, posto in cima al regno animale, viene suddiviso in due specie: l’uomo «diurno», o homo sapiens, e l’uomo «notturno» o homo troglodytes, altrimenti detto uomo delle foreste o orangutan.
 È curioso come la nostra cultura abbia sempre teso a vedere la luce come il divino, l’alto, il sublime, e il buio come il demoniaco, il basso, il territorio dei bruti. Secondo il sistema delle similitudini e analogie, il Sole - simbolo platonico del Bene, che sempre nella sua corsa, tende a occidente - segna l’uomo occidentale.
È curioso come la nostra cultura abbia sempre teso a vedere la luce come il divino, l’alto, il sublime, e il buio come il demoniaco, il basso, il territorio dei bruti. Secondo il sistema delle similitudini e analogie, il Sole - simbolo platonico del Bene, che sempre nella sua corsa, tende a occidente - segna l’uomo occidentale.
 Il secolo dei Lumi, nelle retorica settecentesca, porta la ragione nelle menti ottenebrate dalla superstizione e dall’ignoranza; allo stesso modo, nella retorica coloniale del secolo successivo, dall’uomo occidentale procede la civilizzazione che porta la luce nel “cuore di tenebra” dei continenti selvaggi. Il che è perfettamente in sintonia con la classificazione linneiana di Homo sapiens in sei decrescenti varietà diurne, quattro varietà di «uomini normali», catalogabili secondo la provenienza geografica, il colore della pelle e le corrispettive «qualità morali», e due varietà di «uomini anormali».
Il secolo dei Lumi, nelle retorica settecentesca, porta la ragione nelle menti ottenebrate dalla superstizione e dall’ignoranza; allo stesso modo, nella retorica coloniale del secolo successivo, dall’uomo occidentale procede la civilizzazione che porta la luce nel “cuore di tenebra” dei continenti selvaggi. Il che è perfettamente in sintonia con la classificazione linneiana di Homo sapiens in sei decrescenti varietà diurne, quattro varietà di «uomini normali», catalogabili secondo la provenienza geografica, il colore della pelle e le corrispettive «qualità morali», e due varietà di «uomini anormali».
 Nella tassonomia di Linneo abbiamo
Nella tassonomia di Linneo abbiamo- Homo sapiens europaeus descritto come bianco ordinato, ingegnoso, inventivo, retto da leggi,
 Homo sapiens americanus,, rosso, amante della libertà, soddisfatto del proprio destino, irascibile,
Homo sapiens americanus,, rosso, amante della libertà, soddisfatto del proprio destino, irascibile,
 Homo sapiens asiaticus, giallastro, orgoglioso, avaro, melanconico,
Homo sapiens asiaticus, giallastro, orgoglioso, avaro, melanconico,
 Homo sapiens afer, nero, indolente, infido, scarsamente intelligente e incapace di autogoverno,
Homo sapiens afer, nero, indolente, infido, scarsamente intelligente e incapace di autogoverno,
 Homo sapiens ferus o uomo selvaggio, muto, quadrupede, villoso che comprende anche gli enfants sauvages, bambini abbandonati a se stessi e incapaci di parlare e apprendere, molto numerosi nella letteratura settecentesca,
Homo sapiens ferus o uomo selvaggio, muto, quadrupede, villoso che comprende anche gli enfants sauvages, bambini abbandonati a se stessi e incapaci di parlare e apprendere, molto numerosi nella letteratura settecentesca,
 Homo sapiens monstruosus o uomo teratologico, portatore di “forme devianti”, ovvero di malformazioni congenite e deficit cognitivi.
Homo sapiens monstruosus o uomo teratologico, portatore di “forme devianti”, ovvero di malformazioni congenite e deficit cognitivi.
Nella decima edizione del Systema naturae (1758), compare la classe dei primati, che sostituisce il precedente Anthropomorphae; qui avviene l’abbinamento del genere Homo con la specie sapiens. Dopo la scoperta dei fossili nella valle tedesca di Neanderthal, l’Homo sapiens divenne sapiens sapiens.
Sul tema, nel sito, cfr.:
PIANETA TERRA. Fine della Storia o della "Preistoria"? "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986). Tracce per una svolta antropologica
 OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.
OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE.- L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- EDITH STEIN. Teresa Benedetta della Croce. Dall’ateismo al Carmelo, una storia europea9 agosto 2018, di Federico La Sala
EUROPA: Edith Stein. Ebrea, atea, cristiana...
Teresa Benedetta della Croce.
Dall’ateismo al Carmelo una storia europea di santità
di Matteo Liut giovedì 9 agosto 2018
Solo la ricerca di Dio conta, perché solo in lui la storia ha senso e solo lui trasforma la sofferenza in una strada verso la luce vera. Oggi la compatrona del nostro Continente, santa Teresa Benedetta della Croce (al secolo Edith Stein), offre all’Europa uno spunto per continuare a guardare al futuro. La sua storia è fatta di dolore e speranza, di ricerca e di dono: sono gli "ingredienti" dai quali può nascere una società più giusta.
Era nata nel 1891 a Breslavia in una famiglia di ebrei ma a 14 anni scelse l’ateismo. Si mise a cercare la verità nella filosofia (fu assistente di Husserl) ma nel 1921 leggendo la vita di santa Teresa d’Avila capì che il senso sta nella ricerca di Dio. Nel 1922 si fece battezzare e nel 1934 entrò tra le Carmelitane a Colonia. Arrestata dalla Gestapo in Olanda, morì nel 1942 nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau.
Altri santi. San Romano, martire (III sec.); santa Candida Maria di Gesù Cipitria, religiosa (1845-1912).
 Letture. Os 2,16.17.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13.
Letture. Os 2,16.17.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13.
 Ambrosiano. Os 2,15f-16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13.
Ambrosiano. Os 2,15f-16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CARMELITANI SCALZI ED ECUMENISMO: STORIA E MEMORIA. Ritrovato nel salernitano "file" perduto del tardo Rinascimento
-
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
IL PROBLEMA DELLA GENESI, LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE, E LA FENOMENOLOGIA TRASCENDENTALE....
 HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico")PIAZZA SAN PIETRO: LA "TEOLOGIA" DELL’ELLISSE (DEI "DUE SOLI") E LE ILLUSIONI DELLA "TEOLOGIA" DEL "CERCHIO INCANTATO" (DELLA SCOLASTICA "CATTOLICA" E DELLA "SAPIENZA" RATZINGERIANA). IL DARSI DELLE COSE: LA LEZIONE DI HUSSERL.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO; SINODO DEI GIOVANI, 2018. Note.8 agosto 2018, di Federico La Sala
LA PARABOLA DEi "TALENTI", I "DUE CRISTIANESIMI", E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO.... *
Destinazione sinodo/18.
Dall’ascolto all’incontro. È la gioventù del Papa
di Stefania Falasca (Avvenire, mercoledì 8 agosto 2018)
Una generazione fa, nell’estate del 2013, di fronte alla marea di più di tre milioni di giovani assiepati sulla spiaggia di Copacabana per la Giornata mondiale della gioventù di Rio, papa Francesco era rimasto per un attimo in silenzio spaziando con lo sguardo su quella sconfinata folla di ragazzi sul bordo dell’oceano. Gli parve di vedere «guardando il mare, la spiaggia e tutti voi», disse, quel momento dell’inizio della storia cristiana sulla riva del mare di Galilea quando i primi due, alle quattro del pomeriggio, avevano incontrato Gesù. Gli erano andati dietro attratti da lui. E Gesù a questi due ragazzi - Andrea era sposato, quindi avrà avuto qualche anno di più, ma Giovanni era proprio un ragazzino -, voltandosi aveva domandato: «Che cosa cercate?». E questi non gli risposero ’cerchiamo la verità’, o ’cerchiamo la felicità’, non gli dissero neppure ’cerchiamo il Messia’. Quello che il cuore cercava lo avevano davanti. Allora a quella domanda - «Che cosa cercate?» - risposero chiedendo l’unica cosa che si può domandare: «Maestro dove abiti?», cioè ’dove rimani?’, dove rimani perché possiamo stare con te?
Sono passati cinque anni da quell’esordio vis-à-vis di Papa Francesco con i giovani di tutto il mondo in Brasile, e l’attualità ne resta intatta, anche se è cambiata nel frattempo la generazione dei «nati liquidi», come titola l’opera postuma di Zygmunt Bauman dedicata a queste ultime generazioni considerate sempre più «come bidone dei rifiuti per l’industria dei consumi» e «come un ulteriore fardello sociale», giovani che «hanno smesso di essere inclusi dalla promessa di un futuro migliore», sempre più «parte di una popolazione smaltibile la cui presenza minaccia di richiamare alla mente memorie collettive rimosse della responsabilità adulta». «Vuoti a perdere» a rischio «rottamazione», quelli che escono dalla lucida analisi dell’autore della società liquida, «gli scartati dall’impero del Dio denaro» da parte di chi divora la dignità umana e di cui gli Stati nascondono le stime crescenti dei suicidi. Giovani che sempre più non sanno cosa sia la Chiesa, anzi, che sempre più sono figli e nipoti di generazioni che non sanno più niente della religione.
Ma il dialogo intrapreso da Francesco da quel primo incontro sulla spiaggia di Copacabana si è fatto in questi anni serrato, spesso confidente, nel quale ai sermoni il Papa ha preferito domande e risposte a braccio come espressione di conversazioni dirette, di incontri. «Anche le migliori analisi sul mondo giovanile, pur essendo utili - sono utili -, non sostituiscono la necessità dell’incontro faccia a faccia. Parlano della gioventù d’oggi. Cercate per curiosità in quanti articoli, quante conferenze si parla della gioventù di oggi. Vorrei dirvi una cosa. La gioventù non esiste, esistono i giovani», ha detto di recente Francesco, tanto per essere chiaro. «Esistono le singole storie, i volti, gli sguardi, le illusioni, esistono i giovani... tu, tu.... Parlare della gioventù - ha ripreso in altra occasione - è facile: si fanno astrazioni, percentuali», invece «bisogna interloquire con loro», incontrarli «a tu per tu». Sono ormai decine i colloqui intrapresi non solo nell’ultima Gmg a Cracovia come in ogni viaggio apostolico nel mezzo delle crisi del mondo.
 Forse anche da questi dialoghi è nata la decisione di un Sinodo non su ma dei giovani, per andare insieme. Camminando in controtendenza ha aperto le porte. E ha rotto la divisione noi-voi:
Forse anche da questi dialoghi è nata la decisione di un Sinodo non su ma dei giovani, per andare insieme. Camminando in controtendenza ha aperto le porte. E ha rotto la divisione noi-voi:
 «Nella Chiesa - sono convinto - non dev’essere così: chiudere la porta, non sentire. Il Vangelo ce lo chiede: il suo messaggio di prossimità invita a incontrarci e confrontarci, ad accoglierci e amarci sul serio, a camminare insieme e condividere senza paura» ha ribadito anche nell’ultima riunione in vista del Sinodo di ottobre. «Questa riunione presinodale - ha aggiunto - vuol essere segno di qualcosa di grande: la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso.
E questo non per fare politica. Non per un’artificiale ’giovano-filia’, no, non per adeguarsi, ma perché abbiamo bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. Se mancate voi, ci manca parte dell’accesso a Dio».
«Nella Chiesa - sono convinto - non dev’essere così: chiudere la porta, non sentire. Il Vangelo ce lo chiede: il suo messaggio di prossimità invita a incontrarci e confrontarci, ad accoglierci e amarci sul serio, a camminare insieme e condividere senza paura» ha ribadito anche nell’ultima riunione in vista del Sinodo di ottobre. «Questa riunione presinodale - ha aggiunto - vuol essere segno di qualcosa di grande: la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso.
E questo non per fare politica. Non per un’artificiale ’giovano-filia’, no, non per adeguarsi, ma perché abbiamo bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. Se mancate voi, ci manca parte dell’accesso a Dio».E se ha tenuto conto di tutte le realtà, il Papa più volte ha ribadito la volontà di lasciarsi interpellare da loro e di vederli protagonisti: «Siamo insieme parte della Chiesa, anzi, diventiamo costruttori della Chiesa e protagonisti della storia. Ragazzi e ragazze, per favore: non mettetevi nella ’coda’ della storia. Siate protagonisti. Costruite un mondo migliore, un mondo di fratelli, un mondo di giustizia, di amore, di pace, di fraternità, di solidarietà».
Ma perché la richiesta di questo protagonismo? «In tanti momenti della storia della Chiesa, così come in numerosi episodi biblici, Dio ha voluto parlare per mezzo dei più giovani: penso, ad esempio, a Samuele, a Davide e a Daniele. A me piace tanto la storia di Samuele, quando sente la voce di Dio. La Bibbia dice: ’In quel tempo non c’era l’abitudine di sentire la voce di Dio. Era un popolo disorientato’. È stato un giovane ad aprire quella porta. Nei momenti difficili, il Signore fa andare avanti la storia con i giovani. Dicono la verità, non hanno vergogna».
 E se nella storia della salvezza il Signore si fida dei giovani, nell’incontro pre-sinodale del 19 marzo il Papa ha anche detto che il Sinodo di ottobre sarà anche un appello rivolto alla Chiesa, perché «riscopra un rinnovato dinamismo giovanile». Così come nell’udienza del gennaio 2017 ai partecipanti a un convegno dell’Ufficio Cei per la pastorale delle vocazioni aveva ripetuto che «sono le nostre testimonianze quelle che attirano i giovani. È la testimonianza: che vedano in voi vivere quello che predicate. Quello che vi ha portato a diventare preti, suore, anche laici che lavorano con forza nella Casa del Signore. E non gente che cerca sicurezza, che chiude le porte, che spaventa gli altri, che parla di cose che non interessano, che annoiano, che non hanno tempo... No. Ci vuole una testimonianza grande!».
E se nella storia della salvezza il Signore si fida dei giovani, nell’incontro pre-sinodale del 19 marzo il Papa ha anche detto che il Sinodo di ottobre sarà anche un appello rivolto alla Chiesa, perché «riscopra un rinnovato dinamismo giovanile». Così come nell’udienza del gennaio 2017 ai partecipanti a un convegno dell’Ufficio Cei per la pastorale delle vocazioni aveva ripetuto che «sono le nostre testimonianze quelle che attirano i giovani. È la testimonianza: che vedano in voi vivere quello che predicate. Quello che vi ha portato a diventare preti, suore, anche laici che lavorano con forza nella Casa del Signore. E non gente che cerca sicurezza, che chiude le porte, che spaventa gli altri, che parla di cose che non interessano, che annoiano, che non hanno tempo... No. Ci vuole una testimonianza grande!».Ritorniamo così all’inizio, all’incontro dei primi due discepoli con Gesù. Anche questa dinamica di come si diventa e si rimane cristiani percorre tutto il magistero di Francesco, ed è sempre la stessa - sempre nuova - che attraversa i tempi, le crisi e le generazioni, così che quell’episodio di Giovanni e Andrea raccontato a Copacabana è ripetuto ancora nell’ultimo intervento per il Sinodo di ottobre. E affinché l’assemblea non si trasformi in occupazione momentanea per monsignori forse sarà necessario non lasciarsi andare a una banale sociologia, e assumere invece queste intramontabili provocazioni evangeliche.
Sabato e domenica ci sarà l’incontro del Papa con i giovani delle diverse diocesi d’Italia. In molti sono già in cammino verso Roma per il pellegrinaggio, si parla di 40mila ragazzi. Marta, parte di un gruppo di universitari milanesi, parlando davanti a una pizza insieme agli altri dice che non le interessa niente dei discorsi sui giovani, e che non parte per sentire discorsi ma spinta da un incontro, che l’ha attirata e vuole vedere. Papa Francesco ha fatto sentire più volte come anche duemila anni fa un ragazzo e una ragazza, Giuseppe e Maria, hanno visto Dio con gli occhi e non in una visione mistica. Maria l’ha partorito, Giuseppe e lei lo hanno guardato. È iniziata così la storia cristiana. Sono stati lì a guardare Dio.
 Francesco ha messo bene in evidenza come sia la grazia che crea la fede. Per questo la vita cristiana è semplice. La fede è il riconoscimento di questa attrattiva, di un incontro. E la grazia crea la fede non solo quando la fede inizia ma per ogni momento in cui la fede rimane. In ogni momento, non solo all’inizio, l’iniziativa è Sua, dice sant’Agostino. Solo a partire da questo cuore la Chiesa ringiovanisce e attrae. Il prossimo incontro con i giovani a Roma, come anche il Sinodo, può essere l’occasione per chiedere, per ciascuno, che questo avvenga e continui ad accadere.
Francesco ha messo bene in evidenza come sia la grazia che crea la fede. Per questo la vita cristiana è semplice. La fede è il riconoscimento di questa attrattiva, di un incontro. E la grazia crea la fede non solo quando la fede inizia ma per ogni momento in cui la fede rimane. In ogni momento, non solo all’inizio, l’iniziativa è Sua, dice sant’Agostino. Solo a partire da questo cuore la Chiesa ringiovanisce e attrae. Il prossimo incontro con i giovani a Roma, come anche il Sinodo, può essere l’occasione per chiedere, per ciascuno, che questo avvenga e continui ad accadere.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA!
LA PAURA DI PENSARE E LA PARABOLA DEI TALENTI. Perché chiudere la nostra vita in una scatola?
I "DUE CRISTIANESIMI" E LA PROPRIA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. "Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- AL DI LA’ DEL ’FARISEISMO CATTOLICO-ROMANO’. L’esempio da dare (di Umberto Folena).7 agosto 2018, di Federico La Sala
AL DI LA’ DEL ’FARISEISMO CATTOLICO-ROMANO’, UN ESERCIZIO DI PARRHESIA EVANGELICA: PARLARE IN PRIMA PERSONA, E IN SPIRITO DI CARITA’....*
Dibattito pubblico e cattolici.
L’esempio da dare
di Umberto Folena (Avvenire, martedì 7 agosto 2018)
Dimmi contro chi sei, e ti dirò se hai ragione, se sei mio amico, se possiedi la verità. Dimmi non chi sei e con chi sei, per che cosa lotti, qual è la tua mèta, chi sono i tuoi fratelli. No. Dimmi invece chi bisogna combattere e annichilire, usando ogni mezzo, perfino la manipolazione e la menzogna. Per quanto triste sia, questo sta cominciando ad accadere in settori non solo della società italiana, ma anche del plurale mondo cattolico.
 Meglio parlare di "mondo" che di "comunità", perché quando ciò accade una comunità cessa di esistere, o almeno le manca l’aria ed entra in coma.
Meglio parlare di "mondo" che di "comunità", perché quando ciò accade una comunità cessa di esistere, o almeno le manca l’aria ed entra in coma.Tutto dipende da un equivoco sull’amore. Meraviglie e disastri sono causati dall’amore, diversamente interpretato. L’amore per la patria può tradursi in nobile patriottismo, ma anche in arido nazionalismo, o come si dice oggi in repulsivo sovranismo. In inclusione o in esclusione. L’amore è dono, libero di essere accettato o rifiutato; ma può anche mutarsi in possesso, privo di libertà, che sempre cova in sé una vena violenta.
Amore per Cristo, per la Chiesa. Per la verità (qui pudicamente con la minuscola), parola che racchiude, di volta in volta, il Vangelo o (più o meno) dettagliate norme morali; il comandamento che racchiude tutti gli altri, «Ama il prossimo tuo come te stesso», o infinite norme e codicilli. I guai cominciano forse proprio da qui, dal significato della parola amore.
I fratelli in Cristo, il popolo dei redenti, i battezzati non hanno mai, mai, mai avuto un unico pensiero su tutto lo scibile umano. Probabilmente ciò sarebbe disumano. Ma questo non dovrebbe comportare prendersi a parolacce, insulti, arrivando a dare dell’eretico perfino al Papa, con bombardamenti di citazioni più o meno dotte, raramente autorevoli, quasi sempre fuori contesto. Roba da appartenenti a una setta qualsiasi. Già, perché questo, per questa via, si rischia di diventare: un insieme di sette che "possiedono la verità" (ma non se ne fanno possedere), e insignorendosene la manipolano, la usano come un santo randello e restano imprigionati nelle (e dalle) loro costruzioni.
Restiamo tra i cattolici. Il problema è, oggi, soprattutto, nel modo in cui alcuni vivono la sacra missione, che si sono attribuiti da sé, di una apologetica del Terzo millennio. In genere l’apologetica, per affermare una verità, ha bisogno di muovere da un errore da confutare. Ottimo. Ma qui entra in gioco la qualità dell’interprete, se colto e raffinato e di fede generosa, oppure se schematico e banale. Nel secondo caso, la confusione è immediata: insieme al presunto errore si combatte il presunto errante; anzi, gli si dà addosso direttamente senza pietà, con una ferocia giustificata dal fatto che è nell’errore, e con chi sbaglia non si scende a patti: va spazzato via, con toni violenti e irridenti, e da parte dei più sbrigativi semplicemente appiccicandogli un epiteto, un’etichetta ritenuta infamante.
Anche Avvenire pare meritarsi sovente un simile "fraterno" trattamento, e chi fa un giornale mette in conto cose così, ma mai abbastanza.
Sfugge, infatti, a questi fratelli (e concittadini) che medium is the message, la forma è il primo contenuto; e i modi violenti, cattivi, feroci, sprezzanti, certo utilizzati per meglio condannare il presunto errore che è necessario combattere per affermare la presunta verità, rendono violenta e cattiva quella stessa "verità". I toni sprezzanti rivelano un’anima sprezzante. Simili toni, infine, convincono chi è già convinto, strappano applausi ai propri fan, ma non incidono minimamente sul cuore degli uomini che la pensano diversamente, sulla cultura del tempo, sui modi di pensare e di vivere.
A proposito dei fedeli laici che su singole questioni, anche politiche (a partire dalle migrazioni), maturano opinioni e passioni diverse, valga questa parola autorevole: «Cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso il dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo il bene comune». È il Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 43c *. E magari almeno il Concilio potesse essere una solida base comune a partire dalla quale, pur della diversità di accenti e sensibilità, dare al mondo esempio e testimonianza di fraternità. Il «dialogo sincero» non prevede odio e nemmeno disprezzo.
* "Semper autem colloquio sincero se invicem illuminare satagant, mutuam caritatem servantes et boni communis imprimis solliciti" (Gaudium et Spes, 43 c) [fls].
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
iL FARISEISMO CATTOLICO-ROMANO E LA NOVITA’ RADICALE DELL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA. PARLARE IN PRIMA PERSONA, E IN SPIRITO DI CARITA’.
VITA E FILOSOFIA. Per il ventennale della morte di Elvio Fachinelli (1928-1989).
 METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PIER ALDO ROVATTI INCONTRA ELVIO FACHINELLI.
METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PIER ALDO ROVATTI INCONTRA ELVIO FACHINELLI.DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Arcisenso di Aldo Masullo. La bellezza della paticità e la sapienza del relativo. Così ogni storia va ’sentita’ (di Silvia Lanzani).27 luglio 2018, di Federico La Sala
Arcisenso di Aldo Masullo. La bellezza della paticità e la sapienza del relativo. Così ogni storia va ’sentita’
di Silvia Lanzani (Nuova AGENZIA RADICALE, 18 Febbraio 2018)
Gli scenari si costruiscono sempre insieme, al plurale, sapendo tuttavia - come insegnava il Nolano - che ogni punto è ‘centro’. «Patico» è il modo umano della coscienza. Esso è in atto in ogni momento del Sentir-si. Le emozioni vi si umanizzano ed entrano nella “e-sistenza”. Così avviene il sempre nuovo cadere della coscienza fuori del proprio attuale con-sistere. In questo atto si coinvolgono non soltanto le emozioni ma qualsiasi vissuto. Ce lo insegna uno dei più grandi filosofi del nostro tempo, Aldo Masullo, 95 anni il prossimo 12 aprile, che firma uno straordinario testo filosofico, ‘L’Arcisenso. Dialettica della solitudine’ (Quodlibet, pp. 194, euro 17), nel quale il Professore emerito di Filosofia morale alla Federico II di Napoli reimpagina e approfondisce, con nuove e potenti riflessioni, i temi di una intera vita di ricerca filosofica, lasciando una traccia profonda, potremmo dire lavica amando la sua Napoli, negli studi sulla paticità.
Il percorso, infatti, da ’Paticità. L’intoccabile tocco’, a ’Grazia. Il repentino della poesia’, passando per ’Dolore. La scelta di Chirone’, ’Eraclito. il desiderio eroico’, ’Leopardi. Sentire corporalmente il pensiero’, ’Silenzio. L’indecenza della parola’ e ’Sapienza. Nel relativo è la salvezza’. Preziosa anche l’Appendice ’Nel labirinto della soggettività. Appunti per un’autobiografia filosofica’ e, non ultimo, un autentico ’tocco’ di stile con il ’ringraziamento’ ai suoi allievi migliori - migliaia nel tempo - a iniziare da Giuseppe Cantillo e Bianca Maria d’Ippolito, fino ai dialoghi con amici come Matteo Palumbo e Gerardo Picardo.
Per Masullo non solo non vi sono piacere o dolore, ma neppure ragionamento o azione, immaginazione o ricordo, che siano umani, se non sono sentiti, se non recano, sia pure nascosti ma sempre pronti a saltar fuori o almeno a far capolino tra le pieghe del vivere, «lo stupore con cui si manifesta il sé» e «l’angoscia dell’esser toccati da eventi, senza perché». Ogni accadere tocca a me, proprio a me, senza che io sappia perché, così come non so questo me donde venga né dove vada, anzi neppure perché mai proprio a me questo me sia toccato.
Con l’accadermi, la coscienza di me ancora una volta cade fuori del suo con-sistere, e proprio in ciò io e-sisto. Sensus non c’è, se non è sensus sui. Lo stesso sé in nient’altro consiste che nel sensus sui, nel sentimento di sé, nella tensione verso sé come verso l’unità che si ha l’impressione di essere. Esso non è né «prima» né «dopo» questo o quel sentire, ma è sempre di ogni sentire la condizione originaria. Un filosofo tedesco lo chiamerebbe Ursinn. Masullo lo definisce «Arcisenso».
L’avvertimento del sé muove dall’intimo della vita, che nell’individuo umano, sentendo-si, vive. La vita ogni volta accade, e accade in quanto accade al sé che la vita allucina - ad un sé a cui l’accadere tocca, quasi il sé fosse prima dell’accadere, il vissuto fosse prima e non a partire dalla vita vivente. Se una differenza non colpisse, il sé non apparirebbe; né il colpo della differenza, il tempo, apparirebbe senza un sé colpito. Si tocca così la falda più profonda della fenomenalità di ogni fenomeno, il fenomeno primario con cui s’inaugura la possibilità stessa dell’apparire e senza di cui nessun altro fenomeno sarebbe possibile. «Fenomeno» è il calco italiano del greco φαινόμενον, participio del verbo deponente φαίνεσθαι, che in greco vuol dire «apparire», «manifestarsi».
Il φαινόμενον è l’«apparente», il «manifestantesi», cioè l’apparire, il manifestarsi, nel momento stesso in cui appare, si manifesta. È impersonale, senza soggetto, atto con cui tutto appare, tutto si manifesta, il mondo delle cose e di chi le vede e le usa. Il manifestarsi è tutto. L’apparire, il manifestarsi, è puro accadere o, come pur si dice, evento.
Nel vissuto del tempo e del sé, l’emozione di sorpresa nel sentire come contingente l’accadere e l’emozione di angoscia nel sentire come precario il sé strettamente si tengono. Senza il dolore che l’infallibile arciere del tempo infligge, non emergerebbe il sé come il vivente bersaglio di questa offesa. Ma, se il sé non emergesse, il colpo del tempo cadrebbe nel vuoto o riuscirebbe frustrato.
La vita fa come una piega - si «ri-piega su di sé» - . In ciò sta il punto d’origine della fenomenalità, là dove il vivente si converte in umano e si apre a se stesso, si fa soggettivo. La vita stessa si duplica (si complica nel «vivere il proprio vivere», come letteralmente suona il tedesco er-leben), e vivendo prova l’emozione di sé.
Avviene appunto quel che si esprime con il verbo πάσχειν, che vuol dire «patire», non necessariamente nel senso della sofferenza, ma in quello ampio del «provare», cioè del «vivere» usato transitivamente, come nelle espressioni «ho vissuto un brutto momento» e «ho vissuto una bella esperienza». Radice del verbo πάσχειν è παθ, da cui si forma il sostantivo πάθος: il calco italiano ne è «pathos» o più correntemente «patos». Il primo significato di πάθος è «ciò che si prova di bene o di male», in breve il vissuto. Si designa con ciò un’emozione sofferta, umanizzata dalla coscienza del sé.
Al fondo di ogni vissuto sta una rottura. La vita è un incessante rompersi, anche se abitualmente inavvertito. Quando il rompersi è violento e inabituale, l’in-differenza dell’essere esplode nella differenza dell’e-sistere. E’ questo il «repentino» (il platonico ἐξαίφνης). Esso scopre l’inarrestabile passo del cambiamento, ciò che «noi per abitudine chiamiamo tempo».Si mostra qui l’umanità originaria dell’emozione, la falda profonda di ogni emozione propriamente umana. Ci si trova, per essa, presi nella dinamica esistenziale, in cui non soltanto le emozioni occasionali, ma tutti i vissuti, anche quelli intenzionali e semantici, cioè gli sguardi sulle cose e la nominazione di queste, si costituiscono nella loro fenomenalità, nella loro umanità di vissuti. Solamente nel patico si e-siste.
Il sentir-si non è soltanto dell’emozione, ma di qualsiasi vissuto. Non solo non vi sono piacere e dolore, ma neppure percezione e ragionamento, immaginazione e ricordo, che siano tali, umani, se non sono intrisi di sentir-si, se non recano, sia pure nascosti ma sempre pronti a saltar fuori o almeno a far capolino tra le pieghe di qualsiasi atto del vivere, «lo stupore con cui si manifesta il sé» e «l’angoscia dell’esser toccati da eventi, senza perché». Ogni accadere tocca a me, proprio a me, senza che io sappia perché, così come non so questo me donde venga né dove vada, e neppure perché proprio a me questo me sia toccato.
Con l’«accadermi» la coscienza di me ogni volta salta fuori del suo con-sistere, e proprio in ciò io e-sisto. Essa qualifica il vissuto, il riferimento esplicito o implicito a un sé, coscienza riflessiva, autocentrata ancora prima che nella pubblicità della forma linguistica «io» e nella determinazione dialogico-concettuale. Insomma, se il vissuto è l’evento propriamente umano, la paticità è il nucleo intimo del vissuto, la fenomenalità di ogni fenomeno, l’arcisenso.
All’autocentramento però concorrono non soltanto la folgorante emozione del tempo, sofferto trauma della differenza, con la sua oscura figura del sé, ma pure la bruciante inquietudine dell’incontro con l’altro, il tacitamente interpellante, a me familiare o estraneo, seducente o minaccioso, comunque sempre enigmatico, tra me e lui reciprocità interiormente vissuta di speculari rimandi simpatetici o antipatetici. Nell’incontro, in ogni uomo l’immagine dell’altro lo anima del suo sé, e questa a sua volta intanto corrobora il sé di lui e lo arricchisce di tocchi. In questo vivo gioco di reciprocità ognuno si sovradetermina, enfatizzando sé come io e l’altro come tu.
L’emozione, in cui consiste il tempo, l’avvertimento «destabilizzante» di repentini cambiamenti, l’irrompere della differenza in noi, frantuma l’inerte identità dell’ente, ne distrugge l’apaticità, mette in moto la dialettica dell’altro nel sé di ognuno, e di ognuno nel sé dell’altro. La paticità è costitutiva dell’e-sistenza. Nella vertigine patica, sotto l’imperio del tempo, ci si ritrova comunque sempre da capo presso ad una soglia del nuovo, soli nel deserto di un assoluto «inizio». Tutto si ripete, nulla dura. Si danno infinite repliche, ma nessuna identica.
Il vissuto di tempo si rifrange nei molteplici cromatismi emotivi: nella sofferenza per l’identità perduta e l’abitualità sconvolta, nel tremore del destino incombente, nella insicurezza del rapporto con l’altro. Ma esso intero fiammeggia nell’inquietante sfida dell’inizialità, nel muoversi verso il nulla, il vuoto del futuro, a partire dal nulla, dal vuoto del passato. Nella paticità ogni volta, al centro della vita, le occasionali emozioni si “umanizzano”, da fatti naturali si ri-generano in prove umane. In umana anzi si ri-genera la vita tutta, da semplice vita vivente convertendosi in vita vissuta.
Nell’esplosa drammaticità dell’e-sistenza, l’oscuro avvertire che l’identità della coscienza di sé dura solo attraverso la difficile prova del suo incessante perdersi scatena l’emozione originaria, il vissuto decisivo. La morte non è che il caso estremo, la chiusura di partita, di tutte le infinite morti per cui la vita, che è «tempo» ma più propriamente l’incessante cambiamento delle cose (il sempre nuovo irrompere della differenza), fatalmente patisce la sua intrinseca precarietà non solo, dalla parte del dopo, nella straordinaria tragicità della catastrofe finale quanto pure, dalla parte del prima, in certa ordinaria catastroficità del quotidiano.
L’Arcisenso è impenetrabile, ma penetra di sé ogni esperienza. Esso contrasta l’intersoggettività, la relazione d’ogni singolo con gli altri, e tuttavia è condizione necessaria della sua possibilità. È evidente che il principio antropologico - l’idea con cui si comprende il senso di essere «uomo» -, si muove in un circolo. Punto di partenza e punto d’arrivo è sempre la relazione, ma in due versioni diverse. Tra il primo e il secondo funziona una cerniera, un medio: la solitudine. Questa può essere puro sentire o ragionata consapevolezza, ma è comunque paticità del sentir-si. Essa non sarebbe chiaramente e dolorosamente presente senza l’io, che si costituisce nella relazione, a cominciare dalla simbiosi bambino-madre.
A sua volta, senza la patita coscienza della solitudine, della propria separante differenza e unicità, cioè dell’irriducibile esclusività del proprio punto di vista, neppure esisterebbero la pluralità degli individui e la relazione sociale che ognuno d’essi strenuamente e in vari modi persegue, affaticandosi a costruire sistemi di comunicazione con altri soggetti-persone.
Senza l’incontro di un vivente con altri, nessun vissuto si avrebbe. I fenomeni patici e le fenomeno-patie non si originerebbero senza il gioco di una pluralità di viventi. L’ «universalità» della «verità» e dei «valori» in genere non se ne potrebbe generare nell’indifferenza. Essa può dischiudersi soltanto con il crescere dei vissuti nell’assidua e vivente reciprocità della «cura», nell’illimitato complicarsi delle relazioni sin-patetiche; nel sempre nuovo incrociarsi di Aufforderungen («appelli», «pro-vocazioni», «inviti»), come genialmente proponeva Fichte nel dedurre il fondamento intersoggettivo della soggettività e nell’annunziare con esso il significato nuovo dell’universalità dello «spirito».
Pensare l’assoluto non della morte, il nulla, ma della vita, è pensare la relazione, l’illimitata relazione di relazioni. Etico, o più propriamente ’path/ethico’, è il pensiero che, coltivando la sapienza del relativo, ci mantiene nella vita. Liberi.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA "TEOLOGIA" DELL’ELLISSE (DEI "DUE SOLI"). Johannes Keplero. Com’è armonico il mondo (di Franco Giudice).22 luglio 2018, di Federico La Sala
LE ILLUSIONI DEL "CERCHIO INCANTATO" E ... LA "TEOLOGIA" DELL’ELLISSE (DEI "DUE SOLI")
- «L’orbita descritta da un pianeta è un’ellisse, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi » (Keplero, Prima Legge - Legge delle orbite ellittiche, 1609) *
Johannes KepleroCom’è armonico il mondo
Cade quest’anno l’anniversario della scoperta della terza legge dei moti planetari. Ma il senso delle sue opere era proclamare la gloria di Dio studiando la natura
di Franco Giudice (Il Sole-24 Ore, Domenica, 22.07.2018)
I libri, si sa, vanno quasi sempre incontro a un destino che si cura assai poco delle intenzioni di chi li ha scritti. Una volta pubblicati, prendono la loro strada e finiscono irrimediabilmente in balìa dei lettori, che se ne appropriano spesso in modo selettivo. Non stupisce quindi che l’Harmonice mundi (1619) di Johannes Keplero sia oggi ricordata soltanto perché vi si trova esposta la terza legge dei moti planetari, di cui proprio quest’anno ricorre il quarto centenario della sua scoperta, avvenuta il 15 maggio 1618. Esattamente come la sua opera precedente, l’Astronomia nova (1609), è nota per l’enunciazione delle prime due leggi, quelle cioè che stabiliscono che i pianeti si muovono lungo orbite ellittiche e che con i loro raggi condotti verso il Sole descrivono aree uguali in tempi uguali.
Sembra insomma che il senso e il valore delle opere di Keplero siano compendiati nelle tre leggi che portano il suo nome e che tutti abbiamo imparato a scuola. Come se fosse irrilevante che il loro autore le avesse invece originariamente concepite per altre e ben più elevate ragioni: proclamare la gloria di Dio attraverso lo studio della natura.
Un destino un po’ beffardo, non c’è che dire. Ma di cui forse Keplero non si sarebbe rammaricato più di tanto, poiché da buon protestante, che da giovane voleva diventare un pastore luterano, lo avrebbe interpretato come l’esito del disegno imperscrutabile della volontà divina.
Sono tuttavia convinto che una lettura così riduttiva delle sue opere, oltre a essere decisamente anacronistica, ne trascuri l’imprescindibile retroterra spirituale. Ma questo dipende anche, e soprattutto, dal diverso punto di vista che distingue lo storico della scienza dallo scienziato di professione.
Se è vero infatti che Keplero fu uno degli astronomi più dotati che la storia abbia mai conosciuto, lo è altrettanto che a guidare gli sviluppi delle sue ricerche fu sempre una profonda devozione religiosa. Che emerge fin dal Mysterium cosmographicum (1596), la sua prima pubblicazione, dove dimostrava con estrema audacia come la necessità del sistema copernicano scaturisse direttamente da Dio, che aveva creato l’universo attraverso l’armonia dei cinque solidi regolari della geometria euclidea. E che prorompe come un’esigenza insopprimibile anche dalle pagine dell’Harmonice mundi che annunciano la scoperta della terza legge dei moti planetari.
Era appunto il 15 maggio 1618. Un giorno memorabile per Keplero, che stava finendo di scrivere il libro, gran parte del quale era già in corso di stampa. Aveva aspettato questo momento per ben ventidue anni, e ora un’illuminazione improvvisa dissolveva le tenebre dalla sua mente, facendogli perfino temere di essere vittima di un sogno. Ma non c’erano dubbi: «È cosa certissima ed esattissima che il rapporto che esiste tra i tempi periodici di due pianeti qualsiasi è precisamente nel rapporto della potenza 3/2 delle loro distanze medie». Ovvero, nella formulazione più usuale, il rapporto tra i quadrati del periodo di rivoluzione di due pianeti è uguale a quello tra i cubi della loro distanza media dal Sole.
La scoperta della relazione tra le distanze e i periodi dei pianeti si era dunque rivelata a Keplero proprio mentre stava ultimando l’opera che considerava il culmine della sua carriera scientifica. Un fatto che lo aveva letteralmente mandato in estasi, in preda a un «sacro furore», al punto che non gli importava se a leggerla sarebbero stati i suoi contemporanei o i posteri. Poteva benissimo aspettare cent’anni i suoi lettori, «se Dio stesso aveva atteso seimila anni il Suo contemplatore».
Eppure, per quanto strano possa sembrare, soprattutto di fronte ad affermazioni così entusiastiche, questa legge non gioca affatto un ruolo centrale nell’astronomia dell’Harmonice mundi. Per Keplero, quella che noi chiamiamo «terza legge» - ma che lui, al pari delle altre due, non definì mai in tali termini, né tanto meno le diede alcuna numerazione - esprimeva semplicemente uno dei tanti rapporti celesti riscontrabili nell’armonia dell’universo. Un’armonia inoltre che rispecchiava i principi della consonanza musicale, che indicava lo stretto legame tra Dio e la sua creazione, e che si poteva scorgere in ogni parte del cosmo. Un’armonia infine che si trovava impressa come un archetipo negli esseri umani, i quali, essendo plasmati a immagine di Dio, erano quindi in grado di apprezzarla, anche se ignoravano le proporzioni geometriche da cui essa discendeva.
L’idea di scrivere sull’armonia universale risaliva al 1599. A incoraggiare Keplero nell’impresa aveva contribuito anche la recente lettura dell’Armonica dell’astronomo alessandrino Tolomeo, che confermava la sua convinzione che il cosmo fosse governato da un’armonia musicale. Ai suoi occhi, tutto ciò non poteva essere soltanto un caso: se la segreta natura dell’universo si andava rivelando a due uomini separati da una distanza di quindici secoli, voleva dire che «c’era il dito di Dio». Può darsi. Sta di fatto che durante i vent’anni in cui Keplero inseguì il suo progetto, la vita gli aveva fornito ben pochi segni di una divinità armonica e benevola.
Certo, i dieci anni trascorsi a Praga, dove nel 1601 era succeduto al grande astronomo danese Tycho Brahe nel ruolo di matematico dell’imperatore Rodolfo II, furono alquanto sereni e tra i più fecondi della sua attività scientifica, facendogli ottenere importantissimi risultati nel campo dell’astronomia e dell’ottica. Ma prima e dopo, era stato tutto un susseguirsi di incredibili tragedie personali e professionali. Il 1599, proprio l’anno in cui concepì l’idea dell’Harmonice mundi, coincise con la prematura scomparsa della sua secondogenita, che aveva soltanto trentacinque giorni. Nel 1611, quando la situazione politico-religiosa a Praga lo aveva costretto a trasferirsi a Linz, aveva assistito impotente alla morte di un altro suo figlio e della prima moglie Barbara. Tra il 1617 e il 1618, in poco meno di sei mesi, aveva perso i due bambini avuti dalla seconda moglie Susanna. Come se non bastasse, nel 1615 la madre Katharina era stata accusata di stregoneria e Keplero dovette assumerne la difesa legale per i successivi sei anni.
L’Harmonice mundi fu completata il 27 maggio 1618, dodici giorni dopo la scoperta della terza legge. La sua famiglia era stata letteralmente decimata e il mondo che lo circondava stava precipitando nel disordine. Ma da uomo dalla fede incrollabile, Keplero vedeva nell’armonia celeste la più alta manifestazione della saggezza di Dio. E dedicava l’opera a Giacomo I Stuart, nella speranza che il sovrano che aveva riunito le tre corone d’Inghilterra, Scozia e Irlanda, potesse usare gli esempi della gloriosa armonia di cui Dio aveva dotato la sua creazione per portare altrettanta armonia e pace tra le chiese divise. Si trattava però di una pia illusione: soltanto quattro giorni prima, il 23 maggio 1618, la rivolta boema con la celebre defenestrazione di Praga segnava l’inizio della guerra dei Trent’anni, una delle più lunghe e sanguinose della storia europea.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
PIAZZA SAN PIETRO: LA "TEOLOGIA" DELL’ELLISSE (DEI "DUE SOLI") E LE ILLUSIONI DELLA "TEOLOGIA" DEL "CERCHIO INCANTATO" (DELLA SCOLASTICA "CATTOLICA" E DELLA "SAPIENZA" RATZINGERIANA). IL DARSI DELLE COSE: LA LEZIONE DI HUSSERL.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA. Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --Noi dobbiamo avere - ragazze ribelli che non si adeguano. Un’intervista a Rita Segato (di Paola Rudan).6 luglio 2018, di Federico La Sala
Ragazze ribelli che non si adeguano.
Un’intervista a Rita Segato
di PAOLA RUDAN (SConnessioni precarie, 06.07.2018)
- Una versione abbreviata di questa intervista è stata pubblicata su «Il Manifesto» del 5 luglio 2018.
L’intervista è stata realizzata lunedì 2 luglio a Bologna, durante la Summer School «The Human in Question», organizzata dall’Academy of Global Humanities and Critical Theory, dove Rita Segato ha tenuto un corso intitolato Race Patriarchy in the Light of the Perspective of the Coloniality of Power e mercoledì 4 luglio, insieme a Paola Rudan, ha partecipato, presso la Biblioteca dell’Archiginnasio, a un Dialogue on Ni una Menos. Il 5 luglio, l’antropologa latinoamericana sarà presente - insieme a diverse attiviste provenienti da Argentina, Ecuador, Messico e Colombia, all’assemblea organizzata da Non una di meno Bologna e Ni una Menos Argentina su La struttura della violenza patriarcale. Razzismo, precarietà e giustizia femminista.
***
Vorrei partire dalle immagini di un milione di voci che esultano di fronte al Congresso Argentino il 14 giugno, quando è stata data la media aprobación alla legge sull’aborto. La mobilitazione per l’aborto libero, sicuro e gratuito è cominciata molti anni fa, ma solo ora ha conquistato la forza necessaria a conseguire questo risultato storico, benché ancora parziale. Da che cosa dipende secondo te questo salto in avanti, pensi che abbia un rapporto con la lotta contro la violenza patriarcale che in America Latina, come in tutto il mondo, le donne hanno portato avanti con crescente intensità negli ultimi anni?
La mobilitazione per l’aborto va avanti da molti anni, ha coinvolto donne ‒ come Martha Rosenberg e Nelly Minyersky ‒ a cui bisogna rendere onore per avere portato avanti questa lotta così a lungo. Ci sono le socorristas, un gruppo molto importante di donne che aiutano altre donne a praticare l’aborto, un gruppo molto ben organizzato. È importante ricordarle in questo contesto. Queste donne, le mujeres soccorristas, non condividono l’idea di un «diritto» all’aborto, perché la loro pratica è la disobbedienza, ed è più complicata. All’interno del movimento ci sono state delle rotture e dei conflitti, proprio perché alcune non volevano una «concessione» da parte dello Stato, affermavano semplicemente di praticare l’aborto e così facendo esprimevano il loro sospetto verso lo Stato. Questo lo comprendo. Ma nella situazione presente le donne colgono ogni occasione per unirsi. La battaglia per l’approvazione dell’aborto alla Camera - e la legge deve ancora passare dal Senato - è stata un modo per unirsi e mostrarsi insieme di fronte allo Stato e alla società. L’aborto è una pratica importante, la proibizione e la criminalizzazione dell’aborto sono uno stupro di Stato, perché tu hai nel tuo corpo un pezzo di carne che non è tuo e che non vuoi, questo è stupro. Obbligarti a tenerlo è uno stupro di Stato. Questo è un argomento cruciale. Ma nel femminismo c’è stata una divaricazione in relazione all’importanza dello Stato e alla possibilità di esercitare la tua libertà senza il permesso dello Stato. È una questione complicata, ma adesso le donne sono tornate insieme e ogni occasione che riguarda loro e il loro corpo è un’occasione per mostrarsi insieme, perché sono già organizzate e questo è fondamentale. Quello che non deve essere dimenticato è anche che in Argentina negli ultimi trent’anni c’è stato un costante incontro tra le donne. Quando il 3 giugno del 2015 c’è stata la prima grande manifestazione, e poi con lo sciopero dell’8 marzo, le manifestazioni sono diventate moltitudinarie, ma questo è stato anche dovuto anche all’importanza crescente che per trent’anni hanno avuto questi incontri, senza partiti, senza associazioni, senza un’egemonia. È un movimento senza egemonia e questa è la storia veramente importante che confluisce oggi nelle manifestazioni delle donne. Ora è davvero visibile, ma non è del tutto nuovo.
Il dibattito e la divaricazione di cui parli hanno avuto luogo anche in Italia negli anni ‘70 a proposito della legge sull’aborto che è stata approvata nel 1978. Alcune femministe sostenevano di non volere una legge che lo regolasse, ma solo una liberalizzazione e depenalizzazione, perché vedevano lo Stato come parte del problema patriarcale. E in effetti la legge sull’aborto dichiara per esempio che la maternità è un «valore sociale», non una possibilità tra le altre per le donne, e in questo modo definisce un loro specifico ruolo. Ma questo movimento di massa che tiene insieme milioni di donne e non solo donne sta anche aprendo una breccia in un ordine come quello neoliberale, di cui il governo di Macri è espressione, che semplicemente rifiuta di accettare qualsiasi istanza collettiva proveniente dalla società, da donne, precari, migranti. Il fatto che un movimento sociale ottenga qualcosa forse è già di per sé importante, un cambiamento rispetto alla percezione di una completa assenza di ogni possibilità di cambiamento.
La cosa importante è il processo che porta le donne a unirsi, a stare insieme, e in questo la legge sull’aborto è un’opportunità di diventare visibili a se stesse, di far crescere una pratica che stabilisce dei vincoli. C’è la produzione di una cultura che riguarda il modo di fare le cose, che nasce dalla pratica dello stare insieme nei luoghi pubblici. Il processo è la dimensione più importante di quello che sta succedendo, forse anche più importante del risultato. Si dà vita a un modo di stare insieme, un modo di costruire una vita insieme. In questo senso penso che il processo sia la cosa più importante. Le manifestazioni delle donne sono completamente diverse da quelle degli uomini, dei sindacati, dalle manifestazioni politiche intese in senso convenzionale. Non appaiono allo stesso modo, non sono sentite nello stesso modo, non funzionano nello stesso modo, c’è un diverso modo di apparire e di fare, una diversa atmosfera delle donne che marciano insieme. Il risultato è importante, ma bisogna focalizzarsi sul processo.
Ho ascoltato il dibattito parlamentare prima del voto sulla legge...
Vergognoso per molti versi...
Sì, davvero. Quello che ho notato è che ci sono stati anche rappresentanti dei partiti di sinistra che si opponevano all’aborto. Per esempio i peronisti che dicevano che siccome la povertà impedisce a molte donne di avere figli, bisogna opporsi all’aborto e rivendicare la maternità contro la povertà, e questa posizione è stata sostenuta anche da molti curas de villeros, ma allo stesso tempo persino i conservatori dovevano ammettere che quello che stava succedendo per strada, un milione di persone, Ni una menos, lo sciopero delle donne, tutto questo non poteva essere ignorato. La cosa che mi pare importante, per chiarire quanto dicevo prima, è la percezione che si sia accumulata una forza tale da poter pensare di cambiare le cose, una forza che non può essere ignorata in un’epoca in cui sembra che niente possa essere cambiato, che il proprio destino sia una sorta di condanna. Questa presa e manifestazione di forza mi pare fondamentale per sostenere il processo di cui parli.
Una delle cose che possiamo imparare è che se partiamo dalle questioni che le donne pongono, dalla posizione delle donne, noi possiamo vedere la storia in un modo radicalmente diverso. I peronisti alla fine hanno votato come dovevano, ma all’inizio il movimento justicialista aveva dichiarato che avrebbe votato contro. Qui si vede un modo di fare politica tradizionale che è stato spazzato via, che ha perso il suo significato. Ci ho pensato molto; questo dibattito mostra precisamente che un momento nuovo sta cominciando. Quando vedi che c’è un rimescolamento complessivo della scena politica, della politica tradizionale di destra e di sinistra a partire dalle istanze femministe. Ci sto ancora riflettendo, ma mi torna in mente il dibattito costituzionale brasiliano del 1998, quando una ONG femminista ha realizzato un’inchiesta con i membri del Parlamento a proposito del disegno di legge costituzionale. In questo disegno c’erano cose positive per le donne, come l’abolizione della patria potestà e anche aperture sull’aborto - queste però non si sono realizzate - e la grande sorpresa è stata che alcuni partiti comunisti, membri del parlamento, esponenti della sinistra, si sono opposti a queste misure, mentre alcuni della destra tradizionale le hanno sostenute. Era solo un’analisi delle dichiarazioni di voto, ma mi ha sorpresa moltissimo che parte della sinistra tradizionale fosse contro le donne e che la destra avesse improvvisamente posizioni illuminate. Questa è una storia ormai lontana, ma oggi sta avvenendo qualcosa di simile. E io credo che abbia anche a che fare con il fatto che i voti sono stati dichiarati a partire da posizioni di partito, che dovevano essere affermate come tali, senza nessuna autonomia. E d’altra parte questo è il problema della politica rappresentativa come tale. Quello che ha caratterizzato la politica tradizionale è stata l’idea di accumulare forza per prendere il potere statale e da lì cambiare le cose. Ma bisogna considerare questa storia come uno specchio per capire che questa politica è fallimentare. Il mio sogno è una politica senza egemonia. Il mio maestro, Anibal Quijano, che ha avuto su di me una grande influenza, mi ha sempre detto «non parliamo dei movimenti sociali, ma dei movimenti della società». Questa cosa per me è fondamentale, questa politica della società, questo rimescolamento della società. Ho una specie di fede storica che mi dice che nessuno cattura la storia, nessuno la controlla, che la storia procede. L’idea della sinistra tradizionale di accumulare forza per poi metterla in una specie di camicia di forza ha fallito troppe volte e dalla storia dobbiamo imparare. Dobbiamo nutrire tutti i movimenti che nella società producono incertezza, indefinizione, e la sinistra non è nella condizione di farlo, non sono in grado di cogliere l’incertezza come qualcosa di positivo. E questo è un modo femminile di guardare alla storia. Perché è un modo pragmatico, pratico, ha a che fare con la capacità di improvvisare per riuscire a difendere la vita, è qualcosa di topico e non utopico. È difficile per me esprimermi anche perché cerco, mentre penso, di creare le parole che permettano di vedere la storia in modo completamente differente. Io credo che l’utopia abbia un carattere autoritario e che l’unica utopia ancora viva sia l’utopia dell’incertezza, della struttura tragica della storia, e la sinistra non è in grado di vederlo. Le donne lo stanno facendo.
Penso però che sia possibile pensare l’egemonia in un modo che non ha a che fare con la tradizionale politica dei partiti. Le donne ci sono sempre state, hanno sempre portato avanti le loro pratiche, ma quello che sta succedendo ora non si radica semplicemente nelle pratiche quotidiane. Possiamo dire che sono state storicamente costrette a occupare una certa posizione e fare determinate cose e che ora stanno partendo da quella posizione per realizzare un cambiamento. Ma solo ora, proprio perché si stanno mobilitando in massa, perché si stanno organizzando come tu stessa hai detto, le cose stanno cambiando. E questo evidentemente mette radicalmente in questione le modalità note di organizzazione, non c’è un percorso già scritto...
A me pare che ci sia una sorta di politica gestionale che le donne stanno praticando, anche nel modo in cui comunicano globalmente, il che vuol dire non avere soluzioni ma domande, la certezza dell’incertezza, accettare l’idea dell’instabilità dell’adesso, dell’attualità radicale. La critica dell’utopia, che ci ha portati nella storia a troppi errori, mi pone il problema di come comportarmi qui e ora. L’utopia non permette di pensare il presente. Le donne hanno una storia. Che cosa significa essere una donna? Significa avere una storia differente, non ha a che fare con la biologia. Quelli che dicono di non parlare del «genere» non considerano che è il termine che abbiamo scoperto per affermare che il nostro corpo non ci identifica, mentre d’altra parte i corpi hanno una storia che è estremamente complicata perché non è sempre la stessa. Per le popolazioni indiane il corpo non significa la stessa cosa che in Occidente, per esempio. Per le popolazioni indiane il femminile non deve essere incarnato in un corpo di un certo tipo, è una posizione, un ruolo, riguarda la divisione sessuale del lavoro. Essere donna oggi significa recuperare una storia che nel transito alla modernità è stata censurata, si è cancellata la storia politica della posizione femminile. Queste mobilitazioni femministe in un certo senso stanno recuperando il senso di quella storia, stanno facendo esplodere il senso della politicità domestica che ci hanno obbligato a dimenticare. Lo stile della politica femminile che nel transito alla modernità abbiamo dimenticato. E questo modo di fare politica con uno stile femminile è qui e ora. Dobbiamo recuperare la topicità più che l’utopia. La modernità è un modo di essere futurista, perché il futuro dà valore al presente, ma questo non è parte della storia femminile per come io la concepisco.
Ho qualche difficoltà a trasformare la storia in uno «stile». Credo sia importante pensare il «femminile» come una posizione che deve essere storicizzata, ma nell’atto di politicizzare questa posizione si esprime un atto di liberazione dalla storia che ci ha oppresso, ed è un atto che apre il futuro come possibilità di essere libere. Non sappiamo come questo avverrà, ma forse possiamo dire che questa pratica di libertà non è individualistica. Questo movimento coinvolge gli individui imponendo una trasformazione soggettiva, ma quello che è nuovo è che non stiamo reclamando una libertà per noi come individui o come donne, ma una libertà contro l’oppressione, per noi e per gli altri che sono oppressi...
Sì c’è la pretesa che quello che noi cambieremo cambierà tutto. Non mi piace la parola nemico - anche se abbiamo dei nemici - ma ci sono antagonisti del nostro progetto storico che lo sanno e da qui viene il cascame fondamentalista, l’opposizione a quella che chiamano «ideologia del genere», perché riconoscono l’importanza di quello che noi stiamo facendo. E quindi reagiscono, reagiscono contro questo movimento, contro il movimento delle donne, LGBTQI, perché vedono che è una minaccia. Capisco la tua preoccupazione, ma dobbiamo trattenerci da questa preoccupazione. Siamo stati addestrati così a fare politica dall’Occidente ‒ e tutti abbiamo imparato a fare politica dall’Occidente, quella sindacale, quella rappresentativa, la rivoluzione comunista, il movimento nero o quello LGBTQ ‒ e questo impone un carattere coloniale ai movimenti sociali. Il problema è proprio che il modo Occidentale di fare politica riguarda il controllo. C’è qualcosa che queste donne mostrano nelle strade ed è il rifiuto del controllo, il rifiuto dell’egemonia, il fatto che le cose si giocano da sole e trovano il proprio posto da sole, la società deve cambiare e sta cambiando, ma se pretendi di controllare questo processo compi un gesto patriarcale.
- [seconda parte - nel post successivo]
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Noi dobbiamo avere - ragazze ribelli che non si adeguano. Un’intervista a Rita Segato (di Paola Rudan).6 luglio 2018, di Federico La Sala
Ragazze ribelli che non si adeguano. Un’intervista a Rita Segato....
- [continuazione - seconda parte]
A proposito di questo cambiamento, nei documenti dello sciopero femminista, in ogni paese, non ci sono solo rivendicazioni delle donne come donne, ma la libertà di movimento per donne e uomini migranti, la fine del debito, la lotta contro la precarietà, e tutto questo è messo in relazione con la violenza patriarcale. Questo è un modo di concepire questa lotta parziale come una lotta che ha valore generale. Allora mi chiedo come si stanno costruendo concretamente queste connessioni.
Queste rivendicazioni sono presenti in tutte le manifestazioni, che denunciano la fine di ogni oppressione, e io le condivido, ma sono poste in modi diversi, ogni cosa ha una forma diversa. Nei movimenti per l’uguaglianza degli anni ‘60 e ‘70, i movimenti della sinistra insorgente in America Latina da cui provengo io e le persone che mi sono vicine, c’erano rivendicazioni simili, ma oggi sono pronunciate in modo diverso. Perché l’oppressione delle donne è la prima scuola di tutte le altre oppressioni. A Buonaventura, nella Costa pacifica della Colombia, ci sono bande di sicari che uccidono le donne, e non solo le donne, in modo estremamente brutale per «ripulire» la terra e fare strada agli investimenti immobiliari, per costruire nuovi porti, hotel eccetera. Il porto di Buenaventura è un porto particolarmente importante per il commercio nel Pacifico, e quindi bisogna ripulire il territorio. Non puoi mettere fine a questa guerra contro le donne con un trattato tra le Farc e lo Stato, perché lo Stato è parte del gioco e lo sostiene anche se informalmente. E allora mi sono chiesta come si pone fine a questa situazione se non smantellando il «mandato di mascolinità», perché è questo che sta alla base del reclutamento degli uomini che ingaggiano questa guerra. Il mandato di mascolinità però fa male agli uomini come alle donne, se smantelli il mandato di mascolinità cambi il mondo, ne sono convinta. Gli uomini sono danneggiati, hanno una vita più breve in ogni parte del mondo, non solo dove c’è la guerra, perché sono obbligati a obbedire a quel mandato. Gli uomini devono combattere contro quel mandato per essere liberi e il movimento femminista è l’occasione per gli uomini di liberarsi dall’obbligo di dare prova della loro potenza. Se demolisci questo imperativo, che è la prima pedagogia della crudeltà e del potere, cambi il mondo, cambi la realtà. Per questo gli uomini devono venire fuori. Nella fase multiculturale, che è stata la fase tra la caduta del muro di Berlino e il presente, il cambiamento non c’è stato perché il multiculturalismo e le identità politiche non hanno toccato il tessuto del capitale, dell’accumulazione, della concentrazione che è invece cresciuta nel periodo multiculturale, come ho scritto in un mio libro (La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad, 2007). L’impatto del movimento femminista sta anche nella possibilità che dà agli uomini di venirne fuori, perché realizzano la possibilità di aggredire il fondamento di ogni potere.
Un’altra domanda a proposito dello sciopero. Che cosa pensi del fatto che le donne abbiano scelto lo sciopero come pratica di lotta?
Io credo che sia stato uno sciopero esistenziale, uno sciopero per un diverso tipo di esistenza e di politica nel senso che ti ho detto, in un modo topico, umoristico, celebrativo, comunalistico, capace di produrre vincoli tra me e te, e questo è ciò che definisco esistenziale...rompe la burocrazia, l’espropriazione. Le donne nel presente sono sequestrate dalla burocrazia che è storicamente legata all’egemonia. Non sono un’anarchica perché credo nell’organizzazione in comune che è basata sui legami, potrebbe essere un anarchismo etnico il mio. Sono tornata in Argentina e ho scelto di vivere nella città dove ho passato l’adolescenza, tra La Paz e Buenos Aires. Quando la modernità è arrivata nella città, quando lo Stato è arrivato nella città, le donne hanno perso la sovranità sul proprio corpo eppure tuttora ci sono rituali solo per le donne, una vita comune nei quartieri, segni di riconoscimento, un modo di relazionarsi in modo diverso. E poi sono un’antropologa e so che la comunità esiste ancora in America Latina, anche se in piccoli pezzi.
La comunità però non è stata disintegrata solo dalla colonizzazione o dal capitale, ma anche dalle donne che si sono sottratte al ruolo che la comunità riservava loro...
Le donne del Chiapas hanno dato una risposta al problema. I creoli hanno imposto la logica per cui prima bisogna lottare per il popolo, poi per le donne. Le donne del Chiapas hanno detto no, quando il vento della politica soffia, soffia per il popolo e per tutte le sue parti. Non c’è un’opposizione, non si escludono.
Non intendevo questo. Nei tuoi lavori tu parli di un patriarcato a bassa intensità che agisce nelle comunità e penso che le donne abbiano rotto i vincoli comunitari anche per sottrarsi al patriarcato, qualunque sia la sua intensità. Le migrazioni delle donne oggi rispondono anche a questa pretesa di libertà contro i vincoli patriarcali della comunità.
Io penso che dobbiamo capire questo nei momenti di transizione dalla comunità alla società, dalla vita comune alla cittadinanza, perché sono stati questi i momenti in cui in America Latina come in Spagna si è intensificata la violenza contro le donne. La maggior parte delle comunità oggi sono in questo momento di transizione. Anche se la cittadinanza astratta nei nostri paesi - non so in Europa - non si è mai realizzata, negli spazi coloniali c’è una storia diversa della storia del rapporto tra Stato e società, la società è stata costituita dallo Stato dall’esterno, come una copia dello Stato coloniale, ci sono metropoli coloniali che si sono trasformate in territori che hanno continuato l’amministrazione coloniale. E questo processo ha creato la società, le Repubbliche nei nostri paesi sono finzioni.
Credo però che questo sia vero anche in Europa, benché in modo diverso. L’omogeneità del popolo è sempre stata una finzione...
Io credo comunque che questo si possa decifrare proprio grazie alla storia della violenza sulle donne e dall’incapacità dello Stato di dare una risposta. Nei momenti di transizione la posizione degli uomini è una posizione che sta in mezzo, l’espansione della colonia è una forma di castrazione che impone loro di restaurare la loro potenza attraverso la violenza. La violenza è una restaurazione della mascolinità contro la castrazione ed è questo che porta le donne ad andarsene. Ma nei luoghi in cui questo processo non si è dato, le donne rimangono nelle comunità e sono alla guida dei movimenti comunalisti, come Berta Cáceres in Honduras.
Questo però è un movimento globale. Tu parli del tuo immaginario politico topico, che parte dall’esperienza della comunità, ma quest’esperienza non è generalizzabile. Allora che cosa significa pensare la trasformazione femminista di cui hai parlato da una prospettiva transnazionale?
Per l’8 marzo alcune donne latinoamericane che vivono in Francia mi hanno chiesto di fare una dichiarazione per lo sciopero e io ho detto che la posta in gioco è la pluralità. Non possiamo unificarlo né possiamo pensare ora di essere tutte allo stesso modo. Ci sono rivendicazioni comuni, ma cercare un’unificazione sarebbe un errore. Si può unificare qualcosa su cui si ha presa, ma nessuno può avere presa su quello che sta succedendo. Il patriarcato pretende di avere presa su tutto e da questo dipende la sua vita, dal controllo. Noi non possiamo farlo, dobbiamo lasciar essere. Il rischio di aspirare all’unità è troppo grande. È come una bambina appena nata. Si può dire: devi essere bella, disciplinata, educata, devi studiare. Noi dobbiamo avere una bambina ribelle.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- De Beauvoir. Quando la donna diventò soggetto (di Francesca Rigotti).17 giugno 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE... *
Julia Kristeva
De Beauvoir. Quando la donna diventò soggetto
di Francesca Rigotti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.06.2018)
- Julia Kristeva,Simone de Beauvoir. La rivoluzione del femminile, trad. di Alessandro Ciappa, Donzelli, Roma, pagg. 140, € 19.
Il prossimo anno ricorrerà il settantesimo dalla pubblicazione di Il secondo sesso, di Simone de Beauvoir (1949), ma non è una cattiva idea cominciare fin d’ora a celebrarlo. Perché quel libro ha rappresentato un evento culturale, una svolta antropologica, una rivoluzione copernicana: con esso, grazie ad esso il soggetto donna si afferma sulla scena dalla quale non sarà più possibile cacciarlo via. E questo per merito di una filosofa e scrittrice, aristocratica, esistenzialista e comunista nonché femminista dell’uguaglianza, il cui status di autrice originale, col suo approccio che è una sintesi di esistenzialismo, hegelianesimo, marxismo e antropologia, si è finalmente consolidato dopo decenni di alterna fortuna.
Lo riconosce Julia Kristeva, migrante venuta da lontano non normalista francese, a sua volta femminista differenzialista e teorica della psicoanalisi, disciplina verso la quale Simone de Beauvoir non nascondeva la propria antipatia e diffidenza. Eppure la vita e l’opera di De Beauvoir (1908-1986) hanno rivoluzionato mentalità e costumi, imprimendo «un’accelerazione all’emancipazione del secondo sesso dopo millenni di dominazione patriarcale e maschile» - riconosce Kristeva in questa raccolta di saggi che invita a rileggere le pagine di una filosofa dalla scrittura romanzesca e di una scrittrice dall’argomentazione filosofica proprio nella nostra epoca polverizzata, nella quale parecchie donne sembrano riadagiarsi nel conformismo sociale.
Alcune correnti femministe rimproverano a De Beauvoir di aver insistito sul registro universale dell’eguaglianza finendo per non vedere, se non negare, il corpo femminile con le sue caratteristiche specifiche tra cui la maternità e l’omosessualità femminile. Eppure ciò non è sufficiente - ribatte proprio Kristeva - a cancellare l’importanza del pensiero di De Beauvoir oggi, non come passaggio storico superato ma in quanto presentificazione degli atti di affermazione del soggetto donna. Operazione che Simone de Beauvoir conduce, sottolinea Kristeva, nei saggi come pure attraverso i romanzi, nei quali la singolarità individuale dei personaggi si trasforma in universalità collettiva politica. Una sfida raccolta anche da Il secondo sesso, ove si invita a singolarizzare il politico e a politicizzare il singolare.
Il lascito di De Beauvoir a tutte le donne è in ogni caso il culto della libertà: la libertà è la sua stella polare, la libertà di Socrate, di Pascal, dell’Illuminismo, di Hegel, di Marx, di Arendt. La libertà che spetta alle donne se riusciranno a uscire dalla condizione di minorità per ottenere la piena eguaglianza, nella polifonia delle posizioni delle donne, femministe o meno, universaliste, differenzialiste, #me too, femen, non una di meno, e se non ora quando. Si potrebbe credere che per riconoscere questo ruolo fondamentale a Simone de Beauvoir Kristeva la spinga verso criteri differenzialisti che non erano i suoi; a me sembra invece che Kristeva rimanga sempre rispettosa e attenta alle peculiarità del pensiero di De Beauvoir di cui affronta persino i sogni, quelli di cui la scrittrice fa dono al lettore in A conti fatti: sogni di cadute e voli, di maternità e fughe e di fughe dalla maternità, nei quali si mostra la geniale capacità dell’autrice di svelare ciò che è più intimo conciliandolo con i disagi dell’epoca per trasformarli in priorità politiche.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA...
 IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
 DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud)
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- LA STORIA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE. Aquarius: se io fossi Papa (di Paolo Farinella)14 giugno 2018, di Federico La Sala
"ADAMO", "ABRAMO", I TRE MONOTEISMI, L’ONU, E LA STORIA DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE ... *
Aquarius: se io fossi Papa, scomunicherei Matteo Salvini
di Paolo Farinella, sacerdoye (Il Fatto quotidiano, 12 giugno 2018)
Finita la civiltà occidentale, è iniziata l’inciviltà di Salvini Matteo, segretario della Lega non più secessionista ma a vocazione planetaria, (vice)Presidente del Consiglio dei ministri in atto e cattolico «coerente» (l’ha detto lui medesimo in persona!), in risposta al cardinal Gianfranco Ravasi che twittava il Vangelo di Matteo al capitolo 25,43: «Ero straniero e non mi avete accolto». La motivazione della coerenza cristiana di Matteo Salvini: «Ho il rosario in tasca, io coerente con gl’insegnamenti del Vangelo».
 È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?
È il capovolgimento di ogni ordine e principio. Se avere un oggetto in tasca è segno di coerenza, chi porta le «Madonne ripiene» di Lourdes, le immagini dei Padri Pii e armamentari di questo genere, cosa è? Un padre/madre eterno in terra?Se io fossi Papa, lo scomunicherei in forza delle sue stesse parole che sono un insulto a tutto l’insegnamento evangelico, tenuto conto che per un ministro della Repubblica Italiana, fresco di giuramento «di servire con disciplina e onore», dovrebbe essere ininfluente l’aspetto, finto o vero che sia, della religione perché bastano e avanzano i principi della Costituzione che anche Salvini difese nel referendum del 2016, le leggi e i trattati internazionali, sottoscritti dall’Italia e la legge della coscienza che su tutto fa prevalere l’umanità e il pericolo imminente di vita.
Nella creazione, «Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte» (Gen 1,4-5), ora le tenebre prendono il posto del giorno come se niente fosse.
Mi ribello a questa ignominia che, come scrive Lucia Annunziata su Huffington Post, ci riporta indietro di 72 anni minimo alla vergogna della nave ebraica «Exodus». In questi giorni, nella mia parrocchia, abbiamo pubblicato tutti i bilanci e gli aiuti che diamo a oltre un centinaio di persone/famiglie (50% italiani e 50% di origine non italiana), provengono unicamente da contribuzioni volontarie di circa 150 persone.
 Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.
Non un soldo pubblico, non un contributo politico che non vogliamo perché abbiamo un senso di dignità che esige la compartecipazione e il sentimento umano. La «pacchia» la rimandiamo indietro al mittente perché è lui che lucra elettoralmente e politicamente dalla disgrazia dei migranti.A Salvini e a Di Maio che ho votato per scardinare l’immondo sodalizio «Renzi/Berlusconi» e non per trovarmi i fascisti al governo, nonostante la Costituzione, dedico queste parole nelle quali mi riconosco io e il meglio del popolo italiano:
- «Tutti i figli di Adamo formano un solo corpo, sono della stessa essenza. Quando il tempo affligge con il dolore una parte del corpo (anche) le altre parti soffrono. Se tu non senti la pena degli altri, non meriti di essere chiamato uomo».
Queste parole sono scolpite nell’atrio del Palazzo dell’Onu. Parole antiche, di Poeta e di Mistico, Saādi di Shiraz, Iran1203-1291. Nove secoli fa un persiano musulmano esprimeva un pensiero che è ebraico e cristiano. Nella Bibbia, «Adamo» non è nome proprio di persona, ma nome collettivo e significa «Umanità - Genere Umano», senza aggettivi perché non è occidentale, orientale, del nord o del sud, ma solo universale.
 L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.
L’Onu ha scolpito le parole sul suo ingresso perché le nazioni possano leggerla prima di deliberare per richiamarsi l’orizzonte delle decisioni. Europa, Italia e Occidente fan parte dell’Onu al punto che spiriti poveri osano parlare di «civiltà occidentale», identificandola, sacrilegamente, con il Crocifisso, senza memoria di storia, di geografia e di civiltà.La nostra civiltà sta regredendo verso la preistoria, verso il nulla. Come insegna il secolo XX, secolo di orrori, la barbarie porta all’abisso e inghiotte la Storia in un buco nero senza ritorno. Guardando le immagini di umanità crocifissa nella miseria dell’opulenza attorno al Grattacielo della Regione Liguria, ho pensato istintivamente alle parole del pastore protestante tedesco, Martin Möller, pronunciate nel 1946 in un sermone liturgico: -***«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».
A Genova il Comune ha deciso di restaurare la Lanterna, simbolo della città, faro di luce nel buio e segnale per rotte sicure; a Genova, in Italia, in Europa e nel Mondo si perseguitano i poveri, i senza dimora, gli sbandati, figli di una società impazzita che crede di potersi chiudere in sé, erigendo muri e fili spinati, mentre si difendono Istituzioni ed Europa, gusci vuoti d’ideali, ma pieni di interessi miopi. Chi costruisce muri distrugge l’Europa e il proprio Paese, chi perseguita il povero si attira la collera di Dio che è «il Dio degli umili, il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati» (Gdt 14,11).
 La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.
La civiltà e il suo cammino lo avevano indicato nei millenni antichi le Scritture degli Ebrei, dei Cristiani e dei Musulmani, recepiti dalla modernità nell’esistenza stessa dello spirito delle Nazioni Unite, che si riconoscono in Saādi di Shiraz.Se oggi, cittadini, uomini e donne, politici e amministratori, vescovi e preti, politici e governanti, sindaci e assessori, credenti e non credenti, docenti e studenti, non si riconoscono laicamente nelle parole che vengono dal lontano Medio Evo, noi abbiamo messo mano alla scure per recidere l’albero su cui siamo seduti. Se non ci si chiede la ragione per cui i poveri aumentano, i senza casa aumentano, gli sbandati crescono esponenzialmente e i migranti africani chiedono il conto, siamo colpevoli di assassinio della civiltà, non salveremo noi, ma ci votiamo destiniamo alla distruzione.
Berthold Brecht (1898-1956), poeta e drammaturgo, nelle Poesie di Svendborg (1933-1938), 1937 (traduzione di E. Castellani-R. Fertonani) ne ha una col titolo «Germania», atto di accusa al sopruso del forte sul debole, all’arroganza del sistema sulla persona. A sessant’anni della sua morte, Germania è nome simbolico, sostituibile con Italia, Ungheria, Polonia, Austria, Olanda, Genova, Torino Milano, Roma, Io, Tu, Egli, Noi, Voi e Loro: -***«Parlino altri della propria vergogna, / io parlo della mia. /O Germania, pallida madre! / come insozzata siedi / fra i popoli! / Fra i segnati d’infamia /tu spicchi. / Dai tuoi figli il più povero/ è ucciso. / Quando la fame sua fu grande / gli altri tuoi figli / hanno levato la mano su lui. / ... Perché ti pregiano gli oppressori, tutt’intorno, ma / ti accusano gli oppressi? / Gli sfruttati / ti mostrano a dito, ma / gli sfruttatori lodano il sistema / che in casa tua è stato escogitato! / E invece tutti ti vedono / celare l’orlo della veste, insanguinato / dal sangue del migliore / dei tuoi figli. / O Germania, pallida madre! / Come t’hanno ridotta i tuoi figli, / che tu in mezzo ai popoli sia / o derisione o spavento!» (Berthold Brecht).
Possano la Poesia e la Memoria rinsavire Ragione e Dignità. Salvini, la Lega, Di Maio e l’illusione passeranno, l’umanità sopravvivrà e i poveri porteranno fiori sulle loro tombe. È la Storia, bellezza! È la Storia!
*
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La "donazione di Pietro", la "donazione di Costantino" e noi, oggi.
- FORZA "CRISTO RE"!!! (Paolo di Tarso): "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef. 4,15-16)
- "È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"" ([Albert Rouet, arcivescovo di Poitiers, 2010).
"ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. "Potrei, per me, pensare un altro Abramo" (F. Kafka).
Federico La Sala
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Sinodo sull’Amazzonia e donne-prete. "La dottrina è definitiva, sbagliato creare dubbi tra i fedeli. Cristo conferì il sacramento ai 12 apostoli, tutti uomini": lo stop di Ladaria.11 giugno 2018, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE....
"Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria
Il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio: "La dottrina è definitiva, sbagliato creare dubbi tra i fedeli. Cristo conferì il sacramento ai 12 apostoli, tutti uomini"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 maggio 2018)
CITTÀ DEL VATICANO - Si tratta "di una verità appartenente al deposito della fede", nonostante sorgano "ancora in alcuni paesi delle voci che mettono in dubbio la definitività di questa dottrina". A ribadire il "no" del Vaticano all’ipotesi dell’ordinazione presbiterale femminile è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il neo-cardinale gesuita Luis Ladaria, in un lungo e argomentato articolo pubblicato sull’Osservatore Romano. Intitolato "Il carattere definitivo della dottrina di ’Ordinatio sacerdotalis’", il testo è scritto per fugare "alcuni dubbi" in proposito.
Evidentemente, il ritorno di proposte aperturiste circa le donne-prete avanzate soprattutto in alcuni paesi sudamericani in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre dedicato all’Amazzonia, ha allarmato la Santa Sede che attraverso la sua massima autorità gerarchica ha voluto ribadire ciò che anche per Francesco sembra essere assodato: "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio tornando nel novembre del 2016 dal suo viaggio lampo in Svezia.
Durante il Sinodo sull’Amazzonia uno dei temi centrali sarà quello della carenza di preti. Come superare il problema? In proposito, da tempo, si parla dell’opportunità di ordinare i cosiddetti viri probati, uomini sposati di una certa età e di provata fede che possano celebrare messa nelle comunità che, appunto, hanno scarsità di sacerdoti e dove è difficile che un prete possa recarsi con regolarità. Altri uomini di Chiesa fanno altre proposte: propongono, come ad esempio ha recentemente fatto monsignor Erwin Krautler della prelatura territoriale di Xingu in Amazzonia, che oltre ai viri probati si proceda con l’ordinazione delle diaconesse. Mentre altri ancora, invece, hanno parlato direttamente di donne-prete.
Ladaria ricorda che "Cristo ha voluto conferire questo sacramento ai dodici apostoli, tutti uomini, che, a loro volta, lo hanno comunicato ad altri uomini". E che per questo motivo la Chiesa si è riconosciuta "sempre vincolata a questa decisione del Signore", la quale esclude "che il sacerdozio ministeriale possa essere validamente conferito alle donne".
Già Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis del 22 maggio 1994, disse che "la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa". Mentre la Congregazione per la dottrina della fede, in risposta a un dubbio sull’insegnamento di Ordinatio sacerdotalis, ha ribadito che "si tratta di una verità appartenente al deposito della fede".
Chi vuole le donne-prete argomenta che la dottrina in merito non è stata definita ex cathedra e che, quindi, una decisione posteriore di un futuro Papa o concilio potrebbe rovesciarla. Dice, tuttavia, Ladaria che "seminando questi dubbi si crea grave confusione tra i fedeli" perché, Denzinger-Hünermann alla mano (l’autorevole volume che raccoglie simboli di fede, decisioni conciliari, provvedimenti di sinodi provinciali, dichiarazioni e scritti dottrinali dei Pontefici dalle origini del cristianesimo all’epoca contemporanea) la Chiesa riconosce che l’impossibilità di ordinare delle donne appartiene alla "sostanza del sacramento" dell’ordine. Una sostanza, dunque, che la Chiesa non può cambiare. "Se la Chiesa non può intervenire - dice ancora Ladaria - è perché in quel punto interviene l’amore originario di Dio".
Ladaria parla anche dell’infallibilità e del suo significato. Essa non riguarda solo pronunciamenti solenni di un concilio o del Papa quando parla ex cathedra, "ma anche l’insegnamento ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, quando propongono, in comunione tra loro e con il Papa, la dottrina cattolica da tenersi definitivamente". A questa infallibilità si è riferito Giovanni Paolo II in "Ordinatio sacerdotalis?, un testo che Wojtyla scrisse dopo un’ampia consultazione portata avanti a a Roma "con i presidenti delle conferenze episcopali che erano seriamente interessati a tale problematica". "Tutti, senza eccezione - ricorda Ladaria - hanno dichiarato, con piena convinzione, per l’obbedienza della Chiesa al Signore, che essa non possiede la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - ESSERE E DINTORNI. Vattimo a Teheran per salvare Heidegger (di Donatella Di Cesare).4 giugno 2018, di Federico La Sala
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI ... *
Vattimo a Teheran per salvare Heidegger
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 3 Giugno 2018)
Il nuovo libro di Gianni Vattimo Essere e dintorni (La nave di Teseo) comprende 31 saggi che sono altrettanti tentativi di interpretare l’attualità. Ecco perché il volume non è un trattato metafisico, bensì un «breviario teologico-filosofico», o meglio, il «diario di una crisi», quella provocata dalla pubblicazione dei Quaderni neri di Martin Heidegger.
In tempi in cui si parla di un «ritorno» della filosofia al centro dello spazio pubblico, le pagine di Vattimo sono esempio di stile, chiarezza, accessibilità. Perché se i filosofi vogliono contribuire a riflettere sulla situazione presente, bisogna che parlino e scrivano in modo comprensibile.
Il «breviario» ruota intorno al nesso stretto fra interpretazione ed emancipazione. Si ricorderà la celebre frase di Karl Marx contenuta nelle Tesi su Feuerbach: «I filosofi hanno finora solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta ora di cambiarlo». Ebbene, questa tesi - così commenta Vattimo - va presa con la dovuta cautela. Perché interpretare è già cambiare. Lo mostra l’ermeneutica, che non è un relativismo tradizionalista. Chi la fraintende in tal senso, presume che ogni interpretazione rispecchi in modo imperfetto e mutevole la «verità oggettiva» del mondo là fuori.
 Al contrario, l’interpretazione - come insegna già Aristotele - è l’apertura in cui, di volta in volta, la verità si costituisce articolandosi. Ogni interpretazione è un contributo alla verità condivisa. Si intuisce il valore democratico dell’ermeneutica. Perché il totalitarismo attecchisce là dove una sola interpretazione vorrebbe imporsi come la verità. Meglio, dunque, diffidare di chi sostiene di possederla.
D’altronde già all’epoca de Il pensiero debole, nel 1983, Vattimo aveva avanzato l’esigenza di un pensiero in grado di farsi carico della dissoluzione di princìpi e strutture forti.
Al contrario, l’interpretazione - come insegna già Aristotele - è l’apertura in cui, di volta in volta, la verità si costituisce articolandosi. Ogni interpretazione è un contributo alla verità condivisa. Si intuisce il valore democratico dell’ermeneutica. Perché il totalitarismo attecchisce là dove una sola interpretazione vorrebbe imporsi come la verità. Meglio, dunque, diffidare di chi sostiene di possederla.
D’altronde già all’epoca de Il pensiero debole, nel 1983, Vattimo aveva avanzato l’esigenza di un pensiero in grado di farsi carico della dissoluzione di princìpi e strutture forti.L’ultimo Vattimo rilancia: se non c’è emancipazione senza interpretazione, ogni interpretazione porta sempre con sé una carica liberatoria. E suggerisce: «Finora i filosofi hanno creduto di descrivere il mondo, ora è venuto il momento di interpretarlo...». Per essere coerente il pensiero debole non potrà rivendicare una «posizione di sovranità», tanto meno nella prassi politica. Ma l’ermeneutica è emancipazione anche perché racconta un’epoca che sa di essere ineluttabilmente contingente, profondamente storica. Sulle orme di Heidegger, Vattimo ripercorre la storia del lungo addio all’Essere, che può restare solo nel ricordo. Così l’ermeneutica si aggira «nei dintorni dell’Essere» - come suggerisce il titolo.
Che avviene, però, all’indomani dei Quaderni neri? Negli ultimi saggi Vattimo ricostruisce l’intenso dibattito esploso non tanto sull’adesione al nazismo, quanto sull’antisemitismo e sull’interpretazione della Shoah. Evita le due scorciatoie più frequenti: quella di coloro che vorrebbero gettare l’opera di Heidegger alle ortiche e quella di chi banalizza fino a negare persino l’antisemitismo.
 Chiaro è tuttavia il suo tentativo di «salvare» Heidegger. Come? Facendone un «teologo cristiano». A Vattimo non interessa tanto la politica di Heidegger, che pure emerge da quelle pagine. Risuona allora la sentenza che suggella l’intervista allo «Spiegel» uscita postuma: «Ormai solo un dio ci può salvare».
Chiaro è tuttavia il suo tentativo di «salvare» Heidegger. Come? Facendone un «teologo cristiano». A Vattimo non interessa tanto la politica di Heidegger, che pure emerge da quelle pagine. Risuona allora la sentenza che suggella l’intervista allo «Spiegel» uscita postuma: «Ormai solo un dio ci può salvare».
 La via di salvezza sarebbe quella di un cristianesimo paolino. Ma a parlare è Vattimo oppure Heidegger? Le parti sembrano confondersi. Tanto più che l’ultimo Vattimo, fulminato sulla via di Damasco, interpreta l’emancipazione in chiave religiosa. Questo sostanzia anche le sue scelte politiche, più che discutibili. Con un salto mortale nella metafisica il pensiero debole si fa pensiero dei «deboli», una categoria reificata senza considerare che debole rinvia a una relazione - si è deboli sempre rispetto a qualcun altro e i deboli non hanno sempre ragione.
La via di salvezza sarebbe quella di un cristianesimo paolino. Ma a parlare è Vattimo oppure Heidegger? Le parti sembrano confondersi. Tanto più che l’ultimo Vattimo, fulminato sulla via di Damasco, interpreta l’emancipazione in chiave religiosa. Questo sostanzia anche le sue scelte politiche, più che discutibili. Con un salto mortale nella metafisica il pensiero debole si fa pensiero dei «deboli», una categoria reificata senza considerare che debole rinvia a una relazione - si è deboli sempre rispetto a qualcun altro e i deboli non hanno sempre ragione.
 La Siracusa di Vattimo si chiama Caracas, se non addirittura Teheran. Per un verso le lodi a Chávez, fulgido esempio di socialismo, per l’altro l’apprezzamento per Ahmadinejad nonché il giudizio su Israele: «Tra i peggiori danni prodotti dalla politica hitleriana e dall’Olocausto».
La Siracusa di Vattimo si chiama Caracas, se non addirittura Teheran. Per un verso le lodi a Chávez, fulgido esempio di socialismo, per l’altro l’apprezzamento per Ahmadinejad nonché il giudizio su Israele: «Tra i peggiori danni prodotti dalla politica hitleriana e dall’Olocausto».
 L’antisionismo di Vattimo - è bene dirlo a chiare lettere - si nutre di un vecchio antiebraismo marcionita, che la Chiesa ha già più volte condannato, si alimenta di una teologia della sostituzione - bandire la vecchia legge per far trionfare lo spirito - che tanti danni ha prodotto nella storia.
L’antisionismo di Vattimo - è bene dirlo a chiare lettere - si nutre di un vecchio antiebraismo marcionita, che la Chiesa ha già più volte condannato, si alimenta di una teologia della sostituzione - bandire la vecchia legge per far trionfare lo spirito - che tanti danni ha prodotto nella storia.L’ermeneutica viene sacrificata sull’altare di un cattolicesimo che vorrebbe cancellare il messianismo ebraico, tradita in nome di forti prese di posizione, che hanno tratti categorici e assiomatici. In futuro bisognerà chiedersi come salvare Vattimo dopo aver salvato Heidegger.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- ESSERE GIUSTI CON KANT. La lezione di Michel Foucault e la sorpresa di Habermas.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- L’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560).27 maggio 2018, di Federico La SalaFILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA...
 IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
 DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
-
>NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. - Il Sessantotto, 50 anni dopo. Intervista ad Agostino Giovagnoli (di Giovanna Pasqualin Traversa).24 maggio 2018, di Federico La Sala
50 anni dopo
Il Sessantotto. Agostino Giovagnoli (storico): “Profondo legame con il Concilio che ne ha anticipato alcuni tratti”
I legami tra Concilio Vaticano II e Sessantotto sono più profondi di quanto si sia portati a ritenere. Il Concilio ha infatti "preparato" in certa misura il terreno al grande movimento di contestazione. Intervista a tutto campo con lo storico Agostino Giovagnoli
 diGiovanna Pasqualin Traversa (Agenzia SIR, 26 aprile 2018)
diGiovanna Pasqualin Traversa (Agenzia SIR, 26 aprile 2018)Gli anni Settanta hanno rappresentato un passaggio cruciale nella vita della Chiesa in Italia. Sono gli anni della recezione del Concilio e sono al tempo stesso attraversati da tensioni e polarizzazioni legate al Sessantotto. Fede e politica intrecciate fra loro? Se sì su quali premesse e con quali sviluppi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all’Università cattolica di Milano
Fra le trasformazioni della Chiesa cattolica legate al Vaticano II e gli eventi del ‘68 c’è stato un intreccio?
Sì; più profondo, soprattutto in Italia, di quanto abitualmente si ritenga.
 La contestazione del 1968 si è intersecata in modi diversi con un’evoluzione del mondo cattolico italiano già in corso da tempo.
La contestazione del 1968 si è intersecata in modi diversi con un’evoluzione del mondo cattolico italiano già in corso da tempo.
 Non è strettamente sul livello politico che si è sviluppato l’influsso del Concilio sulla società e sulle sue trasformazioni. Il Concilio ha in realtà toccato questioni di grande rilievo, ha aperto una riflessione di fondo sull’organizzazione istituzionale della Chiesa cattolica all’interno di un’ampia trasformazione della società europea e occidentale che stava mettendo in discussione le proprie istituzioni ecclesiastiche, politiche, sociali e familiari. Il ‘68 è stato soprattutto una contestazione anti-istituzionale ed è su questo terreno che è ravvisabile il nesso che lega i due fenomeni.
Non è strettamente sul livello politico che si è sviluppato l’influsso del Concilio sulla società e sulle sue trasformazioni. Il Concilio ha in realtà toccato questioni di grande rilievo, ha aperto una riflessione di fondo sull’organizzazione istituzionale della Chiesa cattolica all’interno di un’ampia trasformazione della società europea e occidentale che stava mettendo in discussione le proprie istituzioni ecclesiastiche, politiche, sociali e familiari. Il ‘68 è stato soprattutto una contestazione anti-istituzionale ed è su questo terreno che è ravvisabile il nesso che lega i due fenomeni.Il Concilio ha dunque “preparato in qualche modo il terreno” al Sessantotto?
La Chiesa cattolica ha anticipato una trasformazione che poi si è presentata in modo convulso nel 1968, nel senso di un ridimensionamento del peso delle istituzioni all’interno della società. Da questo punto di vista il dissenso cattolico ha rappresentato un fenomeno specifico e forse anche marginale. Ha ripreso alcune modalità della contestazione studentesca ma non è qui il cuore più profondo del rapporto che investe aspetti più globali.
Qual è stata l’intuizione di Giovanni XXIII?
L’avere compreso che la Chiesa aveva bisogno di mettersi in ascolto del mondo e di se stessa. Nella modalità conciliare ha in qualche modo superato la rigidità istituzionale che l’aveva caratterizzata per cinque secoli sul modello tridentino. In questo senso il Concilio ha avviato un processo di cui ravviso alcuni tratti anche nel 1968.
 Lo storico gesuita Michel de Certeau, che ha partecipato al “maggio francese” a Parigi, ha scritto che nel ’68 “è stata presa la parola come nel 1789 è stata presa la Bastiglia”. Un’immagine metaforica che sottolinea la liberazione della parola, tipica di quel movimento. L’analogia è profonda perché il Vaticano II ha a modo suo “liberato” la parola, in questo caso la Parola di Dio, da una Chiesa che l’aveva rinserrata all’interno di schemi organizzativi e istituzionali che la rendevano in certa misura marginale e l’ha riportata al centro della vita ecclesiale. E’ dalla Parola di Dio che rinasce la Chiesa.
Lo storico gesuita Michel de Certeau, che ha partecipato al “maggio francese” a Parigi, ha scritto che nel ’68 “è stata presa la parola come nel 1789 è stata presa la Bastiglia”. Un’immagine metaforica che sottolinea la liberazione della parola, tipica di quel movimento. L’analogia è profonda perché il Vaticano II ha a modo suo “liberato” la parola, in questo caso la Parola di Dio, da una Chiesa che l’aveva rinserrata all’interno di schemi organizzativi e istituzionali che la rendevano in certa misura marginale e l’ha riportata al centro della vita ecclesiale. E’ dalla Parola di Dio che rinasce la Chiesa.In che modo il ’68 ha influito su associazioni e movimenti del laicato cattolico?
Per l’Azione cattolica un cambiamento importante è cominciato con il pontificato di Giovanni XXIII e soprattutto con l’elezione di Paolo VI nel 1963. La nomina di mons. Franco Costa quale assistente ecclesiastico generale e di Vittorio Bachelet quale presidente nazionale segnano il definitivo distacco dal modello geddiano. Il rinnovamento si è realizzato pienamente con il nuovo statuto (1969) che ha prodotto una vasta riorganizzazione e ha soprattutto affermato “la scelta religiosa” dell’Ac, espressione che sottolinea la fine di ogni collateralismo con qualsiasi partito politico. L’impatto del Sessantotto sull’Ac è stato soprattutto indiretto e probabilmente ha influito sul calo degli iscritti che dal 1964 al 1974 passano da 3,5 milioni a 600mila.
E per quanto riguarda le Acli?
Anche qui si deve parlare di un impatto indiretto. La trasformazione delle Acli era cominciata all’inizio degli anni Sessanta, in stretto rapporto con l’evoluzione economico-sociale della realtà italiana e il nuovo ruolo assunto dai sindacati. Un’ulteriore svolta è avvenuta a seguito dell’“autunno caldo” nelle grandi fabbriche italiane del 1969 con l’adozione della cosiddetta ipotesi socialista alla quale seguì una richiesta di chiarimenti da parte della presidenza della Cei, una presa di posizione critica del Pontefice e il ritiro dell’assistente ecclesiastico. La contestazione del ’68 ha invece riguardato in modo più diretto Gioventù studentesca, ramo dell’Ac che aveva iniziato un percorso originale, soprattutto in Lombardia, a seguito dell’iniziativa assunta da don Luigi Giussani nel 1954. In questo contesto nasce Comunione e Liberazione.
Il Sessantotto ha dunque interferito con un’evoluzione in atto nell’associazionismo cattolico degli anni Sessanta?
Sì. Forse l’impatto maggiore ha riguardato le grandi questioni internazionali con particolare riferimento al terzo mondo: guerra in Vietnam, Cuba, Biafra, lotte per i diritti civili degli afroamericani negli Usa. I membri dell’associazionismo cattolico, soprattutto giovani, furono molto sensibili a queste cause e, più in generale, a quella della pace.
Su questo terreno maturarono una sensibilità simile a quella di molti altri giovani di altra provenienza culturale e ideologica, che fece cadere molti steccati tradizionali.
Ci furono infine esperienze nuove che nacquero al di fuori dall’associazionismo cattolico o del rapporto con la Dc, nel clima del Sessantotto, come la Comunità di Sant’Egidio a Roma, segnata fin dall’inizio da un forte rapporto con il Vangelo e i poveri.
Che giudizio ha del Sessantotto?
Ha avuto peso non tanto quale fenomeno politico, ma piuttosto come istanza culturale e sociale di “inventare” un mondo nuovo affrontando le grandi sfide del tempo, le sfide di un mondo terrorizzato dall’arma atomica e in cerca di pace, che vuole dare la parola a tutti, che affronta le gravi disuguaglianze economiche e sociali. Si è disperso di fronte a forze più grandi; in fondo è stato un movimento di studenti, non avrebbe potuto cambiare il mondo, però ci ha provato ed è questa la sua eredità più preziosa.
Pensare al ’68 ci fa bene perché ci ricorda che possiamo anche non subire il mondo in cui viviamo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL PAPA [GIOVANNI XXIII, 1962] HA DECISO DI DARE IL VIA AD UN NUOVO CONCILIO, AL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II. PACE E E DIALOGO SU TUTTA LA TERRA, TRA TUTTI GLI ESSERI UMANI, TUTTE LE RELIGIONI, TUTTI I CREDENTI E I NON CREDENTI. QUESTA LA DICHIARAZIONE DI APERTURA
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
 UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI. Il cardinale Martini, da Gerusalemme, dalla “città della pace”, lo sollecita ancora!!!
UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI. Il cardinale Martini, da Gerusalemme, dalla “città della pace”, lo sollecita ancora!!!GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Per un nuovo romanzo di formazione. Pensare l’ "edipo completo".14 maggio 2018, di Federico La Sala
Pensare l’ "edipo completo"....
PLAUDENDO al lavoro e alla sollecitazione delle Autrici di "ripensare le figure della maternità", e, al brillante saggio introduttivo di Daniela Brogi, "Nel nome della madre. Per un nuovo romanzo di formazione", mi sia lecito ricordare che il programma di Freud, al di là dei molteplici e "interessati" riduzionismi (in nome del padre o in nome della madre), era quello di = Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico kantiano: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio"; e, possibilmente e ’finalmente’, uscire fuori dalla "caverna", dalla "preistoria", e portarci (tutte e tutti) DAL "CHE COSA" AL "CHI".
Federico La Sala
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) - Come nascono i bambini. Lettera aperta ai dirigenti della Rai TV (di Luisa Muraro).7 maggio 2018, di Federico La Sala
Lettera aperta ai dirigenti della Rai TV
"Pago il canone e pretendo che i giornalisti della tivù pubblica sappiano come nascono i bambini".
di Luisa Muraro
Le sindache (e i sindaci) d’Italia, possono credere nella cicogna che porta i bambini, ma quelli che preparano i telegiornali, no, loro no. Pago il canone e pretendo che i giornalisti della tivù pubblica sappiano come nascono i bambini. Nel telegiornale delle ore19 di sabato 28 aprile, hanno dato la notizia di un bambino che ha due padri, anzi “due papà”, e come tale è stato regolarmente iscritto all’anagrafe di Roma. Non sembrava l’annuncio di un qualche miracolo della scienza medica. La signora che ha letto la notizia, se, come dobbiamo supporre, era incredula, l’ha nascosto molto bene. E così dovranno fare, suppongo, le segretarie, le maestre, i parenti, i nonni, i pediatri, e via via, fino a quando l’interessato, reso consapevole, smetterà di annunciare che lui ha due papà. Che commedia sia questa, se questo è tutto il progresso in cui possiamo sperare, io non so. Dico solo una cosa ai dirigenti della Rai tivù: c’è un sacco di posto per la finzione, per la fantapolitica, per la finta realtà, per la pubblicità e la propaganda; evitate, per favore, di usare lo spazio delle notizie per raccontare certe storie. Prima ho detto “pretendo”, ma ho sbagliato, scusate, nei vostri confronti non ho diritti, pago il canone e ho l’obbligo di pagarlo in ogni caso.
*www.libreriadelledonne.it, 29 aprile 2018
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - Un appello per una rifondazione dell’Europa, minacciata da “autoritarismi e divisioni” che segnalano l’emergere di una sorta di “nuova guerra civile europea”.5 maggio 2018, di Federico La Sala
IL RAZZISMO E LA LEZIONE DI VICO
Una commissione contro il razzismo
di Liliana Segre (la Repubblica, 05.05.2018)
Cari ragazzi e ragazze della Nuova Europa, ci sono molti modi per impegnarsi, efficacemente, nella materia, enorme e delicata, della discriminazione, ed io non cerco scorciatoie. Per dirla con parole antiche (Giambattista Vico) i rischi di una deriva autoritaria sono sempre dietro l’angolo. Lui, l’autore dei corsi e ricorsi storici, aveva visto lungo. Arrivo subito al punto consegnando a voi, che siete su un’isola, un “messaggio in bottiglia”: il mio primo atto parlamentare.
Intendo infatti depositare nei prossimi giorni un disegno di legge che istituirà una Commissione parlamentare d’indirizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, razzismo, e istigazione all’odio sociale. Si tratta di raccogliere un invito del Consiglio d’Europa a tutti i paesi membri, ed il nostro Paese sarebbe il primo a produrre soluzioni e azioni efficaci per contrastare il cosiddetto hate speech.
Questo primo passo affianca la mozione che delibera, anche in questa legislatura ( la mia firma segue quella della collega Emma Bonino) la costituzione di una Commissione per la tutela e l’affermazione dei diritti umani. C’è poi il terzo anello del discorso, l’argomento che più mi sta a cuore e che coltivo con antica attitudine: l’insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado della storia del ‘900. In una recentissima intervista, la presidentessa dell’Anpi, Carla Nespolo, ha insistito sullo stesso punto: «La storia va insegnata ai ragazzi e alle ragazze perché raramente a scuola si arriva a studiare il Novecento e in particolare la seconda guerra mondiale. Ma soprattutto non si studia che cosa ha significato per interi popoli europei vivere sotto il giogo nazista e riconquistare poi la propria libertà». Ora che le carte sono in tavola rivolgo a voi un invito molto speciale.
Un appello per una rifondazione dell’Europa, minacciata da “autoritarismi e divisioni” che segnalano l’emergere di una sorta di “nuova guerra civile europea”.
Il vento che attraversa l’Europa non è inarrestabile. Riprendete in mano le carte che ci orientano, che sono poche ma buone: in quelle righe sono scolpiti i più alti principi della convivenza civile, spetta a voi battervi perché trovino applicazione: grazie alla nostra Costituzione (70 anni fa) siamo entrati nell’età dei diritti e gli articoli 2 e 3 della Carta sono lì a dimostrarlo, il passaporto per il futuro.
La carta europea dei diritti fondamentali (che ha lo stesso valore dei trattati) è l’elevazione a potenza europea di questi principi, intrisi di libertà ed eguaglianza che abbiamo, orgogliosamente, contribuito a esportare.
Se vogliamo impastare i numeri con la memoria direi che siamo passati, in un solo “interminabile” decennio, dalla difesa della razza (1938) alla difesa dei diritti (1948). Il futuro deve essere orientato diversamente nel solco dei diritti inalienabili ecco perché, concedetemi la citazione, a cinquant’anni dal suo assassinio, Martin Luther King diceva che occorre piantare il melo anche sotto le bombe. È questo il momento giusto!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MISTICISMO. Uscire dallo Stato di minorità (superiorità).30 aprile 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MISTICISMO. Uscire dallo Stato di minorità (superiorità) ...
 LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.
LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
 IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".
IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- L’EREDITA’ DI MARX. Un principio e un imperativo da riscoprire in questo nostro tempo (di M. Viroli).28 aprile 2018, di Federico La Sala
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ...
La critica radicale del presente: l’eredità di Marx
di Maurizio Viroli (Il Fatto, 28.04.2018)
Non saprei dire quanti altri giovani della mia generazione misero in soffitta Karl Marx dopo aver letto l’articolo Esiste una teoria marxista dello Stato? che Norberto Bobbio pubblicò nel 1975 su Mondoperaio, e ripubblicò nel 1976 nel libro Quale socialismo?, ma sospetto siano stati molti.
La risposta di Bobbio era netta: negli scritti di Marx e di Friedrich Engels, “una vera e propria teoria socialistica dello Stato non esiste”. A nulla valsero le centinaia di pagine scritte dagli intellettuali ‘organici’, come si diceva allora, al Partito comunista per confutare Bobbio e salvare Marx. Se Marx non aveva fornito una teoria dello Stato, come poteva essere guida intellettuale di un partito che aspirava a guidare lo Stato democratico?
Messo da parte Marx, cercammo altri maestri che potessero aiutarci a credere nel socialismo senza essere marxisti. Trovammo per nostra fortuna Carlo Rosselli e il suo Socialismo liberale che proprio Bobbio aveva curato in una bella edizione Einaudi del 1973. La prima pagina di quel libro aveva il valore di una rivelazione o di una conferma di quanto già pensavamo, vale a dire che il limite maggiore della teoria sociale e politica di Marx era la pretesa (rafforzata e popolarizzata dal buon Friedrich Engels) di essere dottrina scientifica : “L’orgoglioso proposito di Marx fu quello di assicurare al socialismo una base scientifica, di trasformare il socialismo in una scienza, anzi nella scienza sociale per definizione [...] Doveva avverarsi, non poteva non avverarsi; e si sarebbe avverato non per opera di una immaginaria volontà libera degli uomini, ma di quelle forze trascendenti e dominanti gli uomini e i loro rapporti che sono le forze produttive nel loro incessante svilupparsi e progredire.”
Rosselli capì che il Manifesto del Partito comunista aveva immensa forza d’ispirazione perché era profezia travestita da scienza: “Quale pace, quale certezza dava il suo linguaggio profetico ai primi apostoli perseguitati! “
Ma già agli inizi del Novecento, dopo la disputa sul revisionismo aperta dal libro di Eduard Bernstein, uscito nel 1899 (che Laterza ha pubblicato in traduzione italiana nel 1974 con il titolo I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia), i più intelligenti giudicarono la scienza di Marx del tutto incapace di spiegare la realtà economica e sociale, e non trovarono più né conforto né guida nella profezia ormai irrigidita in stanche formule ripetute meccanicamente. Eppure, molte pagine di Marx, soprattutto del giovane Marx, offrono ancora, se le leggiamo senza i vecchi condizionamenti ideologici, elementi per una teoria dell’emancipazione sociale.
La lettera che Marx spedisce ad Arnold Ruge da Kreuznach, nel settembre del 1843, poi pubblicata nei Deutsch-Französische Jahrbücher del 1844, ad esempio, è un testo che ci insegna i lineamenti di una critica sociale e politica intransigente: “Costruire il futuro - scrive Marx - e trovare una ricetta valida perennemente non è affar nostro, ma è certo più evidente ciò che dobbiamo fare nel presente: la critica radicale di tutto l’esistente”. Critica radicale perché senza riguardi, senza paura né dei suoi risultati né del conflitto coi poteri attuali. E ci insegna che la lotta per la libertà e per la giustizia deve essere in primo luogo lavoro paziente di educazione delle coscienze: “Indi il nostro motto sarà: riforma della coscienza, non con dogmi, bensì con l’analisi della coscienza mistica, oscura a se stessa, in qualunque modo si presenti (religioso o politico)”.
L’emancipazione politica e sociale non era per il giovane Marx risultato di tendenze oggettive della storia, ma conquista di coscienze emancipate che sanno riscoprire il sogno o la profezia di giustizia che l’umanità ha coltivato in varie forme nella sua lunga storia: “così si vedrà che da tempo il mondo sogna una cosa, di cui deve solo aver la coscienza per averla realmente. Si vedrà che non si tratta di tracciare una linea fra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità non inizi un lavoro nuovo, bensì attui consapevolmente il suo antico lavoro”.
Nello stesso fascicolo (l’unico che vide la luce) Marx pubblicò anche un’Introduzione a Per la critica della Filosofia del diritto di Hegel, dove sostiene che il proletariato è la sola classe sociale che emancipando se stessa emancipa l’intera società e che la filosofia può trovare nel proletariato “le sue armi materiali”. La filosofia (ovvero gli intellettuali) è dunque la “testa di questa emancipazione”; “il suo cuore è il proletariato”. Due illusioni nobili, queste del giovane Marx, ma pur sempre illusioni.
Il proletariato, allora come oggi, è una classe oppressa e umiliata, ma resta una classe particolare che nella sua storia ha lottato e sofferto per finalità di emancipazione generale, ma ha anche sostenuto demagoghi autoritari. Attribuire al proletariato il semplice ruolo di cuore e forza materiale dello sforzo di emancipazione e agli intellettuali quello di cervello, significa aprire la strada, come la storia ha abbondantemente dimostrato, a freddi professionisti della rivoluzione e del governo, incapaci di condividere le sofferenze e le speranze degli oppressi e dunque pronti a diventare non compagni di lotta, ma nuovi dominatori.
In questo saggio, nato in un contesto segnato da appassionati dibattiti su religione e emancipazione sociale (ben documentato dalla recente biografia scritta da Gareth Stedman Jones, Karl Marx. Greatness and Illusion, Harvard University Press, 2016) Marx ha consegnato alla storia la sua celebre critica dell’alienazione religiosa: “L’uomo fa la religione, e non la religione l’uomo. [...] Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana non possiede una realtà vera. La lotta contro la religione è dunque mediatamente la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l’aroma spirituale. La miseria religiosa è insieme l’espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo”. Sarebbe facile osservare che la religione, in particolare la religione cristiana, ha sostenuto importanti esperienze di liberazione politica e sociale.
Ma dalla critica alla religione, Marx trae due conclusioni di straordinario valore morale e politico: la prima consiste nel principio che “l’uomo è per l’uomo l’essere supremo”; la seconda nell’“imperativo categorico di rovesciare tutti i rapporti nei quali l’uomo è un essere degradato, assoggettato, abbandonato, spregevole”. Un principio e un imperativo da riscoprire in questo nostro tempo che ha completamente perso l’idea stessa, e anche la speranza, dell’emancipazione sociale.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.- "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - Chi è il numero uno? Eugen Rosenstock-Huessy e il ruolo della prima persona (di Damion Searls).6 aprile 2018, di Federico La Sala
Chi è il numero uno?
Eugen Rosenstock-Huessy e il ruolo della prima persona.
di Damion Searls (Il Tascabile, 03.04.2018) *
Può essere sconvolgente rendersi conto, all’improvviso, che qualcosa a cui non avevi mai pensato - qualcosa che avevi sempre accettato come reale - è solo un articolo di fede. Spesso è il linguaggio a far accendere la lampadina: qualcuno ridefinisce la realtà con una nuova parola (mansplaining, Rebecca Solnit) o mostrando i poteri nascosti e le interconnessioni di una parola antica (debito, David Graeber). Raramente la rivelazione riguarda il linguaggio in sé.
- Tra tutti i dogmi dell’antichità classica, solo la grammatica non ha perso terreno. La geometria Euclidea, l’astronomia Tolemaica, la medicina Galenica, la legge Romana, la dottrina Cristiana - tutte sono state radicalmente smantellate dalle Scuole. Ma ancora oggi, la grammatica Alessandrina continua a regnare.
La citazione è di Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973), un teorico del Cristianesimo dell’età moderna molto particolare. (Tutte le traduzioni sono dal volume The Language of the Human Race: An Incarnate Grammar in Four Parts [Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhafte Grammatik in vier Teilen].) Rosenstock-Huessy ha ispirato alcuni connoisseur, tra cui W. H. Auden e Peter Sloterdijk, ma possiamo dire in tutta tranquillità che è ancora poco conosciuto. È difficile capire cosa pensare di lui. Di sicuro trovo fastidiosa la palese importanza della nascita di Cristo - o della Missione Divina - che inserisce regolarmente nei suoi ragionamenti filosofici. (Auden: “Chi lo legge per la prima volta può trovare, come è capitato a me, certi aspetti della sua scrittura un po’ difficili da accettare... Per quanto mi riguarda, posso solo dire che ascoltando Rosenstock-Huessy, io sono cambiato”). Il dogma grammaticale a cui fa riferimento - e contro cui si è battuto a morte in un libro di oltre 1.900 pagine - è la lista all’apparenza innocente che risale ai Greci: la prima persona, la seconda persona, la terza persona. Io amo, tu ami, egli ama, o, se avete studiato Latino, amo, amas, amat.
- “Tutti impariamo le lingue seguendo quelle liste. Cosa possono avere di tanto significativo? ...Nell’ordine Alessandrino, ogni persona è soggetta alla stessa trafila. Ogni persona sembra parlare allo stesso modo. Da qui ha origine l’errore fatale. Tanta della nostra confusione sui rapporti sociali e tanta della nostra ignoranza sul linguaggio può derivare direttamente da questo singolo errore. Mettere in fila amo, amas, amat, amamus, ecc, dà adito all’impressione che tutti questi “giudizi” possano e debbano essere trattati con lo stesso significato interpersonale. L’effetto, su chiunque impari questa sequenza, è l’idea che ogni frase all’indicativo sia pronunciata con lo stesso livello di “passione”. La mia rivendicazione è che amat e amo e amas sono agli antipodi, da un punto di vista sociale, e che quindi non debbano essere insegnati come simili. La lista Alessandrina non è affidabile.”
Non sta dicendo che dovremmo aggiungere una forma per la “quarta persona”, come per esempio la distinzione tra terze persone in Ojibwe, oppure una “persona zero” per le costruzioni impersonali come in Finlandese. Sta dicendo che rendere “io” la prima persona è il peccato originale non solo della linguistica, ma della filosofia, della scienza e della stessa vita sociale. E lo intende davvero. Teoricamente, appiattisce l’esperienza vissuta in resoconti freddi e asettici, assimilando tutto all’“affermazione” di un “dato” in terza persona che non richiede alcun coraggio personale, non ha alcuna rilevanza sociale.
- Amat è pronunciato come un fatto, senza nessun coinvolgimento interiore. Dà delle informazioni su qualcosa. Amo e amas, al contrario, non possono essere pronunciati senza conseguenze sociali importanti. Amo è un’ammissione, confessa un segreto. Amas dichiara qualcosa. Entrambi presuppongono passione, e quindi dobbiamo studiare che cosa significano passione ed enfasi in quanto elementi sociali della grammatica.
Empiricamente, la lista Greca commette un errore: la “prima persona” infatti non arriva per prima. L’io di un bambino si sviluppa quando gli viene rivolta la parola, da un genitore o da un’altra persona che si prende cura di lui. Qualcuno deve dire “tu” nel modo giusto perché un “io” non folle possa di fatto esistere. (Vedi Neither Sun Nor Death di Peter Sloterdijk, p. 30, dove ho sentito parlare di Rosenstock-Huessy per la prima volta). Dal punto di vista psicologico, neurocognitivo e dello sviluppo, “io” è l’ultima persona. Sei un bravo bambino. La bottiglia è lì. Ho fame.
- “Tutte le nostre esperienze insegnano esattamente l’opposto di questa dottrina greca rispetto al primato dell’“io” individuale! Il bambino inizia a definirsi gradualmente come un essere indipendente in seguito alle migliaia di attenzioni e impressioni e influssi che lo avvolgono, lo circondano, lo premono da ogni parte. La prima cosa che scopre è di non essere il mondo, né la madre o il padre, né Dio, ma qualcosa d’altro.
 La prima cosa che succede a ogni bambino, a ogni persona, è che gli o le si rivolge la parola: gli si sorride, gli si domanda qualcosa, gli si dà qualcosa, si culla, si conforta, si punisce, si nutre. Il bambino è prima un Tu per un essere esterno potente, soprattutto i genitori... Sentire che esistiamo per gli altri, che vogliono qualcosa da noi, precede qualsiasi affermazione che noi siamo noi o qualsiasi affermazione di che cosa siamo. Ricevere ordini ed essere giudicati dall’esterno è quello che ci dà consapevolezza di noi stessi.”
La prima cosa che succede a ogni bambino, a ogni persona, è che gli o le si rivolge la parola: gli si sorride, gli si domanda qualcosa, gli si dà qualcosa, si culla, si conforta, si punisce, si nutre. Il bambino è prima un Tu per un essere esterno potente, soprattutto i genitori... Sentire che esistiamo per gli altri, che vogliono qualcosa da noi, precede qualsiasi affermazione che noi siamo noi o qualsiasi affermazione di che cosa siamo. Ricevere ordini ed essere giudicati dall’esterno è quello che ci dà consapevolezza di noi stessi.”
È questa la rivelazione che mi ha tanto colpito. La prima persona non è la prima. Non esiste nessuna lista, a parte quelle che inventiamo. Che aspetto avrebbe il mondo se potessi vedere al di fuori di questo schema? Se prima venisse un legame tanto forte da darti l’autorità di giudicare l’esperienza di qualcun altro - tu ami, tu hai fame, sei carino oggi, ti stai comportando male - e poi venisse una visione condivisa del mondo, e solo successivamente un’espressione di sé? L’idea Cartesiana, “penso dunque sono”, e tutte le distinzioni tra mente/corpo/io/altro avrebbero potuto non emergere mai se Cartesio non fosse stato indottrinato con l’idea che “io” viene per primo. Esistono romanzi in prima e in terza persona, ma la seconda è un’anomalia, proprio come nella vita reale non possiamo prenderci la libertà di parlare per una seconda persona come faremmo di noi stessi in quest’era dell’espressione di sé. Quanto altro ancora della natura del romanzo, e della percezione della mia vita, risale essenzialmente alla grammatica greca di duemila anni fa?
- Nella nostra società moderna, amo e amas sono trattati alla stregua di semplici affermazioni come amat. E la spudoratezza della psicologia, delle classificazioni sociali, della tirannia dei fisici e degli analisti, sono alcuni dei risultati di questa mancanza di saggezza e autorità nello schema grammaticale. Ognuno è portato a pensare a se stesso o se stessa come parte di una sequenza di fatti, come se lui o lei fossero una Terza Persona.
Vale la pena notare che scrisse questi pensieri sulla tirannia nel 1945. E che l’uso del “lui o lei”, ben avanti sui tempi, è suo.
- “Questo fa poggiare i rapporti umani su una falsa base, una base obiettiva, che li svilisce. Perché parliamo in modo obiettivo di chi è assente e quindi non arrossirà per quello che diciamo o non si arrabbierà o in ogni caso non dovrà stare ad ascoltare. I rapporti umani prosperano quando possiamo conservare un legame segreto e un desiderio intimo di ascoltare. I rapporti umani muoiono quando tutte le nostre affermazioni si riducono a un semplice dato di fatto. Perché a quel punto ci stiamo solo insultando l’un l’altro. L’esercito, le fabbriche, le scuole, gli ospedali - insultano così spesso.”
Rosenstock-Huessy fa risalire tutto a questo peccato, dai conflitti con l’autorità a scuola alla schizofrenia, e avanza delle rivendicazioni impressionanti per un proprio “metodo grammaticale” che riconfiguri il linguaggio. Come dicevo, non so cosa pensare al riguardo. Ma è qui, presentato per voi sotto forma di paragrafi alternati da me e da lui. Voi siete la prima persona. Fatene quello che volete.
- “Possiamo studiare la grammatica avanzata così come si studia la matematica avanzata. Quando ancora bruciavamo le streghe sul rogo, la matematica avanzata ci ha guariti illuminando l’universo in modo così completo da non lasciare più spazio alle streghe. La matematica avanzata, abbracciando l’infinito, ci ha permesso di carpire i segreti della massa e dell’energia, del tempo naturale e dello spazio. Il mondo non è più magico e stregato. Il suo ordine atomico è diventato trasparente, con l’aiuto della matematica avanzata. Una grammatica avanzata, che si occupi del tipo di enfasi che il discorso pone sulle nostre parole e sulle nostre azioni, ci permetterebbe di carpire i segreti dei movimenti sociali, delle masse e degli individui, delle patologie e della guarigione della vita politica. La grammatica base ha degradato il linguaggio fino a renderlo uno strumento arbitrario dello spirito umano; la grammatica avanzata lo aggiusterà.”
 Traduzione di Alessandra Castellazzi. Si ringraziano l’autore e The Paris Review per la pubblicazione dell’articolo.
Traduzione di Alessandra Castellazzi. Si ringraziano l’autore e The Paris Review per la pubblicazione dell’articolo.* Damion Searls traduce dal tedesco, dal norvegese, dal francese e dall’olandese. Ha tradotto classici come Proust, Rilke, Nietzsche, e Ingeborg Bachmann. Il suo ultimo libro è Macchie d’inchiostro - Storia di Hermann Rorschach e del suo test.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - Inconscio ergo sum: i "ritratti del desiderio" (di M. Recalcati).27 marzo 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..... *
Inconscio ergo sumChi dice che è morta? Prima che terapeutica l’invenzione freudiana è una rivoluzione etica. E la scommessa più ardita si chiama “desiderio”. Da assecondare così
di Massimo Recalcati (la Repubblica, Robinson, 25.03.2018)
- Il libro. Ritratti del desiderio di Massimo Recalcati (172 pagine, 14 euro, con le fotografie di Giancarlo Fabbri) è pubblicato da Raffaello Cortina Editore. E’ uscita da pochi giorni una ristampa con una nuova prefazione dell’autore
Che cosa resta della grande lezione di Freud? Cosa resiste della esperienza sovversiva dell’inconscio? Cosa della grande rivoluzione culturale rappresentata dalla psicoanalisi è destinato a non essere cancellato? Il progresso delle neuroscienze, l’affermazione delle psicoterapie cognitivo-comportamentali, la potenza chimica dello psicofarmaco, la promessa di terapie brevi ed efficaci centrate sul cosiddetto “ sintomo bersaglio”, sembra abbiamo messo definitivamente all’angolo la psicoanalisi riducendola a uno spettro condannato a circolare solo nel museo delle cere del Novecento. Lo si grida da più parti e ormai da molto tempo: la psicoanalisi è morta, le sue categorie teoriche irrimediabilmente compromesse da un irrazionalismo di fondo che rifiuta di confrontarsi con la valutazione scientifica, la sua efficacia terapeutica dubbia, la proverbiale lunghezza delle sue cure assolutamente sfasata rispetto al ritmo performativo richiesto dallo spirito del nostro tempo e indice di una fumisteria epistemologica e clinica priva di fondamenti.
Perché allora dovremmo insistere nel difendere tenacemente l’invenzione di Freud? Il nucleo di questa invenzione è etico prima che terapeutico. Se il Novecento è stato il secolo del sacrificio della singolarità schiacciata sotto il peso inumano dell’universale ideologico della Causa, la teoria e la pratica della psicoanalisi, sin dalla sua origine, si è posta al servizio del carattere insacrificabile della singolarità. Non certamente della natura borghese dell’Io o dell’individualismo liberista, ma di quella singolarità assai più ampia che sconfina in zone dell’essere che eccedono la coscienza e la sua illusione (cartesiana) di padronanza. La singolarità irregolare e anarchica dell’inconscio impone infatti di ripensare innanzitutto il concetto stesso di identità. Certamente questo riguarda la sessualità umana che Freud rivela essere sempre parzialmente contaminata da quella infantile e pregenitale come se non esistesse una sessualità cosiddetta “matura”, “genitale”, perché essa vive e si nutre di fantasmi che provengono dalle esperienze infantili del corpo pulsionale.
 Ma la prima vera e grande sovversione etica imposta da Freud è quella che ci costringe a modificare la nostra ordinaria concezione della malattia e della sofferenza psichica. Questo è un contributo ancora attualissimo e nevralgico della psicoanalisi: l’eccessivo compattamento identitario del soggetto non è una virtù da salvaguardare, ma è la vera malattia da curare. La divisione multipla interna al soggetto - tra coscienza, preconscio e inconscio, tra Es, Io e Super- io - ci costringe infatti a ridisegnare la nostra idea della vita umana. L’Io non è mai padrone in casa propria: l’alterità non è innanzitutto esperienza dello straniero che viene dal di fuori, ma del nostro stesso essere, della nostra più propria intimità.
Ma la prima vera e grande sovversione etica imposta da Freud è quella che ci costringe a modificare la nostra ordinaria concezione della malattia e della sofferenza psichica. Questo è un contributo ancora attualissimo e nevralgico della psicoanalisi: l’eccessivo compattamento identitario del soggetto non è una virtù da salvaguardare, ma è la vera malattia da curare. La divisione multipla interna al soggetto - tra coscienza, preconscio e inconscio, tra Es, Io e Super- io - ci costringe infatti a ridisegnare la nostra idea della vita umana. L’Io non è mai padrone in casa propria: l’alterità non è innanzitutto esperienza dello straniero che viene dal di fuori, ma del nostro stesso essere, della nostra più propria intimità.
 L’inconscio freudiano è infatti “uno stato nello stato” - un “territorio straniero interno” - che obbedisce a una legislazione che eccede radicalmente quella che governa il funzionamento normativo dell’Io. Nei sogni, nelle nostre più quotidiane sbadataggini, nei lapsus, nei sintomi di una singolarità eccedente l’Io parla, manifesta la propria voce dissonante disturbando il funzionamento diurno della coscienza e del pensiero. Ne deriva, appunto, un’inedita concezione della malattia e della sofferenza psichica che scaturirebbe non tanto da una assenza o da una debolezza dell’Io, ma da una sua postura troppo rigida, da una mancanza di democrazia interna che vorrebbe escludere la voce dell’inconscio dal parlamento interno del soggetto. Se queste procedure egoico-narcisistiche di esclusione si rafforzano, se il soggetto persegue una rappresentazione solo ideale di sé stesso finalizzata a scongiurare l’esistenza di quelle parti di sé giudicate “incompatibili” con questo stesso Ideale, la vita si atrofizza e si ammala. È un principio clinico che riguarda tanto la vita individuale quanto quella collettiva: i confini che disegnano la nostra identità devono essere plastici, capaci più di integrare lo straniero interno che di scindere e segregare. La psicoanalisi incoraggia una politica anti-segregativa.
L’inconscio freudiano è infatti “uno stato nello stato” - un “territorio straniero interno” - che obbedisce a una legislazione che eccede radicalmente quella che governa il funzionamento normativo dell’Io. Nei sogni, nelle nostre più quotidiane sbadataggini, nei lapsus, nei sintomi di una singolarità eccedente l’Io parla, manifesta la propria voce dissonante disturbando il funzionamento diurno della coscienza e del pensiero. Ne deriva, appunto, un’inedita concezione della malattia e della sofferenza psichica che scaturirebbe non tanto da una assenza o da una debolezza dell’Io, ma da una sua postura troppo rigida, da una mancanza di democrazia interna che vorrebbe escludere la voce dell’inconscio dal parlamento interno del soggetto. Se queste procedure egoico-narcisistiche di esclusione si rafforzano, se il soggetto persegue una rappresentazione solo ideale di sé stesso finalizzata a scongiurare l’esistenza di quelle parti di sé giudicate “incompatibili” con questo stesso Ideale, la vita si atrofizza e si ammala. È un principio clinico che riguarda tanto la vita individuale quanto quella collettiva: i confini che disegnano la nostra identità devono essere plastici, capaci più di integrare lo straniero interno che di scindere e segregare. La psicoanalisi incoraggia una politica anti-segregativa.
 La prima grande lezione etica della psicoanalisi consiste nel favorire una concezione indebolita della soggettività che consenta il transito e l’apertura in alternativa a ogni sua illusione identitaria di padronanza che finisce per irrigidire i propri confini contribuendo alla loro chiusura.
La prima grande lezione etica della psicoanalisi consiste nel favorire una concezione indebolita della soggettività che consenta il transito e l’apertura in alternativa a ogni sua illusione identitaria di padronanza che finisce per irrigidire i propri confini contribuendo alla loro chiusura.Quale è il volto dello straniero che si tratta di accogliere? Innanzitutto quello del desiderio che esprime la dimensione radicalmente insacrificabile della singolarità. Si tratta di un’altra grande e ardita scommessa della psicoanalisi: non contrapporre la ragione al desiderio - come la luce all’ombra - ma fare della “ voce del desiderio” la voce stessa della ragione. È questo un punto nevralgico presente nel pensiero di Freud, ripreso con forza da Lacan: non solo la vita si ammala per un eccesso di solidificazione dell’identità, ma anche quando essa volta le spalle alla chiamata del desiderio, quando tradisce la sua attitudine, la sua vocazione, il suo talento fondamentale. Questo desiderio - assimilato kantianamente da Freud alla “voce della ragione” - non può essere normalizzato, irreggimentato, assoggettato da nessun principio, compreso quello di realtà. La difesa della singolarità comporta l’opzione per un pensiero laico, anti-dogmatico, anti-fondamentalista, critico nei confronti di ogni tentativo di assimilazione del singolare nelle procedure anonime dell’universale.
 È il tratto, se si vuole, irriducibilmente “ femminista” della psicoanalisi: la cura è cura per il particolare, per la sua differenza assoluta, per l’incomparabile, per la vita non nel suo statuto generico e biologico ma nel suo nome proprio, nel suo volto unico e irriproducibile. Questo comporta un attrito fatale nei confronti di tutte le pratiche di normalizzazione autoritaria e di medicalizzazione disciplinare della vita. La vita del desiderio - la vita della singolarità - è sempre vita storta, difforme, deviante, bizzarra, anomala.
La psicoanalisi opta per l’accoglienza di questo “straniero interno” come condizione di possibilità per l’accoglienza della vita in tutte le sue forme più divergenti. Essa contrasta politicamente ogni conformismo del pensiero, ogni attitudine all’adattamento passivo, ogni ideale moralistico di normalità. Non esiste infatti mai un “rapporto giusto col reale”, affermava Lacan. Ciascuno ha il compito di trovare la propria misura della felicità.
È il tratto, se si vuole, irriducibilmente “ femminista” della psicoanalisi: la cura è cura per il particolare, per la sua differenza assoluta, per l’incomparabile, per la vita non nel suo statuto generico e biologico ma nel suo nome proprio, nel suo volto unico e irriproducibile. Questo comporta un attrito fatale nei confronti di tutte le pratiche di normalizzazione autoritaria e di medicalizzazione disciplinare della vita. La vita del desiderio - la vita della singolarità - è sempre vita storta, difforme, deviante, bizzarra, anomala.
La psicoanalisi opta per l’accoglienza di questo “straniero interno” come condizione di possibilità per l’accoglienza della vita in tutte le sue forme più divergenti. Essa contrasta politicamente ogni conformismo del pensiero, ogni attitudine all’adattamento passivo, ogni ideale moralistico di normalità. Non esiste infatti mai un “rapporto giusto col reale”, affermava Lacan. Ciascuno ha il compito di trovare la propria misura della felicità.
 La psicoanalisi è una teoria critica della società: il potere che impone una misura unica della felicità diviene necessariamente totalitario. La sua vocazione è antifascista nel senso più radicale e militante del termine: veglia affinché la tentazione autoritaria che spinge l’uomo verso il padrone o verso il suo carnefice che promette la tutela autoritaria da ogni rischio che la libertà della vita fatalmente impone, sia avvistata per tempo.
La psicoanalisi è una teoria critica della società: il potere che impone una misura unica della felicità diviene necessariamente totalitario. La sua vocazione è antifascista nel senso più radicale e militante del termine: veglia affinché la tentazione autoritaria che spinge l’uomo verso il padrone o verso il suo carnefice che promette la tutela autoritaria da ogni rischio che la libertà della vita fatalmente impone, sia avvistata per tempo.
 La psicoanalisi svela che esiste nell’uomo una tendenza pulsionale ad amare più le catene della propria libertà, a disfarsi del proprio desiderio, a consegnarsi nelle mani di una autorità che, in cambio della cessione della propria libertà, assicurerebbe la protezione della vita. È la dimensione “fascista” della psicologia delle masse che costituisce un grande capitolo della ricerca sociale e politica della psicoanalisi oggi più che mai attuale.
La psicoanalisi svela che esiste nell’uomo una tendenza pulsionale ad amare più le catene della propria libertà, a disfarsi del proprio desiderio, a consegnarsi nelle mani di una autorità che, in cambio della cessione della propria libertà, assicurerebbe la protezione della vita. È la dimensione “fascista” della psicologia delle masse che costituisce un grande capitolo della ricerca sociale e politica della psicoanalisi oggi più che mai attuale.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
 CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLIPSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Esperimento di ’eye contact’. ’My mirror’, nell’era dei selfie specchiarsi nell’altro è rivoluzionario.23 marzo 2018, di Federico La Sala
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ... *
- SOCRATE In qual modo potremmo conoscere il più chiaramente possibile la nostra anima? Giacchè, con questa conoscenza, potremo evidentemente conoscere noi stessi. Per gli dei! Comprendiamo bene quel giusto consiglio dell’iscrizione delfica ricordata ora? [...]
- SOCRATE Dunque se un occhio guarda un altro occhio e fissa la parte migliore dell’occhio con la quale anche vede, vedrà se stesso (Platone, “Alcibiade primo”).
- SANT’AMBROGIO - AMBROSIUS, In Epistolam Beati Pauli Ad Corinthios Primam, Caput XIII, Vers. 4-8:
- "Charitas Deus est" (I Joan. 4,8).
- Ambrosius, De Officiis ministrorum, Liber 2, Caput XXX, 155:
 "Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil charitate dulcius, nihil pace gratius"
"Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil charitate dulcius, nihil pace gratius"
 (“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”)
(“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”)
Società & Diritti’My mirror’, nell’era dei selfie specchiarsi nell’altro è rivoluzionario
Esperimento di ’eye contact’, 4 minuti per guardarsi negli occhi altrui
di Redazione ANSA *
- Guardarsi foto bowie15 iStock. © Ansa
 Guarda le foto...
Guarda le foto...
MILANO.
Una doppia cabina, in cui due sconosciuti si siedono uno di fronte l’altro, per 4 minuti, semplicemente per guardarsi negli occhi. Al termine di questa breve interazione, ognuno dei due, assistito da alcuni facilitatori, racconta all’altro le sensazioni che ha provato.
E’ ’My mirror’, un nuovo esperimento di eye contact, organizzato da Caritas Ambrosiana, che sarà possibile sperimentare a Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili dal 23 al 25 marzo.
Le tecniche di eye contact - spiegano gli organizzatori - dimostrano che 4 minuti di contatto visivo avvicinano le persone più di tante parole.
Così, con My Mirror si proverà a favorire l’incontro tra tante persone diverse, per genere, età, nazionalità, storie. L’idea di fondo è che nell’epoca dei selfie, dove ci si specchia solo negli schermi dei propri smartphone, specchiarsi negli occhi di un altro può essere un atto rivoluzionario e comunque non lascia nessuno indifferente
Secondo le stime, in media, ognuno di noi passa 5 anni della propria vita collegato a internet, 11 davanti alla tv. Con quante persone potremmo connetterci se ci prendessimo la briga di guardaci negli occhi gli uni con gli altri? E come cambierebbe la percezione che abbiamo del mondo?
Fragilità, povertà, migrazioni, malattia quando si incarnano in un volto smettono di essere un semplice fenomeno sociale, il titolo di un articolo, spesso di cronaca nera, ma diventano la vita del compagno di scuola e della sua famiglia, del vicino di casa, del parente prossimo.
My Mirror fa parte della campagna di Caritas Internationalis “Share the journey” volta a promuovere la “cultura dell’incontro”.
* ANSA, 23 marzo 2018 (ripresa parziale - senza foto).
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.
- MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO. Il ’cattolicesimo’ è finito...
- GIOACCHINO DA FIORE, LA SORPRENDENTE “CARITÀ”, E IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Sana rivolta verso una sessualità miserrima (di Mariangela Mianiti).20 marzo 2018, di Federico La Sala
USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. Basta - con la connivenza all’ordine simbolico della madre!!!
Sana rivolta verso una sessualità miserrima
Habemus Corpus. Un appunto e una considerazione sulle parole di Papa Francesco sulla prostituzione
di Mariangela Mianiti (il manifesto, 20.03.2018)
«Chi va con le prostitute è un criminale. Questo non è fare l’amore, questo è torturare una donna. È uno schifo! Alcuni governi cercano di fare pagare multe ai clienti. Ma il problema è grave, grave, grave. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% siano battezzati, cattolici. Vorrei che voi giovani lottaste per questo. Se un giovane ha questa abitudine la tagli. La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata».
Così ha parlato Papa Francesco, ieri, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Più chiaro di così non poteva essere e questo vale sia per chi sogna di cancellare la legge Merlin, sia per chi vorrebbe regolamentare la prostituzione, magari copiando la legge approvata in Germania nel 2002 dal governo guidato dal socialdemocratico Gerhard Shröder. Tuttavia, a Francesco è scappata una frase piuttosto infelice quando ha detto: «Non c’è femminismo che sia riuscito a togliere questa mentalità dalla coscienza maschile, dall’immaginario collettivo».
Benché io sia atea, stimo questo Papa che in tanti ritengono ormai l’unico in Italia, e non solo, a dire cose di sinistra, laddove per sinistra si intende ragionare in termini di bene comune e non solo di interesse individuale. Proprio in virtù di questa stima, mi permetto di sottolineare che, se la prostituzione è così viva e vegeta, non è per debolezza del femminismo. Non sono state le donne ad avere inventato, introdotto e alimentato la pratica del sesso a pagamento, ma gli uomini. Sono gli uomini che hanno incrementato, e incrementano, la domanda.
Sono gli uomini a volere pagare per avere a disposizione dei pezzi di corpo femminile. Ora, dire che nessuna forma di femminismo è mai riuscita a sradicare questa mentalità, è un po’ come affermare che le donne, nonostante ci abbiano provato, non sono riuscite a eliminare il problema della prostituzione. Qui bisogna fare un appunto e una considerazione.
L’appunto. Visto che il commercio del sesso esiste perché esiste una domanda maschile, perché dovrebbero essere le donne a farsi carico di tutto il lavoro di rieducazione e lotta? Perché non si chiede agli uomini di farsi un esame di coscienza sul perché hanno bisogno di pagare una donna per poter infilare il loro pene in un orifizio? Per quale ragione il maschio non deve interrogarsi sulla sua idea di desiderio, eros, piacere? Perché non si domanda, e non gli si domanda, dove mai stia la soddisfazione nel comprare sesso? E poi, che cosa sanno del proprio corpo? Che cosa capiscono del corpo altrui? Provano, sentono qualcosa? O sono solo dei poveracci in cerca di un contenitore eiaculatorio?
Se è così, come è molto probabile, gli uomini che pagano per avere sesso soffrono di una malattia gravissima che si chiama Miseria Sessuale.
La considerazione. Nel suo libro Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi e nella sua intervista concessa di recente a Caterina Peroni per il blog Studi sulla questione criminale, Ida Dominijanni spiega molto bene come il movimento #MeToo, e prima ancora le denunce delle escort contro Berlusconi, abbiano svelato un dispositivo sessuale poverissimo, lo scambio di potere per briciole di sesso, che il «fare sesso adesso è proprio un fare, è un fare una cosa, è molto neoliberale, un’attività!», e come «dal MeToo trapeli una sana rivolta contro una sessualità miserrima». Caro Francesco, il femminismo è vivo, vegeto e lotta. Sono certi maschi a essere molto arretrati.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA. L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- "NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
 Uscire dallo "stato di minorità" non significa mangiare un "piatto di lenticchie" ... né "sposare" il Figlio!!!
Uscire dallo "stato di minorità" non significa mangiare un "piatto di lenticchie" ... né "sposare" il Figlio!!!
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta ... sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - “Donne e Potere”. Intervista alla storica Mary Beard (di Anna Lombardi).13 marzo 2018, di Federico La Sala
Donne e potere...
- Quando nell’Odissea omerica Penelope chiede a Femio, l’aedo, di cantare qualcosa di meno triste del periglioso ritorno da Troia degli eroi achei, l’imberbe Telemaco interviene bruscamente, invitando la madre a rientrare nelle proprie stanze e ricordandole che «la parola spetta agli uomini». Per quanto saggia e matura, Penelope china il capo di fronte al figlio e si ritira in silenzio...
L’intervista alla storica Mary Beard
“Il primo #MeToo? Lo twittò Penelope”
Nel nuovo saggio, “Donne e Potere”, la studiosa di Cambridge ripercorre le origini della misoginia Partendo dalla moglie di Ulisse, zittita dal figlio Telemaco in un passaggio sottovalutato dell’Odissea
di Anna Lombardi (la Repubblica, 13.03.2018)
Il movimento #MeToo ha un precedente classico: il mito di Filomele come lo narra Ovidio. Violentata da Tereo, re di Tracia e marito di sua sorella Procne, subisce il taglio della lingua per non svelare la violenza. Ma denuncia ugualmente: tessendo lo stupro sulla tela. Non è simile a quel che fanno le donne in questo momento? Messe a tacere per secoli ora trovano voce su Twitter: la rete è la loro tela». Mary Beard, 63 anni, è la classicista di Cambridge che con bestseller come SPQR ha reso accessibile a tutti, senza mai banalizzarla, la storia dell’antica Roma. La scorsa estate finì nella bufera per aver difeso un cartoon della Bbc che raffigurava un centurione nero, ricordando a chi protestava che “sì, quella romana era una società mista”.
 Ora torna a far discutere col suo ultimo saggio, Donne e potere (Mondadori), basato su due conferenze tenute nel 2014 e 2017, dove traccia una storia della misoginia: cercando di spiegare quanto siano radicati nella cultura occidentale i meccanismi che impongono alle donne il silenzio - e tendono a escluderle dalle posizioni di potere. -Partendo da un episodio dell’Odissea: Penelope zittita dal figlio Telemaco per aver chiesto al cantore Femio qualcosa di meno triste del difficile ritorno da Troia degli eroi achei: «La parola spetta agli uomini».
Ora torna a far discutere col suo ultimo saggio, Donne e potere (Mondadori), basato su due conferenze tenute nel 2014 e 2017, dove traccia una storia della misoginia: cercando di spiegare quanto siano radicati nella cultura occidentale i meccanismi che impongono alle donne il silenzio - e tendono a escluderle dalle posizioni di potere. -Partendo da un episodio dell’Odissea: Penelope zittita dal figlio Telemaco per aver chiesto al cantore Femio qualcosa di meno triste del difficile ritorno da Troia degli eroi achei: «La parola spetta agli uomini».Perché proprio quell’episodio è fondamentale?
«È il primo esempio letterario di un uomo che mette a tacere una donna: dimostra che in questo ambito la cultura occidentale ha migliaia di anni di pratica. L’ho scelto perché, solo capendo quanto sia antico il privilegio dato alla voce maschile, possiamo comprendere il presente: e lavorare sul futuro».
Per comprendere lo scandalo Weinstein e quel che ha comportato dobbiamo dunque andare indietro di 3000 anni?
«Certi comportamenti non sono innati o naturali: sono culturali, tramandati nei secoli. Nell’esporli non ho pensato certo di condannare la cultura classica che pure offre una visione delle donne che deploriamo. Ma per contrastarli dobbiamo capire da dove vengono».
Nel libro lei suggerisce che le donne hanno sempre tentato di rompere il silenzio. Il #MeToo ha dunque radici storiche?
«Battersi per se stesse e le altre alle donne è sempre stato permesso. Il #MeToo dunque rientra in uno spazio tradizionalmente concesso. Plaudo a chi se lo è ripreso: ma non è nuovo».
Nel libro dice di aver notato solo di recente l’episodio di Telemaco che zittisce la madre: siamo così abituate a scene del genere da considerarle norma?
«Temo di sì: per i miei studi ho letto e riletto i classici notando cose nuove ogni volta, ma anche io sono così abituata a veder zittire le donne da non averci fatto caso fino a poco tempo fa. Lavoro a questo tema da prima del #MeToo, ma quel che sta succedendo ha certo ravvivato la nostra sensibilità. Una volta notato quell’episodio non puoi più non vederlo: è un “momento Penelope” inconfondibile, che torna in molti altri esempi letterari. E qualcosa in cui tutte le donne si riconoscono per averlo vissuto sulla loro pelle».
Una sorta di archetipo?
«Piuttosto un’attitudine tramandata e radicata nei secoli. Essendo qualcosa di appreso possiamo disimparare ad attuarla».
Lei nota come da allora la voce femminile in letteratura sia stata irrisa o svilita: ancora oggi quando le donne prendono la parola rischiano ingiurie. Accade anche a lei su Twitter: le sue battaglie coi troll sono celebri.
«C’è ancora chi considera la competenza femminile meno autorevole di quella maschile. E la situazione è più grave per le donne che fanno politica: un esempio è l’immagine di Hillary Clinton decapitata come Medea circolata in ambienti vicini a Donald Trump. O il tentativo di zittire la democratica Elizabeth Warren mentre leggeva una lettera di Coretta King in Senato. La scena ha dato vita allo slogan femminista Nevertheless she persisted, nonostante tutto è andata avanti. Quel “ nonostante tutto” indica che, anche se i tentativi di silenziare le donne falliscono, le cose non sono cambiate abbastanza».
Il silenzio come arma contro le donne nell’America moderna come nella Grecia antica?
«Per fortuna le cose in 3000 anni - e soprattutto negli ultimi 100 - sono cambiate. Non sminuisco i progressi: ma c’è ancora da fare».
Nel libro racconta delle lezioni prese da Margaret Thatcher per rendere la voce più profonda...
«Nei corsi di leadership alle donne si raccomanda ancora di abbassare il tono per renderla più calda: più maschile. Ma perché una voce acuta non è considerata autorevole?».
Lei conosce il passato: come vede il futuro?
«Conoscere la storia mi rende ottimista. Dobbiamo però restare vigili. In tempi di austerità economica i progressi che riguardano le donne subiscono i rallentamenti maggiori».
Il suo è un invito a lavorare sul nostro linguaggio, troppo discriminatorio: dobbiamo inventarne uno nuovo?
«Dovremmo riflettere sulle implicazioni di certe parole. In inglese “ambizioso” è un complimento se rivolto a un uomo, ma un insulto per una donna. Il linguaggio conta. Dobbiamo avviare un processo di aggiustamento e trovare un più giusto modo di esprimerci».
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, CFR.:
- "DONNE E POTERE. Per troppo tempo le donne sono state messe a tacere" (Mary Beard - 2018): Quello a cui penso è il momento immortalato, quasi tremila anni fa, all’inizio dell’Odissea omerica. Oggi tendiamo a considerarla ... Quando dice che lì la «parola» spetta «agli uomini», egli ricorre al termine mythos, che però, in questo caso, non ha il significato che ci è stato trasmesso, quello di «mito». Nel greco omerico il ...
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".DONNE, UOMINI E MATEMATICA. La punta di un "iceberg": una "nota" del "disagio della civiltà"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico la Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - "La bilancia della giustizia": "Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World" (N. Fraser). Rec. di Brunella Casalini.9 marzo 2018, di Federico La Sala
N. Fraser, Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World, Polity Press, Cambridge (UK) 2008, pp. 224, ISBN 978-07456-4486-8 *
di Brunella Casalini (Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale)
Giocando sulla plurivocità semantica del termine inglese "scales", con il titolo Scales of Justice Nancy Fraser evoca due immagini: la bilancia come simbolo classico della capacità della giustizia di agire in modo imparziale e lo spazio cui necessariamente deve far riferimento qualsiasi teoria della giustizia. Sia il concetto di imparzialità sia la dimensione spaziale della giustizia sono oggi oggetto di una contestazione radicale. La contrapposizione tra paradigma redistributivo e paradigma del riconoscimento si è mossa oltre la problematica della risoluzione equa dello scontro tra rivendicazioni conflittuali; è infatti la sostanza stessa dell’idea di giustizia ad essere messa in discussione da coloro che si dividono sulla priorità di redistribuzione e riconoscimento, presentandole come istanze incommensurabili che non possono trovare risposta semplicemente pesandole sulla stessa bilancia.
 Una teoria della giustizia che tenga conto delle diverse concezioni sostantive della giustizia oggi presenti nel dibattito politico, qualora ritenga che ciascuna di esse colga aspetti importanti e diversi del fenomeno dell’ingiustizia, secondo la Fraser, deve rispondere a due sfide: la prima consiste nel vedere cosa possa essere salvato dell’ideale dell’imparzialità e come esso possa essere riformulato, la seconda nel decidere contestualmente, accettando l’esistenza di una pluralità di prospettive, a quale visione della giustizia dare di volta in volta maggiore attenzione.
Una teoria della giustizia che tenga conto delle diverse concezioni sostantive della giustizia oggi presenti nel dibattito politico, qualora ritenga che ciascuna di esse colga aspetti importanti e diversi del fenomeno dell’ingiustizia, secondo la Fraser, deve rispondere a due sfide: la prima consiste nel vedere cosa possa essere salvato dell’ideale dell’imparzialità e come esso possa essere riformulato, la seconda nel decidere contestualmente, accettando l’esistenza di una pluralità di prospettive, a quale visione della giustizia dare di volta in volta maggiore attenzione.Da Justice Interruptus (1997) all’acceso confronto con Axel Honneth, contenuto in Recognition or Redistribution?, la Fraser ha tentato di superare la contrapposizione tra paradigma del riconoscimento e paradigma redistributivo, mediante due operazioni principali: 1) una teorizzazione del riconoscimento incentrata sulla differenza di status, che tende a separare la politica del riconoscimento dalla politica dell’identità, e a vedere nel mancato riconoscimento un’ingiustizia, un impedimento alla parità partecipativa, e non un ostacolo all’autorealizzazione e una ferita psichica (come nei modelli di Honneth e Taylor); e 2) la formulazione di un dualismo di prospettiva capace di cogliere analiticamente tanto le dinamiche di esclusione connesse alle caratteristiche intrinseche del sistema economico capitalistico quanto quelle legate al sistema simbolico-culturale, così da poter proporre soluzioni di volta in volta diverse a seconda delle specifiche condizioni di particolari gruppi sociali e dei presupposti necessari a garantire la parità partecipativa.
Accusata di aver dimenticato il ruolo autonomo della sfera politico-giuridica e l’importanza delle discriminazioni che avvengono sul piano prettamente giuridico e politico, a cominciare dal saggio Redefining Justice in a Globalizing World (2005, qui ripubblicato), Nancy Fraser ha posto accanto alla dimensione culturale del riconoscimento e alla dimensione economica della redistribuzione, una terza dimensione specificamente politica: la dimensione della rappresentanza. Il criterio della rappresentanza risponde a una questione decisiva oggi nei dibattiti intorno alle diverse teorie della giustizia, dibattiti che non vertono più sul "che cosa" la giustizia deve riconoscere, ma sempre più su "a chi" deve riconoscerlo, su quali sono e come si determinano i confini della comunità cui una teoria della giustizia intende applicarsi.
La theory of justice as parity of participation della Fraser viene così a configurarsi come una teoria tridimensionale, che costituisce una sorta di ripresa e revisione della triade weberiana di classe, status e partito - cui, del resto, l’autrice esplicitamente si è richiamata fin dall’inizio nella sua ridefinizione del paradigma del riconoscimento.
 L’aggiunta della terza dimensione appare inscindibile dall’attenzione per la questione del framing, dell’inquadratura dello spazio entro cui si pongono problemi di giustizia. In un contesto post-socialista, post-fordista e soprattutto post-westphaliano le ingiustizie sono insieme incentrate su questioni di misrecognition, misredistribution e misframing. Distribuzione e riconoscimento potevano essere considerate come le due dimensioni cruciali della giustizia finché il quadro di riferimento dello stato-nazione era dato per scontato.
L’aggiunta della terza dimensione appare inscindibile dall’attenzione per la questione del framing, dell’inquadratura dello spazio entro cui si pongono problemi di giustizia. In un contesto post-socialista, post-fordista e soprattutto post-westphaliano le ingiustizie sono insieme incentrate su questioni di misrecognition, misredistribution e misframing. Distribuzione e riconoscimento potevano essere considerate come le due dimensioni cruciali della giustizia finché il quadro di riferimento dello stato-nazione era dato per scontato.
 Con la globalizzazione e la contestazione della cornice keynesiano-westphaliana, la dimensione politica emerge come la terza dimensione fondamentale nell’ambito delle teorie della giustizia. Domanda cruciale diviene infatti se la teoria della giustizia debba continuare a muoversi nello spazio della cittadinanza nazionale, se debba divenire cosmopolitica o se debba venire a riguardare le "comunità transnazionali del rischio".
Con la globalizzazione e la contestazione della cornice keynesiano-westphaliana, la dimensione politica emerge come la terza dimensione fondamentale nell’ambito delle teorie della giustizia. Domanda cruciale diviene infatti se la teoria della giustizia debba continuare a muoversi nello spazio della cittadinanza nazionale, se debba divenire cosmopolitica o se debba venire a riguardare le "comunità transnazionali del rischio".
 La Fraser si è sentita inizialmente vicina alle posizioni di coloro che - come Iris Marion Young - hanno cercato di arrivare alla formulazione di una concezione transazionale mediante l’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia in base al c.d. "all affected principle", ovvero in base ad un principio che fa riferimento alla possibile co-implicazione oggettiva di soggetti anche lontani tra loro in una rete di relazioni causali che può scavalcare i confini nazionali. Ora, Fraser riconosce due limiti a questa soluzione teorica: da un lato, il rimando a reti causali oggettive sembra delegare alle scienze sociali l’individuazione dei soggetti interessati; dall’altro, a causa del paradosso prodotto dal c.d. butterfly principle, per cui siamo tutti influenzati da tutto, rischia di non riuscire a delimitare lo spazio di relazioni sociali rilevanti.
La Fraser si è sentita inizialmente vicina alle posizioni di coloro che - come Iris Marion Young - hanno cercato di arrivare alla formulazione di una concezione transazionale mediante l’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia in base al c.d. "all affected principle", ovvero in base ad un principio che fa riferimento alla possibile co-implicazione oggettiva di soggetti anche lontani tra loro in una rete di relazioni causali che può scavalcare i confini nazionali. Ora, Fraser riconosce due limiti a questa soluzione teorica: da un lato, il rimando a reti causali oggettive sembra delegare alle scienze sociali l’individuazione dei soggetti interessati; dall’altro, a causa del paradosso prodotto dal c.d. butterfly principle, per cui siamo tutti influenzati da tutto, rischia di non riuscire a delimitare lo spazio di relazioni sociali rilevanti.
 Per ovviare a questi inconvenienti, l’autrice propone quale alternativa il c.d. all subjected principle, in base al quale chi è soggetto ad una data struttura della governance (concepita in senso lato in modo da poter comprendere non solo gli stati, ma anche, per esempio, le organizzazioni non governative e agenzie come il WTO e il IMF), ha diritto ad essere riconosciuto come destinatario di giustizia da parte di quella medesima struttura. Il principio all subjected individua non un unico "chi" destinatario della giustizia, ma una pluralità di "chi" collocati a livello locale, nazionale, regionale e, in alcuni casi, globale.
Per ovviare a questi inconvenienti, l’autrice propone quale alternativa il c.d. all subjected principle, in base al quale chi è soggetto ad una data struttura della governance (concepita in senso lato in modo da poter comprendere non solo gli stati, ma anche, per esempio, le organizzazioni non governative e agenzie come il WTO e il IMF), ha diritto ad essere riconosciuto come destinatario di giustizia da parte di quella medesima struttura. Il principio all subjected individua non un unico "chi" destinatario della giustizia, ma una pluralità di "chi" collocati a livello locale, nazionale, regionale e, in alcuni casi, globale.L’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia transazionale può avvenire soltanto lasciando voce alla contestazione e al dialogo ai diversi livelli e creando canali istituzionali formali che consentano di arrivare a decisioni vincolanti. In questa direzione, la Fraser guarda al ruolo che rivestono oggi i movimenti sociali globali: la loro contestazione del quadro westphaliano è insieme un modo per rivendicare il diritto a determinare il "chi" della giustizia e il "come" arrivare alla sua definizione.
 Sbagliano tuttavia, secondo la Fraser, i sostenitori delle visioni populiste, à la Negri e Hardt, che collocano il nesso contestazione/decisione nella società civile, perché le formazioni presenti nella società civile non sono da sole capaci di trasformare le loro proposte in decisioni politiche stringenti e perché esse mancano di rappresentatività e democraticità per poter rivendicare il diritto a ridisegnare i confini della giustizia. Una giustizia transnazionale richiede adeguati canali istituzionali che rispondano alla società civile, ma funzionino al tempo stesso secondo eque procedure e un sistema di rappresentanza che ne assicuri il carattere democratico dando legittimità alle decisioni prodotte. I tratti delle nuove sfere pubbliche transnazionali e delle nuove istituzioni democratiche globali rimangono, tuttavia, al momento, estremamente vaghi nel disegno della Fraser, che evita qui, per altro, di confrontarsi criticamente con le istituzioni sovranazionali esistenti, con i loro limiti e le loro possibilità di riforma.
Sbagliano tuttavia, secondo la Fraser, i sostenitori delle visioni populiste, à la Negri e Hardt, che collocano il nesso contestazione/decisione nella società civile, perché le formazioni presenti nella società civile non sono da sole capaci di trasformare le loro proposte in decisioni politiche stringenti e perché esse mancano di rappresentatività e democraticità per poter rivendicare il diritto a ridisegnare i confini della giustizia. Una giustizia transnazionale richiede adeguati canali istituzionali che rispondano alla società civile, ma funzionino al tempo stesso secondo eque procedure e un sistema di rappresentanza che ne assicuri il carattere democratico dando legittimità alle decisioni prodotte. I tratti delle nuove sfere pubbliche transnazionali e delle nuove istituzioni democratiche globali rimangono, tuttavia, al momento, estremamente vaghi nel disegno della Fraser, che evita qui, per altro, di confrontarsi criticamente con le istituzioni sovranazionali esistenti, con i loro limiti e le loro possibilità di riforma.* La bilancia della giustizia. Ripensare lo spazio politico in un mondo globalizzato di Nancy Fraser edito da Pensa Multimedia, 2012
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE: H. DE LUBAC E IL CATTOLICISMO.7 marzo 2018, di Federico La SalaSTORIA E (FENOMENOLOGIA DELLO) SPIRITO. Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto...
 IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
IL DRAMMA DEL CATTOLICESIMO ATEO E DEVOTO: HENRI DE LUBAC E LA POSTERITÀ SPIRITUALE DI GIOACCHINO DA FIORE.
 L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- «Storia delle donne in Occidente». Michelle Perrot, quando la storia è sessuata. Un’interv. (di Francesca Maffioli)2 marzo 2018, di Federico La Sala
Michelle Perrot, quando la storia è sessuata
Un’intervista con la militante, attivista e intellettuale francese. Cruciale la sua «Storia delle donne in Occidente», insieme a Georges Duby per Laterza nel 1990
di Francesca Maffioli (il manifesto, 02.03.2018)
Nel 1973 Michelle Perrot, insieme a Pauline Schmidt e Fabienne Bock intitolano il loro primo corso all’Università Paris-Diderot: Les femmes ont-elles une histoire? (Le donne hanno una storia?). Tale interrogativo, provocatorio, rappresentava il mezzo per affermare l’esistenza di un campo di conoscenza e di studio pressoché sconosciuto. La seconda generazione della scuola storiografica delle Annales aveva rinnovato le prospettive d’osservazione e d’analisi della storia, comprendendo la storia economica, quella sociale e la considerazione delle categorie oppresse, tra le quali spiccavano le donne. Tuttavia, nei primi anni Sessanta la storia insegnata anche in ambito universitario restava una disciplina tendenzialmente asessuata.
L’INTERROGATIVO delle giovani studiose aveva messo a fuoco la questione dell’invisibilità delle donne nella storia e aveva condotto a domande sui tempi, i luoghi e le modalità dell’oppressione e della dominazione maschile. La storia di questa dominazione aveva cominciato a mettere in risalto la place degli uomini attraverso i secoli, guardando al loro ruolo in quanto soggetti non universali né neutri, ma maschili. In tal senso era stato necessario esaminare e riflettere sul confronto e lo studio della differenza tra i sessi, al fine di consentire una visione più ampia, rinnovata, diremmo più completa, della storia.
Negli anni Novanta la pubblicazione dei cinque volumi della Storia delle donne in Occidente, opera curata dalla stessa Michelle Perrot e da Georges Duby, costituisce uno spartiacque di riconoscenza della legittimità di una storia delle donne. È da ricordare che tale pubblicazione venne proposta e sostenuta dall’editrice italiana Laterza, solo a seguito della quale l’opera venne editata anche in Francia. La riflessione epistemologica attorno alla storia delle donne resta ancora valida, sebbene da una storia in cui le donne sono le protagoniste assenti si è passati a una storia sessuata del mondo intero. Ne chiediamo conto proprio a Michelle Perrot, oggi professoressa emerita all’Università Paris-Diderot, autrice di numerosi testi sulla storia delle donne, tra i quali Mon histoire des femmes (Seuil, 2006) e direttrice, con Georges Duby, del già citato Histoire des femmes en Occident, (Plon, 1991-1992).
La sua opera sulla storia delle donne in occidente ha conosciuto un grande successo. Si tratta di un frutto monumentale - sulla storia della rappresentazione delle donne e sulla storia dei rapporti tra i sessi attraverso i secoli. Quale il legame, quale la connessione, nella storiografia femminile, tra la storia della vita privata e quella pubblica?
È doveroso riconoscere la lungimiranza della casa editrice italiana Laterza, la quale chiese a Georges Duby, ed egli a me, di scrivere una storia delle donne. In realtà l’equipe che lavorò all’opera si era formata molto prima, circa 10 anni, e le nostre riflessioni erano già arrivate a un certo livello di maturazione. Per me e l’equipe (una settantina di persone) fu prioritario che il titolo portasse il sostantivo «donne» al plurale, per rappresentare un panorama tanto composito.
Bisogna tener conto che Duby codiresse precedentemente un’opera a più volumi che trattava della «storia della vita privata», dall’impero romano fino ai giorni nostri; questo aspetto dimorava ampiamente nella sua prospettiva di ricerca. Certo, quando si pensa alla storiografia femminile l’aspetto «del privato» non può essere trascurato, in ordine al legame intrinseco, secolare, tra donne-famiglia-casa; tuttavia a me interessava descrivere in che modo il legame tra le donne e la dimensione pubblica poteva costituirsi come dispositivo per rendere visibili le donne e la loro parola alla luce di una «storia pubblica» che le ignorava. Significava andare oltre la questione privata dei legami e delle strutture della parentela ad esempio, significava distaccarsi da Lévi-Strauss. Per me si trattava anche di una sorta di evoluzione rispetto al debutto dei miei studi: sono stata allieva di Ernest Labrousse, storico e militante anarchico, poi socialista e con lui mi ero specializzata sulla questione degli scioperi in seno al movimento operaio. Non senza stupore da parte del mio maestro sono passata a occuparmi della storia delle donne. Nonostante le polemiche a tal proposito, in particolare mi riferisco a quelle che hanno visto il femminismo degli anni Sessanta «traditore» delle istanze della lotta operaia, sono convinta che le due prospettive non siano da considerarsi in opposizione o inconciliabili. Anzi il contrario.
Fare la storia delle rappresentazioni e dei discorsi maschili riguardo le donne può rischiare di farci dimenticare le donne in quanto soggetto?
Non posso negare che il rischio sia presente, anche in misura piuttosto decisiva. In effetti la storia delle rappresentazioni e dei discorsi maschili mette in luce una prospettiva parziale e circoscritta. Tuttavia possiamo analizzare lo stesso attraverso la differenza dei sessi, possiamo cercare di interrogarlo, di decostruirlo. Faccio un esempio: invece di studiare il tema della «bellezza femminile» attraverso i secoli, secondo la prospettiva dello sguardo maschile, si può farlo chiedendosi come le donne hanno reagito a tale sguardo e qual è il loro. Si tratta di essere in grado di capovolgere delle prospettive attraverso la consapevolezza della loro parzialità. Credo che il recente movimento del #me too possa a tutti gli effetti rappresentare un esempio del capovolgimento di prospettiva e una rideterminazione del ruolo delle donne, a fronte dell’invisibilizzazione e del silenziamenento forzato. Non esito a ribadire che protestare contro le violenze, le più subdole, vuol dire rideterminare il proprio ruolo e reimpossessarsi della propria voce e del proprio corpo in quanto soggetti.
Da quale momento, nella storia delle donne in occidente, possiamo cominciare a parlare di «svolte storiche» per i rapporti tra i sessi? E a partire da quale momento si comincia a percepire il mondo e la storia come sessuate?
Questo interrogativo mi consente di dichiarare a piena voce che il mio punto di vista riguardo a queste svolte storiche coincide con quello di Michel Foucault esposto nella sua Histoire de la Sexualité (1976-1984). Credo infatti che una grande svolta sia stata quella che ha coinciso con la maturazione del pensiero sulla sessualità sviluppato nei testi dell’antichità cristiana; non il pensiero sessuato greco-romano ma soprattutto quello dei padri della Chiesa, in particolare S. Agostino. L’incisività di quest’ultimo limitatamente alla peccaminosità dell’atto sessuale o all’imposizione del velo definiscono la sua auctoritas sul pensiero del rapporto tra i sessi. Tengo a sottolineare quest’ultimo aspetto, per ribadire «il primato» della patristica a fronte delle polemiche che da anni si susseguono a tal proposito. Anche il XVII secolo, di prospettive sorprendentemente egualitarie, rappresenta una svolta storica: penso a François Poullain de La Barre e a Marie de Gournay - in che misura il loro razionalismo ha prodotto delle svolte di pensiero sull’eguaglianza dei sessi. Bisogna sottolineare che si può assistere anche a regressi in tal senso: un esempio è stato il secolo successivo, il XVIII, che ha rimesso in discussione quanto sembrava acquisito, con un ritorno al biologismo più basilare e alla «re-naturalizzazione».
Che ne pensa della tendenza a concepire una storia delle donne attorno alle grandi figure, secondo «un sostenersi» alle singolarità, alle biografie di donne più o meno celebri? Mi riferisco in tal senso alla recentissima traduzione francese di «Storie della buonanotte per bambine ribelli» (Mondadori), ma anche a «Ni vues ni connues» (Hugo doc-Les Simone) del collettivo Georgette Sand...
È un modo come un altro di scrivere la storia delle donne. Tuttavia io trovo che facilmente possa incorrere nel rischio di integrarsi a una tradizione decisamente datata. Mi riferisco a quel biografismo che si attiene a fatti curiosi: penso al biografismo «delle regine, delle sante e delle cortigiane». In questo senso si rischia di perdere la ricchezza della complessità e la storia delle donne rischia di diventare aneddotica.
Cosa ci resterebbe della «Nouvelle Histoire» e della scuola delle «Annales»?
Credo che tale formula possa funzionare solo nella misura in cui l’orizzonte di osservazione delle storiche e degli storici sia aperto. Intendo dire che lo studio delle biografie e degli avvenimenti rivela certi limiti; penso che invece di soffermarsi su individui o eventi eccezionali sarebbe auspicabile studiare le «strutture» e recuperare nuovi soggetti storici, più ribelli e dimenticati.
Non voglio essere troppo severa, anche a me è capitato di redigere capitoli o testi in cui un certo biografismo predominava, tuttavia l’ho sempre fatto col beneficio degli apporti delle scienze umane, che considero espedienti irrinunciabili. La storia dovrebbe avere priorità collettive e problematizzare lo studio sulle differenze tra i sessi, come fanno ad esempio gli studi femminili e di genere.
DAL MOVIMENTO OPERAIO AL FEMMINISMO
Storica e militante femminista, MIchelle Perrot nasce nel 1928 a Parigi. Nel 1947 comincia i suoi studi alla Sorbona; la sua tesi, diretta da Ernest Labrousse, tratta il tema degli scioperi operai. Fin dalla pubblicazione de «Il Secondo sesso» di Simone de Beauvoir desidera avvicinarsi alle scritture delle donne, fino a creare (nel 1974) insieme a Françoise Basch il Ged (Gruppo di studi femministi), sui temi dell’aborto, della violenza sessuale, del lavoro domestico, dell’omosessualità. Professoressa emerita di storia contemporanea all’università Paris VII - Denis Diderot, ha contribuito in maniera decisiva alla nascita degli studi sulle donne e sul genere ed è stata insignita nel 2014 del Prix Simone-de-Beauvoir per la libertà delle donne. Tra le sue opere tradotte in italiano figurano i cinque volumi della «Storia delle donne in occidente» (Laterza), «Immagini delle donne» (Laterza e «Storia delle camere» (Sellerio).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Per una filosofia affermativa (Roberto Esposito). Il negativo è il limite che attraversa la vita (di Roberto Ciccarelli)..1 marzo 2018, di Federico La Sala
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE.... *
Il negativo è il limite che attraversa la vita
Storia delle idee. «Politica e negazione. Per una filosofia affermativa» di Roberto Esposito, pubblicato da Einaudi. Il filosofo si interroga su un’inarrestabile deriva nichilista e esplora le radici dell’alternativa di un pensiero affermativo. Una riflessione che porta la vita alla sua massima espansione senza sottrarsi a nessun conflitto. La scoperta di Spinoza per il quale la sapienza è una meditazione sulla vita, non un pensiero sulla morte. Quello del filosofo non è incauto ottimismo, né cieco volontarismo. Conosce la potenza che ci abita
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 28.02.2018)
In giorni oscuri torniamo a interrogarci sulla negazione. L’avevamo rimossa, avevano detto che la storia era finita e avremmo vissuto in un eterno presente pacificato. Ci siamo risvegliati in una specie di guerra civile mondiale dove la negazione è intesa come distruzione della vita: il terrorismo jihadista che rivendica il potere di dare la morte in maniera indiscriminata. Oppure lo stragismo fascista e razzista contro gli immigrati, rovescio diabolico di una risposta uguale e terribile.
ABBIAMO PERSO il contatto con l’idea per cui il negativo sia l’anima del reale, ciò che lo spinge a rovesciare la contraddizione e affermare la vita. Il negativo è invece inteso come una negazione senza rimedio. Oltre il suo «non» c’è il niente. Il «negare» ritrova la sua lontana origine latina: «necare», uccidere. Tutto sembra essere stato assorbito da un dominio di un potere assoluto che non salva, ma uccide anch’esso. Sfumano così le distinzioni che hanno costruito la politica moderna: quella tra guerra e pace, tra il militare e il civile, tra il criminale e il nemico. Anche davanti a fenomeni meno estremi - il lutto, l’afasia, il dolore, la precarietà, la contraddizione più acuta - sembriamo incapaci di afferrare il negativo con categorie diverse dalla distruzione della differenza che abita l’essere.
SIAMO IN UN’«INARRESTABILE deriva nichilista di una negazione sfuggita di mano a chi l’ha teorizzata - scrive Roberto Esposito nel suo ultimo libro Politica e negazione. Per una filosofia affermativa (Einaudi, pp. 207, euro 22) - La logica del nichilismo si traduce in un’ontologia dell’inimicizia». E «l’annientamento diventa auto-annientamento». L’altro va distrutto per affermare un’identità tanto autentica, quanto fittizia e mortifera: l’identità nazionale e «sovrana», oppure la proprietà e la concorrenza tra individui atomici e disperati.
C’E’ STATO UN TEMPO in cui si è ritenuto che il nemico fosse chiaro, almeno dal punto di vista della razionalità politica. Questa logica, in realtà, non era così ferrea, tanto è vero che lo stesso Carl Schmitt in Teoria del partigiano ne ha indicato i limiti. Se a Lenin è stata riconosciuta una superiorità politica per avere trasformato il Capitale da «vero nemico» in «nemico assoluto» (ricambiato dall’altra parte), la deriva nichilistica dell’annientamento non è stata fermata. Anzi, si è intensificata.
POLITICA E NEGAZIONE è alla ricerca di un’alternativa. Esposito riparte dal significato di «negazione» e conduce un corpo a corpo con Hegel, il grande pensatore di questa categoria. Non c’è dubbio che il negativo sia l’essere altro da sé, il superamento verso qualcosa che non ritorna all’identico. Il punto è che non è l’espressione di una negatività di fondo dell’essere, un divenire privo di determinazioni che non siano quelle rispetto a se stesso. Il negativo fa parte della vita: è la sua necessità. Per questo va contestualizzato, non generalizzato. È una forma dell’affermazione, non l’elemento originario che annulla l’essere.
IL NEGATIVO RIGUARDA anche l’azione, il modo in cui concepiamo le relazioni e la politica. Non è un ostacolo o una forza contraria che si oppone alla libera volontà di chi vuole affermare qualcosa. Il «non» - ovvero il conflitto, la contraddizione - non è esterno al soggetto, ma è interno ad esso. Il negativo è il limite che attraversa la vita costretta tra necessità e finitezza. E tuttavia non è la fine di qualcosa, ma l’indice di ciò che potrebbe essere. Non è l’annichilimento della vita, ma «il punto vuoto che spinge il presente oltre se stesso», scrive Esposito. Lo scopo di questo approfondimento vertiginoso è modificare la nostra disposizione verso la vita. Se la vita è imprigionata nel negativo, allora è immobile povera e paranoica. Se invece è un momento determinato di un divenire storico che si sporge oltre se stesso, allora diventa una pratica.
PER AFFRONTARE questa impresa Esposito si è rivolto a Spinoza, l’unico filosofo che ha dato una definizione affermativa della negazione. Spinoza, il grande eretico aggredito da Hegel e sistematicamente travisato dai suoi posteri. Per lui la sapienza è una meditazione sulla vita, non un pensiero sulla morte. È una meditazione su ciò che può fare una vita, non su ciò a cui deve rinunciare per sopravvivere. Questa è ancora oggi la sua gloria: avere una grande fiducia nella vita e denunciare tutti i fantasmi del negativo.
OGGI POSSIAMO INTUIRE quanto contro-corrente possa essere un simile atteggiamento. Ma questa è la vocazione «inattuale» del filosofo. Il suo non è incauto ottimismo, né cieco volontarismo. Conosce la potenza che ci abita, a dispetto del negativo che ci circonda. Ha fiducia nelle potenzialità della vita, come nell’amore per il mondo e per chi lo vive.
L’APPRODO ALLO SPINOZISMO di un filosofo importante come Esposito non è improvvisato. Già in passato aveva parlato di «biopolitica affermativa». Oggi parla di «filosofia dell’affermazione». Una definizione rilevante in un panorama culturale come quello italiano dove prevale un «pensiero del negativo» che porta ad esiti impolitici, elitari o addirittura teologici. Il pensiero affermativo non è un positivismo del fatto compiuto, né una stanca decostruzione. Indica la strada per una nuova forma di materialismo, istanza che sembrava remota, o riservata a poco, fino a poco tempo fa.
SUL PIANO POLITICO questa filosofia mette in discussione la «sovranità», il fantasma di tutti i dibattiti politici o economici. Con «sovranità» si allude a uno Stato che nega l’inimicizia degli uomini e impone il monopolio della violenza. Esiste, invece, un’altra concezione dello «Stato» che incanala la potenza istituzioni capaci di salvaguardarne l’esistenza. In questo modo «il governo degli uomini non passa per una denaturazione della vita», ma da una forma immanente di auto-governo che mira al raggiungimento del «punto massimo della propria espansione». È la differenza che passa tra una politica sulla vita e una politica della vita, per usare le categorie di Esposito.
UNA «FILOSOFIA DELL’AFFERMAZIONE» non nega l’esistenza del conflitto - il negativo - né allude a una pacificazione come fa la retromania che devasta il dibattito pubblico attuale. Il conflitto è un elemento della relazione, oltre che della creazione di nuove istituzioni. Per renderla concreta è necessaria una politica dell’amicizia.
NELLA POLITICA novecentesca l’amicizia è stata considerata una categoria parassitaria dell’inimicizia. O amici, non ci sono amici in questo mondo. E così il mondo si scopre popolato solo da nemici. Davanti a questo paradosso va sperimentata una prassi politica che metta insieme corpo e intelletto, materia e spirito, vita e forma, e non rifugga ma abbracci il conflitto. Una politica dell’amicizia consiste nel costruire opere comuni, nel saperle difendere e nell’affermarle.
LA SOLIDARIETA’ E LA FRATELLANZA vanno riscoperti come strumenti affermativi, non come mezzi per attaccare il diverso. Creano legami, non impongono vincoli. Se intesi come strumenti del conflitto servono a liberarsi da ciò che impedisce di godere insieme di quello che abbiamo: la carne, la nascita, il corpo, la differenza e, più in generale, l’idea che la norma (giuridica, politica, sociale) nasca dalla vita in comune. L’amicizia è capace di affermare qualcosa che è in potenza e a disposizione di tutti. È tempo di imparare a coglierne i frutti.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
 "Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
"Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE. A partire da due, e non da uno!!! Una nota su una polemica tra "esportatori di democrazia" e di "libertà" (Giovanni Sartori e Gian Maria Vian) e la proposta di una Fenomenologia dello Spirito di "Due Soli". Con Rousseau, Kant, Marx, Freud e Dante, oltre Hegel, per una seconda rivoluzione copernicana.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".Federico La Sala
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- GUERRA DI GENERE... E CONVERSAZIONE INFINITA. Una modesta considerazione.21 febbraio 2018, di Federico La Sala
GUERRA DI GENERE... E CONVERSAZIONE INFINITA. Una modesta considerazione....
Una nota a "Guerra di genere. Una modesta proposta" (di Paolo Fabbri, Alfabeta2)
Se non ricordiamo più "(...) la prima messa in italiano dopo due millenni di *latinorum* e la distruzione della statua del padrone illuminato Marzotto ad opera di scioperanti iconoclasti(...)" e non sappiamo più e nemmeno distinguere tra chi grida "forza Italia" e chi grida «"forza Italia"», come è possibile venir fuori dalla "fattoria degli animali" e accedere allo Spazio *neutro* e alla Terra *neutra*?! *
Abbiamo dimenticato della connivenza tra *grammatica* e *metafisica* e che , rispetto alla *lingua*, la coscienza «arriva dopo, zoppicando»; che "non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza"?!
"Come sarebbe questo italiano neutro?". Per andare oltre *Scilla* e *Cariddi*, forse, non potremmo e dovremmo chiedere ancora (e di nuovo) consulenza al mondo greco e alla società greca, quello e quella di Omero, Ulisse e Penelope?! O vogliamo continuare ancora (e sempre?) il vecchio *gioco* dell’ «io parlo, io mento» e dell’«io mento, io parlo»?!
Federico La Sala
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. "Paolo Fabbri, la conversazione infinita" (Maria Pia Pozzato, Alfabeta2).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" - UN PASSO AL DI LÀ DEL NARCISISMO E DELL’EDIPO. "Lo spettacolo di sé. Filosofia della doppia personalità" (Barbara Chitussi).16 febbraio 2018, di Federico La Sala
UN PASSO AL DI LÀ DEL NARCISISMO E DELL’EDIPO: "SE’ COME UN ALTRO". OSSERVARE SE STESSI, SE STESSE ... CON "SIMPATIA"! *
- PER "un’etica della non-coincidenza con sé quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”». nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”» (Paolo Godani).
Il tizio che mi guarda dallo specchio
di Paolo Godani (Alfabeta-2, 11.02.2018)
- Barbara Chitussi, Lo spettacolo di sé. Filosofia della doppia personalità, Meltemi, 2018, 298 pp., € 16
L’attuale eclissi della psicanalisi, cioè la marginalizzazione della sua posizione epistemologica e della sua funzione sociale in favore delle scienze cognitive, è un’ottima notizia per almeno due ragioni. Innanzitutto perché, come alcuni segni già invitano a immaginare, c’è la possibilità che la psicanalisi stessa, da una posizione di minorità, torni a produrre qualcosa di interessante. Ma anche perché può ora riapparire, in tutto lo splendore che la bolla psicanalitica aveva lungamente offuscato, l’immenso patrimonio della ricerca psichiatrica, soprattutto francese, cresciuta nella seconda metà del XIX secolo.
Jean-Martin Charcot, Théodule Ribot, Alfred Binet, Pierre Janet, solo per nominare gli autori un tempo più celebri di questa età dell’oro della psicologia francese, non sono stati soltanto curiosissimi ricercatori sperimentali, ma anche e soprattutto inventori di ipotesi, spiegazioni, concetti che ancora sfidano l’asfissia della cultura contemporanea.
 Lo dimostra brillantemente Barbara Chitussi che in un saggio appena uscito da Meltemi non solo, quasi come in un romanzo, mette in scena i casi clinici, le storie fantastiche di personalità multiple di cui si sono occupati gli psichiatri francesi, ma ne trae il materiale teorico per costruire una vera e propria filosofia della personalità. «Se mi sono occupata dell’analisi di questi casi - spiega l’autrice fin dall’introduzione - è stato per studiare in una prospettiva filosofica le strategie con le quali il soggetto si è pensato e costruito nella forma di un rapporto con sé, accettando di essere un personaggio, assumendo l’inautenticità della propria immagine, aprendosi al dominio della finzione attraverso l’imitazione dell’altro, o meglio osservandosi come uno spettatore osserva uno spettacolo».
Lo dimostra brillantemente Barbara Chitussi che in un saggio appena uscito da Meltemi non solo, quasi come in un romanzo, mette in scena i casi clinici, le storie fantastiche di personalità multiple di cui si sono occupati gli psichiatri francesi, ma ne trae il materiale teorico per costruire una vera e propria filosofia della personalità. «Se mi sono occupata dell’analisi di questi casi - spiega l’autrice fin dall’introduzione - è stato per studiare in una prospettiva filosofica le strategie con le quali il soggetto si è pensato e costruito nella forma di un rapporto con sé, accettando di essere un personaggio, assumendo l’inautenticità della propria immagine, aprendosi al dominio della finzione attraverso l’imitazione dell’altro, o meglio osservandosi come uno spettatore osserva uno spettacolo».Tutto è iniziato, si potrebbe dire, negli anni che seguono il 1875, quando la Francia sembrava attraversata da un’epidemia di personalità multipla. Tra i casi anonimi, raccolti dal dottor Krishaber e analizzati da Émile Littré, c’è chi «voleva parlare, ma fu costretto a interrompersi, tanto il suono della sua voce lo stordiva», chi credeva di «non essere di questo mondo», chi sentiva in sé stesso «un io che pensa e un io che esegue». Ma, come accade spesso, il brusio delle voci senza volto finisce per raccogliersi nel fulgore di un nome che quelle voci, tutte, le fa risuonare assieme. «Racconterò - spiega in un articolo del 1876 il chirurgo-psicologo Eugène Azam - la storia di una giovane donna la cui esistenza è tormentata da un’alterazione della memoria che non ha precedenti nella scienza; l’alterazione è tale che è lecito chiedersi se questa giovane donna non abbia due vite». La ragazza di cui parla Azam si chiama Félida, è «bruna, di statura media», molto intelligente e piuttosto istruita, seria, taciturna, grande lavoratrice, «di carattere triste e persino cupo». O meglio, triste e cupa Félida appare di solito sino al momento della sua crisi. Le accade infatti, talvolta, di cadere improvvisamente nel sonno e di risvegliarsi in uno stato che non è più quello nel quale si era addormentata: «solleva la testa e aprendo gli occhi saluta sorridendo i nuovi arrivati, la sua fisionomia si illumina emanando allegria». Dopo il sonnellino o la catalessi, insomma, «il suo carattere è completamente cambiato; da triste è diventata allegra e la sua vivacità raggiunge l’impetuosità, la sua immaginazione è più esaltata». Per spiegare che cosa significhi e come possa accadere che la malinconica Félida-1 lasci il posto all’estroversa Félida-2, gli psicologi si lanciano nell’invenzione di nomi e concetti: amnesia periodica, raddoppiamento o sdoppiamento della vita, doppia coscienza o doppia esistenza, per arrivare alla nozione più carica di conseguenze: sdoppiamento della personalità.
Come nota con finezza Barbara Chitussi, gli psicologi che a proposito del caso di Félida iniziano a parlare di doppia personalità, operano a loro volta uno sdoppiamento dello stesso termine di personalità. Non più sinonimo di coscienza o di vita, la personalità torna ora a riavvicinarsi al significato originario del latino persona: avere una personalità significa ormai «indossare una maschera, avere un particolare modo di essere». Passaggio decisivo, con ogni evidenza, che consentirà a Pierre Janet di verificare la distinzione tra un moi interiore e un moi esteriore, tra un sentimento della pura esistenza di sé, cioè di un’esistenza indipendente da qualsivoglia attributo, qualità o maschera, e un sentimento della propria personalità, che come tale è complessa e variabile, nonché esteriore rispetto al mero sentimento dell’esistenza. Ma passaggio decisivo, questo, lo è soprattutto perché stabilisce che la personalità di ognuno non è un che di sostanziale, ma semmai un modo, una maniera di essere, una postura, un’immagine che può essere assunta o rigettata, un abito che si può indossare, ma anche cambiare e sostituire.
Da qui in avanti, il percorso dell’autrice attraversa una molteplicità di campi all’interno dei quali la questione della personalità, confrontata con problematiche diverse come lo sdoppiamento nel sogno, la costruzione immaginaria di un sé ideale in quello che si chiamerà «bovarismo», le questioni della co-coscienza e della doppia moralità, assume nuove connotazioni. Ma questa varietà di campi problematici - ognuno con i suoi casi singolari che rendono Lo spettacolo di sé così avvincente (fra cui non si può passare sotto silenzio l’affascinante e riottosa Sally, una delle personalità della «famiglia Beauchamp», analizzata da Morton Prince) - non toglie nulla alla compiutezza filosofica del testo.
La sua tesi fondamentale è che il soggetto è un rapporto, cioè che la formazione soggettiva di ognuno avviene sempre e soltanto attraverso lo sdoppiamento di sé, prendendo distanza da ciò che si è o si crede di essere, trattando se stessi come altri. In questo senso, il sé figura come una contrattazione continua, come un campo sul quale si alternano una pluralità di caratteri o personaggi, nessuno dei quali può affermare di essere l’autentico rappresentante del soggetto.
 «Ripensare il paradigma della personalità-maschera - spiega di conseguenza
l’autrice - significa [anche] disancorare nuovamente la vita personale [...] dall’ottusa identità della vita biologica». Infine, è ancora un’etica della non-coincidenza con sé, quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”».
«Ripensare il paradigma della personalità-maschera - spiega di conseguenza
l’autrice - significa [anche] disancorare nuovamente la vita personale [...] dall’ottusa identità della vita biologica». Infine, è ancora un’etica della non-coincidenza con sé, quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "PIGMALIONE". Diffido dell’istruzione (di Alessandro DAvenia)6 febbraio 2018, di Federico La Sala
"PIGMALIONE", UNA "FIGURA" NARCISISTICA ED EDIPICA, ANCORA MODELLO DI ESSERE UMANO E DI MAESTRO?!
- L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore. Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale (...) Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi (Alessandro D’Avenia)
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
Diffido dell’istruzione
di Alessandro D’Avenia (Corriere della Sera, 05.02.2018)
«Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. Ho visto ciò che nessuno dovrebbe vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti, bambini avvelenati da medici ben formati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati e laureati. Diffido - quindi - dell’istruzione. Aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri formati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani».
 Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.
Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.Il divorzio tra istruzione ed educazione è uno dei mali peggiori della scuola, frutto del luogo comune secondo cui esisterebbe un’istruzione neutra. Invece sempre si educa mentre si istruisce, perché la prima comunicazione è quella dell’essere, e solo dopo arrivano le parole, altrimenti non sarebbe necessaria la relazione viva con i ragazzi, ma basterebbe caricare le lezioni sulla rete. In senso stretto non esiste insegnamento in differita , ma solo in diretta.
Insegnare è una branca della drammaturgia. È l’essere dell’insegnante che genera la conoscenza, perché apre la via al desiderio dello studente, che scorge nel docente una vita più viva e libera grazie alla cultura e al lavoro ben fatto, e la vuole anche per sé. Lo ricordava con precisione il Nobel Canetti nella sua autobiografia: «Ogni cosa che ho imparato dalla viva voce dei miei insegnanti ha conservato la fisionomia di colui che me l’ha spiegata e nel ricordo è rimasta legata alla sua immagine. È questa la prima vera scuola di conoscenza dell’uomo».
Le nozioni più raffinate da sole non rendono umani, tutto dipende da come gli insegnanti si relazionano tra loro e con i ragazzi, perché, prima delle nozioni, sono le relazioni a essere generative dell’io e del sapere. È nella relazione che si impara a sentire il valore del sé come destinatario del dono del sapere. Quali insegnanti siete tornati a ringraziare e per cosa? Per la lezione sulle leggi della termodinamica e su Leopardi, o per come vivevano e offrivano la termodinamica e Leopardi proprio a voi?
Qualche tempo fa mi scriveva uno studente: «Le racconto due esperienze. La prima: la faccia polverosa della scuola. Un professore, che aveva esordito in prima liceo con “siete troppi: vi ridurremo”, pochi giorni fa ha condensato l’amore per il suo lavoro in questa frase: “Un insegnante non deve avere cuore, deve avere un cuore di pietra... altrimenti farà preferenze”. Uno scherzo, pensavamo. Un mio compagno ribatte: “Ma no, prof! Un insegnante deve avere un cuore talmente grande da non fare nessuna preferenza!”. “No, no: un cuore di pietra”. Parlava seriamente. La seconda: la faccia luminosa della scuola. Quest’anno ho scoperto la poesia grazie al gesto straordinario di un ordinario professore di filosofia, che un giorno ci ha parlato della sua giovinezza e di come la poesia ai tempi occupasse la sua vita e impegnasse la sua fantasia. Interessato anche io dal momento che non avevo letto nessun grande poeta ho chiesto un consiglio. Il giorno seguente lo vedo estrarre dalla sua ventiquattrore un libricino invecchiato. Viene verso di me. “Questo è per te”. Mi ha regalato una delle sue copie di Elegie duinesi, di R.M. Rilke, il suo libro di poesia preferito. Il libro della sua giovinezza!».
La differenza tra le due impostazioni è proprio quella che corre tra chi si illude si possano separare istruzione ed educazione e chi invece le tiene naturalmente unite. Nel primo caso si pensa che il docente sia un distributore di nozioni, nel secondo la didattica è conseguenza della relazione. Il primo professore educa all’insensibilità di cuore, a non sentire l’unicità del tu, il secondo rende Rilke interessante prima di averne letta una riga. Il nesso che tiene unite istruzione ed educazione è nella realtà, e nessuna presa di posizione teorica le può nei fatti separare. L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore.
Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale. Non si può aumentare la conoscenza di qualcosa senza che prima aumenti l’interesse nei confronti del soggetto in questione (vale per l’amicizia come per la chimica). L’amore genera conoscenza e la conoscenza ampliata rinnova l’amore: se il docente non «erotizza» la materia, la materia per quanto ben conosciuta resta inerte, come spiega Massimo Recalcati.
Non esistono cose poco «interessanti», ma uomini e donne poco «interessati», perché le emozioni (la neurobiologia qui ci conforta) sono le guide che aprono la strada allo sviluppo cognitivo. Solo così gli studenti diventano soggetti di possibilità e non oggetti al peggio da ridurre o al meglio da riempire. È questa la rivoluzione copernicana chiesta a ogni docente: non sono gli alunni a ruotare attorno a lui ma il contrario. Un professore - il letto da rifare oggi lo suggerisce lo studente della lettera - è chiamato ad avere un cuore tale da non far preferenze perché preferisce tutti e ciascuno diversamente: sfida difficilissima (quanti errori, quante gioie...) ma decisiva.
È la stessa sfida narrata da Ovidio, nelle sue Metamorfosi, a proposito del mito di Pigmalione. Uno scultore che, deluso da tutte le donne, si innamora della donna ideale che ha scolpito nel marmo. Il suo trasporto è tale che gli dei trasformano la statua in una donna in carne e ossa. Il mito viene usato per descrivere lo sguardo educativo, il cosiddetto effetto-Pigmalione, per il quale se un docente (ma vale per ogni educatore) guarda un alunno convinto che farà bene, genererà in lui una fiducia in sé tale che, nella quasi totalità dei casi, anche a fronte di un’inadeguata disposizione iniziale, otterrà risultati positivi.
L’effetto vale anche in negativo: se sono convinto che non vali, l’effetto sui risultati sarà coerente, anche a fronte di buone capacità. Lo sguardo educante non è mai neutro ma sempre profetico, nel bene e nel male. Ne abbiamo conferma quotidiana nel bambino che, appena caduto, si volge verso i genitori: se si mostrano allarmati ne provocano il pianto, se sorridenti il sorriso, quasi che il dolore, pur oggettivo, venga trasformato nello e dallo sguardo.
I ragazzi non hanno bisogno di insegnanti amiconi né aguzzini, ma di uomini e donne capaci di guardarli come amabili soggetti di inedite possibilità a cui non fare sconti. E non è questione di missione o di poteri magici, ma di professionalità. Per questo l’appello è il momento chiave della giornata scolastica: segna il tono della relazione e fa sì che ognuno senta su di sé lo sguardo profetico che spinge a far bene come conseguenza dell’ esser bene. Il contrario del «siete troppi, vi ridurremo», sterile autoritarismo, è il fecondo «sei unico, ti aumenterò».
La parola autorità viene da augeo (aumentare): la esercita non chi ha il cuore molle o sprezzante, ma chi si impegna ad aumentare la vita che ha di fronte, per quanto fragile, difficile, resistente possa sembrare. Questa è l’istruzione di cui non diffido, perché ispirata da un umanesimo maturo, l’umanesimo dell’altro uomo, come lo chiama il filosofo Lévinas, che fa del tu il cuore dell’etica e smaschera il falso umanesimo dell’istruito incapace di sentire il tu, tanto da distruggerlo proprio attraverso l’istruzione.
Non è facile però essere educatore in un sistema scolastico che asfissia di burocrazia e svilisce la dignità sociale ed economica, e in un contesto culturale che spesso attacca dall’alto (genitori) e dal basso (studenti). Ma questi elementi possono anche diventare scuse per non fare ciò che è alla portata di un uomo libero: prendersi cura di chi gli viene affidato.
Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
- "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. - #Metoo: nella ricontrattazione dei rapporti fra i sessi che la presa di parola femminile domanda, io credo che ci sia anche la rivolta contro questa miseria dello scambio eterosessuale" (I. Dominjani)..3 febbraio 2018, di Federico La Sala
Parlano le donne parlano - Ida Dominijanni
Introduzione all’incontro di Via Dogana 3: Parlano le donne parlano domenica 14 gennaio 2018
Ida Dominijanni
1.Il movimento #metoo - slogan inventato dieci anni fa da una donna nera, Tamara Burke - esplode negli Stati uniti il 15 ottobre dell’anno scorso, a seguito dello scandalo Weinstein, e si diffonde a macchia d’olio su scala pressoché planetaria: due settimane dopo, a inizio novembre, il Newsweek conta due milioni e trecentomila tweet in 28 paesi - ai primi posti Usa, Canada, Brasile, Messico, Gran Bretagna, Svezia, Francia, Italia, Germania, Australia, India, Giappone, Sudafrica[1]. L’11 gennaio il New York Times elenca 78 uomini “high profile” - appartenenti ai circuiti della politica, dei media, dell’intrattenimento, dell’accademia - accusati dalle loro vittime di molestie o “cattiva condotta sessuale” (sexual misconduct) e licenziati, o sospesi, o costretti a dimettersi: tra loro sei esponenti politici, parlamentari o uomini di partito, e tra questi l’ex comico democratico Al Franken, il caso forse più controverso e Roy Moore, candidato repubblicano al Senato, cha ha perso le elezioni in Alabama anche in seguito alle denunce femminili di sexual harassment e pedofilia[2]. Parzialmente diverso il quadro in altri paesi. In India ad esempio - uno dei casi di #metoo più interessanti - il campo più colpito è quello accademico; sotto accusa, in particolare, alcuni tra gli esponenti più amati dei post-colonial studies, da cui un dibattito incentrato soprattutto sullo scarto fra ideologie rivoluzionarie professate in pubblico e comportamenti privati[3]. In Francia invece - altro esempio - il dibattito sul caso più esplosivo, le accuse di molestie e stupro a Tariq Ramadan, è “deragliato” su quello sui rapporti fra cultura occidentale e cultura islamica[4].
Come sempre accade, un movimento femminile transnazionale con contenuti sostanzialmente omogenei acquista pieghe e accentuazioni diverse a seconda dei contesti nazionali, e domanda perciò uno sguardo comparativo. Il mio si poserà soprattutto sulla comparazione fra Stati uniti e Italia, per una ragione precisa: molto di quanto sta accadendo nell’America trumpiana - compresa la scoperta, grazie alla presa di parola pubblica femminile, di un sistema diffuso di scambio fra sesso e potere - è stato anticipato nell’Italia berlusconiana; ma con effetti in parte simili, in parte - sembra - assai diversi. Da qui la strana sensazione di stare assistendo a un déjà vu da una parte, a qualcosa di inedito dall’altra.
2.Negli Stati uniti il #metoo è stato/è un enorme e contagioso movimento femminile di presa di parola pubblica, potentemente aiutato dai social network, appoggiato dalla stampa illuminata, sostenuto sia dall’autorizzazione reciproca delle donne coinvolte sia da una forte autorizzazione dell’opinione pubblica, che è riuscito a ribaltare una congiuntura che pareva svantaggiosa per le donne - l’elezione di Trump e la sconfitta di Hillary Clinton - in una situazione di protagonismo femminile socialmente riconosciuto e supportato. La congiuntura politica è di estrema rilevanza e dà risposta alla domanda che è imperversata sui media italiani: “Perché parlano adesso e non hanno parlato prima?”.
Le donne, lo sappiamo, parlano quando possono parlare: quando si può aprire una crepa nel regime del dicibile e dell’indicibile, e l’autorizzazione a dire la verità soggettiva prevale sul silenzio-assenso femminile necessario al mantenimento dell’ordine patriarcale. Dopo la vittoria di Trump e la sconfitta di Hillary - una candidata che il femminismo radicale riteneva non idonea perché moderata e neoliberale, ma che tutto il femminismo ha difeso dagli attacchi misogini del suo avversario - negli Stati uniti le donne hanno reagito con un salto di prospettiva politica, ben visibile fin nella women’s march del 21 gennaio 2017, che con i suoi due slogan principali, inclusività e intersezionalità, già annunciava un femminismo determinato a prendere in mano le redini di un movimento di opposizione più vasto. A distanza di un anno scrive infatti il NYT: “Allora non era chiaro se si trattasse di un momento o di un movimento, ma ora è chiaro che le donne sono diventate le leader emergenti di una doppia scommessa: sostenere l’opposizione a Trump e lanciare una sfida culturale più ampia al potere maschile, com’è accaduto con il #metoo”[5].
La presa di parola individuale che ha fatto esplodere il caso Weinstein non sarebbe stata possibile, dunque, senza l’autorizzazione simbolica del movimento già sceso in campo contro il Presidente che si vanta di “prendere le donne per le parti intime”. Vale la pena di notare che questa congiuntura politica conquista al femminismo la generazione di donne nata e cresciuta sotto le insegne dell’individualismo neoliberale che ne era rimasta fin qui più estranea, come fanno notare nelle loro testimonianze molte protagoniste del #metoo che raccontano la loro scoperta della dimensione collettiva dell’agire politico[6]. Di questa congiuntura, infine, fa parte il “divenire minoranza” degli uomini (bianchi), sotto i colpi della globalizzazione, della crisi economica, dei cambiamenti demografici e della perdita di privilegi innescata mezzo secolo fa dal femminismo storico: una condizione declinante del tutto compatibile tanto con i colpi di coda del suprematismo bianco che ha portato Trump alla presidenza quanto con i colpi di coda dell’aggressività sessuale “virile” disvelata dal #metoo.
A fronte di questo “divenire minoranza” degli uomini bianchi, c’è il “divenire maggioranza” delle donne: per la prima volta, in una società come quella americana abituata a rappresentarsi per segmenti, le donne non sono percepite come una minoranza da tutelare ma come una potenziale maggioranza vincente, una forza di cambiamento da sostenere e di cui fidarsi. All’autorizzazione femminile si aggiunge quindi un’autorizzazione sociale più vasta, ben percepibile attraverso il racconto incoraggiante e positivo che del #metoo hanno fatto i media mainstream liberal: il New York Times, il New Yorker, il Guardian, il Washington Post, The Nation - per citare solo quelli che ho cercato di seguire da qui.
3.Questo sostegno dell’opinione pubblica americana è il dato che stride di più con l’esperienza italiana. L’Italia non avrebbe dovuto restare sorpresa daI #metoo, avendo sperimentato, solo pochi anni fa, l’analogo fenomeno di una imprevista presa di parola pubblica femminile contro il “dispositivo di sessualità” dominante. Mi riferisco, ovviamente, all’esplosione del Berlusconi-gate, dovuta alla denuncia, da parte di Veronica Lario e Patrizia D’Addario (e altre dopo di loro, tra le quali Ambra Battilana, che ritroviamo oggi fra le donne che negli Usa hanno denunciato Weinstein), del sistema di scambio fra sesso, danaro e potere che vigeva nelle residenze dell’ex premier e decideva la distribuzione di lavori e di candidature alle donne nelle sue televisioni e nelle sue liste elettorali. Anche allora questa presa di parola si avvalse di una parte dei media, o perché contrassegnati dalla sensibilità di opinioniste femministe o perché, più semplicemente e strumentalmente, anti-berlusconiani. Ma subì anche e soprattutto una fortissima dose di incredulità, discredito e ostracismo, non solo da parte dei media berlusconiani (oggi in prima fila anche contro il #metoo, e con gli stessi argomenti di allora) ma anche negli ambienti della sinistra, e perfino in quella parte del femminismo che considerava “poco degne” le donne che si erano ribellate al sistema berlusconiano dal suo interno. Che fosse in atto, anche allora, una scossa tellurica che investiva verticalmente i rapporti fra donne e uomini, dalla sessualità al mercato del lavoro alle istituzioni della rappresentanza, lo si capì forse solo di fronte alla manifestazione del febbraio 2011 - le manifestazioni di piazza essendo la sola forma in cui l’esistenza del femminismo viene tuttora registrata. La risposta del circuito politico e mediatico mainstream fu tuttavia, anche nel campo della sinistra, momentanea, strumentale all’abbattimento di Berlusconi e inadeguata[7]. Soprattutto, non pare abbia seminato consapevolezza alcuna della crisi e della domanda di trasformazione di cui quei fatti erano il segno: lo si vede benissimo oggi che Berlusconi torna in campo come simulacro di se stesso, per ironia della storia contemporaneamente all’esplosione del #metoo, e nessuno, nei circuito mediatico, ricorda che a farlo cadere nel 2011 furono le donne prima dello spread, né associa la rivolta femminile italiana di allora a quella planetaria di oggi. Si potrebbe anzi sostenere, io sostengo, che la scarsa considerazione di cui il #metoo ha goduto in Italia è figlia diretta della rimozione della vicenda del 2009-2011.
A commento dei fatti di allora e di oggi, resta vero quello che Luisa Muraro aveva scritto ben prima, in tempi non sospetti: “Ci sono numerosi indizi che il regime di verità abbia fin qui funzionato, nelle sue succcessive forme storiche, sulla mutezza femminile. Se una donna si mette a dire la verità, diventa una minaccia per l’altro sesso e per la civiltà, insieme. ‘Virilità’ è un nome, o forse il nome, di questo insieme”. La verità soggettiva femminile detta in pubblico ha una forza dirompente della quale noi stesse non siamo forse abbastanza consapevoli. La comparazione fra le due vicende dimostra però anche che questa dirompenza, per essere efficace, ha bisogno di una qualche risonanza, e deve dunque dotarsi di una strategia mediatica. La differenza fra l’Italia e gli Usa si sta rivelando, da questo punto di vista, abissale, fin nell’uso del linguaggio e negli stili che connotano il racconto giornalistico, e non può essere attribuita solo al diverso valore che nella cultura americana e nella nostra ha il “dire la verità al potere”: attiene anche alla peculiare misoginia dell’establishment intellettuale e giornalistico italiano, e alla capacità o all’incapacità di associare mutamento femminile e mutamento sociale, e di fidarsene. Dedicando la copertina della “persona dell’anno” alle silence breakers, il Time ha acutamente osservato che il #metoo ha mostrato che i due principali obiettivi polemici di Trump, le donne e il giornalismo, hanno reagito, e sono in qualche modo “risorti”, insieme. Si può ragionevolmente sostenere che finché non avrà imparato a trattare sensatamente di donne e di femminismo, il giornalismo italiano continuerà a precipitare nell’abisso di ignoranza, pressapochismo, autoreferenzialità in cui vivacchia da anni.
4.La rimozione dei fatti del 2009-2011 spiega anche la ripetizione, in Italia, di molti argomenti contro le silence breakers di allora e di oggi. Riassumo qui brevemente i principali, maschili ma anche femminili, talvolta presenti in modo ben più pacato anche nel dibattito americano, proponendo per ciascuno di essi un rovesciamento di prospettiva.
a) L’(auto)vittimizzazione. Si va dal “fanno le vittime, ma sono state conniventi per anni”, scagliato contro Asia Argento soprattutto ma non solo da uomini, al timore, soprattutto femminile e femminista, che il #metoo possa risolversi in un processo regressivo di vittimizzazione e infantilizzazione delle donne. Alla prima obiezione ho già risposto: le donne parlano quando possono parlare. La seconda è più comprensibile, ma a mio avviso è infondata. È vero che il #metoo condivide con il femminismo di ultima generazione la tendenza a una soggettivazione basata sulla denuncia della violenza subìta piuttosto che sull’affermazione di un desiderio positivo, com’è stato invece per il femminismo degli anni Settanta; ed è vero che questa accentuazione della condizione di vittima rischia di riprodurla, nonché di riportare indietro il discorso, dal paradigma della libertà a quello dell’oppressione femminile. Ma nel caso del #metoo a me pare che il rischio di un attaccamento alla condizione di vittima sia decisamente inferiore alla spinta collettiva a uscirne, anche con una buona dose di allegria. Faccio inoltre notare che in Italia il fronte che accusa di vittimismo ritardato le attrici oggi, è lo stesso che ieri accusava le escort e le olgettine di non rappresentarsi come vittime e di rivendicare il loro lavoro come una scelta: a dimostrazione che il victim blaming è sempre attivo, nell’un caso e nell’altro.
b) Il fantasma della “caccia alle streghe”, ovvero il panico da rischio di reazione “maccartista” contro i maschi sospettati di “comportamenti inappropriati, a Hollywood e altrove. Il ricorso alla evocazione della caccia alle streghe per esprimere il terrore di una caccia agli orchi ha qualcosa di comico, e dice quanto sia radicata la fantasia di una simmetria fra i sessi e di una vocazione ritorsiva della rivoluzione femminista. Storicamente, la caccia alle streghe (donne) l’hanno fatta gli uomini, e oggi, casomai, sono di nuovo uomini a farla su altri uomini. Con modalità talvolta violente e discutibili, come la cancellazione dai titoli dei film di attori fino a ieri osannati, o la “maledizione” di opere d’arte che dovrebbero sopravvivere ai comportamenti sessuali dei loro autori. Queste modalità però segnalano che una crepa si è davvero aperta nell’omertà maschile, e questo è un fatto positivo.
c) Invocazione/scongiuro della legge e delle regole. Vasta e contraddittoria gamma di posizioni. Da una parte il #metoo viene attaccato perché agisce sulla base di una denuncia pubblica ma non giudiziaria dei comportamenti maschili, impedendo così l’esercizio del diritto di difesa: si invocano insomma i tribunali, temendo - come di recente Margareth Atwood[8] - la sostituzione dello stato di diritto con di una giustizia “immediata” o con quello che in Italia chiamiamo “giustizialismo”. Oltre a non tener conto della storica - e giustificata - diffidenza femminile per l’esercizio maschile della giustizia, questo tipo di obiezioni occulta quello che è il pregio, non il limite del #metoo: il suo carattere eminentemente politico, basato sulla presa di parola e sulla solidarietà collettiva, e non sull’uso dei tribunali. La questione che il #metoo pone è politica, non penale.
Dall’altra parte però, e contraddittoriamente, lo stesso fronte paventa che l’esito del #metoo possa essere quello di una regolamentazione forzata e di un controllo moralista e normativo dei comportamenti sessuali[9] - esito peraltro da non escludere, data la tendenza alla codificazione dei comportamenti propria della società americana. Va detto però che questa regolamentazione, talvolta fin troppo rigida, negli Usa vigeva già prima del #metoo, ad esempio nelle università; il #metoo, casomai, ne segnala l’inutilità. C’è un eccesso della sessualità maschile che sfugge, evidentemente, a ogni regola e a ogni codice di comportamento: merito del #metoo è l’averlo messo in luce, riportando il fuoco del discorso dalle forme del politicamente corretto alla sostanza delle cose.
Più in generale, l’altalena fra invocazione e scongiuro delle norme è sintomatica di una condizione tutta maschile, che sembra non poter fare a meno delle norme per regolamentare le pulsioni: le invoca mentre le scongiura, e le scongiura mentre le invoca. Vale sulla sessualità, dove gli uomini sembrano voler delegare a un codice di comportamento quello che non riescono a regolare relazionalmente, come vale, lo sappiamo bene, per tutti i campi della vita associata, la politica in primis.
d) Il fantasma della fine della seduzione e della morte della sessualità, con la correlata confusione fra seduzione e violenza, “avance” e molestia. Su questa confusione, impugnata come una bandiera in Italia dal Foglio e dalla stampa di destra e fatta propria in Francia dal testo firmato da Catherine Deneuve di cui tanto si è parlato, ho poco da dire: a differenza di Deneuve non conosco donna alcuna che non sappia distinguere fra l’una e l’altra cosa, mentre mi arrendo alla constatazione che tale confusione c’è davvero nella testa di molti uomini, che infatti la rivendicano come se il confine fra sesso e violenza fosse effettivamente poroso e facilmente valicabile.
Il punto tuttavia a me non pare questo, palesemente strumentale, ma un altro. Rebecca Traister ha sostenuto, con buoni argomenti, che puntare il discorso sul terreno della sessualità significa evadere la questione principale posta dal #metoo, che a suo avviso riguarda la ricattabilità delle donne nel lavoro più che il sesso[10]. Si tratta a mio avviso di una falsa alternativa: la questione riguarda, direi, la ricattabilità delle donne nel lavoro attraverso il sesso, ovvero l’uso della sessualità come moneta di scambio nel mercato del lavoro. E dunque il #metoo, esattamente come in Italia gli “scandali sessuali” di qualche anno fa, dice qualcosa del “dispositivo di sessualità” della nostra epoca. Esattamente come allora, anche stavolta colpisce la miseria della sessualità maschile che risulta dalle testimonianze femminili: uomini che scambiano potere con briciole di sesso come un massaggio sotto un accappatoio o una masturbazione all’aperto. Se è così, il #metoo non annuncia la fine della seduzione e della sessualità, ma la registra, per aprire, si spera, una pagina più ricca e più felice. Nella ricontrattazione dei rapporti fra i sessi che la presa di parola femminile domanda, io credo che ci sia anche la rivolta contro questa miseria dello scambio eterosessuale.
(Via Dogana 3, 30 gennaio 2018)
 [1] www.newsweek.com/how-metoo-has-spread-wildfire-around-world
[1] www.newsweek.com/how-metoo-has-spread-wildfire-around-world [2] www.nytimes.com/interactive/2017/11/10/us/men-accused-sexual-misconduct-weinstein
[2] www.nytimes.com/interactive/2017/11/10/us/men-accused-sexual-misconduct-weinstein [3] www.dinamopress.it/news/abusi-silenzi-nellaccademia-postcoloniale-la-necessita-lettura-femminista-dei-saperi
[3] www.dinamopress.it/news/abusi-silenzi-nellaccademia-postcoloniale-la-necessita-lettura-femminista-dei-saperi [4] www.newyorker.com/news/news-desk/how-the-tariq-ramadan-scandal-derailed-the-balancetonporc-movement-in-france?
[4] www.newyorker.com/news/news-desk/how-the-tariq-ramadan-scandal-derailed-the-balancetonporc-movement-in-france? [5] www.nytimes.com/newsletters/2018/01/21/gender-metoo-moment
[5] www.nytimes.com/newsletters/2018/01/21/gender-metoo-moment [6] www.nytimes.com/2017/12/12/magazine/the-conversation-seven-women-discuss-work-fairness-sex-and-ambition.html
[6] www.nytimes.com/2017/12/12/magazine/the-conversation-seven-women-discuss-work-fairness-sex-and-ambition.html [7] Per la ricostruzione dell’intera vicenda e dei suoi effetti rimando al mio Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, Ediesse, Roma 2014.
[7] Per la ricostruzione dell’intera vicenda e dei suoi effetti rimando al mio Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, Ediesse, Roma 2014. [8] www.theguardian.com/books/2018/jan/15/margaret-atwood-feminist-backlash-metoo
[8] www.theguardian.com/books/2018/jan/15/margaret-atwood-feminist-backlash-metoo [9] www.newyorker.com/news/our-columnists/sex-consent-dangers-of-misplaced-scale
[9] www.newyorker.com/news/our-columnists/sex-consent-dangers-of-misplaced-scale [10] www.thecut.com/2017/12/rebecca-traister-this-moment-isnt-just-about-sex.html
[10] www.thecut.com/2017/12/rebecca-traister-this-moment-isnt-just-about-sex.html -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - "GENERARE DIO" (M. Cacciari). Narciso e l’arte di restare a galla (di Luisa Muraro)30 gennaio 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA DELLA RIVELAZIONE. "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": "GENERARE DIO". L’immaginario del cattolicesimo romano....
Narciso e l’arte di restare a galla: una lezione di Massimo Cacciari
di Luisa Muraro *
Narciso non sapeva niente di narcisismo. Il pastorello vanitoso si sporge per specchiarsi, casca nello stagno e annega. Doveva venire in Italia a imparare dai nostri uomini di spicco. Specchiarsi e, soprattutto, restare a galla, è un’arte. Per esempio, come fa il narciso italiano quando succedono cose notevoli che lo mettono ai margini? Aspetta un po’ che passino ma se non passano, come sta succedendo con il femminismo?
Massimo Cacciari, intervistato sul suo ultimo libro risponde con una lezione esemplare.
Il suo libro è di argomento teologico ed è il giorno di Natale. Il Professore si vanta di aver fatto una scoperta filosofica, teologica e politica su Maria di Nazareth. L’intervistatore, Nicola Mirenzi, è ammirato ma mostra incredulità. L’intervistato ammette di non essere stato il primo e fa il nome di un grande teologo del passato. L’intervistatore chiede: come mai neanche le femministe si sono dedicate a pensare la grandezza di Maria? Neanche loro, conferma il professore. Dice il falso ma lui non teme che la verità gli secchi la lingua perché non la sa, lui di femminismo non ha mai voluto saper niente con un minimo di precisione. L’ignoranza, però, non basta più con i tempi che corrono, ci vuole un tampone e Cacciari l’ha pronto. Ripete un elogio del femminismo fatto da altri (sempre lo stesso, “ultima vera rivoluzione” ecc.). Intanto pensa: nessuno può lontanamente aver visto quello che ho visto io! E a voce alta dice: le femministe “sono rimaste vittime della lettura maschilista dell’incarnazione, hanno guardato Maria come una figura servile, totalmente oscurata dal rapporto tra padre e figlio, non riuscendo a scorgere quello che c’è oltre”. Questa è la mossa classica dell’intellettuale italiano: s’inventa una posizione “femminista” fasulla, che gli pare verosimile e che trova facile da eliminare.
Termina così l’intervista; la trovate su Huffington Post, che in seguito ha pubblicato l’intervento di Nadia Lucchesi su questo argomento; lo trovate anche qui.
Inventarsi un femminismo finto, dopo quasi mezzo secolo di un movimento che sta modificando i tratti di una civiltà, e uno studioso di chiara fama che crede di poterlo fare impunemente, tutto questo non sarebbe possibile senza la complicità dei suoi pari e dei mass-media che vanno per la maggiore. È questo un andazzo che è durato troppo e danneggia il nostro paese. Da notare però anche, in questo caso, un certo desiderio maschile di mettersi alla luce della differenza femminile. Nadia Lucchesi e le sue amiche sono intervenute a smentire il Professore con molta serenità, come se, sotto le sue arie da grande pensatore, riconoscessero uno dei pastori che andarono alla grotta di Betlemme. (Luisa Muraro)
Il commento di Nadia Lucchesi e amiche all’intervista di Massimo Cacciari
Se i filosofi hanno ignorato Maria, le filosofe ne hanno invece valorizzata la figura, liberandola dagli stereotipi e dalle incomprensioni della tradizione. Penso, per nominarne alcune, a María Zambrano, a Simone Weil e a Edith Stein. Le femministe hanno guardato ben oltre la lettura maschilista dell’incarnazione: come scriveva Luisa Muraro nel 2011 «Data la scarsa conoscenza del femminismo, dovuta più alla novità delle idee che all’ignoranza delle persone, vi capiterà di leggere che noi femministe eravamo contro la figura di Maria. No, non solo la mariologia fu un terreno di coltura del femminismo cattolico, ma anche le agnostiche si sono dedicate a strappare Maria alla devozione di tipo patriarcale. Penso al Magnificat di Rosetta Stella (Marietti)... Di Maria si è enfatizzato il protagonismo, la mobilità, l’autonomia. La sua verginità è stata interpretata in termini d’indipendenza simbolica dagli uomini. Fondamentale è stato l’apporto di Luce Irigaray, che, dagli anni Ottanta, ha contribuito a diffondere un nuovo linguaggio religioso...» (Maria. Il latte della Vergine, Madre di Dio e Dio lei stessa, Il manifesto - Alias, 24 dicembre 2011).
Infatti, Luce Irigaray ha pubblicato nel 2010 «Il mistero di Maria» (Edizioni Paoline, 2010), mentre nel 2002 Nadia Lucchesi aveva dato alle stampe «Frutto del ventre, frutto della mente: Maria, madre del Cristianesimo» (Luciana Tufani, Ferrara 2002).
Nel 2014 si è svolto a Venezia il convegno «Rivisitazione di Maria. Per una teologia in lingua materna», a cura di Laura Guadagnin e Grazia Sterlocchi delle associazioni Settima Stanza e Waves in collaborazione col Centro Donna, mentre a Roma, all’interno del progetto speciale culturale Biblioteche di Roma 2014 «Presenza e mistero di Maria», Annarosa Buttarelli e Suor Michela Porcellato sono intervenute sul tema: «La sovranità di Maria di Nazareth».
Raffaella Molinari e Monica Palma, relatrici di un intervento dal titolo «Maria della Sororità, Nostra Signora Nostra Sorella» continuano il lavoro straordinario di Ivana Ceresa, fondatrice della Sororità, un ordine religioso posto sotto l’autorità di Maria, concepita come figura di donna potente.
Da più di cinquant’anni, inoltre, Angela Volpini diffonde un’immagine di Maria che rappresenta l’umanità realizzata e ci insegna la “via della felicità sulla terra”.
Non parlo dei tantissimi contributi delle teologhe cattoliche e non, che hanno interpretato in modo non tradizionale la figura della Vergine, della Maestra di Sapienza: cito, per nominarne solo una, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, teologa statunitense, femminista cattolica, autrice di due opere fondamentali: «In memoria di Lei» (Claudiana, Torino 1990) e «Gesù, figlio di Myriam, profeta della Sophia» (Claudiana, Torino 1996).
* www.libreriadelledonne.it, 19 gennaio 2018
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- PER LA NUOVA ALLEANZA, UN ALTRO SOGGETTO: LA LUCE DI IRIGARAY SUL "MISTERO DI MARIA" (E DI GIUSEPPE!?). Alcune pagine sul "silenzio di Maria", con alcune note
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO". Una riflessione di Massimo Cacciari su "cosa significa ereditare il passato"
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- «stop al più grande furto della storia», #stoptherobbery. Il quarto che manca agli stipendi delle donne. Campagna social mondiale.21 gennaio 2018, di Federico La Sala
Denuncia Onu. Il quarto che manca agli stipendi delle donne. Campagna social mondiale
Arriva #stoptherobbery ovvero «stop al più grande furto della storia». Mediamente gli stipendi rosa sono inferiori del 23% di quelli degli uomini.
di Antonella Mariani (Avvenire, sabato 20 gennaio 2018)
Un hashtag (il cancelletto che definisce l’argomento sui social network) tira l’altro. Dopo #MeToo, “anch’io”, il movimento contro le molestie sessuali che si è guadagnato il titolo di Persona dell’anno e la copertina del settimanale Time, arriva #stoptherobbery. Il messaggio della campagna dell’Onu è un po’ brutale ma perlomeno è chiaro e concreto: stop al «più grande furto della storia», quello ai danni dei portafogli femminili.
Nel mondo le donne saranno anche l’altra metà del cielo, ma guadagnano in media il 23% in meno degli uomini, a parità di incarico: il dato è stato diffuso ieri dall’economista indiana Anuradha Seth, consigliere dell’Un Women, il dipartimento Donne delle Nazioni Unite creato nel 2011. Dunque, Seth ha riproposto quel che si sapeva già, e cioè che in tutto il mondo le donne guadagnano 77 centesimi per ogni dollaro guadagnato da un uomo. I motivi sono ampiamente analizzati da economisti e sociologi da almeno un ventennio. La stessa Seth ne elenca alcuni, riscontrati in tutti i Paesi del mondo: il livello più basso di qualifiche, la minor rappresentanza nei gradi gerarchici più alti, la iniqua distribuzione delle cure domestiche e familiari che spinge le donne verso impieghi informali, saltuari o a orario ridotto. Secondo stime dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), a ogni figlio che mettono al mondo, le donne perdono il 4% del loro stipendio rispetto agli uomini.
A queste differenze «strutturali» si aggiunge la più classica delle discriminazioni, quella salariale: a parità di incarico «non esiste un solo Paese né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini». L’obiettivo della campagna social dell’Onu (tutte le informazioni su www.23percentrobbery.com) è di aumentare il livello di consapevolezza, in modo da spingere i governi a impegnarsi per colmare la distanza. Il modo più rapido, suggeriscono gli esperti dell’Organizzazione mondiale del lavoro, è la fissazione per legge di livelli salariali minimi e l’estensione di misure di protezione sociale.
Il «grande furto» del reddito femminile offre anche un orizzonte simbolico: un quarto in meno di stipendio significa un quarto in meno di libertà per le donne. Di opportunità. Di autostima, talvolta. Continuando nella lista: un quarto in meno di possibilità di decidere. Di scalfire il famigerato soffitto di cristallo che lascia intravvedere la vetta, ma non consente di raggiungerla. Di cambiare le cose per sé e per le proprie figlie. Molti progressi sono stati compiuti negli ultimi decenni, e la crescente partecipazione femminile nel mondo del lavoro e della politica è un dato di fatto. Non si parte da zero, resta però quell’ultimo miglio che non sono solo i soldi guadagnati sul lavoro, ma è l’essere considerate pari agli uomini, valutate e stimate solo per le idee e per l’impegno, per la creatività e per la passione. È un quarto ancora. Ce la possiamo fare: non da sole, ma con gli uomini al fianco.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89)."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Quarant’anni di un diritto. Relazione al Parlamento. Così la legge 194 ha fatto crollare gli aborti in Italia (di Maria Novella De Luca)16 gennaio 2018, di Federico La Sala
L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO: IL MAGGIORASCATO. UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"...
La relazione
Quarant’anni di un diritto
Così la legge 194 ha fatto crollare gli aborti in Italia
di Maria Novella De Luca (la Repubblica, 16.01.2018)
ROMA «Le donne hanno smesso di morire d’aborto, basterebbe questo per dire che la legge 194 ha funzionato e funziona. E io me le ricordo, quarant’anni fa, quelle donne e ragazze che arrivavano di notte in ospedale, devastate dalle emorragie dopo le famose interruzioni con il ferro da calza. Molte restavano mutilate per sempre. Con la legge 194 l’aborto ha smesso di essere una questione privata per diventare una questione sociale di cui lo Stato si è fatto carico. È stata una rivoluzione. Imperfetta, ma una rivoluzione». Carlo Flamigni ha 85 anni, è uno dei ginecologi più famosi d’Italia, pioniere della fecondazione assistita, ma anche protagonista di quella battaglia che negli anni Settanta ha cambiato nel profondo la nostra società, la famiglia, la maternità.
Approvata nel 1978, confermata dal referendum del 1981, la legge sull’aborto compie quarant’anni il 22 maggio prossimo. Un tempo abbastanza lungo per fare un bilancio, come infatti suggerisce la Relazione al Parlamento sull’attuazione della 194 presentata dalla ministra Lorenzin, dove per la prima volta si tenta una “analisi storica”. E se i numeri di quest’anno confermano la drastica riduzione degli aborti, passati dai 234.801 del 1982 (l’anno in cui le “Ivg”, interruzioni volontarie di gravidanza, raggiunsero il massimo storico) ai 84.926 del 2016, nello stesso tempo si assiste a un vero e proprio boom della contraccezione d’emergenza. In particolare dell’uso della “pillola dei cinque giorni dopo” (EllaOne) le cui vendite, dopo la caduta dell’obbligo di ricetta medica per le donne maggiorenni, è passata dalle 7mila confezioni del 2012 alle 189.589 del 2016. Se dunque abbiamo imparato a non abortire (pur potendo farlo), sul fronte dell’uso di pillola e condom siamo davvero indietro. Di fatto una contraddizione.
Ma al di là dei dati di oggi, nello sguardo sui 40 anni della legge, la Relazione afferma un principio fondamentale. «L’aborto volontario, dopo una prima fase iniziale, è costantemente diminuito e non è mai stato un mezzo di controllo delle nascite».
Se pensiamo che nel 1961, come denunciò una famosa inchiesta di “Noi donne”, gli aborti clandestini superavano il numero (spaventoso) di un milione l’anno, è evidente quanto la legge del 1978 abbia segnato il passaggio da un’Italia quasi post contadina a un’ Italia moderna. Livia Turco, a lungo parlamentare del Pd, ministra delle Pari Opportunità e poi della Salute, quella stagione da giovane militante comunista se la ricorda bene. E al tema della difesa della legge 194 ha dedicato un bel libro uscito di recente: “Per non tornare nel buio”. Perché in fondo nulla è garantito. E le proposte di revisione (restrittiva) della legge si susseguono ad ogni legislatura.
«Lo scontro fu feroce e lacerante. La Destra e una parte dei Cattolici dicevano che la legalizzazione avrebbe fatto aumentare a dismisura il numero degli aborti, banalizzandone la scelta. Invece oggi si dimostra che l’autodeterminazione delle donne ha prodotto una cultura della responsabilità e soprattutto si è arginata la piaga dell’aborto clandestino. Ma è della applicazione della 194 che bisogna tornare a parlare, uscire dal cono d’ombra». Perché l’obiezione di coscienza è ormai un dramma.
Spiega Livia Turco: «Ci sono interi ospedali dove le interruzioni non vengono praticate e le donne devono migrare di regione in regione, spesso con il rischio di superare i tempi legali. E poi i dati sul ricorso alla pillola del giorno dopo dimostrano che è sulla contraccezione che bisogna investire, pensando ai giovani, rendendola gratuita. Ma credo che una maggiore diffusione della Ru486, l’aborto farmacologico, potrebbe mitigare il ricorso all’obiezione di coscienza».
Immigrate, ragazze giovani. Sono loro le donne più a rischio. (Il 30% di tutte le interruzioni riguarda le straniere). Silenzio e solitudine i loro nemici.
Racconta Carlo Flamigni: «A 40 anni dalla sconfitta delle mammane e dei cucchiai d’oro, ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di clandestinità che il ministero rifiuta di vedere. Avete presente quante pillole per abortire si possono comprare su Internet? O farmaci che comunque aumentano la contrazioni uterine? La legge 194 va protetta e pubblicizzata, la contraccezione favorita in ogni modo. Altrimenti si torna indietro».
Michele Mariano è l’unico ginecologo non obiettore del Molise. Dirige un piccolo reparto di eccellenza all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, dove applica la legge 194. «Ormai da me arrivano donne da tutto il centro Sud. È incredibile. Dal Lazio, dall’Abruzzo, dalla Campania, perché i centri chiudono. Fanno centinaia di chilometri ma sanno che qui saranno accolte. E poi le migranti, spesso sbarcano in Italia già incinte. Ho visto troppe donne rovinate dagli aborti clandestini prima che ci fosse la legge, per questo continuo a lavorare in trincea, praticando 400 aborti l’anno. Sono orgoglioso di quello che faccio, ma sa qual è l’amarezza? A 40 anni dalla nascita di questa legge, noi che l’abbiamo voluta, siamo anche tra gli ultimi ginecologi ad applicarla, perché ormai tutti obiettano. Cosa accadrà quando andremo in pensione?».
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. - "SOL SOLUS IN MEDIO". Michelangelo precursore di Copernico.16 gennaio 2018, di Federico La Sala
DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Michelangelo precursore di Copernico ...
- "SOL SOLUS IN MEDIO. «In mezzo a tutti sta il Sole»: Copernico l’ha riscoperto e ripetuto, ma nessun saggissimo ha voluto restare «fedele alla terra» (Nietzsche), e pochi l’hanno seguito nella navigazione e nell’esplorazione dell’«oceano celeste» (Keplero). Tutti, pur di restare fermi al centro del loro bel mondo, si sono vestiti alla moda e... si sono trasferiti a corte, dal «re Sole»: come prima e peggio di prima - troni, altari e roghi su tutta la Terra. Molare lenti (Spinoza), per vedere e far vedere meglio, non è mai stata attività di nobili - né ieri, né oggi" (Federico La Sala, "Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una Cappella Sistina" carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barberi (1481) e la domanda antropologica", Milano 2013, pp. 136-137.).
Arte e astronomiaMichelangelo precursore di Copernico
di Antonio Rocca (la Repubblica, 15.01.2018)
Alcuni studi attestano che nel dipingere il Cristo del “Giudizio universale” Buonarroti abbia offerto una figurazione dell’eliocentrismo. E ciò anche per iniziativa del papa Clemente VII
Trovatosi a constatare la stringente analogia tra la rivoluzione copernicana e la rivoluzione iconografica con la quale Michelangelo impone un Cristo-Apollo nel cuore del Giudizio sistino, Charles de Tolnay scrive che il Buonarroti «giunge a una visione dell’universo curiosamente anticipante quella del suo contemporaneo Copernico. L’idea della composizione di Michelangelo precede di sette anni la pubblicazione dell’astronomo di Thorn (uscita a stampa nel 1543)».
Mancano documenti ad attestare un rapporto diretto tra l’astronomo e l’artista, pertanto Tolnay è costretto a utilizzare il termine “curiosamente”, ma il legame è evidente e con l’intento di colmare tale lacuna si è mossa Valerie Shrimplin. La studiosa britannica ha ricostruito il quadro che tiene assieme i due, sottolineando l’importanza di un episodio del 1533.
 In giugno Clemente VII invita Albert Waldstadt affinché, nei giardini del Vaticano e di fronte a un ristretto cenacolo di cardinali, gli illustri il modello copernicano.
Quella visione eliocentrica, disposta nel solco del neoplatonismo fiorentino, appassionò il Medici che donò al Waldstadt un prezioso manoscritto. Secondo la Shrimplin il papa maturò allora la decisione di realizzare il Giudizio.
In giugno Clemente VII invita Albert Waldstadt affinché, nei giardini del Vaticano e di fronte a un ristretto cenacolo di cardinali, gli illustri il modello copernicano.
Quella visione eliocentrica, disposta nel solco del neoplatonismo fiorentino, appassionò il Medici che donò al Waldstadt un prezioso manoscritto. Secondo la Shrimplin il papa maturò allora la decisione di realizzare il Giudizio.La commissione al Buonarroti si concretizzò già alla fine dell’estate del 1533 e la morte del pontefice non bloccò il progetto, che fu immediatamente ripreso da Paolo III Farnese.
La memoria dei processi a Giordano Bruno e Galileo Galilei sembra gettare un’ombra sulla possibilità che due papi potessero concepire la realizzazione di un colossale manifesto eliocentrico nel cuore della cristianità, tuttavia dobbiamo ricordare che siamo negli anni trenta del ‘500 e che la difesa del sistema tolemaico s’impone solo nel secolo successivo. Il De revolutionibus orbium coelestium fu messo all’Indice nel 1616. Avversione peraltro incerta come dimostrano le simpatie per Galilei del cardinal Barberini, divenuto in seguito Urbano VIII, e l’affresco di Andrea Sacchi in palazzo Barberini, che all’eliocentrismo allude.
Ipotesi antica, quella eliocentrica, che aveva conosciuto una fase di svolta con la pubblicazione del De Sole di Marsilio Ficino. Riprendiamola da questo momento, osservandola dalla prospettiva dei protagonisti della nostra storia, allora solo tre ragazzi. È il 1493, Copernico ha vent’anni e studia astronomia a Cracovia, il De Sole è libro di testo; Michelangelo gode della protezione di Piero de’ Medici, cui il De Sole è dedicato; Alessandro Farnese, già studente di Ficino, si appresta a diventare cardinale.
Il trattato esprime pochi concetti con grande chiarezza: il sole, immagine di Dio, occupa una posizione centrale nell’universo e rappresenta la giustizia divina. «La giustizia, regina di tutte le cose», scrive Ficino, «si diffonde attraverso il tutto a partire dal trono del Sole, e tutto dirige, quasi sia il Sole a guidare tutte le cose».
Copernico prese allora a cercare una via per allineare matematica, astronomia e platonismo. Nel corso del suo pluridecennale lavoro non ottenne risultati decisivi perché i suoi calcoli furono inficiati da assiomi interni al platonismo. Così, a dispetto di ogni dato empirico, il polacco non intese mai rinunciare alla perfetta circolarità delle orbite planetarie.
Concetti pitagorici che Copernico insegnava nelle sue lezioni romane del 1500, cui pare partecipassero anche Michelangelo e Alessandro Farnese. Col senno di poi, sapendo che Paolo III sarà il committente finale del Giudizio e che a lui è dedicato il De revolutionibus, si è portati a ritenere che sin da allora, sin dal principio del secolo, tra i tre si fossero instaurati dei rapporti diretti. Troppo stretti i giri, nella Roma agostiniana e neoplatonica, per immaginare che simili personaggi s’ignorassero, tuttavia ciò che qui interessa è osservare come l’artista, lo scienziato e l’uomo di chiesa, abbiano saputo inverare concetti astratti appresi in gioventù.
Diventati anziani uomini di successo, il Farnese, Michelangelo e Copernico declinarono i principi ficiniani, attribuendogli sostanza e creando un panorama culturale coerente. Intanto, però, tutto era cambiato. Il Giudizio e il De revolutionibus sono inattuali, nascono già vecchi o pregni di un futuro che li rende incomprensibili. Nel presentare il suo lavoro, Ficino aveva scritto che il libro andava letto in modo allegorico e anagogico, non dogmatico. La traduzione in immagine di quel testo vedeva la luce nel momento in cui la chiesa di Roma puntava a bandire modelli di lettura figurale, a vantaggio di una precisa rappresentazione dei dogmi formulati a Trento.
Il conflitto era inevitabile, sia sul piano formale che su quello del merito. Michelangelo aveva posto tra i beati una donna che esibisce un copricapo ebreo, due indios e una coppia d’infedeli, afferrati da un angelo per mezzo di un rosario a cento grani, tipico dei musulmani. Decisamente troppo per Paolo IV, il pontefice del ghetto, dell’indice dei libri proibiti e dell’Inquisizione.
Fortunatamente l’affresco restò intatto, seppure dovette subire qualche limitato intervento censorio. Integro ma incompreso, reso opaco e preso a tenaglia da pedanti cattolici e dalle favole protestanti di una Roma pagana, nella quale gli idoli greci avevano preso il posto di Dio. Del resto cosa poteva apprezzare un uomo come Lutero, vagamente iconoclasta e avversario di Copernico?
Ma ciò che ha fatto più danno è stata la Modernità o, meglio, la ricostruzione apologetica delle origini della Rivoluzione scientifica. Progresso scientifico e anticlericalismo col tempo presero a divenire quasi sinonimi. Si ricostruì la narrazione di una faticosa e costante riemersione alla luce ottenuta per mezzo della lotta contro l’oscurantismo cattolico, fatto di libri proibiti, processi, abiure, torture e condanne.
 Episodi reali, ma infilati su di un percorso unilineare nel quale sono trascurati l’eliocentrismo del vescovo Cusano, del sacerdote Ficino e l’ortodossia del canonico agostiniano Copernico. Tutti loro, come il domenicano Bruno, osservavano la volta celeste perché, come recita il Salmo 18, «i cieli narrano la gloria del Signore». Oltre la Modernità, dopo aver preso congedo dai miti solari di ogni Illuminismo, è più facile riconoscere che il Giudizio non è un’incongrua esaltazione della bellezza pagana e che Copernico non era un precursore del libero pensiero.
Episodi reali, ma infilati su di un percorso unilineare nel quale sono trascurati l’eliocentrismo del vescovo Cusano, del sacerdote Ficino e l’ortodossia del canonico agostiniano Copernico. Tutti loro, come il domenicano Bruno, osservavano la volta celeste perché, come recita il Salmo 18, «i cieli narrano la gloria del Signore». Oltre la Modernità, dopo aver preso congedo dai miti solari di ogni Illuminismo, è più facile riconoscere che il Giudizio non è un’incongrua esaltazione della bellezza pagana e che Copernico non era un precursore del libero pensiero.
 Leggiamo nel De revolutionibus: «La macchina dell’universo è stata creata per noi dal migliore e più perfetto artefice (...) E in mezzo a tutto sta il Sole.
Chi infatti, in tale splendido tempio, disporrebbe questa lampada in un altro posto o in un posto migliore, da cui poter illuminare contemporaneamente ogni cosa? Non a sproposito quindi taluni lo chiamano lucerna del mondo, altri mente, altri regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l’Elettra di Sofocle colui che vede tutte le cose. Così il Sole, sedendo in verità come su un trono regale, governa la famiglia degli astri che gli fa da corona». La Cappella Sistina, che ha le stesse dimensioni del tempio di Gerusalemme, è quel tempio.
Leggiamo nel De revolutionibus: «La macchina dell’universo è stata creata per noi dal migliore e più perfetto artefice (...) E in mezzo a tutto sta il Sole.
Chi infatti, in tale splendido tempio, disporrebbe questa lampada in un altro posto o in un posto migliore, da cui poter illuminare contemporaneamente ogni cosa? Non a sproposito quindi taluni lo chiamano lucerna del mondo, altri mente, altri regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l’Elettra di Sofocle colui che vede tutte le cose. Così il Sole, sedendo in verità come su un trono regale, governa la famiglia degli astri che gli fa da corona». La Cappella Sistina, che ha le stesse dimensioni del tempio di Gerusalemme, è quel tempio.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- USCIRE DALLA CAVERNA. Al di la’ della "liberta’ dell’importunare". Je ne suis pas Catherine Deneuve (di Ida Dominijanni)11 gennaio 2018, di Federico La Sala
FEMMINISMO
Je ne suis pas Catherine Deneuve
di Ida Dominijanni, giornalista *
La scoperta delle molestie e dei ricatti sessuali in uso a Hollywood e in tutto il mondo del lavoro americano dimostra che questi non sono tempi buoni né per il desiderio né per l’esercizio della sessualità fra donne e uomini. Com’era già accaduto in Italia con gli scandali sessuali d’epoca berlusconiana, quello che viene alla luce non è solo la tentazione maschile perenne all’abuso di potere, che riduce le donne a oggetto da possedere e la libertà femminile a disponibilità di concedersi. È anche, forse soprattutto, una diffusa miseria della sessualità maschile, che scambia potere, favori, assunzioni in cambio di briciole come un massaggio sotto un accappatoio, una masturbazione a cielo aperto, un assoggettamento a una virilità incerta. Una miseria sessuale che è parente stretta di una miseria relazionale, ovvero di una altrettanto diffusa incapacità maschile di relazionarsi all’altra, al suo desiderio e ai suoi dinieghi, alla sua forza e alla sua vulnerabilità, alla sua libertà e alle sue necessità.
Precisamente il cinema hollywoodiano, a ben guardare, ci aveva lentamente abituato, nell’ultimo decennio, a questo progressivo immiserimento, per non dire scomparsa, della sessualità nelle relazioni fra uomini e donne, con un sottile ma percettibile scivolamento dalle scene di sesso passionale degli anni novanta a quelle quasi sempre giocate successivamente su un ambiguo confine fra sesso e violenza, sesso e possesso, sesso e performance. E del resto basterebbe il successo sorprendente, e non a caso contemporaneo al #metoo, di un racconto come Cat person per farsi un’idea dello stato delle cose: in questo caso non c’è ombra di violenza né di molestie, ma la miseria sentimentale è la stessa, l’alfabeto della seduzione è precipitato nel dimenticatoio e ogni passione è spenta.
Quello che sta saltando con il #metoo e il Time’s up è il tappo di silenzio-assenso femminile che copriva questa situazione. A un primo sguardo, certo, si tratta di movimenti contro le molestie e i ricatti sessuali, e contro l’abuso di potere maschile che c’è dietro. Ma com’era già avvenuto in Italia pochi anni fa, la presa di parola femminile ha l’effetto di svelare qualcosa di più profondo, un “dispositivo di sessualità”, per dirlo con l’espressione di Foucault, in cui il desiderio non ha più posto e il sesso è ridotto a contrattazione, ricatto, performance. E da cui è urgente uscire, se i destini della sessualità come espressione libera e creativa della specie umana ci stanno a cuore.
- La Francia è la Francia, e pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”
Perciò è del tutto fuori campo e fuori fuoco la reazione, finora prevalentemente maschile nonché prevalentemente italiana, di chi ulula che all’esito del #metoo ci sarebbe l’oscurantismo politically correct di un totalitarismo (sic!) proibizionista e sessuofobico.
 È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
 Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.
Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.Stupisce di più - ma in fondo neanche tanto - che a usare gli stessi argomenti sia adesso un gruppo di donne francesi - intellettuali, artiste, attrici, psicoanaliste, giornaliste, fra le altre una campionessa riconosciuta della seduzione doc come Catherine Deneuve - le quali si lanciano nella difesa della “libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale”, come se il #metoo avesse già instaurato un regime del divieto dove nessuno può sporgersi sull’altra e nessuna sull’altro, il nemico delle donne sono gli uomini nella loro totalità, la parola femminile, altro che liberarsi, si autoimprigiona in un codice politically correct autoinibitorio, e le donne, altro che guadagnarci qualcosa, si auto-segregano nel ruolo di “eterne vittime dominate da demoni fallocrati”. Potenza dei fantasmi maschili interiorizzati anche dalla mente femminile, o “differenza culturale” francese vs egemonia “puritana” americana? L’una e l’altra cosa, probabilmente, e la seconda non meno influente della prima.
Non c’è donna al mondo che non sappia distinguere un “corteggiamento insistente e maldestro” da uno stupro, come le firmatarie dell’appello francese temono: esse stesse non possono non saperlo. Non c’è persona sana di mente che non possa aver registrato, seguendo le vicende del #metoo o più semplicemente la recente cerimonia dei Golden Globe sotto il segno del Time’s up, che tutto circola fra le silence breakers americane tranne un’autovittimizzazione inerziale e passiva: tutta la faccenda sembra al contrario parecchio empowering, e parecchio liberatoria anche per quegli uomini che la guardano con curiosità e fiducia invece che attaccarsi come Francesca Bertini alle tende di una virilità decadente. E anche questo le consorelle francesi non possono non averlo notato.
 Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
 Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.
Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.- L’attrice Catherine Deneuve a Berlino, il 14 febbraio 2017. (John Macdougall, Afp)
* Internazionale, 10 gennaio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
Ragione ("Logos") e Amore ("Charitas"). Per la critica dell’economia politica ..... e della teologia "mammonica" ( "Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)
 L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana" -
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA,IL BRILLANTE COLORE. -- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! Dove e come si perde il ruolo del professore5 gennaio 2018, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
Al liceo.
Chat con studentesse
Dove e come si perde il ruolo del professore
di Ferdinando Camon (Avvenire, venerdì 5 gennaio 2018)
Non illudiamoci: noi parliamo raramente, con reticenza e malvolentieri delle simpatie (per usare un termine neutro) che nascono nelle classi tra professori e studentesse, ovviamente delle superiori, tendiamo a minimizzare, ma loro, le studentesse, ne parlano sempre, e le commentano, con tendenza ad esagerare. La conseguenza è che per loro la loro versione è quella vera, e resterà nel loro cervello per tutta la vita. E se c’è una relazione immaginaria tra un prof e una studentessa, che per loro diventa una relazione vera, corredata di chissà quali e quanti incontri di cui nessuno sa niente, quella storia sarà per loro il marchio che contrassegnerà per sempre quella scuola e quegli anni, e per tutta la vita, a ogni rimpatriata, ne riparleranno. Quella storia, quelle storie, saranno più importanti di Hegel e Kant, che pure le hanno tanto impressionate.
Più importanti di Nietzsche, che oggi va per la maggiore. Quando qualcuna di queste storie trapela sui giornali, diventa subito la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia. In questo momento la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia è certamente l’accusa di rapporti inopportuni del prof di filosofia di un liceo romano con alcune studentesse, quattro delle quali hanno presentato denuncia. Due sono minorenni. Ci sarà una causa. Il prof sarà interrogato e sapremo le sue risposte. Finora non c’è una sentenza, e quindi non parliamo di un reato e di una condanna. Parliamo del fenomeno carsico, sempre negato e tuttavia presente in tutte le scuole, dei legami sentimentali che nascono tra insegnanti e allievi.
Anticipo subito, qui ad apertura, una mia vecchia tesi, ma non obbligo nessuno ad accettarla: il professore, di cui le studentesse non s’innamorano, è un cattivo professore; il professore, che s’innamora delle studentesse, è un cattivo professore. Perciò qui, nel caso del liceo romano, per quel che ne sappiamo finora, il problema non è che le studentesse si scambiavano tra loro email sospirose (o anche esplicite) sul professore, il problema è che email sospirose, anzi esplicite e audaci (parole degli studenti) le scambiava il prof con loro.
La difesa del prof sostiene che i messaggi del prof non sono molestie o violenze, perché hanno sempre ottenuto risposta. Da parte delle ragazze (nel caso delle minorenni, potremmo parlare di bambine) c’è insomma il consenso. Ma, a parte il fatto che il consenso delle minorenni non è valido (per questo son dichiarate minorenni), se la relazione vien corrisposta, vuol dire che è andata molto avanti e che è diventata stabile. Per la ragazza, e per la bambina, innamorarsi del prof è un fenomeno di crescita: si sente più grande, diventa più grande.
Per il prof, innamorarsi di una ragazza o una bambina è un fenomeno di de-crescita, e nel caso della bambina di rimbambimento. Il rapporto del prof con i suoi studenti e studentesse non è diverso dal rapporto dell’analista con i suoi e le sue pazienti. In questo caso, come insegna Freud, è inevitabile, utile, necessario che nasca un trasporto affettivo, che Freud chiama transfert. Il transfert è un grosso problema analitico. Per anni Freud lo intese come un ostacolo all’analisi, il paziente s’innamora del suo analista e va in transfert perché vuole uscire dall’analisi, il transfert va dunque combattuto e ignorato, affinché l’analisi prosegua.
Ma alla fine Freud si convinse che il transfert è un nuovo terreno sul quale il paziente replica i suoi problemi e i suoi bisogni, e che dando importanza al transfert e analizzandolo si favorisce l’analisi, e la si porta a compimento. Posso sbagliare (sono uno scrittore, non uno psicanalista), ma ho sempre guardato con sospetto lo psicanalista che si mette con una sua paziente, e la sposa. Mi sembra un rapporto analitico interrotto e deviato. Per la stessa ragione guardo con sospetto il prof che scambia email erotiche con le sue alunne, ancora minorenni o appena maggiorenni: mi sembra un rapporto didattico perduto e non più recuperabile.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPOCHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- DAL MEDIOEVO AL #METOO, QUANT‘È DURA ESSERE DONNE. Nota sul libro "La violenza contro le donne nella storia" (di Simonetta Fiori).15 dicembre 2017, di Federico La Sala
#MeToo: cos’è il movimento premiato dal Time. *
Me too, anch’io. Sono bastate appena due parole usate da migliaia di donne in tutto il mondo per dare il via al movimento contro le molestie sessuali premiato oggi dal Time come persona dell’anno. Un movimento nato sulla scia dello scandalo Weinstein e divenuto ben presto valvola di sfogo di quanti, almeno una volta nella vita, sono stati vittime di violenze sessuali e hanno scelto di denunciarle pubblicamente dopo averle tenute nascoste per anni. Da qui l’uso dell’ormai celebre hashtag #MeToo, lanciato per la prima volta dall’attivista Tarana Burke e condiviso poi dall’attrice americana Alyssa Milano, proprio per condividere via social i drammatici racconti delle molestie subite.
Tra le cinque "Silence Breakers" che compaiono sulla copertina del settimanale vi sono invece l’attrice Ashley Judd, tra le prime star a puntare il dito contro il produttore statunitense Weinstein, e la cantante Taylor Swift, che lo scorso agosto ha vinto il primo round della causa per molestie sessuali in corso a Denver contro il dj David Mueller, accusato di averle palpato il sedere dopo un suo concerto nel 2013. E ancora, tra le donne in copertina sul ’Time’ anche Adama Iwu, la lobbysta 40enne che ha lanciato il sito ’We said enough’ per denunciare le molestie nel mondo del lavoro e della politica, Susan Fowler, l’ex ingegnere informatico di Uber la cui denuncia di molestie sessuali lo scorso giugno ha portato al licenziamento del Ceo e di altri venti dipendenti e Isabel Pascual(nome di fantasia), la 42enne raccoglitrice di fragole del Messico che ha raccontato pubblicamente le minacce ricevute per aver denunciato gli abusi.
* ADNKRONOS, Pubblicato il: 06/12/2017
DAL MEDIOEVO AL #METOO QUANT‘È DURA ESSERE DONNE
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 14 dicembre 2017)
Ci voleva proprio un libro come questo sulla violenza contro le donne. Perché per la prima volta inquadra il problema nella storia, nella profondità del tempo, dall’età moderna all’evo contemporaneo. E solo uno sguardo storico così lungo può aggiustare il tiro, correggere il significato delle parole, introdurre bussole fondamentali nel caotico flusso di coscienza che deborda sui social e nei media (La violenza contro le donne nella storia, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Viella).
Che casa ci insegna la storia? La prima lezione e che non bisogna restare inchiodati alla prima, elementare evidenza che la brutalità maschile è sempre esistita: a qualsiasi latitudine, in epoche e culture diverse, in ogni ordine e grado della classe sociale. Tutto vero, tutto giusto.
Ma la storia ci insegna che molto è cambiato dai tempi in cui l’aristocratico o il borghese esercitavano legittima violenza sulla moglie riparandosi dietro lo ius corrigendi. Molto è cambiato da allora perché è mutato il mondo in cui la violenza maschile è stata socialmente percepita. Ed è cambiato il modo in cui la violenza è stata riconosciuta e sanzionata dalla cultura giuridica.
Parliamo di tempi biblici, questo sì. Ed è questa la seconda lezione che scaturisce dalle ricerche delle storiche. Nella vita domestica degli italiani la pratica dello ius corrigendi è sopravvissuta di fatto fino agli anni Settanta del secolo scorso, e anche oltre. È sopravvissuta nella permanenza del delitto d’onore (abolito soltanto nel 1981) o nel potere di indirizzo che il pater familias ha potuto imporre alla moglie fino alla riforma del diritto di famiglia (1975). E per fermarci alla più turpe delle violenze - lo stupro - fa ogni volta impressione imbattersi nella penosa circostanza che fino al 1996 è stato giudicato come reato contro la morale e non contro la persona.
Mutamenti significativi, certo, che però hanno richiesto il tenace contributo del femminismo. E a proposito di cesure storiche, un traguardo è stato raggiunto anche da quest’ultima seppur confusa campagna di denunce.
Ce lo fanno capire le storiche quando lamentano un lungo resistente vuoto nelle pubblicità progresso o nella stessa informazione sulla violenza contro le donne. E questa clamorosa assenza ha riguardato finora il volto dell’aggressore. Oggi gli artefici delle molestie hanno una faccia. È la prima volta che accade. E non è un caso che Time abbia dedicato la copertina dell’anno proprio a quelle donne che l’hanno disegnata. Con mano ferma, senza ambiguità. Solo nel nitore del segno c’è la conquista.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- UN NUOVO "PADRE NOSTRO": LA LEZIONE DI GUGLIELMO D’OCKHAM E LA SOLLECITAZIONE DI PAPA FRANCESCO.9 dicembre 2017, di Federico La Sala
CHI E’ DIO? CHI E’ IL "PADRE NOSTRO"?! Chi è il Papa? Chi induce in tentazione .... *
- Quello che ti induce in tentazione è Satana, quello è l’ufficio di Satana" (Papa Francesco).
A
GUGLIELMO DI OCKHAM
Chi è il Papa? Un eretico
di Armando Torno (Il Sole-24 Ore, 13 settembre 2015)
- Guglielmo di Ockham, Dialogo sul papa eretico, Bompiani, Milano, pagg. CXCIV+ 2046, € 55
Chi avesse cercato, magari in una biblioteca, l’edizione del Dialogo sul papa eretico di Guglielmo di Ockham, si sarebbe visto recapitare un volume ponderoso, in un latino non da parroco. In Rete l’ipotetico lettore qualcosa avrebbe trovato, rischiando però di peggiorare la comprensione: se fosse finito, putacaso, nel sito della Bayerische Staatsbibliothek, dove c’è la riproduzione digitale dell’editio princeps di Parigi del 1476, alle difficoltà della lingua avrebbe aggiunto quelle per la lettura dell’incunabolo. Aggirare l’ostacolo con una versione? Eccolo in un vicolo cieco: non ci sono traduzioni integrali in una lingua moderna. Eppure se il solerte bibliotecario avesse, per esempio, mostrato l’edizione di Francoforte del 1614, la curiosità sarebbe arrivata alle stelle, ché l’editore a pagina 957 aggiunse un Compendio degli errori di papa Giovanni XXII. Un’altra opera di Ockham, d’accordo, ma ne rafforzava le tesi.
Da qualche giorno tali preoccupazioni fanno parte del passato: Alessandro Salerno ha tradotto integralmente per la prima volta nella serie «Il pensiero occidentale» di Bompiani, con il testo latino a fronte, il Dialogo sul papa eretico di Ockham, che morì nel 1349 o nel 1350. Con tutta l’acutezza e la conoscenza di cui disponeva (era noto come il Doctor invincibilis), il celebre francescano tentò di dimostrare - senza allontanarsi dai punti fermi del cristianesimo - la possibilità dell’eresia del vicario di Cristo, mettendo in discussione tutte le relazioni tra papato e impero. La questione non era di poca importanza, giacché il sovrano diventava giudice naturale del pontefice, anzi avrebbe addirittura potuto invocare la difesa della fede per giustificare il suo intervento negli affari della Chiesa.
Certo, il papa a cui frate Guglielmo guardava, ovvero Giovanni XXII sedente in Avignone, non era una mammoletta e i francescani mal lo sopportavano. Basti ricordare che nel 1322, durante il suo pontificato, la disputa sulla povertà di Cristo e degli Apostoli appassionava dotti e semplici fedeli, tanto che un professore del convento dei minori di Narbona, Berengario, difese con forza un tale accusato di aver sostenuto che Cristo e i suoi seguaci nulla possedevano, né in comune né in proprio. Quando fu invitato a ritrattare, decise addirittura di appellarsi alla Santa Sede. Berengario invocò la decretale Exiit qui seminat di Nicola III (agosto 1279), nella quale la tesi era anzi obbligatoria. Giovanni XXII fece arrestare l’entusiasta difensore appena giunto ad Avignone; propose pubblicamente la questione della povertà di Cristo e, siccome Nicola III aveva comminato la scomunica per chi avesse cercato di intenderla in altro modo, con la bolla del 26 marzo di quell’anno, Quia quorundam, sospese la restrizione. La cosa andò avanti e nel dicembre successivo revocò la decretale del predecessore. Bonagrazia da Bergamo, anch’egli francescano, cercò di impugnare tali decisioni: finì a sua volta in prigione.
In un simile contesto nasce il Dialogo di Ockham, in sette libri, scambio di idee tra un maestro e un discepolo. L’opera pone questioni quali «A chi spetta definire la verità cattolica o l’eresia?» o «Esiste un giudice del papa?». Le domande sono radicali e tutto il sesto libro è dedicato alla condanna del pontefice eretico con pagine che recarono grande gioia all’imperatore. Due quesiti (meglio leggerli senza punto di domanda): «Il papa deve essere sottomesso all’autorità come lo fu Cristo» o «Se il papa oppone resistenza all’indagine sul suo conto, è lecito arrestarlo, detenerlo e metterlo in catene». Nella sua introduzione, poco meno di 200 pagine, Alessandro Salerno inquadra l’opera e offre un’analisi del sintagma «papa eretico» (compare circa 1200 volte a partire dal libro quinto). Pone in evidenza ironie e maschere, esamina i concetti di verità e potere, propone considerazioni sull’infallibilità.
Il “papa eretico” riapparirà nella storia della Chiesa con accusatori che non avranno l’acume di Ockham. Qualche storico chiamerà così Alessandro VI, e lo stesso Savonarola lo vide tale; altri, come il presbitero e teologo tedesco Ignaz von Döllinger, lo sussurrarono dopo la proclamazione del dogma dell’infallibilità pontificia con Pio IX. Ma questi sono dettagli. Ockham, scomunicato, accolto dall’imperatore Ludovico il Bavaro, passò la parte finale della vita a combattere i papi avignonesi con i suoi trattati. I quali, anche se non furono graditi o odoravano di zolfo, restano dei capolavori di intelligenza.
B
Papa Francesco vuole cambiare il ’Padre Nostro’: "Traduzione non è buona, Dio non ci induce in tentazione"
Uno dei passaggi più noti potrebbe presto cambiare, come già successo in Francia *
CITTÀ DEL VATICANO - Il testo in italiano della preghiera più nota, il ’Padre Nostro’ , potrebbe presto cambiare. A farlo intendere è lo stesso papa Francesco: "Dio che ci induce in tentazione non è una buona traduzione. Anche i francesi hanno cambiato il testo con una traduzione che dice ’non mi lasci cadere nella tentazione’. Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito".
Il pontefice lo ha spiegato nella settima puntata del programma ’Padre nostro’, condotto da don Marco Pozza, in onda su Tv2000. Francesco dialoga con il giovane cappellano del carcere di Padova nell’introduzione di ogni puntata. "Quello che ti induce in tentazione - conclude il Papa - è Satana, quello è l’ufficio di Satana".
Della controversia sulla preghiera più nota del cristianesimo - fu insegnata da Gesù stesso ai suoi discepoli che gli chiedevano come dovessero pregare - si è parlato in queste settimane quando in Francia si è detto appunto addio al vecchio ’Padre Nostro’. Dopo anni di discussioni sulla giusta traduzione, la nuova versione francese non include più il passaggio ’ne nous soumets pas à la tentation’ - ’non sottometterci alla tentazione’ -, che è stato sostituito con una versione ritenuta più corretta: ’ne nous laisse pas entrer en tentation’, ’non lasciarci entrare in tentazione’.
Secondo quanto ha scritto Le Figaro, la prima formula - ’non sottometterci’ - ha fatto credere a generazioni di fedeli che Dio potesse tendere in qualche modo una sorta di tranello, chiedendo loro di compiere il bene, li ’sottometteva’ alla tentazione del male. "La frase attuale lasciava supporre che Dio volesse tentare l’essere umano mentre Dio vuole che l’uomo sia un essere libero", ha commentato il vescovo di Grenoble, monsignor Guy de Kerimel, citato dal giornale. Dopo mezzo secolo - la controversa versione venne introdotta il 29 dicembre 1965 - la Conferenza episcopale transalpina ha quindi optato per la nuova traduzione del Notre Père. Per aiutare i fedeli a memorizzarla, la nuova preghiera è stata distribuita in decine di migliaia di copie nelle chiese di Francia. Il cambio ufficiale è avvenuto due giorni fa, domenica 3 dicembre.
Per la verità, anche in Italia, nella versione della Bibbia della Cei (2008), il passo ’et ne nos inducas in tentationem’ è tradotto con ’e non abbandonarci alla tentazione’; l’edizione del Messale Romano in lingua italiana attualmente in uso (1983) non recepisce tuttavia questo cambiamento. Ora però è il Papa a sostenere pubblicamente che si dovrebbe cambiare.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. Una nota di Henri Tincq - con premessa.
IL NOME DI DIO. L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" -- Di donne non ne abbiamo? Il caso Mdp fa particolarmente impressione. non solo che non ci sia una donna nella prima foto di gruppo, ma anche e soprattutto che la cosa non faccia problema per nessuno.4 dicembre 2017, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT). Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi........ *
Di donne non ne abbiamo?
di Roberta Carlini (Lunedì, 04 Dicembre 2017)
Liberi e uguali, avete un problema. Non mi dite che quella foto non ha urtato anche voi. Piero Grasso, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni, Pippo Civati. Quattro su quattro, foto evento della nascita di un partito, tutta al maschile - persino nel presentatore, un giornalista. Compagni, amici, fondatori, fratelli. Qualche pagina più avanti, o un altro clic, e spunta la foto della rielezione di Giorgia Meloni alla presidenza di Fratelli d’Italia, insieme a Daniela Santanché che passa con lei - c’è anche Isabella Rauti, a fare politica nella dirigenza di quel partito.
Perché? L’ascesa delle donne nei movimenti di destra, estrema destra, populisti, xenofobi, è un fenomeno a sé che merita e ottiene grande attenzione. Mentre abbiamo accettato, digerito, sepolto nell’irrilevanza la scomparsa delle donne dalla leadership dei partiti progressisti, di sinistra, socialdemocratici, democratici.
Il caso Mdp fa particolarmente impressione. Perché è un movimento al quale guarda, con interesse o rabbia, con passione o sconforto, chi non accetta l’ordine delle cose. Fa impressione non solo che non ci sia una donna nella prima foto di gruppo, ma anche e soprattutto che la cosa non faccia problema per nessuno dei quattro, o dei 5000 che erano lì.
Di nuovo: perché? Non si risponda - come fece Monti, dicono, quando formò un governo ipermaschile e dovette rimediare all’ultimora - “di donne non ne abbiamo”; perché tra i fondatori di Mdp ce n’è una seria, preparatissima, nientemeno che un’economista, addirittura proveniente dalla società civile (università), ossia Maria Cecilia Guerra. Che magari, come molte donne e al contrario di molti uomini, non ama andare in giro a parlare di cose che conosce poco, ma può dire molto di quelle che conosce bene (qui il suo lavoro politico): politica economica, occupazione, sicurezza sociale... cosette importanti, diciamo, per un soggetto di “liberi e uguali”. Uguali a chi?
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- La dittatura della X fra affetti e affari e l’ultimo totem per il villaggio globale.1 dicembre 2017, di Federico La Sala
PERDITA DELLA MEMORIA FILOLOGICA E TEOLOGICA: LA “X” (“CHI”, GRECO) DIVENTA “X” (“ICS”, LATINO; E, SEMPLICEMENTE, "C", IN ITALIANO) E GESU’, IL FIGLIO DELLA GRAZIA EVANGELICA ("CHARITAS") DIVENTA IL "TESORO" DI "MAMMONA" ("CARITAS") E DI "MAMMASANTISSIMA" DEI FARAONI ...
- "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS": LA CARITA’ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia) NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!).
opinioni
La dittatura della X fra affetti e affari
di Vittorio Zucconi (la Repubblica D, 25.11.2017)
Il Medioevo italiano la mise al bando, ma ora si usa ovunque, perché, evidentemente, attira l’attenzione. Che si tratti di business o di baci
ATTESO DA ALMENO cento milioni di esseri umani, molti dei quali in fila da giorni, è arrivato l’ultimo totem per il villaggio globale: l’iPhone X della Apple. Niente di misterioso in quella X, solo la celebrazione in numeri romani del decimo anniversario dell’iPhone lanciato da Steve Jobs: così dicono dalla Mela, ma mentono sapendo di mentire. Per segnalare il decennale, avrebbero potuto benissimo chiamarlo iPhone 10, come i predecessori 6, 7 o 8.
I geni del marketing hanno scelto la X per lo stesso motivo che ha spinto i concorrenti della Microsoft a chiamare la loro scatola da giochi XBox e (nell’ultima edizione diffusa negli stessi giorni dell’iPhone X, per tormentarci il Natale) addirittura XBoxOneX. Tre X al prezzo di una. Non è necessario essere geni dell’enigmistica e dei cruciverba per notare la fissazione per una lettera-simbolo che, da secoli e mai come ora, è uscita dal recinto dell’algebra per invadere i territori del commercio, dell’immaginazione, del calcio e del sesso, pardon, del sex.
La X vende, piace, intriga, nella sua invadenza. L’epidemia di questa lettera (che, nel Medioevo, l’alfabeto italiano aveva escluso, insieme con K e Y, presenti invece nell’alfabeto latino) è naturalmente partita dagli Stati Uniti ed è un indizio del dominio culturale anglofono. È ovunque e le femmine ne hanno pretese addirittura due nei propri cromosomi, XX, lasciando a noi maschi l’umiliazione di quella Y solitaria.
S’insinua nella vita di ogni paziente, che ha sicuramente inghiottito una pillola il cui nome conteneva una X o è stato esposto ai raggi X. Ci sono almeno 50 farmaci da ricetta che la esibiscono, dal tranquillante Xanax, che raddoppia per sembrare più efficace, all’antibiotico Ciprofloxacina, somministrato a milioni di persone afflitte da infezioni delle vie urinarie.
Qualche linguista Usa ha cercato di spiegare l’attrazione con il Cristianesimo, partendo dalla croce che i Romani usavano per uccidere i nemici più pericolosi e che era fatta appunto a X, e non a T come nell’iconografia ufficiale. Ma non c’è nulla di mistico in banali varietà musicali come X Factor, copiato anche in Italia. Dubbi religiosi riaffiorano in dicembre, quando gli americani, sempre impazienti, abbreviano Christmas, Natale, in XMas. Ma poi si sprofonda nel prosaico esercizio del voto, che utilizzò quel segno affinché anche gli analfabeti potessero manifestare sulle schede le scelte politiche.
Resta in esso sempre il brivido del mistero, dell’incognita, come nelle equazioni o nella fantascienza della serie X-Files. Sa di frutto proibito, nei film porno classificati come XXX o nei commerci erotici, in quei Sex Shop che, se si chiamassero "botteghe del sesso", farebbero ancora più schifo. Diventa il richiamo alla morte e alla ferocia dei pirati, con le ossa incrociate a forma - che altro? - di X sotto il teschio. È uno dei molti simboli satanici, ma anche di tenerezza, nella stenografia da chat o da sms, dove sta per "baci", insieme con O, per "abbracci": XOXO, "ti mando baci e abbracci". Tende a essere estremista nell’abbigliamento, con le taglie XS, XL o addirittura, aiuto!, XXL. Anche l’immagine che guardiamo sul televisore, sul computer o sullo schermo dello smartphone paga un tributo, essendo formata da pixel.
Non ha colpe, né meriti questa lettera prepotente, immigrata senza autorizzazione fra di noi, ma qualche segreta e scaramantica influenza negativa forse sì. Soltanto uno, fra i 45 presidenti degli Stati Uniti in 200 e più anni, ha osato avere una X nel proprio nome, Richard Nixon. Finì infatti, primo e unico dimissionario nella storia, crocefisso alla vergogna delle proprie colpe.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori - a c. di Federico La Sala
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- NI UNA MENOS. NON UNA DI MENO. Aborto - Libere di scegliere sul nostro corpo (di Rachele Gonnelli).30 settembre 2017, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELL’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE (E DEL FIGLIO), DONNE E UOMINI, CITTADINE-SOVRANE E CITTADINI-SOVRANI. Il "romanzo familiare" edipico della chiesa e della cultura cattolico-romana è finito... *
Libere di scegliere sul nostro corpo: sit-in in varie città e corteo a Roma
Non Una di Meno. Giornata mondiale per l’aborto libero e sicuro, nella capitale manifestazione anche contro le ricette antistupro che colpevolizzano donne e migranti
di Rachele Gonnelli (il manifesto, 29.09.2017)
- Molti presidi di donne davanti agli ospedali di varie città, da Firenze alla Sicilia, a Lecce, a Brindisi, ieri, per la Giornata per l’aborto libero e sicuro lanciata dal movimento femminista argentino Ni Una Menos a livello mondiale.
A Roma il comitato della rete Non Una di Meno ha organizzato, oltre a un presidio in mattinata davanti al Policlinico Umberto I - sempre contro i troppi ginecologi obiettori e per l’utilizzo della pillola abortiva Ru486 - anche un corteo. O meglio, un sit-in in piazza dell’Esquilino che in serata si è trasformato in un piccolo corteo - tollerato dalla polizia - fino a piazza Vittorio.
CARTELLI E TAMBURI hanno accompagnato la manifestazione romana che, oltre alla libertà di scelta per quanto riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza, si è caratterizzata per una rivendicazione più a tutto tondo sul corpo delle donne. E quindi «contro tutte le risposte securitarie che a Roma ci vogliono propinare dalle varie autorità come soluzioni antistupro», spiega Sara, dai militari a cavallo nei parchi, al vademecum pubblicato dal quotidiano il Messaggero, contro il quale c’è già stato un sit-in di protesta specifico la scorsa settimana. «Vogliono colpevolizzare le donne per come si vestono e gli immigrati - spiega ancora Sara - nascondendo che l’80 per cento delle violenze sessuali accadono tra le mura domestiche».
LE FEMMINISTE ROMANE non ci stanno e insistono a dire, dal camion-palco della manifestazione, negli slogan gridati e sui cartelli che «le strade sicure le fanno le donne che le attraversano», contro tutti quelli che vorrebbero invece rinchiuderle in casa o messe sotto scorta e sotto tutela. E infatti scrivono anche «Le strade libere non le fanno i militari, i taxi o i lampioni», e anche, con evidente riferimento ai carabinieri di Firenze: «Dopo una sbronza mi aspetto un mal di testa non uno stupro».
SUI SAMPIETRINI dietro la Basilica di Santa Maria Maggiore le ragazze più giovani sono le più diffidenti con i giornalisti, temono di essere strumentalizzate. Ma un grappolo di studentesse del liceo Tasso accetta di parlare, collettivamente e senza nomi. Hanno 17 anni, al quarto anno, di varie sezioni, e non si sono riunite in collettivo o in assemblea «perché nel nostro liceo non è molto possibile», dicono. Hanno iniziato a parlare tra loro a partire dalle lezioni di un comune professore di filosofia. «Dice di essere dalla nostra parte - spiegano - ma in realtà molte sue lezioni sono solo propaganda di un maschilismo soft, ci dice di non girare di notte con le gambe nude, perché altrimenti “ve la siete cercata”, per lui niente cambierà mai, il femminismo è solo speculare al maschilismo, che invece è sbagliatissimo, e certi ruoli sono cementati dalla tradizione, per cui immutabili. Alla fine non fa che dare spazio a discorsi razzisti sugli immigrati e non dice i dati veri, siamo dovute andarli a cercare ma neanche i giornali li chiariscono».
È GIOIOSO il corteo romano e mescolati tra le tante donne ci sono anche uomini, di varia età. «Se ce ne sono di più è perché le nostre donne stanno facendo un percorso anche con loro, e questo è un successo», sostiene Simona di Non Una di Meno. Ma le ragazze del Tasso sostengono che «sono le donne che dovrebbero essere più partecipi su ciò che le riguarda direttamente».
NON SI VEDONO INVECE cartelli del tipo «la 194 non si tocca», che invece contrassegnavano i presidi davanti agli ospedali pugliesi, dove l’obiezione di coscienza nei reparti Ivg raggiunge punte dell’89 per cento. Non che nel Lazio la situazione sia tanto migliore: al Policlinico a fare gli aborti ci sono solo medici assunti a tempo determinato. E anche le sale parto sono insufficienti.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
LA COMPETENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEL VATICANO E’ "PREISTORICA" E "MAMMONICA". Il "romanzo familiare" edipico della chiesa e della cultura cattolico-romana è finito
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
Federico la Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" -- LA COSTITUZIONE E 4 PAROLE DA RIPENSARE (LEX, LUX, REX, DVX). Una sollecitazione da Nardò (Lecce).28 settembre 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, IL SEDILE, LA SELLA CURULE, LA "X" DI "REX" E "DUX", HENRY W, LONGFELLOW, E IL "DVX" DEL FASCISMO.... *
AD AMPLIARE e a contribuire a rendere più comprensibili ed evidenti i nessi tra i vari livelli del brillante lavoro di Armando Polito sul SEDILE di Nardò (Lecce), è bene tenere presente e ricordare cosa era la SELLA CURULE nella società dell’antica Roma:
"La sella curule (in lat. sella curulis) era un sedile pieghevole a forma di "X" ornato d’avorio, simbolo del potere giudiziario, riservato inizialmente ai re di Roma e in seguito ai magistrati superiori dotati di giurisdizione, detti perciò "curuli".
I magistrati solevano portare con sé la sella curulis assieme agli altri simboli del loro potere (fasci, verghe e scuri) e ovunque disponessero questi simboli, lì era stabilita la sede del loro tribunale.
Durante il periodo della Repubblica, il diritto di sedere sulla sella curule era riservato a: consoli, pretori, edili curuli, sacerdoti massimi, dittatori e al magister equitum. In epoca imperiale l’uso della sedia curule fu ampliato anche all’imperatore, al praefectus urbi e ai proconsoli.
Il simbolo di potere rappresentato dalla sedia curule affonda le sue radici nell’antica Etruria; infatti già gli Etruschi consideravano lo scranno pieghevole a forma di sella una prerogativa di chi poteva esercitare il potere (giudiziario ed esecutivo) sul popolo. Fu portato a Roma dal quinto re, Tarquinio Prisco.[1]
- (LAT.)
 « Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
« Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit. Alii ab numero avium quae augurio regnum portenderant eum secutum numerum putant. Me haud paenitet eorum sententiae esse quibus et apparitores hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse Etruscos quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lictores dederint. »
- (IT)
 « Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
« Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunita in assemblea la massa che non avrebbe mai potuto unificarsi in un unico organismo popolare se non con leggi, Romolo dettò norme giuridiche. Dunque, stimando che esse sarebbero apparse inviolabili a un materiale umano ancora rozzo solo se egli stesso si fosse reso venerabile per mezzo di segni esteriori dell’autorità, si fece più maestoso con fasto dell’abbigliamento e particolarmente con la guardia dei dodici littori. Alcuni ritengono che egli abbia considerato il numero degli uccelli che gli avevano presagito il potere. A me non dispiace l’opinione di coloro che pensavano che anche questo tipo di guardie derivasse dai vicini Etruschi da cui fu ricavata anche la sella curule e la toga pretesta, e pensano che anche il numero dei littori venisse di là e che tale fosse presso gli Etruschi per il fatto che, dopo che i dodici popoli avevano eletto in comune il re ciascuno di essi gli assegna un littore. » (Liv. Hist. I, 8) "( cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Sella_curule).
RICORDARE CHI ERA HENRY W. LONGFELLOW:
"Henry Wadsworth Longfellow (Portland, 27 febbraio 1807 - Cambridge, 24 marzo 1882) è stato uno scrittore e poeta statunitense, tra i primi letterati americani ad assurgere alla fama mondiale.
Longfellow fu il più famoso poeta della scena del New England nell’’800 e scrisse numerose opere tra cui Evangeline e Il faro.
Fu un acceso promotore dell’abolizione della schiavitù negli anni prima e durante la Guerra Civile Americana insieme ad altri intellettuali che gravitavano nell’orbita di Harvard e soprattutto insieme all’allora Governatore del Massachusetts John Andrew.
Intorno al 1862 insieme ai letterati James Russell Lowell, Oliver W. Holmes e George Washington Greene diede vita al cosiddetto "Circolo Dante", atto a promuovere la conoscenza della Divina Commedia di Dante Alighieri negli Stati Uniti. Insieme ai suoi colleghi del circolo, Longfellow ne portò a termine la prima traduzione statunitense in inglese nel 1867.
Da allora il successo dell’opera di Dante in America fu costante ed in seguito il Circolo diventò la "Dante Society", una delle più famose associazioni di dantisti nel mondo [...]" (cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Henry_Wadsworth_Longfellow).
LE PAROLE ("DVX-LVX, REX-LEX") SCRITTE SULLA "CROCE" INSCRITTA NEL "CERCHIO" SULLA TOMBA DI LONGFELLOW sicuramente - via Dante Alighieri (e probabilmente anche via Dante Gabriele Rossetti) - si ricollegano al filo della tradizione religiosa cristiana, e sono riferite a CRISTO, concepito come LUCE, LEGGE, RE, DUCE.
E, ANCORA, per capire come e perché siano apparse le scritte "REX" e "DVX" sulla parete del SEDILE di Nardò (Lecce), bisogna RICORDARE chi era MARGHERITA GRASSINI SARFATTI e rileggere il suo "DVX" (sul tema, mi sia consento, cfr IL MITO DELLA ROMANITÀ E IL FASCISMO: MARGHERITA SARFATTI E RENZO DE FELICE).
E, INFINE, PER CAPIRE MEGLIO, E ALLA LUCE DEL SOLE ("INVICTUS"), IL SENSO DELLE "QUATTRO PAROLE" (LVX, LEX, REX, DVX), LEGGERE E RILEGGERE E ANCORA RILEGGERE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ....
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
 ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
EICHMANN A GERUSALEMME (1961). “come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- (LAT.)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - Innanzi tutto amare se stessi. La lezione di Laura Mesi, la prima sposa single d’Italia .23 settembre 2017, di Federico La Sala
CONOSCI TE STESSO, CONOSCI TE STESSA!!! Dopo millenni di riflessione, la nostra identità ("tautòtes" - greco) ancora nella culla ...
Abito bianco, bomboniere e 70 invitati alla festa: in Brianza la prima sposa single d’Italia
"Se a 40 non ho ancora il fidanzato faccio il matrimonio con me stessa": Laura Mesi ha mantenuto la promessa. E ha organizzato un mega party costato 10mila euro, viaggio di nozze compreso. "Ecco la mia fiaba senza principe azzurro"
di LUCIA LANDONI *
- Dal taglio della torta alle bomboniere: il fotoracconto del matrimonio della sposa single di Lissone Laura, la prima sposa single: ’’Non divorzierò mai da me stessa, nemmeno per l’uomo della mia vita"
Abito bianco, bomboniere, taglio della torta, lancio del bouquet, familiari e amici commossi. Quello di Laura Mesi, 40enne istruttrice di fitness di Lissone (in provincia di Monza e Brianza), è stato un matrimonio tradizionale in tutto e per tutto, salvo per un particolare: mancava lo sposo.
"Sono la prima sposa single d’Italia. Qualche mese fa l’ha fatto anche un uomo di Napoli, ma a me l’idea era già venuta due anni fa. Avevo detto a parenti e amici che se entro il quarantesimo compleanno non avessi trovato la mia anima gemella mi sarei sposata da sola - spiega - Credo fermamente che ciascuno di noi debba innanzi tutto amare se stesso. Si può vivere una fiaba anche senza il principe azzurro. Se un domani troverò un uomo con cui progettare un futuro ne sarò felice, ma la mia felicità non dipenderà da lui".
- Dal taglio della torta alle bomboniere: il fotoracconto del matrimonio della sposa single di Lissone
Laura si è data da fare e ha organizzato in totale autonomia la sua cerimonia dei sogni: "Ho speso un po’ più di 10mila euro, pagando tutto di tasca mia. Ho fatto una piccola follia per il vestito e per le fedi, che sono due intrecciate in un unico anello. Grazie ai regali dei 70 invitati sono riuscita a coprire le spese del pranzo nuziale. Mi sono concessa anche il viaggio di nozze. Il giorno dopo la cerimonia, che si è tenuta in un ristorante di Vimercate, sono partita per Marsa Alam, sempre da sola".
Il matrimonio, celebrato da un amico che per l’occasione ha indossato una fascia tricolore, non ha alcun valore legale né religioso, ma la sposa garantisce che le emozioni provate sono state assolutamente reali: "Ho promesso di amarmi per tutta la vita e di accogliere i figli che la natura vorrà donarmi. Anche i miei familiari sono stati molto felici, compreso mio fratello che all’inizio era scettico sulla mia idea e invece poi ha finito per commuoversi accompagnandomi verso il celebrante".
Un’esperienza che la sposa single - seguita sull’omonima pagina Facebook da circa 1300 persone - ammette non essere per tutti: "Per portate avanti un progetto del genere servono una certa disponibilità economica, il sostegno di chi si ha intorno e soprattutto un pizzico di follia"
* LA REPUBBLICA, 21 SETTEMBRE 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- NUOVO REALISMO: LA LEZIONE DI DANTE, OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
 Per ben agire e ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!!
Per ben agire e ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!!
CONOSCI TE STESSO!!! Dopo millenni di riflessione, la nostra identità ("tautòtes" - greco) ancora nella culla o, meglio, nella bara ("taùto" - napoletano)
 LA FILOSOFIA E IL NARCISISMO "DIALOGICO". AMORE DELL’ALTRO O AMORE DI SE’? E’ LO STESSO. Una "risposta" di Umberto Galimberti
LA FILOSOFIA E IL NARCISISMO "DIALOGICO". AMORE DELL’ALTRO O AMORE DI SE’? E’ LO STESSO. Una "risposta" di Umberto GalimbertiFederico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - “Maschio e femmina Dio li creò” (di Enzo Bianchi).19 settembre 2017, di Federico La Sala
"DEUS CHARITAS EST" (1 Gv.): LO SPIRITO CHRISTICO, LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO... *
“Maschio e femmina Dio li creò”
di Enzo Bianchi *
- dalla lectio al FestivalFilosofia di Modena
Nel libro della Genesi, il primo libro della bibbia, il libro dell’in-principio (be-re’shit: Gen 1,1) troviamo due racconti della creazione, composti da autori e redattori umani, dunque segnati da una precisa cultura, in un tempo definito della nostra storia. Appartengono a un genere letterario che qualifichiamo come mitico: il mito è un racconto situato culturalmente, dotato di una visione specifica, ma che vuole significare ciò che è universale, costitutivamente antropologico; ovvero, nel nostro caso, cosa ne è dell’’adam, dell’essere umano, il “terrestre”. Sono redazioni diverse e non contemporanee della creazione, ma sono stati posti intenzionalmente l’uno dopo l’altro dai redattori finali della Torah: non giustapposti, ma collocati in successione, in modo che apparisse la dinamica dell’umanizzazione.
Nel primo racconto (Gen 1,1-2,4a), un vero e proprio inno, una narrazione ritmata e ripetitiva, è contenuta la creazione dell’’adam, dell’umano, descritta con un testo che nella sua armonia poetica scandisce il cuore del messaggio biblico su Dio e l’umanità nei suoi rapporti con Dio e con gli animali. Ascoltiamola in una versione calco dell’ebraico: “Ed ’Elohimdisse: Facciamo ’adam in nostra immagine, come nostra somiglianza: dominino i pesci del mare, i volatili dei cieli, il bestiame, tutta la terra e ogni strisciante sulla terra. Ed ’Elohim creò ha-’adam in sua immagine, in immagine di ’Elohim lo creò, maschio e femmina li creò” (Gen 1,26-27).
Chi è l’umano creato “in immagine di Dio”, chi è rispetto a Dio e rispetto agli animali? E cosa comporta quel singolare “lo creò”, ripetuto nel duale “maschio e femmina li creò”? Gli esseri umani, l’umanità immagine di Dio è in relazione con Dio stesso e con le altre creature. L’essere umano è in sé relazione, e ciò che lo attesta in modo paradigmatico è la differenza sessuale, perché l’umano esiste in quanto maschio e femmina, con tutte le possibili varianti e intersecazioni di questa polarità. Gli umani sono immagine di Dio, ciascuno di loro nell’umanità di cui fa parte, in sé sono uniti e si completano accettando la differenza reciproca. In questo testo vi è un’immensa valorizzazione del rapporto uomo-donna, valorizzazione della completezza: non c’è una svalutazione della sessualità né una visione cinica o angosciata della differenza sessuale! La sessualità è positiva e Dio vuole che l’uomo e la donna insieme portino a compimento l’opera di umanizzazione: creati a immagine di Dio, devono diventargli conformi, somiglianti.
Ciò deve avvenire nel vivere: nella vita e solo nella vita! Vivere significa venire al mondo, abitarlo, stare tra co-creature di cui gli umani devono assumersi una responsabilità. Gli umani hanno un corpo come gli animali, sono animali, ma sono anche diversi da loro, innanzitutto nella responsabilità. L’umano è e deve farsi responsabile della terra e dell’ambiente, non è la terra che deve essere responsabile dell’umanità.
Nel secondo racconto (Gen 2,4b-25), più antico di secoli, o forse addirittura di più di un millennio confluiscono elementi mitologici di diverse culture e intende collocare l’umano nel mondo e metterlo in relazione, riaffermare attraverso un altro percorso che l’umano è relazione, è alterità. Ora, la differenza sessuale è parabola di ogni alterità, in nome della quale l’altro, “gli altri - come diceva Jean-Paul Sartre - sono l’inferno”, o meglio, possono esserlo. L’umano è veramente tale quando vive la relazione, ma ogni relazione di differenza comporta tensione e conflitto. Il rapporto uomo-donna è l’epifania della differenza e della reciproca alterità. Solo nella relazione l’umano trova vita e felicità, ma la relazione va imparata, ordinata, esercitata, perché in essa occorre dominare l’animalità presente in ciascuno, che nel rapporto si manifesta come violenza.
Ecco dunque l’umano, un essere in relazione con la terra da cui è tratto, con gli animali in quanto animale, con l’altro da sé che ha il suo stesso soffio di vita ricevuto da Dio e infine con Dio stesso . È in questo fascio di relazioni che l’umano, uomo e donna, si umanizza. E quando il terrestre, uscito dal torpore in cui Dio lo aveva posto, vede l’altro lato, il partner, allora parla con stupore. Ecco l’accesso alla parola, possibile quando c’è di fronte l’altro: finalmente un partner degno, che accende la parola, che abilita all’io-tu, al dialogo, alla relazione! Finalmente - dice l’uomo - un essere che è “osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. La si chiamerà ’isshah perché da ’ish è stata tratta” (Gen 2,23). La relazione ormai è inaugurata: ecco l’uomo e la donna.
Ma se oggi riusciamo a fare questa lettura delle prime due pagine della Bibbia, occorre però ricordare che l’interpretazione non è sempre stata questa. Né si dimentichi che già nell’ultima parte del secondo racconto vi sono in luce tutti i segni del dramma che attraversa la storia fino a noi, fino al femminicidio che purtroppo tante volte appare ancora nei nostri giorni. In verità l’umano, ha-’adam, già qui si rivela in tutta la sua problematicità. Infatti, non appena l’uomo vede la donna, non parla alla donna, non imbocca la strada dell’io-tu, ma parla a se stesso: “Questa sì che osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne”. In tal modo esprime una verità, e cioè che la donna ha la stessa natura e perciò la stessa dignità e vocazione dell’uomo, ma la dice male, esprimendo subito la sua possessività: osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. Parla a se stesso e parla del suo possesso. La donna tace, è ridotta al silenzio e per l’uomo appare una cosa. Egli dice: “È stata tratta da me, è mia carne”, e così nega ogni alterità, quell’alterità che richiede che la donna sia un soggetto di fronte a lui. Subito la volontà e il progetto di Dio sono traditi, e il dramma che seguirà immediatamente è già abbozzato qui, nell’emergere della differenza negata!
Scriveva Thomas Stearns Eliot in uno dei suoi Quattro quartetti : “Nel mio principio è la mia fine ... Nella mia fine è il mio principio” (East Coker, inizio e fine del testo). In queste prime pagine dell’in-principio c’è già tutta la storia dell’umanità, c’è già il misconoscimento dell’altro partner, c’è già la pretesa che l’altro sia un possesso omologo, che l’altro non sia altro, differente, diverso! Culture patriarcali e rare culture matriarcali manifestano la lotta tra i sessi, manifestano la ferita che ognuno di noi sente di fronte alla differenza: ne è attratto ma ne ha paura, vuole relazione ma ne vuole il possesso, vuole comunione ma anche guerra.
Queste pagine tentano allora di dirci come le singolarità di ciascuno di noi, dovute a molte differenze, a partire da quella sessuale, devono coniugarsi affinché vi siano vita e felicità, seppur segnate dal limite. La differenza sessuale maschio-femmina è paradigma di ogni differenza, ma tutte le differenze sono legate a quel tragitto che ognuno umano compie, tra la nascita e la morte, quando ognuno di noi ritornerà alla terra da cui è stato tratto (cf. Gen 3,19), dunque ritornerà a colui che l’ha creato. Allora ciascuno darà una risposta personalissima alla domanda sul cammino di umanizzazione rivoltagli da Dio. Mi riferisco alla prima domanda di Dio, narrata subito dopo nella Genesi, domanda rinnovata in ogni giorno della nostra vita: “’Adam, dove sei?” (Gen 3,9). Nella nostra fine è la risposta alla domanda dell’in-principio, alla responsabilità dell’umanizzazione. (fonte: Monastero di Bose)
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Chiesa. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica .... Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!
FEDE E CARITÀ ("CHARITAS"): CREDERE "ALL’AMORE" ("CHARITATI"). Enzo Bianchi si domanda "come si può credere in Dio se non si crede nell’altro?", ma non si rende conto che è il quadro teologico costantiniano e mammonico che va abbandonato!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - IL "PADRE NOSTRO" E DUEMILA ANNI DI "LATINORUM".14 settembre 2017, di Federico La Sala
IL "PADRE NOSTRO": BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E
DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" CATTOLICO-ROMANO... *
A)
Dubbi sul Padre Nostro
Alcuni lettori ci scrivono.
"Non ci indurre in tentazione", il vero significato
Risponde il teologo Giuseppe Pulcinelli (Avvenire, 13.09.2017)
- La frase del Padre nostro «non ci indurre in tentazione» (Mt 6,13) crea problemi: come va tradotta e interpretata? UN ABBONATO
Nell’originale greco c’è il verbo eisenenkes che significa “immettere”, “introdurre”. Ma si vuol forse dire che Dio spinge l’uomo verso il male (la tentazione) e quindi gli si chiede di non farlo?
In realtà, alla luce di altri passi della Scrittura (cfr. Gc 1,13: «Dio non tenta nessuno»), si può e si deve dare un’altra spiegazione. Il verbo greco probabilmente traduce - in modo approssimativo - un originale semitico che va compreso in base a testi come il Salmo 140 (141),4: «Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori».
Il senso dell’invocazione è dunque: «Non ci lasciare entrare e soccombere nella tentazione». Speriamo che presto venga adottata anche nella liturgia la versione ufficiale della Cei (2008), che ha corretto con «non abbandonarci alla tentazione».
B)
Chiedi al teologo
Non abbandonarci «alla» o «nella» tentazione?
di Luigi Lorenzetti (Famiglia Cristiana, 02/06/2017)
- SERGIO - Nella nuova traduzione del Padre nostro la frase «non abbandonarci alla tentazione» potrebbe far pensare che essere tentati è già un peccato. Non era meglio la preposizione «nella»?
Nella nuova traduzione della Bibbia Cei (2008) la dizione «Non c’indurre in tentazione», è cambiata in «Non abbandonarci alla tentazione». La tentazione mette la libertà-responsabilità della persona di fronte a un bivio: il bene e il male. Ad esempio, aiutare il prossimo o lasciarlo perdere? Per scegliere il bene, è necessario l’aiuto di Dio che, d’altra parte, non lo impone a nessuno. Da qui la consapevolezza d’averne bisogno e di chiederlo fiduciosi nella preghiera.
Il significato della nuova dizione è tutto nell’invocazione «Non abbandonarci» alla (traduzione ufficiale) o (il che è lo stesso) nella tentazione. Nell’una come nell’altra versione, è chiara la distinzione tra «essere tentati» e «consentire ». È consolante pensare e credere che Dio è sempre presente alla (o nella) tentazione, così da vincerla, anzi, trasformarla in conferma nella scelta del bene.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Dio è amore ("charitas") e il cristianesimo non è un cattolicismo!!!
IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. Una nota di Henri Tincq - con premessa
IL "PADRE NOSTRO" NON E’ QUELLO DI PAPA BENEDETTO XVI. IL "DIO" DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI NON CI INDUCE IN TENTAZIONE!!!
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?! Bergoglio incontra Ratzinger: "Siamo fratelli". Ma di quale famiglia?!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! - MATEMATICA ED EDUCAZIONE. LA LEZIONE DI KANT.11 settembre 2017, di Federico La Sala
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ... *
PER UNA SCUOLA CHE INSEGNI A VOLARE. Una nota a margine di "Una domanda eterna: che cosa significa educare?" ...
- "La matematica ci dà uno splendido esempio di quanto possiamo spingerci innanzi nella conoscenza a priori, indipendentemente dall’esperienza. È vero che essa ha che fare con oggetti e conoscenze solo in quanto si possono presentare nell’intuizione: ma questa circostanza vien facilmente trascurata, perché l’intuizione stessa può essere data a priori, e perciò difficilmente si può distinguere da un concetto puro. Eccitato da una siffatta prova del potere della ragione, l’impulso a spaziare più largamente non vede più confini.
 La colomba leggiera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di aria. Ed appunto così Platone abbandonò il mondo sensibile, poiché esso pone troppo angusti limiti all’intelletto; e si lanciò sulle ali delle idee al di là di esso, nello spazio vuoto dell’intelletto puro. Egli non si accorse che non guadagnava strada, malgrado i suoi sforzi; giacché non aveva, per così dire, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui potesse applicare le sue forze per muovere l’intelletto.
La colomba leggiera, mentre nel libero volo fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che le riuscirebbe assai meglio volare nello spazio vuoto di aria. Ed appunto così Platone abbandonò il mondo sensibile, poiché esso pone troppo angusti limiti all’intelletto; e si lanciò sulle ali delle idee al di là di esso, nello spazio vuoto dell’intelletto puro. Egli non si accorse che non guadagnava strada, malgrado i suoi sforzi; giacché non aveva, per così dire, nessun appoggio, sul quale potesse sostenersi e a cui potesse applicare le sue forze per muovere l’intelletto.
 Ma è un consueto destino della ragione umana nella speculazione allestire più presto che sia possibile il suo edifizio, e solo alla fine cercare se gli sia stato gettato un buon fondamento. Se non che, poi si cercano abbellimenti esterni di ogni specie per confortarci sulla sua saldezza, o anche per evitare del tutto tale tardiva e pericolosa verifica" (Immanuel Kant, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 38).
Ma è un consueto destino della ragione umana nella speculazione allestire più presto che sia possibile il suo edifizio, e solo alla fine cercare se gli sia stato gettato un buon fondamento. Se non che, poi si cercano abbellimenti esterni di ogni specie per confortarci sulla sua saldezza, o anche per evitare del tutto tale tardiva e pericolosa verifica" (Immanuel Kant, Critica della ragion pura, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 38).
EDUCAZIONE? CHI EDUCA CHI: INSEGNARE A VOLARE. I SOGGETTI sono DUE, e tutto è da ripensare...
Pur condividendo con l’Autore di "Una domanda eterna: che cosa significa educare?", la linea strategica della sua riflessione ("della libertà faccio il perno centrale dell’educazione, un perno che ricomprende l’idea di educazione come introduzione alla realtà, il punto che sussume tutti i percorsi e le esperienze attivate per educare i cittadini di domani a una vita virtuosa"), credo che sia necessario e opportuno (anche sul filo delle sue stesse accennate indicazioni di Aristotele, Rousseau, Kant) portarci oltre e RIFLETTERE su quanto nella domanda è "nascosto", vale a dire su "CHI" educa "CHI" - a tutti i livelli! I SOGGETTI sono DUE, e tutto è da ripensare...
Se di Rousseau non vogliamo (continuare a) farne un teorizzatore dell’e-duc-azione autoritaria ( "ex-DUX-azione"), dobbiamo problematizzare proprio la sua frase finale, (ripresa dall’ "Emilio"), sull’uomo virtuoso, sul diventare "padrone di se stesso", e sul comandare al proprio "cuore", e, con lo stesso Rousseau, reinterrogarci sulla nostra condizione: "L’uomo è nato libero, e ovunque è in catene. Anche chi si crede padrone degli altri, non è per questo meno schiavo degli altri" ("Il contratto sociale"); e, insieme, sul tema del "CAPO" (preziosa al riguardo la "lezione" di Gramsci del 1924).
La questione è "eterna" ed è ... intrecciata con la questione delle Sibille e dei Profeti di Copertino (cfr. Pierpaolo Parsi: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/30/copertino-si-scopre-casa-delle-sibille/), con la filologia e l’affresco di sant’Agostino di Nardò (cfr. M. Gaballo: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/), e, ancora e in particolare, con il lavoro di Sigmund Freud. Non a caso in un mio lavoro su questi temi (cfr.: "Della Terra, il brillante colore. Parmenide, una "Cappella Sistina" carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barberi (1481) e la domanda antropologica", Prefazione di Fulvio Papi, Milano 2013), un capitolo è dedicato al problema J.-J. ROUSSEAU: "Al di là della cecità edipico-parmenidea e al di là della "società civile". J.-J. Rousseau: una coscienza aperta e una triplice fedeltà" (pp. 101-110).
PER ANDARE AVANTI democraticamente occorre rimeditare (come Pierpaolo Tarsi sollecita a fare) la lezione kantiana racchiusa nell’immagine della colomba della "Critica della Ragion Pura", occorre INSEGNARE A VOLARE. E, su questo, il contributo di KANT è enorme. Se si vuole uscire dallo "stato di minorità", non si può non tenerne conto!
ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN!
Federico La Sala
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ARITMETICA E ANTROPOLOGIA. UNA DOMANDA AI MATEMATICI: COME MAI "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia)?! Non è il caso di ripensare i fondamenti?!
- "La matematica ci dà uno splendido esempio di quanto possiamo spingerci innanzi nella conoscenza a priori, indipendentemente dall’esperienza. È vero che essa ha che fare con oggetti e conoscenze solo in quanto si possono presentare nell’intuizione: ma questa circostanza vien facilmente trascurata, perché l’intuizione stessa può essere data a priori, e perciò difficilmente si può distinguere da un concetto puro. Eccitato da una siffatta prova del potere della ragione, l’impulso a spaziare più largamente non vede più confini.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Chi ha paura di Jorge Mario Bergoglio (di Riccardo Cristiano).3 settembre 2017, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA ... *
Chi ha paura di Jorge Mario Bergoglio
di Riccardo Cristiano (Articolo 21, 1 settembre 2017)
Le anticipazioni di un libro intervista che contiene la trascrizione di dodici dialoghi con il sociologo Dominique Wolton (titolo: “Politique et sociétéˮ, edizioni L’Observatoire) riferiscono che Papa Francesco ha detto di essere andato per alcuni mesi da una psicanalista. In queste ore non sono pochi i giornali che riferiscono le condanne preconciliari della psicanalisi. Forse è il bisogno di trovare qualcosa di “inaudito” in quanto ha detto Bergoglio. Eppure a partire da Pio XII, passando attraverso gli apprezzamenti positivi del Vaticano II nei confronti della psicologia del profondo, si è giunti al riconoscimento di Paolo VI - nella Sacerdotalis coelibatus (1967) - della possibile necessità di un aiuto psicanalitico per i sacerdoti in difficoltà. Questa evoluzione è stata facilitata da una schiera di psicoanalisti dichiaratamente cattolici.
 C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”
C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”Passa in ombra così l’usuale coraggio di Jorge Mario Bergoglio, che anche in questa “confessione” di essere andato per sei mesi da una psicanalista ebrea, che lo ha molto aiutato, sembra stare in questo: anch’io sono un uomo, e tutti gli uomini hanno bisogno di aiuto. Lo dice lui, noi lo diciamo molto più difficilmente. -L’epoca buia dello scontro tra religione e psicanalisi è andata in soffitta da tempo. Ma siccome siamo in un’epoca che si fa nuovamente buia, intrisa di odio per l’altro, di pregiudizio, fondamentalmente di paura, sono moltissime le affermazioni fatte da Papa Francesco che colpiscono. E che per leggere bene dovremmo avere il suo stesso coraggio, cioè quello di toglierci il paraocchi e leggere per quel che sono. Un invito ad andare oltre gli steccati di oggi, oltre quei confini che ci chiudono in ghetti tanti asfittici quanto rassicuranti.
Leggiamo alcuni altri passaggi fondamentali delle sue riflessioni, partendo dall’ Africa e i migranti.
 “[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”
“[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”Per un uomo come Papa Francesco generalizzare è sempre difficile, ma se proprio deve farlo non generalizza sulle “razze”, ma sulle azioni degli Stati e le loro conseguenze. Per condannare? No, per esortare a invertire tendenza, a non cercare scorciatoie, a non vedere nelle vittime degli esseri inferiori, ma delle vittime.
Passiamo a Laicità e religioni. “Lo stato laico è una cosa sana. C’è una laicità sana. [...] Credo che la Francia - questo è il mio parere personale, non quello ufficiale della Chiesa - dovrebbe “elevareˮ un po’ il livello della laicità, nel senso che deve dire che anche le religioni sono parte della cultura. Come esprimerlo in modo laico? Attraverso l’apertura alla trascendenza. Ognuno può trovare la sua forma di apertura.” Come si vede, come si legge, qui non c’è una pretesa di superiorità del credente, ma la rivendicazione della spiritualità dell’uomo, del suo bisogno “naturale” di trascendenza.
Quarto punto, l’Europa. “Non vedo più Schumann, non vedo più Adenauer... L’Europa, in questo momento, ha paura. Chiude, chiude, chiude... L’Europa ha una storia di integrazione culturale, multiculturale come dice lei, molto forte. I Longobardi, i nostri Longobardi oggi, sono barbari che sono arrivati molto tempo fa... E poi tutto si fonde e abbiamo la nostra cultura. Ma qual è la cultura europea? Come definirei oggi la cultura europea? Sì, ha importanti radici cristiane, è vero. Ma non è sufficiente per definirla. Ci sono tutte le nostre capacità. Queste capacità per integrarsi, per ricevere gli altri. C’è anche la lingua nella cultura. Nella nostra lingua spagnola, il 40% delle parole è arabo. Perché? Perché erano lì per sette secoli. E hanno lasciato il segno... Credo che l’Europa abbia delle radici cristiane, ma non sono le uniche. Ci sono altre che non possono essere negati. Tuttavia, credo che sia stato un errore non citare le “radici cristianeˮ nel documento dell’Unione europea sulla prima Costituzione, e questo è stato anche commesso dai governi. Era un errore non vedere la realtà. Questo non significa che l’Europa debba essere interamente cristiana. Ma è un patrimonio, un patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto.”
C’è qualcosa di enorme in queste parole, in questa capacità di ricordarci che quel che è stato vero ieri è vero anche oggi. Non esiste purezza, esiste contaminazione. La purezza è delle pietre, la contaminazione è della vita. Anche se non vogliamo più capirlo qualcuno, per fortuna, ce lo ripete.
L’insistenza sulla morale «sotto la cintura». “Ma noi cattolici, come insegniamo la moralità? Non puoi insegnarla con precetti del tipo: “Non puoi farlo, devi farlo, devi, non devi, puoi, non puoiˮ. La morale è una conseguenza dell’incontro con Gesù Cristo. È una conseguenza della fede, per noi cattolici. E per altri, la moralità è una conseguenza dell’incontro con un ideale, o con Dio, o con se stessi, ma con la parte migliore di se stessi. La morale è sempre una conseguenza... C’è un grande pericolo per i predicatori, quello di cadere nella mediocrità. Condannare solo la morale - la prego di perdonare l’espressione - “sotto la cinturaˮ. Ma degli altri peccati, quali l’odio, l’invidia, l’orgoglio, la vanità, l’uccisione dell’altro, prendere la vita, non se ne parla. Entrare nella mafia, fare accordi clandestini...”
Il Vaticano, se posso dir così, è apparso a lungo strabico: l’etica vista dalla Città del Vaticano sembrava riguardare l’inizio e la fine della vita, la morale limitata alla sfera sessuale... Ora l’etica torna a riguardare tutta la vita, dal momento in cui si concepisce a quando si muore, passando però per tutti i momenti della nostra esistenza: da quando sfruttiamo a quando veniamo sfruttati, da quando siamo vittime a quando facciamo nostra vittima un altro. Poco?
Amoris laetitia e rigidità. “La tentazione è sempre quella dell’uniformità delle regole... Prenda ad esempio l’esortazione apostolica Amoris laetitia. Quando parlo di famiglie in difficoltà, dico: “Dobbiamo accogliere, accompagnare, discernere, integrare...ˮ e poi ciascuno vedrà le porte aperte. Quello che sta realmente accadendo è che le persone sentono dire la gente: “Non possono fare la comunione”, “Non possono farlo”: la tentazione della Chiesa è lì. Ma “noˮ, “noˮ e “noˮ!”
Papa Francesco parla di uniformità delle regole, si potrebbe dire che allora la sua Chiesa non si pensa un giudice eterno ed esterno alla storia. Poco?
«L’aborto rimane un peccato grave». “ L’estensione del potere di assolvere il peccato dell’aborto a tutti i sacerdoti, «attenzione, questo non significa banalizzare l’aborto. L’aborto è grave, è un peccato grave. È l’omicidio di un innocente. Ma se c’è peccato, è necessario facilitare il perdono.” Un papa non poteva fare un esempio più rilevante e drammatico per indicare la portata rivoluzionaria della misericordia. Che non è “cancellare il peccato”, ma rigenerare la vita del peccatore. La misericordia così appare la vera cultura alternativa all’odio e, quindi, al terrorismo.
Reciprocità con i musulmani. “Non accettano il principio della reciprocità. Alcuni paesi del Golfo sono aperti e ci aiutano a costruire chiese. Perché sono aperti? Perché hanno lavoratori filippini, cattolici, indiani... Il problema in Arabia Saudita è che è davvero una questione di mentalità. Con l’Islam, comunque, il dialogo sta andando bene, perché non so se lo sa, ma l’Imam di Al-Azhar è venuto a trovarmi. E ci sarà incontro: vado. Penso che farebbe bene a loro fare uno studio critico sul Corano, come abbiamo fatto con le nostre Scritture. Il metodo storico e critico di interpretazione li farà evolvere.”
E’ questo il punto per me più importante, più forte. Senza nessuna pretesa di superiorità, né religiosa né culturale, Bergoglio indica la strada della salvezza dell’islam, in una parola: ermeneutica. Non esita a far presente ai suoi interlocutori il punto decisivo, il punto “critico”, ma lo fa per il bene dell’islam, dei musulmani. E questo, francamente, è commovente.
SUL TEMA, BEL SITO, SI CFR.:
EUROPA ED EVANGELO. LA ’CROCE’ DI CRISTO ("X" = lettera alfabeto greco) NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL "CROCIFISSO" DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Una indicazione dall’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò (Lecce).28 agosto 2017, di Federico La Sala
IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").
"ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS"), DALLA GRAZIA ("gr.: "XAPIS", lat.: "CHARIS") DI DIO AMORE ("CHARITAS"), NON DI DIO MAMMONA ("CARITAS") ...
Lode a Marcello Gaballo per questa bellissima e preziosa nota su "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/#_ftn1) - e il lavoro di De Giorgi: la sua trascrizione della scritta sul cartiglio (ormai scomparsa) "iuste/et cas/te viv/ere et/ xarita(te)" - contrariamente alla protervia che ha portato allo "sproposito maiuscolo" e alla brutta abitudine instauratasi almeno a partire da Ludovico A, Muratori di una "caritas" latina! - conserva ancora la memoria del legame della tradizione dell’evangelo (non: "vangelo"!) con la lingua greca ("charis", "charites"... "charitas").
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. Giambattista Vico ("De constantia iurisprudentis", 1721) giustamente e correttamente e onestamente così pensava e scriveva: "Solo la carità cristiana insegna la prassi del Bene metafisico"("Boni metaphysici praxim una charitas christiana docet"). Sapeva che Gesù ("Christo") aveva cacciato i mercanti FUORI dal tempio, e non aveva autorizzato i sacerdoti a vendere a "caro-prezzo" (lat.: "caritas") la "grazia" (gr.: "Xapis", lat.: "Charis") di Dio (lat.: "Charitas")!!!
Due padroni: Dio "Charitas" o dio "Caritas"?!, Dio Amore o dio Mammona?! In questo bivio ("X") ancora siamo, oggi - e ancora non sappiamo sciogliere l’incognita (""x")!
Sul tema, mi sia consentito, si cfr. la seguente nota:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Relazioni chiasmatiche e civiltà. Tracce per una svolta antropologica.17 agosto 2017, di Federico La Sala
"Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986):
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DEMIURGICO. La scoperta della “Particella Xi”: “Così capiamo la forza che lega insieme l’Universo” (Alessandro Cardini).8 luglio 2017, di Federico La Sala
AL DI LA’ DELL’ORIZZONTE DEMIURGICO. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA
- "[...] Platone, nel suo presente storico. Egli aveva capito (Timeo: 36, c) che l’Anima era “a figura della lettera X [oion chei]” e, da Demiurgo, pur sapendo di non sapere bene come si facesse a ‘produrla’, cerca di fare del suo meglio"(Federico La Sala, CHI SIAMO NOI IN REALTA’. Relazioni chiasmatiche e civiltà ).
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
“Così capiamo la forza che lega insieme l’Universo”
di Nicla Pancera (La Stampa, 07.07.2017)
«Non era mai stata osservata sperimentalmente, ma sapevamo che prima o poi l’avremmo trovata, perché la sua esistenza era prevista dalle teorie attuali». È orgoglioso Alessandro Cardini,responsabile dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell’esperimento LHCb, uno dei quattro montati sul l Large Hadron Collider del CERN (gli altri sono ATLAS, ALICE e CMS) che ha osservato la nuova particella, chiamata X_cc^(++) (Xicc++) la cui peculiarità è quella di essere composta da due quark charm, pesanti, e da un quark leggero, e di essere quindi molto pesante, quattro volte più del protone. «Protoni e neutroni sono composti da tre quark, di cui solo uno pesante, ma le teorie fisiche prevedevano da tempo la possibilità di ottenere particelle formate da più quark pesanti».
Come è nata la vostra scoperta?
«Dal 2015 a oggi, nel corso del secondo periodo di funzionamento di LHC, il Run2, abbiamo osservato 300 particelle Xicc++ e un altro centinaio sono state riconosciute a posteriori negli esperimenti del Run1».
Finora ci avevano già provato, senza successo, altri esperimenti, come «BaBar» in California e «Belle» in Giappone.
«Anche al CERN, quindici anni fa, sembrò di avere visto qualcosa, ma le conferme non erano mai arrivate».
Come mai era così difficile?
«Capita spesso che fluttuazioni statistiche vengano interpretate come prova dell’esistenza di quanto si sta cercando. Solo dettagliate misurazioni spettroscopiche possono dire con certezza cosa abbiamo davanti».
Quindi, pur non essendo una vera e propria new entry nello zoo delle particelle, Xicc++ è motivo di grande orgoglio per i ricercatori. Vederla è stato possibile solo adesso. Perché?
«Grazie a una grande capacità degli strumenti di identificazione delle particelle e alla potenza dell’acceleratore, di 13 TeV, che ci ha consentito di acquisire dati di una purezza particolare».
«Trovare un barione con due quark pesanti è di grande interesse - aggiunge Giovanni Passaleva, il nuovo coordinatore della collaborazione LHCb - Perché può fornire uno strumento unico per approfondire la cromodinamica quantistica, la teoria che descrive l’interazione forte, una delle quattro forze fondamentali», cioè quella, ancora misteriosa, che tiene unite le particelle al nucleo atomico.
I ricercatori sono già al lavoro per misurare i meccanismi di produzione e di decadimento e la durata di vita della nuova particella. La speranza è che poterla vedere «nascere» e «morire» porti verso una maggior comprensione delle regole che creano la materia dell’Universo.
La “Particella Xi”
Ecco che cosa unisce la materia
Inseguita da anni, l’ha trovata il Cern grazie al Large Hadron Collider Servirà per capire una delle forze fondamentali della natura
di Piero Bianucci (La Stampa, 07.07.2017)
L’anagrafe del mondo subnucleare registra una nuova particella, annunciata ieri a Venezia in apertura del convegno della Società Europea di Fisica. Si chiama Xi ed è esotica rispetto alla materia di cui siamo fatti. Mentre tutto il mondo che conosciamo è costruito con due tipi di quark leggeri, Up e Down, la particella Xi è costituita da due quark più pesanti, chiamati Charm, e da uno «normale», un quark Up. La cosa eccitante per i fisici è che mai finora due quark Charm erano stati osservati insieme. Singolare è anche l’assetto delle tre particelle che formano la Xi: i due quark Charm stanno al centro come un minuscolo sole e il quark Up gira loro intorno come un pianeta.
Nell’insieme, Xi è una particella alquanto massiccia. Pesa 3,6 GeV, cioè quasi 4 volte un protone. Ora i fisici cercheranno di produrre un grande numero di Xi per osservarne il comportamento e comprendere meglio i meccanismi dell’interazione forte, cioè la forza che regola i rapporti tra adroni, nome collettivo che si dà alle particelle pesanti. E poiché l’estremamente piccolo e l’estremamente grande dipendono strettamente l’uno dall’altro, alla fine potrà uscirne una migliore conoscenza dell’evoluzione stessa dell’universo.
La scoperta di Xi è interessante ma non rivoluzionaria. Anzi, l’esistenza di questa particella era prevista dalla teoria del Modello Standard e c’erano già indizi della sua esistenza. Non siamo dunque di fronte a una nuova fisica ma piuttosto a una conferma. L’importanza di Xi sta nelle possibilità di indagine che apre ad una sempre più robusta definizione del Modello.
L’osservazione di Xi è frutto di uno dei grandi esperimenti distribuiti lungo il gigantesco collider LHC del Cern di Ginevra, un anello di magneti superconduttori lungo 27 chilometri nel quale vengono fatti scontrare protoni che corrono in direzioni opposte a una velocità vicina a quella della luce. L’energia delle collisioni è la massima mai raggiunta in un laboratorio: LHC lavora a 14 TeV, cioè 14mila miliardi di elettronvolt. Per farsi un’idea di che cosa significa, l’energia in gioco nella vita quotidiana, per esempio quella dei fotoni della luce solare, è dell’ordine di un elettronvolt. A 14 TeV si ricreano le condizioni di energia che esistevano nell’universo miliardesimi di secondo dopo il big bang, un miscuglio di quark, elettroni, neutrini.
I quark previsti dal Modello Standard sono sei: l’ultimo, il quark Top, è stato trovato al Fermilab di Chicago nel 1995. I sei quark possono combinarsi in vari modi, alcuni consentiti e altri proibiti dalle leggi della fisica. Nel mondo ordinario, i nuclei atomici sono costituiti da protoni e neutroni, i quali a loro volta sono combinazioni di quark Up e Down. Solo in un mondo super-energetico compaiono gli altri quattro tipi di quark, le cui combinazioni sono in parte da esplorare. Xi è un passo in questa direzione. Non cambia niente nella nostra vita, non ci sono applicazioni immaginabili. Quello che è si è ottenuto è tassello di conoscenza pura. Il piacere della scoperta per la scoperta.
L’esperimento che ha rivelato Xi è noto tra i fisici come LHCb ed è pensato per indagare su violazioni della simmetria nelle particelle elementari, in particolare la simmetria di carica elettrica e destra/sinistra. Una terza simmetria è quella rispetto al tempo. Nella maggioranza dei casi le simmetrie sono rispettate. Ma sono le rare violazioni ad essere interessanti: si ritiene che una di queste violazioni abbia prodotto la scomparsa dell’antimateria e quindi l’universo che ora ci ospita.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Scoperta al Cern la particella Xi, la chiave per capire la ’colla’ della materia.6 luglio 2017, di Federico La Sala
Scoperta al Cern la particella Xi, inseguita da anni
Mai vista una simile, aiuta a capire colla che unisce la materia
di Redazione ANSA 06 luglio 2017
- Rappresentazione grafica della particella appena scoperta al Cern, chiamata Xi (fonte: CERN) © Ansa FOTO
Scoperta al Cern la particella Xi: inseguita da decenni, potrà aiutare a studiare la ’colla’ che tiene unita la materia, ossia per capire una delle quattro forze fondamentali della natura: la forza forte. La scoperta, annunciata nella conferenza della Società Europea di Fisica in corso a Venezia e in via di pubblicazione sulla rivista Physical Review Letters, è avvenuta grazie all’acceleratore più grande del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc).
Vista dall’esperimento chiamato Lhcb, la particella appartiene alla famiglia dei barioni, la stessa di cui fanno parte protoni e neutroni che costituiscono la materia visibile, e come tutti i barioni è composta da tre quark, come prevede la teoria di riferimento della fisica chiamata Modello Standard. Tuttavia nei barioni finora noti si trova al massimo un solo quark pesante, mentre la particella Xi ha due quark pesanti.
"E’ la prima volta che si osserva una particella simile: un barione con due quark pesanti", ha detto Donatella Lucchesi, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell’università di Padova e membro della collaborazione Lhcb. "Osservare una particella del genere - ha detto ancora Donatella Lucchesi - è stato possibile grazie alla grandissima quantità di dati che sta producendo l’acceleratore Lhc. Questo - ha rilevato - permette di raggiungere un obiettivo non facile, come è riuscire a riprodurre la materia in tutti i suoi stati possibili".
Nella particella Xi un sistema planetario in miniatura
La particella Xi appena scoperta al Cern è già generosa di sorprese, al punto che i mattoni della materia che la costituiscono, i quark, potrebbero comportarsi come un sistema planetario in miniatura. I due quark pesanti, che sono l’elemento distintivo della nuova particella avrebbero infatti movimenti più lenti e solenni rispetto a quelli dei quark leggeri presenti in protoni e neutroni, che ricordano una danza. Lo ha rilevato il britannico Guy Wilkinson, che ha coordinato la collaborazione Lhcb fino al 30 giugno, giusto in tempo per assistere alla scoperta. "In contrasto con gli altri barioni finora noti, in cui i tre quark eseguono una elaborata danza l’uno attorno all’altro, ci aspettiamo che il barione con due quark pesanti agisca come un sistema planetario", ha osservato Wilkinson. In questo sistema planetario in miniatura, ha aggiunto "i due quark pesanti giocano il ruolo di stelle che orbitano l’una attorno all’altra, mentre il quark più leggero orbita intorno al sistema binario".
Dalla particella Xi la chiave per capire la ’colla’ della materia
La particella Xi promette di essere una chiave senza precedenti per scoprire i segreti della ’colla’ della materia, ossia il comportamento delle forze che agiscono nel mondo dell’infinitamente piccolo. Per il nuovo coordinatore della collaborazione Lhcb, l’italiano Giovanni Passaleva, c’è grande speranza nelle nuove conoscenze che la particella Xi potrà rendere possibili. "Trovare un barione con due quark pesanti - ha rilevato - è di grande interesse perché può fornire uno strumento unico per approfondire la cromodinamica quantistica", ossia il campo di ricerca che studia come l’intensità delle forze si riduce quando le distanze tra le particelle diventano molto piccole e che si chiama così in riferimento alle otto cariche che prendono il nome dai tre colori che descrivono i quark: rossi, gialli e blu.
E’ un campo di ricerca molto importante, nato grazie alle ricerche inaugurate 1963 fa dal fisico Nicola Cabibbo con il teorema che porta il suo nome, l’Angolo di Cabibbo, e che ha gettato le basi per comprendere come i mattoni della materia, i quark, si mescolano dando origine alle particelle elementari.
*
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" -- Cern, scoperta la particella Xi: "Inseguita da anni, ci aiuterà a capire cosa tiene insieme la materia".6 luglio 2017, di Federico La Sala
Cern, scoperta la particella Xi: "Inseguita da anni, ci aiuterà a capire cosa tiene insieme la materia"
La scoperta, annunciata nella conferenza della Società Europea di Fisica in corso a Venezia è avvenuta grazie all’acceleratore più grande del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc)
di ELENA DUSI *
VENEZIA - Scoperta al Cern la particella Xi: inseguita da decenni, potrà aiutare a studiare la ’colla’ che tiene unita la materia e capire una delle quattro forze fondamentali della natura: la forza forte, la più intensa ma anche quella con il raggio di azione più piccolo, che agisce solo a livello delle particelle subatomiche. La scoperta, annunciata nella conferenza della Società Europea di Fisica in corso a Venezia e in via di pubblicazione sulla rivista Physical Review Letters, è avvenuta grazie all’acceleratore più potente del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc), in particolare a uno dei suoi quattro rivelatori: LHCb, coordinato dall’italiano Giovanni Passaleva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
La particolarità di "mister Xi" è di avere al suo interno due quark pesanti. Pur essendo prevista dalla teoria, la presenza di due "pesi massimi" all’interno della stessa particella è stata osservata solo oggi per la prima volta. La sua massa, di conseguenza, è particolarmente grande: oltre 3.600 Mev, quasi quattro volte quella del protone. Anche la carica elettrica positiva è doppia rispetto al protone. Quindici anni fa il laboratorio americano Fermilab annunciò un’osservazione simile (ma con margini di incertezza molto più alti rispetto a oggi), ma con una massa molto diversa rispetto a quanto teorizzato. L’osservazione del Cern invece rispetta esattamente le previsioni, e dissipa le ansie che il precedente americano poteva aver sollevato.
"Trovare una particella con due quark pesanti è di grande interesse perché può fornire uno strumento unico per approfondire la cromodinamica quantistica, la teoria che descrive l’interazione forte, una delle quattro forze fondamentali", spiega Passaleva. "Queste particelle contribuiranno così a migliorare il potere predittivo delle nostre teorie". La "nuova arrivata" non esiste normalmente in natura. "E’ molto instabile" conferma Passaleva. "Viene prodotta negli acceleratori o quando i raggi cosmici, ad esempio protoni prodotti da una supernova che viaggiano nello spazio, raggiungono l’atmosfera e la colpiscono con tutta la loro energia". La vita di questa particella è molto breve: circa un millesimo di miliardesimo di secondo. Poi "mister Xi" decade in particelle più leggere.
La maggior parte della materia che vediamo intorno a noi è composta da barioni, particelle comuni composte da tre quark. I più noti sono protoni e neutroni, ma poiché in natura esistono sei tipi di quark diversi, teoricamente le combinazioni di barioni possibili sono molto numerose. Non tutte, però, sono state osservate nella realtà. All’appello mancavano proprio le particelle composte da più di un quark pesante (detto quark charm). Il terzo componente della nuova particella (il cui nome completo è Xicc++) è un quark up. "Trovata questa particella, ora cercheremo di osservare anche le sue due sorelle" aggiunge il fisico fiorentino che guida LHCb. "Quella con il terzo quark di tipo down oppure di tipo strange".
"In contrasto con le altre particelle finora note, in cui i tre quark eseguono una elaborata danza l’uno attorno all’altro, ci aspettiamo che il barione con due quark pesanti agisca come un sistema planetario, dove i due quark pesanti giocano il ruolo di stelle che orbitano l’una attorno all’altra, mentre il quark più leggero orbita intorno a questo sistema binario", ha aggiunto Guy Wilkinson, ex-coordinatore della collaborazione. Proprio ieri, il 4 luglio, cadeva il quinto anniversario dell’annuncio della scoperta del bosone di Higgs, sempre grazie all’acceleratore di particelle Lhc del Cern di Ginevra.
* la Repubblica, 06 luglio 2017 (ripresa parziale - senza note).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- Quanto è atavica la mentalità maschile. Una "risposta" di U. Galimberti.26 giugno 2017, di Federico La Sala
L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!!:
- “De Testicoli delle donne”.Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap.15 dell’ ANATOMIA di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli delle donne”(p. 91).
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Lettere
Quanto è atavica la mentalità maschile
La donna che non genera è esposta a un dubbio logorante.
Ed è guardata ancora con sospetto
Risponde Umberto Galimberti *
- Si parla tanto di femminismo e parità dei sessi, ma io mi trovo all’età di 43 anni a dubitare che questa parità possa esistere davvero. Sostenuta da una famiglia in cui padre e madre hanno sempre avuto ruoli intercambiabili e paritari, pur essendo donna ho vissuto sempre secondo quello che i miei valori e il mio carattere mi avrebbero dettato, senza piegarmi, e ho considerato sopportabile un giusto prezzo da pagare per l’indipendenza. Finché non ho messo piede in quell’età in cui "l’orologio biologico" ticchetta più velocemente e tutti intorno a te si affrettano ad accoppiarsi e a riprodursi. E in un attimo gli amici di una vita spariscono e ti ritrovi davanti a una decisione incombente da cui sembra dipendere tutta la tua vita, la tua identità, il tuo futuro. Eppure tra mille dubbi senti che per te quella strada non funziona, che hai ancora molto da studiare, dare, fare e vedere, e che il tuo corpo intanto è invecchiato e non si convince dell’idea del "puoi avere figli senza rinunciare a niente" venduta dalla società della maternità romanticizzata e idealizzata.
 Concludo che l’idea della parità è una chimera. Arriva un momento in cui l’identità di una donna si arena davanti al bivio madre/non-madre. Qualunque altra cosa tu faccia come donna e come persona, sbiadisce, viene sminuita. Se non desideri essere madre, diventi una non-madre, prima di tutto. Non so perché scrivo a lei, che è un uomo, ma nelle sue risposte e nei suoi libri leggo una visione del mondo e delle cose che illumina ed evolve invece di auto-ribadirsi.
Concludo che l’idea della parità è una chimera. Arriva un momento in cui l’identità di una donna si arena davanti al bivio madre/non-madre. Qualunque altra cosa tu faccia come donna e come persona, sbiadisce, viene sminuita. Se non desideri essere madre, diventi una non-madre, prima di tutto. Non so perché scrivo a lei, che è un uomo, ma nelle sue risposte e nei suoi libri leggo una visione del mondo e delle cose che illumina ed evolve invece di auto-ribadirsi.
 virginial@email.it
virginial@email.it
Alla parità tra maschi e femmine non si arriverà mai, perché, non essendo in grado di generare, i maschi capiscono del mondo femminile unicamente quello che loro ritengono sia proprio della donna, e precisamente ciò che per natura a loro non è concesso. Svincolati dai ritmi della natura, i maschi, per occupare il tempo e non morire d’inedia nell’ozio, hanno inventato la storia, e in questa storia hanno inserito la donna come generatrice, madre dei loro figli, prostituta per le loro soddisfazioni sessuali e, a sentire Lévi-Strauss, il più grande antropologo del ’900, come merce di scambio nei loro traffici.
Un altro antropologo, Bronislaw Malinowski, riferisce che gli abitanti delle numerose tribù da lui visitate ignoravano il ruolo maschile nella generazione, e pur tuttavia, le donne da lui interrogate, rispondevano che tutti i figli assomigliano al padre, mentre la madre, genitrice riconosciuta dai suoi figli, non ha con essi alcuna somiglianza. La coppia parentale, "paritetica" nella riproduzione sessuale, diventa "gerarchica" nella rappresentazione sociale. A questo schema non sfugge neppure Aristotele per il quale "la femmina offre la materia e il maschio la forma", e neanche il mito cristiano di Maria Vergine, che con il suo corpo mette al mondo il figlio di Dio che di sé dice: "Io e il Padre siamo una sola cosa" (Gv. 10,30).
Questo impianto ideologico, che affonda negli abissi del tempo e della storia, governa ancora la mentalità maschile, che da qui prende spunto per esercitare il suo potere sul mondo femminile ridotto al rango di "materia", a proposito della quale Aristotele scrive: "La femmina desidera il maschio come la materia desidera la forma, il brutto desidera il bello".
A questo punto il dominio dell’uomo sulla donna appare come perfettamente "naturale", perché non c’è niente di più naturale e di più evidente del suo corpo fatto apposta per la generazione. Ebbene, proprio nella differenza tra il corpo dell’uomo e il corpo della donna si trova la prova inconfutabile del dominio del primo sulla seconda, di cui sono convinti non solo gli uomini, ma anche le donne che per secoli hanno trovato naturale il dominio esercitato su di loro da parte dell’uomo. Com’è noto, infatti, il potere non sta tanto nell’esercizio della sua forza, ma nel consenso dei dominati alla propria subordinazione.
È da questo consenso, quello dei subordinati, che lei si deve liberare. E liberandosi potrà persuadere la mente di qualche uomo e di qualche donna che la donna non è solo materia per la generazione e i piaceri sessuali, ma al pari dell’uomo può generare anche a un altro livello, quale può essere la realizzazione di sé nel mondo lavorativo, in quello culturale, persino in quello sessuale senza doversi ridurre alla pura e semplice opacità della materia. E se sente sopra di sé la disapprovazione di molti tra quanti le stanno intorno, sappia che dobbiamo fare a meno di mezzo mondo per poter generare il nostro mondo, che non è deciso solo dalla biologia al servizio della specie, perché la specie, come sappiamo, è interessata agli individui unicamente per la sua sopravvivenza. E dopo che hanno generato, nella sua crudeltà innocente, li destina alla morte, perché altri individui, nascendo e generando, le assicurino la sua vita.
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- LE ARCHEOLOGHE DELEL STELLE. Per la prima volta l’Agenzia spaziale pubblica uno studio firmato da sole donne. Tra i 27 e i 46 anni, hanno svelato i segreti dei buchi neri nati dopo il Big bang1 giugno 2017, di Federico La Sala
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Le sei ragazze italiane delle stelle: "Così abbiamo conquistato la Nasa"
Per la prima volta l’Agenzia spaziale pubblica uno studio firmato da sole donne. Tra i 27 e i 46 anni, hanno svelato i segreti dei buchi neri nati dopo il Big bang. Ma solo una di loro ha un contratto stabile
- Da sopra a sinistra: Raffaella Schneider, Edwige Pezzulli, Rosa Valiante, Tullia Sbarrato, Simona Gallerani, Maria Carmela Orofino
di MATTEO MARINI *
Sei astrofisiche, tutte italiane, formano un team di "archeologhe delle stelle" che ha attirato l’attenzione della Nasa. Cinque di loro hanno un contratto da "precaria della ricerca" e tre di loro non hanno ancora compiuto 30 anni. Il loro studio sui buchi neri dell’Universo primordiale è stato pubblicato a gennaio sul Monthly notices of royal astronomical society. Edwige Pezzulli, Rosa Valiante, Maria Orofino, Raffaella Schneider, Simona Gallerani e Tullia Sbarrato, così tante scienziate, tutte insieme, che firmano una ricerca così importante: anche per la Nasa è una cosa nuova. L’Agenzia spaziale americana ha deciso di pubblicare una "press release" e invitare una delle studiose a collaborare al blog, per raccontare cosa è successo nei primi milioni di anni dopo il Big bang.
Edwige, Raffaella e Rosa fanno parte del team di First, finanziato dallo European Research Council, che studia la formazione di stelle e galassie quando l’Universo era appena nato. L’indagine che, assieme alla storia di una squadra tutta al femminile, ha "conquistato" la Nasa è uno dei frutti di questo progetto. La loro non è stata forse una rivoluzione, come quella raccontata nel film Il diritto di contare, la storia di tre donne afroamericane che hanno conquistato un ruolo di grande responsabilità nella Nasa negli anni 60. Ma è comunque un grande riconoscimento per la ricerca italiana al femminile.
Delle sei, solo Raffaella non è "in scadenza", perché è professoressa associata alla Sapienza. A inizio carriera, più di 20 anni fa, è stata in qualche modo una pioniera: "Ho avuto il primo figlio durante il dottorato, era il 1996. Fui la prima in Italia a poter congelare la borsa per un anno per la maternità. Si poteva fare per il servizio militare ma non era previsto per una ricercatrice mamma".
Edwige Pezzulli, 29 anni, è dottoranda presso la Sapienza, Istituto nazionale di astrofisica e Tor Vergata. Ma nella sua storia controcorrente c’è un anche passato da thai boxer e rugbista a Roma nelle All Reds e nelle Red and Blue di Valmontone.
Rosa, 38 anni, ha lavorato tenendo in braccio la sua bambina. Aurora è nata un anno e mezzo fa: "Nelle notti e nei weekend di lavoro, quelli decisive prima dell’uscita dello studio, mi si addormentava in braccio, così scrivevo e rispondevo a mail e chat con le colleghe usando una mano sola - racconta - ma questo impegno è ripagato: proprio grazie al progetto First ho avuto il rinnovo del contratto per un altro anno".
Alle teoriche di First, che studiano modelli, si sono aggiunte le conoscenze sperimentali delle colleghe Maria Orofino e Simona Gallerani della Scuola Normale superiore di Pisa e Tullia Sbarrato del dipartimento di Fisica all’Università di Milano Bicocca, per interpretare i dati delle osservazioni. "Solo al momento di inviare il lavoro ci siamo accorte che le firme erano tutte quante di donne. Non ci avevamo fatto nemmeno caso" commenta sorridendo Raffaella Schneider, che è principal investigator del progetto First. "Vent’anni fa mi capitava di andare a convegni nei quali le donne si potevano contare sulle dita di una mano. Ora è molto diverso".
E sulla "eccezionalità" del loro team di archeologhe delle stelle anche Edwige ha un’idea chiara: "Sono convinta che la chiave del progresso risieda nella diversità e nel confronto tra più punti di vista. Non solo differenza di genere, dunque, ma anche occhi e culture diversi. In questo senso abbiamo portato la sguardo femminile su un problema sempre affrontato da uomini".
Per il loro studio sono partite da un quasar (una sorgente molto lontana e luminosa associata ai buchi neri), a 13 miliardi di anni luce da noi, per risalire ai suoi "progenitori", come per tracciarne l’albero genealogico. I "black holes" primordiali, appunto, che però sembrano non essere dove dovrebbero. "Abbiamo usato le osservazioni dello Sloan digital sky survey e del telescopio spaziale Chandra per osservare le attività di buchi neri quando l’Universo aveva meno di 800 milioni di anni - spiega Edwige Pezzulli - guardando lontano infatti è come se guardassimo indietro nel tempo".
Le sei ricercatrici hanno così spiegato una dinamica fondamentale su cosa succedeva poco tempo dopo il Big bang e perché è tanto difficile scoprire quei buchi nello spazio-tempo formatisi quando l’Universo era ancora giovanissimo: "Non riusciamo a vederli perché il loro accrescimento, il periodo in cui aumentano di dimensioni divorando materia ed emettendo radiazioni, è molto rapido e si spegne in fretta".
* la Repubblica,31 maggio 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) -- L’ultimo rapporto di Save the Children: «Infanzia rubata» (di Francesca Paci).1 giugno 2017, di Federico La Sala
TEOLOGIE E PEDAGOGIE SENZA GRAZIA ("DEUS CHARITAS EST": 1 Gv., 4.8). Mentre si scrivono tante belle parole sull’amore, ci si rifiuta di vedere come la capacità di amare venga distrutta quando si è ancora bambini.
L’infanzia violata: 168 milioni di minori costretti a lavorare, ogni 7 secondi una bambina si sposa
L’ultimo rapporto di Save the Children: il mondo ha dimenticato l’età dell’innocenza
di Francesca Paci (La Stampa, 01/06/2017)
Majerah ha diciassette anni e dal 2017 è coniugata con un uomo che ne ha ventisette. Quando il padre concordò il suo futuro lei frequentava l’ottavo grado della scuola dove era un’alunna modello e sognava di diventare un dottore capace di aiutare le donne del villaggio precluse dall’assistenza sanitaria. Adesso il marito, un negoziante della periferia di Kabul, vuole risposarsi liberandosi di lei perché l’accusa di non riuscire a diventare mamma e, picchiandola come ha già fatto più volte, le ha dato due mesi di tempo prima di ripudiarla. «Non ho mai chiesto ai miei genitori di comprarmi vestiti o portarmi al parco, tutto quello che volevo era studiare e diventare un giorno dottore» racconta la ragazzina che non c’è più.
Majerah è una delle migliaia di bambine che ogni giorno, a getto continuo, vengono dare in sposa a pretendenti dell’età dei padri o talvolta dei nonni: una ogni 7 secondi, secondo l’ultimo rapporto di Save the Children «Infanzia rubata» pubblicato proprio in queste ore.
Senza istruzione, sfruttati, uccisi
Majerah e le altre sono un tassello del puzzle composto da «Infanzia rubata», che compone il quadro di un mondo a tinte foschissime: un bambino su 6 non ha accesso all’educazione (263 milioni non vanno a scuola), 168 milioni sono coinvolti nel lavoro minorile, oltre 16 mila minori di 5 anni muoiono ogni giorno per malattie facilmente curabili come polmonite o diarrea, 156 milioni hanno problemi di crescita legati alla malnutrizione. E poi ce ne sono 28 milioni in fuga da guerre e persecuzioni (la Siria ma non solo), 75 mila uccisi violentemente nel solo 2015 (più di 200 al giorno), un esercito di piccolissime spose che ogni 2 secondi mettono al mondo un neonato (15 milioni ogni anno).
Maglia nera dell’infanzia rubata Niger, poi Angola e Mali
Nell’indice globale dell’infanzia negata, il primo del genere, Save the Children stila la classifica dei peggiori paesi in cui essere bambini: al primo posto c’è il Niger seguito da Angola, Mali, Repubblica Centrafricana, Somalia. La maglia rosa va alla classifica c’è la Norvegia, società modello. L’Italia è in buona posizione, migliore della Germania e del Belgio ma peggiore di Olanda, Svezia, Portogallo, Irlanda e Islanda.
“Protezione ed educazione per tutti entro il 2030”
«È inaccettabile che nel 2017 milioni di bambini continuino ad essere privati della propria infanzia e del loro diritto di essere al sicuro» dice il Direttore Generale di Save the Children Valerio Neri. Qualcosa è stato fatto, ma non basta: «Nel 2015, i leader mondiali si sono impegnati a garantire a tutti i bambini, entro il 2030, il diritto alla salute, alla protezione e all’educazione, a prescindere da chi siano e dove vivano. Si tratta indubbiamente di un obiettivo molto ambizioso ma che deve essere raggiunto, i governi dovranno impegnarsi per assicurare a tutti i bambini l’infanzia che meritano».
Le spose bambine
Majerah ha raggiunto una consapevolezza pagata con la propria vita: «Mi ero sempre concentrata sugli studi indipendentemente dalle difficoltà quotidiane, le mie sorelle sono tutte più piccole di me, non ho mai avuto la possibilità di godermi l’infanzia sono stata forzata troppo presto a entrare nell’età adulta». Quindici milioni di ragazze l’anno si maritano come lei quando sono ancora sui banchi di scuola. I giochi - quando c’erano - s’interrompono senza appello, i doveri si moltiplicano nell’assenza totale dei diritti, l’orizzonte si frantuma sulle pareti di una casa-prigione. Le spose bambine sono il paradigma di una società che non si limita a perdere l’età dell’innocenza ma la violenta. Lo sappiamo, lo leggiamo, avviene drammaticamente in costante diretta alla luce del sole.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Per Millicent Fawcett, attivista del suffragio femminile. Londra, per la prima volta la statua di una donna tra i grandi del mondo.3 aprile 2017, di Federico La Sala
Londra, per la prima volta la statua di una donna tra i grandi del mondo
Millicent Fawcett, attivista del suffragio femminile, avrà la sua effige in Parliament Square, la piazza che sorge davanti a Westminster. L’inaugurazione nel 2018, centenario dell’anniversario del voto alle donne
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
LONDRA - Per la prima volta ci sarà la statua di una donna su Parliament Square, la piazza del parlamento che sorge davanti al palazzo di Westminster, una sorta di mausoleo dei grandi personaggi del Regno Unito, a cominciare da Winston Churchill, e del mondo, perché vi trovano posto anche Lincoln e Mandela - ma finora tutti uomini. Un maschilismo storico, se così si può definire, che finirà nel 2018, quando finalmente verrà eretta una statua a una donna: Millicent Fawcett, leader del movimento che è stato il precursore delle suffragette, le attiviste che un secolo fa lottarono per i diritti delle donne e in particolare per dare il diritto di voto alle donne.
La statua verrà inaugurata proprio nel centenario del primo allargamento del voto alle donne, passato dal parlamento britannico appunto nel 1918. La decisione è stata annunciata stamane da una donna: Theresa May, primo ministro britannico. Millicent Fawcett costituì nel 1897 la National Union of Women’s Suffrage Society, l’Unione Nazionale delle Donne per il Suffragio, un’associazione che usò metodi pacifici, petizioni e lobby per convincere il parlamento a estendere alle donne il suffragio universale, ovvero il diritto di votare. Da questo gruppo nacque il movimento delle suffragette, più radicale e militante, guidato da Emmeline Pankhurst, a cui è ispirato il recente film "Suffragette".
Millicent Fawcett morì nel 1929, un anno dopo la raggiunta parità completa di voto per uomini e donne in Gran Bretagna, un diritto che gradualmente si è esteso nel resto del mondo. La statua a lei dedicata sarà la prima e l’unica a ritrarre una donna in mezzo agli undici monumenti dedicati a uomini nella piazza davanti al parlamento britannico. Detto "la madre" di tutti i parlamenti, perché è stato il primo dell’era moderna. E presto, appropriatamente, avrà davanti a sé l’immagine di una donna.
* la Repubblica, 02 aprile 2017
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- 8 MARZO 2017. Si comincia da qui. Una generazione, nuova e globale, sulla scena politica.11 marzo 2017, di Federico La Sala
Una generazione, nuova e globale, sulla scena politica
8 marzo. Uno sciopero guidato e pensato da donne, una mobilitazione internazionale come non succedeva dai tempi dei social forum. Si comincia da qui, dalle giovani femministe
di Bia Sarasini (Il manifesto, 10 marzo 2017)
Ha fatto un bel po’ paura, lo sciopero delle donne, l’8 marzo. Tutte quelle ragazze, ragazzi, donne, uomini, persone lgbt in piazza. Rumorosamente assenti dal lavoro. Un milione? Bisognerà fare le mappe e i conti delle mille iniziative sparse nel pianeta.
Il punto è che un’enorme quantità di persone si sono mobilitate. Un popolo che sciopera, cioè si prende e mostra la propria forza. Che si muove non contro i nemici additati dalla propaganda di destra, i migranti, gli stranieri, o una casta politica diventata ormai metafisica, fantasma di un potere che rimane invisibile.
No, la mobilitazione, proprio perché era uno sciopero, era contro un’organizzazione del sociale, della divisione sessuale del lavoro e del lavoro stesso. Insomma, contro il potere reale, le sue radici violente, arcaiche e contemporanee, di cui il femminicidio è la forma estrema e paradigmatica.
Uno sciopero guidato e pensato da donne, poi. Un fatto inaudito. La visione delle donne si allarga, mostra di sapere e potere riorganizzare la vita sociale e il mondo. A partire dalla propria esperienza, dal dominio subito e dalla lotta per ribaltarlo. Non succedeva dal tempo dei social forum, una mobilitazione internazionale nella stessa giornata. Non si era più abituate neanche a un 8 marzo che non fosse un rito, di presidenti che elogiano l’indispensabilità delle donne, multinazionali che creano premi, sindaci che danno le medaglie. E la leadership femminile, è una novità assoluta. Tutte e tutti a invocarla, e quando te la trovi squadernata davanti, cosa si finisce per dire? Che è stato un successo, ma alla fine è un disastro.
Dispiace che una femminista autorevole come Alessandra Bocchetti, invece di chiedersi perché tante, tantissime sono scese in strada, evochi un’autonomia delle donne che questo 8 marzo, con la sua proposta inclusiva e intersezionale, avrebbe messo a a rischio. Più conseguente Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, che critica lo sciopero come strumento arcaico, visto che il lavoro è precario.
E dire che proprio questa è la forza di questo otto marzo 2017. Donne che proclamano uno sciopero. Avere rotto una barriera. Avere buttato all’aria quella compartimentazione prima di tutto mentale in cui è imprigionata la società. Quella frammentazione per cui ai sindacati spettano gli scioperi, quelli veri, che riguardano i lavoratori veri che stanno nei posti di lavoro riconosciuti come tali. Cosa ne sanno le donne? Cosa c’entrano le case, o i femminicidi, i lavori precari e qualificati, che puoi fare perfino in autobus e sulla metro, visto che quello che conta è la connessione? Che cosa si sono messe in testa le femministe, di proclamare lo sciopero? Il maschilismo ha molte facce. Questa rigidità ne è senz’altro un aspetto.
Eppure spero che proprio il successo dell’8 marzo globale apra gli occhi. Perché l’inerzia misogina rischia di farsi complice della passivizzazione di chi lavora, rischia di coltivare l’impotenza prodotta dalla svalorizzazione del lavoro, invece di combatterla. Dispiace che la Fiom, che pure ha incontrato la rete organizzatrice dello sciopero in Italia, NonUnaDiMeno, non abbia colto l’occasione.
Perché lasciare che sia il mercato a mettere al lavoro migranti, donne povere e impoverite in attività malpagate e sfruttate, tutto delegato all’iniziativa individuale? Perché non pensare a un nuovo welfare, a nuovi lavori da unire a un reddito minimo, da garantire quando necessario?
Si comincia da qui, dalle giovani femministe, una nuova generazione politica, che hanno preso la guida. È un progetto, una speranza. Si rivolge a tutti coloro che subiscono il potere neocapitalista, le conseguenze di una globalizzazione violenta che, lasciandosi noncurante alle spalle i propri detriti, defluisce in una de-globalizzazione addirittura più barbara.
In tante abbiamo cercato la strada, da donne libere e sempre impreviste, come diceva Carla Lonzi. Ora possiamo. Partiamo da qui.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" -- Lo sciopero dell’8 marzo: «non saremo una di meno». Dallo storico NiUnaMenos fino alla Women’s March, il movimento delle donne si mobilita in 40 Paesi4 marzo 2017, di Federico La Sala
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
- CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Lo sciopero dell’8 marzo: «non saremo una di meno»
Dallo storico NiUnaMenos argentino fino alla Women’s March, il movimento delle donne si mobilita per uno sciopero che, in 40 Paesi, porterà, come dice Lea Melandri, una «seconda rivoluzione culturale, a un ’68 delle donne»
di Benedetta Verrini *
- Per conoscere tutti i luoghi e gli appuntamenti: https://nonunadimeno.wordpress.com
«Strabiliata da queste ragazze» dice Lea Melandri, femminista storica, giornalista e fondatrice della Libera Università delle Donne, ammirando le giovani donne che stanno animando e si preparano all’8 marzo più combattivo degli ultimi decenni. Dallo storico NiUnaMenos argentino fino alla Women’s March, che negli States ha visto molte donne riaggregarsi e trovare voce contro l’elezione alla presidenza di Donald Trump, Non Una Di Meno è un movimento femminile nato come un’onda sismica, scatenato dal trauma della violenza sulle donne - fisica, economica, sociale - che accomuna l’Italia a tutti i Paesi del mondo.
Il risultato, in occasione della Festa della Donna, sarà una manifestazione globale, con uno sciopero proclamato in contemporanea in quaranta Paesi per una «seconda rivoluzione culturale, un ’68 delle donne, in cui vedo forza di intenti e contenuti, orgoglio, radicalità, intelligenza» commenta Melandri. «Ho assistito a quarant’anni di femminismo, ma questa generazione è diversa, ha un potenziale inatteso. Sono giovanissime, universitarie e anche liceali, e in molti casi non conoscono molto delle battaglie del femminismo storico, eppure hanno saputo farle proprie con un vigore e una prospettiva completamente nuova. La nostra era stata una battaglia “contro”: contro le generazioni delle nostre madri, contro gli uomini su un terreno privato di sessualità e ruoli. Queste giovani si sono invece riappropriate del femminismo senza cliché, rinnovandolo dall’interno, portando il tema della parità in tutti gli ambiti sociali, dalla salute riproduttiva alla libertà di movimento delle migranti, dalla formazione a un nuovo modello di economia, che ci affranchi da quella forma di “patriarcato” che è il capitalismo».
Per l’8 marzo NonUnaDiMeno ha proposto a tutte le organizzazioni sindacali uno sciopero, sia del settore pubblico che privato. Diverse realtà del sindacalismo di base lo hanno accolto e proclamato formalmente. «Si tratta di uno sciopero di 24 ore perché l’esperienza della violenza si propaga in tutta la giornata di una donna» spiega Simona Ammerata, di NonUnaDiMeno Roma.
 Lo strumento dello sciopero arriva anche alle tante che sperimentano la precarietà lavorativa? «Lo sciopero è internazionale, si svolgerà in 40 diversi Paesi e mette dolorosamente in luce la difficoltà attuale di tante donne che non hanno un rapporto di lavoro stabile, che sono precarie o autonome. Stiamo organizzando delle casse di solidarietà per le precarie che desiderano aderire alla giornata ma non possono permetterselo» aggiunge. «E abbiamo organizzato spazi di nursery e chiesto agli uomini di mettersi a disposizione per accudire i bambini nel tempo in cui le donne saranno in assemblea o in corteo».
Lo strumento dello sciopero arriva anche alle tante che sperimentano la precarietà lavorativa? «Lo sciopero è internazionale, si svolgerà in 40 diversi Paesi e mette dolorosamente in luce la difficoltà attuale di tante donne che non hanno un rapporto di lavoro stabile, che sono precarie o autonome. Stiamo organizzando delle casse di solidarietà per le precarie che desiderano aderire alla giornata ma non possono permetterselo» aggiunge. «E abbiamo organizzato spazi di nursery e chiesto agli uomini di mettersi a disposizione per accudire i bambini nel tempo in cui le donne saranno in assemblea o in corteo».
 Oltre allo sciopero lavorativo, sottolineano le organizzatrici, è possibile aderire anche trovando un momento della giornata per partecipare agli eventi della città, oppure non esercitando, a titolo esemplificativo, una delle tante attività domestiche o di cura che non vengono riconosciute né retribuite.
Oltre allo sciopero lavorativo, sottolineano le organizzatrici, è possibile aderire anche trovando un momento della giornata per partecipare agli eventi della città, oppure non esercitando, a titolo esemplificativo, una delle tante attività domestiche o di cura che non vengono riconosciute né retribuite.La manifestazione dell’8 marzo arriva dopo un cammino durato circa otto mesi, con un’assemblea a Bologna in cui, i primi di febbraio, oltre duemila donne hanno sviluppato diversi tavoli di discussione: dal tema della violenza di genere a quello della salute riproduttiva, dal gender pay gap alla formazione. Per l’8 marzo, queste elaborazioni sono culminate in otto punti di discussione. «L’obiettivo è stato quello di impegnarsi a elaborare un Piano femminista antiviolenza che racchiuda ogni aspetto della vita di una donna» conclude Ammerata. «Come dicevo, il tema della violenza è trasversale: è troppo facile, anche sul piano politico, affrontarlo in modo settoriale».
«Le donne affrontano la violenza maschile in ogni momento e in ogni situazione: dai banchi di scuola alle pareti di casa, dal luogo di lavoro a quel luogo virtuale che sono i social» aggiunge Carlotta Cossutta, del Collettivo Ambrosia e di NonUnaDiMeno Milano. «Stiamo mettendo tutte le nostre energie, intelligenze, passione a cambiare per sempre questa situazione, in ogni contesto e in tutti i Paesi del mondo. Non siamo sole, la nostra rete è già attraversata da molti uomini che condividono questa battaglia: ciò che domandiamo loro è di mettersi in ascolto e appoggiare il cambiamento”.
L’8 marzo sono previsti presidi, mobilitazioni, flash mob in tante città italiane, con una convergenza oraria dei cortei intorno alle ore 18. A Roma il corteo inizia invece alle ore 17, appuntamento al Colosseo. La Casa delle Donne di Milano organizza, con il patrocinio del Comune, una performance artistica presso l’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele: a partire dalle 15 sarà realizzato un gigantesco Mandala a rappresentare un momento di meditazione, condivisione, aggregazione femminile.
Per conoscere tutti i luoghi e gli appuntamenti: https://nonunadimeno.wordpress.com
- CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Biografie di 100 donne illustri. Storie di donne audaci e creative , come favole della buona notte13 febbraio 2017, di Federico La Sala
- ESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
ARTECattive ragazze: storie di donne audaci e creative
di Monica D’Ascenzo (Il Sole-24 ore, 18 Gennaio 2017)
Puntavano a raccogliere 40mila dollari, ad oggi hanno superato quota 675mila dollari. Elena Favilli e Francesca Cavallo, con la startup Timbuktu, hanno sbancato nel crowdfunding di idee editoriali lanciate su Kickstarter. Il progetto è Good night stories for rebel girls, pensato per ispirare le bambine attraverso le biografie di 100 donne illustri, dalla regina Elisabetta I alla tennista Serena Williams, narrate come favole della buona notte. Alla composizione del libro parteciperanno 100 illustratrici da ogni parte del mondo.
Nella stessa direzione era andata un’altra iniziativa editoriale, di tre anni prima, che potete trovare ancora nelle librerie: “Cattive ragazze: 15 storie di donne audaci e creative”, graphic novel scritta da Assia Petricelli e illustrata da Sergio Riccardi. “Le donne hanno scoperto, inventato, costruito, ma non sono state raccontate” sottolinea Assia. E non ha tutti i torti. Basta sfogliare i libri su cui studiano i ragazzi per rendersene conto. O girare per le strade delle città, generalmente tutte al maschile.
Come è nata l’idea del libro?
Le questioni di genere e la storia delle donne mi interessano da tempo, ma la scintilla che ha acceso l’idea di “Cattive ragazze” è nata per caso, da un incontro con Della Passarelli di Sinnos Editrice, all’epoca in cerca di progetti per una nuova collana di graphic novel per ragazzi. Sergio e io, che già lavoravamo insieme, non avevamo mai pensato ad un fumetto per ragazzi, però ci piaceva quello che faceva la Sinnos e così abbiamo cominciato a ragionarci su ed è nata l’idea di raccontare biografie di donne realmente vissute che avessero messo in discussione ruoli e stereotipi femminili. Donne forti, ribelli, protagoniste delle proprie vite. E soprattutto donne che alla fine ce la fanno, che non sono vittime. Di storie così ce ne sono tante, ma sono poco conosciute.
Basta sfogliare un manuale scolastico per farsi l’idea che per millenni il genere femminile non abbia fatto altro che accudire mariti, figli e case. Ma non è vero. Le donne hanno scoperto, inventato, costruito, ma non sono state raccontate. Con “Cattive ragazze” volevo rendere giustizia ad alcune di queste figure e offrire alle giovani di oggi delle narrazioni che le aiutassero ad acquisire fiducia in se stesse e nella possibilità di essere quelle che vogliono, al di là degli stereotipi. Per raggiungerle abbiamo scelto una forma che fosse il più possibile semplice e accattivante.
Come hai scelto le 15 storie da raccontare?
Il filo rosso che lega le 15 biografie è riassunto nel sottotitolo del libro, donne “audaci” e “creative”, capaci di inventare per se stesse e per le altre che sono venute dopo un ruolo diverso da quello che la cultura patriarcale imponeva loro. Sulla base di questa premessa mi sono messa a cercare e ho incontrato decine di storie fantastiche. Scegliere non è stato affatto facile. Ho privilegiato le vicende meno note e, anche quando ho incluse figure celebri, l’ho fatto perché mi interessavano alcuni aspetti non particolarmente conosciuti: ad esempio il modernissimo rapporto tra Marie Curie e suo marito Pierre.
Inoltre ho prestato molta attenzione alla varietà, volevo restituire il senso di una ricchezza di possibilità, e così abbiamo l’artista, la giornalista, l’attivista politica e così via, ma anche una varietà di appartenenze culturali e geografiche. Non volevo cadere nella trappola di una narrazione troppo centrata sull’Occidente, che sarebbe stata menzognera e fuorviante: in particolare negli ultimi anni le donne del cosiddetto “Sud del mondo” sono state protagoniste di straordinari movimenti di liberazione. Infine ho inserito figure di donne che hanno partecipato a grandi processi collettivi, perché il mondo non si cambia da soli, ma sempre insieme ad altre e ad altri.
Il progetto ha avuto un seguito?
Da quando sono state pubblicate, le “Cattive ragazze” non si sono mai fermate. Hanno dato vita a uno spettacolo teatrale, a una mostra e sono state il motore di un progetto di ricerca e di educazione alle differenze che ha coinvolto studenti e studentesse dal Nord al Sud del paese. Se invece ti riferisci alla possibilità di realizzare un Cattive ragazze 2, per il momento non abbiamo questa intenzione; preferiamo che il nostro libro funga da stimolo affinché altri e altre vadano alla ricerca e raccontino le proprie cattive ragazze, è quello che facciamo nelle scuole. Noi ci riserviamo di tornare presto a parlare di donne, di identità e relazioni, ma con progetti nuovi e diversi da “Cattive ragazze”.
Cosa ti piacerebbe ne traessero le adolescenti di oggi?
La fiducia nelle proprie risorse e la forza per costruire se stesse e la propria storia senza farsela dettare da nessuno, così come hanno fatto le protagoniste del nostro libro. Se ci sono riuscite loro, possiamo farcela tutte.
- ESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- "Uno psicologo nei Lager e altri scritti inediti": L’amore per la vita, nonostante tutto.27 gennaio 2017, di Federico La Sala
- L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6).
Viktor Frankl, L’amore per la vita, nonostante tutto
- Si riproduce l’introduzione a Viktor E. Frankl, L’uomo alla ricerca di senso. Uno psicologo nei Lager e altri scritti inediti, in libreria in questi giorni presso Franco Angeli, che si ringrazia.
di Daniele Bruzzone (Alfabeta2, 27.01.2017)
-
Nell’andare se ne va e piange, portando la semente da gettare;
 ma nel tornare viene con giubilo , portando i suoi covoni.
ma nel tornare viene con giubilo , portando i suoi covoni.
 Sal 125, 6
Sal 125, 6
Quello sui campi di concentramento è il secondo libro pubblicato da Viktor Frankl, una volta rientrato a Vienna nell’aprile del 1945, dopo due anni e mezzo di prigionia. Era stato deportato nel settembre del 1942 a Theresienstadt, in Boemia. Sarebbero seguiti Auschwitz, in Polonia, poi Kaufe- ring III e Türkheim (due filiali di Dachau), in Baviera 1.
Già nei mesi precedenti la deportazione Frankl aveva apprestato il manoscritto del suo lavoro più rappresentativo, Ärztliche Seelsorge (Cura medica dell’anima), che secondo un illustre psichiatra dell’epoca, Oswald Schwarz, avrebbe offerto alla storia della psicoterapia un contributo paragonabile a quello rappresentato dalla Critica della ragion pura di Kant per la storia della filosofia. Frankl conservò, finché gli fu possibile, questa prima stesura del suo lavoro e, quando fu trasferito ad Auschwitz, la nascose nella fodera del cappotto nella segreta speranza di poterla un giorno dare alle stampe. Naturalmente quel manoscritto andò perduto, e lo stesso Frankl rammenta che, nelle gelide notti trascorse nei Lager, in preda alla febbre, una delle cose che lo tennero in vita fu proprio la volontà di ricostruire il manoscritto perduto, stenografandone i contenuti su piccoli foglietti di carta sottratti di nascosto alle SS 2. Dopo essere rientrato a Vienna, su suggerimento del nuovo Ordinario di Psichiatria dell’Università, il prof. Otto Kauders, Frankl riscrisse il libro e lo pubblicò presso la casa editrice Deuticke nel marzo del 1946 3.
Subito dopo iniziò a comporre le sue memorie, che comparvero ancora in quella primavera del ’46, con il titolo Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager («Uno psicologo nei campi di concentramento»), per i tipi di Jugend und Volk. Tra i due lavori pubblicati in quell’anno corre un intimo legame: se da un lato le intuizioni di Frankl sulla psicoterapia, così come sono state sviluppate nel primo libro, erano precedenti alla deportazione, dall’altro l’esperienza dei Lager ne costituiva, paradossalmente, la riprova empirica più inconfutabile. Auschwitz, in un certo senso, era stato il vero experimentum crucis delle sue teorie.
Qui le capacità propriamente umane dell’autotrascendenza e dell’autodistanziamento, sulle quali ho richiamato l’attenzione più volte negli ultimi anni, furono verificate e convalidate in termini esistenziali. Quest’empiria, nel significato più ampio del termine, confermò il survival value, per parlare con la terminologia psicologica americana, che spetta a ciò che io chiamo “volontà di senso” o autotrascendenza, ossia l’orientamento dell’esistenza umana al di là di sé, verso qualcosa che non è se stessa 4.
La prima edizione uscì anonima. In soli nove giorni e nove notti, un misterioso medico viennese deportato dai nazisti aveva sottoposto i lunghi anni di inaudite sofferenze al vaglio saggio e paziente della scrittura, costringendo la congerie di ricordi e il carico emotivo di cui erano intrisi a incanalarsi in una rigorosa operazione di analisi e riflessione. Ciò che ne scaturì non era un trattato, beninteso, ma non si poteva neppure considerare un semplice memoriale della deportazione: si trattava di un documento umano di straordinario valore, il cui successo, evidentemente, non è dovuto tanto all’oggetto del discorso, quanto alla particolarissima prospettiva con cui viene affrontato. Da questo punto di vista, il titolo della prima edizione è significativo: rappresentava il tentativo, da parte di uno psichiatra, di sezionare con metodo scientifico la propria esperienza, per restituirne una comprensione più profonda.
Tuttavia, in quella fase di faticosa ripresa postbellica, nessuno voleva (ancora) ricordare il passato, bensì trovare prospettive di fiducia e di speranza per il futuro. Non a caso, quando il libro, alcuni anni dopo, venne ribattezzato ... trotzdem Ja zum Leben sagen (Nonostante tutto dire sì alla vita) 5, conobbe quel successo di pubblico che immediatamente non aveva raccolto 6 . In effetti, il nuovo titolo riusciva, più del precedente, a comunicare l’essenza del messaggio frankliano: che, cioè, la vita vale la pena di essere vissuta in qualunque situazione, o meglio, che l’essere umano è capace, anche nelle peggiori condizioni della vita, di “mutare una tragedia personale in un trionfo” 7. Proprio questo aspetto costituisce uno dei motivi dell’inossidabile attualità dello scritto di Frankl: esso, infatti, pur narrando i tragici eventi a cui si riferisce, li trascende per incentrarsi sull’esplorazione della natura umana e delle sue potenzialità. E, in questo senso, ciò che dice vale non solo per l’esperienza della detenzione, ma anche e a maggior ragione per tutte le altre “situazioni-limite” (la sofferenza, la malattia, la disabilità, il lutto, ecc.) che, in certo qual modo, sfidano la capacità umana di resistere e di sopravvivere.
Ogni singolo lettore, pertanto, può trovare in questo libro un riflesso di sé: non necessariamente di ciò che è stato, ma magari di ciò che può diventare. Leggere Frankl, infatti, è un’esperienza di rivelazione: ci induce a scoprire i lati migliori di noi stessi 8.
Del resto, il libro di Frankl non è solo un’incursione in una delle pagine più dolorose della nostra storia, ma un vero e proprio viaggio alla ricerca dell’essenza dell’umanità. Questa è forse la ragione principale per cui il suo contributo si distingue dalle altre - ancorché inestimabili - memorie della Shoah. Egli non si limita (pur facendolo) a raccontarci le efferatezze compiute nei Lager, né è interessato (benché li descriva in modo accurato) a restituire oggettivamente i fatti più salienti.
Il suo intento è tutto orientato a comprendere dall’interno l’esperienza del deportato, sviluppando una fenomenologia dell’internamento che, per molti versi, converge con altre analisi psicologiche effettuate sui detenuti di diversi regimi. Soprattutto, però, Frankl non si accontenta di descrivere e spiegare i modi in cui progressivamente le persone, in quelle condizioni estreme, si adattavano al contesto, perdevano gradualmente la loro umanità e, infine, soccombevano al destino; egli infatti è assai più incuriosito dai motivi per cui alcune di esse (non necessariamente quelle fisicamente più robuste) resistessero più a lungo e, soprattutto, si opponessero al quel processo di disumanizzazione che in tali situazioni apparirebbe, se non proprio inevitabile, quanto meno prevedibile e ampiamente giustificato. La domanda sorgeva spontanea: che cosa consentiva a queste persone di resistere e di non smarrire la dignità e la speranza?
La risposta a questo interrogativo ci conduce a una revisione delle più consuete teorie motivazionali con cui tendiamo a interpretare - o addirittura a prevedere - il comporta- mento umano. Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, infatti, gli interessi spirituali delle persone che si trovano in situazioni di deprivazione radicale sul piano psico-fisico non regrediscono fino a scomparire, ma possono acuirsi e perfino manifestarsi laddove sembravano sopiti. Come dire: proprio laddove la natura umana è ricondotta e ancorata implacabilmente alla sua “bassezza”, il suo spirito è capace di elevarsi a un’“altezza” (intellettuale, morale, religiosa) altrimenti forse insospettata.
Ciò che Frankl mette a fuoco nel suo scritto è l’incredibile “forza di resistenza dello spirito” (una sorta di resilienza ante litteram) che, proprio nei momenti più difficili, permette alle persone di opporsi al proprio destino e - pur non potendolo mutare esteriormente - le rende capaci di dominarlo dall’interno. In tal modo, con l’autorevolezza dello scienziato e la credibilità del testimone, lo psichiatra sopravvissuto ai Lager sostiene che le persone sono capaci non solo di resistere, ma perfino di crescere, nonostante gli “urti” della vita e talvolta grazie ad essi 9. Questo aspetto costituisce altresì il principale motivo di distinzione dell’interpretazione frankliana rispetto alle altre descrizioni psicologiche dei campi di concentramento. Ad esempio quella di Bruno Bettelheim, che fu deportato nel 1938, venne rilasciato nel 1939, si rifugiò negli Stati Uniti dove insegnò psicologia per trent’anni e poi morì suicida: laddove Bettelheim vede il trionfo dell’istinto di morte sulla pulsione di vita, Frankl scorge invece la possibilità di “dire sì alla vita” nonostante tutto10.
Dagli abissi della sofferenza emerge l’intuizione che la libertà interiore e la responsabilità (la capacità, cioè, di rispondere al proprio destino) sono l’intimo baluardo della dignità umana contro la spersonalizzazione e il fatalismo:
Che cos’è, dunque, l’uomo? Noi l’abbiamo conosciuto come forse nessun’altra generazione precedente; l’abbiamo conosciuto nel campo di concentramento, in un luogo dove veniva perduto tutto ciò che si possedeva: denaro, potere, fama, felicità; un luogo dove restava non ciò che l’uomo può “avere”, ma ciò che l’uomo deve “essere”; un luogo dove restava unicamente l’uomo nella sua essenza, consumato dal dolore e purificato dalla sofferenza.
Che cos’è, dunque, l’uomo? Domandiamocelo ancora. È un essere che sempre decide ciò che è. Un essere che porta in sé contemporaneamente la possibilità di abbassarsi al livello degli animali o di innalzarsi al livello di una vita santa. L’uomo è l’essere che ha inventato le camere a gas, ma è anche l’essere che è entrato in esse a fronte alta, sulle labbra il Padre nostro o la preghiera ebraica per la morte 11.
Forse il pessimismo e la disperazione che hanno insidiato l’esistenza di tanti superstiti (incluso, forse, il nostro amato Primo Levi) fino a spegnere in loro il desiderio di vivere, sono dovuti a una domanda che li ha assillati ogni giorno, rodendone l’anima dall’interno come un tarlo: Perché ha potuto accadere tutto questo? Perché abbiamo dovuto soffrire? Perché così tanti sono morti nell’indifferenza del mondo?
Anche Frankl esce dai campi di concentramento chiedendosi perché, ma la sua è una domanda molto diversa. Egli non si chiede perché abbia dovuto soffrire, né pretende di sapere perché abbia dovuto perdere le persone più care (il padre Gabriel, la madre Elsa, il fratello Walter e la giovanissima moglie Tilly morirono nei campi); si domanda piuttosto: Perché io sono tornato indietro? Perché a me la vita è stata risparmiata? La differenza è evidente: la risposta al perché del male e della morte non è in nostro potere, e la domanda è destinata a infrangersi contro il silenzio (o la morte) di Dio; la risposta alla domanda sul perché della vita, invece, dipende interamente da noi: sta a noi, infatti, decidere per chi o per che cosa siamo disposti a vivere, soffrire e perfino morire.
Questo spiega anche, almeno in parte, il carattere di Viktor Frankl: la sua instancabile dedizione al lavoro, il suo spiccato senso dell’umorismo, la sua irriducibile passione per le sfide che la vita, ad ogni età, poteva presentargli. Non si trattò, probabilmente, di una consapevolezza immediata, ma di una conquista progressiva, l’esito di un lungo lavoro su di sé. Dalle lettere che Frankl inviò agli amici nei mesi immediatamente successivi alla liberazione si evince lo stato di profonda prostrazione in cui era precipitato. Il 14 settembre 1945 scriveva a Wilhelm e Stepha Börner:
- Mi sento indicibilmente stanco, indicibilmente triste, indicibilmente solo. Non ho più nulla da sperare e niente più da temere. Non ho più alcuna gioia dalla vita. [...] Nel Lager si credeva di aver già toccato il fondo dell’esistenza ma al ritorno abbiamo dovuto constatare che non è così, che ciò a cui si teneva è andato perduto, che nel momento in cui siamo tornati a essere uomini possiamo piombare in una sofferenza ancora più grave, più abissale 12.
Forse il farmaco per questo malessere fu proprio la scrittura. Scrivere, probabilmente, gli consentì di metabolizzare la materia grezza del dolore trasformandola in nutrimento per l’anima. In questo senso, si potrebbe dire che il libro non è solo il ricettacolo di una sofferta saggezza, ma anche lo strumento con cui è stata distillata.
Il risultato sta sotto gli occhi di ogni lettore. L’esperienza della sofferenza poteva spegnere in Viktor Frankl l’amore per la vita oppure farlo divampare come un fuoco inestinguibile. Sono passati 70 anni da quando queste pagine hanno visto la luce per la prima volta. Bruciano ancora.
Note
1 Per un’introduzione alla vita e al pensiero di Frankl, si rimanda a D. Bruzzone, Viktor Frankl. Fondamenti psicopedagogici dell’analisi esistenziale, Carocci, 2012. Per un avvicinamento al modello clinico della logoterapia e analisi esistenziale, cfr. D. Bellantoni, L’analisi esistenziale di Viktor E. Frankl, 2 voll., LAS, 2011.
2 Alcuni di questi esemplari sono tuttora conservati come reliquie al museo recentemente inaugurato del Viktor Frankl Zentrum di Vienna, al numero 1 di Mariannengasse, proprio nell’appartamento adiacente a quello in cui Frankl ha vissuto ininterrottamente dal suo ritorno a Vienna fino alla sua scomparsa, il 2 settembre del 1997.
3 L’edizione italiana, tradotta da Danilo Cargnello nel 1953 e successivamente rivista da Eugenio Fizzotti, reca il titolo Logoterapia e analisi esistenziale ed è pubblicata dall’editrice Morcelliana di Brescia. Solo alcuni anni dopo la sua morte, nell’archivio di casa Frankl, è stata rinvenuta la prima stesura del ’42 (probabilmente Frankl aveva affidato una copia del manoscritto a un amico, prima dell’arresto) e ciò ha permesso di mettere al confronto le diverse stesure, raccolte nel IV volume delle Gesammelte Werke, a cura di A. Batthyany, K. Biller e E. Fizzotti (Böhlau, Wien, 2011).
4 V. E. Frankl, Ciò che non è scritto nei miei libri. Appunti autobiografici sulla vita come compito, FrancoAngeli, 2012, p. 100.
5 Si trattava del titolo di una delle prime conferenze tenute da Frankl presso l’Università Popolare di Ottakring nel 1946.
6 Quando poi nel 1959, per volere dell’allora Presidente dell’American Psychological Association, Gordon W. Allport, ne venne pubblicata la traduzione in lingua inglese (dapprima con il titolo From Death-Camp to Existentialism e poi con il titolo tuttora in vigore Man’s Search for Meaning), il volume divenne rapidamente un bestseller, tanto che gli studenti universitari americani lo elessero più volte “libro dell’anno” e la Library of Congress di Washington D.C. lo ha decretato “uno dei 10 libri più influenti d’America”. Alla morte di Frankl, l’opera era stata tradotta in 24 lingue e aveva venduto oltre 10 milioni di copie.
7 V. E. Frank l , La sfida del significato. Analisi esistenziale e ricerca di senso , a cura di D. Bruzzone e E. Fizzotti, Erickson, 2005, p. 119.
8 Si veda, a questo proposito , P. Versari, Dalla « bella vita» a una vita bella. Colmare i vuoti di senso alla scuola di Viktor E. Fr ankl , Ares, 2015.
9 Da questo punto di vista l’intuizione frankliana anticipa e ispira le successive ricerche sulla capacità di resilienza e i fattori di protezione e di rischio che la condizionano, ma si lega anche al costrutto, più recentemente definito, della “crescita post-traumatica”, secondo cui una persona può esibire un grado di consapevolezza, di maturità e di integrazione personale, non solo pari a quello che possedeva prima del trauma, ma addirittura superiore.
10 Per approfondimenti si rinvia a D. Bruzzone, Ricerca di senso e cura dell’esistenza, Erickson, 2007, pp. 37-59.
11 V. E. Frankl, Homo patiens. Soffrire con dignità, Queriniana, 1998, pp. 97-98.
12 V. E. Frankl, Lettere di un sopravvissuto.Ciò che mi ha salvato dal lager, a cura di E. Fizzotti , Rubbettino, 2008, pp. 137-138.
- L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6).
- L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6).
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE --- APPELLO. L’8 Marzo fermiamo il mondo per dire no alla violenza maschile sulle donne.26 gennaio 2017, di Federico La Sala
Appello a tutti i sindacati confederali, di base e autonomi:
l’8 Marzo fermiamo il mondo per dire no alla violenza maschile sulle donne
di nonunadimeno *
Siamo le donne che hanno costruito la grande mobilitazione nazionale dello scorso 26-27 novembre che ha visto scendere in piazza più di duecentomila persone.
Con lo slogan Non Una di Meno ci siamo rimesse in marcia contro la violenza maschile sulle donne insieme a tutt* coloro che hanno riconosciuto questa lotta imprescindibile per la trasformazione radicale dell’esistente.
La manifestazione ha ribadito che la violenza è un problema strutturale delle nostre società e agisce in ogni ambito della nostra vita. Il femminicidio è la punta dell’iceberg, l’epilogo tragico di una catena di discorsi e atti, simbolici e concreti, che dalla casa al posto di lavoro, dalla scuola all’università, negli ospedali e sui giornali, nei tribunali e nello spazio pubblico tende ad annientarci.
Sappiamo come la violenza sulle donne si esprime in una molteplicità di agiti/piani: nella disparità salariale; nelle tante discriminazioni sui posti di lavoro, nei luoghi della formazione e della ricerca; nello sfruttamento del lavoro domestico e di cura, che sia svolto gratuitamente oppure in cambio di un salario, nella maggior parte dei casi da una donna migrante obbligata dal ricatto del permesso di soggiorno; nel ricatto della precarietà; nella privatizzazione della salute e dei servizi; nella negazione della libertà di scelta e dell’autodeterminazione, nella violenza ostetrica e medica, nell’obiezione di coscienza dilagante, nella squalificazione del nostro ruolo e della nostra dignità.
Ma siamo altrettanto consapevoli - e dobbiamo farlo capire a molti - del peso che le donne, più della metà della popolazione mondiale, hanno nei processi economici, sociali,culturali, produttivi e riproduttivi, e della forza di mobilitazione trasformativa che possono esprimere e stanno esprimendo in tutto il mondo.
Le giornate del 26 e 27 Novembre sono state solo l’inizio di un percorso di lotta, di elaborazione, di trasformazione, dunque, perché sentiamo fortemente il bisogno che tutto questo non rimanga sul piano esclusivamente simbolico.
Per questo abbiamo fatto nostro l’appello delle donne argentine alla costruzione di uno SCIOPERO INTERNZIONALE DELLE DONNE PER IL PROSSIMO 8 MARZO. Una giornata in cui rivendicare la nostra forza agendo la nostra sottrazione/astensione da ogni funzione produttiva e riproduttiva che ci riguardi.
Si tratta di una pratica già sperimentata in passato ma inedita nella sua dimensione internazionale, che prende spunto dagli scioperi delle donne argentine e polacche dei mesi scorsi. E’ una sfida che lanciamo per rimettere al centro, dopo il 26 e il 27 novembre, il protagonismo delle donne contro la violenza psicologica, fisica, sociale, economica, politica e culturale, perché “Se le nostre vite non valgono, allora ci fermiamo”.
Chiediamo, quindi, a tutti i sindacati confederali, di base e autonomi, in particolare a tutti quelli che hanno aderito alle giornate del 26 e del 27 Novembre, di mettersi al servizio della mobilitazione delle donne e di indire lo sciopero generale per la giornata dell’8 Marzo 2017, essere strumento utile allo sciopero e non ostacolo all’adesione delle lavoratrici e di tutt* coloro intendano partecipare a questa nuova giornata di lotta per la nostra autodeterminazione.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- ESODO E RIVOLUZIONE: LE SPINE DEL C17.24 gennaio 2017, di Federico La Sala
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Le spine di C17di Franco Berardi Bifo (alfapiù, 21 gennaio 2017)
In singolare e spiritosa coincidenza con l’inizio della prima presidenza del Ku Klux Klan, comincia oggi a Roma una conferenza dal titolo C17. Si svolge in parte al centro sociale ESC, dove parlerà una folta schiera di pensatori contemporanei, da Saskia Sassen a Silvia Federici a Christian Marazzi e tanti altri. E in parte si svolge alla Galleria d’arte moderna dove ci saranno performance di vario genere, a cominciare con Franco Piperno che ci insegna come leggere il cielo e ci racconta come si è letto il cielo nel corso dei secoli e dei millenni. Guardare il cielo in modo consapevole e immaginativo è il modo migliore di cominciare, perché così il tema del comunismo si ripresenta nella sua cornice più vasta, quella che contiene la sensibilità, l’immaginazione e il desiderio (che d’altra parte è parola che scende etimologicamente dalle stelle).
La questione del comunismo ritorna?
Il comunismo del ventesimo secolo è morto, questo è fuori discussione.
La tragedia del secolo passato ha avuto tre attori protagonisti: il comunismo il fascismo e la democrazia. Il fascismo apparve sconfitto, morto e sepolto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Poi venne l’epoca della guerra fredda: i due attori sopravvissuti si contesero l’egemonia sul mondo fino al collasso finale del comunismo sovietico e al trionfo della democrazia.
Il comunismo apparve allora definitivamente liquidato, irreversibilmente condannato perché la democrazia prometteva di rispondere alle domande cui il comunismo sovietico non aveva dato risposta: benessere, pace, allegria.
Il decennio novanta cominciò però subito con una spiacevole sorpresa. Invece della pace promessa la democrazia americana lanciò la guerra nel Golfo.
E nel secolo nuovo anche la promessa di benessere economica è andata svanendo, così che la miseria si è diffusa insieme alla rabbia e all’impotenza.
Molti hanno allora cominciato a pensare che la democrazia non può convivere a lungo con il capitalismo senza diventare un’odiosa ipocrisia.
L’odio per l’ipocrisia democratica ha allora riportato il fascismo sulla scena.
E poiché le sorprese non finiscono mai, in pochi anni partiti razzisti, autoritari quando non apertamente fascisti si sono impadroniti del potere in gran parte del mondo.
Hitler ritorna? Se ritorna è moltiplicato per dodici e per di più ha la bomba nucleare. E poiché la democrazia si è rivelata un’illusione, una maschera dietro cui si nasconde la violenza economica del capitalismo finanziario globale, dobbiamo riconoscere che il comunismo è urgente.
L’urgenza la sentono molti, forse la maggioranza della società, ma molto pochi chiamano quest’urgenza con il suo vero nome: comunismo.
La sofferenza si diffonde, ma pochi sanno che la cura non è farmacologica, perché la cura si chiama comunismo.
Artisti attivisti e pensatori si sono quindi dati appuntamento a Roma, e sarebbe bello se riuscissero a trovare parole, gesti e forme capaci di nominare questa urgenza.
Ci riusciranno?
Io sono andato a leggermi alcuni documenti che introducono questa conferenza e particolarmente le pagine che sono uscite sul Manifesto una settimana fa, una intervista di Benedetto Vecchi con Sandro Mezzadra e una di Francesco Raparelli con Toni Negri.
Confesso che entrambe queste interviste mi hanno molto deluso, come chi fosse invitato ad un pranzo succulento e si trovasse a dover sorbire un’insipida minestrina da ospedale.
Negri ci ha ripetuto negli ultimi anni che la moltitudine si oppone all’impero. Ma la moltitudine oggi si esprime votando per i peggiori nazionalisti o respingendo i profughi che fuggono dalla guerra e dalla fame, e costruendo campi di concentramento lungo le coste del Mediterraneo.
Ora, in questa intervista sul Manifesto dice che occorre trasformare la sofferenza del bisogno in un noi desiderante, e siamo tutti d’accordo naturalmente. Ma questa frase, che è il centro del suo ragionamento, è un’ovvietà poco interessante, perché vorremmo sapere come questo passaggio dalla miseria psichica e sociale dell’oggi può trasformarsi in solidarietà felice.
Mezzadra ripete alcune cose che abbiamo sentito mille volte negli ultimi anni ma sembra dimenticarsi che nel frattempo, proprio in questo ultimo anno, in questo maledetto anno dell’apocalisse 2016, tutte la parole degli ultimi decenni sono diventate vecchie perché il razzismo si è impadronito del governo del mondo.
Negri e Mezzadra (e tutti i documenti che introducono questo appuntamento C17) dimenticano di pronunciare il nome dell’uomo del Ku Klux Klan che proprio in questi giorni si insedia al governo del mondo.
La rimozione non ci sarà di nessun aiuto, eppure è sotto il segno della rimozione che questo appuntamento comincia.
La sintesi di queste interviste sembra essere in un titolo scelto dal Manifesto: I movimenti saranno una spina nel fianco del potere.
Ma questa sintesi è sconsolante. La spina? Il fianco? Ma di che stiamo parlando?
I movimenti sono scomparsi e non ritorneranno, perché sono stanchi di essere una spina in un fianco tanto pingue che della spina neppure se ne accorge.
Speriamo che questi giorni di discussioni e di sperimentazioni ci permettano di intravvedere un orizzonte un po’ più originale ed efficace di questo.
NOTA:
LE SPINE DEL "C17" 0 DEL "C22"?! CHI SIAMO NOI IN REALTA’?!
CONCORDO PIENAMENTE CON L’INTERVENTO DI BIFO ...
A PRIMO MORONI, IN MEMORIA. E ALLA SUA LIBRERIA "CALUSCA", IN UNA BREVE "LETTERA", nel marzo del 2000, così scrivevo:
=[...] "Caro Primo, su questa strada, mi sembra, è la via d’uscita (sul tema, cfr. Michael Walzer, Esodo e rivoluzione, Milano, Feltrinelli, 1986) dall’Egitto capitalistico e la ‘chiave’, consegnataci dal Dio dei nostri padri e delle nostre madri, per entrare nella Terra... promessa e abitarla in spirito di pace, giustizia, e amicizia. Il comunismo è la cosa semplice, più difficile a farsi.
Dar vita a quello che Tu, nella piccola terra-libreria - lo specchio della tua identità e della tua libertà, il grande spazio aperto e accogliente della Calusca prima e della Calusca City Lights dopo, superando difficoltà e mai perdendo il coraggio e la lucidità, hai saputo far accadere, e mostrarne la possibilità: esseri umani che si incontrano nella libertà, nel rispetto reciproco, e, amichevolmente, fanno Uno (la Relazione Chiasmatica) e questo Uno illumina, spezza le catene e apre i recinti, trasforma le relazioni (a riguardo, ricordo la ‘magica’ giornata - una per tutte, simbolicamente - in cui, in [via] Conchetta, si presentò e si discusse il lavoro di Giorgio Antonucci, Critica al giudizio psichiatrico, Roma, Edizioni Sensibili alle foglie, 1993), e realizza un nuovo rapporto sociale di produzione (di esseri umani, di idee, e di cose), apre a una nuova, chiasmatica, prassi e a una nuova misura di tutti gli affari umani.
Nonostante gli inevitabili errori e inciampi, molti sono stati i LUMHI (Libera Università di Milano e del suo HInterland “Franco Fortini”), i nuclei di microutopie (cfr. Sergio Bologna, Due parole tanto per..., in AA. VV., Lezioni sul revisionismo storico, Cox 18 Books, Calusca City Lights, Milano 1999), da te accesi e disseminati per le strade (del mondo e) della Milano che fa male [...]
Forse è bene riprenderla e rileggerla, questa Lettera. Il suo titolo è proprio sul tema "Chi siamo noi in realtà. Relazioni chiasmatiche e civiltà" (cfr. http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=3920). E, fondamentalmente, non lo sappiamo ancora!
Federico La Sala
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE. La vecchia filatrice "Al mercato della felità" (di Francesca Rigotti)23 gennaio 2017, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
Se desideri molto, avrai? E cosa?di Francesca Rigotti (DOPPIOZERO, 16 Dicembre 2016)
Dopo che Giuseppe l’ebreo fu tirato su dal pozzo e venduto dai suoi fratelli ai mercanti di schiavi Medianiti, e prima che venisse acquistato dall’eunuco Potifar per conto del faraone d’Egitto, molti, al mercato degli schiavi, si erano offerti di comprarlo. Tra loro una vecchia filatrice che mostrando alcuni gomitoli di lana colorata da lei stessa filata disse al sensale: «Ci sono anch’io, vendi a me quel giovanotto, lo desidero pazzamente, ecco qui il mio pegno». Il sensale rise: «Anima semplice, guarda che per questo gioiello di schiavo mi hanno offerto tesori; con il tuo filo non puoi comprarlo». «Lo so che in questo mercato io non lo compro» gli rispose la donna. «Mi sono messa in fila perché dicano, amici e nemici: anche lei ci ha provato». Con questo magnifico apologo, tratto da una breve storia scritta fra i secc. XII e XIII dal mistico persiano Farid al-din ’Attar, inizia il primo capitolo/non capitolo del saggio/non saggio di Luisa Muraro dal titolo Al mercato della felicità (nuova edizione presso Orthotes di un libro uscito per i tipi di Mondadori nel 2009).
La storia dell’anziana donna che vorrebbe comprare il bel giovanotto da lei pazzamente desiderato mi è proprio piaciuta, sia per il rovesciamento dei ruoli di gender, sia per il messaggio finale: anche la vecchia ci ha provato, provarci è importante. Se non vai al mercato non avrai nulla. E fin qui tutti d’accordo. Ma anche se vai al mercato coi tuoi gomitoli di lana colorata, si potrebbe obiettare, non otterrai un bel niente e tanto meno Giuseppe in persona. E allora? Che cosa cambia? Cambia il desiderio, cambia l’intensità del desiderio, cambiano gli effetti del desiderio sulla realtà - afferma Muraro - perché il reale non è indifferente al desiderio. Vuol dire allora, continuiamo a domandarci, che se desideri molto, avrai? Avrai che cosa, la merce che desideri? O l’apologo sta soltanto a significare che la realizzazione (=il divenire reale) del desiderio avverrà soltanto se desideri non beni materiali, per i quali i gomitoli di certo non bastano, ma un altro tipo di oggetti: l’arte, la libertà, il rispetto, la cura?
Mi par di capire che Muraro intenda l’uno e l’altro. Da una parte ella esalta quella capacità che oggi molti glorificano con estrema facilità e faciloneria, ovvero la resilienza. Resilienza, termine preso in prestito dall’ingegneria e trasferito dal linguaggio della tecnologia dei materiali a quelli dell’ecologia, del linguaggio informatico e della psicologia; qui esso indica, nell’illustrazione offerta da Marco Belpoliti, «la capacità di un organismo di autoripararsi dopo un danno: un sistema operativo capace di adattarsi e resistere all’usura. La capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre». Dunque, in altre parole, l’abilità di far tesoro degli handicap e delle carenze per diventare campioni di qualcosa, dal giornalismo allo sport.
È una sorta di resilienza la dote della vecchia filatrice, il cui oggetto del desiderio, il bel Giuseppe, è posto talmente in alto da essere irraggiungibile? È un altro modo per esprimere la morale cattolica nel punto in cui essa esorta a fare di necessità virtù commisurando i desideri alle possibilità, e diventare una buona monaca, nelle parole di Alessandro Manzoni, anche se ti hanno monacato a forza contro la tua volontà?
I due messaggi di Muraro vengono rafforzati nel pensiero esposto nel secondo non capitolo del non saggio, Dei difetti fai profitti (se premetto le negazioni è perché il volume di Muraro non è una monografia tematica quanto una serie di considerazioni sparse ispirate a lavori precedenti e disposte lungo un percorso personale che l’autrice espone alla condivisione). Un «pensiero per tutti», lo chiama, che per tutti e tutte non è in quanto si ancora a due pilastri non da tutti/e condivisibili: la prospettiva fideistica cattolica con inclinazione alla mistica, primo, e, secondo, la posizione - all’interno del femminismo - definita di tipo «differenzialista».
Io per esempio non condivido né il primo né il secondo pilastro; per quanto riguarda il secondo, faccio parte di quelle donne legate alla «landa d’insensatezza» - così Muraro la definisce - del femminismo dell’eguaglianza e dell’emancipazione che esige parità dei sessi e non sopporta la logica religiosa (non necessariamente cristiana, in questo tutte le religioni monoteiste sono sorelle) della differenza/complementarietà dei sessi, che mi sembra una sorta di apartheid sessuale: diversi ma uguali, o uguali ma diversi, come preferite, voi di qua noi di là e tutti felici e contenti. Io donna con le mie caratteristiche (innate? naturali? genetiche?) che risiedono nell’attenzione, nella cura, nella passività, nella devozione o nell’accompagnamento (sic) e di là gli uomini col coraggio, la decisionalità, l’audacia, l’attività, la creatività. O anche tutti insieme, non importa, purché sia ribadita la differenza.
Per quanto riguarda il primo pilastro mi associo alla posizione di Virginia Wolf: noi siamo le parole, noi siamo la musica, noi siamo la realtà, sicuramente e decisamente non esiste alcun Dio; cui aggiungo, di mio, noi siamo la misericordia che mette un po’ di riparo al male; di Dio, se Dio ci fosse.
Ecco che allora il pensiero della differenza, già saldato con la dottrina della chiesa, si connette in Muraro col pensiero della resilienza o del far profitti da difetti, usando a proprio vantaggio il fatto di essere donne, minus habentes, dotate, lo dice Sant’Agostino, di parvus intellectus. Bello. Suona bene. (Hillary Clinton ci ha provato e le è andata male. Clinton ha perso perché ha affermato di essere donna ma essere una donna, e una donna di una certa età, non coincide con l’ideale vittorioso di forza, dinamicità e potenza che gli USA pretendono di incarnare). Il femminismo di Muraro con la sua logica del mercato della felicità esorta dunque a lottare contro il male di essere nate donne per vivere il femminile liberamente e incondizionatamente. Il suo è il femminismo filato col filo della resilienza e del far profitto del difetto, e tessuto al telaio della fede e della mistica. Che piace e ha successo. Non è il mio e di chi mi accompagna nella «landa d’insensatezza», ma pazienza.
*
Luisa Muraro, Al mercato della felicità, revisione a cura di Clara Jourdan, Napoli-Salerno, Orthotes, 2016, pp. 178 (prima edizione: 2009 Arnoldo Mondadori Editore, Milano).
SCHEDA EDITORIALE.
 In questo libro Luisa Muraro, tra le più importanti filosofe italiane, lancia una sfida: che cosa sarebbe la nostra vita senza grandi desideri? Si può desiderare ciò che sembra impossibile da ottenere? Nella cultura che cambia senza andare avanti, in un’economia che cresce e si espande ma non si cura di far crescere né la gioia né il senso di sicurezza, nella vita che sembra tutta un mercato, con l’umanità stretta fra il troppo e troppo poco, traspare l’intuizione che il reale non è indifferente al desiderio e non assiste indifferente alla passione del desiderare. Il mondo è salvo solo a patto che coloro che lo abitano abbiano aspettative incommensurabili ai propri mezzi e non perdano mai la fiducia di essere destinati a qualcosa di grande.
In questo libro Luisa Muraro, tra le più importanti filosofe italiane, lancia una sfida: che cosa sarebbe la nostra vita senza grandi desideri? Si può desiderare ciò che sembra impossibile da ottenere? Nella cultura che cambia senza andare avanti, in un’economia che cresce e si espande ma non si cura di far crescere né la gioia né il senso di sicurezza, nella vita che sembra tutta un mercato, con l’umanità stretta fra il troppo e troppo poco, traspare l’intuizione che il reale non è indifferente al desiderio e non assiste indifferente alla passione del desiderare. Il mondo è salvo solo a patto che coloro che lo abitano abbiano aspettative incommensurabili ai propri mezzi e non perdano mai la fiducia di essere destinati a qualcosa di grande. - UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Papa Francesco che cammina sulle tracce di Agostino (di E. Scalfari).17 dicembre 2016, di Federico La Sala
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE. Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito. *:
Gli 80 anni del papa
Papa Francesco che cammina sulle tracce di Agostino
di EUGENIO SCALFARI (la Repubblica, 17 dicembre 2016)
COMPIE ottant’anni papa Francesco e li porta molto bene, sia fisicamente e sia spiritualmente. Viaggia continuamente nel mondo intero e nelle parrocchie romane. Di Roma è vescovo e questa qualifica la rivendica spesso perché gli consente di definirsi come “primus inter pares” e lui è consapevole di quanto sia utile a quella Chiesa missionaria da lui realizzata.
Personalmente ho avuto la fortuna di diventargli amico ancorché io non sia un credente. Papa Francesco aveva bisogno di un non credente che approvasse la predicazione di quello che lui chiama Gesù Cristo ed io chiamo Gesù di Nazareth figlio di Maria e di Giuseppe della tribù di David, cioè era figlio dell’uomo e non di Dio. Ma su questo modo di considerare Cristo papa Francesco è d’accordo: il Figlio di Dio quando decide di incarnarsi diventa realmente un uomo con tutte le passioni, le debolezze, le virtù d’un uomo. Francesco racconta spesso la settimana della Passione che ha il suo inizio con l’ingresso quasi trionfale di Gesù a Gerusalemme, seguito da molti dei suoi fedeli e naturalmente dei suoi apostoli. Ma a Gerusalemme trova anche quelli che lo temono e lo odiano. Soprattutto la gerarchia ebraica del Tempio che si sente minacciata nei suoi privilegi.
A quell’epoca Israele era sotto la "protezione" dell’impero di Roma e l’imperatore era Tiberio che nulla sapeva di quanto avvenisse in province assai lontane. Papa Francesco ricorda gli ultimi giorni di quella che poi fu chiamata la "Via Crucis", l’ultima cena e poi quel che avvenne nell’orto di Getsemani. Gli apostoli a quella cena erano tredici ma uno di loro, Giuda Iscariota, lo aveva già tradito e quando Gesù cominciò a parlare abbandonò quel tavolo e andò via. Restarono in dodici e fu lì che Gesù condivise il pane e il vino identificandoli con il suo corpo e il suo sangue. Il Signore era già stato battezzato da Giovanni nelle acque del Giordano e battesimo ed eucarestia furono i soli due Sacramenti; gli altri vennero dopo. La natura umana del Cristo si ha nei racconti dei Vangeli, nel Getsemani e poi sulla Croce. Nell’orto, dove sarà poi arrestato dai soldati romani guidati dall’Iscariota, Gesù entra in contatto con il Padre e dice: «Se tu puoi allontana da me questo amaro calice ma se non vuoi lo berrò fino in fondo». Sulla Croce, negli ultimi istanti prima della morte dice: «Padre, perché mi hai abbandonato?». Quindi era un uomo, l’incarnazione era stata reale.
- Scalfari: "Gli 80 anni del mio Papa rivoluzionario"
Papa Francesco è affascinato da questi racconti. Mi sono chiesto e gli ho chiesto il perché del fascino che esercitano su di lui e la risposta è stata che nel mistero trinitario Cristo rappresenta l’amore in tutte le sue manifestazioni. L’amore verso Dio che si trasforma in amore verso il prossimo. «Ama il prossimo tuo come te stesso» è una legittimazione dell’amore all’individuo e alla comunità, in cerchi concentrici: la famiglia, il luogo dove vive e soprattutto la specie cui appartiene.
Francesco indica i poveri, i bisognosi, gli ammalati, i migranti. Francesco sa bene quello che dice la Bibbia: «I ricchi e i potenti debbono passare per la cruna d’un ago per guadagnare il Paradiso». Occorre dunque che i popoli si integrino con gli altri popoli. Si va verso un meticciato universale che sarà un beneficio, avvicinerà i costumi, le religioni.
 Il Dio unico sarà finalmente una realtà. È questo che Francesco auspica. «È ovvio che sia unico, ma finora non è stato così. Ciascuno ha il suo Dio e questo alimenta il fondamentalismo, le guerre, il terrorismo. Perfino i cristiani si sono differenziati, gli Ortodossi sono diversi dai Luterani, i protestanti si dividono in migliaia di diverse confessioni, gli scismi hanno accresciuto queste divisioni. Del resto noi cattolici siamo stati invasi dal temporalismo, a cominciare dalle Crociate e dalle guerre di religione che hanno insanguinato l’Europa e l’America del Nord e del Sud. Il fenomeno della schiavitù e la tratta degli schiavi, la loro vendita alle aste. Questa è stata la realtà che ha deturpato la storia del mondo».
Il Dio unico sarà finalmente una realtà. È questo che Francesco auspica. «È ovvio che sia unico, ma finora non è stato così. Ciascuno ha il suo Dio e questo alimenta il fondamentalismo, le guerre, il terrorismo. Perfino i cristiani si sono differenziati, gli Ortodossi sono diversi dai Luterani, i protestanti si dividono in migliaia di diverse confessioni, gli scismi hanno accresciuto queste divisioni. Del resto noi cattolici siamo stati invasi dal temporalismo, a cominciare dalle Crociate e dalle guerre di religione che hanno insanguinato l’Europa e l’America del Nord e del Sud. Il fenomeno della schiavitù e la tratta degli schiavi, la loro vendita alle aste. Questa è stata la realtà che ha deturpato la storia del mondo».Quando papa Francesco ha partecipato alla celebrazione di Martin Lutero e della sua Riforma ha colto l’essenza delle tesi luterane: l’identificazione dei fedeli con Dio non ha bisogno dell’intermediazione del clero ma avviene direttamente.
 Questo ci conduce al Dio unico e assegna al sacerdozio un ruolo secondario. Così avveniva nei primi secoli del cristianesimo, quando i Sacramenti erano direttamente celebrati dai fedeli e i presbiteri facevano soltanto il servizio. Francesco è d’accordo su queste tesi luterane che coincidono con quanto avvenne nei primi secoli.
Questo ci conduce al Dio unico e assegna al sacerdozio un ruolo secondario. Così avveniva nei primi secoli del cristianesimo, quando i Sacramenti erano direttamente celebrati dai fedeli e i presbiteri facevano soltanto il servizio. Francesco è d’accordo su queste tesi luterane che coincidono con quanto avvenne nei primi secoli.- Bergoglio racconta Bergoglio: gli 80 anni del Papa
Ma quali sono i Santi che il nostro Papa predilige? Gliel’ho chiesto e lui mi ha risposto così: «Il primo è naturalmente Paolo. È lui ad aver costruito la nostra religione. La Comunità di Gerusalemme guidata da Pietro si definiva ebraico-cristiana, ma Paolo consigliò che bisognava abbandonare l’ebraismo e dedicarsi alla diffusione del cristianesimo tra i Gentili, cioè ai pagani. Pietro lo seguì in questa sua concezione anche se Paolo non aveva mai visto Gesù. Non era un apostolo, eppure si considerò tale e Pietro lo riconobbe. Il secondo è San Giovanni Evangelista, che scrisse il quarto Vangelo, il più bello di tutti. Il terzo è Gregorio, l’esponente della Patristica e della liturgia.
 Il quarto è Agostino, vescovo di Ippona, educato adeguatamente da Ambrogio vescovo di Milano. Agostino parlò della Grazia, che tocca tutte le anime e le predispone al bene compatibilmente con il libero arbitrio. La libertà accresce il valore del bene e condiziona il suo eventuale abbandono.
Il quarto è Agostino, vescovo di Ippona, educato adeguatamente da Ambrogio vescovo di Milano. Agostino parlò della Grazia, che tocca tutte le anime e le predispone al bene compatibilmente con il libero arbitrio. La libertà accresce il valore del bene e condiziona il suo eventuale abbandono.Ebbene, sembrerà che io esageri ma ne sono fermamente convinto: dopo Agostino viene papa Francesco. L’intervallo temporale è enorme, ma la sostanza è quella. L’ho definito, quando l’ho conosciuto, rivoluzionario e profetico ma anche modernissimo.
In uno dei nostri incontri gli chiesi se pensava di convocare un nuovo Concilio e lui rispose: «Un Concilio no: il Vaticano II, avvenuto cinquant’anni fa, ha lasciato una precettistica che in buona parte è stata applicata da Giovanni Paolo II, da Paolo VI e da Benedetto XVI. Ma c’è un punto che non ha fatto passi avanti ed è quello che riguarda il confronto con la modernità. Spetta a me colmare questa lacuna. La Chiesa deve modernizzarsi profondamente nelle sue strutture ed anche nella sua cultura».
Santità - ho obiettato io - la modernità non crede nell’Assoluto. Non esiste la verità assoluta. Lei dovrà dunque confrontarsi con il relativismo. «Infatti. Per me esiste l’Assoluto, la nostra fede ci porta a credere nel Dio trascendente, creatore dell’Universo. Tuttavia ciascuno di noi ha un relativismo personale, i cloni non esistono. Ognuno di noi ha una propria visione dell’Assoluto da questo punto di vista il relativismo c’è e si colloca a fianco della nostra fede».
Buoni ottant’anni, caro Francesco. Continuo a pensare che dopo Agostino viene Lei. È una ricchezza spirituale per tutti, credenti o non credenti che siano.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA QUESTIONE MORALE, QUELLA VERA - EPOCALE:
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Verso una società conviviale. Una discussione con Alain Caillé sul "Manifesto convivialista" (F. Fistetti - Ugo M. Olivieri)14 dicembre 2016, di Federico La Sala
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
SCHEDA EDITORIALEEDIZIONI ETS
Una discussione con Alain Caillé sul Manifesto convivialista
A cura di: Francesco Fistetti e Ugo M. Olivieri /
Collana: Boulé. Collana di Filosofia e Scienze umane (15)
Pagine: 146 Formato: cm.14x21 Anno: 2016 ISBN: 9788846743824
Descrizione
Questo libro nasce dalla discussione a più voci dei temi del Manifesto convivialista, riproposti da Alain Caillé nell’intervista a Francesco Fistetti, che insieme con Elena Pulcini ne è uno dei primi firmatari. Al di là delle diverse prospettive intellettuali, gli autori convengono sull’urgenza improcrastinabile di scongiurare, pena la sopravvivenza della vita umana sulla Terra, i disastri imminenti o ormai in atto: ambientali, economici, sociali, morali. Perciò, si tratta di offrire un respiro teorico unitario ai vari movimenti sociali sorti dalla resistenza ad un capitalismo rentier e speculativo, che «è divenuto il nemico principale dell’umanità e del pianeta», e ciò al fine di dare una forma plausibile alle speranze di costruire un mondo comune, frugale e conviviale, che si lasci alle spalle il mito della crescita economica illimitata.
Francesco Fistetti insegna Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari. Dirige la collana «Humanities» presso la casa editrice Pensa Multimedia (Lecce/Brescia) e la collana «L’intreccio» presso l’editore D’Anna (Firenze). È condirettore della rivista «Post-filosofie», fa parte del comitato scientifico della «Revue du M.A.U.S.S». Tra i suoi lavori più recenti: Il Novecento nello specchio dei filosofi (D’Anna, 2013), Chiasmi filosofici tra Europa e America (Pensa Multimedia, 2015), Convivialità. Una filosofia per il XXI secolo (il nuovo melangolo, 2016).
Ugo M. Olivieri insegna Letteratura Italiana all’Università Federico II di Napoli. Tra i suoi interessi il romanzo dell’Ottocento e la teoria della letteratura (Lo specchio e il manufatto, Milano 2013). Ha curato l’edizione di vari classici tra cui I. Nievo, Opere II, 2015 presso l’editore Ricciardi). Lavora da vari anni sul tema del dono ed ha curato con A. Lucarelli, Dono e beni comuni, Napoli, 2013 e con R. Luzzi, Comunità e reciprocità. Il dono nel mondo antico e nelle società tradizionali, Napoli 2014.
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE - "Manifesto convivialista" -- I "purciddhuzzi": i dolci di Natale, l’Unesco, e la cultura. Una nota a margine.15 dicembre 2016, di Federico La Sala
PURCIDDHUZZI
I DOLCI DI NATALE, L’UNESCO, E LA CULTURA. Una nota a margine *
MAGNIFICO: COMPLIMENTI [ALLA FONDAZIONE TERRA D’OTRANTO.]. I caratteristici dolci salentini del Natale: purciddhuzzi e cartiddhate [di Massimo Vaglio] Un articolo sapiente - dal basso all’alto e dall’alto al basso. Tutto ben preparato, e da gustare: dai sapori ai saperi, e viceversa.
Questa è cultura - e coltura!!! Da qui, dal grano e dalla farina (e tutto il resto), dall’agri-coltura alla antropologia, e alla teologia - all’ "istituzione Eucaristica": "Un-esco" formidabile, altrimenti si resta sempre e solo nella caverna!
SENZA GRAZIA (gr.: "CHARIS"), non si esce dall’ "inferno": in giro, non ci sono che mercanti e mercantesse (altro che profeti e sibille: si cfr. Armando Polito, Dalla Sibilla ai "carmati.. http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/09/13/dalla-sibilla-ai-carmati-di-san-paolo-e-allorto-dei-turat/), che pensano a come diventare "nobili" (come certi metalli), con il caro-prezzo e la carestia - e nessun Cristo che sappia e possa istituire Eu-charis-tia!!!
I "purciddhuzzi" e le "cartiddhate" sono proprio dei bei segnavia per un percorso di umanità e solidarietà - e non di dis-umanità e af-far(aon)ismo! - da riprendere e da ripercorre con occhi aperti, innocenti come colombe e prudenti come serpenti (su questo, si cfr. l’art. di Armando Polito, Serpente? Presente! ...http://www.fondazioneterradotranto.it/2016/10/04/serpente-presente/ e le note nella "coda", nel "forum").
Per UNA NUOVA ALLEANZA, LA RICETTA c’è - ci vuole solo la buona volontà ...
PER UN BRILLANTISSIMO NATALE - CON TANTISSIMI STRUFFOLI SU OGNI TAVOLA,
MOLTISSIMI AUGURI
Federico La Sala
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- L’universo a cavallo di un raggio di luce: Mileva Einstein, nata Marić.12 dicembre 2016, di Federico La Sala
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).
- Mileva Einstein, nata Marić - Милева Марић (Titel, 19 dicembre 1875 - Zurigo, 4 agosto 1948), è stata una scienziata serba compagna di studi di Albert Einstein, di cui divenne anche prima moglie (...) Dal 1990 si è aperta la discussione sulla sua partecipazione ai lavori sulla teoria della relatività di Einstein.
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
>NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- IL CANTICO DEI CANTICI. La verità sull’amore (di Silvia Ronchey)6 dicembre 2016, di Federico La Sala
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
- "Amore è più forte di Morte"(Ct., 8.6): Cantico dei cantici, traduzione e cura di Giovanni Garbini, Paideia, Brescia 1992
- SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota
- "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO -
Il Cantico dei cantici
La verità sull’amore nascosta nel più erotico dei libri
Il testo biblico che descrive il desiderio resta un codice segreto. Come dimostrano gli ultimi studi
- “È un enigma” scriveva già Sant’Agostino La sua sacralità andava di pari passo al suo mistero Nel III secolo perse l’originario connotato realistico e diventò allegoria dell’eros mistico
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 06.12.2016)
Di cosa parliamo quando parliamo del Cantico? Questa domanda non può avere risposta. «Il cantico è un enigma», scriveva Agostino (“Sermo” 46, 35). È un mistero nel senso tecnico della parola. L’iniziato non parlerà perché non potrà farlo (“mysterion” da “myein”, «tenere le labbra serrate»). Il profano parlerà, ma non saprà di che parla. «Perché chi sa non parla e chi parla non sa», secondo il detto di Lao Tse.
Ma alla fine del I secolo, quando si formò il canone della bibbia giudaica, il sapiente Rabbi Aqiba disse: «Il mondo intero non vale il giorno in cui il Cantico dei cantici è stato donato a Israele, perché tutte le Scritture sono sante, ma il Cantico dei cantici è il Santo dei santi». Già allora che cosa fosse il Cantico non lo si sapeva né voleva dire: la sua santità era direttamente proporzionale al suo mistero; anzi, era proprio la profondità abissale dei suoi enigmi a sprigionare quel vertice di santità.
«Petali di loto le labbra del mio amato /colano mirra. Il suo inguine è avorio / tempestato di zaffiri. / Favi colanti le tue labbra mia sposa / miele e latte sotto la tua lingua / come incenso del Libano / l’aroma del tuo grembo / giardino chiuso fonte sigillata. / Entri il mio amato nel suo giardino / succhi il suo frutto prodigioso. / Nel mio giardino entravo / mia sorella mia sposa / e la mirra e ogni essenza rapivo / e succhiavo il miele dal favo».
Poemetto di età post-esilica, forse patchwork di canti attinti al patrimonio della tradizione assiro-babilonese ed egizia oltre che ebraica, con echi greco- ellenistici nello stile di Teocrito, il Cantico è indubitabilmente un testo erotico, quasi pornografico.
Nella traduzione latina di Girolamo: Dilectus meus misit manum suam per foramen / et ventrem meus intremuit ad tactum eius. «Il mio amato infila la mano nel mio grembo/ le mie viscere fremono per lui. / Per aprirgli mi alzo /le mie mani colano mirra /dalle dita la mirra fluisce / sul chiavistello che impugno». Secondo la tradizione rabbinica, alcuni brani del Cantico venivano cantati nelle taverne. Si sdegnava Rabbi Aqiba: «Chi canta il Cantico nelle taverne o lo tratta come una canzone profana non avrà posto nel mondo futuro».
Levitò presto l’esegesi anagogica midrashica, gelosamente sacra, del Cantico come celebrazione dell’alleanza sponsale tra JH-WH e Israele, protratta poi nell’interpretazione cristiana che per secoli e secoli vi lesse la figura dell’amore di Cristo per la chiesa, non senza lasciare spazio a una congerie di altri sistemi allegorici minori, spesso iniziatici - astrologici, cabalistici, filosofico- sapienziali -, nella letteratura medievale, rinascimentale e moderna. Sulle ali della metafora della sposa-chiesa i versetti del Cantico si disseminarono nella fonosfera della liturgia, della musica, della letteratura, tramandole come mantra sempre meno dischiusi al senso. Più la torsione simbolica della teologia occidentale sottraeva loro il significato naturale - da Ambrogio a Gregorio Magno, da Guglielmo di Saint-Thierry a Bernardo di Clairvaux, da Francesco di Sales a Bossuet - più le sillabe e le immagini spandevano il loro mistero elementare.
Nigra sum sed formosa.
Da Monteverdi a Giovanni della Croce, da Maupassant a Moreau duemila anni di omissioni hanno addensato connessioni così colossali nel Cantico da renderlo simile all’Aleph di Borges: un punto dello spazio letterario che contiene una pluralità infinita di altri punti. Già il Talmud ammoniva, comunque, a non sottovalutare la letteralità che nessun testo biblico deve mai perdere. I letteralisti o naturalisti sono sempre, a ragione, esistiti: bizantini come Teodoro di Mopsuestia o giudaici come Ibn Ezra. Un grande saggio protestante del Cinquecento, Sébastien Castellion, propose di eliminare il Cantico dal canone dei testi ispirati, in polemica con Calvino; lo seguì Herder. Il Novecento ha visto anche esegeti ecclesiastici cattolici, da Dietrich Bonhoeffer a Luis Alonso Schökel, assaliti dal dubbio: se dietro i versetti del Cantico non ci fosse nulla?
Bisogna intendersi. Il Cantico è nulla. È un prisma trasparente nella cui luce si riflette, moltiplica e illumina qualunque esperienza reale o spirituale, intellettuale o dottrinale vi si accosti. Inoltre, dietro al Cantico c’è il nulla. «In verità, il vuoto del Cantico è lì per confermarne la sacralità. Il Cantico è un pezzo di vuoto sacrale. Dico che è vuoto per non negargli niente», ha scritto Guido Ceronetti.
Almeno quanto l’Ecclesiaste evoca il vuoto e almeno quanto Giobbe il dolore, il Cantico evoca la dolorosa inattingibilità dell’amore. «L’uomo non può capire il Cantico se non ha mai amato», ha scritto Bernardo. Anima mea liquefacta est. Quaesivi, et non inveni illum. Vocavi, et non respondit mihi. «La mia anima si disfa. / Lo cerco e non lo trovo / lo chiamo e non risponde».
Ha scritto Jung: «Mi sono ripetutamente trovato di fronte al mistero dell’amore, e non sono mai stato capace di spiegare cosa sia. Qui si trovano il massimo e il minimo, il più remoto e il più vicino, il più alto e il più basso, e non si può mai parlare dell’uno senza considerare l’altro. Non c’è linguaggio adatto a questo paradosso. Qualunque cosa si possa dire, nessuna parola potrà mai esprimere tutto».
Nessuna parola può esprimere tutto, ma il Cantico, illusionisticamente, lo fa. Se la natura del desiderio è indicibile, il Cantico la dispiega in enigmi. «Mettimi come un sigillo sul tuo cuore / come un tatuaggio sul tuo braccio / perché forte come la morte è l’amore / duro come l’Ade il desiderio ». L’amore è più forte della morte: cosa vuol dire? che l’amore può vincere la morte? che il piacere è una piccola morte? che l’eros è la morte dell’io e ci fa uscire dai suoi confini portando all’insania, come già segnalato da Lucrezio?
«L’eros lo conosciamo solo nella distanza del fallimento. Prima del fallimento non si dà conoscenza », ha scritto Christos Yannaras, massimo esperto contemporaneo del Cantico (alcune delle sue pagine in AA.VV., Il più bel canto d’amore. Letture e riscritture del Cantico dei cantici, Qiqajon, Comunità di Bose, pagg. 231, euro 20, che del Cantico contiene anche la migliore traduzione italiana, di Enzo Bianchi). «Dopo il fallimento sappiamo che l’eros è il modo della vita, ma un modo inaccessibile alla natura umana. Il modo della vita lo palpiamo nella privazione, nel calco dell’assenza ».
La riflessione sull’eros del teologo ortodosso Yannaras conclude oggi il discorso sul Cantico aperto da un altro filosofo greco-orientale, Origene: nel III secolo, quando da poco quell’erma testuale bifronte che esaltava un amore fisico e carnale fino all’oscenità era entrata nel libro sacro a tre religioni e in queste aveva cominciato a porre, o trasporre, il suo enigma. Enfant prodige del platonismo alessandrino, a poco più di vent’anni Origene si era evirato. Aveva, narra Eusebio, troppo da fare coi libri, giorno e notte, e questa era per lui già «una passione e una ginnastica ». Nulla doveva distoglierlo dal comparare e commentare i testi della bibbia. Il suo fu il più grande esperimento di applicazione dell’esegesi allegorica neoplatonica al cristianesimo.
Nel Commento al Cantico, opera della sua maturità, uscito ora in traduzione italiana insieme alle magnifiche Omelie sul Cantico di un altro grande padre greco, Gregorio di Nissa (Origene, Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei cantici, a c. di V. Limone e C. Moreschini, Bompiani, pagg. 1565, euro 50), raccolse l’eredità della ricerca platonica sull’essere e la sua contrapposizione fra anima e corpo, tra metafora e lettera, tra esoterismo e “annuncio”. Sottrasse al Cantico letteralità e fisicità per accenderne l’erotismo metaforico in un modo che nessuno aveva mai osato prima: utilizzandolo in senso psicologico. Col bisturi della filologia neutralizzò la carne degli sposi, per lasciare tutto lo spazio al loro puro spirito. Operò, in un certo senso, come aveva operato sul suo stesso corpo.
L’autoevirazione di Origene, che la tradizione antica riporta, fu reale o simbolica? Di fatto, in uno dei più fantasmagorici trompe l’oeil della letteratura universale, con Origene il Cantico perse per sempre il suo originario connotato realistico per diventare un’allegoria dell’eros mistico, di quell’amore sofferente che sta in ogni atto di ricerca o tentativo di creazione o impulso di unione.
La Sulamita che cerca lo sposo non è solo Israele, secondo l’interpretazione giudaica, e non è solo la chiesa, secondo la versione cristiana vulgata. È in primo luogo l’anima, che secondo la tradizione platonica cerca sempre, e non trova, la perfezione del Logos. Con il Commento al Cantico di Origene il cristianesimo orientale si è fin dall’inizio affiancato agli altri grandi saperi tradizionali nell’esprimere il quaesivi et non inveni, il “cerco e non trovo” che si applica a tutte le sfere dell’indagine, ma anzitutto a quella su noi stessi.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- COSTITUZIONE, REFERENDUM, E SOVRANITA’.3 dicembre 2016, di Federico La Sala
- IL SONNO MORTIFERO DELL’ITALIA. In Parlamento (ancora!) il Partito al di sopra di tutti i partiti.
- SE VADO A CASA DI ZAGREBELSKY E ... COMINCIO A FARE IL MIO COMODO DICENDO DI ESSERE DEL PARTITO "FORZA ZAGREBELSKY", CHE COSA HO FATTO E CHE COSA SONO?! L’ITALIA NON S’E’ DESTATA ED E’ STATA UCCISA!!!
Caro Scalfari, con il Sì passa un’espropriazione di sovranità
di Gustavo Zagrebelsky *
Caro Eugenio Scalfari, ieri mi hai chiamato in causa due volte a proposito del mio orientamento pro-No sul referendum prossimo venturo e, la seconda volta, invitandomi a ripensarci e a passare dalla parte del Sì. La "pessima compagnia", in cui tu dici ch’io mi trovo, dovrebbe indurmi a farlo, anche se, aggiungi, sai che non lo farò. Non dici: "non so se lo farà", ma "so che non lo farà", con il che sottintendi di avere a che fare con uno dalla dura cervice.
I discorsi "sul merito" della riforma, negli ultimi giorni, hanno lasciato il posto a quelli sulla "pessima compagnia". Il merito della riforma, anche a molti di coloro che diconono di votare Sì, ultimo Romano Prodi, appare alquanto disgustoso. Sarebbero piuttosto i cattivi compagni l’argomento principale, argomento che ciascuno dei due fronti ritiene di avere buoni motivi per ritorcere contro l’altro.
Un topos machiavellico è che in politica il fine giustifica i mezzi, cioè che per un buon proposito si può stare anche dalla stessa parte del diavolo. Non è questo. Quel che a me pare è che l’argomento della cattiva compagnia avrebbe valore solo se si credesse che i due schieramenti referendari debbano essere la prefigurazione d’una futura formula di governo del nostro Paese. Non è così. La Costituzione è una cosa, la politica d’ogni giorno un’altra. Si può concordare costituzionalmente e poi confliggere politicamente. Se un larghissimo schieramento di forze politiche eterogenee concorda sulla Costituzione, come avvenne nel ’46-’47, è buona cosa. La lotta politica, poi, è altra cosa e la Costituzione così largamente condivisa alla sua origine valse ad addomesticarla, cioè per l’appunto a costituzionalizzarla. In breve: l’argomento delle cattive compagnie, quale che sia la parte che lo usa, si basa sull’equivoco di confondere la Costituzione con la politica d’ogni giorno.
Vengo, caro Scalfari, a quella che tu vedi come un’ostinazione. Mi aiuta il riferimento che tu stesso fai a Ventotene e al suo "Manifesto", così spesso celebrati a parole e perfino strumentalizzati, come in quella recente grottesca rappresentazione dei tre capi di governo sulla tolda della nave da guerra al largo dell’isola che si scambiano vuote parole e inutili abbracci, lo scorso 22 agosto. C’è nella nostra Costituzione, nella sua prima parte che tutti omaggiano e dicono di non voler toccare, un articolo che, forse, tra tutti è il più ignorato ed è uno dei più importanti, l’articolo 11. Dice che l’Italia consente limitazioni alla propria sovranità quando - solo quando - siano necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Lo spirito di Ventotene soffia in queste parole. Guardiamo che cosa è successo. Ci pare che pace e giustizia siano i caratteri del nostro tempo? Io vedo il contrario. Per promuovere l’una e l’altra occorre la politica, e a me pare di vedere che la rete dei condizionamenti in cui anche l’Italia è caduta impedisce proprio questo, a vantaggio d’interessi finanziario-speculativi che tutto hanno in mente, meno che la pace e la giustizia. Guardo certi sostegni alla riforma che provengono da soggetti che non sanno nemmeno che cosa sia il bicameralismo perfetto, il senato delle autonomie, la legislazione a data certa, ecc. eppure si sbracciano a favore della "stabilità". Che cosa significhi stabilità, lo vediamo tutti i giorni: perdurante conformità alle loro aspettative, a pena delle "destabilizzazioni" - chiamiamoli ricatti - che proprio da loro provengono.
Proprio questo è il punto essenziale, al di là del pessimo tessuto normativo che ci viene proposto che, per me, sarebbe di per sé più che sufficiente per votare No. La posta in gioco è grande, molto più grande dei 47 articoli da modificare, e ciò spiega l’enorme, altrimenti sproporzionato spiegamento propagandistico messo in campo da mesi da parte dei fautori del Sì. L’alternativa, per me, è tra subire un’imposizione e un’espropriazione di sovranità a favore d’un governo che ne uscirebbe come il pulcino sotto le ali della chioccia, e affermare l’autonomia del nostro Paese, non per contestare l’apertura all’Europa e alle altre forme di cooperazione internazionale, ma al contrario per ricominciare con le nostre forze, secondo lo spirito della Costituzione. Si dirà: ma ciò esigerebbe una politica conforme e la politica ha bisogno di forze politiche. E dove sono? Sono da costruire, lo ammetto. Ma il No al referendum aprirà una sfida e in ogni sfida c’è un rischio; ma il Sì non l’aprirà nemmeno. Consoliderà soltanto uno stato di subalternità.
Questa, in sintesi, è la ragione per cui io preferisco il No al Sì e perché considero il No innovativo e il Sì conservativo.
Ti ringrazio dell’attenzione. A cose fatte avremo tempo e modo
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- UOMINI, DONNE, E VIOLENZA. Il femminismo non è morto. L’abbiamo visto in piazza a Roma (di Lea Melandri)29 novembre 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
Il femminismo non è morto. L’abbiamo visto in piazza a Roma
di Lea Melandri *
Valeva la pena aspettare dieci anni per ritrovarci di nuovo in tante e poter dire che siamo un movimento, anche solo per un giorno, e non solo una rete virtuale, anche se le reti ci sono state di aiuto come spinta a uscire dalla carsicità. Confluire in massa in una storica piazza di tutte le proteste, quale è piazza San Giovanni a Roma, è stato sicuramente il modo più felice per rispondere a una ricorrenza, come il 25 novembre, che felice non è.
Una manifestazione come quella di sabato 26, come quelle che si sono succedute da quarant’anni a questa parte, deve darci il coraggio di dire che il femminismo, in tutta la varietà delle sue pratiche, dei suoi gruppi, collettivi, associazioni, ecc... - o forse proprio per questa varietà - è l’unico movimento sopravvissuto agli anni ’70, l’unico che nonostante la messa sotto silenzio, l’ostilità che incontra nel nostro Paese in particolare, non ha mai smesso di riempire le piazze con donne di generazioni diverse, che non ha mai smesso, pur con tante contraddizioni, di ripresentarsi con la radicalità dei suoi inizi.
Non mi soffermerò sulle tante ragioni che ci hanno portato qui. Sulla violenza sappiamo molto, molto abbiamo detto e scritto e analizzato, sia sulle sue forme manifeste - stupri, omicidi, maltrattamenti - sia su quelle meno visibili e perciò più subdole, più ambigue, che passano nella «normalità», nel senso comune, nei gesti e nelle parole della quotidianità, e dell’amore così come lo abbiamo inteso o male inteso finora.
Non si uccide per amore, ma l’amore c’entra, c’entrano quei vincoli di indispensabilità reciproca presenti anche là dove non ce n’è bisogno, c’entra l’infantilizzazione dei rapporti all’interno delle famiglie. Di quanto sia complesso liberarsi di rapporti di potere che si sono confusi con le esperienze più intime, sappiamo molto e molto dovremo ancora scoprire, analizzare.
Ma c’è un altro modo per parlare della violenza, che viene visto meno. È il fatto che da mezzo secolo a questa parte, le donne hanno dato vita a una cultura e a pratiche politiche per contrastare la violenza maschile in tutte le sue forme, a partire da quei segni profondi che ha lasciato dentro di noi, costrette a incorporare quella stessa visione del mondo che ci ha segregate fuori dalla vita pubblica, identificate con la natura, il corpo, la conservazione della specie.
Abbiamo scritto e detto più volte che il sessismo è l’atto di nascita della politica, intendendo con questo sottolineare che il rapporto di potere tra i sessi è l’impianto originario di tutte le oppressioni e disuguaglianze che la storia ha conosciuto. Forse è il momento di dire con chiarezza quello che non siamo più disposte a tollerare:
 che questo patrimonio di sapere, consapevolezze, studi, battaglie vinte venga messo sotto silenzio, lasciato negli archivi e che qualcuno ancora si permetta di dire che il femminismo è morto o silenzioso;
che questo patrimonio di sapere, consapevolezze, studi, battaglie vinte venga messo sotto silenzio, lasciato negli archivi e che qualcuno ancora si permetta di dire che il femminismo è morto o silenzioso;
 che quando interviene una «parola pubblica» a istituzionalizzare pratiche nate dal femminismo, come i consultori, i centri antiviolenza, ciò significhi emarginare le persone che vi hanno dato vita, cancellare l’autonomia delle pratiche che li ha caratterizzati. Mi riferisco al Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere dove i centri antiviolenza finiscono per essere confusi con il Terzo settore, i servizi sociali;
che quando interviene una «parola pubblica» a istituzionalizzare pratiche nate dal femminismo, come i consultori, i centri antiviolenza, ciò significhi emarginare le persone che vi hanno dato vita, cancellare l’autonomia delle pratiche che li ha caratterizzati. Mi riferisco al Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere dove i centri antiviolenza finiscono per essere confusi con il Terzo settore, i servizi sociali;
 che si parli tanto di educazione di genere e si lascino le donne che insegnano, quasi tutte precarie, a dover affrontare campagne denigratorie da parte di presidi e famiglie, rischiare il posto di lavoro, affrontare temi che richiedono una formazione, senza avere la certezza di finanziamenti al riguardo.
che si parli tanto di educazione di genere e si lascino le donne che insegnano, quasi tutte precarie, a dover affrontare campagne denigratorie da parte di presidi e famiglie, rischiare il posto di lavoro, affrontare temi che richiedono una formazione, senza avere la certezza di finanziamenti al riguardo.Siamo qui per dire che non dimentichiamo le donne che la violenza l’hanno subita nella sua forma più selvaggia, ma che non vogliamo più leggere su un giornale o sentire in un commento televisivo che sono «vittime» della passione o della gelosia di un uomo. Sono donne che hanno pagato il prezzo di una affermazione di libertà: quella, inconsueta per un dominio maschile secolare, della donna che dice «Io decido» della mia vita, della mia sessualità, di avere o non avere figli.
Vorrei che ci portassimo a casa questi due bellissimi slogan - «Io decido», «Non una in meno» - per dire che continueremo a batterci contro imposizioni esterne, controlli, divieti, intimidazioni, ma anche per la liberazione da modelli, pregiudizi, leggi non scritte che ci portiamo dentro e che ci impediscono di trovare la forza collettiva di cui abbiamo bisogno. Se non possiamo condividere la varietà delle nostre pratiche, teniamoci almeno disponibili a momenti come questo e forse riusciremo a trovare quei «nessi» che legano la specificità dei nostri interessi, delle nostre esperienze, delle nostre storie.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- A Roma il 26 novembre in piazza. «In Polonia, in Argentina, in Spagna gli scioperi e le proteste delle donne che si ribellano alla violenza e al femminicidio hanno paralizzato interi paesi»22 novembre 2016, di Federico La Sala
Non una di meno. «Adesso basta! Saremo una marea»
26 novembre in piazza. A Roma il 26 per la manifestazione e il 27 per i tavoli sul piano femminista contro la violenza maschile. «In Polonia, in Argentina, in Spagna gli scioperi e le proteste delle donne che si ribellano alla violenza e al femminicidio hanno paralizzato interi paesi»
di Alessandra Pigliaru (il manifesto, 22.11.2016)
Invaderemo le strade di Roma e saremo marea. Lo promettono le realtà promotrici del progetto politico «Non una di meno», Rete IoDecido, D.i.Re - Donne in Rete Contro la violenza, Udi - Unione Donne in Italia, che sabato 26 alle 14 partiranno da Piazza della Repubblica e arriveranno a Piazza San Giovanni per una grande, forte e partecipata manifestazione.
È un percorso perché l’appuntamento di sabato non è da considerarsi occasione isolata a ridosso del 25 novembre, giornata internazionale della violenza contro le donne.
Nelle intenzioni delle protagoniste che in questi mesi si sono riunite in assemblee cittadine per poi confluire nei ragionamenti dell’incontro nazionale (lo scorso 8 ottobre alla Sapienza) c’è un pensiero più lungo. Un fermento plurale che ha molte voci, anche in dissonanza come il femminismo insegna, che contengono in sé molte pratiche.
Sono voci di autodeterminazione, di rabbia, rifiuto ma anche rilievo preciso sul peso di una parola pubblica contro la violenza maschile e il femminicidio.
Come si legge nell’appello alla manifestazione, «è una fenomenologia strutturale che come tale va affrontata». Qualcosa che insomma si fa avanti in quanto dinamica chiara da indagare e scandagliare ancora. Soprattutto per essere detta, discussa, gridata non da vittime - come è nella più retorica e trita rappresentazione - perché non risponde a un’emergenza ma a una misura che si colma ogni volta che una donna viene uccisa o diviene s-oggetto di violenza.
Tantissime le associazioni (proprio ieri anche l’adesione della Cpo del Fnsi, Federazione nazionale stampa italiana), singole e singoli che hanno dato il proprio sostegno in queste ultime settimane preparatorie. Le promotrici, che non gettano alle ortiche i guadagni che il femminismo ha portato all’interno della relazione fra i sessi, né si riconoscono in blocchi identitari, raccontano invece di un ribadire politico che dica che a questo punto, il 26 novembre, in piazza saranno moltissime e moltissimi; una marea di corpi a sostegno della grande e importante manifestazione delle donne.
Come in tutte le fasi preparatorie, si agisce in un terreno che non è mai liscio soprattutto quando a essere affrontato è un tema incandescente che ha al centro dei corpi e le loro differenze.
Nel volantino della manifestazione appare chiara la consapevolezza che in piazza, «senza confini e geografie», si mostrerà una lotta con radici lontane poiché «la violenza maschile sulle donne può essere affrontata solo con un cambiamento culturale radicale, come ci hanno insegnato l’esperienza e la pratica del movimento delle donne e dei Centri Antiviolenza che da trent’anni resistono a ogni tentativo delle istituzioni di trasformarli in centri di accoglienza neutri, negando la loro natura politica e di cambiamento».
Seconda tappa di «Non una di meno» sarà domenica 27 dalle 10 (Scuola Di Donato, via Bixio 83 Roma) per l’assemblea nazionale, con la costituzione di alcuni tavoli e workshop per l’approfondimento e la definizione di un «Piano Femminista contro la violenza maschile» e la discussione dei successivi appuntamenti.
Per maggiori informazioni e adesioni nonunadimeno.wordpress.com
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant --- Governare il mondo o cambiarlo? (di Lea Melandri).22 novembre 2016, di Federico La Sala
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
- CHI SIAMO NOI, IN REALTÀ?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Governare il mondo o cambiarlo?
di Lea Melandri *
- I movimenti delle donne non sembrano esaurire il loro grido e il loro fare con le agende elettorali, perché, tra inevitabili alti e bassi, non rinunciano a ripensare completamente la politica e l’idea stessa di potere. In fondo, come dimostra la vicenda di Hillary Clinton, è evidente che molte donne guardano in primo luogo a coloro che portano visioni della vita davvero diverse, che rimettono al centro le relazioni e i corpi. In questo articolo di Lea Melandri emerge come il femminismo si interroga da tempo su questi temi *
Il femminismo, come disse lucidamente Rossana Rossanda nelle sue conversazioni su Radio Tre alla fine degli anni Settanta (Le Altre, Feltrinelli 1978), era stato il sintomo più evidente della crisi della politica e l’embrione del suo possibile ripensamento. Chi se ne ricorda più? Confrontato con la “persona” e con la vita tutta intera, così come emergevano dall’esplorazione e dai racconti di soggettività restituite finalmente alla storia, il lessico con cui si erano definite fino a quel momento le istituzioni pubbliche appariva per la prima volta in tutta la sua astrattezza.
Inevitabile che, nel sovvertimento di un ordine protrattosi per secoli, che aveva diviso e contrapposto, subordinato secondo criteri gerarchici di complementarità privato e pubblico, corpo e polis, cadesse anche il dilemma che aveva tenuto fino ad allora l’emancipazione femminile nel limbo di una cittadinanza imperfetta: da un lato, battaglie di parità e diritti; dall’altro, pressione per far riconoscere una specificità della condizione della donna - madre, moglie, responsabile dei bisogni della famiglia -, che doveva essere valorizzata socialmente e come tale fatta oggetto di tutela.
Uguaglianza e differenza, alla luce della critica al dualismo sessuale, apparivano non altro che lo specchio di quel potere maschile che aveva creduto di poter confinare nella natura, insieme al destino dell’altro sesso, esperienze cruciali dell’umano. Sono passati alcuni decenni da quando una pratica politica anomala e sorprendente come l’“autocoscienza” ha portato sulla scena pubblica una cultura “antagonista”, ostile a un processo di “integrazione” della donna che avrebbe finito - come si legge già in un documento del Gruppo Demau del 1967 (Daniela Pellegrini) - “per obbligarla a trovare un compromesso tra due sfere definite finora in modo decisamente separatistico”, dal momento che non era in discussione “il suo ruolo primario di riproduttrice sessuale”. (I movimenti femministi in Italia, Savelli 1977)
Dal dibattito su donne e rappresentanza politica, che si è venuto affermando nelle tante realtà associative femminili e femministe presenti nelle città italiane, e di riflesso anche nei media, si ha l’impressione che insieme alla memoria di una straordinaria svolta culturale e di uno sguardo inedito sulle molteplici implicazioni del conflitto tra i sessi, si stia perdendo anche la capacità di vedere i profondi cambiamenti avvenuti nella nostra società, proprio a partire da quelli che negli anni Settanta erano solo segnali sintomatici, avvertimenti, esigenze radicali del presente che si sarebbero sicuramente ripresentate.
Oggi, a fronte di uno svelamento evidente dei legami che ci sono sempre stati tra sessualità e politica, interessi, bisogni e desideri personali e istituzioni - una contaminazione di cui parla l’antipolitica populista, l’aziendalizzazione dello Stato, l’uso privato del denaro pubblico, il declino delle forme tradizionali della partecipazione, il saccheggio che il consumismo sta facendo della vita intima -, colpiscono prese di posizione, riguardo alla volontà delle donne di “contare di più” nei luoghi decisionali del potere, che sembrano riportare indietro il tempo e la coscienza critica creata pazientemente dalla storia del femminismo: considerazioni contrastanti sulla questione donne e politica, ma accomunate da logiche di genere, sia pure con un singolare ribaltamento di parti. Il rimprovero che viene fatto alle femministe è la facilità con cui i loro gruppi continuano a “dividersi, frammentarsi, disgregarsi”, allontanandole dall’obiettivo di una presenza paritaria in politica.
Ciò di cui le donne mancherebbero, per incidere sulla vita pubblica come forza collettiva, sarebbe la “coesione” e la “compattezza” che ha permesso agli uomini di conquistare potere e di spartirselo. Il prezzo, così come viene solitamente descritto, ricorda l’aspetto più deteriore della politica maschile: risparmiare o rinviare a migliore occasione la critica, anche quando si è in disaccordo, sostenere candidati del proprio schieramento anche quando non li si considera idonei al loro ruolo, limitandosi a “detestarli silenziosamente”, rinunciare alla “schiettezza” e alla voglia di esprimere le proprie emozioni, mantenere la distanza “tra l’amore e la civile convivenza”.
Non si può non restare perplessi di fronte a un’idea di convivenza che sembra tutto fuorché “civile”, fatta di reticenze e odi mascherati, ma soprattutto di compattezze costruite sull’irrigidimento di fedeltà e appartenenza, che come sappiamo hanno sempre avuto come contropartita l’esclusione dell’altro, del diverso, vissuto come un pericolo per l’integrità del gruppo.
Per un movimento che ha avviato con tanta chiarezza quarant’anni fa la critica a ogni forma di dualismo - dalle differenze tradizionali di genere alla separazione tra il cittadino e la persona, tra la politica e la vita quotidiana - e la ricerca di “nessi” tra realtà astrattamente contrapposte, è incomprensibile che si possa cancellare la storia di secoli nell’analisi del comportamento femminile, o ignorare i cambiamenti che sono intervenuti tra privato e pubblico, famiglia e Stato, ruolo maschile e femminile, e le risposte che la cultura femminista nella sua radicalità può dare agli interrogativi del presente, come ripensamento della politica, della rappresentanza, dell’idea stessa di potere.
*-*** Saggista, scrittrice e giornalista, Lea Melandri ha diretto per molti anni la rivista “L’erba voglio” ed è un punto di riferimento del movimento delle donne. Altri suoi articoli sono leggibili qui. Ha aderito alla campagna 2016 Facciamo Comune insieme. È tra le autrici del quaderno Ci vuole il tempo che ci vuole (edizioni Comune). L’articolo di questa pagina è apparso per la prima volta su Gli Altri nell’aprile 2012)
* Comune-info, 13 novembre 2016 (ripresa parziale).
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE -- DOPO LA VERITA’. Per dizionario Oxford ’post-verità’ è parola del 2016.17 novembre 2016, di Federico La Sala
- LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO E IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE. PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA E DELLA TEOLOGIA POLITICA DI "MAMMONA" E DI "MAMMASANTISSIMA" - E DEL SUO "SUPERUOMO". L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" DEI "VISONARI" DELLA TEOLOGIA POLITICA ATEA E DEVOTA.
- FOUCAULT, HADOT, PROSPERI, VATTIMO. L’ "addio alla verità" degli antichi e la coraggiosa proposta della carità ("charitas"), oggi. Materiali sul tema
Per dizionario Oxford ’post-verità’ è parola del 2016
Scelta fatta sullo sfondo di elezioni Usa e referendum Brexit
di Redazione Ansa *
LONDRA E’ ’post verità’, in inglese ’post-truth’, il neologismo dell’anno secondo gli esperti di Oxford Dictionaries. La scelta e’ quella di un’espressione che secondo un comitato di esperti ha segnato profondamente la scena politica internazionale durante il 2016, con riferimento in particolare alle polemiche legate alla campagna referendaria britannica sfociata a giugno nella vittoria della Brexit (il divorzio dall’Ue) e a quella americana per le presidenziali appena culminata nel trionfo di Donald Trump.
L’annuncio è arrivato in queste ore, riporta la Bbc: ’post-truth’ ha prevalso in una short list finale che comprendeva anche termini come ’Brexiteer’ (sostenitore della Brexit). Si tratta, ha sentenziato Casper Grathwohl, fra i curatori dei prestigiosi dizionari editi a Oxford, "di una di quelle parole che definiscono il nostro tempo".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI"DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. - La società a una dimensione: elezioni Usa. Quelle urne sommerse da sessismo e razzismo (di Judith Butler)10 novembre 2016, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT):
- UNA DOMANDA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
- SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH. LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
- L’abbraccio di Hillary e Bush La foto che può turbare la campagna elettorale [14 marzo 2016]
- http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_marzo_14/abbraccio-hillary-bush-foto-che-puo-turbare-campagna-elettorale-0af58d74-e9e6-11e5-9549-2d2df3bd31ee.shtml
- È la foto che in queste ore sta facendo il giro della rete e che potrebbe avere rilevanti conseguenze sulla campagna elettorale dei democratici. Siamo ai funerali di Nancy Reagan e lo scatto ritrae un abbraccio e due facce sorridenti. I protagonisti, però, sono l’ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, repubblicano doc, e la candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton. Una foto che, in piena campagna elettorale, non passerà certo inosservata (Foto tratta dal profilo @DavidChalian su Twitter)
- Stati Uniti: l’abbraccio «materno» di Michelle Obama a George W. Bush scatena la Rete [25 settembre 2016]
- http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_settembre_25/stati-uniti-l-abbraccio-materno-michelle-obama-george-w-bush-scatena-rete-124c290c-833d-11e6-879e-4c7914542a03.shtml
- L’immagine c’è da ammetterlo non è di quelle più consuete: la first lady Michelle Obama che abbraccia l’ex presidente americano George W. Bush. Succede all’inaugurazione del primo museo della storia afroamericana a Washington. Presenti appunto l’ex capo di Stato Usa con la moglie, e Obama con Michelle. E durante la cerimonia, ecco che i fotografi immortalano l’abbraccio di lei a Bush. Immagine che rimbalza subito in Rete e scatena ironia e fotomontaggi. (Afp)
Quelle urne sommerse da sessismo e razzismo
Elezioni Usa. Un commento inedito della filosofa statunitense a proposito dell’elezione presidenziale di Donald Trump. «Con quali condizioni abbiamo a che fare se l’odio più scatenato e la più sfrenata smania di militarizzazione riescono a ottenere il consenso della maggioranza?»
di Judith Butler (il manifesto, 10.11.2016)
Due sono le domande che gli elettori statunitensi che stanno a sinistra del centro si stanno ponendo. Chi sono queste persone che hanno votato per Trump? E perché non ci siamo fatti trovare pronti, davanti a questo epilogo? La parola «devastazione» si approssima a malapena a ciò che sentono, al momento, molte tra le persone che conosco. Evidentemente non era ben chiaro quanto enorme fosse la rabbia contro le élites, quanto enorme fosse l’astio dei maschi bianchi contro il femminismo e contro i vari movimenti per i diritti civili, quanto demoralizzati fossero ampi strati della popolazione, a causa delle varie forme di spossessamento economico, e quanto eccitante potesse apparire l’idea di nuove forme di isolamento protezionistico, di nuovi muri, o di nuove forme di bellicosità nazionalista. Non stiamo forse assistendo a un backlash del fondamentalismo bianco? Perché non ci era abbastanza evidente?
Proprio come alcune tra le nostre amiche inglesi, anche qui abbiamo maturato un certo scetticismo nei riguardi dei sondaggi. A chi si sono rivolti, e chi hanno tralasciato? Gli intervistati hanno detto la verità? È vero che la vasta maggioranza degli elettori è composta da maschi bianchi e che molte persone non bianche sono escluse dal voto? Da chi è composto questo elettorato arrabbiato e distruttivo che preferirebbe essere governato da un pessimo uomo piuttosto che da una donna? Da chi è composto questo elettorato arrabbiato e nichilista che imputa solo alla candidata democratica le devastazioni del neoliberismo e del capitalismo più sregolato?
È dirimente focalizzare la nostra attenzione sul populismo, di destra e di sinistra, e sulla misoginia - su quanto in profondità essa possa operare.
Hillary viene identificata come parte dell’establishment, ovviamente. Ciò che tuttavia non deve essere sottostimata è la profonda rabbia nutrita nei riguardi di Hillary, la collera nei suoi confronti, che in parte segue la misoginia e la repulsione già nutrita per Obama, la quale era alimentata da una latente forma di razzismo.
Trump ha catalizzato la rabbia più profonda contro il femminismo ed è visto come un tutore dell’ordine e della sicurezza, contrario al multiculturalismo - inteso come minaccia ai privilegi bianchi - e all’immigrazione. E la vuota retorica di una falsa potenza ha infine trionfato, segno di una disperazione che è molto più pervasiva di quanto riusciamo a immaginare.
Ciò a cui stiamo assistendo è forse una reazione di disgusto nei riguardi del primo presidente nero che va di pari passo con la rabbia, da parte di molti uomini e di qualche donna, nei riguardi della possibilità che a divenire presidente fosse proprio una donna? Per un mondo a cui piace definirsi sempre più postrazziale e postfemminista non deve essere facile prendere atto di quanto il sessismo e il razzismo presiedano ai criteri di giudizio e consentano tranquillamente di scavalcare ogni obiettivo democratico e inclusivo - e tutto ciò è indice delle passioni sadiche, tristi e distruttive che guidano il nostro paese.
Chi sono allora quelle persone che hanno votato per Trump - ma, soprattutto, chi siamo noi, che non siamo state in grado di renderci conto del suo potere, che non siamo stati in grado di prevenirlo, che non volevamo credere che le persone avrebbero votato per un uomo che dice cose apertamente razziste e xenofobe, la cui storia è segnata dagli abusi sessuali, dallo sfruttamento di chi lavorava per lui, dallo sdegno per la Costituzione, per i migranti, e che oggi è seriamente intenzionato a militarizzare, militarizzare, militarizzare? Pensiamo forse di essere al sicuro, nelle nostre isole di pensiero di sinistra radicale e libertario? O forse abbiamo semplicemente un’idea troppo ingenua della natura umana? Con quali condizioni abbiamo a che fare se l’odio più scatenato e la più sfrenata smania di militarizzazione riescono a ottenere il consenso della maggioranza?
Chiaramente, non siamo in grado di dire nulla a proposito di quella porzione di popolazione che si è recata alle urne e che ha votato per lui. Ma c’è una cosa che però dobbiamo domandarci, e cioè come sia stato possibile che la democrazia parlamentare ci abbia potuti condurre a eleggere un presidente radicalmente antidemocratico. Dobbiamo prepararci a essere un movimento di resistenza, più che un partito politico. D’altronde, al suo quartier generale a New York, questa notte, i supporter di Trump rivelavano senza alcuna vergogna il proprio odio esuberante al grido di «We hate Muslims, we hate blacks, we want to take our country back».
 (traduzione di Federico Zappino)
(traduzione di Federico Zappino)-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. - Do not agonize: Organize! La parola chiave è ri-radicallizzarsi, per una vuova prassi politica.11 novembre 2016, di Federico La Sala
- UN UOMO PIÙ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO: LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
Do not agonize: Organize!
Elezioni Usa. Un commento inedito della filosofa e femminista Rosi Braidotti. «Sì, la parola chiave è ri-radicallizzarsi.- superare questa sconfitta traumatica, imparare dai nostri errori e dagli errori altrui per sviluppare una nuova prassi politica»
di Rosi Braidotti (il manifesto, 11.11.2016)
«È nostro dovere - scriveva Viginia Woolf in Le Tre Ghinee - pensare: che società è questa in cui ci troviamo a vivere? Cosa significano queste cerimonie e perché dovremmo prendervi parte?» Non dobbiamo mai smettere di chiederci che prezzo siamo disposte a pagare per fare parte di questa civiltà e delle istituzioni al maschile che la sostengono. Queste parole risuonano oggi con rinnovato vigore.
Bisogna sempre pensare contro il proprio tempo, soprattutto ora che ci troviamo a raccogliere i pezzi di un sogno infranto: la prima donna eletta alla presidenza degli Stati Uniti. Come ha scritto Donna Haraway su Facebook: «Sì ho pensato che avremmo lottato insieme nel contesto dell’amministrazione neoliberale e parzialmente progressista di Clinton. Ho pensato che il cambiamento climatico e l’estinzione e tante altre cose sarebbero rimasti temi centrali. Devono esserlo ancora. Ma ora dovremmo unirci per combattere fascismo, razzismo scatenato, misoginia, antisemitismo, islamofobia, anti-immigrazione, e molto altro. Sento il cuore spezzarsi e ri-radicalizzarsi».
Sì, la parola chiave è ri-radicalizzarsi - superare questa sconfitta traumatica, imparare dai nostri errori e dagli errori altrui per sviluppare una nuova prassi politica.
Derrida, d’altro canto, ricorda il carattere suicida della democrazia. Partirei dalla consapevolezza che la democrazia in sé non ci salverà, non in una fase storica di ascesa di nuovi populismi. Negli anni Trenta del XX secolo, l’epoca di Virginia Woolf, si è votato «democraticamente» per i partiti nazional-socialisti, che hanno poi affossato le libertà più basilari e commesso immani atrocità. La ripetizione di questi fenomeni induce a chiedersi perché la democrazia rappresentativa non sia capace di sviluppare anticorpi verso gli elementi reazionari. Penso ovviamente all’uso strumentale che del referendum è stato fatto in Gran Bretagna, Olanda e Italia.
La vittoria di un misogino, incapace, maschilista e pericoloso razzista quale è Trump rende più che mai evidente la vulnerabilità e i limiti della democrazia rappresentativa. Assistiamo a un re-imporsi delle retoriche razziste della politica dell’emergenza e della crisi, Trump ha marciato proprio sul senso di insicurezza diffuso tra le classi meno abbienti americane. All’alba del Terzo millennio Bush aveva una strategia simile. Certo il ritorno in auge del populismo presenta importanti elementi di novità, da indagare con urgenza.
Tutti i populismi - che siano di destra o di sinistra - si equivalgono. A destra, gli appelli astratti alla nozione sacralizzata di autenticità culturale hanno sostituito le retoriche del sangue e del suolo. A sinistra, le classi devastate da declino economico e austerità hanno autorizzato l’espressione pubblica della rabbia dei bianchi - per lo più uomini: whitelash, colpo di ritorno dei bianchi.
Comportandosi come un’etnia urbana in pericolo di estinzione, producono forme virulente di populismo ultra-nazionalista. Fanno del loro senso di vulnerabilità un vero cavallo di battaglia - come se le sole ferite che contano fossero le loro. Queste ferite inflitte alle classi più vulnerabili sono state interpretate come disincanto politico post-ideologico, ma non si può dire che il populismo di sinistra non sia altrettanto misogino e xenofobo. Io mi oppongo fermamente ad entrambe le versioni: tutti i populismi ruotano attorno al perno della supremazia maschile e della bianchezza. Basti considerare il sostegno entusiasta che un intellettuale come Žižek ha prestato a Trump nei giorni cruciali prima delle elezioni americane. La misoginia di Žižek è nota, tuttavia stavolta si è svenduto alle destre e dovrebbe essere ritenuto responsabile per una tale deriva.
Certo, la sinistra ha enormi responsabilità: è anche grazie agli errori dei precedenti leader e delle vecchie coalizioni «democratiche» che i repubblicani hanno vinto. D’altra parte, il populismo di destra di personaggi quali Trump e Johnson è una forma così palese di manipolazione da risultare nauseante, si esercita sulle persone più colpite da ristrettezze economiche.
Questi manipolatori usano i/le migranti e tutte le soggettività «altre» come capri espiatori. Appellarsi a tali leader nazionalisti significa riprodurre quello che Deleuze e Guattari chiamavano micro-fascismo. E i micro-fascisti sono a destra tanto quanto a sinistra.
Sul piano filosofico, non posso fare a meno di interpretare queste elezioni attraverso il Nietzsche di Deleuze: siamo nel regime politico della «post-verità», alimentato da passioni negative quali risentimento, odio e cinismo. In quanto docente ritengo che il mio compito risieda nel combattere con gli strumenti critici del pensiero, dell’insegnamento, ma anche della resistenza politica: non solo nelle aule, ma nella sfera pubblica.
In quanto filosofa ritengo necessario portare avanti una critica dei limiti della democrazia rappresentativa, a partire dallo spinozismo critico e dall’esperienza storica dei femminismi. Non possiamo fermarci all’antagonismo, non è sufficiente la fede nella dialettica della storia, dobbiamo elaborare una politica dell’immanenza e dell’affermazione, che richiede cartografie politiche precise dei rapporti di potere dai quali siamo attraversate/i. Abbiamo bisogno di ri-radicalizzare in primis noi stesse/i.
Nel mio lavoro ho sempre sostenuto che l’afflizione e la violenza conducono all’immobilismo, non sono foriere di cambiamento. All’indomani della vittoria di Trump ne sono ancora più convinta: occorre mettersi alla ricerca di forme di opposizione costituenti, capaci di dar vita a politiche concrete. Non nego che il processo in corso sia doloroso e difficile. Tuttavia, come ha sostenuto Hillary Clinton, la rabbia non è un progetto, va trasformata in potenza di agire, organizzata, indirizzata non solo «contro», ma anche «per».
Risulta chiaro a tutte/i che Trump è il baratro di negatività della nostra epoca, che avevamo bisogno di tutto meno che della sua vittoria. Mi permetto però di chiedere: e poi? Siamo contro l’alleanza tra neolibersimo e neofondamentalismo che Trump oggi, come Bush ieri, incarna a pieno. Dobbiamo però accordarci su cosa vogliamo, cosa desideriamo costruire insieme come alternativa. Dobbiamo capire chi e quante/i siamo «noi».
La risposta, e la reazione a questi fenomeni, passa attraverso la composizione collettiva di pratiche collegate all’etica dell’affermazione di alternative condivise e situate. Quello delle passioni negative non è il linguaggio che propongo come antidoto all’avvelenamento dei nostri legami sociali. Pertanto mi chiedo: siamo capaci di immaginare pratiche e teorie politiche affermative, di creare orizzonti sociali di resistenza? Di che strumenti ci dotiamo per non arrenderci al nichilismo e all’individualismo?
Abbiamo dalla nostra parte parte potenti etiche politiche: da Spinoza a Haraway, da Foucault a Deleuze. Abbiamo pratiche all’altezza della sfida: dalle Riot Grrrl alle Pussy Riot, passando per le cyborg-eco-femministe e le attiviste antirazziste e antispeciste, innumerevoli irriverenti e cattive ragazze rivendicano autodeterminazione, creano nuovi immaginari e nuove forme di affettività. Muse ispiratrici per modelli di soggettività alternativi a quelli costruiti sull’isolamento, queste cattive ragazze ci insegnano che le modalità di resistenza alle violenze e alle contraddizioni del presente viaggiano di pari passo alla creazione di stili di vita in grado di sostenere i desideri di trasformazione.
Forse in Italia vedremo questa potenza politica nelle piazze il 26 novembre. Ed è forse giunto il momento che la sinistra impari dal pensiero e dalle pratiche femministe, dai movimenti antirazzisti e ambientalisti. È inaccettabile che nel 2016 come nel 1966 i sedicenti intellettuali di sinistra sminuiscano il portato delle nostre lotte riducendole a politiche identitarie. È tempo di ri-radicalizzare la sinistra mostrandole gli effetti del suo stesso sessismo e della sua negazione della politica affermativa femminista.
(traduzione di Angela Balzano)
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE --- Gesù rese libera la Donna. Censurata per secoli dalla Chiesa la parabola dell’adultera (di Enzo Bianchi).8 novembre 2016, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO:
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO.
- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
- CIVILTA’ DELL’AMORE E VOLONTA’ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica di papa Ratzinger
Quando Gesù rese libera la Donna
Censurata per secoli dalla Chiesa la parabola dell’adultera rivela tutta la misericordia divina. Perché Cristo difende anche la figura femminile dalla violenza del mondo maschile
di Enzo Bianchi priore della comunità monastica di Bose *
- IL LIBRO Gesù e le donne di Enzo Bianchi (Einaudi pagg. 136 euro 17)
Gesù andò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio, e tutto il popolo veniva da lui; e sedutosi, insegnava loro. Ora, gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala in mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu dunque che ne dici?».
Dicevano questo per metterlo alla prova, per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi giù, scriveva per terra con il dito. Ma poiché continuavano a interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma essi, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Ora, Gesù, alzatosi, le disse:
 «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ella disse: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno. Va’ e d’ora in poi non peccare più».
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ella disse: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno. Va’ e d’ora in poi non peccare più».
 Questo brano ha conosciuto una sorte particolarissima, che attesta il suo carattere scandaloso e imbarazzante: è stato infatti “censurato” dalla Chiesa!
Questo brano ha conosciuto una sorte particolarissima, che attesta il suo carattere scandaloso e imbarazzante: è stato infatti “censurato” dalla Chiesa!
 È assente nei manoscritti più antichi, è ignorato dai padri latini fino al IV secolo, per cinque secoli non è stato proclamato nella liturgia e non ci sono commenti a esso da parte dei padri greci del primo millennio. Al termine di un lungo e travagliato migrare tra i manoscritti è stato inserito nel vangelo secondo Giovanni, dopo il settimo capitolo e prima del versetto 15 dell’ottavo.
È assente nei manoscritti più antichi, è ignorato dai padri latini fino al IV secolo, per cinque secoli non è stato proclamato nella liturgia e non ci sono commenti a esso da parte dei padri greci del primo millennio. Al termine di un lungo e travagliato migrare tra i manoscritti è stato inserito nel vangelo secondo Giovanni, dopo il settimo capitolo e prima del versetto 15 dell’ottavo.Non è una scena insolita: spesso i vangeli annotano che gli avversari di Gesù tentano di metterlo in contraddizione con la Legge di Dio, per poterlo accusare di bestemmia, di disobbedienza al Dio vivente. A quegli scribi e farisei, in realtà, non importava nulla della donna, per loro era importante trovare motivi di condanna contro Gesù: non volevano lapidare l’adultera, ma far lapidare Gesù! Questi uomini religiosi fanno irruzione nell’uditorio di Gesù, portano davanti a lui una donna sorpresa in flagrante adulterio, la collocano in mezzo a tutti e si affrettano a dichiarare: «Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa».
Tale dichiarazione sembra formalmente ineccepibile, perché cita la Legge; a uno sguardo attento, però, si coglie che il loro ricorso alla Torah è parziale. La Legge, infatti, prevedeva la pena di morte per entrambi gli adulteri e attestava la stessa pena, mediante lapidazione, mentre se erano già sposati allora si ricorreva allo strangolamento. Resta però altamente significativo che solo lei sia stata catturata e portata davanti a Gesù, mentre l’uomo che ha commesso adulterio con lei, e secondo la Legge è colpevole come lei, non risulta né imputato né condotto in giudizio!
Cerchiamo di sostare per un momento su questa scena. Ci sono alcuni che hanno portato a Gesù una donna, perché sia condannata. Ma Gesù inizia a rispondere agli accusatori parlando con il corpo, non con parole: si china, abbassandosi, rompe il cerchio della «violenza mimetica » (René Girard), spezza il faccia a faccia con quei farisei e si mette a scrivere per terra, in assoluto silenzio.
Dalla posizione di chi è seduto passa a quella di chi si china verso terra; di più, in questo modo si inchina di fronte alla donna che è in piedi davanti a lui! Poiché però gli accusatori insistono nell’interrogarlo, dopo quel lungo e per loro fastidioso silenzio riempito solo dal suo mimo profetico, Gesù si alza e non risponde direttamente alla questione postagli, ma fa un’affermazione che contiene in sé anche una domanda: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei».
Poi si china di nuovo e torna a scrivere per terra. Così una parola di Gesù, una parola sola ma incisiva (al punto da essere divenuta proverbiale) e autentica, una di quelle domande che ci scuotono e ci fanno leggere in profondità noi stessi, impedisce a quegli uomini di fare violenza in nome della Legge. Solo Dio, e quindi solo Gesù, potrebbe condannare quella donna.
Ebbene, qui Gesù - mi si permetta di dire - “evangelizza” Dio, cioè rende Dio Vangelo, buona notizia per quella donna. Gesù, l’unico uomo che ha raccontato in pienezza di Dio, che ne è stato l’esegesi vivente, afferma che di fronte al peccatore, alla peccatrice, Dio ha un solo sentimento: non la condanna, non il castigo, ma il desiderio che si converta e viva. Gesù, inviato da Dio «non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo» anche qui agisce come aveva annunciato all’inizio del suo ministero: «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Solo quando tutti se ne sono andati egli si alza in piedi e sta di fronte alla donna. Lei, posta lì in piedi in mezzo a tutti, ora è finalmente restituita alla sua identità di donna e vede Gesù in piedi davanti a sé: così è possibile l’incontro vero.
Infine, Gesù conclude questo incontro con un’affermazione straordinaria: «Neanch’io ti condanno. Va’ e d’ora in poi non peccare più». Sono parole assolutamente gratuite e unilaterali. Ecco la gratuità di quella assoluzione: Gesù non condanna, perché Dio non condanna, ma con questo suo atto di misericordia preveniente offre a quella donna la possibilità di cambiare.
Non sappiamo se questa donna perdonata dopo l’incontro con Gesù abbia cambiato vita; sappiamo solo che, affinché cambiasse vita e tornasse a vivere, Dio, che non vuole la morte del peccatore, l’ha perdonata attraverso Gesù e l’ha inviata verso la libertà: «Va’, va’ verso te stessa e non peccare più»... Le persone religiose vorrebbero che a questo punto Gesù avesse detto alla donna: «Ti sei esaminata? Sai cosa hai fatto? Ne comprendi la gravità? Sei pentita della tua colpa? La detesti? Prometti di non farlo più? Sei disposta a subire la giusta pena?». Queste omissioni nelle parole di Gesù scandalizzano ancora, oggi come ieri!
Nessuna condanna, solo misericordia: qui sta la grandezza e l’unicità di Gesù. Questo incontro tra Gesù e la donna sorpresa in adulterio non ci rivela solo la misericordia di Gesù, ma anche la sua capacità di difendere la donna da un cerchio di uomini, sempre pronti a giustificare se stessi e a condannare le donne. Purtroppo tutta la storia dei credenti, dell’antica come della nuova alleanza, testimonierà questo «occhio spione, esigente e condannante» degli uomini religiosi nei confronti delle donne, ritenute colpevoli per la loro condizione - dicono gli uomini - di creature sempre tentatrici e facili alla tentazione. Questo esempio di Gesù sarà poco compreso e ancor meno vissuto, ma sarà comunque memorizzato nel vangelo e vi saranno sempre lettori che vi troveranno una buona notizia.
* la Repubblica, 08.11.2016
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) - «La Politica e altri scritti»: Walter Benjamin, la felicità profana degli uomini26 ottobre 2016, di Federico La Sala
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI. Note per una rilettura del "De vulgari eloquentia" e della "Monarchia"
Walter Benjamin, la felicità profana degli uomini
«La Politica e altri scritti» di Walter Benjamin, a cura di Dario Gentili
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 26.10.2016)
Filosofo dei frammenti, e del loro montaggio, Walter Benjamin ha fatto di necessità virtù. La sua esistenza nomade, alla prese con una precarietà che non ha nulla da invidiare alla nostra, si è conclusa in fuga dai nazisti con un tragico suicidio. Un’esistenza costellata di illuminazioni e anticipazioni sulle quali si continua ancora a riflettere. L’ultimo caso è quello della «Politica»: sin da giovane il filosofo aveva concepito un’opera organica di cui si conoscono frammenti notissimi come Sulla critica della violenza, pubblicata nel 1921.
La Politik è al centro di una discussione intensa almeno quanto le discussioni sulla valigetta che Benjamin portava sempre con sé e che si pensa custodisse il suo ultimo lavoro, un libro a cui il filosofo diceva di tenere più che alla sua vita. Oggi non è possibile ricostruirla completamente, ma dai frammenti emergono lampi significativi. È questo il tema de La politica e altri scritti (Mimesis, pp.122, euro 12), un volume per il quale il curatore Dario Gentili ha scelto un filo conduttore che, pur non rispettando la disposizione dei materiali nell’opera completa, permette di organizzarli secondo un ordine tematico e cronologico. Per ricostruire il senso di questa opera incompiuta è decisiva la corrispondenza con l’amico e filosofo Gershom Scholem. In questi scritti Benjamin lega la «verità» all’opera «comune» che gli uomini possono fare insieme. A differenza di una lunga tradizione iniziata con Weber, il politico non è una personalità o individualità, ma si dà nella radicale immanenza dell’opera comune degli uomini. In questo consiste la loro felicità profana.
La politica, nella sua caducità, non aderisce a ciò che esiste, ma adempie a un compito messianico. Accompagnato da visioni materialistiche, il messianesimo comunista di Benjamin procede in senso inverso rispetto alla teologia e alla volontà di rappresentare il Regno di Dio sulla Terra. Tra l’anarchismo giovanile e la stagione marxista della maturità la distanza è notevole, ma esistono alcune costanti.
In questa raccolta di frammenti emergono due idee che Benjamin ha coltivato ancor prima di scoprire il materialismo: la rivoluzione è «innervazione degli organi tecnici della collettività» e «scassinare la teleologia naturale». Concetti che ribaltano molte versioni del materialismo che ha ignorato il fatto che la tecnologia è un fenomeno sociale e incarnato nella forza lavoro. Per non parlare della filosofia della storia che ha legato il comunismo alla teleologia naturale. Per Benjamin nulla è irreversibile, la tecnica è una questione politica, la politica si dà quando l’azione non ha uno scopo finale, ma è l’espressione di una felicità comune.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI".. DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Il pensiero "critico" e l’Italia, Repubblica popolare fondata sull’asineria.24 ottobre 2016, di Federico La Sala
- CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
- INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE
- IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO NELLA CAVERNA DI IERI E DI OGGI.
IL PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEL MIUR
Educare al pensiero critico
di Gaspare Polizzi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 23 Ottobre 2016)
Lunedì 3 ottobre è stato presentato al Miur il Piano nazionale di formazione degli insegnanti. Il Ministro Stefania Giannini lo ha illustrato dopo gli interventi di Andreas Schleicher, Direttore del Directorate of Education dell’Ocse, Jordan Naidoo, Direttore della Divisione Education 2030 Support and Coordination dell’Unesco, Oon Seng Tan, Direttore dell’ Institute of Education di Singapore. Il Piano prevede un investimento di 325 milioni di euro per la formazione in servizio degli insegnanti, che diventa - come previsto dalla legge 170/2016, art. 1, comma 124 - «obbligatoria, permanente e strutturale». Sarà presto adottato con decreto del Ministro e sarà subito operativo. Se a queste risorse si aggiunge il miliardo e 100 milioni della Carta del Docente, si arriva a un totale di 1,4 miliardi stanziati nel triennio 2016/2019 per la formazione del corpo insegnante. Non ci sono precedenti per un impegno di spesa simile del Miur per valorizzare la crescita professionale dei docenti.
Saranno coinvolti nel Piano di formazione tutti i docenti di ruolo, circa 750mila. Nove le priorità tematiche: tre riguardano le competenze di sistema (Autonomia didattica e organizzativa, Valutazione e miglioramento, Didattica per competenze e innovazione metodologica), le altre sei mirano all’innovazione (Lingue straniere, Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, Scuola e lavoro) e all’inclusione (Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, Inclusione e disabilità, Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile). La qualità dei percorsi sarà assicurata attraverso nuove procedure di accreditamento a livello nazionale dei soggetti erogatori che consentiranno anche di monitorare gli standard offerti. Sarà fatto un investimento specifico sulla ricerca in questo campo, pari a tre milioni di euro, per favorire il finanziamento, la raccolta e diffusione delle migliori startup formative. Le «buone pratiche» formative, saranno raccolte, a cura dell’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa), in una «biblioteca delle innovazioni».
I tre prestigiosi relatori internazionali hanno variamente sottolineato limiti e potenzialità del sistema italiano di istruzione. Schleicher, a nome dell’OCSE, ha illustrato un triangolo perfetto della professionalità docente, ai vertici del quale si trovano l’autonomia, ovvero il potere decisionale dei docenti sul proprio lavoro, la base di conoscenze per l’insegnamento, le opportunità di sostegno e confronto necessarie per mantenere elevati standard di qualità. Nel caso italiano il triangolo è squilibrato perché a una dose elevata di autonomia fanno riscontro basse opportunità di confronto tra docenti e una ridotta base di conoscenze specifiche. È evidente che la formazione si gioca in Italia sulle conoscenze funzionali alla didattica e sulla capacità di dialogare e lavorare in gruppo.
Il ministro Stefania Giannini ha dichiarato che «siamo davanti ad un cambio di paradigma culturale: da oggi ciascun docente sarà inserito in un percorso di miglioramento lungo tutto l’arco delle sua vita professionale. Abbiamo immaginato la formazione in servizio come un ambiente di apprendimento permanente, un sistema di opportunità di crescita costante per l’intera comunità scolastica”. Il Ministro ha posto una particolare enfasi sulla centralità della didattica per competenze, che afferisce agli aspetti strategici del sistema.
Non a caso la svolta impressa dal PNF è stata sottolineata da Tan, Direttore dell’Institute of Education di Singapore, Paese all’avanguardia mondiale nei sistemi educativi: «il lancio di questo Piano rappresenta per l’Italia un traguardo importante nelle politiche di miglioramento del sistema scolastico. Il Piano farà crescere la qualità dell’insegnamento e avrà ricadute positive su scuole e studenti». Tan ha sottolineato la cura che a Singapore si dedica all’apprendimento cooperativo dei docenti, che ridiventano di buon grado studenti disposti in classi di apprendimento gestite da maestri riconosciuti. L’insegnamento collaborativo si realizza grazie alla disponibilità dei docenti a seguire un apprendimento collettivo secondo i criteri del life long learning.
Viene da pensare alla convergenza tra il «nuovo paradigma» della formazione degli insegnanti e lo straordinario impegno profuso dal Sole 24 Ore per l’attuazione del «Manifesto della Cultura», nel quale si sostiene tra l’altro che «l’azione pubblica deve contribuire a radicare a tutti i livelli educativi, dalle elementari all’università, lo studio dell’arte e della storia, non disgiunto dalla formazione di una mentalità scientifica e antidogmatica, per rendere i giovani i custodi del nostro patrimonio, e per poter fare in modo che essi ne traggano alimento per la creatività del futuro, formando nel contempo i giovani ad una cultura del merito, che deve attraversare tutte le fasi educative». Gli Stati Generali della Cultura, che quest’anno celebrano la loro quinta edizione, sono imbevuti della medesima volontà di cambiare il paradigma dell’istruzione e della cultura, nella convinzione che soltanto su queste nuove basi potrà avvenire la rinascita del Paese.
Su un punto, in particolare, il PNF può convergere con un obiettivo concreto degli Stati Generali della Cultura: l’esercizio del pensiero critico. Il dossier Ocse 2015 su scuola e università (Education at a Glance) segnala che l’Italia registra uno dei punteggi più bassi in termini di lettura e comprensione (literacy) dei 25-34enni, titolari di un diploma universitario e il dato si riflette sulle competenze logico-linguistiche degli insegnanti, e degli studenti, ostacolando anche il pieno sviluppo dell’educazione alla cittadinanza. Il potenziamento delle competenze logiche e argomentative permette l’esercizio di pratiche di ragionamento volte alla risoluzione dei problemi e in quanto tale è aspetto formativo strategico. Ne possono derivare significativi risultati metodologici quali l’impegno al dialogo e al lavoro di gruppo, la consuetudine con le procedure di verifica empirica di un’ipotesi, il controllo ragionato dei fattori che influenzano le soluzioni, la critica degli automatismi, in una parola, l’esercizio del pensiero critico. Tali azioni formative si iscrivono nel quadro del potenziamento degli apprendimenti di base degli allievi (esiti Invalsi, Ocse-Pisa, Iea-Pirls, ecc.) e della didattica per competenze.
Quella stessa didattica per competenze viene vista dal PNF come la chiave di volta della nuova formazione dei giovani: «la didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola - e soprattutto a ciascun insegnante - una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche degli studenti».
Il Piano nazionale di formazione degli insegnanti potrebbe favorire concretamente l’introduzione nell’insegnamento dell’esercizio del pensiero critico, fornendo quegli strumenti logici e metodologici che fanno perdere al docente la sua funzione tradizionale di indottrinamento tramite una lectio, per favorire un ruolo dialogico attivo degli studenti che realizzi, anche con l’apporto consapevole delle tecnologie digitali, una pratica attenta della dialettica come arte del dialogare, analisi critica delle parole e dei discorsi altrui. L’esercizio del pensiero critico potrebbe far diventare un ricordo lontano i bassi risultati dei nostri giovani in lettura e comprensione dei testi, e ridurre il diffuso analfabetismo funzionale.
ALFABETO - TULLIO DE MAURO. Italia, Repubblica popolare fondata sull’asineria
di Antonello Caporale *
Tullio De Mauro Siamo la Repubblica dell’ignoranza, degli asini duri e puri, degli analfabeti di concetto, di concorso, di condominio, da passeggio e da web. Passano gli anni ma restiamo sempre stupiti della mostruosa cifra dei concittadini incapaci di comprendere o persino leggere una frase che non sia un periodo semplice (soggetto, predicato e complemento) e un’operazione aritmetica appena più complessa dell’addizione o della sottrazione a due cifre.
Tullio De Mauro è il notaio della nostra ignoranza.
Sono ricerche consolidate, l’ultima dell’Ocse è del 2014, che formalizza il grado italiano di estremo analfabetismo. Mi succede ogni volta di dover spiegare che la sorpresa è del tutto fuori luogo, i dati sono consolidati oramai.
Professore, asini eravamo e asini siamo.
Abbiamo una percentuale di analfabetismo strutturale intorno al 33% in misura proporzionale per classi di età: dai 16 anni in avanti. Il 5% di essi non riesce a distinguere il valore e il senso di una lettera dall’altra. Avrà difficoltà a capire ciò che divide la b con la t la f la g. Cecità assoluta. Il restante 28 ce la fa a leggere, ma con qualche difficoltà, parole semplici e a metterle insieme: b a c o, baco. Singole parole.
Qui siamo al livello 1: totale incapacità di decifrare uno scritto.
Il cosiddetto livello degli analfabeti strutturali.
Passiamo al secondo livello.
Gli analfabeti funzionali. Riescono a comprendere o a leggere e scrivere periodi semplici. Si perdono appena nel periodo compare una subordinata o più subordinate. E uguale difficoltà mostrano quando le operazioni aritmetiche si fanno appena più complicate della semplice addizione e sottrazione. Con i decimali sono guai.
Dentro questo comparto di asineria alleviata c’è un altro 37% di compatrioti.
Purtroppo non ci schiodiamo da queste cifre.
Quanta gente ha una padronanza avanzata di testi, parole e concetti?
Il 29%. Si parte dal terzo gradino, quello che definisce il minimo indispensabile per orientarsi nella vita privata e pubblica, e si sale fino al quinto dove il forestierismo è compreso, si ha la padronanza della lingua italiana e anche di quella straniera.
Con gli anni si peggiora.
È un processo di atrofizzazione del sapere costante e lievitante.
Solo tre italiani su dieci andranno a votare al referendum sulla Costituzione con qualche idea di cosa sono chiamati a decidere.
Siamo lì, purtroppo.
È un disastro!
Il Giappone nel 1870 investì ogni risorsa nella scolarizzazione. Nel 1900 tutti i giapponesi erano in possesso della licenza elementare. Traguardo che noi abbiamo raggiunto 80 anni dopo.
Per la politica è un grande business trovarsi di fronte elettori inconsapevoli. Frottole a gogò!
È un’attrazione fatale. Ricordo che il ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer licenziò una riforma nella quale il Parlamento si faceva carico di ascoltare ogni anno una relazione sullo stato dell’istruzione in Italia e ogni tre anni di avanzare gli eventuali correttivi. Un po’ come la manovra finanziaria, pensava che fosse necessaria una legge di stabilità culturale. Era un modo per tenere sott’occhio anche questa sciagura e per ridurre o limitare l’evento calamitoso dell’ignoranza. Venne la Moratti e dopo un giorno dal suo insediamento la cassò.
Anche lei è stato ministro dell’Istruzione.
In Parlamento risposi a un’interrogazione di una deputata (insegnante tra l’altro). Dissi: l’onorevole preopinante (colui che ha appena dubitato, opinato ndr). Lei mi interruppe: come si permette di offendere?
Ma l’ignoranza non incide anche nella qualità del lavoro?
L’ignoranza costa in termini civili, naturalmente culturali e persino nel processo produttivo. L’indice di produttività subisce un assoluto condizionamento dall’asineria.
Di cosa ci sarebbe bisogno?
Di cicli di aggiornamento culturale di massa. E nessun sussidio (penso alla cassa integrazione) dovrebbe essere possibile senza un contestuale periodo di educazione alla lingua.
Dovremmo tutti andare al doposcuola.
Prima si andava al mercato e si sceglieva la lattuga. Adesso c’è il supermercato dove tutto è imbustato. Per capirne provenienza e confezionamento è necessario saper leggere. Posso anche leggere Cile, ma se non so dove si trova quel Paese che me ne faccio di quella indicazione?
Siamo il Paese della onesta incomprensione.
Esisteva un servizio intelligente e puntuale che indagava sulla nostra capacità di comprendere, il servizio opinione Rai poi incredibilmente chiuso. Nel 1969 fu avanzata una ricerca su tre campioni: la casalinga di Voghera, gli operai di Bari e gli impiegati di Roma. Questi ultimi si distinsero per la loro selvaggia ignoranza.
E noi a prendercela con la casalinga di Voghera.
Invece i peggiori erano gli impiegati dei ministeri. Asinissimi!
* Blog di Antonello Caporale - Il Fatto Quotidiano, 22 ottobre 2016
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- COSTITUZIONE ED "ELOGIO DEL DUBBIO" (di Remo Bodei) .23 settembre 2016, di Federico La Sala
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
- OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una svolta antropologica
COSTITUZIONI. Contro intolleranza e assolutismni, solo il dubbio permette di costruire una sana convivenzaI valori penultimi delle democrazie
di Remo Bodei (Corriere della Sera, La Lettura, 18.09.2016)
Nella maggior parte delle cosiddette lingue indoeuropee (a partire dal sanscrito dva o dvi, che significa «due» e in analogia con il latino dubium o il tedesco Zweifel) il dubbio indica incertezza dinanzi ad alternative pratiche o teoriche, il trovarsi davanti a un dilemma o, come nel simbolo pitagorico Y, davanti a un bivio, graficamente rappresentato, quale simbolo della difficoltà di prendere decisioni.
Soppesare le scelte, non farsi trascinare dalle circostanze o dagli impulsi spontanei è stata - e continua a essere - una conquista che spetta a ogni persona e a ogni civiltà nel corso della propria evoluzione. Governare le passioni, non significa ancora, tuttavia, porsi dei dubbi di natura teorica. Ma il primo passo, quello dell’astrarsi dal contesto, del fermarsi a riflettere, è stato compiuto e lo spazio di perplessità creato e aperto.
Il ragionare prima di decidere la propria linea di condotta o di articolare il proseguimento dei propri pensieri è segno di raggiunta maturità. Certo, tutto ciò ancora non basta. Occorre evitare il pericolo più ovvio: che il dubbio si trasformi in paralisi, in alibi o in fatalistica pigrizia che lascia andare alla deriva i comportamenti, le idee, le fantasie. Per questo, quasi avesse bisogno di un’àncora, il dubbio è stato spesso diametralmente contrapposto non tanto alla verità logica o empirica (quella sottomessa al «tribunale della ragione» e capace di rettificare i suoi eventuali errori), quanto alla verità rivelata o imposta con la violenza.
I totalitarismi del secolo scorso hanno preteso che i loro capi (il Duce, il Führer, il Caudillo, il Conducator, il Piccolo Padre, il Grande Timoniere) incarnassero l’indiscutibile verità e l’esemplare moralità: «Il Duce ha sempre ragione» o «Agisci in modo che, se il Führer ti vedesse, approverebbe la tua azione». Ogni pensiero autonomo e ogni dubbio sono considerati sovversivi perché minano l’autorità del Capo o del Partito. Devono essere stroncati. Per fortuna, come disse Mussolini al giornalista tedesco Emil Ludwig, la disposizione dell’uomo moderno a credere ha dell’incredibile. Proprio per questo viene sollecitato il comportamento gregario, condensato nel motto delle SS («Il mio onore si chiama fedeltà») e, nell’ambito del fascismo italiano, nello slogan «Credere, obbedire e combattere» (dove, si noti, il «credere» occupa il primo posto).
Che le masse si lascino facilmente guidare, è convinzione profonda anche di Hitler: «È una bella fortuna per gli uomini di governo che le masse non pensino! Si pensa soltanto quando si tratta di impartire un ordine o di assicurarne l’esecuzione. Se fosse diversamente la società umana non potrebbe sussistere». Non potendo impartire ordini, ma soltanto riceverli, le folle non corrono il rischio del dubbio. Da qui l’invito - o, meglio, il comando - a praticare una «entusiastica intolleranza» non solo contro quanti dubitano, ma anche contro coloro che dimostrano troppa volontà di sapere, raffigurati come soggetti a ipertrofia intellettualistica. Il dubbio si trasforma in una malattia.
Giovanni Paolo II ha parlato, con espressione paradossale, di «dittatura del relativismo», per dire che, specie dopo la fine del comunismo, la democrazia occidentale, avrebbe esaurito le sue energie: marcet sine adversario virtus . Sarebbe cioè diventata più evidente la sua propensione a lasciare ai cittadini un’eccessiva libertà dai valori della tradizione, che sconfina nella licenza e nell’anarchia.
La democrazia però non è soltanto relativistica. È vero che le democrazie moderne nascono dall’onda lunga delle guerre di religione che hanno insanguinato il Cinquecento e il Seicento, facendo scorrere tanto sangue - secondo un contemporaneo - da far girare le ruote dei mulini e da mostrare un grado d’intolleranza che oggi noi attribuiamo ad altre culture e religioni. La stanchezza per il sangue versato ha, tuttavia, provocato un salutare passo indietro dai valori ultimi - assoluti, non negoziabili e, se è il caso, da imporre con la forza - ai valori penultimi, su cui fondare gli Stati. La democrazia relativistica perché ammette più fedi e più verità e ha proprio il dubbio come sua specifica virtù, ma vi è in essa qualcosa che non è relativistico: è la compatibilità interna tra i valori, garanzia di convivenza di tutti in uno spazio pubblico e neutro, sempre minacciato da ritorni di fiamma di intolleranza e prepotenza.
In questo senso, il richiamo che, negli anni della Guerra fredda, Norberto Bobbio rivolgeva agli intellettuali («seminare dubbi» piuttosto che «raccogliere certezze») costituisce l’antidoto a ogni schieramento ideologico a priori, perché, come lo stesso filosofo ha insistito più tardi, lo scopo di ogni persona ragionevole, e, in particolare, di chi sceglie l’intelligenza quale strumento di lavoro, dovrebbe essere «l’inquietudine per la ricerca, il pungolo del dubbio, la volontà del dialogo, lo spirito critico, la misura nel giudicare, lo scrupolo filologico, il senso della complessità delle cose».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! -- PER IL DIALOGO, QUELLO VERO. «Parliamoci. È vera rivoluzione culturale»(Zigmunt Bauman).21 settembre 2016, di Federico La Sala
- IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO". La questione della "Parola" e della "Lingua" ...
- RILEGGERE SAUSSURE (E ANCHE ARISTOTELE). UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!! Un omaggio e un appello a Tullio De Mauro.
Intervista
Bauman: «Parliamoci. È vera rivoluzione culturale»
di Stefania Falasca (Avvenire, 20/09/2016)
«Le guerre di religione? Solo una delle offerte del mercato ». Zygmunt Bauman, il più acuto studioso della società postmoderna che ha raccontato in pagine memorabili l’angoscia dell’uomo contemporaneo - lo incontriamo ad Assisi prima del suo intervento - ci parla della sfida del dialogo.
Professore, la sua intuizione sulla postmodernità liquida continua a offrire uno sguardo lucido sul tempo presente. Ma in questa liquidità si registra un esplosione di nazionalismi, identitarismi religiosi. Come si spiegano?
Cominciamo dal problema della guerra. ll nostro mondo contemporaneo non vive una guerra organica ma frammentata. Guerre d’interessi, per denaro, per le risorse, per governare sulle nazioni. Non la chiamo guerra di religione, sono altri che vogliono sia una guerra di religione. Non appartengo a chi vuole far credere che sia una guerra tra religioni. Non la chiamo neppure così. Bisogna stare attenti a non seguire la mentalità corrente. In particolare la mentalità introdotta dal politologo di turno, dai media, da coloro che vogliono raccogliere il consenso, dicendo ciò che loro volevano ascoltare. Lei sa bene che in un mondo permeato dalla paura, questa penetra la società. La paura ha le sue radici nelle ansietà delle persone e anche se abbiamo delle situazioni di grande benessere, viviamo in una grande paura. La paura di perdere posizioni. Le persone hanno paura di avere paura, anche senza darsi una spiegazione del motivo. E questa paura così mobile, inespressa, che non spiega la sua sorgente, è un ottimo capitale per tutti coloro che la vogliono utilizzare per motivi politici o commerciali. Parlare così di guerre e di guerre di religioni è solo una delle offerte del mercato.
Al panico delle guerre di religione si unisce quello delle migrazioni. Già anni fa Umberto Eco diceva che per chi voleva capitalizzare la paura delle persone, il problema dell’emigrazione era arrivato come un dono dal cielo....
Sì è così. Guerre di religione e immigrazione sono nomi differenti dati oggi per sfruttare questa paura vaga incerta, male espressa e mal compresa. Stiamo però qui facendo un errore esistenziale, confondendo due fenomeni differenti: uno è il fenomeno delle migrazioni e l’altro il fenomeno dell’immigrazione, come ha fatto osservare Umberto Eco. Non sono un fenomeno, sono due differenti fenomeni. L’immigrazione è un compagno della storia moderna, lo Stato moderno, la formazione dello Stato è anche una storia di immigrazione. Il capitale ha bisogno del lavoro il lavoro ha bisogno del capitale. Le migrazioni sono invece qualcosa di diverso è un processo naturale che non può essere controllato, che va per la sua strada.
Come pensa si possa trovare un equilibrio per questi fenomeni?
La soluzione offerta dai governi è quella di stringere sempre più il cordone delle possibilità di immigrazione. Ma la nostra società è ormai irreversibilmente cosmopolita, multiculturale e multireligiosa. Il sociologo Ulrich Beck dice che viviamo in una condizione cosmopolita di interdipendenza e scambio a livello planetario ma non abbiamo neppure iniziato a svilupparne la consapevolezza. E gestiamo questo momento con gli strumenti dei nostri antenati... è una trappola, una sfida da affrontare. Noi non possiamo tornare indietro e sottrarci dal vivere insieme.
Come integrarci senza aumentare l’ostilità, senza separare i popoli?
È la domanda fondamentale della nostra epoca. Non si può neppure negare che siamo in uno stato di guerra e probabilmente sarà anche lunga questa guerra. Ma il nostro futuro non è costruito da quelli che si presentano come ’uomini forti’, che offrono e suggeriscono apparenti soluzioni istantanee, come costruire muri ad esempio. La sola personalità contemporanea che porta avanti queste questioni con realismo e che le fa arrivare ad ogni persona, è papa Francesco. Nel suo discorso all’Europa parla di dialogo per ricostruire la tessitura della società, dell’equa distribuzione dei frutti della terra e del lavoro che non rappresentano una pura carità, ma un obbligo morale. Passare dall’economia liquida ad una posizione che permetta l’accesso alla terra col lavoro. Di una cultura che privilegi il dialogo come parte integrante dell’educazione. Si faccia attenzione, lo ripete: dialogo-educazione.
Perché secondo lei il Papa è convinto che sia la parola che non ci dobbiamo stancare di ripetere? Alla fine il dialogo cos’è?
Insegnare a imparare. L’opposto delle conversazioni ordinarie che dividono le persone: quelle nel giusto e quelle nell’errore. Entrare in dialogo significa superare la soglia dello specchio, insegnare a imparare ad arricchirsi della diversità dell’altro. A differenza dei seminari accademici, dei dibattiti pubblici o delle chiacchiere partigiane, nel dialogo non ci sono perdenti, ma solo vincitori. Si tratta di una rivoluzione culturale rispetto al mondo in cui si invecchia e si muore prima ancora di crescere. È la vera rivoluzione culturale rispetto a quanto siamo abituati a fare ed è ciò che permette di ripensare la nostra epoca. L’acquisizione di questa cultura non permette ricette o facili scappatoie, esige e passa attraverso l’educazione che richiede investimenti a lungo termine. Noi dobbiamo concentraci sugli obiettivi a lungo termine. E questo è il pensiero di papa Francesco, il dialogo non è un caffè istantaneo, non dà effetti immediati, perché è pazienza, perseveranza, profondità. Al percorso che lui indica aggiungerei una sola parola: così sia, amen.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- USCIRE FUORI DALLA CAVERNA - DALL’AGONISMO TRAGICO, CATTOLICO-ROMANO.15 settembre 2016, di Federico La Sala
- OCCIDENTE, AGONISMO TRAGICO, E MENTE ACCOGLIENTE. Un contributo alle discussioni del FESTIVAL DI FILOSOFIA 2016
Festival di Filosofia
Remo Bodei
“Si corre per vincere, anche San Paolo invitava a colpire duro”
Il filosofo: i greci ci hanno dato la linea
di Francesca Sforza (La Stampa, 15.09.2016)
Quest’anno si corre, al Festival della Filosofia di Modena. Si corre per capire, per restare al passo con il tempo inquieto della contemporaneità. E anche, un po’, per vincere. Remo Bodei, professore di Filosofia presso la University of California a Los Angeles e Presidente del comitato scientifico del Festival, è uno dei protagonisti di questa maratona del pensiero.
Professore, partiamo dall’origine greca della parola agonismo, cosa resiste dell’antica accezione del termine, e cosa invece è andato perduto o si è trasformato?
«“Agon” è la lotta in vista di una vittoria, in tutte le sue accezioni, fino all’agonia, che è la lotta estrema contro la morte. Direi che grosso modo si è conservato l’essenziale dell’accezione greca, che anzi si è estesa dal campo di partenza, quello sportivo, ad altri ambiti, penso ad esempio a quello economico, che vede tra l’altro l’uso di un modello di origine sportiva di tipo specifico, la corsa.
 Se pensiamo poi alla concorrenza, come non ricordare la metafora agonistica usata da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi? “Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo”, scrive San Paolo, sottolineando che la differenza, semmai, è nel fatto che gli atleti si muovono per “una corona che appassisce”, mentre i cristiani sono chiamati per “una che dura per sempre”. Interessante notare il suo riferimento al pugilato - “Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria”, cioè invita a colpire in modo da fare male».
Se pensiamo poi alla concorrenza, come non ricordare la metafora agonistica usata da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi? “Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo”, scrive San Paolo, sottolineando che la differenza, semmai, è nel fatto che gli atleti si muovono per “una corona che appassisce”, mentre i cristiani sono chiamati per “una che dura per sempre”. Interessante notare il suo riferimento al pugilato - “Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria”, cioè invita a colpire in modo da fare male».In che cosa differisce l’agonismo religioso da quello laico?
«Più che di differenze parlerei di una ripresa laica dello stesso tema, ad esempio con Hobbes, in cui la gara non è conquistare il paradiso, ma vincere sugli altri al punto che la felicità consiste nel sorpassare, l’infelicità nel rimanere indietro, e la fine della corsa - l’abbandono della gara - coincide con la morte. Non c’è nessun premio, nella visione laica di Hobbes, si corre per vincere».
Nella condizione agonistica prevale il cimentarsi con la vittoria (e il rassegnarsi alla sconfitta) o il partecipare alla lotta e alla competizione?
«Se uno prendesse alla lettera Pierre de Coubertin si corre per gareggiare e confrontarsi, ma da un punto di vista più essenziale la concorrenza è spietata, quindi si corre per vincere. La cosa interessante che emergerà da alcune lezioni è che sul piano animale c’è una forma di altruismo che fa bene alla competizione, e anche in campo economico, la cosiddetta economia altruistica, insegna che non sempre è un bene stravincere. Ne parlerà Massimo Recalcati in un suo intervento: anche essere sconfitti aiuta a crescere».
È pensabile una declinazione equa dell’agonismo?
«Nei cicli vitali ci sono sempre i salvati e i sommersi, per dirla con Primo Levi, e la conquista della democrazia vorrebbe che ci fossero, intorno a noi, non nemici, ma avversari. Il problema è nelle condizioni di partenza: è vero che bisogna crearle, in modo tale che poi ognuno sia messo in grado di fare la sua corsa, ma spesso è un’ipocrisia».
Quali sono gli autori che meglio di altri hanno illustrato la dimensione dell’agonismo?
«Nella filosofia è davvero una dimensione iniziale. Pitagora paragonava la contemplazione filosofica con l’andare allo stadio a guardare i contendenti - aggiungendo che se c’era una differenza consisteva nel fatto che la contemplazione filosofica era gratis, mentre allo stadio si doveva pagare. Nei cosiddetti presocratici, il “polemos”, la guerra, è il padre di tutte le cose, segna l’inizio per eccellenza. E da questo discendeva non solo una filosofia, ma un modo di vita per cui la disciplina, l’entrare in conflitto con se stessi, il sottoporsi a esercizi fisici e spirituali, rafforza l’individuo».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- Antropologi nelle scuole per lezioni di convivenza (di Marino Niola)9 settembre 2016, di Federico La Sala
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI...
 IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin - di Nicola Fanizza.
IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin - di Nicola Fanizza.
- ANTROPOLOGIA CRITICA: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
Antropologi nelle scuole per lezioni di convivenza.di Marino Niola (la Repubblica, Il Venerdì, 09.09.2016)
La paura degli attentati, la polemica sul burkini, l’emergenza migranti, le discussioni sulla poligamia, il velo trasformato in simbolo identitario, la demagogia xenofoba montante. Le cronache di quest’estate hanno tutte come minimo comune denominatore il rapporto sempre più problematico tra noi e gli altri. Perché da un po’ di tempo la differenza genera diffidenza. E ogni alterità appare come una minaccia alla nostra identità.
Fino a qualche anno fa ci sembrava di essere in grado di assorbire i problemi posti dal multiculturalismo incipiente e di poterne godere i vantaggi, soprattutto economici. Ma oggi i processi di integrazione che sembravano, sia pur faticosamente, avviati, sembrano invece in stand by. E su questo impasse il terrorismo getta benzina sul fuoco, spingendo le teste calde d’Europa verso una radicalizzazione che trova nell’integralismo religioso simboli, parole d’ordine e ideologie per esprimere un antagonismo che in altri tempi avrebbe preso strade diverse.
E quel che emerge in maniera preoccupante è che non ci siamo per nulla attrezzati a governare le differenze con le quali conviviamo gomito a gomito. Perché? Semplice, perché non abbiamo imparato a conoscerle. Ma, come avrebbe detto il maestro Manzi, alfabetizzatore televisivo dell’Italia in bianco e nero, non è mai troppo tardi.
E oggi, proprio come allora, c’è bisogno di una nuova educazione alla convivenza con chi è diverso. In una parola un’alfabetizzazione all’antropologia culturale. Che è l’unico sapere specializzato nello studio delle altre culture e, soprattutto delle compatibilità tra tradizioni, modi di vita, usi e costumi dei diversi popoli. Insomma è urgente avviare un iter formativo che vada dalla scuola all’università alla società.
E proprio per porre all’ordine del giorno questa emergenza pedagogica, gli antropologi europei, riunitisi di recente a Milano rispondendo alla chiamata delle due associazioni italiane, Anuac (Associazione nazionale universitaria degli antropologi culturali) e Aisea (Associazione italiana per le scienze etno-antropologiche), hanno lanciato un appello alle istituzioni scolastiche perché introducano l’antropologia in tutti i percorsi educativi come arma per combattere razzismo, integralismo e intolleranza.
È assurdo e anacronistico che in un mondo sempre più globalizzato, dove credenze, valori, consuetudini antitetiche coabitano in una prossimità sempre più conflittuale, sia clamorosamente latitante proprio una materia come l’antropologia che, dello studio dei modi di fare, pensare e sentire degli altri ha fatto la sua mission conoscitiva.
 Figlia primogenita dell’umanesimo e dell’illuminismo occidentale.
Figlia primogenita dell’umanesimo e dell’illuminismo occidentale.Non a caso, come diceva il celebre etnologo Claude Lévi-Strauss, solo l’Occidente ha prodotto antropologi, anche come controcanto critico, e autocritico, del colonialismo. E fa riflettere il fatto che proprio nei Paesi islamici da cui provengono, direttamente o indirettamente, i terroristi di Daesh,l’antropologia sia addirittura bandita dai programmi d’insegnamento. Perché mettendo sullo stesso piano tradizioni, religioni e valori, revoca radicalmente quella superiorità di alcuni popoli sugli altri sancita dal Corano. Una ragione in più per diffondere nelle nostre classi scolastiche e universitarie questo insegnamento doppiamente fondamentale. Sia per i ragazzi di cultura europea sia per i migranti di seconda e terza generazione che, sempre più spesso, reagiscono negativamente all’impatto con il Paese ospitante. Col risultato di rinchiudersi nella propria apartheid identitaria. E di radicalizzare la propria origine, o il proprio credo, trasformandoli in un’arma politica a disposizione del fondamentalismo.
La sfida dell’educazione delle giovani generazioni richiede innanzitutto l’alfabetizzazione degli alfabetizzatori, ovvero la formazione degli insegnanti. Che devono fare propri gli strumenti dell’antropologia «per educare i loro allievi al confronto positivo con le diversità, da quelle di genere, a quelle culturali, fino a quelle religiose».
A dirlo è Cristina Papa, dell’Università di Perugia e presidente dell’Anuac che, insieme a Mario Bolognari, professore a Messina e leader dell’Aisea, sottolinea le possibilità innovative offerte dalla legge 107, la cosiddetta riforma Giannini. Che, tra le competenze trasversali, ritenute indispensabili per tutti i docenti, indipendentemente dalla disciplina che insegneranno, prevede anche quelle antropologiche.
Purché, sottolinea Papa «i decreti attuativi, che sono in via di elaborazione a livello ministeriale, rispondano pienamente agli obiettivi della legge e diano uno spazio adeguato all’antropologia in tutte le fasi della formazione». Si tratta di problemi che Paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Canada affrontano da tempo. Ricorrendo all’aiuto di celebri antropologi per impostare i loro programmi educativi.
Per esempio la grande Margaret Mead (1901-1978), docente alla Columbia University, fu a lungo consulente del Ministero dell’educazione Usa nell’elaborazione di strategie scolastiche per contrastare razzismo, bullismo e disuguaglianze di genere. E Lévi-Strauss (1908-2009) elaborò per conto dell’Unesco progetti educativi contro il razzismo e i pregiudizi etnici. Mentre, nel corso del secondo conflitto mondiale,
Ruth Benedict (1887-1948) docente alla Columbia, e Clyde Kluckhohn (1905-1960), fondatore del dipartimento antropologia di Harvard, collaborarono con il Pentagono e con il generale Mc Arthur per aiutare i comandi americani a capire il sistema di valori dei nemici giapponesi. Il caso più recente è quello della statunitense Montgomery McFate, che nel 2006 venne messa a capo del discusso programma Human Terrain Systems, un esperimento tra ricerca e intelligence condotto in Afghanistan e Iraq per coadiuvare le truppe nella lotta al terrorismo.
A sostenere l’indispensabilità degli antropologi nei teatri di guerra fu il generale David Petraeus, capo dell’US Army in Iraq e poi direttore della Cia, convinto della necessità di una svolta culturale fondata sulla conoscenza dei valori e delle forme di vita delle popolazioni locali, per evitare incomprensioni e malintesi.
Secondo il colonnello Martin Schweitzer l’impiego degli studiosi ha consentito una diminuzione delle operazioni militari del 60 per cento. «Gli antropologi ci hanno liberato dall’ossessione del nemico e aiutato a capire meglio le culture degli altri». A dire il vero sul progetto sono piovute critiche per la sua militarizzazione del sapere.
E in effetti non è questa l’antropologia che ci auguriamo di mettere in campo. Molto meglio le proposte didattiche elaborate nel nostro Paese. Un esempio per tutti, i Laboratori di antropologia educativa proposti dal progetto RibaltaMente, guidato da Giulia Cerri e Gianmarco Grugnetti. Insomma solo una corretta formazione antropologica ci salverà da due errori simmetrici e opposti. Il buonismo beota e il razzismo idiota.
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI...
-
>DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) -- DALL’ECO DELLE SIBILLE, LA VOCE DELLA PROFEZIA (di Chiara Magaraggia)19 luglio 2016
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E STORIA. UOMINI E DONNE, PROFETI E SIBILLE, OGGI...
 IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin - di Nicola Fanizza
IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin - di Nicola Fanizza
DALL’ECO DELLE SIBILLE, LA VOCE DELLA PROFEZIA
di Chiara Magaraggia*
- FOTO. Perugino, Profeti e Sibille, Aula dell’Udienza, Collegio del Cambio di Perugia
Sono le creature più misteriose della storia della salvezza: non sono nominate nella Bibbia, non sappiamo quante siano,vengono dalla notte dei tempi, vengono dai quattro angoli del mondo allora conosciuto, vengono da quei confini inconoscibili in cui storia e leggenda si fondono, in cui mondo pagano e mondo cristiano si saldano. Sono donne, sono sapienti e sono la voce del Verbo. La loro parola è capace di scrutare segni di secoli remoti e leggerli in un’ottica di salvezza futura; la loro immagine è da sempre legata al rotolo o al libro, in cui questa parola un tempo oscura e misteriosa si imprime, diventando finalmente chiara solo nella pienezza dei tempi.
Creature affascinanti, le Sibille: un tempo vergini dotate di virtù profetiche ispirate dal dio Apollo, nel mondo cristiano le profetesse di Cristo, le facce femminili della profezia.
- FOTO. Le Sibille
E’ vero che la Sacra Scrittura ci presenta alcune profetesse: Maria sorella di Mosè, Debora, Anna. Nessuna di loro, però, ha conseguito la popolarità delle Sibille, né ha avuto la loro fortuna. L’arte cristiana si è impossessata di loro a piene mani, la poesia e la musica hanno loro riservato una posizione privilegiata in pagine rimaste immortali.
“Dies irae, dies illa / solvet saeculum in favilla / teste Davide cum Sibylla”. La celebre sequenza duecentesca attribuita a Tommaso di Celano, in cui, con immagini di forte impatto emotivo e figurativo, viene rappresentata la grandiosa scena del Giudizio Universale - il terribile giorno in cui il mondo e il tempo saranno ridotti in cenere - collega la profezia biblica di Davide con quella di origine classica delle Sibille: pagani e cristiani, uomini e donne, ovunque abbia alitato lo spirito di Dio, hanno profetizzato “dies illa”, quel giorno. Dalla musica raccolta degli antichi monasteri alla sublime solennità dell’ultimo Mozart fino alla travolgente grandiosità di Verdi, ovunque il Requiem con la sequenza del “Dies irae” ha scandito la colonna musicale di secoli e secoli, così che, come scrive Dante nell’ultimo canto del Paradiso “al vento nelle foglie lievi si perde la sentenza di Sibilla” (Par. 33, vv. 65-66).
Amatissime nell’arte di ogni tempo, con i loro volti dai mille lineamenti a seconda dei luoghi, delle epoche, dei contesti, della sensibilità degli artisti, fanno capolino dai posti più impensati. Potremmo quasi affermare che le mutevoli Sibille incarnino l’immagine stessa della donna, che si trasforma senza sosta per rendere continuamente nuova l’antica attesa dell’avvento di Dio nel mondo. Ci vengono incontro leggiadre e piene di grazia in un luogo veramente particolare: il Collegio del Cambio di Perugia, affrescato, negli ultimi anni del Quattrocento dal pittore umbro Perugino, forse con la collaborazione del giovane allievo Raffaello.
Un luogo davvero inconsueto: la sede ufficiale dei cambiavalute perugini, in cui si stabiliva il valore delle monete del tempo per renderle più competitive negli scambi commerciali e in cui si tentava di controllare la diffusione del prestito ad usura. Una piccola Borsa rinascimentale. Ma perché proprio qui, nel tempio degli affari, si sono dipinte le Sibille?
La lunetta peruginesca della Sala dell’Udienza (la stanza in cui si prendevano le decisioni più importanti), sullo sfondo di un verde, luminoso paesaggio umbro ci mostra due distinti gruppi di personaggi: da un lato sei Profeti (Isaia, Mosè, Daniele, Geremia, Davide, Salomone) dal volto grave e ispirato, dall’altro le sei Sibille (Eritrea, Persica, Cumana, Libica, Tiburtina, Delfica) dai visi dolci, botticelliani e gli sguardi assorti di chi più che sul presente, è concentrato sul futuro; i capelli sono acconciati secondo i dettami del tempo, gli abiti leggeri, sobri, dalle delicate sfumature cromatiche, i piedi atteggiati a passo di danza, le mani dai gesti “parlanti”. Profeti e Sibille sono avvolti da filatteri con brani allusivi alla prima e all’ultima venuta di Cristo. Il Padre Eterno benedicente, circonfuso da una mandorla dorata, sovrasta i due gruppi.
Nella parete opposta della Sala, Perugino dipinge le Virtù di cui uomini e donne devono rivestirsi: la venuta di Cristo, dunque, dovrà originare nuove creature, dotate di quelle virtù che sole possono guidarci nella realizzazione concreta del progetto divino.
In questo affresco, dipinto in pieno Umanesimo, è celebrata la dignità dell’uomo: il pittore l’ha qui rappresentato così come Dio l’ha creato, maschio e femmina, senza distinzioni di provenienza, biblica o pagana, anche nella profezia. Ognuno è inserito nel progetto divino, ne è non solo testimone, ma attore e responsabile in prima persona. Sembrano riecheggiare qui le splendide parole con cui in questi stessi anni Giovanni Pico della Mirandola ha tessuto forse il più bell’elogio alla dignità e al libero arbitrio dell’essere umano: “Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale perché sia tu stesso, quasi libero e sovrano, a plasmarti secondo la tua libera decisione: potrai annullarti in terra come le creature brute, potrai sollevarti fino alle cose più alte che sono divine”. Così un mestiere come quello del cambiavalute, inviso nel Medioevo perché a contatto col denaro considerato materiale impuro e ora rivalutato nell’ottica dei nuovi tempi e delle profonde trasformazioni, esercitato con prudenza, con giustizia, con sobrietà, guidato dalla fede, dalla speranza, dalla carità, sarà nella società strumento di cambiamento positivo per tutti e perciò degno della benedizione divina.
- FOTO. Sibilla Cumana, Jan Van Eyck, Gand, Cattedrale di San Bavone
Dal centro dell’Italia alla ricca città di Gand. Siamo nelle Fiandre del primo Quattrocento, una delle aree più ricche dell’Europa: i mercanti, i banchieri, i borghesi attivi nei piccoli liberi centri stanno creando un mercato economico dove transitano merci di ogni tipo, con investimenti e profitti che segnano l’alba del capitalismo europeo. Fasto e splendore in breve rendono splendide Bruges, Gand, Anversa. E proprio a Gand opera il maggiore pittore del Rinascimento nordico: Jan Van Eyck. Per la cattedrale di San Bavone egli realizza un grandioso polittico in 20 pannelli in legno di quercia, in cui, attraverso 250 figure dai colori squillanti, sviluppa la storia della Redenzione dal peccato originale al trionfo finale di Cristo. E lì, sopra la scena dell’Annunciazione, avvolta in vesti sontuose, la Sibilla Cumana dà il suo vaticinio: “Verrà il tuo Re dei secoli futuri”. Parole che precedono e sottolineano il sottostante annuncio dell’angelo a Maria. Ciò che colpisce nella Sibilla fiamminga è lo splendido copricapo trapuntato da una reticella di candide perle e il verde mantello di pesante velluto con le maniche e il collo di preziosa pelliccia. E’ la moda con cui le ricche dame del nord si riparavano dai geli invernali. Colpiscono quel volto intenso e meditativo, quelle mani dai gesti così femminili: una sul grembo, come farà Maria, a sottolineare che quel Re verrà proprio da un corpo di donna, l’altra sorregge l’abito, nel gesto di alzarsi in piedi, stupita, ancora una volta come Maria, da un annuncio tanto solenne. Eppure la Sibilla sembra comunicarci dell’altro col suo viso pensoso: quel re non nascerà avvolto in velluti e pellicce, né sarà coccolato da banchieri e mercanti. Chi lo accoglierà? E come?
- FOTO. Sibilla Libica, Siena, Cattedrale
Il dialogo dai quattro confini del mondo si fa stringente e drammatico. Le risposte ci riportano ancora in Italia, nella città di Siena. La Cattedrale dedicata all’Assunta domina la città del Palio dal colle più alto. Ci accoglie con la facciata dai bianchi marmi, ci apre la porta guidando gli occhi verso la splendida vetrata multicolore con cui Duccio di Buoninsegna celebra Maria. Ma ciò che subito attira l’attenzione è lo straordinario pavimento, che in 56 grandi tarsìe di marmi bianchi, neri, colorati compone con un originale programma teologico la storia del tempo, dell’uomo, della salvezza. E’ come se il fedele si mettesse lui stesso in cammino per arrivare, col suo fardello di dolori, di speranze, di errori a Cristo che dall’altare tutti accoglie, sotto la luminosa custodia di Maria. Può qui mancare la voce delle Sibille? Le loro figure occupano i 10 riquadri delle navate laterali, con un effetto di bianche statue classicheggianti, ciascuna con la propria profezia. Ma, sorpresa, la prima Sibilla, quella Libica “di cui parla Euripide” ha il viso, le mani, i piedi neri. L’immagine è di assoluta novità: è una delle prime raffigurazioni di un personaggio femminile di pelle nera nella storia della salvezza e nell’arte in senso generale. Da una donna nera viene una delle profezie più drammatiche, che risponde in modo spiazzante ai dubbi della Sibilla fiamminga. Mostra nelle pagine del volume aperto alla sua destra la scritta latina che annuncia: “Ricevendo pugni tacerà”, che si collega alla tabella sorretta da un vaso fiorito a cui s’attorcigliano due serpenti: “Capiterà in mani malvagie. Daranno a Dio schiaffi a piene mani. Misero e vergognoso recherà speranza ai miseri”. Che sia proprio una donna nera, da sempre negletta, da sempre umiliata e battuta, a pronunciare la profezia della Passione è un fatto sconvolgente. E’ un’immagine che perfora i secoli e che per noi, oggi, assume un significato ulteriormente nuovo. Nella certezza consolante che dopo la Passione c’è la Resurrezione.
- FOTO. La Sibilla Cumana di Michelangelo nella Cappella Sistina
Certo, fra tutte le Sibille, l’immaginario di tutti non può non volare a Roma, nella Cappella Sistina, lo scrigno del genio di Michelangelo. Come i cicli in mosaico delle antiche basiliche, quello della Sistina è l’esempio più alto dell’arte al servizio della parola: un credo per immagini capace di tradurre in forme concrete, comprensibili a tutti, le verità che per tanto tempo erano appannaggio solo dei sapienti. Occorreva però che, accanto ad artisti pur grandi (Perugino, Botticelli, ecc.) che avevano affrescato le pareti laterali se ne aggiungesse un altro capace di imprimere unità e organicità al ciclo. Siamo nel 1508: Michelangelo riceve da papa Giulio II l’incarico di affrescare la volta, un lavoro immane (680 mq di superficie). Sette anni di lavoro massacrante, solo con i suoi tormenti e la sua immaginazione, con i pennelli e i colori ad ideare le nove scene della Genesi, dalla Separazione delle tenebre dalla luce al Diluvio e all’Ebbrezza di Noè, simbolo di un’umanità ineluttabilmente schiava degli istinti, degli errori, della perdizione. Occorreva far irrompere la speranza, riecheggiando le parole di Paolo: Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo trionfo?
Ed ecco, nel cornicione che affianca le nove scene, le figure dei Profeti e delle Sibille: tutti ispirati da Dio, ma in modo diverso, hanno il presentimento della Redenzione: se i primi la prevedevano con certezza, le Sibille, dal confuso orizzonte del mondo pagano, hanno saputo farsi interpreti del perpetuo anelito al rinnovamento dell’uomo, al di là delle tenebre. Sembrano compresse in troni troppo piccoli, le Sibille di Michelangelo, esponenti di un’umanità quasi asessuata, primordiale, colta nel momento di un improvviso risveglio, quasi una faticosa percezione della profezia, che suscita faticose, titaniche torsioni, in uno sforzo immane per uscire da una materia che sembra opprimerle: lo sforzo tutto michelangiolesco di una verità nascosta, di uno spirito incatenato che si dibatte per liberarsi e sprigionarsi.
La Sibilla Cumana della Sistina è agli antipodi della ricca signora dipinta da Van Eyck: non c’è grazia, non c’è femminilità in quelle forme gigantesche e mascoline della corporatura, in quel braccio poderoso che sorregge il libro, che sembrano contrastare con i tratti marcati e rugosi di un volto di vecchia. Le vesti sono disadorne, essenziali, spoglie; una sacca appesa al sedile sembra suggerire che non è propria dell’uomo la stabilità, che siamo tutti eterni pellegrini nel tempo della salvezza. Eppure, a questa donna così fuori dai canoni della femminilità ideale, è affidata, partendo dalle parole del poeta latino Virgilio, la profezia della nascita di un bambino generato da una vergine, che avrebbe aperto agli uomini un’era di pace e di felicità. Virgilio, primo secolo avanti Cristo, si salda idealmente alle parole del più antico Isaia, che, non a caso, Michelangelo ha affrescato proprio accanto alla Cumana: “Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà Emmanuele”. La grazia di Perugino, l’eleganza pensosa di Van Eyck, la pelle nera di Siena, la vecchiaia quasi deforme di Michelangelo: ritratti di donne di mondi diversi, capaci di andare oltre, di guardare lontano... in ognuna di esse possiamo trovare qualcosa di noi. Tanti accordi che si uniscono in un’unica grande voce. La voce delle Sibille capace di vincere di mille secoli il silenzio.
* Chiara Magaraggia
*FONTE. Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro cuore di Maria (ripresa parziale - senza immagini).
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) --- Movimenti improvvisi (di Lea Melandri)13 luglio 2016, di Federico La Sala
Movimenti improvvisi
di Lea Melandri *
Dell’ “erba voglio” si dice proverbialmente che non cresce neppure nel giardino del re. Eppure c’è stato un tempo, una stagione «breve, intensa ed esclusiva», in cui è comparsa nei luoghi più impensati: dalla scuola alle fabbriche, agli interni di famiglia.
Tra gli anni Sessanta e Settanta, nella fase di massima espansione della società dei consumi, che prometteva cibo in cambio di una dipendenza incondizionata, due “soggetti” tenuti per secoli ai margini della storia - i giovani e le donne - hanno dato prova di una straordinaria «creatività generativa», destinata a cambiare il volto della politica e dell’idea stessa di rivoluzione.
Con loro hanno fatto ingresso nella polis le categorie del “desiderio” e della “felicità”, guardate con sospetto dalla sinistra parlamentare ed extraparlamentare perché ritenute meno materialistiche di quella del bisogno, e hanno aperto prospettive inedite al “tragico” dualismo che ha diviso e contrapposto privato e pubblico, individuo e società, natura e cultura, destino del maschio e della femmina.
Elvio Fachinelli, originale interprete del ’68, in un articolo uscito sui Quaderni piacentini nel febbraio dello stesso anno, così definiva il «desiderio dissidente»: una «diversa logica di comportamento rispetto al reale e al possibile, contrapposta alla logica del soddisfacimento dei bisogni fino allora dominante».
Il desiderio e la dissidenza oggi sembrano essersi inabissati nella bocca vorace di una civiltà che, pur dando segni di visibile decadenza, macina ogni segnale di cambiamento, ogni forma nuova di socializzazione, ogni sapere che non sia funzionale alla sua conservazione.
Il venir meno dei confini tra vita e politica, anziché portare all’evidenza i nessi, che ci sono sempre stati, tra due poli astrattamente divisi dell’esperienza umana, sembra aver prodotto un amalgama difficile da districare, ma proprio per questo destinato a muovere resistenze, prese di distanza individuali e collettive.
A lasciare aperta la speranza è ancora una volta la lettura che Fachinelli fece dell’“utopia” di Walter Benjamin: «esigenze radicali», di cui si può dire che rappresentino in un particolare momento storico il «possibile attualmente impossibile», e che per questa stessa ragione si ripropongono nel tempo a venire, chiedendo risposte e soluzioni.
Che la crisi economica sia anche la crisi di un modello di sviluppo e di una civiltà che ha avuto come protagonista unico il sesso maschile, che la sessualità sia parte essenziale non riconosciuta della vita pubblica, dei suoi poteri, della sue istituzioni, dei suoi linguaggi, sono acquisizioni oggi presenti nelle coscienze di uomini e donne, più di quanto la generazione del ’68 potesse immaginare. Il «primum vivere», che viene dalle teorie e pratiche originali del femminismo, trova paradossalmente nell’orizzonte chiuso di chi dice di non avere futuro, la sua spinta più forte e più convincente.
Chi ha seguito un’altra logica, un altro ritmo, non può fallire e scomparire per sempre. Attualità e inattualità, presente e passato, continuità e imprevisto, intelligenza personale ed elaborazione collettiva, non ubbidiscono a «passaggi meccanici». Il rimando reciproco non è quello di causa-effetto e del discorso lineare, ma dei movimenti improvvisi, della frattura.
A tenerli insieme è la possibilità della “ripresa” aperta a nuove, impensate soluzioni. Non resta che sperare che la logica del desiderio, come la “passione” di Marx, la spinta ad autorealizzarsi da parte dell’uomo, lavori sotterraneamente, da vecchia talpa, e torni a sorprenderci, quando meno ce lo aspettiamo.
* Comune-info, 10 luglio 2016 (ripresa parziale)
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Scienza, cultura e natura dell’uovo. Una lettura divertente e documentata, che non si sottrae a riflessioni sui temi caldi dell’attualità scientifica.8 luglio 2016, di Federico La Sala
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
- Cogliere le cose alla radice non è facile. E la radice dell’uomo non è l’uomo stesso. Si ricordi quanto la completa conoscenza scientifica del fenomeno della procreazione sia recente nella scienza occidentale. E si ricordi che «dopo l’antica credenza nella sola responsabilità del maschio, la questione viene riveduta, diventa argomento di polemiche e resta a lungo incerta», e che, «fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società pre-patriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme»(Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, pref. di Fulvio Papi, pp. 140-141).
- PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
SIRONI EDITORE
- Storia di una cellula fantastica
 Scienza, cultura e natura dell’uovo
Scienza, cultura e natura dell’uovo
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio! Carlo Alberto Redi torna in libreria per raccontare la storia di questa cellula fantastica. Dalla conservazione degli oociti, alla produzione artificiale dei gameti, alla regolamentazione della ricerca pubblica e privata: dove vogliamo andare e con quali regole?
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio!
Il “biologo furioso” Carlo Alberto Redi torna in libreria, questa volta insieme a Manuela Monti, per raccontare la sorprendente storia di questo oggetto fondamentale della biologia che da sempre esercita un fascino speciale sulle culture di ogni epoca.
A partire dalla loro esperienza di scienziati impegnati sul campo, gli Autori ci guidano in un viaggio meraviglioso alla scoperta di noi stessi che dalla biologia passa per l’arte, la letteratura, la sociologia e - poteva mancare? - la gastronomia.
Una lettura divertente e documentata, che non si sottrae a riflessioni sui temi caldi dell’attualità scientifica.
 Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
 Pagine: 224
Pagine: 224
 Prezzo di copertina: € 19,80
Prezzo di copertina: € 19,80
 Prezzo scontato 10%: € 17,82
Prezzo scontato 10%: € 17,82 Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).
Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).Manuela Monti è biologa. Lavora alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Collabora con iisitituti di ricerca negli USA e in Giappone. È coautrice con Redi di Staminali. Dai cloni alla medicina rigenerativa (Carocci).
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) -- Violenza contro le donne. Quanto ha contato il silenzio della politica e della cultura maschile? (di Lea Melandri)4 luglio 2016, di Federico La Sala
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
- CHI SIAMO NOI IN REALTA’? Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO:
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
Violenza contro le donne
Quanto ha contato il silenzio della politica e della cultura maschile?
di Lea Melandri *
- Uomini che si interrogano su se stessi: se c’è stato un silenzio, non è «del» femminismo ma «sul» femminismo
La recente sequenza di femminicidi deve aver fatto cadere, da parte maschile, alcune delle resistenze più forti a interrogarsi come «genere», a chiedersi se la «follia omicida» di pochi non sia imparentata, nel profondo di «antiche e oscure emozioni» - come le chiama Virginia Woolf -, con l’idea di «virilità» di cui sono improntati sia la cultura alta che il senso comune.
«Viviamo ancora, noi maschi in Italia - scriveva Nicola Lagioia sulla prima pagina di Repubblica (il 10 giugno scorso - in un contesto che ci mette in una posizione di predominanza. Quanto ne siamo consapevoli? Quanto, consapevolmente o meno, cediamo alla tentazione di contribuire a cementare un modello che ci vede in differenti blocchi di partenza rispetto alle donne? E quanto siamo tentati di trasferire questo modello nel privato delle nostre relazioni sentimentali?».
Altalenando tra riflessioni più teoriche e testimonianze di vita personale, la parola degli uomini parla oggi con una coscienza di sé e della propria storia che il femminismo sollecitava da anni e che finora non era andata oltre la pratica politica di gruppi ristretti, come Maschile Plurale.
Sul Sole 24ore, un «intellettuale trentenne», Raffaele Alberto Ventura, descrive la nascita della figlia come una «piccola apocalisse»: la caduta di un intero edificio di valori e priorità, la scoperta che le «mutilazioni» che la paternità - e a maggiore ragione la maternità - avrebbe imposto a carriere, sogni di gloria, distrazioni, ecc., potevano non essere temute ma desiderate come tempo liberato dalle «promesse di un avvenire che non giungerà mai».
Si tratta di «legittimi dubbi su se stessi», sulle proprie fragilità, su logiche di potere interiorizzate inconsapevolmente e diventate «normalità», privilegio «naturale» maschile, che andrebbero però trasferite - come sottolineava giustamente Nicola Lagioia nel suo articolo - in un dibattito pubblico.
Sulla necessità del passaggio, dai cambiamenti che stanno avvenendo nelle esperienze singole e nella quotidianità a un impegno più esteso che investa la cultura e la politica, sono totalmente d’accordo, ma non posso non chiedermi perché non è ancora avvenuto, perché le riflessioni e le pratiche di mezzo secolo di femminismo siano tenute ancora nell’ombra, per non dire osteggiate, date per morte e richiamate in vita all’occorrenza.
Come ho scritto più volte, se c’è stato un silenzio, non è «del» femminismo ma «sul» femminismo. Nelle pagine dei maggiori quotidiani nazionali, che oggi sembrano aprirsi a una parola maschile inusuale, si aspetta ancora, e non si sa per quanto, la voce di quella rivoluzione delle coscienze che ha portato allo scoperto e analizzato nella sua complessità, un dominio del tutto particolare, che ha visto confuse logiche d’amore e di guerra, tirannie del privato e del pubblico. Gli archivi, i centri di documentazione, le case delle donne conservano scrupolosamente memoria di un sapere a cui pochissimi uomini, compresi gli insospettabili, hanno portato il loro sguardo: libri, riviste, documenti che per entrare nel dibattito mediatico, televisivo, dovrebbero prima di tutto essere letti.
È per questo che, a differenza degli altri, l’articolo di Michele Serra (apparso su Repubblica.it il 12 giugno) mi ha irritato e convinto che è stata prima di tutto le generazione maschile degli anni ’70 a volersi liberare del peso inquietante di relazioni, intellettuali e sentimentali, che stavano cambiando rapidamente, sotto la spinta di presenze femminili «impreviste», nelle case come nelle piazze e nei luoghi tradizionali della politica.
È vero che «per spiegare l’orrore delle tante donne assassinate» non bastano - come scrive Serra - le analisi della psicologia e della criminologia, che portano tra l’altro firme quasi esclusivamente maschili. La mancanza di una «parola politica» ha permesso che un fenomeno «strutturale», radicato nella storia di tutte le civiltà, restasse confinato nella patologia o in zone marginali di arretratezza, disagio sociale.
Ma le nostre convinzioni e le nostre idee non sono mai state separate da «materiali psichici complessi», e se hanno potuto spesso diventare «ideologiche», cioè un volontaristico «dover essere», goffamente svincolato da pulsioni profonde, durature e difficilmente modificabili, è proprio perché questi «nessi» raramente vengono visti e indagati. L’intuizione più radicale del femminismo degli anni ’70 è stata la messa in discussione di tutte le contrapposizioni astratte, a partire da quella che ha deciso del destino dell’uomo e della donna, a cui ha fatto seguito la ricerca di legami che ci sono sempre stati tra il corpo, la sessualità e la politica, tra la ragione e i sentimenti, la cultura e la vita.
Lo slogan «il personale è politico» - che Serra traduce erroneamente con «il privato è politico» - intendeva portare allo scoperto la storia non scritta che è rimasta sedimentata nella memoria dei corpi, nelle configurazioni inconsce, restituire alla cultura, alla storia tutte quelle esperienze dell’umano - le più universali - che sono rimaste confinate nella natura. E perciò immodificabili. In altre parole, si andava verso una «sprivatizzazione» del rapporto tra i sessi, ma anche tra individuo e società, famiglia-Stato, e così via. Può darsi che il femminismo sia stato vissuto dai «ragazzi» di quella generazione come una «forzatura ideologica» e che la scomparsa di slogan così mirati a un cambiamento che partiva dalle loro vite, dalle loro relazioni familiari e amorose, sia apparsa liberatoria.
Ma non si capisce allora perché Serra oggi li rimpianga, riconoscendo in quelle parole «brevi e di implacabile precisione» una idea rivoluzionaria capace di «modificare la struttura sociale perfino più radicalmente di quanto la muterebbe la sovversione della gerarchia padrone-operaio». Se le idee che parvero allora «troppo determinanti» oggi valgono come detriti di un passato, o banalità scontate - come le definisce Serra -, se hanno perso appeal per quanto riguarda il discorso politico, non è certo perché le femministe abbiano smesso di pronunciarle e scriverne, farne oggetto delle loro pratiche. La sordità, l’indifferenza o la volontaria messa in ombra hanno contraddistinto innanzi tutto una politica e una cultura ancora saldamente in mano agli uomini, esitanti a volgere lo sguardo su di sé e a riportare al proprio interno le consapevolezze nuove che venivano dal movimento delle donne, che interrogavano allo stesso modo la sfera privata e quella pubblica, l’esperienza del singolo e la vita sociale, lo psichismo profondo e le storia che vi è cresciuta sopra.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI"... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali). -- I margini infuocati del mondo. Intervista a Gayatri Chakravorty Spivak (di Francesca Maffioli)25 giugno 2016, di Federico La Sala
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
CulturaI margini infuocati del mondo
Gayatri Chakravorty Spivak. Un’intervista con la teorica femminista indiana, presenza fondamentale dei postcolonial e subaltern studies. Disapprendere il proprio privilegio significa imparare a costruire una relazione etica e politica tra i viventi
di Francesca Maffioli (il manifesto, 23.06.2016)
Contestare l’occupazione da parte dell’Occidente e della filosofia occidentale riguardo la posizione di Soggetto cardine del discorso è sempre stato un punto fondamentale dell’analisi di Gayatri Chakravorty Spivak. Così anche in un recente incontro pubblico tenutosi presso la sede dell’University of Paris, e titolato emblematicamente Il presente in dissolvenza, la filosofa e femminista ha sottolineato la presa di parola da parte dei «soggetti subalterni», secondo una logica di decostruzione di questa dinamica gerarchizzata e ignorante della diversità.
Il soggetto che le interessa è sessuato, femminile, messo a margine da un sistema di valori centralizzato, in cui l’Occidente è sovrano e l’altra esiste in quanto oggetto da analizzare, da rappresentare e da controllare, anche nel momento della locuzione.
Quando alla «subalterna» è concessa la parola si tratta, infatti, di una parola che mima le aspettative del Soggetto che le ha permesso la libertà di espressione. La finalità della presa di parola del «soggetto subalterno donna», in comunicazione con il soggetto femminista occidentale, dovrebbe passare, secondo Spivak, dal superamento e dalla decostruzione dei rapporti gerarchici e dalla (ri)costruzione di un dialogo tra agenti parlanti. Si tratta di articolare un’agentività che implica un’egemonia non convenzionale, oltre i sistemi simbolici prestabiliti - in uno spazio dove la comunicazione si costituisce in quanto atto performativo.
Quanto, disporci all’ascolto di un «Other Knowledge», può renderci aperti a spazi di comunicazione che consentano di cogliere le opportunità per un dialogo con le voci marginalizzate? In che misura mettere in discussione la credibilità e la significatività di categorie teoretiche apprese agevolerebbe i requisiti per instaurare una comunicazione che ci volga alla comprensione dell’altra e dell’altro, della subalterna e del subalterno?
Abbiamo incontrato Gayatri Chakravorty Spivak per porle qualche domanda a riguardo.
Il suo monito «unlearn one’s privilege as one’s loss», ovvero «disimparare il proprio privilegio perché è una perdita», l’ha portata a riconsiderare il privilegio, anche di carattere gnoseologico, per (auto)instillare il dubbio critico e stabilire un rapporto etico con l’altro e l’altra - nell’obiettivo cioè di apprendere ad ascoltare le voci marginalizzate. Crede che oggi sia ancora valido?
Voglio partire dalla mia esperienza biografica, dalla storia della mia condizione di soggetto privilegiato in un contesto esplicitamente e sfacciatamente non-egualitario: il sistema delle caste hindu. Questo sistema, apparentemente imprescindibile, i ruoli sociali occupati dalla mia stessa famiglia di origine, costituiscono l’esemplificazione di privilegi millenari profondamente radicati. Ciò per dire che vi è una radicata struttura di potere in cui sono consapevole di essere attualmente collocata, riguardo per esempio il mio ruolo accademico negli Stati Uniti. Questa breve premessa che introduce ai privilegi che ho conosciuto, vuole essere però funzionale a ciò che intendo quando convoco il senso del disapprendere. Disimparare il privilegio significa allora costruire la risposta a un modello teorico a partire dalla mia esperienza di donna privilegiata, cresciuta in una famiglia facoltosa, in un sistema di diseguaglianze non celate.
La decostruzione dei propri privilegi può allora condurre ad una comunicazione autentica e a farci attori ed attrici di una pratica dialogica relazionale, definibile come relazionalità etica?
Il disapprendimento dei propri privilegi non significa la loro decostruzione. Sarebbe stata una posizione eccessivamente narcisistica da parte mia quella dell’insistenza, negli anni, verso il non riconoscimento e l’inconsapevolezza dei miei privilegi. Sarebbe stato come ripiegarsi nella negazione, riconoscere solo come perdita il privilegio di essere nata in una famiglia facente parte della casta dei brahmani (la casta sacerdotale, la prima delle quattro caste della società induista, ndr). A partire da un esatto momento della mia vita ho smesso di considerare i miei privilegi come perdita: ho trasformato questa presa di coscienza in un vettore di chance per la ricerca, in una pratica di utilizzo volta al dialogo con i soggetti meno ascoltati, i soggetti per cui l’identità e la parola sono forcluse. La necessità di «unlearn one’s privilege as one’s loss» deve essere rivista, completata secondo il fluire trasformativo del mio pensiero, che nel tempo ha subito delle evoluzioni. Devo confessare che questa considerazione l’avevo concepita precocemente, ben prima di entrare nel cuore dei temi che poi ho trattato nella mia attività di ricerca. In altre parole, credo sia fondamentale focalizzarsi sui privilegi, ma invece di disapprenderli, o prima ancora di imparare a disapprenderli, è necessario vedere dove essi si situano, riconoscerli e «to use them»: vedere e usare un privilegio in maniera funzionale, per volgersi a nuove pratiche di apprendimento e di comunicazione.
I riferimenti a questi interrogativi, come lei ce li descrive, sono suggeriti anche dalle intuizioni dalla filosofa e femminista postcoloniale Sara Ahmed che nel suo «Declarations of Whiteness: The Non-Performativity of Anti-Racism» sostiene come le stesse culture dell’apprendimento siano modellate esattamente sul privilegio...
Disapprendere il privilegio deve infatti trasformarsi in «learning to learn by below». Imparare a imparare dal basso, disattendendo le aspettative e le risposte che ci saremmo aspettati di ricevere e modificando i meccanismi di apprendimento, diventa un processo attivo per minare i meccanismi di dominazione e di controllo. Ammettere il privilegio significa cambiare la propria prospettiva d’osservazione, rappresenta il tentativo di ruotare l’angolo d’apprendimento attraverso cui ci hanno insegnato si debba guardare; significa andare oltre la tradizione che ha limitato le opportunità per una conoscenza alternativa. La prima fase per mettersi in ascolto dell’altro, per consentire che alle nostre orecchie la sua parola non sia muta, è dunque il riconoscimento critico del proprio privilegio.
* BIOGRAFIA E RICEZIONE - Al centro del dibattito internazionale e fuori commercio in Italia
Dal 2007, Gayatri Chakravorty Spivak, insegna alla Columbia University e fa parte dell’Institute for Comparative Literature and Society. Teorica della letteratura e critica femminista, è riconosciuta come una delle figure di spicco degli studi post-coloniali.
 Si deve al suo contributo in quanto traduttrice l’introduzione della filosofia contemporanea francese - e in particolare di Jacques Derrida - nell’accademia statunitense. Ha partecipato alla fondazione a Dehli nel 1982 della rivista «Subaltern Studies» e nel 1988 ha codiretto la pubblicazione del celebre Selected Subaltern Studies.
Si deve al suo contributo in quanto traduttrice l’introduzione della filosofia contemporanea francese - e in particolare di Jacques Derrida - nell’accademia statunitense. Ha partecipato alla fondazione a Dehli nel 1982 della rivista «Subaltern Studies» e nel 1988 ha codiretto la pubblicazione del celebre Selected Subaltern Studies.
 Si deve a Spivak inoltre la pubblicazione di uno degli articoli fondatori degli studi post-coloniali, intitolato «Can the Subaltern Speak» del 1983: la filosofa ha contribuito infatti a rilanciare il termine di «subalterno» che Ranajit Guha aveva ripreso direttamente dalla concezione marxiana di Gramsci, per riconfigurarlo nella prospettiva della voce della donna subalterna e non in quella della storia raccontata dagli altri, il patriarcato o gli stati coloniali.
Si deve a Spivak inoltre la pubblicazione di uno degli articoli fondatori degli studi post-coloniali, intitolato «Can the Subaltern Speak» del 1983: la filosofa ha contribuito infatti a rilanciare il termine di «subalterno» che Ranajit Guha aveva ripreso direttamente dalla concezione marxiana di Gramsci, per riconfigurarlo nella prospettiva della voce della donna subalterna e non in quella della storia raccontata dagli altri, il patriarcato o gli stati coloniali.
 Tra le sue opere più note si ricordano: «A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present» (1999), «Death of a Discipline» (2003) e «An Aesthetic Education in the Era of Globalization» (2012).
Tra le sue opere più note si ricordano: «A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present» (1999), «Death of a Discipline» (2003) e «An Aesthetic Education in the Era of Globalization» (2012).
 In Italia, grazie alle traduzioni e le cure di Ambra Pirri, Angela D’Ottavio, Patrizia Calefato, Vita Fortunati, Lucia Gunella, Sandro Mezzadra e altri, alcuni suoi titoli, molti dei quali ormai fuori commercio, sono stati pubblicati per le case editrici Meltemi e ombre corte.
In Italia, grazie alle traduzioni e le cure di Ambra Pirri, Angela D’Ottavio, Patrizia Calefato, Vita Fortunati, Lucia Gunella, Sandro Mezzadra e altri, alcuni suoi titoli, molti dei quali ormai fuori commercio, sono stati pubblicati per le case editrici Meltemi e ombre corte.
 Il 6 giugno l’University of Paris, l’Institut Humanités et Sciences de Paris (Université Paris Diderot) e il CIPh (Collège International de Philosophie) hanno organizzato una giornata dedicata alla filosofa: «Pensée post-coloniale et genre. Rencontre autour de Gayatri Chakravorty Spivak». Il titolo della sua conferenza è stato «The Vanishing Present».
Il 6 giugno l’University of Paris, l’Institut Humanités et Sciences de Paris (Université Paris Diderot) e il CIPh (Collège International de Philosophie) hanno organizzato una giornata dedicata alla filosofa: «Pensée post-coloniale et genre. Rencontre autour de Gayatri Chakravorty Spivak». Il titolo della sua conferenza è stato «The Vanishing Present». - CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
-
> DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) --- I maestri del disprezzo per le donne (di Daniela Monti)8 giugno 2016, di Federico La Sala
I maestri del disprezzo per le donne
di Daniela Monti (Corriere della Sera, 08.06.2016)
Nel 1929 Virginia Woolf, nel saggio Una stanza tutta per sé, inventa una storia: quella di Judith, ipotetica sorella di William Shakespeare, stessa genialità, stessa irrequietezza, stessa voglia di fare del fratello. Per seguire il proprio talento, Judith si istruisce come può, leggendo il poco che trova per casa (ma appena i genitori se ne accorgono, le tolgono i libri e le mettono in mano delle calze da rammendare), rifiuta il matrimonio spezzando il cuore al padre, scappa per inseguire il sogno di fare teatro e viene accolta da un impresario che la schernisce e da un agente teatrale che, impietosito, la mette incinta. Alla fine, non trova altra via di uscita che uccidersi.
Mentre il talento del fratello è celebrato, il suo non vale niente: ha sfidato l’ordine naturale delle cose che la vuole debole, inferiore, indegna di ricevere un’istruzione e, insieme, selvaggia e ingestibile, una a cui mettere fin da subito il guinzaglio; si è illusa di potersi esprimere da donna e artista, senza neppure ricorrere all’espediente di camuffarsi da uomo, che pure è una strada battuta; ha sbagliato tutto, è andata fuori ruolo e infatti non c’è nessuno disposto ad ascoltarla. Così Judith «giace sepolta a un certo incrocio, lì dove ora gli autobus si fermano nei pressi di Elephant and Castle». Potessimo posare una lapide mortuaria, sopra ci sarebbe scritto: coraggiosa e ingenua Judith Shakespeare, vittima di due millenni di pregiudizi contro le donne.
Perché quello contro il genere femminile, «a conti fatti, appare come il più antico, radicato, diffuso pregiudizio che la vicenda umana è stata in grado di produrre», scrive Paolo Ercolani nel suo Contro le donne (Marsilio, pp. 318, e 17,50), resoconto dettagliato di come, dalle origini della società occidentale, scrittori, filosofi, intellettuali abbiano alimentato un dibattito «tutto fra uomini» - le donne sembrano assenti dalla filosofia, se non come oggetto del discorso dei filosofi maschi - «per arrivare a stabilire l’inferiorità inemendabile e irrecuperabile dell’essere femminile». I grandi filosofi greci, i padri della Chiesa, gli illuministi, i rivoluzionari, i filosofi idealisti, persino quel campione della causa femminile che fu John Stuart Mill: un’operazione culturale a senso unico che affonda le radici nella presunta «deficienza fisica» delle donne per poi esportare tale mancanza in altri campi, quelli dell’etica, della morale, dell’organizzazione politica della società.
Fu nell’Atene democratica, «tanto esaltata dalla tradizione occidentale, che si diffuse il costume di imporre alle donne il velo di fronte a situazioni pubbliche e a uomini scapoli, al contrario di quello che accadeva a quel tempo in Persia o in Siria», scrive Ercolani, aprendo il fronte della globalizzazione del pregiudizio, il quale, come le malattie contagiose, è riuscito a infettare culture lontane e all’apparenza inconciliabili, stringendole in un unico blocco misogino.
E loro, le donne? «Molto spesso sono le donne stesse a sminuirsi rispetto al maschio, in una sorta di autofobia indotta da secoli di indottrinamento», scrive Ercolani. Il femminismo, che pure è una delle grandi narrazioni della modernità, resta ai margini del lungo excursus, diventando esso stesso un bersaglio quando «negando l’esistenza di una specificità femminile (differente dal maschio) e prefigurando irrealistici scenari di individui a-sessuati ha finito con il fare da sponda al pensiero misogino».
La via d’uscita proposta sta nel ridefinire i canoni dell’identità e soggettività umana, al di là del «narcisismo di genere». Come scriveva Caterina Botti nel suo Prospettive femministe (Mimesis), «fino a relativamente poco tempo fa l’assenza delle donne dalla filosofia non era considerata una questione degna di nota. Oggi invece lo è».
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
- DAL "CHE COSA" AL "CHI" ... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant
- IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" -DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Apriamo gli studenti all’ubuntu (di Luca M. Scarantino)6 giugno 2016, di Federico La Sala
- Per la dignità e la libertà di tutti gli esseri umani ...
 UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone". NELSON MANDELA, UN COMBATTENTE SUL RING DELLA STORIA.
UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone". NELSON MANDELA, UN COMBATTENTE SUL RING DELLA STORIA.
- DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali
 DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
- LA SCUOLA, IL WEB, E LA LEZIONE DI KANT. "SAPERE AUDE!": IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ .....
 IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO NELLA CAVERNA DI IERI E DI OGGI. (federico la sala)
IL MONDO COME SCUOLA, LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO, LA CREATIVITA’, I NATIVI DIGITALI, E L’ATTIVISMO CIECO NELLA CAVERNA DI IERI E DI OGGI. (federico la sala)
OLIMPIADI DI FILOSOFIA
Apriamo gli studenti all’ubuntu
 di Luca Maria Scarantino (Il Sole-24 Ore, 05 giugno 2016)
di Luca Maria Scarantino (Il Sole-24 Ore, 05 giugno 2016)Donna non si nasce, lo si diventa: commentando questa celebre massima di Simone de Beauvoir, due liceali della Corea del Sud hanno vinto le Olimpiadi mondiali di filosofia. La terza medaglia d’oro, ex-aequo, è andata a uno studente turco, autore di un saggio sulla logica di Aristotele. Nessun paese aveva mai ottenuto due primi posti in una stessa edizione.
Leggendo gli elaborati nello splendore fiammingo di Gent, ripensavo alle parole di un collega della giuria. «Stanno vincendo», mi aveva detto il giorno prima, mentre i militari belgi in tenuta di guerra ci perquisivano in prossimità dell’aeroporto di Charleroi: nell’Europa sotto attacco siamo noi le armi che i nostri nemici stanno preparando. Non si tratta solo di abitudini quotidiane sconvolte da questo stato d’assedio strisciante. È la crescente tentazione di chiudersi, di ripiegarsi in una tradizione, in un’identità, di restringere il proprio mondo a un insieme circoscritto, rassicurante, quasi tribale di coordinate culturali. Gli scritti dei liceali venuti a Gent da tutto il mondo per comporre un breve saggio di filosofia dicevano cose molto diverse.
«Ogni volta che devo barrare una casella, la società mi impone di scegliere “femmina”; eppure tutto dentro di me si sente maschio»: inizia all’incirca così uno degli elaborati vincitori. «Sono donna perché da diciassette anni la società mi impone di esserlo... ma ogni donna dovrebbe battersi non solo per il diritto di diventare donna, ma anche per quello di non diventarlo»: parole decise, coraggiose e piene di vita di ragazze e ragazzi coreani, svizzeri, norvegesi, croati che non hanno paura di esplorare i propri sentimenti e la propria identità di genere, servendosi della filosofia per capire meglio se stessi e la società in cui vivono. Oltre metà delle medaglie d’oro e d’argento, compresi due dei tre vincitori, sono andate a saggi dedicati a questi temi. Non è strano che adolescenti cerchino di costruirsi, né che si interroghino sul proprio rapporto con la società che li circonda; ma è evidente che la rilevanza sociale delle questioni di genere sta diventando un fenomeno universale, parecchio sentito da questi ragazzi che si chiedono in modo consapevole quanto siano pertinenti per la loro vita le norme tradizionali che regolano l’identità di genere: e lo fanno con stili, convinzioni, tesi e conclusioni assai diverse.
Alcuni colleghi europei si chiedevano quanto gli studenti giapponesi, indiani, coreani o cinesi conoscano la tradizione filosofica occidentale. I saggi arrivati in finale ci dicono che maneggiano assai bene Aristotele e Putnam, Locke e Wittgenstein, Foucault, Heidegger, Sartre e Derrida, la tradizione analitica e il pensiero femminista... Questa familiarità con altri mondi, unita a sistemi educativi particolarmente efficaci, aiuta a capire i ripetuti successi degli studenti asiatici.
Chiediamoci allora quanto i nostri studenti, liceali o universitari, conoscano delle altre culture e siano esposti al confronto con esse. Cosa sanno i ragazzi italiani (e prima ancora: cosa sappiamo noi) di Nishida, Wonhyo, Dasan, Laozi, dell’ubuntu, di Senghor, Iqbal e di tanti altri autori e autrici di formidabile rilievo teorico e culturale? Qualcosa si muove, certo; le iniziative rivolte ad aprire l’insegnamento della filosofia e delle scienze umane in senso interculturale non si possono più trascurare; e l’Italia non sta peggio di altri paesi europei. Eppure, troppo spesso si continua a identificare la filosofia con la filosofia occidentale.
È tesi corrente, in Italia e non, che molte delle espressioni culturali non occidentali siano forme di spiritualità, di religiosità, di saperi tradizionali - ma non siano filosofia. Può darsi. Ma da sempre il pensiero filosofico trae la propria forza dalla capacità di integrare una pluralità di forme e pratiche culturali, sino a fondersi con esse: si pensi all’indissolubile rapporto con la religione che ha caratterizzato gran parte del pensiero occidentale, o all’importanza dell’astrologia che attraversa l’intero Rinascimento. Certo, proprio questi saperi, una volta esaurito il proprio ruolo storico, sono stati rifiutati, evacuati dalla comprensione storica del pensiero filosofico: al punto che oggi non siamo quasi più in grado di riconoscerli.
Ma a cosa può aspirare oggi una filosofia che si mura entro un’unica tradizione, lasciando fuori e anzi respingendo oltre i propri confini intere tradizioni spirituali e di pensiero? Davvero vogliamo escludere dall’ambito del pensiero filosofico interi secoli di storia della cultura, abbandonare ad altre discipline lo studio del sufismo, del confucianesimo, delle tradizioni dell’India? Aprire invece, viene da pensare, spalancare le porte della propria mente a culture, filosofie, letterature, religioni di tutto il mondo, anche a costo di scardinare alcuni riflessi culturali ben radicati nella tradizione europea: è di questo che hanno bisogno questi ragazzi per competere nel mondo di oggi e di domani.
La Corea raccoglie i frutti di decenni di investimenti in cultura, educazione, scienze; ed è comunque probabile che già l’anno prossimo si abbiano vincitori di paesi diversi. Eppure, da uno dei più suggestivi borghi della vecchia Europa giunge un segnale da non sottovalutare: al netto di facili generalizzazioni, molti ragazzi extra-europei, e asiatici in particolare, sembrano assai meglio preparati a muoversi nella complessità del mondo di oggi. Ne capiscono e ne affrontano di petto i problemi, le esigenze, le difficoltà. Anche con qualche ingenuità, certo. Ma non hanno alcuna paura di mettersi in gioco: sono gay, ci dice la ragazza coreana con inesorabile forza argomentativa, e se la società vuole a tutti i costi fare di me una donna, allora la società va cambiata. Chissà se i risultati delle Olimpiadi di Gent saranno motivo di stimolo e di accresciuta apertura anche per il nostro sistema educativo.
- Per la dignità e la libertà di tutti gli esseri umani ...
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- LA CONFESSIONE E IL DESIDERIO DI MICHEL SERRES.21 maggio 2016, di Federico La Sala
"Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986):
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" - DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE -- "Il mancino zoppo": Serres, il computer e San Dionigi (di Luigi Bruschi)20 maggio 2016, di Federico La Sala
La Città Invisibile
Serres, il computer e San Dionigi
di Luigi Bruschi *
Michel Serres è un filosofo francese molto noto in tutto il mondo. I suoi interessi hanno riguardato la matematica, la storia della scienza, la comunicazione, l’informatica, la politica e l’ecologia. Docente presso l’ Université - I - Panthéon-Sorbonne e presso la Stanford University, viene considerato l’ultimo dei maîtres a penser di Francia.
«Michel Serres è la mente filosofica più fine che esista oggi in Francia» ebbe a dire di lui, in una sua lectio magistralis del 2015, Umberto Eco.
Michel Serres - 85 anni - conferma alla grande questo lusinghiero giudizio con il suo ultimo bellissimo libro dal titolo Il Mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente (Bollati Boringhieri, aprile 2016, pp. 285, € 18,00).
Un libro così denso di idee affascinanti che richiederebbe molte pagine solo per darne dei cenni. Mi limiterò pertanto ad un paio di argomenti.
Il primo è quello che illustra in qualche modo il titolo. Secondo Serres l’evoluzione «deriva dagli scarti dell’equilibrio» e sono i personaggi sghembi e magari difettosi a realizzare questi scarti perché per loro è più facile imboccare le biforcazioni.
Non a caso Mosè è balbuziente, Edipo ha i piedi gonfi e discende da Labdaco, «il cui nome significa "zoppo", "asimmetrico", come le due gambette, una più corta e una più lunga, della lettera greca lambda». Efesto «gobbo e deforme, fabbro geniale, che Omero chiama Κυλλοποδίων cioè "Piè-Zoppo" non era mancino, ma avrebbe meritato di esserlo» e molti altri sono gli esempi.
«Per innovare, bisogna uscire dal cammino previsto, biforcare. Innovare significa biforcare. Il mio mancino zoppo è qualcuno che è “biforcato” nel corpo. E’ una metafora, perché non voglio dire che tutti gli innovatori siano mancini o zoppi o tutti e due insieme. Però, per esempio, i miti dell’Antichità sono pieni di zoppi». (intervista a La Stampa, Salone del Libro).
E nel libro possiamo leggere:
«La mutazione presuppone la diversa lettura di un messaggio - un errore? - come se il lettore, mancino, o il trascrittore, zoppo, avesse dato anche segni di strabismo».
La seconda questione (collegata alla prima) di cui voglio parlare è l’entusiasmo di Serres per l’innovazione e per "la mutazione antropolgica indotta dalle tcnologie".
Per magnificare il computer il filosofo ricorre al supplizio di San Dionigi che (come racconta nella Legenda aurea Jacopo da Varagine) decapitato da un centurione romano si china a terra per raccogliere la sua testa e portarla in cima alla collinetta di Montmartre.
«Adesso considerate il computer, lì sul tavolo, di fronte a voi, è sotto le vostre mani: dotato di una memoria colossale, non paragonabile alla mia o alla vostra, fornito di un motore di ricerca che presentifica il ricordo quasi all’istante; ricco di un numero gigantesco di immagini; provvisto, infine, di programmi capaci di risolvere mille calcoli operazioni che né voi né io sapremo portare a buon fine. [...] Le nostre facoltà non sono forse ancora una volta appena salpate, uscite dal corpo, esternalizzate?[1] Eccoci decapitati come il Vescovo di Lutezia: prodotta nel senso forte del termine, la nostra testa rotola davanti a noi, e noi la teniamo tra le mani. Il miracolo previsionale della Legenda aurea ha avuto luogo. Chiamate "Dionigi" la vostra macchina.
Sì, perché quella testa è il nostro computer.
Ancora una volta resto stupito dall’entusiasmo di un pensatore che palesa un’audacia intellettuale insospettabile in un’età così avanzata.
Ennesima dimostrazione che l’intelligenza poco ha a che fare con l’anagrafe.
- Léon Bonnat, Le martyre de Saint-Denis (particolare) - Paris Panthéon
* [l’Espresso, Verba Woland, 15 mag 2016->http://bruschi.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/15/serres-computer-zoppo/] (ripresa parziale).
MICHEL SERRES
 "Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente".
"Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente".Indice
Premessa - Pensare, inventare - Il viaggio e l’itinerario
Tempo
I. Le cose del mondo
 Quattro regole universali - Informazione, novità
Quattro regole universali - Informazione, novitàII. Viventi, idoli, idee
 Figure di flora e di fauna - Trasformazioni - I feticci - Imitare o trasformarsi - L’ego di questo cogito - Pensare costruendosi - Un albero della conoscenza - Idea o figura? - Un esempio di questo processo: il vulcano greco - Sfolgorii della bellezza
Figure di flora e di fauna - Trasformazioni - I feticci - Imitare o trasformarsi - L’ego di questo cogito - Pensare costruendosi - Un albero della conoscenza - Idea o figura? - Un esempio di questo processo: il vulcano greco - Sfolgorii della bellezzaIII. Il corpo inventivo
 Le età del corpo - La durata del pensiero - La storia o l’oblio - Emergenza di personaggi annunciatori - Emergenza: scoperta - Emergenza: l’acqua trasformata in vino - Emergenza: incarnazione
Le età del corpo - La durata del pensiero - La storia o l’oblio - Emergenza di personaggi annunciatori - Emergenza: scoperta - Emergenza: l’acqua trasformata in vino - Emergenza: incarnazioneFigure e movimenti
IV. Personaggi
 Esplosione di mille personaggi - La filosofia produce personaggi - Il pastore che guida molteplicità fluttuanti - Molteplicità - Prime figure dolci
Esplosione di mille personaggi - La filosofia produce personaggi - Il pastore che guida molteplicità fluttuanti - Molteplicità - Prime figure dolciV. Messaggeri
 Di ritorno al Grande Racconto - Altri personaggi - Doppio peso della figura - Apertura politica? - Inviare o esternalizzare - Angeli messaggeri - L’ego del nuovo cogito - I miei tre giri del mondo
Di ritorno al Grande Racconto - Altri personaggi - Doppio peso della figura - Apertura politica? - Inviare o esternalizzare - Angeli messaggeri - L’ego del nuovo cogito - I miei tre giri del mondoVI. Levare gli ormeggi
 Macchine semplici e macchine a vapore - San Dionigi decollato - Pensare, inventare - I personaggi emergono alla fine dell’analisi - Cogito, cogitamus - Pensare, inventare, ossia produrre - Delle interferenze - Ritorno ai feticci
Macchine semplici e macchine a vapore - San Dionigi decollato - Pensare, inventare - I personaggi emergono alla fine dell’analisi - Cogito, cogitamus - Pensare, inventare, ossia produrre - Delle interferenze - Ritorno ai feticciVII. Il mancino zoppo
 I suoi scarti dall’equilibrio producono movimento - Lo schema corrispondente - La deviazione - Modello generale - I modelli migliori - Pensare o pesare - La nostra essenziale debolezza - Chiasmo, rottura di simmetria - Un elogio della distrazione - Essere-nel-mondo - Invenzione x: corpo e anima - La rete - Banalità - Il sesto senso, la propriocezione - La più antica metamorfosi - Sostanza e sostituzione - Di nuovo, degli inviati - Serendipità contro metodo - Ambo: variazioni attorno al punto vernale - Il ramo delle confluenze - La confusione dimostrata - Tempio e tenda - Cattedrale - Deviazione per Città del Messico - Il passo della temporalità - Novità
I suoi scarti dall’equilibrio producono movimento - Lo schema corrispondente - La deviazione - Modello generale - I modelli migliori - Pensare o pesare - La nostra essenziale debolezza - Chiasmo, rottura di simmetria - Un elogio della distrazione - Essere-nel-mondo - Invenzione x: corpo e anima - La rete - Banalità - Il sesto senso, la propriocezione - La più antica metamorfosi - Sostanza e sostituzione - Di nuovo, degli inviati - Serendipità contro metodo - Ambo: variazioni attorno al punto vernale - Il ramo delle confluenze - La confusione dimostrata - Tempio e tenda - Cattedrale - Deviazione per Città del Messico - Il passo della temporalità - NovitàSpazi e campi
VIII. Traversate
 Il feticcio attraversa più regioni - La filosofia come traversata - Analisi triviale - Una legge dei tre stadi - L’inviante e l’inviato - Dualità della decisione - Dalla marineria al governo e alla teologia - Nave e governo - L’inviato, il deviato o il vagabondo - Le proposizioni indicizzano le geodetiche della Pantopia
Il feticcio attraversa più regioni - La filosofia come traversata - Analisi triviale - Una legge dei tre stadi - L’inviante e l’inviato - Dualità della decisione - Dalla marineria al governo e alla teologia - Nave e governo - L’inviato, il deviato o il vagabondo - Le proposizioni indicizzano le geodetiche della PantopiaIX. Tra
 La tempesta di Giorgione - Lo spazio del pensiero si situa "tra" - Carpaccio, Sacra Conversazione - Questo non è uno scenario - Rivali di Goya - Spazio di comunicazione: energia, topologia - Delle cose, prima di tutto - Denaro e quasi oggetti - Utopia dello stadio: il pallone - Chimica delle catalisi - Dei viventi - Gli umani - Scienze cognitive primitive - Per vedere il sapere - Invenzione della pietra filosofale - Mi-lieu e milieu - Anassimandro e lo spazio indefinito - Le matematiche - Fisica e chimica - I voli spaziali abitati - Il messaggero diventa il messaggio - Corpi - Da capo: una favola alla rovescia - Esitazione tra presenziale e virtuale - Annunciazione, Visitazione, nozze di Cana - Religione
La tempesta di Giorgione - Lo spazio del pensiero si situa "tra" - Carpaccio, Sacra Conversazione - Questo non è uno scenario - Rivali di Goya - Spazio di comunicazione: energia, topologia - Delle cose, prima di tutto - Denaro e quasi oggetti - Utopia dello stadio: il pallone - Chimica delle catalisi - Dei viventi - Gli umani - Scienze cognitive primitive - Per vedere il sapere - Invenzione della pietra filosofale - Mi-lieu e milieu - Anassimandro e lo spazio indefinito - Le matematiche - Fisica e chimica - I voli spaziali abitati - Il messaggero diventa il messaggio - Corpi - Da capo: una favola alla rovescia - Esitazione tra presenziale e virtuale - Annunciazione, Visitazione, nozze di Cana - ReligioneX. Serre
 Serre - Topologia aperta-chiusa di questo spazio - Porte, pori, passi, ponti, porti - Dell’amore e dell’odio - Abitare, ancora - Ancora l’amore
Serre - Topologia aperta-chiusa di questo spazio - Porte, pori, passi, ponti, porti - Dell’amore e dell’odio - Abitare, ancora - Ancora l’amorePotenze
XI. Preposizioni
 Eureka!
Eureka!XII. Elogio del virtuale
 Il quadrato modale: del dolce e del virtuale - La virtù del virtuale - Breve racconto della mano: come pervenne al dolce - Come il dolce perviene alla blocca e al corpo - Non definire la vita - Dei personaggi possibili - Rivalsa del virtuale - Morale della storia - L’impotente - Che cos’è la letteratura - Il ritorno del Terzo Istruito
Il quadrato modale: del dolce e del virtuale - La virtù del virtuale - Breve racconto della mano: come pervenne al dolce - Come il dolce perviene alla blocca e al corpo - Non definire la vita - Dei personaggi possibili - Rivalsa del virtuale - Morale della storia - L’impotente - Che cos’è la letteratura - Il ritorno del Terzo IstruitoXIII. Capitale
 Gli strumenti musicali capitalizzano dei possibili - Che cos’è un artefatto? - Progresso: da una finalità ristretta a fanalità generalizzate - Avatar degli artefatti - Apertura delle finalità - Riassunto in tre stadi - Il possibile come capitale - Ed ecco il capitale - La caverna inondata di luce - La notte delle luci e delle molteplicità - Dalle rivoluzioni per rotazione a un Universo in espansione - Materia e specchi
Gli strumenti musicali capitalizzano dei possibili - Che cos’è un artefatto? - Progresso: da una finalità ristretta a fanalità generalizzate - Avatar degli artefatti - Apertura delle finalità - Riassunto in tre stadi - Il possibile come capitale - Ed ecco il capitale - La caverna inondata di luce - La notte delle luci e delle molteplicità - Dalle rivoluzioni per rotazione a un Universo in espansione - Materia e specchiElogio dell’attuale
XIV. Fine della rivoluzione industriale
 Fine delle età dure - Conseguenze culturali - Professioni - Della libertà banale
Fine delle età dure - Conseguenze culturali - Professioni - Della libertà banaleXV. Condizioni dolci del pensiero
 Pace - Anonimati dolci - Omnes in unum: scienze dolci e dure - Favola dell’abete e dell’acero globoso - Hermes e la pace - La distruzione uccide la concentrazione - Effetti sociopolitici: la fine della Tour Eiffel - Le Pollicine travolgono gli augusti - Degli individui invisibili in massa - Il prezzo del capo - Ancora spazi - Variazione formale sulla questione - Utopia - Sociologia dolce - Secondo capovolgimento di questo libro - Perdita dei punti di riferimento - Variazione erudita sulla questione - Un altro pastore: un’etica individuale - L’invisibilità per ciascuno - Dalla morale al diritto: un’altra foresta
Pace - Anonimati dolci - Omnes in unum: scienze dolci e dure - Favola dell’abete e dell’acero globoso - Hermes e la pace - La distruzione uccide la concentrazione - Effetti sociopolitici: la fine della Tour Eiffel - Le Pollicine travolgono gli augusti - Degli individui invisibili in massa - Il prezzo del capo - Ancora spazi - Variazione formale sulla questione - Utopia - Sociologia dolce - Secondo capovolgimento di questo libro - Perdita dei punti di riferimento - Variazione erudita sulla questione - Un altro pastore: un’etica individuale - L’invisibilità per ciascuno - Dalla morale al diritto: un’altra forestaXVI. Questo dissolverà quello
 La fluidità - Uccelli volano - Vecchio elogio dei solidi - Questo dissolverà quello
La fluidità - Uccelli volano - Vecchio elogio dei solidi - Questo dissolverà quelloInvio
 Progetto di una filosofia della storia
Progetto di una filosofia della storia -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- ENZO PACI. IL FILOSOFO E LA VITA Il rapporto tra maestro e allievo nel ricordo di Carlo Sini (di Fulvio Papi)20 maggio 2016, di Federico La Sala
- IN MEMORIA DI ENZO PACI E DELLA SUA RISPOSTA A VICO....
 IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
IL PROBLEMA GIAMBATTISTA VICO. CROCE IN INGHILTERRA E SHAFTESBURY IN ITALIA. La punta di un iceberg.
ENZO PACI. IL FILOSOFO E LA VITA
Il rapporto tra maestro e allievo nel ricordo di Carlo Sini
di Fulvio Papi *
Alla ricchissima produzione filosofica di Carlo Sini si aggiunge ora un libro di rara eleganza filosofica e narrativa. Il suo titolo, molto rapido, è Enzo Paci. Il filosofo e la vita, Feltrinelli, Milano, 2015. Se poi desiderassimo anticipare quella che è la gradevole scoperta del testo, dovremmo scrivere “La mia giovanile vita filosofica intrecciata all’esperienza decisiva di Enzo Paci della fenomenologia di Husserl”. Rendere i titoli referenziali ha solo il vantaggio di svelare al lettore un cammino di verità, poiché proprio in questo intreccio sta il fascino di queste pagine. La filosofia vive (fenomenologicamente) in una esperienza vivente, in una intenzionalità che si ripete e così si rinnova.
Siamo nel 1957 quando Sini, dopo la dolorosa scomparsa di Barié con cui era laureando, si trova a comporre il suo lavoro di tesi hegeliano nell’atmosfera filosofica che Paci sta inaugurando. È l’inizio di quell’epoca straordinaria, quando il filosofo era impegnato in una rinascita fenomenologica, che fu una esperienza molto importante nella nostra cultura. Poi Paci aveva una energia straordinaria e una dedizione totale propria di un filosofo che in Husserl trovava la modalità veritativa del pensiero. Il lavoro delle lezioni, dei seminari, della promozione editoriale, della rivista «Aut-Aut», convegni, dibattiti in Italia e all’estero. È una ebbrezza intellettuale ma anche una passione personale. Paci, che riconobbe subito Sini come un ingegno fuor dal comune e un giovane filosofo cresciuto nella filosofia, gli assegnò il posto di assistente, e così Sini fu coinvolto teoreticamente ed emotivamente in questa impresa filosofica il cui stile passava, come processo di formazione, dal maestro all’allievo. Il libro di Sini rimanda con chiarezza filosofica e con un ricordo pieno di partecipazione questo riflettersi di compiti e di obiettivi filosofici. Le pagine nella loro stilistica sobrietà fanno rinascere il tessuto vitale di quel tempo.
Lo “stacco” di Sini avviene su una domanda fondamentale: “che origine ha l’autocoscienza, come si è costituita?” Quindi Nietzsche, il pragmatismo, la concezione della scrittura alfabetica come condizione del pensiero oggettivante, le pratiche che costituiscono, nel loro intreccio, gli orizzonti filosofici e culturali. È Sini che, nella memoria del suo cammino, ci presenta un Paci vivente. Come oggi non è, per molte ragioni che potrei anche elencare facilmente. Ma chiuderò un po’ alla Kraus: “Il lavoro filosofico di Paci era troppo intelligente e troppo ampio per ridurlo a una banalità”.
- IN MEMORIA DI ENZO PACI E DELLA SUA RISPOSTA A VICO....
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- I fondamenti nascosti della società moderna: «Il contratto sessuale» di Carole Pateman (di A. Pigliaru)15 maggio 2016, di Federico La Sala
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
-
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Storie congetturali che raccontano l’inaudito
SAGGI. «Il contratto sessuale» di Carole Pateman pubblicato per Moretti&Vitali. I fondamenti nascosti della società moderna in un libro che dopo quasi trent’anni fa ancora discutere
di Alessandra Pigliaru (il manifesto, 14.05.2016)
Dare conto di ciò che Carole Pateman ha prodotto in relazione al pensiero politico moderno è decisivo. Al centro di numerose discussioni pubbliche, sia accademiche come docente al dipartimento di Scienze Politiche dell’università della California, sia politiche per le sue caustiche critiche alla democrazia liberale, tra i molti volumi e interventi che ha scritto nel corso della sua lunga vita soltanto uno è stato tradotto in italiano. Unico però, in tanti sensi - di cui il primo è l’aver costituito un punto di non ritorno. Si tratta di The sexual contract, pubblicato nel 1988 (Stanford U.P.) e tradotto per la prima volta in Italia nove anni dopo (Editori riuniti). Ormai nel dimenticatoio dei tanti «fuori commercio», è allora più che lodevole la sua recente ristampa.
Il contratto sessuale (Moretti&Vitali, pp. 339, euro 21, traduzione di Cinzia Biasini, collana «Pensiero e pratiche di trasformazione») è pietra miliare della teoria politica contemporanea, così scrive Olivia Guaraldo nell’ottima introduzione di questa nuova edizione, inquadrando il lavoro che Carole Pateman ha condotto non solo sotto il rilievo del dibattito femminista, ma anche nel senso di inaggirabilità che ha assunto nella scolarship internazionale da parte di chi si occupa di contrattualismo. A osservare la diversità di ricezione in Italia e all’estero, non potrà sfuggire che in altri paesi del mondo le ristampe sono proseguite costanti in questi decenni.
L’inganno iniziale
La discontinua ricezione de Il contratto sessuale ne perimetra tuttavia la circolazione, tracciando il terreno in cui hanno attecchito le tesi di Pateman, ovvero quasi esclusivamente nell’ambito della riflessione del pensiero della differenza sessuale (di cui l’esito più recente in merito è Sovrane, di Annarosa Buttarelli per Il Saggiatore). Avere l’occasione di rileggere un testo simile significa oggi ribadire con forza intanto la tesi iniziale, e cioè che esiste un momento precedente al contratto sociale - così chiaro nello stesso titolo - che non è stato compreso dai teorici sei-settecenteschi (Hobbes, Locke, Rousseau e poi lo stesso Kant) quando si sono prodigati dapprima a stabilire l’esistenza di quel patto secondo loro originario - e poi a descrivere con minuziosa tenacia le forme della vita associata. Tornare a Pateman non è solo consigliabile a chi desidera rispolverarne il tenore teorico-pratico.
Assistere allo svelamento dell’inganno iniziale vuol dire stanare il rimosso, misurarsi con una radicalità che può costruire un ragguardevole equipaggiamento per leggere il presente. La storia «congetturale» a cui si affida Pateman serve certo all’avanzamento rivoluzionario della sua tesi; al contempo e per converso, dispone anche la cifra di ciò che è stato «il racconto più autorevole dell’età moderna».
Molti sono allora gli elementi da rimarcare della conquistata libertà civile. Intanto non è universale, visto che il contratto originario istituisce sia la libertà che il dominio, bensì ha un attributo maschile e dipende dal diritto patriarcale.
E se massiccia è stata la decostruzione operata da Pateman intorno alla radice democratica moderna, individualista e proprietaria, la narrazione ha a che fare con la genesi del diritto politico inteso come «diritto patriarcale o diritto sessuale, ossia in quanto potere che gli uomini esercitano sulle donne»; da qui viene proposta la tesi secondo cui il contratto sessuale si mantenga su un patto tra fratelli, un «fratriarcato». Seguendo la lezione di Adrienne Rich, anche Pateman si posiziona nella certezza che esista una «legge del diritto sessuale maschile». Tale diritto è, sostanzialmente, quello coniugale.
Assunzioni materiali
Eppure, se nella separazione tra contratto sociale e contratto sessuale si viene a delineare una precisa rappresentazione (il primo è tangente alla sfera pubblica e il secondo alla sfera privata), ignorando la metà della storia si cade facilmente in equivoco. Alla fine degli anni ‘80, cioè quando Pateman scrive, ha in mente di fare luce sulle strutture istituzionali di Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti per chiarire come, attraverso l’interezza della storia del contratto originario, si verifichino comunanze patriarcali insospettabili.
In questa direzione, l’autrice analizza diversi tipi di contratto, da quello di matrimonio, disossato in verità da numerosi contributi soprattutto da parte di teoriche femministe, a quello di lavoro, come anche quello che viene a definirsi tra prostituta e cliente. Tutte assunzioni che andrebbero discusse, e che infatti lo sono state possibilmente piegandole ai vari contesti, transitori e pur sempre materiali. Se i contratti presi in esame sono connotabili da iter che ne prevedono regolamentazioni o proibizioni da parte della legge, è chiaro come si tratti di particolari forme ascrivibili alla proprietà che si ritiene ciascuno e ciascuna abbiano sulle proprie persone. Ciò nonostante, «il contratto sessuale è il mezzo attraverso il quale gli uomini trasformano il proprio diritto naturale sulle donne nella sicurezza civile patriarcale».
Contingenze complesse
A restituire gradi di attualità che il testo non solo conserva ma intuisce con puntuale efficacia, il riferimento è a una clausola su cui Pateman si sofferma alla fine del settimo capitolo e che è da tenere presente nel contratto sessuale: la maternità surrogata, definita «una nuova forma di accesso e di uso del corpo femminile da parte degli uomini».
Questo per dire come il dibattito intorno alla «surrogazione», fosse il caso di tenerlo a mente quando imperversa spesso non privo di strumentalità e costruzione di blocchi identitari, aveva assunto già alla fine degli anni ‘80 una declinazione cruciale. Il caso sollevato da Pateman accenna alla celebre sentenza disposta dalla corte del New Jersey (1986 ma in due fasi e l’una contraddittoria rispetto l’altra) passata poi alla storia come «il caso Baby M.» in cui la «madre surrogante» cambiò idea e decise di non separarsi più dalla bambina. Se il carattere vincolante dello statuto giuridico di questi contratti poneva infatti delle questioni complesse in uno scenario come quello in cui già diverse erano le agenzie aperte per la surrogazione, venivano già dettagliati numeri rispondenti a profitti precisi, differenziando circa il legame tra accordi commerciali o non commerciali con la relativa soglia di legalità e liceità o meno secondo i paesi.
Ciò che viene messa a tema è però la domanda iniziale, quella secondo cui a essere in gioco sia una semplice prestazione. Da un punto di vista contrattuale infatti è puramente accidentale che la prestazione attenga o meno a questo o a quell’oggetto, così come trascurabile è il fatto che ciò che viene prodotto sia un bambino, una bambina. Su questo punto, come per altri su cui Pateman si sofferma, Il contratto sessuale è un volume ancora incandescente che vale la pena di essere rimeditato.
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- «Il contratto sessuale» - Sovrane e libere dal potere(di M. Terragni). Sovrane e puttane (di M. Recalcati)16 maggio 2016, di Federico La Sala
Blog, Maschile/Femminile, DONNE E UOMINI, POLITICA 29 settembre 2013
Sovrane e libere dal potere
di Marina Terragni *
- Annarosa Buttarelli, Sovrane. La libertà femminile al governo (il Saggiatore, pp. 238, € 18,00)
Ogni anno a Katmandu, Nepal, nel corso di una solenne cerimonia, la dea-bambina Kumari è chiamata a rilegittimare con la sua superiore autorità il potere del Presidente della Repubblica laica.
Non è raro che sia una fanciulla a incarnare l’idea di una sovranità ben più alta di ogni potere. Una vergine, ovvero non ancora compromessa con l’ordine simbolico maschile, capace di un’autorità che non è dominio e di una potenza che non è violenza. Come la “nostra” Maria, come Agata e le altre sante celebrate e blandite con processioni e “cannalore”.
Nel suo ardente “Sovrane” (il Saggiatore, pp. 238, € 18,00) la filosofa Annarosa Buttarelli ragiona su quest’altra idea di sovranità, ben più antica della potestas che ha orientato l’assolutismo monarchico e la democrazia rappresentativa. Idea che i riti, prevalentemente maschili, custodiscono e a un tempo esorcizzano: finita la festa, gabbate le sante, che sono rimesse a tacere.
Si tratta invece, a questo punto critico della storia del mondo, di onorare definitivamente il debito con le “sovrane” lasciandole parlare, e fare. Di intraprendere un nuovo inizio della convivenza umana che tenga conto della differenza femminile.
Si tratta di “ripartire dalle origini dei processi e, se queste origini si rivelassero infauste, trovare la forza e l’intelligenza necessaria per crearne altri differenti”. Cominciando con il “togliere definitivamente dalla rimozione ciò che è accaduto del 403 a. C. ad Atene”, anno e luogo di nascita della democrazia: ciò che lì fu rimosso è il due che siamo, uomini e donne ritenute “parenti acquisite” e rinchiuse nel privato. Non aver tenuto conto dei corpi e dei pensieri delle donne, e della fonte della loro autorità, è ragione di ogni altra ingiustizia, che non può essere sanata se non confidando in una “conversione trasformatrice”.
Nel saggio, scritto con arendtiano “amor mundi” e con l’intento di orientare l’azione politica qui e ora, molti esempi di sapienza al governo: Cristina di Svezia, Elisabetta I d’Inghilterra, Ildegarda di Bingen. Inaspettatamente, anche la derelitta Antigone: sovrana, lei? e di che cosa? In lei il principio di sovranità si mostra purissimo nell’amore radicale per una verità che esiste “da sempre: la vita con le sue leggi e la sua trascendenza, le relazioni di cui abbiamo bisogno per vivere e la condizione umana calata in un cosmo che impone spesso un suo ordine”. Antigone non contro la legge, ma sopra -sovrana-, nell’ordine di ciò che è “eterno, universale e incondizionato” (Simone Weil), immersa nel mistero della “struttura che connette”, come la chiamerà Gregory Bateson, e da cui la politica di oggi sembra voler prescindere.
La logica inclusiva della parità e delle quote, scrive Buttarelli, è ben poca cosa: la posta in gioco “non sono i posti di potere”, ma “la decisa dislocazione della sovranità dal potere”. In particolare, le donne si mostrano estranee al concetto di rappresentanza, per affidarsi alla pratica delle relazioni reali. Portare la sapienza al governo significa portarvi questa competenza relazionale e attenersi in ogni atto al primato della vita.
Due esempi di questo governare che non è rappresentare: la vicenda delle operaie tessili di Manerbio, Brescia, che tra gli anni Ottanta e Novanta affrontarono la crisi della fabbrica rifiutando la rappresentanza sindacale e portando l’amore -tra loro stesse, per i loro prodotti, per chi li comprava- al tavolo di trattativa. E quella di Graziella Borsatti, sindaca a Ostiglia, Mantova, tra il 1991 e il 2004, che saltando l’astrazione della rappresentanza e mettendo in campo relazioni contestuali e concrete, fece della sua giunta e di tutta la città una “comunità governante”, orientata dal proposito di “disfare il potere e agire il benessere”: primum vivere.
Presentando “Sovrane” al Festivaletteratura di Mantova, Stefano Rodotà si è detto colpito dalla sapienza di queste pratiche, ha parlato di “fondazione di un pensiero” e ha ammesso di avere “imparato molto”. Gli rispondono idealmente, invitando a una nuova politica da subito, le parole con cui Annarosa Buttarelli chiude il saggio: “Se il meglio è accaduto a Brescia e a Ostiglia può accadere ancora, oggi e ogni volta che sarà necessario”.
(pubblicato oggi su La Lettura-Corriere della Sera)
LO PSICOANALISTA E LA CITTA’ Riflessioni sulla vita contemporanea
SOVRANE E PUTTANE
di Massimo Recalcati (Psychiatry-on-line, 22 novembre, 2013)
Due libri recenti e molto diversi tra loro offrono ritratti opposti della femminilità: nel primo, titolato Sovrane, edito da Il Saggiatore, Annarosa Buttarelli - filosofa e femminista - s’impegna a ricuperare le tracce di una pratica femminile del governo, mentre nel secondo, quello di Lucrezia Lerro, già nota per romanzi di un certo successo come Certi giorni sono felice o Il rimedio perfetto - , titolato La confraternita delle puttane, edito da Mondadori, emerge un universo di disperazione e di morte dove il destino delle donne appare segnato da una solitudine senza speranza.
Si tratta di due testi che sembrano meditare attorno a quel rifiuto della femminilità messo a tema da Freud. Un destino di rimozione colpisce il femminile non solo nella società patriarcale, ma nelle vicissitudini più profonde della vita psichica, sottraendogli ogni diritto di cittadinanza. E’ precisamente contro questa rimozione che Annarosa Buttarelli lotta a viso aperto. Ecco la posta in gioco del suo lavoro: è possibile dare voce ad una filosofia e ad una pratica femminile della democrazia che si emancipi dalla “storia monosessuata maschile delle istituzioni politiche d’Occidente?”.
Domanda che - secondo l’autrice - si rende necessaria constatando come “tutte le cose “maschie” sono oggi in agonia o già morte - Stato, famiglia dell’uomo che porta a casa il pane, matrimonio esclusivo tra uomo e donna, democrazia rappresentativa, polis, solidarietà di classe, salari, divisione privato-pubblico”. Esiste una narrazione solo maschile della sovranità che s’incarna nell’autorità del pater familias come nella democrazia rappresentativa e che esalta l’universale della Legge contro il particolare della vita. Diversamente, la sovranità femminile si esercita “non contro ma sopra la Legge” prendendosi cura della vita nella sua particolarità. E’ il concetto stesso di rappresentanza che viene qui messo in discussione. Non si tratta di riabilitarne la funzione, ma di cogliere nella sua crisi attuale l’apertura ad un’altra pratica di governo.
Nelle donne - continua il ragionamento della Buttarelli - esiste una sensibilità affettiva che intende il governare non come rappresentanza di un’altra volontà - della Nazione, dello Stato, del popolo - ma come esercizio di una cura fondata sul “primato assoluto della relazione”. Dall’Antigone di Zambrano, alla regina Elisabetta, da Hanna Arendt a Carla Lonzi, dalla dea bambina Kumari alla scrittrice Anna Maria Ortnese, da Chiara di Assisi alla sindaca di Orsiglia Graziella Borsatti, l’autrice convoca i testimoni di questa “democrazia senza rappresentanza” capace di dare luogo ad un economia non vincolata all’assillo dell’utile e del profitto e ad una vita politica non preoccupata di unificare le differenze quanto piuttosto di esaltarle. Ne scaturisce un libro che può essere un contributo importante nell’attuale dibattito politico impegnato a ripensare le ragioni della nostra vita insieme.
Il testo di Lucrezia Lerro ci offre invece un’altra visione del femminile che completa, come in un contrappunto tragico, il libro della Buttarelli: dalle sovrane alle puttane. Si tratta di un romanzo scritto con il consueto stile asciutto e ricco di una poesia che scaturisce dall’attenzione al dettaglio delle cose e al peso delle parole. Ambientato in un claustrofobico paesino del profondo Sud nel corso degli anni Ottanta, dove domina il fantasma maschilista che vuole le donne “tutte puttane”, ritrae le ambizioni di giovani donne dalle condizioni sociali umili, esposte ai miti consumistici di quegli anni, prive di prospettive se non quelle di farsi sposare da qualche soldato della vicina postazione militare della Nato o dai giovani più benestanti del paese.
Tuttavia questa rincorsa alla propria sistemazione che sfiora il cinismo più disperato e l’abbruttimento di sé, cela il vero tema del libro che è quello del fallimento dell’eredità. E’ il destino afflitto e sconfitto delle madri e dei padri a non trasmettere nulla alle loro figlie. Le sovrane lasciano qui il posto al loro rovescio: alla apatia e alla distruzione di sé. Schiacciate dall’arroganza e dall’ignoranza machista queste madri sembrano plasmarsi sul fantasma che le umilia. Lerro entra qui con grande sensibilità nelle pieghe del rapporto devastante tra madre e figlia.
E’ la rassegnazione delle madri a non permettere la trasmissione del sentimento della vita e del desiderio. Tutto appare come un grande e spettrale aborto: la vita appassita trasmette morte senza vita. Com’è possibile per una figlia non replicare l’infelicità materna? Non lasciarsi contagiare dall’apatia e dalla tendenza alla flagellazione? Non credere che la sola cosa che conti in una donna sia “farsi sposare”?
Nella dedica, come un gesto liberatorio, si legge: “a mia madre che non mi ha impedito di partire”. Essa ci rivela il dono più grande della genitorialità: sapere perdere i propri figli, saper stare dalla parte dei loro sogni.
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Neoliberismo, riproduzione e comunità. Un dialogo con Silvia Federici (di Gea Piccardi)7 maggio 2016, di Federico La Sala
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
Neoliberismo, riproduzione e comunità
- Sono milioni le persone, soprattutto donne, che non vedono alcuna possibilità che lo Stato possa rispondere in modo dignitoso alle loro aspettative. La sola possibilità di riproduzione e di costruzione del futuro diventa il lavoro collettivo. Silvia Federici la chiama organizzazione collettiva della riproduzione e ne disegna qua e là alcuni tratti in questa lunga e appassionata conversazione. Una gimcana a perdifiato tra le domande chiave per l’elaborazione politica femminista postcoloniale e l’apertura dei concetti essenziali del “fare comunità», vale a dire del ricreare un tessuto di relazioni di reciprocità che investano la materialità delle vite e le condizioni comuni di sussistenza e di benessere. Sullo sfondo, in campo lungo, il paesaggio riproduttivo, lo spazio rimosso dall’economia politica moderna e dalla critica marxista, abitato da corpi di donne che garantiscono le condizioni affettive, materiali e di cura di ogni comunità. L’inquadratura sulle crisi nel vivere il nostro tempo è profonda e di una lucidità impressionante
di Gea Piccardi* (Comune-info, 07.05.2016)
Ho incontrato i testi di Silvia Federici quattro anni fa. Mentre in Europa ancora erano in corso le traduzioni, in America Latina i suoi scritti stavano già passando di mano in mano, di assemblea in assemblea, tra collettivi di donne e misti. È stata una compagna italiana, parte del progetto di Universidad de La Tierra a Oaxaca (Messico), a mostrarmi per la prima volta il libro tradotto in spagnolo come Caliban y la bruja. Mi disse poche parole, semplici ed efficaci. Quel libro, disse, avrebbe permesso di ripensare la nascita dell’economia mondo capitalistica e degli Stati Nazione come un fenomeno di colonizzazione interna allo stesso territorio europeo, avvenuta sui corpi delle donne, terreno strategico di sfruttamento e appropriazione. Pochi mesi dopo, a Buones Aires, un’altra compagna mi raccontò che quell’anno, nella loro assemblea presso una villa di periferia, avevano letto e studiato insieme Caliban y la bruja, trovandovi strumenti fondamentali per l’elaborazione di un’azione politica femminista e postcoloniale.
Da allora, con alcune compagne, amiche e ricercatrici abbiamo cominciato a lavorare, qui in Italia, sui testi di Federici. Uno dei termini su cui ci siamo maggiormente imbattute è quello di «riproduzione», concetto che Federici comincia ad indagare con il collettivo padovano di Lotta Femminista dentro alle lotte delle donne negli anni Settanta. La loro analisi sul lavoro domestico e riproduttivo all’interno delle società capitalistiche occidentali ha permesso alla parola «riproduzione» di indicare via via molteplici campi semantici non riducibili al solo linguaggio della biologia o al concetto marxiano di «riproduzione sociale». Ha permesso di spostare l’attenzione teorica e politica dalla relazione capitale-lavoro centrata sullo sfruttamento del salariato, alle condizioni di possibilità di quella stessa relazione che risiedono altrove, in quello spazio - fino ad allora senza tempo e senza storia - della casa, del privato e delle reazioni sessuali, per indagarne le grammatiche specifiche. Finalmente oggi, anche in Italia, siamo in grado di poter ricostruire i passaggi della ricerca di Silvia Federici, grazie a un lavoro di traduzione e diffusione dei suoi testi avvenuto negli ultimi tre anni. È infatti di recente pubblicazione l’ultimo libro di Federici, Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, curato da Mimesis. L’impegno di compagne e compagni in diverse città ci ha offerto la possibilità, qualche settimana fa, d’incontrare l’autrice in Italia, nelle università e negli spazi sociali.
Con Calibano e la strega Federici prosegue con approccio storico e genealogico l’analisi critica sul lavoro riproduttivo contenuta nei saggi de Il punto zero della rivoluzione. Quali sono le origini della separazione tra produzione e riproduzione? Tra un maschile e un femminile che si riflettono in organizzazioni gerarchiche e oppressive di facoltà e attività umane? A partire da questi interrogativi, l’autrice mostra i nessi storici esistenti tra le esigenze dell’accumulazione originaria nel «passaggio al capitalismo», la nascita degli apparati di sapere e di potere su cui si sono costituiti gli Stati moderni, e l’organizzazione, attraverso la caccia alle streghe, del «nuovo ordine patriarcale» occidentale. Qui Federici propone con scientificità la storia della modernità occidentale ma da un’angolazione prospettica che si radica nelle urgenze di libertà del presente, senza cadere nelle gabbie dei pensieri totalizzanti. È proprio questa direzione di sguardo, carica di etica e di politica, che conduce a un pensiero complesso e aperto come quello che il suo libro ci regala. Un metodo d’analisi (ispirato ai lavori di Marx, Foucault e al pensiero femminista) che inchiesta il sociale, attuale e passato, mostrando le contemporaneità.
L’ideazione del libro, scrive nell’introduzione, nasce dalla sua permanenza in Nigeria durante gli anni Novanta, periodo di attivazione - in tutta l’Africa e nei paesi del cosiddetto Terzo Mondo - dei «programmi di aggiustamento strutturale» imposti dall’FMI e dalla Banca Mondiale, che hanno coinciso con l’indebitamento, nuovi processi di espropriazione delle terre comuni, tagli alle spese sociali e ondate repressive e di violenza.
Da una parte, quindi, sono gli attuali fenomeni di naturalizzazione, espropriazione e attacco alla riproduzione, a livello globale, che illuminano la sua storia della caccia alle streghe nella fase di transizione al capitalismo. E dall’altra, è lo studio dei processi di violenta riorganizzazione del lavoro delle donne nella prima età moderna che permette di comprendere l’attualità neoliberista in cui il paesaggio riproduttivo - quello spazio da sempre rimosso dall’economia politica moderna e dalla critica marxista, abitato da corpi di donne che continuamente garantiscono le condizioni affettive, materiali e di cura di qualsiasi comunità - vive una fase di tremenda crisi che colpisce le vite delle singole, dei singoli, e della società tutta. Fuori da una lettura storicistica e progressista della storia Federici ritiene, dunque, che lo scenario della cosiddetta «accumulazione originaria» non si sia dato una volta per tutte, ma, al contrario, persista nel nostro presente sebbene con attrici/attori e in contesti differenti, coloniali e neocoloniali. E che ridisegni, non senza conflitto, le condizioni sociali di estrazione di profitto economico.
Tuttavia, di fronte ai segni della crisi, Federici trova esempi concreti di apertura e d’immaginazione radicale nelle esperienze di lotta di donne che oggi, in tutto il mondo, resistono alle logiche dell’economia capitalistica e ai «nuovi modelli di patriarcato». Da queste prende piede la sua riflessione sui commons o sulla pratica del commoning, intesa nel senso di «fare comunità», ricreare, cioè, un tessuto di relazioni di reciprocità che investano la materialità delle vite e le condizioni comuni di sussistenza e di benessere (leggi anche Comune? È la società in movimento ndr). L’esistenza di comunità autonome e resistenti sparse per il globo e radicate nelle pratiche di autodeterminazione delle donne, le permette di rintracciare nuovi profili possibili della prassi politica oggi; una prassi che indica altri tempi e spazi dell’azione e del pensiero, nuovi e differenti strumenti teorico-pratici di comprensione del mondo e di consapevolezza del proprio potenziale storico. È nel nesso tra crisi della riproduzione e pratiche di commoning che Federici rintraccia nuove priorità etico-politiche, non più legate alle grammatiche del potere maschile novecentesco e al modello di militanza da questo ereditato, ma aperte a nuovi orizzonti di senso.
L’intervista * cerca di sciogliere questi nodi teorici, passando per la biografia dell’autrice e cercandovi i momenti sorgivi, quelli in cui incontri virtuosi con persone, luoghi o movimenti sociali hanno modificato e approfondito la sua ricerca. Quello che Federici propone a tutte e tutti noi, nel dipanarsi delle sue risposte, nella franchezza del linguaggio e nell’apertura dialogica del suo pensiero, è di affrontare la fatica immaginativa che richiede qualsiasi desiderio di cambiamento. Non c’è nulla di immediato e di automatico, ciascun gesto per esser libero richiede una grande attenzione, direi di weiliana memoria. Silvia Federici parla di «altri modi di fare politica» per ritrovare, in essa, un momento di soddisfazione di vita e di resistenza sociale forte.
* L’intervista segue IMMEDIATAMENTE ... QUI.
* Gea Piccardi, laureata in Filosofia Politica presso l’Università di Roma Tre, fa parte della redazione di Iaph e partecipa al gruppo di ricerca Eco-Pol - studi su altri paradigmi di ecologie ed economie politiche. Ha vissuto per periodi più o meno lunghi in Messico, dove ha partecipato all’Escuelita Zapatista.
*Pubblicato su Iaph, con il titolo completo “Neoliberismo, riproduzione e comunità. Un dialogo con Silvia Federici tra biografia, politica e pensiero”
- Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Una formula di Lacan: “l’amore è sempre eterosessuale”. Come dobbiamo intenderla (di M. Recalcati)2 maggio 2016, di Federico La Sala
(federico la sala)
I tabù del mondo
Si fa presto a dire famiglia
 La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
 Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
 Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?
Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?di Massimo Recalcati (la Repubblica, 01.05.2016)
Famiglia è ancora una parola decente che può essere pronunciata senza provocare irritazione, fanatismi o allergie ideologiche? Famiglia è ancora una condizione fondamentale e irrinunciabile del processo di umanizzazione della vita oppure è un tabù da sfatare? Se c’è stato un tempo nel quale essa appariva circondata da un alone di sacralità inviolabile non rischia forse oggi di essere condannata come una sopravvivenza ottusa della civiltà patriarcale? Sono solo i cattolici più intransigenti a sostenere la sua esistenza come indispensabile alla vita umana?
Dal punto di vista laico della psicoanalisi la famiglia resta una condizione essenziale per lo sviluppo psichico ed esistenziale dell’essere umano. La vita umana ha bisogno di casa, radici, appartenenza. Essa non si accontenta di vivere biologicamente, ma esige di essere umanamente riconosciuta come vita dotata di senso e di valore. Lo mostrava “sperimentalmente” un vecchio studio di Renè Spitz sui bambini inglesi orfani di guerra che dovettero subire il trauma della ospedalizzazione ( Il primo anno di vita del bambino, Giunti 2009).
La solerzia impeccabile delle cure somministrate dalle infermiere del reparto nel soddisfare tutti i bisogni cosiddetti primari dei bambini non erano sufficienti a trasmettere loro il segno irrinunciabile dell’amore. Effetto: cadute depressive gravi, anoressia, abulia, marasma, stati di angoscia, decessi. Se la vita del figlio non è raccolta e riconosciuta dal desiderio dell’Altro, resta una vita mutilata, cade nell’insignificanza, si perde, non eredita il sentimento della vita. Non è forse questa la funzione primaria e insostituibile di una famiglia? Accogliere la vita che viene alla luce del mondo, offrirle una cura capace di riconoscere la particolarità del figlio, rispondere alla domanda angosciata del bambino donando la propria presenza.
La clinica psicoanalitica ha riconosciuto da sempre l’importanza delle prime risposte dei genitori al grido del figlio. Non si tratta solo di soddisfare i bisogni primari perché la vita umana non è la vita di una pianta, né quella dell’animale, non esige solo il soddisfacimento dei bisogni, ma domanda la presenza del desiderio dell’Altro; vive, si nutre del desiderio dell’Altro. La vita umana non vive di solo pane, ma dei segni che testimoniano l’amore.
L’attualità politica ci impone a questo punto una domanda inaggirabile: tutto questo concerne la natura del sesso dei genitori? Essere capaci di rispondere alla domanda d’amore del figlio dipende dalla esistenza di una coppia cosiddetta eterosessuale? La famiglia come luogo dove la vita del figlio viene accolta e riconosciuta come vita unica e insostituibile - ogni figlio è sempre “figlio unico”, afferma Levinas, - è un dato naturale, un evento della biologia? Siamo sicuri che l’amore di cui i figli si nutrono scaturisca, come l’ovulo o lo spermatozoo, dalla dimensione materialistica della biologia? Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni che riflettono una concezione naturale della famiglia contengono una profonda e insuperabile contraddizione in termini?
Se, infatti, quello che nutre la vita rendendola umana non è il “seno”, ma il “segno” dell’amore, possiamo davvero ridurre la famiglia all’evento biologico della generazione? Non saremmo invece obbligati a considerare, più coerentemente, che un padre non può essere mai ridotto allo spermatozoo così come una madre non può mai essere ridotta ad un ovulo?
La domanda si allarga inevitabilmente: cosa significa davvero diventare genitori? Lo si diventa biologicamente o quando si riconosce con un gesto simbolico il proprio figlio assumendosi nei suoi confronti una responsabilità illimitata? Le due cose non si escludono ovviamente, ma senza quel gesto la generazione biologica non è un evento sufficiente a fondare la genitorialità. In questo senso Françoise Dolto affermava che tutti i genitori sono genitori adottivi.
Generare un figlio non significa già essere madri o padri. Ci vuole sempre un supplemento ultra-biologico, estraneo alla natura, un atto simbolico, una decisione, un’assunzione etica di responsabilità. Un padre e una madre biologica possono generare figli disinteressandosi completamente del loro destino. Meritano davvero di essere definiti padri e madri? E quanti genitori adottivi hanno invece realizzato pienamente il senso dell’essere padre e dell’essere madre pur non avendo alcuna relazione biologico-naturale coi loro figli?
Questo ragionamento ci spinge a riconsiderare l’incidenza del sesso dei genitori. Ho già ricordato come l’amore sia a fondamento della vita del figlio. Ma l’amore ha un sesso?
Prendiamo come punto di partenza una formula di Lacan: “l’amore è sempre eterosessuale”. Come dobbiamo intendere seriamente l’eterosessualità? Questa nozione, per come Lacan la situa a fondamento dell’amore, non può essere appiattita sulla differenza anatomica dei sessi secondo una logica elementare che li differenzia a partire dalla presenza o meno dell’attributo fallico.
L’amore è eterosessuale nel senso che è sempre e solo amore per l’Altro, per l’eteros. E questo può accadere in una coppia gay, lesbica o eterosessuale in senso anatomico. Non è certo l’eterosessualità anatomica - come l’esperienza clinica ci insegna quotidianamente - ad assicurare la presenza dell’amore per l’eteros! È invece solo l’eterosessualità dell’amore a determinare le condizioni migliori affinchè la vita del figlio possa trovare il suo ossigeno irrinunciabile.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI"... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- HUSSERL E LA CRISI DELLE SCIENZE. LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI).8 aprile 2016, di Federico La Sala
HUSSERL CONTRO L’HOMUNCULUS: LA ’LEZIONE’ DI ENZO PACI AI METAFISICI VISIONARI (ATEI E DEVOTI) DI IERI (E DI OGGI). Una ’traccia’ dal "Diario fenomenologico"): *
- ENZO PACI. “Negli anni passati in Germania, in un campo di concentramento, la grande ombra di Vico venne a trovarmi e mi sembrò di sentire che tutta la sua opera era stata una lotta eroica contro la ingens sylva della barbarie (...)” (cfr.: Lettere di carteggio di Enzo Paci con B. Croce e F. Nicolini, a c. di A. Vigorelli, “Rivista di storia di filosofia”, I, 1986, p. 103).
 L’homunculus di Goethe è il simbolo di quella che Husserl denuncia come “crisi delle scienze”.
L’homunculus di Goethe è il simbolo di quella che Husserl denuncia come “crisi delle scienze”. Dal “Diario fenomenologico” di Enzo Paci, una traccia per la lettura della "Crisi delle scienze europee" di Edmund Husserl
Dal “Diario fenomenologico” di Enzo Paci, una traccia per la lettura della "Crisi delle scienze europee" di Edmund Husserl- 4 febbraio 1960*
Nel patto biblico tra Dio e l’uomo c’è una clausola fondamentale: “Sia chiaro” dice Dio “che creatore sono soltanto io che ti ho creato e non tu. Io sono, su questo punto, un Dio geloso”. Come può essere nato un pensiero di questo genere?
Per una analisi fenomenologica vedo due vie. La prima è la proiezione, in Dio, del padre. Il figlio, per essere uomo, deve ribellarsi al padre. È la via del complesso edipico, la via di Freud. Ovviamente la proiezione si pone come divieto e come gelosia proprio perché il divieto deve essere superato. L’uomo diventa “virile” per la violazione della proibizione. Se il padre è Dio, raggiunge il massimo della umana virilità e cioè diventa Dio. Questa posizione è immatura. Infatti il padre è sempre divinizzato. La sostituzione al padre è eroica: il figlio diventa o Dio o il Diavolo. La maturità dell’uomo in quanto uomo viene raggiunta proprio quando cade la divinizzazione del padre. Se il padre diventa un uomo, anche il figlio diventa un uomo. Di solito ciò avviene quando il figlio, di fatto, diventa padre. di un nuovo figlio, e così via. Di fronte a suo figlio, il figlio divenuto padre si pacifica col proprio padre: ora lo può. Spetta a lui l’essere divinizzato.
La seconda via. Nell’atto sessuale procreante non mi accoppio per avere un figlio. Nella esperienza jn prima persona di me stesso e dell’altro nell’atto sessuale non sento di procreare, non ho l’esperienza in prima persona del “far nascere”. L’evidenza sessuale è l’evidenza dell’altro in me e di me nell’altro. Non può essere l’evidenza del figlio che non c’è ancora.. Se le conseguenze saranno procreative, nota Husserl, lo saprò dopo. Dai fatti. Ma posso pormi la domanda: “come avviene?” Fenomenologicamente questo “come” deve essere sperimentato dal soggetto. Ma il soggetto è il soggetto che inizia la sua nascita in seguito alla fecondazione. Non sono io ma è mio figlio, o sono io, ma nell’atto del mio nascere. C’è qui un distacco. Il distacco che si inizia subito, appena compiuto l’atto sessuale. Anche la donna si estrania da me. Ciò che ha di mio in sé è ancora mio, ma non sono più io.
Nell’amore, all’inizio, ho proiettato me stesso in lei: è diventata la “mia vita”. Proprio per questo devo possederla: per “riavere la mia vita”. Ma la “mia vita”, invece di essermi restituita, diventa concretamente un’altra vita. Così si diventa padre, diventando un altro soggetto. Ma così si è figli: si inizia geneticamente la propria storia, la storia della propria soggettività. Procreare e nascere sono due operazioni mie, di me soggetto, che mi sfuggono.
La prima mi sfugge nel distacco che segue all’atto sessuale dal quale ha inizio, appunto, la procreazione. La seconda operazione, il nascere, mi sfugge perché che sia mia mi viene detto da altri. Non è in prima persona. Non posso ricordare la mia vita intrauterina e la mia nascita. Le due operazioni, che mi sfuggono, sono proiettate in Dio che diventa il solo creatore.
C’è un’implicazione: lo studio scientifico della procreazione e della nascita è, alla fine, la genetica. Come scienza fenomenologica rientra, in qualche modo, nell’antropologia, oltre che nella psicologia e nella somatologia, in quanto il suo problema si pone come studio delle modalità e del significato della genesi, sperimentata soggettivamente, e per ciò fenomenologicamente. Una delle conseguenze dell’implicazione scientifica è la seguente: lo studio scientifico della genesi, lo studio scientifico obiettivo, può porsi come un sostituto dell’atto sessuale.
Uno scienziato si può accorgere, magari tardi, che la conoscenza scientifica si è per lui sostituita alla “conoscenza” in senso biblico e cioè all’atto sessuale. Ciò può accadere al filosofo in quanto ricercatore della genesi del mondo. O allo storico: la genesi è la storia.
La feticizzazione è fascinosa perché sostituisce l’atto sessuale creativo. Le tecniche possono esercitare, da questo punto di vista, un’attrazione magica. Una tecnica può sostituire l’atto sessuale e, in cibernetica, la procreazione mancata.
Il tecnico vorrà costruire il figlio come un homunculus nell’inconsapevole desiderio di sostituire agli uomini le macchine. L’homunculus di Goethe è il simbolo di quella che Husserl denuncia come “crisi delle scienze”.
* Enzo Paci, Diario fenomenologico, Il Saggiatore, Milano 1961, pp. 95-97.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
 HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI*
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’ADULTO E IL BAMBINO. "Il figlio del desiderio" (M. Gauchet): quel che resta della “educazione” (di M. Recalcati)28 marzo 2016, di Federico La Sala
- EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
 COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!
Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!
Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud
- "LA MENTE ACCOGLIENTE": LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera
-
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
I tabù del mondoQuel che resta della parola “educazione”
Nessun tempo come il nostro ha così esaltato la centralità del bambino nella vita della famiglia. I piccoli non si piegano più alle leggi degli adulti e finiscono per ignorare il senso del limite. Davanti ai figli e alle loro richieste, i genitori rinunciano a ogni possibile pedagogia
Gli esiti di questo processo si possono riassumere con una difficoltà crescente dei nostri ragazzi di accedere alla dimensione generativa del desiderio
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 27.03.2016)
È sempre esistita una corrente della pedagogia che, a diverso titolo, ha preteso di liberarsi dell’educazione considerata come un vero e proprio tabù: le vite dei figli traggono più danno che benefici dall’educazione, la quale non sarebbe altro che una museruola messa da genitori paranoici sulla legittima voglia di libertà dei loro figli. Tra tutti i riferimenti possibili possiamo pensare al recente lavoro di Peter Gray dal titolo, che è già, come si può intendere facilmente, tutto un programma: Lasciateli giocare (Einaudi). La tesi di questo libro è quella che bisogna restituire ai nostri figli la loro autonomia che una concezione aridamente disciplinare della scuola gli ha sottratto. Quella che l’autore definisce “istruzione forzata” appare come una macchina repressiva tale da spegnere la creatività nel nome di una esigenza di controllo e di disciplinamento coatto che proviene dal mondo degli adulti.
Questa rappresentazione della problematica dell’educazione risente di una ideologia libertaria che misconosce la funzione della differenza simbolica tra le generazioni e il ruolo essenziale degli adulti giocato nel processo di formazione. Si tratta di una vera e propria “mutazione antropologica” che è stata descritta con efficacia da Marcel Gauchet in un bel libro titolato Il figlio del desiderio (Vita e pensiero).
Riassumo sinteticamente il suo ragionamento: se c’è stato un tempo dove l’educazione aveva il compito di liberare il soggetto dalla sua infanzia, oggi si tende invece a concepire l’infanzia come un tempo al quale si vorrebbe essere eternamente fedeli, come una sorta di “ideale del sé” puro e incontaminato da tutti quei condizionamenti culturali e sociali che rischiano di corrompere la sua affermazione. Non si tratta più di educare il bambino alla vita adulta ma di liberare il bambino dalla vita degli adulti perché la vita adulta non è una vita, ma solo la sua falsificazione morale. Nessun tempo come il nostro ha mai esaltato così la centralità del bambino nella vita della famiglia. Tutto pare capovolgersi: non sono più i bambini che si piegano alle leggi della famiglia, ma sono le famiglie che devono piegarsi alle leggi (capricciose) dei bambini.
Nanni Moretti ne fornì un esempio esilarante in Caro diario: in una piccola isola delle Eolie i bambini diventano i padroni anarchici della famiglia obbligando tutti gli adulti al telefono a prodigarsi in improbabili imitazioni di animali per poter ottenere il permesso di parlare coi loro genitori. Il compito dell’educazione viene aggirato nel nome della felicità del bambino che solitamente corrisponde a fargli fare tutto quello che vuole: il soddisfacimento immediato non è solo un comandamento del discorso sociale, ma attraversa anche le famiglie sempre più in difficoltà a fare esistere il senso del limite e del differimento della soddisfazione. Non è forse questa la nuova Legge che governa le nostre vite? Lo spirito del mercato non esige forse la realizzazione del massimo profitto in tempi sempre più brevi?
Gli esiti di questo processo si possono riassumere con una difficoltà crescente dei nostri figli di accedere alla dimensione generativa del desiderio poiché la condizione di questo accesso è data dall’incontro con il trauma virtuoso del limite. Solo se la vita riconosce che non tutto è possibile può fare esistere il desiderio come una possibilità autenticamente generativa. Altrimenti il desiderio si eclissa soffocato dalla marea montante della soddisfazione immediata dei bisogni. È un problema cruciale del nostro tempo.
L’elevazione del bambino a nuovo idolo di fronte al quale, al fine di ottenere la sua benevolenza, i genitori si genuflettono, è un effetto di questa erosione più diffusa del discorso educativo.
Nella pedagogia falsamente libertaria che oscura il trauma benefico del limite come condizione per il potenziamento del desiderio, l’educazione stessa è diventata un tabù arcaico dal quale liberarsi, una parola insopportabile che nasconde e giustifica subdolamente il sadismo gratuito degli adulti verso l’innocenza dei figli.
In realtà, questa dismissione del concetto di educazione è un modo con il quale gli adulti - che, come ricorda Lacan, sono i veri bambini - tendono a disfarsi del peso della loro responsabilità di contribuire a formare la vita del figlio. Ne è una prova il sospetto coi quali molti genitori osservano gli insegnanti che si permettono di giudicare negativamente i loro figli o di sottoporli a provvedimenti disciplinari.
Dando per scontato il fatto che non esistono genitori ideali, o, che, come sentenziava Freud, il mestiere del genitore è impossibile, cioè è impossibile per un genitore non sbagliare, questo non significa affatto disertare la responsabilità di assumere delle decisioni, di non farsi dettare la Legge dai propri figli.
Non si tratta per i genitori di proporsi come modelli educativi infallibili - niente di peggio per un figlio che avere un padre o una madre che si offrono come misura ideale della vita - ma di fare sentire che esiste sempre un mondo al di là di quello incarnato dell’esistenza del figlio, che l’esistenza di un figlio non può esaurire l’esistenza del mondo. In un recente colloquio clinico con una famiglia in difficoltà di fronte ad un bambino che ha progressivamente cannibalizzato le loro vite mostrando di non aver alcun rispetto per il senso del limite, il padre, per definirlo, ha usato questa espressione eloquente: «Lui pensa di essere il centro del mondo». Aggiungendo però subito dopo, senza riuscire a trattenere una certa soddisfazione: «Lui non sa quanto per noi questo sia assolutamente vero».
- EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- IL BOOMERANG DELL’AGONISMO E L’INDICAZIONE DI NIETZSCHE (di Donatella Di Cesare)13 marzo 2016, di Federico La Sala
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
La competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione. È la versione ultima della razionalità moderna che ruota intorno al calcolo. Ma se la vita è solo gara, qual è la sorte di chi perde? Cercherà di rovesciare il verdetto giocando d’azzardo? Il problema è trovare una forma di contesa non distruttiva
Il boomerang dell’agonismo
Destino ineluttabile. Se l’esistenza è una lunga rincorsa al successo, l’ultima sfida diventa la morte. Perciò alla fine, malgrado le vittorie, si viene comunque sconfitti
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 13.03.2016)
«Non arrenderti! Ancora uno sforzo!». «Sei a un passo dalla vittoria!». Sono le parole rivolte di solito da un allenatore agli atleti di cui cura la preparazione. Ma sono anche le formule di incitamento che scandiscono ormai la vita quotidiana di ciascuno, formule che, anzi, ciascuno ripete spesso tra sé e sé, quasi fosse il proprio personal trainer. Come mai? Immaginiamo forse di vivere tutti come atleti? Pensiamo sia un dovere l’esercizio, il perfezionamento continuo? Aspiriamo a primeggiare? Ebbene, occorre ammetterlo, condividiamo, anche se inconsapevolmente, una concezione agonistica dell’esistenza.
Il fenomeno ha assunto negli ultimi anni contorni più nitidi e proporzioni sempre più vaste. Al punto da spingere i filosofi a interrogarsi su ciò che caratterizza l’agonismo diffuso, sui motivi che lo provocano, sulle ripercussioni etiche e politiche. Perché questo è almeno certo: che le generazioni che ci hanno preceduto, quelle delle nostre madri e dei nostri padri, non concepivano la propria vita come una gara incessante. Il che non vuol dire che non si mettessero in gioco o che si sottraessero alle sfide.
Che cos’è cambiato allora negli ultimi vent’anni? La questione è più complessa di quel che appare a prima vista. Senza dubbio la concorrenza è il cardine dell’economia capitalistica, che ha mostrato i suoi effetti esiziali non solo nel consumismo sfrenato, ma anche nell’ingiunzione alla crescita, nella spinta propulsiva, e nondimeno distruttiva, a produrre sempre di più. Tuttavia l’estremizzazione della sfida, l’inseguimento del prestigio, il sogno della superiorità, che si accompagnano perfino a un certo disprezzo per il denaro, sembrano tradire - come osservava già Jacques Derrida - una provenienza non economica.
Se parole come valutazione, classifica, selezione, merito, prevalgono nel discorso pubblico, indirizzano i programmi politici, improntano il lessico dell’economia, è perché il modello competitivo ha un successo incontrastato. La competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, con se stessi e con gli altri, quasi fosse una legge primordiale. Non c’è più quasi lembo di vita che si sottragga al modello della gara.
Non vediamo più il mondo, attraverso le lenti di Marx, solo come un grande magazzino di merci, né più solo come un immane spettacolo; per noi è sempre più lo spazio planetario di innumerevoli e differenti gare che si intersecano e si succedono a ritmo vertiginoso e nelle quali siamo ininterrottamente coinvolti.
Il paradigma agonistico ha un’estensione e una profondità tali da poter essere considerato uno dei tratti peculiari della nostra epoca. La visione imprenditoriale della vita, su cui attirava l’attenzione Foucault, non è sufficiente a spiegare il fenomeno nel suo complesso. Né basta puntare l’indice sull’alleanza che da tempo lega il pensiero liberale alle scienze sociobiologiche, basate, nella vulgata, sulla lotta per la sopravvivenza. Se il mito agonistico si è imposto nel neoliberalismo attuale, è perché questo è la versione ultima della razionalità moderna che - come ha visto Heidegger - ruota intorno al calcolo, a ciò che è quantitativo, a ciò che è oggettivo.
Ecco perché lo sport svolge nella vita attuale un ruolo senza precedenti. Si può essere sedentari, e seguire tuttavia un modello sportivo di vita dove l’imperativo categorico è primeggiare. L’uomo nuovo è l’atleta. Non è un caso che manager e soprattutto politici, da Clinton a Sarkozy, a Cameron, accettino volentieri di essere ripresi mentre fanno jogging o corrono in bicicletta. Sono dunque l’economia e la politica a piegarsi, quasi, allo schema dello sport.
Il successo del paradigma sportivo-agonistico va ricondotto all’esigenza di farsi valere in un mondo dove tutti sono - o dovrebbero essere - uguali in partenza, in cui cioè, secondo i dettami della democrazia, non ci sarebbe margine per nessun privilegio e il merito sarebbe oggettivamente misurabile. In breve, la gara sportiva assurge a modello della competizione democratica. Perché si tratta di un confronto aperto a tutti, dove le prestazioni agonistiche sono quantificabili, dove i tecnici, in veste di arbitri imparziali, proclamano vincitore il migliore. Proprio per questo lo sport, praticato prima da una élite, è divenuto fenomeno di massa. In un libro dedicato a questo tema Alain Ehrenberg ha parlato di «culto della performance». Lo sport concilierebbe concorrenza e giustizia - anche se la giustizia non sarebbe che il diritto del più forte.
Non importa poi che lo sport, tra doping, trucchi e corruzione, sia ben lontano da questo miraggio. L’importante è che resti l’ideale di una gara corretta, perché oggettiva, il cui responso è incontestabile. Chi ha vinto, e ha battuto il record, è migliore, è anzi superiore. Di qui lo spazio enorme che gli sportivi hanno nella sfera pubblica e nei media; osannati come eroi nazionali, vengono presi come veri e propri maestri di vita. Eppure, lo sportivo che ha vinto, ha vinto per sé, non ha combattuto per gli altri; è un eroe isolato che può essere solo ammirato da lontano.
Dietro questa fiducia nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una gara. L’assunzione di questo agonismo, che porta con sé l’obbligo di vincere, ha conseguenze devastanti. Che ne è, infatti, di chi perde? Disagio, depressione, «passioni tristi», come le chiamava Spinoza, scandiscono questa tarda modernità. Ma qui non deve sfuggire un altro fenomeno correlato: il gioco d’azzardo. Chi si sente escluso, avviato alla sconfitta, tenta la mossa estrema. Il «rischia tutto!», messaggio reiterato dalla pubblicità, viene preso alla lettera: si mettono in gioco non solo i soldi, gli averi, ma il tempo, i legami affettivi, la dignità, la vita stessa. Da un lato il gioco d’azzardo appare la rivolta esterna all’agonismo, la scorciatoia per aggirare tutte le gare vincendo d’un colpo, dall’altro ne è solo la versione parossistica che porta quasi sempre alla rovina.
Se la vita è una gara, un percorso finalizzato alla vittoria, la morte è l’ultima sfida - con inquietanti effetti per la bioetica. E su questo ha invitato di recente a riflettere Remo Bodei. Perché in extremis , nonostante le vittorie accumulate, si viene comunque sconfitti. Il modello agonistico, per l’affinità persino etimologica tra gara e guerra, ostenta non di rado tratti bellici. E se il confronto umano si riduce a uno strenuo misurarsi con gli altri, il conflitto - come già sottolineava Thomas Hobbes - è inevitabile. Se qualcuno vince, qualcun altro deve perdere. Di più: l’altro, se non si erge ad allenatore o arbitro, serve solo a identificare meglio la nostra posizione in classifica, o a riconoscere magari la nostra vittoria. Per il resto l’atleta, che ciascuno di noi dovrebbe essere, punta a essere leggero e flessibile, liberandosi da ogni relazione e da ogni responsabilità. Collabora solo di tanto in tanto o, come si dice, «fa squadra», cioè si aggrega temporaneamente in vista di un avversario comune. Poi fa ritorno a sé. E continua a competere - ma con se stesso.
Nell’età in cui domina l’incantesimo scientista della cifra, il fascino perverso di statistiche, classifiche, sondaggi, la valutazione impronta la vita intera. Si dilata a tutte le età (basti pensare a quel che avviene nelle scuole e negli atenei), non risparmia la politica e il mondo dello spettacolo. La valutazione fa anzi spettacolo, come dimostrano programmi quali MasterChef, The Voice of Italy e i numerosissimi reality.
Occorre essere «in forma», belli, sani, abbronzati - a ogni prezzo, con ogni sforzo. Non per vivere una vita migliore, bensì per vincere. Dal dentista alla palestra, dall’estetista al corso di lingua: la giornata diventa un lungo training, un immenso addestramento. Eccelle chi resiste eroicamente.
Ma l’esercizio non è forse encomiabile? E il desiderio di perfezionamento non va elogiato? Si può rispondere con Peter Sloterdijk, quando riflette su quella che chiama l’antropotecnica del postumanismo. Abbiamo ereditato dal Novecento la figura dell’oltreuomo, la spinta a sfidare i vincoli fisici, a superare ogni limite. Siamo tutti acrobati. Ci misuriamo con difficoltà sempre maggiori. La nostra esistenza è una «prestazione acrobatica». Ma il nostro atletismo eroico è una «ascesi de-spiritualizzata». Abbiamo perso la trascendenza e il senso della verticalità. Procediamo in solitudine, lungo una fune tesa non in alto, ma raso terra - come aveva intuito Kafka. Malgrado la tensione e lo stress, rischiamo miseramente di inciampare a ogni passo.
Si deve per questo condannare la competizione come tale? Certo che no. D’altronde nell’agone greco è sorta la stessa filosofia. È Nietzsche, il filosofo a cui non è sfuggito il tratto tragico-distruttivo del pensiero greco, a offrire nel suo scritto Agone omerico una indicazione decisiva. Nei versi di Esiodo scorge «due dee chiamate Eris». C’è una contesa buona, che «spinge al lavoro anche l’uomo inetto»; il vicino gareggia con il vicino, ma la gara, stimolata dall’invidia e dalla gelosia, tende al benessere. C’è invece una contesa cattiva che porta solo all’annientamento reciproco. Qui non si dà misura e trionfa perciò l’ambizione smisurata dell’unico genio. Per l’agone greco è indispensabile invece un secondo genio - nessuno deve essere per sempre il migliore. Altrimenti il gioco agonistico si esaurirebbe con grave danno per la città e la società politica. Ecco allora il male dell’agonismo moderno: è la cattiva Eris che da un lato favorisce la mediocrità aggressiva, dall’altro non conosce che un singolo, isolato vincitore.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Il prestito dell’utero, il mercato dei corpi, e la donazione (di Sarantis Thanopulos).12 marzo 2016, di Federico La Sala
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Il prestito dell’utero e la prostituzione
Verità nascoste. Nella gravidanza surrogata il fantasma del concepimento verginale è ovviamente attivo, ma nelle donne surroganti manca, di regola, la serialità dell’offerta che confermerebbe il potere condizionante del fantasma
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, Alias, 12.03.2016)
L’equiparazione del prestito dell’utero con la prostituzione rischia di dare una lettura semplificata a una questione complessa. La prostituzione ha due risvolti diversi, per quanto interconnessi. Il suo sfruttamento (che crea un plusvalore per lo sfruttatore) la pone sul piano dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Quest’ultimo è espressione di uno spostamento delle relazioni di scambio dalla parità dei soggetti sul piano del desiderio alla loro ineguaglianza sul piano del bisogno materiale, che le costituisce come rapporti di potere. Più le relazioni di scambio diventano relazioni di potere, quindi di sfruttamento, più l’appagamento del desiderio diventa un miraggio e il piacere tende a essere scarica pura dell’eccitazione, sollievo più che esperienza di trasformazione sensuale, emotiva e mentale.
Lo sfruttamento dell’operaio esclude l’impiego diretto del corpo sessuale che è, invece, l’oggetto da sfruttare nel campo della prostituzione. Tuttavia, in entrambi i casi l’uso del corpo, della donna come dell’uomo, è centrato sulla sua componente maschile. La componente femminile diventa periferica fino ad essere inibita, silenziata nella prostituzione. Più la componente femminile del corpo - sciogliersi, coinvolgersi, lasciarsi andare, aprirsi- si marginalizza, più la componente maschile- concentrarsi, disciplinarsi, coordinarsi, dirigersi- si irrigidisce, perdendo la sua creatività e la sua forza espressiva. Diventa lo strumento di un agire meccanico, esecutivo. Lo sfruttamento della prostituzione illumina la natura profonda dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo: esso trae il massimo vantaggio dal totale eclissarsi del corpo femminile.
L’altro risvolto della prostituzione, la sua realizzazione come lavoro autonomo, senza padroni, mostra la velleità della pretesa di usare liberamente il proprio corpo in dissociazione dallo scambio di doni nella relazione amorosa: la donazione reciproca del proprio coinvolgimento e della propria vulnerabilità da parte degli amanti. Il sesso a pagamento fa del denaro la protesi inerte con cui si ripara la mutilazione del tessuto vivo della femminilità, che consente lo scambio di doni. Se lo sfruttamento della prostituzione spiega il meccanismo dello sfruttamento del corpo del lavoratore, la prostituzione senza sfruttatori fa capire che la mercificazione delle relazioni umane trae il suo consenso da una riparazione disumanizzante, ma percepita come salda, compatta. Questa riparazione è mediata inconsciamente dal fantasma della “madre virginale”: il permanere del corpo femminile nel commercio erotico in superficie, che garantisce la sua inaccessibilità al piacere profondo.
Nella gravidanza surrogata il fantasma del concepimento verginale è ovviamente attivo, ma nelle donne surroganti manca, di regola, la serialità dell’offerta che confermerebbe il potere condizionante del fantasma. Le motivazioni inconsce soggiacenti al prestito dell’utero vanno cercate altrove. Nella delegittimazione del desiderio di disporre pienamente della propria creatività. Nel desiderio di donare ai propri genitori la genitorialità: offrire loro un altro figlio come riparazione per il fatto di averli delusi o, nella direzione opposta, dare loro una seconda opportunità, visto che sono stati deludenti. Il compenso finanziario, che è anche una forma surrettizia di legittimazione, non sarebbe sufficiente da sé, in assenza di questo tipo di motivazioni.
Il prestito dell’utero non è prostituzione, non è vendita di eccitazione: si trova in bilico tra il mercato dei corpi, che cerca di appropriarsene, e la donazione.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. -- ASTROSAMANTHA. Samantha Cristoforetti, lo spazio e i confini dell’Umanità2 marzo 2016, di Federico La Sala
- Astrosamantha, dallo spazio al cinema. In uscita l’1 e il 2 marzo in oltre 120 sale italiane, Astrosamantha - la donna dei record nello spazio, è il film-documentario di Gianluca Cerasola che ha seguito Samantha Cristoforetti nella preparazione della missione Futura, con cui la prima astronauta italiana ha conquistato il record europeo e femminile di permanenza nello spazio in un unico volo. Dal 3 marzo il film sarà disponibile per proiezioni scolastiche di Giulia Alice Fornaro (LE SCIENZE)
- "LEFT". Solo questa sera e domani nei cinema d’Italia verrà proiettato il documentario "Astrosamantha" che racconta la storia di Samantha Cristoforetti la prima italiana ad andare sullo spazio considerata la donna dei record. Qui un suo ritratto che vi avevamo proposto all’inizio di quest’anno: http://goo.gl/aVpZ9X:
Nel 2016 ne sentirete parlare: Samantha Cristoforetti, lo spazio e i confini dell’Umanità
di Giorgia Furlan ("Left", dicembre 29th, 2015)
Questo 2015 è indubbiamente stato l’anno dello spazio, siamo andati al cinema a vedere Interstellar e abbiamo seguito Matt Damon sopravvissuto in The Martian. Incollati allo schermo abbiamo guardato le nuove foto di Plutone, assistito alla scoperta dell’acqua, e quindi della potenziale vita, su Marte. Soprattutto abbiamo sentito parlare di Samantha Cristoforetti. Samantha, classe 1977, passerà alla storia perché è la prima donna italiana ad essere andata nello spazio e vi ha trascorso ben 220 giorni, anche questo un record.
La rivista Time ha voluto assolutamente intervistarla: «con equipaggi ancora prevalentemente maschili, rimane solo un soffitto di cristallo tra la Terra e l’ orbita, e sono le donne, non gli uomini, a doverlo sfondare» scriveva Jonathan D. Woods il 10 agosto di quest’anno presentando l’astronauta italiana. Il Financial Times addirittura la indica, unica italiana insieme alla scrittrice Elena Ferrante, nella lista delle donne del 2015, forse proprio per quel record di permanenza nello spazio conquistato sulla Stazione Internazionale. Lei che per arrivare lassù ha superato una selezione fra altri 8500 candidati. Lei che volente o no, quest’anno, tra un tweet dal suo account @AstroSamantha e un altro, sempre mentre era ancora in orbita, è diventata un simbolo nazional popolare tanto da essere stata ospite in collegamento dalla Iss durante il Festival di Sanremo. Tanto da essere invitata da Matteo Renzi - uno che alle cose che hanno anche solo un sentore di nazional popolare non sa resistere - alla Leopolda 6. Invito a quanto pare rispedito al mittente dall’ingegnere trentina.
Sicuramente quella della Cristoforetti è una storia che ci piace raccontare perché parla di un’Italia fatta di eccellenza e meritocrazia, ma Astrosamantha è anche qualcosa di più. È un simbolo, inconsapevole, che in qualche modo racchiude in sè i desideri, le aspirazioni e le difficoltà dell’anno appena trascorso.
Lanciare una navicella nel buio lassù ci entusiasma e ci galvanizza, è il trionfo dell’illuminismo, un piccolo passo per un uomo, enorme per una donna, sicuramente: “un grande passo per l’Umanità”
Samantha Cristoforetti non ci ha appassionato così tanto perché eravamo consci dell’importanza scientifica della sua missione, ma perché per noi la sua era un’impresa epica, un viaggio oltre il confine dell’atmosfera che su di noi, poveri profani rimasti con i piedi sulla terra, ha avuto lo stesso fascino della conquista del West. Ha mostrato la possibilità concreta di pensare come valicabile un confine che sembrava invalicabile. “Sfondare il soffitto di cristallo” di cui parla Jonathan D. Woods sulle pagine di Time.
Se, infatti, indubbiamente questo è stato l’anno dello spazio, altrettanto indubbiamente, è stato anche quello dei confini. E lo stesso spazio è questione di confini, limiti tecnici e fisici, che vengono superati (pensate all’atmosfera o alla gravità). Lanciare una navicella nel buio lassù ci entusiasma e ci galvanizza per questo, è il trionfo dell’illuminismo, un piccolo passo per un uomo, enorme per una donna - dopo tutto che saranno mai 8.500 concorrenti - sicuramente: “un grande passo per l’umanità”.
L’umanità, ecco, un’altra cosa che, soprattutto quest’anno, ha avuto a che fare con i confini. Quelli segnati dal filo spinato varcati dai rifugiati; quelli liquidi del Mediterraneo solcati dai migranti; quelli rivendicati dai kurdi impegnati nella resistenza contro Daesh; quelli che, dopo Charlie Hebdo e gli attentati di Parigi, le destre populiste hanno tentato di tracciare tra noi e “loro”, come se la vita fosse un film hollywoodiano dove esistono solo buoni e cattivi.
Quest’anno ha avuto a che fare con i confini europei - quelli di un’Unione che vorrebbe essere forte, ma spesso si dimostra fragile - per cui la Grecia doveva essere dentro o fuori. E con le “frontiere” ambientali discusse a Parigi che, più che confini, sono limiti da rispettare e traguardi a cui tendere. Infine, quest’anno ha appunto avuto a che fare con la linea di confine tracciata dall’idea di spazio dove è finita Samantha Cristoforetti e che, forse per una banale questione metaforica di micro e macro o per il fatto altrettanto simbolico che in tutte quelle foto il globo lo vediamo dall’alto e per intero, potrebbe includere tutti quanti gli altri. Quasi si trattasse di un monito e di un memento.
A dicembre, nell’ultimo numero di Left abbiamo inserito uno degli scatti di Samantha nel nostro portfolio di fine anno e abbiamo titolato l’immagine così: “Se da lassù a guardarci è una donna”.
Ecco, “se da lassù a guardarci è una donna”, forse si finirebbe con il pensare che no, non è vero che l’Umanità ha dei confini. Che dividere il mondo in noi e loro è solo una questione di prospettiva, ridotta. Che per questo 2016 dovremmo impegnarci a guardare il mondo dalla prospettiva di AstroSamantha.
In fondo: «Visto da lassù il Mediterraneo è una pozzanghera. Non ha senso barricarsi» parola di astronauta.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Freud dava due notizie ai genitori. L’importante è dare ai figli la loro libertà (di M. Recalcati).29 gennaio 2016
L’importante è dare ai figli la loro libertàdi Massimo Recalcati (la Repubblica, 29.01.2016)
Freud dava due notizie ai genitori. La prima, piuttosto disarmante, è che si tratta di un mestiere impossibile. La seconda, che forse ci può rincuorare, è che i migliori tra loro sono quelli consapevoli di questa impossibilità.
Ma perché il mestiere del genitore sarebbe impossibile? Perché, come mostra l’esperienza, non si può esercitare questa funzione se non in modo sempre, più o meno, insufficiente, incerto. Nessuno può, infatti, possedere la risposta infallibile su qual è il senso della vita, del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto. Tutti noi ci barcameniamo alla meno peggio navigando a vista, rinunciando alla favola della mano sicura che guida la vita dei figli. Questo spiega anche perché i peggiori genitori sono invece quelli che pensano di essere dei buoni genitori, o, peggio, di incarnarne il loro modello ideale.
La psicoanalisi raccoglie sovente i cocci provocati da questo tipo di genitori eccessivamente identificati alla loro funzione educativa. Accadde, tra gli altri, al povero Schreber, presidente della Corte di Appello di Lipsia, paranoico delirante, che dovette sopportare da bambino il sadismo folle di un padre inventore di apparecchi educativi finalizzati a correggere la scarsa forza di volontà dei suoi figli.
Affermare che il mestiere del genitore è impossibile significa che non esistono manuali in grado di spiegare come si fa ad essere un genitore sufficientemente buono. La credenza - al limite della superstizione - del nostro tempo alimenta invece la fantasia che esistano ricette predefinite e valide per tutti capaci di rendere le cure genitoriali efficaci. Manuali che spiegano come regolare il sonno del proprio bambino, il suo appetito, le sue facoltà cognitive, il suo temperamento, il suo comportamento in generale. Manuali che spiegano come calibrare nella giusta misura gratificazioni e frustrazioni, premi e punizioni, affettività e normatività.
Non casualmente questo proliferare di un sapere educativo pret-à-porter fiorisce proprio nel momento in cui si assiste al tramonto dell’autorità simbolica in tutte le sue declinazioni, prima fra tutte quelle del pater familias. Se il tempo del padre-padrone si è esaurito, bisogna affidarsi a manuali dall’aspetto più democratico e ammantati da una parvenza di scientificità per orientare con sicurezza la vita dei nostri figli. Ecco allora apparire un esercito di esperti specializzati sulla funzione genitoriale che spiegano - di fronte al vuoto lasciato dal declino (benedetto) dell’ideologia patriarcale - in che cosa consisterebbe la “giusta” educazione. Una pletora di istruttori di genitori (solitamente, a loro volta, genitori protagonisti di fallimenti) si prodiga nell’elencare le regole che dovrebbero garantire un successo educativo.
Ma è questa la via per provare a reinventare un modello educativo alternativo a quello che abbiamo ereditato dall’ideologia patriarcale e ai fallimenti di quello libertario post ‘68? I migliori genitori, spiega Freud, sono quelli consapevoli della loro insufficienza, ovvero quelli che rifuggono da un sapere predefinito, standard. Quelli che sanno che la sola cosa che conta nel rapporto coi figli è aver fatto loro segno dell’amore, ovvero riconoscerli nella loro assoluta particolarità. Senza questo riconoscimento la vita si ammala, si depotenzia, si disperde.
Quello che conta nel processo di umanizzazione della vita è avere fede nel desiderio dei propri figli, donare loro la possibilità della sconfitta e del fallimento, ma anche quella di rialzarsi, di ripartire contando sul sostegno dei loro genitori. Quello che conta è donare loro la libertà di essere diversi da come li avremmo voluti; è lasciarli essere quello che sono. Sartre diceva che se i genitori hanno delle attese sui figli i figli avranno dei destini e, solitamente, assai infelici. Nessuna regola comportamentale può compensare l’assenza del segno d’amore che sa riconoscere la particolarità reale del figlio al di là di ogni sua rappresentazione ideale.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. - Note.18 gennaio 2016
-
> NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- KANT, L’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA, E IL "MEIN KAMPF. Note.12 gennaio 2016, di Federico La Sala
FILOSOFIA E TEOLOGIA POLITICA DELL’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
- LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
 "LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO".
- SOVRANITA’ E OBBEDIENZA. "DICO": DI CHI, DI QUALE LEGGE - A CHI, A QUALE LEGGE OBBEDIRE?!! ALLA LEGGE DEL PAPA - "COME UN CADAVERE" o ALLA LEGGE DEL "PAPA’-PADRE NOSTRO" (Amore-Charitas, dei nostri "padri" e delle nostre "madri") - COME UN FIGLIO E UNA FIGLIA, UNA CITTADINA SOVRANA E UN CITTADINO SOVRANO?!
 Al Faraone e alla sua legge o a Mosè e alla Legge che egli stesso segue?! Abramo, chi ascoltò: Baal, il dio dei sacrifici e della morte, o Amore, il "dio" dei viventi?! Un’analisi di Giovanni Filoramo
Al Faraone e alla sua legge o a Mosè e alla Legge che egli stesso segue?! Abramo, chi ascoltò: Baal, il dio dei sacrifici e della morte, o Amore, il "dio" dei viventi?! Un’analisi di Giovanni Filoramo
Hitler, un figlio dell’occidente
70 anni fa il fututo Fuhrer diventava cancelliere del Reich. Aveva già programmato tutto in "Mein Kampf".
Lo storico Giorgio Galli ha curato la ristampa del libro per Kaos: "Razzismo e antisemitismo non erano sue invezioni".
di Oreste Pivetta *
Settant’anni fa Adolf Hitler diventava cancelliere dei Reich. Era la mattina del 30 gennaio quando il presidente Paul Hindenburg gli affidò l’incarico. Hitler poteva contare su una coalizione di destra, ma quarantotto ore dopo l’investitura ottenne da Hindenburg lo scioglimento del parlamento. A febbraio il nuovo governo decretò la sospensione della libertà di stampa e i nazisti scatenarono un’ondata di violenze contro gli oppositori politici. Soprattutto i nazisti misero in moto la formidabile macchina della propaganda, diretta da Goebbels, mentre per decreto legge (a fine febbraio) venivano sospese le libertà costituzionali e proibito l’attivismo politico delle sinistre. Il giorno prima, il 27 febbraio, era stato dato alle fiamme il Reichstag. Dell’incendio fu accusato un cittadino olandese di presunte simpatie comuniste, Marinus van der Lubbe.
Cominciava così la più tragica avventura del nostro secolo, alla fine la guerra, le deportazioni, lo sterminio. Le idee che ispirarono tutto questo, stanno in un libro, Mein Kampf, che Hitler aveva dettato al suo segretario Rudolf Hess nell’anno di prigionia, nel carcere di Landsberg, tra l’11 novembre 1923 e il 20 dicembre 1924. Hitler era stato condannato per alto tradimento per il tentato putsh di Monaco, il putsh della birreria. Mein Kampf, scritto in forma prolissa e contorta, fu rivisto e corretto (anche dagli errori grammaticali) da un prete che era diventato giornalista antisemita, Bernhard Stempfle, e da Josef Czerny, di origine cèca, giornalista e poeta ugualmente antisemita. Il titolo era di Max Amman, che stava in carcere con Hitler ed era il direttore commerciale della casa editrice del partito nazionalsocialista.
Il libro ebbe all’inizio scarsa fortuna. Alla fine della guerra, al crollo del nazismo ne erano state vendute dieci milioni di copie. Veniva regalato ad ogni coppia di neo-sposi. In Italia fu Bompiani a pubblicare nel 1934 il secondo volume, quello dichiaratamente teorico, che si intitolava Il movimento nazional socialista. Il primo volume (Resoconto), più autobiografico, apparve sempre con Bompiani nel 1938. L’editore Kaos ristampa ora entrambi i volumi, a cura di Giorgio Galli, che ha scritto anche un’ampia introduzione (con una postfazione di Gianfranco Maris, presidente dell’Aned, associazione nazionale ex deportati).
Professor Galli, la prima domanda nasce dal disagio: il disagio, persino materiale di fronte a un oggetto come un libro, di chi ha sempre visto in «Mein Kampf» uno dei simboli della barbarie nazista. Un libro respinto dalla nostra coscienza. Perchè ristamparlo?
«Intanto perchè in una società aperta non dovrebbero esistere tabù. Poi perchè Mein Kampf non è mai scomparso: ne sono circolati estratti in una chiara logica apologetica e si sa che una cosa proibita esercita sempre una certa attrazione. Questa riedizione ha un dunque un senso: non accettare i tabù e offrire un testo storicamente collocato, un testo che può illuminare la figura di Hitler, che tante ambiguità, tante rimozioni e persino le censure possono avvolgere di un fascino sinistro... Proprio sere fa in un programma televisivo, padre Amorth, il prete esorcista del Vaticano, trattava Hitler al pari di un indemoniato. L’oscurità può sedurre: una indagine ha catalogato centocinquanta siti internet ispirati ad una sorta di mito hitleriano».
L’idea della follia è anche un’idea di alterità. Leggendo invece «Mein Kampf» si dovrebbe capire quanto Hitler viva invece nel solco della cultura del suo tempo?
«Mein Kampf è stato sempre giudicato un prodotto abbastanza singolare, sorprendente, quasi un incidente nei percorsi della storia politica occidentale. Non è vero. Hitler raccoglie idee che vengono da lontano. Mi rifaccio alle tesi di Poliakov e di Mosse. Il razzismo e l’antisemitismo non sono invenzioni di Hitler».
Raul Hilberg, nella «Distruzione degli ebrei d’Europa» (Einaudi), presenta addirittura le tavole comparative tra diritto canonico e misure naziste: dal divieto dei matrimoni misti (Sinodo di Elvira del 306) alla legge per la difesa del sangue e dell’onorabilità tedesca (15 settembre 1935), dalla proibizione per gli ebrei a rivestire cariche pubbliche (Sinodo di Clermont del 535) alla legge sulla riorganizzazione delle professioni burocratiche pubbliche (7 aprile 1933). Il distintivo di riconoscimento fu inventato dal Concilio Lateranense nel 1215. Scrive Hilberg: i nazisti non hanno rinnegato il passato, hanno costruito sulle vecchie fondamenta...
«Nel testo hitleriano il razzismo antigiudaico è l’approdo di una concezione razziale che affonda nella cultura occidentale. Hitler per esempio utilizza il francese Joseph-Arthur Gobineau e il suo Saggio sull’ineguaglianza delle razze. Ne ricava l’esecrazione per il "meticciato", che avrebbe portato alla degenerazione dell’umanità. Nel Mein Kampf si ritrovano le teorie eugenetiche dello psicologo inglese Francis Galton...».
Erano tutte letture di Hitler?
«Non letture dirette, ma non credo che la cultura di Hitler si limitasse a pochi opuscoli antisemiti. Conosceva Nietzsche e Schopenhauer. Ipotizzo che conoscesse anche Weber: nella concezione che Hitler manifesta del "capo carismatico", che dev’essere confermato dal successo e che è forte di una tradizione, vi è affinità con il pensiero del sociologo. Tra i dirigenti nazisti era popolare Gobineau».
La storiografia revisionista, che come scrive uno studioso che lei cita, Enzo Traverso, tende a espellere i crimini nazisti dalla traiettoria del mondo occidentale, spiegandoli come una reazione alla rivoluzione russa...
«Non fu l’antibolscevismo a indurre Hitler all’invasione dell’Unione Sovietica. L’operazione Barbarossa non fu il risultato di una contrapposizione ideologica, ma di una pretesa di "spazio vitale". Lo si legge appunto nel Mein Kampf: "Chiudiamo finalmente la politica coloniale e commerciale dell’anteguerra... quando oggi parliamo di nuovo territorio in Europa, dobbiamo pensare in primo luogo alla Russia o agli Stati marginali a essa soggetti. Sembra che il destino stesso ci voglia indicare queste regioni: consegnando la Russia al bolscevismo, rapì al popolo russo quel ceto di intellettuali che finora ne addusse e garantì l’esistenza statale...".
Come si spiega invece la simpatia per l’Inghilterra. Anche qui fa testo il «Mein Kampf», a proposito di Inghilterra e Italia: «La più grande Potenza mondiale e un giovane Stato nazionale offrirebbero ben altri elementi per una lotta in Europa, rispetto ai putridi cadaveri di Stati ai quali la Germania si alleò nell’ultima guerra».
«Sullo sfondo c’è sempre la missione della razza ariana. Secondo i nazisti da una parte della Manica stavano gli ariani di mare, dall’altra gli ariani di terra».
«Mein Kampf» definisce anche il ruolo dello stato. Che cosa rappresenta per Hitler lo stato?
«Lo stato è uno strumento. Scrive: "Lo stato non rappresenta un fine, ma un mezzo. Esso è la premessa della formazione di una civiltà umana superiore, ma non è la causa di questa...". Hitler ribalta le conclusioni di Gobineau: il meticciato non è irreversibile, l’ariano resiste, lo stato è solo il mezzo per invertire la tendenza alla degenerazione, da qui la politica eugenetica dedotta da Galton, teorizzata nel Mein Kampf, attuata dal Terzo Reich. Nella concezione hitleriana lo Stato non è dunque un oggetto di culto, ma uno strumento al servizio di una razza che si edifica in nazione e costruisce una civiltà».
Altro tema fondamentale del «Mein Kampf» è quello relativo alla concezione della classe politica...
«Di Weber appunto è l’idea del capo carismatico investito di una missione, attorno al quale si forma il primo nucleo dei fedeli e che deve essere confermato dal successo, "la inequivocabile prova del successo visibile, il quale, in fin dei conti darà sempre l’ultima conferma della giustezza di un’azione". I profeti disarmati non contano».
Siamo ancora nella tradizione occidentale?
«Tutti i politici anche i più moderati coltivano l’idea di essere investiti da una missione, coltivano la convinzione di avere un compito di pubblica utilità. Questo Weber lo coglie con lucidità. La storia politica dell’Occidente è costruita da personaggi di questo genere, da Cronwell a Napoleone. Hitler ha aggiunto la dimensione divina: capo politico e sacerdote del nuovo rito. Le sue oceaniche assemblee erano quasi cerimonie liturgiche: la massa dei sottoposti nel buio, la tribuna nella luce, il capo che arriva al culmine della rappresentazione. Non cita ovviamente una religione: Hitler si appella agli dei o a una provvidenza che non è mai la provvidenza cristiana... Hitler scrive: "Noi ci rivolgiamo a quelli che adorano non il denaro, ma altri Dei, ai quali votano la loro esistenza"».
«Mein Kampf» dunque sintesi della futura politica hitleriana. Singolare che non faccia cenno alle fonti...
«Mein Kampf esprime un progetto compiuto. Gli atti successivi sono rintracciabili in quelle pagine. Il nazismo si affermò sulla base di un disegno preciso e chiuso, al contrario del fascismo che procedette in modo molto più empirico. L’unica teorizzazione del fascismo sta in quella voce dell’enciclopedia Treccani scritta da Gentile e rivista da Mussolini... Per quanto riguarda le fonti, tacendole Hitler rivendicava l’originalità del proprio pensiero».
Non fu solo un progetto però ad assicurare il successo del nazismo... un movimento che fino al 1928 non aveva che il tre per cento dei voti dopo cinque anni andava al potere.
«Non fu l’ideologia ed anche questo smentisce i revisionisti. Furono sei milioni di disoccupati, con i quali il comunismo non aveva nulla a che fare. La crisi tedesca stava tutta all’interno del sistema liberal democratico. La classe politica della repubblica di Weimar si era mostrata incapace, non solo divisa. La soluzione venne da una medicina keynesiana, come quella adottata negli Stati Uniti, proposta a Hitler da Hjalmar Schacht, il presidente della Banca tedesca: investimenti pubblici per rilanciare l’economia. Il bello è che Schacht aveva presentato lo stesso piano al governo di Weimar, che l’aveva respinto. Fu il primo successo di Hitler: la disoccupazione di massa cancellata. Il "miracolo economico" consentì la seconda performance di Hitler: il riarmo. Nel 1933 la Germania aveva un esercito di centomila uomini, male armati, senza aerei. Nel 1938 la Germania era la prima potenza militare europea».
Mein Kampf, il libro di Hitler torna in vendita: “Meglio, l’ignoranza non aiuta mai. E i tedeschi hanno fatto i conti con la Storia. Non come l’Italia”
di Davide Turrini
Il volume in cui il Führer anticipava l’ideologia dello sterminio antisemita. Ilfatto.it ha intervistato un giornalista (Gad Lerner), un politologo (Piero Ignazi) e uno storico (Gian Enrico Rusconi). E sono tutti d’accordo: è giusto che quelle pagine tornino "libere" di circolare. "Edizione critica come questa ci aiuterà a capire cosa abbiamo imparato in questi 70 anni"
di Davide Turrini *
Duemila pagine, quasi 5mila note a margine, 4mila copie in prima tiratura, e 59 euro come prezzo di copertina. Il Mein Kampf di Adolf Hitler tornerà ufficialmente nelle librerie della Germania dopo 70 anni da gennaio 2016. L’iniziativa della pubblicazione di un edizione “critica” del testo scritto dal dittatore nazista in due volumi, tra il 1924 e il 1926 mentre era detenuto in carcere dopo il fallito Putsch del 1923, e dove venivano delineati i prodromi ideologici dello sterminio antisemita, è stata presa dal prestigioso Istituto di Storia Contemporanea di Monaco di Baviera. Secondo la legge tedesca la scadenza del copyright scatta a 70 anni dalla morte dell’autore (Hitler si suicidò nel bunker di Berlino il 30 aprile 1945).
 E’ dal 1946 che il ministero delle Finanze del governo della Baviera detiene i diritti del libro che tra il 1933 e il 1945 aveva registrato 13 milioni di copie vendute. Il Land bavarese ne ha negato la pubblicazione a livello editoriale più volte nel corso dei decenni del dopoguerra, anche se non ha potuto fare nulla rispetto alle copie agiografiche circolate sottobanco in lingua inglese o francese (diverso il caso italiano che ha visto la pubblicazione di un volume “critico” di tutto rispetto edito in Italia da Kaos Edizioni e curato dal politologo Giorgio Galli).
E’ dal 1946 che il ministero delle Finanze del governo della Baviera detiene i diritti del libro che tra il 1933 e il 1945 aveva registrato 13 milioni di copie vendute. Il Land bavarese ne ha negato la pubblicazione a livello editoriale più volte nel corso dei decenni del dopoguerra, anche se non ha potuto fare nulla rispetto alle copie agiografiche circolate sottobanco in lingua inglese o francese (diverso il caso italiano che ha visto la pubblicazione di un volume “critico” di tutto rispetto edito in Italia da Kaos Edizioni e curato dal politologo Giorgio Galli).
 Un’opposizione che però il ministero bavarese non potrà più esercitare per legge dal 31 dicembre 2015. Ed è qui che è entrato in gioco l’Ifz, con un team di validi e preparati storici tedeschi - Christian Hartmann, Thomas Vordermayer, Othmar Plöckinger, Roman Töppel -, a cui era già stata rifiutata a metà anni 1990 la pubblicazione del Mein Kampf dove aver dato alle stampe un volume contenente diversi discorsi hitleriani tenuti tra il 1925 e il 1933. “Il libro di Hitler è già ‘disponibile’ in una varietà di modi. L’obiettivo è quello di decostruire completamente la propaganda in maniera duratura e, quindi, di indebolirne l’ ancora vivo potere simbolico. In questo modo cerchiamo anche di contrastarne un uso improprio ideologico e propagandistica con fini commerciali”, viene spiegato sul sito dell’Istituto Storico di Monaco.
Un’opposizione che però il ministero bavarese non potrà più esercitare per legge dal 31 dicembre 2015. Ed è qui che è entrato in gioco l’Ifz, con un team di validi e preparati storici tedeschi - Christian Hartmann, Thomas Vordermayer, Othmar Plöckinger, Roman Töppel -, a cui era già stata rifiutata a metà anni 1990 la pubblicazione del Mein Kampf dove aver dato alle stampe un volume contenente diversi discorsi hitleriani tenuti tra il 1925 e il 1933. “Il libro di Hitler è già ‘disponibile’ in una varietà di modi. L’obiettivo è quello di decostruire completamente la propaganda in maniera duratura e, quindi, di indebolirne l’ ancora vivo potere simbolico. In questo modo cerchiamo anche di contrastarne un uso improprio ideologico e propagandistica con fini commerciali”, viene spiegato sul sito dell’Istituto Storico di Monaco.Sono stato di recente a visitare il serissimo istituto tedesco che ha ricevuto l’incarico di questa pubblicazione - racconta spiega Gad Lerner a ilfattoquotidiano.it - Ho parlato con i curatori che hanno molto ben presente la responsabilità che si assumono: l’alternativa è una circolazione clandestina dell’opera in forma apologetica venduta nei mercatini, mentre loro invece con grande senso di responsabilità ne fanno un’edizione critica, soprattutto come strumento di lavoro per studiosi, perfino poco maneggevole, oserei dire dissuasiva, costosissima, sovrastata di note, dove vengono denunciate molte delle falsità storiche contenute”. Secondo quanto spiega il giornalista, gli storici dell’Ifz “hanno avuto un confronto anche aspro con le personalità del mondo ebraico tedesco, che ha vissuto con fatica questa decisione. Però la scelta è stata veramente soppesata e non presa alla leggera. Non mi sento di criticarla anzi trovo positivo il fatto che questo tabù in Germania venga affrontato”.
 In Germania “grazie ad un’opera di divulgazione storica avvenuta persino in prima serata sulla tv pubblica già dagli anni Novanta ci si è richiamati ad una responsabilità storica collettiva su quanto accaduto col nazismo - continua Lerner - Da questo punto di vista i tedeschi hanno fatto i conti con un buco nero della loro storia in modo ben più consapevole rispetto a quanto l’Italia ha fatto con il fascismo. La classe dirigente italiana ha adottato uno spirito di autoassoluzione e di reticenza culminata nella minimizzazione del ruolo di Mussolini su quegli avvenimenti, come nelle bestialità proferite da Berlusconi al memoriale del Binario 21 nel Giorno della Memoria nel 2013”.
In Germania “grazie ad un’opera di divulgazione storica avvenuta persino in prima serata sulla tv pubblica già dagli anni Novanta ci si è richiamati ad una responsabilità storica collettiva su quanto accaduto col nazismo - continua Lerner - Da questo punto di vista i tedeschi hanno fatto i conti con un buco nero della loro storia in modo ben più consapevole rispetto a quanto l’Italia ha fatto con il fascismo. La classe dirigente italiana ha adottato uno spirito di autoassoluzione e di reticenza culminata nella minimizzazione del ruolo di Mussolini su quegli avvenimenti, come nelle bestialità proferite da Berlusconi al memoriale del Binario 21 nel Giorno della Memoria nel 2013”.“Era ora”, commenta il politologo Piero Ignazi che si è occupato in parecchi volumi delle origini dell’estrema destra in Europa. “Non sono per la censura dei libri in generale, come comprendo il problema che può vivere la Germania. Ma attenzione, di testi maledetti se ne trovano sempre come ad esempio alcuni di Rousseau che portano ai disastri della Rivoluzione francese. Questi sono documenti che servono per capire ancora meglio ciò che è accaduto. L’ignoranza non aiuta mai. Anche se più complessa e spiacevole è sempre meglio affrontare la realtà dei fatti”. “Dal punto di vista della propaganda partitica dei partiti di destra odierni, a parte qualche folkloristico gruppo neonazista, non c’è più nessuno che si richiama al fascismo storico - continua Ignazi - Anche il Front National per ricevere così tanti consensi ha avuto la capacità con la nuova leadership di distaccarsi dal filo conduttore sottile del passato francese dell’Oas e di Vichy, altrimenti avrebbero fatto la fine del Movimento Sociale Italiano”.
Per lo storico Gian Enrico Rusconi, esperto del Novecento tedesco, il ritorno alla pubblicazione del Mein Kampf “è un segno di maturità questa pubblicazione a cui i miei colleghi di Monaco pensavano da tempo. Non siamo ingenui: copie del Mein Kampf ne giravano da anni. Scientificamente e storicamente il capitolo lo reputo relativamente chiuso, mentre rimane aperto e diffuso un aspetto antropologico-culturale più sottile e presente prima e dopo la pubblicazione di questo libro, perché le radici profonde del volkisch erano già vive prima di Hitler”.
 Quindi secondo Rusconi questo testo non va letto “in maniera deterministica”. La “radicalizzazione sterminatoria”, aggiunge, è un processo “che avviene lentamente in una cultura che ha trovato l’espressione di Hitler per realizzarla e che adesso magari trova altre scorciatoie dove incanalarsi.
Quindi secondo Rusconi questo testo non va letto “in maniera deterministica”. La “radicalizzazione sterminatoria”, aggiunge, è un processo “che avviene lentamente in una cultura che ha trovato l’espressione di Hitler per realizzarla e che adesso magari trova altre scorciatoie dove incanalarsi.
 Se non fossimo in questo clima xenofobo, dell’ostilità verso lo straniero, legato alle ondate migratorie dal Medio Oriente, non ne parleremmo neanche. Semmai cogliamo l’occasione della pubblicazione di un’edizione critica del Mein Kampf come questa per capire, paradossalmente, quali sono le forme con cui oggi si manifesta questo sentimento radicale di appartenenza nazionale e di patria, e cosa abbiamo imparato in questi 70 anni”.
Se non fossimo in questo clima xenofobo, dell’ostilità verso lo straniero, legato alle ondate migratorie dal Medio Oriente, non ne parleremmo neanche. Semmai cogliamo l’occasione della pubblicazione di un’edizione critica del Mein Kampf come questa per capire, paradossalmente, quali sono le forme con cui oggi si manifesta questo sentimento radicale di appartenenza nazionale e di patria, e cosa abbiamo imparato in questi 70 anni”. - LO STATO DEL FARAONE, LO STATO DI MINORITA’, E IMMANUEL KANT "ALLA BERLINA" - DOPO AUSCHWITZ
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA FIABA, LA FAVOLA, E ... LA "CONFUSIONE" DI MASSIMO GRAMELLINI. Non sappiamo più raccontare le favole!?9 gennaio 2016, di Federico La Sala
- LA FIABA, LA FAVOLA, E ... LA "CONFUSIONE" DI GRAMELLINI.
- Innanzitutto invito a leggere l’articolo, e, nello stesso tempo, invito a tenere ben distinte le due parole "favola" e "fiaba" (due generi diversi di "racconti"), e, poi, a riflettere di più e meglio sull’inizio (tragico!) di "Pinocchio": "C’era una volta. - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno"!!!
 SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
SI TRATTA della "storia di un burattino"!!! Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! Per questo non è male accogliere le sollecitazioni e provocazioni di Gramellini e e rifletterci su...
- INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
Non sappiamo più raccontare le favole
Un saggio americano: solo gli inglesi riescono a inventarle. Non hanno paura del lato oscuro
di Massimo Gramellini (La Stampa, 08/01/2016)
La rivista letteraria The Atlantic, americana, ha condotto un’inchiesta dettagliata ed è giunta alla conclusione che in quest’epoca di ansie assortite e lettori bisognosi di cure affabulatorie, soltanto gli inglesi siano ancora capaci di popolare l’immaginario dei bambini di ogni nazione ed età. Alla notizia che l’Inghilterra, magari con l’aggiunta dell’Irlanda, detenga l’esclusiva delle favole qualcuno storcerà il naso e opporrà le sue eccezioni, però è un fatto che il più formidabile parto fantastico degli ultimi decenni è stato il maghetto Harry Potter, britannico, la cui saga si inserisce in un filone avviato dai personaggi di Tolkien e C.S Lewis, britannici anch’essi. Sarà il rapporto più stretto con la natura e con i miti fondativi pagani, l’assenza di una religione troppo moralista e inibente, la passione diffusa per i saperi esoterici, ma gli inglesi (e gli irlandesi) sembrano avere conservato un seme di conoscenze antichissime e la capacità di diffonderle attraverso un codice di immagini e archetipi che non parla all’emisfero razionale del cervello, ma si rivolge direttamente al subconscio di tutti gli esseri umani.
Uno dei momenti più emozionanti della mia vita è stata la scoperta che, accanto al significato letterale, le favole ne celavano un altro simbolico. Uno dei momenti più tristi è stato accorgermi che di questa scoperta non importava niente quasi a nessuno. Eppure mi vengono ancora i brividi quando penso agli artisti illuminati che dalla notte dei tempi hanno rivestito i segreti dell’esistenza e persino le future rivelazioni della fisica quantistica con le metafore dei racconti per l’infanzia. Quando penso che la Bella e la Bestia è la storia dello spirito che si riconcilia con la materia. Che la spada nella roccia è un simbolo fallico e la sua estrazione da parte del giovane Artù un rito di iniziazione sessuale. Che il bacio del principe azzurro alla bella addormentata è la metafora di quel risveglio consapevole che sta alla base di ogni antica tradizione spirituale. Che la rinuncia al simbolo del potere - sia esso l’anello elfico che Frodo va a gettare nel vulcano di Mordor o la bacchetta di sambuco che Harry Potter decide di spezzare dopo averla vinta a lord Voldemort nel duello finale - è l’atto supremo di distacco che completa l’evoluzione interiore dell’eroe.
Non è importante comprenderli con la mente, certi significati reconditi. L’emozione della favola li porta egualmente là dove devono andare: al di sotto della corteccia dell’Ego, nel regno della coscienza che Jung chiamava il Sé. La lettura delle favole procede su due livelli. Il subconscio infatti non comprende le parole. Il suo alfabeto è fatto di immagini e suoni. Mentre il piccolo lettore ascolta le avventure di principi e principesse, da qualche parte dentro di lui si forma l’immagine simbolica su cui potrà fare affidamento per il resto della vita. Quando, smarrita la sbornia di “realtà” tipica dell’età dello sviluppo, sentirà il bisogno di attingere a una conoscenza eterna per lenire le proprie paure e sviluppare i propri talenti.
Tutto questo gli inglesi non lo hanno dimenticato. E hanno avuto la forza di ricordarlo al mondo. Non è solo questione di lingua. Anche gli americani scrivono in inglese, ma le loro trame per l’infanzia esprimono un intento educativo, e dunque pragmatico, che smorza sul nascere lo sbrigliarsi della fantasia. Huck Finn è un capolavoro e Mark Twain un genio, ma si tratta di un capolavoro e di un genio intrisi di realtà. Persino la metafisica Moby Dick di Melville è appesantita da decine di pagine francamente noiose sulle varie tipologie di balene, quasi che lo scrittore avesse voluto rimarcare la base scientifica della sua straordinaria creazione. La cultura nordamericana ha compresso l’irrazionale fin dalle origini, assieme ai nativi indiani che ne sarebbero stati i naturali cantori. La concretezza etica della società fondata dai Padri Pellegrini ha spinto i compositori di favole a interpretarle non come una vacanza del pensiero, ma come il rivestimento zuccheroso di una medicina fatta di regole morali da impartire sotto forma di apologo con morale incorporata.
E gli italiani? Avendo copiato gli americani praticamente in tutto, non potevamo che seguirli anche in questa strage della fantasia immolata sull’altare della cosiddetta realtà. Pinocchio è un gigante della narrativa universale, eppure fu ignorato per un certo periodo persino dai suoi contemporanei. Le biografie di Collodi pubblicate dai giornali dopo la sua morte liquidano il burattino in poche righe. L’autore stesso non ebbe piena consapevolezza della sua opera, che toccò a Benedetto Croce sdoganare almeno dal punto di vista letterario. Collodi era un massone e non c’è pagina di Pinocchio che non contenga un riferimento alchemico (a cominciare dal nome del protagonista che si rifà alla ghiandola pineale, il “terzo occhio” di cui ogni tradizione esoterica si ripropone l’attivazione). Ma non ha lasciato eredi. Oggi si scrivono favole anche molto poetiche, intasate soprattutto di animali che parlano e ragionano come gli umani, ma manca la magia della spiritualità che in un Paese cattolico come il nostro viene ancora associata esclusivamente alla religione. Mentre il misticismo pagano che è alla base delle fantasie immortali degli inglesi si nutre di boschi, di orfani e di lettori che abbiano voglia di lasciarsi lambire dalla loro ombra a costo di perdervisi.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI". DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- «Diritto d’amore» di Stefano Rodotà e il divenire universale dell’autonomia individuale (di R. Ciccarelli)7 gennaio 2016, di Federico La Sala
Rodotà, il divenire universale dell’autonomia individuale
Saggi. «Diritto d’amore» di Stefano Rodotà per Laterza. Dalle unioni civili alla laicità dell’istruzione. Un libro che segnala come la legge non può colonizzare la vita affettiva e la sessualità di uomini e donne. L’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 07.01.2016)
È arduo per un giurista parlare del diritto di amare, dato che la disciplina che rappresenta ha usato l’amore come premessa di un progetto di controllo delle donne, ridotte a proprietà del coniuge, mentre la politica continua a decidere sulla vita di uomini e donne. E tuttavia, scrive Stefano Rodotà nel suo ultimo libro Diritto d’amore (Laterza, pp.151, euro 14), l’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica.
Proprietà, credito e obbedienza: questa è la triade usata dal «terribile diritto», il diritto privato, per assoggettare l’amore - e la vita delle persone - alla razionalità dello Stato e al dominio della legge. Rodotà conduce da sempre una critica instancabile a questo modello. Per lui il diritto d’amore, come tutti i diritti, non nasce dall’arbitrio soggettivo, né da un fondamento naturalistico, ma dal legame tra il diritto e la realizzazione di un progetto di vita. Il diritto è legittimato dalle persone che decidono di riconoscerlo e lo usano per affermare l’autonomia e la libertà di tutti, non solo la propria.
Ciò non toglie che il diritto e l’amore, il desiderio di unirsi a un’altra persona, indipendentemente dal suo sesso, mantengano una distanza irriducibile. Quasi mai, infatti, il diritto è un complice della vita. Anzi, esiste per disciplinare gli affetti e per creare il modello del cittadino laborioso, maschio, proprietario. L’amore, invece, non sopporta regole o norme. Preferisce crearle da sé, nell’esperienza delle relazioni, seguendo un divenire che difficilmente può essere contenuto in un’unica disciplina valida per tutti. Per questa ragione il diritto ha preferito confinare «l’amore senza legge in uno stato di eccezione», come ha scritto un grande giurista francese, Jean Carbonnier.
L’autonomia irrinunciabile
In questo stato di eccezione prevale l’originaria ispirazione del diritto privato - cioè la riduzione della passione a cosa e della persona a proprietà di qualcuno. Orientamenti presenti ancora oggi in alcune sentenza della Corte Costituzionali o in fatali decisioni come quella sulla legge 40 sulla fecondazione assistita approvata dal governo Berlusconi.
A tutela dell’autonomia e della libertà delle persone, Rodotà usa la Costituzione e dai suoi articoli fondamentali traccia un uso alternativo del diritto che distrugge i valori di cui la stessa carta fondamentale è espressione. A questo punto è quasi inevitabile per il giurista raccontare la storia dei movimenti che hanno fatto esplodere il perimetro formalizzato dei poteri e della legge nel secondo Dopoguerra. Prima il movimento femminista, oggi i movimenti Lgbtq a cui Rodotà dedica un intero capitolo. Il diritto di amare è diventato una questione politica di rilievo perché alimenta la ricerca dell’autonomia delle persone. Il conflitto è emerso, fortissimo, sulle unioni civili come, di recente, hanno dimostrato i movimenti Lgbtq che hanno organizzato una «marcia dei diritti» per criticare l’insufficienza, addirittura le potenziali discriminazioni presenti nel disegno di legge Cirinnà che il governo intende approvare.
Storia di un incontro
In questa partita rientra anche il conflitto sull’educazione alle differenze nelle scuole: da una parte, c’è un movimento vasto che sostiene la laicità dell’istruzione pubblica e la critica dei ruoli sessuali per tutelare la libertà dei bambini e degli insegnanti. Dall’altra parte, c’è una reazione furibonda che attraverso il meme dell’«ideologia del gender» - una narrazione tossica strumentale e infondata - ha saldato un ampio movimento conservatore con le istanze più reazionarie del cattolicesimo e mira a colpire la laicità dell’istruzione e la libertà nelle scelte d’amore.
Come accade nei suoi libri, Rodotà unisce la storia dei movimenti a quelle della Costituzione italiana e della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea alla quale ha contribuito. L’incontro con i movimenti serve al diritto per «conoscere se stesso, il proprio limite, l’illegittimità di ogni sua pretesa di impadronirsi della vita - scrive Rodotà -. Emerge così uno spazio di non diritto nel quale il diritto non può entrare e di cui deve farsi tutore, non con un ruolo paternalistico, ma con distanza e rispetto». Dal punto di vista dei movimenti, il diritto serve a riconoscere e a coltivare una tensione nel darsi regole che possono cambiare, seguendo una geometria delle passioni interna alle relazioni tra il soggetto e la sua vita.
In questo quadro è fondamentale il ruolo delle minoranze: il movimento omosessuale, insieme a quello femminista, quello Lgbtq, interpretano lo stesso modo di fare politica: per vincere i movimenti si coalizzano con altri soggetti attivi nella società al fine di ottenere un riconoscimento sociale e istituzionale. Le conquiste sulle libertà personali sono valide per tutti, come hanno dimostrato l’aborto e il divorzio. Il diritto d’amore si inserisce in questa nobile vicenda e risponde a un’esigenza che ha dato il titolo a un altro, notevole, libro di Rodotà: il diritto ad avere diritti.
Tensioni singolari
Auspicio, affermazione performativa, atto di cittadinanza: il diritto ad avere diritti è una formula che caratterizza l’azione coordinata delle minoranze e afferma i diritti universali di tutti: il welfare state, l’ambiente, i beni comuni, per esempio. L’universalismo singolare dei diritti si pratica sottraendosi dall’identità maggioritaria fissata per legge (Deleuze la definiva «divenire minoritario») e, allo stesso tempo, nella creazione di un diritto all’esistenza che sfugge ai principi della morale dominante e agli assetti del potere organizzato dal diritto. Questa duplice azione rivela l’esistenza di uno spazio rivoluzionario. Rodotà lavora alla sua riapertura, in un momento non certo felice di arretramento generale.
Diritto d’amore è infine un libro che va letto insieme a quello dedicato da Rodotà alla solidarietà. Da tempo il giurista è impegnato in una ricostruzione genealogica delle passioni e delle pratiche volte alla costituzione di una soggettività caratterizzata da un rapporto di reciprocità, irriducibile al narcisismo o alla naturalizzazione dei ruoli. Parla di uguaglianza e ne rintraccia la storia nelle pratiche della solidarietà e nella dignità della persona. In questa fittissima tessitura, l’amore è un «rapporto sociale», mentre la sua tensione singolare «a bassa istituzionalizzazione» spinge a creare mondi nuovi. Questa può essere considerata una risposta all’invocazione di Auden: «La verità, vi prego, sull’amore».
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- Tutti gli dèi nascosti dietro al dio chiamato Gesù (di Silvia Ronchey).6 gennaio 2016, di Federico La Sala
Riti di Mitra, misteri dionisiaci, saturnali e la “vera” Epifania.
Ritorna “Jesus Rex”, il capolavoro di Robert Graves
Tutti gli dèi nascosti dietro al dio chiamato Gesù
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 06.01.2016)
Nel 1614 Keplero, dopo laboriosi calcoli, dimostrò che nel 7 a.C., quando dovette grossomodo avere luogo la nascita di Gesù (che il calendario etiopico colloca nell’8 a.C. e che comunque non poté precedere il 5 a.c., anno di morte di Erode), Giove e Saturno ebbero tre congiunzioni ravvicinate nella costellazione del Pesce, un evento raro che avviene ogni svariate centinaia di anni e che era stato tuttavia già, previsto, si dice, dagli astronomi caldei. Una di queste congiunzioni fu nel mese di dicembre.
Non che l’evento in sé spieghi la “stella grandissima”, che secondo i testi sacri - Matteo 2, 1-12, ma soprattutto gli apocrifi - sarebbe apparsa in quel tempo e avrebbe segnalato ai Magi la nascita di “un re per Israele”; o giustifichi un aumento della luminosità tale da oscurare le altre stelle, come scritto nel Protoevangelo di Giacomo. Né risulta compatibile con la cronologia della nascita di Gesù la visibilità della cometa di Halley, il cui passaggio si ascrive al 12 a.C. Ma la relazione tra il formarsi del calendario liturgico protocristiano e gli eventi astronomici che già sostanziavano i riti delle più antiche religioni, zoroastriana anzitutto e poi romana, è indubitabile.
La festività che nel mondo cristiano ortodosso è detta “delle Luci” ( ton Photon) accomuna in un breve giro di calendario il pellegrinaggio escatologico dell’élite pagana d’oriente e la festa solare chiamata nell’antica Roma dies natalis Solis Invicti, e ancora oggi da noi Natale; a sua volta legata sia ai Saturnali, sia alla festa di Mitra, il cui culto misterico prettamente maschile, originariamente indopersiano, romanizzato nella pratica rituale degli eserciti, era in grande espansione nel periodo in cui nacque la fortunata eresia giudaica che le scritture canoniche ed extracanoniche associano alla nascita di un “nuovo re di Israele” proprio in occasione dell’evento che qui festeggiamo il 6 gennaio e chiamiamo Epifania.
Nome a sua volta desunto dalla terminologia dei misteri greci. È l’epiphàneia di un dio, la sua sacra manifestazione, al centro della leggenda della stella e dei Magi. I tre maghi persiani dal cappello a cono del mosaico di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, i Drei Könige sulle cui magnetiche reliquie si impennò la cattedrale di Colonia,i tre savii stranieri dai nomi incerti e contorti che seguirono la stella ed ebbero l’epifania di un fanciullo divino, si prostrarono, scrive Matteo, con la rituale proskynesis che si riconosce al capo di un’altra e nuova religione, recandogli il crisma dei sommi doni sapienziali.
«I misteri religiosi sono in gran parte connessi con le predizioni astronomiche», scrive con apparente candore Robert Graves all’inizio della terza e culminante parte di Io, Gesù, il capolavoro (ora ripubblicato da Longanesi, e all’epoca intitolato Jesus Rex) che settant’anni fa dedicò al formarsi del culto di quelli che chiama i crestiani - i seguaci del Chrestòs, in greco “il Buono” - nell’epoca che va appunto dalla teofania occorsa ai Magi a quello che definisce «lo scisma dei gentili, capeggiato dal visionario Paolo di Tarso. Un culto che sancisce - è la grande teoria di Graves, che fa qui la sua prima comparsa - la vittoria delle religioni dominate da divinità maschili, di cui JHWH, il dio onnipotente del monoteismo biblico, è l’esempio massimo, sulla religione femminile originaria, quella della Grande Dea, cui Graves dedicherà due anni dopo il suo libro più noto, La dea bianca.
 L’eclissi della divinità lunare e l’oblio del suo culto porteranno a fraintendere l’identità storica di Gesù, che nella ricostruzione di Graves, fantastorica, deliberatamente fantasmagorica ma non per questo meno scientificamente probante, riunisce in sé, per discendenza matrilineare, un’effettiva e clamorosa regalità.
L’eclissi della divinità lunare e l’oblio del suo culto porteranno a fraintendere l’identità storica di Gesù, che nella ricostruzione di Graves, fantastorica, deliberatamente fantasmagorica ma non per questo meno scientificamente probante, riunisce in sé, per discendenza matrilineare, un’effettiva e clamorosa regalità.
 La legittima successione del trono di Davide, ossia dell’antica Israele, e di Erode, ossia della Giudea romana, gli è assicurata da Maria, vergine di sangue regale consacrata al Tempio, che ha però segretamente sposato uno dei figli di Erode, avuto dalla prima moglie, di altrettanto impeccabile discendenza idumonea.
La legittima successione del trono di Davide, ossia dell’antica Israele, e di Erode, ossia della Giudea romana, gli è assicurata da Maria, vergine di sangue regale consacrata al Tempio, che ha però segretamente sposato uno dei figli di Erode, avuto dalla prima moglie, di altrettanto impeccabile discendenza idumonea.
 È alla luce dell’effettivo status di aspirante Rex Iudaeorum che Graves interpreta, nel finale del libro, l’udienza personale concessa da Pilato a Gesù, il suo straordinario favore, l’inusuale titulus, INRI, apposto per suo ordine alla croce; così come il successivo, irrazionale e imprevedibile svolgersi del fatti, la catena di fraintendimenti, censure, tendenziosità che plasmeranno, in un sincretismo assoluto e a tratti costernante, la nuova religione maschile destinata a pervadere i confini dell’impero romano, dal medio oriente giudaico all’estremo occidente celtico, di quella gelosa idea di elezione e linearità, legata a un’inquietante promessa di “al di là”, che si sostituirà alla preesistente idea femminile di ciclicità della storia come della natura del cosmo.
È alla luce dell’effettivo status di aspirante Rex Iudaeorum che Graves interpreta, nel finale del libro, l’udienza personale concessa da Pilato a Gesù, il suo straordinario favore, l’inusuale titulus, INRI, apposto per suo ordine alla croce; così come il successivo, irrazionale e imprevedibile svolgersi del fatti, la catena di fraintendimenti, censure, tendenziosità che plasmeranno, in un sincretismo assoluto e a tratti costernante, la nuova religione maschile destinata a pervadere i confini dell’impero romano, dal medio oriente giudaico all’estremo occidente celtico, di quella gelosa idea di elezione e linearità, legata a un’inquietante promessa di “al di là”, che si sostituirà alla preesistente idea femminile di ciclicità della storia come della natura del cosmo.Al bene informato Agabo, alter ego narrante di Graves nell’ipotetico anno Domini 93 d.C. cui la narrazione è ascritta, il nuovo culto si presenta dominato da un rito conosciuto col nome di eucarestia [eu-charis-tia, fls] e adibito «a comodo ponte tra il giudaismo e i culti misterici greci e siriani, in cui il sacro corpo di Tammuz viene mangiato sacramentalmente e sacramentalmente bevuto il sacro sangue di Dioniso», il dio “Figlio della Duplice Porta”, nato prima a sua madre Semele e poi al padre Zeus, cui Gesù somiglia anche nell’avere due date astronomiche di nascita: a quella del solstizio d’inverno, che coincide con la nascita del sole, si aggiunge quella estiva cui si riconduce il suo battesimo - rappresentato con matematica perfezione neoplatonica da Piero della Francesca - che coincide con la levata eliaca di Sirio, la stella messianica del versetto di Isaia.
In Io, Gesù Graves, superbo esperto di mitografia greca ed ebraica, dipana il sincretismo fin dalla Natività. Se la Vergine Madre dalla veste azzurra e dalla corona di stelle d’argento è necessaria ipòstasi di Iside, nella grotta la mangiatoia dov’è adagiato il Bambino ripropone quella usata allo stesso scopo nei misteri delfici ed elusini e il bue e l’asino, cui già allude Isaia, simboleggiano i due messia promessi, il figlio di Giuseppe e il figlio di Davide, che il neonato adorato dai Magi riunisce. La sua storia ha tratti in comune con quella di Pèrseo, che il re Acrisio tenta di uccidere in fasce.
Nella narrazione di Graves, ironicamente accademica, irresistibilmente sacrilega, implacabilmente laica, i Magi non sono nulla di ciò che per due millenni l’esegesi dei teologi cristiani o degli storici delle religioni o tanto meno degli esoteristi e teosofi in voga in quegli anni ha abilmente e spesso fondatamente congetturato, ma solo tre ebrei damasceni della tribù di Issachar, che nel palazzo di Erode a Gerico si presentano come astrologi appartenenti alla nuova setta degli “alleanzisti”: hanno stipulato una nuova alleanza con Dio attraverso la mediazione di uno spirito chiamato “Colui che viene” ovvero “la Stella”, che secondo la loro previsione si incarnerà quanto prima sotto spoglie umane e darà a Erode gloria eterna. Ma Erode stesso ha basato la sua politica e il suo regno sulla congiunzione astrale di Giove e Saturno individuata da Keplero nel 1614.
Dal fallimento del piano dinastico di Erode, che in Graves si snoda in sostanziale aderenza a Matteo, ascende l’astro del nuovo re che i tre astrologi giudei hanno correttamente individuato e adorato, ma che non sarà scorto in vera luce dai gentili. I suoi Atti e detti, originariamente scritti in aramaico, riceveranno, riferisce il beffardo Agabo, versioni multiple di una traduzione greca «erronea, a volte goffa e di tanto in tanto fraudolenta », cosicché i fondatori delle chiese gentili fraintenderanno «così stranamente la sua missione da fare di lui la figura centrale di un nuovo culto che, se lui oggi fosse vivo, giudicherebbe solo con avversione e orrore». Lo vedranno come un giudeo rinnegato che «unendo la propria sorte a quella degli gnostici greci aspirò a una sorta di divinità apollinea, per di più fornendo credenziali che devono essere accettate per cieca fede - suppongo perché nessuna persona ragionevole», aggiunge Agabo, «potrebbe mai accettarle in alcun altro modo».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- LE ISOLE TOBRIAND E LA SCOPERTA DI MALINOWSKI. Il dono alla base dell’economia (di Marino Niola)17 dicembre 2015, di Federico La Sala
Cent’anni fa l’antropologo Malinowski scoprì una società aborigena fondata sulla generositàQuando il dono diventò la base dell’economia
di Marino Niola (la Repubblica, 17.12.2015)
- L’ANTROPOLOGO Bronislaw Malinowski (1884- 1942) pubblicò il saggio Le isole Trobriand nel 1915 e nel 1922
 La pubblicazione dello studio del 1915 ispirò le teorie contemporanee dell’antiutilitarismo
La pubblicazione dello studio del 1915 ispirò le teorie contemporanee dell’antiutilitarismo
 Per i trobriandesi ogni passaggio di mano in mano caricava il regalo fatto di prestigio
Per i trobriandesi ogni passaggio di mano in mano caricava il regalo fatto di prestigio
Chi fa regali alla fine ci guadagna sempre. E non solo in gratitudine. Perché il dono è un investimento sul futuro. Un contratto a lungo termine. E a insegnarcelo non è stato nessun guru dell’economia ma gli aborigeni delle isole Trobriand, che del dare a piene mani hanno fatto un’arte della convivenza, nonché la base della loro dottrina politica. Anticipando, e di fatto ispirando, le teorie contemporanee del convivialismo e dell’antiutilitarismo.
A scoprire i segreti di questa economia della generosità è stato, giusto un secolo fa, Bronislaw Malinowski, il celebre antropologo polacco, professore alla London School of Economics. Che, per uno scherzo del destino, si trovava in Australia per studiare gli aborigeni, quando scoppiò la prima guerra mondiale. Come suddito dell’impero austroungarico, e quindi cittadino di un paese nemico, gli sarebbe toccato l’internamento in un campo. Ma il giovane Bronislaw riuscì a convincere le autorità australiane a confinarlo nell’arcipelago delle Trobriand, oggi isole Kiriwina, dal quale non c’era pericolo che fuggisse. Ma in compenso avrebbe potuto continuare le sue ricerche sugli usi e costumi delle tribù di questi atolli corallini che si trovano nel Pacifico occidentale, tra la Nuova Guinea e le isole Salomone.
Il 1915 fu un annus horribilis per l’Europa, ma per l’antropologia fu un anno fortunato. Perché appena mise piede su quelle spiagge, dove il vento mormora tra le palme, Malinowski fu subito colpito da un’usanza che ai suoi occhi di occidentale nutrito di economia politica, sembrava priva di qualsiasi logica.
Gli indigeni affrontavano traversate oceaniche lunghissime e piene di pericoli a bordo delle loro piroghe per portare doni agli abitanti di isole lontane. Una generosità incomprensibile e un coraggio ai limiti dell’incoscienza, visto che a viaggiare su quelle acque tempestose e infestate di squali era una bigiotteria senza valore. Collane e braccialetti di conchiglia. Cose futili e non beni necessari.
E, come se non bastasse, questi monili da poveri venivano regolarmente rigirati da coloro che li avevano ricevuti agli abitanti dell’isola più vicina. Che a loro volta li indossavano un po’ di tempo per farsi belli e poi prendevano il mare per andare a farne omaggio agli abitanti di altre terre. Creando così un circuito di scambi che chiamavano kula. Apparentemente un circolo vizioso per cui il cadeau, prima o poi, finiva per tornare nelle mani del primo proprietario. Un po’ come certi regali, riciclati di Natale in Natale, che alla fine tornano al mittente come un boomerang.
Ma per i Trobriandesi questa sorta di sbolognamento sistematico era un valore aggiunto. Perché ogni passaggio di mano in mano caricava il dono di prestigio. Per dirla con parole nostre, ne impreziosiva il pedigree. Che stava in buona parte in un plusvalore relazionale. Come certi diamanti leggendari di cui si sciorina sistematicamente la cronologia di coloro che li hanno posseduti.
Il caso trobriandese, raccontato da Malinowski nel suo capolavoro Gli argonauti del Pacifico occidentale, divenne subito un rompicapo per gli economisti che non riuscivano a trovare senso in un comportamento tanto irrazionale. Così alla fine molti esponenti di questa scienza che noi moderni ci ostiniamo a ritenere esatta - e che i Greci, con maggior prudenza, definivano semplicemente “governo della casa” (da oikos abitazione e nomia regola) - conclusero che si trattava di un’assurdità. Un comportamento da tribù primitiva, economicamente immatura che, incapace di calcolare costi e benefici, sprecava il tempo a fare regali, per di più senza guadagnarci nulla.
Ma l’imperturbabile polacco non fece una piega e restituì colpo su colpo, sbattendo in faccia agli scettici la soluzione del rebus, l’algoritmo segreto che governava quella strana giostra di regali e regalini. In realtà la ragione di quella fatica, apparentemente inutile, non stava nel valore d’uso degli oggetti, bensì nel loro valore di scambio. Che si fondava soprattutto sulle alleanze e partnership prodotte da quel circuito di reciprocità.
Il dono insomma funzionava come un contratto sociale, facendo di tante popolazioni straniere, lontane e potenzialmente nemiche, un vero e proprio sistema. Ordinato e coordinato. Una federazione che metteva in moto una rete di relazioni sovralocale. Dalla quale non si usciva mai. Infatti i Trobriandesi dicevano con orgoglio che «l’appartenenza al kula è per sempre».
Questa sorta di mercato globale primitivo era insomma capace di connettere genti e paesi separati da migliaia chilometri di mare, a dispetto dei loro fragili mezzi. Basti pensare che nelle capanne dei cacciatori di teste della Nuova Guinea indonesiana e delle isole Molucche sono state trovate preziose porcellane cinesi d’epoca Ming. Insomma lo scambio di doni era una pensata geniale per fare uscire quelle isole dal loro isolamento e farne un solo grande arcipelago.
Il che in fondo vale anche per noi, utilitaristi disincantati, quelli che “nessuno ti regala niente per niente”. E si vede chiaramente in momenti come il Natale. Con la sua girandola di doni e controdoni, che non a caso gli americani chiamano big swap, il grande scambio. Un circuito cerimoniale che tiene in equilibrio reciprocità e gratuità, generosità e socialità, obbligo e piacere. Col risultato di riaffermare il principio dell’utile, ma proiettandolo su un piano più generale, e soprattutto meno egocentrico. Perché quel che regaliamo oggi ci verrà restituito in qualche modo con gli interessi. E non necessariamente da chi ha ricevuto.
Come dire che il dono è la forma più sottilmente disinteressata del profitto, perché è l’origine stessa del legame sociale, il gesto primario, incondizionato e gratuito che fa uscire l’individuo da se stesso e lo lega agli altri in una rete che assicura scambio protezione, solidarietà. E di conseguenza anche guadagno. Non è un caso che le religioni nascano tutte da un dono fatto al dio. E che il dio ricambia. Ecco perché, perfino il nostro Natale consumistico, continua ad essere animato da quell’energia collettiva messa in moto dallo spirito del dono. Che anche se per pochi giorni all’anno, fa di quelle isole che noi siamo un solo arcipelago.
- L’ANTROPOLOGO Bronislaw Malinowski (1884- 1942) pubblicò il saggio Le isole Trobriand nel 1915 e nel 1922
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- LA TRILOGIA "New Weird" DI JEFF VAN DER MEER. Ci vuole un teologo per capire l’Area X (di Alessandro Zaccuri)16 dicembre 2015, di Federico La Sala
CI VUOLE UN FILOLOGO E UNO PSICOANALISTA, PER CAPIRE L’AREA X (L’EU-ROPA E L’EV-ANGELO):
LetteraturaCi vuole un teologo per capire l’Area X
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, 16 dicembre 2015)
Quelli della Brigata di Scienza e Spiritismo girano sempre in coppia, ma il fatto strano è che, tra i due, la più incline alla superstizione è la scienziata. Non che l’altro, lo studioso dell’inspiegabile, abbia le idee molto più chiare, tant’è vero che a un certo punto Saul, il guardiano del faro attorno al quale si svolgono le indagini, avrebbe voglia di spiegargli che credere in Dio non significa necessariamente credere nell’occulto. Saul se ne intende, perché prima di finire in quell’avamposto marino nel Sud degli Stati Uniti è stato un predicatore in una qualche congregazione evangelica, nella parte settentrionale del Paese.
Bisogna masticare un po’ di teologia e, più che altro, avere una certa dimestichezza con la Scrittura per orientarsi nei meandri dell’Area X, il luogo/non luogo - organismo senziente, semmai, o distopia cosmica, se non insidiosa creazione di un demiurgo in vena di ironia - che sta all’origine della trilogia dello scrittore americano Jeff Van der Meer tradotta da Cristiana Mennella per Einaudi. Tre romanzi concatenati fra loro, dunque, e tre titoli che anche nell’originale iniziano tutti con la lettera “a”: Annientamento (pagine 186, euro 16,00), Autorità (pagine 286, euro 17,00) e Accettazione (pagine 282, euro 17,00). Sono, a ben vedere, le tappe di un percorso mistico, che i principali personaggi dell’intricata vicenda affrontano da prospettive e con esiti differenti. Ammesso e non concesso che laggiù, nell’Area X, un concetto come “differente” abbia ancora diritto di cittadinanza.
Che cos’è, un’altra saga di fantascienza? Sì e no. Van der Meer, classe 1968, è considerato il capostipite di un genere finora mai documentato, proprio come la flora e la fauna nella quale ci si imbatte esplorando il suo mondo immaginario. È il teorico del New Weird, espressione non semplicissima da riproporre in italiano: weird sta per “strano”, ma anche “inquietante”, “perturbante”. Per farsi intendere il “New York Times” ha suggerito un incrocio fra le mostruose fantasie di H.P. Lovecraft e il naturalismo militante proclamato da Henry David Thoreau nel celeberrimo Walden, o la vita nei boschi.
A noi europei, invece, l’idea di un territorio soggetto a una mutazione inspiegabile, di probabile origine extraterrestre e con terribili conseguenze per i terrestri, non può non ricordare uno dei capolavori cinematografici di Andrej Tarkovskij, Stalker (1979), ispirato al romanzo Picnic sul ciglio della strada dei fratelli Arkadi e Boris Strugatzki (in Italia è edito da Marcos y Marcos). Allo stesso modo, la presenza di una glottologa all’interno della Southern Reach - l’ineffabile agenzia governativa che studia e sorveglia l’Area X - sembra rimandare alla figura del filologo Elwin Ransom, protagonista della “trilogia spaziale” pubblicata tra il 1938 e il 1945 da C.S. Lewis, lo scrittore inglese amico di Tolkien e autore anche delle Cronache di Narnia.
Il mistero dei misteri da cui tutto nell’Area X sembra dipendere è insieme biologico, linguistico e biblico. Si tratta di una lunga scritta che appare sulle pareti, o membrane, di una caverna, o tunnel, o torre capovolta che di volta in volta appare e scompare dalle mappe della zona. Non diversamente dal sermone del killer Jules in Pulp Fiction di Quentin Tarantino (1994), l’iscrizione non rimanda a una citazione riconoscibile, è semmai un centone di brani scritturistici più o meno orecchiati, più o meno vaticinanti e minacciosi. Il testo comincia così: «Dove giace il frutto soffocante che giunse dalla mano del peccatore io partorirò i semi dei morti per dividerli con i vermi che si raccolgono nelle tenebre e circondano il mondo col potere delle loro vite» e sembra proseguire all’infinito, vergato da una creatura pressoché irriconoscibile, alla quale viene riservato l’appellativo di Scriba.
Analisi di laboratorio e testimonianze registrate da una parte, rituali e superstizioni dall’altra: l’Area X è un posto nel quale il principio di non contraddizione risulta sospeso. È una conseguenza della visione complessiva che sostiene la trilogia, quella di un immanentismo delirante per cui la nozione di Deus sive natura finisce per produrre esiti aberranti e distruttivi. Piovuta da chissà dove (anzi, situata chissà dove), l’Area X assimila tutto e tutti a sé, senza mai rinunciare all’astuzia di mimare l’ambiente di cui si sta impossessando. L’epicentro del processo è rappresentato dal faro in cui Saul - nome biblico, e anche questo non è un caso - ha trovato rifugio. Van der Meer, peraltro, è abbastanza abile da non chiarire se la dimestichezza del personaggio con i temi e le parole del sacro sia un aspetto accidentale e non piuttosto l’elemento catalizzante della mutazione.
Resta il fatto che, una volta di più, un’ambiziosa invenzione narrativa nostra contemporanea si colloca nell’orizzonte di un’immaginazione teologica decisamente eterodossa, ma non per questo meno indispensabile per concepire e abitare un universo di finzione nel quale, però, la realtà si rispecchia. Capita nell’Area X come nei romanzi di Stephen King (che di Van der Meer è ammiratore dichiarato), capita nella galassia di Star Wars e nell’isola della serie tv Lost come nelle avventure del giovane mago Harry Potter. A proposito: il debutto cinematografico di Annientamento, primo film tratto dalla trilogia, è previsto per il 2017, con un cast del quale dovrebbe far parte anche Natalie Portman. Nel frattempo gli appassionati possono fare un salto sul sito della Southern Reach (join.thesouthernreach.com) e controllare se per caso si sta ancora cercando personale per scandagliare l’Area X.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. --- L’antropologia culturale e il sogno dell’universalità umana concreta (di Franco Toscani)1 dicembre 2015, di Federico La Sala
L’antropologia culturale e il sogno dell’universalità umana concreta
di Franco Toscani
La storia del mondo sta attraversando un periodo denso di violenza, terrorismo, guerre e venti di guerra, conflittualità e veleni d’ogni tipo, disorientamento, confusione, diffidenza. Una delle questioni che sempre di nuovo si ripropone è quella del male, della sua ostinazione e persistenza, banalità e stupidità, crudeltà e tragicità.
Da molti secoli la filosofia e la teologia si sono interrogate e continuano a interrogarsi sulla questione del male, senza poter giungere a conclusioni certe e definitive. Il male resta per noi un grande enigma, possiamo esser certi soltanto della sua tenace presenza nella storia e nel mondo umano, delle sue varie forme, della sua diffusione e delle continue, incessanti difficoltà che incontra la necessaria, sacrosanta, sempre rinnovata lotta contro di esso.
Ha perciò ragione Liliana Segre (deportata quattordicenne nel 1944 e tra i 25 sopravvissuti dei 776 bambini di età inferiore ai 14 anni deportati nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau) quando, in una recente intervista sugli attentati terroristici parigini del 13 novembre ("Corriere della Sera", 16 novembre 2015, a cura di Paolo Conti), invita gli adulti, in particolare i genitori e gli insegnanti ad avere il coraggio di "non girare la faccia dall’altra parte", di dire la verità ai nostri ragazzi, di spiegare che cosa è realmente accaduto a Parigi, cercando di non "ripararli" troppo dal dolore, dal pericolo e raccomandando pure di non odiare mai, perché l’odio genera sempre altro odio.
Le nuove generazioni, infatti, sono state sin troppo "protette" da quel male e quel dolore che invece fanno sempre parte della vita reale di ciascuno di noi e che, se vengono ignorati, sottovalutati e non riconosciuti in tutto il loro spessore, rischiano di annichilire e distruggere le personalità più fragili o comunque di renderci incapaci di affrontare la vita in tutti i suoi aspetti e dimensioni. L’eccesso di protezione e le troppo facili "caramelle di consolazione" non aiutano a vivere, a crescere e ad assumersi responsabilità. Occorre cercare sempre di fare i conti - anche se non è facile come dirlo - col male e col dolore che sono presenti non solo negli altri e nel mondo, ma anche in noi, in ciascuno di noi.
Solo così, con lucidità e coscienza, possiamo andare avanti, affrontare la vita con coraggio e responsabilità, partendo sempre da noi stessi, dalle situazioni concrete, cominciando quindi a vivere quotidianamente nelle nostre aule scolastiche e universitarie, in tutti i luoghi di lavoro e di vita rapporti umani caratterizzati dal rispetto, dall’attenzione, dall’ascolto reciproco, dal dialogo, dall’ospitalità culturale fra diversi. Solo così, trovando la vera forza in noi e negli altri, nel meglio di noi stessi, possiamo uscire dal tunnel della paura e del terrore, dall’isolamento nelle nostre case, tornare ad aprirci al mondo e vivere più pienamente il mondo.
Per vivere meglio, occorre fra l’altro che riscopriamo e rimeditiamo gli insegnamenti dell’antropologia culturale, che si studia o, dati i tempi che corrono, si dovrebbe studiare nelle nostre scuole. Per Bronislaw Malinowski, l’antropologia, in virtù dell’attenzione posta sulle differenze culturali e sulla comparazione tra culture, ci ispira il senso delle prospettive e delle proporzioni, un più fine umorismo e consente una conoscenza globale dell’umanità.
Dopo aver studiato le altre culture e civiltà, l’antropologo ritorna alla propria con una nuova prospettiva, più ampia e lucida. La presa di coscienza dei diversi modi di vivere dell’umanità, dell’irriducibile ricchezza delle civiltà e culture umane getta una nuova luce anche sulla nostra civiltà e cultura. Diveniamo capaci di spirito critico e autocritico, di distanza critica dalla nostra stessa cultura, contribuendo così a rifondarla e a rinnovarla efficacemente.
I Nambikwara del Mato Grosso, in Brasile, su cui riflette Claude Lévi-Strauss in Tristes Tropiques (Tristi Tropici, 1955) sono molto poveri e indifesi, ma la loro gentilezza e tenerezza risultano per noi commoventi, oltre che evidente la ricchezza della loro umanità. L’antropologia culturale ci libera dai pregiudizi dell’etnocentrismo, consistente nella tendenza a considerare superiori le regole e i valori del proprio gruppo di appartenenza rispetto a tutti gli altri gruppi; l’etnocentrismo è un vero e proprio cancro, che in tutti i tempi e in tutte le latitudini ha seminato violenza, odio, disprezzo, guerre, paura.
Secondo Lévi-Strauss, i veri barbari sono coloro che credono nella barbarie e l’attribuiscono agli altri. Per questa mentalità, mentre "noi" siamo i soli veri esseri umani, gli "altri" sono sottouomini, barbari, selvaggi, primitivi, esseri inferiori.
Già Michel de Montaigne (si veda il saggio Des Cannibales, negli Essais) aveva compreso nel XVI secolo, con straordinaria lucidità e preveggenza, che "ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi; sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo".
La cultura occidentale ha cominciato da tempo a fare i conti con il colonialismo, l’eurocentrismo e l’imperialismo che l’hanno a lungo caratterizzata. Questi conti non sono ancora terminati, ma abbiamo iniziato a capire che l’uomo occidentale può comprendere meglio sé stesso soltanto se dismette l’attitudine e lo sguardo del dominio, se l’altro non viene più considerato e ridotto a oggetto, se lo sfruttamento, l’asservimento e l’oppressione non sono più il suo orizzonte.
Da questo punto di vista l’antropologia può davvero essere intesa come figlia del rimorso dell’uomo bianco, europeo, occidentale e come una via di riscatto e di espiazione dalle colpe del colonialismo e dell’imperialismo.
Vi è un universalismo falso, che nasconde e ricopre i propri interessi particolaristici col richiamo ai valori universali dell’uomo. Lo studio dell’antropologia culturale può consentirci la riconciliazione dell’uomo con la natura e dell’uomo con l’uomo, c’insegna che l’umanità intera è composta da tutti i suoi esempi particolari e non può prescindere da essi, che davvero nulla di umano può essere estraneo all’uomo. E’ il senso di una universalità umana concreta, non astratta, spiritualistica o retorica, ma frutto del riconoscimento, della valorizzazione e della ricchezza delle differenze.
Tale universalità concreta cerca di salvaguardare insieme i valori della diversità, della pluralità e dell’eguaglianza, dell’equità, della dignità di tutti gli esseri umani. Essa consente di muoverci nella direzione di una nuova civiltà planetaria, di una nuova cultura, etica e politica dell’uomo planetario, secondo la felice intuizione di Ernesto Balducci.
Ora, però, proprio questa possibile universalità umana concreta (diciamo possibile, perché non si dà nella forma odierna della cosiddetta globalizzazione, anzi appare ancora come un sogno) viene seriamente minacciata e compromessa nella difficile e delicata situazione mondiale del presente.
Per noi si tratta non solo di reagire e di lottare contro il terrorismo, ma anche di contrastare qualsivoglia tipo di fondamentalismo, integralismo, fanatismo politico, ideologico e religioso. Qui le risposte in termini meramente militari o di repressione non bastano. Occorre sì lottare in termini netti e duri contro il terrorismo islamico e il "Califfato del terrore", ma occorre fare pure molta attenzione a non criminalizzare l’intero Islam, come invece tendono a fare i fondamentalisti dell’occidentalismo, gli intolleranti e razzisti di casa nostra. Non possiamo dimenticare, ad esempio, che le sūre del Corano si aprono con l’invocazione al Dio clemente e compassionevole oppure quanto leggiamo nel Corano (sūra 5, 28): "se stenderai la mano contro di me per uccidermi, io non stenderò la mano su di te per ucciderti, perché ho paura di Dio, il Signore dei mondi".
Sappiamo bene che del Corano, come di tutti i testi sacri, si possono fare diverse letture e che vi è pure l’interpretazione dei fanatici, degli intolleranti, dei violenti. Pure noi occidentali ne sappiamo qualcosa, perché anche in nome del Dio cristiano e della Croce si sono compiuti nel corso dei secoli innumerevoli e ben noti misfatti, le Crociate, guerre spaventose, si sono arsi vivi gli "eretici" e le "streghe", si è sparso a piene mani sangue innocente, etc. . Molti sono anche i nostri peccati e scheletri nell’armadio.
Nel proporre la propria identità, tutte le religioni - nessuna esclusa - sono poste davanti a un bivio, a un aut-aut: o alimentare una cultura (e un’etica) della pace, della convivenza, della solidarietà, dell’amore e del dialogo oppure rafforzare lo spirito settario, erigere muri dottrinali, inseguire i propri fantasmi idolatrici, contrastare qualunque forma di contaminazione e di cooperazione.
Non possiamo più permetterci questa seconda strada, peraltro già ampiamente praticata in modo fallimentare. Senza ciò che Hans Küng ha chiamato Weltethos, ossia senza un’etica mondiale fondata sulla condivisione a livello planetario di un minimo comune denominatore di tipo etico, non vi sarà un futuro per il pianeta. Tutte le religioni possono dare un grande contributo in questa direzione, se e soltanto se torneranno a riconoscere come essenziale la legge dell’amore.
Noi oggi dobbiamo favorire in tutti i modi possibili coloro che, all’interno del mondo islamico, mirano alla convivenza, vogliono vivere nella pace, puntano a un’integrazione fruttuosa, non vogliono innalzare muri di odio e di disprezzo.
So che non è facile, ma è necessario provarci, se non vogliamo lasciare l’ultima parola agli intolleranti e ai violenti di tutte le risme.
So anche che nelle riviste di propaganda di Daesh, del "Califfato del terrore", di questi ignobili tagliagole che non si vergognano di richiamarsi al nome di Allāh, tutto ciò che proviene dai "miscredenti", dal mondo occidentale è soltanto fonte di peccato, corruzione e male; persino le nostre scuole sono soltanto, ai loro occhi, "scuole della perdizione", caratterizzate dalla tolleranza e dalla secolarizzazione, dall’ateismo e dal pluralismo religioso. Lo stato islamico insiste molto sulla carenza valoriale dell’Occidente, vuole conquistare anche le menti e i cuori delle persone che vivono tra i "miscredenti", propone un’alternativa complessiva di sistema.
A questo proposito è bene essere molto chiari sull’ambivalenza della cultura occidentale, che ritrova in sé stessa da un lato il consumismo, il neoliberismo, il trionfo del Dio-mercato, del capitale, della tecnica e delle merci, profonde diseguaglianze economico-sociali, la desertificazione del senso, il nichilismo dell’ultracapitalismo vincente e dall’altro i valori essenziali della democrazia e dei diritti umani, del dialogo e della libertà di espressione in tutte le sue forme, della dignità umana, del pluralismo.
Noi dovremmo ovviamente far leva su questi ultimi aspetti, ma vanno rimessi in questione un sistema che, in nome del primato del profitto economico, produce ingiustizia all’interno degli stessi paesi ricchi e la violenza di un mondo che si regge sullo squilibrio abissale di ricchezza e di potere fra Nord e Sud del pianeta. Questo è oggi il brodo di coltura del terrorismo, soprattutto per i giovani musulmani di seconda generazione, senza lavoro, riconoscimenti e opportunità, spesso stigmatizzati e privati della loro dignità.
Se non avvertiremo dolorosamente sulla pelle la mancanza di un’etica e di una cultura dell’uomo planetario, se non mediteremo sulla desertificazione del senso che riguarda anche noi occidentali, sulle molteplici, inedite forme dell’odierno nichilismo e della barbarie, sulla mancanza di progetti di futuro e di nuovi assetti di civiltà che ci assilla, la decadenza e il tramonto dell’Occidente saranno inevitabili.
Piacenza, 1 dicembre 2015
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- Se il concetto di umanità cambia tra Parigi e Beirut (di Donatella Di Cesare)17 novembre 2015, di Federico La Sala
Se il concetto di umanità cambia tra Parigi e Beirut
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, 17.11.2015)
«Un attacco all’umanità e ai nostri valori universali». Così Obama ha commentato l’attentato di Parigi. Ma le sue parole sono stata aspramente criticate in un articolo del New York Times molto cliccato nei social media. Non sono forse esseri umani quelli sterminati qualche giorno prima nella strage di Beirut? E che dire delle tante stragi che trovano spazio marginale nei media? Viene da pensare che ci siano ranghi diversi di umanità. Quel concetto, che prometteva di essere universale, sembra disgregarsi. I corpi mutilati, che un’impietosa telecamera ci mostra sul selciato di Beirut, o per le vie di una sconosciuta città della Siria, non ci inquietano come i feriti e i morti intravisti nel buio della notte di Parigi.
Per giustificarci potremmo dire che dove riconosciamo un volto, l’umanità ferita suscita in noi compassione e sdegno. In quelle strade di Parigi avremmo potuto trovarci anche noi; ci immaginiamo al posto dell’altro, vittima inerme. E l’immaginazione diventa la spinta per l’etica. Se invece l’umanità ci appare lontana, anonima, senza volto, il nostro sentire si inceppa. Diventiamo quasi analfabeti emotivi, mentre quelle persone scadono a nonpersone. Ecco perché è così importante il ruolo dei media.
Tuttavia dobbiamo ammettere che continuiamo a dividere l’umanità per ranghi (non sta forse qui la fonte del razzismo?) e che anche dove razionalmente riconduciamo gli essere umani a un concetto universale, riguardiamo l’«umanità» di quegli «estranei» come se fosse diversa dalla nostra, non dello stesso rango.
L’umanità, così spesso invocata nel discorso pubblico, si rivela un concetto troppo astratto, quasi vuoto, che richiede di essere ripensato. A partire dal volto di ciascuno.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA COMPETENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEL VATICANO E’ "PREISTORICA" E "MAMMONICA".20 settembre 2015, di Federico La Sala
 A SIGMUND FREUD, GLORIA ETERNA. L’ordine simbolico della madre con il figlio ( "mammasantissima" con il "padrino" e la sua "andragathia" ) non ha niente a che fare con il "Padre Nostro" di Gesù e dei padri e delle madri degli esseri umani: Amore ("Charitas").
A SIGMUND FREUD, GLORIA ETERNA. L’ordine simbolico della madre con il figlio ( "mammasantissima" con il "padrino" e la sua "andragathia" ) non ha niente a che fare con il "Padre Nostro" di Gesù e dei padri e delle madri degli esseri umani: Amore ("Charitas").
 LA COMPETENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEL VATICANO E’ "PREISTORICA" E "MAMMONICA". Il "romanzo familiare" edipico della chiesa e della cultura cattolico-romana è finito
LA COMPETENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEL VATICANO E’ "PREISTORICA" E "MAMMONICA". Il "romanzo familiare" edipico della chiesa e della cultura cattolico-romana è finito
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- La Chiesa del futuro. Intervista al priore di Bose, Enzo Bianchi (di Silvia Ronchey).11 settembre 2015, di Federico La Sala
Le sfide del cristianesimo, la minaccia dell’Is, il ruolo femminile e il pontificato di Francesco.
Intervista al priore di Bose che da oggi ospita il Convegno Ecumenico di spiritualità ortodossa dedicato a "Misericordia e perdono"
La Chiesa del futuro
Enzo Bianchi: "Critichiamo l’Islam, ma poi emarginiamo le donne".
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 9 settembre 2015)
«Il papa ha lanciato l’allarme già due anni fa, dopo la visita a Lampedusa. È rimasto inascoltato e credo che anche questo suo nuovo appello lo sarà. Il fastidio di un certo clero verrà magari dissimulato dall’ipocrisia religiosa, che è la più bieca e spaventosa di tutte». Siamo a Bose, alla vigilia dell’apertura dell’annuale convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, e il priore Enzo Bianchi commenta l’esortazione di Bergoglio ad accogliere nelle parrocchie i rifugiati del grande movimento di popoli di cui quest’estate, con i suoi avvenimenti sconvolgenti, sembra avere cambiato la percezione generale. «Un mese fa il vescovo di Crema ha chiesto di ospitare i rifugiati in locali adiacenti a una scuola cattolica, è stato contestato dalle famiglie. La situazione italiana è una vergogna, soprattutto nelle regioni tradizionalmente più cattoliche, il Veneto e la Lombardia».
Il rifiuto è più sociale o più confessionale?
«Quello confessionale l’hanno gridato a suo tempo il cardinal Biffi e il vescovo Maggiolini, secondo cui bisognava eventualmente accogliere solo i cristiani. Ma il problema è la vera e propria fabbrica di paura dei barbari, edificata da forze politiche attente solo all’interesse locale, forze che prima di Francesco la chiesa italiana ha assecondato, anche se all’inizio sembravano assumere riti pagani, precristiani, quelli sì barbarici. Ora si proclamano cattolici ma io li chiamo cristiani del campanile. Il grande silenzio di una chiesa complice li ha aiutati a iniettare nel tessuto sociale del territorio il veleno della xenofobia».
Guardiamo gli eventi nella misura dei millenni di storia anche ecclesiastica, parliamo del V secolo, quando alle cosiddette invasioni barbariche si è affiancata l’assunzione del cristianesimo a religione di stato.
«Quando con Teodosio il cristianesimo è diventato religione dello stato imperiale la furia dei monaci - lo dico con dolore, mi strappa il cuore - ha distrutto i templi pagani, fatto uno scempio di opere d’arte non diverso da quello dell’Is, ma ben più vasto. È il motivo per cui san Basilio non ha mai usato nei suoi scritti la parola "monaco": designava integralisti violenti, i talebani del momento. Guardando i secoli mi permetto di dire, pur con tutte le differenze: vediamo che altri rifanno a noi quello che abbiamo fatto».
Come ad Alessandria d’Egitto, quando fu distrutto il Serapeo e i parabalani del vescovo Cirillo assassinarono Ipazia. Nel "Libro dei testimoni", lo straordinario martirologio ecumenico di Bose, questa martire pagana potrebbe trovare posto?
«Sì, come tutti coloro che - da Buddha a Savonarola, da Rumi a Gandhi - in qualunque religione o anche all’esterno hanno perseverato in una posizione di umanità e di tolleranza. La dottrina cattolica del Vaticano II ribadisce con chiarezza che la coscienza prevale su qualsiasi autorità, anche su quella papale».
Torniamo ai movimenti di popoli della cosiddetta fine dell’antichità.
«Con saggezza papa Gregorio Magno chiese accoglienza per i barbari in arrivo dando un’unica dignità a stranieri e latini, che si espresse nel monachesimo benedettino e fece fiorire il cristianesimo, allora esangue soprattutto in occidente. La storia serve da un lato a non stupirci dell’intolleranza, dall’altro a spegnerla richiamandoci alla razionalità, che oggi significa mostrare ai popoli dell’oriente postcoloniale che gli riconosciamo soggettività, dignità, diritto di sedere alla tavola delle genti, anziché continuare a sfruttarli economicamente».
La memoria storica ecclesiastica, la conoscenza delle ere passate di cui si nutre, non ha anche il dovere di ricordare a tutti l’onda lunga della tolleranza islamica?
«Al tempo della conquista musulmana i cristiani del Medio Oriente hanno aperto le porte delle loro città agli arabi che portavano libertà di culto e affrancavano dalle angherie economiche del governo imperiale cristiano. La convivenza di cristiani, ebrei e musulmani nel corso del medioevo islamico ha fatto fiorire momenti di cultura straordinari, come nel mondo sufita, che conosco bene. L’islam è una religione di pace e mitezza con una mistica di forza pari a quella cristiana. Se nel Corano ci sono testi di violenza, non sono molto diversi da quelli che troviamo nella Bibbia e che ci fanno inorridire. La lettura integralista della Bibbia può rendere integralisti quanto quella del Corano. L’esegesi storico-critica delle scritture, cui il cristianesimo è approdato con fatica e subendo terribili condanne dell’autorità ecclesiastica, è il primo passo di un lungo cammino che aspetta anche i musulmani. Nel frattempo servono ascolto, dialogo, seri studi universitari per dissipare la propaganda ideologica che attecchisce sull’ignoranza: non è vero che l’islam è una religione della violenza e della jihad, affermarlo serve solo a giustificare la nostra nei suoi confronti».
Dai Buddha di Bamyan al tempio di Bel a Palmira, il nostro secolo assiste ad atti islamisti di cancellazione del passato dal contenuto altamente simbolico. Ma non è chiaro quanta parte effettiva vi abbia la religione o la religiosità.
«Una parte minima. Il problema non è religioso, è sociale ed economico. Gli integralisti islamici, anche abbattendo una chiesa, non mirano tanto a offendere la fede cristiana quanto a colpire l’occidente. Un pacifico abitante di Palmira mi ha detto: "Voi occidentali, piangendo la distruzione di templi etichettati dall’Unesco, date l’idea di averli più cari della nostra popolazione. Cosi li fate diventare una protesi dell’occidente nella nostra terra". Mostrando di tenere così tanto a un pezzo di colonna - giustamente, perché è segno di un cammino di umanizzazione - ma facendo saltare in aria le persone nelle guerre da noi scatenate in Iraq, in Siria, in Libia, finiamo per apparire mostruosi. Certo le distruzioni dell’Is sono crimini contro l’umanità oltre che contro la cultura e la dignità dei monumenti va difesa, ma abbiamo la stessa forza nel difendere le popolazioni perché non soccombano alle nostre armi o non trovino vie di morte nella migrazione?».
I popoli sono in marcia e un’ibridazione, che la si voglia o no, dovrà avvenire, perché questa è la storia. Il che pone anche specifici problemi sociali come quello del ruolo della donna: l’islam impone il velo, ma non trovi che anche nella chiesa cristiana ci sia un ritardo?
«Si dice sbrigativamente che certi musulmani siano ancora nel medioevo. Ma il velo completo per le suore di clausura è stato abolito solo nel 1982. È molto recente la presa di coscienza della pari dignità della donna e dell’uomo nel cristianesimo, che non ha ancora nemmeno il linguaggio per esprimerla. La soggezione delle donne agli uomini è un retaggio scritturale nell’islam, ma è presente anche nelle nostre scritture: san Paolo afferma che le donne non devono assolutamente parlare nell’assemblea della chiesa e devono stare a capo coperto. Di nuovo, serve una rilettura storico-critica di tutti i libri sacri, per scorgerne l’intenzione e non le forme. Nella chiesa c’è buona volontà ma poi della donna si hanno immagini irreali: il modello di Maria, vergine e madre, che non può essere il riferimento per una promozione della donna nella chiesa; l’idea, insinuata per moda, che la Madonna sia più importante di San Pietro, idea insipiente come dire che la ruota in un carro è più importante del volano... Non siamo ancora capaci di prendere sul serio l’uguaglianza indubbia tra uomini e donne. Il cammino per la chiesa è ancora lunghissimo perché ovunque ci sia un esercizio di comando restano gli uomini, mentre le donne sono confinate al servizio umile».
Il convegno che si apre oggi è dedicato a "Misericordia e perdono": sono istanze che, dall’ambito ecclesiale cui appartengono, possono suggerire prassi anche giuridiche e sociali?
«Declinare la giustizia con il perdono, anche a livello politico, è un’esigenza che già Giovanni Paolo II aveva evocato con forza in un suo messaggio per la Giornata della pace. L’insistenza di papa Francesco sulla pratica della misericordia, vissuta nei secoli da tanti cristiani d’oriente e d’occidente anche in controtendenza rispetto alla mentalità dominante, dischiude percorsi fecondi nella faticosa purificazione della memoria cui non ci possiamo più sottrarre, pena l’abbrutimento di ogni nostra relazione».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---- "Parlarsi". Eugenio Borgna spiega come salvare il bene minacciato della comunicazione (di Enzo Bianchi)25 agosto 2015, di Federico La Sala
Ti ascolto dunque sei: l’arte di parlarsi con il cuore
Il nuovo libro dello psichiatra Eugenio Borgna spiega come salvare il bene minacciato della comunicazione: mettendosi in discussione
di Enzo Bianchi (La Stampa, 25.08.2015)
La consapevolezza, ormai ampiamente acquisita dopo l’intuizione di McLuhan, che «il mezzo è il messaggio» ci induce a pensare e parlare di comunicazione solo a partire dai «mezzi», dai media, appunto, e non dalla realtà comunicata né ancor meno dalle persone che comunicano. Eppure, comunicare significa innanzitutto Parlarsi: così Eugenio Borgna ha voluto intitolare il suo ultimo libro (in uscita oggi da Einaudi, pp. 92, €11), dedicato alla «comunicazione perduta» o, meglio ancora, a quel dono salutare che è la comunicazione ritrovata.
«Sinonimo di cura»
Per ogni essere umano, la comunicazione può essere salutare, fonte di salute, «sinonimo di cura» come osserva Borgna, perché la qualità della vita dipende dalla qualità delle relazioni e, quindi, dalla qualità della comunicazione, a tutti i livelli in cui si svolge - con sé stessi, sul piano interpersonale, sociale, politico... - e con tutte le potenzialità racchiuse nel nostro corpo che la veicolano: dallo sguardo alle lacrime, dalle parole alle carezze, nel silenzio come nel dialogo cordiale... Non dimentichiamo che comunicare è anzitutto «donare», rendere comune, condiviso da altri, ciò che è proprio, disponendosi a propria volta a ricevere dall’altro. Dirsi è darsi, in un movimento mai unidirezionale, ma circolare, reciproco e interattivo fra partner che si scambiano segni e messaggi al fine di un’intesa, di un accordo cioè, letteralmente, di una sintonia di cuori. Tale scambio non può lasciare immutati: l’identità è modellata nella comunicazione, perché l’essere umano è comunicativo e nessun suo comportamento, lo voglia o meno, sfugge a questa legge.
La relazione umana
Con l’esperienza pluridecennale di psichiatra e con la grande capacità comunicativa che gli è propria, Borgna concatena pensieri che attraversano il tessuto della vita e, quindi, quell’intreccio di salute e di malattia, di solitudine e convivenza, di messaggi e di non detto che la compongono e la strutturano giorno dopo giorno. Non credo sia un caso che il libro sia senza indice strutturato: i pensieri si innestano l’uno nell’altro, si intrecciano, dialogano con la poesia e le scienze umane, a mo’ di brevi testi che finiscono per attrarre e convincere proprio grazie al nesso logico che le articola.
Così emerge con chiarezza come - nonostante potremmo illuderci di vivere una stagione favorevole alla comunicazione, perché i mezzi di cui disponiamo ce la fanno credere possibile sempre e ovunque - ci stiamo dimenticando che essenziale alla comunicazione è il contenuto e, soprattutto, la relazione umana e non solo virtuale con il destinatario, il quale poi non è mai semplice destinatario ma, a sua volta, «mittente» di nuovi messaggi. Comunicare allora si rivela essere un’arte, non una tecnica, e un’arte che esige umiltà.
Coscienza di un bisogno
La comunicazione infatti non nasce da un di più, da un troppo, da un pieno, bensì da un vuoto, dalla coscienza di una mancanza, di un bisogno: comunicare significa affermare il proprio bisogno dell’altro, riconoscere che siamo sempre debitori e dipendenti da altri per la nostra vita. Sa comunicare chi sa riconoscere come propria verità fondamentale la sua povertà ontologica. Forse anche per questo la riflessione di Borgna prende avvio da quelle esperienze fondamentali che ci insegnano chi siamo noi e chi sono gli altri, in sé stessi e per noi: tristezza, sofferenza, malattia, morte volontaria, ma anche solitudine - non sempre negativa - e poi tenerezza, felicità, speranza, desiderio di comunità... il tutto in un flusso ininterrotto in cui luci e ombre si intrecciano e danzano insieme.
Ma c’è un aspetto particolarmente interessante nelle pagine di Borgna: il non dissociare mai la comunicazione con gli altri da quella con sé stessi. Anzi, ancora più in profondità, si tratta di comunicare con «l’interiorità», sia nostra sia degli altri, cioè di riuscire a trasmettere, e a cogliere, ciò che arde nel cuore. Nel nostro cuore, di cui conosciamo così poco, e in quello degli altri, di cui possiamo sperare di cogliere qualche elemento solo con un ascolto attento. Se è vero infatti, come ricorda Il piccolo principe, che «si vede bene solo con il cuore», è altrettanto vero che solo con il cuore si ascolta bene. Si può discernere il non detto, il significato recondito di parole e messaggi solo se ci si «ac-corda», se si entra in sintonia con l’interiorità dell’altro. «Cor ad cor loquitur», il cuore parla al cuore: il motto di John Henry Newman è ancora attualissimo, non solo per il dialogo con Dio nella preghiera e nell’ascolto della sua parola, ma anche per il dialogo autentico tra due persone disposte a prestarsi ascolto reciprocamente. Il segreto più intimo di ciascuno permane sì inviolabile, eppure sappiamo per esperienza come si possa essere «un cuore solo e un’anima sola» nell’affrontare la vita.
«Solo chi è disposto a tutto - ammonisce Rilke citato da Borgna -, chi non esclude nulla, neanche la cosa più enigmatica, vivrà la relazione con un altro come qualcosa di vivente e attingerà sino al fondo la sua propria esistenza». Ecco perché comunicare non è parlare, ma parlarsi.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": --- SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ: "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.5 luglio 2015
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI:
"X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI":
IL NUOVO PARADIGMA.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’influenza del cervello nella politica e nella cultura. Se a governare il mondo è l’emisfero sinistro (di M. Ammaniti)29 giugno 2015, di Federico La Sala
- PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
Se a governare il mondo è l’emisfero sinistro
L’influenza del cervello nella politica e nella cultura secondo lo psicologo e filosofo britannico Iain McGilchrist
di Massimo Ammaniti (la Repubblica, 20.06.2015)
Probabilmente nessun editore italiano si lancerà nell’impresa di tradurre il libro di Iain McGilchrist The Master and His Emissary: The divided brain and the making of the Western World (Il Signore e il suo Emissario: il cervello diviso e la costruzione del mondo occidentale; Yale University Press) perché si tratta di un testo molto denso e corposo, più di 800 pagine nell’edizione americana. È sicuramente una perdita per gli studiosi e i lettori italiani perché il libro solleva interrogativi di grande originalità, rileggendo in una prospettiva diversa l’influenza esercitata dall’asimmetria dei due emisferi cerebrali, studiata in passato da Roger Sperry a cui fu assegnato il Premio Nobel.
La domanda che si pone McGilchrist, psichiatra e filosofo britannico, può sembrare inizialmente troppo riduttiva e semplificatrice: come può la specifica asimmetria cerebrale aver influito così tanto sulle caratteristiche delle varie società che si sono susseguite nell’Occidente?
Nella prima parte del libro vengono discusse le ricerche neurobiologiche degli ultimi decenni sulle modalità di esperienza dei due emisferi, quello sinistro considerato dominante perché legato al linguaggio, alla pianificazione e alla realizzazione, il polo razionale, mentre quello destro più legato alle emozioni, ossia il polo artistico. Questa concezione è ormai troppo scontata, secondo McGilchrist, sarebbe meglio parlare della diversa attenzione verso il mondo sancita dall’incapacità dell’emisfero sinistro di comprendere le metafore, legate alla figurazione di un significato originario, capacità questa più consona all’emisfero destro. E questa diversa attenzione interverrebbe nel cambiare e modificare il mondo che viene plasmato a seconda della supremazia di uno dei due emisferi.
Proprio come la storia raccontata da Nietzsche e che dà il titolo al libro, l’emisfero destro si comporta come il saggio e generoso signore di un paese con grandi risorse che non può governare da solo e pertanto è costretto a delegare i suoi emissari fra cui un visir, che ben presto si contrappone al suo signore pretendendo lui di governare.
È una storia antica come il mondo ma che si attaglia soprattutto a quello che sta succedendo nel mondo occidentale, che viene troppo condizionato dai dettami dell’emisfero sinistro. Le motivazioni esplicite di questo emisfero sono la competizione e la ricerca del potere che portano ad un mondo meccanico e privo di vita in cui c’è sempre meno spazio per il mondo implicito dell’affettività, dell’empatia e delle metafore.
Naturalmente McGilchrist non ritiene che sia il cervello a guidare la cultura, come anche il contrario, entrambi interagiscono e si plasmano vicendevolmente. Ripercorrendo i periodi storici dell’Occidente nell’antica Grecia viene ampiamente documentata la progressiva affermazione dell’emisfero sinistro con gli inizi della filosofia analitica, la codifica delle leggi e la formalizzazione della conoscenza.
Ma è con la rivoluzione industriale del Diciannovesimo secolo che l’emisfero sinistro diviene egemone, giungendo sempre più a dominare lo scenario del mondo della natura, a cui vengono contrapposte forme regolari, il quadrato, il rettangolo o il cerchio create dall’uomo, che possono essere riprodotte all’infinito anche in modo meccanico.
E ancora di più oggi nel periodo del post-modernismo con l’urbanizzazione crescente, l’espansione industriale a livello globale, la cultura tecnologica di massa si affermano desideri di possesso, competizione e rapporti d’uso che stanno soppiantando i legami e la continuità culturale. E’ la rivincita dell’emisfero sinistro, ma il prezzo che si paga è eccessivo, il senso di appartenenza ne viene indebolito e diventa difficile capire il contesto in cui si vive e i rapporti cogli altri con un distacco crescente.
Per ritornare al racconto di Nietzsche, la verità non è così unilaterale, non è solo colpa del Visir se si va incontro ad un conflitto disastroso forse anche il Signore illuminato non ha prestato abbastanza attenzione a quello che stava succedendo.
- PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Quell’uomo si chiamava don Andrea Gallo. Lui è stato un servo, un servo degli ultimi. Intervento di Alba Parietti nell’ultima puntata di Servizio Pubblico.25 giugno 2015
Servizio Pubblico, Alba Parietti: “Don Gallo, partigiano e servo degli ultimi” *
“Mi chiamo Alba perché Alba è stata la prima città liberata dal nazifascismo”. Così Alba Parietti esordisce nel suo intervento nell’ultima puntata di Servizio Pubblico. E rende un commosso tributo al padre: “Dopo di lui, ho conosciuto un uomo che fumava il sigaro e aveva una faccia da attore. Anche lui era stato partigiano, come mio padre, nome in codice Nan. La sua voce e il suo modo di fare erano seducenti. Con lui potevi parlare di qualsiasi cosa, non ti sentivi mai giudicata. La sua vita era piena di prostitute, di trans, di drogati. Viveva immerso nel popolo della notte. E anche io sentivo il bisogno di chiamarlo e gli parlavo al telefono per ore. Il giorno del suo funerale, fuori dalla chiesa, mentre si celebrava la messa, arrivava il coro di “Bella ciao”. Quell’uomo si chiamava don Andrea Gallo. Lui è stato un servo, un servo degli ultimi”
* Cliccare qui, di seguito, per il video dell’intervento completo: Il Fatto, 19 giugno 2015
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---UOMINI E DONNE: MATERNITA’ E ALTRE SCELTE. Vorrei un figlio, ma con chi lo faccio? (di Lea Melandri))23 giugno 2015, di Federico La Sala
- Della terra, il brillante colore (Eleonora Cirant)
Vorrei un figlio, ma con chi lo faccio?
di Lea Melandri (Internazionale, 20 Giu 2015)
In tempi in cui tutto viene imputato alla crisi economica, alla disoccupazione, alla mancanza crescente di servizi sociali, leggere i dati dell’Istat sul calo delle nascite in Italia in chiave di relazione d’amore tra uomini e donne può sembrare un ripiegamento romantico, idealistico. Eppure basterebbe ascoltare i racconti, le domande che si pongono donne fra i trenta e i quarant’anni sulla scelta di avere o non avere figli, per capire che l’amore c’entra, e che se viene trascurato nell’ordine delle cause è perché nell’era del postmoderno - del “post” di tutto - nessuno fa più caso ai sentimenti.
Ci ha fatto caso invece Eleonora Cirant in un interessante libro corale, uscito un paio d’anni fa (Una su cinque non lo fa. Maternità e altre scelte, Franco Angeli), risultato di incontri, conversazioni, interviste con quindici donne della generazione nata negli anni settanta, disposte a interrogarsi sulla scelta “sia di chi diventerebbe madre nel verificarsi di una eventuale circostanza, sia di quelle che non sentono alcun desiderio di maternità”.
Dalla carrellata di esperienze, pensieri di una saggezza fatta di dubbi, interrogativi, libertà da vincoli secolari e oggi sospesa sulla soglia di un ordine che si è andato sgretolando - famiglia, matrimonio, figli - un dato emerge con chiarezza: il calo delle nascite non è come generalmente si pensa solo l’esito di servizi sociali e politiche familiari mancanti, o di una precarietà divenuta condizione esistenziale.
La crisi, prima ancora che di culle, è di case, convivenze, legami amorosi
L’incertezza di fronte alla scelta di mettere al mondo un figlio, sposarsi, convivere con un uomo, conciliare maternità e lavoro, interessi personali e dedizione agli altri, rimanda fondamentalmente alle ricadute di quella che è stata finora la divisione di ruoli e di potere tra un sesso e l’altro.
In particolare, rimanda al confinamento della donna nella figura idealizzata e al medesimo tempo svilita di moglie e madre, che attende da altri il suo completamento e il senso della propria vita; alla restrizione dei confini del mondo al rapporto duale col figlio/a; al sacrificio di sé per la crescita e il benessere dell’individualità altrui; alla trasformazione dell’amore in possesso, della cura in dipendenza perenne di chi la riceve.
Smascherata la falsa naturalità dell’impianto che ha sorretto finora la permanenza nel tempo dell’istituto del matrimonio, ognuno dei componenti della famiglia umana sembra percorrere strade proprie, dove l’incontro è ancora possibile ma a condizioni profondamente mutate.
Le donne ancora in età fertile non escludono di poter avere un figlio, ma si chiedono anche: “Con chi?”.
La maternità, dopo essere stata per secoli obbligo procreativo, si trova a fare i conti con il fatto che le donne hanno imparato a mettere al primo posto passioni, interessi, occupazioni che le portano verso il mondo, a dirsi senza mentire l’insopportabilità della vicinanza continuativa con un bambino, del dispendio di energie fisiche e psichiche che viene loro richiesto dal maternalismo dominante.
Quanti uomini sono oggi disposti a porsi interrogativi analoghi sui ruoli tradizionali di genere, a immaginare nuove forme dell’amore e della genitorialità, rapporti diversi tra vita e lavoro, privato e pubblico?
Di fronte a una figura maschile sorpresa dal cambiamento nella propria fragilità, senso di inadeguatezza, dipendenza da mamme e nonne troppo protettive, o narcisisticamente ripiegata su se stessa, verrebbe da dire che la crisi, prima ancora che di culle, è di case, convivenze, legami amorosi o coniugali duraturi e rassicuranti quanto basta per decidere di fare un figlio.
- Il mio desiderio in questo momento si accompagna al desiderio di avere un compagno, quindi è più un desiderio di amore che di figli. Però è vero che mi sento pronta come madre. Quindi è brutto pensare che non lo posso essere perché non ho un compagno.
- A me manca più un uomo che un figlio, e mi manca un figlio come risultato di un rapporto. Prendo anche in considerazione la possibilità di non essere fatta per la vita di coppia, però vorrei provarlo, perché ho avuto una storia lunga e altre brevi, ma tutte senza convivenza.(...). I maschi pensano: ‘Questa ha quarant’anni, le è scattato l’orologio biologico, vuole fare un figlio’ e quindi fuggono. Coetanei o anche più grandi, gli uomini vivono diversamente questa cosa: a cinquant’anni si prendono la rumena ventenne e fanno tutti i figli che vogliono (...). Molti sono narcisi alla ricerca del soddisfacimento, erotismo, droga, minorenni. I valori, l’intelligenza, ma che cosa! Molte delle relazioni che ho vissuto, uomo-donna, sono state piuttosto madre-figlio. Molti di questi uomini sono figli.
È chiaro che l’amore, nella forma in cui l’abbiamo ereditato - prolungamento di un vissuto infantile di unità a due, dipendenza da una figura materna creata dal desiderio di un uomo figlio e tenuta per secoli sotto il dominio di una società di padri - si è andato eclissando di fronte all’affermazione di una imprevista libertà femminile.
L’uscita delle donne da un destino di sottomissione, sacrificio della propria individualità, dipendenza da una visione del mondo creata da altri, ha aperto la strada a un percorso di “autonomia” che non è solo economica - oggi minacciata dalla precarietà e dal peso del doppio lavoro, in casa e fuori.
Le ragazze ascoltate da Eleonora Cirant parlano una lingua che si è affrancata dall’ideologia del materno come legge naturale o divina: esprimono senza infingimenti il loro desiderio di avere interessi, passioni, tempi propri.
È come se, spalancate le porte di casa, l’amore trovasse anche per le donne i molteplici investimenti che ha avuto finora solo per l’uomo in virtù della separazione tra la sfera pubblica, a lui riservata, e l’ambito domestico della cura o conservazione della vita, delegata all’altro sesso.
- Ho poco istinto accudente in generale. Mi piacciono molto i bambini. Ma ogni tanto penso che avere un figlio è un limite, perché dedichi tutte le tue energie a una creatura tua, quando invece potresti dedicare queste energie per un progetto. Ci sono tanti modi per essere genitori, che non sono necessariamente biologici.
- Pensavo che diventare madre volesse dire perdere la propria soggettività.
- Il mio istinto è molto preciso nel merito: un figlio non lo voglio. Trovo che il pianto isterico di un bambino sia la cosa meno tollerabile del mondo.
- Perché vedo tanto spesso un egoismo nel fare un figlio. È come se tu deputassi a lui un senso che non hai trovato nella tua vita. Lo vedo tantissimo nelle donne che hanno una età dai 35 ai 45 (...) che hanno un lavoro fisso, hanno un buon reddito e una carriera davanti. A un certo punto decidono di avere un figlio, perché magari in tutto quello che hanno costruito non sono riuscite a trovare un senso. Allora fanno un figlio con il primo che capita, poi magari si lamentano perché il compagno è assente. Vivono la maternità come delegare al figlio qualcosa che non hanno trovato in se stesse.
- Mi chiedo se sarei in grado di lasciarlo per conto suo, di vederlo come una creatura a sé stante, perché dal momento in cui l’ho fatto non è cosa mia.
È chiaro che la ricerca di nuove forme di relazione tra i sessi, nel privato come nel pubblico, necessita prima di tutto di un ripensamento di quella che è stata finora la maternità, come obbligo riproduttivo, ma anche come “lavoro d’amore”: cura, incombenze domestiche, sostegno materiale e psicologico ai componenti della famiglia.
Necessita soprattutto che si passi dalla “questione femminile” - uno svantaggio da colmare, parità di diritti e di salario, politiche a favore delle donne in quanto madri - alla messa in discussione da parte di uomini e donne di un’idea di virilità e femminilità che ha visto confusi per secoli dominio e amore, violenza e tenerezza.
Come ha scritto più volte l’economista femminista Antonella Picchio, occorre “cambiare la struttura delle responsabilità sociali rispetto alla produzione delle persone. È, quindi, un problema politico non statistico. Significa, infatti, far emergere come questione sociale, come responsabilità collettiva, ciò che appare come responsabilità esclusiva delle donne”.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! ---- "Methaphysics and Ontology Without Myths". Le domande di Quine (di Carola Barbero)21 giugno 2015, di Federico La Sala
Le domande di Quine
Che cos’è quello che c’è?
Autorevoli studiosi italiani e stranieri affrontano i temi metafisici e ontologici che furono cari al grande pragmatista
di Carola Barbero (Il Sole-24 Ore, Domenica, 21.06.2015)
- Fabio Bacchini, Stefano Caputo, Massimo Dell’Utri (a cura di), Methaphysics and Ontology Without Myths, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, pagg. 190, £ 41,99.
Nel famoso saggio On what there is del 1948 alla domanda «che cosa c’è?», Willard Van Orman Quine, uno dei padri dell’ontologia contemporanea, rispondeva «tutto», che è un po’ come rispondere alla domanda «chi è?» con «io»; o a «dove sei?» con «qui». Dato che infatti con la parola «tutto» ci riferiamo alla totalità delle cose che esistono, dire «tutto esiste» è equivalente ad affermare l’ovvietà che ciò che esiste, esiste.
Il punto interessante però, come peraltro osservava lo stesso Quine, è capire in base a che cosa possiamo stabilire che qualcosa meriti di essere incluso tra ciò che c’è. Ecco perché «che cosa c’è?» e «che tipi di cose sono quelle che ci sono?», ossia rispettivamente la domanda ontologica e quella metafisica, si caratterizzano come interrogativi rilevanti non solo per molte, o forse tutte, le discipline filosofiche, ma anche per la scienza e per il senso comune.
Per esempio Platone nella Repubblica può muovere la sua condanna all’arte proprio perché il suo inventario ontologico prevede una gerarchia di livelli di realtà ciascuno dei quali dipende, per la sua esistenza, da quello a esso sovraordinato, ed è rispetto a questo meno reale e meno perfetto, costituendone un’imitazione. Al vertice dell’ontologia platonica c’è il mondo delle idee, subito sotto la realtà fisica percepibile con i sensi (che è imitazione del mondo delle idee), e infine, al fondo della gerarchia, c’è il mondo delle opere d’arte che, essendo a loro volta imitazioni della realtà sensibile, risultano confinate al rango di mere copie di copie. Platone può quindi criticare l’arte proprio perché riconosce un particolare statuto ontologico al mondo delle idee.
La concezione di Platone costituisce, secondo i curatori di questo volume, un caso paradigmatico di teorie filosofiche che il «tribunale della ragione» ha oramai definitivamente confinato nella sfera del mito, delle concezioni cioè che non hanno retto alla disamina razionale secondo gli standard di adeguatezza che la ricerca filosofica, in modo a sua volta mutevole nel corso della storia del pensiero, pone a se stessa.
Tuttavia non bisogna pensare che la storia della metafisica e dell’ontologia non sia altro che una carrellata di opinioni, di espressioni che riflettono diverse visioni del mondo, perché invece si caratterizza come un percorso almeno moderatamente progressivo in cui alcune teorie sono (oggettivamente) migliori di altre, in base a standard di volta in volta condivisi.
E oggi quali sono tali standard? Oltre al ricorso ad argomentazioni razionali (ossia conformi a criteri di adeguatezza logica) per suffragare le proprie tesi, svolgono oggi un ruolo regolativo il riferimento alla scienza e al senso comune, non nel senso forte che una teoria metafisica o ontologica debba necessariamente essere conforme ad entrambi, ma in quello più debole che una concezione metafisica che confliggesse tanto con la scienza quanto con il senso comune sarebbe giudicata insoddisfacente. Ed è proprio questo il caso della concezione platonica.
Platone è però in buona compagnia e, più in generale, nei dibattiti in cui su una determinata questione sono difese posizioni opposte, spesso si sentono gli uni accusare gli altri di difendere posizioni poco fondate o dogmatiche. Un nominalista magari accetta solo entità concrete spazio-temporali (come Socrate, poniamo) mentre un platonista non ha difficoltà ad accettare anche entità astratte come le proprietà (come la proprietà di essere un uomo, di essere ateniese, ecc.). Oppure, per spiegare in che cosa consiste il reale, un monista ammetterà solo entità di un certo tipo, per esempio le particelle subatomiche, mentre un pluralista si richiamerà a diverse entità a diversi livelli del reale, quindi a un certo livello avrà oggetti come tavoli e sedie, mentre a un altro livello soltanto atomi e forze). E a ciascuna delle parti l’una contro l’altra armate potrà capitare di accusare l’altra di venir meno ad alcuni degli standard di adeguatezza dell’indagine metafisica, di ricadere dunque dal logos al mythos, di far prevalere sull’argomentazione razionale e/o sul rispetto del senso comune o delle acquisizioni della scienza un ingiustificata inclinazione per una certa concezione del reale.
Methaphysics and Ontology Without Myths si propone di affrontare alcuni dei temi più importanti al centro oggi della discussione in metafisica e ontologia, attraverso i contributi di autorevoli studiosi italiani e stranieri. Si parte dalla annosa questione relativa alla effettiva possibilità di una distinzione netta tra ontologia e metafisica (Bottani), per passare alla presentazione della posizione di Quine e alla sua nota predilezione per i paesaggi desertici (Varzi, Rainone). Poi si prende in esame il dibattito tra realisti e anti-realisti per quanto riguarda il successo delle teorie scientifiche (Alai) e ci si interroga sulla natura degli oggetti matematici criticando alcune posizioni nominalitiche (Plebani). Quindi si valuta la possibilità di una genuina conoscenza metafisica e si spiega come una forma di realismo disposizionale sia particolarmente adatta per garantire la conoscenza delle cose, della loro natura e delle loro proprietà (Tiercelin).
Successivamente si analizza la potenza delle intuizioni negli argomenti contro il principio di indiscernibilità degli identici (Casati e Torrengo) e infine si prendono in esame alcune questioni centrali in quell’ambito dell’ontologia che negli ultimi anni è stato tra i più vivi e produttivi che prende il nome di “ontologia sociale” (Ferraris, Davies, Bojanic, Vaselli).
Si tratta davvero di ottimi esempi di come la metafisica e l’ontologia possano efficacemente resistere alla tentazione di rifugiarsi nel mito, sobbarcandosi la fatica della discussione razionale e facendo di questa l’unica, anche se impervia, strada percorribile per rispondere alle domande «Che cosa c’è?» e «Che cos’è quello che c’è?».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "La porta stretta. Diventare maggiorenni." (U. Curi). Nota di Francesca Rigotti.16 giugno 2015, di Federico La Sala
Diventare adulti
Obbedire o ribellarsi?
di Francesca Rigotti (Il Sole-24 Ore - Domenica, 14.06.2015)
Umberto Curi, La porta stretta. Diventare maggiorenni , Bollati Boringhieri, Torino, pagg. 223, € 16,00.
Nel 1784 Immanuel Kant pubblicò un opuscolo dal titolo Was ist Aufklärung? destinato a diventare il manifesto della ragione illuminata. È un’esortazione all’uso della propria intelligenza, un elogio del rischiaramento dei nuovi tempi, un inno al coraggio e all’azione. Tale «rischiaramento» coincide con l’uscita dalla autocolpevole minorità, che viene premiata col passaggio alla condizione di adulto caratterizzata da libertà, autonomia e indipendenza soprattutto economica.
Da questa particolare uscita prende le mosse Curi, nella sua personale e originale ricognizione del transito alla maggiorità quale processo mai concluso ma che si rinnova, si potrebbe dire, ogni giorno. Per assumere la nuova postura priva di sostegni e abbandonare il girello per bambini di cui parla Kant occorre «osare sapere», ovvero rapportarsi al padre. (Ben consapevole del carattere sessista del linguaggio, Curi lo demolisce subito chiarendo fin dalle primissime pagine che non terrà conto della distinzione di sesso).
Si esce dalla minorità disobbedendo al padre o uccidendolo, commettendo dunque parricidio, come farà Edipo, colui che risolve l’enigma dei piedi perché ha il piede nel nome. La nostra tradizione è ricca di eroi giovani che instaurano il nuovo ordine distruggendo il vecchio, e ricavano da questo atto la legittimità del pensare con la propria testa e agire di propria iniziativa. La faccenda sembra lineare, la soluzione univoca. Si uccide il padre e si eredita il regno, vedi, con le varianti del caso, Amleto, o il Prigaioniero de I Fratelli Karamazov.
Ma con Curi le cose non sono mai semplici e lineari e soprattutto non univoche, perché è proprio Curi che da tempo ci ripete che la condizione dell’essere umano è di essere uno e molti, di avere i tanti piedi di cui parla l’indovinello della Sfinge. E infatti, ecco che il passaggio alla maggiorità segue un altro modello, antitetico al primo: non la ribellione ma l’obbedienza al padre. L’obbedienza di Abramo, Gesù, Francesco d’Assisi, Giovanni della Croce. Obbedienze attive condotte in piedi guardando in faccia il padre con amore. Eppure nemmeno questa è la soluzione, dal momento che la porta di Curi rimane, per quanto stretta, sempre aperta. Anche davanti a chi a uscire dalla minorità non ci pensa nemmeno; è il caso di Bartleby, lo scrivano del racconto di Melville, che alla proposta di modificare la sua banale mansione, risponde pacatamente: «Preferirei di no», affermando la sua libertà di non obbedire né uccidere.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI"... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE --- Perché l’amore si vede meglio dallo spazio (di Arianna Huffington).16 giugno 2015, di Federico La Sala
Perché l’amore si vede meglio dallo spazio
Gli uomini che hanno messo piede sulla Luna dicono: lassù capisci il senso della vita
di Arianna Huffington *
Come scriveva Goethe: «Questa vita, signori, è troppo breve per le nostre anime». Le preoccupazioni e le cure della nostra vita quotidiana non potranno mai soddisfare i nostri bisogni più profondi. «Da ateo quale sono», scriveva, «mi ci è voluto un po’ di tempo per rendermi conto di essere una persona spirituale».
Un numero crescente di individui che si dichiarano atei perché infastiditi dalle religioni organizzate e dal loro modo di ritrarre Dio (specie con l’immagine di un personaggio barbuto che sta nel cielo) ammettono oggi di aver conosciuto nella loro vita la meraviglia e lo stupore, esperienze che li hanno fatti fermare di colpo, trasportandoli in mondi nascosti e facendo loro intravedere l’insondabile mistero della vita.
Einstein considerava la meraviglia un prerequisito per la vita. Scriveva che chiunque non possieda la capacità di stupirsi, «chiunque rimanga indifferente, chiunque non riesca a contemplare o non conosca il profondo fremito dell’anima in preda all’incanto, tanto varrebbe che fosse morto, perché ha già chiuso gli occhi davanti alla vita». Nel corso della storia, tutti i grandi scienziati - che Arthur Koestler definiva «voyeur che sbirciano dal buco della serratura dell’eternità» - hanno avuto in comune questa sensazione di stupore quasi infantile.
Comprendo alla perfezione il senso di meraviglia che nei secoli ha spinto uomini e donne a esplorare lo spazio al di là della nostra atmosfera, ma personalmente sono sempre stata molto più affascinata dall’esplorazione dello spazio interiore. Tra le due cose, naturalmente, esiste un legame. Diversi astronauti hanno raccontato di aver vissuto esperienze catartiche osservando la Terra dallo spazio. È un fenomeno chiamato overview effect, che potremmo tradurre con «effetto prospettiva», «effetto da visione d’insieme». Così lo ha descritto Edgar Mitchell, il sesto uomo a mettere piede sulla Luna: «Una sorprendente presa di coscienza del fatto che la natura dell’universo non era quella che mi avevano insegnato... Non solo ho visto il carattere interconnesso delle cose, ma l’ho avvertito... Sono stato sopraffatto dalla sensazione di estendermi fisicamente e mentalmente nel cosmo e mi sono reso conto che era una reazione biologica del mio cervello, che tentava di riorganizzare e attribuire un significato agli spettacoli meravigliosi e sbalorditivi cui avevo il privilegio di assistere».
Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX intenzionato a colonizzare Marte, ha avuto modo di esprimere anche l’altro più antico desiderio degli esseri umani: «Sono giunto alla conclusione che dobbiamo aspirare ad ampliare la portata e le dimensioni della coscienza umana, per poter meglio capire quali domande formulare. L’unica cosa che ha senso, in realtà, è impegnarsi per raggiungere una più grande illuminazione collettiva. Ma l’illuminazione collettiva non può esistere senza l’illuminazione personale. E nel corso dei secoli tutti - insegnanti di discipline spirituali, poeti e autori di canzoni - ci hanno spiegato che l’amore incondizionato è al tempo stesso l’essenza del mistero umano e l’unico ponte fra la sacralità del nostro mondo interiore e la frenesia del mondo esterno. O per dirla con Kurt Vonnegut nel suo libro Le sirene di Titano: «Uno degli scopi della vita umana, chiunque la controlli, è amare chiunque vi sia da amare».
Ad avvalorare quello che ci hanno insegnato le canzoni e i testi sacri, oggi disponiamo anche di dati empirici. Come ha dichiarato il professor George Vaillant, responsabile dell’Harvard Grant Study, un’indagine che ha seguito le vite di 268 studenti dell’ateneo a partire dal 1938: «I 75 anni e i 20 milioni di dollari investiti nel Grant Study conducono, almeno a mio avviso, a una conclusione molto semplice, riassumibile in cinque parole: "La felicità è amore. Punto"». Ed è la stessa conclusione raggiunta, senza spendere 20 milioni di dollari e 75 anni, dal poeta inglese Ted Hughes: «L’unica cosa che le persone rimpiangono è di non aver vissuto abbastanza coraggiosamente, non aver usato abbastanza il cuore, non aver amato a sufficienza. Non c’è proprio nient’altro che conti». (Traduzione di Matteo Colombo)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- Quasi quattrocento anni dopo, quell’amore rende ancora rovente l’aria. Spiando Bernini e la sua santa Teresa dietro le quinte (di Tomaso Montanari)11 giugno 2015, di Federico La Sala
Spiando Bernini e la sua santa Teresa dietro le quinte
di Tomaso Montanari (la Repubblica, 11.06.2015)
Gian Lorenzo Bernini, probabilmente, non avrebbe apprezzato: come tutti i maghi, non svelava i suoi trucchi. Ma è impossibile star lontani dai ponteggi su cui Giuseppe Mantella e Sante Guido (tra i migliori restauratori di scultura che conti l’Italia) stanno pulendo la Cappella Cornaro, nella chiesa romana di Santa Maria della Vittoria: dove Teresa d’Avila geme di piacere e muore per sempre, eternamente trafitta dalla freccia infuocata dell’amor di Dio.
La Cappella è un palcoscenico gremito di attori, pietrificati all’apice dell’azione drammatica. Entrarci vuol dire toccare le “toppe” fantasmagoriche con cui il regista ha rimediato alle lacune dei già spettacolari, coloratissimi marmi antichi, rendendoli ancora più pirotecnici. Vuol dire scoprire che è stato lui in persona, Bernini, a scolpire il grande capitello della parasta di sinistra: tra le cui foglie si contorce un minuscolo alberello, spettacolarmente autografo.
Ma, soprattutto, intrufolarsi dietro le quinte permette di scoprire le tracce degli aggiustamenti dell’ultim’ora: proprio quella fatica che il regista-prestigiatore avrebbe voluto cancellare per sempre. La mano destra di Teresa è un informe grumo di marmo, ma ha tre dite spettacolarmente cesellate: chiaramente eseguite a parte, e attaccate in un secondo momento.
Stupefacente, visto che tutto il resto del gruppo (Teresa e l’angelo) è scolpito in un unico, enorme bocco. Forse il frutto di una rottura posteriore? No, la trovata di un consumato illusionista: fino a quando il gruppo non fu innalzato alla quota stabilita, Bernini non era sicuro di che cosa si sarebbe visto, di quella mano. Ma gli serviva, invece, che si vedesse: per dare un confine leggibile all’oceano di panni in tempesta che risucchia il corpo della santa. E dunque fissò le dita solo stando lassù, muovendole fino a trovare il punto da cui potevano entrare nel campo visivo dello spettatore: «tutto è finto perché tutto sembri vero», era il suo motto.
Ma se ogni cosa era predisposta con sapienza, perché - con apparente spreco di tempo e lavoro - l’angelo e Teresa sono perfettamente lavorati anche sui lati, cioè dove nessun occhio, dal basso, può vedere? Ecco la prova che il grado di rotazione delle figure rispetto alla parete fu deciso solo all’ultimo momento: non si poteva rischiare di mettere in mostra, e proprio lì, qualche dettaglio incompiuto.
Camminando sempre sul filo, però, anche il team di Bernini qualche volta cadeva. I cardinali Cornaro che si affacciano a destra di chi guarda furono scolpiti in un’unica, lunghissima lastra di marmo: un’esibizione spaccona di virtuosismo. Puntualmente punita, però: perché le misure non tornarono, e ci si dovette acconciare a rilavorarli in loco (le schegge di marmo sono ancora lì dietro: commoventi), adagiandoli poi in un’intercapedine di stucco.
Infine, sono proprio i due celeberrimi attori protagonisti ad apparire in una luce nuova. Chi avrebbe mai detto che al meraviglioso cherubino mancasse tutta la metà anteriore del piede destro? Piede che affonda nella base di marmo come, d’estate, il piede di un bambino scompare nell’acqua di mare. Ma anche Teresa ha qualche segreto da svelare: solo vedendola di fronte, si capisce che indossa anche il grande mantello bianco dei carmelitani, perfettamente riprodotto con tanto di fermaglio, che è simile a uno sbarazzino bottone da montgomery.
Una volta sui ponteggi è impossibile non pensare al primissimo palco, quello su cui salirono Bernini e i suoi. Le biografie dicono che quando Gian Lorenzo era lassù, bisognava sempre tenergli vicino un garzone: perché tendeva a estraniarsi e rischiava di cader di sotto. A chi cercava di richiamarlo alla realtà, rispondeva: «lasciatemi stare, ché sono innamorato ». Quasi quattrocento anni dopo, quell’amore rende ancora rovente l’aria della Cappella Cornaro.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- In relazione: perché? e soprattutto come? Bioetica, biopolitica e tanatopolitica ("Laboratorio Donnae").30 maggio 2015, di Federico La Sala
In relazione: perché? e soprattutto come? Bioetica, biopolitica e tanatopolitica. *
- XIII Edizione Scuola Estiva della Differenza - Lecce 7-10 settembre 2015, in collaborazione con la Comunità delle Benedettine di Lecce
Essere in relazione: pratica politica femminile tematizzata già quarant’anni fa, ma che si presenta con l’urgenza di essere ripensata, non tanto nella direzione di una prospettiva democratica, che risponderebbe alla domanda “perché?”, ma nella direzione di un come che corrisponde meglio alla pratica della differenza. Un come che fa trasparire il metodo nuovo che non è più quello dei saperi e delle discipline esterne che pretendono di rappresentare l’universalità, ma un metodo che si affida a un sapere plurale e pure condiviso, perché sentito, sperimentato in prima persona e insieme percepito come comune.
L’anno scorso, nella “Scuola Estiva della Differenza” eravamo partite dal desiderio di fare il punto su ciò che è davvero essenziale nelle nostre vite di donne. In una società sempre in crisi e sempre pronta a rimescolare sicurezze e strategie, in molte avevamo sottolineato il desiderio di poter far leva sulla forza che è molla per la nostra libertà. Ed è imprescindibile.
Fedeli al progetto di essere sempre nel tempo, continuiamo quest’anno a interrogarci sul come accedere a questo nocciolo di verità e libertà che riconosciamo essere tra noi, ma che ci è presentato, sempre più spesso, avvolto in modo contraddittorio in un involucro apparentemente logico, garantito da norme e discipline e saperi specializzati, e tanto perfettamente calibrato quanto svuotante e insensato. Continuiamo a interrogarci sul perché quel nocciolo di verità, quanto più ci è proposto come assoluto tanto più lo percepiamo come un qualcosa di astratto, che prescinde dai nostri corpi e dai nostri desideri e ci offre certezze a buon mercato e libertà individuali incapaci di modificare alcun paradigma. Continuiamo a interrogarci sul perché quella che viene rappresentata come una parvenza di ripresa economica, istituzionale e di costume appaia a sua volta come una nuova manovra gestita dalla crisi economica internazionale, che ha bisogno di darci sicurezza per mantenerci in stallo.
Abbiamo imparato a leggere e decostruire paradigmi istituzionalizzati, stiamo imparando con sapienza e pazienza ad accedere a quei nuclei di verità incartati in opacità pesanti, ma soprattutto abbiamo imparato che l’amore per la libertà, come ogni amore, non può essere un’esperienza che si fa da sole, da soli: per amare bisogna essere in relazione, in solitudine proprio non si può.
In una società con parametri economici, lavorativi e dottrinari decisi da uomini per uomini, l’essere in relazione aiuta a dare risposte a questi tanti perché. Ma come si sta nella relazione? nella pluralità della relazione, non nella relazione di appartenenza, si può costruire il proprio radicamento. È nella pluralità della relazione che si trova nutrimento e sicurezza per le proprie scelte, è nella relazione che si possono compiere scelte condivise. Nella relazione impariamo l’ascolto e nella relazione siamo aiutati a muoverci tra più sicuri percorsi di autenticità e, perché no, anche più certi sentieri di felicità...
PROGRAMMA
INFO E PARTECIPAZIONE
* LABORATORIO DONNAE. laboratorio di ricerca sul pensiero e sulla rappresentazione che le donne si danno in politica - ripresa parziale..
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Fuori la Chiesa dalle lenzuola d’Irlanda. Pietro Parolin, portavoce del pensiero della Chiesa, è molto triste per la vittoria del referendum sulle unioni gay27 maggio 2015, di Federico La Sala
Fuori la Chiesa dalle lenzuola d’Irlanda
di Deborah Dirani (L’Huffington Post, 27/05/2015)
Che enorme occasione di evangelizzazione ha perso, ancora una volta, la Chiesa di Roma definendo la vittoria dell’amore irlandese una sconfitta per l’umanità. E che infinita tristezza racchiudono le parole del suo Segretario di Stato, un servo di Dio, in teoria. Un servo di quel Dio che raccontano essere buono e misericordioso, incline al perdono e dispensatore di infinito amore. Così lo raccontano, così ce lo propongono dal giorno in cui veniamo al mondo in quella parte di mondo in cui quel Dio lì ancora resiste. Per quanto? Per quanto potrà resistere l’incoerenza di questa chiesa che si riempie la bocca della necessità dell’amore e si chiude gli occhi davanti a una sua umana forma?
L’umanità non è sconfitta per il riconoscimento del diritto di sposarsi tra persone dello stesso sesso, l’umanità è sconfitta ogni volta che non accetta se stessa, in tutte le sue infinite sfumature. L’umanità è sconfitta ogni volta che si ostina, granitica, a non accettare la propria evoluzione. Lo chiamano oscurantismo, io necessità di controllo sociale. Del resto non sono certo la prima a identificare nelle religioni la beatificazione di questa umanissima esigenza: l’ordine sociale va mantenuto, ad ogni costo. Anche se questo costo sono donne ammalate bruciate su un rogo, infedeli trapassati da una spada, miscredenti infiammati o ostracizzati. Il rogo e la spada sono memoria lontana (mai abbastanza), l’ostracismo è il presente di una congregazione di anziani incapaci di mettere in pratica ciò di cui parlano.
Non sono cattolica, non lo sono per la mia impossibilità di accettare l’ineluttabilità di un destino che non mi posso scegliere, innanzitutto. Non lo sono per la poca misericordia nella quale continuo a imbattermi tra i massimi rappresentanti di questa vecchia Chiesa. No, non parlo dei preti di periferia, di quelli che si preoccupano più della vita che del suo ordine: quelli so che ci sono e a loro destino la mia più profonda e sincera ammirazione. Parlo di quei pii uomini ostinati a confondere la salvezza delle anime devote con la quotidianità della vita, con la necessità inviolabile che ogni essere umano ha di amare e di vedere legittimamente riconosciuto il suo amore.
Sotto le lenzuola la Chiesa, lo Stato e la politica non hanno il diritto di entrare: nessuno può decidere sulla liceità di un amplesso, nessuno può definire giusto un sentimento stigmatizzandone al contempo una delle sue possibili sfumature. L’omosessualità è vita, nonostante non sia in grado di generarne. Continuare a negarne la dignità è un errore talmente colossale da meritare, questo sì, le fiamme dell’inferno.
Pietro Parolin, portavoce del pensiero della Chiesa di Cristo, è molto triste per la vittoria del referendum sulle unioni gay avvenuta in un pio Stato quale è l’Irlanda. Ad avercelo vicino mi premurerei di passargli un fazzoletto per asciugarsi le lacrime, quindi gli consiglierei di essere molto felice perché quella che lo rattrista in realtà è la vittoria del principe dei suoi valori: l’amore. Non mi preoccuperei di snocciolargli il rosario delle empietà di cui la sua Chiesa continua a macchiarsi, tra preti che amano un po’ troppo i bambini e cercano di soffiare a Robert Mapplethorpe un posto nell’Olimpo dei fotografi del nudo.
Non mi preoccuperei neanche di ricordargli che tanti di quei bambini troppo amati sono diventati degli adulti incapaci di amare a causa di qualche innamorato con la tonaca. A che serve rinfacciare gli orrori commessi a chi ne è ben consapevole, nonostante l’omertoso silenzio dietro il quale per tanto tempo ha trovato un sicuro rifugio? Com’è, pure che diceva il Figlio di Dio? Ah, ecco: "Chi è senza peccato...". No, a Pietro Parolin offrirei una birretta, gli proporrei un brindisi: "Alla salute dell’amore, Monsignore!". Perché nonostante lei e quelli come lei alla fine vince lui, non dovunque, ma non dispero. Il tempo e la storia sono dalla mia parte.
Anche lei, o chi verrà dopo di lei, Monsignore, sarà costretto a piegare il capo davanti alla meravigliosa realtà della natura umana che ama. Non importa chi e non importa come: anche lei piegherà il capo e onorerà chi mette in pratica nella sua vita la parola di quel Dio di cui lei è devoto. Nel frattempo, Monsignore, mi premurerò di farle arrivare una buona scorta di fazzolettini, prevedo che in futuro gliene serviranno molti, moltissimi. E meno male!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Sull’ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale. Lo storico parere (1976) della Pontificia commissione biblica ("Il Regno")26 maggio 2015, di Federico La Sala
Pontificia commissione biblica*
Lo storico parere della Pontificia commissione biblica (1976)
* A seguito dei numerosi riferimenti fatti da papa Francesco alla necessità di ripensare il ruolo della donna nella Chiesa, pubblichiamo la prima (e nostra) traduzione italiana del documento di lavoro elaborato nella primavera del 1976 dalla Pontificia commissione biblica sul ruolo delle donne nella Scrittura, apparso in inglese in appendice al vol. di A. Swidler, L. Swidler (a cura di), Women Priests, Paulist Press, New York 1977, 338-346.
Il testo porta la firma, oltre che del presidente della Commissione e prefetto della Congregazione per la dottrina della fede card. Franjo Seper, e del segretario, mons. Albert Deschamps, vescovo titolare di Tunisi, dei membri che facevano allora parte della Commissione: Jose Alonso-Diaz, Jean-Dominique Barthelemy, Pierre Benoit, Raymond Brown, Henri Cazelles, Alfons Deissler, Ignace de la Potterie, Jacques Dupont, Salvatore Garofalo, Joachim Gnilka, Pierre Grelot, Alexander Kerrigan, Lucien Legrand, Stanislas Lyonnet, Carlo Maria Martini, Antonio Moreno Casamitjana, Ceslas Spicq, David Stanley, Benjamin Wambacq, Marino Maccarelli (segretario tecnico).
Sono noti anche i risultati delle votazioni: su 20 membri erano presenti in 17; non sono noti i nomi dei tre assenti.
 Le 3 questioni sottoposte a voto, tutte approvate, erano: 1) il Nuovo Testamento non afferma in modo chiaro se le donne possono diventare prete (voto unanime); 2) i motivi scritturistici non sono sufficienti da soli a escludere la possibilità dell’ordinazione delle donne (12 a 5); 3) il piano di Cristo non sarebbe violato con l’ordinazione delle donne (12 a 5).
La dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede circa la questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale Inter insignores, che porta la data del 15 ottobre 1976 - firmata a nome della Congregazione dal card.
Seper -, non tenne conto di questo documento (ndr).
Le 3 questioni sottoposte a voto, tutte approvate, erano: 1) il Nuovo Testamento non afferma in modo chiaro se le donne possono diventare prete (voto unanime); 2) i motivi scritturistici non sono sufficienti da soli a escludere la possibilità dell’ordinazione delle donne (12 a 5); 3) il piano di Cristo non sarebbe violato con l’ordinazione delle donne (12 a 5).
La dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede circa la questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale Inter insignores, che porta la data del 15 ottobre 1976 - firmata a nome della Congregazione dal card.
Seper -, non tenne conto di questo documento (ndr).*
FONTE: IL REGNO - 15/04/2015
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Lo Spirito del mondo. Viene dalla lotta a favore dei diritti umani, l’esito del referendum irlandese (di Vito Mancuso)25 maggio 2015, di Federico La Sala
Lo Spirito del mondo
di Vito Mancuso (la Repubblica, 25.05.2015)
VIENE da lontano l’esito del referendum irlandese con cui oltre il 62 per cento dei votanti ha detto sì alle nozze gay. Viene dalla lotta a favore dei diritti umani.
UNA lotta iniziata più di due secoli fa nel nome dell’uguaglianza e che ha portato a una serie di conquiste sociali tra cui il suffragio universale, la libertà di stampa, la libertà religiosa, l’istruzione per tutti, la parità uomo-donna nel diritto di famiglia, il superamento legale di ogni discriminazione razziale e altri traguardi di questo genere, tutti riconducibili al valore dell’uguaglianza di ogni essere umano. Sabato l’ha ribadito la maggioranza degli irlandesi: “Yes Equality”.
In queste trasformazioni dei costumi e del diritto si manifesta l’evoluzione della cultura e del pensiero prodotta da ciò che Hegel denominava “Spirito del mondo”, nel senso che noi non siamo i padroni delle nostre idee, ma sono le idee a entrare in noi.
C’è però una differenza rispetto al filosofo tedesco, e cioè che ora il primato non è più dello “Spirito oggettivo” rispetto allo “Spirito soggettivo”, ma al contrario. Assistiamo a una radicale riscrittura dei rapporti tra singolo e società: il primato non è più della società e delle sue istituzioni a cui il singolo si deve uniformare come nei secoli passati, ma è piuttosto del singolo a cui la società deve sapersi adattare servendone la felicità e la realizzazione. Prima erano i singoli a piegarsi alle istituzioni, ora sono le istituzioni a piegarsi ai singoli, modificando persino la Costituzione, come in Irlanda.
Il valore in gioco era il diritto di ogni essere umano all’amore integrale. Fino a poco tempo fa nei Paesi più avanzati del mondo (ma in Italia ancora oggi) se una persona nasceva con un orientamento sessuale di tipo omosessuale si vedeva negato il diritto all’amore integrale, che non si accontenta di esprimersi solo come passione privata ma desidera uno statuto pubblico, nel senso che esso entra a definire l’identità sociale di una persona, non più singolo, ma legato a un’altra persona in permanente comunità di vita. È questo desiderio dell’amore di acquisire una dimensione pubblica che porta le persone a sposarsi, e non semplicemente a convivere.
Chi desidera sposarsi non riesce più a pensare se stesso a prescindere dall’altro e chiede alla società di riconoscere pubblicamente il suo nuovo statuto, mutando per così dire la sua carta d’identità sociale e dicendo al mondo: “non sono più solo io, io sono unito con l’altro”. Questo è ciò che io chiamo “amore integrale” e che ritengo essere un diritto costitutivo di ogni essere umano. L’aspirazione all’amore integrale deve essere riconosciuto come diritto inalienabile che ogni essere umano acquisisce alla nascita, un diritto nativo, radicale, di cui nessuno può essere privato.
Ormai il tempo è compiuto anche da noi per sostenere nel modo più esplicito che tutti hanno il diritto di realizzarsi nell’amore integrale, senza distinzione. Il ritardo italiano non va colmato procedendo solo al riconoscimento delle unioni civili senza parlare di matrimonio, ma occorre procedere al matrimonio anche per le coppie gay, perché sono in gioco l’uguaglianza e il diritto nativo all’amore integrale.
Il senso complessivo di questo movimento è altamente evangelico, perché sempre, quando trionfa la singolarità della persona rispetto alla logica di Stato delle istituzioni e delle tradizioni, si afferma il punto di vista di Gesù, il quale sosteneva che il sabato era per l’uomo e non l’uomo per il sabato, e che per questo venne eliminato dal potere istituzionale.
La Chiesa gerarchica però non l’ha ancora capito. Non l’ha capito nel 1789 quando il movimento è iniziato, e non l’ha capito in questi giorni in Irlanda con i vescovi che hanno lanciato un appello per il «rispetto dei valori della famiglia tradizionale ». I singoli credenti invece sì. A meno infatti di non ritenere che essi in una nazione tra le più cattoliche al mondo siano solo il 37,9%, occorre riconoscere che per la maggioranza dei fedeli le posizioni della gerarchia cattolica non hanno rilevanza quando sono in gioco questioni etiche e diritti umani.
L’arcivescovo di Dublino ha detto che «la Chiesa ora deve fare i conti con la realtà». È vero, e spero che qualcosa avverrà. Ma ancora più importante è che i conti con la realtà li faccia la politica italiana, dando al nostro Paese una legge che consenta a ogni cittadino di vivere, nella pienezza del matrimonio, il diritto nativo all’amore integrale.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA MELA REINTEGRATA E IL "TERZO PARADISO". Un omaggio critico a Michelangelo Pistoletto8 maggio 2015, di Federico La Sala
EU-ANGELO E COSTITUZIONE . "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1 Gv., 4. 1-16).
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- "Donne che guadagnano meno degli uomini è puro scandalo" (Papa Francesco)29 aprile 2015
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
Papa Francesco: "Donne che guadagnano meno degli uomini è puro scandalo"Il Santo Padre fa appello alla "uguale retribuzione" tra uomo e donna: "Perché si dà per scontato che debbano essere pagate di meno?". Il cristianesimo "non può essere maschilista": "Il Vangelo ha sconfitto la cultura del ripudio abituale, quando un marito poteva imporre il divorzio anche con i motivi più pretestuosi" *
CITTA’ DEL VATICANO - "La disparità di retribuzione tra uomo e donna è uno scandalo. Serve uguale retribuzione per uguale lavoro". Così Papa Francesco durante l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Papa Francesco: "Donne che guadagnano meno degli uomini è puro scandalo"
"Perché per le donne è scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No, lo stesso diritto! La disparità è un puro scandalo". Per il Papa, "nello stesso tempo, riconoscere come ricchezza sempre valida la maternità delle donne e la paternità degli uomini, a beneficio soprattutto dei bambini. Ugualmente, la virtù dell’ospitalità delle famiglie cristiane riveste oggi un’importanza cruciale, specialmente nelle situazioni di povertà, di degrado, di violenza familiare".
Papa Francesco ha denunciato ancora una volta i danni che compie il maschilismo nella nostra società, partendo dal luogo comune per il quale la crisi della famiglia tradizionale e la diminuzione dei matrimoni, è colpa dell’emancipazione femminile. "Questa - ha scandito il Pontefice - è anche un ingiuria, ed è una forma di maschilismo: l’uomo che sempre vuol dominare". "Così - ha affermato - facciamo la brutta figura di Adamo, che per giustificarsi di aver mangiato la mela ha risposto al Signore: ’Lei me l’ha data’".
Secondo Bergoglio, e il cristianesimo non può essere maschilista: "Il Vangelo - infatti - ha sconfitto la cultura del ripudio abituale, quando un marito poteva imporre il divorzio anche con i motivi più pretestuosi e umilianti". "Dobbiamo difendere le donne!", ha commentato Francesco mentre la folla applaudiva.
Davanti a oltre 20mila persone in piazza San Pietro, Bergoglio, a partire dal racconto delle nozze di Cana, - dove Gesù secondo il Vangelo trasformò l’acqua in vino durante una festa di nozze in cui il vino non era sufficiente - ha parlato della bellezza del matrimonio cristiano, annunciando che ne parlerà anche nella prossima udienza generale. In questo periodo, come noto, papa Francesco svolge delle catechesi sulla famiglia, in preparazione al sinodo del prossimo autunno, e spesso svolge ogni "capitolo" in due "puntate".
"Dai tempi delle nozze di Cana - ha osservato - tante cose sono cambiate ma quel segno di Cristo contiene un messaggio sempre valido: oggi sembra non facile parlare del matrimonio come di una festa che si rinnova nel tempo, nelle diverse stagioni". "E’ un fatto - ha detto ancora - che le persone che si sposano sono sempre di meno, questo è un fatto, i giovani non vogliono sposarsi, in molti paesi aumenta invece il numero delle separazioni mentre diminuisce il numero dei figli".
"La difficoltà a restare insieme sia come coppia che come famiglia - ha commentato il Pontefice - porta a rompere i legami con sempre maggiore frequenza e rapidità, e i figli sono i primi a portarne le conseguenze", "le vittime, le vittime più importanti, le vittime che soffrono di più in una separazione sono i figli, e se sperimenti fin da piccolo che il matrimonio è un legame a tempo determinato, inconsciamente per te sarà così, e infatti molti giovani sono portati a rinunciare al progetto stesso di un legame stabile e di una famiglia duratura. Dobbiamo riflettere - ha invitato papa Francesco - sul perché tanti giovani non si sentono di sposarsi, c’è questa cultura del provvisorio, tutto è provvisorio, niente è definitivo, è una delle preoccupazione di oggi, perché non si sposano? perché preferiscono una convivenza e tante volte anche una convivenza a responsabilità limitata, e tanti, anche battezzati, hanno poca fiducia nel matrimonio e nella famiglia? E’ importante - ha rimarcato il Papa - capire perché non hanno fiducia nella famiglia".
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Differenza Sì disuguaglianze No. Lo diceva già Olympe De Gouges (di Eleonora Cirant).17 aprile 2015Vi prego qualcuno spieghi al Papa Francesco che nessuno ce l’ha con le differenze! Il problema è quando da differenza discende asimmetria di potere. Differenza Sì disuguaglianze no. Lo diceva già Olympe De Gouges ghigliottinata dai cari rivoluzionari francesi perché pubblicò la "Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina". E poi al Papa: le differenze sono tante, mica solo quelle benedette da santa madre chiesa (Eleonora Cirant)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Donne per Expo: note critiche a margine del megaevento 2015 (di Gea Piccardi)17 aprile 2015, di Federico La Sala
Expo 2015
Donne per Expo: note critiche a margine del megaevento 2015
di Gea Piccardi *
Dietro l’icona della vita, le politiche delle multinazionali e della governance attuale
«WE-Women for Expo parla di nutrimento e lo fa mettendo al centro la cultura femminile. Ogni donna è depositaria di pratiche, conoscenze, tradizioni legate al cibo, alla capacità di nutrire e nutrirsi, di “prendersi cura”. Non solo di se stessi, ma anche degli altri... Le artefici di questo nuovo sguardo e nuovo patto per il futuro [saranno] le donne».
Così recita la presentazione del progetto che Expo 2015 dedica alle donne come prime protagoniste del grande evento mondiale che avrà sede a Milano tra qualche mese. Donne, quindi, come icona di salvezza, universale mitico che raccoglie in sé i valori della generazione, della cura, del nutrimento, della maternità. Donna come portatrice di un potenziale differente nel lavoro, nell’impresa, nella cultura. Insomma, Expo lancia un grido al mondo:
«Nutrire il pianeta, energia per la vita», a cui dovrebbero rispondere tutte le donne «per essere le protagoniste del cambiamento e di uno sviluppo pienamente sostenibile».
In questo grido, che è un grido d’allarme, leggo il segno violento di una storia millenaria: la Storia del maschio, dell’Uomo come categoria universale e universalmente imposta, scritta da quell’infamia originaria di cui parla Lea Melandri per cui
«la donna che entra nella storia ha già perso concretezza e singolarità: è la macchina economica che conserva la specie umana, ed è la Madre, un equivalente più generale della moneta, la misura più astratta che l’ideologia patriarcale abbia inventato».
Expo, quindi, smette di essere “solo” un cantiere di speculazioni e un banco di prova delle nuove riforme strutturali del lavoro (all’insegna del self-management, della gratuità e della flessibilità), ma si configura anche come spazio di produzione di discorso, di simboli, di miti e di pratiche che vanno ad alimentare un’idea di mondo nata nella notte dei tempi, «un dramma di cui si cominciano a vedere oggi i protagonisti». Uno dei campi discorsivi e simbolici attorno a cui si costruisce l’Esposizione Universale del terzo millennio è appunto quello della femminilità come insieme di attributi salvifici e creativi della donna e quello della vita come terreno di sfida politica ed economica. Il mito trascendente della Dea Madre o della Madre Terra, mito universale che sacrifica l’immanenza e la singolarità composita delle vite in un’astrazione separata dai corpi, è sempre esistito nella cultura maschile e patriarcale. È quell’ideale prodotto dall’Uomo in corrispondenza a un sistema di dualismi che vedono irrimediabilmente separati mente e corpo, materia e forma, produzione e riproduzione e il cui correlato è stata la creazione di un “femminile” tanto negato e oppresso nello spazio del biologico e del riproduttivo, quanto sacralizzato in veste di principio materno, generativo e vitale. Questo mito non ha smesso di esistere nell’epoca della religione del denaro e anzi, negli ultimi quarantanni, ha avuto un ruolo preminente all’interno di quel passaggio storico in cui un nuovo paradigma economico ha tentato di recuperare la forza dirompente delle lotte femministe degli anni Settanta. Ha stabilito, cioè, quel differenziale femminile da poter valorizzare sul mercato che prende il nome di diversity management: maggior capacità di cura delle relazioni, di creatività e di pragmatismo che richiamerebbero gli attributi tipici del lavoro domestico come luogo - in fondo e sempre - riservato alle donne.
Expo conferma questa narrazione e ne mostra i paradossi, rilancia la sfida internazionale in difesa della vita e in nome delle donne ma ne svela il nesso indissolubile con le logiche di accumulazione di profitto e con le politiche della morte dell’attuale governance globale.
Non a caso uno dei primi partner di Expo (insieme a Nestlé, Coca Cola, McDonald’s, Mekorot e Israele, Barilla e tanti altri) è Monsanto, la più grande multinazionale di biotecnologie agrarie e principale produttrice di semi geneticamente modificati del mondo, nonché mostro devastatore di ambiente (attraverso il monopolio delle sementi e dell’imposizione dei brevetti sui semi e l’uso di agro-tossici e agenti chimici che distruggono le proprietà del terreno e che causano cancri mortali alle persone che vivono nelle località limitrofe alle aree contaminate) e principale obiettivo di lotte e contestazioni da parte di numerosissime organizzazioni disseminate su tutto il pianeta. A questo proposito mi viene in mente il caso di Ituzaingó, una località argentina situata nella periferia di Cordoba e circondata da coltivazioni intensive di soia di proprietà di Monsanto. Qui, a partire dal 2001, un gruppo di madri (Las madres de Ituzaingó) cominciò a denunciare la morte dei propri figli nati con disparate malformazioni, gesto che inaugurò l’inizio di una lotta feroce che dura tutt’ora contro la multinazionale e l’uso di agro-tossici. Quando cominciarono le ricerche si scoprì che su una popolazione di circa mille persone 200 soffrivano di cancro, si rilevarono casi di giovani da 18 a 25 anni con tumore al cervello, altri dai 22 ai 23 che già erano morti e più di tredici casi di leucemia in bambini e ragazzi giovani. Lo scorso Luglio a Buenos Aires ho avuto la fortuna di partecipare all’inaugurazione del FINCA (Festival Internacional de Cine Ambiental) che ha dedicato la prima serata ad Andres Carrasco, un biologo molecolare che aveva lottato in piazza a fianco de las madres e che aveva dimostrato scientificamente gli effetti nocivi del Glifosato, ingrediente contenuto nei pesticidi di Monsanto.
E così penso anche alle centinaia di sgomberi che hanno colpito negli ultimi mesi alcuni quartieri popolari di Milano, in particolare Corvetto, Giambellino e San Siro, e che seguiranno fino all’inaugurazione di Expo, come previsto dalle dichiarazioni del presidente della regione Roberto Maroni. Sebbene non sia esplicitato il nesso che lega il provvedimento repressivo e il mega evento di maggio, è evidente che dietro il primo ci sia l’intento di riqualificare la città in vista del ruolo-vetrina che le sarà attribuito per tutto il 2015. Così centinaia di persone hanno occupato le strade per fermare un’inaudita violenza poliziesca che obbligava decine e decine di famiglie a lasciare le proprie case, un tetto sotto cui vivere. Senza dimenticare la denuncia di quella donna che ha perso il figlio di cui era incinta durante gli scontri e le manganellate.
Questo per mostrare, attraverso due esempi tra migliaia, la faccia oscura, necropolitica, di un evento come Expo e del modello di “sviluppo” che ci propone. Accanto alla costruzione di nuovi miti di generazione, di cura e di nutrimento (con tutta una simbologia che riguarda la Donna, la Terra e la Vita) e alla produzione della femminilità come insieme di fattori messi a valore dal mercato, Expo si fa portatore di un sistema economico e politico che fa della riproduzione della vita e dell’ambiente il principale campo di sfruttamento e di espropriazione. E, sebbene si tratti di un modello di mondo che ha radici in un pensiero sessista e patriarcale che ancora oggi vive in tutte le manifestazioni di violenza diffusa e crescente sul corpo delle donne, la sua portata distruttrice riguarda tanto le donne quanto gli uomini e le altre soggettività oltre il genere, ed è per questo che tutti e tutte siamo tenute a rispondere. La sfida che ci pone Expo è a trecentosessanta gradi, è radicale perché interroga alla radice le strategie future delle multinazionali e della governance globale: si tratta di decostruire categorie di genere imposte dal mercato, di stabilire cosa significa per noi vita e biodiversità, di saper ricostruire il cammino della filiera produttiva che connette a filo teso le piantagioni intensive di soia e mais transgenici del Latino America ai nostri acquisti al supermercato e chiederci che risposta diamo noi alla crisi agro-alimentare, e tanto altro.
Rosi Braidotti scrive che
«confrontarsi con la storicità della nostra condizione significa spostare il fulcro della riflessione verso l’esterno, nel mondo reale, in modo da assumersi le responsabilità delle condizioni e relazioni di potere che definiscono la nostra collocazione. L’epistemologico e l’etico avanzano in tandem nei complicati orizzonti del terzo millennio. Ci occorrono creatività concettuale e coraggio intellettuale per afferrare quest’occasione, e non si può tornare indietro».
Credo che questa esortazione bene riassuma la portata epocale della battaglia contro Expo.
* della sezione italiana dell’Associazione internazionale delle filosofe (Iaph-Italia). Intervento pubblicato sul sito dell’associazione e su Adista
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- NEL NOME DI COSTANTINO. Papa Bergoglio: "Teoria gender espressione di frustrazione che cancella differenze"15 aprile 2015
Papa: "Teoria gender espressione di frustrazione che cancella differenze"
Bergoglio, nel corso dell’udienza del mercoledì, dedicata oggi al tema della complementarietà tra uomo e donna, mette in guardia: "Rischiamo un passo indietro, la rimozione della differenza infatti è il problema non la soluzione". Francia insiste su ambasciatore gay *
CITTA’ DEL VATICANO - "Mi chiedo se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza perché non sa più confrontarsi con essa". Lo ha detto oggi il Papa, nel corso dell’udienza del mercoledì oggi dedicata al tema della complementarietà tra uomo e donna, come preparazione al Sinodo sulla famiglia del prossimo ottobre. Ma così - ha aggiunto - "rischiamo un passo indietro, la rimozione della differenza infatti è il problema non la soluzione", "per risolvere i loro problemi di relazione l’uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia".
E ha insistito: "Come tutti sappiamo, la differenza sessuale è presente in tante forme di vita, nella lunga scala dei viventi...La differenza tra uomo e donna non è per la contrapposizione, o la subordinazione, ma per la comunione e la generazione, sempre ad immagine e somiglianza di dio. L’esperienza ce lo insegna: per conoscersi bene e crescere armonicamente l’essere umano ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna. Quando ciò non avviene, se ne vedono le conseguenze. Siamo fatti per ascoltarci e aiutarci a vicenda. Possiamo dire che senza l’arricchimento reciproco in questa relazione - nel pensiero e nell’azione, negli affetti e nel lavoro, anche nella fede - i due non possono nemmeno capire fino in fondo che cosa significa essere uomo e donna. La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l’arricchimento della comprensione di questa differenza. Ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo". Per questo, Papa Francesco esorta gli intellettuali a non trattare il legame matrimoniale e familiare come se fosse un tema "diventato secondario per l’impegno a favore di una società più libera e più giusta".
Intanto non si placa la tensione tra Eliseo e Vaticano sulla vicenda dell’ambasciatore Laurent Stefanin, non ancora accreditato presso la Santa sede, probabilmente a causa del suo orientamento omosessuale. La Francia non ha intenzione di indietreggiare: "La Francia ha fatto la scelta di avere un ambasciatore presso il Vaticano e la scelta è caduta su Laurent Stefanini. Questa resta la posizione della Francia", ha detto Stéphane Le Foll, portavoce del governo.
Non è la prima volta che Francesco muove una critica del genere: già il mese scorso, in occasione della sua visita a Napoli, incontrando una coppia sposata da 31 anni, aveva definito la teoria del gender "quello sbaglio della mente umana che fa tanta confusione".
Sulle parole del Pontefice era tornato anche l cardinale Angelo Bagnasco, presidente dei vescovi italiani, nella prolusione al Consiglio permanente della Cei a fine marzo: "Il gender - aveva detto il presidente della Cei - si nasconde dietro a valori veri come parità, equità, autonomia, lotta al bullismo e alla violenza, promozione, non discriminazione ma, in realtà, pone la scure alla radice stessa dell’umano per edificare un transumano in cui l’uomo appare come un nomade privo di meta e a corto di identità".
* la Repubblica, 15 aprile 2015 (ripresa parziale).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- AMORE COLPEVOLE. Le due Sonate a Kreutzer della famiglia Tolstoj (di Sergio Romano)9 aprile 2015
Le due Sonate a Kreutzer
Della famiglia Tolstoj
risponde Sergio Romano (Corriere della Sera, 09.04.2015)
- Ho saputo che la moglie di Tolstoj scrisse un romanzo che oggi si potrebbe definire femminista, perché prende la difesa della donna contro l’idea che si faceva suo marito di lei (e di tutte le donne) come oggetto di soddisfazione del suo desiderio e basta. Tutto gira intorno alla Sonata a Kreutzer. Non è sorprendente che in questa epoca di rivalutazione delle figure femminili la moglie di Tolstoj non riceva il suo giusto plauso?
 Michele Montagna
Michele Montagna
Caro Montagna,
Sofia Tolstaja non fu soltanto la devota moglie del grande scrittore russo e la madre dei suoi tredici figli. Copiava e correggeva le opere del marito, teneva i rapporti con gli editori e i funzionari della censura, amministrava i suoi beni. Avrebbe fatto una brillante carriera letteraria se non avesse deciso di vivere nell’ombra di Lev limitandosi a due traduzioni dal tedesco e dall’inglese, a qualche poesia, alla occasionale pubblicazione di articoli su giornali e riviste.
Non è sorprendente, quindi, che questa donna sensibile e intelligente abbia letto con un certo smarrimento un romanzo breve che Tolstoj scrisse nel 1889. Nella Sonata a Kreutzer è raccontata la lunga conversazione di un uomo con il suo compagno di viaggio sul treno che attraversa da un paio di giorni le sterminate pianure russe. L’uomo (Pozdnyshev) prova l’irresistibile bisogno di confessare una pagina oscura e drammatica della sua vita. Aveva sposato la donna di cui era innamorato, una giovane pianista, ma non aveva mai cessato d’interrogarsi sulla sessualità maschile e femminile alternando propositi virtuosi a turbamenti carnali. Era convinto che ogni donna, nobile dama o prostituta, fosse dominata dal desiderio di sedurre e che tutte, quindi, fossero virtualmente impure.
Il dramma della gelosia esplose quando nella vita dei coniugi apparve un brillante violinista con cui la moglie amava esercitarsi al pianoforte. E si concluse drammaticamente quando il marito assistette a una esecuzione della Sonata a Kreutzer di Beethoven in cui il violino e il piano erano appassionatamente affiatati. Convinto di un adulterio che non era avvenuto, Pozdnyshev aveva ucciso rabbiosamente la moglie con un colpo di pugnale. Durante il suo lungo viaggio attraverso la Russia, il marito si dimostra consapevole della propria colpa, ma il racconto sembra suggerire che il potere seduttivo della donna possa giustificare la gelosia maschile.
È probabile che Sofia Tolstaja abbia visto nel romanzo alcuni tratti del carattere e della natura del marito. La Sonata a Kreutzer non era soltanto un’opera della fantasia. Era anche la confessione dell’autore, la rivelazione della sua latente misoginia e delle sue ossessioni sessuali. La risposta, quindi, doveva essere letteraria. Qualche anno dopo la pubblicazione del breve romanzo del marito, Sofia scrisse una «contro-Sonata a Kreutzer» in cui Anna, una giovane donna sensibile, attratta dall’arte e dalla natura, sposa un uomo dominato da una sessualità prorompente e da una incontrollabile gelosia. Come nella Sonata, anche nella «contro-Sonata» il marito, convinto dell’infedeltà della giovane moglie, la uccide. Ma la mano che guida il lettore attraverso questo secondo dramma della gelosia è quella di una donna che si riconosce nei sentimenti della protagonista. E il risultato è una versione rovesciata del racconto di Tolstoj.
Il manoscritto di Sofia Tolstaja, intitolato Di chi la colpa? A proposito della Sonata a Kreutzer di Lev Tolstoj, è rimasto lungamente inedito. Ne esiste ora la traduzione italiana di Nadia Cicognini pubblicata da La Tartaruga Edizioni con il titolo Amore colpevole.
- Ho saputo che la moglie di Tolstoj scrisse un romanzo che oggi si potrebbe definire femminista, perché prende la difesa della donna contro l’idea che si faceva suo marito di lei (e di tutte le donne) come oggetto di soddisfazione del suo desiderio e basta. Tutto gira intorno alla Sonata a Kreutzer. Non è sorprendente che in questa epoca di rivalutazione delle figure femminili la moglie di Tolstoj non riceva il suo giusto plauso?
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- Responsabilità. Oggi nessuno vuole più rispondere di nulla ma chi scarica sugli altri ogni fardello nei fatti si dichiara sostituibile e superfluo (di Donatella Di Cesare)6 aprile 2015, di Federico La Sala
Responsabilità
Oggi nessuno vuole più rispondere di nulla ma chi scarica sugli altri ogni fardello nei fatti si dichiara sostituibile e superfluo
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 05.04.2015)
«Non ne rispondo io - mi spiace». «Che si assuma la responsabilità chi di dovere!». «Sarà il caso di passare la palla ad altri». Quante volte al giorno capita di ascoltare frasi del genere? O persino di pronunciarle? Sfuggire alla responsabilità è una prassi diffusa nella vita privata come nella sfera pubblica. Dai piccoli gesti della quotidianità ai rapporti affettivi, dai legami sociali all’agire politico: non c’è ambito che non sia pervaso da una rinuncia sistematica alle risposte che ciascuno è chiamato a dare. E la rinuncia finisce per volgersi in vera abdicazione là dove le responsabilità aumentano.
Gli esempi sono molteplici: l’insegnante acquiescente che chiude gli occhi sulla prepotente bullaggine dell’allievo; il giornalista che sceglie sbrigativamente la parola più comoda o passa sotto silenzio quel che dovrebbe dire a gran voce; il magistrato che strizza l’occhio agli imputati, proscioglie quando dovrebbe condannare, allunga i tempi del processo fino alla prescrizione; il medico che tratta il paziente come un corpo malato, tra disattenzione e volontà di lucro; il politico che, mentre dovrebbe sollevare lo sguardo verso il bene comune, è chino sul proprio tornaconto.
La rinuncia ad assumere le proprie responsabilità erode ogni relazione, corrode la comunità. La corruzione nasce da qui. È un fenomeno etico, prima ancora che politico. Questo non vuol dire né diluirne la portata né ampliarne pericolosamente i confini. Ma non sarà mai possibile vederne con chiarezza gli effetti devastanti, se non si risale a quel luogo in cui la corruzione affiora. Ed è là dove il legame con l’altro si deteriora, dove chi dovrebbe rispondere preferisce sottrarsi. L’io si deresponsabilizza. Chiamato in causa, non si assume l’onere della decisione, e aggira l’impegno, evade l’obbligo che lo lega agli altri.
Così apre una falla, una incrinatura. E mentre una crepa si aggiunge alla precedente, la comunità, inevitabilmente, si sgretola. La corruzione non sta solo nelle mazzette - simbolo del disfacimento che prevale, dell’integrità che viene meno. Una comunità corrotta è quella i cui membri non rispondono di sé e non rispondono agli altri.
La leggerezza inebriante di cui si compiace l’io deresponsabilizzato è a ben guardare una trappola. Chi ha eluso il fardello della responsabilità, crede di averla fatta franca. Si prepara a schivare così tutti i fardelli a cui andrà incontro. L’onore senza l’onere diventa il suo stile di vita. Ma ogni volta che l’io abdica, che lascia agli altri la responsabilità a cui era stato chiamato, crede, e fa credere, di essere sostituibile. «Perché mai dovrei risponderne proprio io? Che se la veda qualcun altro!». Può darsi che il «qualcun altro» che viene dopo si comporti in modo analogo - in un continuo rinvio, un incessante riversarsi a vicenda pesi e obblighi.
Eppure nessuno è sostituibile. La responsabilità che incombe su di me, in questo momento, non può essere ceduta. Se la cedo, non solo apro una falla, ma accetto l’idea che qualcuno potrebbe rimpiazzarmi. Mentre nessuno, mai, può farlo. L’io deresponsabilizzato ammette invece di essere sostituibile, avvalora la sconcertante ipotesi della propria superfluità. Si crede in genere che la responsabilità sia un gesto ulteriore di un soggetto autonomo e sovrano.
Nella sua superba priorità questo soggetto, privo di vincoli, detterebbe legge a se stesso. Ma che cosa sarebbe l’io senza l’altro che sempre lo precede? Il mondo non è cominciato con me. Prima di me c’è sempre l’altro che mi convoca, mi interroga, e a cui sono chiamato a rispondere. Non per un atto di adesione volontaria - valutando se dire sì o no. Ma semplicemente volgendomi verso chi mi chiama. Prima ancora di ogni possibilità di scelta, perché è nella torsione verso l’altro che l’io si costituisce. Rispondo, dunque sono.
Senza la responsabilità, l’io non esisterebbe neppure. La mia esistenza si coagula ogni volta nell’obbligo che mi vincola all’altro. Se eludo l’obbligo, gli effetti ricadono sul mio stesso esistere. La leggerezza inebriante si rivela inconsistenza angosciosa. E quel detestabile io, che pretendeva di essere soggetto assoluto, rischia di restare tragicamente intrappolato nella sua errata idea di libertà astratta, senza più via d’uscita.
I filosofi non hanno mai parlato tanto di «responsabilità» come in questi ultimi decenni. Con Emmanuel Lévinas e con Hans Jonas la responsabilità è diventata, anzi, uno dei temi più discussi nel dibattito contemporaneo. Il che non sorprende. Perché viviamo nell’epoca di una crescente deresponsabilizzazione.
La complessità del mondo globale, la rilevanza assunta dalla scienza che, malgrado i progressi compiuti, appare sempre più incapace di offrire un orientamento e dar conto delle sue stesse scelte, la specializzazione estrema e il connesso ruolo dell’«esperto», al quale viene spesso lasciata la parola ultima, la frantumazione della responsabilità, che impedisce di scorgere le ripercussioni dei propri gesti: tutto ciò ha contribuito a privare i più della possibilità di decidere e di agire. È la razionalizzazione tecnica della vita a influire, però, in modo determinante.
Dove trionfa la tecnica viene meno la responsabilità. Non solo perché l’essere umano è diventato «antiquato» rispetto ai suoi stessi prodotti, costretto - come ha sostenuto Günther Anders - a rincorrerli disperatamente, nel tentativo vano di sincronizzarsi alla loro disumana rapidità. Ma anche perché l’ingranaggio della tecnica stravolge il rapporto tra mezzi e fini, nel senso che potenzia i mezzi e fa perdere di vista i fini, sia quelli individuali, sia quelli comuni, che rendono coesa una comunità. Si è in grado di fare molte più cose, ma non si sa bene a che scopo.
Così, mentre si moltiplicano le etiche applicate, dalla bioetica all’«etica degli affari», volte non di rado a rassicurare l’opinione pubblica sulla moralità di un settore, ad esempio quello delle imprese, mentre dunque l’etica può diventare a sua volta fonte di profitto, la «responsabilità» resta la terra incognita di questa tarda modernità, la stessa che abita un pianeta devastato, dove nulla sembra ci sia ancora da scoprire.
La responsabilità è infatti rispetto sia per gli altri, sia per quell’altro che sono le cose del mondo. Da quando gli esseri umani sono diventati più pericolosi per la natura, di quanto la natura fosse per loro, si rende necessaria un’etica che risponda all’esigenza di lasciare alle generazioni future un pianeta ancora vivibile.
Sono responsabile non solo verso l’altro che sempre mi precede, ma anche verso l’altro che viene dopo di me. E guardando al suo futuro non dovrei allora mai mancare di chiedermi se anche il più piccolo dei miei gesti non avrà ricadute su di lui. Proprio quello che non mi riguarda richiede la mia attenzione. Solo io sono responsabile - sta qui la suprema dignità umana.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" ---- Perché ha ancora senso dirsi ‘femministe’ (di Lea Melandri)3 aprile 2015
Ha ancora senso dirsi ‘femministe’
di Lea Melandri*
Perché ha ancora senso dirsi ‘femministe’
► Perché il salto della coscienza storica prodotto dal femminismo non si esaurisce con una generazione. Tutti sappiamo cosa vuol dire essere maschi o femmine, ma è come se ognuno/a singolarmente dovesse scoprirlo, partendo da una domanda che nasce dentro di sé, per rendersi conto che i ruoli e le identità di genere, il rapporto di potere tra i sessi, non appartengono alle leggi immutabili della natura, ma alla storia, alla cultura, alla politica, e come tali possono essere modificate.
► Perché il femminismo non è un’ideologia, legata a una fase storica particolare, ma un cambiamento nella consapevolezza che si ha di sé e del mondo, un modo diverso di pensare e agire nella vita privata e pubblica, un processo di liberazione da pregiudizi, schemi mentali, costruzioni immaginarie che abbiamo inconsapevolmente ereditato dalla cultura dominante.
► Perché è stato il primo e finora l’unico movimento di donne che ha mostrato l’inganno del dilemma, proprio dell’emancipazionismo, “uguaglianza/differenza”: omologazione al maschile o tutela/valorizzazione della differenza femminile, un dualismo conseguente alla divisione sessuale del lavoro, all’identificazione della donna con la madre e con gli interessi della famiglia. Da qui viene l’attualità del femminismo in quanto interprete dei cambiamenti a cui stiamo assistendo: presenza sempre più incisiva e critica delle donne nella sfera pubblica; la cura vista come responsabilità collettiva di donne e uomini; riscoperta del tempo di vita come valore rispetto alle logiche produttive e di mercato.
► Perché ha portato la riflessione e la presa di coscienza sul corpo, sulla sessualità, sulla violenza che si annida nei rapporti più intimi, sulla maternità, cioè sulle esperienze che, lasciate per secoli fuori dalla storia, conservano più a lungo l’eredità del passato.
► Perché ha legittimato le donne a ‘vivere per sé’, a riconoscersi come persone, individui e non solo ruoli funzionali al benessere di altri.
► Perché ha fatto scoprire che era possibile una socialità tra donne non segnata dallo sguardo maschile che le ha tenute per secoli divise -madri di, mogli di, figlie di-, un’amicizia produttrice di intelligenza e creatività individuale e collettiva.
► Perché nonostante sia stato osteggiato, messo sotto silenzio, temuto e fatto oggetto di scherno, ha mantenuto la sua forza, la capacità di produrre pensiero, iniziativa, conflitti, di alimentare passioni durature, che ricompaiono di generazione in generazione.
► Perché dopo mezzo secolo, la generazione che vi ha dato avvio negli anni ’70, si è sentita dire, al convegno di Paestum (ottobre 2012) dalle donne venute dopo, alcune delle quali molto più giovani: “siamo coetanee”, “se siamo qui con voi è perché ci avete trasmesso molto”.
* Dopo aver insegnato alle scuole medie e alle superiori, da più di vent’anni tiene corsi presso l’Associazione per una Libera Università delle Donne di Milano, di cui è tra le fondatrici. Saggista, scrittrice e giornalista, Lea Melandri ha diretto per molti anni la rivista “L’erba voglio” ed è un punto di riferimento del movimento delle donne. Ha scritto diversi libri, l’ultimo è “Amore e violenza.Il fattore molesto della civiltà” (Bollati Boringhieri 2011).
* FONTE. COMUNE-INFO: L’articolo di questa pagina è apparso sulla pagina fb dell’autrice. La pubblicazione in questo sito è stata autorizzata da Lea Melandri, che scrive: “Comune mi piace”. (1 aprile 2015).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’amore nei millenni è stato sempre sacrificato al princìpio di autorità. Un manifesto/testimonianza di Alberto Melloni (di Silvana Seidel Menchi).30 marzo 2015, di Federico La Sala
La verità vi prego sul matrimonio
L’amore, ispiratore naturale di ogni unione autentica, nei millenni è stato sempre sacrificato al princìpio di autorità
di Silvana Seidel Menchi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 29.03.2015
Un autore che utilizza la parola “appuntini” nel titolo del suo libro deve essere molto sicuro del fatto suo. Alberto Melloni in Amore senza fine, amore senza fini. Appuntini di storia su chiese, matrimoni e famiglie ( Il Mulino, Bologna, pagg. 142, € 12) ha da dire cose importanti e lo sa. Il tema di Melloni è il matrimonio in quanto amore. Questo tema occhieggia dietro un ventaglio di argomenti che sono attualmente tra i più dibattuti nella società civile italiana - nozze omosessuali, regolazione pattizia della convivenza (già “concubinato”), ammissione alla comunione ecclesiale dei divorziati risposati, femminicidio come frutto del sessismo.
Il saggio tematizza anche gli scontri che stanno a monte di questi dilemmi attuali e che continuano a condizionarli - cioè l’alternativa tra matrimonio religioso e matrimonio civile, le battaglie per il divorzio, per l’interruzione volontaria della gravidanza, per la contraccezione ormonale, contro l’accanimento medicale. Dietro a queste questioni che hanno dominato in passato o dominano oggi il nostro orizzonte quotidiano, riemerge sempre di nuovo il problema cruciale di questo saggio, nel quale tutte le sue molteplici componenti convergono e trovano una loro unità, anzi si potenziano reciprocamente: il matrimonio inteso nella sua accezione più forte e dirompente, cioè in quanto «legame più irresistibile e più fragile che la vita regali». Proprio come preannuncia il titolo.
La storia del matrimonio che l’autore ricostruisce partendo da Adamo ed Eva, toccando (fugacemente) il matrimonio nel diritto romano, fermandosi in modo più analitico sul matrimonio medievale di puro consenso, delineando incisivamente le caratteristiche del matrimonio tridentino, del matrimonio civile sancito dal codice napoleonico e dai codici che a esso si sono improntati, fino al matrimonio come contratto tutelato dagli stati moderni, appare caratterizzata da una continuità millenaria, nella quale lo sguardo severo di questo autore non coglie incrinature sostanziali.
Il matrimonio codifica oggi come sempre ha codificato il «principio di autorità» che regola l’intera società, sancisce anzi «santifica» l’inferiorità femminile, scinde tendenzialmente il coniugio dall’amore, subordina il dono coniugale alla costruzione della famiglia e aggrava la famiglia stessa - la sede di quei «dolori e gioie semplici di cui l’affetto custodisce il senso» - di un compito straniante e deviante, cioè costituire «la cellula della società».
Quale prova più lampante di questa formula - coniata da Jean Bodin al declino del secolo XVI, rilanciata dai giuristi gallicani al servizio della corona di Francia nel secolo XVII, adottata pari pari da Pio XII nel secolo XX -, quale argomento più stringente per provare la perfetta osmosi tra cultura cristiana e cultura secolare, tra matrimonio come sacramento e matrimonio come contratto, ovverosia «l’interscambio tra il matrimonio religioso del regime di cristianità e matrimonio civile del regime di modernità»?
Questa santa alleanza - suggerisce l’autore - celebra i suoi trionfi a spese dell’essere umano individuo, del suo senso della vita, della sua aspirazione alla felicità: a spese di quell’amore, insomma, che non è etero o omo, non divino o umano, non spirituale o carnale, perché «l’amore è uno».
Quello che in particolare suscita lo sdegno lucido dell’autore è il concetto de «i fini propri del coniugio». Tali fini (denunciati fin dal titolo) sarebbero, auspice Agostino, il porre rimedio alla concupiscenza e il mettere al mondo dei figli. Questa dottrina, sancita da una catechesi secolare, ispira all’autore formulazioni che tagliano come lame: perché il matrimonio inteso come atto d’amore, come osare di «mettere la [propria] vita nelle mani di un altro o di un’altra» non ha altro fine che sé stesso, né altra logica che la sua difficile, fragile, dolorosa logica interna. Saldandosi con la visione della famiglia come «cellula della società», la teoria dei «fini» subordina la sussistenza del matrimonio alla procreazione, o alla volontà della procreazione, risolvendo e dissolvendo il dialogo d’amore tra due esseri umani, tra due persone, in una istituzione, in una piccola collettività, in una proiezione fuori del sé.
La ribellione dell’autore contro questo straniamento dell’amore a sé stesso si esprime in una tendenziale scissione, a livello linguistico, tra «matrimonio» e «famiglia», una scissione che si esprime nel fatto che la «famiglia», quando è intesa come «fine», e quindi non coincidente con l’amore, è collocata tra virgolette in tutto il corso del saggio. L’amore può, sì, espandersi e fiorire in una famiglia, ma questo fiorire deve essere libero, non imposto, non costrittivo, non punitivo.
Nel tentativo di orientarmi, come storica del matrimonio, nei tornanti di questa prosa di grande vigore e densità, che impone una lettura lenta - in quanto osa mettere in discussione tutta la pastorale cattolica degli ultimi cinque secoli in materia coniugale - confesso di essermi messa alla ricerca di una professione di fede: che cosa vuole Alberto Melloni? E credo di averla trovata, questa professione di fede, nell’epilogo. E poiché essa mi ha scosso, non posso fare a meno di riprodurla qui, come condensato di un percorso di coscienza e autocoscienza che mi appare di folgorante lucidità e intensa sofferenza: -«Alla fine del Vaticano II monsignor Helder Camara immaginò un finale spettacolare per il Concilio del XXI secolo. Il papa da solo usciva da san Pietro e domandava perdono dell’autoritarismo ai vescovi, che lo perdonavano e si univano a lui; procedevano ora insieme, papa e vescovi, a chiedere perdono ai laici. Stessa scena. Poi i cattolici chiedevano perdono agli altri cristiani, e questi insieme agli ebrei e poi ai credenti delle religioni; e poi tutti alle donne per un soggiogamento blasfemo e durato dalla notte dei tempi».
A questa schiera di esseri umani ai quali la Chiesa Cattolica in capite et in membris potrebbe, dovrebbe, ora chiedere perdono Alberto Melloni propone di aggiungere - questa è una mia ipotesi - la fiumana di coloro ai quali il diritto canonico e una catechesi estraniatasi dal Vangelo hanno reso difficile l’esercizio dell’amore, di quell’amore che non si identifica sempre con la charitas, di quell’amore che è anche - non solo - eros.
Un manifesto/testimonianza come quello che Alberto Melloni ha dato alle stampe ha due coordinate. Una di esse è il pontificato di Jorge Mario Bergoglio, la brezza che spazza via l’aria ristagnante (da secoli?) nei recessi direttivi della Chiesa Cattolica; la seconda è il Vangelo, e in particolare il messaggio di Cristo (per Melloni: Gesù), che va dissepolto, specialmente in un Paese come il nostro, del tutto privo di cultura biblica. «La lingua del perdono e della misericordia e la forza che gli deriva dall’essere il linguaggio del Vangelo e di Gesù» devono essere riscoperte.
Il manifesto/testimonianza di Alberto Melloni, sprigionatosi dalla sua lotta corpo a corpo con la Chiesa in cui vive e di cui vive, e anche con la società in cui vive, nasce al punto di intersezione di queste due coordinate. Mi auguro che questo libro, ingannevolmente snello, arrivi nelle mani di Jorge Mario Bergoglio. E posso immaginare che esso sia destinato a essere ristampato, un giorno, con un apparato di note cinque volte più ampio dell’attuale.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- 8 marzo. Celebrare così un genere significa chiudere una gabbia (di Barbara Spinelli).7 marzo 2015, di Federico La Sala
8 marzo
Celebrare così un genere significa chiudere una gabbia
di Barbara Spinelli (il Fatto, 07.03.2015)
È LA PRIMA VOLTA che scrivo sulla festa delle donne, e probabilmente l’ultima. Non mi piacciono le feste “di genere”, come non mi piacerebbero giorni dedicati a una razza. Penso che ogni essere umano abbia più radici, più essenze e propensioni: naturali o non naturali. Non mi piace essere definita, e appena qualcuno lo fa cerco di dirgli che in quella definizione non mi riconosco, se non parzialmente. Ogni definizione la considero una gabbia, anche se distinguere è necessario sempre . Ogni festa in onore di tale definizione ha il potere, temibile, di confermare ed esaltare la gabbia, dunque una sorta di surrettizia intoccabilità e separatezza.
Non mi piacerebbe neppure una festa dell’essere umano, e non ho mai capito l’usanza di alzarsi un piedi, quando nella liturgia cristiana si ricorda la Creazione e si evoca il giorno in cui Dio creò l’uomo. Mi sembra un giorno infausto: bisognerebbe sprofondare, piuttosto che di ergersi trionfalmente.
Infine: m’infastidisce l’abitudine, apparsa in Germania negli anni 70 e oggi diffusa in Italia, di storpiare la scrittura con il ricorso al maschile-femminile: compagni(e), amici/amiche, cari/care. Aspetto con timore il momento in cui scriveremo, perché imposto dall’etichetta femminista: Dio/Dea.
Avrete capito che guardo al femminismo con un certo distacco prudenziale. Come Doris Lessing, sono convinta che il femminismo ha fatto molte nobili battaglie (e ancora molte avrà da farne), ma ha causato non pochi danni, e durevoli, nel rapporto fra uomini e donne.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- Legami d’amore. Una lucida analisi di Jessica Benjamin spiega perché i legami affettivi si trasformano spesso in dolorosi rapporti di potere (di Vittorio Lingiardi)23 febbraio 2015, di Federico La Sala
Psicoanalisi e femminismo
Madre, soggetto d’amore
Una lucida analisi di Jessica Benjamin spiega perché i legami affettivi si trasformano spesso in dolorosi rapporti di potere
di Vittorio Lingiardi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 22.02.2015)
- Jessica Benjamin, Legami d’amore, traduzione di Anna Nadotti, Raffaello Cortina, Milano, pagg. 220, € 24,00
La riflessione freudiana sull’autorità «ha luogo in un mondo esclusivamente maschile. La lotta per il potere si svolge tra padre e figlio; la donna non vi ha parte alcuna, se non come ricompensa o perché induce alla regressione, oppure come terzo vertice di un triangolo. Non c’è lotta tra uomo e donna in questa storia; anzi, la subordinazione della donna all’uomo è data per scontata, invisibile». Ma la teoria femminista «non può accontentarsi di conquistare per le donne il territorio degli uomini».
Il femminismo, quando incontra la psicoanalisi, ha un compito più complesso: trascendere la contrapposizione. Perché questo avvenga è però necessario che la psicoanalisi rinunci a quelle certezze che, con mano maschile, ha scritto sul corpo delle donne. Rinunci alla polarizzazione di genere, «origine profonda del disagio della nostra civiltà». Apra la gabbia teorico-evolutiva della «scissione tra un padre simbolo di liberazione e una madre simbolo di dipendenza», perché per i bambini di entrambi i sessi tale scissione significa che «l’identificazione e l’intimità con la madre devono essere barattate con l’indipendenza» (e dunque «diventare soggetto di desiderio comporta il rifiuto del ruolo materno», se non della stessa identità femminile). Impari a pensare alla madre «come soggetto a pieno diritto» e non «semplice prolungamento di un bambino di due mesi».
La vera madre non è semplicemente oggetto delle richieste del suo bambino, ma «è un altro soggetto il cui centro indipendente deve restare al di fuori del bambino se dovrà sapergli concedere il riconoscimento che cerca». Solo se la madre diventa soggetto, e non solo oggetto d’amore del bambino, prenderà vita quel reciproco riconoscersi che per tutta la vita nutrirà le relazioni d’amore.
È il 1988 e così scriveva Jessica Benjamin in Legami d’amore, il saggio psicoanalitico e femminista sui rapporti di potere nelle relazioni amorose che la rese famosa nel mondo. Tradotto a regola d’arte da Anna Nadotti per Rosenberg & Sellier, ma da tempo introvabile, il volume viene oggi riproposto da Raffaello Cortina, a conferma dell’interesse della sua casa editrice per un pensiero psicoanalitico d’eccellenza. La nuova edizione, un rosso cuore annodato in copertina, comprende una riflessione dell’autrice sull’attualità del suo saggio, e un testo introduttivo («Vivi in presenza di un altro uguale») a cura di chi scrive e di Nicola Carone.
«Come se avessimo bisogno di una qualche prova della persistenza del patriarcato - scrive Benjamin 25 anni dopo, cioè oggi - la passività e la sottomissione non hanno abbandonato il discorso del femminile». Ma anziché indagare il tema del sadomasochismo dal punto di vista dell’«indignazione morale», lo considera da quello della psicoanalisi e delle cicatrici psichiche prodotte dai percorsi obbligati del binarismo di genere. «In che modo il dominio è radicato nei cuori di coloro che vi si sottomettono?».
Perché Cinquanta sfumature di grigio è diventato un bestseller per giovani madri e per donne manager? Le prime risposte di Benjamin (una delle quali è «perché queste donne vogliono arrendersi al controllo, vogliono perdersi») risalgono al 1967, quando Histoire d’O, letto dal mio gruppo poco dopo de Beauvoir, mi ha consentito di capire le molte permutazioni del desiderio che avrebbero trovato espressione culturale anni più tardi».
Domande solo apparentemente pop che trovano risposte complesse nell’analisi della dinamica servo-padrone di hegeliana memoria, o nel concetto di «complementarità scissa», cioè un sistema dinamico in cui ciascuna incarnazione del partner (sadico, masochista; colui che agisce, colui che viene agito) «dipende dall’altro». Un’idea che diventerà centrale per la comprensione delle impasse cliniche, ma anche delle relazioni tra carnefice e vittima e di quelle «relazioni simmetriche nelle quali ciascuna persona si sente di subire, ciascuna persona sente di aver ragione, ciascuno ha paura di essere incolpato».
Non stupisce che oggi Benjamin si stia dedicando al progetto politico-psicoanalitico di declinare la sua teoria del riconoscimento in una teoria della testimonianza. In The Discarded and the Dignified, ultimo scritto non ancora pubblicato, racconta la sua collaborazione, da cinque anni a questa parte, con il Community Mental Health Programme di Gaza. La scommessa è quella di costruire un dialogo con i professionisti della salute mentale israeliani e palestinesi. Di fronte ai traumi, dice, spesso reagiamo appellandoci al senso di «ciò che è giusto o sbagliato» e perdiamo la possibilità di avvicinarci in maniera autentica all’esperienza di chi soffre.
Essere testimoni e non spettatori indignati rientra invece in un più ampio processo di umanizzazione di vittime e carnefici, in cui le prime non aspirino a una qualche fantasia di vendetta o, al contrario, di rassegnazione malinconica per rimediare alla perdita di persone care o alla violazione di parti di sé e le seconde prendano contatto con parti dolorose di sé dissociate. Nato per fare luce sul perché spesso preferiamo «il dolore che accompagna la sottomissione» al «dolore che accompagna la libertà», Legami d’amore ha nei fatti inaugurato il progetto di una psicoanalisi relazionale e intersoggettiva.
Il motivo per cui sono diventata psicoanalista, dice Benjamin, è stato «la ricerca di una guarigione e di un’integrazione personale». Come intellettuale, genitore, clinica, attivista politica, aggiunge, «cercherò di essere più integrata e di fare in modo che ciò che dico vada insieme a ciò che faccio per tutte quelle parti che non riguardano solo la mia guarigione personale, ma si estendono anche al lavoro e allo stare con gli altri». Creatura di confine, spigolosa e sincera, Benjamin riesce a far dialogare posizioni diverse e spesso in conflitto. «Per quanto mi riguarda - dice - sono arrivata alla convinzione che l’esperienza di essere spinta in più di una direzione nello stesso momento è una cosa fondamentale per la mia vita psichica».
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- MA QUALE "PUGNO"?! Basta con la connivenza all’ordine simbolico della madre!!!19 gennaio 2015, di Federico La Sala
MA QUALE "PUGNO"?! Basta con la connivenza all’ordine simbolico della Madre!!!
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano
CRISI POLITICA E SACRA FAMIGLIA!!! NON SOLO LA TEOLOGIA (E LA FILOSOFIA), MA NEMMENO LA SOCIOLOGIA SA DISTINGUERE TRA FAMIGLIA DEMOCRATICA E FAMIGLIA DI "MAMMASANTISSIMA" E DI "MAMMONA"...
 "FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE:
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE:UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DEL FIGLIO CON LA MADRE, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA-POLITICA EUROPEA
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA-POLITICA EUROPEA -
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Femminicidio: la Regione Puglia parte civile in un processo (di Nadia Somma, Presidente Centro antiviolenza Demetra)20 gennaio 2015, di Federico La Sala
Donne di Fatto
Femminicidio: la Regione Puglia parte civile in un processo
di Nadia Somma, Presidente Centro antiviolenza Demetra *
La Regione Puglia per la prima volta si è costituita parte civile in un procedimento penale per femminicidio insieme al centro antiviolenza Safiya di Polignano a Mare e all’associazione Giraffa. Lo scorso novembre è cominciato il processo ad Antonio Colamonico accusato dell’uccisione di Bruna Bovino avvenuta il 12 dicembre 2013 in piccolo centro estetico a Mola di Bari. Ripetendo un copione purtroppo visto molte volte, una parte della stampa aveva offuscato il ricordo della vittima rispecchiando i pregiudizi culturali che nella società italiana come nelle altre, rimuovono la violenza di genere e colpevolizzano le vittime.
Grazie alla costituzione di parte civile della Regione Puglia e delle associazioni Safiya e Giraffa la realtà delle radici culturali della violenza di genere sarà affermata in maniera ancora più forte in un aula di tribunale e potrà sensibilizzare l’opinione pubblica e cambiarne la percezione nei confronti di questo crimine.
Trent’anni di impegno delle associazioni di donne sul tema della violenza di genere hanno dato risultati. Oggi la costituzione di parte civile da parte della Regione Puglia è prevista in un articolo della legge regionale contro la violenza di genere varata l’estate del 2014.
Il 13 gennaio scorso la Corte D’Assise ha accolto le richieste della Regione e delle due associazioni nonostante le opposizioni dei legali dell’imputato che non ritenevano femminicidio la morte di Bruna perché non era stato conseguenza di un’aggressione sessuale e perché sarebbe stato discriminatorio nei confronti degli uomini o di qualunque altro omicidio. Il pubblico ministero invece si era opposto solo alle richieste delle associazioni Safiya e Giraffa perché i loro interessi sarebbero stati tutelati dalla Regione.
Ma le motivazioni di Barbara Spinelli, avvocata del Foro di Bologna che tutela gli interessi del Centro Antiviolenza Safiya, hanno convinto i giudici. La legale ha spiegato che
 nel nostro ordinamento anche reati “neutri” come l’omicidio e le lesioni possono essere considerati forme di violenza sulle donne proprio perché inclusi nella definizione adottata dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013 e l’Associazione Safiya è portatrice di un danno diretto derivante dal femminicidio di Bruna Bovino perché oltre alla lesione del diritto alla vita della donna a cui è stata usata violenza diretta ad ucciderla, il femminicidio costituisce una profonda ferita per la società tutta.
nel nostro ordinamento anche reati “neutri” come l’omicidio e le lesioni possono essere considerati forme di violenza sulle donne proprio perché inclusi nella definizione adottata dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013 e l’Associazione Safiya è portatrice di un danno diretto derivante dal femminicidio di Bruna Bovino perché oltre alla lesione del diritto alla vita della donna a cui è stata usata violenza diretta ad ucciderla, il femminicidio costituisce una profonda ferita per la società tutta.
 Nel momento in cui a una donna, nell’ambito di una relazione sentimentale, non viene riconosciuta la dignità di persona, ed in quanto tale viene fatta oggetto di violenza, fino alla morte, ricercando poi l’impunità per il delitto commesso, l’intera collettività è responsabile per l’eliminazione di quella cultura e di concezione distorta delle relazioni che ancora oggi minano l’autodeterminazione, la libertà e finanche la vita delle donne.
Nel momento in cui a una donna, nell’ambito di una relazione sentimentale, non viene riconosciuta la dignità di persona, ed in quanto tale viene fatta oggetto di violenza, fino alla morte, ricercando poi l’impunità per il delitto commesso, l’intera collettività è responsabile per l’eliminazione di quella cultura e di concezione distorta delle relazioni che ancora oggi minano l’autodeterminazione, la libertà e finanche la vita delle donne.Safiya sta aiutando anche le famigliari di Bruna Bovino e sta sostenendo le spese legali e per questo ha chiesto la solidarietà delle cittadine e dei cittadini di Polignano a Mare, delle Istituzioni, dei Centri Antiviolenza della rete regionale e nazionale, delle associazioni di donne, di tutte e tutti coloro che vogliono sostenere la battaglia contro il femminicidio, perché venga ribadito il diritto alla libertà delle donne e si spazzi via l’arcaica convinzione che sia giustificabile l’uccisione di una donna che rivendica le sue scelte o che entra in conflitto con un uomo o con gli schemi imposti dalla società.
-
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Il Discorso del Coniglio, il Discorso del Calcio Dove Non Batte Il Sole (di M. Gramellini - Papà Coniglio)20 gennaio 2015, di Federico La Sala
Papà Coniglio
di Massimo Gramellini (La Stampa, 20.01.2015)
Crescete e moltiplicatevi ma senza esagerare, è la lieta novella annunciata ieri dal Papa Pop. I buoni cattolici, dice Francesco, non devono comportarsi come conigli. E due millenni di storia ecclesiastica e di lenzuola ricamate «non lo fo per piacer mio, ma per dare figli a Dio» sembrerebbero finire in naftalina. Perché il corollario logico del Discorso Del Coniglio non può che essere il riconoscimento del ruolo anticonigliesco della contraccezione.
In attesa messianica di un Discorso del Preservativo, dalle prossime performance del Papa Pop si attendono delucidazioni su altri metodi più invasivi, ma meno compromettenti sul piano dell’etica cattolica. La doccia ghiacciata perenne, la tv accesa su una partita di Champions, l’armadio appoggiato alla porta della camera da letto per impedire al partner di entrare.
Il Discorso del Coniglio segue di pochi giorni il Discorso del Pugno (a chi insulta la mamma) e ha preceduto di pochi minuti il Discorso del Calcio Dove Non Batte Il Sole, che secondo questo Papa Don Camillo andrebbe rifilato ai corrotti.
Anch’io, come tutti, vado letteralmente pazzo per il linguaggio disinibito del Pontefice che viene «quasi dalla fine del mondo» e in effetti dice cose quasi dell’altro mondo. E non sarà certo un umile peccatore, e scribacchino per giunta, a fare la predica a un Papa.
Da laico affettuoso mi permetto soltanto di chiedergli se non pensa che alla lunga questo suo parlare semplice e pieno di buon senso, mai seguito però da fatti concreti, non rischi di togliergli autorevolezza e credibilità. Facendolo assomigliare, più che a un vecchio prete argentino, a un giovane premier toscano.
-
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Ai poeti ‘lunatici’ e ai filosofi ‘solari’: "l’abitudine non può rendere insipida la varietà infinita della bellezza" - prodotta dalla luce.10 gennaio 2015ONU: 2015, ANNO DELLA LUCE. Ai poeti ‘lunatici’ e ai filosofi ‘solari’: "l’abitudine non può rendere insipida la varietà infinita della bellezza" - prodotta dalla luce
 LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA ---- "Filosofia della sensibilità. Per un’estetica come pensiero mitologico" di Susanna Mati (rec. di Francesco Roat)7 gennaio 2015, di Federico La Sala
"Filosofia della sensibilità. Per un’estetica come pensiero mitologico" di Susanna Mati
di Francesco Roat *
La riflessione che Susanna Mati compie attraverso il suo ultimo saggio − Filosofia della sensibilità. Per un’estetica come pensiero mitologico (Moretti&Vitali) - parte da un’urgenza a suo avviso ineludibile: accogliere nel discorso filosofico quelle istanze che, essendo espressione di una modalità altra rispetto a quella del logos (della parola declinabile all’insegna univoca della razionalità), sono considerate proprie del mythos, ma che non sono necessariamente/meramente irrazionali, bensì semmai “richiedono di essere pensate” mediante un approccio discorsivo aperto alla “plurivocità della parola”. L’autrice è però ben consapevole di quanto oggi possa apparire a molti contraddittorio e alla fin fine impensabile un pensiero davvero mito-logico, che sappia cioè coniugare filosofia e mito, considerati modalità antitetiche e inconci-liabili. Ma, si/ci domanda la Mati, perché non ipotizzare la possibilità di “dire qualcosa di altamente significante, di umanamente essenziale” nonostante contradditorietà e paradossi?
Ovvio che una nuova discorsività mitologica non sarà più quella articolata un tempo dagli antichi, non potendo più essere teogonica (creatrice di dèi); ma poiché il linguaggio del mito fa riferimento a tutto quanto la ratio/filosofia declinabile tradizionalmente al maschile ha tralasciato di occuparsi (la sfera del pathos: della passione, della sensibilità, dell’intuizione), esso si potrà articolare come un’estetica - chiamiamola pure d’impronta femminile − libera di esprimersi tramite una parola immaginativa proprio perché indeterminata, metamorfica e polisemica. Di contro alla parola speculativa/asseverativa appartenente alla filosofia occidentale che, nata con Platone - il quale coniò/utilizzò per primo tale termine -, volle essere affatto altra da quella del mythos, considerato retaggio arcaico da superare/rifuggire.
Così, sottolinea la Mati, a partire da Platone la filosofia tende a guardare con sospetto l’arte e la poíesis poetica giacché esse rimandano a “pathos, aísthesis, singolarità, individualità”: campi in cui rifugge sostare il logos, che vuole, o forse meglio vorrebbe mantenersi apatico, algidamente razionale, universalmente attendibile. Come fossero possibili intelligenza e pensiero autentici che non implicassero: “percettività e movimento all’altro, arrischio di sé, inter-esse” e non dessero luogo sempre e fatalmente a formulazioni segnate dalla provvisorietà, dal porsi come relative a un esserci che è quello della finitudine e del limite; dunque giammai concepibili quali assolute ovvero, vedi l’etimo del termine, sciolte da ogni legame - che invece sempre mantengono − con il linguaggio, i fenomeni, i sensi, le emozioni.
sensibilita. E, ancora a proposito di etimologia, l’autrice ci invita a tener conto che, se la filosofia della sensibilità prende avvio dalla passività − qui audacemente considerata “disponibilità a lasciarsi affettare” −, pathos, oltre che subire/patire, significa pure recar traccia, portare l’impronta di qualcosa. Quindi, alla pari del sentimento, il pensiero (che non sorge dal nulla) “porta l’impronta di ciò che l’ha impresso”; da cui la nostra conseguente mimesis: una riproduzione che è pur tuttavia atto eminentemente creativo, quantunque esso nasca da un patico subire anteriore che lo attiva. La riflessione estetica, altresì, non fa sua la hybris, la tracotanza del logos illuso di poter dire parole inoppugnabili od oggettive intorno al cosiddetto reale, non essendo essa viziata dalla fiducia ingenua in un “realismo” su cui invece il discorso tecnico-scientifico sostiene di basarsi.
Anzi quello mito-logico è giusto antirealistico, in quanto, nel dichiarare che “il nostro è un mondo di apparenze”, o fenomenico, la filosofia della sensibilità salva a suo modo “l’ulteriorità del senso”, non cercando di imprigionare la o le verità cui essa giunge in formule esaustive, coercitive, animate da velleità di controllo/dominio. Ogni formulazione filosofica, infatti, ha da essere solo provvisoria, ipotetica, metaforica nel significato originario della parola da cui quest’ultimo aggettivo deriva, la quale si riferisce a un’immagine allusiva che conduce (o, se vogliamo, accenna a) oltre e altrove rispetto a essa.
Dice bene a tale proposito la Mati: l’estetica in quanto filosofia “non mira alla dissoluzione dell’enigma dell’esistenza” per quanto continui a riflettere su di essa e a interrogarsi intorno al suo significato per noi, poiché esso “non è qualcosa là fuori” che emerge e si presenta in modo oggettivo, ma è appunto il frutto dell’elaborazione/proiezione di senso da noi effettuata. Un libero conferir senso creato dall’uomo che non esorcizza il venir meno, la perdita, e tutte le contraddizioni, irrisolutezze e ambivalenze del vivere.
Ma è forse l’ultima parte del saggio la più stimolante, laddove l’autrice - rifacendosi al monito plotiniano áphele panta (“rimuovi tutto”) − accenna alla possibilità/necessità d’un oltrepassamento/affrancamento contemplativo che ci faccia approdare a “qualcosa che è non-sensazione, non-discorso, non-pensiero”. Un approdo senza ancoraggio stabile/immutabile, che allude alla prospettiva della mistica d’ogni tempo e luogo, cioè a quell’abbandono (equivalente alla Gelassenheit di Meister Eckhart) che è ascesi onde giungere alla capacità di liberarsi da tutto, tramite uno “smarrimento definitivo” - sono le parole conclusive del saggio inconcludibile di Susanna Mati - “che è il vero/vuoto ritorno a se stessi”.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Il “genio del cristianesimo” è morto. La vita dei testimoni sinceri, il solo punto di appoggio (di Vito Mancuso - Se la Chiesa rinuncia alla bellezza).18 dicembre 2014
Se la Chiesa rinuncia alla bellezza.
L’amore di Chateaubriand e di altri filosofi del passato per una religione “estetica” tramonta nella nostra epoca
 Dalla pittura alla poesia, la fede ha ispirato per secoli l’arte. Oggi prevale lo stile piatto
Dalla pittura alla poesia, la fede ha ispirato per secoli l’arte. Oggi prevale lo stile piatto
 Non solo teologia, anche la scienza difende nelle sue teorie un’idea di eleganza
Non solo teologia, anche la scienza difende nelle sue teorie un’idea di eleganzadi Vito Mancuso (la Repubblica, 17.12.2014)
- L’AUTORE François-René de Chateaubriand (1768-1848) è l’autore di Genio del cristianesimo
QUALI sono gli argomenti che inducono a ritenere vero un enunciato? Il fatto che corrisponda all’effettivo stato delle cose, è la risposta che sorge spontanea nella mente. Se infatti posso verificare la corrispondenza tra l’enunciato (sta piovendo) e la realtà (la pioggia che scende) sono indubbiamente in presenza di un enunciato vero. È la classica definizione di verità come adeguazione tra realtà e mente, adaequatio rei et intellectus, che da Aristotele passa a Tommaso d’Aquino e a tutta la tradizione occidentale. Di essa il cristianesimo fece largamente uso nel passato per presentarsi come verità definitiva.
Il cristianesimo è la verità, si sosteneva, perché la Bibbia e il Magistero della Chiesa dicono come stanno realmente le cose sull’origine del mondo, l’esistenza di Dio, la comparsa dell’uomo, la natura dell’anima, e tutte le altre questioni capitali della vita; né si tralasciava di sottolineare che gli eventi narrati o predetti nella Bibbia, dall’arca di Noè sino all’imminente fine del mondo, hanno avuto o avranno presto puntuale conferma nella realtà effettiva delle cose.
Il progresso della conoscenza umana ha vanificato tale impostazione perché ha fatto emergere in modo inconfutabile la non corrispondenza tra non poche affermazioni bibliche e la realtà, si pensi per esempio all’origine del mondo. Se a ciò si aggiunge l’evoluzione della coscienza morale e il superamento del principio di autorità (secondo cui un enunciato è vero per l’autorità di chi lo sostiene) si comprende quanto le tradizionali apologie cristiane siano divenute armi spuntate e il cristianesimo bisognoso di rifondazione.
È quanto già intuiva il nobile controrivoluzionario François-René de Chateaubriand (1768-1848) rifugiatosi a Londra per evitare la ghigliottina durante gli anni del Terrore e fervente cattolico. Una volta tornato in Francia a seguito della restaurazione, l’intuizione lo condusse a pubblicare nel 1802 Genio del cristianesimo, opera oggi riproposta nei Millenni Einaudi con un’edizione a cura di Mario Richter. La novità del libro è tutta nel titolo completo: Genio del cristianesimo ovvero bellezze della religione cristiana.
Mentre per secoli al fine di mostrare la fondatezza della fede cristiana l’apologetica aveva insistito sulla verità del cristianesimo, con Chateaubriand per la prima volta ci si basa sulla bellezza, sostenendo che il cristianesimo viene direttamente da Dio, e quindi è la verità, per la sua capacità di produrre bellezza.
Si tratta di una tesi fondata? Nella sua impostazione di fondo sì, anche l’epistemologia contemporanea afferma che tra i criteri di veridicità di una teoria scientifica, oltre a semplicità, capacità di predire e potere unificante, vi è appunto eleganza o bellezza. E per molti secoli il cristianesimo ha saputo produrre bellezza e ha avuto potere unificante sulle vite degli uomini.
Si pensi ai capolavori dell’architettura che sono le chiese romaniche e le cattedrali gotiche; si pensi alle icone bizantine, a Cimabue, Giotto, Beato Angelico, Simone Martini, Piero della Francesca, Michelangelo e persino Caravaggio che senza il cristianesimo sarebbero impensabili; si pensi alla più alta creazione poetica della nostra letteratura, la Commedia di Dante; si pensi allo splendore del canto gregoriano. Si pensi alle molte altre creazioni di cui testimoniano le nostre città e i nostri più piccoli paesi, e le si accosti alle forme di vita concreta che il cristianesimo del passato sapeva produrre in quanto dotato di forte potere unificante sul caos dell’esistenza: eremiti del deserto, benedettini, cluniacensi, cistercensi, camaldolesi, cassinesi, vallombrosani, olivetani, certosini, trappisti, francescani, domenicani, trinitari, mercedari, serviti, agostiniani e molti altri, per non dire della galassia ancora più estesa della vita religiosa femminile.
Anche da questo appariva che il cristianesimo era vero, per la sua capacità di generazione di molteplici forme di vita. Ma oggi quale salute gode l’intuizione di Chateaubriand di legare la verità del cristianesimo alla bellezza?
A livello teoretico sono due i principali teologi che si sono fatti carico di approfondirla, lo svizzero Hans Urs von Balthasar (1905-1991) con l’opera in sette volumi Gloria. Un’estetica teologica, e il tedesco Christoph Theobald, nato nel 1946, con l’opera in due volumi Il cristianesimo come stile. Ma quando è in gioco la verità nella sua capacità estetica, ben prima di concetti che parlano alla mente, si parla di forme che incantano i sensi, di colori, suoni, architetture e si parla di vite concrete così affascinate dal messaggio cristiano da lasciare ogni altra cosa.
E da questo punto di vista credo si debba rilevare una preoccupante insufficienza del cristianesimo contemporaneo. L’ingresso in una qualunque delle nostre chiese raramente genera nell’anima un’esperienza di bellezza, tanto più durante le funzioni liturgiche, quando le musiche e le voci sono spesso approssimative e dilettantistiche, mentre la nuova architettura sacra spesso propone edifici freddi e intellettualistici, e la pittura si rifugia in una pedissequa ripetizione delle icone. Le diverse forme di vita religiosa dal canto loro languono per un’assenza di vocazioni che quasi ne preannuncia l’estinzione.
Tutto ciò porta il cristianesimo contemporaneo a vivere tra due estremi: da un lato un tradizionalismo cupo e insicuro che sa solo riprodurre gusti e parole di un mondo che non c’è più, dall’altro un’affannosa rincorsa alle tendenze dell’oggi che quasi non sa più distinguere la canzone tra amici dalla cantata sacra a gloria di Dio, un edificio sacro da uno comune, una vita consacrata con il suo abito distintivo da un’esistenza del tutto laica.
Al fondo è la stessa idea di apologetica a mostrare tutta la sua fragilità e con ciò si ripropone con urgenza la domanda su quanto induce la mente a ritenere vero il cristianesimo, o qualsiasi altra religione: quali sono gli argomenti che inducono a ritenere vero un sistema di enunciati che intende abbracciare niente di meno che il senso del mondo e presentarsi come verità?
Crollata l’idea di una dimostrazione razionale della verità cristiana, anche la capacità di generare bellezza non potrà mai essere inquadrata in un sistema di pensiero, tanto più se esso è funzionale al potere politico e religioso, come l’opera di Chateaubriand era funzionale alla restaurazione e all’alleanza trono-altare.
Ne viene che non c’è e non ci sarà mai nessuna garanzia per la fede cristiana di potersi dimostrare come “verità”, a dispetto del dogma, e del conseguente anatema per chi lo nega, dichiarati dal Vaticano I.
Rimane solo la vita dei testimoni sinceri, alieni da ogni logica di potere, a costituire il punto di appoggio: sono essi il vero “genio del cristianesimo”, solo da essi potrà scaturire quell’umile bellezza, per nulla geniale ma direi austera nella sua semplicità, già all’origine delle beatitudini evangeliche e del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- La Chiesa anglicana ha nominato il suo primo vescovo donna, scegliendo per la sede di Stockport, nell’Inghilterra settentrionale, la reverenda Libby Lane.17 dicembre 2014
Regno Unito, Libby Lane nominata primo vescovo donna anglicano
LONDRA - La Chiesa anglicana ha nominato il suo primo vescovo donna, scegliendo per la sede di Stockport, nell’Inghilterra settentrionale, la reverenda Libby Lane. Lo storico annuncio è stato dato un mese dopo che il Sinodo generale ha formalmente riconosciuto una legislazione che permette alle donne di diventare vescovo. La nomina ha ribaltato così una tradizione secolare e mettendo fine a una ’querelle’ su cui si era profondamente divisa.
- "Congratulazioni alla reverenda Libby Lane per essere diventata la prima donna vescovo della Chiesa. Una nomina storica e un giorno importante per la parità", scrive su Twitter il premier britannico David Cameron.
Come accennato, dopo un dibattito prolungato e spesso dai toni accesi, il Sinodo generale della Chiesa Anglicana aveva votato a luglio di consentire alle donne di diventare vescovo; e il 17 novembre ha formalmente adottato la decisione con la modifica della legge canonica, ultimo passaggio nel processo legislativo per mettere fine a secoli di monopolio maschile. Le donne possono essere sacerdoti della Chiesa d’Inghilterra dal 1994.
"E’ un giorno straordinario per me e -io ritengo- un giornata storica per la Chiesa", ha detto il vescovo Lane, subito dopo l’investitura. Lane, che ha 48 anni, è pastore dal 2007 nelle chiese di St. Peter, a Hale, e St. Elizabeth, ad Ashley, nella diocesi di Chester.
* la Repubblica, 17 dicembre 2014 (ripresa parziale).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ" !15 dicembre 2014, di Federico La Sala
- "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
Spermatozoo incontra uovo: un esplosione di fuochi d’artificio
Scienziati Usa fotografano per la prima volta ciò che accade al momento della fecondazione. Lo scintillio dipende dagli atomi di zinco rilasciati dall’ovulo. Passo importante anche per procreazione assistita: si possono identificare le uova migliori *
Un «primo appuntamento» esplosivo. Quando lo spermatozoo incontra l’uovo volano letteralmente scintille. Di zinco. Un team di scienziati Usa è riuscito a fotografare per la prima volta i «fuochi d’artificio» che accompagnano il lieto evento e ha scoperto che le uova di mammiferi fecondate rilasciano dalla loro superficie miliardi di atomi di zinco in «scintille», un’ondata dopo l’altra.
Lo scatto che immortala il momento dell’incontro è stato rubato grazie a una tecnologia all’avanguardia sviluppata dal team multidisciplinare guidato dalla Northwestern University, che ha potuto così fermare le immagini del «colpo di fulmine» fra seme e uovo. Un’impresa da paparazzi con un risvolto scientifico che potrebbe rivelarsi prezioso per migliorare i risultati della fecondazione in vitro.
I ricercatori hanno catturato l’immagine di fuochi d’artificio molecolari e individuato l’origine delle scintille: piccoli pacchetti ricchi di zinco appena sotto la superficie dell’uovo. In uno studio pubblicato su «Nature Chemistry», gli esperti spiegano che le fluttuazioni di zinco giocano un ruolo centrale nella regolazione dei processi biochimici che assicurano la transizione da uovo sano a embrione.
Queste nuove informazioni, assicurano, potrebbero aprire nuovi scenari: «La quantità di zinco rilasciato da un uovo potrebbe essere un marker ideale per identificare l’alta qualità di un uovo fecondato, cosa che adesso non siamo in grado di fare», spiega l’esperta di biologia ovarica Teresa K. Woodruff, direttore del Women’s Health Research Institute della Northwestern University Feinberg School of Medicine, e uno dei 2 autori corrispondenti dello studio. «Se riusciamo a identificare le uova migliori, un numero minore di embrioni potrebbe essere trasferito durante i trattamenti di fertilità. La nostra ricerca aiuterà a muoversi verso questo obiettivo».
Gli esperti dell’ateneo e dell’Us Department of Energy’s Advanced Photon Source (Aps), hanno sviluppato un pacchetto di 4 metodi fisici per determinare quanto zinco c’è in un uovo e dove si trova all’atto della fecondazione e nelle due ore successive. Dopo aver inventato un nuovo sensore fluorescente, gli scienziati hanno «mappato» quasi 8 mila compartimenti nell’uovo, ognuno contenente approssimativamente 1 milione di atomi di zinco. Tasche che, spiegano, rilasciano il loro carico simultaneamente in un processo ben orchestrato, simile al rilascio di un neurotrasmettitore nel cervello o al rilascio di insulina nel pancreas. I risultati sono stati ulteriormente confermati con metodi chimici.
«Al momento giusto vediamo l’uovo liberare migliaia di pacchetti, ciascuno con scariche milionarie di atomi di zinco. Poi la ”tempesta” si calma», spiega Thomas V. O’Halloran, l’altro autore corrispondente dello studio. «Successivamente c’è un altro scoppio con rilascio di zinco. Ogni uovo ha 4 o 5 di queste periodiche scintille. È bello da vedere, sembra quasi una sinfonia».
Lo zinco, spiegano i ricercatori, è parte di un interruttore principale che controlla la decisione di crescere e trasformarsi in un organismo genetico completamente nuovo. Un primo passo per comprendere più a fondo i meccanismi molecolari coinvolti nella nascita di una nuova vita. Le indagini degli scienziati proseguono.
* La Stampa, 15/12/2014 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Scoperto il ’turbo’ degli spermatozoi. E’ un enzima e li fa viaggiare spediti verso l’ovulo.18 marzo 2016, di Federico La Sala
Scoperto il ’turbo’ degli spermatozoi
E’ un enzima e li fa viaggiare spediti verso l’ovulo *
Scoperto il ’turbo’ degli spermatozoi, ossia il meccanismo molecolare che li fa viaggiare spediti verso l’ovulo. Ad accendere la miccia che li guida veloci verso la meta e’ un enzima, che risponde al progesterone, un ormone rilasciato dall’ovulo. Il risultato, che puo’ aprire la strada a contraccettivi ’unisex, nonche’ a cure contro l’infertilita’ maschile, è pubblicato sulla rivista Science. La ricerca è stata coordinata da Melissa R. Miller, dell’Universita’ della California a Berkley.
All’interno dell’apparato riproduttivo maschile, gli spermatozoi hanno una capacita’ di movimento limitata, non sufficiente da sola a spingerli verso l’ovulo una volta che le cellule si trovano nell’apparato riproduttivo femminile. Per iniziare il loro viaggio, hanno bisogno di essere attivati da un ormone, il progesterone, che viene rilasciato dall’ovocita. La molecola cui si attacca il progesterone è il recettore dell’enzima ABHD2, che si trova sulla membrana esterna degli spermatozoi.
Recettori come questi si trovano a migliaia sulla superficie della coda degli spermatozoi e vengono attivati quando si avvicinano all’ovulo, innescando una cascata di cambiamenti, che rendono la coda dello spermatozoo veloce come una frusta, dandogli l’energia necessaria a penetrare nelle cellule che proteggono l’ovulo.
Cio’ significa che se in futuro di mettessero a punto molecole in grado di bloccare questo enzima, si potrebbe sviluppare un contraccettivo ’unisex’, da usare nelle donne e negli uomini. Al contrario, potenziando l’enzima, si potrebbe aprire la strada nuove terapie per contro l’infertilita’ maschile causata da spermatozoi poco mobili
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- "camminare nella carità". Ermetismo ed ecumenismo rinascimentale, oggi.10 dicembre 2014
 PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)
 ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE OGGI, OGGI: PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara Santomiero
ERMETISMO ED ECUMENISMO RINASCIMENTALE OGGI, OGGI: PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL. Un’intervista a John Chryssavgis di Chiara Santomiero
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Comunismo ermeneutico. Il saggio di Gianni Vattimo e Santiago Zabala sull’idea d’una società alternativa (di Franca D’Agostini)..28 novembre 2014
Marx più Heidegger. Ecco il comunismo 2.0
È uscito il saggio di Gianni Vattimo e Santiago Zabala sull’idea d’una società alternativa. A differenza dal passato però la violenza rivoluzionaria è esplicitamente rifiutata
di Franca D’Agostini (La Stampa, 28.11.2014)
Comunismo ermeneutico, di Gianni Vattimo e Santiago Zabala, è un libro che è necessario leggere, per chiunque sia interessato alla filosofia, alla politica, e ai rapporti tra l’una e all’altra. Non perché sia ineccepibile (al contrario avrei da eccepire a diverse tesi presentate dai due autori) ma per un’altra ragione, più seria e profonda.
Dal punto di vista ideologico-politico viviamo in un’epoca di morti viventi: teorie già morte e finite, che però continuano a fare danno (si possono tralasciare gli esempi: chiunque potrebbe citare due o tre casi, da destra o da sinistra). Ma viviamo anche in un’epoca di sepolti vivi: teorie e ipotesi che sono state affrettatamente tumulate, prima che riuscissero a svilupparsi pienamente e a manifestare i loro meriti e le loro ragioni.
E uno di questi sepolti vivi è precisamente, io credo, quella variante dell’ermeneutica che Vattimo pensò come «pensiero debole»: una posizione filosofica che è stata troppo rapidamente liquidata, quando aveva ancora qualcosa da dire, o anzi (mia opinione) non aveva ancora incominciato a dire il meglio di quel che doveva-poteva dire.
Uno degli aspetti centrali del debolismo ermeneutico era la sua ricaduta politica, e in particolare l’idea che l’ermeneutica (la filosofia dell’interpretazione elaborata da Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Luigi Pareyson) potesse configurarsi non tanto come «pensiero debole», ma come «pensiero dei deboli»: voce delle parti più sfortunate della società, e parola pronunciata in loro difesa. Questo aspetto legava il pensiero debole di Vattimo al Cristianesimo, creando l’idea paradossale ma plausibile di un Gesù «nichilista», pronto a mettere in discussione le (false) verità degli scribi, dei sacerdoti, dei farisei.
In Comunismo ermeneutico i due autori non sviluppano molto le basi filosofiche della loro prospettiva. E non c’è molto, nel libro, delle posizioni originarie di Vattimo. C’è invece una rapida liquidazione delle problematiche della verità, del realismo, della metafisica, semplicemente identificati come i tre costituenti della «politica delle descrizioni» che secondo gli autori starebbe alla base del capitalismo. E per tutto il libro con ostinazione si ripete che «l’imposizione della verità e la difesa del realismo» sono i grandi nemici della giustizia globale.
L’ermeneutica, in quanto pensiero interpretativo e non descrittivo, si contrapporrebbe a tali nemici, in una guerra che è la nostra attuale «emergenza», secondo gli autori. Si tratta allora di contrastare il ferreo ordine capitalistico mondiale con un pensiero che non aspira né alla verità né all’oggettività, e neppure alla forza rivoluzionaria, ma si concede libero al conflitto delle interpretazioni.
Non so se davvero il capitalismo in questa fase storica terminale debba davvero descriversi (interpretarsi) come «politica delle descrizioni». Non so se i nemici che i poveri del mondo devono combattere siano davvero la metafisica, il concetto di verità, o quella astrazione che gli autori chiamano «realismo», e che a me sembra una specie di caricatura del cosiddetto «realismo ingenuo». Dubito che sia così.
Inoltre, i due autori citano la politica di Chávez come «la grande novità della politica mondiale». Ma ci chiediamo: davvero il «nuovo» di Chávez, e di Morales, Correa, Mujica e dei Kirchner, e «persino Papa Bergoglio» ha come sfondo filosofico il rifiuto della verità e il contrasto tra descrizioni e interpretazioni? L’aggancio tra l’ermeneutica debolista e il decisionismo forte, veritativo e descrittivo, necessario per una politica concreta (specie di stampo comunista) sembra delineato nel libro in modo piuttosto vago.
Ma è ovvio che Vattimo e Zabala lavorano in un linguaggio speciale, che hanno ereditato da interpretazioni e reinterpretazioni di Rorty, Derrida, Heidegger, Nietzsche; e per capire la loro proposta occorre entrare in questo linguaggio, e condividerne le regole.
Per esempio, ciò che unisce Marx e Heidegger, dicono, è la critica della metafisica, ma «metafisica» non è la disciplina filosofica che ha questo nome, bensì un modo di vedere la realtà funzionale agli interessi dei potenti della Terra. Ciò che chiamano «descrizioni» non è il semplice descrivere cose più o meno reali o immaginate, ma la pretesa «oggettivistica» di catturare il mondo «dall’alto», con le parole i discorsi i concetti, e imprigionare in tale cattura anche le libere esistenze dei singoli umani.
E il comunismo a cui pensano Vattimo e Zabala non è ciò che canonicamente si può intendere per comunismo ma il principio della comunanza, quale si esprime nel vangelo di Matteo: «Dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, quivi son io in mezzo a loro». E «nel nome mio», spiegano gli autori, significa «nel nome della giustizia, della fraternità, e della solidarietà».
Iniziamo dunque a vedere la ragione per cui occorre leggere Comunismo ermeneutico: per riprendere il discorso sul rapporto tra filosofia e «pensiero dei deboli», e se mai confermare che la filosofia (anche nella variante quasi «anti-filosofica» delineata da Vattimo e Zabala) in definitiva è sempre stata e dovrebbe continuare a essere, come diceva Jean-François Lyotard, la force des faibles.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- CENTRO PUECHER. Presentazione del libro di Federico La Sala, "Della terra, il brillante colore".22 settembre 2014
Spazio del sole e della luna
Via U. Dini 7 - 20141 Milano
(tram 3 e 15; MM2-capolinea piazza Abbiategrasso)
Mercoledì 24 settembre 2014, ore 18.00
SIBILLE E PROFETI
La questione antropologica, oggi
Presentazione del libro di Federico La Sala,
Della terra, il brillante colore,
Edizioni Nuove Scritture, Abbiategrasso 2013
Modera
Giuseppe Deiana
Intervengono
Nicola Fanizza, docente di Storia e Filosofia
Franca Gusmini, docente di Latino e Greco
Attilio Mangano, scrittore e saggista
Federico La Sala, autore del libro, docente di Storia e Filosofia
Dibattito
STUDENTI E CITTADINI SONO INVITATI
Agli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Con il patrocinio del Consiglio di Zona 5
Il presidente del CZ5 Il presidente della Comm.ne Cultura
Aldo Ugliano Michela Fiore
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- Le donne e la Chiesa. Le vie di Papa Francesco per la questione femminile (di Carlo Marroni)9 luglio 2014, di Federico La Sala
- PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT):
Le donne e la Chiesa
Le vie del Papa per la questione femminile
di Carlo Marroni (Il Sole-24 Ore, 09.07.2014)
«La Madonna è più importante degli apostoli, la Chiesa è femminile, è sposa, è madre, e il ruolo della donna nella Chiesa non solo deve finire come mamma, come lavoratrice... limitata. No, è un’altra cosa!!!». Così esclamava un anno fa papa Francesco durante il viaggio di ritorno dal Brasile, interpellato sul ruolo delle donne nella Chiesa. Un tema ricorrente nell’apostolato del papa argentino, che più volte ha messo la donna al centro dell’attenzione. Qualcosa sta cambiando? Il tema è affrontato e analizzato da Papa Francesco e le donne, un bel libro pubblicato dal Sole 24 Ore in collaborazione con l’Osservatore Romano, in edicola da oggi e per un mese insieme al quotidiano.
Il libro raccoglie tutti i testi in cui il Pontefice ha parlato della "questione femminile" nella Chiesa. Testi efficaci, profondi, sorprendenti, che hanno suscitato attenzione e che sono introdotti da due saggi di Giulia Galeotti e della storica Lucetta Scaraffia, firme di punta del quotidiano della Santa Sede, diretto da Giovanni Maria Vian, che da due anni pubblica un inserto mensile femminile.
«In un contesto di emancipazione femminile realizzato, quale è quello dei Paesi occidentali, l’atteggiamento della Chiesa sembra invece rovesciarsi. Soprattutto in una cultura in cui l’emancipazione delle donne è misurata sul libero accesso agli anticoncezionali e sulla legalizzazione dell’aborto, la Chiesa viene percepita come una nemica dell’emancipazione. A questo conflitto culturale si aggiunge - scrive Lucetta Scaraffia - l’assenza di donne nelle sfere decisionali della Chiesa, benché le religiose siano, almeno per ora, molto più numerose dei religiosi. Inoltre, esse sono in genere relegate in ruoli di sottoposte con compiti subalterni".
Gli ultimi dati disponibili, risalenti al 2012, dicono che le religiose cattoliche nel mondo sono 702.529, i religiosi (esclusi i sacerdoti) 55.314: a livello mondiale i maschi costituiscono il 7% della comunità religiosa cattolica. Le proporzioni cambiano se ai maschi religiosi sommiamo i vescovi (5.133) e i sacerdoti (414.313): in questo caso il peso femminile risulta ridimensionato, ma le donne rappresentano comunque il 60% della Chiesa consacrata, quindi un’ampia maggioranza. "Le donne nella Chiesa ci sono - scrive Giulia Galeotti - sono molte e fanno tantissimo (...) Eppure non contano. È incredibile la discrasia tra il reale impegno femminile nella Chiesa a tutti i livelli e il misero spazio che è loro lasciato ai vertici (...) Davvero - si chiede Galeotti a proposito degli uomini di Chiesa - non vedono oppure torna loro più comodo fingere di non vedere?".
Emblematiche appaiono le parole di suor Viviana Ballarin, che in passato ha guidato l’organismo da cui dipendono gli ordini femminili italiani: "È ancora raro che nella Chiesa siano affidati alle donne ruoli a più ampio respiro, di responsabilità, di decisionalità". La causa? Per Ballarin alla fine il nodo è un influsso culturale che "influenza e condiziona anche la Chiesa degli uomini. Ma non la Chiesa di Cristo". Parole coraggiose in un contesto "gerarchico" come quello ecclesiastico, che testimoniano come il dibattito sul tema sia franco e aperto, con prese di posizione decise.
In questo contesto sono provvidenziali le posizioni di Francesco che denuncia con una sincerità e un coraggio nuovi la condizione di subalternità in cui si trovano oggi le donne nella Chiesa. Dal libro emerge anche un’ansia di fondo, il timore che la straordinaria apertura del papa, per quanto forte e autorevole, da sola non sia sufficiente per un cambio strutturale e duraturo, che richiede una riflessione profonda a tutti i livelli.
E infatti l’ultimo capitolo del libro si intitola "Un cantiere aperto", "un cantiere - scrive Scaraffia - di cui il Papa indica sempre più nettamente le caratteristiche. Cominciare ad affrontare la situazione dal punto di vista teologico significa muoversi in una direzione ben lontana da quella auspicata da chi pensa semplicemente che la Chiesa si debba adeguare al mondo, introducendo donne a tutti i livelli di potere di decisione".
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" ---- SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE E LA "RABBIA" DI UNA FILOSOFA. «Changing the Ideology and Culture of Philosophy» (Sally Haslanger).8 luglio 2014
Sebben che siamo donne non ci fa paura la filosofia
Il «pensiero femminile» è socialmente discriminato: un condizionamento negativo
La “rabbia” di una filosofa americana del Mit: in questo campo siamo discriminate, molte di noi costrette a lasciare
di Franca D’Agostini (La Stampa, 25.03.2012)
Sally Haslanger è una delle più brillanti filosofe americane: in un articolo su Hypathia confessa che da quanto è arrivata al Mit, nel ’98, si è più volte domandata se non fosse il caso di lasciare la filosofia “C’ è in me una rabbia profonda. Rabbia per come io sono stata trattata in filosofia. Rabbia per le condizioni ingiuste in cui molte altre donne e altre minoranze si sono trovate, e hanno spinto molti a lasciare. Da quando sono arrivata al Mit, nel 1998, sono stata in costante dialogo con me stessa sull’eventualità di lasciare la filosofia. E io sono stata molto fortunata. Sono una che ha avuto successo, in base agli standard professionali dominanti». S’inizia così «Changing the Ideology and Culture of Philosophy», un articolo di Sally Haslanger, una delle più brillanti filosofe americane, apparso su Hypathia .
C’è un problema, che riguarda le donne e la filosofia: inutile negarlo. «Nella mia esperienza è veramente difficile trovare un luogo in filosofia che non sia ostile verso le donne e altre minoranze», scrive Haslanger. E se capita così al Mit, potete immaginare quel che succede in Italia. È facile vedere che, mentre in tutte le facoltà le donne iniziano a essere presenti (anche se rimane il cosiddetto «tetto di cristallo», vale a dire: ai gradi accademici più alti ci sono quasi esclusivamente uomini), in filosofia la presenza femminile scarseggia.
Non sarà forse che le donne sono refrattarie alla filosofia, non la capiscono, non la apprezzano? Stephen Stich e Wesley Buchwalter, in «Gender and Philosophical Intuition» (in Experimental Philosophy, vol. 2), hanno riproposto il problema, esaminandolo nella prospettiva della filosofia sperimentale: una tendenza filosofica emergente, che mette in collegamento le tesi e i concetti filosofici con ricerche di tipo empirico (statistico, neurologico, sociologico, ecc). La prima conclusione di Stich e Buchwalter è che effettivamente sembra esserci una «resistenza» del «pensiero femminile» di fronte ad almeno alcuni importanti problemi filosofici. Stich e Buchwalter si chiedono perché, e avanzano alcune ipotesi, ma non giungono a una conclusione definitiva.
Le femministe italiane di Diotima avrebbero pronta la risposta: la filosofia praticata nel modo previsto da Stich e compagni è espressione estrema del «logocentrismo» maschile, dunque è chiaro che le donne non la praticano: sono interessate a qualcosa di meglio, coltivano un «altro pensiero». Ma qui si presenta un classico problema: in che cosa consisterebbe «l’altro pensiero» di cui le donne sarebbero portatrici? Se si tratta per esempio di «pensiero vivente», attento alle emozioni e alla vita, come a volte è stato detto, resta sempre da chiedersi: perché mai questo pensiero sarebbe proprio delle donne? Kierkegaard, che praticava e difendeva una filosofia di questo tipo, era forse una donna?
Forse si può adottare un’altra ipotesi. Come spiega Miranda Fricker in Epistemic Injustice (Oxford University Press, 2007) le donne subiscono spesso ciò che Ficker chiama ingiustizia testimoniale, vale a dire: ciò che pensano e dicono viene sistematicamente sottovalutato e frainteso. Un’osservazione fatta da una donna che gli uomini non capiscono, per ignoranza o per altri limiti, viene all’istante rubricata come errore, o come vaga intuizione. Fricker cita Il talento di Mr. Ripley: «Un conto sono i fatti, Marge, e un conto le intuizioni femminili», dice il signor Greenleaf. Ma Marge aveva ottime ragioni nel sostenere che Ripley aveva ucciso il figlio di Greeenleaf.
In questa prospettiva il quadro muta. Consideriamo la rilevazione dell’attività cerebrale di un ragazzo e una ragazza che svolgono una prestazione intellettuale «di livello superiore», ossia risolvono per esempio un’equazione difficile. A quanto pare, mentre il cervello del ragazzo si illumina in una sezione molto circoscritta dell’emisfero frontale, il cervello della ragazza si illumina in modo diffuso, diverse zone dell’encefalo sono coinvolte. Ecco dunque la differenza emergere dai fatti cerebrali: le donne - così si dice - avrebbero un’intelligenza aperta e «diffusa». Naturalmente, questa diffusività è un limite: è appunto la ragione per cui le prestazioni intellettuali femminili sarebbero meno rapide ed efficaci. L’ipotesi differenzialista a questo punto ribatte: attenzione, l’intelligenza diffusa è un pregio, ed è il mondo che privilegia rapidità ed efficacia a essere sbagliato.
Ma l’altra ipotesi - che tanto Haslanger quanto Fricker indirettamente sostengono - sembra più ragionevole: se c’è un «pensiero femminile», la sua prima caratteristica consiste nell’essere un pensiero socialmente discriminato, che subisce sistematicamente ingiustizie testimoniali. Il cervello discriminato è coinvolto sul piano emotivo, a causa del grande quantitativo di ingiustizia che ha dovuto subire. E a questo punto il mistero è risolto: provate voi a risolvere un difficile problema filosofico in un ambiente in cui tutto vi dice che non sapete risolverlo. Provate, in più, avendo dentro di voi la rabbia descritta da Haslanger: quella che vi viene dal conoscere questa ingiustizia, che riguarda voi ma anche altre persone, e altre minoranze discriminate (anche tra i neri non ci sono molti filosofi). Poi vedete un po’ se non vi si illumina tutto il cervello.
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- LA BUONA INTERPRETAZIONE DEI SOGNI, LA GRATUITA’: GIUSEPPE E IL FARAONE (di Luigino Bruni - Gli occhi onesti del profeta)7 luglio 2014, di Federico La Sala
NOTA INTRODUTTIVA.
La "buona" interpretazione dei sogni è quella che nasce dalla gratuità ("charitas"), non quella per profitto ("caritas").
- Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
 DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
Gli occhi onesti del profetadi Luigino Bruni (Avvenire, 7 luglio 2014
Le carestie sono molte e diverse. Il nostro tempo sta attraversando la più grande carestia di sogni che la storia umana abbia conosciuto. La carestia di sogni prodotta da questo capitalismo individualistico e solitario è una forma molto grave di indigenza, perché mentre la mancanza di pane non estingue la fame, se ci priviamo dei sogni finiamo per non accorgerci più della loro assenza; ci abituiamo a un mondo impoverito di desideri sempre più soffocati dalle merci, e presto diventiamo talmente poveri da non riuscire ad accorgerci di questa povertà. Come è possibile sognare angeli, il paradiso, i grandi fiumi d’Egitto quando ci addormentiamo di fronte alla tv accesa? Per i sogni grandi occorre addormentarsi con una preghiera sulle labbra, o svegliarsi con un libro di poesie aperto sopra il petto, che ha vegliato sul nostro sonno.
Il giovane Giuseppe si ritrovò innocente in una prigione, rigettato di nuovo in fondo a un «pozzo» (Genesi 40,15). Quella prigione divenne, però, anche il luogo della piena fioritura della sua vocazione, quella annunciatagli dai sogni profetici di ragazzo. Quei primi sogni lo avevano fatto arrivare schiavo in Egitto; i sogni che interpreterà nella terra del Nilo saranno la strada che consentirà ai suoi grandi sogni giovanili di avverarsi, e di ritrovare i suoi fratelli-venditori e suo padre.
È in un carcere dove inizia una nuova fase della vita di Giuseppe, quella decisiva per sé e per il suo popolo (non è raro che un "carcere" diventi il luogo di inizio di una vita nuova). In quel «pozzo», da raccontatore dei suoi sogni Giuseppe diventa interprete dei sogni degli altri. Quand’era ragazzo narrava i suoi sogni, ma non li interpretava. Il dolore per essere stato odiato e venduto dai fratelli, la servitù e poi il carcere, lo avevano maturato e gli avevano rivelato se stesso. E nel crogiuolo delle sofferenze e delle ingiustizie scoprì la sua vocazione, divenne servitore dei sogni degli altri.
In quel carcere si trovavano con lui due alti officiali di corte: il coppiere e il panettiere del faraone (40,1). Questi «fecero entrambi un sogno, ciascuno il suo sogno» (40,5). Il mattino «Giuseppe venne da loro e li vide: erano turbati», e chiese loro: «Perché oggi avete una faccia così brutta?». Gli risposero: «Abbiamo fatto un sogno e non c’è chi ce lo interpreti» (40,7-8). I due funzionari raccontarono i loro sogni a Giuseppe, e lui glieli interpretò.
Solo chi ha sognato e ha avuto il coraggio di raccontare i suoi sogni può diventare ermeneuta dei sogni degli altri. Per una legge paradossale che è al cuore di molte cose alte della vita, i migliori interpreti dei sogni degli altri sono coloro che hanno più sofferto a causa dei propri sogni. Avere dei sogni e non trovare qualcuno che ce li interpreti è una grande causa di infelicità per chi, nonostante la carestia, continua a sognare - ce ne sono ancora molti, soprattutto nei paesi più poveri di Pil e più ricchi di sogni, sogni che presto produrranno anche ricchezza.
I sogni sono sempre cose serie, ma decisivi sono i "sogni a occhi aperti", quelli che chiamiamo progetti, aspirazioni, voglia di riscatto e di giustizia, desideri di futuro e di felicità, quelli che ci fanno intravvedere il nostro posto nel mondo. Ieri e oggi, però, i sogni hanno bisogno di interpreti, di qualcuno che ne sappia decifrare il contenuto, altrimenti quei sogni si spengono. Questi interpreti sono importanti sempre, ma sono fondamentali da giovani, nella stagione dei sogni grandi.
Giuseppe inizia a interpretare i sogni come dono a due compagni di carcere: «Giuseppe disse loro: le interpretazioni non appartengono forse a Dio? Raccontatemi, vi prego» (40,8). La "buona" interpretazione dei sogni è quella che nasce dalla gratuità, non quella per profitto («le interpretazioni non appartengono forse a Dio?»). Sta nel bisogno essenziale di questa gratuità la ragione della scarsità dei buoni ermeneuti dei nostri sogni. Sono un dono raro, ma non rarissimo.
Le "guide spirituali" appartengono a questa preziosa categoria umana, persone che ascoltano e interpretano i nostri sogni e i nostri segni. La buona interpretazione dei sogni è gratuità chiesta e donata. Non è un mestiere, e se diventa mestiere non è buona. Le interpretazioni che Giuseppe dà a quei due sogni sono molto diverse: al capo dei coppieri predice la liberazione, al capo dei panettieri annuncia la morte - come poi accadrà.
Il valore morale di un interprete di sogni si misura dalla sua onestà, cioè dalla capacità e dal coraggio di dirci anche le interpretazioni che non vorremmo sentire. Sono troppi, ieri e oggi, gli interpreti ruffiani che ci dicono soltanto le interpretazioni che ci piace sentire. A volta le interpretazioni sbagliate possono provenire anche da interpreti onesti, che però non hanno abbastanza coraggio e amore - anche se il carisma dell’interpretazione dei sogni si spegne se non lo si custodisce nella sofferenza delle interpretazioni difficili. Ho conosciuto giovani ai quali è stata resa la vita molto difficile, a volte guastata, da cattivi interpreti dei loro sogni, che di fronte ad evidenti segni di vocazione diversa da quella che quel giovane pensava di avere, non hanno avuto né l’onesta né il coraggio della interpretazione vera; e così invece di prendere su di loro il dolore per quella verità costosa, hanno manipolato i sogni e alimentato in quei giovani illusioni, delusioni, frustrazioni, infelicità. Fidarsi di un manipolatore di sogni è più dannoso della morte del sogno per mancanza di interpreti.
Dopo due anni, anche il faraone fece un sogno. «Egli stava presso il Nilo. Ed ecco salire dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse di carne, a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo quelle, altre sette vacche salire dal Nilo, brutte di aspetto e magre di carne ... Ma le vacche brutte di aspetto e magre di carne divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse» (41,1-4). Il faraone si svegliò turbato; si riaddormentò e fece subito un altro sogno: «Sette spighe da un unico fusto, grosse e belle. Ma ecco sette spighe minute e riarse dal vento d’oriente germogliare dopo di quelle. Le spighe minute inghiottirono le sette spighe grosse e piene» (41,5-7). Quei due sogni agitarono l’animo del faraone, che mandò «a chiamare tutti i divinatori e tutti i sapienti d’Egitto. Il faraone raccontò il suo sogno ma non ci fu nessuno che li sapesse interpretare» (41,8).
A questo punto del racconto arriva una svolta narrativa. Quel capo dei coppieri, al quale Giuseppe aveva interpretato il sogno due anni prima, si ricordò di lui. Ne parlò al faraone, che lo mandò a chiamare. Giuseppe gli rivela immediatamente la chiave per comprendere quanto sta per accadere, e la natura del suo operare: «Non io: Dio risponderà per il benessere [shalom] del Faraone» (41,16).
Siamo di fronte a un momento cruciale ed epocale: la fine dell’età dei divinatori, degli aruspici, dei maghi, e l’inizio del tempo della profezia. Qui Giuseppe diventa il primo profeta di Israele. In questa lettura del sogno del faraone vi ritroviamo, infatti, i tratti essenziali che distinguono l’autentica interpretazione profetica dai prodotti dei divinatori e dai falsi profeti di tutti i tempi. Questa interpretazione profetica è dono-gratuità, perché è esercizio di un carisma che il "profeta" riceve, non un suo manufatto né una tecnica appresa in qualche scuola. È un dono che per poter operare deve essere accolto dal suo destinatario, credendoci. E spinge sempre all’azione e al cambiamento.
La nostra società abbonda di consulenti for-profit, è sempre più inondata da maghi e da oroscopi, ma ci mancano troppo i buoni interpreti di sogni - e quei pochi che ci sono non vengono né cercati né ascoltati, e così rischiano di estinguersi per mancanza di domanda.
Quel Faraone, invece, credette all’interpretazione-profezia di Giuseppe, e agì. «Ecco, stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutta la terra di Egitto. Poi, dopo questi, si leveranno sette anni di carestia: si dimenticherà tutta quell’abbondanza nella terra d’Egitto e la carestia consumerà la terra [le vacche-spighe magre che divorano le grasse]» (41,29-30). E quindi Giuseppe continuò: «Il Faraone ravvisi un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sulla terra d’Egitto ... per prelevare il quinto dei prodotti della terra d’Egitto durante i sette anni di abbondanza» (41,33-34).
Le carestie da vacche magre passano. Queste carestie, prima o poi, finiscono naturalmente, anche se a volte con grandi costi. Le carestie di sogni, invece, non terminano da sole. Finiscono soltanto se, a un certo preciso punto, decidiamo di reimparare a sognare. Non è impossibile. Lo abbiamo saputo fare dopo miserie infinite e indicibili: dopo le guerre e le dittature, dopo i fratricidi, dopo le morti dei bambini. Abbiamo voluto, insieme, ricominciare a sognare. Abbiamo così ascoltato i poeti, i santi, gli artisti, che hanno saputo interpretare i nostri nuovi sogni. Abbiamo pregato e pianto insieme, recitato le loro-nostre poesie, cantato le loro-nostre canzoni. Le persone e i popoli rinascono e risorgono veramente soltanto così. «Il faraone si tolse di mano l’anello e lo pose sulla mano di Giuseppe; lo fece rivestire di abiti di lino finissimo e gli mise al collo un monile d’oro» (41,42).
- Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Compendio del Manifesto convivialista.30 giugno 2014, di Federico La Sala
Compendio del Manifesto convivialista
Dichiarazione di interdipendenza *
- Questo testo è il compendio del Manifeste convivialiste , pubblicato il 14 giugno 2013 presso la casa editrice Le Bord de l’eau (ora disponibile in traduzione italiana: Manifesto convivialista, edizioni ETS, Pisa 2014). I lettori che saranno d’accordo con i princìpi qui esposti potranno testimoniarlo dichiarando il loro appoggio (www.lesconvivialistes.fr).
 Trad. it. di Francesco Fistetti.
Trad. it. di Francesco Fistetti.
Mai come oggi l’umanità ha avuto a disposizione tante risorse materiali e competenze tecnico-scientifiche. Considerata nella sua globalità, essa è ricca e potente come nessuno nei secoli passati avrebbe potuto mai immaginare. Non è detto che sia anche più felice. Tuttavia, non c’è nessuno che desideri tornare indietro, poiché ognuno si rende conto che di giorno in giorno si aprono sempre maggiori e nuove potenzialità di realizzazione individuale e collettiva. Eppure, nonostante ciò, nessuno è disposto a credere che questa accumulazione di potenza possa essere perseguita indefinitamente senza che, in una logica immutata di progresso tecnico, si ritorca contro se stessa e metta a repentaglio la sopravvivenza fisica e morale dell’umanità. Le prime minacce che incombono su di noi sono di ordine materiale, tecnico, ecologico ed economico. Minacce entropiche.
 Ma noi siamo molto più impotenti nell’immaginare delle risposte adeguate al secondo tipo di minacce. Alle minacce di ordine morale e politico. A quelle minacce che potremmo definire antropiche.
Ma noi siamo molto più impotenti nell’immaginare delle risposte adeguate al secondo tipo di minacce. Alle minacce di ordine morale e politico. A quelle minacce che potremmo definire antropiche.
 Il problema numero uno
Sotto i nostri occhi c’è un’evidenza accecante: l’umanità ha saputo realizzare dei progressi tecnici e scientifici sorprendenti, ma resta ancora incapace di risolvere il suo problema fondamentale: come gestire la rivalità e la violenza tra gli esseri umani? Come convincerli a cooperare, pur consentendo loro di contrapporsi senza massacrarsi? Come contrastare l’accumulazione della potenza, ormai illimitata e potenzialmente auto-distruttiva, contro gli uomini e contro la natura? Se l’umanità non saprà trovare una risposta a questi interrogativi, è destinata a scomparire. E questo proprio quando si sono create tutte le condizioni materiali di un benessere generalizzato, purché si prenda coscienza della loro finitezza. Abbiamo a disposizione molteplici elementi di risposta, che nel corso dei secoli sono stati apportati dalle religioni, dalle morali, dalle dottrine politiche, dalla filosofia e dalle scienze umane e sociali. -Così pure, le iniziative che si muovono in direzione di un’alternativa all’attuale organizzazione del mondo sono innumerevoli, promosse da migliaia e migliaia di organizzazioni o associazioni, e da diecine o centinaia di milioni di persone. Queste iniziative si presentano sotto varie denominazionie ai più diversi livelli: la difesa dei diritti dell’uomo, del cittadino, del lavoratore, del disoccupato, della donna o dei bambini; l’economia sociale e solidale con tutte le sue componenti: le cooperative di produzione o di consumo, la mutualità, il commercio equo, le monete parallele e complementari, i sistemi di scambio locale, le innumerevoli associazioni di mutuo soccorso; l’economia cognitiva dei network (cfr. Linux, Wikipedia, ecc.); la decrescita e il post-sviluppo; i movimenti slow food , slow town , slow science ; la rivendicazione del buen vivir , l’affermazione dei diritti della natura e l’elogio della pachamama ; l’altermondialismo, l’ecologia politica e la democrazia radicale, gli indignados , Occupy Wall Street ; la ricerca di indicatori alternativi di ricchezza, i movimenti della trasformazione personale, della sobrietà volontaria, dell’abbondanza frugale, del dialogo tra le civiltà, le teorie del care , la nuova concezione dei “beni comuni” ( commons ), ecc. Perché queste iniziative così ricche possano contrastare con un’adeguata potenza le dinamiche letali del nostro tempo e non siano confinate nel ruolo di mera contestazione o di semplice palliativo, diventa decisivo unire le loro forze e le loro energie. Da qui l’importanza di sottolineare ed enunciare ciò che hanno in comune.
Il problema numero uno
Sotto i nostri occhi c’è un’evidenza accecante: l’umanità ha saputo realizzare dei progressi tecnici e scientifici sorprendenti, ma resta ancora incapace di risolvere il suo problema fondamentale: come gestire la rivalità e la violenza tra gli esseri umani? Come convincerli a cooperare, pur consentendo loro di contrapporsi senza massacrarsi? Come contrastare l’accumulazione della potenza, ormai illimitata e potenzialmente auto-distruttiva, contro gli uomini e contro la natura? Se l’umanità non saprà trovare una risposta a questi interrogativi, è destinata a scomparire. E questo proprio quando si sono create tutte le condizioni materiali di un benessere generalizzato, purché si prenda coscienza della loro finitezza. Abbiamo a disposizione molteplici elementi di risposta, che nel corso dei secoli sono stati apportati dalle religioni, dalle morali, dalle dottrine politiche, dalla filosofia e dalle scienze umane e sociali. -Così pure, le iniziative che si muovono in direzione di un’alternativa all’attuale organizzazione del mondo sono innumerevoli, promosse da migliaia e migliaia di organizzazioni o associazioni, e da diecine o centinaia di milioni di persone. Queste iniziative si presentano sotto varie denominazionie ai più diversi livelli: la difesa dei diritti dell’uomo, del cittadino, del lavoratore, del disoccupato, della donna o dei bambini; l’economia sociale e solidale con tutte le sue componenti: le cooperative di produzione o di consumo, la mutualità, il commercio equo, le monete parallele e complementari, i sistemi di scambio locale, le innumerevoli associazioni di mutuo soccorso; l’economia cognitiva dei network (cfr. Linux, Wikipedia, ecc.); la decrescita e il post-sviluppo; i movimenti slow food , slow town , slow science ; la rivendicazione del buen vivir , l’affermazione dei diritti della natura e l’elogio della pachamama ; l’altermondialismo, l’ecologia politica e la democrazia radicale, gli indignados , Occupy Wall Street ; la ricerca di indicatori alternativi di ricchezza, i movimenti della trasformazione personale, della sobrietà volontaria, dell’abbondanza frugale, del dialogo tra le civiltà, le teorie del care , la nuova concezione dei “beni comuni” ( commons ), ecc. Perché queste iniziative così ricche possano contrastare con un’adeguata potenza le dinamiche letali del nostro tempo e non siano confinate nel ruolo di mera contestazione o di semplice palliativo, diventa decisivo unire le loro forze e le loro energie. Da qui l’importanza di sottolineare ed enunciare ciò che hanno in comune.
 Sul convivialismo
Sul convivialismo
 In comune hanno la ricerca di un convivialismo , di un’arte di vivere insieme ( con- vivere ) che consenta agli esseri umani di prendersi cura gli uni degli altri e della Natura, senza negare la legittimità del conflitto, ma trasformandolo in un fattore di dinamismo e di creatività, in uno strumento per scongiurare la violenza e le pulsioni di morte. Per trovarlo abbiamo urgente bisogno di un corredo dottrinale minimo e condivisibile, che consenta di rispondere contemporaneamente, ponendole su scala planetaria, almeno a quattro questioni di base (più una):
In comune hanno la ricerca di un convivialismo , di un’arte di vivere insieme ( con- vivere ) che consenta agli esseri umani di prendersi cura gli uni degli altri e della Natura, senza negare la legittimità del conflitto, ma trasformandolo in un fattore di dinamismo e di creatività, in uno strumento per scongiurare la violenza e le pulsioni di morte. Per trovarlo abbiamo urgente bisogno di un corredo dottrinale minimo e condivisibile, che consenta di rispondere contemporaneamente, ponendole su scala planetaria, almeno a quattro questioni di base (più una):
 La questione morale: che cosa è lecito per gli individui sperare e che cosa devono proibirsi?
La questione morale: che cosa è lecito per gli individui sperare e che cosa devono proibirsi?
 La questione politica: quali sono le comunità politiche legittime?
La questione politica: quali sono le comunità politiche legittime?
 La questione ecologica: che cosa possiamo prendere (d)alla natura e che cosa dobbiamo restituirle?
La questione ecologica: che cosa possiamo prendere (d)alla natura e che cosa dobbiamo restituirle?
 La questione economica: quale quantità di ricchezza materiale ci è lecito produrre, e in che modo, per essere coerenti con le risposte date alla questione morale, politica ed ecologica?
La questione economica: quale quantità di ricchezza materiale ci è lecito produrre, e in che modo, per essere coerenti con le risposte date alla questione morale, politica ed ecologica?
 Ognuno è libero di aggiungere, se vuole, a queste quattro questioni quella del rapporto con il sovrannaturale o con l’invisibile: la questione religiosa o spirituale. O la questione del senso.
Ognuno è libero di aggiungere, se vuole, a queste quattro questioni quella del rapporto con il sovrannaturale o con l’invisibile: la questione religiosa o spirituale. O la questione del senso.
 Considerazioni generali
Considerazioni generali
 Il solo ordine sociale legittimo universalizzabile è quello che si ispira ad un principio di comune umanità, di comune socialità, di individuazione, e di un conflitto che bisogna saper tenere sotto controllo e, quindi, creativo.....
Il solo ordine sociale legittimo universalizzabile è quello che si ispira ad un principio di comune umanità, di comune socialità, di individuazione, e di un conflitto che bisogna saper tenere sotto controllo e, quindi, creativo.....PER IL TESTO INTEGRALE, CLICCARE QUI DI SEGUITO: POSTFILOSOFIE. Anno 7/8. Numero 7. Convivialismo
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Verso una società conviviale. Una discussione con Alain Caillé (a c. di F. Fistetti e Ugo M. Olivieri).14 dicembre 2016, di Federico La Sala
SCHEDA EDITORIALE
EDIZIONI ETS
Una discussione con Alain Caillé sul Manifesto convivialista
A cura di: Francesco Fistetti e Ugo M. Olivieri /
Collana: Boulé. Collana di Filosofia e Scienze umane (15)
Pagine: 146 Formato: cm.14x21 Anno: 2016 ISBN: 9788846743824
Descrizione
Questo libro nasce dalla discussione a più voci dei temi del Manifesto convivialista, riproposti da Alain Caillé nell’intervista a Francesco Fistetti, che insieme con Elena Pulcini ne è uno dei primi firmatari. Al di là delle diverse prospettive intellettuali, gli autori convengono sull’urgenza improcrastinabile di scongiurare, pena la sopravvivenza della vita umana sulla Terra, i disastri imminenti o ormai in atto: ambientali, economici, sociali, morali. Perciò, si tratta di offrire un respiro teorico unitario ai vari movimenti sociali sorti dalla resistenza ad un capitalismo rentier e speculativo, che «è divenuto il nemico principale dell’umanità e del pianeta», e ciò al fine di dare una forma plausibile alle speranze di costruire un mondo comune, frugale e conviviale, che si lasci alle spalle il mito della crescita economica illimitata.
Francesco Fistetti insegna Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari. Dirige la collana «Humanities» presso la casa editrice Pensa Multimedia (Lecce/Brescia) e la collana «L’intreccio» presso l’editore D’Anna (Firenze). È condirettore della rivista «Post-filosofie», fa parte del comitato scientifico della «Revue du M.A.U.S.S». Tra i suoi lavori più recenti: Il Novecento nello specchio dei filosofi (D’Anna, 2013), Chiasmi filosofici tra Europa e America (Pensa Multimedia, 2015), Convivialità. Una filosofia per il XXI secolo (il nuovo melangolo, 2016).
Ugo M. Olivieri insegna Letteratura Italiana all’Università Federico II di Napoli. Tra i suoi interessi il romanzo dell’Ottocento e la teoria della letteratura (Lo specchio e il manufatto, Milano 2013). Ha curato l’edizione di vari classici tra cui I. Nievo, Opere II, 2015 presso l’editore Ricciardi). Lavora da vari anni sul tema del dono ed ha curato con A. Lucarelli, Dono e beni comuni, Napoli, 2013 e con R. Luzzi, Comunità e reciprocità. Il dono nel mondo antico e nelle società tradizionali, Napoli 2014.
- Questo testo è il compendio del Manifeste convivialiste , pubblicato il 14 giugno 2013 presso la casa editrice Le Bord de l’eau (ora disponibile in traduzione italiana: Manifesto convivialista, edizioni ETS, Pisa 2014). I lettori che saranno d’accordo con i princìpi qui esposti potranno testimoniarlo dichiarando il loro appoggio (www.lesconvivialistes.fr).
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- Privilegiare legami sociali e condivisione. Convivialità. L’alternativa all’utilitarismo (di Adriano Favole)29 giugno 2014, di Federico La Sala
Scenari. Un manifesto di studiosi invoca più solidarietà e più attenzione alla natura. Senza demonizzare conflitto e mercato
Convivialità. L’alternativa all’utilitarismo
Privilegiare legami sociali e condivisione. L’uomo non è una macchina calcolatrice
di Adriano Favole (Corriere della Sera - La Lettura, 29,06,2014)
Che cosa hanno in comune quelle migliaia o forse decine di migliaia di associazioni, movimenti, organizzazioni che si battono oggi in ogni continente per la cura e la salvaguardia del mondo e dell’umanità? Che cosa unisce i promotori delle economie sociali e solidali, i difensori dei diritti dell’uomo, della donna e dei lavoratori, gli inventori dei sistemi di scambio locale (dalle banche del tempo alle varie forme di volontariato), la rivendicazione del buen vivir, la ricerca di indicatori di ricchezza alternativi al Pil, Slow Food e gli Indignados, i promotori della sobrietà volontaria e i difensori dei beni comuni? Viviamo un’epoca caratterizzata da minacce incombenti: il riscaldamento globale, la crescita delle diseguaglianze e della disoccupazione, il proliferare delle mafie e della corruzione. L’insicurezza pervade una contemporaneità che spesso reagisce trasformando la sicurezza in un’ossessione. Il crollo dei sistemi politici del passato non è supportato da forme di immaginazione che ci aiutino a trovare nuove vie del vivere insieme in società di grandi dimensioni.
Viviamo però, ugualmente, un’epoca di speranze e di promesse: la democrazia si diffonde ovunque e anima movimenti contro i dittatori e contro la finanziarizzazione del mondo; le tecnologie informatiche promettono una maggior condivisione e partecipazione ai saperi e un accesso partecipato al potere; la ricerca mette a punto nuovi ed efficaci strumenti per la «transizione ecologica » verso forme di economia sostenibile.
È a partire da queste premesse e su proposta del sociologo francese Alain Caillé che un nutrito gruppo di intellettuali appartenenti a università e centri di ricerca americani, asiatici, mediorientali ed europei ha redatto e sottoscritto il Manifesto convivialista. Dichiarazione di interdipendenza, uscito di recente in Italia per le edizioni Ets. Tra i firmatari ci sono Edgar Morin e Serge Latouche, tra gli italiani Francesco Fistetti (autore di una lunga postfazione al Manifesto) ed Elena Pulcini.
«Convivialismo» è un neologismo coniato ad hoc, un termine che si vuole simbolo e bandiera di un filo capace di unire le pezze di un patchwork variegato e tuttavia forte e resistente. I convivialisti promuovono «l’arte di vivere insieme (con-vivere) che valorizza la relazione e la cooperazione e che permette di contrapporsi senza massacrarsi, prendendosi cura degli altri e della natura ». Se il Manifesto convivialista fosse stato redatto in italiano, forse i suoi promotori avrebbero scelto come nomi-simbolo il «con-vivere», il «con-dividere», la «con-vivenza» o un neologismo come «con-dividersi»: uno insomma di quei numerosi termini del «con-» che enfatizzano nella nostra lingua il «noi» piuttosto che l’«io», la relazione piuttosto che l’individualità. L’interdipendenza, richiamata nel sottotitolo del Manifesto, esprime una concezione relazionale della persona. Una concezione diffusa nell’humus culturale in cui il testo ha preso forma, quella del «Movimento anti-utilitarista delle scienze sociali», il cui acronimo (Mauss), riproduce il cognome di quel Marcel Mauss che novant’anni fa diede alle stampe il Saggio sul dono (Einaudi), svelando o ricordando all’Occidente l’esistenza di una logica economica alternativa o complementare a quella del mercato. Proprio all’inizio degli anni Ottanta, Caillé (Il terzo paradigma, Bollati Boringhieri, 1998) fu tra i fondatori del Mauss, che non ha mai cessato di perseguire una terza via da affiancare allo Stato e al mercato.
I convivialisti non sono contro il mercato e la loro ricerca di una miglior cura dell’umanità e del mondo non prescinde dal conflitto. «Il mercato e la ricerca di una redditività monetaria sono pienamente legittimi dal momento in cui rispettano i postulati di comune umanità e di comune socialità, e dal momento in cui sono coerenti con le considerazioni ecologiche». Quattro sono i principi che, nella filosofia dei convivialisti, dovrebbero animare la buona politica. Il principio di comune umanità afferma che esiste una sola umanità che deve essere rispettata nella persona dei suoi membri, al di là delle differenze di colore della pelle, nazionalità, genere, ricchezza ecc. Il principio della comune socialità afferma che la più grande ricchezza dell’umanità sono i rapporti sociali. Il principio di individuazione è quello che permette a ciascuno di sviluppare la «propria singolare individualità in divenire». Infine, il principio di opposizione controllata è quello che permette agli esseri umani di differenziarsi, accettando e controllando il conflitto.
In questo quadro il problema non è costituito dal mercato in sé: la madre di tutte le minacce che oggi affliggono l’umanità è piuttosto il neoliberismo, ovvero la mostruosa e indebita estensione dell’economia, della competizione e della ricerca del profitto individuale a (praticamente) tutte le sfere dell’agire umano. A partire dagli anni Settanta, la scienza economica e la sua creatura fittizia (l’homo oeconomicus) ha «cominciato ad estendere la validità potenziale delle sue spiegazioni all’integralità delle attività umane». Le complesse motivazioni che spiegano l’agire umano sono state ipersemplificate e ridotte al solo perseguimento dell’interesse individuale. Se «niente è fatto per senso del dovere, per solidarietà o per il gusto di un lavoro ben fatto e il desiderio di creare, allora non restano da attivare che le “motivazioni estrinseche”, ovvero il gusto del guadagno e della promozione gerarchica». Se arricchirsi è il primo scopo legittimo, se l’homo oeconomicus coincide con la natura umana, come stupirsi davanti al trionfo della finanza, ai paradisi fiscali, al dilagare della corruzione politica? Il fantasma della scienza economica diffusa a ogni livello della realtà ha colonizzato il mondo.
La madre di tutte le minacce è ugualmente rappresentata dall’idea che l’umanità possa perseguire una crescita economica infinita. Anche se Serge Latouche è tra i firmatari del Manifesto, i convivialisti in realtà non sono sostenitori della decrescita. Si tratta piuttosto di immaginare delle democrazie post-crescita: per promuovere l’uguaglianza di opportunità, il ben-vivere e la libertà di un crescente numero di persone nel mondo non ci si può più affidare al sogno di una crescita infinita che rischia di trasformarsi nel peggior incubo dell’umanità. Altre sono le ricette che i convivialisti cucinano per un rinnovamento della politica e dell’umanità: prima fra tutte una migliore distribuzione delle risorse attraverso l’adozione di un salario minimo e di un profitto massimo. In secondo luogo l’uso di nuove tecnologie al servizio della «transizione ecologica»; e ancora la considerazione delle reti telematiche come beni comuni accessibili a tutti. Il web, come l’acqua e l’aria che respiriamo, dovrebbe essere destinato a divenire in breve tempo uno dei commons sottratti alle dinamiche del mercato.
È insomma un ben-vivere a crescita zero quello che i convivialisti auspicano, insistendo sulla necessità di instaurare con la Natura un rapporto improntato alla logica maussiana del dono e della reciprocità. La relazione di dono e contro-dono dovrebbe esercitarsi soprattutto nei confronti degli animali, i quali «non devono più essere considerati come materiale industriale».
Espressione della corrente progressista, ma moderata, del Mauss, i firmatari del Manifesto non sono sognatori idealisti. Il conflitto, scrivono, è parte integrante delle relazioni sociali. Esso «esiste necessariamente e naturalmente in ogni società». Il problema però, ancora una volta, è che la svolta neoliberista degli anni Settanta ha trasformato il conflitto in una hybris incontrollata. L’aspirazione di ogni essere umano a vedersi riconosciuto nella sua singolarità si è tradotta nell’idea che comunque e dovunque l’uomo persegua il proprio interesse individuale (l’homo oeconomicus) o comunque un potere inteso come relazione gerarchica diffusa (l’homo strategicus che popola le narrazioni foucaultiane e agambeniane della contemporaneità).
Che fare dunque per valorizzare le ricchezze umane come la gratuità, la creatività, le relazioni con gli altri? Occorre indignarsi per la dismisura con cui alcuni perseguono il profitto attraverso la corruzione; rafforzare la consapevolezza di non essere soli, ma che ormai una comunità mondiale si batte per un mondo umanizzato («siamo il 99%», gridavano i giovani di Occupy Wall Street); occorre valorizzare la mobilitazione degli affetti e delle passioni, contro i cupi teorici delle «scelte razionali ». Su queste basi, concludono gli estensori del Manifesto, «sarà possibile per quelli che si riconoscono nei principi del convivialismo influenzare radicalmente i giochi politici istituiti e sviluppare tutta la loro creatività per inventare altre maniere di vivere, di produrre, di giocare, di amare, di pensare e di sognare». Serviva un nuovo Manifesto per indebolire il virus pan-economico che vaga per il mondo e cucire insieme le motivazioni di coloro che vi si oppongono, contribuendo a rafforzare la coscienza di appartenere a una comunità globale di antiutilitaristi? Forse sì, anche perché, come scriveva profeticamente Marcel Mauss nel Saggio sul dono, «sono state le nostre società occidentali a fare, assai di recente, dell’uomo un “animale economico”. Ma ancora non siamo diventati tutti esseri di questo genere. (...) L’uomo è stato per lunghissimo tempo diverso, e solo da poco è diventato una macchina, anzi una macchina calcolatrice».
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- A PIENE MANI. Una discussione su “Il Manifesto del Convivialismo” (Francesco Fistetti, Fabio Ciaramelli, Laura Pennacchi)29 giugno 2014, di Federico La Sala
A PIENE MANI dono dis-interesse beni comuni
 Una discussione su “Il Manifesto del Convivialismo”:
Una discussione su “Il Manifesto del Convivialismo”: intervento di Laura Pennacchi
intervento di Laura Pennacchi un intervento di Fabio Ciaramelli
un intervento di Fabio Ciaramelli un commento di F. Fistetti
un commento di F. Fistetti -
> NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento (di Nicola Fanizza)25 giugno 2014
Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento
di Nicola Fanizza
(L’Acropoli, n. 3, maggio 2014,
rivista bimestrale diretta da Giuseppe Galasso,
Rubbettino Editore)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA --- IL DONO E IL RIFIUTO DEL MERCATO (di Chris Carlsson)20 giugno 2014, di Federico La Sala
Il dono e il rifiuto del mercato
di Chris Carlsson (Comune-info, 12 febbraio 2014) *
Il dono è un concetto con molti significati diversi e contraddittori. Esiste perfino una storia buia del dono, che arriva fino ad alcune forme dell’”economia della condivisione”, ovvero quello che il capitalismo, travestendosi, fa da sempre: trasformare relazioni basate su cooperazione e solidarietà sociale in prodotti da vendere. Tuttavia, l’economia del dono che molti auspicano e alcuni sperimentano, è ciò che libera dalle relazioni di mercato e dal dominio del denaro, per proporre sistemi che cercano prima di tutto di ricomporre le relazioni tra le persone.
 Scrive Chris Carlsson: “Credo che la nostra speranza sia che quello spirito simile ai primi anni di vita nelle braccia delle nostre madri e dei nostri padri, dove tutto veniva offerto gratuitamente e con amore, possa essere la base di una trasformazione a livello sociale. Forse è possibile. Se ci riuniamo per discutere di queste idee ma dobbiamo sempre tornare a una vita dove la logica predominante è far soldi per pagare i conti, continueremo a pedalare a vuoto per un lungo tempo”
Scrive Chris Carlsson: “Credo che la nostra speranza sia che quello spirito simile ai primi anni di vita nelle braccia delle nostre madri e dei nostri padri, dove tutto veniva offerto gratuitamente e con amore, possa essere la base di una trasformazione a livello sociale. Forse è possibile. Se ci riuniamo per discutere di queste idee ma dobbiamo sempre tornare a una vita dove la logica predominante è far soldi per pagare i conti, continueremo a pedalare a vuoto per un lungo tempo”Il dono è apparentemente un concetto che si porta dietro un notevole peso specifico. Le persone lo usano in tutti i tipi di contesto e può contenere molti significati differenti, perfino riferirsi a cose completamente diverse. Per riflettere sulla nozione di economia del dono, è prima necessario avere un’idea abbastanza chiara su quello di cui si sta discutendo.
Alcuni prendono la nozione di dono e la collegano ai sentimenti che hanno provato quando ne hanno ricevuto uno, di solito una sorta di gratitudine e/o sorpresa. Non ci vuole molto perché questa percezione assuma una forma ulteriore e qualcuno inizi a rivivere momenti nei quali ha ricevuto qualcosa che inconsciamente dava per scontato e successivamente si è reso conto che avrebbe dovuto sentirsi grato per quella cosa. Per quelli con inclinazioni religiose, il concetto di dono diventa immediatamente un fulcro per ringraziare Dio per la vita stessa, o Gaia/Terra, oppure, se con una mentalità più secolare, per ringraziare le persone della propria vita per i doni del cibo, dell’acqua, persino dell’aria.
Penso che circoscrivere l’dea di un’economia del dono nell’ambito di queste modalità fortemente soggettive, spesso fondamentalmente spirituali, renda quasi impossibile affrontare l’enorme sfida di porre la logica del dono contro la logica del capitalismo. Il capitalismo è un sistema sorprendentemente complesso e adattivo di organizzazione sociale basata su classe, proprietà privata e scambio strettamente correlati in un regime produttivo concepito per crescere infinitamente. Proporre il dono come un’alternativa conduce a problemi immediati, poiché tende a rafforzare il punto di partenza della proprietà privata che può essere data da qualcuno a qualcun altro. (Mentre scrivo, la Tv in sottofondo trasmette uno spot per lo shopping natalizio incentrato su un personaggio che hanno soprannominato The Gifter - La Donatrice, ndt -. una donna impegnata in compere febbrili per donare dozzine di regali durante le festività). Inoltre, la nozione di regalo tende anche a dirigere la nostra attenzione sui beni e servizi che vengono dati (o ricevuti), piuttosto che sulle relazioni sociali, entrambi prerequisiti e risultati logici di una cultura di libera condivisione.
La storia buia del dono
I doni esistono da quando esiste lo scambio tra diversi gruppi di persone, fin dalla storia non scritta. L’’opera di David Graeber sul debito (Debt: The First 5000 Years) mostra come il denaro stesso sia nato da un processo di contabilizzazione che cominciò misurando le equivalenze tra regali. I regali erano usati in molte culture anche come meccanismo per cementare relazioni specifiche tra figure di potere, di solito uomini, o famiglie potenti. La storia buia dei regali è che sono anche il punto di partenza della schiavitù! Uomini potenti davano in moglie le loro figlie come dono ad altre famiglie per ragioni politiche, senza rispetto dei desideri delle donne coinvolte. L’idea che le persone fossero oggetti che potevano essere spostati come altre proprietà nacque da questi comportamenti primordiali, e alla fine ha distrutto la vita di milioni di individui nel corso dei secoli.
Nel Nord America c’erano centinaia di culture tribali diverse prima che arrivassero gli europei. Nell’estremo nord-ovest, vicino all’attuale Seattle, le popolazioni locali avevano la tradizione del potlatch un festival annuale in cui i capi locali più potenti competevano tra loro per vedere chi avrebbe sprecato la maggiore ricchezza al festival, al punto di distruggere in modo stravagante pelli, animali, utensili e cibo in una frenesia di mostrare il proprio vantaggio (cercando di svettare in maniera capovolta rispetto ai nostri standard contemporanei). Un’altra cultura tribale che dominò le Grandi Pianure meridionali dall’inizio de 1700 alla metà del 1800, i Comanches, aveva una politica estera economica basata sui doni e sul commercia e saccheggia. Mandavano carovane per il commercio e gruppi di guerra alle colonie spagnole (più tardi messicane) in Texas e New Mexico, e all’arrivo chiedevano doni a profusione ai loro ospiti. Se le elite locali decidevano di non soddisfare adeguatamente le loro richieste, i guerrieri attaccavano e prendevano quello che volevano in qualsiasi modo. Per i Comanches il commercio iniziava ricevendo doni materiali considerevoli, e solo poi seguiva il vero scambio. Senza il dono, la relazione si trasformava in forza bruta e gli stessi beni venivano presi senza alcuna reciprocità.
Reintrodurre meccanismi sociali
Tutto ciò è per dire che la nostra idea di dono e di economia del dono è, si spera, del tutto differente da quella che i secoli della storia umana suggeriscono. O forse no? E comune tra i radicali dell’inizio del XXI secolo attaccare i mercati e il denaro come meccanismi di oppressione se non una forma di schiavismo. Ma per molte persone che vivono nelle città comprare e vendere nei negozi da commessi anonimi è una sorta di libertà dalle complicate relazioni sociali correlate all’acquisto di beni in un luogo dove tutti ci conoscono e dove conosciamo tutti. La sola affidabilità di cui siamo responsabili è se abbiamo o non abbiamo abbastanza denaro. Per noi non ha alcuna importanza chi abbia prodotto quello che stiamo comprando, dove o come, né quali conseguenze ecologiche possano derivare dalla produzione. Che ci piaccia o no, anche questa è una forma di libertà, libertà dal dover tenere in considerazione tutti quelle complicate esternalità (come il capitalismo ama etichettarle). Se stiamo rifiutando la grande libertà che il mercato concede all’individuo (almeno a quelli che hanno risorse sufficienti per comprare e vendere ciò di cui hanno bisogno e ciò che vogliono), forse vogliamo davvero sostituirla con un sistema che unisca più strettamente le persone in relazioni che sono precisamente specifiche. Forse stiamo proponendo un’economia del dono come una modalità per disfare l’anonimato della vita moderna e reintrodurre meccanismi sociali di affidabilità e responsabilità che sono stati distrutti dall’unico sistema di misurazione rimasto: i soldi. Forse desideriamo davvero l’idea di un’economia del dono per tornare a relazioni de visu dove dobbiamo prendere decisioni su cosa facciamo, perché, come e con chi? Ma questo può crescere fino a fare l’acciaio? A costruire ponti? A far muovere complessi sistemi sotterranei? A continuare a far uscire l’acqua fresca l’acqua c dai milioni di rubinetti? Come potrebbe funzionare?
Penso sia importante per chiunque proponga un’economia del dono come alternativa alla vita quotidiana di oggi essere chiaro su ciò che comporta. Penso che dovremmo proporre il dono come un mezzo per una decommodification dei beni che produciamo collettivamente e da cui dipendiamo per la nostra riproduzione. Il dono dovrebbe essere un modo di dimostrare la nostra intenzione di spostare sempre di più la vita materiale dal regno della proprietà privata a un nuovo tipo di diritti. Se questa è la nostra intenzione, allora abbiamo grandi problemi politici! La maggioranza delle persone sta dalla nostra parte? Come le convinciamo? Come spieghiamo alla gente che ancora non vede positivamente questa trasformazione che la loro vita sarà molto migliore durante e dopo la transizione? Possiamo cominciare a creare le pratiche sociali che ci permettono di riprodurre una vita complessa, per lo più urbana per milioni di persone, sulla base di produttori che si associano liberamente e che mettono a disposizione gratuitamente competenza e tempo e, nello stesso momento, altrettanto gratuitamente, ottengono l’accesso al cibo, alla casa, all’energia, ai trasporti, alle comunicazioni, ecc. di cui hanno bisogno per vivere?
Libertà dalle relazioni di mercato?
Possiamo vedere piuttosto facilmente che non stiamo parlando di comportamenti personali, scelte e preferenze (sebbene ne facciano parte), bensì di proposte per nuovi sistemi di vita sociale. Ma cosa stiamo proponendo? Più libertà? Meno? Libertà dalle relazioni di mercato? Libertà dall’anonimato e dalle conseguenti anomie sociali? Ma un sistema in cui dovessimo decidere ogni singolo componente delle nostre vite materiali non sarebbe un nuovo tipo di oppressione? Come potremmo organizzare una complessa società tecnologica, prevalentemente urbana in modo da poter tutti lavorare molto meno, amare il lavoro che facciamo perché lo scegliamo liberamente e lo controlliamo democraticamente, e assicurarci che non stiamo distruggendo l’ecologia planetaria producendo “abbastanza” per tutti? In che modo decideremmo quanto sia abbastanza? Come apparirebbe e cosa vorrebbe la democrazia una volta avviato il meccanismo per gestire collettivamente la riproduzione materiale di una società urbana complessa?
L’idea di una cultura del dono è certamente un buon punto di inizio per pensare a queste cose, ma non se fermiamo il processo al ringraziamento perché respiriamo, mangiamo o per la luce del sole. Ringraziare è un bel gesto di solidarietà sociale, ma non è minimamente sufficiente. Spesso ho dovuto convenire sul fatto che meglio è meglio di peggio quando si fa riferimento a un intero complesso di scelte inadeguate, ma anche se è meglio acquistare cibo biologico sano, o sponsorizzare una piccola attività di amici o lavorarci invece che lavorare in un grande centro commerciale come Walmart, o andare in bicicletta anziché che in auto, non è abbastanza! Le scelte dei consumatori non sono molto importanti quando si parla di cambiare vita (naturalmente, fate le scelte migliori invece di quelle peggiori se potete). Detta in maniera semplice, non la nostra via verso una nuova vita non è acquistabile.
La condivisione? Si può vendere
Questo ci conduce faccia a faccia con la crescente presenza di uno dei più recenti slogan commerciali del capitalismo, l’”’economia condivisa”, di solito fondata su un altro concetto in voga, quello di imprenditorialità sociale. Questo spazio scivoloso del mondo degli affari pretende di essere qualcosa di nuovo, mentre in realtà è piuttosto familiare. E quello che il capitalismo ha fatto incessantemente dall’inizio: convertire normali comportamenti umani basati sulla cooperazione, la condivisione e la solidarietà sociale in prodotti da vendere. Fin quando le persone prendono il loro tempo e le loro competenze e risorse fuori dal mercato e le rendono disponibili gratuitamente ad altri, aiutando le persone a usare il benessere condiviso per ridurre la loro dipendenza dal denaro e dall’’acquisto di beni nel mercato, le pretese di una “nuova economia” che sfida i paradigmi del capitalismo hanno ragione d’essere. Ma laddove manchi questa deliberata rottura con i mercati, il denaro, il lavoro salariato e la proprietà privata, assistiamo in realtà all’’espansione delle relazioni sociali capitaliste in aree che non erano ancora colonizzate da quella logica.
La buona volontà è importante. Il desiderio di aiutare e sostenersi reciprocamente sono pietre fondanti della solidarietà sociale. Ma la confusione su ciò contro cui stiamo combattendo è probabilmente uno dei nostri maggiori problemi. Non saremo in grado di creare affari per spodestare il business! Una economia del dono degna di questo nome implica una trasformazione massiccia di dimensioni alle quali, francamente, la maggior parte di noi ha paura di pensare. Apprezzo i miei amici con cui ho soprattutto goduto una generosità e una reciprocità incommensurabili. Credo che la nostra speranza sia che quello spirito simile ai primi anni di vita nelle braccia delle nostre madri e dei nostri padri, dove tutto veniva offerto gratuitamente e con amore, possa essere la base di una trasformazione a livello sociale. Forse è possibile. Ma se così è, dovremo comprendere il dibattito politico le dinamiche istituzionali ultime che faciliteranno una tale trasformazione. Non accadrà solo perché lo desideriamo, o perché proviamo molto amore per coloro che ci circondano. Se ci riuniamo per discutere di queste idee ma dobbiamo sempre tornare a una vita dove la logica predominante è far soldi per pagare i conti, continueremo a pedalare a vuoto per un lungo tempo a venire.
* Chris Carlsson, scrittore e artista da sempre nei movimenti sociali statunitensi, è stato tra i promotori della prima storica Critical mass a San Francisco e autore, tra le altre cose, dell’ottimo «Nowutopia» (Shake edizioni) e, più recentemente, di «Critical mass. Noi siamo il traffico» (Memori). Invia periodicamente i suoi articoli, molti dei quali raccolti su nowtopians.com, a Comune-info: il saggio qui pubblicato è stato scritto in occasione del Giftval (neologismo che lega dono e festival), ospitato a Gezi Park, Istanbul (Turchia), lo scorso ottobre.
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- In una biografia, la storia di Eleanor Marx (di Siegmund Ginzberg - Mio padre si chiamava Karl Marx)14 giugno 2014, di Federico La Sala
Mio padre si chiamava Karl Marx
Il comunismo, il rapporto con Engels, gli amori sfortunati e la militanza
In una biografia uscita in Inghilterra la storia di Eleanor detta “Tussy”
di Siegmund Ginzberg (la Repubblica, 14.06.2014)
Poco prima delle 10 del 31 marzo 1898, Eleanor Marx, allora poco più che quarantenne, inviò la fedele cameriera Gertrude in farmacia a comprare del cloroformio e una piccola quantità di acido di cianuro. “Per un cane”, aveva scritto nel bigliettino indirizzato al farmacista. La trovarono morta, vestita con un abito tutto bianco fuori stagione. Sulla scrivania dello studio c’erano i giornali con deprimenti notizie sugli scandali di corruzione in tutta Europa, che lambivano anche la sinistra, la corrispondenza con il sindacato dei minatori e altri esponenti socialisti.
C’erano poi le bozze di Valore, prezzo e profitto , l’opuscolo del padre che lei aveva scoperto e si accingeva a pubblicare con una propria prefazione (“da Sonnenschein, che è un ladro, ma tutti gli altri editori con cui ho provato non l’hanno voluto”), e i lavori preparatori per una biografia del padre che non era mai riuscita a completare. “Tutto sommato Marx il politico (Politiker) e il pensatore (Denker) possono andare, ma dal punto di vista umano forse un po’ meno” aveva scritto alla sorella maggiore Laura. Era stato durissimo per lei scoprire che Freddy, il figlio della cameriera di sua madre, Helene Demuth, era invece figlio di Karl Marx.
“Eleanor, non sposata, suicidio per ingestione di cianuro, sotto stress mentale”, scrisse il medico legale. In realtà non era “single” ma aveva convissuto per quasi vent’anni con Edward Aveling, mantenendo la sua vita dispendiosa e tollerando le sue continue scappatelle. Lui era già sposato, ma non le aveva mai detto che la prima moglie era deceduta da tempo e lui aveva incassato e sperperato l’eredità. Solo il giorno prima del suicidio lui le aveva confermato quello che già tutti gli altri sapevano, che si era risposato un’altra volta ancora, in segreto, con un’attricetta. Lei finalmente lo aveva diseredato in extremis, ma il codicillo era stato fatto sparire. Si disse dallo stesso Aveling, che aveva frugato tra le sue carte in presenza del cadavere. Anzi, corse voce che addirittura fosse stato lui ad assassinarla. Lui morì l’anno seguente, dopo aver sperperato in pochi mesi anche l’ingente patrimonio che lei aveva ereditato dal suo “secondo padre”, il “vecchio generale” come lo chiamavano in famiglia, Friedrich Engels.
La stampa si buttò a pesce sulla notizia. Scrissero che era la dimostrazione del fallimento morale dello stile di vita del “libero amore” socialista. Scrissero che lei si era suicidata perché lui aveva deciso di tornare a vivere con la prima moglie e i figli e voleva imporle un mènage a tre. Questo era pura invenzione, la prima moglie era morta da tempo. A prendere le difese del “buon nome” del socialismo fu Eduard Bernstein, il leader riformista e “revisionista” della socialdemocrazia tedesca. Scrisse un opuscolo sull’“enigma psicologico” di una donna in preda ad un “malessere morale”, simile a quello di “ Frau Alving”, la protagonista degli Spettri di Ibsen.
Quello della figlia più piccola e preferita (“Tussy - questo il nomignolo di Eleanor - è me” soleva dire il vecchio Karl) non fu l’unico suicidio in casa Marx. Anni dopo, nel 1911, si sarebbero uccisi anche Laura e il marito parlamentare Paul Lafargue, iniettandosi cianuro nelle vene. Ma erano ormai vecchi (si avvicinavano alla settantina) e malati, è un caso diverso, la si potrebbe definire auto-eutanasia. Quella volta, a difendere la loro scelta, al posto di Bernstein, fu Lenin. In modo alquanto agghiacciante: “Comprensibile quando si sente di non poter più lavorare per la rivoluzione”.
Ma certo i grandi padri spesso sono ingombranti. Sigmund Freud non era stato un modello di padre, anche se 4 delle sue 5 sorelle non morirono suicide ma nei campi nazisti. Gandhi era stato un pessimo padre e marito. Il figlio di Einstein, Eduard, morì in manicomio. Per non parlare dei figli che Mao abbandonò durante la Lunga marcia e di Svetlana, figlia di madre suicida, che per sottrarsi al padre Stalin dovette scappare in America.
Eppure Eleanor non era affatto una donna sprovveduta. Era la più intellettuale e politicamente attiva della sorelle Marx. Era una femminista combattiva in un’epoca in cui le donne non avevano accesso né al voto né agli studi. È sua la prima traduzione in inglese di Madame Bovary e la messa in scena di diversi dei drammi di Ibsen (fu lei a recitare Nora alla prima londinese di Casa di bambola ). Come il padre adorava Shakespeare e Balzac. Ancora adolescente scriveva lunghe lettere di “consigli politici” ad Abraham Lincoln (che Marx naturalmente si guardava bene dallo spedire). Assieme ad Aveling aveva scritto un libro sul “Socialismo di Shelley” e partecipava a tutte le iniziative sindacali e politiche in tutta Europa.
Aveva fatto da segretaria e assistente di ricerca del padre. Alla morte di Engels fu lei a tentare di trascrivere il Quarto libro del Capitale e mettere insieme il suo carteggio. Fu lei a recuperare l’ebraismo con cui il padre aveva chiuso con la giovanile Questione ebraica rivendicando con orgoglio le proprie origini e mettendosi addirittura a studiare lo yiddish: “Mio padre era ebreo ...la lingua degli ebrei ce l’ho nel sangue... in famiglia dicono che assomiglio a mia nonna paterna, che era figlia di un dotto rabbino”. Lasciando perdere il fatto che la nonna si era arrabbiata moltissimo quando Karl aveva deciso di sposare l’aristocratica prussiana Jenny Von Westphalen, anziché una brava ragazza ebrea.
È fresco di stampa Eleanor Marx. A Life di Rachel Holmes (già autrice di successo di una biografia della Venere Ottentotta), pubblicata per i tipi di Bloomsbury. Mi sono chiesto anch’io se servisse un nuovo libro sull’argomento dopo The Life of Eleanor Marx: A Socialist Tragedy di Chusichi Tsuzuki (1967) e il monumentale lavoro di Yvonne Kapp (1972).
Ebbene, è diverso. Un’interpretazione più “moderna”, se così si può dire, più rispondente forse ai gusti dell’epoca dei pettegolezzi da tabloid, dei sitcom, reality e teleromanzi, anche se fondati su ricerche meticolose nelle lettere, nei diari e nei “sentiti dire” dei protagonisti.
L’autrice confessa di sperare che possa essere trascinato dal successo editoriale del Capitale nel XXI secolo di Piketty (80.000 copie solo nelle prime settimane, mentre il primo libro di Das Kapital nel 1867 aveva trovato pochissimi lettori). Glielo auguriamo. Anche Il Capitale di Marx era, a modo suo, un romanzo. La struggente telenovela su Eleanor tocca tasti ancora più universalmente umani.
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’AMORTE E I "NESSI". Alessandro Bergonzoni, connessi alla vita. Intervista (a c. di Anhela Calvini)9 giugno 2014, di Federico La Sala
Intervista
Bergonzoni, connessi alla vita
di Angela Calvini (Avvenire, 9 giugno 2014)
Restare connessi alla vita reale, in un mondo che si illude di essere unito grazie alla tecnologia. I “nessi” di Alessandro Bergonzoni hanno a che fare con la vita e con la morte, con i fili che ci legano gli uni agli altri. Fili che l’artista bolognese muove da perfetto burattinaio della parola nel nuovo spettacolo Nessi, applauditissimo al Teatro Elfo Puccini di Milano, avvolgendo in una morsa “pensante” il pubblico proprio nel momento in cui questo abbassa le difese davanti alle armi della comicità.
Bergonzoni, dopo trent’anni in scena, quattordici spettacoli, svariati romanzi, un costante impegno nel sociale (l’ultimo coi ragazzi del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino), oggi arriva a una svolta. Non a caso l’artista debutta nella poesia con la nuovissima raccolta L’amorte edita da Garzanti (pagine 164, euro 12,00). Una svolta più vicina al cuore del pubblico, meno cerebrale, dove la “meraviglia” del coltissimo gioco di parole rallenta il ritmo per accompagnarci, passo passo, verso una nuova coscienza. «È finito il tempo dei leader. Falcone, Mandela, don Diana siamo noi - grida dal palco -. Non possiamo più nasconderci dietro a un “non ci riesco”».
Bergonzoni, quali sono questi nuovi “nessi”?
«Non hanno a che fare con la connettività di internet che usiamo quotidianamente. I nessi hanno a che fare con i legami e i legacci dell’uomo che da quando nasce a quando muore annodano le persone. Con i lontani, gli sconosciuti, gli evitati. Grazie alla rete pretendiamo di essere dappertutto e con chiunque, ma il nostro corpo, la nostra mente e la nostra anima non sono accanto a nulla. Attraverso i media crediamo di avere esaurito la nostra conoscenza. Occorre invece una rinascita, occorre risorgere».
Da dove ripartire, allora?
«Attraverso la comicità, le forme d’arte e, soprattutto, la poesia noi riusciamo a stabilire un contagio, una vicinanza, una presenza e anche un cambiamento. Prima della politica, bisogna parlare di ante-politica. E quello che viene prima è la poetica. Noi invece effettuiamo dei “geniocidi”, l’assassinio della parte più artistica, poetica e metafisica che è in noi: è il più grande obbrobrio che possiamo commettere».
Il suo spettacolo suona come un invito a tornare a un concetto “antico”, quello della partecipazione.
«Non possiamo più permetterci di cercare un leader, ma dobbiamo diventare noi stessi leader del nostro partito politico, della nostra Europa, della nostra Italia e del nostro cosmo. Noi siano diventati Falcone e Borsellino e dobbiamo smettere di pagare il pizzo alle nostre ’ndranghete che sono certe pubblicità, certi non ci riesco, certi non posso, certa televisione, certa radio. L’artista è il pubblico, il nostro è un lavoro artistico comune. Il bene comune è quello che si vuole a quelli che non si conoscono».
Bergonzoni, il suo è comunque un discorso “politico”.
«La gente oggi si ribella, ma non occorre cambiare partito, occorre cambiare spartito. Spartito musicale interiore. Ovviamente esistono la democrazia e il voto. Ma noi votiamo ogni giorno: quando guardiamo un handicappato, quando ne abbiamo fastidio, quando non sopportiamo la morte. Siamo sempre alle urne. Nello spettacolo dico: “Io non posso mica, mio non riesco mica: chi è questo mica che non ci permette di operare?”. Noi siamo opere d’arte, operanti e operabili. Io non posso più fare solo lo scrittore, l’artista, l’attore e poi sono a posto con la vita. Io devo cominciare quello che è considerato il dovere degli altri».
Nello spettacolo, lei dice essere stanco delle divisioni in categorie, anche fra credenti e non credenti...
«Innanzitutto sono insofferente verso certi cambiamenti superficiali. L’esoterismo e la new age sono sempre in agguato, con un atteggiamento estetico (e statico) che si limita a lanciare mode alimentari. Il cambio va fatto con un moto interiore. Non parlo di religione, o di dogmi. A me interessa la spiritualità, la metafisica, la surrealtà, l’oltre. Nello spettacolo dico che non sopporto di dividere il mondo in credenti, non credenti, laici e quant’altro. A me interessano i non creduti e gli incredibili, i non veduti e non visibili».
Tutto questo a che fare anche con il suo impegno con la “Casa dei risvegli di Luca De Nigris” di Bologna?
«Certamente. Il mio lavoro con loro si è ampliato. Il 10 giugno sarò a Varese per un incontro pubblico con un neurologo sul tema “La coscienza della cura”. Il concetto di “curabile” è più importante di “guaribile”. Dicono che una persona quando guarisce si salva: no, quando è curata si salva. La “Casa dei risvegli” mi ha dato la possibilità di avvicinare la vita e “la vita della morte”. È proprio quello che ispira il mio libro di poesie L’amorte».
Vita e morte si intrecciano sempre più nel suo percorso artistico.
«Non possiamo separare vita e morte, davanti alla Siria, agli immigrati, a quello che è costante sacrificio umano. Quando mi piego dietro un bidone della spazzatura per allacciarmi una scarpa devo essere in connessione con un siriano che in questo momento è dietro un bidone perché un cecchino gli sta sparando. Noi siamo invocati da quelli lontani da noi. Io non voglio amici di Facebook. Nel mio sito www.alessandrobergonzoni.it lancio il progetto artistico Vite in fasce [che è anche il monologo finale dello spettacolo di cui proponiamo un estratto, ndr]. Pubblico il numero aggiornato delle morti e delle nascite nel mondo: quelli sono tutti gli amici che avevo, e sono tutti gli amici nuovi che avrò. Sono stanco dell’umanità, a me interessa la sovrumanità. Altrimenti l’uomo resta solo un uomo».
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Alle radici dell’intolleranza. «Elogio del politeismo» di Maurizio Bettini: rec. di Luigi Spina.9 giugno 2014, di Federico La Sala
Alle radici dell’intolleranzaRecensione del libro del filologo Bettini «Elogio del politeismo» che parte dall’idea che ci possa essere qualcosa da imparare dalle religioni antiche esempio di tolleranza
- Duemila anni di monoteismo ci hanno abituato a ritenere che Dio non possa essere se non unico, esclusivo. Al contrario, il politeismo antico prevedeva la possibilità di far corrispondere fra loro dèi e dèe appartenenti a culture diverse, ovvero di accogliere nel proprio pantheon divinità straniere. Questa disposizione all’apertura ha fatto sì che il mondo antico non abbia conosciuto quella violenza a carattere religioso che invece ha insanguinato, e spesso ancora insanguina, le culture monoteiste. È possibile attingere oggi alle risorse del politeismo per rendere più agevoli e sereni i rapporti fra le varie religioni? È quello che si chiede Maurizio Bettini nel suo libro. ...
di Luigi Spina (l’Unità, 08.06.2014)
PER PARLARE ADEGUATAMENTE DELL’ «ELOGIO DEL POLITEISMO » DI MAURIZIO BETTINI, È DOVEROSO TRACCIARE PRIMA UN BREVE ELOGIO DELLA COMPARAZIONE ANTROPOLOGICA, che è il metodo che più volte l’autore richiama come guida della sua analisi. A differenza dell’analogia, che schiaccia il nuovo sul già conosciuto (non si contano gli Hitler, i Mussolini e gli Stalin che si sono susseguiti nella politica italiana), la comparazione distingue le due realtà, quella che si conosce e quella che si vuol comparare, per coglierne soprattutto le differenze e le singolarità.
Ecco, completato il mini-elogio della comparazione, si può cominciare a dire che il saggio di Bettini affronta un tema non usuale: l’idea che ci possa essere qualcosa da imparare dalle religioni politeiste antiche. Farne materia di ricerca sì, ma pensare che si possano importare, per quanto criticamente, idee e comportamenti da qualcosa che non rientri nella dialettica fra le tre religioni monoteiste e la non religiosità non è pensiero ricorrente.
Proprio nell’Introduzione, Bettini propone un argomento convincente: di Platone, di Aristotele, di Agostino, della democrazia antica non si può fare a meno di parlare, qualsiasi argomento attuale si voglia affrontare; difficile invece che si parli della religione antica, politeista. Il volume è organizzato in 15 capitoli e due appendici.
I titoli dei capitoli offrono i terreni della comparazione: dal presepio e dalle moschee alle statuette romane e al larario; dalla proclamata unicità del Dio alla possibilità di riadattare gli dèi; dai possibili contatti sotterranei fra monoteismi e politeismi alle strutture sociali e comunitarie nelle quali la/le divinità si insediano; dalla pregnanza delle parole, infine, ai paradossi della/e scrittura/ e. Le appendici approfondiscono due temi: la tolleranza e l’intolleranza; gli usi e i significati del termine paganus.
Fra gli elementi positivi, in base ai quali il politeismo antico potrebbe far riflettere meglio sulle rigidità del monoteismo c’è sicuramente la curiosità, anche di massa, che costituiva la molla per conoscere davvero il funzionamento di religiosità diverse dalla propria. L’ostacolo dell’unicità condiziona quello stesso dialogo interreligioso che rimane, comunque, un tentativo auspicabile per mantenere aperto un canale comunicativo e di reciproca conoscenza.
Quando Papa Benedetto XVI richiamò, nel 2006, la controversia del 1391 fra Manuele II Paleologo e un maestro persiano, un mudarris di fede musulmana, non fu difficile constatare che non si trattava di un vero dialogo, ma di una specie di doppio monologo, come scriveva proprio Théodore Koury, il filologo a cui lo stesso Ratzinger si riferiva. D’altra parte, la scoraggiante presa d’atto non riguardava solo la controversia antica ma anche le modalità con cui furono lette le parole del Papa.
Il rapporto con la (o le) divinità altrui è la cartina di tornasole che Bettini sperimenta per comparare la cultura romana e le culture odierne, in uno scavo che è contemporaneamente antropologico e linguistico. Non si può prescindere dal modo in cui gli antichi hanno denominato un fenomeno, una pratica, un oggetto, e dal modo in cui, spesso, sono i moderni a rinominare quello stesso dato, cercando di retrodatarne la sostanza e mascherando, in tal modo, i differenti quadri mentali.
La raffigurazione del politeismo da parte dei moderni avviene attraverso termini che non corrispondono quasi mai alla denominazione da parte delle culture antiche, l’unica che consentirebbe di capire effettivamente cosa gli antichi stessi intendessero. Questa indagine, che Bettini conduce con grande chiarezza si concentra su termini per noi familiari quali politeismo, e il corrispettivo monoteismo, pagano, idolatria ecc., ma la cui storia, il cui uso, presenta molti aspetti più complessi e spesso inattesi.
La traducibilità degli dèi, cioè la possibilità di accogliere divinità di altre culture nella propria, rinominandole, riconoscendo loro nuove funzioni, rappresenta il vero punto originale del politeismo antico. In quel mercato comune della divinità non era un problema inserire nel contatto fra i popoli e le culture i rapporti fra le divinità, in una tendenza all’inclusione e all’allargamento, piuttosto che all’esclusione e alla reductio; la traducibilità tra divinità, inoltre, non consente di identificare superficialmente quelli che potrebbero sembrare suoi inaspettati residui nelle religioni monoteiste, come per esempio, in quella cattolica, il culto dei santi. Le funzioni che si attribuiscono alla Madonna e a molti santi, di patronato, di assistenza, di protezione mancano del requisito della traducibilità, della trasferibilità, per cui mantengono quella che Bettini definisce una pluralità esclusiva.
Un’attenzione particolare Bettini dedica alla tolleranza, che è termine moderno altrettanto abusato che contestato, in quanto conserva insieme un valore tendenzialmente positivo e un rischio negativo di tipo etimologico. Non a caso la tolleranza è contrapposta alla interpretatio degli dèi, quel carattere di traducibilità che percorre tutto il libro. L’interpretatio è quella traducibilità potenziale che viene stabilita attraverso la mediazione, il compromesso che presiede a qualsiasi negoziazione perché abbia un buon esito.
Si capisce, dunque, come la tolleranza, spesso sentita come punto di avvio di un dialogo fra diversi, marchi nello stesso tempo la gerarchia fra i diversi stessi: il rispetto che si sottintende nel termine cela, infatti, la sofferenza della accettazione risolta solo da un’etica caritatevole che sa anche tollerare gli errori. Se non si pensasse di possedere l’unica verità, forse, non scatterebbe la vocazione alla tolleranza.
Connesso al tema della tolleranza è quello della violenza, dello scontro di carattere religioso. Che le divinità dei Greci e dei Romani fossero coinvolte nelle guerre umane, che fossero immaginate addirittura in guerra fra loro, ciò non toglie che questo scontro non avesse per nulla carattere religioso, ma che la religione rappresentasse, anzi, un motivo per attenuare lo scontro stesso. Tanto più che le divinità facevano parte sostanziale delle comunità, in particolare attraverso quei riti di attribuzione della cittadinanza che Bettini ben spiega.
Nel capitolo che non a caso si intitola «Il sacrificio del presepio e le bombe della moschea», Bettini affronta un tema divenuto di forte attualità da qualche anno in occasione delle feste natalizie, da quando, cioè, la presenza del presepio o del Crocifisso, simboli del cristianesimo, nei luoghi pubblici dello Stato (scuole, tribunali), è diventato argomento di polemica; allo stesso modo, Bettini segnala le polemiche contro la costruzione di una moschea in Val d’Elsa.
Questo tema riassume i termini della comparazione possibile fra politeismi e monoteismi nella vita non solo religiosa di una comunità. Entrambe le reazioni, la rinunzia al presepio proposta da alcuni insegnanti e genitori di scuole italiane come gesto di rispetto verso altri culti e, dall’altra parte, la protesta di segno opposto, mostrano come al fondo delle due opzioni vi sia un unico vincolo: l’unicità del dio nel quale si crede, al punto che la scelta si può dividere fra: se non quello, meglio nessuno.
Eppure, il presepio mi pare possa rappresentare ancora uno spazio nel quale simboleggiare le dinamiche interne a comunità che hanno nella diversità religiosa fra monoteismi un punto vulnerabile.
La grotta del presepio mi sembra abbia perso la sua posizione centrale, per la spinta a dare voce e spazi a presenze le più varie, fino all’irruzione, grazie ai ben noti artigiani napoletani, di personaggi dell’attualità. Una sorta di cittadinanza riconosciuta a elementi estranei alla tradizionale ambientazione del presepio potrebbe essere la chiave di volta per aprirlo a una vera tensione politeista, sperimentando un quadro mentale che adottasse gli schemi della traducibilità, della mediazione negoziata: un inizio in cui una nuova cittadinanza risulti visibile e leggibile, per dèi, uomini e donne, ciascuno con le proprie credenze e divinità e, anche aggiungerei, in assenza di esse.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- Cacciari nel «labirinto» del Moderno demoniaco e inattuale (di Giuseppe Cantarano)5 giugno 2014
Cacciari nel «labirinto» del Moderno demoniaco e inattuale
Il nuovo testo del filosofo che fa ritorno alla nostra concreta esistenza
di Giuseppe Cantarano (l’Unità, 05.06.2014)
IL MODERNO - È STATO PIÙ VOLTE DETTO - È COME UN LABIRINTO. MA UN LABIRINTO UN PO’ PARTICOLARE. Perché, sebbene vi sia un centro, questo centro è in realtà vuoto. Non contiene, non custodisce, non nasconde, diciamo così, nessuna Verità. Nessuna salvezza. Non solo. Ma le molteplici vie - i molteplici percorsi - che lo costituiscono a volte si incontrano, si intersecano, si annodano in un groviglio apparentemente inestricabile. Per poi di nuovo separarsi, dividersi, allontanarsi. Sentieri - percorsi - tutti diversi. Inassimilabili. Ciascuno geloso della propria irriducibile, intraducibile singolarità. Della propria distinta identità. Del proprio inconfondibile timbro linguistico. Sentieri - percorsi - tutti differenti. Eppure tutti «identici». Perché tutti hanno in comune l’identico labirinto che li contiene. Quel labirinto le cui vie sono - di volta in volta - tratteggiate, segnate dal loro stesso cammino. Dal loro stesso procedere. Che a volte improvvisamente e inaspettatamente si arresta, si interrompe - come i sentieri di un bosco - per tornare indietro. E per intraprendere un altro cammino. Un’altra direzione. Poiché se è vero che in questo curioso labirinto - che è la filosofia - non c’è un centro, è altrettanto vero che non c’è un’unica via d’uscita prestabilita, predeterminata. Ecco perché ciascun sentiero filosofico è «condannato» a costruirsela, a trovarsela da sé, la via d’uscita.
Metafora del Moderno, questo strano labirinto è però il luogo dove l’interrogazione della filosofia non ha smesso mai di aggirarsi, di avventurarsi, se ci pensiamo bene. È il luogo da dove i molteplici e differenziati percorsi della filosofia non riescono ancora a congedarsi. Perché nessuno è sinora riuscito a crearsi la propria via d’uscita. Mentre il centro è sconsolatamente, disperatamente vuoto. E non c’è più alcun motivo, alcuna ragione, alcun senso per soggiornare in esso.
È a questo paradossale labirinto filosofico che Massimo Cacciari ha dedicato il suo ultimo bel libro, Labirinto filosofico, (Adelphi, pp.348, euro 38,00 ). Un libro «inattuale». Controcorrente, diciamo così. E a suo modo «demoniaco », se vogliamo. Perché non si può certamente scrivere un libro come questo, se non si è spinti, trascinati quasi a farlo da quel demone - di cui parlava Socrate - che abita in ciascuno di noi. E che ci obbliga incessantemente a interrogarci. A tornare a interrogarci ancora sulle «cose ultime». Che ci obbliga, insomma, a far ritorno alla metafisica. E alle sue «eterne» questioni. Troppo frettolosamente - e, peraltro, con puerile ingenuità - liquidate dalle correnti mode filosofiche. Che hanno contribuito a inaridire la filosofia. Relegandola nell’astrazione degli specialismi accademici. Dove agonizza ormai da troppo tempo. Lontano dalla vita. Lontano da quelle domande che cercano di scuoterla. Di acciuffarla. Di «curarla».
Far «ritorno» alla metafisica, per Massimo Cacciari, è tornare infatti a prendersi cura soprattutto di quella «cosa ultima» che è il nostro esserci. La nostra concreta esistenza. Ma senza l’amore - senza la philia - nessun sapere - nessuna sophia - sarebbe davvero in grado di corrispondere a questa disperata «vocazione terapeutica». Perché è vero che è la meraviglia - thauma -, lo stupore per le cose esistenti che muove l’interrogazione della filosofia. È vero - come scrive Cacciari - che «metafisica è l’interrogazione intorno alla physis dell’ente che ci ha tremendamente meravigliato».
Certo, la prima domanda della filosofia scaturisce dallo stupore per le cose esistenti:« Che è “questo” che ci sta di fronte? È qualcosa, certamente - osserva Cacciari -. Da Dove? Perché qualcosa esiste?».
Ma cos’è che tremendamente ci meraviglia, ci spaventa - delle cose che esistono - se non l’angosciante esperienza che noi facciamo del loro dileguamento? Se noi non amassimo le cose che esistono - e le creature che vivono - perché dovremmo tremendamente meravigliarci - angosciarci - del loro dileguamento? Il thauma - la paura più tremenda - è il fatto che dobbiamo morire, ci dice Cacciari.
Ma il nostro pensiero - il «divino», il trascendente che è in noi - si ribella a questa «apparente» evidenza. È l’angoscia della nostra morte che ci costringe a pensare. A filosofare. Che ci costringe a trascenderci.
Ecco perché la filosofia - come erroneamente si crede - non potrebbe mai essere una «cura» per il morire. Non potrebbe mai essere una preparazione alla morte - melete thanatou. Ma è «cura- angoscia contra il nudo fatto che moriamo », precisa Cacciari. È davvero mortale il soffio che dà vita al nostro corpo? Può davvero spegnersi il principio della nostra vita? Siamo davvero convinti che tutto, nel divenire, sia destinato al nulla? Siamo davvero sicuri - si chiede Cacciari - che per «guarire» dall’angoscia della morte, dobbiamo rassegnarci ad abbandonare il nostro corpo - che è soltanto dolore e sofferenza - e «correre a morire, correre incontro alla sua morte per poter credere alla immortalità della pura anima»?
No, la filosofia non è cura per la morte, ma per la vita. La filosofia è sì interrogazione dell’angoscia massima, la morte. Ma non si può «guarire» dalla morte morendo. Ma semmai pensando la morte. Al centro della nostra psiche c’è il nostro pensiero vivente, che ci dice che noi viviamo. Il nostro pensiero vive, è pensiero del vivente poiché si oppone al fatto «apparente» che noi dobbiamo morire. Solo chi è dotato-armato del logos - proprio della filosofia - potrà mettere a morte ogni padrone. Perfino quel padrone che è la nostra morte. Ecco perché la filosofia non può essere una attesa impaziente e impotente della morte liberatrice.
Ma è un saper mettere a morte tutto ciò che ostacola, impedisce una piena vita: «Trapassare il padrone ultimo - la morte - e fare del dato “che si muore” un fatto del pensiero: ecco la cura suprema e il supremo esercizio. Da limite del vivere - ci dice Cacciari - la morte, nell’esser pensata da parte dell’anima, diviene così fattore essenziale della sua vita».
-
>NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- CAVA DEI TIRRENI. Presentazione del libro "Della terra, il brillante colore" di Federico La Sala28 maggio 2014
CAVA DEI TIRRENI. Presentazione del libro "Della terra, il brillante colore" di Federico La Sala
Giovedì 15 maggio, nel Salone di rappresentanza del comune di Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 18,00 sarà presentato il libro di Federico La Sala “Della terra, il brillante colore”.
 L’evento è organizzato dall’Associazione giornalisti Cava Costa d’Amalfi "Lucio Barone". Dopo il saluto del presidente dell’Associazione Giornalisti, Walter Di Munzio, sono previsti interventi dell’ispettore MIUR Agnello Baldi e dell’architetto Lorenzo Santoro, funzionario della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino.
L’evento è organizzato dall’Associazione giornalisti Cava Costa d’Amalfi "Lucio Barone". Dopo il saluto del presidente dell’Associazione Giornalisti, Walter Di Munzio, sono previsti interventi dell’ispettore MIUR Agnello Baldi e dell’architetto Lorenzo Santoro, funzionario della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino.
 A moderare Magrina Di Mauro, dirigente della Lucio Barone.
A moderare Magrina Di Mauro, dirigente della Lucio Barone.Il libro trae spunto dalla scoperta di un poema pittorico di un ignoto carmelitano degli inizi del XVII secolo per poi giungere a uno degli interrogativi che da secoli tormenta l’uomo “Che cosa è l’uomo”.
La pittura è espressione dell’immaginario rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana in sequenza col Cristianesimo. Il poema pittorico di Contursi descrive il viaggio iniziatico di un pellegrino che, accompagnato da dodici Sibille e dodici Profeti, giunge alla presenza di Maria madre del Cristo. Le Sibille di Contursi vantano parentele illustri: sono presenti nella cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel tempio Malatestiano di Rimini e, infine, nella Cappella Sistina di Michelangelo.
L’elemento antropologico è alla base del libro. La Sala analizza i maggiori filosofi che, ciascuno per suo conto e con diverse modalità di pensiero hanno rivendicato l’esigenza di mediare fra l’anima e il corpo. Ciò nondimeno non sono riusciti a produrre un paradigma radicalmente nuovo, poiché hanno continuato a pensare con le categorie del mondo ellenico. Da qui l’esigenza di pervenire a nuova Rivoluzione copernicana, che è possibile solo attraverso una nuova percezione dello spazio. In questo senso l’autore ci invita ad uscire dalla Terra per collocarci alla giusta distanza. La spazializzazione del soggetto con la sua giusta dose di trascendenza ci permetterà finalmente di vedere la Terra con il suo brillante colore come la Nostra Terra. Nondimeno La Sala è altresì consapevole che un nuovo ordine simbolico del mondo è possibile solo attraverso lo sviluppo dello spazio sociale.
 Comunicato scritto da Magrina Di Mauro
Comunicato scritto da Magrina Di Mauro Segretario dell’Associazione Giornalisti
"Lucio Barone"
Segretario dell’Associazione Giornalisti
"Lucio Barone"
 Dott. Imma Della Corte
Dott. Imma Della Corte -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ" ! ---- LE “DONNE DEI PRETI” SCRIVONO A PAPA FRANCESCO.21 maggio 2014, di Federico La Sala
LE “DONNE DEI PRETI” SCRIVONO AL PAPA *
Caro Papa Francesco
siamo un gruppo di donne da tutte le parti d’Italia (e non solo) che ti scrive per rompere il muro di silenzio e indifferenza con cui ci scontriamo ogni giorno. Ognuna di noi sta vivendo, ha vissuto o vorrebbe vivere una relazione d’amore con un sacerdote, di cui è innamorata. Abbiamo deciso di unire le nostre voci dopo esserci rese conto che pur nella nostra diversità, i nostri vissuti non rappresentano casi isolati, ma che tantissime donne vivono nel silenzio, e per questo, pur essendo noi un piccolo campione, ci sentiamo di parlare a nome di tutte le donne coinvolte sentimentalmente con un sacerdote o religioso.
Come tu ben sai, sono state usate tantissime parole da chi si pone a favore del celibato opzionale, ma forse ben poco si conosce della devastante sofferenza a cui è soggetta una donna che vive con un prete la forte esperienza dell’innamoramento.
Vogliamo, con umiltà, porre ai tuoi piedi la nostra sofferenza affinchè qualcosa possa cambiare non solo per noi, ma per il bene di tutta la Chiesa.
Si, l’amore è proprio un’esperienza forte e rigenerante, che ti rimodula dentro, che ti fa crescere con l’altro, finchè ti ritrovi a desiderare con lui quel meraviglioso sogno di una vita insieme. Cosa che con un prete non è possibile, secondo le leggi attuali della chiesa cattolica romana.
Noi amiamo questi uomini, loro amano noi, e il più delle volte non si riesce pur con tutta la volontà possibile, a recidere un legame così solido e bello, che porta con se purtroppo tutto il dolore del "non pienamente vissuto". Una continua altalena di "tira e molla" che dilaniano l’anima.
Quando, straziati da tanto dolore, si decide per un allontanamento definitivo, le conseguenze non sono meno devastanti e spesso resta una cicatrice a vita per entrambi. Le alternative sono l’abbandono del sacerdozio o la persistenza a vita di una relazione segreta.
Nel primo caso la forte situazione con cui la coppia deve scontrarsi viene vissuta con grandissima sofferenza da parte di entrambi: anche noi donne desideriamo che la vocazione sacerdotale dei nostri compagni possa essere vissuta pienamente, che possano restare al servizio della comunità, a svolgere la missione che per tanti anni hanno svolto con passione e dedizione, rinvigoriti adesso ancor di più dalla forza vitale dell’amore che hanno scoperto insieme a noi, che vogliamo sostenerli e affiancarli nel loro mandato. Chi si sente chiamato al sacerdozio sceglie di vivere nel mondo, di partecipare alla vita sociale e di rendersi utile agli altri nella comunità in cui è inserito. La dolcezza e solarità di una donna può davvero essere sale e luce nel ministero di un sacerdote, per camminare insieme verso la Sua Luce e per maturare i frutti (che in due si moltiplicano esponenzialmente) da donare alla gente.
Nel secondo caso, ovvero nel mantenimento di una relazione segreta, si prospetta una vita nel continuo nascondimento, con la frustrazione di un amore non completo che non può sperare in un figlio, che non può esistere alla luce del sole. Può sembrare una situazione ipocrita, restare celibi avendo una donna accanto nel silenzio, ma purtroppo non di rado ci si vede costretti a questa dolorosa scelta per l’impossibilità di recidere un amore così forte che si è radicato comunque nel Signore.
L’amore è davvero la forza più potente che esista!
E allora ci chiediamo e ti chiediamo se è davvero giusto sacrificare l’Amore in virtù di un bene più alto e grande che è quello del servizio totale a Gesù e alla comunità, cosa che a nostro avviso sarebbe svolto con maggiore slancio da un sacerdote che non ha dovuto rinunciare alla sua vocazione all’amore coniugale,unitamente a quella sacerdotale, e che sarebbe anche supportato dalla moglie e dai figli. Probabilmente ne gioverebbe l’intera comunità, si respirerebbe aria di famiglia, di libertà e accoglienza. Questa nostra società ne ha bisogno!
Siamo tutti alla ricerca della propria identità, che possiamo solo trovare nel volto di Cristo; ma la chiesa ne riflette il suo volto? Noi speriamo che tu, con questa ventata di speranza che hai portato, possa davvero riuscire a ridare alla chiesa la sua dignità, liberandola dalla pretesa della Verità Assoluta, e affidandola semplicemente alla volontà di Dio.
Siamo fiduciose che il nostro grido, rimasto per troppo tempo inespresso, venga da te accolto e compreso, per discernere quale sia la giusta strada per una Chiesa migliore.
Se tu lo riterrai adeguato, siamo pronte e anzi ti chiediamo di essere da te convocate in un’udienza privata, per portare davanti a te umilmente le nostre storie e le nostre esperienze, sperando di poter attivamente aiutare la Chiesa, che tanto amiamo, verso una possibile strada da intraprendere con prudenza e giudizio.
Grazie Papa Francesco! Speriamo con tutto il cuore che tu benedica questi nostri Amori, donandoci la gioia più grande che un padre vuole per i suoi figli: VEDERCI FELICI!!!
Ti auguriamo ogni Bene.
*
FONTE. Adistanews: http://www.adistaonline.it/
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ" ! --- Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin (di Nicola Fanizza)10 aprile 2014
Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
di Nicola Fanizza (Nazione Indiana, 10 aprile 2014)
Il libro di Federico La Sala - Della Terra, il brillante colore, Prefazione di Fulvio Papi, Edizioni nuove scritture, Milano 2013 - si configura come un viaggio nei sotterranei della cultura occidentale. Il protagonista del viaggio è il classico flâneur, che ha la straordinaria capacità di cogliere nell’opacità delle immagini del passato la luce che rende visibile le «perle» e i «coralli»: ossia tutto ciò che, sottraendosi al morso del tempo, è destinato all’eternità!
Nella prima parte del suo lavoro, La Sala adopera una sorta di «scandaglio archeologico» per ricostruire la preistoria del presente: ossia la genealogia dei concetti che strutturano tutt’oggi il nostro modo di pensare e di stare nel mondo. Si tratta di una ricostruzione che, pur comportando il rifiuto sistematico della ricerca, non rinuncia tuttavia alla contestualizzazione dei saperi in gioco. L’origine dei modelli del pensiero, infatti, non viene individuata tanto nella tradizionale storia della filosofia, quanto nella storia delle istituzioni totali: ovvero nella dimensione del Sacro, che con i miti e le pratiche rituali permette - ieri come oggi - la comunicazione fra gli individui e dà un senso alla nostra stessa vita.
Il «luogo d’inizio» è la piccola chiesa di S. Maria del Carmine, a Contursi Terme. Qui nel 1989 - in seguito ai lavori di restauro approntati dopo il terremoto del 1980 -, è stato scoperto un poema pittorico di un ignoto carmelitano degli inizi del XVII secolo. La pittura è espressione dell’immaginario rinascimentale che colloca la filosofia e la teologia pagana - Prisca Theologia - in sequenza col Cristianesimo. Il poema pittorico di Contursi descrive il viaggio iniziatico di un pellegrino che, accompagnato da dodici Sibille e dodici Profeti, giunge alla presenza di Maria madre del Cristo. Le Sibille di Contursi vantano parentele illustri: sono presenti nella cattedrale di Siena, nell’appartamento Borgia in Vaticano, nel tempio Malatestiano di Rimini e, infine, nella Cappella Sistina di Michelangelo.
Il rapporto di filiazione fra la teologia cristiana e quella pagana - la tesi che la storia del Cristianesimo cominciava prima di Cristo come attestavano le testimonianze profetiche ebree e pagane - non fu instillato nel movimento umanistico sulla scorta di un semplice fraintendimento: ossia la pubblicazione da parte di Gemisto Pletone degli Oracoli caldaici - risalenti al II secolo dopo Cristo - come scritti precristiani. L’Umanesimo più che recuperare il Mondo Classico nei fatti valorizza la cultura della Tarda Antichità. Non vengono recuperati Platone o Aristotele, ma Plotino, gli Oracoli caldaici, gli Scritti ermetici e gli Scritti degli antichi Teosofi che risalgono per l’appunto al II secolo. La stessa cosa si può dire del movimento nazional socialista. Georges Dumezil ha dimostrato che i nazisti pensavano di ridare vita alle divinità degli antichi Germani mentre di fatto riciclavano materiali mitici risalenti all’età medievale.
Tuttavia ciò che ci fa decidere rispetto a un movimento non è tanto il recupero più o meno selettivo di un passato mitizzato - ogni movimento rielabora il materiale mitico della tradizione (il mito è nella sua essenza un portatore di senso nei confronti del presente e, insieme, del passato!) -. Ciò che ci fa decidere sono i nuovi contenuti, ovvero la rivendicazione o negazione di forme di sociabilità più giuste e più libere, di nuove pratiche di liberazione e di nuovi percorsi di conoscenza. Su questo piano, a più di cinquecento anni di distanza, va riconosciuto il valore profetico della cultura del Rinascimento: è un’onda lunga che mantiene intatta la sua pregnanza di significato e il suo vigore!
E’ da questo ultimo spunto che s’origina e si articola il discorso antropologico di La Sala, che scorge una evidente analogia fra il ruolo svolto dalle Sibille nelle pratiche cultuali della religione pagana e la funzione che le «figlie del Sole» svolgono nel poema di Parmenide. Anche qui il viaggio-rivelazione del prescelto è tracciato dalle dee-fanciulle, sono le donne a consentire il transito nei riti di passaggio.
La funzione della donna come viatico del transito nei riti di passaggio pervade l’intero immaginario ellenico. Qui erano presenti due diverse rappresentazioni della vita. Il fantasma della zōé indicava la vita che non contemplava la morte: ossia la vita come specie, la vita infinta, priva di determinazioni, senza accidenti. Viceversa il fantasma della bios indicava la vita che contempla la morte: ovvero la vita che ha un inizio e una fine, la vita determinata con i suoi accidenti. Ebbene nella religione dionisiaca la zōé - la vita indistruttibile! - assume la forma maschile, la genesi delle anime assume, invece, quella femminile. Dioniso e Arianna stanno a indicare - dice Carl Kerenyi -, rispettivamente, l’eterno insorgere e trascorrere della zōé nella nascita e nei diversi stadi della vita. Il ruolo di Arianna non venne, tuttavia, compreso da Nietzsche, il quale negli ultimi anni della sua vita si chiedeva in modo ossessivo: «Chi è Arianna?».
Sta di fatto che il venire alla luce del «soggetto» nel mondo ellenico - un soggetto che si costituisce attraverso il discorso profetico, del saggio, del tecnico e del parresiates - si configura come un’emergenza che riguarda solo gli uomini e giammai le donne. Di fatto la Pizia nell’antica Grecia e le Sibille nel mondo latino sono solo il ventriloquo - un corpo senz’anima! - di cui si servono le diverse divinità per veicolare le loro oscure profezie!
Viceversa nell’immaginario rinascimentale le Sibille assumono, sulla base della rivendicazione dell’uguaglianza fra l’uomo e la donna, l’inedito profilo di avanguardie femminili. Di fatto, nelle immagini cultuali che costellano le chiese rinascimentali, le donne vengono rappresentate per la prima volta come soggette sovrane - le donne rappresentate da Michelangelo sono, per la prima volta, pensose! -, poiché svolgono, allo stesso modo dei Profeti, una funzione messianica. La cifra del Rinascimento, pertanto, va individuata proprio nella parola che sta a evocare, per l’appunto, la Rinascenza del soggetto!
Nonostante la spinta propulsiva della cultura rinascimentale, nei secoli successivi la donna non è tuttavia riuscita a farsi riconoscere come soggetto autonomo della comunicazione, come soggetto che dice il vero.
La storia di questo disconoscimento è costellata dalle tante sofferenze che le donne hanno subito nel corso dei secoli e dalle tante lacrime amare che tutt’oggi versano. Una sofferenza che suscita nell’animo nobile un sentimento di pietà che va comunque custodito attraverso i secoli. Non è inutile qui ricordare: la filosofa e scienziata Ipazia - la prima martire del libero pensiero! -, che nel 415, in Egitto, fu trucidata dagli fondamentalisti cristiani per aver rivendicato il diritto di costituirsi come soggetto che dice il vero; la persecuzione delle Streghe, che ebbe luogo non nel Medioevo ma in Età Moderna e, fra i giudici che le condannavano, Jean Bodin, l’«Aristotele del Rinascimento!»; le disposizioni del regime fascista che vietavano alle donne l’insegnamento della filosofia nelle nostre scuole; e, infine, la negazione dei diritti civili e, insieme, politici delle donne nei Paesi islamici. D’altra parte, va rilevato che fino alla Grande guerra le donne avevano il diritto di voto soltanto in quattro Paesi - Nuova Zelanda, Norvegia, Australia e Finlandia -; in Italia l’hanno ottenuto nel 1946 e in Svizzera solo nel 1974.
Nella seconda parte del suo lavoro, La Sala ritiene che sia auspicabile mettersi alle spalle le forme di sociabilità edipiche che fino ad ora hanno precluso alla maggior parte degli individui - non solo alle donne! - l’accesso alla sovranità: ossia il diritto di costituirsi come soggetti autonomi, il diritto di prendere la parola. Sostiene, inoltre, che le dinamiche relazionali che inibiscono l’autonomia delle donne - dinamiche che signoreggiano tutt’oggi nell’immaginario del modo occidentale - sono riconducibili da una parte all’alleanza tra la madre e il figlio - il mito di Edipo! - che ritroviamo nel mondo ellenico; e, dall’altra, all’alleanza fra il padre e il figlio - Il Vecchio Testamento! - che ritroviamo, invece, nel mondo ebraico.
La liberazione è possibile - dice La Sala - solo se usciamo dall’orizzonte teorico che la tradizione dei nostri padri ci ha trasmesso. Le forme della narrazione, della politica, della retorica, della dialettica, insieme all’esiziale corredo di scissioni (anima e corpo, la ragione e i sensi, ecc.) - tutte invenzioni del genio Mediterraneo - sono state adoperate per troppo tempo e, sempre più, appaiono logore. D’altra parte, i miti e i riti del mondo ellenico, ormai, sono diventati letteratura, ossia oggetto di semplice godimento estetico - non sono portatori di senso! - e, a volte, autentici detriti!
Rousseau, Kant, Feuerbach, Marx e Nietzsche - ciascuno per suo conto e con diverse modalità di pensiero - hanno rivendicato l’esigenza di mediare fra le diverse scissioni. Ciò nondimeno non sono riusciti a produrre un paradigma radicalmente nuovo, poiché hanno continuato a pensare con le categorie del mondo ellenico.
Da qui l’esigenza di pervenire a nuova Rivoluzione copernicana, che è possibile solo attraverso una nuova percezione dello spazio. In questo senso La Sala ci invita ad uscire dalla Terra per collocarci alla giusta distanza. La spazializzazione del soggetto con la sua giusta dose di trascendenza ci permetterà finalmente di vedere la Terra con il suo brillante colore come la Nostra Terra. Nondimeno La Sala è altresì consapevole che un nuovo ordine simbolico del mondo è possibile solo attraverso lo sviluppo dello spazio sociale.
Nell’attesa che ci sia una ripresa dell’effervescenza sociale e, insieme, una rifioritura dei movimenti di liberazione, il flâneur può cogliere già da ora in alcune forme di sociabilità disseminate sull’esergo del sistema la luce di una nuova bellezza, lo splendore che emerge dalle pratiche sociali in cui tutti gli individui signoreggiano come soggetti autonomi della comunicazione
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- L’inclusione delle donne nella polis. Altro che quote rosa, è democrazia paritaria (di Francesca Izzo)18 marzo 2014, di Federico La Sala
Altro che quote rosa, è democrazia paritaria
di Francesca Izzo (l’Unità, 18.03.2014)
È ACCADUTO CON LA PAROLA «FEMMINICIDIO»: AL PRINCIPIO C’ERA UNA RESISTENZA FORTISSIMA AD USARLA perché brutta e urticante, ma poi l’ha spuntata perché è l’unico termine appropriato per denotare l’uccisione di una donna solo perché è donna. Quando con una grande campagna di informazione si è chiarito che mariti, fidanzati, conoscenti le uccidono perché, aspettandosi acquiescenza e subordinazione, non riescono invece a tollerare la loro libertà e il loro rifiuto, allora il termine è diventato di uso corrente.
Ecco ora siamo alle prese con un’analoga situazione, forse ancora più difficile. L’espressione che deve entrare nell’uso comune è «democrazia paritaria» ma deve combattere per affermarsi contro quella semplice e diffusa di «quote rosa». In questi giorni di quote rose se ne è scritto e detto a destra e manca per raccontare dell’iniziativa di un consistente numero di deputate di inserire nella nuova legge elettorale il principio della parità. Chi si è dichiarato a favore chi contro, ma tranne pochissime eccezioni, tutti a parlare di quote rosa.
Appena qualche giorno fa, ad esempio, Gian Antonio Stella ne ha sostenuto la necessaria e temporanea introduzione per vincere uno storico gap. Invece una platea vasta, arringata a sorpresa ieri sera a Che tempo che fa da una Luciana Littizzetto antiquote, è duramente contraria perché respinge le tutele, vuole il merito e non i recinti protetti. Soprattutto le giovani donne si mostrano ostili: hanno misurato a scuola, negli studi, nei concorsi il loro valore e sanno di poter competere alla pari con i loro coetanei e quindi non vogliono essere ricacciate nel ghetto degli svantaggiati, di quote infatti si parla per chi ha degli handicap, per le minoranze ...
Hanno pienamente ragione: le donne non sono una minoranza e per giunta oggi le giovani donne sono forti, preparate e competitive, altro che svantaggiate. E allora? Il fatto è che le parole sono le cose e usare la parola quota per indicare qualcosa di diverso produce terribili fraintendimenti.
Democrazia paritaria è l’espressione adeguata. Adeguata ad indicare che la rappresentanza del popolo (quella che con il voto eleggiamo in Parlamento), per essere democratica e non «oligarchica», deve dare «rappresentazione» del dato basilare che il popolo è fatto per metà da uomini e per metà da donne e che quindi la composizione parlamentare deve essere paritaria. I criteri con i quali vengono scelti i rappresentanti, cioè i famosi merito, qualità e competenza dei candidati riguardano in egual misura sia gli uomini che le donne e prescindono dalla regola paritaria, a meno che non si pensi che merito, qualità e competenza abbondino tra gli uomini e scarseggino tanto drammaticamente tra le donne da dover ricorrere a sciocche incompetenti per rispettarla.
La democrazia paritaria non configura alcuna concessione, alcun regalo o tutela, è la semplice presa d’atto (frutto però di un’epocale rivoluzione culturale e politica) che il popolo sovrano è fatto di uomini e donne e non è una nozione neutra, indistinta. È stata quella nozione neutra a consentire, anche nella storia repubblicana, di considerare «normale» che la rappresentanza fosse monopolizzata dagli uomini e che la presenza delle donne fosse un’anomalia, un’eccezione da giustificare con meriti altrettanto eccezionali. Questa visione, diffusa ancora oggi, è l’eredità di un lungo passato che non vuole passare, nel quale la politica era per definizione cosa esclusivamente di uomini e alle donne era vietato, proibito di occuparsene e qualcuna, per sfidare il divieto, ci ha rimesso pure la testa.
La democrazia paritaria è il compimento della democrazia, perché porta a compimento l’inclusione delle donne nella polis. E fa anche un’altra cosa non meno rilevante: sottrae all’arbitrio o alla «generosità» degli uomini che ne detengono le chiavi una parte del potere di decidere, rendendo più libere le donne.
Non si chiedono meriti o medaglie speciali alle donne per entrare nella cittadella della rappresentanza, né ci aspettiamo azioni miracolistiche dalla loro presenza. Ma credo sia chiaro a tutti che una rappresentanza popolare composta per metà da donne, cambiamenti nella concezione e nella concreta azione politica li produce e sicuramente in meglio, vista la crisi drammatica di credibilità e di fiducia delle istituzioni rappresentative.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! --- «Le ribelli di Dio». Il potere delle donne che non hanno potere (di Giancarla Codrignani)26 febbraio 2014, di Federico La Sala
Il potere delle donne che non hanno potere
di Giancarla Codrignani (“confronti”, marzo 2014)
- Nel libro «Le ribelli di Dio», la teologa e storica Adriana Valerio ricorda le importanti personalità femminili presenti nella Scrittura, dimostrando il ruolo fondamentale svolto dalle matriarche dell’ebraismo, dalle profete e dalle testimoni cristiane.
N on si era ancora visto un libro sulla Bibbia e le donne che fosse insieme teologico, storico e politico. Adriana Valerio è una docente di Storia del cristianesimo che da quarant’anni si dedica con passione e coraggio a questa tematica e da ultimo ha progettato, insieme con tre bibliste europee (Irmtraud Fisher, Mercedes Navarro e Jorunn Oekland) una ricerca in 21 volumi assolutamente scientifica.
In questo nuovo libro non ha solamente ripreso la memoria delle personalità femminili presenti nella Scrittura o verificato l’antropocentrismo della tradizione esegetica delle Chiese, ma ha dimostrato che le matriarche dell’ebraismo, le profete e le testimoni cristiane hanno di fatto agito sulla «storia che conta», a prescindere dalla damnatio memoriae che ha discriminato le «madri della Chiesa».
Una Rut, di malvista etnia moabita, vedova come la suocera ebrea, non torna alla sua casa cercando protezione e nuove nozze, ma segue Noemi, lavora per la sopravvivenza di entrambe, seduce Booz e gli chiede oltre che per sé anche per Noemi il riscatto che la legge imponeva solo al fratello del morto. Innova ancora la legge ebraica dedicando il primo figlio non al marito morto (secondo la prescrizione del levirato) né a Booz, ma alla suocera. Con lei accade che l’impurità dello straniero non impedisca ad una moabita di essere l’antenata di Davide e, secondo l’evangelista Matteo, di Gesù: ha reso universale la Legge. È il potere delle «donne che non hanno potere», ma che hanno intelligenza, intuito strategico, che usano per attraversare i conflitti, in questo caso senza ricorrere alla violenza. Così sono state donne le autrici della liberazione dalla schiavitù in Egitto, anche se l’esegesi tradizionale ha messo i riflettori su Mosè senza domandarsi chi ha fatto sì che sopravvivesse.
Sono le donne all’origine della fondazione sia di Israele sia degli Arabi, non solo perché Sara e Agar sono madri di Isacco e Ismaele, ma perché Abramo, certo non esemplare quando ha ceduto la bellissima moglie al Faraone, ha comperato per darle sepoltura il campo che «costituirà il diritto di cittadinanza nella terra promessa» e perché Agar si salva da sola per fede.
È un ribaltamento copernicano della visione patriarcale secondo cui la donna è inferiore fisiologicamente (è impura), moralmente (è inadeguata), giuridicamente (è inferiore), visione che per secoli è stata sacralizzata dall’autorità religiosa di un clero rigorosamente maschile che ha confermato il potere monocratico di un solo genere.
Le donne l’hanno sempre saputo. Le cristiane avevano trovato nelle parole di Gesù una verità incompresa anche dai discepoli e tradita da Paolo che, pur dicendo «non c’è più né uomo né donna», negava loro l’autonomia del corpo e il diritto di parola. Le donne argomentavano la superiorità di Eva per la sua sete di conoscenza (le eretiche montaniste), il favore di Dio non verso la forza virile, ma la debolezza femminile incarnata nel Cristo (Ildegarda), la creazione di Adamo dal fango inferiore a quella di Eva da materia organica (Lucrezia Marinella): il clero leggerà sempre la Scrittura a propria immagine e somiglianza.
Le donne avevano anche accusato, come Margherita di Navarra nel 1564: «Quelli che dicono che non è da donna guardare i Sacri Scritti son uomini malvagi ed empi, seduttori e anticristi. Ah, mie donne, le vostre povere anime non lasciate in balia di tali demoni abominevoli che vi fanno dannare». Ma l’interpretazione escludente persiste e lascia come sola via di fuga la lettura «altra», con un altro Dio (padre che non è mai padrone), un altro Gesù (che risana l’impurità assoluta della donna che soffre di perdite di sangue), un’altra Maria: non sottomessa, ma «sovversiva», non imprigionata in un ruolo, «la donna dello Spirito» dall’Annunciazione alla Pentecoste, «la serva del Signore» secondo il Magnificat.
Nessuna donna è mai andata ad attaccare tesi sulle porte di un tempio; ma è configurabile da sempre un protestantesimo femminile che percorre tutte le confessioni e le religioni. Oggi sono tutte in difficoltà storica: forse il genere escluso può diventare necessario per riforme indilazionabili. Occorre però capire chi sono state (e sono) davvero «le ribelli di Dio».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI" --- "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE" ("ROMA ART MEETING - 2014")18 gennaio 2014
PROGRAMMA - "ROMA ART MEETING - 2014" *
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 Giovedì 23 gennaio 2014 - ore 20:30
Giovedì 23 gennaio 2014 - ore 20:30
 "Sala del Refettorio" presso l’Istituto Sacro Cuore di Roma
"Sala del Refettorio" presso l’Istituto Sacro Cuore di Roma
 Via di Val Tellina, 97 - ROMA
Via di Val Tellina, 97 - ROMA
 "Della Terra il Brillante Colore" è un Caffè Letterario
"Della Terra il Brillante Colore" è un Caffè Letterario
 tra Filosofia, Ironia e Quotidiano
tra Filosofia, Ironia e Quotidiano
 Federico LA SALA (Filosofo)
Federico LA SALA (Filosofo)
 Vincenzo AMBROSIO (Filosofo)
Vincenzo AMBROSIO (Filosofo)
 modera Emiliano MORRONE
modera Emiliano MORRONE
* Per il programma completo, vedi:
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- Il Rinascimento tecnologico Quelle banche dati che ci obbligano ad essere intelligenti (di Michel Serres)17 gennaio 2014, di Federico La Sala
Il Rinascimento tecnologico
Quelle banche dati che ci obbligano ad essere intelligenti
di Michel Serres (la Repubblica, 17.01.2014) *
Da quando siamo uomini, abitiamo in uno spazio polarizzato attorno a luoghi diconcentrazione, case, villaggi e tesori diversi; in particolare, il luogo stesso in cui vivo e al quale riferisco il mio indirizzo. Viviamo in questo spazio perché costruire lo forma, abitare lo consolida e pensare consiste nel riprodurlo.
Lo spazio immagazzina, l’individuo pensa: stesso processo. Non saremmo potuti sopravvivere senza queste concentrazioni che condizionavano la vita, l’individuo, il collettivo, le pratiche e la teoria; non ci smettevamo, instancabilmente, di inventarne di nuove sotto tutti i rapporti. Ed ecco che i computer portano a compimento questo segmento dell’ominizzazione. Perché se queste macchine possono essere definite universali, meritano tale titolo sotto la rubrica, appunto, della concentrazione.
Che bisogno abbiamo di riunire libri, segni, beni, studenti, case o mestieri dal momento che il computer lo fa? Il problema generale dell’immagazzinamento che cercavamo di risolvere e sul quale lavoravamo follemente fin dalla nostra origine ha trovato soluzione, non solo reale ma virtuale: ogni questione di questo tipo trova molteplici risposte possibili, secondo le sue condizioni e costrizioni.
Le reti rendono desueta la concentrazione attuale, voglio dire un ammasso qualsiasi qui e ora.La rapidità delle comunicazioni concentra virtualmente ovunque, ad libitum, tutto o parte del connesso disponibile. Al contrario delle antiche tecnologie, le nuove macchine sostituiscono con trasmissioni rapide la funzione del conservare. Non immagazziniamo più cose, bensì relazioni.
Le reti sostituiscono la concentrazione con la distribuzione. Da quando disponiamo, su una postazione portatile o sul telefonino, di tutti i possibili accessi ai beni o alle persone, abbiamo meno bisogno di costellazioni espresse. Perché anfiteatri, classi, riunioni e colloqui in un dato luogo, e perché una sede sociale, dal momento che lezioni e colloqui possono tenersi a distanza? Gli esempi culminano in quello dell’indirizzo.
In tutto il corso della storia è stato riferito a un luogo, di abitazione o di lavoro, mentre oggi l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono cellulare non indicano più un determinato luogo: un codice o una cifra, pura e semplice, basta. Quando tutti i punti del mondo godono di una sorta di equivalenza, la coppia qui e ora entra in crisi. Heidegger, filosofo oggi assai letto nel mondo, nel chiamare esserci l’esistenza umana, designa un modo di abitare o di pensare in via di estinzione. Il concetto teologico di ubiquità - la capacità divina di essere ovunque - descrive meglio le nostre possibilità rispetto al funebre qui giace.
Un altro modo di interpretare il gesto di immagazzinare: depositare informazione su pergamena, carta stampata o supporto elettronico significa costruire una memoria. I nostri antenati assomigliavano agli attori di oggi che sono in grado di recitare a memoria migliaia di versi o di sostenere altrettante repliche. Simili eroismi superano ormai la nostra capacità.
Man mano che costruiamo memorie performanti, perdiamo la nostra, quella che i filosofi chiamavano una facoltà. Possiamo davvero dire: perdere? Niente affatto, perché il corpo deposita, a poco a poco, quell’antica facoltà nei supporti mutevoli; cervicale e soggettiva, essa si oggettivizza e si collettivizza. Una stele di pietra, un rotolo di papiro, una pagina di carta: ecco memorie materiali, in grado di dare sollievo alla nostra memoria corporea. Era vero per le biblioteche, lo è ancora di più per la rete, memoria globale ed enciclopedia collettiva dell’umanità.
Secoli fa cantastorie, aedi, gli apostoli di Gesù, gli interlocutori di un dialogo di Platone, anche uno studente della Sorbona medievale, potevano ripetere a distanza di anni, senza omettere una sillaba, i discorsi di un maestro o di un oratore uditi da giovani. Al riparo dagli errori di copisti troppo interventisti, la tradizione orale tracciava una via più sicura rispetto alla trasmissione scritta.
I nostri predecessori coltivavano dunque la loro memoria e disponevano di sottili strategie mnemotecniche. Man mano che prendevamo note o leggevamo stampati, non tanto abbiamo perso quella facoltà quanto l’abbiamo depositata nei libri e nelle pagine.
Così come la ruota fu ispirata dal corpo, dalle caviglie e dalle rotule in rotazione nella marcia, allo stesso modo l’immagazzinamento dell’informazione prese le mosse da funzioni cognitive antiche. Al contrario degli animali, bloccati in un organismo senza “secrezione” di questo tipo, noi non cessiamo di riversare le nostre prestazioni corporee in strumenti prodotti a partireda esse. Perdiamo la memoria perché ne costruiamo di multiple.
Ci uniamo qui ai piagnoni antichi e moderni, i cui discorsi e testi deplorano la perdita dell’oralità, della memoria, della concettualizzazione e di tante altre cose preziose per i nostri avi. In realtà la perdita della memoria, nell’epoca che seguì quella in cui si declamavano a mente i poemi di Omero, liberò le funzioni cognitive dal carico impietoso di milioni di versi; apparve allora, nella sua semplicità astratta, la geometria, figlia della Scrittura.
Allo stesso modo nel Rinascimento una perdita ancora più importante sollevò i saggi dallo schiacciante obbligo della documentazione, che allora si chiamava dossografia, e li riportò bruscamente alla nuda osservazione che fece nascere le scienze sperimentali, figlie della stampa.
A bilancio, i vantaggi prevalgono in maniera preponderante sui pregiudizi, poiché in tali circostanze nacquero due altri mondi, che permisero di comprendere questo. Sapere consiste allora non più nel ricordare, ma nell’oggettivare la memoria, nel depositarla negli oggetti, nel farla scivolare dal corpo agli artefatti, lasciando la testa libera per mille scoperte.
Ho impiegato molto a capire che cosa volesse dire Rabelais, quando i professori mi obbligavano a dissertare sulla celebre frase: Preferite una testa ben fatta a una testa piena. Prima di poter allineare i libri nella loro libreria, Montaigne e i suoi antenati dotti dovevano imparare a memoria l’Iliade e Plutarco, l’Eneide e Tacito, se volevano averli a disposizione per meditare.
L’autore degli Essais li cita ormai ricordandosi solo del loro posto sugli scaffali per consultarli: quanta economia! All’improvviso la pedagogia, che quel Rinascimento auspica, vuoterà la testa un tempo piena, e ne modellerà la forma senza preoccuparsi del contenuto, ormai inutile in quanto disponibile nei libri. Liberata della memoria, una “testa ben fatta” si volgerà ai fatti del mondo e della società per osservarli. Rabelais, in quella frase, in realtà, loda l’invenzione della stampa e ne trae lezioni educative.
Decisamente, bisogna riscrivere Pantagruel o gli Essais. Come vecchi cadenti, i bambini di oggi non ricordano neppure la trasmissione vista ieri sera in televisione. Quale scienza immensa promuoverà quest’altra perdita di memoria? Questo sapere recente si può già apprenderlo o almeno visitarlo sulla rete, come il nuovo oblio l’ha già modellato.
Sì, l’enciclopedia, la cui rete mondiale gronda informazioni singolari, ha appena cambiato paradigma, sotto l’effetto della nuova liberazione. Il nostro apparato cognitivo si libera anche di tutti i possibili ricordi per lasciare spazio all’invenzione. Eccoci dunque consegnati, nudi, a un destino temibile: liberi da ogni citazione, liberati dallo schiacciante obbligo delle note a piè di pagina, eccoci ridotti a diventare intelligenti!
Come nel Rinascimento, giungono una nuova scienza e una nuova cultura, i cui grandi racconti producono un’altra cognizione che li riproduce a loro volta arricchiti. Questo cambiamento d’intelletto ha avuto luogo più volte nella storia, ad esempio quando arrivarono i modelli astratti della geometria o gli esperimenti in fisica, quando appunto cambiavano le tecnologie. Così la storia della filosofia e la storia stessa, tributarie della storia della conoscenza, seguono quella dei supporti.
* Sull’ultimo numero di Vita e Pensiero appare la versione integrale del testo qui anticipato
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- Come si individua la pseudoscienza. Il problema della demarcazione.15 gennaio 2014, di Federico La Sala
Il problema della demarcazione
Come si individua la pseudoscienza
di Alessandro Pagnini (Il Sole 24 Ore/Domenica, 12.01.2014)
- Massimo Pigliucci & Maarten Boudry (eds.), Philosophy of Pseudoscience. Reconsidering the Demarcation Problem, Chicago, University of Chicago Press, pagg. 470, £ 24.50.
 Silvano Fuso, La falsa scienza, Roma, Carocci, pagg. 302, € 21,00.
Silvano Fuso, La falsa scienza, Roma, Carocci, pagg. 302, € 21,00.
Stamina è un caso di "pseudoscienza", di "cattiva scienza" o di "falsa scienza con frode"? Nel nostro modo comune di affrontare certi problemi di plausibilità scientifica o di efficacia terapeutica non ci preoccupiamo gran che delle differenze e delle definizioni. Tuttavia un conto è sostenere il Disegno Intelligente rappresentando disonestamente come fallace la teoria dell’evoluzione solo perché si vuole impedire che un’educazione scientifica possa progressivamente sostituire un’educazione religiosa (che fa di certe spiegazioni ultime e di certi "misteri" la sua ragione); un conto è difendere una cura omeopatica credendo davvero nella sua efficacia; un altro ancora è lucrare sulla dabbenaggine e la disperazione della gente contrabbandando per scienza un’illusione.
Eppure se dovessimo dire quale dei casi citati è socialmente meno dannoso, soprattutto dopo aver riflettuto sulla ricca e documentata rassegna di esempi storici di "falsa scienza" che Silvano Fuso ci racconta, forse dovremmo dire il primo. Perché il Disegno Intelligente lo si può trattare a tavolino, magari con in mano qualche libro di supporto alle nostre argomentazioni; mentre gli altri costano: costano risorse economiche (per controlli alla fine inutili), costano tempo (e il tempo può a sua volta costare salute e vite umane), e soprattutto costano perché insinuano in menti deboli e ignoranti il tarlo dello scetticismo e della sfiducia nella scienza.
Ecco perché, da Hume in poi, i filosofi moderni hanno considerato importante quello che Popper battezzò come "problema della demarcazione". Finché però, nell’83, un saggio del filosofo e storico della scienza Larry Laudan ne decretò la "demise", ritenendolo uno "pseudoproblema" che nulla aggiunge, se non per una sua valenza emotiva e retorica, al problema della distinzione «tra una conoscenza affidabile e una conoscenza non affidabile», o ai tradizionali problemi relativi al controllo empirico di una ipotesi.
Oggi, a distanza di trent’anni, a dispetto della sua fortuna (qualcuno, non a caso di vocazione religiosa, lo ha addirittura considerato «uno dei saggi più importanti nella filosofia della scienza del XX secolo»), i contenuti del saggio di Laudan appaiono poco convincenti, talvolta concettualmente confusi, e i suoi argomenti, come anche le sue sinossi storiche, tutt’altro che incontestabili. Meno ancora appare accettabile il verdetto con cui esso liquida come inutile o fuorviante un interesse epistemologico sulla demarcazione. Lo si evince dalla raccolta di saggi curata da Pigliucci e Boudry che si concentra sul problema particolare di una possibile definizione di "pseudoscienza".
Va detto subito che nessuno degli autori che intervengono nella discussione pretende di aver trovato, né ritiene si possano trovare, i criteri necessari e sufficienti affinché si possa dire in assoluto di una teoria o di un’ipotesi se è scientifica o pseudoscientifica. E i più sembrano concordi nel differenziare i criteri di demarcazione tra ambiti di conoscenza diversi (tra scienze mediche, scienze fisiche e scienze della vita, per esempio), nel rispetto della specificità delle loro teorie, delle loro leggi (quando ci sono) e dei loro metodi. I più sono anche concordi nel riconoscere che il problema riguarda meno la logica o la metafisica che non una ragion pratica.
Ma l’idea di tutti è che quella demarcazione si abbia da fare; e che, anzi, non solo sia resa urgente dalle policies nella sanità, dall’allocazione delle risorse in medicina e negli investimenti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, da scelte e priorità nell’educazione, da questioni legali riguardo alle frodi e da questioni etiche sul tipo di modelli cognitivi destinati a orientare i nostri comportamenti e le nostre decisioni, ma che di fatto sia (spesso tacitamente) presupposta in gran parte delle nostre considerazioni e dei nostri atteggiamenti normativi e valoriali, e non solo quando si parla del ruolo della scienza e dello scienziato nella società.
Questo significa che il problema della demarcazione ci sfida a trovare soluzioni orientative, certo fallibili e revedibili, ma che riguardano in astratto e in generale una definizione di scienza (sia pure in termini di "somiglianze di famiglia" tra le sue unità), del tipo di quelle utilmente adottate, per esempio, dalla National Academy of Sciences, che periodicamente si premura di render pubblici dei criteri in base a cui valutare la "buona" condotta degli scienziati.
Ciò non ammonta a riesumare il mito del Metodo con la M maiuscola, inteso come algoritmo per dedurre verità; quello che Joseph Agassi icasticamente definì una «science sausage machine» (una macchina per fare scienza simile a quella che fa uscire le salsicce da un impasto prescritto in una ricetta). Serve solo a ricordarci che negare il Metodo non appiattisce la scienza su altre forme di conoscenza o di attività umana. Le differenze ci sono, ed è nostro obbligo, anche morale, renderne conto.
Non sto a elencare i numerosi spunti di grande interesse e attualità che questi due libri ci forniscono sia per comprendere le pseudoscienze sia per comprendere la scienza, e intendo concentrarmi brevemente su una domanda: c’è, nell’evoluzione cognitiva umana, una tendenza "naturale" all’irrazionalità, alla pseudoscienza, come qualcuno sostiene? La mente umana è equipaggiata di euristiche semplici e veloci, le cui operazioni configurano una razionalità adattativa, ecologica.
Tuttavia quando queste euristiche operano per risolvere problemi cognitivi astratti e complessi che richiedono una più lenta riflessione, se non c’è il vaglio di una razionalità normativa basata sulla logica e la probabilità, allora l’esito irrazionale diventa quasi inevitabile. Spesso l’autorità epistemica riconosciuta a una pseudoscienza è una scorciatoia alla fine della quale il pensiero trova l’approdo pigro di una credenza.
I rimedi non possono che essere a livello normativo ed educativo, e non possono che consistere nel favorire, pervasivamente, una forma mentis in cui logica, ragionamento, argomentazione ed etica (molto convincente, nel volume sulla pseudoscienza, l’argomentazione del logico Van Bendegem ... per un’«etica dell’argomentazione») trovino una loro naturale consistenza.
- Massimo Pigliucci & Maarten Boudry (eds.), Philosophy of Pseudoscience. Reconsidering the Demarcation Problem, Chicago, University of Chicago Press, pagg. 470, £ 24.50.
-
>TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. ---- AUGUSTO, LA SIBILLA TIBURTINA, E LA "MADONNA DI FOLIGNO". Una nota (di Federico La Sala)8 gennaio 2014RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: AUGUSTO, LA SIBILLA TIBURTINA, E LA "MADONNA DI FOLIGNO". Una nota di Federico La Sala
 VERSO IL 2015. A MILANO, DOPO "COSTANTINO (313-2013)" AL PALAZZO REALE, LA "MADONNA DI FOLIGNO" DI RAFFAELLO A PALAZZO MARINO (FINO AL 12 GENNAIO 2014)
VERSO IL 2015. A MILANO, DOPO "COSTANTINO (313-2013)" AL PALAZZO REALE, LA "MADONNA DI FOLIGNO" DI RAFFAELLO A PALAZZO MARINO (FINO AL 12 GENNAIO 2014)
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- L’ARITMETICA, L’ANTROPOLOGIA, E IL SENSO COMUNE DELLA MATEMATICA.7 gennaio 2014, di Federico La Sala
 La "scienza per tutti" in un saggio dello studioso
La "scienza per tutti" in un saggio dello studioso WILLIAM CLIFFORD E IL SENSO COMUNE DELLA MATEMATICA
WILLIAM CLIFFORD E IL SENSO COMUNE DELLA MATEMATICA di Paolo Zellini (la Repubblica, 07.01.2014)
di Paolo Zellini (la Repubblica, 07.01.2014)IL LIBRO Etica, scienza e fede di William K. Clifford (Bollati Boringhieri trad. di S. Bourlot pagg. 154 euro 12)
Una teoria matematica non è perfetta finché non risulta comprensibile alla prima persona che si incontri per strada. Ne era convinto David Hilbert quando proponeva, in occasione del celebre Congresso a Parigi ne11900, 23 problemi ancora irrisolti alle future generazioni de1XX secolo. Ma Hilbert non era certo il solo a esigere che le astrazioni matematiche risultassero comprensibili a chiunque. Richard Dedekind, nel suo fondamentale trattato Sulla natura e sul significato dei numeri del 1888, spiegava che alla sua teoria poteva accostarsi qualsiasi persona dotata di buon senso. E ancora prima William Kingdon Clifford, matematico inglese della seconda metà dell’Ottocento, dichiarava che è cattiva algebra quella che, voltata nella nostra lingua, non soddisfi il senso comune.
La dichiarazione di Clifford merita ora attenzione anche per l’uscita di una raccolta di suoi interventi dal titolo Etica, scienza e fede, con un bel saggio introduttivo di Claudio Bartocci e Giulio Giorello. Clifford pubblicò il suo più celebre articolo scientifico sulle algebre geometriche nel 1878, un anno prima della sua morte a soli 34 anni. Per descrivere le proprietà delle particelle elementari scienziati come Pauli, Dirac e Majorana si sarebbero poi serviti di algebre che portano il loro nome senza accorgersi che stavano usando algebre di Clifford.
Una coincidenza singolare ma frequente: accade spesso che diversi matematici inventino teorie simili a loro insaputa e a poca distanza di tempo, come se le teorie si sviluppassero da sé, in modo fatale e univoco, in virtù di una loro necessità intrinseca. L’autorità e la forza logica con cui si impongono alla nostra attenzione potrebbe pure dipendere dalla continuità che sembra esistere tra pensiero scientifico e pensiero comune, o dalla connessione logica delle nuove scoperte con idee più antiche, consuete e incontestate. Come fece poco più tardi Ernst Mach con le sue celebri Lezioni divulgative, Clifford scrisse The common sense of the exact sciences, un libro che ripropone di ricondurre fondamentali concetti alle più elementari operazioni della nostra vita quotidiana.
Al senso comune, dimostrava Clifford, possono rapportarsi non solo teorie acquisite dal canone, come l’aritmetica dei numeri complessi o una computatio deducibile dai numeri pitagorici, ma anche idee innovative che poco sembrano condividere con la nostra esperienza del mondo reale. Tra queste l’idea, poi ripresa da Einstein, di interpretare come una curvatura dello spazio ciò che realmente succede in quel fenomeno che chiamiamo "moto della materia".
Come interferiva tutto ciò con la filosofia di Clifford? Clifford era convinto che gli scienziati non facessero ancora abbastanza per liberare l’uomo dal peso dei dogmi. Egli perseguiva l’idea di un Illuminismo radicale, di un rischiaramento incentrato sulla responsabilità e sulla libertà individuale, in polemica con il principio di autorità su cui si basava la società vittoriana del suo tempo.
Un secolo prima Kant aveva sostenuto che al «rischiaramento non occorre altro che la libertà; e precisamente quella di fare pubblico uso della ragione in tutti i campi», e che «regole e formule, strumenti meccanici di un uso razionale» possono diventare «ceppi di una eterna minorità».
Ora, cercare un nesso tra scienza e senso comune e ricollegare ciò che è astrattamente deducibile alla conoscenza più intuitiva e immediata, avrebbe allontanato il rischio che "regole e formule" matematiche diventino per i più una verità a cui si deve credere senza ragionare, come sarebbe stato per i numeri complessi del giovane Tórless di Robert Musil (1906): «Caro amico, devi semplicemente avere fiducia; quando conoscerai la matematica dieci volte tanto rispetto a ora sarai in grado di capire, ma intanto devi credere!».
Non a caso Clifford scrisse un breve saggio sull’Etica della religione. Quello era per Kant il punto culminante del rischiaramento: «La minorità in cose di religione è, fra tutte le forme di minorità, la più dannosa ed anche la più umiliante». E Clifford manifestava un aperto scetticismo nei confronti dei dogmi di qualsiasi religione, pur apprezzando la profonda religiosità del Buddha o di Spinoza.
Sembra paradossale ma, se la religione può essere un ostacolo al rischiaramento, non si può escludere che possa esserlo anche la scienza. Max Weber notava come l’uomo razionale ignora tranquillamente, di solito, come funziona il tram da cui si lascia trasportare; e Norbert Wiener avvertiva che lo studio delle scienze informatiche, a cui lui stesso aveva dato preziosi contributi, avrebbe potuto incoraggiare l’inclinazione diabolica a delegare la propria ragione e responsabilità a una "mente superiore". Questa, egli spiegava, si incarna volentieri in congegni elettronici il cui funzionamento è solo in parte compreso e che possiede tuttavia una presunta obiettività; e allora non ci deve stupire che l’uso di grandi sistemi di calcolo per un’infinità di scopi elementari possa diventare «l’esatto equivalente della Magia e della Simonia».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- DONNE, UOMINI, E DISORDINE SIMBOLICO. UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!!7 gennaio 2014
DONNE, UOMINI, E DISORDINE SIMBOLICO
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DEL FIGLIO CON LA MADRE, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- PLATONE E NOI, OGGI. Materiali sul tema.6 gennaio 2014PLATONE: ILLUMINISTA O TOTALITARIO?! Al di là dell’illuminismo e del platonismo per il popolo ....
 PLATONE E NOI, OGGI. Una nota di Federico La Sala, seguita da un’intervista a Mario Vegetti di Antonio Gnoli e la risposta di Dario Antiseri.
PLATONE E NOI, OGGI. Una nota di Federico La Sala, seguita da un’intervista a Mario Vegetti di Antonio Gnoli e la risposta di Dario Antiseri.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.2 gennaio 2014, di Federico La SalaCREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Da Emilio Garroni, una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- L’immaginario del cattolicesimo romano: decodificare i codici della famiglia.30 dicembre 2013, di Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- Capitalismo e pipistrelli. Creare ricchezza, non valore (di Jean-Marie Harribey - "Le Monde Diplomatique").29 dicembre 2013, di Federico La Sala
 Capitalismo e pipistrelli
Capitalismo e pipistrelli
 Creare ricchezza, non valore
Creare ricchezza, non valore Con una totale capacità di recupero il capitalismo cerca di appropriarsi delle conoscenze e di ampliare i limiti dello sfruttamento della natura. Un credo: tutto si può trasformare in moneta. Così alcuni economisti hanno calcolato che i «servizi resi dalla Natura» valevano fra i 16.000 e i 54.000 miliardi di dollari all’anno. Essi confondono valore e ricchezza.
Con una totale capacità di recupero il capitalismo cerca di appropriarsi delle conoscenze e di ampliare i limiti dello sfruttamento della natura. Un credo: tutto si può trasformare in moneta. Così alcuni economisti hanno calcolato che i «servizi resi dalla Natura» valevano fra i 16.000 e i 54.000 miliardi di dollari all’anno. Essi confondono valore e ricchezza.di Jean-Marie Harribey (Le Monde Diplomatique - dicembre 2013, pag. 3)
 Professore incaricato presso l’Università Bordeaux IV. Ultima opera pubblicata: “La ricchezza, il Valore e l’Inestimabile: fondamenti di una critica socio-ecologica dell’economia capitalista” (La Richesse, la Valeur et l’Inestimable. Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste), Les Liens qui libèrent, Paris, 2013
Professore incaricato presso l’Università Bordeaux IV. Ultima opera pubblicata: “La ricchezza, il Valore e l’Inestimabile: fondamenti di una critica socio-ecologica dell’economia capitalista” (La Richesse, la Valeur et l’Inestimable. Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste), Les Liens qui libèrent, Paris, 2013
 (traduzione dal francese di José F. Padova)
(traduzione dal francese di José F. Padova)“Il lavoro quindi non è l’unica fonte dei valori d’uso che esso produce, della ricchezza materiale. Esso ne è il padre e la terra ne è la madre. Come dice William Petty”. Karl Marx, Le Capital [1867], in Œuvres, tome I, Gallimard, Paris, 1965.
Lo sapevate? I servizi resi dai pipistrelli negli Stati Uniti valgono 22,9 miliardi di dollari l’anno. Come si arriva a questa bella sommetta? Valutando la quantità d’insetticidi che essi permettono di economizzare, distruggendo gli insetti nocivi. I servizi resi dagli insetti impollinatori rappresentano, da parte loro, 190 miliardi all’anno, dei quali 153 dalle sole api. Quanto al valore della fotosintesi operata dalla foresta in Francia, è stimato al prezzo di mercato della tonnellata di carbone (1).
Da dove viene questa pratica che consiste nell’attribuire alla Natura un valore economico basato sull’utilizzo dei suoi benefici a favore dell’uomo? Il degrado dell’ambiente e l’esaurimento delle risorse hanno raggiunto un punto tale che gli economisti liberisti, colti dal panico di fronte all’entità del disastro e presi da nuovo zelo, intendono introdurre nei modelli neoclassici il dato ambientale, che fino a poco tempo fa avevano completamente ignorato, perché la Natura era stata dichiarata inesauribile.
La crisi del capitalismo globalizzato è passata da lì. Lungi dall’essere una questione di congiuntura, essa affonda le sue radici nelle contraddizioni sociali ed ecologiche spinte all’estremo limite nella fase neoliberista. Da una parte, la svalutazione della forza-lavoro rispetto alla sua produttività provoca una situazione di sovrapproduzione in gran parte dei settori industriali. Le classi abbienti malgrado ciò si arricchiscono in misura scandalosa, grazie agli sgravi fiscali di cui beneficiano e ai loro esorbitanti redditi finanziari. Ne consegue disoccupazione endemica, precarietà, diminuzione della protezione sociale e crescente disuguaglianza. Dall’altra parte, l’accumulazione infinita del capitale preme sui limiti del Pianeta: minaccia l’equilibrio degli ecosistemi, esaurisce una grande quantità di risorse naturali, impoverisce la biodiversità, causa inquinamenti multipli e sconvolge il clima.
Da queste due serie di contraddizioni nascono la difficoltà e, a un certo punto, l’impossibilità d’imporre alla forza-lavoro di produrre sempre più valore economico e di monetizzarlo sul mercato. Con altre parole il capitalismo non può andare di là di un certo limite di sfruttamento dell’essere umano senza mandare in rovina le sue possibilità d’espansione e non può nemmeno superare una certa soglia nello sfruttare la natura, senza deteriorare o distruggere la base materiale dell’accumulazione. Con la crisi finanziaria apertasi nel 2007 svanisce l’illusione che la finanza avrebbe potuto liberarsi dalla costrizione sociale e materiale e diventare una fonte di valore endogena e autosufficiente. Queste due costrizioni sono insuperabili.
La trama, smagliata, della vita
In questo contesto di globalizzazione e di crisi del capitale due importanti trasformazioni hanno contribuito a riaprire la discussione teorica sulla ricchezza e il valore. L’una conduce alla generalizzazione su scala planetaria di un modo di sviluppo produttivistico devastante. L’altra riguarda lo spazio sempre più vasto delle conoscenze nel processo produttivo.
Due fenomeni, due domande: che tipo di ricchezza è messa a repentaglio nel primo caso? E in che cosa è modificata la fonte del valore nel secondo?
La strumentalizzazione della natura è diventata tale che, perfino entro la corrente dominante neoclassica, gli economisti si sono messi a difendere l’ambiente, considerato come un «capitale naturale». La «valorizzazione di ciò che vive», il «valore economico intrinseco della natura» e il «valore dei servizi resi dalla natura» sono oggetto di studio prioritario da parte della Banca Mondiale, del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUA), dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE), dell’Unione Europea, ecc.
Tutti credono sia possibile sommare elementi la cui misura dipende dai costi della produzione realizzata dall’uomo, come anche da elementi che non sono prodotti e che inoltre si riferiscono alla qualità o a valori etici non valutabili. Se tutto è valutato economicamente, tutto può essere considerato come capitale. Gli economisti neoclassici definiscono allora la ricchezza come la somma di ciò che essi chiamano capitale economico, capitale umano, capitale sociale e capitale naturale, che tutti derivano da un’analoga procedura di calcolo.
Cosa ancor più grave, quest’analisi non può tenere conto del metabolismo interno agli ecosistemi naturali. Isolando ogni elemento per calcolarne il costo, il prezzo, perfino l’utilità, essa non ne può afferrare il più importante: le interazioni che costituiscono la trama della vita e la cui preservazione condiziona la sua riproduzione.
Quest’ approccio è stato inaugurato nel 1997 con lo studio diretto dallo specialista dell’ambiente Robert Costanza: i servizi resi dalla Natura rappresentavano allora fra 16.000 e 54.000 miliardi di dollari, quotazione 1994 (2). In seguito gli studi si sono moltiplicati. Ma il prezzo sulla stima del quale è valutata, per esempio, la foresta della Francia costituisce una categoria intrinseca alla sfera finanziaria, caratterizzata dalla volatilità e dalla speculazione; nella sfera naturale non esiste. Quindi non vi è unità di misura che sia comune alle due sfere. L’economia e la natura sono incommensurabili.
Così conviene riallacciarsi alla distinzione di Aristotele, Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx fra valore d’uso e valore di scambio, per dire che le risorse naturali sono una ricchezza, ma senza valore economico intrinseco, e che la Natura è indispensabile a tutta la produzione di valore economico, che proviene solamente dal lavoro umano. In breve, la parte di ricchezza che proviene dalla Natura non è in sé un valore economico, perché questa categoria è sociale e non naturale. Se per mettere in moto una strategia di sostenibilità dello sviluppo si attribuisce un prezzo a questo o a quel bene naturale, questo avrà una condizione di prezzo politico e non economico, fissato al livello della norma ecologica che si è scelto di rispettare.
Il valore del complesso di risorse naturali non si può stimare in termini economici - vale a dire è infinito, perché le risorse naturali condizionano la vita della specie umana. Perciò essa non può essere ridotta a una categoria economica. Di contro, la misura del valore economico creato dallo sfruttamento di queste risorse può essere ridotto al lavoro, ma non ha nulla a che vedere con uno pseudo valore economico intrinseco alle risorse. Si tratta di un paradosso incomprensibile al di fuori dall’economia politica e dalla sua critica marxista. Senza la natura l’uomo non può produrre nulla, né in termini fisici, né in termini di valore economico. L’attività economica si inserisce inevitabilmente nei rapporti sociali e nella biosfera. Non si può quindi fare a meno della Natura per produrre collettivamente valori d’uso e non si può sostituirla indefinitamente con manufatti. Ma non è la Natura che produce valore, categoria socio-antropologica per definizione.
D’altra parte, la rivoluzione delle tecniche dell’informazione e della comunicazione integra le conoscenze come fattore decisivo della creazione di ricchezza. Così nasce e si sviluppa un capitalismo qualificato come «cognitivo», o di «economia della conoscenza», o di «economia dell’informazione» o ancora come «economia dell’immateriale», che prende slancio dall’antico capitalismo fordista dell’industria di massa del dopoguerra (3). L’evoluzione sarebbe tale da condurre progressivamente siaa eliminare il lavoro come fonte del valore, secondo alcuni, siaa inglobarvi tutti gli istanti della vita, secondo altri. In ogni caso, questa evoluzione obbligherebbe ad abbandonare la legge marxista del valore, detta del «valore-lavoro», che avrebbe avuto il suo apogeo nell’epoca del fordismo.
Ormai il lavoro non produrrebbe più il valore, che «si forma principalmente nella circolazione (4)» del capitale. La sola via d’uscita sarebbe di guidare la trasformazione del capitalismo, che promette a ogni lavoratore la possibilità di «produrre sé stesso» e, simultaneamente, di versare un reddito di sopravvivenza a tutti coloro che il sistema mette comunque in disparte, invece di volere un pieno impiego ormai definitivamente fuori dalle previsioni e soprattutto contrario all’obiettivo dell’emancipazione dal lavoro.
Tuttavia questa tesi del capitalismo cognitivo solleva numerosi interrogativi. Il più importante conduce alla distinzione fra ricchezza e valore, o fra valore d’uso e valore di scambio. A mano a mano che aumenta la produttività del lavoro e diminuisce il lavoro che Mrax chiama «vivo» - e per lui si tratta di una «affermazione tautologica (5)» - il valore di scambio delle merci regredisce anch’esso, in conformità alla legge del valore. Così s’instaura un distacco sempre più grande fra il lavoro e le ricchezze create, vale a dire fra il lavoro e i valori d’uso, senza che ciò significhi un distacco fra lavoro e valore di scambio.
La nuova contraddizione del capitalismo è di voler trasformare la conoscenza in capitale da valorizzare. Due ostacoli almeno sorgono dinanzi a quest’ assunto. Il primo è il carattere difficilmente appropriabile della conoscenza in sé, poiché essa nasce dallo spirito umano e non può esserne tolta. Soltanto l’uso della conoscenza è facilmente appropriabile e il brevetto lo segna con la sua esclusiva o lo sottopone al pagamento di una rendita. Al di fuori da questo caso la conoscenza è un bene collettivo o comune per eccellenza, addirittura nel senso in cui lo definiscono gli economisti neoclassici: essa soddisfa le regole di non esclusione (non si può, per esempio, escludere chiunque dall’uso dell’illuminazione notturna delle strade) e di non-rivalità (l’uso da parte di qualcuno non impedisce l’uso da parte di qualcun altro).
Il secondo ostacolo all’appropriazione delle conoscenze da parte del capitale è il rischio che ciò fa correre alla loro diffusione e alla loro estensione. La socializzazione della produzione e della trasmissione delle conoscenze entra in contraddizione con la loro appropriazione privata. Questa contraddizione sta al centro della crisi del capitalismo contemporaneo, che ha difficoltà nel fare funzionare il sapere come capitale, ossia nel farne oggetto di profitto. Essi vi si dedica, ma non può per questo fare a meno della forza-lavoro che porta il sapere.
Dal momento in cui si riconosce che è possibile decidere un prezzo che sfugge all’obbligo di procurare una redditività sufficiente al capitale per rispettare una norma d’altra natura, si entra in un registro che, pur essendo monetario, diventa non commerciale. A questo proposito la produzione di servizi non commerciali, come l’educazione e la sanità pubblica, deve essere considerata come risultato di un lavoro produttivo di persone assegnate a questi compiti (6). La ricchezza non commerciale non è quindi un prelievo sull’attività commerciale: è un di più proveniente da una decisione pubblica di utilizzare a fini non lucrativi le forze-lavoro e le attrezzature e risorse disponibili. Essa è socializzata a doppio titolo: dalla decisione di utilizzare collettivamente le capacità produttive e da quella di ripartire socialmente il carico dei costi, attraverso le imposte.
La teoria liberale confonde ricchezza e valore e tende a ridurre ogni valore a quello destinato al capitale. Da un lato, il valore della produzione commerciale resta governato dal lavoro necessario, che è convalidato dal mercato. Ma, dall’altro, il riconoscimento del carattere produttivo del lavoro effettuato nella sfera non commerciale partecipa alla ridefinizione della ricchezza e del valore, indispensabile per contenere il processo di commercializzazione della società.
Questo lavoro risponde a bisogni sociali fuori dal campo delle merci; contribuisce inoltre al benessere, quest’altra specie di ricchezza che supera il quadro del valore in senso economico. A questa stregua la ricchezza socializzata non è meno ricchezza di quella privata; al contrario. Limitare lo spazio delle merci rende possibile l’allargamento di quello della gratuità costruita in senso sociale, ovvero delle attività umane che, benché abbiano un costo, non hanno prezzo nel senso del mercato. Questo permette infine di preservare i beni naturali e i legami sociali i quali, da parte loro, sono inestimabili.
 (1) Cf. Annabelle Berger et Jean-Luc Peyron, « Les multiples valeurs de la forêt française », Institut français de l’environnement (IFEN), Les Données de l’environnement, n o 105, Orléans, août 2005.
(1) Cf. Annabelle Berger et Jean-Luc Peyron, « Les multiples valeurs de la forêt française », Institut français de l’environnement (IFEN), Les Données de l’environnement, n o 105, Orléans, août 2005.
 (2) Robert Costanza (sous la dir. de), «The value of the world’s ecosystem services and natural capital », Nature, vol. 387, n o 6630, Londres, 15 mai 1977.
(2) Robert Costanza (sous la dir. de), «The value of the world’s ecosystem services and natural capital », Nature, vol. 387, n o 6630, Londres, 15 mai 1977.
 (3) Christian Azaïs, Antonella Corsani et Patrick Dieuaide (sous la dir. de), Vers un capitalisme cognitif. Entre mutations du travail et territoires, L’Harmattan, Paris, 2000 ; Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Exils, Paris, 2000 ; André Gorz, L’Immatériel. Connaissance, valeur et capital, Galilée, Paris, 2003.
(3) Christian Azaïs, Antonella Corsani et Patrick Dieuaide (sous la dir. de), Vers un capitalisme cognitif. Entre mutations du travail et territoires, L’Harmattan, Paris, 2000 ; Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Exils, Paris, 2000 ; André Gorz, L’Immatériel. Connaissance, valeur et capital, Galilée, Paris, 2003.
 (4) Yann Moulier Boutang, L’Abeille et l’Economiste, Carnets Nord, Paris, 2010.
(4) Yann Moulier Boutang, L’Abeille et l’Economiste, Carnets Nord, Paris, 2010.
 (5) Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858. Grundrisse, tome II, Editions sociales, Paris, 1980.
(5) Karl Marx, Manuscrits de 1857-1858. Grundrisse, tome II, Editions sociales, Paris, 1980.
 (6) Lire « Les vertus oubliées de l’activité non marchande », Le Monde diplomatique, novembre 2008.
(6) Lire « Les vertus oubliées de l’activité non marchande », Le Monde diplomatique, novembre 2008. -
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- "Ventisei secoli nel mondo dei filosofi" e "Lo scisma sommerso". La fede di Pietro Prini fra verità e dialogo28 dicembre 2013
La fede di Prini fra verità e dialogo
intervista a Walter Minella
a cura di Roberto Cutaia (Avvenire, 28 dicembre 2013)
P ietro Prini (14 maggio 1915-28 dicembre 2008) è stato uno dei più importanti filosofi cattolici del Novecento e tra i massimi esperti dell’esistenzialismo cristiano. Il filosofo di origini piemontesi ha lasciato un inedito, un corposo testo intitolato Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, che verrà prossimamente pubblicato dalla Lateran University Press. Ne parliamo con il curatore, Walter Minella, autore di una biografia intellettuale di Prini, premessa al testo.
 Quali sono le caratteristiche di questo inedito?
Quali sono le caratteristiche di questo inedito?«Si tratta di una serie di schede o medaglioni su molti dei più importanti filosofi occidentali, dalla Grecia antica fino alla prima metà del Novecento. Prini ha lavorato a quest’opera negli ultimi anni, fino alla stremo delle sue forze fisiche e intellettuali, ma non è riuscito a rifinirla. Il libro presenta dunque marginali difetti di carattere formale (che hanno reso indispensabile un minimo di intervento redazionale), alcuni dislivelli di approfondimento, qualche lacuna. Detto questo, l’opera è sostanzialmente compiuta, lo stile è accattivante, semplice e scorrevole».
 È un’autobiografia?
È un’autobiografia?«Indirettamente sì. Credo che, nelle intenzioni dell’autore, quest’opera dovesse rappresentare una sorta di sintesi conclusiva, un ultimo colloquio con i grandi del pensiero che lo avevano accompagnato tutta la vita».
 Quali sono gli autori con cui Prini si confronta in modo puntuale e convincente?
Quali sono gli autori con cui Prini si confronta in modo puntuale e convincente?«Direi Platone, Plotino e Agostino per quanto riguarda la filosofia antica, Pascal, Vico e Kant per la filosofia moderna, Heidegger, Jaspers e Marcel per la filosofia contemporanea. Sono tutti filosofi nei cui confronti Prini è variamente debitore, con cui instaura un dialogo aperto e affascinante. Esemplare è il confronto con la genialità straordinaria e debordante di Agostino».
 Come si inserisce quest’opera nello sviluppo del pensiero
complessivo di Prini?
Come si inserisce quest’opera nello sviluppo del pensiero
complessivo di Prini?«Il principio ispiratore di tutta la produzione filosofica di Prini è la sua fede cristiana: un’esperienza personale, che a suo parere non era derivabile da un atto di ragione, né era dimostrabile dalla ragione, ma che poteva essere mostrata, tanto nella testimonianza personale (Prini era particolarmente affezionato san Francesco, inteso come la più alta espressione di una civiltà dell’essere contrapposta alla civiltà dell’avere) quanto nelle tracce di bellezza, di bene, di armonia riscontrabili nel creato. Detto questo, per Prini esisteva un’altra caratteristica fondamentale del cristianesimo».
 Di che si tratta?
Di che si tratta?«Del rapporto tra dimensione metastorica e storicità. Prini era convinto che occorresse distinguere, all’interno del cristianesimo, tra il Vangelo come “buona notizia”, messaggio metastorico, universale, di salvezza e di gioia, e l’incarnazione storica di questo messaggio, che era necessariamente transitoria e storicamente mutevole. A suo parere era un grave errore confondere questi due livelli, e ritenere che l’inculturazione del cristianesimo nelle categorie della tarda grecità (che aveva studiato e che amava) fosse esaustiva della pienezza esuberante del messaggio cristiano (come avevano capito i gesuiti già nel XVII secolo) ».
 Certe critiche dagli ambienti cattolici non gli sono state
risparmiate. Alla luce di questo
inedito,
perché?
Certe critiche dagli ambienti cattolici non gli sono state
risparmiate. Alla luce di questo
inedito,
perché?«Questo inedito è un testo filosofico e serve a confermare che la preoccupazione di Prini, anche nella stesura del volume Scisma sommerso, era fondamentalmente filosofica: i dati statistici di sociologia religiosa erano da lui citati nel testo soltanto come esemplificazione, certo importante, del suo discorso, non come fondamento o come pilastro dell’edificio argomentativo. La preoccupazione filosofica di Prini, come ho detto prima, era relativa all’inculturazione del cristianesimo nella modernità, caratterizzata dalla cultura scientifica e dalla consapevolezza della libertà della coscienza dell’individuo, che deve essere convinto, non oggetto di un comando o di un’intimidazione. Prini pensava che la fede cristiana fosse indipendente dalla filosofia o dalla scienza, ma riteneva anche che le singole affermazioni della religione cristiana, in cui la fede si incarna, dovessero essere compatibili con “la cultura più accreditata del tempo”.
 In questo senso
scriveva nel 1967 che “la scienza non è certamente la chiave ermeneutica della Rivelazione: ma può
liberarne il senso da interpretazioni certamente false”. E nel 1998 che “il linguaggio simbolico che è
proprio del Sacro non può essere confuso con il linguaggio fattuale che è proprio della narrazione
profana”».
In questo senso
scriveva nel 1967 che “la scienza non è certamente la chiave ermeneutica della Rivelazione: ma può
liberarne il senso da interpretazioni certamente false”. E nel 1998 che “il linguaggio simbolico che è
proprio del Sacro non può essere confuso con il linguaggio fattuale che è proprio della narrazione
profana”». Nonostante ritenesse “virtuosismo inconcludente” il pensiero debole, di Prini oggi sono molto
interessati, almeno all’apparenza, coloro che tendono a fare un’ermeneutica del cristianesimo
al di fuori della Tradizione...
Nonostante ritenesse “virtuosismo inconcludente” il pensiero debole, di Prini oggi sono molto
interessati, almeno all’apparenza, coloro che tendono a fare un’ermeneutica del cristianesimo
al di fuori della Tradizione...«Prini ha sempre combattuto il nichilismo. Contemporaneamente è sempre stato un uomo del dialogo, ha sempre cercato un confronto critico e serrato con correnti filosofiche anche lontane dalla sua impostazione, oltre che con le scienze naturali e le scienze umane. Per quanto riguarda la Tradizione, Prini ne accettava integralmente lo spirito, mentre combatteva il tradizionalismo, perché riteneva che la ricezione letterale o formale della Tradizione ne distruggesse il senso più profondo».
 L’attualità del pensiero di Prini?
L’attualità del pensiero di Prini?«Penso all’immagine di papa Francesco, secondo la quale il pastore deve entrare in stretto contatto con le sue pecore, avere il loro stesso odore. Credo che con lo Scisma sommerso ( oggi introvabile) Prini ponesse la stessa esigenza di principio. Ma forse allora i tempi non erano ancora maturi. Forse oggi abbiamo più strumenti per capire il senso del lavoro di Prini, che era anzitutto un dono alla sua Chiesa».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- MICHELANGELO AL DI LA’ DI MACHIAVELLI.26 dicembre 2013, di Federico La Sala
 SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI.
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI.
 MACHIAVELLI E MICHELANGELO.
MACHIAVELLI E MICHELANGELO. Una nota dal lavoro di Romeo De Maio (a suo onore):
Una nota dal lavoro di Romeo De Maio (a suo onore): "(...) Michelangelo e Machiavelli, che pure avevano avuto rapporti amichevoli, erano in antitesi. La diversitù dei loro pensieri si può confrontare nella loro meditazione sull’insignificante Lorenzo de’ Medici, divenuto duca d’Urbino con lo sperpero del denaro della Chiesa fatto da suo zio Leone X. Machiavelli gli dedica il Principe e gl’insegna come si rende duraturo uno stato usurpato e come si crea una dinastia. Michelangelo, che dirà "bestia in forma di huomo" ogni tiranno, spogliò Lorenzo, fra la meraviglia dei contemporanei, delle sue sembianze e lo ritrasse scalzo sotto la corazza: non c’è un richiamo alla statua di Nabucodonosor dai piedi di argilla? Meditò anche sulla qualità del governante, e perciò circondò il monumento di profonde allegorie e lo fece "pensieroso", come non era stato" (Michelangelo e la Controriforma, Laterza, Roma-Bari 1978, pp. 418-419)
"(...) Michelangelo e Machiavelli, che pure avevano avuto rapporti amichevoli, erano in antitesi. La diversitù dei loro pensieri si può confrontare nella loro meditazione sull’insignificante Lorenzo de’ Medici, divenuto duca d’Urbino con lo sperpero del denaro della Chiesa fatto da suo zio Leone X. Machiavelli gli dedica il Principe e gl’insegna come si rende duraturo uno stato usurpato e come si crea una dinastia. Michelangelo, che dirà "bestia in forma di huomo" ogni tiranno, spogliò Lorenzo, fra la meraviglia dei contemporanei, delle sue sembianze e lo ritrasse scalzo sotto la corazza: non c’è un richiamo alla statua di Nabucodonosor dai piedi di argilla? Meditò anche sulla qualità del governante, e perciò circondò il monumento di profonde allegorie e lo fece "pensieroso", come non era stato" (Michelangelo e la Controriforma, Laterza, Roma-Bari 1978, pp. 418-419) GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE (federico la sala)
GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE (federico la sala)
Per Gennaro Sasso nell’opera del grande fiorentino la lotta del principe con la fortuna esprime un senso acuto della precarietà che caratterizza il potere politico. E la stessa condizione umana
Machiavelli come Sartre: un esistenzialista
di Antonio Carioti (Corriere/La Lettura, 22.12.2013)
L’interesse di Gennaro Sasso per Niccolò Machiavelli risale ai tempi del liceo. Il primo libro sul grande autore fiorentino lo pubblicò trentenne, nel 1958. Mentre termina un 2013 di celebrazioni un po’ retoriche per i cinque secoli del Principe , la sua lettura spicca per il richiamo alla radicalità di un pensiero che, da giovane, ha approfondito in parallelo a filosofi di tutt’altro genere, gli esistenzialisti.
«All’università - racconta Sasso - leggevo con passione Karl Jaspers e Jean-Paul Sartre, autori che insistono sulla precarietà di una condizione umana esposta alla contingenza. Suggestioni che mi sono servite per intendere meglio un motivo centrale in Machiavelli: la contestualizzazione estrema dell’azione politica in quella che lui chiama la fortuna, cioè gli accadimenti che non si controllano. Il dramma del principe è appunto la lotta con la fortuna, l’esigenza di sfruttare opportunità che non dipendono da lui».
Fronteggiare l’imponderabile, continua Sasso, diventa così la priorità assoluta: «Il destino dello Stato è sempre incerto. E bisogna difenderlo, perché ne va della vita di chi ne fa parte. Sono i venti della fortuna che spingono a usare i mezzi più utili nella situazione concreta, anche se malvagi. Perciò per Machiavelli bontà e cattiveria non contano. Lui stesso se ne duole, ma osserva che rimanere sempre fedeli ai valori etici nell’agire politico non produrrebbe alcun bene, perché causerebbe la rovina dello Stato».
Ma come si concilia tale crudo realismo con la chiusa del Principe , l’appello a liberare l’Italia dagli stranieri? «Il capitolo finale si riallaccia al sesto, dove si parla dell’azione salvifica svolta da individui eccezionali, come Mosè o Teseo, in situazioni che richiedevano una particolare virtù politica. In fondo proprio il realismo induce a ritenere che tempi terribili esigano personalità provvidenziali. Qui Machiavelli unisce acutezza di analisi e capacità d’immaginazione».
Tuttavia è ben lontano dall’affidarsi solo ai capi carismatici: «Machiavelli - osserva Sasso - esalta la virtù individuale del principe, ma la sua preferenza va a una repubblica in cui la solidità dello Stato risieda negli ordini, cioè nel quadro istituzionale. Nei principati c’è il problema spinoso della successione personale al potere, mentre nelle repubbliche la continuità è assicurata da un intreccio di forze diverse che, garantendo se stesse, tutelano anche il complesso dello Stato, in modo che non dipenda dall’autorità di un solo individuo. Machiavelli considera un modello ideale la tripartizione della repubblica romana: consoli, senato, plebe. E vede il perno della garanzia istituzionale nel coinvolgimento del popolo».
Eppure Machiavelli descrive un volgo infido e credulone. «Ma si riferisce al popolo dell’Italia di allora, abbandonato alla sua vena deteriore. Invece il popolo romano, con i tribuni della plebe, era un soggetto politicamente attivo. Le buone istituzioni servono appunto a fare in modo che le cattive inclinazioni umane non provochino troppi danni. Del resto Machiavelli è uno scrittore pagano, estraneo al senso cristiano del peccato. Per lui l’uomo non è malvagio in sé, ma perché è un essere a rischio, sempre in lotta per la sopravvivenza: un altro punto di consonanza con l’esistenzialismo ateo».
La religione gli importa solo come fattore politico: «Nell’Arte della guerra Machiavelli narra che, quando aveva cercato di arruolare contadini nella milizia fiorentina, si era trovato di fronte individui “venuti su per li bordelli”, ben poco affidabili. E si era chiesto su quale Dio farli giurare per trasformarli in soldati. Insomma, per lui la religione serve a creare un legame sacrale tra i cittadini e lo Stato. A tal fine si può usare anche il Dio cristiano, ma così lo si paganizza.
Un altro tema centrale in Machiavelli è appunto la decadenza: «Pensa che la caduta dell’impero romano abbia aperto una lunga fase di declino. L’Italia dei suoi tempi sta rinnovando i fasti dell’antichità quanto a splendore artistico e letterario, ma sul piano politico è in ginocchio, percorsa dagli eserciti di popoli barbari e rozzi. Machiavelli disprezza francesi e spagnoli: lo tormenta il fatto che la forza militare consenta a quelle genti incivili di straziare la sua terra».
Nel motivo della decadenza Sasso coglie aspetti attuali: «Nei Discorsi Machiavelli si chiede che fare quando un sistema politico va in crisi e nulla funziona più. Se le istituzioni sono a pezzi, non possono risanarsi da sole. Servirebbero uomini adatti a restaurare i princìpi originari dello Stato, ma è difficile che nascano in un’era di corruzione. L’Italia di oggi mi pare in condizioni del genere: necessita di governanti seri, con le idee chiare, e non sa dove trovarli».
Qualcuno vede il presidente Giorgio Napolitano come un aspirante principe. «Non capisco perché da tante parti si spari sul capo dello Stato. Non credo che, alla sua età, nutra ambizioni monarchiche: se può aver ecceduto i limiti costituzionali, è perché siamo nel caos e i vuoti vanno riempiti. Chiede solo che si faccia una legge elettorale, per mandare il Paese alle urne con qualche speranza che ne esca un governo stabile».
Forse il principe del XXI secolo dovrebbe avere una dimensione europea: «Invocherei piuttosto un legislatore capace di dare all’Europa consistenza politica. Oggi, con la crisi dell’euro, l’Unione è al tempo stesso una casa da cui sarebbe folle uscire, ma anche una gabbia soffocante. Del resto l’Ue è un’entità indefinibile dal punto di vista giuridico. Ci vorrebbe un punto di riferimento forte per andare oltre la visione angusta, monetarista e burocratica dell’Europa, per trasformarla in un vero Stato federale».
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- "Altri scrieei":Jacques Lacan e l’inconscio visto da vicino (di Massimo Recalcati)20 dicembre 2013, di Federico La Sala
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- DIO, NATURA, TECNICA COMUNICATIVA, E DEMOCRAZIA.16 dicembre 2013, di Federico La Sala
 DIO, NATURA, TECNICA COMUNICATIVA, E DEMOCRAZIA. IL "CHARISMA" DELL’ITALIA E IL "CHARISMA" DEGLI ITALIANI E DELLE ITALIANE.
DIO, NATURA, TECNICA COMUNICATIVA, E DEMOCRAZIA. IL "CHARISMA" DELL’ITALIA E IL "CHARISMA" DEGLI ITALIANI E DELLE ITALIANE.
 CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LA’ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione di Lidia Ravera - con una nota
CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LA’ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione di Lidia Ravera - con una nota
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- DIO, UOMINI E DONNE. Quella rivoluzione dottrinale che spaventa la gerarchia (di Gian Enrico Rusconi).17 dicembre 2013, di Federico La Sala
Quella rivoluzione dottrinale che spaventa la gerarchia
di Gian Enrico Rusconi (La Stampa, 16 dicembre 2013)
È spiazzante nella comunicazione pastorale. E non mette mai in forse la correttezza dottrinale. Papa Bergoglio è suggestivo nel suo stile personale di esprimersi, ma controllato, persino sofisticato, nel mantenere le posizioni tradizionali su punti controversi. Prendiamo uno dei passaggi più ironici, breve ma significativo, della sua intervista alla Stampa: «Le donne nella Chiesa devono essere valorizzate, non clericalizzate, facendole magari cardinali».
L’arguzia dell’affermazione evade la sostanza di un problema dottrinale irrisolto. Mi sarei atteso che Papa Francesco dicesse: la donna collocata in posti decisionali e in ruoli istituzionali essenziali, potrà de-clericalizzare la Chiesa così come è oggi. Perché non ha detto così? Si tratta di un limite personale o del timore che una autentica innovazione su questo tema (che implica una seria rivisitazione storico-dottrinale) sarebbe intollerabile per molti esponenti della gerarchia? Papa Francesco non è un ingenuo. È consapevole di muoversi su un crinale fragilissimo: la sua innovazione espressiva nella pastorale non è un “aggiornamento” vecchia maniera. Molte delle sue parole hanno un potenziale innovatore che entusiasma ed emoziona - in modo confuso - ampi strati di popolazione, fedeli credenti e fedeli critici o disillusi. Ma contemporaneamente inquieta molta parte della gerarchia che non sa decifrare l’esito di questa emozione collettiva .
Ma il Pontefice non vuole affatto creare tensioni o divisioni all’interno della Chiesa. Al contrario, come nessun altro dei suoi predecessori intende valorizzare al massimo le forme di collegialità esistenti. Prende molto sul serio il fatto che la problematica, apparentemente minore della comunione ai credenti divorziati risposati, e quella assai più impegnativa di una riflessione sulla famiglia, sia affidata alla risoluzioni del Sinodo del 2014. Non alla autorevolezza della sua parola ma a processi di convincimento della comunità dei fedeli sotto la guida dei suoi pastori.
E’ una prospettiva interessante, anche se non credo che verranno fuori novità. Ma sarà già importante che a livello di società civile, di dibattito pubblico e soprattutto di normative giuridiche sparisca lo spirito falsamente militante (legato all’uso e abuso della formula dei “valori non negoziabili”) a favore di un confronto più maturo e ragionevole fra tutti i cittadini, credenti e non credenti.
Come si lega tutto questo alle suggestive parole di Papa Bergoglio sulla “tenerezza” e “la speranza” che è la parte centrale del suo discorso? Sarebbe facile considerare questa parte una edificante predica natalizia, meno concreta ad esempio delle puntualizzazioni con cui respinge il presunto marxismo della sua posizione, rivendicando l’anticapitalismo della dottrina sociale della Chiesa. Ma l’affermazione «quando i cristiani si dimenticano della speranza e della tenerezza, diventano una Chiesa fredda che non sa dove andare e si imbroglia», introduce considerazioni di sapore mistico che sono tipiche dello stile di Francesco. Non solo la quasi palpapile «tenerezza di Dio che ti accarezza» ma anche la dimensione opposta, dura, di Dio che non parla davanti al perché della sofferenza «Lui non spiega niente. Ma sento che mi guarda. Tu non me lo dici, ma mi guardi».
Il dramma antico dell’ inspiegabilità del dolore, che omologa credente e non credente, trova qui la sua via di fuga. Che un Papa sappia trovare le parole giuste in una intervista ad un giornale e più in generale padroneggiando con perizia il circuito mediatico, fa parte della personalità di Bergoglio. Che questa sia la strada per evitare una “Chiesa fredda” è tutto da verificare.
-
> DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. --- [LA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI18 dicembre 2013, di Federico La SalaLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E IL MAGISTERO DEI SANTI PADRI DELLA CHIESA CATTOLICA DI OGGI. Il cardinale Ravasi si rende conto che "è grave atrofizzare la facoltà, di cui è dotata la nostra mente, di sceverare tra vero e falso", ma continua a fare "sogni d’oro"!
-
-
