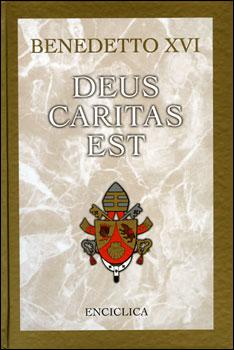
LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA E LA SCIATTERIA NAZIONALE. Una nota di Piero Ottone e una di Giulio Nascimbeni - a cura di Federico La Sala
lunedì 18 maggio 2009.
- [...] NON CAPIRE UN’ACCA - Il significato di questo modo di dire è «non capire niente». Eppure «h» è l’ ottava lettera dell’ alfabeto, però è priva di suono proprio. In italiano «h» è presente nelle voci verbali «ho, hai, ha, hanno» che testimoniano la derivazione dal latino (habeo, habes, habet, habent) e nelle esclamazioni «ah!, ahi!, deh!, ehi!», ma non ha alcun valore agli effetti della pronuncia e quindi corrisponde a «niente, nulla» [...]
L’insostenibile leggerezza della lettera «h»
di PIERO OTTONE *
La h è di tutte le lettere dell’alfabeto, notoriamente la più capricciosa. Non ha un suo suono autonomo, o lo ha scarsamente percettibile: una semplice aspirazione di cui si può fare a meno. Ma agisce su altre lettere dell’alfabeto: in modo cervellotico, secondo la latitudine. Alla nostra, conferisce alla c un suono gutturale: che si pronuncia come se fosse ke. Ma a una latitudine superiore (Inghilterra) conferisce alla stessa consonante, c, un suono palatale: chester diventa alla pronuncia cester.
Come se non bastasse, a una latitudine intermedia ch è l’equivalente del nostro sc: in francese, chef corrisponde all’italiano scef. Alla latitudine tedesca la h fa poco: si limita a imporre, distrattamente, una certa aspirazione. Chemie corrisponde a hhemie, e so che la mia trascrizione è imperfetta. Quanto ai russi, meglio non parlarne: li la lettera h non esiste, siamo in un mondo tutto diverso, e Hitler diventa Ghitler. Sappiamo, poi, come è andata a finire. Vi sono parole internazionali di uso comune che contengono una h muta. Sarebbe di buon gusto trascriverle, quando le adoperiamo, in modo corretto. Una delle più frequenti è yacht, coi suoi derivati: yachting, yachtsman... E qui cominciano i guai. Perché tanti miei cari colleghi, quando si occupano di chi naviga per diporto, usano il vocabolo acconcio: ma nella trascrizione si trovano di fronte al problema della h, e non sanno dove piazzarla. Yachtsman? O yahctsman? 0 yacthsman? Quella h ballerina finisce dove finisce. Eppure, eppure... Non sarebbe difficile, per una persona dotata di media intelligenza, imparare a memoria dove si colloca il segno puramente simbolico, h, e scrivere come si deve il vocabolo di cui fa parte.
Non lo si fa perché non si dà importanza all’esattezza. Si procede per approssimazione: con sciatteria (quella che i tedeschi, ricordate?, chiamano Schlampigkeit). La stessa sciatteria per cui in tv si pronuncia qualsiasi nome straniero come capita. Vlàdimir? Vladìmir? Vladimìr? Come viene viene.
Addirittura ho constatato che, nella lettura di un testo sulla famiglia imperiale russa, che durava un’ora, colui che leggeva non si era preso la briga di scoprire se stesse parlando dei Ròmanov, dei Romànov, o dei Romanòv, e pronunciava il nome, costantemente, nel modo sbagliato. Che importa? Come viene viene. Ma quanti guai derivano, per tutti noi, dalla sciatteria nazionale.
* Il Venerdì di Repubblica, 15.05.2009, p. 19.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
A FRANCESCO E CHIARA DI ASSISI. A DANTE E ALL’ ITALIA. "Deus charitas est: et qui manet in charitate, in Deo manet, et Deus in eo" (1 Gv., 4.16).
 SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
MODI DI DIRE
 La lettera che non conta nulla
La lettera che non conta nulla
 Il piccolo regno di una cicca
Il piccolo regno di una cicca
 Come «acca», molte altre parole significano «niente», tra cui fico secco
Come «acca», molte altre parole significano «niente», tra cui fico secco
NON CAPIRE UN’ACCA - Il significato di questo modo di dire è «non capire niente». Eppure «h» è l’ ottava lettera dell’ alfabeto, però è priva di suono proprio. In italiano «h» è presente nelle voci verbali «ho, hai, ha, hanno» che testimoniano la derivazione dal latino (habeo, habes, habet, habent) e nelle esclamazioni «ah!, ahi!, deh!, ehi!», ma non ha alcun valore agli effetti della pronuncia e quindi corrisponde a «niente, nulla». Come «acca», molte altre parole significano «niente, nulla», soprattutto se accompagnate al verbo «valere»: non valere una cicca, un fico secco, uno zero, un soldo, un accidente. Quanto all’ espressione «non valere un ette», il riferimento è al latino «et» come parte del discorso di importanza minima, trascurabile.
Nascimbeni Giulio
* Corriere della Sera, 5 agosto 2004, Pagina 33
Forum
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA E LA SCIATTERIA NAZIONALE. --- «A» con l’acca o senza? Le avventure della lettera «H», la più odiata dagli italiani (di Redazione sScuola - Cor. Sera).23 ottobre 2021, di Federico La Sala
UNA QUESTIONE DI SPIRITO. La storia millenaria di un errore secolare... *
Trappole dell’ortografia
«A» con l’acca o senza? Le avventure della lettera «H», la più odiata dagli italiani
Dall’alfabeto fenicio all’Ariosto, la vicenda millenaria del simbolo grafico «H» ricostruita dal ricercatore Fabio Copani e rilanciata dai social
di Redazione Scuola *
La più strana delle lettere dell’alfabeto
«Mamma, ma perché “Mario ha un amico” si scrive con l’acca visto che si pronuncia nello stesso identico modo di “Mario va a scuola”?». Perché è voce del verbo avere. «E allora perché non si scrive habbiamo e havete?». In latino effettivamente si scriveva così, ma si pronunciava anche diversamente, aspirando l’acca. Mentre in italiano la «H» è una lettera strana, una lettera muta.
Si scrive ma non si legge, si vede ma non si sente. Eppure è importantissima. Talmente importante che se non ci fosse si scatenerebbe l’Apocalisse: le chiese senza l’acca crollerebbero come sotto le bombe, i cherubini cadrebbero dal cielo, i bicchieri esploderebbero in mano, i galli invece di cantare starnutirebbero: CICCIRICÌ. E’ quanto immaginava Gianni Rodari in una filastrocca del Libro degli Errori in cui l’Acca - «stufa di non valere un’acca» - fuggiva dall’Italia. Ebbene a restituire l’onore perduto alla più bistrattata delle lettere dell’alfabeto ci ha pensato Fabio Copani, giovane dottore di ricerca in Storia greca, che ha ricostruito la sua lunga e travagliata odissea attraverso il Mediterraneo. Una storia che comincia sulle spiagge fenicie, monta a bordo delle navi dei commercianti libanesi, sbarca in Grecia, di lì a Cuma, e poi a Roma dove indispettisce Catullo e insuperbisce l’Ariosto, per atterrare infine sui manuali di scuola.
- [Foto] L’Acca in fuga di Gianni Rodari
La lettera Het nella lingua fenicia
La storia della H è antica quanto quella dell’alfabeto che, come si sa, fu inventato dai fenici. La «het» era l’ottava lettera dell’alfabeto fenicio e si scriveva con un segno a forma di rettangolo con un trattino in mezzo («acca chiusa»). Corrispondeva a un suono per noi sconosciuto che veniva prodotto con un restringimento della cavità orale all’altezza della faringe (i linguisti lo chiamano «spirante faringale»).
- [Foto] L’alfabeto fenicio
Dalle coste libanesi alla Grecia
A partire dal IX secolo a.C. i commercianti libanesi ebbero contatti sempre più frequenti con i greci i quali non restarono insensibili alle loro straordinarie invenzioni tecnologiche, dal vetro all’alfabeto. L’adozione dell’alfabeto fu un processo complesso perché il greco antico era una lingua indoeuropea con suoni diversi dal fenicio che era una lingua semitica. In greco molte parole iniziavano con delle vocali aspirate: quelle parole furono trascritte con il segno «het» davanti che stava a indicare appunto un’aspirazione.
- [Foto] Nave fenicia
Dalla acca chiusa all’acca aperta
Verso la fine del VII secolo a.C. vi fu una semplificazione dell’antico segno «het»: i due trattini superiore e inferiore vennero tralasciati e la lettera assunse la forma della nostra acca. Si passò così, gradualmente, dalla «acca chiusa» alle «acca aperta».
- [Foto] Alfabeto greco arcaico
L’alfabeto di Mileto
In greco antico esistevano però molti dialetti. A Mileto per esempio, e più in generale nella Ionia asiatica corrispondente alla costa centrale della Turchia, i greci parlavano un dialetto privo di aspirazioni (i linguisti lo chiamano «psilotico»). Loro usavano il simbolo «het» fenicio per indicare la vocale «e» lunga.
 Nel 403 a.C. la città di Atene decise con un decreto ufficiale di adottare l’alfabeto di Mileto. Fu così che il segno a forma di «acca» si impose quasi ovunque nel mondo greco come simbolo della lettera eta, cioè della «e» lunga, mentre per indicare il suono aspirato entrò in uso lo «spirito aspro» sopra le vocali iniziali.
Nel 403 a.C. la città di Atene decise con un decreto ufficiale di adottare l’alfabeto di Mileto. Fu così che il segno a forma di «acca» si impose quasi ovunque nel mondo greco come simbolo della lettera eta, cioè della «e» lunga, mentre per indicare il suono aspirato entrò in uso lo «spirito aspro» sopra le vocali iniziali.- [Foto] La porta del mercato di Mileto ricostruita al Pergamon di Berlino. Il reperto è di età romana
L’alfabeto dei cumani
Il segno a forma di acca ebbe una sorte diversa nelle colonie greche in Campania, prima fra tutte Cuma, che fu fondata dai greci dell’isola Eubea nell’VIII secolo. Nell’alfabeto dei cumani quel segno continuava a indicare il suono dell’acca aspirata e così passò anche ai romani che adottarono il simbolo nella sua variante aperta proprio per indicare il suono dell’aspirazione all’inizio di molte parole latine (homo, uomo, habere, avere, da cui l’acca che sopravvive ancora in italiano - anche se muta - nelle voci del verbo avere).
- [Foto] Cuma, l’antro della Sibilla
Catullo e l’acca del sussiegoso Arrio
Come avvenne il passaggio dalla acca aspirata latina all’acca muta italiana? Il fatto è che nell’Antica Roma i ricchi parlavano in un modo e i poveri in un altro: la lingua colta marcava l’acca all’inizio delle parole, il popolo ignorante invece non pronunciava l’acca. Ne dà testimonianza Catullo in una sua poesia in cui ironizza su un certo Arrio che per darsi un tono piazza l’acca aspirata a sproposito un po’ dappertutto.
- [Foto] Gaio Valerio Catullo
Ariosto e l’uomo senz’acca che è senza onore
La lingua parlata italiana ereditò la dizione del latino rustico che non pronunciava il suono aspirato all’inizio della parola. Tuttavia la acca sopravvisse nell’italiano scritto. Fra i suoi paladini più convinti, nel Rinascimento, vi fu Ludovico Ariosto («Chi leva la H all’huomo, e chi la leva all’honore, non è degno di honore»). Alla fine però i nemici dell’acca ebbero la meglio e imposero una grafia semplificata senza il segno «H» all’inizio della parola. A partire dalla fine del Seicento si definì una consuetudine ortografica che salvava l’acca solo nelle prime tre persone singolari e nella terza plurale dell’indicativo presente del verbo avere («ho», «hai», «ha», «hanno»), quelle cioè che si prestavano a confusione con altre parole dal suono uguale ma dal significato diverso («o», «ai», a», «anno»). E qui si chiude la storia millenaria di un errore secolare.
- [Foto] Ludovico Ariosto
* Corriere della Sera, 9 dicembre 1917 (ripresa parziale - senza immagini).
*
Sul tema, cfr.:
- IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione" [2006].
- Eric A. Havelock, "Dalla A alla Z. Le origini della civiltà della scrittura in Occidente", Il melangolo, 1987
FLS
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA E LA SCIATTERIA NAZIONALE. --- ASCOLTARE (ANCORA E SEMPRE) LA LEZIONE DI PONZIO PILATO E NON CAPIRE UNA "H" (ACCA)?!1 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE.
Da Giovanni Pico della Mirandola* a Herbert Marcuse** e ...
CARO ARMANDO, PER IMPARARE "a vivere meglio senza lasciarci condizionare dalla paura della morte, cioè dalla religione, qualunque essa sia", CREDO CHE SIA NECESSARIO riconsiderare il problema di "come nascono i bambini" (a tutti i livelli)! Hai ragione: "Non possiamo permetterci, con le Sibille, Maria Vergine, Cristo come dio, Maometto ed altre favolette l’illusione di un altro Messia"! Ci siamo addormentati nella tradizione cattolico-costantiniana e illuministica acritica (contro Kant), e abbiamo finito per "concepire" noi stessi e noi stesse secondo la bio-logia e l’andro-logia “unidimensionale” dell’omuncolo!
L’«ECCE HOMO» di Ponzio Pilato, al contrario!, ci dice proprio questo - la fine delle "favolette" e di ogni "illusione di un altro Messia". Il discorso è di diritto e di fatto, romanamente universale, vale a dire, antropologico (non limitato all’«omuncolo» di qualche "uomo supremo" o “superuomo”!):
- PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
SE SIAMO ANCORA CAPACI DI LEGGERE, COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA LEZIONE DI PONZIO PILATO?! Non è una lezione critica contro i "sovranisti" laici e religiosi di ieri e di oggi?!
Che vogliamo fare? Continuare a riportare noi stessi e noi stesse davanti a Pilato e ripetere da scemi e da sceme la stessa scena, riascoltare il suo "Ecce Homo" e non capire una "H" (acca)?!
* Discorso sulla dignità dell’uomo.P.S. - RICORDANDO ... GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA.
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA E LA SCIATTERIA NAZIONALE --- SCIENZA E FILOSOFIA. "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia" (di Antonio Rainone)28 dicembre 2019, di Federico La Sala
USCIRE DALL’INFERNO EPISTEMOLOGICO. Amore (Charitas) o Mammona (Caritas)?! Il "principle of charity", il «principio di carità» ("caritas"!), un assunzione di tipo «imperialistico» (Robert Nozick, "The Nature of Rationality", 1993) *
CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO
di Antonio Rainone *
- 3.Linguaggio ed empatia in W. V. Quine
Carità o empatia?
Esiste una tematica nella filosofia del linguaggio e nell’epistemologia di W. V. Quine che può apparire per molti versi atipica o sorprendente a chi abbia del celebre filosofo statunitense un’immagine limitata alle sue concezioni fisicalistiche e comportamentistiche, per non dire “scientistiche”, non di rado considerate le più caratteristiche della sua produzione filosofica. Si tratta della tematica dell’empatia, cioè della capacità di avanzare spiegazioni o interpretazioni del comportamento (linguistico e non) di altri soggetti “mettendosi nei loro panni” o “simulandone” la situazione cognitiva o, ancora, assumendone immaginativamente il ruolo.
 L’empatia - anche indipendentemente da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object (1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione più tarda.
L’empatia - anche indipendentemente da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object (1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione più tarda.A partire dagli anni Settanta, ma più esplicitamente negli anni Novanta, Quine ha considerato il metodo dell’empatia come il metodo fondamentale di traduzione nel celebre Gedankenexperiment della traduzione radicale (ovvero la traduzione di una lingua completamente sconosciuta), ma anche come una capacità naturale ai fini dell’acquisizione del linguaggio e dell’attribuzione di stati mentali intenzionali (ossia percezioni, credenze, desideri ecc.) ad altri. In effetti, l’empatia ha acquisito un rilievo così crescente in Quine che nei suoi due ultimi lavori sistematici, Pursuit of Truth (1992) e From Stimulus to Science (1995), essa appare come un nucleo centrale della sua filosofia del linguaggio e della mente.
È stato del resto lo stesso Quine a sottolineare la rilevanza dell’empatia nella sua filosofia del linguaggio, “retrodatandone”, per così dire, la teorizzazione agli anni Cinquanta. Così Quine si esprime in uno dei suoi ultimi interventi sulla questione:
- Il mio uso della parola “empatia” è piuttosto recente ed è stato notato, ma io avevo già riconosciuto che l’approccio del traduttore radicale è di tipo empatico in Word and Object e, in realtà, già nove anni prima. «Il lessicografo - avevo scritto - dipende [...] da una proiezione di sé stesso, con la sua Weltanschauung indo-europea, nei sandali del suo informatore Kalaba» (Quine, 2000, p. 410).
Il brano qui citato da Quine, ripreso dall’importante The Problem of Meaning in Linguistics (1951b, p. 63) - una notevole anticipazione della problematica della traduzione radicale - non è privo di una certa ambiguità, prestandosi a una duplice lettura. È forse vero che in Word and Object alcune affermazioni di Quine potrebbero essere interpretate come la proposta di un metodo empatico, sostenuto comunque in modo non del tutto esplicito (cfr. Rainone, 1995), ma possono essere avanzati dei dubbi circa la difesa di tale metodo nel saggio del 1951. Se da un lato il concetto di proiezione sembra proporre il metodo dell’empatia nell’attività di traduzione di una lingua completamente sconosciuta da parte di un etnolinguista, dall’altro sembra in effetti riferirsi non tanto al metodo empatico, quanto, piuttosto, a quello che, grazie allo stesso Quine, e in seguito a Donald Davidson (cfr. Davidson, 1984), sarebbe diventato noto come «principio di carità» (principle of charity). Il linguista - asseriva infatti Quine - proietta sé stesso con la sua Weltanschauung nei panni del nativo che usa una lingua sconosciuta, presupponendo (o ipotizzando) così che il suo informatore si conformi ai suoi principi logici e abbia le sue stesse credenze (ritenute vere) riguardo alla realtà (sono questi, grosso modo, i principali tenet del principio di carità, che presuppone una comune natura razionale tra interprete/ traduttore e interpretato/parlante).
In Word and Object Quine avrebbe esplicitamente utilizzato - e teorizzato - il principio di carità riguardo alla traduzione dei connettivi logici e degli enunciati “ovvi”. L’esempio più pertinente, in merito, è rappresentato dal «caso estremo» di qualche nativo che accetti come veri enunciati traducibili nella forma “p e non-p” (per esempio, “piove e non piove”), una forma enunciativa che, violando il principio di non contraddizione, deporrebbe per Quine non a favore dell’irrazionalità dei parlanti - come riteneva Lévy-Bruhl con la sua teoria della «mentalità prelogica» - ma contro la correttezza della traduzione (Quine, 1960, p. 58).
Il medesimo argomento varrebbe inoltre per la traduzione di enunciati ovvi: una risposta negativa da parte del nativo alla domanda (nella lingua nativa) “sta piovendo?” fatta sotto la pioggia costituirebbe una prova di cattiva traduzione nella lingua nativa, non del fatto che il nativo non condivida con il traduttore la credenza in qualcosa di così evidente. In generale, nota Quine in un famoso passo di Word and Object, «quanto più assurde o esotiche sono le credenze attribuite a una persona tanto più sospetti abbiamo il diritto di essere nei confronti delle traduzioni; il mito dei popoli prelogici segna solo il caso estremo» (ivi, p. 68).
Difficilmente, pertanto, la «proiezione» del linguista nei «sandali» del nativo di cui Quine parlava nel saggio del 1951 potrebbe apparire come una forma di metodo empatico, dal momento che essa “imporrebbe” al nativo uno «schema concettuale» (quello del linguista) che, per quanto il linguista può saperne, potrebbe essergli del tutto estraneo. Questo è, in fondo, il problema sottostante a tutto il celebre secondo capitolo di Word and Object 3. Non vi sarebbe alcuna garanzia, infatti, secondo Quine, che i nativi condividano lo stesso schema concettuale (la stessa Weltanschauung) del linguista. Ma il linguista non può, d’altro canto, che fare affidamento sul proprio linguaggio (o schema concettuale), data la scarsa evidenza empirica di cui dispone nel tradurre la lingua sconosciuta. Basarsi sul proprio schema concettuale, proiettandolo sul «linguaggio della giungla», è una necessità pratica, che - asseriva Quine in Word and Object - investirebbe soprattutto l’elaborazione delle «ipotesi analitiche», ovvero le ipotetiche correlazioni tra le emissioni verbali olofrastiche dei nativi e le loro possibili traduzioni mediante cui il linguista deve stabilire quali frammenti di enunciati andranno considerati termini (singolari e generali), quali congiunzioni, quali articoli, quali desinenze per il plurale e quali pronomi, sulla cui base individuare un insieme plausibile di credenze ontologiche ed epistemiche. La scelta delle ipotesi analitiche, infatti, non è altro che un modo di «catapultarsi nel linguaggio della giungla utilizzando i propri modelli linguistici » (ivi, p. 70).
 Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.
Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.Utilizzare i modelli del proprio linguaggio per tradurre un linguaggio alieno non equivale quindi ad applicare un metodo empatico di comprensione, trattandosi al massimo di un’ulteriore e più ampia applicazione del principio di carità. L’empatia sembra in realtà qualcosa di diverso dalla carità: a differenza di quest’ultima, l’empatia non presuppone necessariamente una condivisione di significati e stati cognitivi (credenze). Forse l’assunzione di un’analogia di stati cognitivi tra interprete e interpretato - il «ritrovamento dell’io nel tu», secondo la celebre formula di Wilhelm Dilthey (1927, trad. it. p. 293) - può apparire inevitabile ed efficace riguardo alle risposte verbali fenomenologiche direttamente connesse a stimolazioni elementari provenienti da eventi osservativi intersoggettivi del mondo esterno (la pioggia, il colore rosso, il caldo e il freddo ecc.): ci si aspetta infatti che i nativi, che presentano una conformazione neurofisiologica e neuropsicologica analoga alla nostra, non abbiano percezioni di tipo diverso dalle nostre, rispondendo linguisticamente a tali percezioni in modo analogo a come risponderemmo noi; in tal caso l’empatia sembrerebbe indistinguibile dalla carità interpretativa, in quanto fondata sull’assunzione dell’esistenza di meccanismi percettivi comuni ai soggetti coinvolti. Ma difficilmente tale analogia potrebbe essere presupposta allorché si tratti di tradurre il linguaggio o spiegare il comportamento di soggetti appartenenti a una cultura del tutto estranea a quella dell’interprete. In questo caso l’interprete dovrà in qualche modo “entrare”, per così dire, nella “mente” dei soggetti da interpretare per comprendere il loro peculiare punto di vista, le loro credenze sulla realtà e i significati delle loro parole.
In definitiva, la differenza tra carità ed empatia può essere intesa come la differenza tra imporre il proprio punto di vista all’altro e assumere il punto di vista dell’altro. La differenza è particolarmente rilevante nei casi di interpretazione di soggetti appartenenti a “mondi” radicalmente diversi da quello dell’interprete. Se così non fosse, difficilmente gli etnoantropologi avrebbero potuto attribuire credenze animistiche o culti religiosi atipici (come i celebri cargo cults) alle popolazioni studiate (in entrambi i casi si dovrebbe trattare, secondo un’interpretazione caritatevole, di errori di traduzione o interpretazione).
Non dovrebbe costituire motivo di sorpresa, allora, che David K. Lewis, in un saggio dedicato alla problematica davidsoniana dell’«interpretazione radicale», avesse dato una definizione del principio di carità che ingloba, per così dire, anche il procedimento empatico: un soggetto di interpretazione, asseriva Lewis, «dovrebbe credere ciò che crediamo noi, o forse ciò che avremmo creduto noi al suo posto; e dovrebbe desiderare ciò che desideriamo noi, o forse ciò che avremmo desiderato noi al suo posto» (Lewis, 1974, p. 336; corsivi aggiunti). In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.
Ma forse c’è ancora qualcosa da dire: mentre la carità impone dei vincoli normativi sulla razionalità dei soggetti da interpretare - vincoli a priori basati sui principi logici e sulle norme di razionalità epistemica e pratica dell’interprete, ritenuti universali 4 -, l’empatia sembrerebbe invece un metodo descrittivo ed empirico, essendo subordinata all’acquisizione di un’ampia gamma di informazioni relative alle credenze, alla cultura e alle esperienze passate dei soggetti da interpretare (inutile aggiungere che non c’è accordo su quest’ultimo punto).
4. Si può ricordare, riguardo a questa presunta universalità, che Robert Nozick ha contestato il principio di carità in quanto assunzione di tipo «imperialistico», conferendo tale principio «un peso indebito alla posizione che accade di occupare a noi, alle nostre credenze e alle nostre preferenze» (Nozick, 1993, p. 153). Giustamente, Nozick fa notare che difficilmente questa sarebbe l’assunzione di un antropologo relativamente alle cosiddette società “primitive” (ivi, p. 154).
* Cfr. Antonio Rainone, "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia", Carocci editore, Roma, 2019, pp. 55-59, ripresa parziale.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO"
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA E LA SCIATTERIA NAZIONALE. --- "Venite e vedrete: memoria dell’apostolo Andrea, morto martire su una croce a forma di "x" e a testa in giù attorno al 60.30 novembre 2019, di Federico La Sala
Il santo del giorno
Andrea.
Pescatore, portò a Gesù il fratello Pietro. È un modello per gli evangelizzatori
di Matteo Liut (Avvenire, sabato 30 novembre 2019)
Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci faccia conoscere Gesù e che ci porti all’incontro con lui: sant’Andrea è il modello per tutti coloro che "accompagnano alla fede" proprio perché fu il fautore del primo fondamentale incontro nella storia della Chiesa, quello tra Gesù e Pietro.
Il Vangelo di Giovanni ci presenta Andrea - che era nato a Betsaida sulle rive dell’omonimo lago in Galilea - intento ad ascoltare il Battista quando egli indicò il Messia. Andrea chiese allora a Gesù dove stava di casa e la risposta è un invito che vale ancora oggi per tutti gli esseri umani: "venite e vedrete".
Il primo pensiero di Andrea fu quello di andare a raccontare al fratello Pietro, anche lui pescatore, quell’incontro straordinario.
Secondo la tradizione Andrea, dopo la Risurrezione e la Pentecoste, fu evangelizzatore in Asia Minore, arrivando in seguito a Patrasso, dove sarebbe morto martire, su una croce a forma di "x" e a testa in giù attorno al 60.
Altri santi. San Tutwal, abate e vescovo (VI sec.); san Taddeo Liu Ruiting, martire (1773-1823).
 Letture. Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22.
Letture. Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22.
 Ambrosiano. 1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22.
Ambrosiano. 1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22. -
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA -- E LA LEZIONE DEL "DE OFFICIIS MINISTRORUM" DI SANT’AMBROGIO.21 marzo 2018, di Federico La Sala
IL "LOGOS" E LA "CHARITAS". Sul Vaticano, e su Roma, il "Logo" del Grande Mercante.Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
- SANT’AMBROGIO - AMBROSIUS, In Epistolam Beati Pauli Ad Corinthios Primam, Caput XIII, Vers. 4-8:
- "Charitas Deus est" (I Joan. 4,8).
- Ambrosius, De Officiis ministrorum, Liber 2, Caput XXX, 155:
- "Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil charitate dulcius, nihil pace gratius"()
Il motto dello stemma episcopale del Vescovo Ausiliare di Roma, S.E.R. Mons. Angelo De Donatis
- NIHIL CARITATE DULCIUS (Ambrosius “De Officiis ministrorum” Liber 2, Caput XXX, 155)
Le parole scelte da Don Angelo per il proprio motto episcopale sono tratte dal “De officiis ministrorum” di Sant’Ambrogio laddove dice
 “Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”
“Sit inter vos pax, quae superat omnem sensum. Amate vos invicem. Nihil caritate dulcius,nihil pace gratius...”
 (“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) *
(“Sia tra di voi la pace che supera ogni sentimento. Amatevi gli uni gli altri. Nulla è più dolce dell’amore, nulla più gradevole della pace”) **
Fonte: http://www.sanmarcoevangelista.it (ripresa parziale).
Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ACCA -- PERDITA DELLA MEMORIA FILOLOGICA E TEOLOGICA. La dittatura della X fra affetti e affari.1 dicembre 2017, di Federico La Sala
PERDITA DELLA MEMORIA FILOLOGICA E TEOLOGICA: LA “X” (“CHI”, GRECO) DIVENTA “X” (“ICS”, LATINO; E, SEMPLICEMENTE, "C", IN ITALIANO) E GESU’, IL FIGLIO DELLA GRAZIA EVANGELICA ("CHARITAS") DIVENTA IL "TESORO" DI "MAMMONA" ("CARITAS") E DI "MAMMASANTISSIMA" DEI FARAONI ...
- "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS": LA CARITA’ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia) NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!).
opinioni
La dittatura della X fra affetti e affari
di Vittorio Zucconi (la Repubblica D, 25.11.2017)
Il Medioevo italiano la mise al bando, ma ora si usa ovunque, perché, evidentemente, attira l’attenzione. Che si tratti di business o di baci
ATTESO DA ALMENO cento milioni di esseri umani, molti dei quali in fila da giorni, è arrivato l’ultimo totem per il villaggio globale: l’iPhone X della Apple. Niente di misterioso in quella X, solo la celebrazione in numeri romani del decimo anniversario dell’iPhone lanciato da Steve Jobs: così dicono dalla Mela, ma mentono sapendo di mentire. Per segnalare il decennale, avrebbero potuto benissimo chiamarlo iPhone 10, come i predecessori 6, 7 o 8.
I geni del marketing hanno scelto la X per lo stesso motivo che ha spinto i concorrenti della Microsoft a chiamare la loro scatola da giochi XBox e (nell’ultima edizione diffusa negli stessi giorni dell’iPhone X, per tormentarci il Natale) addirittura XBoxOneX. Tre X al prezzo di una. Non è necessario essere geni dell’enigmistica e dei cruciverba per notare la fissazione per una lettera-simbolo che, da secoli e mai come ora, è uscita dal recinto dell’algebra per invadere i territori del commercio, dell’immaginazione, del calcio e del sesso, pardon, del sex.
La X vende, piace, intriga, nella sua invadenza. L’epidemia di questa lettera (che, nel Medioevo, l’alfabeto italiano aveva escluso, insieme con K e Y, presenti invece nell’alfabeto latino) è naturalmente partita dagli Stati Uniti ed è un indizio del dominio culturale anglofono. È ovunque e le femmine ne hanno pretese addirittura due nei propri cromosomi, XX, lasciando a noi maschi l’umiliazione di quella Y solitaria.
S’insinua nella vita di ogni paziente, che ha sicuramente inghiottito una pillola il cui nome conteneva una X o è stato esposto ai raggi X. Ci sono almeno 50 farmaci da ricetta che la esibiscono, dal tranquillante Xanax, che raddoppia per sembrare più efficace, all’antibiotico Ciprofloxacina, somministrato a milioni di persone afflitte da infezioni delle vie urinarie.
Qualche linguista Usa ha cercato di spiegare l’attrazione con il Cristianesimo, partendo dalla croce che i Romani usavano per uccidere i nemici più pericolosi e che era fatta appunto a X, e non a T come nell’iconografia ufficiale. Ma non c’è nulla di mistico in banali varietà musicali come X Factor, copiato anche in Italia. Dubbi religiosi riaffiorano in dicembre, quando gli americani, sempre impazienti, abbreviano Christmas, Natale, in XMas. Ma poi si sprofonda nel prosaico esercizio del voto, che utilizzò quel segno affinché anche gli analfabeti potessero manifestare sulle schede le scelte politiche.
Resta in esso sempre il brivido del mistero, dell’incognita, come nelle equazioni o nella fantascienza della serie X-Files. Sa di frutto proibito, nei film porno classificati come XXX o nei commerci erotici, in quei Sex Shop che, se si chiamassero "botteghe del sesso", farebbero ancora più schifo. Diventa il richiamo alla morte e alla ferocia dei pirati, con le ossa incrociate a forma - che altro? - di X sotto il teschio. È uno dei molti simboli satanici, ma anche di tenerezza, nella stenografia da chat o da sms, dove sta per "baci", insieme con O, per "abbracci": XOXO, "ti mando baci e abbracci". Tende a essere estremista nell’abbigliamento, con le taglie XS, XL o addirittura, aiuto!, XXL. Anche l’immagine che guardiamo sul televisore, sul computer o sullo schermo dello smartphone paga un tributo, essendo formata da pixel.
Non ha colpe, né meriti questa lettera prepotente, immigrata senza autorizzazione fra di noi, ma qualche segreta e scaramantica influenza negativa forse sì. Soltanto uno, fra i 45 presidenti degli Stati Uniti in 200 e più anni, ha osato avere una X nel proprio nome, Richard Nixon. Finì infatti, primo e unico dimissionario nella storia, crocefisso alla vergogna delle proprie colpe.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori - a c. di Federico La Sala
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE DELLA "H" -- DOPO DUEMILA ANNI DI "LATINORUM". Francia. Con l’Avvento arriva il «nuovo» Padre Nostro.17 novembre 2017, di Federico La Sala
IL PADRE NOSTRO: BIBBIA, INTERPRETAZIONE, E DUEMILA ANNI DI "LATINORUM" CATTOLICO-ROMANO...
Francia.
Con l’Avvento arriva il «nuovo» Padre Nostro
Nella traduzione approvata dai presuli francesi «non indurci» diventa «non lasciare che entriamo in tentazione»
di Andrea Galli (Avvenire, giovedì 16 novembre 2017)
«Non lasciare che entriamo in tentazione» al posto di «non indurci in tentazione»: è questa la nuova formulazione della sesta richiesta del Padre nostro che i cattolici francesi sono invitati a usare nelle celebrazioni pubbliche a partire dal 3 dicembre prossimo, prima domenica di Avvento, inizio del nuovo anno liturgico. In un incontro con la stampa ieri mattina a Parigi - riporta l’agenzia Sir - il vescovo di Grenoble Guy de Kerimel, che è anche presidente della Commissione episcopale per la liturgia e la pastorale sacramentale, ha spiegato il significato di questa modifica, là dove si chiede a Dio di «essere liberati dalla tentazione che conduce al peccato e a una forma di schiavitù».
La traduzione precedente non era sbagliata dal punto di vista esegetico, ha detto il vescovo, ma rischiava di essere «mal compresa dai fedeli». La modifica sarebbe quindi «un’occasione per i cristiani di riappropriarsi della preghiera che Gesù ha insegnato loro». Per questo i vescovi francesi hanno voluto accompagnare questo passaggio con un volume, «Preghiera del Padre nostro, uno sguardo rinnovato». La nuova formulazione, che è già stata introdotta nella Pentecoste scorsa in alcuni Paesi francofoni come il Belgio e il Benin, sarà utilizzata anche in tutte le celebrazioni ecumeniche, come raccomandato dal Consiglio delle Chiese cristiane in Francia.
Intanto, sempre Oltralpe, continua fra i vescovi la discussione su un tema che ha percorso i lavori della loro assemblea plenaria autunnale si è tenuta a Lourdes dal 3 all’8 novembre. Nell’occasione don Jean-Luc Garin, rettore del Seminario di Lille e responsabile del Consiglio nazionale dei grandi Seminari, ha fornito un quadro aggiornato della situazione vocazionale: in sedici anni, dal 2000 al 2016, i seminaristi in Francia sono passati da 976 a 662: un calo del 30% che non sembra destinato ad arrestarsi, per ora. L’arcivescovo messicano Jorge Carlos Patrón Wong, segretario della Congregazione per il clero, intervenuto nel secondo giorno dei lavori illustrando all’assemblea la «Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis», ovvero le linee guida sulla formazione sacerdotale pubblicate dal dicastero vaticano nel dicembre 2016, ha ricordato che stando al documenti i Seminari, per sussistere o essere aperti, devono avere un numero di vocazioni sufficienti. Un minimo che va «da 17 a 20 persone» ha specificato Wong. Attualmente su 32 Seminari e case di formazione presenti in Francia solo 15 superano la soglia dei 17 seminaristi, per cui dopo l’assemblea plenaria il tema della possibile chiusura di circa la metà degli odierni Seminari è ufficialmente sul tavolo.
Per quanto riguarda i seminaristi diocesani, oggi la metà risiede in soli cinque Seminari: Fréjus-Tolone, Tolosa, Issy-les-Moulineaux, Rennes e Parigi. Un caso non diocesano in forte controtendenza vocazionale - di cui i vescovi hanno discusso, tra coloro che invitano a studiarne l’esempio e altri che manifestano diffidenza - è quello della Comunità di San Martino, associazione di diritto pontificio fondata nel 1976 da monsignor Jean-François Guérin e che ebbe la sua prima approvazione nel 1979 nell’arcidiocesi di Genova, dal cardinale Giuseppe Siri: oggi un seminarista su sei in Francia appartiene a tale comunità.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL MAGISTERO DI MENZOGNA DELLA CHIESA CATTOLICA: IL "PADRE NOSTRO" CHE INDUCE IN TENTAZIONE. Una nota di Henri Tincq - con premessa
DAL "DEUS CARITAS EST" AL "DEUS CHARITAS EST"?
 DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!
DUE PAPI IN PREGHIERA: MA CHI PREGANO?!Federico La Sala
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA -- Quella cosa molto seria che si chiama dono (di Luigino Bruni).16 novembre 2017, di Federico La Sala
Quella cosa molto seria che si chiama dono.
di Luigino Bruni *
Una delle povertà più grandi del nostro tempo è quella delle domande generative. Siamo inondati di risposte a domande che non facciamo, a ricette per soluzioni di problemi che non avvertiamo come tali, e al contempo siamo dentro una carestia impressionante di domande grandi, capaci di farci intravvedere orizzonti nuovi, di attivare la nostra creatività individuale e collettiva, di spingerci all’azione per cambiare il mondo, e non solo per gestire l’ordinario business.
Una delle domande non fatte, ma che attraversa tacita l’intera nostra civiltà ha a che fare con una delle parole più abusate e umiliante della nostra generazione: il dono. Dovremmo sempre più tornare ad interrogarci, in un tempo dominato dal consumo e dalla ricerca del piacere che fine ha fatto il dono nella nostra vita, soprattutto nella sfera pubblica. E’ infatti il dono che crea la comunità (cum-munus, dono reciproco), veniamo al mondo e qualcuno ci accoglie con gratuità e la vita si rigenera non per i contratti ma per i doni.
E allora chiediamoci: che cosa diventa il dono quando lo trasformiamo in filantropia, quando finisce per svolgere il ruolo di tappabuchi dello stesso capitalismo? Possiamo ancora chiamare dono le donazioni che le multinazionali dell’azzardo fanno alle associazioni che si occupano delle loro vittime? Che cosa sta allora diventando il dono? E che cosa il mercato?
Domande impegnative, questioni che negli ultimi decenni sono uscite troppo velocemente dall’orizzonte della nostra società, dai temi trattati sui giornali e nei media, dagli argomenti insegnati nei corsi di economia e business. Il mercato nasce come elaborazione del dono. Millenni fa abbiamo iniziato a scambiare con il linguaggio del dono, il contratto è nato dal patto, le monete avevano come effige gli dei, e il primo contratto che troviamo nella Bibbia è l’acquisto di Abramo della terra per la tomba della moglie Sara (Genesi).
Se giungiamo alla modernità, vediamo che il capitalismo nasce come riflessione sul rapporto fra dono (grazia, charis) e mercato. La Riforma protestante è stata decisiva per la natura del capitalismo moderno. Nata dalla ferita di un mercato che era penetrato nel cuore del dono (il mercato delle indulgenze), l’umanesimo luterano e calvinista si è caratterizzato per una netta separazione tra l’ambito del mercato e quello del dono, tra l’economia for-profit intesa come il regno degli interessi e dei contratti e quella non-profit vista come il luogo della gratuità.
L’umanesimo latino-cattolico, invece, non ha mai smesso di mescolare dono e contratto, grazia e mercato, profitto e gratuità, e l’economia cooperativa, l’impresa famigliare e la cosiddetta Economia civile sono comprensibili solo all’interno di un umanesimo meticcio, con le sue tipiche ferite e benedizioni - come ho cercato di dimostrare nel mio ultimo saggio Il mercato e il dono. Gli spiriti del capitalismo, Egea Bocconi 2015. Il nostro tempo sta conoscendo un appiattimento delle differenze regionali, del genius loci dei diversi capitalismi, sotto l’incedere di una ideologia che ci sta convincendo che il capitalismo «buono» è uno solo, quello costruito attorno agli incentivi, all’individuo e all’efficienza, i tipici valori dell’umanesimo protestante, relegando così il dono e i suoi valori in una sfera sempre più angusta e irrilevante.
Il dono è una cosa molto seria. E’ diventato quasi impossibile parlare bene oggi del dono, perché lo abbiamo messo in un angolo, e ridotto a ben poca cosa, soprattutto nella sfera pubblica, civile, economica. L’attacco al dono è comunque cosa antica. Abbiamo iniziato a relegarlo in ambiti molto angusti quando, anche per responsabilità di una certa teologia cristiana, tra l’Umanesimo e la modernità abbiamo iniziato a pensare che la giustizia fosse veramente essenziale per la costruzione di una buona società, e che, invece, la carità fosse un di più. La giustizia - abbiamo pensato e scritto - chiede di dare a ciascuno il suo, la carità di andare oltre il proprio. La giustizia è necessaria, la carità è facoltativa. La giustizia è essenziale, la carità volontaria, quindi inessenziale. La giustizia è importante, la carità superflua.
Il passo verso l’inutilità della carità è stato immediato, e così abbiamo immaginato una giustizia possibile senza agape, e una vita in comune buona senza amore civile. Abbiamo pensato che la carità/agape/amore potesse essere utile in alcuni ambiti specialistici - famiglia, le chiese, un certo non-profit, nella gestione delle emergenze umanitarie ... - ma che per la vita ordinaria pubblica ci bastasse la giustizia, che è già cosa molto ardua. I contratti e gli interessi sono necessari, il dono no: ci viene sempre più presentato come qualcosa di carino, il limoncello alla fine di una cena, che se c ’è fa piacere, ma se non c ’è in fondo nessuno se n ’accorge (tranne, nel lungo periodo, i produttori di limoncello). Il dono nella nostra società finisce per pesare per il 5 o l’8 per mille, e dobbiamo anche scontare l’evasione fiscale.
Il primo colpo, quasi mortale, al dono lo abbiamo allora dato quando, ormai da un po’ di anni, abbiamo ridotto la carità all’elemosina, alle donazioni, alla filantropia, alle offerte in chiesa, alle pesche di beneficienza o (molto più recentemente) ai due euro degli SMS umanitari. Abbiamo così, e nel giro di qualche decennio, annullato quell’operazione mirabile che fecero i cristiani dei primi secoli, quando scelsero di tradurre agape (l’amore gratuito) con charitas.
La caritas (senza h ) era, nel tardo latino, una parola economica - è antico il rapporto tra dono e mercato. Era usata dai mercanti per indicare il valore delle cose: un bene era caro se valeva e costava molto, come diciamo ancora oggi. Ai cristiani, in cerca di una parola latina per tradurre l’amore-agape, una parola diversa da amor (troppo vicino all’eros greco), trovarono in caritas una buona soluzione. Ma volevano differenziarla, almeno un po’, dalla parola economica del loro tempo. E così vi aggiunsero quella ‘h’, che era tutt’altro che muta, perché voleva dirci una cosa importante: charitas traduce le due grandi parole greche su cui si stava fondando la chistianitas (ancora questo ch): agape e charis, amore e gratuità, grazia. In quella charitas c’era praticamente quasi tutto: le vite donate dai martiri del loro tempo, gran parte dell’insegnamento delle lettere di Paolo, il kerigma dei vangeli; ma c ’era soprattutto un messaggio: la persona umana è capace di charitas, perché è capace di amare oltre l’eros e oltre la già grande philia (amicizia). È capace di oltrepassare il registro della condizionalità, persino oltre quel bisogno radicale di reciprocità che muove il mondo, e anche le stelle.
Questo era il dono: agape, charis, charitas. Questo non è più il dono nella nostra società. Cose, parole, realtà, che hanno generato, come ingredienti coessenziali, Notre Dame de Paris, il Duomo di Milano, gli affreschi di Signorelli a Orvieto e quelli di Michelangelo a Roma, la cappella Baglioni a Spello, le prime scuole per le ragazze povere a Viterbo, Barbiana, tante Costituzioni democratiche, le casse rurali che ci hanno salvato dalla miseria dei campi e generato il miracolo economico, una casa e un cuore per i disperati di Calcutta. E questo continua ad essere ancora in alcune periferie della nostra civiltà il dono: una energia straordinaria che continua a far nascere, per motivazioni più grandi del denaro, molte istituzioni, associazioni, cooperative, imprese. Che continua a farci alzare al mattino per andare a lavorare, per soffrire molto quando perdiamo il lavoro, perché smettendo di lavorare smettiamo non solo di percepire un reddito, ma non possiamo più donare la nostra vita lavorando, e ci fa gioire molto quando il lavoro lo ritroviamo. Tutto questo è il dono, ma non lo vediamo più. Se vogliamo veramente cominciare a sognare e costruire una nuova civiltà, prima di prevedere gli incentivi, gli sgravi fiscali e la crescita del PIL, dobbiamo tornare a vedere quella cosa molto seria che si chiama dono.
* Cfr. [DOC] 151028_BCC_Quella cosa molto seria che si chiama dono.docx
 www.consorziofarsiprossimo.org/il-contenuto-della-chiavetta.../14-bruni?...bruni
www.consorziofarsiprossimo.org/il-contenuto-della-chiavetta.../14-bruni?...bruni* Cfr.INTRODUZIONE a Il mercato e il dono. Gli spiriti del capitalismo
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA -- IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").29 agosto 2017, di Federico La Sala
IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").
"ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS"), DALLA GRAZIA ("gr.: "XAPIS", lat.: "CHARIS") DI DIO AMORE ("CHARITAS"), NON DI DIO MAMMONA ("CARITAS") ...
Lode a Marcello Gaballo per questa bellissima e preziosa nota su "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/#_ftn1) - e il lavoro di De Giorgi: la sua trascrizione della scritta sul cartiglio (ormai scomparsa) "iuste/et cas/te viv/ere et/ xarita(te)" - contrariamente alla protervia che ha portato allo "sproposito maiuscolo" e alla brutta abitudine instauratasi almeno a partire da Ludovico A, Muratori di una "caritas" latina! - conserva ancora la memoria del legame della tradizione dell’evangelo (non: "vangelo"!) con la lingua greca ("charis", "charites"... "charitas").
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. Giambattista Vico ("De constantia iurisprudentis", 1721) giustamente e correttamente e onestamente così pensava e scriveva: "Solo la carità cristiana insegna la prassi del Bene metafisico"("Boni metaphysici praxim una charitas christiana docet"). Sapeva che Gesù ("Christo") aveva cacciato i mercanti FUORI dal tempio, e non aveva autorizzato i sacerdoti a vendere a "caro-prezzo" (lat.: "caritas") la "grazia" (gr.: "Xapis", lat.: "Charis") di Dio (lat.: "Charitas")!!! Due padroni: Dio "Charitas" o dio "Caritas"?!, Dio Amore o dio Mammona?! In questo bivio ("X") ancora siamo, oggi - e ancora non sappiamo sciogliere l’incognita (""x")!
Sul tema, mi sia consentito, si cfr. la seguente nota:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> LA QUESTIONE DELLA "H" --- UNA "GAFFE" PLANETARIA. "The Prodigy": La Casa Bianca toglie la "h" a Theresa May e la fa diventare una star del soft porno27 gennaio 2017, di Federico La Sala
La Casa Bianca toglie la "h" a Theresa May e la fa diventare una star del soft porno *
Nuova gaffe dell’amministrazione Trump in politica estera. Dopo aver confuso il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop per il premier Malcolm Turnbull, l’ufficio stampa della Casa Bianca ha ’dimenticato’ la ’h’ nel nome della premier britannica Theresa May. Risultato: in due documenti l’inquilina di Downing Street è diventata la nota star del soft-porn Teresa May.
L’errore, poi corretto, è stato ripetuto due volte nel comunicato di ieri con il quale la Casa Bianca annunciava l’agenda odierna degli incontri Trump-May e una volta in un comunicato dell’ufficio del vice presidente.
"Nel pomeriggio il presidente parteciperà ad un incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Teresa May", recitava la nota dell’ufficio stampa della Casa Bianca. E qualche riga dopo la ’h’ era di nuovo sparita nel previsto "pranzo di lavoro con Teresa May...".
Ancora una volta, nella nota dell’ufficio di Mike Pence il nome di battesimo di May è diventato quello della star di un video per la canzone Smack My Bitch Up del gruppo The Prodigy.
"È per questo che Donald Trump era eccitato di incontrarla?", commenta ironico il tabloid britannico Mail online riferendosi al previsto colloquio di oggi tra il neo presidente e la premier britannica a Washington. Sempre ieri, ricorda il Mail online, in un altro comunicato la Casa Bianca ha definito il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop il ’primo ministro degli Esteri’ del Paese.
-
> LA QUESTIONE DELLA "H": IL NON CAPIRE UN’ ACCA E LA SCIATTERIA NAZIONALE. --- Una frase di Ludovico Ariosto e "L’Acca in fuga" di Gianni Rodari (di Antonio Caruso).10 settembre 2009, di Antonio Caruso
Acca - a proposito dell’acca su Wikipedia ho trovato qualcosa d’interessante
di Antonio Caruso
" Sono famose le parole di Ludovico Ariosto: «Chi leva la H all’huomo non si conosce huomo, e chi la leva all’honore, non è degno di honore». Nell’Ottocento, Pietro Fanfani (1815-1879) e Giuseppe Rigutini (1829-1903) furono fautori della h, mentre il Petrocchi preferiva le forme accentate (per esempio, ò, à invece di ho, ha). La controversia è proseguita sempre più stancamente fino a tutti gli anni Trenta del Novecento. La rivista di Giuseppe Bottai, Critica fascista, usava il verbo avere senza l’h, che veniva normalmente bandita anche nelle scuole elementari."
Ma c’è anche una bella storiella di Rodari, dovrebbero leggerla anche i preti
L’Acca in fuga
[di Gianni Rodari
C’era una volta un’Acca. Era una povera Acca da poco: valeva un’acca, e lo sapeva. Percio’ non montava in superbia, restava al suo posto e sopportava con pazienza le beffe delle sue compagne. Esse le dicevano:
 E cosi’, saresti anche tu una lettera dell’alfabeto? Con quella faccia?
E cosi’, saresti anche tu una lettera dell’alfabeto? Con quella faccia?
 Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia?
Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia?Lo sapeva, lo sapeva. Ma sapeva anche che all’estero ci sono paesi, e lingue, in cui l’acca ci fa la sua figura.
 "Voglio andare in Germania, - pensava l’Acca, quand’era piu’ triste del solito. - Mi hanno detto che lassu’ le Acca sono importantissime".
"Voglio andare in Germania, - pensava l’Acca, quand’era piu’ triste del solito. - Mi hanno detto che lassu’ le Acca sono importantissime".Un giorno la fecero proprio arrabbiare. E lei, senza dire ne’ uno ne due, mise le sue poche robe in un fagotto e si mise in viaggio con l’autostop.
Apriti cielo! Quel che successe da un momento all’altro, a causa di quella fuga, non si puo’ nemmeno descrivere. Le chiese, rimaste senz’acca, crollarono come sotto i bombardamenti. I chioschi, diventati di colpo troppo leggeri, volarono per aria seminando giornali, birre, aranciate e granatine in ghiaccio un po’ dappertutto.
In compenso, dal cielo caddero giu’ i cherubini: levargli l’acca, era stato come levargli le ali. Le chiavi non aprivano piu’, e chi era rimasto fuori casa dovette rassegnarsi a dormire all’aperto.
Le chitarre perdettero tutte le corde e suonavano meno delle casseruole. Non vi dico il Chianti, senz’acca, che sapore disgustoso. Del resto era impossibile berlo, perche i bicchieri, diventati "biccieri", schiattavano in mille pezzi.
Mio zio stava piantando un chiodo nel muro, quando le Acca sparirono: il "ciodo" si squaglio’ sotto il martello peggio che se fosse stato di burro.
La mattina dopo, dalle Alpi al Mar Jonio, non un solo gallo riusci’ a fare chicchirichi’: facevano ciccirici’, e pareva che starnutissero. Si temette un’epidemia.
Comincio’ una gran caccia all’uomo, anzi scusate, all’Acca. I posti di frontiera furono avvertiti di raddoppiare la vigilanza. L’Acca fu scoperta nelle vicinanze del Brennero, mentre tentava di entrare clandestinamente in Austria, perche non aveva passaporto. Ma dovettero pregarla in ginocchio: - Resti con noi, non ci faccia questo torto! Senza di lei, non riusciremmo a pronunciare bene nemmeno il nome di Dante Alighieri. Guardi, qui c’e’ una petizione degli abitanti di Chiavari, che le offrono una villa al mare. E questa e’ una lettera del capo-stazione di Chiusi-Chianciano, che senza di lei diventerebbe il capo-stazione di Ciusi-Cianciano: sarebbe una degradazione.
L’Acca era di buon cuore, ve l’ho gia’ detto. E’ rimasta, con gran sollievo del verbo chiacchierare e del pronome chicchessia. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti ci piantera’ in asso un’altra volta.
Per me che sono miope, sarebbe gravissimo: con gli "occiali" senz’acca non ci vedo da qui a li’.
 Ciao, Antonio
Ciao, Antonio