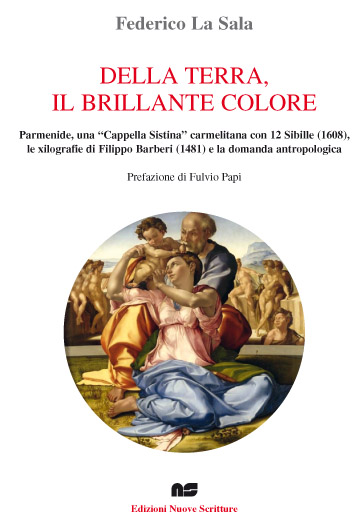
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. - di Federico La Sala
mercoledì 2 luglio 2025.
- [...] Contro ogni illusione di continuità di istituzioni e di divinità, un fatto resta determinante. Siamo giunti a un grado zero di civiltà. La secolarizzazione non è stata uno scherzo: non solo «Dio è morto» ma anche l’Uomo. Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, come una necessità esteriore, e, nel contempo, ha spinto l’individuo a un progressivo isolamento nella società, ha ormai toccato il fondo e ha portato a galla le determinazioni più semplici (Marx) [...]
- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).
- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:
- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).
Per l’ “amore conoscitivo” - In memoria di Kurt H. Wolff
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
Note per un nuovo patto sociale
di Federico La Sala *
- "Per recuperare la salute, il nostro mondo ha bisogno di una duplice cura: la rigenerazione politica include la resurrezione dell’amore. Entrambi, amore e politica, dipendono dalla rinascita della nozione che è stata il cardine della nostra civiltà: la persona. Non penso a un impossibile ritorno alle antiche concezioni dell’anima; ma penso che, pena l’estinzione, dobbiamo ritrovare una visione dell’uomo capace di restituirci la coscienza della singolarità e dell’identità di ciascuno. Visione a un tempo nuova e antica, visione che contempli, in termini attuali, ogni essere umano come una creatura unica, irripetibile e preziosa” (O. Paz, La duplice fiamma. Amore ed erotismo, Milano, Garzanti, 1994, p. 134).
__
Il cielo della preistoria (Marx) getta ancora le sue terribili ombre sul nostro presente e continua a devastare sempre piu la nostra mente e la nostra Terra. Si continua a credere che la civiltà dell’amore - come ha ammesso l’ultimo ‘hegelo-marxista’ nella sua recente circolare del 23.2.1994 - sia possibile, e non un’utopia (1), ma nessuno (non i filosofi, e meno che mai il Papa) osa far pulizia nel cielo delle nostre idee di violenza, di tramonto e di morte (Occide-re-nte). E tutti perseverano nel ritenere cosa sacra e giusta “per diritto naturale che la materia obbedisca alla forma, il corpo all’anima, l’appetito alla ragione, i bruti all’uomo, la moglie al marito, l’imperfetto al perfetto, il peggiore al migliore, per il bene dell’uno e l’altro dei due”(2).
Se è vero che un uomo più una donna ha prodotto per secoli e per millenni un uomo (3), non è un caso che la dinamica del rapporto tra il soggetto, l’umanità, e l’oggetto, la natura, sia stato concepito dialetticamente, e uni-totalitariamente - sia in senso idealistico sia materialistico - come un percorso bellico di superamento delle differenze e trionfo dell’Uomo. E il mondo in cui hanno vissuto e vivono l’uomo e la donna è stato sempre e solo interpretato come il mondo dell’Uomo e del Cittadino: si ricordi che in Italia solo l’altro ieri, 1946, è stato riconosciuto il diritto di voto alle donne.
Cogliere le cose alla radice non è facile. E la radice dell’uomo non è l’uomo stesso. Si ricordi quanto la completa conoscenza scientifica del fenomeno della procreazione sia recente nella scienza occidentale. E si ricordi che «dopo l’antica credenza nella sola responsabilità del maschio, la questione viene riveduta, diventa argomento di polemiche e resta a lungo incerta», e che, «fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società pre-patriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano [...] che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme»(4).
Si tratta di riprendere da capo, a partire dalle radici, l’interrogazione sia su che cosa significa pensare sia, e ancor di più, su che «cosa significa creare rapporti e legami», e su come trasformare i vecchi esistenti rapporti di produzione. Nel momento in cui, accanto all’uomo, la donna «è entrata nel campo e può essere amica o nemica»(5), se vogliamo ridurre e non raddoppiare il numero già infinito delle occasioni di guerre e di distruzione, altre sono le domande e altre sono le risposte di cui abbiamo bisogno:
"Prigionieri di una logica vecchia e con radici profonde secondo la quale v’è sempre chi vince e chi perde, si riuscirà ad uscire da questo gioco che consente, al massimo, di invertire le parti? Che senso ha rifiutare la propria oppressione dell’altro, per rivendicare il diritto ad opprimerlo nello stesso modo e con gli stessi strumenti? Come strappare il potere dalle mani di chi lo detiene, senza esercitare lo stesso potere su chi viene reso impotente? Come superare i tempi delle rivendicazioni, del capovolgimento dei termini che lascia intatta la natura dell’oppressione la qualità del rapporto tra chi tiene il coltello dalla parte del manico e chi si trova con un coltello puntato?
È un problema che non riguarda soltanto il rapporto tra l’uomo e la donna, ma tra l’oppressore e l’oppresso, tra il forte e il debole, tra chi ha il potere e chi non lo possiede: sono quindi domande che coinvolgono l’intera struttura sociale e tutti i valori da essa prodotti, e non possono trovare risposte parziali. Ma nel rapporto tra l’uomo e la donna v’è qualcosa di piu complicato e insieme più semplice: la necessità naturale che reciprocamente li unisce e che la storia ha diviso. La sopraffazione dell’uno sull’altro poggia su questa reciproca necessità, che può essere garanzia di un cambiamento.
Riconoscere lo stesso peso alle esigenze, ai bisogni e ai desideri di entrambi - anche se la donna, tra l’altro, sarà madre se vuole - non dovrebbe essere un’operazione che esige il massacro"(6).
Si tratta di uscire «da interi millenni di labirinto» secondo un’espressione di Nietzsche: e per questo non servono più né l’astuzia della ragione né la volontà di potenza. Non v’è nessuno da uccidere o da aggiogare, e tutti e tutte da liberare - Teseo, Arianna e il Minotauro. Per una nuova terra, abbiamo bisogno di un nuovo cielo, non più platonico e non più cristiano-hegeliano. Ha ragione Ida Magli: L’Osservatore romano «mi contesta perché affermo che non è più tollerabile per la coscienza dell’uomo moderno teorizzare l’ amore di un dio che ha voluto la morte del figlio per salvarci? E perché affermo che non era questo il messaggio di Gesù? Ma è la storia dei duemila anni di Europa cristiana a dimostrare con le sue infinite guerre che si tratta di una religione di morte. Quello che stiamo vivendo in questi giorni lo dimostra meglio che qualsiasi laboratorio. È nel centro delle religioni del sacrificio - ebraismo, islamismo, cristianesimo - che si deve continuare ad uccidere per salvarsi: perché là dove esiste sacrificio deve esistere il sacrificatore [...].. Perché condanno Wojtyla? Perché rappresenta, nel mondo moderno, l’incarnazione del sacerdote-sacrificatore dell’Antico e del Nuovo Testamento, e, come tale, non può non individuare nelle donne le vittime per eccellenza. Strumenti sacrificali, al servizio della procreazione anche là dove vengono stuprate appositamente come in Bosnia, perché procreino figli ai nemici vincitori come sempre è avvenuto in tutte le guerre, da quelle di cui parla Omero fino ad oggi»(7).
Siamo ancora nella preistoria: come in cielo, cosi in terra. Ma nessuno sembra rendersene conto, e disponibile a «interrogarsi anche su ciò che sembra talmente ovvio, da non suscitare il minimo dubbio, anzi, da non apparire alla coscienza neanche come fatto su cui interrogarsi». Ha ragione Ida Magli: «Le donne sono esseri storici, sono persone. Chiedo a Wojtyla di prenderne atto. Soltanto questo».
Il re è nudo, letteralmente. Si tratta di non continuare a chiudere un occhio o, che è lo stesso e peggio, a chiudere gli occhi sull’incarnazione e sulla nascita -«questa origine, sperimentabile come quell’evento che noi siamo»(8) - e «non smettere mai di porsi domande»: sàpere aude!
Benché occasionali e velocissime, le riflessioni qui presentate questo tentano: fare luce sull’ombelico del sogno (Freud) della ragione (Hegel) del re (Platone). Per tutti e per tutte, ciò che è in giuoco è proprio l’aprire gli occhi (nel doppio senso di nascere e conoscere) su quel crocevia di relazioni chiasmatiche da cui emergiamo, che ci costituiscono e strutturano, e che ci legano alla stessa realtà in cui viviamo - in grande e pericolosa ignoranza.
Pur se con molti limiti, Feuerbach l’aveva capito quando affermava che la vera dialettica non è un monologo del pensatore solitario con se stesso, ma un dialogo tra l’io e il tu. «Due esseri umani occorrono per creare l’uomo, sia l’uomo spirituale sia quello fisico: la comunione dell’uomo con l’uomo è il primo principio e il primo criterio della verità e della validità universale»(9). Cosi Saussure: «Per trovare nell’insieme del linguaggio la sfera che corrisponde alla lingua, occorre collocarsi dinanzi all’atto individuale che permette di ricostruire il circuito della parole. Questo atto presuppone almeno due individui, il minimo esigibile perché il circuito sia completo. Siano dunque due persone che discorrono...»(10).
Uomo e donna, prima di tutto. All’origine della nostra stessa vita, come dell’intera società, non vi sono il silenzio e la morte: v’è l’amore. È l’amore che illumina le differenze e svela la comune identità: vere duo in carne una, sia nell’unione dei due (uomo e donna) sia nell’uno (figlio o figlia) prodotto dai due. Ogni uomo e ogni donna nascono da donna, ma ogni individuo (letteralmente, il duo da non dividere) - sia uomo sia donna - è generato dall’uomo e dalla donna: due esseri umani, diversi nella loro fisicità (differenza sessuale) e identici nella loro soggettività (attiva e recettiva insieme). Hic Rhodus, hic saltus! Con Kant, oltre Hegel e Freud.
Né idealismo, né materialismo, non la metafora dello specchio e neppure la dialettica. La logica del X (=Chi, nel senso unificato della lettera dell’alfabeto greco simbolizzante una relazione incrociata o, appunto, chiasmatica e del pronome relativo che rinvia alle persone che si incontrano e discorrono) precede e fonda la logica del che cosa (Socrate), non viceversa: continuare a ignorare chi siamo non porta se non a prolungare la strada di coloro che «non sanno quello che fanno» e a non vedere mai né la luce del Sole, né la Terra, né noi stessi e noi stesse - neonati e neonate, in un cielo puro e in un libero mare.
Il nuovo inizio è possibile. Ma, giammai come ora, esso dipende da noi - uomini e donne della Terra. Si tratta di decidersi, consapevolmente e responsabilmente, per relazioni amorose e non per relazioni furbesche e odiose. Non ci sono altre soluzioni: o distruggere il mondo e noi stessi e noi stesse o «cambiare l’anfiteatro da gladiatori dell’insieme delle nostre relazioni» (M. Serres).
Continuare a intendere la relazione-matrice (uomo e donna all’esterno, maschile e femminile all’interno dell’uno e dell’altra) come relazione di dipendenza «significa voler svuotare della sua realtà uno dei portatori della relazione, e con ciò la relazione stessa» (M. Buber), e scegliere ancora una volta di camminare sulla vecchia strada della guerra e della distruzione.
Contro ogni illusione di continuità di istituzioni e di divinità, un fatto resta determinante. Siamo giunti a un grado zero di civiltà. La secolarizzazione non è stata uno scherzo: non solo «Dio è morto» ma anche l’Uomo. Il lungo processo storico che in Europa e nel mondo, almeno dal XVIII secolo, ha innescato la contrapposizione delle diverse forme del contesto sociale all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, come una necessità esteriore, e, nel contempo, ha spinto l’individuo a un progressivo isolamento nella società, ha ormai toccato il fondo e ha portato a galla le determinazioni più semplici (Marx).
Ciò che è emerso non è l’ideologico individuo isolato, ma l’uomo isolato e la donna isolata, con la loro diversità (differenza sessuale) e la loro identità (bisessualità psichica), e lo stesso nesso che li costituisce e unifica isolato. Ed è con questo che oggi bisogna fare i conti - se vogliamo uscire dall’inferno in cui stiamo sprofondando sempre più, non con qualcos’altro.
Nessuna restaurazione ci può salvare. Quando la potenza unificatrice scompare dalla vita dell’uomo e della donna e gli opposti hanno perduto il loro vivo rapporto e la loro reciproca dipendenza acquistando la loro autonomia, non è della filosofia - come sosteneva Hegel - che si ha bisogno. Caso mai, essa serve solo a completare l’opera.
La sua coscienza infatti, pur se desiderosa di sapere, è cieca come la coscienza di Edipo: non sa nulla del prima e del dopo; e la sua intelligenza è capace solo di consegnare alla vecchia Giustizia e a un destino di negazione e morte tutto ciò che incontra sulla strada del suo presente. Nel proprio lavoro e sul suo terreno, è anche una coscienza eroica, astuta e potente, ma al di là non va e non può andare: è paurosa e miope, come una nòttola o una talpa, e non sa far altro che tornare indietro e rimuovere la complessità delle condizioni del suo stesso essere e del suo stesso agire.
A veder bene, il dialogo socratico come la dialettica hegeliana non sono che potenti e sofisticate macchine da guerra di una coscienza (storicamente datata) volta ad aggiogare e confinare l’altro dentro di sé (il femminile) e fuori di sé (la donna) e la stessa natura, in un cerchio o, meglio, una sfera - senza tempo e senza vita, oltre che senza luce.
Il desiderio-di-sapere di questa coscienza non ha più storia, né in terra né in cielo. Oggi, gli uomini e le donne non solo hanno appreso come nascono i bambini e le bambine sulla Terra, ma, portatisi e portatesi fuori - nell’oceano cosmico, hanno visto la sfera in cui abitano: la nostra Terra è illuminata dal Sole ed è piena di vita e di brillante colore. Al di là della disperazione e del nulla, oltre le colonne di Ercole-Parmenide, hanno trovato e provato - quanto nessuna coscienza nata e cresciuta tra le mura delle varie accademie ha mai neppure lontanamente sognato - il piacere, più profondo ancora della sofferenza (Nietzsche), e "Amore più forte di Morte"(11).
Benché accecati, Marx, Nietzsche e Freud hanno scavato più di tutti - per aprire un varco: non è la coscienza dell ’uomo o della donna che determina il nesso sociale, ma è il nesso sociale che determina la coscienza dell’uno e dell’altra. Non vi sono riusciti ma ora il nesso dialettico è stato spezzato. Lo Stato etico come il partito etico è morto, e la strada a un nuovo patto sociale e a una nuova conoscenza è aperta.
Né egoismo, né altruismo ... né un’altra religione! Si tratta di aprire le porte e le finestre della coscienza alla legge scritta nel nostro stesso corpo e nella nostra stessa mente (non nella testa di qualche filosofo-papa) e di cominciare a mettersi in cammino. La critica non ha strappato i fiori immaginari dalla catena perche l’uomo e la donna continuino a trascinarla triste e spoglia, ma perche la gettino via e colgano il fiore vivo.
Uscire dal caos è possibile, e mettere al mondo una nuova polis non è un’utopia. Ormai né a Johannesburg, né a Gerusalemme, né a Gaza, e nemmeno a Roma, si ignora che la verità nasce da due e non da uno e che amare l’altro come se stesso, o sé come un altro (12), è un dire di sì all’eterno ritorno della vita, non della morte.
_________
* Si riprende qui, con lo stesso titolo, il cap. 6 della Parte III, del mio lavoro: Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, pref. di Fulvio Papi, Roma-Salerno, Edizioni Ripostes, 1996, pp. 141-148.
NOTE:
1. Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie, supplemento al n. 45 di “Avvenire» di mercoledì 23 febbraio 1994, pf. 15
2 . Ginés De Sepulveda, De la justa causa de la guerra contra los Indios. Roma 1550. A riguardo, cfr. E Dussel, La conquista dell’America e il mito della modernità nella disputa di Valladolid (1550), in .”lnvarianti”, n. 22, pp. 53-58, Roma, Antonio Pellicani editore, 1992.
3. Franca Ongaro Basaglia, Donna, in Enciclopedia, 5, Torino, Einaudi, 1978, p. 89.
4. F. D’Eaubonne, Le donne prima del patriarcato, Roma, Felina Editrice, 1981, p. 11.
5. Franca Ongaro Basaglia, op. cit., p. 103.
6. F. Ongaro Basaglia, op. cit., p. 101.
7. Ida Magli, Le donne, vittime del Cristianesimo, in «L’Unità" dell’ 8 marzo 1994.
8. A. Kolleritsch, Dell’Infanzia, Genova, Il Melangolo, 1993, p. 13.
9. L. Feuerbach, Principi della filosofia dell’avvenire, f. 41 e pf. 62, Torino, Einaudi, 1971.
10. F. De Saussure, Corso di Linguistica Generale, cap. III, pf. 2, Bari, Laterza, 1991. Su questo tema, inoltre, si cfr. E. Benveniste, La soggettività nel linguaggio, in: Problemi di Linguistica generale, Milano, Il Saggiatore, 1971, pp. 310-320.
11. Cantico dei Cantici: 8.6, trad. e cura di Giovanni Garbini, Brescia, Paideia, 1992.
12. P. RICOEUR, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993.
___
* IL DIALOGO, Mercoledì, 11 maggio 2005
- QUESTIONE ANTROPOLOGICA (CRISTOLOGICA): "ECCE HOMO". L’UOMO ("Homo") PER L’UOMO ("homini"), L’ESSENZA DEL GENERE ("GATTUNGSWESEN") UMANO, E IL RAPPORTO MASCHIO ("Vir") E FEMMINA ("Mulier"): LUPO ("Lupus") O DIO ("Deus")?!
- ARTE, TECNOLOGIA, E LETTERATURA: UNA RISATA SEPPELLIRA’ QUEL PIGMALIONE (DI "TALETE"). Un "Sillo", una parodia critica della filosofia dell’uomo dell’età delle macchine:
- "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (Giacono Leopardi, "Operette morali", 1827).
- SOLLECITATO DA FUERBACH ("l’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO", 1841), MARX (1844) APRE ALLA QUESTIONE "ANDROLOGICA", MA TROPPO "CIVETTANDO" CON LA DIALETTICA DI HEGEL PERDE LA POSSIBILITA’ DI UN LEGAME CON L’ANTROPOLOGIA CRITICA DELL’ETICA DI SPINOZA E DELLA "LOGICA" DI KANT (1800) E FINISCE PER AUTOLIMITARSI ALLA SOLA "CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA"!
- Karl Marx (1844): "[...] Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie [genere umano].
 Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.
Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale. Così in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.
 In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.
In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo. In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura.
 In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.
In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità.
 La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").
La prima soppressione positiva della proprietà privata, il comunismo rozzo, è dunque soltanto una manifestazione della abiezione della proprietà privata che si vuol porre come comunità positiva[...]" (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 - da "Proprietà privata e comunismo").
- L’AUTOCOSCIENZA DALLA RELAZIONE DIALETTICA AL DIALOGO: "L’autocoscienza attraversa nella sua formazione o movimento questi tre stadi: 1. quello del desiderio [Begierde], in quanto rivolto ad altre cose; 2. quello della relazione signoria-servitù, nella misura in cui l’autocoscienza si rivolge ad un’altra autocoscienza disuguale da sé; 3. quello dell’autocoscienza in generale, che si riconosce in un’altra autocoscienza uguale a sé" (Hegel).
- LIVELLI DI REALTA’: UNA REC. DELL TESTO RELATIVO AL CONVEGNO (UNA VERA E PROPRIA RIUNIONE DEGLI "STATI GENERALI DEL REALISMO FILOSOFICO E SCIENTIFICO" - FIRENZE 1978) E AGLI ATTI (PUBBLICATI DALLA FELTRINELLI, MILANO 1984) (CFR. "ALFABETA", 66, 1984, pp.29-30)
- "UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO"Franca Ongaro Basaglia, Donna, in Enciclopedia, 5, Torino, Einaudi, 1978, p. 89:
- Una stanza tutta per sé [1929] (Virginia Woolf, , Feltrinelli, Milano 2011, p. 151):
 "Cos’altro posso fare per incoraggiarvi a far fronte alla vita? Ragazze, dovrei dirvi - e per favore ascoltatemi, perché comincia la perorazione - che a mio parere siete vergognosamente ignoranti. Non avete mai fatto scoperte di alcuna importanza. Non avete mai fatto tremare un impero, né condotto in battaglia un esercito. Non avete scritto i drammi di Shakespeare, e non avete mai impartito i benefici della civiltà ad una razza barbara.
"Cos’altro posso fare per incoraggiarvi a far fronte alla vita? Ragazze, dovrei dirvi - e per favore ascoltatemi, perché comincia la perorazione - che a mio parere siete vergognosamente ignoranti. Non avete mai fatto scoperte di alcuna importanza. Non avete mai fatto tremare un impero, né condotto in battaglia un esercito. Non avete scritto i drammi di Shakespeare, e non avete mai impartito i benefici della civiltà ad una razza barbara.
 Come vi giustificate? È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo gremite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell’industria, nel commercio, nell’amore: abbiamo avuto altro da fare. Senza la nostra attività nessuno avrebbe solcato questi mari, e queste terre fertili sarebbero state deserto.
Come vi giustificate? È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo gremite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell’industria, nel commercio, nell’amore: abbiamo avuto altro da fare. Senza la nostra attività nessuno avrebbe solcato questi mari, e queste terre fertili sarebbero state deserto.
 Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all’età di sei o sette anni, i milleseicentoventitré milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo; e questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.
Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all’età di sei o sette anni, i milleseicentoventitré milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo; e questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.
 C’è del vero in quel che dite - non lo nego. Ma nello stesso tempo devo ricordarvi che fin dal 1866 esistevano in Inghilterra almeno due colleges femminili; che, a partire dal 1880, una donna sposata poteva, per legge, possedere i propri beni; e nel 1919 - cioè più di nove anni fa - le è stato concesso il voto? Devo anche ricordarvi che da ben dieci anni vi è stato aperto l’accesso a quasi tutte le professioni?
C’è del vero in quel che dite - non lo nego. Ma nello stesso tempo devo ricordarvi che fin dal 1866 esistevano in Inghilterra almeno due colleges femminili; che, a partire dal 1880, una donna sposata poteva, per legge, possedere i propri beni; e nel 1919 - cioè più di nove anni fa - le è stato concesso il voto? Devo anche ricordarvi che da ben dieci anni vi è stato aperto l’accesso a quasi tutte le professioni?
 Se riflettete su questi immensi privilegi e sul lungo tempo in cui sono stati goduti, e sul fatto che in questo momento devono esserci quasi duemila donne in grado di guadagnare più di cinquecento sterline l’anno, in un modo o nell’altro, ammetterete che la scusa di mancanza di opportunità, di preparazione, di incoraggiamento, di agio e di denaro non regge più. Inoltre gli economisti ci dicono che la signora Seton ha avuto troppi figli. Naturalmente dovete continuare a far figli, ma, così dicono, solo due o tre a testa, non dieci o dodici".
Se riflettete su questi immensi privilegi e sul lungo tempo in cui sono stati goduti, e sul fatto che in questo momento devono esserci quasi duemila donne in grado di guadagnare più di cinquecento sterline l’anno, in un modo o nell’altro, ammetterete che la scusa di mancanza di opportunità, di preparazione, di incoraggiamento, di agio e di denaro non regge più. Inoltre gli economisti ci dicono che la signora Seton ha avuto troppi figli. Naturalmente dovete continuare a far figli, ma, così dicono, solo due o tre a testa, non dieci o dodici".
- HANNAH ARENDT E IL "SELBSTDENKEN" DI LESSING: «La verità è che io non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa d’altro o
diversa da quello che sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come dire che ero un uomo e non una donna - cioè qualcosa di insensato. [...] ho
sempre considerato la mia ebraicità come uno di quei fatti indiscutibili della mia vita, che non ho mai desiderato cambiare o ripudiare. [...] Ciò che ti confonde è che
le mie argomentazioni e il mio metodo sono diversi da quelli cui tu sei abituato; in altre parole, il guaio è che sono indipendente.
 Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa
tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).
Con questo intendo dire, da un lato, che non appartengo ad alcuna organizzazione e parlo sempre solo per me stessa; dall’altro, che credo profondamente nel Selbstdenken di Lessing, che né l’ideologia, né l’opinione pubblica, né le ‘convinzioni’ potranno mai sostituire, Qualunque cosa
tu possa obiettare a queste conclusioni, non le capirai se non ti renderai conto che sono davvero mie e di nessun altro» (H. Arendt, Lettera a Gershom Scholem del 24/7/1963).
- LUCE IRIGARAY, In tutto il mondo siamo sempre in due. Chiave per una convivenza universale:
- "[...] «Si tratta di compiere un progresso nel divenire umano, in particolare grazie a una differenziazione più compiuta rispetto all’immediatezza naturale, per la donna ma anche per l’uomo, e anche grazie al #riconoscimento dell’altro come altro e alla pratica di una relazione con lui, o con lei, non sottoposta all’istinto. Senza dominio, dunque, senza possesso [...]».(Baldini Castoldi Dalai, Milano 2006).
Sul tema generale, in rete e nel sito, cfr.:
- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
UNA DOMANDA SUL TEMA DEL "FIGLIO DELL’UOMO" ["Filius hominis","υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου]: "Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque tu dici che il Figlio dell’uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell’uomo?»"(Gv. 12,34).
IL "SEGRETO" DEL "NOME" RIVELATO E CHIARITO: GIUSEPPE dà a suo Figlio, GESÙ (= "Dio" salva), il NOME del Suo "Dio", e Gesù rivela che il Nome di "Dio" è "Amore", al di là dell’Eros e dell’Agape, è - teocritica-mente - Charitas!!!
- IL "VANGELO" SECONDO LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- PAOLO DI TARSO E COSTANTINO:"IN HOC SIGNO VINCES"!: «Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace.
 Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi» (Ef 6, 10-18).
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
- BAMBINE E COMPLESSO DI EDIPO "(...)Come si compie lo sviluppo corrispondente nella bambina? Il nostro materiale diventa qui - incomprensibilmente - molto più oscuro e lacunoso. Anche il sesso femminile sviluppa un complesso edipico, un Super-Io e un’epoca di latenza. Gli si può attribuire anche un’organizzazione fallica e un complesso di evirazione? La risposta è affermativa, ma la situazione non può essere identica a quella del maschio.
 La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
 Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
 STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione
STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione
- La teologia romana dei secoli XIX e XX.
 Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
Costantino tra la Chiesa trionfante e la Chiesa dei poveri(Stanisław Adamiak, Sergio Tanzarella -"Enciclopedia Costantiniana", 2013).
- La formula di Friedrich Heer dell’era costantiniana (1949-1953). Il cristianesimo in mezzo al tempo e all’eternità (Gianmaria Zamagni - "Enciclopedia Costantiniana", 2013).
ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN!!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).
- Trittico di Mérode (1427): L’annunciazione (Adoratrici).
- LA "RICAPITOLAZIONE" DI SAN PAOLO, ANTROPOLOGICAMENTE, ZOPPA E CIECA, A MISURA DEL FIGLIO PRIMOGENITO (MAGGIORASCATO):"[...] tutto il mondo, soggetto alla «vanità» e alla «corruzione» per il peccato di Adamo, attende gemendo la liberazione dal male e «tutta la creazione sarà liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». «Primogenito di tutta la creazione», Cristo, facendosi uomo e immolandosi sulla croce, «riunisce e riassume» tutti gli esseri - terrestri e celesti - e li riconcilia al Padre: si attua cosi il «mistero» della redenzione che Dio ha concepito da tutta l’eternità [...]" (cfr. Tullio Gregory, Giovanni Scoto Eriugena: tre studi,Firenze, Le Monnier, 1963: "II. Mediazione e Incarnazione", pp. 34-35 ).
- CHRISTUS DOMINUS: "PROEMIO. 1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è venuto per salvare il suo popolo dai peccati (1) e per santificare tutti gli uomini; com’egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli (2) e li santificò dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l’edificazione del suo corpo » (Ef 4,12), che è la Chiesa.
- Il papa e i vescovi perpetuano l’opera di Cristo
- 2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese, detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese [...]" (PAOLO VI,"VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO A PERPETUA MEMORIA", "DECRETO SULLA MISSIONE PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA", 28 ottobre 1965 - senza le note).
- MARIA NELLA COMUNITÀ UMANA: «NUOVA EVA»(Domenico Bertetto)
- L’IMMAGINARIO DEL CATTOLICESIMO-ROMANO: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- "ANATOMIA" (GIOVANNI VALVERDE, 1560) E PSICANALISI (2005).Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo. Una risposta-commento di Luigi Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).
- UNA METODOLOGIA PER L’ANALISI QUALITATIVA: RESA E CATTURA DI WOLFF (di ROBERTO CIPRIANI)
DEUS CARITAS EST. IL "LOGO" DEL GRANDE MERCANTE...
- USA (1630) - Come fare le cose con i testi: A Modell of Christian Charity di John Winthrop (Carla Vergaro - "L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA", 2017.)
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO...
Federico La Sala
|
LE 21 DONNE DELLA COSTITUENTE |
Forum
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL "SOGNO" D’AMORE DELLA "VITA NUOVA" E IL "GRAN COMMENTO" AL MESSAGGIO EVANGELICO. Note a margine di "Dante il sogno" (di Fjodor Montemurro).29 giugno 2025, di Federico La Sala
DANTE ALIGHIERI E IL "GRAN COMMENTO" AL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota a margine di una lezione di Fjodor Montemurro su "Dante e il sogno: poesia in forma di visione" *
Dante e il sogno: poesia in forma di visione
di Fjodor Montemurro
 (Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera) *
(Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera) *Sognare è un’attività prevalentemente umana, ma che permette all’uomo di trascendere in una dimensione che supera i confini della vita quotidiana. Il sogno si manifesta attraverso visioni oniriche, si carica di simboli e si pone ad un livello medio tra il reale e il divino: ad ogni modo, sognando si ha la sensazione di vivere in una dimensione diversa. Tuttavia, ogni sogno non potrebbe esistere senza la realtà, perché solo se esiste il reale allora può esserci l’immaginazione, la fantasia, lo spirito. Dante ne è pienamente consapevole, e non è un caso che la cantica dove il poeta sogna più spesso (all’interno del suo immaginifico e visionario viaggio nell’Oltretomba, anch’esso un grande sogno mistico e letterario) sia proprio il Purgatorio, il regno dell’umano, dove il giorno si alterna alla notte, dove non vige né il buio eterno dell’Inferno né la luce perpetua delle anime sfolgoranti del Paradiso.
Conforme al gusto medievale della numerologia, Dante colloca nel secondo regno tre diversi sogni, ciascuno dei quali occupa la mente del poeta viator quando egli si addormenta al calar della luce: il primo nel canto IX, il secondo nel canto XVIII (lo descrive nel XIX) e il terzo nel canto XXVII. Non si tratta solo di un parallelismo narrativo ben calibrato, poiché i sogni sono situati nei canti che contengono il numero 9 e i suoi multipli, e come sappiamo il 9 è il quadrato della Trinità. Si tratta infatti di visioni che descrivono situazioni fortemente connotate di valori simbolici, recanti profondi significati morali, spesso con la presenza di figure religiose o allegoriche, tutti accomunati dall’apparire di una immagine che idealmente si collega ad elementi divini o celesti. Il sogno dantesco è lontano dai sogni freudiani poiché non esprime desideri repressi o disagi interiori, ma al contrario è prefigurazione di un cambiamento che il pellegrino può cogliere con la ragione se opportunamente guidato nella comprensione dalla sua guida Virgilio.
Il primo dei tre sogni è narrato dal poeta all’inizio del canto IX, e accompagna il trapasso dalla Valletta dei Principi Negligenti, ultima sezione dell’Antipurgatorio dove Dante sta passeggiando scortato da Virgilio e Sordello, all’ingresso del Purgatorio vero e proprio. Mentre è ormai l’alba, evocata dalla preziosa immagine di Aurora, compagna del vecchio Titone, che “già s’imbiancava al balco d’Oriente” (IX, 3), Dante ci fa capire che sta sognando attraverso la formula “in sogno mi parea” (Purg. IX 19 e XXVII 97). L’ora in cui gli si presenta il sogno sembra assicurare al pellegrino che si tratta di una visione attendibile e molto realistica: è noto infatti che i sogni elaborati dalla nostra mente nella parte finale della notte, ossia all’alba, fossero creduti sin dall’antichità molto veritieri e degni di maggior rispondenza con il mondo reale.
Dante confessa di aver visto apparire un’aquila che piombava su di lui per rapirlo e trasportarlo sul monte Ida presso l’antica città di Troia (da non confondere con il monte Ida dell’isola di Creta), luogo da cui prese le mosse la progenie degli antichi Romani. Precisa poi di sentire un forte calore, tanto che è costretto a ridestarsi immediatamente. Virgilio poco dopo (vv. 55-60) gli chiarisce che in realtà, durante il suo sonno, è sopraggiunta Santa Lucia che lo ha afferrato per condurlo in volo in un punto dove la montagna rocciosa ha una fessura, ossia proprio all’ingresso del Purgatorio (Purg. IX, 13-33):
Ne l’ora che comincia i tristi lai
la rondinella presso a la mattina,
forse a memoria de’ suo’ primi guai,
e che la mente nostra, peregrina
più da la carne e men da’ pensier presa,
a le sue visïon quasi è divina,
in sogno mi parea veder sospesa
un’aguglia nel ciel con penne d’oro,
con l’ali aperte e a calare intesa;
ed esser mi parea là dove fuoro
abbandonati i suoi da Ganimede,
quando fu ratto al sommo consistoro.
Fra me pensava: ‘Forse questa fiede
pur qui per uso, e forse d’altro loco
disdegna di portarne suso in piede’.
Poi mi parea che, poi rotata un poco,
terribil come folgor discendesse,
e me rapisse suso infino al foco.
Ivi parea che ella e io ardesse;
e sì lo ’ncendio imaginato cosse,
che convenne che ’l sonno si rompesse.
È evidente che il sogno unisce in maniera mirabile sensazioni irreali, ma fortemente simboliche (il volo, che rappresenta l’innalzamento verso una dimensione altra del suo viaggio; l’aquila, che è interpretabile come una allusione politica all’istituto imperiale, elemento imprescindibile nella concezione universalistica e anti-regionale di Dante), a sensazioni vere che vengono rielaborate nella visione onirica (il prendere fuoco della sua pelle e dell’aquila che lo trasporta, evidente trasfigurazione del calore del sole che già era alto nel Purgatorio al suo risveglio: “e ‘l sole er’alto già più che due ore”, IX, 44). Non c’è alcuna frammentazione irrazionale, nessuna scomposizione da rielaborare per ricomporre un quadro coerente, tutto avviene in una successione temporale chiara e univoca. Il sogno dantesco non è ineffabile e indecifrabile, come siamo abituati a concepirli noi contemporanei persuasi dall’impostazione freudiana.
Alla fine del canto XVIII Dante si addormenta nuovamente. Siamo giunti al secondo momento topico della sua salita, ossia l’ingresso nella quinta cornice che segna l’inizio dell’alto Purgatorio; Dante sogna una donna di aspetto deforme la cui bruttezza simboleggia i vizi morali e i peccati in cui la nostra anima inciampa: essa è infatti balbuziente (“femmina balba”, Purg. XIX 7), con evidente richiamo ai vizi della gola, ha gli occhi strabici (“ne li occhi guercia”, Purg. XIX 8), segno di lussuria, e le braccia e le gambe storte (“e sovra i piè distorta, / con le man monche” XIX 8-9), a ricordare l’avarizia. È definita femmina con evidente disprezzo per alludere alla sua ferinità, proprio perché riassume in sé quanto vi è di moralmente indegno e repellente. Nonostante il suo aspetto ripugnante, la donna sembra affascinare il pellegrino, che rimane inebetito e non riesce a distogliere da lei lo sguardo: coerente alla tradizione classica e biblica, che rappresentava il male travestito da seduzione e ingannevole falsificazione, Dante si sente un novello Ulisse ammaliato da una sirena, che con accenti suadenti e sottilmente erotici
«Io son», cantava, «io son dolce serena,
che’ marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena! (21)
Io volsi Ulisse del suo cammin vago
al canto mio; e qual meco s’ausa,
rado sen parte; sì tutto l’appago!».
A salvare il pellegrino interviene, sempre nel sogno, un’altra donna, simbolo della Ragione, o della Grazia, o della Temperanza: ella intima a Virgilio di afferrare la femmina per squarciarne le vesti e palesarne la vera sembianza, e il fetore emesso dal suo ventre provoca l’improvviso risveglio del poeta.
Il sogno ha turbato Dante, il quale procede meditabondo interrogandosi sul significato della visione (vv. 55-57); per rassicurarlo, Virgilio gli fornisce la corretta interpretazione di quanto ha sognato, spiegandogli che la femmina balba rappresenta i peccati che vengono espiati nelle ultime tre cornici del Purgatorio, per combattere i quali l’uomo deve operare con sollecitudine e solerzia respingendo le seduzioni dei beni materiali.
Il terzo sogno del Purgatorio si svolge in una atmosfera pastorale, ma che solo apparentemente ha sapore bucolico perché è tutta intrisa di quella solennità che caratterizza i momenti di contemplazione mistica; Dante, alle soglie del Paradiso Terrestre che è in cima al monte del Purgatorio, si addormenta insieme a Virgilio e Stazio: è calata la notte e il loro viaggio non può proseguire. Dante osserva le stelle, e mentre le guarda, gli sopraggiunge il sonno e sogna nuovamente (Purg. XXVII, 94-108):
Sì ruminando e sì mirando in quelle,
mi prese il sonno; il sonno che sovente,
anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle.
Ne l’ora, credo, che de l’oriente,
prima raggiò nel monte Citerea,
che di foco d’amor par sempre ardente, (96)
giovane e bella in sogno mi parea
donna vedere andar per una landa
cogliendo fiori; e cantando dicea: (99)
«Sappia qualunque il mio nome dimanda
ch’i’ mi son Lia, e vo movendo intorno
le belle mani a farmi una ghirlanda. (102)
Per piacermi a lo specchio, qui m’addorno;
ma mia suora Rachel mai non si smaga
dal suo miraglio, e siede tutto giorno. (105)
Ell’è d’i suoi belli occhi veder vaga
com’io de l’addornarmi con le mani;
lei lo vedere, e me l’ovrare appaga». (108)
La donna che appare a Dante è molto diversa da quella del canto XIX: è una donna virtuosa, Lia, la seconda moglie di Giacobbe, che rappresenta la vita attiva, come è testimoniato dalla sua attività manuale, dedita all’intreccio di ghirlande, e del compiacimento nel sapere di operare bene, come è provato dall’immagine dello specchio.
A differenza di Lia, la sorella Rachele è simbolo della vita contemplativa, dato che si specchia tutto il giorno e mai si allontana “dal suo miraglio” (105). Dante ribadisce che il sonno prefigura qualcosa che sta per accadere, e infatti Lia e Rachele da un lato richiamano le figure di Virgilio e Stazio, rispettivamente incarnanti lo spirito cristiano attivo e la visione contemplativa della potenza divina, dall’altro preannunciano l’apparizione di Matelda nel canto XXVIII, collocata in una natura statica e accogliente, intenta a intrecciare fiori come Lia nel sogno.
I sogni della Divina Commedia richiedono una identificazione trasfigurale tra le persone e le cose che appaiono nella visione e ciò che esse rappresentano; nella Vita Nova, invece, Dante fa un sogno diverso, che si connota come premonizione della morte della donna amata. Nel capitolo III, dopo la seconda apparizione della “gentilissima”, Dante confessa di aver sognato che Amore faceva mangiare a Beatrice il cuore del poeta; la visione lo sconvolge a tal punto che decide di comporre il sonetto “A ciascun’alma presa e gentil core” per renderla nota a “tutti li fedeli d’Amore, e pregandoli che giudicassero” quanto vi riferiva.
 Facendo propria la lezione di Macrobio, che nel Commentario al ciceroniano Somnium Scipionis, appuntava che ogni sogno copre con figurazioni e vela di difficoltà i significati che necessitano di uno sforzo ermeneutico per essere correttamente decifrati (“somnium proprie vocatur quod tegit figuris et velat ambagibus non nisi interpretatione intellegendam significationem rei quae demonstratur”), Dante presenta il suo sogno come una profezia il cui senso è ormai chiaro a tutti, poiché, quando compone la Vita Nova, Beatrice è ormai morta per davvero: “lo verace giudicio del detto sogno non fue veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo a li più semplici”.
Facendo propria la lezione di Macrobio, che nel Commentario al ciceroniano Somnium Scipionis, appuntava che ogni sogno copre con figurazioni e vela di difficoltà i significati che necessitano di uno sforzo ermeneutico per essere correttamente decifrati (“somnium proprie vocatur quod tegit figuris et velat ambagibus non nisi interpretatione intellegendam significationem rei quae demonstratur”), Dante presenta il suo sogno come una profezia il cui senso è ormai chiaro a tutti, poiché, quando compone la Vita Nova, Beatrice è ormai morta per davvero: “lo verace giudicio del detto sogno non fue veduto allora per alcuno, ma ora è manifestissimo a li più semplici”.Dante, pertanto, ci testimonia come il sogno sia interpretabile come un momento figurale: diversamente dalla psicologia moderna, quello che si sogna non è tanto un rimescolamento della coscienza, un coacervo informe di frammenti di realtà, ma è un momento di annuncio di qualcosa che sta per avvenire e che all’inizio trascende i limitati orizzonti della nostra umana comprensione. Il sogno ha una sua logica interna per Dante, vicino in questo alla sensibilità moderna che mette in campo ogni sforzo per cogliere nella realtà una manifestazione concreta e tangibile di quanto abbiamo sognato. Per questo noi proviamo a tradurre segni e simboli dei sogni: giochiamo numeri, interpretiamo situazioni e fatti irrazionali cercando di calarli nel vissuto quotidiano o rispolverando eventi lontani nel tempo, ricerchiamo corrispondenze pragmatiche alle immagini inspiegabili o evanescenti che occupano la nostra mente durante il cosiddetto lavoro onirico.
 Dante, tuttavia, ci esorta a ripensare il sogno come un momento di elevazione spirituale, una fase della nostra coscienza che si distacca dalla realtà e che ci mette in comunicazione con una dimensione spirituale, non necessariamente mistica, che ci parla in maniera diretta, cifrata ma sincera, per scandire i momenti in cui dobbiamo assurgere ad un modo di vivere e di essere più alto e meditato, nella consapevolezza che il sogno “anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle” (Purg. XXVII, 93).
Dante, tuttavia, ci esorta a ripensare il sogno come un momento di elevazione spirituale, una fase della nostra coscienza che si distacca dalla realtà e che ci mette in comunicazione con una dimensione spirituale, non necessariamente mistica, che ci parla in maniera diretta, cifrata ma sincera, per scandire i momenti in cui dobbiamo assurgere ad un modo di vivere e di essere più alto e meditato, nella consapevolezza che il sogno “anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle” (Purg. XXVII, 93).*
Fjodor Montemurro
 (Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera)
(Professore e Presidente della Società “Dante Alighieri” di Matera)FONTE: I QUADERNI DELLA SCALETTA
* DANTE ALIGHIERI E IL "GRAN COMMENTO" AL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota a margine di una analisi e di una riflessione di Fjodor Montemurro su "Dante e il sogno: poesia in forma di visione":
SE NELL’ENIGMATICO SOGNO DELLA "VITA NUOVA", DANTE NARRA IL "MISTERO" DELLA FECONDAZIONE ("INCARNAZIONE") DELLA "BELLA" MADRE ("MARIA" BEATRICE); NELLA "DIVINA COMMEDIA", E, IN PARTICOLARE, NEL "PURGATORIO" (NEI CANTI IX, XVIII, E XXVII), CON ALTRI TRE SOGNI, SEGNATI RISPETTIVAMENTE DALLA PRESENZA DELLA FIGURA DI "LUCIA", DI "MARIA" BEATRICE, E DI "LIA", EGLI CHIARISCE MEGLIO IL SENSO DEL "SUO" PRIMO SOGNO (QUELLO DELLA "VITA NUOVA"), E, AL CONTEMPO, E, DELL’ ESSERE UN "ALTRO CRISTO", E, ANCORA, DEL SUO STRAORDINARIO ITINERARIO DI VITA E DI PENSATORE (CON LA "COMMEDIA" E LA "MONARCHIA"), E, INFINE, DELLA SUA STESSA INTERPRETAZIONE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, RIPROPOSTO DA GIOACCHINO DA FIORE E DA FRANCESCO DI ASSISI (COME HA BEN CAPITO ERNESTO BUONAIUTI CON IL SUO LAVORO "La prima Rinascita: il profeta, Gioacchino da Fiore, il missionario, Francesco di Assisi, il cantore, Dante Alighieri", 1952).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).8 giugno 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, LETTERATURA, E FILOLOGIA.
UNA "CANZONE" SULLA NASCITA DI UN BAMBINO, CHE NON SI SA COME "CANTARE" CON AMORE ("CHARITAS").
STORIA E METASTORIA: AL TEMPO DI DANTE (E DI "AMLETO"), «L’«ENTRÉE D’ESPAGNE», UNA "CHANSON DE ROLAND ", CON AL CENTRO UN "DUELLO" TEOLOGICO-POLITICO CON FERAGU (CHE "CONTINUA" ANCORA).
- "Questo poema è l’opera di gran lunga più importante dell’epica trecentesca d’Italia in lingua francese.. Vigore creativo e spessore culturale ne fanno un monumento letterario autentico, e molto resta ancora da portare alla luce" (A. Limentani).
"[...] Disse Feragu [a Rolando]: «Se mi dimostrate / in modo chiaro come fece Dio / a far nascere suo figlio in una donna/ con carne umana - e ne spiegate il motivo -, / e come sua madre si mantenen vergine / sia prima, sia dopo averlo partorito, / oggi mi battezzerò al sacro fonte» (Anonimo Padovano, "L’Entrée d’Espagne", Interlinea edizioni, Novara 2021, pp. 138-139).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "CONTRO IL METODO" (PAUL K. FEYERABEND): UNA #RISATA "ALL’ INFINITO" CON GIACOMO LEOPARDI CONTRO LA FILOSOFIA DELLA "ETA’ DELLE MACCHINE".6 giugno 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, PSICOANALISI, ED EPISTEMOLOGIA: "SÀPERE AUDE!" " (KANT, 1784 - MICHEL FOUCAULT, 1984) E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI (S. FREUD, 1937).
- "CONTRO IL METODO" ("ANARCHISMO METODOLOGICO"). Una nota in #memoria di Paul Feyrabend (1924-1994) a svegliarsi dal #sonno dogmatico, e, un omaggio alla sollecitazione a riflettere (di Ipse dixit):
- "La scienza è molto più vicina al mito di quanto una filosofia scientifica sia disposta ad ammettere. Essa è una fra le molte forme di pensiero che sono state sviluppate dall’uomo, e non necessariamente la migliore. (...)
 La scienza è solo uno dei molti strumenti inventati dall’uomo per far fronte al suo ambiente. Essa non è l’unico, non è infallibile ed è diventata troppo potente, troppo aggressiva e troppo pericolosa perché le si possa lasciare la briglia sciolta. (...)
La scienza è solo uno dei molti strumenti inventati dall’uomo per far fronte al suo ambiente. Essa non è l’unico, non è infallibile ed è diventata troppo potente, troppo aggressiva e troppo pericolosa perché le si possa lasciare la briglia sciolta. (...)
 La scienza del tardo secolo XX ha rinunciato a tutte le sue pretese filosofiche ed è diventata un’attività economicamente importante, che plasma la mentalità di coloro che la praticano. (...)
La scienza del tardo secolo XX ha rinunciato a tutte le sue pretese filosofiche ed è diventata un’attività economicamente importante, che plasma la mentalità di coloro che la praticano. (...)
 La separazione di scienza e non scienza è non soltanto artificiale ma anche dannosa per il progresso della conoscenza. Se desideriamo comprendere la natura, se vogliamo padroneggiare il nostro ambiente fisico, dobbiamo usare tutte le idee, tutti i metodi e non soltanto una piccola scelta di essi.
La separazione di scienza e non scienza è non soltanto artificiale ma anche dannosa per il progresso della conoscenza. Se desideriamo comprendere la natura, se vogliamo padroneggiare il nostro ambiente fisico, dobbiamo usare tutte le idee, tutti i metodi e non soltanto una piccola scelta di essi.
 L’affermazione che non c’è conoscenza fuori della scienza − extra scientiam nulla salus − non è altro che un’altra favola, molto conveniente. (...)
L’affermazione che non c’è conoscenza fuori della scienza − extra scientiam nulla salus − non è altro che un’altra favola, molto conveniente. (...)
 Una scienza che pretende di possedere l’unico metodo corretto e gli unici risultati accettabili è ideologia." (Paul K. Feyerabend, Contro il metodo, 1975).
Una scienza che pretende di possedere l’unico metodo corretto e gli unici risultati accettabili è ideologia." (Paul K. Feyerabend, Contro il metodo, 1975).
MITO ("#SONNO"), #SCIENZA ("#VEGLIA"), #ARCHEOLOGIA, E #CRITICA DELLA #RAGIONE "PURA, MOLTO PURA"! Come si può dedurre, da quanto detto nella citazione (v. allegato), si tratta #nascere alla propria #libertà, far buon uso della propria "#capacità di #giudizio", e indagare criticamente (kantianamente) "il ruolo del sogno nella storiografia filosofica" (cfr. #Vicente #Serrano, "Il mito dell’inconscio e il trauma moderno", in "L’inconscio. Rivista Italiana di Filosofia e Psicoanalisi", N. 8 - Sogno e Trauma come materiale storiografico", Dicembre 2019, p. 228, Università della Calabria), e, non lasciarsi #ipnotizzare dai "#sogni" dei metafisici "#pastori"dell’#essere, sia dal lato della #metafisica #idealistica sia dal lato della metafisica #materialisica (da #Platone, #Cartesio, #Fichte, #Schelling, #Hegel, a #Heidegger, e a #Lacan)!
- NOTA:
- ARCHEOLOGIA DELLA #TRAGEDIA E #COSMOTEANDRIA #DIVINA E #UMANA: UNA #RISATA "ALL’ #INFINITO" CON #GIACOMO LEOPARDI CONTRO LA #PIRAMIDE DEL "SAPIENTE" (#BOVILLUS, 1510). Un "Sillo", una #parodia #critica dell’#età delle #macchine: "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi" (cfr. G. Leopardi, "Operette morali", 1827).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- UNA HAMLETICA QUESTIONE EPOCALE DI RICONOSCIMENTO, DI DUPLICE RICONOSCIMENTO ("ANERKENNUNG").5 giugno 2025, di Federico La Sala
FILOLOGIA CRITICA E #STORIAELETTERATURA: UNA HAMLETICA QUESTIONE EPOCALE DI #RICONOSCIMENTO ("ANERKENNUNG"), UN #AMORE ("CHARITAS") "AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE" (#NIETZSCHE), E UN SEGNAVIA PER UN’ALTRA LETTURA DELLA #DIVINACOMMEDIA....
- «CONFESSO: "SONO UN PECCATORE"». Una nota in omaggio alla "testimonianza" di Emiliano Antonino Morrone.
ALLA LUCE della brillante riflessione e della finale citazione di una frase di #Giovanni Paolo II dall’Enciclica “#Veritatis Splendor” (“La correzione fraterna è un atto di carità, e non può essere separata dalla verità oggettiva del bene morale: ammonire il peccatore è un’opera di misericordia spirituale”), chiarissimo #Emiliano Antonino #Morrone, approfondendo il senso e la portata della sollecitazione sul tema (e, mi sia consentito , in memoria del prof. #GianniVattimo), a mio parere, c’è da mettersi nei panni di #DanteAlighieri e dello stesso #Gesù di #Nazaret e, andando oltre la "#correzionefraterna", riattivare la #memoria e, ringraziando, ri-accogliere la amorosa #correzione materna e paterna (dei #duesoli, dei #due #genitori):
- "[...] Com’io voleva dicer ‘Tu m’appaghe’, /vidimi giunto in su l’altro girone, /sì che tacer mi fer le luci vaghe. // Ivi mi parve in una visione / estatica di sùbito esser tratto, /e vedere in un tempio più persone; // e una donna, in su l’entrar, con atto / dolce di madre dicer: «Figliuol mio / perché hai tu così verso noi fatto? // Ecco, dolenti, lo tuo padre e io /ticercavamo». E come qui si tacque, / ciò che pareva prima, dispario. [...]" (Purg. XV, 83-93).
A questo #punto (seguendo la #linea e tutta la #superficie del problema), è finalmente possibile seguire anche la #buonavolontà di Karol J. #Wojtyla e di Jorge Mario #Bergoglio e, con la collaborazione di #Sigmund #Freud, progettare (nel senso di "#concepire" da parte degli uomini e delle donne della intera umana famiglia) non solo un "ospedale da campo", ma anche una "#raffineria" per uscire dall’ inferno dell’attuale presente storico del #PianetaTerra. E, ovviamente, rileggere la Commedia, la "divina commedia": è "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145), non il caso e la necessità.
- NOTA:
- MEMORIA, #STORIA, E #ANTROPOLOGIA DEL DUPLICE RICONOSCIMENTO: "#MARIA E #GIUSEPPE". MI AUGURO CHE, QUANTO PRIMA IN OMAGGIO E ALLA #LUCE ANCHE DEGLI ULTIMI SFORZI DI #PAPA FRANCESCO E DI QUELLI GIA’ AVVIATI DA #PAPA #LEONEXIV, SULLA BASE DEL #SEGNAVIA DELLA "#MADONNADELBUONCONSIGLIO" ( E DELLE ANTICHE SOLLECITAZIONI DELLE #SIBILLE E DEI #PROFETI), SI GIUNGA FINALMENTE ALLA RICOMPOSIZIONE DEL #PRESEPE, COME DA #INDICAZIONE DI #FRANCESCO DI ASSISI (#GRECCIO, 1223), E, AL #RICONOSCIMENTO DI "GIUSEPPE, #PADRE DEL "#BUONCONSIGLIO" , "RE DI CONTURSI".
 MOLTISSIMI AUGURI: BUONA DOMENICA DELL’#ASCENSIONE DI GESU’ E BUON #2GIUGNO, #FESTADELLAREPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL #LAVORO (#MEMORIA DI #SANGIUSEPPE, #PRIMO #MAGGIO). ONORE A #CONTURSITERME E #VIVA L’#ITALIA!
MOLTISSIMI AUGURI: BUONA DOMENICA DELL’#ASCENSIONE DI GESU’ E BUON #2GIUGNO, #FESTADELLAREPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL #LAVORO (#MEMORIA DI #SANGIUSEPPE, #PRIMO #MAGGIO). ONORE A #CONTURSITERME E #VIVA L’#ITALIA!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- STORIOGRAFIA D’EUROPA: NOTE SUL "VICISTI, GALILAEE" (KEPLERO A #GALILEO, 1611), SU #NICEA (325-2025), E SULLA "COSTITUZIONE" DEL VATICANO ii.26 maggio 2025, di Federico La Sala
STORIA E #STORIOGRAFIA D’#EUROPA: "VICISTI, GALILAEE" (PAROLE DI OMAGGIO DI #KEPLERO A #GALILEO GALILEI, 1611) E L’ANNIVERSARIO COSTANTINIANO DEL #PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325-2025).
UNA "RIPRESA" DI UNA "RIFLESSIONE" (2012) A MARGINE DI UNA INTERVISTA SUL "#FATO" E SUL "FATTO" DEL #CONCILIO VATICANO II: IL #MESSAGGIO EVANGELICO E LA #COSTITUZIONE "SACROSANTUM CONCILIUM" NON HANNO NULLA A CHE FARE CON IL "MAGISTERO" della gerarchia cattolico-costantiniana di "#Gesù" come "#Dominus #Iesus" e di Dio come "#ricchezza" (Benedetto XVI, Deus #caritas est, 2006)!
"Bisogna intendersi sul termine sacro: anche l’adorazione del vitello d’oro era sacra!" (Iginio Rogger): Riscoprire l’essenza della Chiesa, intervista a mons. #Iginio #Rogger, a c. di Maria Teresa Pontara Pederiva (“Vita Trentina”, 8 gennaio 2012).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ANTROPOLOGIA FILOLOGIA E TEOLOGIA: AL DI LA’ DEL PLATONISMO, UNA "QUARTA NAVIGAZIONE" CON IL "GALILEO".25 maggio 2025, di Federico La Sala
CULTURA E DISAGIO DELLA CIVILTÀ E NELLA SOCIETÀ:
FISICA (COSMOLOGIA), METAFISICA (PLATONISMO), E "QUARTA NAVIGAZIONE" ("DIVINA COMMEDIA") CON IL "GALILEO".
- Alcuni appunti per cercare di non fare #naufragio...
Riprendendo il "discorso" sulle "Tre navigazioni" della tradizione filosofico-scientifica occidentale (si cfr. la breve scheda del prof. Ivano Dionigi, [sull’ Avvenire del 7 marzo 2020), forse, è possibile avanzare qualche ipotesi di #ricerca e di riflessione antropologica su una ignorata "quarta navigazione", che ha visto impegnati molti grandi protagonisti della travagliata storia mediterranea, ed, eventualmente, contribuire ad aprire qualche varco che possa portare fuori da una visione sempre più buia della della vita sul #PianetaTerra...
- TRE NAVIGAZIONI. La traversata del mare della vita, così insegna la riflessione classica, può essere compiuta con due diversi tipi di navigazione: la scienza e la filosofia. La “prima navigazione” è quella in cui gli uomini in mare si affidano alla forza naturale dei venti.
 Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.
Ma per Platone (Fedone 99 d) a questa navigazione, precaria e occasionale, occorre sostituire la “seconda navigazione” (déuteros ploûs), affidata alla certezza dei remi, che ti soccorrono laddove non spira più il vento: agli occhi del corpo, propri dell’indagine fisica, Platone sostituisce gli occhi dell’anima, che colgono la realtà meta-fisica: è la filosofia che medita sulla vita e sulla morte e nutre la "grande speranza" (megále elpís 114 c-d) della sopravvivenza.
 Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).
Tuttavia Platone è consapevole che per poter fare il viaggio con maggior sicurezza e su una nave più solida, occorrerebbe affidarsi a un discorso divino (85 d theîos lógos). Ma per salire su quella nave più solida e attingere a questo discorso divino, che Platone ipotizza ma non certifica, bisognerà attendere la rivelazione cristiana, dove, in una sorta di “terza navigazione” (G. Reale) - la navigazione della fede -, soccorre quel «legno della croce di Cristo che ci consente di attraversare il mare di questo secolo» (Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni II 2)." (I. Dionigi).
A PARTIRE DA SE’, #HAMLETICA-MENTE ("ESSERE, O NON ESSERE"): IL "#GALILEO" (#MESSAGGIOEVANGELICO), LA "DIVINA COMMEDIA" (#DANTEALIGHIERI), E IL "DIALOGO DOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO TOLEMAICO E COPERNICANO" (#GALILEOGALILEI).
SULLA VIA DELLO "SPIRITO PROFETICO" DI GIOACCHINO DA FIORE E, A PARTIRE DALLA "LEZIONE" IN PRIMA PERSONA DI FRANCESCO DI ASSISI, DANTE ALIGHIERI, CON L’AIUTO DI (MARIA, LUCIA, E) "#BEATRICE" E "#VIR_GILIO", REALIZZA IL SUO "VIAGGIO" TERRESTRE E CELESTE, BEN OLTRE LA "#SECONDANAVIGAZIONE" DI PLATONE, E LA "#TERZANAVIGAZIONE" (CON LA #CROCE, IL "LEGNO", LA "NAVE") DI SANT’#AGOSTINO.
Platone, nonostante tutto, è stato chiaro: «Non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità, o scoprirla da sé medesimi, oppure, se ciò è impossibile accettare, fra i ragionamenti umani, quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita. A meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio, su una più solida nave, cioè affidandosi a una divina rivelazione» ( Platone, "Fedone", 85c-d).
AFFIDANDOSI ALLA "DIVINA RIVELAZIONE" DI #FRANCESCO DI ASSISI: IL SUO "#PRESEPE" (GRECCIO, 1223), UNA NUOVA #ARCA ("UNA PIU’ SOLIDA NAVE"), QUELLA DELLO STESSO "GALILEO", DANTE ALIGHIERI RITROVA SE’ STESSO E LA #SORGENTE DI TUTTE LE SORGENTI ( "L’ AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE") E RI-DIVENTA ANCH’EGLI UN ALTRO "CRISTO". (Sul tema, mi sia lecito, si cfr.: "La FenomenologiadelloSpirito... dei “Due Soli”. Ipotesi di rilettura della “Divina Commedia”).
- NOTE:
- FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPEREAUDE!" (#KANT, 1784). Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi. Una breve nota a margine della sua considerazione .....
- ANTROPOLOGIA #FILOLOGIA E #TEOLOGIA: COME IN #CIELO, COSI’ IN #TERRA. CON LA "DIVINA COMMEDIA" E CON LA "#MONARCHIA" DANTE SI PORTA AL DI LA’ DELLA #COSMOTEANDRIA CELESTE E TERRESTRE DELLA #CHIESA PLATONICO-PAOLINA E COSTANTINIANA E AGOSTINIANA (#NICEA, 325-2025). "Sant’Agostino, la presenza assente nel viaggio di Dante. Sant’Agostino, uno dei più importanti padri della Chiesa, non compare mai come personaggio nella Divina Commedia. Viene, al massimo, solo nominato nell’Empireo del Paradiso. Ma la sua filosofia è presente ovunque, come fonte di ispirazione del Sommo poeta [...]" (cfr. Giovanni Fighera, "La Nuova Bussola Quotidiana"", 11_04_2021).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- COSMOLOGIA ED ECOLOGIA QUOTIDIANA: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. Un omaggio ad A. Zichichi e a Claudia Fanti24 maggio 2025, di Federico La Sala
FISICA (#RAGIONE), METAFISICA (#FEDE), #TEOANTROPOLOGIA E #COSMOLOGIA #QUOTIDIANA: "#SÀPERE AUDE!" (#KANT, 1784).
Un omaggio alla sollecitazione a riflettere del prof. Antonino Zichichi.
 Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:
Una breve nota a margine della sua seguente considerazione:- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.
 Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.
Fermi comprese qualcosa che ancora oggi sfugge a molti: la Cultura non è un ornamento, ma una necessità per la vita quotidiana.
 È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.
È dalla Cultura - quella vera, fondata sulla conoscenza, sul metodo, sul dubbio costruttivo - che nasce ogni progresso: medico, tecnologico, sociale.
 Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.
Lui, uomo schivo e rigoroso, visse sulle proprie spalle questa responsabilità.
 Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.
Sapeva che fare scienza non è solo risolvere equazioni o scoprire leggi dell’Universo. È aiutare l’#uomo a capire dove si trova, chi è, e come costruire un mondo migliore.
 Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.
Fermi non fu solo un Nobel. Fu una #coscienza etica della scienza.
 E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).
E noi, oggi, abbiamo il dovere di tenere viva quella lezione. Perché senza cultura vera, non c’è #libertà vera. " (cfr. Antonino Zichichi, Fbook, 20 maggio 2025).
***
CULTURA E #SOCIETÀ : #FERMI TUTTI E TUTTE, E, "CUM GRANO SALIS", SI CERCHI (E CERCHIAMO) DI PENSARCI ANCORA E BENE SUL #GALILEO DI CUI SI STA PARLANDO: "VICISTI, GALILAEE" (#KEPLERO, 1611).
La #rivoluzionecopernicana (contro i profeti della "fine della storia"), a mio parere, è solo iniziata, e, la navigazione nell’#oceanoceleste, con la #nave di #GalileoGalilei, se ha oltrepassato Scilla e Cariddi, non è andata affatto oltre le colonne d’Ercole della #cosmoteandria dell #tragedia.
"DIVINA COMMEDIA" (#Dante Alighieri). Non è meglio continuare a rifletterci? Così #EnnioFlaiano, nella sua “Autobiografia del Blu di Prussia”, scriveva: “L’amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco un verso di Dante che vede oltre il telescopio di Galilei”. Una forte e bella illuminante idea! Non è bene tenerne conto?
- NOTE:
- ARITMETICA E #ANTROPOLOGIA: #IMPARARE A #CONTARE. UNA #HAMLETICA #DOMANDA TEOLOGICO-POLITICA AI MATEMATICI PER USCIRE DALL’#IMMAGINARIO DELLA #TORREDIBABELE. Come "è stata possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ...
- STORIA #STORIOGRAFIA E #RICERCA SCIENTIFICA: A NICCOLO’ #COPERNICO (19 febbraio 1473 - #24MAGGIO 1543). ALLA #LUCE DEL SOLE, CONTRO I PROFETI DI #SVENTURA, DOPO #NEWTON, #KANT ED #EINSTEIN, ANCORA UN ALTRO "NEW TON": "LA #MENTEACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA" (#ANTONIOPELLICANI EDITORE, ROMA 1991) .... UN GRANDE OMAGGIO AL "FRATE #SOLE" E ALLA "SORA NOSTRA MADRE #TERRA"! UN "INVITO" AD ASCOLTARE E AD ASCOLTAR-SI IL "CANTICO DELLE CREATURE" (E IL "CANTICO DEI CANTICI"): UNA SOLLECITAZIONE #SOLARE PER UN #PIANETATERRA ANCORA IMBOZZOLATO NEL " #BUIO" DELLA SUA CAVERNICOLA "#INTELLIGENZA #ARTIFICIALE" E DELLA SUA "PLATONICA" #MATEMATICA COSMOTEANDRICA. UNA "RICOGNIZIONE" STORICO-FILOSOFICA PER RIPRENDERE IL FILO CON LA PRIMA #RINASCITA" (#ERNESTOBUONAIUTI), "L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" (#DANTE ALIGHIERI, Par. XXXIII, 145), E LA "#RIVOLUZIONE COPERNICANA" NELLA #SCIENZA E NELLA #FILOSOFIA.
- STORIA E #METASTORIA D’#EUROPA: OLTRE L’ANTICA #TRAGEDIA, "LA PRIMA #RINASCITA" E LA "#DIVINA COMMEDIA". Storiograficamente, forse, è ora di #capovolgere, il "tempo" proprio dell’#Umanesimo e del #Rinascimento: per la #società e la #cultura del cosiddetto "#MedioEvo" (così dagli "umanisti"), l’epoca (al contrario) "fu sentita - scrive E. #Gilson - come un’età di innovazione in tutti i sensi della cultura, una #modernità in progresso". A mio parere, a ben vedere, Ernesto Buonaiuti aveva ragione: il formidabile processo della "prima #rinascita" cominciò con #GioacchinodaFiore, #Francesco di Assisi, e #Dante Alighieri. Riprendere il filo...
- COSMOLOGIA ED #ECOLOGIA #QUOTIDIANA: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. Per riflettere e approfondire, un libro di #ClaudiaFanti, "A casa nel cosmo. Per una nuova alleanza tra spiritualità e scienza" (#GabrielliEditori, 2025):
- "DESCRIZIONE [...] Con straordinaria chiarezza e competenza riguardo al mondo della scienza, in particolare dell’astrofisica, della fisica contemporanea, della biologia, l’autrice sviluppa il testo attraverso cinque parole dense di significato che iniziano tutte con la lettera “c”: #casa (il nostro pianeta, ma anche, più in generale, l’intero universo di cui siamo parte), #creatività (il nome della storia cosmica), #coscienza (come possibile fondamento della realtà), #conoscenza (compagna inseparabile del mistero) e #connessione (l’interdipendenza di tutto con tutto come “legge morale” dell’universo). [...] “A ottocento anni dalla morte di #sanFrancesco, questo è un libro che riecheggia in pieno il suo insegnamento di amore per tutto il creato. È una revisione moderna del #CanticodelleCreature.” #MaurizioBusso [...]" (cit.)
- "Enrico Fermi fu il più grande galileiano dell’ultimo secolo. E con questo non intendo solo dire che fu un genio della fisica - cosa indiscutibile - ma che incarnò in pieno lo #spirito di Galileo: il #coraggio di pensare in modo nuovo, la lucidità logica e la devozione assoluta alla verità scientifica.
-
>STORIA E LEGGENDA: ALCUNE NOTE A LATO DELLA "TRADIZIONE" DEL TITANISMO E DELLA FIGURA "CRISTOLOGICA" DEL SUPERUOMO COSTANTINIANO (NICEA, 325-2025).21 maggio 2025, di Federico La Sala
LEGGENDA (TEATRO), STORIA (METATEATRO),PSICOLOGIA (METAPSICOLOGIA), E LINGUAGGIO (METALINGUAGGIO):
SHAKESPEARE, "LA #TRAPPOLA DEL #TOPO" ("THE #MOUSETRAP"), E "LA PROFEZIA Di JENNY: LA GATTA DEL TITANIC":*
- Una indicazione per una rilettura dell’#Amleto ("#Hamlet"), più attenta al tema del #tempo uscito "fuori dai cardini", e, insieme, alla connessa "#sublime" e "subliminale" sollecitazione a svegliarsi dal millenario titanico "#letargo" di #Dante Alighieri (Par. XXXIII, 94), a riprendere la #navigazione, e a #cambiarerotta e #vita.
*
"[...] Hai mai sentito parlare di Jenny, la gatta che predisse il naufragio del Titanic? Jenny non era una semplice cacciatrice di topi: diventata mamma a bordo del transatlantico, si dice che abbia intuito il tragico destino della nave. Poco prima della partenza, Jenny portò i suoi gattini a terra, seguita dal fuochista Jim Mulholland, che interpretò il suo comportamento come un segnale di pericolo. La storia di Jenny ci ricorda quanto misteriosi e straordinari possano essere i nostri amici felini. Un misto di leggenda e realtà che continua a stupire! ("Fenomenologia della lingua").
- NOTE:
- TEATRO, #METATEATRO, #COSTRUZIONI NELL’#ANALISI: AMLETO (#HAMLET) E "LE GATTE" E I GATTI ("THE #MOUSETRAPPERS") DI SHAKESPEARE (E SIGMUND FREUD).
- OLTRE LA "TRADIZIONE" DEL #TITANISMO E OLTRE LA FIGURA "CRISTOLOGICA" DEL #SUPERUOMO COSTANTINIANO (#NICEA, 325-2025). Per #chiarezza hamletica e antropologica, a mio parere, le "allusioni" di #Shakespeare nel testo dell’#Hamlet vanno ben al di là della #logica contrapposta (o #dialettica) del #patriarcato o del #matriarcato e, al contempo, rinviano a una "#idea" di "#rinascita", di strategia teologico-politica di "ritorno" nel "#paradiso terrestre", più vicina a quella di Dante Alighieri e Giordano Bruno e ben lontana dai sogni di onipotenza androcentrica (#platonismo e #paolinismo) del "#parto #maschio del tempo" e del "#NovumOrganum" di #Francesco Bacone.
Per dirla in immagine, con Michelangelo e #Marx ed #Engels e #HaroldBloom, si tratta di ripensare un altro "Sè come un altro" (non narcisisticamente e non edipicamente) e l’intera "sacra famiglia".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- UNA PERSONA COME "COME-(u)N-IO (COMENIO): MATEMATICA, GEOMETRIA, E COSTITUZIONE17 maggio 2025, di Federico La Sala
MATEMATICA, GEOMETRIA, COSTITUZIONE (e REFERENDUM).
"UNO" OMAGGIO AL #2GIUGNO PER UNA #PERSONA COME "COME-(u)N-IO (#COMENIO *):
 "UNO = "Uno" (ma "Uno+Uno" fa sempre "Due" uno, l’Uno di"#DueSoli").
"UNO = "Uno" (ma "Uno+Uno" fa sempre "Due" uno, l’Uno di"#DueSoli").- In memoria di #DanteAlighieri e di #Galileo Galilei e Immanuel #Kant, e Ferdinand de #Saussure...
#ANTROPOLOGIA E #ARCHEOLOGIA (#PSICOLOGIA E #ALCHIMIA). SE, come ha #bene detto #EUCLIDE, nelle sue "Definizioni", che "Ogni punto ["#individuo"] è ciò che ["#chi"] non ha parti ["non si può dividere in #due" o più parti, "#atomo"]", come è possibile che "UN #UOMO PIU’ UNA #DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (#FrancaOngaro #Basaglia)?!
- * Per informazioni più dettagliate sulla vita e le opere di Jan Amos #Comenius e sulle varie attività del Museo Comenius di Naarden, visitate il sito web www.comeniusmuseum.nl .
Alcuni appunti sul tema:
- NOTE:
- ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA #PEDAGOGIA #EDUCAZIONE #DIDATTICA E #STORIA: #COMENIO.
- "Giovanni Amos #Comenio (in latino Iohannes Amos #Comenius; in ceco Jan Amos #Komenský; in ungherese János Comenius-Szeges; #Nivnice, 28 marzo 1592 - #Amsterdam, 15 novembre 1670) è stato un teologo, pedagogista, filosofo, drammaturgo, scrittore, educatore, insegnante, linguista e pacifista ceco. Fu uno dei pastori protestanti più colti e importanti dell’Unione dei #FratelliBoemi. La sua fama e le sue dottrine sono dovute non solo alla vita da rifugiato religioso e alla difesa dell’#istruzionepubblica e della scuola materna paritaria, ma anche alla sua enorme conoscenza e alle sue innovazioni letterarie. #Pensatore tra i più importanti del #Seicento , viene considerato il padre dell’#educazionemoderna. [...]" (cit.).
- Per informazioni più dettagliate sulla vita e le opere di Jan Amos Comenius e sulle varie attività del Museo Comenius di #Naarden, visitate il sito web www.comeniusmuseum.nl.
- IL "LOGOS" IN "PRINCIPIO" («Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος»), «DIO NESSUNO L’HA MAI VISTO» (Gv.1,18), E UNA #HAMLETICA #QUESTIONE DI #FILOLOGIA, DI #ANTROPOLOGIA, E DI "#PRINCIPI DELLA #MATEMATICA" (#BERTRANDRUSSELL, 1903).
 Una nota di commento a margine del "vecchio" tentativo di Bertrand Russell, di portarsi sulle ali del "#neutral #monism"
("monismo neutro" ), oltre l’#assolutismo metafisico sia del #materialismo sia dell’#idealismo, e, oltre l’#inferno epistemologico dell’#empirismo, del #razionalismo e, infine, dello stesso #scetticismo.....
Una nota di commento a margine del "vecchio" tentativo di Bertrand Russell, di portarsi sulle ali del "#neutral #monism"
("monismo neutro" ), oltre l’#assolutismo metafisico sia del #materialismo sia dell’#idealismo, e, oltre l’#inferno epistemologico dell’#empirismo, del #razionalismo e, infine, dello stesso #scetticismo.....
- ARITMETICA E #ANTROPOLOGIA: #IMPARARE A #CONTARE. UNA #HAMLETICA #DOMANDA TEOLOGICO-POLITICA AI MATEMATICI PER USCIRE DALL’#IMMAGINARIO DELLA #TORRE DI BABELE. Come "è stata possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#FrancaOngaro #Basaglia)?!? Non è il caso di ripensare i fondamenti?! ...
- FILOSOFIA, #MATEMATICA #GEOMETRIA: GLI "#ELEMENTI" DI #EUCLIDE.
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE: C’E’ #DIO E "DIO" , #PATRIA E "PATRIA", E #FAMIGLIA E "FAMIGLIA". IERI COME OGGI, IL #NODO DI "#ERCOLE" E’ QUELLO DI USCIRE DALLO #STATO DI #MINORITA’ SIGNIFICA "RINASCERE", #APRIREGLIOCCHI E DIVENTARE "CHI" SI E’, E, SAPER #DISTINGUERE. COME AVEVA GENIALMENTE COMINCIATO A CAPIRE E A INDICARE #GRAMSCI GIA’ NEL MARZO DEL 1924. RIPARTIRE DALLE SUE RIFLESSIONI SUL TEMA DEL "#CAPO", FORSE, PUO’ ESSERE UNA BUONA OPPORTUNITA’ PER SVEGLIARSI DAL #SONNODOGMATICO ATEO-DEVOTO DI #COSTANTINO (#NICEA 325-2025).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL PROBLEMA "MATEMATICO-ANTROPOLOGICO" DEL "MENTITORE" E "L’ANALISI DELLA MENTE". Un omaggio a bertrand Russell e a Dora Black Russell.14 maggio 2025, di Federico La Sala
IL "LOGOS" IN "PRINCIPIO" («Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος»), «DIO NESSUNO L’HA MAI VISTO» (Gv.1,18), E UNA #HAMLETICA #QUESTIONE DI #FILOLOGIA, DI #ANTROPOLOGIA, E DI "PRINCIPI DELLA #MATEMATICA" (#BERTRAND RUSSELL, 1903).
- Una nota di commento a margine del "vecchio" tentativo di Bertrand Russell, di portarsi sulle ali del "#neutral #monism" ("monismo neutro" ), oltre l’#assolutismo metafisico sia del #materialismo sia dell’#idealismo, e, oltre l’#inferno epistemologico dell’#empirismo, del #razionalismo e, infine, dello stesso #scetticismo.
NELLA "PREFAZIONE" AL SUO LAVORO SULLA "ANALISI DELLA MENTE" (1921), #Russell così scrive: "Questo libro nasce dal tentativo di armonizzare due diverse tendenze, una in psicologia, l’altra in fisica, con cui mi trovo in sintonia, sebbene a prima vista possano sembrare incoerenti. Da un lato, molti psicologi, soprattutto quelli della scuola comportamentista, tendono ad adottare una posizione essenzialmente materialistica, per una questione di metodo se non di metafisica. Rendono la psicologia sempre più dipendente dalla fisiologia e dall’osservazione esterna, e tendono a pensare alla materia come a qualcosa di molto più solido e indubitabile della mente. Nel frattempo i fisici, soprattutto Einstein e altri esponenti della teoria della relatività, hanno reso la "materia" sempre meno materiale. Il loro mondo è costituito da "eventi", da cui la "materia" deriva da una costruzione logica. Chiunque legga, ad esempio, "Spazio, tempo e gravitazione" del professor Eddington (Cambridge University Press, 1920), si renderà conto che un materialismo antiquato non può ricevere alcun sostegno dalla fisica moderna. Credo che ciò che abbia un valore permanente nella prospettiva dei comportamentisti sia la convinzione che la fisica sia la scienza più fondamentale attualmente esistente. Ma questa posizione non può essere definita materialistica se, come sembra essere il caso, la fisica non presuppone l’esistenza della materia. [...]" (cfr. "L’analisi della mente/Prefazione").
Nonostante le buone intenzioni, Russel mostra di non essere affatto ben disposto a staccarsi "meta-fisica-mente" (andare-oltre) né dall’uno né dall’altro dei "due" e a saper realizzare una visione "neutrale" (da "monismo neutro", come vuole), né nei confronti della psicologia né della fisica, e, anzi, di avere (neopositivisticamente e neoidealisticamente) un punto di vista epistemologicamente e kantianamente del tutto "pre-critico"!
IL PROBLEMA "MATEMATICO-ANTROPOLOGICO" DEL "MENTITORE". In particolare nei confronti di "Einstein e altri esponenti della teoria della relatività" e sul libro «"Spazio, tempo e gravitazione" del professor Eddington (Cambridge University Press, 1920)», Russell mostra di ’guardare’ all’oggetto in esame da un punto di vista molto superficiale, e non neutrale!
Eddington, nella sua "Filosofia della fisica" (1939), mostra decisa consapevolezza critica nel suo sostenere che, "se fosse necessario scegliere una guida tra i filosofi del passato, non ci sarebbe nessun dubbio che la nostra scelta cadrebbe su Kant", e, ancora, che, "come riconoscimento, è giusto dire che Kant anticipò in notevole misura le idee a cui siamo ora spinti dagli sviluppi moderni della fisica" (cfr. Arthur S. Eddington, "Filosofia della fisica", Laterza, Bari 1984).
"#NESSUNO E’ IL MIO NOME" ("Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα"): TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA. ANCORA E DI NUOVO, E’ NECESSARIO LASCIARE IL VECCHIO "MONDO" E RIPRENDERE IL VIAGGIO CON OMERO E DANTE ALIGHIERI, OLTRE SCILLA E CARIDDI E LE COLONNE DI ERCOLE DEL "#MATRIARCATO" E DEL "#PATRIARCATO", DELLA "CADUTA" E DELLA "TRAGEDIA" DI "VECCHIE" ALLEANZE E DI COSTITUZIONI DOGMATICHE.
CON LA CRITICA DELLA RAGIONE "PURA" E IL "SÀPERE AUDE!" DI ORAZIO E KANT, E, CON LE "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. #FREUD, 1937), FORSE, E’ POSSIBILE RIPRENDERE IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" DEL #GALILEO (1632) E PORTARSI AL DI LA’ DELLA #DOTTAIGNORANZA E DELL’ASTUZIA (DEL FIDEISMO) DELLA RAGIONE "#UNIVERSALE", NELLA TERRA "ILLUMINATA" DA "DUE SOLI". L’ALBA DELLA MERAVIGLIA: #EARTHRISE...
- Note:
- STORIA E STORIOGRAFIA DELLA #SCIENZA E DELLA #FILOSOFIA. "#Freud, #biologo della #psiche": l’opera di Frank J. #Sulloway (Feltrinelli, Milano, 1982), nella recensione dello psichiatra e psicoanalista #FrancoDeMasi. Una "citazione":
- "Il titolo può anche risultare fuorviante e non sembra rendere giustizia al contenuto di questo libro [...] La tesi centrale è che vi è una continuità nel pensiero di Freud dal periodo del suo stretto interesse biologico a quello dello sviluppo psicoanalitico. L’autore sostiene che, contrariamente a quanto hanno affermato gli studiosi di psicoanalisi, in particolare gli analisti come Jones, che si sono occupati di storia della psicoanalisi e che sottolineano l’importanza dell’autoanalisi per le scoperte psicoanalitiche, Freud, avendo iniziato la sua carriera scientifica come biologo, trovò perfettamente naturale, anche durante gli anni successivi e cruciali delle scoperte analitiche, continuare a collocare l’entità biologica dell’uomo nello stesso cuore del sistema psicoanalitico e che, anche nelle ultime opere, questa fonte di L’ispirazione non venne mai meno anche se non è stata riconosciuta o menzionata." (Rivista di Psicoanalisi).
- STORIA E MEMORIA: BERTRAND #RUSSELL E DORA #BLACK.
- Doc.: Una straordinaria donna moderna (#DoraRussel, "#Ipazia e la #guerra tra i #sessi") di Francesca Magni ("Letto fra noi", 29 gennaio 2013):
- Dora Russel (Mrs Bertrand Russell), Ipazia e la guerra tra i sessi (La Tartaruga, 2012, traduzione di Simone Lenzi € 12,00, pp. 100.
- LA #FILOSOFIA E L’#ANTINOMIA ANTROPOLOGICA DEL COSIDDETTO "#PARADOSSO DEL #MENTITORE": "I PRINCIPI DELLA MATEMATICA" (#BERTAND RUSSELL). SCHEDA EDITORALE:
- "Pugnace censore di ogni forma di dogmatismo e fanatismo, è stato uno dei fondatori della filosofia analitica e ha avuto un ruolo di primo piano, con G. E. Moore, nella "rivoluzione" che ha travolto l’idealismo della filosofia anglosassone d’inizio Novecento: rivoluzione di cui i #Principidellamatematica (1903) rappresentano uno dei testi fondativi. "L’opera - scrive #Russell - ha un duplice scopo: primo, provare che tutte le proposizioni della matematica pura sono deducibili da un numero piccolissimo di principi logici fondamentali; [...] secondo, spiegare i concetti fondamentali che la matematica accetta come indefinibili - un compito puramente filosofico, e io non mi illudo di aver fatto altro che indicare un vasto campo di ricerche" (cit.).
- PIANETATERRA E #COSMOTEANDRIA: TRACCIA PER UNA #SECONDA #RIVOLUZIONE COPERNICANA (#KANT, 1724- 2024).
 STORIA DELLA #CIVILTA’ E #FILOLOGIA: COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO (TEOLOGICO E COSMOLOGICO) E’ STATO DECLINATO DALL’#ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE "PRINCIPIO #ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato): "The #Stages of #Man (1510)", by Charles de #Bouelles (c. 1470-1553).
STORIA DELLA #CIVILTA’ E #FILOLOGIA: COME IL #PRINCIPIO ANTROPOLOGICO (TEOLOGICO E COSMOLOGICO) E’ STATO DECLINATO DALL’#ANDROCENTRISMO (PLATONICO-PAOLINO ED HEGELIANO), NEI SECOLI DEI SECOLI, FINO A DIVENTARE "PRINCIPIO #ANTROPICO", IN UNA SINTETICA "#PIRAMIDE" PROPOSTA DAL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS (v. allegato): "The #Stages of #Man (1510)", by Charles de #Bouelles (c. 1470-1553).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---"C’ERA UNA VOLTA...": ALLA RICERCA DEL "TEMPO PERDUTO". RICORDANDO WALTER BENJAMIN: C’E’ "MESSIANISMO" E MESSIANISMO28 aprile 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA TEOLOGICO-FILOSOFICA. IL "CERA UNA VOLTA..." DELLA #COSMOTEANDRIA E DEL #LETARGO DENUNCIATO DA #DANTEALIGHIERI E IL "C’ERA UNA VOLTA..." DELL’ESSERE SVEGLI, DELL’ESSERE PRONTI ("THE #READINESS IS ALL") DELL’#AMLETO DI #SHAKESPEARE.
C’E’ "MESSIANISMO" (ATEO-DEVOTO, COSTANTINIANO E ANDROCENTRICO) E MESSIANISMO (CRITICO, BENJAMINIANO, ANTROPOLOGICO ED EVANGELICO):
FILOLOGIA ("#CARITAS"), #CRITICA ("#CHARITAS), E #CHIAREZZA ("#CLARITAS"): C’E’ "DIO" ("#DEUS") E #DIO (DEUS),"PATRIA" E #PATRIA, E, "FAMIGLIA" E #FAMIGLIA. PRIMA DISTINGUERE E POI UNIRE: IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA (IL "#LOGOS" DI #NESSUNO), NON LA "PAROLA" (IL "#LOGO" DI UN "PADRE-#PADRONE", DI UN "#DOMINUS").
UNA "CITAZIONE" ALL’ORDINE DEL GIORNO, DALLE "TESI DI FILOSOFIA DELLA STORIA" DI WALTER BENJAMIN:
"[16] Al concetto di un presente che non e’ passaggio, ma in bilico nel tempo ed immobile, il materialista storico non puo’ rinunciare. Poiche’ questo concetto definisce appunto il presente in cui egli per suo conto scrive storia. lo storicismo postula un’immagine "eterna" del passato, il materialista storico un’esperienza unica con esso. Egli lascia che altri sprechino le proprie forze con la meretrice "C’era una volta" nel bordello dello storicismo. Egli rimane signore delle sue forze: uomo abbastanza per far saltare il continuum della storia." (cit.).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- RIPENSANDO AL GALILEO GALILEI, ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI PAPA FRANCESCO:26 aprile 2025, di Federico La Sala
RIPENSANDO AL GALILEO, "CUM PETRO ET SUB PETRO", ALCUNI SEGNAVIA DELL’EREDITA’ DI JORGE MARIO BERGOGLIO E DI #PAPA #FRANCESCO: "QUELLE SCARPE CONSUMATE" E LA "SCELTA" DELLA #BASILICA DI "SANTA MARIA MAGGIORE" (ROMA)
- Una nota a margine di una riflessione di Andrea Arena in omaggio e in memoria di Papa Francesco (26aprile 2025).
ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA. "LE SCARPE CONSUMATE, I SORRISI SINCERI, E I DIALOGHI AUTENTICI" INDICANO, A MIO PARERE, IN UNA BREVISSIMA SINTESI ANTROPOLOGICA, I TRATTI ESSENZIALI DEL #VIAGGIO TERRENO E TERRESTRE DELL’#UOMO BERGOGLIO E DEL #PAPA FRANCESCO, DEL SUO #CAMMINARE #SINODALE ("CUM PETRO ET SUB PETRO", 2014), SUL "COME SI VA IN CIELO" (EVANGELICAMENTE), SUL "COME VA IL CIELO" (SCIENTIFICAMENTE ), E, APRENDO STORIOGRAFICAMENTE E FRANCESCANAMENTE MENTE OCCHI E CUORE, SUL COME E DA DOVE RIPARTIRE PER PORTARE AVANTI LA #SECONDA "#RIVOLUZIONECOPERNICANA": "VICISTI, #GALILAEE" (COSì #KEPLERO A #GALILEO, 1611).
FEDE E SCIENZA: "DUE SOLI" (DANTEALIGHIERI). LA BASILICA PAPALE DI #SANTAMARIAMAGGIORE E’ UN LUOGO LEGATO NON SOLO ALLA TRADIZIONE RELIGIOSA DEL CATTOLICESIMO-ROMANO E AL FAMOSO MIRACOLO DELLA #NEVE AD AGOSTO, MA ANCHE ALLA TRADIZIONE ARTISTICA E SCIENTIFICA DELL’EUROPA MODERNA, AL "SIDEREUS NUNCIUS" DI #GALILEO GALILEI (1610), E, ALL’OPERA DEL SUO AMICO PITTORE, #LUDOVICOCARDI, DETTO IL CIGOLI: [LA LUNA GALILEIANA, PRESENTE NEL QUADRO DELLA "IMMACOLATA CONCEZIONE CON APOSTOLI E SANTI", NELLA CAPPELLA PAOLINA DI SANTA MARIA MAGGIORE, INFATTI, E’ OPERA SUA.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA "INUTILE STRAGE", UN OSPEDALE DA CAMPO MILITARE E LA PROPOSTA DI UN "SATANARIUM" - CON UNA "RAFFINERIA".24 aprile 2025, di Federico La Sala
OLTRE IL PLATONISMO E IL PAOLINISMO, UNA "CONCORDANZA" PER UNA "ALLEANZA TERAPEUTICA" TRA CRISTIANESIMO E PSICOANALISI. Appunti sul tema:
A) EUROPA: LA "INUTILE STRAGE" DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, UN OSPEDALE DA CAMPO MILITARE E LA PROPOSTA DI UN "SATANARIUM": "[...] In occasione della prima guerra mondiale [ #Groddeck] fu richiamato in servizio nella sua qualità di medico militare. Poiché aveva cercato di dirigere anche l’ospedale da campo come fosse stato quello che spesso chiamava il suo #Satanarium (invece di #sanatorium) si attirò le antipatie di tutti, fino ad essere allontanato dal servizio nonostante l’intervento di autorevoli pazienti di un tempo, quali la stessa sorella del #Kaiser e il marito. Fu nel maggio 1917 che Groddeck scrisse la sua prima #lettera a #Freud [...]" (cfr. #MartinGrotjahn, "#GeorgGroddeck (1866-1934). L’analista indomito", in AA. VV., "#Pionieri della Psicoanalisi", #Feltrinelli, Milano 1971).
B) PSICOANALISI E RELIGIONE: IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO. "Frammento inedito" (1931) di Sigmund Freud.
C) PAPA FRANCESCO E LA CHIESA COME "UN OSPEDALE DA CAMPO": «Io vedo con chiarezza - prosegue - che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite... E bisogna cominciare dal basso». (cfr. INTERVISTA A PAPA FRANCESCO di Antonio Spadaro, Santa Marta, lunedì 19 agosto 2013).
D) OLTRE LA CECITÀ DELL’AMORE DI PLATONE, L’INDICAZIONE DI PAPA FRANCESCO RELATIVA ALLA IMPORTANZA E ALLA NECESSITÀ DI UNA "RAFFINERIA" ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA (cfr. la "Catechesi sul “Padre nostro”: 7. Padre che sei nei cieli", 2019).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA (KANT), PARRESIA (MICHEL FOUCAULT), ED EVANGELO. Un omaggio a Jorge Mario Bergoglio, a Papa Francesco,23 aprile 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, MESSAGGIO EVANGELICO, "#SÀPERE #AUDE (#ORAZIO - #KANT), E "#COSTRUZIONI NELL’#ANALISI" (S. #FREUD, 1937): UNA QUESTIONE DI TESTIMONIANZA.
- Un omaggio a #Jorge #Mario #Bergoglio, a #Papa Francesco, e, all’Arcidiocesi di #Benevento...
LE #PERSONE, LE #PAROLE E LE #COSE. Parole di #PapaFrancesco all’Arcidiocesi di Benevento (20 febbraio 2019): "[...] È questo che gli uomini e le donne anche nel nostro tempo attendono dai discepoli del Signore. Testimonianza. Pensate a san #Francesco - che il vostro Vescovo conosce bene - cosa ha detto ai suoi discepoli? “Andate, fate testimonianza, non sono necessarie le parole”. Alle volte si deve parlare ma incominciate con la testimonianza, vivete come cristiani, testimoniando che l’#amore è più bello dell’#odio, che l’#amicizia è più bella dell’#inimicizia, che la #fratellanza fra tutti noi è più bella della #guerra." ("PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO ALL’ARCIDIOCESI DI BENEVENTO. Basilica Vaticana - Mercoledì, 20 febbraio 2019" ).
- NOTE:
- "ANATOMIA" (#GIOVANNI #VALVERDE, 1560) E #PSICOANALISI (2005). "Parlare dell’embrione per dimenticare il mondo". Una risposta-commento di #Luigi #Cancrini (l’Unità, 28.02.2005, p. 27).
- ARTE, #TECNOLOGIA, E #ANTROPOLOGIA: UNA "#RISATA" SEPPELLIRA’ QUEL #PIGMALIONE (DI "#TALETE"). Un "Sillo", una parodia #critica della #filosofia dell’#uomo dell’età delle #macchine: "Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi"(Giacomo Leopardi, "Operette morali", 1827).
- CRISTIANESIMO, #CATTOLICESIMO, #PSICOANALISI, "#DISAGIODELLACIVILTÀ" ("Das Unbehagen in der Kultur"), E #PSICHIATRIA. Per "orientarsi nel pensiero" (#Kant), rileggere le note di #FrancaOngaro #Basaglia su "Così parlò #Edipo a #Cuernavaca" ("PM-Panorama Mese", novembre 1982) e ricordare il legame della "#Interpretazionedei Sogni" (1899) con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, #Acheronta #movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della #DivinaCommedia (Pg. II, 46-48) di #DanteAlighieri.
- ANTROPOLOGIA (#KANT), PARRESIA (MICHEL FOUCAULT), ED EVANGELO (#GIOVANNI 1.1): IN #PRINCIPIO ERA IL #LOGOS (NON IL "#LOGO" DI UN #UNO "FARAONE")! Parole di Papa Francesco all’apertura del #Sinodo dei Vescovi (6 ottobre 2014): «[...] parlare chiaro. Nessuno dica: "Questo non si può dire; penserà di me così o così...". Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia. Dopo l’ultimo Concistoro (febbraio 2014), nel quale si è parlato della #famiglia, un Cardinale mi ha scritto dicendo: peccato che alcuni Cardinali non hanno avuto il #coraggio di dire alcune cose per rispetto del #Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di diverso. Questo non va bene, questo non è #sinodalità, perché bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire: senza rispetto umano, senza pavidità. E, al tempo stesso, si deve ascoltare con umiltà e accogliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli. [...] #parlare con parresia e #ascoltare con #umiltà. E fatelo con tanta tranquillità e pace, perché il Sinodo si svolge sempre #cum_Petro et #sub_Petro, e la presenza del Papa è garanzia [...]» (cit.).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA (KANT, 1800). "Chi ama, ama al di là del premio e della pena" (Friedrich Nietzsche, 1883-1885)19 aprile 2025, di Federico La Sala
TEATRO (#STORIA) E #METATEATRO (#METASTORIA): GIUDA E GESU’, E, IL FILO DEL "SERPENTE", LA VIA PER USCIRE DALL’INFERNO DELLA #DIALETTICA TRAGICA (PLATONICO-PAOLINA ED HEGELIANA).
- ARCHEOLOGIA FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA (#KANT, 1800). "Chi ama, ama al di là del premio e della pena" (Friedrich #Nietzsche, "Così parlò Zarathustra", parte IV: "Fuori servizio" - parole del vecchio papa, "a riposo", 1883-1885).
ALLA #LUCE DELLA SOLLECITAZIONE A RIFLETTERE SUL TEMA PROPOSTO IN "Cain and Jesus in Gertrude’s Closet, Hamlet 3.4" (Paul Adrian Fried)), forse, è ora di decidersi ad accogliere coraggiosamente che per #Shakespeare, come per #DanteAlighieri, nel cammino verso la #sorgente stessa della Legge, "l’amor che move il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145), l’unica possibilità di raggiungere la meta sta proprio nel pensare insieme (dialogicamente e amorosamente) la identità e la differenza tra i #due "fratelli" (al di là "del "bene e del male") e, così, capire che nel "cuore" di "entrambi" si annida (anagrammatica-mente) un "serpent-e" di #speranza, la modalità stessa del "#Trasumanar" (Par. I.70), di andare oltre l’#androcentrismo (e il "#cristocentrismo") della #cosmoteandria della "tragedia" e della "caduta". Rileggere la #Commedia: "E prima, appresso al fin d’este parole, / ‘#Sperent_in_te’ di sopr’a noi s’udì: a che rispuoser tutte le carole." (Dante Alighieri, Par. XXV, 97-99).
- BUONAPASQUA, #PASQUA2025...
- NOTA:
- ULTIMACENA, #EUCHARISTIA, "#TRADIMENTO" DI #GIUDA, #CROCIFISSIONE: IL "RICHIAMO" DEL "#SERPENTE" DI #MOSE’ ("#CappellaSistina", #Michelangelo - v. foto) E LA "PREPARAZIONE" ALLA #PASQUA DI #GUARIGIONE E #RESURREZIONE (DI OGNI #ESSEREUMANO).
- "SÀPERE AUDE" (ORAZIO): "[...] Dette queste cose, #Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Di’, chi è colui a cui si riferisce?». Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose allora Gesù: «È colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a #Giuda #Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, #satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte." (Gv. 13, 21-30).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ANTROPOLOGIA E CRISTIANESIMO, AL DI LÀ DEL PAOLINISMO. UNA SVOLTA EPOCALE: DA GIOVANNI XXII A GIOVANNI XXIII, CON L’INFLUSSO DI DANTE ALIGHIERI.15 aprile 2025, di Federico La Sala
LA STORIA, LA LETTERATURA, I "SEGNI DEI TEMPI", E LA "SOLLECITAZIONE" DI #DANTE ALIGHIERI AD ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, PAPA #GIOVANNI XXIII, A PORTARSI OLTRE LO #SPIRITO DELLA #TRAGEDIA. Alcuni appunti sul tema...
A) - «DANTE E I #PAPI. L’influsso dell’Alighieri sul magistero di Giovanni XXIII: "[...] Dante è una delle fonti del pensiero teologico di Angelo Roncalli. Pertanto indichiamo tre cause, ma anche conseguenze, di questa affermazione: la formazione teologica e spirituale, la scelta del nome Giovanni XXIII, la ri-fondazione della cattedra di Teologia dantesca (a.a. 1961/1962), in coincidenza con la fase preparatoria del concilio. [...]"» (cfr. Gabriella M. Di Paola Dollorenzo, "Una delle fonti del pensiero teologico", L’Osservatore Romano, 14 dicembre 2020)
B) - UNA SVOLTA EPOCALE: DA "GIOVANNI XXII" (Jacques Duèze) A "GIOVANNI XXIII" (Angelo Giuseppe Roncalli ).
C) - I SEGNI DEI TEMPI: "L’espressione segni dei tempi fu usata per la prima volta ufficialmente nella bolla di Giovanni XXIII Humanae salutis (25.12.1961) con cui convocava il Concilio. Nell’enciclica Pacem in terris (11.4.1963) dello stesso Pontefice, diventa una categoria fondamentale. In modo chiaro, vengono in essa indicati #quattro segni dei tempi contemporanei: la socializzazione, l’emancipazione delle classi lavoratrici, l’ingresso della donna nella vita pubblica, la libertà dei popoli oppressi. [...]" (cfr. C. Floristán, "Dizionario sintetico di pastorale").
D) - ANTROPOLOGIA E CRISTIANESIMO, AL DI LÀ DEL PAOLINISMO: #DANTE #ALIGHIERI. «La #Fenomenologia dello Spirito... dei “#DueSoli”. Ipotesi di rilettura della “#DivinaCommedia”» (cfr. Federico La Sala, "IL DIALOGO/Quaderni di teologia", 24 luglio 2007).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- L’«URLO» DI «JUDITH SHAKESPEARE» (VIRGINIA WOOLF, 1929) E IL “DISAGIO DELLA CIVILTÀ” (S. FREUD, 1929).9 aprile 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, “AGRICOLTURA”, E “DISAGIO DELLA CIVILTÀ” (S. FREUD, 1929):
L’«URLO» DI «JUDITH SHAKESPEARE».
- Un omaggio a “Phrasikleia” (Jesper Svenbro, 2024). *
A MEMORIA DI VIRGINIA WOOLF, a suo onore e gloria, forse, è bene rimeditare le sue stesse parole, “pronunciate” nella “conferenza” dedicata al tema di “Una stanza tutta per sé” (1929):
- “[...] sarebbe stato impossibile, completamente e interamente impossibile che una donna scrivesse nell’epoca di Shakespeare le opere di Shakespeare. Immaginiamo, giacché ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, diciamo.” (Virginia Woolf, “Romanzi e Altro”, Mondadori, Milano).
“TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION” (“HAMLET, III.1). Se si considera il luogo e la modalità della morte di Virginia Stephen Woolf, con i suoi particolari riferimenti (“appoggia il suo bastone da passeggio sull’argine dell’Ouse e poi si getta nelle acque del fiume”: https://www.lindau.it/Libri/La-morte-di-Virginia ), data la dichiarata “sorellanza” di “Judith” con “William Shakespeare” e la sua “urlata” domanda amletica sul «Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna?», come non “registrare” (chissà se mai è stato fatto) la forte “consonanza” con il “racconto” della regina Gertrude sulla morte di Ofelia: “C’è un salice che cresce di traverso /a un ruscello e specchia le sue foglie /nella vitrea corrente; qui ella venne [...]” (“Amleto”, IV. 7)?!
 E, ancora, come non sollecitar-si a una rilettura delle opere degli “Shakespeare” e a una più ampia e profonda riflessione sulla “tragedia” della “zoppicante" e “cieca” questione antropologica, a partire dal “due”, dai “due soli” della "Monarchia” di Dante Alighieri e delle “tre corone” dello “Spaccio della bestia tropnfante” di Giordano Buno?!
E, ancora, come non sollecitar-si a una rilettura delle opere degli “Shakespeare” e a una più ampia e profonda riflessione sulla “tragedia” della “zoppicante" e “cieca” questione antropologica, a partire dal “due”, dai “due soli” della "Monarchia” di Dante Alighieri e delle “tre corone” dello “Spaccio della bestia tropnfante” di Giordano Buno?!*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA. L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».31 marzo 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, FILOLOGIA E TEOLOGIA TEOCRITEA ("CHARITAS), E MEMORIA DEL #CORAGGIO DI #ASSAGGIARE ("SÀPERE AUDE") (ORAZIO - KANT):
- L’UNIVERSO, PER IL FISICO ALAN GUTH E’ «IL PIU’ GRANDE DEI PRANZI GRATIS».
Una lezione di "recupero" di antropologia filosofica di Armando Massarenti ("Il Sole 24 Ore", 24 aprile 2011):
Sicuri che nessun pasto è gratis?
«Nessun pasto è gratis», fu la risposta che un re ebbe dai suoi consiglieri dopo aver a lungo insistito per sapere, in un sola frase, quale fosse il senso della scienza economica. #Michael #Brooks, già autore del best seller "13 cose che non hanno senso", nel volume sulla #Fisica nella collana "Le grandi domande", diretta da #Simon #Blackburn (Edizioni Dedalo) esordisce con queste parole: «La bellezza della fisica si riassume in un fatto semplicissimo: un #bambino può fare domande cui nessun professore può rispondere».
Una di queste è «Perché non esistono pranzi gratis?». Che, in fisica, ci spinge a dare risposte in termini di «energia, entropia e ricerca del moto perpetuo». #LeonardodaVinci fece un’analisi dettagliata di una famosa macchina che pretendeva di generare il moto perpetuo, e spiegò perché non poteva funzionare. «O ricercatori del moto perpetuo», concludeva, «quante idee sconclusionate avete concepito nel corso di questa ricerca. Sareste pronti per andare a fare gli alchimisti». Cioè a sognare altri pranzi gratis. Eppure un pasto gratis sembrerebbe esistere, ed sarebbe niente meno che il nostro stesso Universo.
Per il fisico Alan Guth è «il più grande dei pranzi gratis», e ciò è dovuto al concetto cosmologico di «inflazione»: «l’Universo e tutta l’energia che contiene si sarebbero sviluppati a partire da un grammo di materiale. Una frazione di secondo dopo il #BigBang, l’Universo era cento miliardi di volte più piccolo di un protone, ma nel giro di 10-34 secondi aveva già raggiunto una dimensione pari a 1025 volte quella di partenza - qualcosa di simile a una biglia» e da lì sì è espanso sempre più fino alle immensità attuali. Nel corso di questo processo l’energia interna dell’Universo è cresciuta di un fattore 1075, il che sembrerebbe violare il principio che impedisce di avere qualcosa in cambio di nulla.
Invece c’è un dettaglio che permette di restare nell’ambito delle leggi fisiche conosciute: una parte dell’energia è negativa, come mostra la teoria della relatività generale. «L’energia associata alla materia è positiva - riassume Brooks -, e la creazione continua di materia fece aumentare l’energia positiva in modo tale da compensare l’aumento dell’energia negativa. In questo modo l’energia totale può rimanere costante. Gli antichi Greci affermavano che nulla può essere creato dal nulla, ma l’inflazione si permette di non essere d’accordo». E di affermare dunque la totale #gratuità dell’Universo.
Sarà proprio così? Di certo, nella nostra vita, ahinoi, continua a vigere la dura legge degli #economisti.
- NOTA:
- UN "SOGNO" DI #TEOCRITO, LE GRAZIE ("#CHARITES"), E UNA QUESTIONE DI #GRATITUDINE: UNA #DOMANDA DI ARCHEOLOGIA, #LINGUISTICA, #FILOLOGIA, #FILOSOFIA, #TEOLOGIA, #ARTE, #SOCIOLOGIA E #PEDAGOGIA...
- In ricordo di #LorenzoValla e di #GiambattistaVico, una breve nota....
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTHROPOLOGY, THEOLOGY, "GLOBE THEATRE" (SHAKESPEARE): "TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION" ("HAMLET", III.1)24 marzo 2025, di Federico La Sala
IL #DANTEDI’ (#25MARZO 2025), LA "#FENOMENOLOGIA DELLO #SPIRITO" DEI "#DUE SOLI", E LA HAMLETICA QUESTIONE DELL’#UNO IN #ANTROPOLOGIA, #MATEMATICA, #TEOLOGIA-#POLITICA E #PSICOANALISI.
DIVINA COMMEDIA: #PRIMA DELLA #PASQUA, forse, è meglio ricordarsi con #Freud di #apriregliocchi (sogno sulla morte del padre #Jacob Freud), e, con Dante, di non scambiare l’#agnello (l’#ariete, che "nascose" #Ulisse sì da portarlo fuori dalla #claustrofilia polifemica) con un capro (un #caproespiatorio, alla René #Girard).
Altrimenti, come è possibile ri-cominciare a contare antropologica-mente, capire la "Monarchia" dei "Due Soli", il "gioco" delle "Tre Corone per un Re", dei "#Tre Anelli", e il "cerchio di tutti i cerchi", «Quell’uno e due e tre che sempre vive/e regna sempre in tre e due e uno» (#DanteAlighieri, Par. XIV, 28-29), l’#amore "che move il sole e le altre stelle" Par. XXXIII, 145)?
- NOTE:
- ANTHROPOLOGY, THEOLOGY, "GLOBE THEATRE" (SHAKESPEARE): "TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION" ("HAMLET", III.1). "Cats and dogs in a library": "[...] In spite of rationalism’s disdain for the particular, the personal, and the unwholesome, the drift of all the evidence we have seems to me to sweep us very strongly towards the belief in some form of superhuman life with which we may, unknown to ourselves, be co-conscious. We may be in the universe as dogs and cats are in our libraries, seeing the books and hearing the conversation, but having no inkling of the meaning of it all." (#William James, ’A Pluralistic Universe’, 1909).
- STORIA #LETTERATURA E #FILOSOFIA: LA "CRITICA DELLA RAGION PURA" NON DISTRUTTA DAI "TOPI" DELLE BIBLIOTECHE, MA DA "CANI" E "GATTI" DELLA "FATTORIA DEGLI ANIMALI".
- DOPO DANTE ALIGHIERI, DOPO GIORDANO BRUNO, DOPO SHAKESPEARE, DOPO GALILEO GALILEI, E DOPO #KANT, TUTTI "#PRAGMATISTI" (ALLA JOHN #DEWEY, NELLA "#RICERCA DELLA #CERTEZZA. Studio del rapporto fra #conoscenza e #azione", 1929), INCAPACI DI SAPERE DELLA #VITA E DELLA #MORTE, ABILISSIMI COME "CANI" E "GATTI" A RISOLVERE LE "DISCUSSIONI" SUL #DISTRUGGERE LA #MEMORIA (LA #BIBLIOTECA) DELLA TERRESTRE #UmaNITA’.
- IL "SAPERE AUDE" (1784) E L’ESERCIZIO DELLA "CRITICA". UNA CIT. DALLA "PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE" DELLA "CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT, 1787):
- "[...]Soltanto dalla critica possono essere tagliati alla radice il materialismo, il fatalismo, l’ateismo, l’incredulità dei liberi pensatori, il fanatismo, la superstizione, che possono diventare perniciosi a tutti, e infine anche l’idealismo e lo scetticismo, che sono dannosi più specialmente alle scuole, e difficilmente possono passare nel pubblico. Se i governi trovano conveniente mescolarsi nelle faccende dei dotti, sarebbe più conveniente alla loro savia sollecitudine per le scienze come per gli uomini, favorire la libertà di una tale critica, per cui soltanto le produzioni della ragione potrebbero essere messe su un solido piede, anzi che sostenere il ridicolo dispotismo delle scuole, che mandano alte grida annunziando un pubblico danno, quando si strappano quelle loro ragnatele, di cui, pure, il pubblico non ha avuto mai notizia e non può avvertire perciò la perdita." (Immanuel Kant, "Critica della ragion pura", Laterza, Roma-Bari 2000).
- ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA, E #TEOLOGIA: IL PROBLEMA DEL "#MONOTEISMO" E DEI "#TRE #ANELLI", DELLE "TRE #CORONE", E DEI "TRE #IMPOSTORI". SULLE #ALI DI #DANTEALIGHIERI (#25MARZO, #Dantedì), PRIMA DI #LESSING E PRIMA DI #HEGEL, GIORDANO #BRUNO, AVEVA GIA’ INDICATO NELLO "#SPACCIO DELLA #BESTIA TRIONFANTE", LA "SOLUZIONE": "Tertia coelo manet).
- SCRITTURA, #LETTURA, "#DISAGIO DELLA #CIVILTA" (S. #FREUD, 1929), E #BIBLIOTECHE DI #BABELE: ALLA #RICERCA DEL #PARADISO PERDUTO. Una "sintesi" sul tema...
- "L’arte perduta della ricerca come svago [...] I fondamenti letterari della civiltà. Incastonata in uno spazio per eventi-caffetteria-museo-bar a Fort Mason, il campus militare di San Francisco, con vista mozzafiato sul Golden Gate Bridge, si trova una biblioteca a tutta altezza che ospita il Manual for Civilisation della Long Now Foundation. Una collezione curata dal pubblico dei 3.500 libri "più essenziali per sostenere o ricostruire una civiltà", il Manual for Civilisation iniziava con una domanda: se fossi bloccato su un’isola (o un piccolo planetoide ostile), quali libri vorresti avere con te?
- La collezione, esposta lungo pareti industriali, è al tempo stesso solenne e ottimista, seria e futile, il Golden Record libresco di un romantico. È, in modo più vivido, un monumento umile alla proclamazione della storica Barbara Tuchman secondo cui "I libri sono i portatori di civiltà". "Senza libri", scrisse Tuchman, "lo sviluppo della civiltà sarebbe stato impossibile".[...]" (Mariam Mahmoud, "Kasurian", 09 marzo 2025).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- IL SOGNO E IL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla riflessione «I Papi Giovanni XXIII e Francesco “sognatori” come san Giuseppe».23 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #FILOLOGIA #ARCHEOLOGIA E "#CHARITAS":
IL "TONDO DONI" (#MICHELANGELO #BUONARROTI).
SE SI PENSA, COME SI CREDE ( «I Papi Giovanni XXIII e Francesco “sognatori” come san Giuseppe» ), CHE "secondo le Scritture i “#sognatori” sono «gli unici capaci di far andare avanti la storia», facendola «uscire dai vicoli ciechi creati dagli uomini». E san Giuseppe è il #modello «di ogni credente chiamato a essere un sognatore: uomini e donne che fanno la volontà di Dio; giusti che ascoltano la sua parola» [...]" (cfr. L’Osservatore Romano, 21 marzo 2025), ALLORA NON RESTA CHE "#SOGNARE", FARE IL #SOGNO DI TUTTI I BAMBINI E DI TUTTE LE BAMBINE DEL "MONDO", E, RICONOSCERE E RESTITUIRE A #GIUSEPPE, ACCANTO A #MARIA, E, A MARIA ACCANTO A GIUSEPPE, #DIGNITA’, #ONORE E #GLORIA.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---C’E’ DA DIRE CHE l’UOMO DEL PIANETA TERRA non sa come "orientarsi nel pensiero" (KANT), e nella realtà (FRANCA ONGARO BASAGLIA).20 marzo 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E FENOMENOLOGIA (DELLO "#SPIRITO"): "NICODEMO O DELLA NASCITA" (ENZO PACI).
UNA NOTA in memoria di Edmund Husserl, Paul Ricoeur, Enzo Paci, e Fulvio Papi...
A BEN RIFLETTERE SULLE PAROLE DI HUSSERL:
- «Il matematico, in realtà, non è il teorico puro, ma soltanto il tecnico ingegnoso, è per così dire il costruttore che, guardando unicamente ai nessi formali, è per così dire il costruttore che, guardando unicamente ai nessi formali [...] Al filosofo non basta che noi ci orientiamo nel mondo oppure che possediamo leggi espresse in formule in base alle quali prevediamo il futuro corso delle cose e possiamo ricostruire quello passato; egli vuole chiarire che cosa sia l’essenza di ’’cosa’’, ’’evento’’, ’’causa’’, ’’effetto’’, ’’spazio’’, ’’tempo’’, ecc. E se la scienza costruisce teorie per la soluzione sistematica dei suoi problemi, il filosofo chiede che cosa sia la scienza della teoria, che cosa renda possibile la teoria in generale.» ("Ricerche Logiche", vol.1, § 71),
BISOGNA RICONOSCERE CHE continuiamo, antropologicamente, a procedere su questa strada, con una DOPPIA CECITÀ, sia in MATEMATICA sia in FILOSOFIA (sia in #FILOLOGIA).
C’E’ DA DIRE CHE l’#UOMO DEL #PIANETA TERRA non sa come "orientarsi nel pensiero" (KANT), e nella realtà (#FRANCA ONGARO #BASAGLIA), vive ancora nella "#CAVERNA" POLIFEMICA E PLUTONICA (di #PLATONE, PAOLO DI TARSO, e COSTANTINO: #NICEA, 325-2025), E CHE NON SA (per confessarlo con sant’Agostino) come "FARE LA VERITÀ" (Roberto #Osculati, #Bompiani, 1974).
A mio parere, forse, è meglio fare autocritica sulla "#dotta ignoranza" e, #galileiana-#mente, riprendere il "#dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo", rileggere la husserliana "crisi delle scienze europee" (il Saggiatore ), e rimeditare la "Prefazione alla terza edizione italiana" dell’opera da parte di #Enzo Paci (Milano, 16 settembre 1968), e, al contempo, cercare di ritrovare il filo della riflessione sul "come nascono i bambini", sul problema di "Nicodemo o della nascita" (ricordata da Paci, nel 1973, ma iniziata, con Paul #Ricoeur e compagni, nel Lager di #Wietzendorf, nel 1944.
- NOTA:
- ANTROPOLOGIA, #INTERPRETAZIONE DEI #SOGNI, E #FILOLOGIA DI PRIMAVERA: #EARTHRISE (#20MARZO 2025)
- UNA NOTA SUL #COMENASCONOIBAMBINI" E SUL "BUON-MESSAGGIO". Un omaggio alla figura di san Giuseppe ....
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO--- L’ARATRO (TERRA), LO STILO (SCRITTURA ALFABETICA), E L’ANTROPOLOGIA DELLA "INTELLIGENZA ARTIFICIALE".17 marzo 2025, di Federico La Sala
LA STORIA (TEATRO), L’ARATRO (TERRA), LO STILO (SCRITTURA ALFABETICA), LO STORYTELLING ("GLOBE THEATRE"), E L’ANTROPOLOGIA DELLA "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" (AI=IA).
- In memoria di Immanuel Kant...
CONSIDERANDO la storia dell’ "agricoltura" e l’importanza dell’invenzione dell’aratro per la seminagione del grano e del suo mito fondante connesso al rapimento di Persefone/Proserpina, la figlia di Demetra /Cerere, da parte di Ade/Plutone, si comprende meglio quale "matrimonio" impone la Legge della antica Grecia e cosa "nasconde" la nascita della tragedia: "«non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi", 657 ss.). #Shakespeare insegna: "The time is out of joint" ("Hamlet", I.5).
TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA. A reimpostare, antropologicamente e matematicamentre, la questione, è da dire che aveva ragione #Whitehead (con #BertrandRussell, autore dei "Principia Mathematica"): "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine a #Platone".
Se è vero, come è stato scritto, che "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1978), che fare, oggi, se non andare oltre l’antico programma, codificato nella "macchina" di "scrittura" della tragedia, e portarsi fuori dal rapporto sociale di produzione "cinematografico" platonico?
A mio parere, la "question" è epocalmente hamletica - alla Shakespeare (#Freud): antropologica. Il nodo è che la narrazione della intelligenza artificiale (AI = IA) di questa odierna "società elettronica" è fondata sul codice di una "immaginazione sociologica" (vale a dire, alla Karl #Marx e alla Charles Wright Mills, su un "rapporto sociale di produzione"), proprio e ancora di quello della tragedia (Eschilo, Sofocle, Euripide) della Grecia antica (cfr. Jesper Svenbro, "Phrasikleia, anthropologie de la lecture en Grèce ancienne", Paris 1988).
DIVINA COMMEDIA E CREATIVITA’. Il grande racconto cosmoteandrico di un "mondo come volontà e rappresentazione" di un #Autore - #Sovrano, a tutti i livelli, è finito, e, se non si vuole finire asfissiati nella sua "caverna", non si può non seguire #DanteAlighieri e cercare di ritrovare la "diritta via" della #Commedia!
Meglio riprendere con "Il Nome della rosa (#UmbertoEco), il filo del "maestro di color che sanno" (Inf., IV, 131), #Aristotele, rileggere criticamente "La sposa meccanica" (Marshall McLuhan), e, dopo millenni, uscire dallo storico inferno epistemologico e riequilibrare la teoria del campo cosmo-politico e antropologico: "il resto è silenzio" ("Amleto", V.2).
#Dantedì, #25marzo 2025
- NOTA:
- LA TERRA, LA #SCRITTURA ALFABETICA E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO (#Nicea, 325-2025): SAN BENEDETTO, “CON LA CROCE, CON IL #LIBRO E CON L’ #ARATRO”. Un invito a a riconsiderare, storiograficamente e antropologicamente. la “tenuta” dell’#architettura costituzionale della “casa comune” europea e terrestre ...
- Una nota in memoria di #Galileo #Galilei e di #Immanuel #Kant...
- CULTURA E SOCIETA’. SE NEL “LONTANO” 1610, #GALILEO #GALILEI PUBBLICA IL SUO “#MESSAGGERO #CELESTE” (“SIDEREUS NUNCIUS”), nel non troppo “recente” 1964, il 24 ottobre, nel secondo anno del suo Pontificato, papa Paolo VI, con la “Lettera apostolica”, intitolata “PACIS NUNTIUS” (“MESSAGGERO DI PACE”), proclama SAN BENEDETTO, PATRONO D’#EUROPA....
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- CREATIVITÀ, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, E ANTROPOLOGIA. Una nota in memoria di Ester Boserup14 marzo 2025, di Federico La Sala
SCRITTURA E SOCIETÀ: CREATIVITÀ, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, E ANTROPOLOGIA.
- In memoria di Ester Boserup (1910 -1999)
A PARTIRE DALL’ALFABETO, DALL’ALFA E DALL’OMEGA. Se consideriamo che già #Democrito era riuscito (non solo a #ridere, ma anche) a concepire una #cosmologia fondata su atomi-lettere e, quindi, la possibilità di costruire una macchina che potesse "rac-contare" automatica-mente la "storia del cosmo", o, che è lo stesso, che un giorno fosse facile ottenere esatte mappe del cielo del passato, questo ci dice che abbiamo portato avanti un programma "scientifico", imbozzolato nelle coordinate di un vecchio "#storytelling" cosmoteandrico. Aveva ragione #Whitehead (con #BertrandRussell, autore dei "#Principia #Mathematica"): "Tutta la storia della filosofia occidentale non è che una serie di note a margine su #Platone".
Se questo è, che fare, oggi, se non andare oltre l’antico programma, codificato nella "macchina" di "scrittura" della #tragedia, e portarsi fuori dal rapporto sociale di produzione "cinematografico" platonico?
La narrazione di un "mondo come volontà e rappresentazione" cosmoteandrica di un #Autore #Sovrano, a tutti i livelli, è finita, e, se non si vuole restare asfissiati nella sua "#caverna", non si può non seguire #DanteAlighieri e cercare di ritrovare la diritta via della #commedia!
LA PRODUZIONE DEL GRANO (ARATURA, SEMINAGIONE, SARCHIATURA, E TREBBIATURA) E IL "RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE" ("PRENDETE E MANGIATE"). Considerato che la nascita dell’#agricoltura e l’invenzione dell’#aratro "camminano insieme" e, ancora, che la stessa "direzione di scrittura dei Greci fu dapprima bustrofedica (cioè con una direzione alterna: una riga da destra verso sinistra e la successiva da sinistra verso destra, come il tracciato che un aratro trascinato da un bue disegna sul campo) e in seguito essa divenne solamente destrorsa, cioè da sinistra verso destra" (cfr. Francesco De Renzo, "Alfabeto", Treccani, 2005), è bene ricordare lo stravolgimento epocale prodotto dall’aratro nella storia dell’eco-nomia e dell’ecologia (nella "#casa" degli esseri umani):
- "Due grandi rivoluzioni: la nascita dell’agricoltura e l’invenzione dell’aratro. [...] L’uomo primitivo usava bastoni per forare il terreno e apporvi il #seme, in seguito modificò lo strumento per creare zappette che erano inefficienti nel garantire la preparazione del #letto di #semina. Pertanto l’invenzione dell’aratro, che ha luogo in Mesopotamia nel IV millennio a.C. ad opera dei Sumeri, è un evento rivoluzionario perché aumenta in modo rilevante la produttività dell’agricoltura consentendo la creazione di quelle eccedenze di cibo che sono alla base della genesi di società complesse basate sulla #divisione del lavoro. L’aratura è una pratica antica, il poeta latino #Virgilio lo considerava “lavoro dell’uomo e dei buoi in grado di rivoltare la #terra” [...]" (SDF Archivio Storico).
- NOTE:
- "SAPERE AUDE!" (KANT): UNA “NOTA” DI “RISCHIARAMENTO” SUI “RAPPORTI SOCIALI DI PRODUZIONE”, SULL’#ECONOMIA POLITICA, SULLA #STORIA, E SULL’ #ANTROPOLOGIA ...
- “Pioniere. #Ester Boserup e il ruolo delle #donne in #agricoltura:
- [...] Nel 1970 pubblica il suo Woman’s role in economic development, quasi un manifesto per ciò che diventerà il programma Women in development (Wid) delle Nazioni Unite. #Boserup descrive per i paesi in via di sviluppo un sistema di produzione agricolo in cui gradualmente le donne passano da sistemi di produzione autogestiti che le vede economicamente indipendenti, a sistemi all’europea in cui finiscono con l’essere alle dipendenze dei coniugi, senza essere retribuite. L’attacco nei confronti dei colonizzatori europei è diretto e senza mezzi termini. [...]” (Marcella Corsi, “inGenere.it”, 02 Agosto 2016).
- AGRICOLTURA, STORIA, E SOCIETA’: "LA CAMPAGNA APPENA IERI". La #sarchiatura del #grano. (Fbook, 11 marzo 2025).
- ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA CRITICA: LA RIVOLUZIONE COPERNICANA, IN #ASTRONOMIA (#COPERNICO, 1543) E IN #ANATOMIA (#VALVERDE, 1560) E IL PERSISTERE DELLA "#AGRICOLTURA" DELLA #TRAGEDIA DELLA TRADIZIONE TEOLOGICO-POLITICA PLATONICO-COSTANTINIANA (NICEA, 325-2025).
- "I TESTICOLI DELLE DONNE: Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]": così inizia il cap.15 dell’Anatomia di #GiovanniValverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli delle donne” (p. 91).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- CON DANTE, OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’ANDROCENTRISMO "MAMMONICO" DELLA TRAGEDIA.10 marzo 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #STORIA D’#EUROPA (#8MARZO 2024 / #10MARZO 2025): RICORDANDO #DANTEALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA,
 RIPENSARE L’#UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia.
RIPENSARE L’#UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson) - e uscire dall’ orizzonte della #tragedia."DIVINA COMMEDIA": CON #DANTE (#25MARZO 2025), OLTRE #VERSAILLES E OLTRE L’ #ANDROCENTRISMO DI NAPOLEONE: LA #FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-#MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO "MAMMONICO" DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- DANTE ALIGHIERI, CON ORAZIO E KANT ("SÀPERE AUDE!"). Dantedì, #25marzo 2025.21 febbraio 2025, di Federico La Sala
DANTE ALIGHIERI, CON ORAZIO E KANT ("SÀPERE AUDE!"): L’AMORE, "CHE MOVE IL SOLE, E LE ALTRE STELLE", IL LIBERO ARBITRIO, E LA LEGGE MORALE (IL "TU DEVI"). *
- Dantedì, #25marzo 2025
DIVINA COMMEDIA. Il verso «Amor, ch’a nullo amato amar perdona» (Inf., V, 103), pronunciato da Francesca nell’inferno in cui con Paolo è precipitata (e si trova ancora vivo lo stesso #Dante), a ben riflettere, è un filo che conduce all’uscita del labirinto del #destino e della #necessità e restituisce a ogni essere umano la coscienza del libero arbitrio (Purg. XVIII, vv. 70-72): detto in altro modo, è la formulazione del principio che richiama l’#imperativo #categorico concepito da Kant (in ripresa del #Logos mediterraneo di #Eraclito di #Efeso). Il "Tu devi" amare, al fondo (e al fondamento) di ogni essere "che è amato", "che è stato amato", permette di capire antropologicamente come e perché non possa essere perdonato chi non risponda all’Amore ("che ama") e, al contempo, come e perché il "Regnum celorum vïolenza pate" e "la divina volontate" sia vinta "da caldo amore e da viva speranza: / non a guisa che l’omo a l’om sobranza, /ma vince lei perché vuole esser vinta, / e, vinta, vince con sua beninanza."(Par., XX, 94-99).
* SUL TEMA, mi sia lecito, si cfr. "KANT, FREUD, E LA BANALITA’ DEL MALE".
- NOTE:
- TEOLOGIA #ANTROPOLOGIA ED #ECONOMIAPOLITICA.... SULLA "BERLINISCHE MONATSSCHRIFT", NEL 1784, SI ’DISCUTE’ INTORNO A "L’UOMO E’ CIO’ CHE MANGIA" (FRIEDRICH #GEDIKE) E, ALLA DOMANDA SU "CHE COSA E’ L’ILLUMINISMO?", IMMANUEL #KANT ’RISPONDE’ CON LE PAROLE DI ORAZIO E NE FA UN #MOTTO: "SÀPERE AUDE!" - UN "A...BBI...CCI" SUL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA #FACOLTÀ DI #GIUDIZIO...
- COSMOLOGIA E #ANTROPOLOGIA: "AMOR, CHE A NULLO AMATO AMAR PERDONA" (#DanteAlighieri, #Inferno, V, 103) #Dantedì, #25marzo 2025). Riflettendo criticamente , sulle abitudine "cavernicola" che "abbiamo bisogno di amici e soprattutto di nemici per avere una ragione per vivere!", si può ben comprendere e condividere la sollecitazione antropologica di Rocco #Scotellaro a finirla con questo "lavoro interminabile" da "infaticabili talpe" di un presente "preistorico" e, finalmente, capire il legame tra il Cielo e la Terra: "Pape Sàtan, pape Sàtan aleppe!" (Inf., VII, 1). Forse, oggi, è proprio il caso e il tempo di ri-#leggere insieme "il #nomedellarosa" e la "#divina #commedia", il lavoro di #UmbertoEco e l’#Opera di #Dante, e, infine, riconoscer-si come figli e figlie di quello stesso "amor che move il sole e le altre stelle" (#Dantedì, #25marzo 2025).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA (OLTRE LA TRAGEDIA): "AMOR, CHE A NULLO AMATO AMAR PERDONA".20 febbraio 2025, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA: "AMOR, CHE A NULLO AMATO AMAR PERDONA" (#Dante Alighieri, #Inferno, V, 103).
- Un omaggio alla memoria di Rocco Scotellaro e di Umberto Eco
Riflettendo criticamente sulla abitudine "cavernicola" che ancora "abbiamo bisogno di amici e soprattutto di nemici per avere una ragione per vivere!", non è possibile comprendere e condividere la sollecitazione antropologica di Rocco #Scotellaro a finirla con questo "lavoro interminabile" da "infaticabili talpe" di un presente "preistorico" e, finalmente, capire il legame tra il Cielo e la Terra?!
"Pape Sàtan, pape Sàtan aleppe!" (Inf., VII, 1). Forse, #oggi, è proprio il caso e il #tempo di ri-leggere insieme "il #nome della rosa" e la "#divina #commedia", il lavoro di Umberto Eco e l’Opera di Dante Alighieri, e, infine, riconoscer-si come figli e figlie di quello stesso "amor che move il sole e le altre stelle" (#Dante, Par. XXXIII, 145).
#Dantedì, #25marzo 2025.
- NOTA:
- SUL FILO DELLA COMMEDIA E DEL "COMICO" (AL DI LA’ DELLA TRAGEDIA E DEL "TRAGICO"). A teatro, un "invito" al Teatro alla Scala.
 NOTIZIA DEL #19Maggio2023 (Connessi all’Opera): "Il nome della rosa: la nuova opera di Francesco Filidei per la Scala. In scena nel 2025".
NOTIZIA DEL #19Maggio2023 (Connessi all’Opera): "Il nome della rosa: la nuova opera di Francesco Filidei per la Scala. In scena nel 2025".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- SAPERE AUDE!"(KANT, 1784). "Antropologia e civiltà nel pensiero di Giordano Bruno" (1968): "l’amore come metodo di conoscenza" (Fulvio Papi, 1971).17 febbraio 2025, di Federico La Sala
STORIA, FILOSOFIA, BIOLOGIA, E MEMORIA DI GIORDANO BRUNO (17 FEBBRAIO 2025): ANDREA CESALPINO E IL PROBLEMA DELLA NASCITA DEGLI ESSERI UMANI (DEL "COME NASCONO I BAMBINI").
DIVINA COMMEDIA. Una nota a margine del #Dantedì (#25marzo) e, in particolare, della indicazione "evangelica" e "comica" dell’ "amor che move il sole e le altre stelle" e dell’#amore come "metodo della conoscenza" (* )
- In memoria e in onore di William #Shakespeare, di #Enzo #Paci, #Elvio #Fachinelli, #FrancaOngaro #Basaglia, #Fulvio #Papi, e #Nuccio #Ordine....
Nel primo capitolo del libro "Antropologia e civiltà nel pensiero di Giordano Bruno" (La Nuova Italia, 1968; e, Liguori Editore, Napoli 2006, con una "Introduzione" di Nuccio Ordine) , intitolato "Il naturalismo divino", Fulvio Papi così scrive:
- "[...] Qualche anno prima del processo a #Bruno era stata pubblicata un’opera che ebbe certamente una certa risonanza nel tardo Rinascimento e anche dopo, i cinque libri delle Questioni peripatetiche [1571] di Andrea Cesalpino, nella quale il medico e botanico aristotelico si era impegnato a dimostrare che « Quaecunque ex semine fiunt, eadem fieri posse sine semine ». Naturalmente quest’indagine di biologia si presentava al lettore cautelata da molte prudenze che dovevano servire a tenere in ombra le conseguenze che si potevano trarre dal punto di vista teologico. [...] il Cesalpino non ebbe censure, ma forse vale la pena di fare caso al fatto che egli si trovava a Roma professore sovraordinario proprio nello stesso periodo in cui anche Bruno si trovava a Roma ma nelle carceri dell’Inquisizione °. La tesi centrale del Cesalpino è estremamente chiara: è possibile sostenere scientificamente, anche al di là del testo aristotelico, che vi sia nella natura un processo di generazione spontanea nel quale non vanno compresi soltanto gli animali superiori, ma l’uomo stesso [...]
 La generazione spontanea ha quindi in Bruno la sua estensione e
la sua metamorfosi. Ciò che viene a cadere è l’antropocentrismo di tipo teologico e ciò che nasce è l’uomo naturale. La « dignità dell’uomo» non si collega al suo poter divenire anima immortale nel grembo celeste, al suo essere creatura dall’indefinito statuto ontologico, al suo conoscersi come esistente che può conoscere la natura e indirizzare la propria vita seguendo solo la regola della intelligenza , ma ha la sua radice nell’essere frutto di un amore naturale che percorre tutta l’infinità del cosmo. Questo non vuoi dire che elementi delle altre tradizioni non convergano in questa antropologia, ma non bisogna dimenticare qual è l’essere dell’uomo perché solo partendo da qui si potranno comprendere i motivi che costituiscono il suo valore." (op. cit.).
La generazione spontanea ha quindi in Bruno la sua estensione e
la sua metamorfosi. Ciò che viene a cadere è l’antropocentrismo di tipo teologico e ciò che nasce è l’uomo naturale. La « dignità dell’uomo» non si collega al suo poter divenire anima immortale nel grembo celeste, al suo essere creatura dall’indefinito statuto ontologico, al suo conoscersi come esistente che può conoscere la natura e indirizzare la propria vita seguendo solo la regola della intelligenza , ma ha la sua radice nell’essere frutto di un amore naturale che percorre tutta l’infinità del cosmo. Questo non vuoi dire che elementi delle altre tradizioni non convergano in questa antropologia, ma non bisogna dimenticare qual è l’essere dell’uomo perché solo partendo da qui si potranno comprendere i motivi che costituiscono il suo valore." (op. cit.).
- NOTE:
- "DITELO" CON LE PIANTE ("CAESALPINIA PULCHERRIMA"). #ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA E #BOTANICA. RIPRENDERE IL FILO DEL #RINASCIMENTO E DELLA #RIVOLUZIONESCIENTIFICA. Un omaggio alla #memoria di Andrea Cesalpino (e al suo libro "De Plantis", 1583).
 ANDROCENTRISMO, #GEOCENTRISMO, ED #ELIOCENTRISMO: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA...
ANDROCENTRISMO, #GEOCENTRISMO, ED #ELIOCENTRISMO: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA...
 ANDROCENTRISMO, #GEOCENTRISMO, ED #ELIOCENTRISMO: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA...
ANDROCENTRISMO, #GEOCENTRISMO, ED #ELIOCENTRISMO: TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA... -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---AL DI LA’ DEL PLATONISMO: SHAKESPEARE, CON DANTE E GIORDANO BRUNO, NELL’ANALISI DELLA FIGURA DI "GIULIO CESARE".15 febbraio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA E FILOLOGIA DELLA TRADIZIONE CULTURALE EUROPEA: CON SHAKESPEARE (DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO), PER UNA ANALISI CRITICA DEL"CESARICIDIO" E UNA COMPRENSIONE ANTROPOLOGICA DELLA #MONARCHIA DEI "#DUE SOLI" ("DIVINA COMMEDIA").
- Una nota intorno al tema del "Giulio Cesare" (e dell’ "Amleto").
CHE NELLA MODALITA’ IN CUI SHAKESPEARE PRESENTA LA "RESA" DI BRUTO ALLE ARGOMENTAZIONI DI #CASSIO (ALLA "SOCRATE") PER COINVOLGERLO (COME UN "ALCIBIADE") NELL’AVVENTURA DEL "CESARICIDIO", IN CUI APPARE evidente il rinvio critico al "gioco" narcisistico del guardarsi nell’occhio dell’altro per conoscere sé stesso del dialogo di #Platone ("Alcibiade primo", 132c - 133b ), è già ben chiaro che egli pensi al di là del #platonismo e del #paolinismo storico:
"BRUTO
 No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso
No, Cassio; perché l’occhio non vede se stesso
 se non di riflesso, attraverso altri oggetti.
se non di riflesso, attraverso altri oggetti.
 CASSIO
CASSIO
 È così;
È così;
 e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia
e ci si rammarica molto, Bruto, che tu non abbia
 specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore
specchi che volgano ai tuoi occhi il tuo valore
 nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine
nascosto, così che tu possa vedere la tua immagine
 riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione
riflessa. Ho sentito molte persone di alta reputazione
 qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -
qui a Roma - eccetto l’immortale Cesare -
 che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo
che, parlando di Bruto, e gemendo sotto il giogo
 di questa epoca, hanno espresso il desiderio
di questa epoca, hanno espresso il desiderio
 che il nobile Bruto abbia occhi.
che il nobile Bruto abbia occhi.
 BRUTO
BRUTO
 In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,
In quali pericoli vorresti spingermi, Cassio,
 invitandomi a cercare in me stesso
invitandomi a cercare in me stesso
 quello che in me non c’è?
quello che in me non c’è?
 CASSIO
CASSIO
 Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.
Per questo, caro Bruto, preparati ad ascoltare.
 E poiché tu sai di non poterti vedere bene
E poiché tu sai di non poterti vedere bene
 se non per riflesso, io, il tuo specchio,
se non per riflesso, io, il tuo specchio,
 rivelerò con discrezione a te stesso
rivelerò con discrezione a te stesso
 quello che di te stesso tu ancora non conosci.
quello che di te stesso tu ancora non conosci.
 E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.
E non essere sospettoso con me, gentile Bruto.
 Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo
Se io fossi un buffone qualsiasi, o fossi avvezzo
 a svilire con volgari giuramenti il mio affetto
a svilire con volgari giuramenti il mio affetto
 al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta
al primo venuto che mi assicuri il suo; se ti risulta
 che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte
che scodinzolo con le persone e prima le abbraccio forte
 e poi le calunnio; o se ti risulta
e poi le calunnio; o se ti risulta
 che, alle feste, io mi professo amico
che, alle feste, io mi professo amico
 di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "
di tutta la marmaglia, allora ritienimi pericoloso. "
 ("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).
("Giulio Cesare," Atto I, Scena 2).Shakespeare, nel solco e sul filo della lezione di Dante e di Bruno, sollecita la riflessione sul legame antropologico-politico e teologico dei "due soli" della "Monarchia" di Dante, e delle "#Tre corone" dello "Spaccio della bestia trionfante" di Giordano Bruno: sotto la spinta della #RiformaProtestante (1517) e Anglicana (1534) e della #Rivoluzionescientitica (#Copernico, 1543), egli insegna a "vedere" nella figura di "Giulio Cesare" (e di "Amleto") la unità e la unificazione - nelle mani e nella testa - non solo del sovrano ("cristiano") o della sovrana ("cristiana") ma di ogni "cristiano" e "cristiana", di ogni "cittadino" e di ogni "cittadina", del potere sia politico ("#sovranità universale") che religioso ("#sacerdotalità universale"): "Sàpere aude!" (#Kant, 1784).
#Dantedì, #25marzo 2025
- NOTA:
- PER USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA #COSMOTEANDRIA PLATONICA, E, AL CONTEMPO, DA UNA CAPACITA’ DI “#LETTURA” DIMEZZATA DELLA REALTA’ E UNA PARZIALE E ”#SPECULARE” #CONOSCENZA DI SE’, UN “INVITO” A RICONSIDERARE (ANCHE E ANCORA) LA SEGUENTE DISCUSSIONE TRA SOCRATE E ALCIBIADE ...
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ARCHEOLOGIA DEL "SAPERE" E ANTROPOLOGIA DELLA "LETTURA" (JESPER SVENBRO): UN "LECTOR IN FABULA" PER PORTAR-SI OLTRE LA TRAGEDIA.14 febbraio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA DEL "SAPERE" E ANTROPOLOGIA DELLA "LETTURA":
IL "LUPO NEL DISCORSO" DEL "FEDRO" DI #PLATONE, LA "VOLPE E LA MASCHERA TRAGICA" NELLE "FAVOLE" DI #ESOPO E DI #FEDRO, E IL "CANTO DEL #CAPRO" (LA NASCITA DELLA TRAGEDIA).
UN "LECTOR IN FABULA" PER PORTAR-SI OLTRE LA TRAGEDIA (DEL "MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE" PLATONICO ) E LIBERARE SOCRATE DALLA APOLOGIA DELLA RETORICA ("CAVERNA") DEL PLATONISMO ("SERVO-PADRONE") E RIPRENDERE LA SMARRITA "#DIRITTA VIA" DELLA #COMMEDIA (#DANTE ALIGHIERI).
"IL LUPO E L’AGNELLO". NEL "FEDRO" DI PLATONE, a conclusione del suo primo intervento, Socrate dice parole fortemente critiche contro il caso di un filosofo-sofista che pretenda di "leggere" (o di essere una "persona che vuole amare", essere un "amante", un "#erastès") un "libro" (una "persona che vuole essere amata", un "amato", un "#eròmenos") interpretandolo egoisticamente: "Dunque o ragazzo mio, devi comprendere e convincerti che l’amicizia di un innamorato non nasce da affetto, ma è fame che cerca di saziarsi, e che come i lupi amano gli agnelli, così gli amanti adorano il fanciullo" ("Fedro", 241 d: "ὡς λύκοι ἄρνας ἀγαπῶσιν, ὣς παῖδα φιλοῦσιν ἐρασταί").
Che cosa questa considerazione "esopica" ed "esotica" dice? Non, forse, che, dopo i famosi "venticinque secoli" di "letargo", calcolati da Dante (Par. XXXIII, 94), l’umanità è ancora "bloccata" nell’orizzonte antropologico di un "compromesso olimpico" che non è né un #patriarcato né un #matriarcato, ma solo una naturalistica alleanza "edipica" (zoppa e cieca, sia dal lato femminile sia maschile)?
Benché Platone e Socrate e tutta la società greca avesse già acquisito consapevolezza che "comportarsi da filosofi" significava, come già #Eraclito e #Parmenide avevano ben chiarito, seguire il "Logos" ed essere pari di fronte alla "Legge", dopo millenni, si vorrebbe sentire anche un suono di festa e di liberazione dal giogo e dal gioco del "servo-padrone", ma all’orecchie continua a giungere solo il frastuono assordante del "canto del capro" ([quello a cui rinvia l’origine stessa della tragedia:https://www.treccani.it/enciclopedia/tragedia_(Enciclopedia-Italiana)/]), e nient’affatto e non ancora il suono del corno dell’ariete, quello di un vero giubileo - altro che quello di Bonifacio VIII.
"DE TE FABULA NARRATUR" (#ORAZIO). Esopo, e anche Fedro, forse, quando sollecitavano a riflettere sul caso della "volpe e la maschera" , a questo alludevano: a una tragedia di lunga durata. Una "volpe" (famosa per la sua capacità di sciogliere nodi e risolvere enigmi ), vistasi allo "specchio" di una bellissima "maschera tragica ["personam tragicam"], perse il suo stesso "cervello" (testa, intelligenza e astuzia) e divenne una onorata e famosa "persona", nello spettacolo fatale della tragedia della tradizione "giocastolaia" del platonismo occidentale (e planetario).
Dantedì, #25marzo 2025
- NOTE:
- ANTROPOLOGIA CULTURALE, #STORIA E #FILOLOGIA "BESTIALE" (L’#ODISSEA DI UN #MONTONE, CHE DA #ARIETE DIVENTA UN "#CAPRONE"): "IL #CAPROESPIATORIO". Una scheda editoriale del libro di #RenéGirard: "Dice Heidegger che ogni vero pensatore pensa un solo pensiero: nel caso di René Girard è quello del «capro espiatorio». In questo saggio egli prende per mano il lettore e, passo per passo, illumina in modo definitivo quel meccanismo della persecuzione e del sacrificio a cui già aveva dedicato La violenza e il sacro. Ed è impossibile sottrarsi alla luce cruda e netta che in queste pagine viene gettata su alcuni temi che per forza ci riguardano tutti. In particolare, colpiranno per la loro radicale novità le interpretazioni di parabole ed episodi dei Vangeli, dove secondo Girard si compie quell’oscillazione decisiva per cui la vittima sacrificale non consente più alla colpa che le viene attribuita, ma diventa l’innocente che come tale si rivendica: così il capro espiatorio si trasforma nell’agnello di Dio.".
- DIVINA COMMEDIA (#Dantedì, #25marzo 2025). #Beatrice (Pd. XXIV) chiede a #SanPietro di verificare se #Dante ha capito la differenza tra l’#Ecce #Homo dell’#antropologia (#PonzioPilato: gr. «idou ho #anthropos») e il #vir dell’#andrologia di #SanPaolo (#capo della #donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ]: 1Cor 11,1-3). A quanto pare la #filologia è ancora al servizio di #Platone che della #Parola e dell’#Amore (#14febbraio 2025).
- STORIA #FILOSOFIA E #LETTERATURA. "Phrasikleia. Antropologia della lettura nella Grecia antica" (di #Jesper Svenbro, La Vita Felice, 2024): "[...] Questo saggio fondamentale, scritto nel 1988, ricostruisce la storia della lettura nella Grecia antica a partire dalle parole usate per designarla, e si domanda come sia nata la lettura nel mondo greco e quale sia stata la sua funzione. Perché nella lingua greca c’è un verbo che significa contemporaneamente “leggere” e “avere rapporti sessuali”? Quale rapporto si stabilisce tra lo scrittore e il lettore? Le risposte che Svenbro desume dalla sua indagine cambiano radicalmente la visione della lettura e del suo rapporto con la scrittura a cui siamo abituati.").
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- PSICOANALISI E FILOLOGIA:"I SIMBOLI DELLA TRASFORMAZIONE" (SULLA "STRADA DI DAMASCO"). Una nota sul "coraggio di trasformarsi" (di Romeo Pulsoni).10 febbraio 2025, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E FILOLOGIA: COME JUNG DIVENNE JUNG: LA ROTTURA TEORICA CON FREUD (1912), "I SIMBOLI DELLA TRASFORMAZIONE" (SULLA "STRADA DI DAMASCO"), E IL PROBLEMA DI "NICODEMO O DELLA NASCITA" (ENZO PACI: "COME NASCONO I BAMBINI"). *
- In memoria di Giovanni Bollea
"SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784). Un omaggio a Romeo Pulsoni: una nota a margine del suo "Il coraggio di trasformarsi" ("Insula Europea", 12 Gennaio 2025):
"[...] arduo e forse impossibile per me commentare “i simboli della trasformazione" in C. G. Jung, e nello stesso tempo cercare di demarcare quello che a mio parere è fondamentale per discernere il culturale dal terapeutico e dallo spirituale e cioè la differenza tra il cambiamento tra la trasformazione e la trasfigurazione.
 Jung intende il processo di auto-realizzazione come un continuo cammino di trasformazione. La meta del processo di trasformazione consiste nell’unificazione degli opposti, nell’autorealizzazione dell’uomo. [...] Il contrasto di fondo in cui si trova l’uomo è la tensione tra spirito e istinto. [...] La trasformazione degli istinti avviene dunque, secondo Jung, a causa dell’attivazione dell’archetipo: ma gli archetipi vengono attivati tramite riti e simboli, e portati alla conoscenza. Jung chiama i simboli “trasformatori”. Come una centrale di energia idrica trasforma la pressione dell’acqua in energia elettrica, così i simboli trasformano l’energia biologica in energia spirituale. [...]
Jung intende il processo di auto-realizzazione come un continuo cammino di trasformazione. La meta del processo di trasformazione consiste nell’unificazione degli opposti, nell’autorealizzazione dell’uomo. [...] Il contrasto di fondo in cui si trova l’uomo è la tensione tra spirito e istinto. [...] La trasformazione degli istinti avviene dunque, secondo Jung, a causa dell’attivazione dell’archetipo: ma gli archetipi vengono attivati tramite riti e simboli, e portati alla conoscenza. Jung chiama i simboli “trasformatori”. Come una centrale di energia idrica trasforma la pressione dell’acqua in energia elettrica, così i simboli trasformano l’energia biologica in energia spirituale. [...]
 Per il cristiano il più importante simbolo della trasformazione è l’eucarestia. Jung chiama la Santa Messa “rito del processo di individuazione (...) il suo compito è quello di trasformare l’anima dell’uomo empirico, che è solo una parte di esso, nella sua totalità, che si esprime in Cristo” (volume XI, p. 262: Il simbolo della trasformazione nella messa). [...]
Per il cristiano il più importante simbolo della trasformazione è l’eucarestia. Jung chiama la Santa Messa “rito del processo di individuazione (...) il suo compito è quello di trasformare l’anima dell’uomo empirico, che è solo una parte di esso, nella sua totalità, che si esprime in Cristo” (volume XI, p. 262: Il simbolo della trasformazione nella messa). [...]
 La trasformazione dell’uomo inizia nel suo subconscio. Spesso è una situazione difficile a costringerlo a occuparsi del subconscio; sovente sono archetipi che di colpo appaiono nei suoi sogni o che incontra nei riti della sua fede o nella lettura. [...]
La trasformazione dell’uomo inizia nel suo subconscio. Spesso è una situazione difficile a costringerlo a occuparsi del subconscio; sovente sono archetipi che di colpo appaiono nei suoi sogni o che incontra nei riti della sua fede o nella lettura. [...]
 La caduta da cavallo sulla via di Damasco provoca il cambiamento, il percorso successivo lungo dolce e soave sono la trasformazione, l’unione del subconscio al conscio. [....]
La caduta da cavallo sulla via di Damasco provoca il cambiamento, il percorso successivo lungo dolce e soave sono la trasformazione, l’unione del subconscio al conscio. [....]
 La grande aspirazione degli uomini è la trasformazione dell’umano nel divino, del mortale nell’immortale. La via della trasformazione consiste in varie iniziazioni o riti che cambiano sempre più la figura interiore degli iniziati, anche se, come nel caso di Nicodemo, sono domandati sconti. [...]" (Romeo Pulsoni, op. cit.).
La grande aspirazione degli uomini è la trasformazione dell’umano nel divino, del mortale nell’immortale. La via della trasformazione consiste in varie iniziazioni o riti che cambiano sempre più la figura interiore degli iniziati, anche se, come nel caso di Nicodemo, sono domandati sconti. [...]" (Romeo Pulsoni, op. cit.).* http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4365#forum3185426.
- NOTE:
- PLATONE E NOI, #OGGI (*): "IL #COLTELLO E LO #STILO" E IL "#CONCETTO". UNA RIFLESSIONE INTORNO A TEMI DI #ARCHEOLOGIA E #ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024) E DI #COSMOTEANDRIA PLATONICA, PAOLINA ED HEGELIANA.... COME NASCONO I #BAMBINI, COME NASCONO LE #IDEE, COME NASCONO I #SOGNI?.
- ANTROPOLOGIA #STORIA E #FILOLOGIA: #PAOLINISMO E #MESSAGGIOEVANGELICO. Di Paolo di Tarso, definito "apostolo delle genti", forse, non è bene e tempo (anche #grazie alle "acquisizioni" delle ricerche di #Jung e di #Freud) di riconsiderare le sue "dichiarazioni", sul fatto di aver "ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso" (1 Cor. 11, 23ss.), e le sue "sollecitazioni" a seguirlo come se fosse Cristo in persona: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?! Se non ora, quando? Non è tempo (ancora) di svegliarsi dal "letargo" (Dante Alighieri, Par. XXXIII, 94)?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL "SÀPERE AUDE" DI ORAZIO E KANT E IL CAMMINO DI NIETZSCHE, OLTRE L’ORIZZONTE DI SCHOPENHAUER.3 febbraio 2025, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA DEL #SAPERE, PSICOANALISI, E ANTROPOLOGIA: IL "SÀPERE AUDE" DI ORAZIO E KANT E IL CAMMINO DI NIETZSCHE, OLTRE L’ORIZZONTE DI SCHOPENHAUER, CON #MACH E #FREUD...
KANT (1789) E #NIETZSCHE (1889): IL "#CREPUSCOLO DEGLI #IDOLI". Da #Orazio di #Venosa, a Kant di #Koenigsberg: "#Illuminismo (#Aufklärung) è la liberazione dell’uomo dallo stato volontario di minorità intellettuale. Dico minorità intellettuale, l’incapacità di servirsi dell’intelletto senza la guida d’un altro. Volontaria è questa minorità quando la causa non sta nella mancanza d’intelletto, ma nella mancanza di decisione e di coraggio nel farne uso senza la guida di altri. #Sapere #aude! Abbi il #coraggio di servirti del tuo proprio intelletto!" Questo è il motto dell’illuminismo. [...]" (Immanuel Kant, “Risposta alla domanda: Che cosa è l’illuminismo?”. 1789).
LA "PSICOLOGIA DI MASSA" DI SCHOPENHAUER E L’ "ECCE HOMO" DI NIETZSCHE. #Schopenhauer, in una sua frase, invita a riflettere sul fatto che "«Ciò che il gregge odia di più è chi la pensa diversamente; non è tanto l’opinione in sé, ma l’audacia di pensare da sé, qualcosa che non sanno fare». La frase, come si sa, è quasi un proverbio (un ritornello dei "sapientissimi di tutti i tempi"), ma qui, Schopenhauer fa il "furbo" e incorpora nel suo "pensiero", come si può ben capire, il coraggio dei maestri Orazio e Kant, e cerca di proporsi come maestro dei maestri delle "pecore"!
Nietzsche, infatti, pur riconoscendo qualità e potenzialità straordinarie allo "Schopenhauer come #educatore" (la terza delle sue "Considerazioni Inattuali", 1874), capisce la famosa"antifona" (così anche con #Wagner) e prosegue il suo cammino, in #autonomia (oltre "il mondo come #volontà e #rappresentazione" del suo "maestro"), con Kant: "#Ecce #Homo. Come si diventa ciò che si è" (1888).
"BUCHI BIANCHI" (Carlo Rovelli, 2023). Con #Shakespeare, e come #Amleto, egli prosegue la sua strada e cerca di chiarirsi le idee su #Edipo, #Prometeo, #Arianna, il #Labirinto, "la #nascita della #tragedia (1872), #Dioniso e il #Crocifisso, e sul "Crepuscolo degli idoli" (1889). Egli, a partire da "#Aurora" (1881) e dalla "#Gaia #Scienza" (1882), ha camminato con Kant, Friedrich A. #Lange, Hermann von #Helmholtz, Ernst #Mach, e #DanteAlighieri (#Dantedì, #25marzo 2025).
- Nota:
- SCHOPENHAUER E L’ APOTEOSI DEL PLATONISMO E DEL PAOLINISMO. DAGLI "AFORISMI SULLA SAGGEZZA" del "Maestro" del "Mondo come volontà e rappresentazione", una "citazione" dal capitolo "II. Di ciò che si è:
- Noi abbiamo già conosciuto in modo generale che ciò che si è contribuisce alla nostra felicità più di ciò che si ha o di ciò che si rappresenta. La cosa principale è sempre ciò che un uomo è, in conseguenza ciò che possede in lui stesso, perocchè la sua individualità l’accompagna dappertutto e dovunque, e colora di sua tinta tutti gli avvenimenti della vita. In ogni cosa, ed in ogni occasione quello che a bella prima gli fa impressione è lui stesso. Questo è già vero per i piaceri materiali, e, a più forte ragione, per quelli dell’anima. Così l’espressione inglese: To enjoy one’s self è molto ben trovata; non si dice mica in inglese: Parigi gli piace, si dice invece: egli si piace a Parigi (He enjoys himself at Paris)". (cfr. A. Schopenhauer, "Aforismi sulla saggezza" ).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- UNA NOTA SUL LEGGERE UNA ISCRIZIONE (COME QUELLA DI DELFI) E IL “LEGGERSI” NEGLI OCCHI (TRA SOCRATE E ALCIBIADE).2 febbraio 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, STORIA, E “PSICOANALISI”: QUALE RAPPORTO TRA IL LEGGERE UNA ISCRIZIONE (COME QUELLA DI DELFI) E IL “LEGGERSI” NEGLI OCCHI, AI FINI DELLA CONOSCENZA DI SE’ (NELL’ANTICA GRECIA)?
PER USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA COSMOTEANDRIA PLATONICA, E, AL CONTEMPO, DA UNA CAPACITA’ DI “LETTURA” DIMEZZATA DELLA REALTA’ E UNA PARZIALE E “”SPECULARE” CONOSCENZA DI SE’,
UN “INVITO” A RICONSIDERARE (ANCHE E ANCORA) LA SEGUENTE DISCUSSIONE TRA SOCRATE E ALCIBIADE (Platone, “Alcibiade primo”, XXVII 132c - XXVIII 133b):
SOCR. In qual modo potremmo conoscere il più chiaramente possibile la nostra anima? Giacché, con questa conoscenza, potremo evidentemente conoscere noi stessi. Per gli dèi! Comprendiamo bene quel giusto consiglio dell’iscrizione delfica ricordata ora?
ALC. Con quale intenzione lo dici, o Socrate?
SOCR. Ti dirò cosa sospetto che questa iscrizione ci voglia realmente consigliare. Perché si dà il caso che ad intenderla non vi siano molti esempi di confronto, tranne quello solo della vista.
ALC. Cosa vuoi dire con questo?
SOCR. Rifletti anche tu. Se l’iscrizione consigliasse l’occhio, come consiglia l’uomo, dicendo: “guarda te stesso”, in che modo e cosa penseremmo che voglia consigliare? Non forse a guardare verso qualcosa guardando la quale l’occhio fosse in grado di vedere se stesso?
ALC. Certo.
SOCR. Ecco: indaghiamo quale oggetto c’è che a guardarlo possiamo vedere lui e noi stessi.
ALC. È chiaro, Socrate, gli specchi e oggetti simili. SOCR. Esatto. Non c’è forse anche nell’occhio, con il quale vediamo, qualcosa dello stesso genere?
ALC. Certo.
SOCR. Hai osservato poi che a guardare qualcuno negli occhi si scorge il volto nell’occhio di chi sta di faccia, come in uno specchio, che noi chiamiamo pupilla, perché è quasi un’immagine di colui che la guarda.
ALC. È vero.
SOCR. Dunque se un occhio guarda un altro occhio e fissa la parte migliore dell’occhio con la quale anche vede, vedrà se stesso.
ALC. Evidentemente.
SOCR. Ma se l’occhio guarda un’altra parte del corpo umano o degli oggetti, ad eccezione di quella che ha simile natura, non vedrà se stesso.
ALC. È vero.
SOCR. Se allora un occhio vuol vedere se stesso, bisogna che fissi un occhio, e quella parte di questo in cui si trova la sua virtù visiva; e non è questa la vista?
ALC. Sì.
SOCR. Ora, caro Alcibiade, anche la psiche, se vuole conoscere se stessa, dovrà fissare una psiche [...]».
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL "DE BERYLLO" DI CUSANO, 1458) E L’ANTROPOLOGIA DELLA "DOTTA IGNORANZA". Una nota a margine del "Ritratto dei coniugi Arnolfini" del pittore fiammingo Jan van Eyck (1434).30 gennaio 2025, di Federico La Sala
"DOTTA IGNORANZA" (1440) E "DE BERYLLO" (1458).
Una nota a margine del "Ritratto dei coniugi Arnolfini" del pittore fiammingo Jan van Eyck (1434).
Arte, Antropologia, Filosofia e Scienza nello "Occhio ("Specchio") polifemico e tragico di Niccolò Cusano (il cardinale Nicola di Kues ).
"VEDERE COME IN UNO SPECCHIO, IN MANIERA CONFUSA" (1 Cor. XIII, 12). A ben analizzare l’opera il "Ritratto dei coniugi Arnolfini" del pittore fiammingo Jan van #Eyck, realizzato nel 1434 (come sollecita a fare Vincent De Luise , in "SPECULUM SINE MACULA: The Eye behind the Mirror in the Arnolfini Double Portrait"), il senso che emerge appare essere (come del resto è storicamente) una apologia della "dotta ignoranza" della tradizione socratica, una astuzia della cosmoteandria platonica e paolina (cfr. Cusano, "De Beryllo", i capp. XIV e XV), molto lontana dallo spirito della tradizione evangelica (e dall’ idea di "sacra famiglia" di memoria francescana), e, ovviamente, anche da una logica della ricerca scientifica antropologicamente fondata!
A mio parere, accogliendo il contributo di Vincent de Luise, si tratta storiograficamente di riconsiderare l’analisi di Scott Horton ("Cusano e Van Eyck: l’occhio dietro lo specchio") e "capovolgere" il senso della interpretazione del suo stesso lavoro.
Come, ad aprire gli occhi, ben aiuta a capire Johan Huizinga, siamo storicamente alla fine della "Prima #Rinascita" (Gioacchino da Fiore, Francesco di Assisi, e Dante Alighieri), all’ "Autunno del Medioevo" (1919), all’inizio dell’ inverno del cosiddetto "Rinascimento", avviato dallo "straordinario" programma teologico-politico di Filippo il Buono di Borgogna, con la sua fondazione dell’ordine del "Toson d’oro" (o, meglio, del "#Vitello d’oro"), ripreso e rilanciato poi "alla grande" da Massimiliano I d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero e CarloV d’Asburgo.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- VITA E FILOSOFIA: PER UN’ALTRA CONCEZIONE DEL CONCETTO (E DEL CONCEPITO).19 gennaio 2025, di Federico La Sala
VITA E FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E TEOLOGIA-POLITICA:
PER UN’ALTRA CONCEZIONE DEL CONCETTO (E DEL CONCEPITO).
UNA "VECCHIA" SOLLECITAZIONE AD USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA E DEL PLATONISMO. "Sàpere aude": riprendere il "programma" di Kant, e, con Helmholtz, orientarsi meglio nel pensiero e nell’azione...
- In memoria di Nelson Mandela, Enzo Paci, Fulvio Papi, e Franca Ongaro Basaglia, e Vincenzo Cappelletti... e un omaggio a Pietro Barbetta*
Ubuntu: una parola da e per non dimenticare.
 Una nota a margine della Lettera enciclica SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003):
Una nota a margine della Lettera enciclica SULL’ EUCARISTIA (del 17.04.2003):"[...] La storia sembra finita: la Chiesa non permette a Milingo di essere sposato . .. e Maria promette di seguirlo nella sua missione. Che peccato e che confusione! A questo punto credo che sia necessario e doveroso mettere in evidenza il terreno e le radici da cui è nato e nasce lo scandalo. La questione ruota intorno alla parola-chiave padre o, se si vuole, abate (cfr. l’omonima voce del Dizionario filosofico di #Voltaire), e mette in gioco non tanto e solo la vita interna della Chiesa ma la libertà e la dignità di tutti gli uomini e di tutte le donne in carne ed ossa. Il cardinale Milingo è stato quello che è stato ed è quello che è, ma ora e in questo caso il suo Partito, quello dell’Uomo-Dio, se ha vinto un’altra battaglia, ha perso la faccia e la guerra. E per gli uomini dell’Apparato le parole di Voltaire saranno ancora e sempre più all’ordine del giorno: "badate che non venga il giorno della ragione".
[...] è da dire che è proprio dall’#Africa e, in particolare, dal #Sudafrica di Mandela, De Klerk e Tutu, che è venuta alla luce una grande novità - la fine dell’apartheid e la fondazione di una nuova repubblica democratica, e ci viene una bella indicazione. In occasione della giornata ONU alla memoria in onore dei milioni e milioni di esseri umani ridotti in schiavitù, Desmond Tutu ha ricordato a tutti e a tutte che nella lingua del Sudafrica hanno da sempre una parola-bussola per non perdersi nella disumanità e nella barbarie: ubuntu - le persone diventano persone attraverso altre persone. Forse vale la pena fissarla per sempre. Così sapremo orientarci sia nel pensiero sia nel mondo, ed evitare a noi stessi e a noi stesse come ai vari Milingo e alle varie Marie di vendere la propria anima, di rinnegare il rinnegamento della propria dignità di esseri umani, e costruire una società - come esortava don Milani - che sappia dire ai suoi giovani e alle sue giovani che sono tutti e tutte sovrani e sovrane o, che è lo stesso, figli e figlie del Dio di Maria e di Giuseppe.... non figli e figlie di Nessuno! Non cè alcuno che è sapiente o buono come Dio, così ha insegnato Socrate e così ha insegnato Gesù: perché continuare a confondere le idee e impedire il dialogo ... e l’eucaristia tra tutti gli esseri umani? ("Il dialogo.org", 30 aprile 2003)
* Pietro Barbetta: "Gilles Deleuze, matematiche dinamiche. Il testo di Andrea de Donato Morfogenesi del concetto. Matematica e stile a partire da Deleuze, immanenza e molteplicità, edito da Orthotes, fornisce un importante contributo per ripensare la matematica dal punto di vista filosofico. [...]
 A partire dal libro di de Donato, potremmo sostenere che i sistemi patologici sono sistemi assiomatici, come la geometria euclidea" (PietroBarbetta, "Gilles Deleuze, matematiche dinamiche", Doppiozero 1 dicembre 2024).
A partire dal libro di de Donato, potremmo sostenere che i sistemi patologici sono sistemi assiomatici, come la geometria euclidea" (PietroBarbetta, "Gilles Deleuze, matematiche dinamiche", Doppiozero 1 dicembre 2024).- NOTE:
- ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA E #MATEMATICA. "Gilles Deleuze, matematiche dinamiche:
 Il testo di Andrea F. de Donato #Morfogenesi del #concetto. Matematica e stile a partire da Deleuze, immanenza e molteplicità, edito da Orthotes, fornisce un importante contributo per ripensare la matematica dal punto di vista filosofico...." (Pietro Barbetta, Doppiozero, 1 dicembre 2024).
Il testo di Andrea F. de Donato #Morfogenesi del #concetto. Matematica e stile a partire da Deleuze, immanenza e molteplicità, edito da Orthotes, fornisce un importante contributo per ripensare la matematica dal punto di vista filosofico...." (Pietro Barbetta, Doppiozero, 1 dicembre 2024).
- ANTROPOLOGIA, LINGUISTICA, E COSTITUZIONE. Sui suoi interessi per il linguaggio, Gramsci così rispose a Tatiana Schucht (19 marzo 1927): «... che cosa potrebbe essere più "disinteressato" für ewig di ciò?» (Tullio De Mauro, 1979).
- VITAEFILOSOFIA, #ANTROPOLOGIA, #FILOLOGIA, E #TEOLOGIA-#POLITICA: PER UN’ALTRA CONCEZIONE DEL CONCETTO (E DEL #CONCEPITO), UNA "VECCHIA" SOLLECITAZIONE AD USCIRE DALL’#ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA E DEL PLATONISMO.
- "Sàpere aude": riprendere il "programma" di #Kant, e con #Helmholtz, #orientarsi meglio nel #pensiero e nell’#azione... [...] A partire dal libro di de Donato, potremmo sostenere che i sistemi patologici sono sistemi assiomatici, come la geometria euclidea" (Pietro Barbetta, "#Gilles Deleuze, matematiche dinamiche", #Doppiozero 1 dicembre 2024).
- FOTO ALLEGATA: LA PIRAMIDE "ANDROCENTRICA" RIPRESA DAL "SAPIENTE" (1510) DI BOVILLUS.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- MITO, STORIA, E ANTROPOLOGIA: A CHE GIOGO, CI SI AGGIOGA? CON JEAN-JACQUES ROUSSEAU A SCUOLA DI #CORAGGIO ("SAPERE AUDE!")3 gennaio 2025, di Federico La Sala
FILOLOGIA STORIA E ANTROPOLOGIA:
CON JEAN-JACQUES ROUSSEAU A SCUOLA DI #CORAGGIO ("#SAPERE #AUDE!"), DA "#GISELE PELICOT", PER UN #BUON 2025...
Una nota di commmento all’articolo di Nicoletta Vallorani ("Gisèle Pelicot. Il posto del coraggio", Le parole e le cose, 27 dicembre 2024).
- NOTE:
- QUALE #EUROPA PER UN #BUON 2025?: UNA STORIA DI LUNGA DURATA E UNA ORAZIANA SOLLECITAZIONE SUL "SAPERE AUDE!" (#KANT, #KOENIGSBERG, 1784; #KALININGRAD, 2024) DA RIPRENDERE....
- Critica dell’#economia politica, #storia, e #antropologia: "Pioniere. #Ester Boserup e il ruolo delle #donne in #agricoltura
 [...] Nel 1970 pubblica il suo Woman’s role in economic development, quasi un manifesto per ciò che diventerà il programma Women in development (Wid) delle Nazioni Unite.[3] Boserup descrive per i paesi in via di sviluppo un sistema di produzione agricolo in cui gradualmente le donne passano da sistemi di produzione autogestiti che le vede economicamente indipendenti, a sistemi all’europea in cui finiscono con l’essere alle dipendenze dei coniugi, senza essere retribuite. L’attacco nei confronti dei colonizzatori europei è diretto e senza mezzi termini. [...]" (Marcella Corsi, "inGenere", 02 Agosto 2016).
[...] Nel 1970 pubblica il suo Woman’s role in economic development, quasi un manifesto per ciò che diventerà il programma Women in development (Wid) delle Nazioni Unite.[3] Boserup descrive per i paesi in via di sviluppo un sistema di produzione agricolo in cui gradualmente le donne passano da sistemi di produzione autogestiti che le vede economicamente indipendenti, a sistemi all’europea in cui finiscono con l’essere alle dipendenze dei coniugi, senza essere retribuite. L’attacco nei confronti dei colonizzatori europei è diretto e senza mezzi termini. [...]" (Marcella Corsi, "inGenere", 02 Agosto 2016).
- ANTROPOLOGIA, #LETTERATURA, #ARCHEOLOGIA, E #PSICOANALISI (S. #FREUD, "#DISAGIO DELLA #CIVILTÀ", 1929). A che #giogo si continua ad #aggiogare?! La "#memoria" di una #denuncia della #infamia #originaria" , di un #tradimento strutturale della #fiducia di #lungadurata, "biblico"! (cfr. Lea Melandri).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ANTROPOLOGIA E ASTRONOMIA: L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI.28 dicembre 2024, di Federico La Sala
L’ALBERO DI NATALE NELL’EUROPA MODERNA E IL "SIDEREUS NUNCIUS" DI GALILEO GALILEI: LA PUNTA DI UN ICEBERG DELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE
UNA NOTA sulla considerazione che "Nella sua concezione moderna, l’albero di Natale casalingo sarebbe stato creato quasi casualmente da una nobildonna tedesca nel 1611, desiderosa di illuminare un angolo vuoto della casa, la duchessa di Brieg." (cfr. Elisa Chiari, "Albero di Natale, la vera storia dalle radici antiche a noi", "Famiglia cristiana", 18.12.2024 )
CULTURA E SOCIETA’. Tenendo conto di quanto sta succedendo nella società europea, a partire dalla #RiformaProtestante (1517), e dal "Sacco di Roma" dei lanzichenecchi al soldo dell’imperatore Carlo V (1527), dalla #Riforma #Anglicana (1534), dalla stampa dell’opera di #Astronomia di #Copernico (1543) e dell’opera di #Anatomia di #Vesalio (1543), dalla #Controriforma Cattolica (#ConciliodiTrento,1545-1563), e, ancora, dalla introduzione del #CalendarioGregoriano del 1582 (non accettato né dalla Germania e dall’Olanda fino al 1700, né dall’Inghilterra fino al 1752), e, al contempo, dall’attacco della cattolicissima "Invincibile Armada" spagnola di Filippo II all’Inghilterra di Regina Elisabetta I d’Inghilterra (1588), si può comprendere meglio (e subito) perché all’#Amleto di #Shakespeare non piaccia il "#presepe" della "Danimarca" cattolica, e, al contempo, nella Germania protestante si comincia a diffondere in occasione del Natale la tradizione dell’#albero, sia come critica della tradizione religiosa cattolico-spagnola sia come sollecitazione a ripensare all’albero del #Paradisoterrestre e anche a un rinnovato legame matrimoniale tra "#Adamo ed #Eva" (come già indicato e fatto da Lutero e da #EnricoVIII, padre della regina Elisabetta).
"SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610). Alla #luce di questa "contestualizzazione" relativa al diffondersi della tradizione dell’ Albero di Natale nei Paesi Protestanti, forse, è bene ricordare che l’Annuncio Sidereo (il "Sidereus Nuncius"), relativo alla "scoperta" della #Luna come la Terra e della #Terra come la Luna, di Galileo Galilei è del 1610 ed è salutato da #Keplero proprio nel 1611 con parole augurali che fanno tremare ancora oggi di "paura" tutta la teologia-politica cattolico-costantiniana dell’epoca: "Vicisti, Galilaee!" (Hai vinto, o Galileo!).
PIANETA TERRA: SPERANZA. Forse, oggi, alla fine del 2024, la navigazione nell’#oceano celeste (come da indicazione e sollecitazione dello stesso Keplero al Galileo, nella lettera del 1611) può riprendere.
#Buonanno, #Buon2025.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ARCHITETTURA E COMUNICAZIONE: MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO" (O, DIVERSAMENTE, L’INIZIO DEL "CONTRORINASCIMENTO").27 dicembre 2024, di Federico La Sala
CON "IL PANTHEON SUL PARTENONE", FATTO "SAN PIETRO DI ROMA" (VICTOR HUGO, 1831):
MICHELANGELO E IL TRAMONTO DEL "RINASCIMENTO" (O, DIVERSAMENTE, L’INIZIO DEL "CONTRORINASCIMENTO").
- In memoria di #Michelangelo Buonarroti, Marcel #Proust, e Walter #Benjamin
L’ ARCHITETTURA E IL LIBRO: L’INVENZIONE DELLA #STAMPA. Victor Hugo, in "Notre-Dame de Paris 1482", pubblicato nel 1831, in poche pagine sottolinea tutta l’importanza dell’#apertura di infiniti occhi, connessa al grande "occhio" che si apre nel #cielo culturale dell’#Europa #moderna con la invenzione di Gutenberg.
Nel cap. II del L. VII dell’opera, Hugo così inizia:
- "Le nostre lettrici ci scuseranno se ci fermiamo un momento per cercare quale potesse essere il pensiero che si celava sotto le enigmatiche parole dell’arcidiacono: Questo ucciderà quello. Il libro ucciderà l’edificio. A nostro avviso, quel pensiero aveva due facce. Era innanzitutto un pensiero da prete. Era il terrore del sacerdozio di fronte ad un elemento nuovo, la stampa. Era lo spavento e lo sbalordimento dell’uomo del santuario di fronte al torchio luminoso di Gutenberg. Erano la cattedra ed il manoscritto, la parola parlata e la parola scritta, che si allarmavano per la parola stampata [...].
- In effetti, dall’origine delle cose fino al quindicesimo secolo dell’era cristiana compreso, l’architettura è il grande libro dell’umanità, l’espressione principale dell’uomo ai suoi diversi stadi di sviluppo, sia come forza che come intelligenza.
- [...] Così, fino a Gutenberg, l’architettura è la scrittura principale, la scrittura universale. [...]
- [...] a partire dalla scoperta della stampa [...] a partire dal sedicesimo secolo, la malattia dell’architettura è visibile; essa ormai non esprime più in modo essenziale la società; si fa miserevolmente arte classica [...].
- È proprio questa decadenza che prende il nome di Rinascimento. È questo tramonto che noi scambiamo per un’aurora [...]
- Michelangelo, che fin dal sedicesimo secolo aveva senz’altro avvertito la sua morte, aveva avuto un’ultima idea, un’idea dettata dalla disperazione. Questo titano dell’arte aveva eretto il Pantheon sul Partenone e aveva fatto San Pietro di Roma. Morto Michelangelo, che fa questa miserabile architettura che sopravviveva a se stessa allo stato di spettro e di ombra? Prende San Pietro di Roma, lo ricalca, ne fa la parodia. È una mania. È una cosa pietosa. Ogni secolo ha il suo San Pietro di Roma; nel diciassettesimo secolo il tempio di Val-de-Grâce, nel diciottesimo Sainte-Geneviève. Ogni paese ha il suo San Pietro di Roma. Londra ha il suo. Pietroburgo ha il suo. Parigi ne ha due o tre. Testamento insignificante, ultimo vaneggiamento di una grande arte decrepita che rimbambisce prima di morire." (V. Hugo, cit.).
- Nota: "Cupola di San Pietro".
- NOTE:
- PIANETATERRA: UN #PANTHEON DA RIPENSARE E IL #SOLSTIZIO D’#INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "#TERRA" ALLA #LUCE DEL #SOLE... In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ....
- PER LA #PACEPERPETUA. ALLA #RICERCA DEL #TEMPO PERDUTO....
 MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
MICHELANGELO, PER UN RITRATTO A PROUST: UNA ILLUMINANTE INDICAZIONE DI WALTER BENJAMIN. Materiali sul tema ...
"Nel secolo scorso c’era a Grenoble un’osteria che si chiamava «Au temps perdu» (non so se ci sia ancora). Anche da Proust noi siamo avventori che sotto l’insegna oscillante varchiamo una soglia [...]".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "TERRA" ALLA LUCE DEL SOLE.22 dicembre 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA: UN PANTHEON DA RIPENSARE E IL SOLSTIZIO D’INVERNO. UNA TRACCIA PER UN "RIORIENTAMENTO GESTALTICO" E UNA "#SVOLTA_ANTROPOLOGICA": APRIRE LA "PORTA" DELLA "#TERRA" ALLA #LUCE DEL #SOLE...
- In memoria di Andrea #Vesalio, Niccolò #Copernico, #Galileo #Galilei ...
ARCHITETTURA ECOLOGIA FILOSOFIA E OCULISTICA. Una nota sull’#occhio del Pantheon:
"[...] L’Oculus è un’apertura nel soffitto della cupola, realizzata con un diametro di oltre 8 metri, e rappresenta l’unica fonte di luce naturale all’interno dell’edificio. La sua creazione risale al I secolo d.C., quando l’imperatore romano Adriano fece ristrutturare l’antico Pantheon, che originariamente risaliva al 1 a.C.
Questo misterioso occhio circolare non solo illumina con la luce del sole l’interno del Pantheon, ma ha anche una funzione simbolica e mistica. L’Oculus rappresenta una connessione tra l’edificio e il cielo, come se un raggio di luce divina scendesse in quel santuario dedicato agli dei.
Inoltre, l’Oculus è stato progettato in modo tale da favorire una perfetta distribuzione dei pesi della cupola, che ha contribuito alla straordinaria stabilità e durevolezza di questo monumento. La cupola è in cemento e la sua costruzione fu una straordinaria opera di ingegneria per l’epoca.
L’Oculus del Pantheon offre anche un affascinante spettacolo naturale durante i giorni di pioggia. La pioggia che entra dal foro forma un effetto suggestivo, simile ad una cascata rovesciata, creando un’atmosfera mistica all’interno del tempio. [...]" (cfr. Accademia Studio Italia, "Il misterioso occhio del Pantheon: un buco nel paradiso!").
- AUGURI PER UN BUON #NATALE2024 E UN #BUONANNO2025...
- Note:
- STORIAELETTERATURA #ANTROPOLOGIA E #FILOSOFIA: #SAPEREAUDE (#KANT)! CON #ULISSE E #DANTE, RIPRENDERE IL FILO DALL’OPERA DI ANDREA #VESALIO ("De humani corporis #fabrica, 1543) E DI NICCOLO’ #COPERNICO ("De revolutionibus orbium coelestium", 1543), DALLA RIVOLUZIONE IN #ANATOMIA E IN #ASTRONOMIA, DALLA "LOGICA" DEL "CHIASMA OTTICO".
- ECOLOGIA (#OIKOS - #LOGOS), #COSMOLOGIA, #ARCHITETTURA. Una "#Casa", come lo è per l’intera umanità, e tutti gli altri esseri viventi, il #pianeta "#Terra", concepita "senza porta e senza finestra" (da dove entra la luce e da dove esce il fumo?), diventa una #caverna alla #Polifemo (il #ciclope con uno e uno solo "occhio" , incapace di #visione "#binoculare" - ricordare le ricerche di #Helmholtz), e, infine, una #tomba per un morto (ricordare il luogo di #sepoltura per eccellenza, quello di Gesù, della tradizione evangelica). Da non dimenticare è il "fatto" che #Virgilio sa bene indicare a #DanteAlighieri "la diritta via" per uscire dalla "casa chiusa", riprendere il viaggio interrotto di #Ulisse ed #Enea, e, infine, proseguire la navigazione nell’#oceanoceleste (Keplero, 1611).
- STORIA DELLA #FILOSOFIA E #STORIOGRAFIA: L’#EUROPA, LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’#OCCIDENTE, E "IL #CREPUSCOLO DEGLI #IDOLI". La lezione di #Nietzsche: "[...] io amo perfino le chiese e i sepolcri degli dèi, ma quando, con l’#occhio suo puro, il #cielo penetra dai loro soffitti in rovina" (cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", #AntonioPellicani Editore, Roma 1991, p. 188).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- MAIEUTICA E FILOSOFIA. COME ARTEMIDE (DIANA DI EFESO), LA SORELLA DI APOLLO, VENNE "AGGIOGATA" AL CARRO DI UN "APOLLINEO" PLATONE, SOSTENUTO DA UN SOCRATE, CHE "GIOCAVA" A FARE L’OSTETRICO PER SOLI MASCHI.17 dicembre 2024, di Federico La Sala
MITOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E CRITICA DELLA "RAGIONE OLIMPICA":
RIPRENDERE IL FILO DA ARTEMIDE E DALLA "APOLOGIA" DI PLATONE DEL SOCRATE "LEVATRICE" E PORTARSI CON #DANTE E #VIRGILIO E #BEATRICE FUORI DALL’INFERNO...
- BUON #NATALE2024 E #BUONANNO 2025.
Una sollecitazione a riflettere (ancora e meglio) sulla teologia-politica della relazione uomini e donne nell’antica Grecia (#Eschilo, #Sofocle, ed #Euripide) e sul tema del #comenasconoibambini (ancora oggi, all’ordine del giorno).
COME ARTEMIDE (DIANA), LA SORELLA DI APOLLO, VENNE "AGGIOGATA" AL CARRO DELL’ANIMA DI UN "APOLLINEO" PLATONE, SOSTENUTO DA UN SOCRATE, CHE "GIOCAVA" A FARE (COME LA MADRE FENARETE, DIVENUTA STERILE, E LA STESSA #VERGINE ARTEMIDE) L’OSTETRICO PER SOLI MASCHI.
ARTE DELLA MAIEUTICA E "AGRICOLTURA". Nel "Cratilo", Platone, nell’etimologie dei nomi degli dei e delle dee, così scrive:
- "Ἄρτεμις" δὲ ‹διὰ› τὸ ἀρτεμὲς φαίνεται καὶ τὸ κόσμιον, διὰ τὴν τῆς παρθενίας ἐπιθυμίαν· ἴσως δὲ ἀρετῆς ἵστορα τὴν θεὸν ἐκάλεσεν ὁ καλέσας, τάχα δ’ ἂν καὶ ὡς τὸν ἄροτον μισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί· ἢ διὰ τούτων τι ἢ διὰ πάντα ταῦτα τὸ ὄνομα τοῦτο ὁ τιθέμενος ἔθετο τῇ θεῷ.
- "Ad Artemide poi sembra che il nome sia stato posto per l’artemes (’l’integrità’) per l’ornatezza e per il suo desiderio di verginità. E probabilmente chi le assegnò il nome volle chiamarla esperta di virtù ("aretes histora") o forse anche che detesta l’aratura ("ton aroton misesases") del maschio nella femmina: o per uno di questi motivi oppure per tutti questi insieme le pose questo nome colui che pose il nome alla dea" (406b).
FILOSOFIA E SOCIETA’: "LA NASCITA DELLA TRAGEDIA". * All’altezza dell’anno 2024, e dopo la rivoluzione copernicana e dopo i "maestri del sospetto" (Marx, Nietzsche, e Freud), si continua a concepire la relazione uomo-donna secondo la concezione della tragica #segnatura della "Scuola di Atene" (Raffaello, 1509-1511) e del "#Sapiente" (1510) di #Bovillus, vale a dire come lezione di Platone dal "Teeteto":
- "SOCRATE - E non hai mai osservato [...], che [le levatrici] sono abilissime a combinar matrimoni, esperte come sono a conoscere quale uomo e quale donna si hanno da congiungere insieme per generare i figliuoli migliori? TEETETO - Non sapevo codesto. SOCRATE - E allora sappi che di questa lor arte esse menano piú vanto assai che del taglio dell’ombelico. Pensa un poco: credi tu che sia la medesima arte o siano due arti diverse il raccogliere con ogni cura i frutti della terra, e il riconoscere in quale terra qual pianta vada piantata e qual seme seminato? TEETETO - La medesima arte, credo. SOCRATE - E quanto alla donna, credi tu che altra sia l’arte del seminare e altra quella del raccogliere? TEETETO - No, non mi pare. [...] SOCRATE - Ora, la mia arte di ostetrico, in tutto il rimanente rassomiglia a quella delle levatrici, ma ne differisce in questo, che opera su gli uomini e non su le donne, e provvede alle anime partorienti e non ai corpi. E la piú grande capacità sua è ch’io riesco, per essa, a discernere sicuramente se fantasma e menzogna partorisce l’anima del giovane, oppure se cosa vitale e reale. Poiché questo ho di comune con le levatrici, che anch’io sono sterile ... di sapienza; e il biasimo che già tanti mi hanno fatto, che interrogo sí gli altri, ma non manifesto mai io stesso su nessuna questione il mio pensiero, ignorante come sono, è verissimo biasimo. E la ragione è appunto questa, che il dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi vietò di generare. Io sono dunque, in me, tutt’altro che sapiente [...]" (Platone, "Teeteto", 149d-150d).
SOCRATE E L’APOLOGIA DEL "COMPROMESSO OLIMPICO". Eschilo aveva già chiarito molto bene la "ragione" del volere di Apollo e Atena e dello stesso discorso di Platone nel "Teeteto": «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi").
- * Sul tema, mi sia lecito, si cfr. Federico La Sala, "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma 1991.
- NOTA:
- ARCHEOLOGIA #ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI ("#COSTRUZIONI NELL’#ANALISI, 1937)", E #FILOLOGIA: «GRANDE E’ LA #DIANA DEGLI EFESINI» (S. #FREUD, 1911): #EFESO, LA DEA MADRE, IL DIO FIGLIO, E L’#INTERPRETAZIONE PAOLINA DEL #MESSAGGIOEVANGELICO. Alcuni appunti: *
- In memoria di Eraclito e di Shakespeare e ad omaggio di Eleusis2023...
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---ANTROPOLOGIA E STORIA: L’ENIGMA DEL SOGGETTO, L’ENIGMA DEL DESTINO ("ANANKE") E ... L’ENIGMA DI "DIO" ("CHARITAS")9 dicembre 2024, di Federico La Sala
L’ENIGMA DEL NOME, L’ENIGMA DEL SOGGETTO, L’ENIGMA DEL DESTINO ("ANANKE") E ... L’ENIGMA DI "DIO" ("CHARITAS") *
L’ENIGMA DEL DESTINO
di Gianfranco Ricci*
Lo storico Erodoto di Alicarnasso racconta nelle celebre opera “Storie” che nell’anno 499 a.C., Istieo, avventuriero e tiranno di Mileto, si trovava alla corte del re Dario I e non aveva modo di mettersi in contatto con il suo compatriota e tiranno della città Aristagora.
In quel tempo le città ioniche preparavano la grande ribellione contro il dominio persiano e Istieo voleva comunicargli che era il momento di dare il via alla sollevazione.
Alla fine ebbe un’idea: fece rasare la testa al suo schiavo più fedele e gli tatuò sul cuoio capelluto il messaggio che desiderava trasmettere, poi aspettò che i capelli ricrescessero, in modo da nascondere il messaggio.
Solo allora inviò lo schiavo a Mileto, dove gli rasarono nuovamente la testa e poterono leggere il messaggio. Il procedimento aveva diversi vantaggi, perché neppure il latore del messaggio ne conosceva il contenuto e pertanto non avrebbe potuto rivelarlo neanche se fosse stato sottoposto a interrogatorio o tortura.
Già Freud nello scritto “Isteria” (1888) aveva notato come i sintomi isterici seguissero una logica diversa da quella della mera anatomia. Tra il sintomo e la base organica non vi era un legame diretto, bensì l’emergere di una sorta di “dialetto”, di fenomeno linguistico.
Lacan porterà all’estremo la lettura freudiana, parlando di “crivellatura” del corpo per effetto del significante. Le parole, osserva Lacan, possono essere veri e propri “proiettili” che toccano, feriscono e perforano il corpo.
Abbiamo qui l’aspetto centrale della psicoanalisi: il rapporto fondamentale tra corpo e parola.
Il soggetto viene al mondo parlato dall’Altro, prima ancora di accedere direttamente al linguaggio.
Il primo significante che incontra è spesso il nome proprio, intraducibile per definizione, presente quindi nella sua dimensione di significante che si sgancia da ogni significato.
Tuttavia sappiamo bene che il significato è presente nel luogo dell’Altro e per questo può divenire come un “destino” per il soggetto che lo porta: il nome proprio può essere un destino.
Perché un certo nome? Perché non altri? Nel nostro nome e nelle parole che circolano nella nostra infanzia è evidente l’effetto di scrittura, di incisione che il significante opera su di noi.
Ciascuno di noi assomiglia quindi allo schiavo della storia di Erodoto: portiamo su di noi le tracce di un messaggio che non conosciamo e che ci resta enigmatico, misterioso, inaccessibile.
Compito dell’analisi è svelare questo messaggio inconscio: far emergere il discorso che l’Altro ha fatto per noi e su di noi, per assumere questo discorso e farlo nostro, riformularlo alla luce del nostro desiderio.
Sartre mostra l’importanza di questa operazione nel suo studio sulla vita di Jean Genet: l’intera opera di uno degli scrittori più discussi e controversi del Novecento si organizza intorno ad un significante che ha segnato per sempre la sua vita. Sartre ricostruisce infatti un episodio preciso dell’infanzia del piccolo Genet, quando, sorpreso dalla sua balia, viene ripreso con una parola: “ladro!”.
Come sottolinea Sartre nell’opera “Santo Genet, commediante e martire”, l’intera opera di Genet risponde ad una logica precisa: “il genio non è un dono, ma la via d’uscita che ci si inventa in casi disperati”.
- Per approfondire:
- Erodoto - Storie;
- Sartre - Santo Genet, commediante e martire;
- Massimo Recalcati - Ritorno a Jean Paul Sartre.
Il lavoro di Sartre ha indagato il ruolo della storia, dell’infanzia e dell’Altro nella vita dell’uomo.
In particolare, questo ambito di ricerca segna un punto di contatto con la pratica e la teoria analitica.
Sartre ha articolato il suo lavoro concentrandosi su due grandi figure dell’universo culturale francese: Jean Genet e Gustave Flaubert.
Entrambi, nella loro vita, sono stati segnati da un marchio indelebile; la storia di questi due autori rappresenta il tentativo singolare di riprendere questa iscrizione originaria, per trasformarla.
In particolare, se nel caso di Genet il significante padrone, S1, è “ladro!”, nella storia di Flaubert vi è “idiota”.
L’opera elefantiaca di Sartre dedicata a Gustave Flaubert si intitola proprio “L’idiota della famiglia”.
Terzo di tre figli, Flaubert si trova gettato, scartato tanto dal desiderio paterno, investito integralmente sul figlio maggiore (divenuto “copia” del padre), quanto di quello materno (destinato interamente alla figlia femmina, tanto voluta).
La sua “idiozia”, destino già scritto dall’Altro familiare, tradotto in un ritardo nell’acquisizione della parola, diviene base di una ripresa singolare, che porterà Flaubert a divenire, a suo modo, uno degli scrittori più importanti della letteratura francese.
*Cfr. Gianfranco Ricci, 29 novembre 2023 (ripresa parziale - senza immagini).
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- DANTE E SAUSSURE: UNA SOLA TEORIA, QUELLA DEI "DUE SOLI". Ipotesi di lavoro
- PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006). "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ARCHEOLOGIA, E FILOLOGIA: L’HAMLETICA QUESTIONE DEL "CORPO MISTICO" E DEL "CAPO" DELLA "POLIS" DI EFESO AI TEMPI DI ERACLITO.5 dicembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, ARCHEOLOGIA, E FILOLOGIA: L’HAMLETICA QUESTIONE DEL "#CORPO MISTICO" E DEL "#CAPO" DELLA "#POLIS" DI #EFESO AI TEMPI DI #ERACLITO...
- Una nota a margine e a commento del frammento 49: «Uno per me vale diecimila, se è il migliore» .
RICORDANDO LE PAROLE-CHIAVI DELLA hashtag#FILOSOFIA,"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS" (Gv., 1.1), QUALE LA #DIFFERENZA TRA IL LINGUAGGIO RELATIVO AL "PRIMOGENITO" (IL PRIMO "UNO" DI ALTRI #MOLTI "UNO") E IL #METALINGUAGGIO "COSTITUZIONALE" (DEL "LOGOS" E) DEL SUO "UNIGENITO" E MIGLIORE CITTADINO DI EFESO?!
QUALE LA DIFFERENZA TRA IL "PRESEPE" DI FRANCESCO DI ASSISI E QUELLO DELLA CHIESA "PAOLINA", FONDATA DA COSTANTINO (NICEA 325 - 2025)?
- "Lezione" di Paolo di Tarso: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3):
Per non perdere la bussola (e non confondere la Logica della #Costituzione (il #Logos) con la "logica" settaria e proprietaria di un partito o di un’azienda (il #logo), forse, può essere utile tenere presente la seguente riflessione dell arcivescovo di Poitiers, Albert Rouet (2010): «È significativo che l’espressione di Tertulliano: "Il cristiano è un altro Cristo", sia diventata: "Il prete è un altro Cristo"» (2010):
A) UNIGENITO: unigènito agg. [dal lat. tardo, eccles., unigenĭtus, comp. di uni- «uno solo» e genĭtus, part. pass. di gignĕre «generare»]. - Che è l’unico generato, l’unico figlio; riferito quasi esclusivam. a Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio secondo la teologia cattolica (anche s. m., l’U., Gesù Cristo). (Treccani)
B) PRIMOGENITO: primogènito agg. e s. m. (f. -a) [dal lat. tardo primogenĭtus, comp. di primo, avv., «dapprima» e genĭtus, part. pass. di gignĕre «generare»]. - 1. Detto di chi, tra più figli degli stessi genitori, è nato per primo: figlio p.; fratello p.; per estens., ramo p. (di una famiglia nobiliare), quello che ha per capostipite il figlio primogenito; come sost.: dei quattro figli, Alfredo è il p.; lo zio Alessandro era il primogenito. 2. fig. Che è venuto prima, più antico, e quindi più importante, o che tale per qualche motivo viene considerato (talora anche con il sign. di prediletto): la gramatica, primogenita del sapere e per ciò dagli antichi chiamata «arte prima» (V. Monti); la Francia è stata spesso chiamata la figlia p. della Chiesa. (Treccani)
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- “ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO” (PROUST) Una nota sul tema “Filosofia tra (auto)critica e trasformazione".4 dicembre 2024, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, MEDICINA, FISICA E METAFISICA:
- In memoria di Michelangelo Buonarroti (1475 -1564), Immanuel Kant (1724 -1804), Hermann von Helmholtz (1821 - 1894), Walter Benjamin (1892 -1940), e Vincenzo Cappelletti (1930 - 1920).
DIALOGO CON UN AMICO IN OCCASIONE DEL SUO ONOMASTICO NEL GIORNO DELLA MEMORIA DI SAN FRANCESCO SAVERIO:
a) "Messaggio (inoltrato)":
Memoria di san Francesco Saverio, sacerdote della Compagnia di Gesù, evangelizzatore delle Indie, che, nato in Navarra, fu tra i primi compagni di sant’Ignazio. Spinto dall’ardente desiderio di diffondere il #Vangelo, annunciò con impegno Cristo a innumerevoli popolazioni in India, nelle isole Molucche e in altre ancora, in Giappone convertì poi molti alla fede e morì, infine, in Cina nell’isola di Sancian, stremato dalla malattia e dalle fatiche. è il mio onomastico quindi...
b) Risposta:
Ma "Gesù" non aveva nessuna "Compagnia" ... e la compagnia che lo seguiva lo portava là dove si "va-n-gelo". Francesco I, per or-goglio, si richiama a Ignazio di Loyola, è un "gesuita" non un "cristiano" né un "francescano". È tempo di rifare il presepe e restituire a Giuseppe e Maria, il loro ", Bambino...
Molti auguri e buon compleanno, a te e ai tuoi genitori, "Giuseppe e Maria" ... E padre di Andrea, ginecologo.
La X dell’Apostolo Andrea richiama X di "IXTHUS", "Christos", non dell’ "Ictus", così la Caritas, da non confondere con "caritas" ("mammona"). Buona ri-nascita e buon onomastico ... Buona giornata.
- NOTA: XAPITAS - CHARITAS. Caritas, richiama il "caro" del " prezzo" e di Mammona (nel doppio senso di Mamma e di Mammona).
c) Risposta
Dante aspetta ancora. Dalla tragedia "divina" alla "divina" Commedia
d) Messaggio dell’Amico:
La vita dei continui passaggi, per metterla in filosofia, del continuo divenire di Eraclito. Senza la tragedia( il negativo assoluto) non ammireremmo neanche la Bellezza e la Bontà.
e) Risposta:
infatti! Eraclito era di Efeso ed è suo il principio ripreso e rilanciato dall’ Apostolo Giovanni (non dal Paolo, Saulo di Tarso): il Logos. Il Logos, non è il logo di un’azienda, di una setta,o di un partito: è "l’amore che move il sole e le altre stelle" (Dante Alighieri). Della Terra, il brillante colore...
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ALLA "PERSONA AMATA" DALLA PERSONA CHE AMA": UN GRANDE SEGNAVIA PER USCIRE DALL’INFERNO, CON DANTE E PASOLINI.21 novembre 2024, di Federico La Sala
UNA #HAMLETICA #QUESTIONE FILOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA DI #LUNGADURATA E
UN GRANDE SEGNAVIA PER USCIRE DALL’INFERNO, CON #DANTE E #PASOLINI...
- Un omaggio a Emanuela Monini, studentessa magistrale di #Filologia moderna, e alla rivista Insula Europea...
Per Pasolini «chi ama è egoista, e vorrebbe tutta per sé la persona amata» (cfr. Emanuela Monini, "Tu sai che chi ama è egoista", "insula europea", 17 novembre 2024 ); ma, pur avendo capito, come scrive nel sonetto 110, che
- «C’era nel mondo - nessuno lo sapeva - / qualcosa che non aveva prezzo, / ed era unico: non c’era codice né Chiesa / che lo classificasse. Era nel mezzo / della vita e, per confrontarsi, non aveva / che se stesso. Non ebbe, per un pezzo, / nemmeno senso: poi riempì l’intera / mia realtà. Era la tua gaiezza»,
HA difficoltà ad andare oltre sé stesso e riconoscere che "quel qualcosa che non aveva prezzo" è solo la "gaiezza" sua, non della "persona amata".
Il grande #dono della sua vita, forse, sta nel segnalare il "tradizionale" #nodo tragico del non riconoscere alla "persona amata" (gr."#Filomena") la sua #autonomia e la sua #libertà di #amare (gr. "#Filousa").
La sua passione per #DanteAlighieri lo ha portato, oltre la "#ego-logica" di san Paolo, sulla stessa strada e, deposto il suo "vorrebbe", gli ha permesso di giungere a consapevolezza della #dirittavia e a proseguire coraggiosamente il suo viaggio.
A ben distinguere e a ben unire, non è possibile confondere antropologicamente e filologicamente l’amore "prezzolato" (quello con il suo "#caro-prezzo"), la "#caritas", con quell’#amore, quel "qualcosa che non aveva prezzo, / ed era unico: non c’era codice né Chiesa / che lo classificasse", la "#charitas". Un grande segnavia, a mio parere, per uscire con Dante dall’inferno.
- NOTE
- Dante e Pasolini. La #DivinaCommedia e "La #DivinaMimesis: "l’#amor che move il #sole e le altre #stelle" (Par. XXXIII, 145) e il "#Trasumanar e organizar": "un #affetto e la #vita di #PierPaoloPasolini".
- Dante e Pasolini. La #DivinaCommedia e "La #DivinaMimesis: "l’#amor che move il #sole e le altre #stelle" (Par. XXXIII, 145) e il "#Trasumanar e organizar": "un #affetto e la #vita di #PierPaoloPasolini".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! UNA DOMANDA HAMLETICA PER "RE-SHAKESPEARE" BENE: «TE PIACE ’O PRESEPIO?» DEL PIANETA TERRA?11 novembre 2024, di Federico La Sala
A PARTIRE DA #AMLETO, CON #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO: «TE PIACE ’O PRESEPIO?» DEL #PIANETATERRA?!
- A PARTIRE DAL "NATALE IN CASA CUPIELLO" (1931), ALCUNE NOTE DI #FILOLOGIA E #ARCHEOLOGIA FILOSOFICA INTORNO AL #CATTOLICESIMO COSTANTINIANO.
INTRODUZIONE. Si racconta che Saulo / Paolo di Tarso, un "cittadino romano"(At. 22, 25-28), sia stato portato fino al terzo cielo (2 Corinzi 12:2): va bene! Da ricordare, però, che #DanteAlighieri ("Io non Enëa, io non Paulo sono") è andato ben oltre i cieli di #Aristotele, come racconta l’astrofisico Carlo Rovelli, una volta uscito dal "buco nero" in cui lucifericamente era caduto!
#METATEATRO E #STORIOGRAFIA: UNA DOMANDA #HAMLETICA PER "RE-SHAKESPEARE" BENE. Antropologicamente (e cristologicamente), c’è da chiedersi, se Paolo ha visto “Gesù Cristo”, come mai - contriamente a quanto visto e insegnato da #Francesco di Assisi con il suo “presepe” (#Greccio, 1223) - non ha notato, accanto a “Cristo” che lo “sgridava” («Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»), “Giuseppe” accanto a “Maria”?! Dov’è finito il "Giuseppe", discendente della "casa del #ReDavide" ("de domo David")?
UNA "#IMITAZIONEDICRISTO" ALLA PAOLO DI TARSO DI LUNGA DURATA: #NICEA (325 -2025). La domanda logico-storica è: come mai alla sua proposta di imitarlo e seguirlo, tutti e tutte si sono sbagliati e sbagliate a tal punto da seguire lui, Saulo (Paolo di Tarso), e non Gesù: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e #capo della #donna è l’#uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?
"ECCE HOMO" (F. #NIETZSCHE, 1888): QUALE #PRESEPE SI VUOLE CONTINUARE ANCORA A "COSTRUIRE", OGGI? Quello di Paolo di Tarso o quello di #FrancescodiAssisi? #Dante, cosa aveva già capito, come anche Shakespeare, e Pirandello e, infine, #Eduardo De Filippo (1931)?
"#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610): QUALE FUTURO PER IL "#DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (#GALILEO GALILEI, 1632)?
- NOTE:
- TEATRO (FILOSOFIA) E #METATEATRO (METAFILOSOFIA): "NATALEINCASACUPIELLO".
- STORIAELETTERATURA #TEATRO, #METATEATRO E #FILOLOGIA: RE-#SHAKESPEARE CHIARA-MENTE, CON #VICTORHUGO, LUIGI #PIRANDELLO ED #EDUARDODEFILIPPO.
- In onore e memoria di Victor Hugo e Charles Baudelaire...
- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....
- LA «CHARITE’» DEL VESCOVO #MYRIEL DEI "MISERABILI", LA #CRITICA (#KANT) DELLA #ECONOMIAPOLITICA (#MARX), E IL #CATTOLICESIMO DELL’#AGAPE COSTANTINIANO....
- Alcuni appunti a margine della presentazione nell’articolo allegato - v. in fondo - di Paola Martino, “Perdere la testa”: a Milano una mostra sulla decapitazione", (#Artuu, 29 Ottobre 2024 ), presso la Galleria BKV Fine Art di #Milano.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- FILOLOGIA E "SAPERE AUDE!" (KANT): UN PARALLELO TRA CRISTO E SAN PAOLO, MARX E LENIN (GRAMSCI), E, UNA SOLLECITAZIONE A RITORNARE A #EFESO.31 ottobre 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA E FILOSOFIA: CON KANT A EFESO, IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS...
- UN PARALLELO TRA #CRISTO E SAN #PAOLO, #MARX E #LENIN, E,UNA SOLLECITAZIONE A RITORNARE A #EFESO E A PORTARSI OLTRE I "#LOGO" DEI VARI "CATTOLICISSIMI" #PARTITI ATEI O DEVOTI:
Alcuni appunti a margine di UN CONTRIBUTO DI GRAMSCI PER "ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT) E TENTARE DI RIUSCIRE AD #ABITARE UN #PIANETATERRA COMUNE (ERACLITO): RI-PENSARE LA #QUESTIONEANTROPOLOGICA E #CRISTOLOGICA ("ECCE HOMO") E, AL CONTEMPO, LA #QUESTIONE TEOLOGICO-POLITICA DEL #CORPOMISTICO DELLA #COMUNITA’:
A) - "POSIZIONE DEL PROBLEMA: [...] Marx è un creatore di Weltanschauung, ma quale è la posizione di Ilici? È puramente subordinata e subalterna? La spiegazione è nello stesso marxismo - scienza e azione -. Il passaggio dall’utopia alla scienza e dalla scienza all’azione (ricordare opuscolo relativo di Carlo Radek). La fondazione di una classe dirigente (cioè di uno Stato) equivale alla creazione di una Weltanschauung. [...] Marx inizia intellettualmente un’età storica che durerà probabilmente dei secoli, cioè fino alla sparizione della Società politica e all’avvento della Società regolata. Solo allora la sua concezione del mondo sarà superata (concezione della necessità, 〈superata〉 da concezione della libertà). Fare un parallelo tra Marx e Ilici per giungere a una gerarchia è stolto e ozioso: esprimono due fasi: scienza-azione, che 〈sono〉 omogenee ed eterogenee nello stesso tempo. Così, storicamente, sarebbe assurdo un parallelo tra Cristo e S. Paolo: Cristo-Weltanschauung, S. Paolo organizzazione, azione, espansione della Weltanschauung: essi sono ambedue necessarii nella stessa misura e però sono della stessa statura storica. Il Cristianesimo potrebbe chiamarsi, storicamente, cristianesimo-paolinismo e sarebbe l’espressione più esatta (solo la credenza nella divinità di Cristo ha impedito un caso di questo genere, ma questa credenza è anch’essa solo un elemento storico, non teorico)." (A. Gramsci, "Quaderno 7, § 33").
B) - PAOLO DI TARSO, IL "CITTADINO ROMANO", DIVENTA "CRISTIANO", E COSTRUISCE LA "WELTANSCHAUUNG" DEL SUO "PARTITO", FA DI #CRISTO IL "RE" DELLA "COSMOTEANDRIA" DELLA SOCIETA’ DEL SUO TEMPO, E COMINCIA A LAVORARE ALLA CONQUISTA DELL’#EGEMONIA SUI VARI "PARTITI" DEGLI APOSTOLI. Alcune note dai testi evangelici:
- a) Dagli "Atti degli Apostoli" (19, 1-7): "Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell’altopiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero.
 Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini." (cfr."La Parola - C.E.I.");
Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano. Erano in tutto circa dodici uomini." (cfr."La Parola - C.E.I.");
- b) Dalla "Prima Lettera ai Corinzi" (1-13): "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);
- c) Dalla "Lettera agli Efesini" (4. 1/11-13): "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (cfr. Efesini, 4.1/11-13).
C) "IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS": STUDIANDO LE OPERE DI #SWEDENBORG, CON "I SOGNI DI UN VISIONARIO CHIARITI I SOGNI DELLA METAFISICA" (1766), PUR SE CON UN LAPSUS SIGNIFICATIVO DI "ARISTOTELISMO" RESIDUO, RISCOPRE LA LEZIONE DEL FILOSOFO DEL "LOGOS", #ERACLITO DI #EFESO ("Vegliando, noi abbiamo un mondo comune; ma sognando ciascuno ha il suo mondo") E INIZA A LAVORARE AL SUO PROGRAMMA DI CRITICA DELLA "RAGION "PURA, DELLA "RAGION PRATICA", E DELLA "CAPACITA’ DI GIUDIZIO" E,INFINE A RIFLETTERE SULLA "FINE DI TUTTE LE COSE" ( E SUL COSIDDETTO "CRISTIANESIMO") E, ANCORA, A RIPROPORRE E A RIAPRIRE LA QUESTIONE ANTROPOLOGICa ("LOGICA", 1800).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA, ANDROCENTRISMO, E COSMOTEANDRIA: "IL COLTELLO E LO STILO" E "IL CONCETTO". Alcuni appunti di storia della filosofia e della linguistica ,21 ottobre 2024, di Federico La Sala
PLATONE E NOI, OGGI (*):
"IL COLTELLO E LO STILO" E IL "CONCETTO". UNA RIFLESSIONE INTORNO A TEMI DI ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024) E DI #COSMOTEANDRIA PLATONICA, PAOLINA ED HEGELIANA.
- Un omaggio alla #memoria del prof. Mario Vegetti, del prof. Fulvio Papi, e del prof. Enzo Paci...
COME NASCONO I #BAMBINI, COME NASCONO LE #IDEE, COME NASCONO I #SOGNI? SE E’ VERO COME E’ VERO CHE « [...] Platone non può #concepire la “pura teoria” che come transito, necessario ma provvisorio, verso una restaurazione del dominio: un dominio certo fondato ora non sull’immediatezza della forza ma sulla cogenza di una verità neutralizzata, perciò necessariamente valida in universale.» (M. Vegetti, "Il coltello e lo stilo. Le origini della scienza occidentale", il Saggiatore, Milano 1996, p. 74), è possibile continuare a usare il "coltello" e lo "stilo" e, addirittura, a sezionare cadaveri all’inferno?! E’ mai possibile continuare a costruire piramidi come il "#Sapiente" (1510), ancora teorizzato da #Bovillus e dalla ecclesiastica "#Scuola di Atene" di #Raffaello (1509-1511) e a seguire sul piano di un #androcentrismo ateo e devoto la lezione teologico-politica di Paolo di Tarso?!
LEZIONE ANDROCENTRICA DI #TEOLOGIA-POLITICA DI #PAOLO DI #TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. PLATONE: ILLUMINISTA O TOTALITARIO?! PLATONE E NOI, OGGI.
- NOTE:
- ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA, E FILOLOGIA: MARIO VEGETTI. ["Mario Vegetti (Milano, 4 gennaio 1937 - Milano, 11 marzo 2018) è stato uno storico della filosofia e traduttore italiano, professore ordinario fino al 2005 di Storia della filosofia antica presso l’Università degli Studi di Pavia. Apprezzato in ambito internazionale per le sue traduzioni di Platone, Aristotele, Ippocrate, Galeno,[1] pubblicò diversi saggi su Platone, sull’etica e sulla medicina antica.(...)"->https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Vegetti].
- ANTROPOLOGIA CULTURALE #ARTE E #FILOLOGIA: LA DONNA VITRUVIANA. L’ALTRA META’ DEL #CIELO E DELLA #TERRA, UNA QUESTIONE DI #RICAPITOLAZIONE, SECONDO #UMANITÀ ("#ECCE #HOMO"), NON SECONDO #VIRILITÀ ("ECCE #VIR")! Un omaggio all’artista Maria Paola #Speranza e alla sua #Donna Vitruviana.
- PITTURA SESSUALITA’ LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA. A NON SPRECARE LA RIEVOCAZIONE DELLA #LEZIONE DEL MAESTRO #GUTTUSO “Al giovane Lopiparo ricordo di Guttuso, Roma 9-6-64” (cfr. Franco Lo Piparo, "GUTTUSO «DIPINGEVA CON IL PENE»", 20 Ottobre, 2021), forse, non è bene richiamare sia il lavoro degli amici e dei maestri (da #TullioDeMauro a #UmbertoEco) del prof. Franco Lo Piparo sia il lavoro del #pittore René #Magritte e del filosofo #MichelFoucault sui quadri relativi al problema della #rappresentazione riflettendo ancora sul quadro "QUESTA PIPA NON E’ UNA #PIPA" e rimettere in movimento le #idee relative al "circuito fallico", al circuito sessuale, e, finalmente, al circuito della #parole (alla #Saussure), di #due "soggetti sovrani" (come da #Costituzione teologico-politica italiana, e, da "#Canticodeicantici", nel blu dipinto di blù, alla #Totò), e passare, finalmente, agli "atti linguistici" di un regime non più segnato da un #androcentrismo teologico-politico tragico a un’antropologia all’altezza della famosa "#dignità dell’uomo" e della "#divinacommedia" (#Dante)!?!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- INDIVIDUO E SPECIE. MA QUALE "RICAPITOLAZIONE", COME DA ANTROPOLOGIA DI DANTE ALIGHIERI, O DA ANDROCENTRISMO DA "CAVERNA" PLATONICA?!18 ottobre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOGENESI FILOLOGIA E FILOSOFIA: CHE GRANDE "PREISTORIA" DELL’INTERA #UMANITA’ DEL PIANETA TERRA!
RIPARTIRE DA CAPO, E IMPARARE A #CONTARE, A #CALCOLARE...
INDIVIDUO E SPECIE: "L’ONTOGENESI RICAPITOLA LA FILOGENESI" (ERNST #HAECKEL).
MA QUALE "RICAPITOLAZIONE", COME DA #ANTROPOLOGIA COSMICA, QUALE QUELLA DI #DANTE ALIGHIERI ("L’#AMOR CHE MUOVE IL #SOLE E LE ALTRE #STELLE") O COME QUELLA (DELL’ATTUALE #PRESENTE STORICO) DA #ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DA "#CAVERNA" PLATONICA E PAOLINA)?!
"SAPERE AUDE!" (#KANT, 1784). NON E’ IL CASO DI CORRERE AI RIPARI E, FINALMENTE, uscire dall’orizzonte della #tragedia e dal #letargo epistemologico e #correggere un’operazione #matematica "sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (#Franca Ongaro #Basaglia, 1978)!!!
COSMOTEANDRIA E STORIA. LA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO:
 "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).
"Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).- NOTE:
- MEMORIA, #STORIA, #SCIENZA, #STORIOGRAFIA E #CRITICA: ERNST HAECKEL. "Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Potsdam, 16 febbraio 1834 - Jena, 9 agosto 1919) è stato un biologo, zoologo, filosofo e artista tedesco.( ...)".
- ELIOCENTRISMO (COPERNICO), "ELIOCENTRISMO" (COSMOTEANDRIA), ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024) E #TEOLOGIA-#POLITICA DEI #DUESOLI (#DANTEALIGHIERI) ALLA #LUCE DEL #SOLE (NON DEL "RE SOLE")!
- "SÀPERE AUDE" (#ORAZIO). Da sempre ogni #essere umano cammina "#insieme" ("#together"( con #sé stesso (come un #altro), ma dopo la lezione minoica-ateniese (di #Arianna e #Teseo) e millenni di #labirinto edipico (e dopo gli innumerevoli tentativi di chiarimenti di tanti esploratori e tante esploratrici) non è ancora tempo di venir fuori dallo "#stato di #minorità" (#Kant, 1784), uscire dall’#inferno, e arrivare alla #Terra Promessa?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- NAPOLEONE, FREUD, E LA GIORNATA MONDIALE DELL’ANATOMIA. LA LEZIONE ANTROPOLOGICA DI MICHELANGELO E LA SCOPERTA DI GIOVANNI VALVERDE.16 ottobre 2024, di Federico La Sala
GIORNATA MONDIALE DELL’#ANATOMIA ("World Anatomy Day"): NON SOLO VESALIO.
- ANTROPOLOGIA, #STORIA, E #STORIOGRAFIA:
GIOVANNI VALVERDE DE AMUSCO E LA "SCOPERTA" DEI "#TESTICOLI DELLE #DONNE" (cfr. allegato: cap. 15 del Libro III dell’ "Anatomia" di #GiovanniValverde, stampata a Roma nel 1560).
COME NASCONO I BAMBINI: #RIVOLUZIONE COPERNICANA (IN #TERRA E IN #CIELO) E #MENSCHWERDUNG. #AL TEMPO DI #FILIPPO II e #TERESA D’AVILA, il medico Giovanni Valverde riconosce alla #donna il ruolo attivo nell’atto del #concepimento e pone le premesse per l’#uguaglianza, per la "#ley de #igualdad".
- NOTE:
- ANATOMIA E RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN MEDICINA (E IN ASTRONOMIA): ANDREA VESALIO.
- IL CAMMINO DELLE SIBILLE E DEI PROFETI E L’ANATOMIA TEOLOGICO-POLITICA DI MICHELANGELO. Prima di #Harvey (1578 - 1657), nel XVI secolo, all’epoca di Ferrante Sanseverino (1507-1568) e di Girolamo #Seripando (1493-1563), la rivoluzione scientifica (in #astronomia e in #medicina) già correva al galoppo (come il #serviziopostale gestito dalla famiglia dei #Tasso, e di #Torquato Tasso), e #Michelangelo Buonarroti ne sa già molto, come l’amico medico #Realdo Colomdo (1516-1559), #GiovanniValverde, #Vesalio (1514-1564), ed #ElGreco (1541-1614). Allegato (foto): omaggio di Giovanni Valverde, nella sua Anatomia" a Michelangelo (e al suo apostolo #Bartolomeo della #Cappella Sistina).
- MEMORIA STORIA E FILOLOGIA CRITICA: NAPOLEONE E SIGMUND FREUD. "CONTRIBUTI ALLA PSICOLOGIA DELLA VITA AMOROSA. Secondo contributo. Sull’universale degradazione della vita amorosa": "[...] Modificando una nota frase di Napoleone il Grande, si potrebbe dire a questo proposito: «l’anatomia è il destino»"(S. Freud).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- TEATRO E FILOSOFIA: AMORE, O MORTE? RIPRENDERE LA #RICERCA SUL TEMA DELLA NASCITA E DELL’ ANTROPOLOGIA PSICOANALITICA E FILOSOFICA.16 ottobre 2024, di Federico La Sala
TEATRO E FILOSOFIA: AMORE, O MORTE? "ESSERE, O NON-ESSERE: QUESTA E’ LA DOMANDA" ("THE QUESTION": HAMLET, III.1.56). CHE #RISPONDERE, "QUI E ORA"?!
- Una nota a margine del lavoro "archeologico" in progress sull’#Hamlet di #Shakespeare da parte di Paul Adrian Fried, "Seven ways Hamlet might see a mirror of himself in Laertes".
SE E’ VERO, COME E’ VERO, come scrive lo stesso #Shakespeare, che "conoscere bene un uomo sarebbe conoscere se stessi" ("#Amleto", V. 2. 139), la sollecitazione a riflettere sui "Sette modi in cui Amleto potrebbe vedere uno specchio di se stesso in Laerte" (cit.), a mio parere, è un ottimo consiglio a pensare ancora, di nuovo, e meglio, all’antico "#programma" metastorico, filosofico e antropologico (di ogni #essereumano), del #conoscere sé stesso della tradizione delfica e dell’ #amare il prossimo come sé stesso della tradizione evangelica.
METATEATRO E METAPSICOLOGIA. Inoltre, il contributo è anche un invito a riconsiderare il lavoro fatto da Otto Rank sia sullo stesso #Amleto ("Das «Schauspiel» in «Hamlet»", 1915) sia sul tema del "Doppio" ("Der Doppelgänger", 1914) ) e, infine, sul più generale e comune tentativo di portarsi con #Freud, oltre l’orizzonte della #Tragedia (Dante Alighieri) e del #Tempo "fuori dai cardini" di Amleto (Shakespeare).
- NOTA:
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- METATEATRO E METASTORIA: QUALE "MODELLO" DI #RELAZIONE IN UNA MODERNA SOCIETA’ DEMOCRATICA? QUALE RAPPORTO TRA LE #GENERAZIONI?10 ottobre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (KANT), TEATRO (#SHAKESPEARE), E #PSICOANALISI (#FREUD):
IL "MOUSETRAP" DI "AMLETO ED OFELIA" ("HAMLET", III.2) E L’ "ONORA IL PADRE E LA MADRE" ANTROPOLOGICO E "BIBLICO".
QUALE "MODELLO" DI #RELAZIONE IN UNA MODERNA SOCIETA’ DEMOCRATICA? QUALE RAPPORTO TRA LE #GENERAZIONI? CITTADINI SOVRANI E CITTADINE SOVRANE, FIGLI E FIGLIE DI ’MARIA’ E ’GIUSEPPE’, O DI ’GIOCASTA’ E ’LAIO’? O, PER CASO E ANCORA, FIGLI E FIGLIE DELLA LUPA (DI REA SILVIA E MARTE)?
LO "SPETTRO" DI "#GIUSEPPE" SI AGGIRA ANCORA PER LA "#DANIMARCA" ..... MA IN VATICANO NON LO SANNO. Vivono tutti ancora a Tebe, nella città del re Edipo! Con un’antropologia preistorica, la Chiesa Cattolica avanza sicura, verso il tremila prima di Cristo E SI PREPARA A FESTEGGIARE #NICEA (325-2025)!
Fino a quando zoppicheremo con i due piedi?: questa è una domanda - già di molti secoli prima di Cristo - del profeta Elia (1 Re: 18, 21), ma - come si sa - rilanciata da #SigmundFreud, nel XX secolo dopo Cristo! A CHE "GIOCO" SI VUOLE CONTINUARE A GIOCARE?
- Nota:
- STORIAELETTERATURA E #FILOLOGIA #CRITICA: DANTE ALIGHIERI E WILLIAM SHAKESPEARE. Come MARIA: "FIGLIA DEL TUO FIGLIO", così GIUSEPPE: "FIGLIO DEL TUO FIGLIO"!!! Dante non "cantò" non i "mosaici" dei "faraoni" --- E Shakespeare "cantò" il programma di "Amleto" e "Ofelia": portarsi "Scilla e Cariddi", le colonne d’Ercole, e divenire ed essere cittadino-sovrano e cittadina-sovrana dello "stato di Danimarca"..
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA (KANT), STORIOGRAFIA, E LETTERATURA (BAUDELAIRE): IL CASTIGO DELL’ORGOGLIO ("Châtiment de l’orgueil").30 settembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (KANT), STORIOGRAFIA, E LETTERATURA (BAUDELAIRE):
IL CASTIGO DELL’ORGOGLIO ("Châtiment de l’orgueil").
DAI "FIORI DEL MALE", UN #RACCONTO "STORICO" DI ALTA PROFONDITA’: COME UN TEOLOGO, CHE EBBE PAURA DEL "TRAUMA DELLA NASCITA" E, SULLA #NEGAZIONE DEL "RIDICOLO FETO", APRI’ LA STRADA ALLA "GLORIA" DELLA #COSMOTEANDRIA DELLA "#CAVERNA" PLATONICO-LUCIFERINA ("MAMMONICA") E FINI’ PER ESSERE "LA GIOIA E LO SCHERNO DEI #FANCIULLI".
- "XVI. CASTIGO DE L’ORGOGLIO:
In quei tempi meravigliosi in cui la Teologia fiorì con la massima forza ed energia, si narra che un giorno uno dei più grandi dottori, dopo aver forzato i cuori indifferenti ed averli commossi ne le loro nere profondità; dopo aver superato verso le glorie celesti strani sentieri a lui stesso ignoti, dove forse eran giunti solo i puri Spiriti, come un uomo salito troppo in alto, preso da vertigine, gridò in un trasporto di satanico orgoglio:
- "Gesù, o meschino Gesù! io t’ho collocato ben alto!
 Ma se avessi voluto attaccarti nel lato debole,
Ma se avessi voluto attaccarti nel lato debole,
 la tua vergogna eguaglierebbe la gloria tua,
la tua vergogna eguaglierebbe la gloria tua,
 e non saresti più che un ridicolo feto!"
e non saresti più che un ridicolo feto!"
- [Jésus, petit Jésus! Je t’ai poussé bien haut!
 Mais, si j’avais voulu t’attaquer au défaut
Mais, si j’avais voulu t’attaquer au défaut
 De l’armure, ta honte égalerait ta gloire,
De l’armure, ta honte égalerait ta gloire,
 Et tu ne serais plus qu’un fœtus dérisoire!]
Et tu ne serais plus qu’un fœtus dérisoire!]
Immediatamente la sua ragione scomparve. Lo splendore di quel sole si velò; tutto un caos piombò in quell’intelligenza, tempio già vivo, pieno d’ordine e di opulenza, sotto le cui vòlte tanto fasto era stato sfoggiato. Il silenzio e la notte regnarono in lui, come in un sotterraneo di cui si è smarrita la chiave.
Da quel giorno fu simile a le bestie di strada, e, quando andava pei campi senza nulla vedere, incapace di distinguere l’estate da l’inverno, sudicio, inutile e brutto come una cosa logora, formava la gioia e lo scherno dei fanciulli. (Charles Baudelaire, "I fiori del male").
-
>IL CASTIGO DELL’ORGOGLIO ("Châtiment de l’orgueil") --- FILOLOGIA E CRITICA: BAUDELAIRE, DE QUINCEY, E "LES SEPT ViEILLARDS" ( E I "SETTE DORMIENTI DI EFESO")12 ottobre 2024, di Federico La Sala
POESIA, LETTERATURA, STORIOGRAFIA E FILOLOGIA CRITICA:
BAUDELAIRE, DE QUINCEY, E "LES SEPT ViEILLARDS" ( E I "SETTE DORMIENTI DI EFESO").
- Una "ipotesi" di commento a margine della "Lettura di «Les septs vieillards» di Charles Baudelaire («Les Fleurs du Mal», XC), "Le parole e le cose", 9 maggio 2012, di Umberto Fiori.
SE E’ VERO, COME E’ VERO, CHE IL SIGNIFICATO della figura dei "Sept vieillards" rimane "enigmatico. Qui, l’altrove (alle) a cui la figura rimanda o da cui parla (agoreuo) si sottrae al dominio della ragione (“vainement ma raison voulait prendre la barre”, v.49), è un mare “mostruoso e senza limiti” (v.52). [...] Baudelaire ci descrive gli effetti dell’apparizione dei vecchi [2]: la ragione non riesce più a governare ciò che vede, deve arrendersi al suo nauseante “sdoppiamento”; una tempesta si oppone ai suoi sforzi, ma lo fa en jouant, come per gioco; quel gioco crudele sembra contagiare anche l’anima che, invece di opporglisi, si mette a danzare come una vecchia scialuppa senza alberi né vele",
E’ ALTRETTANTO VERO CHE, COME E’ DETTO NELLA NOTA "[2]", "L’immagine presenta non poche analogie con un passo di De Quincey sulla “tirannia del volto umano” che Baudelaire cita nei Paradisi artificiali: «Allora sulle acque inquiete dell’Oceano cominciò a mostrarsi il volto dell’uomo; il mare mi parve selciato da innumerevoli teste rivolte verso il cielo; visi furiosi, imploranti, disperati, si misero a danzare sulla superficie, a migliaia, a miriadi, a generazioni, a secoli; la mia agitazione diventò infinita e il mio spirito balzò e rotolò con le onde dell’Oceano»”.
MESSO A FUOCO QUESTO LEGAME E, AMPLIANDO LO SGUARDO SULLO SPAZIO LETTERARIO E STORICO, A CUI RINVIANO PER LA LORO STESSA FORMAZIONE SIA BAUDELAIRE SIA DE QUINCEY, FORSE, E’ IL CASO DI RIAPRIRE LA DISCUSSIONE SUL TEMA E RIPENSARLO ALLA LUCE DELLA #LEGGENDA DEI "SETTE DORMIENTI DI EFESO"".
PROBABILMENTE, un indizio per la risoluzione dell’enigma del significato della figura dei "Sept viellards" è da rintracciarsi nella sintesi "storiografica" (e "teologico-politica") dello "chá timent de l’orgueil" ("L’orgoglio punito" di "Les Fleurs du Mal", XVI) e, al contempo, al ’fatto’ segnalato già da De Quincey, che "sulle acque inquiete dell’Oceano cominciò a mostrarsi il volto dell’uomo; il mare mi parve selciato da innumerevoli teste rivolte verso il cielo; visi furiosi, imploranti, disperati, si misero a danzare sulla superficie, a migliaia, a miriadi, a generazioni, a secoli".
GIOVANNIMACCHIA: "Baudelaire aveva ragione. La nostra epoca è divenuta sempre più «baudelairiana». E’ divenuta baudelairiana senza che noi siamo tornati indietro d’un passo" (Charles Baudelaire, "Poesie e Prose", Milano 1973).
- NOTA:
- STORIA E #METASTORIA: I SETTE DORMIENTI DI EFESO.
- CarloOssola, "La guerra e la lezione dei sette dormienti":
- "[...] ciò che nei secoli ha sfigurato il volto dell’umanità. Di questa “vocazione” si fa testimone un’antica tradizione: chi entri nello splendido e austero duomo di Crema, troverà sul lato destro dell’abside un frammento di affresco medievale che incornicia, superstiti, i profili dei sette dormienti di Efeso (raffigurati anche nella Crypta Balbi a Roma e in forma lignea nella Cappella dei Santi Cosma e Damiano ad Angri). La tradizione cristiana, trasmessa in Occidente da Gregorio di Tours e da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum, fu soprattutto diffusa dalla Legenda aurea ed ebbe una larga fortuna figurata. I santi “dormienti”: Costantino, Dionisio, Giovanni, Massimiano, Malco, Marciano e Serapione sono venerati anche dalla tradizione ortodossa. Ed un’eco è non meno presente nella sura XVIII del Corano, detta appunto “sura della caverna”
- [...] per Dante, anche i beati attendono di ritrovare i loro corpi terreni: «Che ben mostrar disio d’i corpi morti: / forse non pur per lor, ma per le mamme, / per li padri e per li altri che fuor cari / anzi che fosser sempiterne fiamme» (Paradiso, XIV, 63-66). L’apologo dei “sette dormienti” vale anche più in profondo: risorti per un istante, chiesero la grazia di tornare alla terra sino al giorno del Giudizio: troppo avevano già visto di persecuzioni, di miseria, di abominio. [...] " (Avvenire, 3 maggio 2022).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- FILOLOGIA E PSICOANALISI: CHI HA PAURA DI "BEATRICE", LA "BELLA" MADRE DI DANTE ALIGHIERI?!23 settembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI: DANTE ALIGHIERI, LA #DIVINA COMMEDIA, "LA SACRA #FAMIGLIA" (#MARX-#ENGELS), E L’#ANDROCENTRISMO CONTEMPORANEO.
- Una nota di commento a margine di una sollecitazione a riflettere sul "femminismo, Beatrice, e gli anni ‘70 che erano più avanti di noi" (cfr. Galatea Vaglio Pillole di Storia, 23 settembre 2024 )
#STORIA #LETTERATURA E #FILOLOGIA. CONSIDERANDO CHE il #23settembre richiama anche il giorno della morte di #SigmundFreud, e RICORDANDO, ancora , che all’inizio della sua "#Interpretazione dei sogni (1899) c’è il virgiliano #AcherontaMovebo", personalmente, devo dire che resto sempre più che sorpreso dell’accettazione del #fatto che si accolga acriticamente non solo il "giudizio" di #UmbertoEco ma anche dell’intero mondo accademico delle scienze storiche logiche e filologiche (dopo i #maestridelsospetto), e non si aprino gli occhi sugli innumerevoli #segnavia posti dallo stesso #Dante Alighieri sul suo cammino.
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! COME E’ (STATO) POSSIBILE (ADDIRITTURA PER SETTE SECOLI) ACCREDITARE la #madre di #Dante, #Bella (che a #Virgilio così parla:
- "Or movi, e con la tua parola ornata
 e con ciò c’ha mestieri al suo campare
e con ciò c’ha mestieri al suo campare
 l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata.
l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata.
- I’ son Beatrice che ti faccio andare;
 vegno del loco ove tornar disio;
vegno del loco ove tornar disio;
 amor mi mosse, che mi fa parlare": Inf. II, 67-72),
amor mi mosse, che mi fa parlare": Inf. II, 67-72),
come la giovane Beatrice ... fino a fare del Poeta una persona incapace di essere spiritualmente fedele alla sua sposa #GemmaDonati, di essere un #padre onesto e leale con i propri figli e, infine, di capire persino la ragione del perché sua figlia Antonia, entrata in convento, prenda il nome di suor #Beatrice? Boh e Bah?! Mistero dell’altro mondo? Chi ha paura di Beatrice?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- A LEZIONE DI ANTROPOLOGIA: ALUNE NOTE SUL "GIOCO DEL ROCCHETTO" E SULLA "MOUSETRAP" NELL’AMLETO.21 settembre 2024, di Federico La Sala
AMLETO, FREUD E RANK: UN INVITO A RIPRENDERE LA RICERCA SUL TEMA DELLA NASCITA E DELL’ ANTROPOLOGIA PSICOANALITICA E FILOSOFICA.
- "SAPERE AUDE!" (#KANT, 1724-2024): "DA DOVE VENGONO I BAMBINI?" (Emma #Eckstein, 1900).
A CHE #GIOCO SI CONTINUA A GIOCARE? ANCORA A UN #BAMBINO, CONCEPITO COME UN #FETO "TOTALMENTE NARCISISTICO"?! Freud comprese l’importanza antropologica del "gioco del #rocchetto" del nipotino, ma Rank riuscì a meglio comprendere «La "Rappresentazione" nell’Amleto» (1916) di #Shakespeare, il "gioco" della #Mousetrap (della "scena primaria", della "scena madre").
Una nota a margine di un mio vecchio articolo su un grande protagonista della storia della psicoanalisi: Federico La Sala, "Otto Rank, il doppio e la psicoanalisi" ("Psicoterapia e Scienze Umane", Anno III, OTTOBRE-DICEMBRE 1980, 4, pp. 75-79: Vol. 4, 1980, Volume XIV, serie arancione).
A BEN VEDERE, l’opera di Freud, "Inibizione, sintomo e angoscia" è del "1926". Data l’importanza dell’argomento, legato al problema della nascita (e alla "angoscia di castrazione"), forse, vale la pena rileggere con attenzione quesa "citazione":
- "[...] La prima esperienza angosciosa, almeno per l’uomo, è la nascita, la quale significa, obiettivamente, la separazione dalla madre; la nascita potrebbe anzi essere paragonata a una evirazione che la madre subisce (in base all’equivalenza bambino = pene). Ora, sarebbe molto soddisfacente se l’angoscia, quale simbolo di una separazione, si ripetesse per ogni separazione ulteriore; ma l’apprezzamento di questa corrispondenza ci è purtroppo impedito dal fatto che la nascita non viene soggettivamente vissuta come una separazione dalla madre, in quanto questa, quale oggetto, è del tutto sconosciuta al #feto, che è #totalmente #narcisistico" (cfr. Freud, "Inibizione, sintomo e angoscia", cap. 7, Opere Vol. 10).
Essendo tutto il discorso legato polemicamente al "Trauma della Nascita" di Otto Rank (1924), all’ #enigma della #Sfinge (al tragico "#nodo di#Ercole"), e alla questione antropologica sul #comenasconoibambini (#SigmundFreud, 1937), non è il caso di rianalizzare meglio e di più il contributo di Otto Rank e le stesse riflessioni di Freud che toccano infine, anche e ancora Rank, la discussione di lunga durata sulla "Analisi terminabile e interminabile"?
ANTROPOLOGIA CULTURALE PSICOANALISI STORIA E STORIOGRAFIA. Otto Rank, "#Beyond #Psychology" (1941): "[...] Among the subjects investigated in this searching analysis are kingship and magic participation, the institution of marriage, power and the state, Messianism, the doctrine of rebirth, the two kinds of love (Agape and Eros), the creation of the sexual self, feminine psychology and masculine ideology, and psychology beyond the self.".
- Nota:
- USCIRE DAL #LETARGO DI "XXV SECOLI" (#DANTEALIGHIERI). SENZA #MEDEA, IL "#GIOCO" NON HA PIU’ FUTURO: RIPARTIRE DAL’#INDICAZIONE DI "#AMLETO E #OFELIA". Purtroppo siamo al #bordo (#edge) del "burrone" e, come volevasi dimostrare, si ha ancora #paura della propria #ombra (#Otto #Rank) e si è antropologicamente incapaci di capire di cosa "parla" il "#gioco del #rocchetto" (#Freud) e la "scena primaria", la "scena madre" a cui allude la "Rappresentazione" nell’#Amleto (O. Rank, 1916), la "trappola per topi", il #Mousetrap (#Shakespeare). Se è vero, come è vero, che il "marcio nello stato di Danimarca" planetario cresce sempre di più, occorre ri riprendere il filo del "#sàpere #aude!" (#Kant, 1784; e #MichelFoucault, 1984) e avere il #coraggio di ribaltare il discorso #dell’#androcentrismo e #invertire il #presente - e la rotta.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- IL "CERCATE ANCORA" DI CLAUDIO NAPOLEONI E IL "CARINO" DI UNO STUDENTE: "IL CAPITALE NON TRAMONTA MAI".19 settembre 2024, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA E DELLA TEOLOGIA MAMMONICA:
IL"CARINO" DI UNO STUDENTE E IL "CERCATE ANCORA" DI CLAUDIO NAPOLEONI (1990)!
- STORIAELETTERATURA: "IL CAPITALE NON TRAMONTA MAI". Una nota a margine della recensione di Alfonso Maurizio Iacono ("Doppiozero", 19 settembre 2024) di "una nuova edizione con una nuova traduzione del I Libro di Il capitale, l’unico che Marx pubblicò (K. Marx, Il capitale, Libro I, Einaudi, Torino 2024, pp. 1287)":
- "Un giorno di tanti anni fa, nella sede della redazione di ‘Pace e Guerra’, la rivista diretta da Luciana Castellina, Stefano Rodotà e Claudio Napoleoni, quest’ultimo, professore di economia politica all’Università di Torino, ci raccontava che un suo studente, che aveva letto Il capitale di Marx e a cui aveva chiesto come l’aveva trovato, aveva risposto: “carino!”. Napoleoni andò su tutte le furie esclamando: “del Capitale non si può dire che è carino! È un libro che o ti sconvolge e ti lasci prendere dal suo argomentare oppure lo respingi!”. Napoleoni aveva ragione. Oggi nessuno osa dire che è carino e tuttavia i tentativi di imbalsamarlo tra i ‘classici’ o di presentarlo come superato e obsoleto non sono poi così diversi dall’affermazione dello studente di Napoleoni. Eppure, ogni qual volta esplode una crisi economico-sociale, Marx e, in particolare Il capitale, ritorna in circolazione. [...]" (cit.).
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?! Ricordando ancora con stima la sollecitazione #critica di Claudio Napoleoni a non addormentarsi nel #sonnodogmatico dominante, mi permetto di #pensare che lo #studente, nella sua risposta, si riferisse al #costo economico del #libro (non al contenuto) e, al contrario, fosse molto pertinente! A ben riflettere, il "carino" avrebbe dovuto allarmare il prof. e fargli #apriregliocchi e le orecchie sulla "#doppiezza" della "#carità" cattolico-paolina, nel suo significato "mercantile" ("#caritas": "caro-prezzo" e "caro-affetto") e #accogliere con #grazia la ironica sottolineatura dello studente!
"SAPERE AUDE!" (KANT, 1784; MICHEL FOUCAULT, 1984))."Da dove iniziare, volendo recuperare, soprattutto ora, il pensiero e l’opera - complessa, molteplice, culturalmente alta - di Claudio Napoleoni?" (cfr. Lelio Demichelis, "Cercare ancora. Il capitalismo, la tecnica, l’ecologia e la sinistra scomparsa. L’attualità di Claudio Napoleoni", Economia&Politica, 26 Aprile 2020).
- NOTE:
- STORIA E FILOSOFIA: "LA MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una #svolta_antropologica" (Federico La Sala, Antonio Pellicani editore, Roma 1991): l’omaggio a Claudio Napoleoni e al suo "Cercate ancora" del 1990 (v. foto della pagina 7 - allegato).
- ANTROPOLOGIA, #ECONOMIA #POLITICA, #TEOLOGIA, E #FILOLOGIA: #CHARITAS (non #Caritas)! "Le #Cariti (in greco antico: #Χάριτες, #Chàrites) sono dee della mitologia greca, corrispondenti nella mitologia romana alle #Grazie (in latino: Gratiae). [...]" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Cariti ).
- STORIA E SOCIETA’. [...] A quanto pare, la "musica" non è proprio cambiata e il "#carino" vale (ancora) sia per il discorso su "Fineschi e i suoi collaboratori" sia su "Il futuro del capitalismo: Crollo o sviluppo?" (di #Colletti e #Napoleoni, dell’editore Laterza del 1970, di ben 687 pagine). Il "circolo filologico" della #critica dell’#economia politica e della #religione "mammonica", a quanto pare, è chiuso e il #capitalismo (con il suo #Capitale) ha "vinto" il suo "e-terno al #lotto".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- L’ANTROPOLOGIA DEI "DUE SOLI": IMPARARE A INDOVINARE ("ERRATEN") E AVER IL CORAGGIO DI ACCOGLIERE ("SÀPERE AUDE!") E "SPOSARE" ("HEIRATEN") LA IPOTESI "COSTRUITA".12 settembre 2024, di Federico La Sala
SHAKESPEARE, FREUD, E L’ANTROPOLOGIA DEI "DUE SOLI": LA FILOSOFIA DELLA "MENTE ACCOGLIENTE".
- In memoria di Elvio #Fachinelli (1928-1989).
ALLA RICERCA DEL "TEMPO PERDUTO": IMPARARE A INDOVINARE ("ERRATEN") E AVER IL #CORAGGIO DI #ACCOGLIERE ("SÀPERE AUDE!") E "#SPOSARE" ("HEIRATEN") LA IPOTESI "COSTRUITA".
- Una nota a margine della recensione di R. Musella e M. Pappadella della nuova traduzione di “Costruzioni nell’analisi” di S. Freud (Jaca Book ed., 2024->):
- "Per apprezzare la nuova traduzione del saggio di Freud (1937a), Costruzioni nell’analisi, ad opera di Francesco Barale e Ingrid Hennemann Barale, è opportuno partire da quella che riteniamo esserne la chiave interpretativa più originale proposta nel saggio introduttivo dello stesso Francesco Barale. Prima di dichiarare le nostre carte, però, dobbiamo fare una premessa che prende le mosse dal lontano 1895. Come è noto, Freud in una lettera a Fliess del 25 maggio 1895, indica tre verbi chiave, necessari per la comprensione della teoria del funzionamento psichico: phantasieren, übersetzen, erraten. Verbi che hanno conosciuto traduzioni diverse e che costituiscono il presupposto indispensabile per la comprensione di quello che l’anno successivo, il 13 febbraio 1896, sempre in una lettera a Fliess, viene denominato lavoro metapsicologico. La triade proposta inizialmente allo storico confidente berlinese, attraverserà tutta l’opera freudiana, fino alle ultime formulazioni contenute in Analisi terminabile e interminabile (Freud, 1937a), nel Compendio di psicoanalisi (Freud, 1938) e, appunto, come rileva Francesco Barale, in Costruzioni nell’analisi (Freud, 1937b).
 [...] La nozione di “costruzione” non è una novità: è un tema già ampiamente trattato da Freud, ma che in questo scritto viene ulteriormente elaborato. Per comprendere a fondo la portata di tale concetto nella sua estensione, è opportuno soffermarsi sul termine chiave che lo introduce: questo “indovinare” (erraten) che è nel cuore del “costruire”, tanto quasi da definirlo. Il termine erraten torna anche nel punto in cui Freud discute quali indizi possano far pensare che l’analista, con la sua costruzione, ci abbia o meno indovinato. [...]"( “Costruzioni nell’analisi” di S. Freud. Recensione di R. Musella e M. Pappa).
[...] La nozione di “costruzione” non è una novità: è un tema già ampiamente trattato da Freud, ma che in questo scritto viene ulteriormente elaborato. Per comprendere a fondo la portata di tale concetto nella sua estensione, è opportuno soffermarsi sul termine chiave che lo introduce: questo “indovinare” (erraten) che è nel cuore del “costruire”, tanto quasi da definirlo. Il termine erraten torna anche nel punto in cui Freud discute quali indizi possano far pensare che l’analista, con la sua costruzione, ci abbia o meno indovinato. [...]"( “Costruzioni nell’analisi” di S. Freud. Recensione di R. Musella e M. Pappa).
***
#PSICOANALISI #ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA #HAMLETICA: "CHI SONO IO?". Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo #Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The #Mousetrap") e di portarsi oltre il #giogo del "matriarcato" e del "patriarcato".!
"COME NASCONO I BAMBINI" (S. Freud, "Analisi terminabile e interminabile", 4). Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita è come quello di Shakespeare, contribuire a sciogliere il nodo di #Ercole, il nodo del nascere, del #comenasconoibambini, alla base della "nevrosi ossessiva", non solo del "caso" dell’uomo dei topi" (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di Danimarca".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- FILOLOGIA E ANDROCENTRISMO PLATONICO-PAOLINO. "María Zambrano non ha venduto l’anima all’Idea" (Emil M. Cioran, "Esercizi di ammirazione"). .10 settembre 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFIA E ANDROCENTRISMO: "ECCE HOMO" (NIETZSCHE, 1888).
LA SFINGE CHIESE AD EDIPO, "CHI SEI ?"; EDIPO "PLATONICAMENTE" RISPOSE: "L’#UOMO!" [#ANTHROPOS].
- Un omaggio alla memoria di María Zambrano e al suo lavoro su "La tomba di #Antigone. #Diotima di Mantinea" [1967], La Tartaruga 1995).
STORIA #LETTERATURA E #STORIOGRAFIA. #PILATO INDICO’ #GESU’ ALLA #FOLLA E DISSE: "ECCE HOMO" ( «Ecco l’uomo», «ἰδοὺ ὁ #ἄνθρωπος»).
TEOLOGIA-POLITICA E #COSMOTEANDRIA. LA LEZIONE DI #PAOLODITARSO:
- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [ἀνήρ], e capo di Cristo è Dio [ ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ ⸀τοῦ Χριστοῦ ὁ θεός.]"(1 Cor. 11, 1-3).
"PERSONA E DEMOCRAZIA. La storia sacrificale" (M. Zambrano, 1958): "María Zambrano non ha venduto l’anima all’Idea" (Emil M. Cioran, "Esercizi di ammirazione. Saggi e ritratti", Adelphi, 1988).
Sul tema, cfr. "Le parole di Antigone nella riscrittura novecentesca di María Zambrano" (di Camilla Tibaldo, Treccani, 13 gennaio 2020).
- NOTE:
- FILOSOFIA STORIOGRAFIA E ANTROPOLOGIA: DIOTIMA DI MANTINEA E SOCRATE. Una vecchia "foto" da "La mente accogliente", Antonio Pellicani editore, Roma 1991 (v. allegato).
- ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI. "Una tomba per Antigone. Clinica del delirio borderline" (di Pietro Barbetta, Orthotes Editrice 2024).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA "MAIEUTICA", IL "PROBLEMA SOCRATE", E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA POSTA DA KANT ("LOGICA", 1800)9 settembre 2024, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! INSEGNAMENTO E #COSTITUZIONE: CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?!
- SCUOLA E SOCIETA’. Una nota a margine di un nodo non sciolto della #storia delle #idee e dei #sogni... *
L’ALGORITMO DELLA TRAGEDIA (SOCRATE-PLATONE-PAOLO DI TARSO-HEGEL) E LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA POSTA DA KANT ("LOGICA", 1800). L’autonomia dello apprendimento e l’#apprendimento dell’autonomia, concepito l’una e l’altro, secondo le indicazioni dell’#illuminismo kantiano (1784), a mio parere, riposa sul #coraggio ("aude") del servirsi della propria intelligenza, sulla propria #capacità e sulla propria #volontà di "mangiare" e "bere" ("#sàpere") da parte dell’alunno e dell’alunna, e non sulla #maieutica di un Socrate che gioca a "sapere di non sapere" con l’alunno-schiavo ("#Menone") a dargli lezioni sul "non sapere di sapere"!
COME NASCONO I BAMBINI (LE IDEE, E I SOGNI): "SAPERE AUDE!" Il "problema Socrate", posto da #Nietzsche e nonostante Nietzsche, è del tutto ignorato e la sollecitazione di Michel Foucault a ripensare il rapporto "illuminismo e critica" (1984) è ancora fuori dall’agenda dei lavori del mondo della "platonica" Accademia e dell’"aristotelico" Liceo: che il trecentesimo anniversario della nascita di Kant (1724-2024) possa essere una buona occasione per cominciare!
- NOTE:
- STORIA E #FILOSOFIA: "ILLUMINISMO E CRITICA" (di Michel Foucault).
- STORIA STORIOGRAFIA E SCUOLA: "INSEGNAMENTO E POTERE" ( di Alfonso Maurizio Iacono, "Doppiozero", #8settembre 2024).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- A SCUOLA DA SHAKESPEARE, CON IL BAMBINO "SULLE SPALLE DEI GIGANTI" (#PROFETI E #SIBILLE).3 settembre 2024, di Federico La Sala
STORIA LETTERATURA E METATEATRO: #HAMLET #ETICA #MENTE, CON IL #BAMBINO "SULLE SPALLE DEI GIGANTI" (#PROFETI E #SIBILLE).
ANTROPOLOGIA STORIOGRAFIA E CRITICA DEL #SONNODOGMATICO (KANT) DELLA "STORICA" #COSMOTEANDRIA PLATONICO-PAOLINA "OCCIDENTALE"...
- Una considerazione a margine di alcune riflessioni storiografiche di Paul Adrian Fried (cfr. "Dennis Taylor notes via Paul Tillich on Protestant-Catholic complimentarity"- September 02, 2024 ).
CRISTIANESIMO E CATTOLICESIMO NELL’EUROPA DEL #SEICENTO. Shakespeare, come #DanteAlighieri, ha (a mio parere) una visione della storia e della società che ha già i piedi nel #futuro, ben al di là della teologia-politica del #paolinismo cattolico e protestante (ateo e devoto), ben oltre l’orizzonte costantiniano di #Nicea (325-2025) e della #tragedia e della "biblica" #caduta. Sia Dante, sia #Michelangelo (v. foto allegata), sia Shakespeare (con #GiordanoBruno e ... Isaac Newton), sono con il bambino "sulle spalle dei giganti" (Robert K. #Merton), non con i pifferai-giganti sulle spalle dei bambini, di ieri e di oggi.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- PSICOANALISI DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA: I GIGANTI SULLE SPALLE DEI BAMBINI E "LA SOCIETA’ SANA" ("THE SANE SOCIETY", 1955).2 settembre 2024, di Federico La Sala
PSICOANALISI DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA: I GIGANTI SULLE SPALLE DEI BAMBINI E "LA SOCIETA’ SANA" ("THE SANE SOCIETY", 1955).
UNA NOTA SUL "TEMPO FUORI DAI CARDINI" E L’ANSIA DELLA "DE-GENERAZIONE" DELLO STORICO PRESENTE
- Un omaggio alla memoria di #William Shakespeare e di #Erich Fromm
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA, E PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE. SE DA MOLTI DECENNI I #PIFFERAI GIGANTI dei "mass-media" e dei "social media" (veri e propri "cavalieri dell’apocalisse"), a cui "abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi" (come denunciava McLuhan), si sono ormai seduti sulle spalle dei "#bambini" e degli stessi "#genitori", non è forse il caso di uscire, con Dante Alighieri, dal #letargo e dall’#inferno, e cercare di ripensare e chiarirsi le idee, con "Amleto" (III.2), sulla "trappola per topi" ("The Mousetrap"), e portare sulla scena il "giogo" del "pifferaio" dello "#stato di Danimarca" planetario"? Se non ora, quando?!
P.S. - IL #BAMBINO SULLE SPALLE DEL GIGANTE: SAN CRISTOFORO.
- NOTE:
- ANTROPOLOGIA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA. ERICH FROMM, "Psicanalisi della società contemporanea", Edizioni di Comunità, Milano 1960 ("The sane society", New York 1955).
- STORIAELETTERATURA #ANTROPOLOGIA E #FILOLOGIA #CRITICA. IL #BAMBINO SULLE ##SPALLE DEL #GIGANTE: SAN #CRISTOFORO.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- "AMLETO IN PURGATORIO" E "NEOSTORICISMO" ("NEW HISTORICISM")? CON DANTE E SHAKESPEARE, MEGLIO USCIRE DAL "LABIRINTO" DI MILLENNI.31 agosto 2024, di Federico La Sala
STORIA (TEATRO), METASTORIA (METATEATRO), LETTERATURA, E STORIOGRAFIA:
"AMLETO IN PURGATORIO" E "NEOSTORICISMO" ("NEW HISTORICISM")?
- Una nota a margine della riflessione di Paul Adrian Fried su "Frank Kermode on New Historicism and Stephen Greenblatt" - August 27, 2024.
"SÀPERE AUDE!" (KANT, 1784; MICHEL FOUCAULT, 1984). Con i "maestri del sospetto" (P. #Ricoeur), #Marx e #Freud e #Nietzsche, e #WalterBenjamin, forse, è bene riprendere la lettura dell’opera di Shakespeare e cercare di uscire dal più che millenario "letargo" (Dante Alighieri).
CULTURA E SOCIETÀ: "NEW HISTORICISM". "WWGD?" ("Cosa farebbe Greenblatt?"). "Cum grano salis": le indicazioni di Kermode, come i lavori di Greenblatt, sono importanti sollecitazioni, ma dicono solo dell’immane "ritardo" storiografico (a tutti i livelli) relativo alle conoscenze della nostra stessa storica realtà (composta di storie di storie di storie...). Già solo i titoli: "Amleto in Purgatorio" ("𝘏𝘢𝘮𝘭𝘦𝘵 𝘪𝘯 𝘗𝘶𝘳𝘨𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺") e "Arte tra le rovine" ("Art Among the Ruins"), cosa cercano di far capire?
"THE TIME IS OUT OF JOINT"("Hamlet", I.5). SHAKESPEARE, cosa fa con "Amleto"? A partire dal proprio "presente storico" (dallo "stato di Danimarca"), con ben altra radicalità, non riprende dall’immaginario ereditato il filo del "#principio" (antropologico e teologico-politico), non lo riporta in #luce con la sua "trappola di topi" ("The #Mousetrap"), e non sollecita a portarsi oltre il proprio tempo, un "tempo fuori dai cardini"?! A quale "storicismo" si vuole continuare a "#giocare", oggi?
- Nota:
- STORIA LETTERATURA E METASTORIA: I "VENTICINQUE SECOLI" DI DANTE... E I "TREMILA ANNI" DI GOETHE : Chi di tremila anni / Non sa darsi conto, / Rimane all’oscuro inesperto, /Vuol vivere così di giorno in giorno" (J. W. Goethe, "Libro del malumore", 1819 ca.).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- CONTRORIFORMA E CONTRORINASCIMENTO, CONTRO LA RIVOLUZIONE IN MEDICINA E IN ANTROPOLOGIA (ANATOMIA).29 agosto 2024, di Federico La Sala
MICHELANGELO, I PROFETI, LE SIBILLE, E LE "STREGHE" DI BENEVENTO: CONTRORIFORMA E CONTRORINASCIMENTO.
- UNA IPOTESI DI "LETTURA" DELLA FIGURA DI SAN #BARTOLOMEO, NEL "GIUDIZIO UNIVERSALE" DELLA "#CAPPELLASISTINA".
ANTROPOLOGIA CULTURALE #ARTE E #STORIA. A lume di #antropologia storica e "#immaginazione sociologica", si può ben pensare che Michelangelo (associandosi al santo patrono di Benevento, all’apostolo Bartolomeo, con la "#sindone" del suo "#autoritratto": ), nel #GiudizioUniversale, protestava "cristianamente", contro la #gerarchia di un #cattolicesimo istituzionalizzato (assetato di potere, all’ombra e al servizio del dio "#Mammona", incapace di accogliere le sollecitazioni della #Riforma Luterana e Anglicana), che aveva rifiutato la proposta di far camminare insieme profeti e sibille, come da chiara indicazione ecumenica e "francescana, nella "Volta" della #CappellaSistina e nel "#presepe" del #TondoDoni) e contro l’equiparazione di #janare e #sibille (come da tradizione "cattolica", delle "streghe", che si riunivano presso l’antico albero di "noce di benevento", per il famoso "concerto" sabbatico.
- NOTE:
- STORIA E STORIOGRAFIA: ROMEO DE MAIO, "#MICHELANGELO E LA #CONTRORIFORMA (Editori Laterza, 1978)
- RIVOLUZIONESCIENTIFICA, MEDICINA, E ARTE: #GIOVANNIVALVERDE. L’omaggio del medico Juan Amusco de Valverde, IN UNA TAVOLA del suo manuale di "ANATOMIA DEL CORPO UMANO" (1560), A "MICHELANGELO - BARTOLOMEO):
 MICHELANGELO COME VALVERDE ERANO ALLIEVI E COLLABORATORI DEL MEDICO, ANATOMISTA E SCIENZIATO, REALDO COLOMBO.
MICHELANGELO COME VALVERDE ERANO ALLIEVI E COLLABORATORI DEL MEDICO, ANATOMISTA E SCIENZIATO, REALDO COLOMBO.
- ANTROPOLOGIA, MEDICINA, E RICERCA SCIENTIFICA: I "TESTICOLI" DELLE #DONNA E LA "COGLIONERIA" DELL’#UOMO, OVVERO ANCHE LE #DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione (v. allegato) di #GiovanniValverde, "#Anatomia" (Roma, 1560).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- UNA QUESTIONE DI INTELLIGENZA: L’ALBERO DI NOCE DI BENEVENTO, LA FIGURA DI SAN BARTOLOMEO NEL "GIUDIZIO UNIVERSALE" DI MICHELANGELO, E LA RICERCA DI FREUD.28 agosto 2024, di Federico La Sala
L’HAMLETICA QUESTIONE DELLA INTELLIGENZA, L’ALBA DELLA TERRA ("EARTHRISE"), L’ALBERO DEL "CERVELLO" (IL NOCE), E LA "NEXOLOGIA" CHIASMATICA DELLE "COSTRUZIONI NELL’ ANALISI" (S. FREUD, 1937). *
- SULLA SPIAGGIA DELL’OCEANO COSMICO (KEPLERO A #GALILEO, 1611). Una nota in #memoria di Immanuel #Kant, di Sigmund #Freud, e di Elvio #Fachinelli...
UNA "NOCE-PESCA", "IL "PESCA-NOCE" E UNA EPISTEMOLOGIA "GENESI-CA": LA MENTE ACCOGLIENTE. Una traccia per una #svolta_antropologica...
ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI. Sulla relazione mente-cervello, sull’#enigma dello #gnommero, dell’ ingarbugliatissimo gomitolo (nascosto all’interno della #testa dell’essere umano, della "noce" - a "drupa aperta"), forse, non è male tenere presente (ancora e) anche il contributo di uno dei suoi grandi "#pescatori", a partire dalle sue ricerche sull’#anguille (non sui "punti di #capitone" di #Lacan: il papà di #SigmundFreud era un #mercante di #lana, ma il figlio non faceva #materassi, per tutta la vita ha cercato la via delle "anguille" per il #mare dei #Sargassi, ed è riuscito a giungere a #Maresfield).
- NOTE:
- ANTROPOLOGIA E #FILOSOFIA. "LA MENTE ACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA" ("V. Un brillante new tono. "Note" per una epistemologia accogliente"), Antonio Pellicani Editore, Roma 1991.
- CON L’ULISSE DI DANTE ALIGHIERI, RI-CONSIDERARE LA "SEMENZA". IL NOCE, L’ALBERO DELLA VITA DELLA "NAVE" TERRA:
- "Il n. ha un grosso tronco cenerino e chioma ampia; le foglie sono imparipennate e i fiori monoici con ovario infero. Il frutto è una drupa, globosa, con parte esterna (mallo) di color verde chiaro, nerastra a maturità, e nocciolo (guscio) bivalve contenente un seme commestibile (gheriglio) con grossi cotiledoni. È spontaneo in Asia Minore, Anatolia e Penisola Balcanica. In Italia si coltiva in collina e nel piano submontano, fino a 1400 m s.l.m. Si moltiplica per seme; le piantine di 2-3 anni si trapiantano in terreni piuttosto sciolti, di solito lungo le strade, i confini dei campi e i corsi d’acqua: vive anche più di un secolo. [...]" (Treccani).
- ANTROPOLOGIA CULTURALE, ARTE E STORIA: "MICHELANGELO E LA CONTRORIFORMA" (ROMEO DE MAIO, 1978) E LE "STREGHE" DELL’ALBERO DI NOCE DI BENEVENTO. A lume di antropologia storica e "immaginazione sociologica", si può ben pensare che Michelangelo (associandosi al santo patrono di Benevento, all’apostolo Bartolomeo, con la "#sindone" del suo "autoritratto"), nel Giudizio Universale, protestava "cristianamente", contro la gerarchia di un cattolicesimo istituzionalizzato (assetato di potere, all’ombra e al servizio del dio #MAmmona"), che aveva rifiutata la proposta di far camminare insieme *profeti e sibille* come nella "Volta" della #CappellaSistina) e contro l’equiparazione di "janare e sibille" (come da tradizione "cattolica" beneventana, delle "streghe", che si riunivano presso l’antico albero di "noce di Benevento", per il famoso concerto "sabbatico".
*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "PATOLOGIE (ANTONELLA MOSCATI) E FENOMENOLOGIA DELL’ESPERIENZA (POSSIBILE): CON KANT (DANTE, PROUST, E HUSSERL), ALLA RICERCA DELL’ IO "ASSENTE".26 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E FENOMENOLOGIA DELL’ESPERIENZA (POSSIBILE):
CON KANT (DANTE, PROUST, E HUSSERL), ALLA RICERCA DELL’ IO "ASSENTE".
- NOTE A MARGINE di UNA RECENSIONE di “Patologie”, il romanzo di Antonella Moscati (Quodlibet, 2024), letto da Irene Calabrò *
________________________________________________________________________________________________________
"L’ESPERIENZA IMPOSSIBILE
di Irene Calabrò (FataMorgana Web, 15 luglio 2024)
In uno dei testi che compongono Idea della prosa, Giorgio Agamben trova il modo di esprimere l’inesprimibile, un’«esperienza decisiva che, per chi l’abbia avuta, si dice sia così difficile da raccontare», che «non è nemmeno un’esperienza» (2013, p. 15): è «il punto in cui tocchiamo i limiti del linguaggio» (ibidem); il punto in cui tocchiamo la nostra materia.
- Chi non ha mai raggiunto, come in un sogno, questa lignea sostanza della lingua, che gli antichi chiamavano “selva”, è, anche se tace, prigioniero delle rappresentazioni. È come per coloro che sono tornati alla vita dopo una morte apparente: in verità, non sono affatto morti (altrimenti non sarebbero tornati) né si sono liberati della necessità di dover un giorno morire; si sono, però, liberati della rappresentazione della morte. Per questo, interrogati su quel che gli è capitato, non hanno nulla da dire sulla morte, ma trovano materia per molti racconti e per molte belle favole sulla loro vita (ibidem).
Cosa significa per uno scrittore o per una scrittrice toccare la materia della parola? Significa forse, seguendo Agamben, fare un’esperienza indicibile; un’esperienza impossibile da raccontare, e che, tuttavia, è la materia che dà forma a qualsiasi scrittura, a qualsiasi racconto. Forse il racconto, che è la messa in forma dell’esperienza, può essere formato solo da chi abbia esperito l’impossibilità di raccontare; che abbia, cioè, fatto esperienza di un’impossibilità di fare esperienza. Che sia stato in un luogo e in un tempo in cui non può, però, dire di esserci stato - quello che Agamben, altrove, definisce un «vuoto centrale, una sospensione o uno scarto», un foglio bianco: «Come se al centro di tutto quello che ho provato a vivere e a scrivere ci fosse un istante, anche solo un quarto di secondo, perfettamente vuoto, perfettamente invivibile» (Agamben 2022, p. 65).
Che ci sia un istante invivibile, significa, innanzitutto, che in un tempo e in luogo imprecisabili, qualcuno non ha potuto fare esperienza di ciò che tuttavia stava esperendo; uno scarto, in cui l’io che cerca di ricordare non può dire di essere stato quell’io che ha vissuto quello che ha vissuto. In effetti, la condizione di possibilità principale che permette di fare esperienza, in un determinato spazio e in un determinato tempo, è la possibilità di dire io. Ma non è proprio rispetto al passato che l’io si trova, spesso, necessariamente, costretto a dubitare della sua presenza passata? Al termine della postfazione al suo testo Patologie (Quodlibet, 2024), Antonella Moscati ragiona proprio su questo vortice di tensioni: c’è un’incalcolabile frazione di tempo che separa le percezioni, le sensazioni, il vissuto dalla memoria che ne abbiamo, ossia dal momento di «registrazione contemporanea o quasi contemporanea di ciò che viviamo» (Moscati 2024, p. 96), separazione che aumenta col passare del tempo, e che è «all’origine di ciò che consideriamo un io umano» (ibidem).
Patologie è composto da due testi, Patologie e Agt. Il primo è «una narrazione semicomica» di una materia, le malattie, che per Moscati è una «materia [...] sempre dolorosa» (ivi, p. 93), di cui si trova traccia in altre sue narrazioni, come in Deliri (2009) o in Una quasi eternità (2022). Quel racconto, in cui Moscati rimaneggia la tara della sua famiglia, ossia la paura delle malattie mortali (ivi, p. 9), è una commedia che è contraria alle sue «disposizioni abituali» narrative (ivi, p. 93), che invece si riconoscono nel secondo racconto, Agt, in cui narra di un episodio di amnesia globale transitoria, che non ha «proprio niente di comico», e che è scritto nella forma più consona a Moscati, ossia «quella che cerca di ritagliare uno spazio fra teoria e narrazione, fra filosofia e vissuto» (ibidem). Benché Patologie e Agt siano allora diametralmente opposti, sono messi insieme perché appaiono «come le due facce di una stessa medaglia, due modi opposti per interrogarsi sulla stessa cosa: come nasce il ricordo, chi è che ricorda, quando, come e se possiamo dire che un ricordo è vero» (ivi, pp. 93-94).
Patologie è un racconto dettagliato della maniera in cui quella tara di famiglia - la paura delle malattie, tutte (o quasi) mortali - prendeva forma: dalla considerazione delle malattie da parte del padre, un «dermosifilopatico» che credeva che «potessero guarire solo le malattie che, come la tonsillite, la sifilide e la scabbia, si vedevano a occhio nudo» (ivi, p. 14), alle pratiche quasi religiose che aiutavano a gestire l’ansia di contrarre malattie, come la lettura del «Roversi», la «bibbia medica» che Moscati e le sue sorelle leggevano anche prima di addormentarsi: «Di certo meno commovente di Piccole donne o Pattini d’argento, ma molto più istruttivo intorno a tutte quelle nozioni che ci sarebbero servite nella nostra carriera di medico non medico» (ivi, p. 33). Fino ad arrivare a immaginare una soluzione per non vivere più nella perenne proiezione di possibili malattie mortali: «Fuggir via dai nostri corpi»; sentirsi «parti infinitesimali, atomi, anzi fotoni, quarks, quanti o addirittura neutrini» (ivi, p. 61); trasferirsi in una dimensione che supera anche la distinzione tra vita e morte, «perché in quell’infinita materia fisica e metafisica morire non è nemmeno come galleggiare e respirare al ritmo e al passo delle brezze e delle onde marine, ma solo come scomparire o comparire nell’aritmia del soffio di venti poderosi, nei movimenti delle onde e delle tempeste cosmiche, delle turbolenze che spazzano le giganti rosse disperdendo le sabbie stellari» (ivi, p. 62).
Agt, invece, è un chiaro momento di riflessione filosofica, dove l’accumulo di ricordi del primo testo sparisce per fare spazio a un buco nella memoria: un episodio accaduto in una mattina di fine maggio al mare, dove Moscati fa esperienza di un’assenza di sé, quindi propriamente, di un’esperienza impossibile. «Agt è acronimo di Amnesia globale transitoria, dove globale sta per retrograda e anterograda, oblio cioè di quanto è accaduto prima e di tutto quanto accade o sta accadendo durante l’episodio di amnesia» (ivi, p. 65).
Moscati riflette sulla sua impossibilità di ricordare quell’episodio, perché nell’Agt «non c’è nessuno che registri alcunché, perché io mi assento, io scompaio» (ivi, p. 67). «L’io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni» è la frase della Critica della ragion pura di Kant a cui Moscati pensa nel momento in cui, subito dopo l’attacco di Agt, recupera «la memoria, quella cosciente, quella che rileva scrupolosamente tutte le nostre percezioni nel momento in cui ci accadono, attestandone così l’esistenza» (ibidem).
Ed è il ritornello del racconto: in quella frase di Kant, si condensa la possibilità dell’io di registrare coscientemente le rappresentazioni, ossia «tutto ciò che si presenta volontariamente o involontariamente alla mente» (ivi, p. 69), e che permette di dire a un io di aver propriamente esperito. In quella mattina al mare, però, benché fosse sveglia e in grado di dare le sue generalità, la sua coscienza si è eclissata, come se qualcuno l’avesse sostituita: «Al mio posto, allora chi c’era? Chi è quell’ombra antica, quel residuo incolore, cieco e sordo, che pur senza aver perso i sensi ne è completamente privo, perché sentire è sempre anche sapere di sentire, forse persino per i neonati» (ivi, p. 71). È possibile considerare un’esperienza quel momento in cui l’io scompare e al suo posto sembra che qualcun altro viva, parli, si muova, guardi senza coscienza alcuna, ossia senza lasciare traccia del vissuto? Quel momento in cui, spiega Moscati con Leibniz, forse sì, si percepisce, ma ciecamente, ossia senza appercepirsi, senza vedere che si sta percependo (ivi, pp. 74-75). Sarà, forse, un’esperienza davvero materica, che si libera di qualsiasi rappresentazione delle rappresentazioni? Che rapporto intrattiene, in quel caso, il pensiero con la memoria, con la registrazione contemporanea della cosa che si sta esperendo? E dove va a finire quell’“io penso” senza cui non si può neppure scrivere? O forse è proprio quella regione impensabile che, diviene, poi, la materia stessa della scrittura?
Di quell’episodio, Moscati riesce a mettere insieme per lo più una serie di domande sulla possibilità o meno di dire che l’io umano è tale anche quando sparisce, anche quando si dimentica di sé:
- Nell’Antropologia, Kant sembra mettere in rapporto, anche se in maniera indiretta, l’io penso con la memoria. La memoria, come l’io penso, nasce soltanto quando le sensazioni disparate si unificano. [...] “Il ricordo della propria infanzia non si spinge molto in là in quel tempo, perché quella non era l’età delle esperienze, ma soltanto delle percezioni sparse non ancora unificate sotto la nozione di oggetto” (ivi, p. 84).
L’io penso che non registri le percezioni non ha memoria, non pensa, non è un io. Percepisce come un animale: in effetti, «gli animali non hanno io, ma hanno percezioni e memoria, forse anche una certa consapevolezza delle percezioni. Probabilmente anche per gli animali in ogni sentire c’è la percezione di sé che percepisce, ma, mancando loro la parola, quell’amalgama compatto di percezione appercettiva dal quale e nel quale ha inizio il pensiero non può mai sapersi e rammemorarsi come tale, venendo a coscienza saputa» (ivi, p. 77).
Alla fine di Deliri, Moscati racconta che una volta, a Trapani, qualcuno le spiegò che i tonni, «animali così grossi e possenti» restano «preda quasi senza reagire delle reti in cui cadono durante la mattanza» per un difetto di vista (Moscati 2009, p. 102): «I tonni vedono gli oggetti vicini molto ingranditi e sopravvalutano quindi la grandezza e la forza delle maglie della rete. Ritengono perciò che sia impossibile forzarle e si mettono a passeggiare lentamente forse per riflettere sul da farsi. Ed è proprio qui, in questo momento di pausa, d’indecisione o di scoraggiamento, che i pescatori affondano i loro arpioni» (ivi, p. 102). La morte dei tonni è destinata a ripetersi perché, come spiega Moscati, nessun tonno è mai tornato da “quell’esperienza di morte” per raccontare l’errore. Accade perché un tonno non può dire e raccontare quell’errore? Forse, però, alcune scritture e alcuni racconti fanno leva proprio su quell’impossibile, su una sorta di “esperienza di morte”: su un buco nell’esperienza; su un’assenza dell’io. Uno scarto nell’esperienza che, tuttavia, diviene la materia stessa della scrittura: una potenza di dire nel vuoto - al limite, una scrittura animale.
In fondo, qualsiasi scrittura, qualsiasi racconto che traggono la loro linfa da un momento del passato devono scontrarsi con un mero dato di fatto: chi scrive non è più nel momento e nel luogo di cui scrive. Poco importa, allora, se l’accaduto che si rimaneggia sia stato vissuto realmente o meno: una specie di in-archiviabile governa quelle “rappresentazioni”, perché il ricordo conservato solo nella mente sembra sfuggire a qualsiasi possibilità di riproduzione che permetta di ripeterlo in altri tempi e luoghi, imponendo a chi scrive di fare i conti con uno scarto nel vissuto, con un’esperienza di cui non è più possibile fare esperienza. Come se la scrittura avesse a che fare con l’irrappresentabile: la morte, ossia con l’esperienza impossibile per eccellenza. Anche in Patologie, in fondo, si fa leva su uno scarto: «Poiché probabilmente anche nel più sincero e abbagliante ricordare ci sono stati strappi impercettibili che abbiamo ricucito con maestria» (Moscati 2024, p. 95).
Patologie, dunque, sembra derivare da un vuoto; un vuoto che diviene la possibilità stessa della scrittura, laddove si mostra che la materia del racconto e delle riflessioni è l’esperienza, talvolta anche impercettibile, della sparizione dell’io.
Riferimenti bibliografici
 G. Agamben, Idea della prosa, Quodlibet, Macerata 2013.
G. Agamben, Idea della prosa, Quodlibet, Macerata 2013.
 Id., Quel che ho visto, udito, appreso..., Einaudi, Torino 2022.
Id., Quel che ho visto, udito, appreso..., Einaudi, Torino 2022.
 A. Moscati, Deliri, nottetempo, Roma 2009.
A. Moscati, Deliri, nottetempo, Roma 2009.
 Id., Una quasi eternità, Quodlibet, Macerata 2022.
Id., Una quasi eternità, Quodlibet, Macerata 2022.
NOTE:
- UN’ASSENZA DELL’IO-SONO DI TRE SECOLI: KANT (1724-1804) E LA DANZA DEL #PENSIERO, IN COMPAGNIA DI BECKETT, "ASPETTANDO GODOT" ("Dance first. Think later. / It`s the normal order").
 Una nota a margine della recensione di Pietro Barbetta del lavoro di Antonella Moscati.
Una nota a margine della recensione di Pietro Barbetta del lavoro di Antonella Moscati.
- FISICA E #METAFISICA: IN PRINCIPIO ERA LA VITA, NON LA MORTE. CON KANT (DANTE MARX E HUSSERL), a scuola da Epicuro:
 "[...] stolto è chi dice di temere la morte non perché quando c’è sia dolorosa ma perché addolora l’attenderla; ciò che, infatti, presente non ci turba, stoltamente ci addolora quando è atteso. Il piú terribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte noi non siamo piú. Non è nulla dunque, né per i vivi né per i morti, perché per i vivi non c’è, e i morti non sono piú. Ma i piú, nei confronti della morte, ora la fuggono come il piú grande dei mali, ora come cessazione dei mali della vita la cercano. Il saggio invece né rifiuta la vita né teme la morte; perché né è contrario alla vita, né reputa un male il non vivere. E come dei cibi non cerca certo i piú abbondanti, ma i migliori, cosí del tempo non il piú durevole, ma il piú dolce si gode. Chi esorta il giovane a viver bene e il vecchio a ben morire è stolto, non solo per quel che di dolce c’è nella vita, ma perché uno solo è l’esercizio a ben vivere e ben morire. Peggio ancora chi dice: “bello non esser nato, / ma, nato, passare al piú presto le soglie dell’Ade”. [...]" (Epicuro, "Opere", Einaudi, Torino, 1970, pp. 62-63).
"[...] stolto è chi dice di temere la morte non perché quando c’è sia dolorosa ma perché addolora l’attenderla; ciò che, infatti, presente non ci turba, stoltamente ci addolora quando è atteso. Il piú terribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte noi non siamo piú. Non è nulla dunque, né per i vivi né per i morti, perché per i vivi non c’è, e i morti non sono piú. Ma i piú, nei confronti della morte, ora la fuggono come il piú grande dei mali, ora come cessazione dei mali della vita la cercano. Il saggio invece né rifiuta la vita né teme la morte; perché né è contrario alla vita, né reputa un male il non vivere. E come dei cibi non cerca certo i piú abbondanti, ma i migliori, cosí del tempo non il piú durevole, ma il piú dolce si gode. Chi esorta il giovane a viver bene e il vecchio a ben morire è stolto, non solo per quel che di dolce c’è nella vita, ma perché uno solo è l’esercizio a ben vivere e ben morire. Peggio ancora chi dice: “bello non esser nato, / ma, nato, passare al piú presto le soglie dell’Ade”. [...]" (Epicuro, "Opere", Einaudi, Torino, 1970, pp. 62-63).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- "BOURDIEU E IL SENSO COMUNE DEGLI SCIENZIATI", ANCORA NEL "CERCHIO DEI CERCHI" DELL’ASSOLUTO DI DI HEGEL.23 agosto 2024, di Federico La Sala
LA "RIFLESSIVITÀ" DI BOURDIEU, COME IL "SENSO COMUNE DEGLI SCIENZIATI", ANCORA NELLA "CAVERNA" DI PLATONE E NEL "CERCHIO DEI CERCHI" DELL’ASSOLUTO DI DI HEGEL.
- Una nota a margine della recensione di Alfonso M. Iacono *
Bourdieu e il senso comune degli scienziati
di Alfonso Maurizio Iacono (Doppiozero, 23 Agosto 2024)
Il ricercatore dovrebbe forse provare per metodo ciò che provò Vitangelo Moscarda guardandosi allo specchio quando si accorse che il suo naso era ben diverso da come pensava che fosse. Ma non deve oscillare tra l’essere uno, nessuno o centomila, deve solo essere sé stesso proprio mentre si vede come altro. Ma in fondo è ciò che dovremmo fare tutti quando ci interroghiamo e poniamo la domanda sul nostro stesso fare. Ma è difficile tanto quanto trovare una buona relazione tra conoscere e fare. È questo il dramma della limitatezza umana, perché noi, come ricorda Giambattista Vico, non possiamo conoscere e fare simultaneamente. Ma possiamo riflettere su questa impossibilità e trasformare il riflettere in un fare.
Un tempo si sarebbe detto che includere l’osservatore nel processo di osservazione sarebbe stata una perdita di oggettività del sapere scientifico, lusso che si sarebbero potuto permettere forse le scienze storico-sociali, ma non certo quelle naturali. Da qui la separazione tra le scienze storico-sociali e quelle naturali oppure la riduzione delle prime al criterio di verità determinata dall’esattezza e dall’evidenza delle seconde. Nel ‘900 invece il tema dell’inclusione dell’osservatore nel contesto dell’osservazione è diventato centrale nell’epistemologia scientifica. Ciò che precedentemente sarebbe stata considerata un’eresia è diventato un interesse metodologico centrale in fisica, in biologia, nelle scienze sociali. Negli anni ’30 del ‘900 Ludwig Fleck aveva già posto il problema dell’osservatore nel campo della ricerca, ma il suo libro, uscito nel 1935, non suscitò alcun interesse, negli anni ’60, il successo del contributo di Thomas Kuhn La struttura delle rivoluzioni scientifiche (Einaudi, Torino 1969), dipese certamente dal fatto che, come si dice, arrivò al momento giusto.
La visione di Giambattista Vico non è poi così lontana da tale interesse metodologico.
Pierre Bourdieu, nel solco del mutamento epistemologico operato da Ludwig Fleck (Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Il Mulino, Bologna 1983) e da Thomas Kuhn, ha chiesto alla sociologia qualcosa di più. Ha posto il problema metodologico dell’oggettività del soggetto scientifico che indaga e ha a che fare, a sua volta, con l’oggettività di ciò che è indagato.
Il libro Sulla riflessività (Edizione italiana a cura di G. Ienna, C. Lombardo, L. Sabetta, M. Santoro, Meltemi, Milano 2024, pp. 117) presenta quattro contributi di Bourdieu sulla riflessività che percorrono un arco della sua ricerca dagli anni ’60 agli anni ’90. Bourdieu chiama questa ricerca dell’oggettività del soggetto riflessività. Cosa significa oggettività del soggetto e cosa significa riflessività? Scrive Bourdieu: “la riflessività non è la riflessione nel senso della cogitatio cogitationis, cioè pensiero di un pensiero, riflessione di un pensiero sul mio pensiero. Non è un semplice ritorno del soggetto conoscente su sé stesso: il soggetto conoscente che prova a conoscersi. La riflessività, così come la intendo io, è effettivamente questo, ma passa attraverso un processo di oggettivazione. Il soggetto conoscente, che si tratti di un sociologo, uno storico, un etnologo e addirittura un economista, è qualcuno che possiede strumenti di conoscenza che può applicare a sé stesso, soggetto conoscente, e più precisamente all’universo sociale in cui questo soggetto conoscente è inserito” (p. 49). Si va dunque oltre l’inclusione dell’osservatore nel contesto di osservazione. Bourdieu aggiunge le condizioni oggettive in cui si trova l’osservatore scientifico quando osserva e fa le sue considerazioni.
In altre parole, la riflessività implica la localizzazione sociale del punto di vista. Si tratta di applicare il metodo sociologico di osservazione allo stesso osservatore. “L’ipotesi, continua Bourdieu, è che il soggetto conoscente non abbia accesso, per semplice riflessione, all’essenziale di ciò che è e di ciò che fa. Per accedere, deve passare attraverso un’esplorazione delle condizioni oggettive in cui è stato prodotto così com’è, e nelle quali fa quel che fa. In altre parole, si tratta di fare sociologia come la facciamo sempre, ma sull’universo delle scienze sociali, sul nostro proprio mondo, sul nostro proprio campo” (ibidem). Bisogna tenere conto degli habitus degli scienziati, di ciò che a loro appare ed è vissuto come ovvio, insomma il loro senso comune che, come direbbe Vico, in assenza di riflessione diventa pregiudizio, e che invece va interpretato criticamente. Husserl e Schutz sono qui presenti con la messa in questione del mondo dato per scontato. Ma si possono anche fare altri due riferimenti teorici, tra i molti indicati da Bourdieu. Il primo è Marx con la sua teoria del rapporto tra ideologia e classe sociale (K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, 1977). Non ci accorgiamo che le idee dominanti, le quali si presentano semplicemente come idee, esprimono l’ideologia della classe dominante. Il secondo è Wittgenstein con la sua critica a Frazer (Note sul ‘Ramo d’oro’ di Frazer, Adelphi, 1975) il quale fa apparire il passaggio dalla magia alla scienza come qualcosa di evolutivamente oggettivo e non come il suo modo di vedere il mondo.
Gli autori della Postfazione (G. Ienna, C. Lombardo, L. Sabetta, M. Santoro) chiamano il metodo di Bourdieu “razionalismo storicista... vera matrice stilistica della riflessività” (Bourdieu, cit. 101). In effetti due concetti importanti che attraversano il pensiero di Bourdieu sono quello di relazione e quello di storia. Richiamarsi alla critica degli habitus sociali e mentali del ricercatore come campo decisivo della riflessione significa richiamarsi alla loro storia e al fatto che le stesse categorie sovrastoriche dell’osservazione scientifica hanno comunque a che fare con la storia. Infine, in Bourdieu troviamo il tema del corpo. “...ci sono due modi di guardare il corpo. C’è quello di guardare il corpo altrui o di guardare il proprio corpo allo specchio come un oggetto, oppure quello che consiste nell’essere in esso, di essere con esso, di essere tutt’uno con il proprio corpo. Il punto di vista scolastico è il punto di colui che guarda gli altri è ha una filosofia dello spettatore. Possiamo andare molto oltre grazie a Maurice Merleau-Ponty e non è fare filosofia. È usare la filosofia per sbarazzarsi della filosofia che si fa quando non si ha alcuna filosofia” (ivi, p. 61). Oggi noi assistiamo a un forte ritorno a una filosofia che si fa quando non si ha una filosofia. Un vecchio tema che risorge ogni qual volta si usa la riflessione sulla conoscenza scientifica più come rassicurazione e bisogno di autorità che come ricerca critica e autonoma.
*
- NOTA:
LA RIFLESSIVITA’ DI BOURDIEU COME IL "SENSO COMUNE DEGLI SCIENZIATI" ANCORA NELLA "CAVERNA" DI HEGEL. "Gli autori della Postfazione (G. Ienna, C. Lombardo, L. Sabetta, M. Santoro) chiamano il metodo di Bourdieu “razionalismo storicista... vera matrice stilistica della riflessività” (Bourdieu, cit. 101). In effetti due concetti importanti che attraversano il pensiero di Bourdieu sono quello di relazione e quello di storia." (A. I. Iacono, cit.).
A TRECENTO ANNI DALLA NASCITA DI #KANT, NON E’ IL CASO DI DARE IL VIA A UNA #SECONDA "#RIVOLUZIONECOPERNICANA" E PORTARSI OLTRE IL #PLATONISMO E IL #PAOLINISMO DELLA #DOTTAIGNORANZA E DELLA SUA #COSMOTEANDRIA?!
#PSICOANALISI, #STORIA, E #CRITICA DELLA #RAGIONE "PURA". A mio parere, benché Bourdieu abbia fatto un lavoro eccezionale, di lui, come egli stesso dice di Freud ("mi piace citare la frase di un grande storico"), è possibile dire altrettanto: "[Bourdieu] Freud dimentica che Edipo era un figlio di re."! Non è proprio ora, con #Kafka, come con #Dante, di uscire dalla "#tana", dall’#inferno epistemologico ed antropologico della #tragedia, e ri-scoprire la nostra propria personale e politica #autonomia e #sovranità ?! Se non ora, quando?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA E CRITICA: UNA HAMLETICA QUESTIONE DI TEMPO (E DI RAPPRESENTAZIONE). Un omaggio a "Kant e all’ornitorinco" (U. Eco).18 agosto 2024, di Federico La Sala
FILOSOFIA LINGUISTICA ANTROPOLOGIA E CRITICA:
UNA HAMLETICA QUESTIONE DI TEMPO E DI RAPPRESENTAZIONE (KANT).
- In occasione dell’anniversario della nascita di Kant, un omaggio alla memoria di Umberto Eco...
SE, COME SCRIVE ERACLITO DI EFESO, "Il tempo [#aìon] è un fanciullo che gioca spostando i dadi: il regno di un fanciullo" (fr. 52), E, COME SCRIVE SHAKESPEARE NEL SUO "AMLETO", "il tempo è fuori dai cardini" ("The time is out of joint": "Hamlet", I.5), RICORDANDO KANT (1724-1804), E CONSIDERANDO "IL TEMPO ESAURITO" (Enrico Castelli, 1900-1977), alla luce di una sintetica "lezione" grafica di Umberto Eco, forse, è opportuno una ripresa di riflessione sul tema.
MEMORIA E STORIA. LA sollecitazione viene da una importante testimonianza di Franco Lo Piparo: "Mi sono ricordato di una vignetta filosofica sul tempo che Eco ideò in occasione di una mia conferenza all’Università di San Marino. Era il 26 gennaio 1995 [...]" (cfr. "UNA VIGNETTA FILOSOFICA DI ECO SUL TEMPO E ALTRE ANCORA",16 agosto 2024):
- DOMANDA DI UN ALLIEVO: "Maestro, che cosa è il tempo? E lo spazio?
- RISPOSTA DEL MAESTRO: "Non c’è spazio per dirlo... Non ho tempo..".
QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("CRISTOLOGICA"). Umberto Eco, oso pensare (#sàpereaude!"), rendeva "silenziosamente" omaggio a Kant e alla sua "Critica della ragion pura": forse, egli aveva cominciato a lavorare intorno al libro che uscirà due anni dopo, "Kant e l’ornitorinco" (Bompiani 1997 - La nave di Teseo 2016) e stava già riflettendo sul rapporto "essere e tempo" e "tempo ed essere" a livello antropologico (nel tentativo di gettare luce sul lavoro di Kant e, infine, anche di Heidegger).
NOTA:
- UMBERTO ECO, "KANT E L’ORNITORINCO", La nave di Teseo , 2016.
- OLTRE LA COSMOTEANDRIA PLATONICO-PAOLINA: LA "VIA DIRITTA" DELLA "DIVINA COMMEDIA". Kant, sul filo della "Logos" di Eraclito, recupera il "regno del fanciullo" e si porta oltre Pascal e la "pascalina" (come già oltre Hegel e la sua "civetta"), è sulla strada di Dante Alighieri, e Einstein: egli sa distinguere tra amore ("charitas") e mammona ("caritas"), sa che "Dio" non "ag-gioga" con i dadi nessuno (nemmeno Ulisse).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- PIANETA TERRA (PROMESSA): COME NASCONO I BAMBINI, COME NASCONO LE IDEE, COME NASCONO I SOGNI?16 agosto 2024, di Federico La Sala
PIANETA TERRA (PROMESSA), ONU (=UNO), E "UmaNITÀ" ("HUMANITAS"):
PROFEZIA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA-POLITICA.
- Una nota "per la pace perpetua". In #memoria di #Immanuel #Kant (1724-1804).
SE E’ VERO CHE "DA TEMPO I PROFETI PARLANO A UNA CITTA’ CHE NON LI VUOLE PIU’ ASCOLTARE!" (Nicola Fanizza), E’ ALTRETTANTO VERO CHE, DA #TEMPO, DA MOLTO TEMPO, nonostante tutta la #storia (già solo quella) dell’#arte e, in particolare, la grande lezione di #Michelangelo #Buonarroti, che sapeva anche di #anatomia e di "vecchio" e "nuovo" #testamento" , è anche colpa dei #PROFETI che hanno "silenziato" le #Sibille, hanno buttato via la #bilancia (Vermeer ), e vogliono continuare a "pesare" solo "l’ #oro"!!!
CON DANTE ALIGHIERI, GIORDANO BRUNO, GALILEO GALILEI, SPINOZA, FREUD, ED EINSTEIN, #OLTRE. Senza #Kant, solo milioni di milioni di "mille piani", vecchi "ritornelli", e "dotta ignoranza" (1440) a volontà.
NOTE:
- ANTROPOLOGIA ANATOMIA E STORIA: "COME NASCONO I BAMBINI".
- IL "TONDO DONI" E LA "PROFEZIA" DELLA "SIBILLA LIBICA" DI MICHELANGELO BUONARROTI:
- «[...] Uterus Matris erit #statera cunctorum. ("L’utero della Madre sarà la #bilancia di tutti gli esseri umani"».
- IPOTESI. Del dipinto "#Pesatrice di perle" (o "#Donna con una #bilancia) di Jan #Vermeer (databile al 1664 e conservato nella National Gallery of Art di Washington), anche alla luce del fatto che dentro il quadro c’è rappresentato un altro quadro - un dipinto con un #GiudizioUniversale - c’è da pensare, probabilmente, che la figura della donna in avanzato stato di #gravidanza rimandi alla figura della "Sibilla Libica" (raffigurata da tantissimi artisti e, in particolare, da Michelangelo nella #CappellaSistina) e al suo specifico #annuncio del #messaggio evangelico, e comunichi il rapporto che esiste tra la #bilancia (la #giustizia e l’#equilibrio), il #grembo (il #concepimento), e la nascita di un #bambino, una #bambina - una #maestra, un #maestro di #umanità...
- IPOTESI. Del dipinto "#Pesatrice di perle" (o "#Donna con una #bilancia) di Jan #Vermeer (databile al 1664 e conservato nella National Gallery of Art di Washington), anche alla luce del fatto che dentro il quadro c’è rappresentato un altro quadro - un dipinto con un #GiudizioUniversale - c’è da pensare, probabilmente, che la figura della donna in avanzato stato di #gravidanza rimandi alla figura della "Sibilla Libica" (raffigurata da tantissimi artisti e, in particolare, da Michelangelo nella #CappellaSistina) e al suo specifico #annuncio del #messaggio evangelico, e comunichi il rapporto che esiste tra la #bilancia (la #giustizia e l’#equilibrio), il #grembo (il #concepimento), e la nascita di un #bambino, una #bambina - una #maestra, un #maestro di #umanità...
- VITAEFILOSOFIA: #COMENASCONOIBAMBINI, COME NASCONO LE #IDEE, COME NASCONO I #SOGNI?
- RILEGGERE PLATONE ("SIMPOSIO")! DIOTIMA DI #MANTINEA SOLLECITA "SAN #SOCRATE" (#ERASMO) AD ANDARE DIRETTAMENTE A #DELFI E A NON #CREDERE DI CREDERE AGLI AMICI CHE LO HANNO ELETTO IL PIù #SAGGIO DI TUTTI: E’ ANCORA UN "PERFETTO FILOSOFO!" (COME #EROS, AVIDO, CIECO E PREPOTENTE) E NON CONOSCE SE’ STESSO! ( v. allegato: una "citazione" dal mio lavoro, "La #menteaccogliente. Tracce per una #svolta_antropologica", #AntonioPellicani, Roma 1991).
- ANTROPOLOGIACULTURALE E #FILOLOGIA-#POLITICA AL SERVIZIO DELL’#OCCIDENTE (325 -2025).
- UN "GIOGO" DI #SOCIETÀ: "CERCARE L’#AGO NEL #PAGLIAIO".
- Foto allegata:
 A) "CHERCHEZ LES FEMMES",
A) "CHERCHEZ LES FEMMES",
 B) "TROUVÉES: AU DERNIER RANG!"
B) "TROUVÉES: AU DERNIER RANG!"
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ANTROPOLOGIA STORIA E LETTERATURA. NOTE A MARGINE DEL "FEMMINILE E L’UOMO GRECO" DI NICOLE LORAUX.12 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, MITO, STORIA, E LETTERATURA:
"IL FEMMINILE E L’UOMO GRECO" (NICOLE LORAUX). Un omaggio e una nota a margine del lavoro di Nicole Loraux (1943-2003).
- A memoria di William Shakespeare, a Immanuel Kant, a Sigmund Freud, a Franca Ongaro Basaglia, e a Gianni Vattimo...
"SAPERE AUDE!" (KANT, 1724-2024). MUOVENDO dal lavoro della brillantissima Nicole Loraux ("Il femminile e l’uomo greco", Laterza 1991, e, Mimesis Edizioni 2024) e, in particolare, dalla sua indicazione, legata alla figura di Tiresia, che «l’uomo non è mai tanto uomo come quando ha qualcosa della donna dentro di sé», forse, è possibile orientarsi meglio sia sui temi fondamentali della sua ricerca storico-antropologica sia del problema del "chi siamo noi, in realtà" (Nietzsche).
COME IN CIELO ("URANO") COSI’ IN TERRA ("GAIA"): MITO E TRAGEDIA (EDIPO). Riconsiderando, il legame tragico (edipico) codificato giuridicamente e teologicamente già nel (prei)storico "compromesso celeste", a partire dal salvataggio e dalla messa in sicurezza da parte della #Madre-#Regina - #Rea, di "#Zeus", del #Figlio, dalle fauci dello Sposo, il Padre-Re #Crono e, poi, nel "compromesso olimpico", dal "matrimonio" tra il "Padre -Re" (Zeus) e la "Madre -Regina" (#Era), rileggere #Amleto (Shakespeare) e riprendere a tutti i livelli la sollecitazione di #Freud (con le "parole" di Era, relative all’Acheronta movebo, citate all’inizio della "Interpretazione dei sogni", bene in mente) di pensare "l’edipo completo", rianalizzare il suo lavoro relativo a "L’uomo dei topi" (e fare attenzione alle sue riflessioni sul "#matriarcato" e sul "#patriarcato") e capire cosa significa la "trappola per topi" ("The Mousetrap") di Amleto ed Ofelia per il "Padre-Re" e la "Madre-Regina" (Shakespeare). Forse, solo così, è possibile ricominciare a pensare sul #comenasconoibambini e a un’altra "Storia universale della natura e teoria del cielo" (Immanuel Kant, 1755).
NOTE:
- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1800): "IL SOGGETTO E LA MASCHERA. NIETZSCHE E IL PROBLEMA DELLA LIBERAZIONE" (GIANNI #VATTIMO, 1974).
- FILOLOGIA CRITICA E "NASCITA DELLA TRAGEDIA": SHAKESPEARE E UNA "CITAZIONE" EVANGELICA. PER AMLETO ("CRISTO"), LA "CASA DEL PADRE" CON LE SUE "MOLTE DIMORE" (Gv. 14, 2) E’ DIVENTATA UNA "PRISON" (UNA PRIGIONE):
- Hamlet: Denmark’s a prison.
 Rosencrantz: Then is the world one.
Rosencrantz: Then is the world one.
 Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." ("Hamlet", II. 2. 242-245).
Hamlet: A goodly one, in which there are many large confines, / wards, and dungeons, Denmark being one o’th’worst." ("Hamlet", II. 2. 242-245).
- FREUD CON SHAKESPEARE, ALLA RICERCA DELLA VIA OLTRE IL "MATRIARCATO" E IL "PATRIARCATO". Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo #Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The Mousetrap").
 Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita, come quello di Shakespeare, è stato quello di contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo del#nascere, del #comenasconoibambini, alla base della #nevrosi #ossessiva, non solo del "caso" dell’uomo dei #topi (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di #Danimarca".
Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita, come quello di Shakespeare, è stato quello di contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo del#nascere, del #comenasconoibambini, alla base della #nevrosi #ossessiva, non solo del "caso" dell’uomo dei #topi (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà", e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di #Danimarca".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ARTE E LETTERATURA: IL "CAMMINO" DELLE SIBILLE E DEI PROFETI DI MICHELANGELO (FIN NELLA CAPPELLA SISTINA) E LA DOMANDA ANTROPOLOGICA DI AMLETO.8 agosto 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA) E ARTE: UNA NOTA DI ANTROPOGENESI CHIASMATICA (NEXOLOGIA) E DI STORICHE COSTRUZIONI NELL’ ANALISI (S. FREUD, 1937).
I VEGGENTI E L’ IPOTESI DELLA NASCITA DELL’ESSERE UMANO (E DELLA SUA COSCIENZA) DI MICHELANGELO BUONARROTI.
- A IMMANUEL KANT (1724-1804), IN MEMORIA
IL "MESSAGGIO" DEI SETTE PROFETI E DELLE CINQUE SIBILLE NELLA VOLTA DELLA CAPPELLA SISTINA E DEI "DUE PROFETI" E DELLE "DUE SIBILLE" DELLA SACRA FAMIGLIA DEL "TONDO DONI".
- TEATRO E METATEATRO: LA LEZIONE EVANGELICA DI SHAKESPEARE. IL "RICORDO" DI AMLETO ("REMENBER ME", I.5.91) E LA SUA "ANIMA PROFETICA" ("O MY PROPHETIC SOUL! [...]"). IL "CAMMINO" DELLE SIBILLE E DEI #PROFETI DI MICHELANGELO (FIN NELLA CAPPELLA SISTINA) E LA #DOMANDA DI AMLETO (Che cos’è / Un uomo": IV. 4. 33), PER PORTARSI CON DANTE ALIGHIERI OLTRE L’ORIZZONTE DELLA "CADUTA" E DELLA "TRAGEDIA".
- ARTE TEATRO PSICOANALISI E FEDE: "IN PRINCIPIO ERA L’ AMORE" (JULIA KRISTEVA, 1987). L’#ANNUNCIAZIONE (E L’#INCARNAZIONE) NEL "TRITTICO DI MERODE" (1425) DI ROBERTCAMPIN E "THE MOUSETRAP" NELL’ HAMLET (III. 2. 247) DI SHAKESPEARE. UNA SOLLECITAZIONE A "RIPROBLEMATIZZARE" IL SIGNIFICATO DELLA "TRAPPOLA PER TOPI", NEL SUO CONTESTO (AMLETO CON LA TESTA IN GREMBO ALLA SUA PROMESSA SPOSA, OFELIA), A GUARDARE LO SPETTACOLO SULL’ "ASSASSINIO DI GONZAGO" (NEL TENTATIVO DI SMASCHERARE IL FALSO "RE-PADRE", LO ZIO ("MY UNCLE?") "SERPENTE".
- USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA: PENSARE L’EDIPO COMPLETO (S. FREUD). Tra i moltissimi contributi di Julia Kristeva, uno dei più importanti sul tema, oltre "Teresa, mon amour" dedicato a Teresa d’Avila, c’ è anche «#MelanieKlein. La madre, la follia» (tit. orig.: «Il genio femminile. La follia. Melanie Klein, o del matricidio come dolore e come creatività»). Per andare oltre la antica "alleanza" cosmoteandrica (platonico-apollinea-paolina-costantiniana) di Madre (Gea)-Figlio (Zeus), e, al contempo, uscire dall’orizzonte "infernale" della "caduta" (Dante Alighieri), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) prendere le distanze non solo dal "padre" ( il "parricidio") ma anche dalla "madre" (il "matricidio"). A suo tempo, già Shakespeare aveva mostrato (ben prima di Manzoni e dello stesso Freud) tutte le difficoltà dei "promessi sposi", Amleto e Ofelia, per capire che cosa significa la "trappola per topi" ("The Mousetrap") e cercare di portarsi fuori dalla realtà adulterina e delittuosa della tragica "famiglia che uccide" dello "stato di Danimarca".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- CON AMLETO E OFELIA, UNA "INSTAURATIO MAGNA" TEOLOGICO-POLITICA NELLA SCIA DI DANTE ALIGHIERI E GIORDANO BRUNO, ALLA WILLIAM SHAKESPEARE, NON ALLA FRANCESCO BACONE (CON IL SUO "PARTO MASCHIO DEL TEMPO").1 agosto 2024, di Federico La Sala
L’#HAMLET E UNA "INSTAURATIO MAGNA" TEOLOGICO-POLITICA NELLA SCIA DI #DANTEALIGHIERI E #GIORDANOBRUNO, ALLA WILLIAM #SHAKESPEARE, NON ALLA FRANCESCO #BACONE CON IL SUO "PARTO MASCHIO DEL TEMPO".
- Una nota sull’Hamlet, a margine dei lavori del #XXVCongressoMondialediFilosofia (Roma, 1-8 agosto 2024).
IL #TEATRO, IL #METATEATRO, E "IL #VANGELO DI #AMLETO". "THE #MOUSETRAP" ("LA #TRAPPOLA PER #TOPI" ) E IL TENTATIVO DI PORTARE ALLA LUCE L’INGANNO DEL "#SERPENTE" E RICOSTRUIRE IL "#PRESEPE", IL "#CORPOMISTICO DELLA "#SACRAFAMIGLIA" IN "#DANIMARCA":
- Una nota in omaggio al lavoro "archeologico" in progress di Paul Adrian Fried (cfr. "Part 56: "Ophelia to Hamlet: "You are as good as a chorus", July 30, 2024):
- "THOUGHT EXPERIMENT: What if Shakespeare uses Ophelia’s line to signal to audiences and readers that, in fact, one could read the whole play as if the very talkative Hamlet is a kind of chorus throughout, who sheds light on other characters, who at some moments are much more important than he is, especially in his absense?" (cit.).
RICORDANDO QUANTO detto nella nota relativa alla "Part 55" sul tema, e, in particolare, mi sia lecito, che il "rendere sempre più esplicita l’#analogia tra Amleto e Gesù, sollecita a guardare a #Ofelia... come a #MariaMaddalena, la donna della tradizione evangelica, legata strettamente alla vita stessa di Gesù (uno scrittore nato nel mio paese di origine, nel 1564, di nome Paolo Silvio, scrive nel 1599, in coincidenza con un miracolo avvenuto a #Fabriano, un’opera di grandissimo successo dal titolo "La Madalena penitente" ), forse, per meglio comprendere tutta l’mportanza del commento di Ofelia (""You are as good as a chorus") sull’operazione per smascherare il "#serpente -re" camuffato da "#topo - re", occorre rileggere e ricontestualizzare la frase (almeno a partire da Amleto, III. 2. 110 e ss.):
"#Amleto [...] (A #Polonio) Sicché, signore, un tempo avete anche voi recitato all’università. Non è così?
#Polonio Infatti, monsignore, ed ero reputato un buon attore.
#Amleto E che parte faceste?
#Polonio Giulio Cesare. Venivo pugnalato in Campidoglio. Era Bruto ad uccidermi.
#Amleto E dev’essere stato un vero bruto per uccidere un tale vitellone!
(Va a sedersi a fianco di #Ofelia) Sono pronti gli attori?
#Rosencrantz Sì, signore, aspettano soltanto un vostro cenno.
#Regina Vieni, mio buon Amleto, vieni a sederti qui, vicino a me.
#Amleto Vogliate perdonarmi, buona madre: ho qui una più attirante calamita.
#Polonio (A parte al #re) Oh, oh, avete visto?
#Amleto Posso giacermi in seno a voi, signora?
#Ofelia No, questo no, signore.
#Amleto La testa, intendo, sopra al vostro grembo.
#Ofelia Oh, questo sì, signore, accomodatevi.
#Amleto Pensavate che avessi per la mente pensieri da villano?
#Ofelia Non ho pensato a nulla, mio signore.
#Amleto È un pensiero gentile dopotutto sdraiarsi tra le gambe di ragazze.
#Ofelia Che dite, monsignore?
#Amleto Niente, niente.
#Ofelia Siete allegro, signore.
#Amleto Allegro, io?
Ofelia Così mi sembra, mio signore.").
NOTA:
- UNA "INSTAURATIO MAGNA" TEOLOGICO-POLITICA NELLA SCIA DI #DANTEALIGHIERI E #GIORDANOBRUNO, ALLA WILLIAM #SHAKESPEARE, NON ALLA FRANCESCO BACONE CON IL SUO "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" ).
- UNA "INSTAURATIO MAGNA" TEOLOGICO-POLITICA NELLA SCIA DI #DANTEALIGHIERI E #GIORDANOBRUNO, ALLA WILLIAM #SHAKESPEARE, NON ALLA FRANCESCO BACONE CON IL SUO "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" ).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- "Philosophy across Boundaries" / "La filosofia attraversa i confini": 𝐗𝐗𝐕 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐟𝐢𝐚 (Roma, 1-8 agosto 2024).31 luglio 2024, di Federico La Sala
𝐗𝐗𝐕 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐟𝐢𝐚
"Philosophy across Boundaries" / "La filosofia attraversa i confini":
𝐗𝐗𝐕 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐟𝐢𝐚 (Roma, 1-8 agosto), organizzato dalla International Federation of Philosophical Societies, dalla Società Filosofica Italiana e da Sapienza Università di Roma.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- RICONOSCER-SI: AUTONOMIA DI "UN UOMO A UNA #DIMENSIONE" (H. #MARCUSE) E "#SOGGETTI DI #DESIDERIO"31 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA E FILOLOGIA: L’EUROPA E LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024.
CON HEGEL (E PAOLO DI TARSO), OLTRE: UN PROBLEMA DI RICONOSCIMENTO, ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL PIANETA TERRA.
- Una nota sulla "com-presenza" della parola greca "#Aner", nella parola-concetto "#Anerkennung" ["An_erkennung"], termine fondamentale della concezione filosofica di Hegel.
DOPO IL FORMIDABILE PUNTO FERMO SUL TEMA DELL’#AUTOCOSCIENZA E DEL RICONOSCIMENTO MESSO DA HEGEL NELLA "#FENOMENOLOGIA DELLO #SPIRITO" (1807), una rimemorazione "storiografica" epocale (da #Delfi a #Jena, e da Socrate e Platone allo stesso Hegel), arrivati a #Paris2024, c’è ancora da riflettere ancora e ancora proprio sul "ri-conoscere" ("an_erkennen"), e, possibilmente e urgentemente, fare un passo oltre lo storico "#compromesso olimpico" della #cosmoteandria della #tragedia! Come mai dopo millenni (e, dopo Napoleone, dopo Auschwitz, e dopo Hiroshima e Nagasaki), si continua a "cantare" il #ritornello dell’ «aner», dell’«uomo» di Paolo di Tarso, e dell’universale #paolinismo:
- "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)?!
#Achegiocogiochiamo? A quali "Giochi" si vuole continuare ad aggiogare l’intero Pianeta, la "nave" Terra, nell’oceano celeste (#Keplero)?! Non è ora di cambiare rotta?! E, con #DanteAlighieri, uscire dall’#inferno?!
NOTE:
- STORIA E #METASTORIA DEL #PIANETATERRA: L’INTERA #CULTURA ACCADEMICA (LAICA E RELIGIOSA), ANCORA E PER LO PIU’, NAVIGA NELL’ORIZZONTE (v. foto allegata) DEL "#SAPIENTE" (1510) DI #BOVILLUS, IN UN #ANDROCENTRISMO CHE "IGNORA" ADDIRITTURA #COMENASCONOIBAMBINI.
- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (KANT, 2024) E STORIOGRAFIA: "L’ETHOS DEL RICONOSCIMENTO" (LUCIO CORTELLA, Editori Laterza 2023.
- CON "Hegel oltre Hegel: una teoria del riconoscimento per la filosofia contemporanea: [...] Per riproporre una rigorosa teoria del riconoscimento nell’epoca post-metafisica della svolta linguistica si tratta quindi di tornare a quel piano trascendentale che Hegel aveva giustamente individuato, senza seguirlo però nella sua “soggettivizzazione”, attingendo ad una tradizione filosofica diversa. Quest’ultima è costituita dall’etica comunicativa di Apel e Habermas, che ha avuto il merito di valorizzare la struttura etica delle relazioni comunicative e intersoggettive: lo stesso confronto argomentativo assurge a modello normativo e implica il riconoscimento reciproco degli argomentanti. [...]" (di Andrea Bianchi, #Micromega, 02 Maggio 2023).
- CON "Hegel oltre Hegel: una teoria del riconoscimento per la filosofia contemporanea: [...] Per riproporre una rigorosa teoria del riconoscimento nell’epoca post-metafisica della svolta linguistica si tratta quindi di tornare a quel piano trascendentale che Hegel aveva giustamente individuato, senza seguirlo però nella sua “soggettivizzazione”, attingendo ad una tradizione filosofica diversa. Quest’ultima è costituita dall’etica comunicativa di Apel e Habermas, che ha avuto il merito di valorizzare la struttura etica delle relazioni comunicative e intersoggettive: lo stesso confronto argomentativo assurge a modello normativo e implica il riconoscimento reciproco degli argomentanti. [...]" (di Andrea Bianchi, #Micromega, 02 Maggio 2023).
 Originally a basic concept of Hegel’s philosophy, the notion of recognition or Anerkennung has become a key concept in contemporary theorizing about issues of identity and difference and, more generally, of contemporary social, political and cultural theory. Beginning with a short survey of some different interpretations of the concept of Anerkennung that are to be found in current discussions I outline the significance of Hegel’s original notion by comparing it with an analysis of the concept of recognition brought forward by Judith Butler. My essay aims at showing how a reappraisal of Hegel’s notion of Anerkennung can provide a fruitful starting point for construing and understanding the complexity of gender-related identification processes: " (cfr. Valentina Chizzola, "Annali di studi religiosi", 10, 2009 ).
Originally a basic concept of Hegel’s philosophy, the notion of recognition or Anerkennung has become a key concept in contemporary theorizing about issues of identity and difference and, more generally, of contemporary social, political and cultural theory. Beginning with a short survey of some different interpretations of the concept of Anerkennung that are to be found in current discussions I outline the significance of Hegel’s original notion by comparing it with an analysis of the concept of recognition brought forward by Judith Butler. My essay aims at showing how a reappraisal of Hegel’s notion of Anerkennung can provide a fruitful starting point for construing and understanding the complexity of gender-related identification processes: " (cfr. Valentina Chizzola, "Annali di studi religiosi", 10, 2009 ).
ANTROPOLOGIA #CRITICA (#KANT) E #VITAEFILOSOFIA (#NIETZSCHE, "#ECCEHOMO", 1888): "LA SOCIETA’ APERTA" (KARL #POPPER) O LA SOCIETA’ CHIUSA?!
- Una nota sulla #parresia, in #memoria di Victor Hugo e della nascita di Immanuel Kant (1724-2024).
RICORDANDO la frase di #Hugo: "Io sono parigino di nascita e «parrisiano» nel parlare, dal momento che «parrhisia» in greco significa libertà" ("Notre Dame de #Paris", L. I, cap. III), OGGI, NON POSSIAMO NON DIRCI "POPPERIANI" E, AL CONTEMPO, NON DIRCI "CRISTIANI" (CON #BENEDETTOCROCE): SI TRATTA DI CAMBIARE ROTTA E ANDARE #OLTRE "L’UOMO" , OLTRE L’#ANDROCENTRISMO E LA #COSMOTEANDRIA DELL’ANTICA #ALLEANZA DELL’ORIZZONTE DELLA "CADUTA", DELLA TRAGEDIA (#PLATONE ED #HEGEL), E DEL #PAOLINISMO COSTANTINIANO (#NICEA, 325-2025).
RICONOSCIMENTO (ANERKENNUNG): RICONOSCER-SI. Tra "Parresia" (parlare chiaro e liberamente) e - #Parousia ("Parusia", #presenza del "divino" nel mondo, nell’ottica teologico-politica socratico-platonica e paolino-hegeliana), corre un rapporto "metafisico" strettissimo che dice proprio se si sta parlando con lo #spirito critico ed evangelico (di libertà uguaglianza fratellanza e sorellanza, nel rispetto della differenza e delle differenze), all’aria aperta e alla luce del Sole ("#Logos"), o nel recinto ("#Logo") dell’ombra del "dio" di turno (quale #AlessandroMagno di fronte a #Diogene di Sinope) di una "preistoria" di lunga durata.
SORGERE DELLA TERRA (#EARTHRISE): CONSIDERAZIONI IN-ATTUALI (2001). "Intorno a noi, la Terra, c’è il "cielo puro" e il "libero mare" - come scriveva Nietzsche, non ci sono gli extra-terrestri, che ci verranno a salvare o a distruggere. Gli extra-terrestri siamo noi! Cosa vogliamo fare? Forse ci conviene deporre le armi e cominciare a dialogare in spirito di verità" (Cfr. Federico La Sala, "L’enigma della sfinge e il segreto della piramide. Considerazioni attuali sulla fine della preistoria in forma di lettera aperta (a Primo Moroni, Karol Wojtyla e, p. c., a Nelson Mandela)", Edizioni Ripostes, Roma-Salerno 2001, p. 48).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA), ARTE, FILOSOFIA E STORIA. A PARTIRE DA FRANCESCO D’ASSISI, UNA QUESTIONE DI DIRITTO E DI FATTO.16 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT, 1724-2024), #STORIA, E #TEOLOGIA:
"N. S. #MONTE #CARMELO", "MADONNA DEL #CARMINE, #16LUGLIO. Un filo di memoria e di tradizione culturale europea e mediterranea, carico di teoria, che tocca nel profondo la #questione antropologica dell’attuale #presentestorico , e richiama l’eccezionale intervento "critico" e "cristico" di #TeresadAvila (1515-1582) e, al contempo, dell’opera del filosofo e teologo Jakob #Boehme (Jacob #Böhme, 1575-1624).
I CARMELITANI SCALZI NEL #REGNO DI NAPOLI (VICEREAME SPAGNOLO) E L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’#ECUMENISMO RINASCIMENTALE. Nel mio paese d’origine (#ContursiTerme, #Salerno), nella "vecchia" Chiesa della #MadonnadelCarmine, dedicata con i #CarmelitaniScalzi alla B.V. del Monte Carmelo (nel 1613), con una pala d’altare del 1608 (v. allegato), sono riemerse dopo il #terremoto del 1980 e il restauro completato nel 1989), le figure di 12 #Sibille (un richiamo forte ed esplicito alla lezione umanistico-rinascimentale, e a #Michelangelo #Buonarroti e alla sua "Sacra Famiglia" - il #TondoDoni).
NOTE:
- ANTROPOLOGIA, ARTE, STORIA, E FILOLOGIA. RICORDANDO IL TONDO DONI ("LA SACRA FAMIGLIA") DI #MICHELANGELO, ACCOGLIERE LA SOLLECITAZIONE DI #TERESA D’AVILA A RESTITUIRE ONORE E #GLORIA A SAN GIUSEPPE.
- TEATRO, METATEATRO, E FILOLOGIA. Amleto: "Oh! La mia anima profetica! Mio zio?" (#Shakespeare, "#Hamlet", I.5). Per duemila e più anni in un #letargo profondissimo, da #preistoria, incapaci di distinguere tra il Figlio di "Dio" ("#Charitas", "#Xapitas") e il Figlio di "Mammona" ("#Caritas").
- Arte, Antropologia, e "Dotta Ignoranza": "L’ interpretazionedeisogni" (1899) e il "Disagio della civiltà" (S. Freud, 1929). Se è vero, come è vero che ogni essere umano nasce da "Maria e Giuseppe", il discorso e la riflessione sulla figura di san Giuseppe ("de domo David") non può non essere "biblica" (richiama infatti l’interprete dei sogni del Faraone, "Giuseppe e i suoi fratelli", di cui si è occupato anche Thomas Mann). In generale, non è possibile pensare che, pur di non seguire #Giuditta e tagliare la testa a #Oloferne e #Davide a #Golia, e, fare chiarezza sulla #hamletica #questione antropologica (e cristologica), la tradizionale chiesa costantiniana (#Nicea, 325-2025) ha difficoltà a celebrare la figura di san Giuseppe in tutta la sua gloria (di "patrono"), di diritto (secondo la legge), e di fatto (secondo la natura), accogliendo l’indicazione e la lezione del #presepe di #Francesco di #Assisi e di #DanteAlighieri che, già con il Galileo e prima di #Galileo Galilei, pensarono a "Maria e Giuseppe" come a "#Due Soli" terrestri che sono mossi dall’#amore "che move il sole e le altre stelle"?!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA E METATEATRO (SHAKESPEARE). UNA NOTA SULLA "MOUSETRAP" ("LA TRAPPOLA PER TOPI") DI "AMLETO"8 luglio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, STORIA, E METATEATRO (SHAKESPEARE).
"THE MOUSETRAP" ("LA TRAPPOLA PER TOPI") DI "AMLETO" E IL CASO DEL "PIFFERARIO" DELLO "STATO DI DANIMARCA".
"SAPERE AUDE!" (Q. ORAZIO F. ; KANT, 1784; M. FOUCAULT, 1984). AL DI LA’ DEL MACHIAVELLISMO E DELL’ #ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO PLATONICO-PAOLINO, a mio parere, ciò che resta del "discorso filosofico della #modernità" (J. Habermas), come ha riepilogato Kant alla fine del suo lungo lavoro di critica delle pretese della "olimpica" #ragione "pura", è proprio quanto indicava quel "Socrate pazzo" di Diogene ("Amleto"): la domanda antropologica, vale a dire il gioco del "gatto" e del "topo" (Shakespeare, "Hamlet", III. 4. 203-212), la questione "hamletica" del "come nascono i bambini" (e non solo)!
NOTE:
- STORIA FILOSOFIA E LETTERATURA: "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO, 1632).
 RICONSIDERARE #UmaNA-MENTE, ANTROPOLOGICA-#MENTE, "LA NOSTRA #SEMENZA" (INF. XXVI, 118) E PORTARSI AL DI LA’ DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE), FUORI DALL’ #INFERNO EPISTEMOLOGICO, E RIPRENDERE LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEOGALILEI, 1611).
RICONSIDERARE #UmaNA-MENTE, ANTROPOLOGICA-#MENTE, "LA NOSTRA #SEMENZA" (INF. XXVI, 118) E PORTARSI AL DI LA’ DEL "MARCIO NELLO STATO DI DANIMARCA" (SHAKESPEARE), FUORI DALL’ #INFERNO EPISTEMOLOGICO, E RIPRENDERE LA #NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEOGALILEI, 1611).
- STORIA FILOSOFIA E LETTERATURA: "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (GALILEO, 1632).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA LEZIONE DI SHAKESPEARE E DI COLLODI: CON AMLETO (ED EDIPO), A SCUOLA DA MACHIAVELLI (FREUD E BONAPARTE).7 luglio 2024, di Federico La Sala
CON AMLETO (ED EDIPO), A SCUOLA DA MACHIAVELLI: TEATRO (FILOSOFIA) E METATEATRO (METAFILOSOFIA).
QUANDO IL "TOPO" DIVENTA UN "#GATTO" (UNA "GATTA") E SVELA IL "GOLPE" (DEL "LIONE"). Una traccia per una ri-lettura dell’opera di Shakespeare ...
- In memoria di Sigmund Freud e Marie Bonaparte...
SHAKESPEARE E COLLODI. Se è vero, come è stato detto da qualcuno, che "L’ Amleto è antiamletico come Pinocchio è antipinocchiesco; totalmente e quindi ambiguamente", c’è da chiarire e precisare che Amleto non diventa un "ragazzino per bene" (un "Pinocchio"), ma vince la sua battaglia (personale e politica), resta fedele a se stesso, alla Legge, e al ricordo del Padre-Re, e restituisce onorevolmente a "Fortebraccio" la #corona della "Danimarca".
UNA QUESTIONE DI #STATO: "IL PRINCIPE". Se la "sconfitta" di Pinocchio passa per la morte e l’impiccagione (cap. XV) prima e poi per la falsa "rinascita" finale (Geppetto: "quando i ragazzi cattivi diventano buoni", cap. XXXVI), al contrario, la "storia" di Amleto passa per il ribaltamento della posizione e la vittoria: "Stasera si recita in presenza del re:/ una scena del dramma s’avvicina ai fatti/che t’ho detto sulla morte di mio padre. /Ti prego, quando vedi cominciare quell’episodio /con tutto l’acume della tua anima osserva mio zio." (III. 2.85-90).
LA VOLPE E IL LEONE. "Sendo, dunque, uno principe necessitato sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione; perché il lione non si defende da’ lacci, la golpe non si defende da’ lupi. Bisogna, adunque, essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi." (N. Machiavelli, "Il Principe", cap. XVIII).
EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA ATTIVA E CRITICA: UN GATTO ("THE MOUSETRAP") E UN ("SERPENTE" CAMUFFATO DA) "TOPO". Amleto, ben consapevole (come chiarisce a Orazio) del fatto che, «se la sua [del Re Claudio] colpa occulta non si stana a un certo discorso, è uno spettro dannato quello che noi abbiam visto» (III.2. 90-92), per chiarire a sé stesso e a tutti e a tutte i dubbi, da "cacciato" si fa "#cacciatore" e aziona la "trappola per topi" ("The Mousetrap"), per mostrare come chiarire gli "amletici" dubbi: "Questo dramma è la rappresentazione di un assassinio compiuto a Vienna. Gonzago è il nome del Duca, quello di sua moglie Battista. [...] l’assassino è un certo Luciano, #nipote del Re [...]. Lo avvelena nel #giardino per prendergli il #regno. Il suo nome è Gonzago. La storia è dei nostri giorni, e scritta in italiano scelto. Ora vedrete come l’assassino ottiene l’#amore della moglie di Gonzago" (III.2.247).
NOTE:
- STORIA FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA (KANT, 2024): CON LA EVANGELICA E FRANCESCANA "REGALITA’ ANTROPOCENTRICA DI #DANTE" ( * ), NON CON IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO" DELL’ANDROCENTRISMO PLATONICO-PAOLINO DI FRANCESCO BACONE. CON IL RIFERIMENTO al tema del #giardino e del #serpente ("Amleto", III.2), Shakespeare colloca la "riflessione" di Amleto nell’orizzonte del suo tempo (ricordare la Riforma Protestante, la Riforma Anglicana, Giordano Bruno, e Tommaso Campanella, Elisabetta I d’Inghilterra sul trono e sull’altare) e, in consonanza, nel solco e in continuità con il programma antropologico e teologico di Dante: andare oltre la "#caduta" (di Eva e di Adamo) e restituire a "Maria" ("Gertrude") e "Giuseppe" ("Amleto") la loro regalità antropologica (non platonico-demiurgica e cosmoteandrica) e la loro genitorialità di ogni Bambino ("Amleto" /"Cristo") del loro "stato di Danimarca".
- * Cfr. E. H. #Kantorowicz, "I #duecorpi del re. L’idea di regalità nella #teologia politica medievale" (cap. "VIII. La regalità antropocentrica: Dante"), Einaudi.
- FRANCESCO BACONE, IL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO", E LA "VIRGINIA COMPANY". "#Francis #Bacon, latinizzato in Franciscus Baco (-onis) e italianizzato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 - Londra, 9 aprile 1626), è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart. [...] Dopo privatizzazione delle terre, come uomo politico concettualizzò la scienza del terrore assecondando e sostenendo le deportazioni di massa dei diseredati e dei poveri nelle colonie americane della #Virginia. Tra le altre cose è necessario ricordare che nel 1619 il Consiglio Privato, di cui a quel tempo Bacone faceva parte, violando apertamente la legge inglese, e per assecondare la volontà della Virginia Company, costrinse alla deportazione nelle colonie americane ben 165 bambini, provenienti dal Bridewell Palace. Di quei 165 bambini (di età compresa tra gli 8 e i 16 anni) nel 1625 a seguito dei maltrattamenti subiti nelle piantagioni ne rimasero in vita solo dodici. Le deportazioni continuarono coinvolgendo altri millecinquecento bambini nel 1627 e ulteriori quattrocento, di origine irlandese, nel 1653 [...]".
- INFANZIA, STORIA, E LETTERATURA. Carlo Collodi, "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino (1881-1883),Cap. 15
- AMLETO (#HAMLET): LA "TRAPPOLA PER TOPI" ("THE MOUSETRAP") E IL PRINCIPE MOSCHETTIERE ("THE MUSKETEER PRINCE") ...
- UN OMAGGIO AI "#TRE MOSCHETTIERI", AL CAPOLAVORO DI #ALEXANDRE #DUMAS: «Non credete ai denigratori. "I tre moschettieri" emana un vero profumo storico: non meno di "Guerra e Pace"; un #profumo che Dumas ricava con #astuzia e #grazia dalle memorie, dalle lettere e dai romanzi del primo #Seicento.».
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- NE’ MATRIARCATO, NE’ PATRIARCATO: CON FREUD E BACHOFEN, NELLO SPIRITO DELL’UNITA’ D’ITALIA E DELLA COSTITUZIONE.23 giugno 2024, di Federico La Sala
STORIA DELL’ARTE, DELLA RELIGIONE, DELLA FILOSOFIA:
FEDE E PROPAGANDA DELL’ANDROCENTRISMO RINASCIMENTALE (PLATONICO-PAOLINO).
- UNA TRAGEDIA DI LUNGA DURATA. Una nota a margine di cinquecento anni di vita europea, all’ombra della #dottaignoranza e della boria delle nazioni...
"DE HOMINIS DIGNITATE" (PICO DELLA MIRANDOLA, 1496). Se la cultura europea (laica e religiosa) continua, ieri come oggi, a orientarsi nel pensiero e nella realtà, secondo l’instaurazione teologico-politica "olimpica" (al seguito di #Apollo e di #Atena), «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, "Eumenidi"), e a celebrare acriticamente la tradizione filosofica della "Scuola di Atene" (Raffaello Sanzio, 1509-1511) e la "mappa mentale" del "De Sapiente" (1510) di Charles de Bovelles - Bovillus, come è possibile uscire dall’orizzonte "edipico" della tragedia e, con la sollecitazione e la guida dell’eretico #DanteAlighieri, uscire dallo storico inferno (antropologico ed epistemologico, teologico e politico) "dell’autunno del medioevo" e dell’ uomo del rinascimento?!
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI, E DIRITTO (COSTITUZIONE). Se è vero, come riconosce Sigmund Freud nel 1909 (nell’affrontare il caso dell’«uomo dei topi»), che "un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal #matriarcato al #patriarcato", è altrettanto vero, come aveva già pensato e anticipato Bachofen nel 1861 (nell’anno stesso della Proclamazione del Regno d’Italia e del primo anniversario dell’Unità d’Italia, come da sottolineatura di Eva Cantarella), che, "[...]svincolandosi da ogni zavorra o mistura materiale, il diritto diventa #amore. Proprio l’amore è il diritto supremo, la legge più alta" (J. J. Bachofen, "Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia nel mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici").
Note:
- ANTROPOLOGIA CULTURALE E STORIA: BACHOFEN E "IL MATRIARCATO".
- ANTROPOLOGIA E CIVILTA’: ANATOMIA E COSTITUZIONE DELL’UOMO E DELLA DONNA. RIPRENDERE IL FILO DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA IN #MEDICINA E ACCOGLIERE L’AMMISSIONE DI GIOVANNI AMUSCO DE VALVERDE (1560):
"Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono, sapendo, che elleno hanno anchora i testicoli, come gli uomini; e che non solo sopportano il travaglio di nutrire la creatura dentro suoi corpi, come si mantiene qual si voglia altro seme nella terra, ma che anche vi pongono la sua parte, e non manco fertile, che quella degli uomini, poi che non mancano loro le membra, nelle quali si fa; pure sforzato dall’historia medesima non ho potuto far altro. Dico adunque che le Donne non meno hanno testicoli, che gli huomini, benche non si veggiano per esser posti dentro del corpo [...]: così inizia il cap. 15 del Libro III dell’ Anatomia di Giovanni Valverde, stampata a Roma nel 1560, intitolato “De Testicoli della Donna” (p. 91).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). ---OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO.18 giugno 2024, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) ED #ENIGMA DELLA #SFINGE (EGITTO E GRECIA): CON SHAKESPEARE E FREUD, OLTRE LO "SCILLA E CARIDDI" DEL "MATRIARCATO" E DEL "PATRIARCATO.
- Una nota a margine dell’#Amleto e dell’#Uomo dei #topi ...
La #question di #Amleto (#Hamlet) è "BIBLICA" E "COSMICA". Si tratta di uscire dalla "preistoria" (#Marx), e di andare oltre la grande instaurazione di Zeus/Apollo/Atena, accettata e sopportata per compromesso "storico-olimpico" da Era/Giunone (#Freud pone #Giunone nella "testa" della sua "#Interpretazione dei #sogni" (1899). The #Mousetrap, teatro nel teatro del mondo planetario terrestre, è per fare affiorare alla coscienza (quanto ha già capito Francesco d’Assisi e Dante Alighieri) e andare oltre "#Adamo ed #Eva": #Amleto ("Gesù") è Figlio del Re #Amleto ("#Giuseppe") e della Regina #Gertrude ("#Maria"). Ciò che dice Freud, in una nota del testo di "L’uomo dei #topi" richiama un problema all’ordine del giorno dell’umanità: comporre in spirito di giustizia e amore la guerra tra #matriacato e #patriarcato, e, riprendere il cammino con tutte le "#sibille" e con tutti i "#profeti" (come da indicazione già di Michelangelo Buonarroti).
- Nota:
TEATRO (#FILOSOFIA) E #METATEATRO (#METAFILOSOFIA): #COSMOTEANDRIA #BOVILLUS-SIANA (#Androcentrismo, 1510) E #ANTROPOLOGIA #COPERNICANA (#COPERNICO 1543 - #KANT2024). Ricordare che il #mondo non è il #mappamondo e "la #mappa non è il #territorio" (Korzybski - Bateson). E la #question è quella di #DanteAlighieri, come di #GalileoGalilei, e di #Kant: #apriregliocchi sul "marcio nello stato di #Danimarca" (#Hamlet, I.4) e uscire dall’orizzonte della #tragedia.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- UNA QUESTIONE DI ASTRONOMIA COPERNICANA (E DI PATERNITA’): LA TRAPPOLA PER I TOPI DI AMLETO E IL PROBLEMA DEL PADRE PER FREUD.16 giugno 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E DISAGIO DELLA CIVILTA’: COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! *
 Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).
Con Dante, Michelangelo e Shakespeare, una nota a margine della questione antropologica (e cristologica).- Un omaggio alla memoria di Mario #Lavagetto.
FREUD (CON SHAKESPEARE), A LONDRA. Contrariamente a quanto si pensa, la lunga ricerca di #Freud, se può apparire (come è apparso per lo più fino ad ora) segnata dalla figura di #Edipo e #Giocasta, dall’altra è molto prossima a quella di #Amleto (#Hamlet), dalla volontà e dal progetto di chiarirsi le idee su di sé, e di suo Padre - di chi è veramente #Figlio: la sua opera, una vera e propria "trappola per topi" ("The #Mousetrap"). Egli, in verità, è andato (come si sa) a "scuola" da Shakespeare, e il problema della sua vita è come quello di Shakespeare, contribuire a sciogliere il #nodo di #Ercole, il nodo della nevrosi ossessiva non solo del caso dell’#uomo dei #topi" (1909), ma "della civiltà" e "nella civiltà" e contrastare il dilagare alluvionale del "marcio nello stato di Danimarca":
RIVOLUZIONECOPERNICANA (#KANT2024). Sigmund Freud: Lichtenberg (17442-1799) "osserva: «L’astronomo sa se la luna sia abitata o no, all’incirca con la stessa sicurezza con cui sa chi sia stato suo padre, ma con ben altra sicurezza sa invece chi è sua madre». Un gran progresso della civiltà si compì il giorno in cui l’uomo decise di avvalersi, accanto alla testimonianza dei sensi, della deduzione logica e di passare dal matriarcato al patriarcato. Le figure preistoriche in cui si vede una piccola forma umana seduta sul capo di un’altra più grande rappresentano appunto la discendenza dal padre, Atena senza madre scaturisce dal capo di Giove. Ancor oggi, in tedesco, il testimone che attesta qualcosa davanti a una corte giudicante si chiama #Zeuge [«testimone», letteralmente «generatore»], per la parte che ha il maschio nell’atto di procreazione; già nei geroglifici troviamo rappresentato il testimone con l’immagine dei genitali maschili." (cfr. S. Freud, "Racconti analitici, a cura di Mario Lavagetto, Einaudi 2011).
* Sul tema, cfr. Federico La Sala, "Cosa succede in casa - nella “camera nuziale”, e cosa succede in Parlamento - nella “camera reale”?! Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud..
NOTE:
- SHAKESPEARE, GERTRUDE ("DE #NIVELLES), E FREUD: TEATRO E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA.
- LO SPIRITO ("GHOST) DI #RE - #PADRE #AMLETO ("RICORDATI DI ME", I.5) E LA #TRAPPOLA PER #TOPI DEL #PRINCIPE - #FIGLIO AMLETO ("THE #MOUSETRAP", III.2): UNA LEZIONE DI STORIA DELL’ARTE (DEL 1427) SULLA "MOUSETRAP" E SULLA QUESTIONE ANTROPOLOGICA (E CRISTOLOGICA) DEL PITTORE FIAMMINGO ROBERT CAMPIN.
- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "CRITICA DELLA RAGION PURA": CON KANT, FREUD, MUSATTI, E FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’ UOMO COL #MAGNETOFONO (J.-J. ABRAHAMS), UNA GENIALE E HAMLETICA "TRAPPOLA PER #TOPI".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- RICORDANDO LA "GINESTRA": GIACOMO LEOPARDI, NELL’ORIZZONTE COPERNICANO DI KANT E DI FREUD15 giugno 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, STORIA E LETTERATURA, E (DISAGIO DELLA) CIVILTA’: GIACOMO LEOPARDI, NELL’ORIZZONTE COPERNICANO DI KANT E DI FREUD. Una nota a sua memoria...
RICORDARE che Giacomo Leopardi (Recanati, 29 giugno 1798 - Napoli, 14 giugno 1837 ), a introduzione del testo della "Ginestra o il fiore del deserto" (1836), abbia premesso le parole riprese dall’evangelo di Giovanni (III,19) "Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἂνθρωποι/ μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς ("E gli uomini amarono/ piuttosto le tenebre che la luce" (Giovanni III, 19), è una valutazione radicale di denuncia della scelta fatta.
 Il "giudizio" della "lenta ginestra" sull’umanità che ha amato (v. "ἠγάπησαν") le tenebre e non la luce, dice di una #negazione dell’ ἀγάπη, dello stesso «amore» cristiano, che in qualche modo richiama le considerazioni fatte da Kant nella "Fine di tutte le cose" ) e, al contempo, anche le riflessioni di Freud sulla svolta data da Paolo di Tarso nella "gestione" del messagio evangelico: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).
Il "giudizio" della "lenta ginestra" sull’umanità che ha amato (v. "ἠγάπησαν") le tenebre e non la luce, dice di una #negazione dell’ ἀγάπη, dello stesso «amore» cristiano, che in qualche modo richiama le considerazioni fatte da Kant nella "Fine di tutte le cose" ) e, al contempo, anche le riflessioni di Freud sulla svolta data da Paolo di Tarso nella "gestione" del messagio evangelico: "[...] Poi che l’apostolo Paolo ebbe posto l’amore universale tra gli uomini a fondamento della sua comunità cristiana, era inevitabile sorgesse l’estrema intolleranza della Cristianità contro coloro che rimanevano al di fuori" (S. Freud, "Disagio della civiltà", 1929).NOTE:
- MEMORIA E POESIA: LA GINESTRA. "La ginestra o Il fiore del deserto è la penultima lirica di Giacomo #Leopardi, scritta nella primavera del 1836 a Torre del Greco nella villa Ferrigni e pubblicata postuma nell’edizione dei Canti nel 1845. [...]".
- Storia dell’#astronomia dalle orgini al duemila e oltre (di Leopardi Giacomo, Hack Margherita )
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI: CHE COSA CERCAVA FREUD IN ITALIA? Una nota a margine del lavoro di Marina D’Angelo, su "I viaggi di Freud in Italia".14 giugno 2024, di Federico La Sala
L’ ITALIA, METAFORA DEL GIARDINO: SIGMUND FREUD (E DANTE ALIGHIERI) ALLA RICERCA DELLA VIA D’USCITA DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA (E DELLA "CADUTA" LUCIFERINA ALL’INFERNO).
- Una nota a margine del lavoro di Marina D’Angelo, su "I viaggi di Freud in Italia" (Boringhieri 2024) *
USCIRE DA SE’ PER CERCARE LA "ANTICA TERRA" E RI-TROVARE "I PROPRI #GENITORI". Come #DanteAlighieri, con #Virgilio ("dolcissimo patre"), così Sigmund #Freud, con più difficoltà edipiche (con il suo padre #Jakob): entrambi cercano "l’antica madre" (#Eneide, III, 116-117), il "sogno di una cosa" (K. #Marx), il "giardino dell’Impero" l’uno, la "Terra promessa" l’altro.
DANTE, MILTON, E FREUD. Alla fidanzata #Martha, il 7 agosto 1882, Sigmund Freud scrive che, nel "Paradiso perduto" (John Milton, 1667), «ancora di recente, in un momento in cui non mi sono sentito sicuro del tuo amore, ho trovato consolazione e conforto».
AMARE L’ITALIA. Freud, confidando nell’amore di sua madre #Amalia (#Nathanson), come Dante, nell’amore di sua madre, la "#Bella e beata", "#Beatrice"), l’uno, come l’altro, affrontano un lungo cammino per risalire "salomonicamente" la corrente, e, finalmente, ritrovare al di là della dell’inferno e della tragedia, "l’antica matre" ("#Eva") e l’antico padre ("#Adamo"), e, finalmente, rigenerarsi nell’acqua viva dell’#amore "che muove il sole e le altre stelle" (Par. XXXIII, 145).
COSMOLOGIA #POESIA E #LOGOS. Quando avremo sondato l’Universo alla ricerca della nostra incapacità di dominarlo e di capirlo, dovremo ritornare al Poeta e concludere che a muover il Sole e le altre stelle (a muoverle, ma non a spiegarle) è l’Amore. Allora la nostra fede non sarà più liberatrice, ma deduttiva, accettata per la nostra incapacità di andare oltre. Crederemo perché è evidente, non perché è assurdo." (#ENNIO #FLAIANO, "DIARIO DEGLI ERRORI", 1967).
- NOTE:
* MARINA D’ANGELO, "I VIAGGI DI FREUD IN ITALIA. LETTERE E MANOSCRITTI INEDITI", BORINGHIERI 2024:
- "Nella primavera del 2009, tra gli scaffali della Library of Congress di Washington D.C., Gerhard Fichtner e Albrecht Hirschmüller fanno una scoperta sorprendente: mentre sono intenti a fotografare alcuni documenti inediti presso la Manuscript Division, si imbattono in un contenitore mai esaminato prima con dieci scomparti, ciascuno con un piccolo taccuino. Realizzano così di aver ritrovato i taccuini tascabili che Sigmund Freud portava con sé durante i suoi viaggi e che fino ad allora erano stati considerati perduti. Si tratta di materiali sfuggiti - forse per un caso fortuito - all’opera di distruzione di documenti autobiografici operata da Freud stesso. [...]".
- CHE COSA CERCAVA FREUD IN ITALIA? “Così voglio sfuggire a me stesso” - I viaggi in Italia di S. Freud, di M. D’Angelo". Alla scoperta delle tracce di S. Freud in Italia e degli influssi dei viaggi italiani nella sua vita e nell’opera. Un vero e sostanziale contributo alla biografia e all’opera di Freud (di Prof. Dr. Jörg Robert, Università di Tubinga, "LA SPI" - WEb, 5/05/22).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL FILO (SPEZZATO) DELL’ONDA RINASCIMENTALE: KAFKA, IL BAMBINO DI PRAGA, E UNA "ARCHAICA" PREMESSA DI CIVILTÀ.8 giugno 2024, di Federico La Sala
FRANZ KAFKA, IL #BAMBINO DI PRAGA, E UNA "ARCHAICA" PREMESSA DI CIVILTÀ.
 UNA NOTA di ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT2024), SULLO STORICO PRESENTE DELL’#EUROPA:
UNA NOTA di ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (#KANT2024), SULLO STORICO PRESENTE DELL’#EUROPA:- STORIA E #STORIOGRAFIA. In memoria di Enzo Paci, Carlo Maria Martini, e Franca Ongaro Basaglia...
"[...] Sull’orlo dell’abisso, non ci resta che venir fuori dallo stato (cartesiano-hegeliano) di sonnambulismo: seguire il filo del corpo (l’ombelico!), riacchiappare il senso della vita, e riattivare la memoria delle origini. Con Kant, con Feuerbach, con Marx, con Nietzsche, con Freud, con Rosenzweig, con Buber, e con Kafka ... si tratta di capire il significato della “spada” impugnata dalla “statua della Libertà”, ritrovare “la fotografia dei genitori” (cfr. America) e riconciliarci con lo spirito di quei due esseri umani, di quei due io, che hanno fatto UNO e dato il via alla più grande rivoluzione culturale mai verificatasi sulla Terra - la nascita di noi stessi e di noi stesse e dell’intero genere umano - e riprendere il nostro cammino di esseri liberi e sovrani, figli della Terra e dello Spirito di D(ue)IO. Camminare eretti, senza zoppicare e con gli occhi aperti, è possibile. Non è un’utopia. Milano,20.01.2001 d.C».
NOTE:
- "EROS E #CIVILTÀ" (H. MARCUSE). UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI #ANTROPOLOGIA (DA PORRE ALL’ORDINE DEL GIORNO, PER EVITARE... UN ARROSSIMENTO GENERALE):
- "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1978).
- LA STELLA DELL’ORCAGNA (SUL TABERNACOLO DI ORSANMICHELE), LA MEMORIA DEL PRESEPE DI GRECCIO, E IL DISAGIO DELLA CIVILTA’, OGGI (EUROPA, 6 GIUGNO 2024):
- "[...] oggi non possiamo che riaprire la mente e il cuore alle domande fondamentali e cercare di dare a noi stessi e a noi stesse le risposte giuste: Come nascono i bambini? Come nascono le bambine? Qual è il principio di tutti gli esseri umani? Come si diventa esseri umani? Come io sono diventato Io? Cosa significa che io sono il figlio, la figlia, dell’UNiOne di due esseri umani?... Essi avevano cominciato a capire l’enigma antropologico dell’Egitto dei Faraoni, delle loro Piramidi e delle loro Sfingi, e il ’segreto’ di Betlemme, del presepio di Greccio (1223) e di Francesco e Chiara di Assisi. [...]" (cfr. Cfr. Federico La Sala, "L’enigma della Sfinge e il segreto della Piramide. Considerazioni attuali sulla fine della preistoria..., Edizioni Ripostes, Roma-Salerno 2001, pp. 7-8).
- A CHE #GIOGO GIOCHIAMO? #STORIAELETTERATURA E #STORIOGRAFIA. ANCORA non è tempo di uscire dal #letargo (#DanteAlighieri, Par. XXXIII, 94) e rileggersi "#Cristo si è fermato ad #Eboli". L’EUROPA, LA LUCANIA, E LA GUERRA DI #TROIA: L’ANALISI DI CARLO LEVI.
- RODOLFO II D’ASBURGO (L’IMPERATORE "GIARDINIERE"), IL #GIARDINO DEI CARMELITANI, E IL "BAMBINO GESÙ" DI #PRAGA:
- "Chiesa della Vergine Maria Vittoriosa - Il Gesù Bambino di Praga (Kostel Panny Marie Vítězné)
- Questo edificio in stile primo barocco risale al 1611 e tra il 1634 ed il 1669 fu ristrutturato dall’ordine dei Carmelitani. La chiesa è conosciuta soprattutto per la #statuetta del #Gesù #Bambino di Praga, proveniente dalla #Spagna e donata ai Carmelitani da #Polyxena di #Lobkowicz (1628). [...] La chiesa venne edificata dai luterani tedeschi tra il 1611 ed il 1612 e, poi, fu consacrata alla Santissima Trinità. [...] assomiglia molto alla chiesa di Neubirg sul Danubio, realizzata da #Josef #Heintz, un artista di corte di #Rodolfo II [1552 - 1612]. [...] Nel 1624, dopo la vittoria degli antiriformisti, Ferdinando II donò la chiesa all’ordine dei #CarmelitaniScalzi, ai quali andava il merito della vittoria delle truppe imperiali nella battaglia sulla #Montagna #Bianca [1620]. Questi la consacrarono alla Vergine Maria Vittoriosa [...] Nei pressi del monastero costruirono il #Giardino del seminario [...]".
IL "SAPERE AUDE" (#ORAZIO), LE "FRUTTIFERE" OPERE DELL’IMPERATORE RODOLFO (ARCIMBOLDO), E LA "PACE PERPETUA" (#KANT): #ARTE, #LETTERATURA, TEOLOGIA-POLITICA E... "PARADISO PERDUTO" (JOHN #MILTON)?!
- STORIA E #STORIOGRAFIA. Dopo la lezione (incompresa) di Arcimboldo (5 aprile 1527 - 11 luglio 1593), l’umanità (tutta) non ha ancora capito nulla della vita sulla #Terra e dell’importanza di aver #cura dell’edenico #giardino terrestre, e cosa fa?: continua a #pestare acqua nel #mortaio, e, si prepara a trasformare il paradiso (il giardino) sempre più in un #deserto "marziano"! Boh e bah?!
- UNA #HAMLETICA #QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA: "L’#ULTIMA #CENA"?!. NON è forse meglio riprendere l’indicazione oraziana sul "#sàpere aude" e interrogarsi criticamente con Immanuel Kant (1784) e #MichelFoucault (1984) sul "prendete e mangiate" (sul #corpomistico, ateo e devoto) e sulla "#piramide" androcentrica della fattoria del "Sapiente" (1510) #Bovillus e smetterla di continuare a #impestare la Terra con l’acqua del bellico "mortaio"!
***
LA LUNGA ONDA DEL #RINASCIMENTO, IL SOGNO "UTOPICO" DEL GIARDINO, E IL "CORPO MISTICO" DELL’IMPERATORE RODOLFO II D’ASBURGO...
- ... se non si sa fare un buon uso del proprio "io", come è possibile farlo del proprio "dio"?!
LA LEZIONE DI ARCIMBOLDO ( https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo ): UN GRANDE INVITO AD AVERE L’ORAZIANO (E KANTIANO) CORAGGIO DI ASSAGGIARE E A FARE UN BUON USO DELLA PROPRIA FACOLTÀ DI #GIUDIZIO.
NOTE:
- ARTE E STORIA. Il Louvre restaura le Quattro Stagioni di Giuseppe Arcimboldo (di Redazione, Finestre sull’Arte, 07/06/2024): "Termina al Louvre il restauro, durato otto mesi, delle Quattro Stagioni di Giuseppe Arcimboldo. I quattro dipinti sono ora di nuovo esposti al pubblico.[...]".
- MUSEO DEL #POMODORO. Il “Vertumno” di Giuseppe Arcimboldo. Realizzato nel 1590 il quadro ritrae lo stesso imperatore Rodolfo II, il cui profilo fiero e maestoso è riprodotto in pieno stile Arcimboldo. Il naso non è altro che una pera, poggiata su due enormi pesche, le guance, e attorniato da grappoli d’uva e spighe di grano, che formano la capigliatura del grande condottiero. Un occhio attento potrà individuare molti altri elementi sul volto di Rodolfo, fin troppi da menzionare. [...]".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL PROBLEMA DEL CORPO MISTICO, IL "SAPERE AUDE" E L’ ANALFABETISMO ANTROPOLOGICO-POLITICO E30 maggio 2024, di Federico La Sala
IL "CORPO MISTICO" (IL MOTTO DEI MOSCHETTIERI: "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO"), L’ANTROPOLOGIA-POLITICA E LA COSTITUZIONE (L’ISOLA DEL "CONTE DI MONTECRISTO").
- "UT UNUM SINT": LA FILOSOFIA E LA FILOLOGIA AL SERVIZIO DEI "PARTITI-NAZIONI" O DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL PIANETATERRA (DELL’ UmaNiTA’, DELL’ONU)?!
"ORIENTARSI NEL PENSIERO" (#KANT2024). Una "vecchia" nota in memoria di Alexandre Dumas, e, delle 21 "Moschettrici" (le Donne, le "Madri della Costituzione" della Repubblica Italiana):
- "[...] La Costituzione è - ripetiamo: come ha detto e testimoniato con il lavoro di tutto il suo settennato il nostro Presidente, Carlo A. Ciampi - la nostra “Bibbia civile”, la Legge e il Patto di Alleanza dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ Costituenti (21 cittadine-sovrane presero parte ai lavori dell’Assemlea), e non la ’Legge’ di “mammasantissima” e del “grande fratello” ... che si spaccia per eterno Padre nostro e Sposo della Madre nostra: quale cecità e quanta zoppìa nella testa e nel cuore, e quale offesa nei confronti della nostra Legge dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’- di tutti e tutte noi, e anche dei nostri cari italiani cattolici e delle nostre care italiane cattoliche!!!
- Nel 60° Anniversario della nascita della Repubblica italiana, e della Assemblea dei nostri ’Padri e delle nostre ’Madri’ Costituenti, tutti i cittadini e tutte le cittadine di Italia non possono che essere memori, riconoscenti, e orgogliosi e orgogliose di essere cittadine italiane e cittadini italiani, e festeggiare con milioni di voci e con milioni di colori la Repubblica e la Costituzione di Italia, e cercare con tutto il loro cuore, con tutto il loro corpo, e con tutto il loro spirito, di agire in modo che sia per loro stessi e stesse sia per i loro figli e le loro figlie ... l’ “avvenire” sia più bello, degno di esseri umani liberi, giusti, e pacifici! Che l’Amore dei nostri ’Padri’ e delle nostre ’Madri’ illumini sempre il cammino di tutti gli italiani e di tutte le italiane... [...]" ("25 GIUGNO: SALVIAMO LA COSTITUZIONE E LA REPUBBLICA CHE E’ IN NOI").
- MEMORIA E #STORIA. DA NON DIMENTICARE alla #Assemblea #Costituente, su 556 eletti, 21 erano donne:
 9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;
9 NEL GRUPPO DC, SU 207 MEMBRI - LAURA BIANCHINI, ELISABETTA CONCI, FILOMENA DELLI CASTELLI, MARIA IERVOLINO, MARIA FEDERICI AGAMBEN, ANGELA GOTELLI, ANGELA GUIDI CINGOLANI, MARIA NICOTRA, VITTORIA TITOMANLIO;
 9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;
9 NEL GRUPPO PCI, SU 104 MEMBRI - ADELE BEI, NADIA GALLICO SPANO, NILDE IOTTI, TERESA MATTEI, ANGIOLA MINELLA, RITA MONTAGNANA TOGLIATTI, TERESA NOCE LONGO, ELETTRA POLLASTRINI, MARIA MADDALENA ROSSI;
 2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;
2 NEL GRUPPO PSI, SU 115 MEMBRI - BIANCA BIANCHI, ANGELINA MERLIN;
 1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.
1 NEL GRUPPO DELL’UOMO QUALUNQUE: OTTAVIA PENNA BUSCEMI.
NOTE:
- STORIA E #LETTERATURA: "ANALFABETISMO" ANTROPOLOGICO-POLITICO. «Per te sono un libro aperto. Non leggo. "Amori sfigati"» (Latini Marco). Da "Il Messia dei Libri proprio una bella sollecitazione ad #apriregliocchi (S. #Freud) e a osare #sapere (il "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa e di #Kant di #Koenigsberg) e a riequilibrare e ristrutturare il #campo della #antropologia, della #filologia, della #matematica, della #filosofia, della psicoanalisi e della #teologia-#politica dell’attuale tempestoso presente storico.
- ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA E #FILOLOGIA: IL PROBLEMA DEL #CORPOMISTICO, IL "#SAPERE AUDE" ("OSA AS-#SAGGIARE") E LA #FACOLTA’ DI #GIUDIZIO. In consonanza anche con il prossimo "XXV Congresso Mondiale di Filosofia - Roma 2024", a mio parere, è decisamente "consigliabile" ricordare e riprendere l’indicazione del prof. #GianniVattimo: «L’uomo è ciò che mangia, ma soprattutto quel che beve» (cfr. Emiliano Morrone, La ricerca (infinita) della verità e il pensiero “forte” di Vattimo per la sua San Giovanni in Fiore, "Corriere della Calabria", 22/09/2023)! Riflettere ancora e di nuovo su ciò che si mangia e si beve è ridiventato un allarme all’o.d.g: è una indicazione "carica di teoria", dal momento che del famoso "sàpere aude" di #Orazio di #Venosa (ripreso e rilanciato da #Kant da #Koenigsberg) è stata data storicamente (e per lo più) una interpretazione intellettualistica (e platonico) tutta a discapito della #sensibilità, tanto da pregiudicare la stessa comprensione del messaggio evangelico e del suo vitale e fondamentale "prendete e mangiate questo è il mio corpo", sia dal punto di vista antropologico sia dal punto di vista teologico-politico.
 Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!
Con #DanteAlighieri, e Gianni #Vattimo, è proprio tempo di rimeditare sullo "spirito profetico" dell’abate Gioacchino da Fiore e cercare di capire quanto sia importante non togliere un’acca dalla sua brillantissima "#charitas e non vendere per sempre la propria #anima e il proprio #corpo a "#mammona" ("caritas"). Se non ora, quando?!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- «CRITICA DELLA "RAGION PURA"» E #ANTROPOLOGIA. "AMLETO" (SHAKESPEARE) E LA LOTTA "VITTORIOSA" PER UNA RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA EUROPEA (IERI E OGGI).29 maggio 2024, di Federico La Sala
"AMLETO" (SHAKESPEARE) E LA LOTTA "VITTORIOSA" PER UNA RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA EUROPEA (IERI E OGGI).
 TEATRO (FILOSOFIA) E METATEATRO (METAFILOSOFIA).
TEATRO (FILOSOFIA) E METATEATRO (METAFILOSOFIA).- In memoria di Giordano Bruno, Galileo Galilei, e immanuel Kant...
- Una nota di commento a margine del lavoro in progress di Paul Adrian Fried: "Part 47: Ophelia’s “O” and the Virtues of Nothingness" (May 28, 2024).
"IN PRINCIPIO ERA LA PAROLA". SE SI CONSIDERA CHE NELLA "#FOLLIA" DEL PRINCIPE #AMLETO C’E’ IL #METODO (COME HA BEN INTUITO #POLONIO) CHE GLI FA CONSEGUIRE VALOROSA-MENTE LA VITTORIA SUL FALSO RE CHE HA UCCISO IL VERO RE E SPOSATO LA REGINA-MADRE E RISPETTARE IL #PATTO DEL RE-PADRE AMLETO CON IL RE-PADRE #FORTEBRACCIO, PENSARE che "Ophelia in Shakespeare’s 𝘏𝘢𝘮𝘭𝘦𝘵 represents a paradox about both the injustice and virtue of nothing, emptiness, poverty" (Paul Adrian Fried, cit.), NON PORTA DA NESSUNA PARTE, SOLO IN UN "O", IN UN #VICOLOCIECO, IN UNA NOTTE IN CUI TUTTE LE #VACCHE SONO NERE.
«CRITICA DELLA "RAGION PURA"» (#KANT2024) E #ANTROPOLOGIA (#KANT, 1800). Per dire in breve il senso del discorso, con le parole di #Einstein, e contro la logica della scommessa di #Pascal (e la sua "Pascalina"), Shakespeare non è né sulle posizioni epistemologiche di Thomas S. #Kuhn né su quelle di Paul K. #Feyerabend: #Hamlet sa "giocare" bene, ma il suo "Dio non gioca a #dadi".
MEMORIA STORIA E LETTERATURA: #DIVINACOMMEDIA. Forse è proprio giunto il tempo di togliere le catene linguistiche della #tragedia gettate intorno a "l’aiuola che ci fà tanto feroci" (Par. XXII, 151) e portare alla luce "della Terra, il brillante colore" (come già sollecitava #DanteAlighieri, ma anche J.-J. #Rousseau). In principio erano le parole del dia-#logos (della legge costituzionale uguale per ogni esssere umano), non del dia-#logo (di un’azienda o di un partito o di un pastore di "pecore").
Nota:
- EUROPA (1600 - 2024): MEMORIA E #STORIA. Per non perdere il filo (e, possibilmente, uscire dal #letargo e dall’infernale #labirinto, come da indicazione già di #DanteAlghieri), a mio parere, è importante #ricordare la sollecitazione "cosmologica" di #GiordanoBruno: "Lo #spaccio della #bestia trionfante". Se non ora,quando?!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- I "SOGNI DEL VISIONARIO" ("AEGRI SOMNIA") DELL’«ARTE POETICA» DI ORAZIO ( VENOSA) E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766)28 maggio 2024, di Federico La Sala
«NON MANGIARE TROPPO»: IL "BANCHETTO" DI #SWEDENBORG, I "SOGNI DEL VISIONARIO" ("AEGRI SOMNIA") DELL’«ARTE POETICA» DI #ORAZIO (VENOSA) E LA INTERPRETAZIONE DI KANT (KOENIGSBERG, 1766) DELLA TEOLOGIA-POLITICA DELL’#UOMOSUPREMO "EUROPEO".
- Alcune "vecchie" note in memoria di Kant (1724-1804).
A) "#TEATRO DEL #SONNO": LA VISIONE DI SWEDENBORG. «Ero a Londra e stavo pranzando nel mio abituale ristorante. Ero affamato e mangiavo con grande appetito. Verso la fine del pasto mi accorsi che una specie di nebbia mi si faceva davanti agli occhi. La nebbia divenne più fitta e io vidi il pavimento della stanza coperto dei più orribili animali striscianti, serpenti, rospi e simili. Io ero stupefatto, perché ero in piena coscienza. Poi l’oscurità divenne più completa per sparire infine completamente, e ora in un angolo della stanza vidi seduto un uomo che mi terrorizzò con le sue parole. Mi disse infatti: «Non mangiare tanto!».
 Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).
Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce e mi ritrovai solo nella stanza. Questa visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso uomo, il quale mi disse che era Dio, il creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello che avrei dovuto scrivere su questo soggetto. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti» (cfr. Emanuele Swedernborg, "Cielo e Inferno L’Aldilà descritto da un grande veggente", a c. di Paola Giovetti, Edizioni Mediterrane, Roma 2005; e, anche, cfr. Guido Almansi - Claude Béguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).B). L’ARCHIVIO DEGLI ERRORI: L’ "IO SONO" DI KANT E L’ "IO SONO" DELL’"UOMO SUPREMO" (cfr. "Kant, Freud, e la banalità del male", 2010).
- [FOTO DELLA PAGINA]: "EMANUEL SWEDENBORG, «Non mangiar troppo»" (cfr. #GuidoAlmansi - #ClaudeBéguin, "Teatro del sonno. Antologia dei sogni letterari", Oscar Mondadori, Milano 1991).
- ANTROPOLOGIA ED #ECOLOGIA (NON EGOLOGIA); “SMONTARE LA GABBIA”! USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO”.... .
- IL "BANCHETTO DI BALDASSARRE": ARTE E PROPAGANDA DELLA FEDE TEOLOGICO-POLITICA DELL’EUROPA DEL QUATTROCENTO, ALLA VIGILIA DELLA CELEBRAZIONE (2025) DEL PRIMO CONCILIO DI #NICEA (325).
- ARTRIBUNE: Roma: a Palazzo Nardini scoperto un affresco del ‘400.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD, 1937) E "STORIA E VERITÀ" (P. RICOEUR, 1955).15 maggio 2024, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA (#KANT2024), FILOSOFIA (KURT H. #WOLFF), E STORIOGRAFIA (PAUL RICOEUR).
"COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD, 1937). UN PROBLEMA DI SPIRITO CRITICO E AMORE CONOSCITIVO
"STORIA E VERITÀ" (P. Ricoeur, "Histoire et vérité", 1955 *), IN #SPIRITO DI #CARITÀ:
- CHARITE’, #CHARITAS, #XAPITAS, #CHARITY, #CHARIDAD .
Un #segnavia antropologico e filologico, per ben #comunicare il "risultato" del "#dialogo", dall’opera di #Victor Hugo (in omaggio a #Michel Foucault): "Io sono parigino di nascita e «parrisiano» nel parlare, dal momento che «parrhisia» in greco significa libertà" ("#Notre Dame de #Paris", L. I, cap. III).
NOTE:
- ANTROPOLOGIA CULTURALE, COMUNICAZIONE, E TEOLOGIA-#POLITICA: IN PRINCIPIO ERA IL #LOGOS ( NON UN #LOGO).
- "Discorso e verità nella Grecia antica". Una nota in memoria di #Michel Foucault (Poitiers, 15 ottobre 1926 - Parigi, 25 giugno 1984):
- PARRHESIA - La "parresia" come etica della verità.
*
- Paul Ricoeur, "Histoire et vérité" (1955): « L’historien va aux hommes du passé avec son expérience humaine propre. Le moment où la subjectivité de l’historien prend un relief saisissant, c’est celui où par-delà toute chronologie critique, l’historien fait surgir les valeurs de vie des hommes d’autrefois. Cette évocation des hommes qui nous soit accessible, faute de pouvoir revivre ce qu’ils ont vécu, n’est pas possible sans que l’historien soit véritablement « intéressé » à ces valeurs et n’ait avec elles une affinité en profondeur; non que l’historien doive partager la foi de ses héros, il ferait alors rarement de l’histoire mais de l’apologétique voire de l’hagiographie ; mais il doit être capable d’admettre par hypothèse leur foi, ce qui est une manière d’entrer dans la problématique de cette foi en la « suspendant », tout en la « neutralisant » comme foi actuellement professée. Cette adoption suspendue, neutralisée de la croyance des hommes d’autrefois est la sympathie propre à l’historien. (...) L’histoire est donc une des manières dont les hommes « répètent » leur appartenance à la même humanité; elle est un secteur de la communication des consciences, un secteur scindé par l’étape méthodologique de la trace et du document, dont un secteur distinct du dialogue où l’autre « répond », mais non un secteur entièrement scindé de l’intersubjectivité totale, laquelle reste toujours ouverte et en débat. (...) La subjectivité mise en jeu n’est pas une subjectivité « quelconque », mais précisément la subjectivité « de » l’historien: le jugement d’importance, -le complexe des schèmes de causalité, -le transfert dans un autre présent imaginé,-la sympathie pour d’autres hommes, pour d’autres valeurs, et finalement cette capacité de rencontrer un autrui de jadis,- tout cela confère à la subjectivité de l’historien une plus grande richesse d’harmoniques que n’en comporte par exemple la subjectivité du physicien ». (Cfr. Paul Ricoeur. "Histoire et vérité", 1955).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- FILOLOGIA E STORIA D’EUROPA: "L’INNO ALLA GIOIA". Flashmob di giovani a Vienna per i 200 anni esecuzione (7 maggio 1824) della Nona Sinfonia (di Marco Di Blas),3 maggio 2024, di Federico La Sala
FILOLOGIA ETIMOLOGIA ANTROPOLOGIA FILOSOFIA, TEOLOGIA, ARTE, POESIA E #MUSICA.
Inno alla Gioia...
- ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ, Χαρμολυπη (kharmolúpē): χαρμολύπη (χάρμ(α) -ο- + λύπη]). From χάρμ(α) (chárm(a), “joy”)....
- XAPITAS - #CHARITAS - #CHARITY, #CHARITE’, #CHARIDAD... JOY, FREUDE, GIOIA.
NOTE:
- STORIA E MEMORIA D’EUROPA: INNO ALLA GIOIA ("FREUDE"). "Flashmob di giovani a Vienna per i 200 anni dell’Inno alla gioia, Austria Vicina, 2 MAGGIO 2024: "[...] Benché il committente fosse la Società Filarmonica di Londra, la prima esecuzione ebbe luogo a Vienna, nel Theater am Kärntnertor, che si trovava all’inizio della Kärntner Strasse, dove oggi c’è l’hotel Sacher. Beethoven, ormai sordo, assistette al conserto. Si dice che al termine il contralto Caroline Unger si fosse avvicinata al compositore e lo avesse fatto voltare perché vedesse ciò che non riusciva a udire: l’ovazione del pubblico che lo applaudiva in piedi. Era la sera del #7maggio 1824. [...]".
- FILOLOGIA, #PSICOANALISI (S. FREUD), POESIA (F. SCHILLER) E MUSICA (L. v. BEETHOVEN): "INNO ALLA #GIOIA" ("FREUDE). Ripensando al lavoro ("L’uomo #Mosè e la religione monoteistica", 1938)", una vera e propria "#sinfonia londinese" di "#Sigismondo di #Vindobona" (#ItaloCalvino), un omaggio a #VIENNA (e all’Austria Vicina e a Marco Di Blas): "[...] Benché il committente fosse la Società Filarmonica di Londra, la prima esecuzione ebbe luogo a Vienna, nel Theater am Kärntnertor, che si trovava all’inizio della Kärntner Strasse, dove oggi c’è l’hotel Sacher." (Austria Vicina, 2maggio 2024).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- RICORDANDO ELVIO FACHINELLI, FREUD O LACAN? Note a margine del XXI Congresso della Società Psicoanalitica Italiana1 maggio 2024, di Federico La Sala
LA CULTURA EUROPEA, SIGMUND #FREUD, E L’INNO ALLA #GIOIA (F. #Schiller, "An die #Freude", 1785).
- NEL "NOME DI FREUD", LA "PSICOANALISI" DEL «JOYOSO» JACQUES LACAN. Due brevi note a margine della seguente "dichiarazione":
- “I wish to begin by saying what, while appearing under Freud’s name, extends beyond the time of his appearance and conceals its truth even in its very unveiling - that Freud’s name signifies «joy»” (Jacques Lacan, «An address: Freud in the century», 1956).
MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA. A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!
- "GIOIOSAMENTE, GIOCOSAMENTE: «FREUD ... E»
- Freud - letto in italiano come si scrive è quasi «fred-do»
- Freud - pronunciato in tedesco dà «Froid», che in-francesce-tradotto-in-italiano è ancora «freddo»
- Freud - più una «e» in tedesco equivale alla nostra «gioia»
- Freud - più la «e», pronunciata in tedesco su suolo italico dà «fro(i)de»
- (cit. da una mia relazione intitolata, "Cosa nasconde Freud a Freud? Cosa nascondiamo noi a noi stessi? Note da/per un seminario interdisciplinare sulla "Interpretazione dei sogni", all’ Università di Salerno, Sede di Via Irno - 30. 03. 1976).
FREUD O LACAN? "SÀPERE AUDE" (ORAZIO - KANT). Nella ricorrenza del XXI Congresso Nazionale della Societa’ Psicoanalitica italiana, RICORDANDO ELVIO FACHINELLI (con le parole di Francesco Marchioro: "Spirito curioso, ironico, indipendente e analista non ortodosso denuncia con forza una sorta di «freudolente» uso della terapia e accusa la sua stessa istituzione di praticare una “psicoanalisi della risposta”, nel senso che si limita a «dare ragione all’esistente, razionalizzare le irrazionalità, tamponare i conflitti», offrire una terapia dell’adattamento invece di essere una psicoanalisi interrogante, capace di sollevare domande radicali sullo statuto del soggetto e la sua relazione alla Lebenswelt, al mondo della vita.": Altoadige.it, 22.12.2019), non è il caso di svegliarsi dal sonno dogmatico e riprendere il filo da Kant (1724-2024), dalla interpretazione dei "sogni di un visionario" (1766), e riprendere coraggiosamente a "servirsi della propria intelligenza ("1784), e, insieme, far un so critico della propria facoltà di giudizio, come ha fatto e sollecitato a fare in prima persona Michel Foucault nel 1984?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- UNA STORIA DI LUNGA DURATA E, FORSE, DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE". "The Critical Spirit" (1967): Il ricordo del libro in onore di H. Marcuse (1967).15 aprile 2024, di Federico La Sala
UNA #STORIA DI #LUNGADURATA E, FORSE, DI UN PROSSIMO "ARROSSIMENTO GENERALE" : IL "#SIDEREUSNUNCIUS" (#GALILEOGALILEI, 1610), L’#ITALIA E IL SUO GRANDE #PROVINCIALISMO NELLO STORICO PRESENTE DEL "#VILLAGGIO #GLOBALE" (2024).
CULTURA E SOCIETÀ, #OGGI: "SÀPERE AUDE!" (Koenigsberg, 1784; Kaliningrad, 2024).
 Una nota a margine di una riflessione di Giorgio Mascitelli: *
Una nota a margine di una riflessione di Giorgio Mascitelli: *- "La situazione italiana è caratterizzata da un marcato provincialismo culturale: esso è senz’altro in aumento rispetto a trent’anni fa. [...] Certo tutta l’#Europa è diventata più provinciale, eppure anche lo scarto con gli altri paesi europei è aumentato. [...] alla base della superprovincializzazione italiana sta una trasformazione di fondo: fino a 30 fa l’Italia era un paese in cui si producevano merci, questo poneva tutta una serie di problemi generali e locali che implicavano una cultura che li affrontasse; oggi dopo la #globalizzazione, l’Italia è diventata un centro di consumo, secondario, di merci prodotto altrove che vive di speculazione edilizia e finanziaria e di turismo [...]
- Pertanto è favorito lo sviluppo di una cultura d’accatto, che idolatra ciò che è secondario, in cui è più importante #imitare che #sperimentare e l’accresciuta internazionalizzazione è il sintomo di questo processo. E tuttavia, stanno arrivando tempi in cui non avere una cultura del tutto provinciale sarà importante e non un semplice orpello." ( cfr. cfr, Giorgio Mascitelli, Fbook 12 aprile 2024 ).
ANTROPOLOGIA, #STORIOGRAFIA, E #CRITICA DELLA #FACOLTÀ DI #GIUDIZIO (#KANT2024). CONSIDERANDO che il "villaggio globale" dell’attuale storico presente (#Nicea 325-2025) è molto prossimo (epocalitticamente) alla "#pace #perpetua" (#Kant2024), è sperabile che in giro emergano molte tracce di rimorso dell’incoscienza passata (e presente) e che "lo spirito critico" sia in Italia sia in Europa riprenda il suo cammino.
 Nota:
Nota:- Anthropology and #Metaphysics: "The Critical Spirit. Essays in Honor of Herbert Marcuse" (Kurt H. #Wolff, #Barrington Moore, Beacon Press, 1967 - 436 pagine).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "CHE VUOL DIRE LEGGE MORALE IN NOI #PROFESSORE?". UNA RISPOSTA ALLA #DOMANDA.9 aprile 2024, di Federico La Sala
"ESSERE, O NON ESSERE" (#SHAKESPEARE): "CHE VUOL DIRE #LEGGEMORALE IN NOI #PROFESSORE?", OGGI (#KANT2024)
 ILLUMINISMO, #ILLUMINAZIONE, E "#SAPEREAUDE!" (#KANT): UNA RISPOSTA ALLA #DOMANDA.
Riconosciuta gratitudine per l’attenzione e per l’intervento, che cosa rispondere (in breve) a chi ha posto la #questione e desidera sapere?
ILLUMINISMO, #ILLUMINAZIONE, E "#SAPEREAUDE!" (#KANT): UNA RISPOSTA ALLA #DOMANDA.
Riconosciuta gratitudine per l’attenzione e per l’intervento, che cosa rispondere (in breve) a chi ha posto la #questione e desidera sapere?Innanzitutto, che Il "professore" è il "tu" stesso con "te" stesso; secondo, che il sapere di non sapere e il #decidere con "te" stesso se si vuole sapere ("essere") o non sapere ("non essere") è già un primo passo, quello decisivo e fondamentale, per uscire dallo "stato di #minorità" (Kant, 1784); e, terzo, che cominciare a #dialogare con "#te" stesso come un #altro, apre al grande "aut aut"! "Che fare?" (Lenin), "Che cosa devo fare?" (Kant). Nel #ribaltamento e nel #riconoscimento di "sé" come un "altro" (Paul #Ricoeur) prende il via la "#fenomenologia dello #spirito" (alla #Hegel) o la #divinacommedia (alla #DanteAlighieri): "To be, or not to be, that is the question" (#Shakespeare, "Amleto", III.1). Uscire dall’inferno, dal #letargo (Inf. XXXIV, 94) è possibile: "#Amore è più forte di #Morte" (Ct. 8.6, trad. di Giovanni Garbini).
ESPERIENZA E CRITICA DELLA FACOLTA’ DI #GIUDIZIO. "Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Viene la pioggia, e così succede. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, è così accade. Ipocriti, sapete giudicare l’aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?" (Lc. 12, 56-57).
Note:
- ANTROPOLOGIA E #STORIA. Immanuel Kant: «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da un difetto d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di fare uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo.» .
- FILOSOFIA E #CRITICA. Immanuel Kant, "Critica della facoltà di giudizio", a cura di Emilio Garroni e Hansmichael Hohenegger, Einaudi....
- Accanto alla Critica della ragione pura e alla Critica della ragione pratica, la Critica della facoltà di giudizio è il terzo capolavoro dell’impresa critica di Immanuel Kant: non solo il suo compimento, ma anche e soprattutto il suo ripensamento e insieme la sua fondazione.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- MUSICA E COSMOLOGIA. Parola di Beethoven: “La legge morale in noi, e il cielo stellato sopra di noi. Kant!!!“ ("Konversations-Hefte").7 aprile 2024, di Federico La Sala
MUSICA, #FILOSOFIA, E #COSMOLOGIA:
#KANT2024.
"Beethoven nomina Kant due volte nei Konversations-Hefte. Una volta con noncuranza là dove egli commenta la noia delle lezioni universitarie tenute dal filosofo kantiano Johann Gottfried Kiesewetter (1766-1819). Un’altra volta con forte commozione, citando senza commento ma con evidenza anche grafica: “La legge morale in noi, e il cielo stellato sopra di noi. Kant!!!“. [...]" (https://www.lvbeethoven.it/biografia08/ ).
NOTA:
- Nel #cielostellato e nel #cerchiodellavita, l’#animale del #BuonMessaggio è un #Montone, non un #caproespiatorio (#ReneGirard): "in questa #primavera sempiterna/ che notturno #Ariete non dispoglia /perpetualemente ‘Osanna’ sberna"(#DanteAlighieri, Pd. XXVIII, 116-118)
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ON DANTE, SHAKESPEARE, MARX ... MOLTI AUGURI (PASQUA 2924).30 marzo 2024, di Federico La Sala
CON LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DELLA #COMMEDIA, AL DI LA’ DELLA #TRAGEDIA:
CON DANTE, SHAKESPEARE, MARX ...
- MOLTI #AUGURI di "buona #pasqua2024"
IN EUROPA, almeno a partire dal ""qualcosa di marcio nello stato di Danimarca" (Shakespeare, #Amleto, I. 4), "The time is out of Joint" (#Hamlet, I. 5). E, con #Dante Alighieri, Marx (da #Londra, 1859) già sollecitava fin dalla Prefazione "Per la Critica della economia politica", ad uscire da un #letargo (Par. XXXIII, 94) di un tragico "#dissesto" di millenni:
- «Qui si convien lasciare ogne sospetto;
- ogne viltà convien che qui sia morta.
- Noi siam venuti al loco ov’i’ t’ho detto
- che tu vedrai le genti dolorose
- c’hanno perduto il ben de l’intelletto».
- (Inf., III, 14-18).
Note:
IL SORGERE DELLA TERRA, DALLA LUNA. UN OMAGGIO ALLA #MEMORIA DI GALILEO GALILEI.
"LA DISCESA AGLI INFERI", #30MARZO: #SABATOSANTO" DELLA #PASQUA2024.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL PROBLEMA DEL "LATO MATERNO" NELL’EDIPICO CAMMINO DI #SIGMUNDFREUD, E L’INDICAZIONE DI #DANTEALIGHIERI.27 marzo 2024, di Federico La Sala
IL CRESCERE DEL "DISAGIO DELLA CIVILTÀ", IL PROBLEMA DEL "LATO MATERNO" NELL’EDIPICO CAMMINO DI #SIGMUNDFREUD, E L’INDICAZIONE DI #DANTEALIGHIERI.
***Tracce per una #svolta_antropologica...
- DANTE E LA "DISCESA ALL’INFERNO" DI FREUD. "L’Interpretazione dei Sogni" (1899) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’ «In exitu Isräel de Aegypto» della "#DivinaCommedia" (Pg. II, 46-48) di Dante Alighieri.
La considerazione di Freud del 1917, relativa al fatto che, “Se un uomo è stato il beniamino incontestato della madre, conserva poi per tutta la vita quel sentire da #conquistatore, quella fiducia nel successo che non di rado trascina davvero il successo con sé" (cfr. S. Freud “«Un ricordo d’infanzia» tratto da «Poesia e verità» di Goethe”, OSF 9, Torino 1977), ha una potente carica ’radioattiva’ di teoria.
- DEL LAVORO intitolato "Freud messo a fuoco. Passando dai padri alle madri" di Roberto Speziale-Bagliacca - come acutamente scrive ROSSELLA VALDRE’ -
- "E’ tesi centrale del libro che i lati oscuri, rimasti rimossi e mai analizzati, del rapporto di Freud con la madre ebbero conseguenze determinanti per lo svIluppo della prima psicoanalisi e che si e’ dovuto attendere il contributo prima di #Ferenczi ed in seguito della #Klein per ridare al rapporto dell’infante con la madre la sua centralità e la sua enorme importanza nello sviluppo primitivo umano"; e ancora, che "Nel moderno paradigma anticipato da Ferenczi e proseguito da altri non vi e’ nulla che contrasti o si opponga al pensiero di Freud, ma solo con l’evoluzione degli uomini e del tempo e’ stato possibile raccogliere quegli embrioni teorici che pure sono tutti contenuti in Freud ma che, nell’ambito della sua sola esistenza umana, avevano inevitabilmente dovuto fare i conti e scendere a compromessi con le difese e le difficoltà." ((cfr. R. Valdrè, "Il lato materno di Sigmund Freud", PsychiatryOnline, 11 febbraio, 2013).
- "CRITICA DELLA RAGION PURA" (I. #KANT), "CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" (K. #MARX), E "PSICOANALISI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA" (#ERICHFROMM).
LA QUESTIONE DELL’#EDIPOCOMPLETO: SOFOCLE ("EDIPO RE") E FREUD ("L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI"):
IL LEGAME "PARADIGMATICO" DI #GIOCASTA, MADRE E REGINA, ED #EDIPO, FIGLIO E PRINCIPE), CHE REGNA ANCORA "COME IN TERRA COSI’ IN CIELO", PENSATO COERENTEMENTE, COME FREUD HA CERCATO DI FARE, METTE IN EVIDENZA IL DOMINIO "NASCOSTO" DI #MAMMONA, L’ ALLEANZA "MADRE-FIGLIO", SU TUTTO IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE" E RIPRODUZIONE, CHE ASSICURA IL COMANDO SUL CICLICO RIPETERSI DELLE #STAGIONI E DELLE #GENERAZIONI, COME HA SANCITO IL TRAGICO "#COMPROMESSO OLIMPICO" TRA #DEMETRA (VITA) E #PLUTONE (MORTE) PROPRIO PER ASSICURARE LA VITA A #PERSEFONE STESSA, ALLA #MADRETERRA, E ... AGLI STESSI DEI E ALLE STESSE DEE DELL’ #OLIMPO - PER "SEMPRE"!?
#pasqua2024 #buonapasqua #Dantedì #25marzo #31marzo ...
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- "L’ISTITUZIONE NEGATA" (FRANCO BASAGLIA,1968) E UNA QUESTIONE DI #FILOLOGIA E DI ANTROPOLOGIA.11 marzo 2024, di Federico La Sala
CREATIVITÀ E SOCIETÀ: ARITMETICA, PSICHIATRIA, PSICOANALISI, E COSTITUZIONE (#Europa2024: #Francia)
- "L’ISTITUZIONE NEGATA" (FRANCO BASAGLIA,1968) E UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI ANTROPOLOGIA (DA PORRE ALL’ORDINE DEL GIORNO, PER EVITARE... UN ARROSSIMENTO GENERALE).
Una "citazione" in #memoria di FRANCO BASAGLIA E DI FRANCA ONGARO:
"un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, "Donna", Enciclopedia, V, Einaudi, Torino 1978).
NOTE:
- "La #clinica dopo #Basaglia: [...] L’#istituzione #negata è una singolare linea di derivazione. Come in #matematica la #singolarità è un punto dove una curva cambia radicalmente e fa nascere l’imprevedibile; oppure in musica, quando si tratta di una variazione repentina - come in alcune composizioni di Schoenberg, o nell’improvvisazione jazz. Se la matematica e la #musica sono all’altezza di gestire la #complessità dei propri contenuti, trasformando i propri limiti in nuove frontiere della #conoscenza - nel primo caso - e in nuove esperienze della sensibilità uditiva e ritmica - nel secondo caso -, perché la società non dovrebbe favorire variazioni esistenziali dello stesso tipo? Se un nuovo teorema e un nuovo brano musicale sono forme della #creazione umana, perché la follia non può esserlo? [...]" (cfr. Pietro Barbetta, "#Doppiozero", 11 Marzo 2024).
- ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #8MARZO2024: RICORDANDO #DANTEALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA, RIPENSARE L’#UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson).
- CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
- RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE E #RIPRODUZIONE: GENITORI E FIGLI. "ALBERTA BASAGLIA: “Non è tardi per parlare di mia #madre #FrancaOngaro e del suo ruolo nella rivoluzione che portò alla chiusura dei manicomi”
 La #psicologa, #figlia dello psichiatra #FrancoBasaglia, racconta nel libro "Contro tutti i muri" (Donzelli editore) il ruolo avuto dalla madre nel processo che portò alla #Legge180: "Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico. Ho il ricordo della presenza contemporanea di entrambi i miei #genitori inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di #cambiare il #mondo" (cfr. EmanueleSalvato, "Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2022).
La #psicologa, #figlia dello psichiatra #FrancoBasaglia, racconta nel libro "Contro tutti i muri" (Donzelli editore) il ruolo avuto dalla madre nel processo che portò alla #Legge180: "Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico. Ho il ricordo della presenza contemporanea di entrambi i miei #genitori inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di #cambiare il #mondo" (cfr. EmanueleSalvato, "Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2022).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- A A PARTIRE DALLA FRANCIA (2024), RIPENSARE L’UNO: CON "PENELOPE" (MARGARET ATWOOD) E "ULISSE" (DANTE ALIGHIERI)10 marzo 2024, di Federico La Sala
PENELOPE- IDEA E COMMEDIA: FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA. Con lo spirito dell’opera “The Penelopiad” di Margaret Atwood e della "Divina Commedia" di Dante Alighieri, un segnavia di uscita dall’orizzonte della tragedia...
#STORIAELETTERATURA. Data la immersione totale di tutta la cultura occidentale nell’immaginario dell’#Odissea, "étudier, très succinctement, la technique d’« écriture féminine » de Margaret Atwood, à travers son ouvrage «The Penelopiad» et plus précisément, à travers l’ironie dans son rapport aux «métamorphoses» apportées au texte de l’Odyssée d’Homère" (cfr. Rebecca Plewinski, "La technique d’«écriture féminine» de Margaret Atwood: l’exemple de The Penelopiad») che con mente "penelope-idea" sa catturare e aggiogare persone e popoli con il proprio "canto" e l’ esperienza tragica della sua "fenomenologia dello #spirito".
L’ALBA DELLA MERAVIGLIA ("Earthrise"). Per #Dante, con l’aiuto del "padre" #Virgilio ("Eneide") su sollecitazione della "#bella e beata" #madre Beatrice (sollecitata a sua volta da Lucia, inviata da Maria, madre di Gesù "Cristo"), la "folle impresa" di uscire dalla "selva oscura" e ritrovare la "diritta via", con il vecchio "Ulisse" e con la vecchia "Penelope" sulle proprie spalle, è possibile: è l’amore che muove il sole e le altre stelle.
- STORIA E LETTERATURA E ANTROPOLOGIA: MARGARET ATWOOD, "IL CANTO DI PENELOPE" (Wikipedia).
- ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #8MARZO2024: RICORDANDO DANTE ALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA "MONARCHIA", RIPENSARE L’#UNO, ri-pensare l’ONU - a partire da #Due, "almeno due" (#GregoryBateson).
 CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "TRA PASSATO E FUTURO": UNA NOTA SULLA CRISI DELLE NASCITE E LA CRISI DELL’ISTRUZIONE (di Hannah Arendt).4 marzo 2024, di Federico La Sala
SOCIETA’, EDUCAZIONE, ED INSEGNAMENTO: IL PROBLEMA DELLA NASCITA E "LA CRISI DELLA ISTRUZIONE"
Hannah Arendt, nel suo "Tra passato e futuro" (1961), in riferimento alla "crisi dell’istruzione", forse, è utile #ricordare che, dinanzi a chi non sa, «l’insegnante si qualifica per conoscere il mondo e per essere in grado di #istruire altri in proposito, mentre è autorevole in quanto, di quel mondo, si assume la responsabilità». Di fronte a chi non sa, all’allievo e all’allieva, «è una sorta di rappresentante di tutti i cittadini della terra che indica i particolari dicendo: ecco il nostro #mondo».
CIO’ CHE INTERESSA TUTTI «noi - ella prosegue - e non va quindi delegato alla scienza specialistica, è il rapporto tra adulti e bambini in genere. Si tratta (in termini più generali e corretti) della nostra posizione nei confronti della #nascita degli uomini: del fatto fondamentale che tutti siamo stati "messi al mondo" e che le nuove nascite rinnovano di continuo il mondo stesso. L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo di esseri nuovi, di giovani. Nell’educazione si decide anche se noi amiamo tanto i nostri figli da non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in balia di se stessi, tanto da non strappargli di mano la loro occasione d’intraprendere qualcosa di nuovo, qualcosa d’imprevedibile per noi; e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti».
fls
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- PER #KANT2024: UN "INVITO" A PORTARSI FUORI DALLE ANTINOMIE DELLA DIALETTICA DI SCILLA E CARIDDI.29 gennaio 2024, di Federico La Sala
COSMOLOGIA E CIVILTA’ (#KANT2024)*:
- CON #LETIZIA (gr. "XAPA") FILOLOGICA E #CARITÀ ( lat. #CHARITAS, gr.#XAPITAS) ANTROPOLOGICA,
UN "INVITO" A PORTARSI FUORI DALLE ANTINOMIE DELLA DIALETTICA DI #SCILLA E #CARIDDI E RIPRENDERE LA NAVIGAZIONE NELL’#OCEANOCELESTE (#KEPLERO A #GALILEO, 1611).
Charis -sima #EUROPA non è un buon tempo (gr. "#eu-#chronos)" questo per ripensare la #relazione chiasmatica (gr. "X") che lega il #genereumano a sé stesso, alla #Terra e al #Cielo, e rendere #onore alla #Lingua #greca e alle sue parole cariche di #Grazia (gr. #XAPIS)? Se non ora, quando?
- * PER #KANT, UNA "#MEMORIA" DI #FULVIOPAPI (1930-2022): “[...] inutile con Kant ricorrere a modelli storiografici che vogliano sceverare un’autenticità del suo pensiero e un piano ideale di natura operativa o tattica o politica tale che faccia nascere un insieme di questioni marginali, che però non corrispondono alla centrale linea speculativa. Quando, ad esempio, Engels nell’Antischelling sottolinea nella Storia generale della natura l’aspetto cosmologico, vedendone solo l’apporto di natura scientifica procede a una semplificazione che vede unilateralmente solo una faccia della problematica kantiana.
— ***Che dal punto di vista engelsiano questo modo di procedere fosse ovvio e che questa valutazione settorialmente scientifica sia stata fatta altre volte e anche con legittimità in quanto la cosmologia costituisce una zona obiettiva del sapere scientifico, non esclude che traducendo in un modello storiografico questo tipo di semplificazione e di riduzione non sia poi più possibile una ricostruzione della totalità filosofica del pensiero kantiano di questo periodo. - Ciò che interessa vedere è invece come il giovane Kant armonizzi in un discorso filosofico questa doppia esigenza, scientifica e religiosa, e nella delineazione di questo come è il compito di chi si proponga di mostrare la forma originale con cui Kant darà equilibrio speculativo al suo problema” (cfr. Fulvio Papi, "Cosmologia e civiltà. Due momenti del Kant precritco", Argalia Editore, Urbino 1969).
Ripropongo, qui ed ora, alcune "vecchie" note sul tema: "Ripensare l’Europa".
- Nota:
- STORIA FILOSOFIA E MEMORIA. Fulvio Papi, l’ultima voce della «scuola di Milano» (Fabio Minazzi).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- NON è il "caso" di ripensare il "Problema Jean-Jacques #Rousseau" e interrogarsi di nuovo e ancora su "come nascono i bambini" (Enzo Paci)10 gennaio 2024, di Federico La Sala
MITO, ANTROPOLOGIA, STORIA, LETTERATURA, E STORIOGRAFIA: IL POMO DELLA DISCORDIA...
LA TERRA, L’AMORE COSMOGONICO DI DANTE ALIGHIERI, IL "CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI" DI ITALO CALVINO, E LA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO" DEI "DUE SOLI".
- RITORNO AL FUTURO, 11. IN MEMORIA DI OVIDIO E DI VIRGILIO...
- Una nota a margine di una riflessione su "LA TERRA SPOSATA O LE DISAVVENTURE DI EROS", proposta dal prof. Flavio Piero Cuniberto.
UNA QUESTIONE "COSMICOMICA", A QUANTO PARE, SEGNATA DALLA "#PAURA" (E DALLA CONSEGUENTE "CADUTA" in una "SELVA OSCURA", in uno"stato di minorità" ) E’ DIVENTATA "BIBLICAMENTE" COSMOTRAGICA: ""Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto" (Gn "3, 8").
Probabilmente, aveva ragione #GiordanoBruno nell’avanzare la teoria che si trattava di un tempo "fuori dai cardini", che era un problema di ordine cosmico, di riforma cosmologica ("Lo spaccio della bestia trionfante") e dopo, al contempo, #Lessing, nel porre all’ordine del giorno la questione di #educazione del genere umano.
Kant, da parte sua, riprendendo il discorso e riannodando insieme il "cielo stellato" e la "legge morale", dice che è soprattutto una questione di maturità, e a chi non vuole sentire ragioni, risponde con determinazione, con e come #Orazio: "#sàpere aude!" (risolviti ad assaggiare"), esci dal tuo personale "stato di minorità", e fà un buon uso della tua propria facoltà di giudizio, senza avere di nuovo e ancora paura: "Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo!".(Mt. 24-25).
FORSE "LA TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI" (CALVINO) E I "DUE SERPENTI" DEL #CADUCEO (DI ERMES/MERCURIO), con i DUE SOLI di Dante Alighieri, ripensati con "IL #MULINO DI AMLETO" (di Giorgio Diaz de Santillana e Hertha von Dechend), e, non ultimo, con lo stesso "AMLETO" (di William #Shakespeare), possono aiutare a focalizzare meglio l’orizzonte spazio-temporale cosmico e le "regole del gioco" entro cui si danno "le disavventure di Eros".
DA considerare e non dimenticare che la memoria di #Demetra -#Cerere (Eleusi) è più viva che mai (se pure in gran pericolo) e che le sue "disavventure" sono iniziate proprio da un intervento voluto da #Afrodite-#Venere e da #Eros - #Cupìdo che, come ha ben visto Dante, ha un suo orrizzonte cosmicomico: "è l’amore che muove il sole e le altre stelle".
NOTA
- ARCHEOLOGIA ICONOGRAFIA E FILOLOGIA: IL POMO DELLA DISCORDIA. Nel "Giudizio di Paride" (https://it.wikipedia.org/wiki/Giudizio_di_Paride ), nella rappresentazione fattane nellla società etrusca e ritrovata in una tomba a Cerveteri, all’interno della sequenza in cui "Paride riceve Hermes che guida Atena, Era e Afrodite, 560-550 AC."), degna di particolare attenzione è l’immagine dell’asta in mano ad Hermes con al vertice un toro (allusione al "vitello d’oro"?) e la figura di Afrodite, con in mano un ramo di pianta di melograno (che "disegna" con molta approssimazione la figura della "Menorah", il candelabro con sette bracci della tradizione religiosa ebraica).
#Eleusis2023 #Buon2024...
ALL’ORIGINE DELLA "GUERRA DI TROIA", LA STESSA "STORIA" DEL "GIOCASTOLAIO" EDIPO:
- PARIDE. Figlio di Priamo e di Ecuba, detto anche Alessandro.
- La sua nascita fu accompagnata da un prodigio: la madre sognò, prima di metterlo al mondo, di dare alla luce una torcia. Esaco, altro figlio di Priamo, interpretando il sogno, predisse che il nascituro avrebbe causato la rovina di Troia e consigliò di metterlo a morte. Fu invece esposto sul monte Ida e poté sopravvivere, a seconda delle tradizioni, o perché raccolto dai pastori, o perché nutrito da un’orsa e poi ritrovato da Agelao.
- Divenuto grande, accadde che un servo di Priamo fosse incaricato di portar via un toro dal branco custodito dallo stesso P., da assegnare come premio al vincitore dei giochi indetti per onorare la memoria del figlio ormai creduto morto. P. seguì il servo, partecipò ai giochi e vinse, riottenendo, dopo il riconoscimento, il posto che gli competeva nella casa del padre. Avvenne poi che durante le nozze di Tetide e Peleo, mentre tutti gli dei erano riuniti in assemblea, Eride, la dea della discordia, lanciò un pomo destinato alla più bella tra Atena, Era e Afrodite.
- Zeus si rifiutò di decidere e incaricò Ermete di condurre le tre dee sul monte Ida, eleggendo ad arbitro della contesa P. che aggiudicò il pomo ad Afrodite, che gli aveva promesso di fargli sposare la donna più bella del mondo, suscitando così contro i Troiani l’odio di Era e di Atena, che gli avevano promesso rispettivamente potenza e sapienza.
- Successivamente P. fu ospite a Sparta (o secondo altri ad Argo) di Menelao, al quale rapì, con l’aiuto di Afrodite, la consorte Elena, provocando così la spedizione contro Troia, decisa dai due Atridi per vendicare l’oltraggio subito da Menelao.[...]" (Cfr. Antonio Martina, "Paride", Enciclopedia Dantesca, Treccani)
MATEMATICA, ANTROPOLOGIA, E ARCHEOLOGIA FILOLOGICA E FILOSOFICA: 1+1=1.....
- RITORNO AL FUTURO, 12. IN MEMORIA DI GIAMBATTISTA VICO, DI JEAN-JACQUES ROUSSEAU, E DI ENZO PACI...
DA UNA ENCICLOPEDICA "VOCE " DI "DONNA": "[...] Un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, 1979),
UNA #HAMLET-ICA #DOMANDA. CHI HA SCRITTO il "#Discorso sull’origine e i fondamenti dell’#ineguaglianza tra gli uomini" ("Discours sur l’origine et les fondements de l’#inégalité parmi les hommes")?
NON è il "caso" di ripensare il "Problema Jean-Jacques #Rousseau" e interrogarsi di nuovo e ancora su "#comenasconoibambini" (come da sollecitazione di un protagonista della "#ScuoladiMilano", #EnzoPaci, che ben conosceva l’opera del napoletano #GiambattistaVico) e dare il via a una "#ScienzaNuova"?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- UNA QUESTIONE DI OCULISTICA TEOLOGICO-POLITICA: IL CASO DELL’OCCHIO, DEL CAMPO VISIVO, E DELLA MOSCA (Wittgenstein).21 dicembre 2023, di Federico La Sala
RIFLESSIONI SULL’OCULISTICA TEOLOGICO-POLITICA:
- IL CASO DELL’OCCHIO, DEL CAMPO VISIVO, E DELLA MOSCA.
SVEGLIARSI DAL #SONNODOGMATICO (#KANT) E RICONSIDERARE IL PROGRAMMA DI RICERCA DI #WITTGENSTEIN: USCIRE DALLA #CAVERNA, DALLA TRAPPOLA POLIFEMICA DEL #CINEFORUM PLATONICO, E DALL’#INFERNO EPISTEMOLOGICO ...
- UN "INVITO" A RIMEDITARE LA LEZIONE DI #OMERO, #DANTEALIGHIERI, E MARSHALL #MCLUHAN:
IL #SOGGETTO "METAFISICO" ("TEOLOGICO-POLITICO") C’E’... MA NON SI VEDE!
«Il soggetto non appartiene al mondo, ma è un limite del mondo. ("Tractatus logico-philosophicus", 5. 632); «Ove, nel mondo, vedere un soggetto metafisico?. Tu dici che qui sia proprio così come nel caso dell’occhio e del campo visivo. Ma l’occhio, in realtà, tu non lo vedi. E nulla nel campo visivo fa concludere che esso sia visto da un occhio.» ("Tractatus logico-philosophicus", 5. 633).
#VISIONE, #DESIDERIO, E #ANTROPOLOGIA DELLA #COMUNICAZIONE: UNA "MEMORIA" DI #MARSHALLMCLUHAN. "[...] Fin quando resteremo legati a un atteggiamento narcisistico e considereremo le estensioni dei nostri corpi qualcosa di veramente esterno e indipendente da noi, non riusciremo ad affrontare le sfide della tecnologia se non con le piroette e gli afflosciamenti di una buccia di banana. Archimede disse una volta: "Datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo". Oggi ci avrebbe indicato i nostri media elettrici dicendo: "M’appoggerò ai vostri occhi, ai vostri orecchi, ai vostri nervi e al vostro cervello, e il mondo si sposterà al ritmo e nella direzione che sceglierò io". Noi abbiamo ceduto questi "punti d’appoggio" a società private [...]" ( "Gli strumenti del comunicare", Milano, Il Saggiatore, 1967 ).
- Nota: "Conoscete Ludwig Wittgenstein?" (Mario Porro, "Doppiozero", 20 dicembre 2022).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- "IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI" (ITALO CALVINO) E L’ITALIA DEL "BENTORNATO MASCHIO (GIANFRANCO PELLEGRINO).29 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’ AMLETICA “QUESTION” DI ELISABETTA I (REGINA D’INGHILTERRA E PAPA DELLA CHIESA ANGLICANA), LA LEZIONE SULLA “VISIBILITA” (“VISIBILITY”) DI ITALO CALVINO, E IL PROBLEMA DEL “MODELLO PATRIARCALE”.
- “C’è un verso di Dante nel Purgatorio (XVII, 25) che dice: «poi piovve dentro a l’alta fantasia»”: una nota in memoria di “Sigismondo di Vindibona” (1856-1939) e di Italo Calvino (1923 -1985). *
A MARGINE E A PROPOSITO DELL’ “USO PERSUASIVO E PROPAGANDISTICO DELLA FAMIGLIA” (DEL “PRESEPE”) E DEGLI ANTROPOMORFISMI MESSI IN LUCE NELLA RIFLESSIONE SUL “BENTORNATO MASCHIO” (Gianfranco Pellegrino, "Le parole e le cose", 26 ottobre 2023), FORSE, non sarebbe male se la sollecitazione a riflettere venisse accolta soprattutto dalle antropologhe, dalle filosofe, dalle psicoanaliste, e dalle teologhe:
- “Alcune autrici hanno proposto una definizione sociale delle donne. Per loro, essere donna significa occupare una specifica posizione sociale, e essere trattate in certi modi, subire certe reazioni, e così via. [...] Semplificando, in questo tipo di visioni, essere una donna o un uomo è un fatto di potere. Sei donna se subisci un certo tipo di potere, quello patriarcale, sei uomo se non lo subisci e lo eserciti.
 L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
L’obiezione che viene subito in mente, e che è stata fatta più volte, è: ma allora la regina Elisabetta I non è una donna? [...]
 la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
la narrazione femminista, sostenuta dai maschi democratici dalla lunga, lunga coda di paglia, non prevede donne che non siano vittime del sistema e uomini che non siano carnefici [...] Il maschio tossico è ancora qui, anche se s’incarna nella prima donna premier d’Italia. [...]” (G. Pellegrino, cit.).
*
VISTO CHE il “modello patriarcale” come strumento di analisi fa acqua da tutte le parti, almeno dal tempo della “dialettica” di Hegel, e, ancor di più, dopo Freud e la sua indicazione a muoversi ad usare il “modello edipico completo”, è più che augurabile fare qualche passo avanti teorico e pensare a un modello “patriarcale-matriarcale” (padrone-serva e padrona-servo), alla luce delle “Lezioni americane” (non solo la quarta, la “Visibilità”) e del “Castello dei destini incrociati” (in particolare, del capitolo della seconda parte, “La taverna dei destini incrociati”, col titolo “Anch’io cerco di dire la mia”).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. - LETTERATURA E PSICOANALISI: “IL CASTELLO DEI #DESTINI INCROCIATI” (ITALO CALVINO). L’INCONTRO CON “SIGISMONDO DI VINDIBONA” [VIENNA] NELLA “TAVERNA DEI DESTINI INCROCIATI”. Una “presentazione” del mito di Edipo con le carte dei Tarocchi:
“ANCH’IO CERCO DI DIRE LA MIA. [...] Tutto questo è come un sogno che la parola porta in sé e che passando attraverso chi scrive si libera e lo libera. Nella scrittura ciò che parla è il represso. E allora Il Papa dalla barba bianca potrebbe essere il gran pastore d’anime e interprete di sogni Sigismondo di Vindobona, e per averne conferma non c’è che verificare se da qualche parte del quadrato dei tarocchi si riesce a leggere la storia che, a quanto insegna la sua dottrina, si nasconde nell’ordito di tutte le storie. [...]” (cfr. I. Calvino, “Anch’io cerco di dire la mia”, “Romanzi e racconti” II, Meridiani, Mondadori, 1992, pp. 592-595).
 Federico La Sala
Federico La SalaP. S. 2 - ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, MATEMATICA, E FILOLOGIA...
“Bentornato maschio”( v. sopra) non è solo una chiamata in causa di intellettuali di ogni genere e di ogni specie, ma anche, e prima di tutto, è un segnavia “storico” per ogni cittadino e ogni cittadina per dare alla amletica “question” teologico-politica posta da Shakespeare, in stretto collegamento alla presenza sul trono d’Inghilterra di Elisabetta I, regina e papessa della Chiesa anglicana, una propria risposta all’altezza dell’attuale “presente storico” - è una chiamata ad uscire dall’epocale “stato di minorità”, personale e politico (Immanuel Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984) !
“DUE SOLI” (DANTE ALIGHIERI). Re-interrogarsi alla Kantorowicz sulla “regalità antropocentrica: Dante”, sui “due corpi del re” e, ovviamente, anche sui “due corpi della regina”, forse, può essere una buona occasione per svegliarsi dal sonno dogmatico e portarsi fuori dalla cosmoteandria, atea e devota! Se non ora, quando?!
QUESTIONE MATEMATICA E ANTROPOLOGICA. Per approfondimenti, volendo accogliere alcune indicazioni sul tema, si potrebbe ricominciare a contare da almeno da due o, meglio da “Quattro”, dal poema di Italo Testa (“Le parole e le cose”, 3 Settembre 2021).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA TALPA E LA CIVETTA (SHAKESPEARE): LA TRACCIA DI UNA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DI "DUE IO".6 ottobre 2023, di Federico La Sala
L’#EUROPA (#GRANADA), #KOENIGSBERG / #KALININGRAD (E #ODESSA), LA "#DEMOCRAZIA" (COME "#STATO DI #MINORITÀ"), E IL PROBLEMA DELLA #TRASPARENZA TEOLOGICO-POLITICA. Alcuni appunti...
Un omaggio alla memoria di Dante Alighieri e William Shakespeare...
LA #TALPA E LA #CIVETTA: LA TRACCIA DI UNA FENOMENOLOGIA DELLO #SPIRITO DI "#DUE #IO" (DI #DUESOLI"). Già per #Shakespeare, ai suoi tempi (1600), Amleto e Ofelia (con il metodo della loro #follia) guardano ben oltre la linea dell’orizzonte teologico-politico di #Erasmo di Rotterdam e #TommasoMoro e lottano per portarsi fuori da un’Europa ormai avviatasi nella "marcia" del tramonto (#Nicea 325/2025).
LE PAROLE DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE. Al centro e al fondo della questione posta da #CarloGalli, nel recente "Democrazia, ultimo atto?"(cfr. estratto: https://www.einaudi.it/.../democrazia-ultimo-atto-carlo.../ ), al di là dei suoi contributi e risultati specifici, vi sono "le idee moderne di libertà, di uguaglianza, di trasparenza, che sono esposte alla contingenza (...) e che meritano ancora una volta di essere il centro intorno a cui ruota la politica".
"DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (#FREUD, 1929). Sul tema, nel suo commento, Francesco Fistetti accoglie con riserva la proposta di variazione e scrive: "[...] Al terzo termine del trinomio #libertà / #eguaglianza / #fraternità Galli sostituisce quello di "trasparenza". Trasparenza nell’accezione già di Bobbio che non devono esserci zone oscure e opacità nell’esercizio del potere e nel governo delle istituzioni, ma il sale della critica e del dibattito razionale. Ma in questo modo, cancellando la fraternità, può cassare senza colpo ferire tutta la storia del socialismo e della lotta per il socialismo come organici alla storia della modernità democratica e dello stesso liberalismo (il liberalsocialismo di un Rosselli e tanti altri). Operata questa amputazione "genealogica’ (almeno per la Modernità) resta una pallida e spettrale idea di liberaldemocrazia. Peraltro, quest’ultima viene declinata come l’ideologia e la pratica di quello che l’autore chiama il "secondo Occidente", quello degli Usa e delle istituzioni dell’Onu: un nuovo Occidente "a guida americana", di cui dalla fine della Seconda Guerra Mondiale "fa parte l’Europa" e la cui "espressione è la Nato" [...]"(cfr. https://www.facebook.com/francesco.fistetti.5/posts/10211262489754567).
"LA SOCIETÀ TRASPARENTE" (GIANNI VATTIMO, 1989), A mio parere, sulla trasparenza, un nodo decisivo legato al problema proprio di una "#societàtrasparente" (#GianniVattimo, 1989) , il dibattito è in alto mare ed è ancora tutto da affrontare, al suo livello antropologico-politico fondamentale, dalla radice (#Marx)!
QUESTIONE ANTROPOLOGICA ("CRISTOLOGICA") E CULTURA CRITICA. La questione è "metafisica", ma, a quanto pare, nessuno si ricorda più di #Kant e del suo illumiNATO "sàpere".
#PACEPERPETUA, Se non si rende trasparente il nodo antropologico e teologico-politico, non è possibile (come è stato dimostrato storicamente, almeno fino ad oggi, fino alla "tappa" europea di Granada 1492/2023) alcuna fraternità (libertà e uguaglianza) e la "pace perpetua" (Kant) è definitivamente assicurata.
Nota:
#FILOSOFIA #STORIA E#METATEATRO: #METAFOROLOGIA.
"La #civetta e la #talpa. Sistema ed epoca in #Hegel" di #RemoBodei (1975, 2021): "[...] Quale il rapporto fra la civetta della filosofia, che interpreta coscientemente l’epoca, e la talpa dello spirito, che la trasforma inconsciamente con il suo cieco lavorio? A tali interrogativi Remo Bodei cerca una risposta in questo saggio ormai classico, che ha offerto una prospettiva originale della filosofia hegeliana." ( https://www.mulino.it/isbn/9788815291226 ).
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E COSMOLOGIA: "IL MOVIMENTO DI UN’ANALISI" E IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI".5 settembre 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E COSMOLOGIA:
"IL MOVIMENTO DI UN’ANALISI" (NELLA "STANZA" DI FREUD) E IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (NELLA "NAVE" DI GALILEO GALILEI).
Una nota sul tema, in memoria di Sigmund Freud (1939), Elvio Fachinelli (1989) e di Jean-Bertrand Pontalis (2013).
- PIANETATERRA: NAVIGAZIONE E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (SIGMUND FREUD, 1937).
- "Finestre" (J.-B. Pontalis): "Spesso, quando ricevo un eventuale futuro paziente, vedo tessersi il canovaccio di un romanzo. Una storia di vita si delinea, con un’infanzia, con drammi, lutti, momenti di svolta, avvenimenti salienti e un ambiente sociale. Sono così convinto di capire, di afferrare i fili di un destino, che mi succede persino di anticipare quanto seguirà, come nella lettura di un romanzo.
 E poi bastano poche sedute e la storia si confonde, l’intelligibile cede il posto all’enigma, e io non sono più capace di raccontare niente.
E poi bastano poche sedute e la storia si confonde, l’intelligibile cede il posto all’enigma, e io non sono più capace di raccontare niente.
 Non so più con che cosa né con chi ho a che fare.
Non so più con che cosa né con chi ho a che fare.
 Avanziamo, l’uno e l’altro, nel buio.[...]
Avanziamo, l’uno e l’altro, nel buio.[...]
 Questo movimento che ci anima - il movimento del pensiero, della lingua, del sogno, della memoria, della parola, del desiderio - non potrà raccontare sé stesso. Tutt’al più potrà essere evocato. È possibile trasmettere il movimento di un’analisi? A questa condizione: che attraverso la mia voce si senta quella dell’altro."(J.-B. Pontalis, "Finestre", e/o 2001).
Questo movimento che ci anima - il movimento del pensiero, della lingua, del sogno, della memoria, della parola, del desiderio - non potrà raccontare sé stesso. Tutt’al più potrà essere evocato. È possibile trasmettere il movimento di un’analisi? A questa condizione: che attraverso la mia voce si senta quella dell’altro."(J.-B. Pontalis, "Finestre", e/o 2001).
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI (*). Nella "#culla" di Freud, a ben considerare, c’è la #memoria della #rivoluzionescientifica, e, al contempo, ci sono le #tracce per una ripresa della #rivoluzionecopernicana kantiana e una #svolta_antropologica epocale: la sollecitazione pontalisiana a "trasmettere il movimento di un’analisi" è un grande invito a rileggere il "#Dialogo sopra i #due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano" (#GalileoGalilei, 1632) e riprendere il lavoro nella "stanza" della "grande nave":
- "[...] Con Freud, probabilmente, nessuno (né del ‘mondo’ psicoanalitico, né tantomeno del ‘mondo’ filosofico) ha ‘dialogato’ con più libertà di giudizio e onestà intellettuale di #ElvioFachinelli (1928-1989). E, come si sa, “essere giusti con Freud” non è affatto facile! [...] Grandezza e limiti di Freud: “Su Freud” (a c. di #LambertoBoni, Adelphi Edizioni, Milano 2012, e. 12, pp. 115) è un’ottima occasione per riconsiderare il percorso di Elvio Fachinelli e rendersi conto del suo lavoro (dal 1966 al 1989) per portare la psicoanalisi fuori dalla claudicanza e dalla cecità dell’orizzonte edipico.[...]" (cfr. FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI).
PSICOLOGIA, FILOSOFIA, E CRITICA DELLA RAGIONE "PURA":
USCIRE DALLO "STATO DI MINORITÀ"(I. KANT, 1784 - M. FOUCAULT, 1984).
- Una lettera di SigmundFreud a Siegmund Heinrich Foulkes, "padre della psicoanalisi dei gruppi"
SUL "MOVIMENTO DELL’ANALISI" (J.-B. PONTALIS) E SULLA "MATURITÀ" DELL’ ANALISTA,
QUESTA LA RISPOSTA DI FREUD (1° maggio 1932) A S. H. FOULKES:
- "[...] Ho l’impressione che voi prendiate un po’ troppo sul personale le precauzioni che la Società tedesca osserva riguardo ai nuovi membri. [...]
- Molto di ciò che voi indicate criticamente nella vostra lettera è purtroppo ben fondato. A me sembra che la più grande delusione dell’analisi sia il fatto che essa non produca un maggiore cambiamento negli analisti stessi. Nessuno ha ancora fatto oggetto di studio con quali mezzi gli analisti riescano ad eludere l’influenza dell’analisi sulla propria persona. Speriamo che ci siano altri e più forti motivi per tenere insieme i membri, oltre al comune rapporto con me, che naturalmente non potrebbe durare a lungo nella mia esistenza.[...]" (cfr. Centro Veneto di Psicoanalisi).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- LO SPIRITO DELL’UTOPIA, IL MATRIMONIO DI MATRIMONIO DI MARTIN LUTERO E KATHARINA VON BORA, E "THE BOOK OF SIR THOMAS MORE"22 luglio 2023, di Federico La Sala
CRISTIANESIMO E GEOPOLITICA, SENZA PREGIUDIZI, ALLA LUCE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICA DEI "DUE SOLI" (DANTE 2021):
- MEMORIA DEL MATRIMONIO DI MARTIN LUTERO E KATHARINA VON BORA (1525).
- Guardando con gli occhi di Shakespeare ("The Book of Sir Thomas More"), e di Elisabetta d’Inghilterra (dopo il 1588), lo "splendore" delle figure di Tommaso Moro e di Erasmo è alquanto oscurato, data la loro "amicizia" con la visione teologico-politica platonica (cosmoteandrica e "golematica") della Chiesa cattolico e del Papato dell’epoca. 🌞🌞🙏
STORIA DI EUROPA, DI IERI E DI OGGI: "THE BOOK OF SIR THOMAS MORE". Partendo dal suo tempo (quasi cento anni dopo), Shakespeare cerca di chiarire il percorso che l’Inghilterra di EnricoVIII ed Elisabetta ha fatto e che cosa ha guadagnato, a partire dagli eventi del 1517 e dopo la rottura con la Chiesa Cattolica e dopo la Riforma Anglicana!
 Una possibile chiave interpretativa sta proprio nella natura del conflitto teologico-politico (e nel legame di Tommaso Moro con le indicazioni di san Paolo, e del Papa):
Una possibile chiave interpretativa sta proprio nella natura del conflitto teologico-politico (e nel legame di Tommaso Moro con le indicazioni di san Paolo, e del Papa):
 " Voi volete schiacciare gli stranieri [...]"Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora?
Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in #Francia o nelle #Fiandre, in qualsiasi provincia della #Germania, in #Spagna o in #Portogallo, anzi no, un luogo qualunque #diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che [...] vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli [...]?". Questo il problema, a mio parere.
" Voi volete schiacciare gli stranieri [...]"Supponiamo adesso che il re, nella sua clemenza verso i trasgressori pentiti, giudicasse il vostro grave reato limitandosi a punirvi con l’esilio: dove andreste, allora?
Quale paese vi accoglierebbe vedendo la natura del vostro errore? Che andiate in #Francia o nelle #Fiandre, in qualsiasi provincia della #Germania, in #Spagna o in #Portogallo, anzi no, un luogo qualunque #diverso dall’Inghilterra, vi ritroverete inevitabilmente stranieri.
Vi farebbe piacere trovare una nazione dal carattere così barbaro che [...] vi cacciasse via come cani, quasi che Dio non vi avesse creati né vi riconoscesse come suoi figli [...]?". Questo il problema, a mio parere. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- "MENSCHWERDUNG" ("DIVENTARE UN ESSERE UMANO"): HEGELISMO, PLATONISMO, E ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA).11 luglio 2023, di Federico La Sala
HEGELISMO, PLATONISMO, FILOLOGIA E ANTROPOLOGIA (CRISTOLOGIA)*
- "SÀPEREAUDE! (KANT, 1784): "IO SONO L’ALFA E L’OMEGA, IL PRIMO E L’ULTIMO" (#APOCALISSE, 1.11).
- CON HEGEL, MA A RICOMINCIARE DA #DIOTIMA DI MANTINEA, #DANTEALIGHIERI, #GALILEOGALILEI, IMMANUEL #KANT...
- ELEUSIS 2023.
"MENSCHWERDUNG" ("DIVENTARE UN ESSERE UMANO"). "Dio è amore" ("Deus charitas est"), condivido (è una questione di "h": "Charitas", gr. "Xapitas"). Hegel ha messo il dito nella piaga: "La vita di Dio e il conoscere divino potranno bene venire espressi come un gioco dell’#amore ["ein Spielen der Liebe"] con se stesso; questa idea degrada fino all’edificazione e addirittura all’insipidezza, quando mancano la serietà, il dolore, la pazienza e il travaglio ["Arbeit"] del negativo" ("Fenomenologia dello Spirito", §19).
 A ben "orientarsi nel pensiero" (Kant) e, al contempo, nel sollecitare una ri-considerazione unitaria della "Prefazione" ("Vorrede") della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel e la figura della profetessa di Mantinea, Diotima, a mio parere, emerge chiaramente il #nodo antropologico di fronte a cui Hegel si è trovato e che ha sciolto in modalità tragica, edipica e paolina, con tutta la "socratica" potenza di un #Napoleone (Alessandro Magno); non con lo spirito del #Logos (di Eraclito e dell’evangelista Giovanni) né della #Giustizia di Parmenide, egli ruba "alla #Platone" l’anima a Diotima ("Simposio") e ripropone una demiurgica e demogorgonica #cosmoteandria t(al)ebana: "[...] che il vero sia effettuale solo come sistema o che la sostanza sia essenzialmente soggetto ciò è espresso in quella rappresentazione che enuncia l’#assoluto come #spirito - elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua #religione" (Fenom. d. spir., § 22).
A ben "orientarsi nel pensiero" (Kant) e, al contempo, nel sollecitare una ri-considerazione unitaria della "Prefazione" ("Vorrede") della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel e la figura della profetessa di Mantinea, Diotima, a mio parere, emerge chiaramente il #nodo antropologico di fronte a cui Hegel si è trovato e che ha sciolto in modalità tragica, edipica e paolina, con tutta la "socratica" potenza di un #Napoleone (Alessandro Magno); non con lo spirito del #Logos (di Eraclito e dell’evangelista Giovanni) né della #Giustizia di Parmenide, egli ruba "alla #Platone" l’anima a Diotima ("Simposio") e ripropone una demiurgica e demogorgonica #cosmoteandria t(al)ebana: "[...] che il vero sia effettuale solo come sistema o che la sostanza sia essenzialmente soggetto ciò è espresso in quella rappresentazione che enuncia l’#assoluto come #spirito - elevatissimo concetto appartenente all’età moderna e alla sua #religione" (Fenom. d. spir., § 22).
 A che gioco giochiamo, a che giogo vogliamo continuare a giocare? Non è meglio, forse, riprendere il filo proprio da Diotima e, con Dante Alighieri ("Due Soli") e portarsi fuori dalla tragedia dei "Tempi moderni" (Charlie Chaplin)?
A che gioco giochiamo, a che giogo vogliamo continuare a giocare? Non è meglio, forse, riprendere il filo proprio da Diotima e, con Dante Alighieri ("Due Soli") e portarsi fuori dalla tragedia dei "Tempi moderni" (Charlie Chaplin)?P. S. 1 - «Senza Hegel non sarebbe stato possibile neppure Darwin, afferma Nietzsche, e l’avrebbe potuto dire anche di se stesso; infatti chi si ammali una volta di hegelite - così mordacemente si era espresso un decennio prima - non ne guarirà mai del tutto. E che cosa sarebbe la critica alla religione di Fuerbach e di Marx, o anche quella odierna di Ernst Bloch e Georg Lukács senza Hegel?» (Hans Küng, "Incarnazione di Dio. Introduzione al pensiero teologico di Hegel, prolegomeni ad una futura cristologia", Queriniana, 1972).
P. S. 2 - EUROPA: CRISTIANESIMO CATTOLICESIMO COSTITUZIONE E SPIRITO DI ASSISI (1986). Quando Benedetto Croce pubblicò il suo «Perché non possiamo non dirci "cristiani"» (1942), don Giuseppe De Luca ’confessò’ al Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai: si è "rincristianito per dispetto". Come concordato...!!!
*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- COSMOLOGIA E ANTROPOLOGIA: UNA QUESTIONE DI ILLUMINAZIONE (E DI ILLUMINISMO KANTIANO).9 luglio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA.
UN PIANETA TERRA DA RIPENSARE E UN IMMAGINARIO DA RISTRUTTURARE: PENSARE L’ EDIPO COMPLETO (S. FREUD). UNA QUESTIONE DI ILLUMINAZIONE (E DI ILLUMINISMO KANTIANO): "NOI ALUNNI DEL SOLE". In memoria di Italo Calvino.
- "Oriente e Occidente - scrive Nietzsche - sono tratti di gesso che qualcuno disegna davanti ai nostri occhi per beffarsi della nostra pavidità" ("Schopenhauer come educatore").
Appunti su un tema del "genere" (il Sole, l’astro del cielo, un dio o una dea?):
A) IL SOLE ("DIE SONNE") DI ZARATHUSTRA (NIETZSCHE):
"Quand’ebbe compiuto il trentesimo anno, Zarathustra lasciò la sua patria e il lago natìo, e si recò su la montagna. Là per dieci anni gioì, senza stancarsene, del suo spirito e della sua solitudine.
 Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
Ma al fine il suo cuore si mutò; e un mattino egli si levò con l’aurora, s’avanzò verso il sole e così gli disse:
 «Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
«Oh grande astro! Che sarebbe della tua felicità, se tu non avessi a chi splendere?
 Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
Per dieci anni tu sei venuto alla mia caverna: ti saresti recato a noja la tua luce e il tuo cammino senza di me e del mio serpente.
 Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");
Ma noi ti attendevamo tutte le mattine, tu ci davi il tuo superfluo e ne avevi ricambio di benedizioni." ("Così parlò #Zarathustra/Parte prima/Prefazione");- "Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahr nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, - und eines Morgens stand er mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also:
 “Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
“Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!
 Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle: du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange.
Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür.”.
B) MITOLOGIA NORRENA ("EDDA DI SNORRI"). LA SIGNORA DEL SOLE ("FRAU SUNNE"):
 "Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);
"Sól era, nella mitologia norrena, la dea del Sole, figlia di Mundilfœri e moglie di Glenr.
Ogni giorno, Sól guida attraverso il cielo il suo carro, tirato da due cavalli, Árvakr e Alsviðr.
Così se ne parla nel Gylfaginning, la prima parte dell’Edda in prosa basso-medievale di Snorri Sturluson (circa 1220 d.C.) [...]
Sól era chiamata anche Sunna e Sunne, e inoltre Frau Sunne (Signora del Sole) [...]" (Sól);C) AMATERASU ("LA DEA DEL SOLE"):
 "Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);
"Amaterasu-ō-mi-kami (天照大御神 lett. "Grande dea che splende nei cieli"?), generalmente abbreviato in Amaterasu, è la dea del Sole nello shintoismo giapponese. È considerata la mitica antenata diretta della famiglia imperiale giapponese.
Amaterasu è comunemente indicata come di genere femminile, nonostante il Kojiki, il più antico documento scritto della storia nipponica, dia pochi indizi riguardo al suo genere [...]" (Amaterasu);D) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E PSICOANALISI. L’ESISTENZA DEL "COMPLESSO EDIPICO COMPLETO" (S. FREUD, 1923);
 "[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
"[...] Vedere il caso del Giappone - nella cultura giapponese c’è la Dea in cielo, e l’imperatore sulla terra; ora-oggi!!!, dal momento che alla coppia imperiale è nata una bambina, si parla di cambiare la Costituzione per far sì che Lei possa accedere al trono ... ma il problema è più complesso - come si può ben immaginare - perché ... deve essere cambiata anche la Costituzione celeste dell’Impero del Sol Levante!!! Se no, l’Imperatrice con Chi si ’sposerà’?! Con la Dea?!!
 Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante).
Non è questa forse la ragione nascosta del “disagio della civiltà” dell’Oriente e dell’Occidente ..... e anche della sua fine, se non ci portiamo velocemente fuori da questo orizzonte edipico-capitalistico di peste, di guerra e di morte? [...]" (Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante). -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ANTROPOLOGIA E STORIA: IL SIMBOLO NICENO (325), "LA PACE DELLA FEDE", 1453), E NICEA (2025).5 giugno 2023, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA: SPIRITO CRITICO E AMORE CONOSCITIVO...
Alcune considerazioni a margine di una riflessione sul Simbolo Niceno-costantinopolitano (Nicea, 325) o Credo niceno-costantinopolitano (Symbolum Nicaenum Costantinopolitanum):
- "4 GIUGNO 2023. SS. TRINITÀ. PER UNA CRITICA E UNA CELEBRAZIONE DELLA DOTTRINA TRINITARIA". [...] Il Simbolo Niceno dice che il Figlio è «generato» dal Padre, utilizzando un lessico biologico («generato, non creato») che solo l’esperienza concreta della vita naturale può rendere comprensibile. Ma sul piano biologico non c’è paternità e non c’è generazione senza un elemento femminile che riceva l’azione paterna, fungendo poi da «matrice» della prole (l’elemento materno è passivo nell’essere fecondato, e attivo nel mettere alla luce).
 Di questo elemento per così dire femminile, indispensabile alla semantica del Padre e del Figlio, nella teologia trinitaria non SEMBRA esserci traccia (non è lo Spirito a svolgere questa funzione). Non a caso la metafisica idealistica, cripto-teologica, tenterà di uscire dall’impasse eliminando il lessico «parentale» e sostituendolo con un lessico «neutro»: l’Io pone nell’Io un Non-io eccetera (Fichte). Uno-due-tre. Un lessico «principiale» che aggira e sterilizza, con quel «porre» («setzen»), l’ostacolo insormontabile della «generazione» biologica.
Di questo elemento per così dire femminile, indispensabile alla semantica del Padre e del Figlio, nella teologia trinitaria non SEMBRA esserci traccia (non è lo Spirito a svolgere questa funzione). Non a caso la metafisica idealistica, cripto-teologica, tenterà di uscire dall’impasse eliminando il lessico «parentale» e sostituendolo con un lessico «neutro»: l’Io pone nell’Io un Non-io eccetera (Fichte). Uno-due-tre. Un lessico «principiale» che aggira e sterilizza, con quel «porre» («setzen»), l’ostacolo insormontabile della «generazione» biologica.
 Ma è fondamentale quel «sembra». Non si tratta infatti di smontare-decostruire l’idea trinitaria, quanto piuttosto di suggerirne il significato nascosto, nascosto e tuttavia presente in qualche modo nella sua stessa formulazione. Di portare alla luce ciò che la «dottrina» già contiene, e che per qualche ragione rimane fino a un certo punto - in realtà per quasi duemila anni, fino all’estrema consunzione - allo stato di latenza. [...]" (Flavio Piero Cuniberto).
Ma è fondamentale quel «sembra». Non si tratta infatti di smontare-decostruire l’idea trinitaria, quanto piuttosto di suggerirne il significato nascosto, nascosto e tuttavia presente in qualche modo nella sua stessa formulazione. Di portare alla luce ciò che la «dottrina» già contiene, e che per qualche ragione rimane fino a un certo punto - in realtà per quasi duemila anni, fino all’estrema consunzione - allo stato di latenza. [...]" (Flavio Piero Cuniberto).
UN "COMPROMESSO STORICO" DI LUNGA DURATA: LA TRAGEDIA. La grande instaurazione "olimpica", con le parole di Atena, parla chiara e tondo: «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda...» (Eschilo, Eumenidi).
DIVINA COMMEDIA (DANTE 2021). LA SCOPERTA DEL LAOCOONTE (1506) E LA MEMORIA DI TROIA (VIRGILIO, "ENEIDE"): LA "SACRA FAMIGLIA" ("TONDO DONI"). Michelangelo, con i suoi profeti e le sue sibille, cosa ha indicato a Firenze (1506-1508), come a Roma (nella Volta della Cappella Sistina, 1508-1512)?
RINASCIMENTO, OGGI: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE" (1996) ... purtroppo da millenni, si preferisce ’navigare’ nel mare della tragica "dotta ignoranza" (Niccolò Cusano), e seguire ancora la rotta del "sapiente" Bovillus, con la sua "piramide" androcentrica (cfr. Stefano Mancuso - AlessandraViola, "Verde brillante", Giunti 2013, p. 19)!!!
PER "LA PACE DELLA FEDE" (Niccolò Cusano, 1453), UN NUOVO CONCILIO DI NICEA (2025)?!
- "4 GIUGNO 2023. SS. TRINITÀ. PER UNA CRITICA E UNA CELEBRAZIONE DELLA DOTTRINA TRINITARIA". [...] Il Simbolo Niceno dice che il Figlio è «generato» dal Padre, utilizzando un lessico biologico («generato, non creato») che solo l’esperienza concreta della vita naturale può rendere comprensibile. Ma sul piano biologico non c’è paternità e non c’è generazione senza un elemento femminile che riceva l’azione paterna, fungendo poi da «matrice» della prole (l’elemento materno è passivo nell’essere fecondato, e attivo nel mettere alla luce).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- FILOLOGIA, "SÀPERE AUDE!", E CENA DELLA VITTORIA. Una nota a margine dell’articolo "Vedere i concetti" di Alfonso Maurizio Iacono.16 maggio 2023, di Federico La Sala
LA CENA DELLA VITTORIA: PLATONISMO, ILLUMINISMO, E INTERPRETAZIONE DEI SOGNI DEI VISIONARI.
- Una nota a margine dell’articolo "Vedere i concetti" di Alfonso Maurizio Iacono (Doppiozero, 15 maggio 2023). Un invito a cambiare rotta e registro...
ANTROPOLOGIA, ECONOMIA POLITICA E METAFISICA. PREMESSO CHE "Il sapere visuale è una sorta di dannazione della filosofia. Le idee di Platone non sono visibili eppure la radice greca che dà vita alla parola idea ha a che fare con il visibile." (Alfonso M. Iacono), FORSE, è meglio cercare di vedere chi cucina "la cena della vittoria" (B. Brecht), di non affidarsi ai freudolenti "sogni di un visionario", e seguire l’indicazione di Orazio Shakespeare Kant Marx Nietzsche Freud e Foucault: "Sàpere aude!" .
FILOLOGIA E CRITICA: "SÀPERE AUDE!" (ORAZIO/KANT). A ben riflettere, accogliendo l’importante sollecitazione, si tratta di cambiare rotta e registro (oltre il platonismo e il paolinismo) e avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza, di "aprire gli occhi" (Sigmund Freud) sulla lezione evangelica di Gioacchino da Fiore sull’amore ("charitas") e, al contempo, di "sàpere" che cosa "mangiamo" a cena, se "grazia di dio" ("eu-charis-tia") o cibo avvelenato (di una tragica bimillenaria "buona-carestia"). Se non ora, quando?!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- MONARCHIA, FASCISMO, E RESISTENZA: LA "DIVINA COMMEDIA" E IL 25 APRILE.23 aprile 2023, di Federico La Sala
MONARCHIA, FASCISMO, E RESISTENZA:
LA DIVINA COMMEDIA E IL 25 APRILE.
- Una nota a margine della #giornatadellaterra 2023 ... *
#ANTROPOLOGIA, #LINGUISTICA, E #POLITICA. A 702 anni dalla morte di #DanteAlighieri, la società italiana mostra ancora grandi difficoltà al suo interno e non riesce a parlare una #lingua #comune, quella propria dei cittadini-sovrani e delle cittadine-sovrane.
#STORIA, #LETTERATURA E #FILOSOFIA. Prima di #Hegel, a tutti i livelli (antropologici e teologici), a cosa alludeva #Dante con la sua paradigmatica proposta della #Monarchia dei #DueSoli?!
LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI". Se, alla base del "dia-logo" delle due parti in cui l’Italia è divisa (la "destra" e la "sinistra" di "sempre"), non c’è il #Logos (l’accettazione e la condivisione della #Parola della #Legge), ma c’è solo il #Logo di una parte contro e sopra l’altra armata, in una "dialettica" da "#padrone e #servo", dov’è più il #dialogo, dove più la #Costituzione?, dove l’#Italia?!
#EarthDay #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- GENERE UMANO E INGEGNO: NELL’ANNO "DANTE 2021", CON "INGENUITY", SULLA "TERRA" DI MARTE.22 aprile 2023, di Federico La Sala
COSMOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E DIVINA COMMEDIA: "SIDEREUS NUNCIUS" (GALILEO GALILEI, 1610) E "SAPERE AUDE!"(I. KANT, 1784). Alcuni appunti sul tema dell’antropogenesi (e cristogenesi) nell’opera di Dante...
- FILOLOGIA E ARCHEOLOGIA FILOSOFICA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI ANDROLOGIA DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3);
- E DELLA SUA COSTRUZIONE DEL "CORPO DI CRISTO": "Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto [...] egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo [εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ], finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo [ἄνδρα] perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo." (Efesini, 4.1/11-13).
NELL’ANNO DANTE2021, SU MARTE, "INGENUITY" INIZIA LA SUA ATTIVITA’ E LA SUA MISSIONE ESPLORATIVA:
CON ULISSE, OLTRE: VIRTU’ E CONOSCENZA. Ai suoi tempi, Dante ha esplorato con il suo "oudemico" ingegno l’intero "oceano celeste" (Keplero) e, al ritorno, ha raccontato che, trovandosi nel V cielo, quello del Pianeta Marte, rimase colpito da "una melode/ che mi rapiva, sanza intender l’inno (Pd XIV, 101 e 123).
L’INGEGNO, IL GENERE UMANO ("GATTUNGSWESEN"), E LA "TERRA" DI MARTE:
NELL’ANNO 2023, "Lo scorso 13 aprile il piccolo elicottero marziano Ingenuity ha azionato le sue eliche per la 50esima volta, percorrendo 320 metri in poco più di 2 minuti e mezzo, durante i quali ha infranto anche il precedente record di altezza, salendo fino a 18 metri. Ingenuity, che il 19 aprile ha festeggiato i suoi primi due anni su Marte, fu inizialmente concepito come dimostratore tecnologico, un modo cioè per provare che il volo controllato a motore su un altro pianeta fosse possibile. [...]
 Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).
Costruito con molti componenti di serie, come processori e fotocamere di smartphone, Ingenuity ha superato di 23 mesi terrestri e 45 voli la durata prevista. Ad oggi, ha volato in totale per oltre 89 minuti e più di 11,6 chilometri. «Abbiamo fatto tanta strada e vogliamo andare ancora più lontano», dice Teddy Tzanetos, responsabile del team della missione al Jpl. «Ma sappiamo fin dall’inizio che il nostro tempo su Marte è limitato e ogni giorno operativo è una benedizione. Che la missione di Ingenuity finisca domani, la prossima settimana o tra qualche mese è qualcosa che nessuno può prevedere al momento. Quello che posso prevedere è che, quando succederà, ci sarà una bella festa». " (cfr. Jacopo Danieli, "Cinquanta voli per l’elicotterino marziano", INAF, 21/04/2023).EARTHDAY 2023 #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- FREUD, KANT, E DANTE ... UN PASSO DA GIGANTE21 aprile 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, CRISTIANESIMO, ANTROPOLOGIA E LETTERATURA:
- L’ENIGMA DI SAN CRISTOFORO (IL GIGANTE, PORTATORE DEL BAMBINO CRISTO , "CRISTO-FORO" O, ALTRIMENTI, "CRISTO-FARO", "LA LUCE DEL MONDO").
- Una nota in omaggio al lavoro di filologia e storia di Michele Lualdi...
"PSICOLOGIA DELLE MASSE E ANALISI DELL’ IO" (S. FREUD, 1921): DANTE ("Io non Enëa, io non Paulo sono": Inf. II, 32) SA "DOVE METTE CRISTOFORO IL PIEDE" (cfr. Wilhelm Stekel, "Il ’Piccolo Kohn’ ", 1903, tradotto e curato da Michele Lualdi).
"IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS", "CRITICA DELLA RAGION PURA" (KANT), E "IDEALE DELL’IO" (S. FREUD). CON GIASONE (OVIDIO) E CON ASTREA (LA "VIRGO" DI VIRGILIO) E MARIA-BEATRICE (LA "VERGINE" DI SAN BERNARDO), DANTE RIPRENDE IL CAMMINO, dall’ INIZIO (dall’Inferno) ma dal PRINCIPIO (Par. XXXIII: "Vergine Madre, figlia del tuo figlio [...] l’amor che move il sole e l’altre stelle") e racconta come è riuscito a ritrovare "LA DIRITTA VIA" e a capire il senso antropologico di sé: "Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine" (Ap., XXII, 13).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- UNO. Uscire dall’inferno epistemologico: ripartire da due, "almeno due" Gregory Bateson).17 aprile 2023, di Federico La Sala
SPIRITO CRITICO E AMORE CONOSCITIVO: ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA E MATEMATICA:
IMPARARE A #CONTARE. Uscire dall’inferno epistemologico
#UNO: "SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI" (2005). In principio era il Logos (Eraclito, Efeso), non il #logo di una azienda sul cui cancello d’entrata sta scritto "il lavoro rende liberi".
"DUE SOLI" (#DANTE2021). Ri-#pensare l’ONU - a partire da Due, "almeno due" (Gregory Bateson):
- “...per creare una differenza occorrono almeno due cose. Per produrre notizia di una differenza, cioè informazione, occorrono due entità (reali o immaginarie) tali che la differenza tra di esse possa essere immanente alla loro relazione reciproca: e il tutto deve essere tale che la notizia della loro differenza sia rappresentabile come differenza all’interno di una qualche entità elaboratrice di informazioni, ad esempio un cervello, o forse un calcolatore.
 Vi è un problema profondo e insolubile a proposito della natura di quelle ‘almeno due’ cose che tra loro generano la differenza che diventa informazione creando una differenza. È chiaro che ciascuna di esse, da sola, è - per la mente e la percezione - una non-entità, un non-essere. Non è diversa dall’essere e non è diversa dal non-essere: è inconoscibile, una Ding-an-sich, il suono dell’applauso di una mano sola. La materia prima della sensazione, dunque, è una coppia di valori di una qualche variabile, presentati in un certo arco di tempo a un organo di senso la cui risposta dipende dal rapporto tra i due elementi della coppia” (G. Bateson, "Mente e Natura", 1984).
Vi è un problema profondo e insolubile a proposito della natura di quelle ‘almeno due’ cose che tra loro generano la differenza che diventa informazione creando una differenza. È chiaro che ciascuna di esse, da sola, è - per la mente e la percezione - una non-entità, un non-essere. Non è diversa dall’essere e non è diversa dal non-essere: è inconoscibile, una Ding-an-sich, il suono dell’applauso di una mano sola. La materia prima della sensazione, dunque, è una coppia di valori di una qualche variabile, presentati in un certo arco di tempo a un organo di senso la cui risposta dipende dal rapporto tra i due elementi della coppia” (G. Bateson, "Mente e Natura", 1984).
#ELEUSIS2023 #Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #EARTHRISE
- “...per creare una differenza occorrono almeno due cose. Per produrre notizia di una differenza, cioè informazione, occorrono due entità (reali o immaginarie) tali che la differenza tra di esse possa essere immanente alla loro relazione reciproca: e il tutto deve essere tale che la notizia della loro differenza sia rappresentabile come differenza all’interno di una qualche entità elaboratrice di informazioni, ad esempio un cervello, o forse un calcolatore.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "ADAMO ED EVA", ARTE, E FILOLOGIA: LA CREATIVITÀ "GENERICA" E "IL DEMONE DI PICASSO"14 aprile 2023, di Federico La Sala
ARTE, "ADAMO ED EVA", ECONOMIA POLITICA E FILOLOGIA.
MARX, IL GENERE UMANO (GATTUNGSWESEN), E LA CREATIVITÀ "GENERICA":
Un libro di Gabriele Guercio da ri-leggere:
***
«Il demone di Picasso», opzione per l’arte nell’epoca del generico
di Stefano Chiodi («Alias - il manifesto», 04 giugno 2017)
Jeder Mensch ist ein Kibistler. Non credo potesse immaginare Joseph Beuys a che punto la posterità avrebbe adottato la sua celebre massima, secondo la quale, appunto, «ognuno è un artista». Non certo nel senso da lui auspicato, e fatalmente impervio, della liberazione di una creatività che potesse non solo esercitarsi senza limiti, ma, tratto essenziale, fosse alla base di un nuovo patto tra umanità e cosmo cui l’arte, ormai trasformata in «scultura sociale», avrebbe conferito illimitate energie spirituali. Piuttosto, la creatività diffusa della nostra epoca sembra al contrario perversamente confermare i presupposti di quell’ordine alienante che per Beuys costituiva la patologia originaria dell’uomo moderno. La convergenza, compulsiva, radicale, estatica, tra la natura spettacolare del neocapitalismo, i suoi nuovi strumenti di produzione e partecipazione immaginaria e cognitiva, e la spinta creativa individuale ci attira sempre più in un territorio in cui i social networks rappresentano solo la seducente parte visibile di un immenso, cruciale sommovimento, in cui, avvertono i filosofi, ormai dissipata la distinzione tra lavoro e non lavoro, è la vita umana tutta a essere trasformata in valore economico.
Ma la febbrile produzione creativa della moltitudine ha anche un inevitabile effetto degradante sulla pretesa dell’arte di conservare la propria antica capacità di dare visibilità a ciò che visibile non è ancora. Nella sua condizione postmodernista e postmediale - vale a dire indipendente da supporti, tecniche, pratiche tradizionali -, l’arte-in-generale del nostro tempo, eterogenea e senza limiti, rischia di apparire genericamente creativa, il suo valore ridotto a mero rilevamento istantaneo della sua approvazione sociale, pragmaticamente assunta a indice unico del suo residuo prestigio.
L’«orinatoio» compie cento anni
Di fronte a questo paesaggio, in cui l’arte sembra cadere vittima della fondamentale indistinzione con la non-arte da essa stessa istigata negli ultimi decenni, sarebbe agevole assumere l`atteggiamento corrucciato e prevedibilmente reazionario di chi lamenta la perdita delle buone pratiche, della «verità del fare», o anche quello, più benevolo, di quanti, e sono la maggioranza, si limitano a comporre tassonomie, astenendosi dal rilevare, se mai esistono, attriti e differenze. La sfida sullo sfondo del recente saggio di Gabriele Guercio, Il demone di Picasso. Creatività generica e assoluto della creazione (Quodlibet, pp. 252, € 18,00), è precisamente questa: interrogare l’indistinzione, l’anything goes che caratterizza le esperienze artistiche più recenti da una prospettiva insieme di critica esigente e di penetrazione storica, che affronti con coraggio la contraddizione e tenti di rileggerla in modo produttivo, senza sottrarsi all’onere di una paziente ritessitura teorica e genealogica.
Sarebbe stato scontato attendersi come punto di partenza di un simile percorso la figura di Marcel Duchamp, la cui invenzione maggiore, il readymade (il più famoso dei quali, l’orinatoio di porcellana ribattezzato Fountain, ha compiuto poche settimane fa cento anni), è all’origine della radicale trasformazione del campo artistico a partire dagli anni cinquanta dello scorso secolo. Invenzione grazie alla quale un’opera può fare a meno di ogni apporto manuale da parte dell’artista e condensarsi in un atto creativo, mentale - nel puro enunciato «questo è arte» -, aprendo una nuova, illimitata prospettiva di riconfigurazione estetica dell’esperienza. È invece con Pablo Picasso che Guercio decide di misurarsi, il Picasso sfacciatamente eclettico, smodato nel suo inventare e reinventare stili, complice della propria trasformazione in figura di culto - l’Artista geniale - ad uso dell’immaginario mediatico, ma anche tenacemente dedito a inseguire il «prodigio» di una creazione assoluta, che si misura alla pari col «demone della creatività generica» ma è qualitativamente differente da essa.
Nel libro, Picasso è osservato da presso in due passaggi rivelatori. Il primo è una fotografia de11913 di un effimero assemblage realizzato nell’atelier al 242 di Boulevard Raspail, in cui i confini tra realtà e finzione, tra segno e oggetto, tra «dato» e «creato» sono consapevolmente violati e rimescolati, così da produrre una sorta di perpetua, caotica oscillazione. Al centro dell’opera appare infatti un vuoto, un’esitazione, un non-sapere: come nel collage cubista, vi si afferma l’impossibilità di stabilire a priori una differenza tra dimensione artistica e non artistica. Il secondo passaggio: l’incontro di artista e modella nello studio - tema ossessivo che accompagna fino alla fine il percorso picassiano -, immaginato come esperienza amorosa, e anzi erotica in senso proprio, in cui la creazione dal nulla si manifesta come sospensione del tempo, come setting in cui diviene possibile concepire un’«opera viva» e tentare di penetrare l’enigma, interamente materialistico, di una origine senza divinità, senza trascendenza, senza regola, «senza radici».
Pratica anarchica, lavoro «morto»
Capiamo meglio a questo punto perché Picasso, e non Duchamp, appaia a Guercio la figura chiave per ridefinire le possibilità dell’arte nell’epoca del generico. Laddove per Duchamp la disseminazione (a determinate condizioni) del concetto unitario di arte nella «cosa qualsiasi» coincide con la sua costante riaffermazione (anche in assenza di creazione: Duchamp come curatore di mostre altrui, come alter ego femminile, come mero respirateur), per Picasso l’operazione artistica, con tutto il suo savoir faire, si misura direttamente con la propria deriva e declassamento in pratica anarchica, in lavoro «morto», e insieme con la necessità di rivendicare una oggettività a se stesso, come «artefice e custode di ciò che non evolve né deriva da un’evoluzione» ma emerge all’improvviso.
Nella dialettica tra creazione «assoluta» e creatività generica, tra l’artista come produttore e l’artista come demiurgo, Picasso addita dunque alla nostra epoca una possibilità diversa, quella di sottrarsi al relativismo e all`indifferenza senza richiudere il confine tra arte e non-arte, senza rifugiarsi nel «mestiere»: l’idea di un’esperienza che passi al tempo stesso nelle menti e nei corpi e manifesti una mancanza, un vuoto, un ignoto, la scoperta della differenza con un «altro da sé» altrove costantemente rimosso.
 Con ricchezza concettuale e un’intensità di argomentazione a tratti visionaria, il libro di Gabriele Guercio ritrova un potenziale troppo spesso occultato della storia dell’arte, la sua capacità cioè di interrogare le opere non solo come documenti di forme di vita trapassate, ma come tracce vive e profezie di umanità potenziale.
Con ricchezza concettuale e un’intensità di argomentazione a tratti visionaria, il libro di Gabriele Guercio ritrova un potenziale troppo spesso occultato della storia dell’arte, la sua capacità cioè di interrogare le opere non solo come documenti di forme di vita trapassate, ma come tracce vive e profezie di umanità potenziale.***
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "GUNTHER ANDERS E LA SCENA ATTUALE": GODOT (BECKETT), CHARLOT (CHAPLIN), E UN PASSO OLTRE HEGEL.2 aprile 2023, di Federico La Sala
ARTE, CINEMA, ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA E PSICOANALISI: "GÜNTHER ANDERS E LA SCENA ATTUALE".
GODOT (BECKETT) E CHARLOT (CHAPLIN). Tracce per una svolta antropologica: una nota su una "vecchia" indicazione di Günther Anders.
RIPRENDENDO IL DISCORSO DA "ADAMO ED EVA", dalla coppia più famosa della preistoria (laica e devota), sul filo della memoria del lavoro del regista Jim Jarmusch, "Solo gli amanti sopravvivono" ("Only Lovers Left Alive"), un film del 2013, e, al contempo, accogliendo la sollecitazione della rivista "Aut Aut" (397/2023) a riprendere il lavoro di Günther Anders (cfr. "L’uomo è antiquato? Günther Anders e la scena attuale", forse, è opportuno (per "orientarsi nel pensiero") cominciare proprio da "L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’era della seconda rivoluzione industriale" (1956), e, in particolare, dal capitolo intitolato "ESSERE SENZA TEMPO. A proposito di En attendant Godot di Beckett". In questo capitolo, nel "§ 6 Entrano in scena gli antipodi", così è scritto:
- "[...] questi antagonisti si presentano loro [a Estragon e Vladimir] nella coppia Pozzo-Lucky. I tentativi di decifrare questi due personaggi, di scoprire chi siano e che cosa significhino non ha dato meno filo da torcere agli interpreti, che il problema dell’identità di Godot. Ma tutti i tentativi di decifrazione erano mal impostati, perché LA COPPIA STESSA È UNA DECIFRAZIONE. Come sarebbe a dire?
 Beckett, cioè, non ha ridotto a cifra astratta una realtà sensibile, ma si serve di questi due personaggi per trasporre dall’esistenza cifrata e speculativa in quella sensibile, ciò che precedentemente era esistito soltanto in versione concettuale? Che cosa?
Beckett, cioè, non ha ridotto a cifra astratta una realtà sensibile, ma si serve di questi due personaggi per trasporre dall’esistenza cifrata e speculativa in quella sensibile, ciò che precedentemente era esistito soltanto in versione concettuale? Che cosa?
 Sin dall’inizio del decennio 1930-1940, quando in Francia i letterati e i filosofi delle nuove generazioni cominciarono a infervorarsi per la dialettica hegeliana e per la teoria marxista della lotta di classe, la famosa coppia «signore e servo» della Fenomenologia dello spirito si è impressa nella coscienza della generazione nata intorno al 1900, che si può dire senz’altro che oggi ha preso il posto che nel secolo XIX era riservata alla figura di Prometeo; è diventata la pura e semplice immagine dell’uomo [...] Caratteristiche dominanti del nuovo simbolo sono la pluralizzazione e l’antagonismo: ossia il fatto che «l’uomo» è personificato ora da una coppia umana, che il singolo (il quale, selfmade man metafisico, aveva combattuto prometeicamente contro gli dei) è sostituito ora da uomini, precisamente da uomini che si contendono reciprocamente il dominio. [...]. Eppure la commedia di Beckett si differenzia in un punto da quasi tutti quesi documenti nichilistici in cui il presente trova la sua espressione letteraria: nel tono. [...]. Non a caso nessun’altra figura del nostro secolo ha suscitato tanta gratitudine quanto la desolata figura dello Chaplin dei primi film. Sembra che la farsa sia diventata il rifugio dell’amore per il prossimo: la complicità degli sconsolati sia diventata l’ultimo conforto. E se ciò che spunta dal terreno sconsolatamente arido dell’assurdità: il mero tono umano, è un minuscolo conforto; e se il conforto non sa perché conforta e quale Godot promette come conforto - esso dimostra tuttavia che IL CALORE È PIÙ IMPORTANTE DEL SIGNIFICATO; E CHE NON È AL METAFISICO CHE SPETTA L’ULTIMA PAROLA, MA SOLTANTO A COLUI CHE SENTE AMORE PER L’UMANITÀ”.
Sin dall’inizio del decennio 1930-1940, quando in Francia i letterati e i filosofi delle nuove generazioni cominciarono a infervorarsi per la dialettica hegeliana e per la teoria marxista della lotta di classe, la famosa coppia «signore e servo» della Fenomenologia dello spirito si è impressa nella coscienza della generazione nata intorno al 1900, che si può dire senz’altro che oggi ha preso il posto che nel secolo XIX era riservata alla figura di Prometeo; è diventata la pura e semplice immagine dell’uomo [...] Caratteristiche dominanti del nuovo simbolo sono la pluralizzazione e l’antagonismo: ossia il fatto che «l’uomo» è personificato ora da una coppia umana, che il singolo (il quale, selfmade man metafisico, aveva combattuto prometeicamente contro gli dei) è sostituito ora da uomini, precisamente da uomini che si contendono reciprocamente il dominio. [...]. Eppure la commedia di Beckett si differenzia in un punto da quasi tutti quesi documenti nichilistici in cui il presente trova la sua espressione letteraria: nel tono. [...]. Non a caso nessun’altra figura del nostro secolo ha suscitato tanta gratitudine quanto la desolata figura dello Chaplin dei primi film. Sembra che la farsa sia diventata il rifugio dell’amore per il prossimo: la complicità degli sconsolati sia diventata l’ultimo conforto. E se ciò che spunta dal terreno sconsolatamente arido dell’assurdità: il mero tono umano, è un minuscolo conforto; e se il conforto non sa perché conforta e quale Godot promette come conforto - esso dimostra tuttavia che IL CALORE È PIÙ IMPORTANTE DEL SIGNIFICATO; E CHE NON È AL METAFISICO CHE SPETTA L’ULTIMA PAROLA, MA SOLTANTO A COLUI CHE SENTE AMORE PER L’UMANITÀ”.
- P. S. - RICORDANDO OTTO RANK, UNA "NOTA" DI GÜNTHER ANDERS SUL "TRAUMA DELLA NASCITA" DI "PROMETEO": "Dal punto di vista filosofico non si apprezzerà mai abbastanza la scoperta del «trauma della nascita» compiuta da Freud: Che cosa potrebbe toccare di più radicale alla vita, che l’essere strappata dal «fondamento»? Per quanto il linguaggio di Freud sia mascherato dal vocabolario proprio delle scienze naturali dell’epoca, i sentimenti che egli ha messo in evidenza («sentimento oceanico», «impulso di morte») sono assolutamente metafisici. Altrettanto si deve dire del trauma della nascita, in cui egli indicò - mascherato quanto si voglia - lo shock della individuazione. Analogamente alla nostra domanda: «Chi si vergogna?», la domanda che dovrebbe essere posta a proposito di questo trauma sarebbe: «Chi è che subisce lo choc in questo caso?». L’individuo stesso? O non piuttosto, dato che ciò che provoca lo choc è il processo di individuazione, la vita non-ancora-individuata? Non è l’individuo soltanto l’erede di questo spavento, che trascina poi con sè tutta la vita come dolore mai superato di essere individuo? Mi sembra che questa sia stata l’opinione di Freud: Perché il suo «impulso di morte in fondo non è certo altro che la brama del’individuo di liberarsi del tormento di essere individuo" (Cfr. Gunther Anders, "L’uomo è antiquato", cap. "Della vergogna prometeica", nota 32).
#Metaphysics #Anthropology #Theology #Cosmology #Koyaanisqatsi #Ubuntu #Earthrise
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "GUNTHER ANDERS E LA SCENA ATTUALE": IL "NATUM ESSE", LA "VERGOGNA PROMETEICA", E "IL CONCETTO INESTIRPABILE DELLA DIGNITÀ UMANA"3 aprile 2023, di Federico La Sala
IL "NATUM ESSE", LA "VERGOGNA PROMETEICA", E "IL CONCETTO INESTIRPABILE DELLA DIGNITÀ UMANA"*:
- "L’odierno Prometeo domanda: Chi sono mai?" (Gunther Anders, 11 Marzo 1942).
I. Primo incontro con la vergogna prometeica.
L’odierno Prometeo domanda: Chi sono mai?
Comincio con alcuni appunti di diario presi in California
11 Marzo 1942
Credo di essere capitato sulle tracce di un nuovo pudendum; di un motivo di vergogna che non esisteva in passato. Lo chiamo per il momento, per mio uso, vergogna prometeica, e intendo con ciò "vergogna che si prova di fronte all’umiliante altezza di qualità degli oggetti fatti da noi stessi".
Si è aperta qui un’esposizione tecnica e insieme a T. ho preso parte a una visita guidata. T. si è comportato in modo stranissimo; tanto strano che, da ultimo, osservavo solo lui invece delle macchine esposte. Infatti, non appena uno dei complicatissimi pezzi veniva messo in azione, abbassava gli occhi e ammutoliva. Ancora più curioso il fatto che nascondeva le mani dietro la schiena, come se si vergognasse di aver portato questi suoi arnesi pesanti, goffi e antiquati, all’alto cospetto di apparecchi funzionanti con tanta precisione e raffinatezza. Ma questo "come se si vergognasse" è un’espressione troppo timorosa. Tutto l’insieme del suo comportamento non lasciava adito a dubbi. Gli oggetti di cui conosceva l’esemplarità, la superiorità, l’appartenenza ad una più elevata classe dell’essere, per lui tenevano realmente il posto che per i suoi antenati avevano avuto le autorità o le classi sociali riconosciute superiori. Doversi presentare al cospetto di quei meccanismi perfetti nella sua goffaggine di essere di carne, nella sua imprecisione di creatura, gli era realmente insopportabile; si vergognava davvero.
Se cerco di approfondire questa vergogna prometeica, trovo che il suo oggetto fondamentale, ossia la macchia fondamentale di chi si vergogna, è l’Origine. T. si vergogna di essere divenuto invece di essere stato fatto, di dovere la sua esistenza, a differenza dei prodotti perfetti e calcolati fino nell’ultimo particolare, al processo cieco e non calcolato e antiquatissimo della procreazione e della nascita. La sua onta consiste dunque nel suo natum esse, nei suoi bassi natali; che egli giudica bassi proprio perché sono natali. Ma se egli si vergogna di questa sua origine antiquata, si vergogna naturalmente anche del risultato difettoso e ineluttabile di questa origine: di se stesso. [...]" (cfr. Günther Anders, "L’uomo è antiquato" [1956], cap. "Della vergogna prometeica").
* PER NON PERDERE IL FILO DEL LAVORO DI GÜNTHER ANDERS, RICORDARE QUANTO EGLI SCRIVE NELLA DEDICA ("L’uomo è antiquato", 1956):
- "È passato esattamente mezzo secolo da quando, nel 1906, mio padre William Stern, allora di vent’anni più giovane e di intere generazioni più fiducioso di quanto non sia oggi suo figlio, pubblicò il primo volume della sua opera «Persona e cosa». Non è stato facile fargli perdere la speranza di poter riabilitare «la persona umana» combattendo una psicologia impersonalistica [...]. In memoria di lui, che ha istillato nel figlio il concetto inestirpabile della dignità umana, sono state scritte queste tristi pagine sulla devastazione dell’uomo".
Federico La Sala
- "[...] questi antagonisti si presentano loro [a Estragon e Vladimir] nella coppia Pozzo-Lucky. I tentativi di decifrare questi due personaggi, di scoprire chi siano e che cosa significhino non ha dato meno filo da torcere agli interpreti, che il problema dell’identità di Godot. Ma tutti i tentativi di decifrazione erano mal impostati, perché LA COPPIA STESSA È UNA DECIFRAZIONE. Come sarebbe a dire?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ECOLOGIA DELLA "MENTE ACCOGLIENTE" E "LlNGUAGGIO DEL #CAMBIAMENTO": COME NASCONO LE "I-DEE".1 marzo 2023, di Federico La Sala
ECOLOGIA DELLA "MENTE ACCOGLIENTE. TRACCE PER UNA #SVOLTA ANTROPOLOGICA".
Un omaggio al prof. Gianni Vattimo e un augurio di buon lavoro a Elly Schlein.
COME NASCONO I BAMBINI: "LlNGUAGGIO DEL #CAMBIAMENTO. Elementi di comunicazione terapeutica" (Paul Watzlawick): per uscire dalla storica e tragica #caverna della cosmoteandria (atea e devota), a mio parere, occorre riprendere il programma di Kant dei "sogni di un visionario spiegati con i sogni della metafisica", riaprire la questione antropologica e portare avanti le indicazioni della Scuola di Palo Alto, in particolare, di Paul Watzlawick (1977), e cominciare a pensare con le "due metà del cervello (cfr. Federico La Sala , "Alfabeta" - Rivista, 17, 1980, p.11), sia all’interno e sia all’esterno.
#Metaphysics #Anthropology #Europa2023 #Eleusis2023 #Roma2024
NOTA: L’ITALIA E IL "CORPO MISTICO" DELLA "REGINA" (DELLE PRIMARIE DEL PD, DEL PARTITO DEMOCRATICO).
Cosmoteandria e "disagio della civiltà" (S. Freud, 1929). "Cum grano salis" e. con le dovute proprorzioni, guardando allo #Stato della #Terra (con un #UNO - #ONU - che non esiste ancora), l’evento "Elly Shlein" ha rotto l’incantesimo e ha aperto la porta a un sottile e tuttavia forte vento di sollecitazione antropologica e teologico-politica a ristrutturare il campo e rimettere in sesto i cardini del #tempo (Shakespeare, "Amleto", I.5) e, a svegliarsi dal sonno dogmatico (Kant).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ESSERE, O NON ESSERE? LA DOMANDA DI AMLETO, STORIA DELLA CRITICA DELL’ARTE, E "LA MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO, A NAPOLI.26 febbraio 2023, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E RINASCIMENTO, OGGI (26 FEBBRAIO 2023):
ESSERE, O NON ESSERE? LA DOMANDA DI AMLETO E "LA LEZIONE DI "ABO" (Achille Bonito Oliva).
Una nota a margine ... *
"L’ARTE DA SOLA NON ESISTE. Senza un sistema composto da media, collezionisti, mercato, musei, pubblico, le opere in sé non avrebbero valore". Con questo titolo, di forte tonalità hegeliana e marxista, Achille Bonito Oliva, sul "Robinson" ("la Repubblica" del 18 febbraio 2023), sollecita in qualche modo lodevolmente a ripensare "tutto".
SOCIALITÀ CRITICA. A onore di Bonito Oliva, per non lasciar cadere l’ago nel pagliaio e rischiare di non ritrovarlo, tenendo presente che né la "religione" né la "filosofia", come l’arte, esiste da sola, forse, è opportuno allargare l’area della coscienza del tempo presente e riprendere a cercare di capire meglio la situazione storica attuale, a tutti i livelli.
NAPOLI E "LA MADONNA DEL PESCE" DI RAFFAELLO. Considerato che «il Pesce puzza dalla testa» (soprattutto se si continua a confondere inconsapevolmente ICTUS con IXTHUS, "I.X.TH.U.S."), a mio parere, solleciterei una urgentissima riflessione antropologica sulla millenaria e moribonda tradizione del “Pensare l’artista come un demiurgo, produttore isolato d’immagini"!
COSMOTEANDRIA. Continuare così, come precisa Achille Bonito Oliva, "vuol dire non riuscire a comprendere l’esistenza di una condizione filosofica dell’arte e dell’artista" e, al di là delle allusioni e delle illusioni dello stesso "ABO" (relative alla "teoria della catastrofe" e allo "spostamento che raccoglie l’esigenza di una struttura edipica uccidendo il padre, ovvero il movimento precedente"), vuol dire interrogarsi radicalmente sulla figura dell’artista e sull’arte stessa, in quanto "produzione linguistica, e dunque, operatività e pratica culturale", al di fuori della logica cosmoteandrica del mondo attuale, che anche il sistema dell’arte ha contribuito a costruire.
NOTA: FILOLOGIA E ITTICA. "Ichthỳs. Antico simbolo cristiano di Cristo; le lettere greche (ΙΧΘΥΣ) che compongono la parola, formano l’acrostico ᾿Ιησοὸς Χριστὸς Θεοῦ υἱὸς Σωτήρ «Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore». (Treccani).
#Earthrise #Metaphysics #Anthropology #Eleusis2023 #Roma2024
*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). ----Oggi (11 febbraio 2023), memoria di "Quella volta che Leopardi decise di arrabbiarsi ..." e di indignarsi fortissimamente a difea di Dante Alighieri.11 febbraio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIOGRAFIA. OGGI (11 FEBBRAIO 2023).
- GIACOMO LEOPARDI, DANTE, LA DONAZIONE DI COSTANTINO, E NICCOLO’ TOMMASEO.
- Una nota in memoria di Lorenzo Valla e del suo "famoso" capolavoro (("La falsa Donazione di Costantino", 1440).
EUROPA 2023. Nella ricorrenza della giornata della firma dei PATTI LATERANENSI (11 Febbraio 1929), brillante la ripresa da parte del Centro documentazione Piero Delfino Pesce di questo articolo di Luca Mazzocchetti, dedicato a "Quella volta che Leopardi decise di arrabbiarsi ..." ("Terza web", 24 Novembre 2016).
DANTE 2021 E LA "MONARCHIA" DEI "DUE SOLI". Al di là della polemica "personale" e "momentanea", nell’epigramma contro Niccolò #Tommaseo dell’agosto del 1836, ("poi però non reso pubblico" e poco conosciuto), nel richiamo al dantesco "Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre...", emerge con forza tutta la tempra eroica di Giacomo Leopardi e la sua consonanza con lo #spirito di #DanteAlighieri critico del potere temporale dei Papi e, anche e ancora, la sua #indignazione contro tutta la sudditanza della intera cultura italiana alla lettura storiografica tradizionale.
Giacomo Leopardi studioso di Dante Alighieri
Tra le pagine dello «Zibaldone» poesia filologica e fraterno incanto
di RITA ITALIANO (La Stampa, 22 Gennaio 2021)
In occasione del suo celebrato anniversario si può anche cercare e trovare Dante in uno scrigno tra i più preziosi che il pensiero umano abbia mai offerto, lo «Zibaldone» di Giacomo Leopardi. Basta scorrere le occorrenze del nome di Dante Alighieri in quelle pagine accurate ed emozionanti, per schiudere le porte di un magico regno nel quale il rigore dell’analisi critica viaggia alle altitudini del genio. La lettura data da Giacomo Leopardi si fa poesia filologica, fraterno incanto.
 Originalissimo esame che della produzione di Dante registra il carattere, lo stile, la lingua, l’interesse per la filosofia, giungendo sino a cogliere le qualità peculiari de «La Divina Commedia». Scegliendo di soffermarsi attento soprattutto sulla rivoluzione linguistica che in questa è evidente. E illustrando le motivazioni che animarono il suo autore: «ebbe intenzione scrivendo, di applicar la lingua italiana alla letteratura. Il che si fa manifesto sì dal poema sacro, ch’egli considerava, non come trastullo, ma come impresa di gran momento».
Originalissimo esame che della produzione di Dante registra il carattere, lo stile, la lingua, l’interesse per la filosofia, giungendo sino a cogliere le qualità peculiari de «La Divina Commedia». Scegliendo di soffermarsi attento soprattutto sulla rivoluzione linguistica che in questa è evidente. E illustrando le motivazioni che animarono il suo autore: «ebbe intenzione scrivendo, di applicar la lingua italiana alla letteratura. Il che si fa manifesto sì dal poema sacro, ch’egli considerava, non come trastullo, ma come impresa di gran momento».
 Da tale svolta si avvia la possibilità di definire Dante «quasi il primo scrittore italiano». È infatti proprio il modo del tutto nuovo che egli ha dato al suo operare che ha avuto per conseguenza non dappoco d’essere «propriamente, com’è stato sempre considerato, e per intenzione e per effetto, il fondatore della lingua italiana». Inoltre, la disamina di Leopardi giudica che nel lavoro di Dante anche lo stile sia assai meritevole di ammirazione. A questo nodo dedica uno spazio di rilievo.
Da tale svolta si avvia la possibilità di definire Dante «quasi il primo scrittore italiano». È infatti proprio il modo del tutto nuovo che egli ha dato al suo operare che ha avuto per conseguenza non dappoco d’essere «propriamente, com’è stato sempre considerato, e per intenzione e per effetto, il fondatore della lingua italiana». Inoltre, la disamina di Leopardi giudica che nel lavoro di Dante anche lo stile sia assai meritevole di ammirazione. A questo nodo dedica uno spazio di rilievo.
 Con righe illuminanti. Si chiede: «Perché lo stile di Dante è il più forte che mai si possa concepire, e per questa parte il più bello e dilettevole possibile?» La risposta spiega con semplicità: «perché ogni parola presso lui è un’immagine». A Ovidio «bisogna una pagina per farci veder quello che Dante ci fa vedere in una terzina». E se «Ovidio descrive» e «Virgilio dipinge», è solo Dante che «non solo dipinge da maestro in due colpi, e vi fa una figura con un tratto di pennello; non solo dipinge senza descrivere [...] ma intaglia e scolpisce dinanzi agli occhi del lettore le proprie idee, concetti, immagini, sentimenti».
Con righe illuminanti. Si chiede: «Perché lo stile di Dante è il più forte che mai si possa concepire, e per questa parte il più bello e dilettevole possibile?» La risposta spiega con semplicità: «perché ogni parola presso lui è un’immagine». A Ovidio «bisogna una pagina per farci veder quello che Dante ci fa vedere in una terzina». E se «Ovidio descrive» e «Virgilio dipinge», è solo Dante che «non solo dipinge da maestro in due colpi, e vi fa una figura con un tratto di pennello; non solo dipinge senza descrivere [...] ma intaglia e scolpisce dinanzi agli occhi del lettore le proprie idee, concetti, immagini, sentimenti».Leopardi si sente forse prossimo a Dante Alighieri, ch’era autore e uomo dal temperamento «grave, passionato, ordinariamente (ai nostri tempi) malinconico, profondo nel sentimento e nelle passioni, e tutto proprio a soffrir grandemente della vita». Una sensibilità difficile e rara, in grado di infondere lo spirito della Storia nel mistero della dottrina. Infatti «il suo poema non è epico, ed è misto di narrativo e di dottrinale, morale». È sapere che diventa sapienza.
 Leopardi annota: «Omero e Dante per l’età loro seppero moltissime cose, e più di quelle che sappiano la massima parte degli uomini colti d’oggidì». Ma non basta. È chiaro che per la propria espressione poetica, tessuta alle vette più alte dell’arte compositiva, occorrevano a Dante, combinate e inestricabili, la rivoluzione dello stile e quella della lingua. Di quest’ultima Leopardi attesta l’enorme valore. Perché «Dante fra gli altri antichi aveva introdotto subito nel quasi creare la nostra lingua, la facoltà, il coraggio, ed anche l’ardire de’ composti» e aveva fatto «espressa professione di non voler restringere la lingua a veruna o città o provincia d’Italia, e per lingua cortigiana l’Alighieri, dichiarandosi di adottarla, intese una lingua altrettanto varia, quante erano le corti e le repubbliche e governi d’Italia in que’ tempi». La scrittura di Dante è ricca, screziata. La conoscenza che Leopardi ne ha, gli consente di parlarne senza esitazioni. «Dante è pieno di barbarismi, cioè di maniere e voci tolte non solo dal latino, ma dall’altre lingue o dialetti ch’avevano una tal qual dimestichezza o commercio colla nostra nazione».
Leopardi annota: «Omero e Dante per l’età loro seppero moltissime cose, e più di quelle che sappiano la massima parte degli uomini colti d’oggidì». Ma non basta. È chiaro che per la propria espressione poetica, tessuta alle vette più alte dell’arte compositiva, occorrevano a Dante, combinate e inestricabili, la rivoluzione dello stile e quella della lingua. Di quest’ultima Leopardi attesta l’enorme valore. Perché «Dante fra gli altri antichi aveva introdotto subito nel quasi creare la nostra lingua, la facoltà, il coraggio, ed anche l’ardire de’ composti» e aveva fatto «espressa professione di non voler restringere la lingua a veruna o città o provincia d’Italia, e per lingua cortigiana l’Alighieri, dichiarandosi di adottarla, intese una lingua altrettanto varia, quante erano le corti e le repubbliche e governi d’Italia in que’ tempi». La scrittura di Dante è ricca, screziata. La conoscenza che Leopardi ne ha, gli consente di parlarne senza esitazioni. «Dante è pieno di barbarismi, cioè di maniere e voci tolte non solo dal latino, ma dall’altre lingue o dialetti ch’avevano una tal qual dimestichezza o commercio colla nostra nazione».Leopardi spazia e approfondisce. Riconosce a Dante meriti che vivono nella letteratura e ne superano i confini, entrando nella Storia. Ricorda «quanto debbano a Dante, non pur la lingua italiana, come si suol predicare, ma la nazione istessa, e l’Europa tutta e lo spirito umano». Da qui l’attribuzione che a Dante spetta del serto d’alloro di un vero primato: «ardì concepire e scrisse un’opera classica e di letteratura in lingua volgare e moderna». Impresa temeraria e suprema che eleva «una lingua moderna al grado di lingua illustre» a dispetto dell’opinione corrente che sino a quel momento aveva ritenuto la lingua latina «unica capace di tal grado».
 Leopardi indaga la natura della «Commedia», vera pietra miliare della letteratura, e afferma che «non fu solo poetica, ma come i poemi d’Omero, abbracciò espressamente tutto il sapere di quella età, in teologia, filosofia, politica, storia, mitologia ecc». Classica da subito e per sempre: «non rispetto solamente a quel tempo, ma a tutti i tempi, e tra le primarie; né solo rispetto all’Italia ma a tutte le nazioni e letterature». Il passo di Dante in questo senso è stato dunque quello di un pioniere. La sua è stata la marcia risoluta di un apripista. In sostanza, «Dante diede l’esempio, aprì e spianò la strada, mostrò lo scopo, fece coraggio e col suo ardire e colla sua riuscita agl’italiani: l’Italia alle altre nazioni. Questo è incontrastabile».
Leopardi indaga la natura della «Commedia», vera pietra miliare della letteratura, e afferma che «non fu solo poetica, ma come i poemi d’Omero, abbracciò espressamente tutto il sapere di quella età, in teologia, filosofia, politica, storia, mitologia ecc». Classica da subito e per sempre: «non rispetto solamente a quel tempo, ma a tutti i tempi, e tra le primarie; né solo rispetto all’Italia ma a tutte le nazioni e letterature». Il passo di Dante in questo senso è stato dunque quello di un pioniere. La sua è stata la marcia risoluta di un apripista. In sostanza, «Dante diede l’esempio, aprì e spianò la strada, mostrò lo scopo, fece coraggio e col suo ardire e colla sua riuscita agl’italiani: l’Italia alle altre nazioni. Questo è incontrastabile».
 Nel prosieguo, lo studio condotto da Leopardi giunge a rimarcare quanta applicazione e quanta ponderazione stessero dietro al rivolgimento dantesco, «né il fatto di Dante fu casuale e non derivato da ragione e riflessione, e profonda riflessione. Egli volle espressamente sostituire una lingua moderna illustre alla lingua latina». Sentiva che i tempi erano ormai maturi, e che anzi esigevano la radicalità di un cambiamento di questa portata. Perciò «volle espressamente bandita la lingua latina dall’uso de’ letterati, de’ dotti, de’ legislatori, notari, ecc., come non più convenevole ai tempi». Un atto di grande perspicacia e ponderazione dal quale venne lo splendido frutto che nelle sue terzine custodisce, tra l’altro, la prova d’eccellenza della risolutezza encomiabile con la quale il poeta Dante Alighieri derivò i propri principi di stile «da proposito e istituto, e mirò ad uno scopo; e il proposito, l’istituto e lo scopo» furono quelli di un «acutissimo, profondissimo e sapientissimo filosofo».
Nel prosieguo, lo studio condotto da Leopardi giunge a rimarcare quanta applicazione e quanta ponderazione stessero dietro al rivolgimento dantesco, «né il fatto di Dante fu casuale e non derivato da ragione e riflessione, e profonda riflessione. Egli volle espressamente sostituire una lingua moderna illustre alla lingua latina». Sentiva che i tempi erano ormai maturi, e che anzi esigevano la radicalità di un cambiamento di questa portata. Perciò «volle espressamente bandita la lingua latina dall’uso de’ letterati, de’ dotti, de’ legislatori, notari, ecc., come non più convenevole ai tempi». Un atto di grande perspicacia e ponderazione dal quale venne lo splendido frutto che nelle sue terzine custodisce, tra l’altro, la prova d’eccellenza della risolutezza encomiabile con la quale il poeta Dante Alighieri derivò i propri principi di stile «da proposito e istituto, e mirò ad uno scopo; e il proposito, l’istituto e lo scopo» furono quelli di un «acutissimo, profondissimo e sapientissimo filosofo». -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- LE PORTE DELLA PERCEZIONE E L’ABBAGLIO NARCISISTICO DEL MACROANTROPO.29 gennaio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA, ARCHEOLOGIA FILOSOFICA, E COSMOLOGIA: IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS (NON UN LOGO).
Una breve nota su un labirintico abbaglio, in cui si vive da millenni:
- "[...] Se si pulissero le porte della percezione, ogni cosa apparirebbe all’uomo come essa è veramente, infinita. Poichè l’uomo s’è da stesso rinchiuso, fino a non vedere più le cose che attraverso alle strette fenditure della sua caverna" (William Blake, "Il matrimonio del cielo e dell’inferno")
ANTROPOLOGIA O ANDROLOGIA?! Alla fine, pur pulendo "le porte della percezione", l’uomo (l’essere umano - maschio, lat. "vir") non vedrebbe altro e ancora che "il mondo come volontà e rappresentazione" di sé stesso: la visione dell’androcentrico vitruviano macroantropo della tradizione platonico-paolina e schopenhaueriana.
"CHI" ("X") SIAMO NOI, IN REALTÀ: DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVO PRINCIPIO DI CARITÀ.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ARISTOFANE E LA FILOSOFIA: QUANTE "NUVOLE" NEL CIELO DELLA "REPUBBLICA"!27 gennaio 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA FILOSOFIA STORIA E DIVINA COMMEDIA (DANTE 2021):
QUANTE "NUVOLE" NEL CIELO DELLA "REPUBBLICA"!
UN LETARGO TEOLOGICO-POLITICO ANTROPOLOGICO E COSTITUZIONALE PROFONDO ha mandato in collasso tutte le istituzioni culturali e politiche di tutte le #Città.
Nelle #Università e nelle #Accademie laiche e devote si insegna ancora a credere che #Aristofane scherzasse su #Socrate! #Nietzsche ("#Crepuscolo degli #idoli") aveva ragione: la #filosofia del suo allievo #Platone contiene il segreto sul come rendere forte il discorso debole e debole il discorso forte, e sul come realizzare il #sogno del #sofista #re: egli ha truccato le "regole del gioco" dell’#Occidente e ha insegnato a una "parte" della intera umanità a come mettersi al di sopra di tutte le "parti", a un "partito" come mettersi al di sopra di tutti i "partiti", e a come imporre le proprie "olimpiche" demiurgiche "#Leggi" su tutta la #Fattoria! Un colpodistato più che millenario - al capolinea... #Giornatadellamemoria, #27gennaio 2023.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO -- PSICOANALISI, RELIGIONE E ANTROPOLOGIA: MEMORIA DI TERESA D’AVILA (1622 -2022).26 gennaio 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ESTASI, E RINASCIMENTO, OGGI: TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA.
- Una nota a margine di un mio lavoro del 1996 e in memoria di Teresa d’Avila (1622-2022): *
CULTURA E SOCIETA’. La vita e l’opera di Teresa d’Avila è ancora una #sfida per la psicoanalisi freudiana, per la psicanalisi lacaniana, per la stessa chiesa cattolica, e per l’intera #cultura laica e devota (oggi, 2023). Nonostante le sollecitazioni generali a portarsi oltre l’orizzonte androcentrico platonico-hegeliano e, in particolare, edipico da parte di psicoanalisiti e psicoanaliste, come Elvio Fachinelli ("La mente estatica", Adelphi,1989) e Julia Kristeva ("Teresa, mon amour. Santa Teresa d’Ávila: l’estasi come un romanzo, Donzelli 2008), il problema del "roveto ardente" di Lacan, "la Cosa di Mosè", resta sempre e "encore" un enigma, quello stesso della Sfinge di Edipo: "L’esperienza mistica - scriveva Fachinelli nel 1988 - è al di là della barriera dell’incesto e in essa si manifesta un aspetto antropologico sinora rifiutato, o temuto, o assimilato tout cort all’impostazione religiosa. E così la gioia eccessiva, che è al cuore dell’esperienza estatica, viene trascurata".
Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo Buonarroti e al suo "Tondo Doni" e al suo Mosè, sollecita a riproblematizzare non solo il rapporto tra #Freud e Lacan, ma anche, e soprattutto, a portarsi oltre la logica cosmoteandrica del "superuomo" del cattolicesimo europeo-costantiniano. Se non ora, quando?!
*http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5195
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- RINASCERE. Rimeditare l’aoristica lezione di Giacomo Leopardi.17 gennaio 2023, di Federico La Sala
Filologia Antropologia, e Cosmoteandria. Dalla Luna, ammirare il sorgere della Terra... *
- Nota a margine dell’articolo di Giovanni Pizza, Una filosofia antropologica deleuziana (rec. del libro di Alberto Simonetti, "La talea della terra. Deleuze tra antropologia e nomadologia", Morlacchi Editore U.P., Perugia), Insula europea, 15 gennaio 2023).
Se ancora #oggi non è possibile nemmeno il #dialogo di sé con sé stesso, e #nessuno è capace di uscire dall’orizzonte narcisistico-tebano e comunicare abbracciando davvero l’altro, barricato com’è nella millenaria #caverna cosmoteandrica atea e devota (di costruzione platonico-hegeliana e cattolico-paolina), come è possibile entrare in #relazione con l’altro in sé e fuori di sé (es.: con "la gitana con sigaretta", non nel quadro di Edouard Manet, ma dinanzi a sé - nella realtà), se non si sa accogliere un filo del vento "che soffia dove vuole", di cui "puoi udire la #voce, ma non sai né da dove viene né dove va” (Gv. 3,8)? Non è meglio rimeditare l’aoristica lezione dell’Infinito di Giacomo Leopardi, uscire dall’#inferno terrestre (#Dante2021), e ammirare dalla #Luna il sorgere della Terra?
*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "ABBRACCIATEVI, MOLTITUDINI" (F. SCHILLER, "INNO ALLA GIOIA"): "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (S. FREUD) DEI NIPOTINI E DELLE NIPOTINE DI PLATONE.11 gennaio 2023
FILOLOGIA FILOSOFIA PSICOANALISI
"ABBRACCIATEVI, MOLTITUDINI" (F. SCHILLER, "INNO ALLA GIOIA", 1785): "INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" (S. FREUD, 1899) DEI NIPOTINI E DELLE NIPOTINE DI PLATONE...
«Che cos’è, o uomini ["anthropoi"], che volete ottenere l’uno dall’altro? [...] Forse è questo che volete: diventare la medesima cosa l’uno con l’altro, in modo che non vi dobbiate lasciare né giorno, né notte? Se è questo che desiderate, io voglio fondervi e unirvi insieme nella medesima cosa, in modo che diventiate da #due che siete #uno solo, e finché vivrete, in quanto venite ad essere in questo modo uno solo viviate insieme la vita, e quando morirete, anche laggiù nell’Ade, invece di due siate ancora uno, uniti insieme anche nella morte. Orsù vedete se è questo che volete e se vi farebbe lieti ottenerlo...» (Platone, Simposio, 192 d-e)
PLATONISMO E TECNOCRAZIA. Dopo interi millenni di letargo, non è meglio svegliarsi e capire che l’intenzione di "Platone" (e di Efesto) è pure lodevole, ma molto, molto artigianale (demiurgica), il suo amore è avido e cieco (Cupìdo) e il suo fare "di due che siete uno solo" sembra voler correggere la divisione fatta da Zeus, ma alla fine fa tutto all’incontrario e fa solo un campo di sterminio, un deserto. All’altezza del 2023, come scriveva Nietzsche, siamo ancora ignoti a noi (stessi e stesse).
MATEMATICA E ANTROPOLOGIA. Forse conviene riprendere il filo da ELEUSI (quest’anno è una delle capitali europee della cultura: Eleusis2023) e cercare di capire il segreto dei misteri eleusini, come nascono i bambini, e, finalmente, scoprire (immergendosi, battesimalmente, nel) l’acqua calda, che ognuno e ognuna è già uno, una, in due; ripartire da sé e riprendere il cammino: "Sàpere aude! (Kant, 1784 - Michel Foucault, 1984). Ricominciare a contare da due, non da uno (dei due, che fa il furbo): "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia). In principio era il Logos - non il logo di una "fattoria degli animali"!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- RIPENSANDO A CELESTINO V E A DANTE ALIGHIERI. Nota a margine dell’attuale presente storico4 gennaio 2023, di Federico La Sala
RIPENSANDO A CELESTINO V E A DANTE ALIGHIERI.
Nota a margine dell’attuale presente storico e del pontificato di papa Bendetto XVI...
A 700 anni (più 1, 701 anni) dalla morte (1321) di #DanteAlighieri, tenendo conto degli "ultimi ritocchi al #Paradiso (1319)" [M. Feo] e della consapevolezza dello stesso #Dante di essere "cive di quella Roma onde Cristo è romano" [Purg. XXXII, 102], si può pensare (come alcuni hanno proposto) che sia #Pilato (e non #CelestinoV) la persona del "gran rifiuto", e che il comportamento di Pilato in campo romano possa essere messo in corrispondenza speculare con il comportamento di #Giuda in campo ebraico.
Se questo è accettabilmente vero, e la cosa appare celestinamente convincente seguendo il percorso di Pietro da Morrone prima e dopo della sua elezione a papa, tutto il castello storiografico costruito in sette secoli crolla e apre a nuovi orizzonti e a inediti punti di vista sia sulla lettura del lavoro di Dante, sia della storia della Chiesa e, al contempo, della stessa storia d’Italia.
Alla luce dello spirito di cittadinanza costituzionale di #Dante (e, su questo, ricordare l’amore del presidente della Repubblica italiana, #Carlo #Azeglio #Ciampi, per il cittadino #Dante), non è possibile non pensare immediatamente al #doppio #tradimento, quello della #monarchia del #Regno d’Italia (#Pilato) e della Chiesa Cattolico-costantiniana (#Giuda), nei confronti della intera popolazione italiana di religione ebraica ("Leggi per la difesa della razza", 1938), e, ancora e subito, riesaminare e rilanciare il programma dei #dueSoli in #terra e dell’unico Sole in #cielo (Giordano Bruno, "Lo spaccio della bestia trionfante") e tentare di portarsi "Fuori dall’Occidente" (Asor Rosa, 1992) e aprire gli occhi (#Freud) su tutta la Terra?
Oggi, nel 2023 (appena iniziato) #Eleusi è una delle capitali europee della #cultura, forse, può essere una buona occasione per riattivare la #memoria della Terra-Madre (#Demetra), riabbracciare la "antica madre" (#Virgilio) e, con #Astrea, ripensare il problema antropologicamente, in spirito di #Giustizia.
- P. S.. - Il tema su cui si propone la riflessione e la discussione è relativo alla #Costituzione, vale a dire intorno al tema antropologico e filosofico del "chi siamo noi in realtà", intorno al tema dell’ "#EcceHomo. Come si diviene ciò che si è" (#Nietzsche, 1888) e, al contempo, al problema del #dialogo tra #duesoli (Dante) e non #uno-solo.
- SUL TEMA, nel sito, si cfr.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- ANTROPOLOGIA E CONOSCENZA."La donna concepisce" - l’uomo non conosce: “Egli ignora la differenza che passa fra il tempo prima dell’amore e quello dopo l’amore" (Parola di una donna - cit. da Frobenius - Kerenyi)Kerényi).14 dicembre 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, CONOSCENZA, E RINASCITA (OMAGGIO AD ELEUSI, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2023).
IL FILO DI M-ARIANNA...
- MILLENNI DI LABIRINTO E TRAGEDIA: "La donna concepisce" - l’uomo non conosce nemmeno da chi e da dove proviene!
- QUI di seguito sono riprese le "parole di una nobile donna abissina, riportate dal Frobenius in uno dei suoi più bei libri, Der Kopf als Schicksal [...]" (K. Kerényi).
- KORE (Kàroly Kerényi) *
“Come un uomo potrebbe sapere che cosa sia una donna? La vita della donna è totalmente differente da quella degli uomini. Dio ha fatto così. L’uomo è sempre lo stesso sin dalla sua circoncisione fino alla sua vecchiaia. Egli è il medesimo prima del suo primo incontro con una donna e dopo. Il giorno in cui una donna conosce per la prima volta l’amore, spezza la sua vita in due. Quel giorno, essa diventa un’altra. L’uomo, dopo il suo primo amore, rimane quello che era prima. La donna, dopo il giorno del suo primo amore, è un’altra. E così rimane per tutta la vita. L’uomo passa la notte insieme con una donna e passa via. La sua vita e il suo corpo restano sempre gli stessi. La donna concepisce. Quale madre, essa è un’altra che la donna senza figli. Essa, innanzi tutto, porta per nove mesi nel proprio corpo le conseguenze di quella notte. Nella sua vita cresce qualcosa che non ne scomparirà più. Essa, infatti, è madre. Essa è e rimane madre anche se suo figlio, anche se tutti i suoi figli muoiono. Perché essa ha portato il bambino sotto il cuore. Dopo però, quando il bambino è già nato, lo porta entro il cuore. E dal cuore egli non uscirà più. Nemmeno quando sarà morto. Tutto questo l’uomo non lo conosce; egli non ne sa niente.
“Egli ignora la differenza che passa fra il tempo prima dell’amore e quello dopo l’amore, fra quello prima della maternità e quello dopo la maternità. Egli non può sapere niente. Soltanto una donna può sapere questo e parlare di questo. È perciò che noi non permettiamo nemmeno che i nostri mariti intervengano con le loro parole nelle nostre faccende. La donna può fare una sola cosa. Essa può stare attenta a sé. Essa può comportarsi decentemente. Essa deve essere sempre come è la sua natura. Essa deve sempre essere fanciulla o essere madre. Prima di ogni amore essa è fanciulla, dopo ogni amore essa è madre. Da questo puoi vedere se essa è una buona donna".
"Queste parole di una nobile donna abissina, riportate dal Frobenius in uno dei suoi più bei libri, Der Kopf als Schicksal , siano messe qui a titolo di motto, per preparare e confermare ciò che verrà esposto nello studio su Kore. Esse siano qui anche in ricordo di quel grande uomo, la cui opera di vita stimola lo studioso delle civiltà e delle mitologie a proseguirla e lo spinge a prendere posizione di fonte ad essa”.
* Cfr. CARL GUSTAV JUNG, KÁROLY KERÉNYI, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Bollati Boringhieri.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA E UNA RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA IN CORSO6 luglio 2022, di Federico La Sala
RIVOLUZIONE COPERNICANA E RIFORMA TEOLOGICO-POLITICA IN CORSO: NUOVO CIELO E NUOVA TERRA.
Una nota*
- "COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA" (PARTE IV): "[...] Detto a tre occhi - disse argutamente il vecchio papa (perché era cieco da un occhio) - nelle cose di Dio ne so più io dello stesso Zarathustra; e può ben essere così. Il mio amore ha servito a lui per tanti anni, la mia volontà ha fatto sempre quanto lui voleva. Un buon servitore sa tutto, e sa anche le cose che il suo padrone spesso nasconde a se stesso.
- Era un Dio nascosto, pieno di segreti. Per dir la verità, ad avere un figlio ci arrivò per vie traverse. Alla soglia del suo Credo ci sta un adulterio.
- Chi lo celebra come un dio d’amore non ha una grande opinione dell’amore. Non voleva forse questo dio fare anche il giudice? Ma chi ama, ama al di là del premio e della pena."(NIETZSCHE).
La grandezza di Shakespeare e l’importanza del suo "Amleto" è analoga a quella di Sofocle e del suo "Edipo Re": della loro lezione, anche dopo la sollecitazione di Freud, si stenta ancora a capire il legame tra il familismo amorale e le manipolazioni istituzionali della Legge (divina ed umana).
Con Lutero (1517), con Copernico (1543), e Giordano Bruno (Nola, 1548 - Roma, 17 febbraio1600), Shakespeare osa aprire un dibattito nel suo globo teatrale che fa tremare tutto l’ordine teologico-politico e sociale precedente e seguente: riapre il discorso sulla dottrina dei "Due corpi del Re" (Ernst H. Kantorowicz)!
La critica dell’adulterio in "Amleto", connesso (come è) all’intero ordine istituzionale e collegato fin nel cuore dello stesso messaggio biblico ed evangelico, pone all’ordine del giorno lo "spaccio della bestia trionfante" e sgombra la strada alla dea Giustizia, alla Vergine Astrea (Virgilio, Egloga IV, V. 6: "Iam redit et Virgo").
*
NOTA.
Europa 1600: RegnodiNapoli->Nola->Salerno->Eboli->Contursi Terme, Chiesa della Madonna del Carmine, 1608/1613..
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). ---"CONTRO TUTTI I MURI. LA VITA E IL PENSIERO DI FRANCA ONGARO BASAGLIA" (A. VALERIANO)..29 giugno 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E MATEMATICA. A PARTIRE DA DUE... *
- A partire dalla mente accogliente di due persone (e, in questo caso paradigmatico, anche dalla relazione della madre e del padre) ... le tracce per una svolta antropologica e un’altra "fenomenologia dello spirito": un omaggio ad Alberta Basaglia!
Festival dei Matti, Alberta Basaglia: “Non è tardi per parlare di mia madre Franca Ongaro e del suo ruolo nella rivoluzione che portò alla chiusura dei manicomi”
- La psicologa, figlia dello psichiatra Franco Basaglia, racconta nel libro "Contro tutti i muri" (Donzelli editore) il ruolo avuto dalla madre nel processo che portò alla Legge 180: "Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico. Ho il ricordo della presenza contemporanea di entrambi i miei genitori inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di cambiare il mondo"
di Emanuele Salvato *
“Fondamentale”. Con quest’aggettivo Alberta Basaglia, psicologa figlia dello psichiatra Franco Basaglia e di Franca Ongaro, definisce il ruolo avuto dalla madre nel percorso che ha generato enormi mutamenti nella psichiatria italiana culminato nella cosiddetta Legge 180 o Legge Basaglia. Una Legge che ha, di fatto, portato alla chiusura dei manicomi in Italia, luoghi in cui la malattia e i malati venivano nascosti, dimenticati e non curati. Eppure raramente il nome di Franca Ongaro è stato associato alla rivoluzione che Franco Basaglia ha prodotto nel mondo della psichiatria insieme al suo gruppo di lavoro, di cui faceva parte anche la moglie la cui figura viene messa al centro nel libro “Contro tutti i muri” (Donzelli editore) scritto da Anna Carla Valeriano, studiosa di storia della psichiatria e delle istituzioni totali, che verrà presentato sabato 25 giugno al festival dei Matti di Venezia alla presenza, oltre che dell’autrice, anche di Alberta Basaglia, Maria Teresa Sega, presidente dell’associazione rEsistenze-memoria e storia delle donne in Veneto e Federica Esposito, psicologa e psicoterapeuta dell’Associazione Festival dei Matti.
“Non è mai troppo tardi - spiega al fattoquotidiano.it la figlia di Franco Basaglia e Franca Ongaro attualmente vicepresidente della Fondazione Franco e Franca Basaglia - per far emergere la figura di mia madre che con il suo lavoro vicino a mio padre è stata determinante per arrivare a generare quella rivoluzione nel mondo della psichiatria iniziata da Gorizia (città in cui Franco Basaglia diresse l’ospedale psichiatrico nel 1958 e dove iniziò a mettere in pratica le sue idee rivoluzionarie in termini di cura, ndr) in poi. E tutti i libri e gli studi usciti in quegli anni sono stati il frutto della collaborazione fra mia madre e mio padre. Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico”. Aggiunge Alberta Basaglia: “Il fatto che sia sempre passata come ‘la moglie di’ fa parte di un determinato periodo storico in cui per una donna era ancora molto complicato cercare di mettersi in evidenza ed avere la giusta considerazione in un ambito prettamente maschile”. Eppure, come spiega Anna Carla Valeriano nel libro, il suo approccio sociologico all’interno di un’istituzione totale come l’ospedale psichiatrico di Gorizia, il suo interessarsi alle storie dei pazienti è stato fondamentale per arrivare a comprendere l’origine di molti disturbi psichiatrici, spesso generati proprio dal contesto sociale.
A proposito dei lavori e degli scritti realizzati insieme al marito, vale la pena di citare “Morire di classe”, un libro fotografico del 1969, nel quale gli scatti di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin hanno rivelato all’opinione pubblica quale era la condizione dei malati nei manicomi italiani. Fotografie senza filtri, con malati legati ai letti, con gli sguardi persi nel vuoto e abbandonati a loro stessi. Un vero e proprio pugno nello stomaco che contribuì ad accendere una luce su realtà scomode e che mise in evidenza la necessità di attuare quei cambiamenti necessari e non più procrastinabili che Basaglia con la moglie e il suo gruppo di lavorò iniziò ad attuare, facendoli culminare nella realizzazione della Legge 180. Il libro uscì qualche mese dopo un altro documento molto importante e utile a mettere in evidenza quanto drammatica fosse la situazione nei manicomi italiani, il documentario di Sergio Zavoli “I giardini di Abele” mandato in onda da rai Tv7 nell’autunno del 1968 e girato proprio nell’ospedale psichiatrico di Gorizia diretto da Franco Basaglia che aveva iniziato a trasformare l’ospedale facendolo diventare una comunità terapeutica. “Sono cresciuta in un clima - racconta Alberta Basaglia, che quegli anni, seppur piccola li ha vissuti e se li ricorda - in cui vedevo persone intorno a me lavorare per qualcosa in cui credevano e, visti i nostri tempi attuali, non è facile immaginare tutto questo. Ho il ricordo della presenza contemporanea di mia madre e mio padre inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di cambiare il mondo. La rivoluzione di Basaglia nel mondo psichiatrico italiano è stata pensata e realizzata con un gruppo di persone che hanno lavorato senza sosta affinché questa rivoluzione cambiasse davvero qualcosa”. Dopo la morte di Franco Basaglia, l’impegno di Franca Ongaro per attuare concretamente i cambiamenti previsti dalla Legge 180 è proseguito anche in Parlamento dove venne eletta per due legislature, dal 1983 al 1992, nelle fila del gruppo parlamentare di Sinistra Indipendente. Fra le sue principali battaglie si ricorda quella di fare in modo che la Legge 180, promulgata nel 1978, venisse messa in pratica nei territori. In tal senso ha elaborato due disegni di legge rivelatisi poi fondamentali per creare di Dipartimenti di salute mentale.
*Fonte: Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2022 (ripresa parziale - senza allegati e note).
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89)..
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- ANTROPOLOGIA E "DIVINA COMMEDIA": LA FEDE DI DANTE, E DI SAN PIETRO, E LA FEDE DI SAN PAOLO.29 maggio 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E
AMORE ("CHARITAS"):
LA FEDE DI DANTE, E DI SAN PIETRO,
E
LA FEDE DI SAN PAOLO.
Beatrice (Pd. XXIV, 34) chiede al "gran viro"(San Pietro) di verificare se Dante ha capito
la differenza tra la fede
in "Nostro Segnor" Gesù
(Ponzio Pilato: Ecce Homo, gr. «idou ho anthropos»)
oppure
nel "Nostro Signore" di San Paolo, l’Uomo (Vir):
"sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo,
e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»],
e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- "HANG UP PHILOSOPHY!". IL SOGNO DI SHAKESPEARE E IL PROGRAMMA DI FRANCESCO BACONE (di Federico La Sala)..16 maggio 2022, di Federico La Sala
IL SOGNO DI SHAKESPEARE E IL PROGRAMMA DI FRANCESCO BACONE.
"HANG UP PHILOSOPHY!". Something is rotten in the state of Denmark...
RIVOLUZIONE COPERNICANA. "Hang up philosophy!" e disagio della civiltà: "Romeo. Ancora esiliato? - All forca la filosofia! Se non può farmi una Giulietta, se non può cambiare di posto una città, annullare la sentenza di un principe, la filosofia non giova a nulla, non può nulla; non me ne parlare" (Shakespeare, Tutte le opere, a c.di Mario Praz, Sansoni, Firenze, p.313).
SORGERE DELLA TERRA (EARTHRISE). Probabilmente Shakespeare, ancor prima della realizzazione della Bibbia di Re Giacomo, ha già avviato un programma di rilettura e reinterpretazione antropologico-politico dell’immaginario della teologia e filosofia tradizionale... Ricordare il Sonetto 116.
NUOVO CIELO E NUOVA TERRA. Considerato il legame profondo con la cultura italiana (Giordano Bruno, ecc.), non è da escludere la ripresa in grande stile dell’idea già ’lanciata’ da Dante Alighieri di ripensare a trovare la strada per tornare nell’Eden, nel Paradiso Terrestre: da tener presente che la parola d’ordine del programma di Francesco Bacone è già e sarà proprio quella di lavorare al Grande Restaurazione (alla Instauratio Magna).
DANTE 2021: RISORGERE - RINASCERE. Al di là della vecchia filosofia ("Hang up philosophy!"): Shakespeare è sulla strada di Dante Alighieri e Giordano Bruno, e non della andrologia iper-platonica e dello "spirito di carità" paolino ("Il parto maschio del tempo" - "Temporis Partus Masculus", 1602) del teorico della Nuova Atlantide...
Nota: Sul tema, cfr. la preghiera che è inserita nella prefazione della Instauratio magna (1620).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). ---- LE "CARTE D’AMORE" E "LA TESSITURA NASCOSTA". Dialogo sull’amore con Antonio Prete (di Anna Stefi - Doppiozero").3 maggio 2022, di Federico La Sala
CARTE D’AMORE /
Dialogo sull’amore con Antonio Prete
di Anna Stefi (Doppiozero, 02 maggio 2022)
“Tutti li miei penser” - scrive Dante Alighieri nella Vita Nuova - “parlan d’Amore”.
 Ma come si scrive di amore? Non c’è forse un certo pudore nell’avvicinarsi a questo “paese che non ha confini”, nel cercare di circoscriverlo, raccontarlo al di là di nomi, corpi, ricordi, al di là del “tu” cui ogni amore si rivolge? E ancora: che cosa è questo “tu”? Già Fedro nel Simposio ricordava quanto nessun uomo avesse mai osato celebrare degnamente Eros. Eppure l’amore è esperienza comune.
Ma come si scrive di amore? Non c’è forse un certo pudore nell’avvicinarsi a questo “paese che non ha confini”, nel cercare di circoscriverlo, raccontarlo al di là di nomi, corpi, ricordi, al di là del “tu” cui ogni amore si rivolge? E ancora: che cosa è questo “tu”? Già Fedro nel Simposio ricordava quanto nessun uomo avesse mai osato celebrare degnamente Eros. Eppure l’amore è esperienza comune.Carte d’Amore prosegue il cammino di Antonio Prete attorno ai modi del sentire: nostalgia, lontananza, compassione, interiorità. Un cammino che qui si fa figure dell’amore - apparizione, seduzione, tenerezza, e ancora ombra, lettera, gelosia - e paesaggi dell’amore - giardino, mare, strada, corpo. A separare questi due momenti un intermezzo: il Simposio. Sappiamo del banchetto in onore di Eros, sappiamo di Pausania, di Aristofane, sappiamo di Agatone e di Diotima. Antonio Prete in questo nuovo libro procede per indugi e divagazioni: l’amore, sembra raccontare la forma di questo saggio che saggio non è, si può solo provare a dire, nominare qualcosa della sua lingua, affacciarsi, lasciare che “appaia”, che qualcosa si dia a vedere nel tentativo sempre fallito di un’ultima parola, di una verità. Dire dell’amore è sostare nello stesso scacco cui l’esperienza dell’amore ci consegna: una pienezza e il suo vuoto; una necessità e un impossibile; un dappertutto e un sempre altrove.
Partirei da questo ampio intermezzo che dedichi al Simposio e che separa le due sezioni da cui sono composte queste tue carte: figure e paesaggio. Partirei da qui perché l’apertura del Simposio mette in forma il problema che attraversa il tuo libro così come ogni tentativo di portare una parola sull’amore: c’è, all’inizio, il racconto di un racconto, Apollodoro racconta a Glaucone quel che Aristodemo ha riferito circa un lontano convito di Socrate con alcuni suoi amici e discepoli. Non solo: quando è il turno di Socrate, quando il filosofo deve portare la propria parola, anche lui racconta, riporta la parola di un’altra, una donna sapiente e divinatrice, Diotima.
Di fatto la domanda come dire l’amore è all’origine di questo libro. È una domanda che viene da lontano. Nel Simposio questa domanda è messa in scena, come ricordavi, in una forma particolare: racconto di un racconto. E non solo: dentro questo racconto c’è anche la posizione di Socrate, che questa volta non fa esplicitamente il maestro, non usa la maieutica per condurre i discepoli verso il riconoscimento della verità, ma semplicemente riporta sull’amore la parola di una donna. Una parola che ha a che fare con il confine del dire: Diotima è divinatrice, è sapiente, è maga, non ha un ruolo definito. La sua parola sull’amore viene dunque da un luogo autorevole ma senza autorità. Dire dell’amore è avere a che fare con l’indicibile, con il sacro, con il limite della parola stessa. Il femminile circola comunque in tutto il Simposio: è la presenza di una donna che è assente, e sulla cui parola si modula la parola di Socrate. Dire dell’amore è dire di qualcosa di cui non possiamo cogliere mai il confine, è mettere in scena il limite della parola stessa, cioè l’assenza del significato pieno e compiuto. L’amore, in effetti, è, tra i sentimenti, quello che più ha a che fare con la mancanza.
Questo tema della non autorità, del femminile, mi porta all’attraversamento che fai proprio a conclusione dell’Intermezzo dedicato al Simposio. Margine leopardiano, scrivi. Leopardi è occasione di interrogare il fantasma Amore in lotta con il fantasma Verità: Amore, scrivi, vuole affermare il diritto all’illusione e al sogno, “ma questo diritto è insediato dal mostrarsi del ‘vero’”. Se Platone, con il Simposio, ci invita ad allargare il discorso intorno ad Eros, ti chiedo se possiamo intendere questa “non autorità” come la possibilità di un dire non assertivo, un dire che ci invita a uno scarto rispetto all’autorità, alla verità, un dire che suggerisce - penso anche in rapporto al tempo storico che stiamo vivendo - una postura non autoritaria. Non il potere ma l’ospitalità, per riprendere temi a te cari.
Certo, ho messo al margine della lettura del Simposio un altro elogio di Eros, quello che è nella prima delle leopardiane Operette morali: Amore inviato tra gli uomini prima come fantasma poi come dio, con il compito di ridare agli animi che sceglie di abitare “l’infinita speranza e le belle e care immaginazioni degli anni teneri”. Contro la cruda cancellazione del sogno messa in opera dalla Verità, il dio Amore, eternamente fanciullo, richiama quell’assenza di confini, quell’oltrelimite, che era proprio della fanciullezza.
Quanto al “dire non assertivo” che richiami, certo, esso nasce dal fatto che l’amore è esperienza del “tu”, della prossimità. La parola dell’amore trova la sua autenticazione quando pronuncia il “tu”: l’amore è parola che si invera nel “tu”. Non solo il “tu” del dialogo, dell’incontro, ma il “tu” come principio stesso della condizione amorosa, principio che muove il desiderio e lo muove anche nell’assenza dell’altro. L’ospitalità è una figura precipua di questo tu che, accolto, diventa sorgente del riconoscimento di sé. “L’io è il miracolo del tu”, dice un passaggio di Jabès.
Questo “tu”, oltretutto, è figura corporea, fisica, di quell’altro che è il principio della relazione tra gli uomini. Figura, dunque, di un mondo in cui il singolare si mette in rapporto con il molteplice, e l’altro è fondamento per poter riconoscere il vivente, per riconoscersi vivente tra viventi. Il verso che chiude la Commedia, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, ci dice che l’amore non è solo principio della visibilità e presenza dell’altro ma principio che trascorre in tutto l’universo. Per questo movimento che porta l’amore oltre il recinto del soggetto ho dato rilievo nel libro anche al rapporto tra eros e agape. Sia nella linea verticale del rapporto tra l’amore e la mistica (la “noche oscura” di Giovanni della Croce) sia nella linea orizzontale della creaturalità, del rapporto con ogni vivente.
Torniamo dunque a Diotima, al suo rapporto con il sacro. Non accade mai, e per fortuna, quell’incontro di due metà che porta alla completezza, come voleva il mito raccontato da Aristofane; l’altro contiene un segreto, una distanza, anche solo per il fatto di esser sempre necessariamente e inevitabilmente altro da noi. E tuttavia mi pare che sia proprio in questo scacco l’occasione di questo “sacro”, di questo passaggio dal “tu” alla comunità dei viventi. Dunque mi domando, e ti domando, il ruolo dell’immaginazione in questo movimento.
Questa è l’esperienza della letteratura: la narrazione dell’amore, la poesia d’amore, hanno dispiegato meravigliosamente quello che dicevi: una rappresentazione in cui l’immaginazione dell’altro segue tutte le vie della presenza-assenza. Il soggetto innamorato partecipa con la sua sensibilità immaginativa costruendo dei mondi. Pensiamo alla Recherche di Proust: il rapporto di Marcel e Albertine è rapporto raccontato come reale ma al tempo stesso immaginativo, ed è quando Albertine non c’è che il sentimento dell’amore mostra la sua potenza. La letteratura rappresenta dell’amore il tempo e lo spazio in cui il soggetto fa esperienza di una vita interiore, che è tumultuosa, animatissima, interrogativa. È l’universo fantasmatico e sensitivo del desiderio, l’esperienza del suo rapporto con il vuoto, con lo scacco, con la mancanza che lo fonda e agita. La scrittura dell’amore rappresenta con situazioni e personaggi questo grande teatro. L’amore, inoltre, contiene ed evoca le figurazioni di molti altri sentimenti. Per questo è insieme la più universale e la più comune delle passioni.
Tu scrivi a un certo punto che è un rapporto con l’enigma delle cose, con l’interrogare: dialogare con il silenzio dell’altro, con la sua presenza interiore. In questo senso contiene un principio conoscitivo.
Come la propria interiorità, anche l’altro è insondabile: da qui lo stato costante di interrogazione, e dunque di conoscenza. Di una forma particolare della conoscenza, quella che conserva il senso del limite. Una conoscenza che non ha modi prestabiliti. Pensiamo al bellissimo racconto di Musil, Il compimento dell’amore. Dove proprio nell’assoluta lontananza dall’amore si dà conoscenza dell’amore. Del resto Musil in L’uomo senza qualità avrebbe poi mostrato, nella figurazione del rapporto tra fratello e sorella, tra Ulrich e Agathe, quanto insondabile e confinante con l’oltre e con un’inattingibile condizione paradisiaca possa essere la tensione amorosa.
Forse possiamo rintracciare qui la valenza politica dell’amore: quest’elemento di non compimento che è assolutamente estraneo a quello di cui facciamo esperienza, a quello cui tutto sembra invitarci.
Sì, il grande racconto d’amore mostra spesso dell’amore il suo svanire, il suo mancare all’approdo, il suo perdersi. Da Madame Bovary a Anna Karenina le creature romanzesche d’amore fanno esperienza di un vuoto che si spalanca e le consuma, e di una società, con le sue istituzioni dell’amore, che corrode e oltraggia il loro desiderio. Fino a farlo naufragare. Ma il romanzesco dà uno svolgimento drammaturgico e qualche volta tragico a quel che tuttavia è proprio dell’amore: la sua distanza da ogni forma di definizione, di compimento, di realizzazione. L’amore, come il desiderio che è la sua anima, e il suo ritmo, e la sua lingua, vive nell’al di qua del possibile, e del compiuto.
Forse è anche per questo che il solo tu che invera l’amore è il tu dell’interiorità, è l’altro del soggetto, l’altro dell’io.
Sì, in effetti, solo curando l’interiorità, lo spazio interiore, riusciamo a staccarci sia da un io affermativo, egotico, sia da un tu pensato come acquisito una volta per tutte, non più da scoprire e interrogare e conoscere. La narrazione e la poesia ci parlano di un amore che è ricerca, attesa, turbamento, raffigurazione dell’assenza, parvenza. E tutto questo sentire ha al centro il corpo, i suoi sensi.
Questa attenzione all’interiorità parla il linguaggio della tenerezza, e mi pare che la tenerezza attraversi tante di queste stanze, che la cura sia un filo che percorre queste carte. Ci sono alcune pagine in cui scrivi di una stagione della tua vita in cui si è interrogato il rapporto tra eros e philia: “dare un corpo all’amicizia: esperienza, certo, dei confini, facile a disperdersi o a ripiegare nella consuetudine delle distinzioni, che allontanano l’amicizia dall’amore. Ma anche esperienza che allude a quell’immagine utopica di una comunità d’amore in grado di liberare la dualità dell’io e del tu dalla sua separata dimora”. Queste carte mi sembrano attraversate da quello stesso tentativo della tua generazione: un desiderio di intersecare delle immagini dell’amore che si insiste a pensare separate, metterle in rapporto tra loro, farle circolare. Forse quella stagione che racconti in alcuni passaggi dice qualcosa di questo tentativo di non dividere il bene dal male, il tradimento dalla fedeltà, il due dai molti.
Sì, in questo libro, in qualche modo confluiscono due storie: da una parte, la mia personale esperienza didattica, che a più riprese, in corsi e seminari, ha indugiato sulla “lingua dell’amore”, sulle sue figure (la lectio pubblica di congedo dall’Università, e lo stesso ultimo corso, era Poesia d’amore e cosmologia); dall’altra, alcune esperienze della mia generazione, ma anche di una generazione successiva, che tra la fine degli anni Sessanta e tutti gli anni Settanta hanno tentato di smuovere i confini definiti delle istituzioni e dei rapporti tra soggetti, con una tensione certamente utopica, e con annaspamenti ed errori, ma con uno slancio che nell’agire e nel dire immaginava possibile un’altra cultura, un altro ordine di rapporti. Anche le forme di sapere, in quegli anni, interrogavano questi confini, cercavano nuovi statuti e nuovi linguaggi.
Forse è un po’ all’ombra di quel lontano cercare ed esperire che in questo libro sull’amore mi son trovato a dare rilievo sia al “dialogo” tra amicizia e amore sia a un sentire come quello della tenerezza, che è lingua mite della passione, sentimento che unisce desiderio e dolcezza, intimità e cura. E ha la sua forma visibile nella delicatezza. È vero quel che dici: la tenerezza è un po’ la tessitura nascosta di tutto il libro.
- CONTINUAZIONE E FINE NEL POST SUCCESSIVO
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). ---- LE "CARTE D’AMORE" E "LA TESSITURA NASCOSTA". Dialogo sull’amore con Antonio Prete (di Anna Stefi - Doppiozero").3 maggio 2022, di Federico La Sala
- ... fine
CARTE D’AMORE /
Dialogo sull’amore con Antonio Prete
di Anna Stefi (Doppiozero, 02 maggio 2022)
- [...]
La tenerezza, così mi sembra, è capace di muovere verso l’altro e, al tempo stesso, di custodirne la differenza.
Nella tenerezza la presenza dell’altro richiede una prossimità particolare, dolce, non appropriativa. La tenerezza è anche lentezza: la leopardiana “lenta ginestra” è anche immagine della tenerezza. “Tenero” è il ramo che si piega per dare ombra. Il piegarsi è entrare in dialogo con il vento, curvarsi alla presenza dell’altro attraverso una forma di amore che implica cura, attenzione, protezione. La tenerezza è parola opposta alla parola guerra, richiama la dolcezza. La tradizione poetica occidentale, quella che riconosciamo come la nostra tradizione poetica che muove dai provenzali e dagli stilnovisti, dà un grande rilievo a questa “dolcezza”: il Dolce Stil Novo apre la nostra poesia. La dolcezza attraversa tutta la poesia fino al leopardiano “naufragar m’è dolce”: la lingua della poesia permette di sopravvivere al naufragio del pensiero che non può dire l’infinito, è la lingua della poesia che porta la percezione di un sentire dolce.
Tenerezza e amicizia, dunque, come lingue intime dell’amore. Quanto all’amicizia, forse la sua forza è proprio nel fatto che non domanda il compimento: per questo, credo, mi piace parlare di “legami amorosi”, mi pare che sia un modo di scartare da quella spinta al compimento che l’amore tende sempre ad avere.
Sì, l’amicizia resta al di qua della domanda di istituzione, è aperta, fluida, esperienza di una fraternità prossima e visibile, figura di una, forse solo sognata, fraternità universale (Montaigne su questa amicizia come fraternità ha pagine bellissime). L’amicizia interroga l’amore, entrando nella sua lingua, animando il suo sentire. Togliendo all’amore il fantasma, appunto, del compimento, e dell’unità del due.
O forse possiamo giocare sul fatto che Carte d’amore contiene lo scarto - écart - e dunque prendere sul serio questa assonanza: la potenza dell’amore - se lo liberiamo da quella prospettiva aristofanea - è generare scarti.
Carte, scarto. Non ci avevo pensato a questa possibile rifrazione del titolo Carte d’amore. Dici: generare scarti. Certo, esperienza del resto, di quel che è sottratto alla pienezza dell’ideale d’amore, anche dell’immaginario d’amore. Scarto anche dal sapere: non c’è un sapere dell’amore, semmai, come mostrava Diotima, una sapienza dell’amore. Per questo il silenzio è la vera anima della lingua d’amore.
Non a caso il silenzio attraversa questo libro. Racconti un episodio molto bello: tu e Mario Luzi alla Galleria Borghese in silenzio davanti a Amor sacro e amor profano di Tiziano.
Visitavamo insieme, un giorno di molti anni fa, la riaperta Galleria Borghese. Con Luzi accadeva che dialogassimo per le strade di Firenze, di Pienza o di Siena, o attraversando in auto i poggi e le piane delle Crete. Quel giorno eravamo dinanzi alle meravigliose opere di Raffaello, di Caravaggio, di Bernini, di Canova... Un’occasione bellissima, per me, poter ascoltare le osservazioni di un poeta, che molto ammiravo, dinanzi alle opere d’arte. Se in ogni sosta dinanzi a un’opera c’era qualche frase, qualche breve considerazione sulla luce, sulle forme, sui particolari, dinanzi a Tiziano, all’amore rappresentato da Tiziano, sopravvenne un silenzio lungo, forte, un silenzio contemplativo. Un silenzio che mostrava la vuota ridondanza di ogni interpretazione, e del linguaggio stesso. Ogni parola sarebbe stata ordinaria, avrebbe come incrinato la bellezza misteriosa dell’opera. Solo uno sguardo silenzioso può corrispondere alla bellezza? L’amore ha a che fare con il silenzio, come con la tenerezza. Ovvero con quel che è al di qua della lingua e in certo senso oltre la lingua.
Nella seconda parte del libro dici del paesaggio d’amore: nelle tue carte i paesaggi parlano, si fanno presenza. L’amore, scrivi, convoca il visibile.
Il paesaggio non è cornice dell’amore, è parte della sua lingua, del suo accadere. Per questo la narrazione e la poesia d’amore contribuiscono a scrivere una storia per dir così intima del paesaggio. Diciamo paesaggio, usando una parola che ci viene dalla pittura del Cinquecento. Il paesaggio insieme contiene l’amore ed è intimo al suo sentire. Pensiamo, tra tanti, al paesaggio dell’amore nei versi di Baudelaire. Gli occhi sono essi stessi cieli, con lampi e tempeste e tramonti e aurore. Allo stesso tempo nella raffigurazione dell’amore si cerca un paesaggio che sia intimo all’amore stesso.
In questo senso - ancora a dire il “sacro” di cui prima parlavamo - il paesaggio forse diviene anche il luogo verso cui andiamo, l’orizzonte entro cui, grazie all’amore, ci proiettiamo.
C’è anche questo, nel paesaggio, la presenza di un’alterità: riconoscere il tu e insieme un’alterità che supera il tu, e cioè la Natura osservata nella sua prossimità a noi. Il visibile, il naturale, ci permette di cogliere la dimensione di alterità inscritta nell’amore stesso. Il paesaggio è poi, nella tradizione letteraria, messo in correlazione fortemente dialogica con il sentire: i sentimenti sono in sintonia con il paesaggio. Ho citato nel libro un racconto di Poe, Eleonora: tutto il sentire della coppia di giovanissimi innamorati è in rapporto profondo con il paesaggio, con il suo mostrarsi e il suo mutare, come se la percezione d’amore dovesse evocare quello che dicevi prima, la necessità di una relazione ulteriore.
Il paesaggio è - oltre il giardino, oltre la selva e la stanza - anche la strada, il treno.
Sì, pensiamo, tra tante situazioni, alla passante di Baudelaire: la strada “assourdissante” è l’avvio ma è anche una presenza che genera lo stacco della figura, il prender campo del suo sguardo, il lampo - l’éclair degli occhi - l’incontro che non avviene ma che è più forte di un incontro realmente accaduto.
Tornerei a dove siamo partiti: il Simposio è anche l’irrompere di Alcibiade sulla scena. Alcibiade che rompe le regole: eccesso, gelosia, corpo, comportamento sconveniente. L’amore è anche un al di là della parola e vorrei che dicessi qualcosa di questo a partire da quel corpo tutto particolare che sono le lacrime.
L’amore nell’immaginario - più che nell’immaginazione - è legato a serenità, gioia, ha a che fare con il piacere. Il racconto d’amore dà invece moltissimo spazio al pianto. Il pianto è la lingua che non può essere più parola o non è ancora parola. Il pianto è un modo corporeo dell’indicibile. C’è un pianto d’amore che è gioia d’amore, riconoscimento, scoperta: è il pianto che descrive Goethe nel Werther, l’abbraccio tra Werther e Carlotta dopo la lettura di Ossian. C’è poi il pianto come mancanza, come attesa. Tutti i sentimenti possono essere detti nel pianto, il pianto raccoglie il sentire in una lingua corporea. Il pianto è anche esperienza dell’impossibilità dell’amore. E c’è anche una strategia del pianto che appartiene alle tecniche della seduzione: non mancano esempi nei Trattati d’amore del Cinquecento, nella tradizione romanzesca libertina.
Quanto a quel che dici su Alcibiade, certo, l’amore si mostra come desiderio che dà al corpo, ai sensi, una forte centralità, ma il discorso socratico sull’amore indica come tutto questo è privo di bellezza e verità se non si misura con quel che è oltre il corpo.
C’è un pudore, una sorta di vergogna, nel dire dell’amore: è solo timore del patetico, di sconfinare nel campo del “banale”? Mi domando quanto questo abbia a che fare con la natura dell’oggetto e quanto invece con quel che dell’amore ne è stato fatto.
Sì, è vero, da una parte è la natura stessa dell’amore, la sua assenza di confini, la sua indicibilità, il suo stesso non sapere, a motivare questo pudore, dall’altra è il timore di implicare la parte più profonda e ignota di sé - “mon coeur mis à nu”, di Poe e Baudelaire! - a trattenere sulla soglia. Ma anche, come dici, quel che dell’amore è pronunciato e vulgato e anche perpetrato: il malinteso, e l’oltraggiato, e l’offeso dell’amore. Siamo ancora nella domanda da cui è nato il libro: Come dire l’amore?
- ... fine
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA CHIAVE DI VOLTA A COLMARE LA BRECCIA FRA GIASONE E MEDEA". Un ’ricorso’ di Dora Russell (di Francesca Magni).28 aprile 2022, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E AMORECONOSCITIVO: GIASONE, MEDEA, "L’OMBRA D’ARGO" (DanteAlighieri, Par. XXXIII, 96), E UNA VIA D’USCITA DALLA TRAGEDIA... *
Una straordinaria donna moderna
(Dora Russel Ipazia e la guerra tra i sessi)
di Francesca Magni ("Letto fra noi", 29 gennaio 2013)
- Foto/Copertina del libro: Dora Russel (Mrs Bertrand Russell), Ipazia e la guerra tra i sessi (La Tartaruga, 2012, traduzione di Simone Lenzi € 12,00, pp. 100).
«Se volessimo aggiungere qualcosa alle conquiste di coloro che vennero prima di noi, dovremmo dire che per noi adesso il corpo non è più un semplice contenitore per la mente, ma quel tempio di gioia e di estasi che, se lo vorremo, già racchiude il nostro futuro.
Il compito fondamentale per il femminismo moderno, per me, è dunque quello di accettare e proclamare il sesso. Di seppellire per sempre la menzogna che per troppo tempo ha corrotto la nostra società, quella secondo la quale il corpo non è che un impaccio per la mente e che il sesso è solo un male necessario alla sopravvivenza della specie.
Comprenderlo, donargli dignità e bellezza, conoscerlo anche su base scientifica, in luogo dell’istinto brutale e dello squallore, credo sarà la chiave di volta a colmare la breccia fra Giasone e Medea» (pag, 38).
Rompo il lungo silenzio su questo blog - e mi scuso di questo silenzio, e vi ringraizio per non esservene andati - con una citazione. Vi invito a rileggere con una domanda: quando è stata scritta?
Difficile indovinare che parole così moderne siano uscite dalla penna di una donna nel 1925. Dora Russell, seconda moglie del filosofo Bertrand Russell, ci regala cento pagine colme di saggezza senza tempo, di impegno politico e civile, di riflessioni mai abbastanza assimilate su una parità fra i sessi che nasca dal riconoscere una verità: siamo, uomini e donne, uguali a cominciare dal bisogno naturale di una vita sessuale che non reprima gli istinti ma sappia guidarli con educazione e intelligenza. «Gli amanti sanno che attraverso l’intesa sessuale ciascuno comprende meglio le qualità della mente dell’altro» dice, ed è una consapevolezza che non a tutti è dato raggiungere.
È un testo imprescindibile che mette una parola di verità su tutte le ciance da guerra dei sessi. Un libro da regalare a tutti, uomini e donne, a chi ha vissuto gli anni del femminismo e a chi viene dall’onda di ritorno della generazione successiva. A questa, alla quale appartengo, dedico un brano su cui non si è ancora riflettuto abbastanza.
«C’è dunque qualcosa di sbagliato nell’educazione delle donne, e nel caso che cosa?
Penso proprio che dobbiamo rispondere affermativamente. E la ragione sta nel senso di inferiorità inculcato nelle donne da tanta oppressione, e il risultato inevitabile fu che il loro primo obiettivo, mentre combattevano dal basso, fosse quello di provare che valevano tanto quanto gli uomini.
Il secondo fu invece di dimostrare che potevano spassarsela tranquillamente anche senza gli uomini. Esattamente come il lavoratore, avanzando nella scala sociale, cerca di provare a se stesso di essere un borghese.
Entrambi gli sforzi sono sbagliati. Ciascuna classe ed entrambi i sessi hanno qualcosa di unico da dare al progresso, alla conoscenza, al pensiero di cui la comunità viene privata con questo scimmiottamento».
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica -
 L’EUROPA IN CAMMINO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...
L’EUROPA IN CAMMINO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO...FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- FIORNATA DELLA TERRA: USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA CADUTA E DELLA CAVERNA E AMMIRARE IL "SORGERE DELLA TERRA".22 aprile 2022, di Federico La Sala
GIORNATA DELLA TERRA (22 aprile 2022): SORGERE DELLA TERRA, ANTROPOLOGIA ("ECCE HOMO"), E CONCORDIA.
In memoria del "discorso sulla dignità dell’uomo" (1486) di Giovanni Pico della Mirandola...
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGIA. "Tutti dobbiamo contribuire a fermare la distruzione della nostra casa comune e ripristinare gli spazi naturali: governi, aziende e cittadini dobbiamo agire come fratelli e sorelle che condividono la Terra, la casa comune che Dio ci ha affidato" (Papa Francesco).
IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS. Memoria di Anselmo d’Aosta (21 aprile): riprendere il lavoro sul "Cur Deus Homo" e portarlo oltre l’orizzonte della Dotta Ignoranza (1440) e della Scuola di Atene: meglio seguire l’indicazione di Michelangelo già presente nel Tondo Doni e ripensare il cammino delle Sibille e dei Profeti.
USCIRE DALLA TERRA (CAVERNA)... E, FINALMENTE, VEDERE DALLO SPAZIO, DALLA LUNA, IL SORGERE DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE DELLA CASA COMUNE DELL’INTERO GENERE UMANO: L’ALBA DELLA MERAVIGLIA.... E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- Forse la chimera, e quindi la storia, è questa. Dialoghi con la Chimera /1: Maria Teresa Carbone: Madre/Figlio (a c. di Laura Pugno).12 aprile 2022, di Federico La Sala
Dialoghi con la Chimera /1:
MARIA TERESA CARBONE, MADRE/FIGLIO.
A cura di Laura Pugno (Le parole e le cose, 1 Marzo 2022)
- Nel 2022 si compiono 15 anni dall’inizio della mia personale avventura con l’ibrido, la pubblicazione del mio primo romanzo, Sirene, nel 2007. Da allora, le figure più che umane, oltreumane, si sono moltiplicate, in letteratura e nell’immaginario, intorno a noi, fino a essere in un certo senso ovunque, o forse solo nell’occhio di chi guarda. La parola Chimera, oltre i Canti Orfici e i Dialoghi con Leucò, riecheggia oggi gli ibridi interspecie della scienza contemporanea insieme alla mitologia greca, etrusca ed egizia, e per questo ce ne serviamo qui: il campo delle ibridazioni, come si vedrà, è molto ampio (lp).
L’idea di questa serie di conversazioni mi è venuta a seguito di un nostro dialogo sulle chimere, naturali o artificiali, e in particolare quella particolarissima Chimera che è la combinazione madre-figlio. Quindi questo è il tuo ibrido, in questa intervista. Qual è qui la storia fa raccontare?
Per la verità non so se c’è una storia da raccontare. O forse ce ne sono così tante che non riesco a vederle, smarrita come sono in una foresta di possibilità, anzi in un territorio selvaggio, per citare il titolo del tuo libro sulla poesia come “terzo paesaggio”. Non meno selvaggio, questo territorio - anzi di più - perché è il mio. E allora forse posso cominciare a risponderti con una poesia che ho scritto qualche mese fa:
Che mentre penso
alle persiane rotte e a te che parti
e che penso che sono
me fino in fondo
un’altra me a me inattingibile
mi spinge verso il bagno
che è questa me che regna
sui miei bisogni
sulla vita nuda
che la me a me nota
riveste di pensieri e di intenzioni
Come vedi, qui non c’è la maternità, ma lo spaesamento di fronte a quanto di noi non conosciamo. In fondo, a dispetto delle nostre convinzioni, sappiamo pochissimo di quello che siamo, microscopici puntolini in un universo sconfinato.
E allora, non parto da me, ma dalla parola chimera che deriva dal greco (χίμαιρα) dove inizialmente significava “capra”, anche se molto presto la gentile capretta delle fiabe si è mutata in mostro, testa di leone e coda di drago, “sbuffante terribile fuoco ardente”, come dice Omero. Già in origine, un elemento familiare pronto a trasformarsi e ad atterrirci.
Ti porto due esempi molto contemporanei. Il primo l’ho trovato per caso, cercando l’etimologia del termine “chimera”: nel sito Una parola al giorno, in data 15 febbraio 2012, giusto dieci anni fa, l’anonimo redattore per definire appunto una chimera evocava “la terrifica pandemia annunciata di una qualche influenza animale con zerovirgola casi accertati” - il che, letto oggi, fa una certa impressione. Il secondo è cronaca dei nostri giorni, il recente trapianto del cuore di un maiale in un corpo umano, un intervento che ha prevedibilmente e giustamente aperto un interrogativo cui è difficile rispondere: alleveremo suini (animali cui viene riconosciuta notevole intelligenza, qualsiasi cosa si intenda per “intelligenza”) pur di garantire la sopravvivenza di esseri appartenenti alla nostra specie?
Vedi, il punto per me è che noi stessi - intendo noi umani, ma vale per gli altri animali e le piante e tutto ciò che è vivo - siamo chimere da sempre, frutti di una quantità di incroci avvenuti in ogni fase della nostra storia, ben prima che fossimo o pretendessimo di essere in grado di padroneggiare queste ibridazioni. E torno alla tua domanda, premettendo che le mie conoscenze scientifiche sono limitatissime e quando parlo della “combinazione madre figlio”, come dici tu, mi baso più su sensazioni e sentimenti che su dati certi.
 Chiarisco però che lo spunto che aveva dato origine al nostro dialogo, e quindi a questa conversazione, era un’altra scoperta relativamente recente: la presenza di dna maschile nel corpo, e specificamente nel cervello, di donne anche in età molto avanzata che avevano avuto figli maschi - questo è appunto il microchimerismo, e aggiungo per completezza che se ne sono registrati esempi anche in donne che non hanno partorito e che hanno probabilmente acquisito queste cellule allo stato fetale, da gemelli poi riassorbiti dentro di loro. (Spero, se ci saranno studiosi di queste materie fra i lettori di quanto scrivo, che perdoneranno il mio pressapochismo).
Chiarisco però che lo spunto che aveva dato origine al nostro dialogo, e quindi a questa conversazione, era un’altra scoperta relativamente recente: la presenza di dna maschile nel corpo, e specificamente nel cervello, di donne anche in età molto avanzata che avevano avuto figli maschi - questo è appunto il microchimerismo, e aggiungo per completezza che se ne sono registrati esempi anche in donne che non hanno partorito e che hanno probabilmente acquisito queste cellule allo stato fetale, da gemelli poi riassorbiti dentro di loro. (Spero, se ci saranno studiosi di queste materie fra i lettori di quanto scrivo, che perdoneranno il mio pressapochismo).Della maternità ho diretta esperienza, e inoltre - come sai - è un argomento che sto studiando nella speranza di affrontarlo in modo non “ideologico” (sarà possibile?), ma forse proprio per questo la osservo con la meraviglia che si prova davanti a un mistero, e quindi senza sorprendermi all’idea che delle cellule dei miei figli - due maschi e una femmina - siano incistate dentro di me a più di trent’anni dalla loro nascita. Perché dovrei stupirmi? Se pure in me c’è qualcosa di “non mio”, cioè di non mio alla nascita, questo “non mio” io non lo conosco, né posso o voglio distinguerlo dal “mio” (“mio” geneticamente e “mio” acquisito dal momento in cui esisto) che, ripeto quello che ho detto all’inizio, mi è altrettanto opaco. Tutt’al più posso rallegrarmi al pensiero che nella continua costruzione di quella persona che io chiamo io, non si ritrovino solo tracce dei miei bisnonni o dei cinodonti del Permiano ma anche particelle del futuro, nella forma del dna dei miei figli, maschi o femmine che siano.
Per quanto ci sforziamo di analizzarci (e ricordiamo, a proposito di etimologie, che “analisi” vuol dire “scomposizione”), sono convinta che il tutto, un tutto in continuo divenire, prevale sulle parti, e questo tutto ci sfugge: ci sono sempre zone in ombra, che non vogliamo vedere, che non sappiamo vedere. Una ignoranza, almeno per me, stupenda e salvifica, perché da un lato ci spinge a conoscere di più, a capire meglio, dall’altro ci nasconde quanto siamo piccoli, irrilevanti, caduchi nella nostra individualità, e dunque ci permette di andare avanti, di vivere.
Sarà un caso allora (e torno a parlare non troppo obliquamente di maternità) che oggi che siamo o ci illudiamo di essere meno ignoranti, il tasso di natalità stia calando - in certi casi crollando - ovunque? Certo, le ragioni sono diverse, e alcune sono molto semplici, concrete, in primo luogo politiche sociali insufficienti, che lasciano i giovani genitori quasi soli a destreggiarsi fra lavori molto spesso precari, e per questo ancora più impegnativi, e la necessaria attenzione alla crescita dei loro figli. Ma mi pare che ci sia una tela di fondo, che il nostro (credere di) sapere di più, mettendoci di fronte ai nostri limiti, ci terrorizzi.
Appartenendo alla generazione di donne che ha affermato “l’utero è mio e lo gestisco io”, oggi mi trovo a ripensare a quella frase, che pure continuo a condividere, da un’altra prospettiva: fino a che punto ognuno e ognuna di noi può dire di possedere il proprio corpo, se smettiamo di vederci come individui e ci pensiamo come appartenenti a una specie?
 Oggi si parla tanto delle responsabilità che abbiamo verso chi verrà dopo di noi ed è giusto, giustissimo, ma ho la sensazione che questa responsabilità ci sia troppo gravosa, proprio quando, e forse non è una coincidenza, possiamo (illuderci di) scegliere se/come/quando avere figli.
Oggi si parla tanto delle responsabilità che abbiamo verso chi verrà dopo di noi ed è giusto, giustissimo, ma ho la sensazione che questa responsabilità ci sia troppo gravosa, proprio quando, e forse non è una coincidenza, possiamo (illuderci di) scegliere se/come/quando avere figli.
 Ora che i bambini non li portano più le cicogne, non si trovano più sotto i cavoli, che spavento! Tocca a noi decidere e pensa un po’, in un mondo che va malissimo (non che prima andasse alla grande, ma ci facevamo meno illusioni).
Ora che i bambini non li portano più le cicogne, non si trovano più sotto i cavoli, che spavento! Tocca a noi decidere e pensa un po’, in un mondo che va malissimo (non che prima andasse alla grande, ma ci facevamo meno illusioni).Forse la chimera, e quindi la storia, è questa: fino a quando gli umani (parlo soprattutto da donna) saranno disposti ad accogliere quell’assoluto inatteso che è un figlio, una figlia, ibridi come noi eppure già diversi e lontani, come noi proiettati verso una fine che non conosciamo?
Pensa alla parola totem. C’è qualcosa nel tuo ibrido che ti parla del passato, tuo e di tutti? E il futuro? Pensa alla parola daimon. Il tuo ibrido può accompagnarci nel futuro?
Unisco queste due domande, perché davanti alle parole totem e daimon confesso che dovrei costruirmi alla svelta strumenti di cui non dispongo. Ne conosco superficialmente il significato, ma non le uso, non mi appartengono. Ho avuto invece un’educazione cattolica più approfondita di quanto capitasse, anche quando ero bambina, alle mie coetanee e ai miei coetanei. E anche se dalla religione mi sono discostata tanti anni fa, è ancora quella educazione a determinare in larga parte il mio vocabolario, il mio modo di pensare. Per questo, se rifletto sul tempo (mi pare questo, in sostanza, il senso delle tue domande), non posso non fare riferimento a una frase che, da quando l’ho sentita la prima volta, avrò avuto sette o otto anni, continua a risuonare in me: “Prima che Abramo fosse, io sono” (Giovanni, 8:51-59): l’indicativo presente come rappresentazione dell’eterno dove, come su un unico piano, si trova tutto quello che (nella nostra percezione) è stato e sarà.
Se, come ha detto Werner Herzog in Cave of forgotten dreams, a un certo punto della nostra storia “noi umani siamo diventati prigionieri del tempo” (un’altra frase a cui non so rinunciare), vorrei pensare che di tanto in tanto possiamo liberarci da questa schiavitù e riusciamo ad avere accesso a quell’altra dimensione, magari senza rendercene conto, mentre ci abbandoniamo al sonno, mentre sogniamo. Chimere, forse.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E "INFAMIA ORIGINARIA". Due note sulla guerra della Russia all’Ucraina, e sul "patriarcato" all’attacco (A. Sofri - L. Melandri).18 marzo 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA E "INFAMIA ORIGINARIA". COME USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA?
Due note sulla guerra della Russia all’Ucraina, e sul "patriarcato" all’attacco...
1) - "Putin vuole uccidere l’infedele Ucraina. Come a Srebrenica, uomini e donne divisi. “Sei stata mia e non andrai con nessun altro”. Nel conflitto ucraino c’è un corto circuito fra guerra e femminicidio: Cara Lea Melandri, vorrei proporti una questione: le divergenze fra te e me in un frangente cruciale come la guerra (più urgente ancora della pandemia, di fronte alla quale eravamo molto più d’accordo) sono anche il segno di un irriducibile resto della differenza fra te donna e me uomo? [...]
 Giovedì sera ho sentito in televisione il giornalista, e militante, ucraino Vladislav Maistrouk dire, quasi per un’idea improvvisa, che l’ossessione di Putin per l’Ucraina somiglia a quelle di certi uomini per la ex moglie che hanno amato, al punto di ucciderla. Mi è sembrato un pensiero folgorante: l’Ucraina è mia perché lo è stata, e se non vuole essere più mia non sarà di nessun altro. Un corto circuito fra guerra e femminicidio: mai casus belli è stato più nitido. I richiami sessuali sono del resto disseminati quasi ingenuamente lungo la frontiera.
Giovedì sera ho sentito in televisione il giornalista, e militante, ucraino Vladislav Maistrouk dire, quasi per un’idea improvvisa, che l’ossessione di Putin per l’Ucraina somiglia a quelle di certi uomini per la ex moglie che hanno amato, al punto di ucciderla. Mi è sembrato un pensiero folgorante: l’Ucraina è mia perché lo è stata, e se non vuole essere più mia non sarà di nessun altro. Un corto circuito fra guerra e femminicidio: mai casus belli è stato più nitido. I richiami sessuali sono del resto disseminati quasi ingenuamente lungo la frontiera.
 L’adorno Kirill prende così sul serio il proprio patriarcato da proclamare la crociata contro la dissoluzione sessuale (la sua franchezza dovrebbe suonare come un allarme ai colleghi di altre confessioni).
L’adorno Kirill prende così sul serio il proprio patriarcato da proclamare la crociata contro la dissoluzione sessuale (la sua franchezza dovrebbe suonare come un allarme ai colleghi di altre confessioni).
 [...] Ti propongo, Lea, di considerare la bomba atomica come il deposito materiale in cui culmina la storia dell’Uomo: il capolavoro del patriarcato che, uscito da lui, gli sta di fronte come un nuovo divieto nel rattoppato giardino dell’eden.
[...] Ti propongo, Lea, di considerare la bomba atomica come il deposito materiale in cui culmina la storia dell’Uomo: il capolavoro del patriarcato che, uscito da lui, gli sta di fronte come un nuovo divieto nel rattoppato giardino dell’eden.
 C’erano tre minacce incombenti sul genere umano: il clima, la pandemia, l’atomica. Putin poteva maneggiarne una sola, e ci si è buttato. Ora, le donne hanno una forte ragione, seppur non intera, a dissociarsi dalla storia che è arrivata alla bomba e a rivendicarne un’altra direzione. Ma c’è. In Ucraina si sta decidendo come muoversi sotto quell’esplicito ricatto. La distanza fra No Fly Zone e fornitura di armi difensive sta lì, in bilico. Dunque, perché tu e io non siamo d’accordo, nemmeno dopo ottant’anni che abitiamo questa terra? [...]
C’erano tre minacce incombenti sul genere umano: il clima, la pandemia, l’atomica. Putin poteva maneggiarne una sola, e ci si è buttato. Ora, le donne hanno una forte ragione, seppur non intera, a dissociarsi dalla storia che è arrivata alla bomba e a rivendicarne un’altra direzione. Ma c’è. In Ucraina si sta decidendo come muoversi sotto quell’esplicito ricatto. La distanza fra No Fly Zone e fornitura di armi difensive sta lì, in bilico. Dunque, perché tu e io non siamo d’accordo, nemmeno dopo ottant’anni che abitiamo questa terra? [...]
 Io desidero dare un’arma di difesa - contro un tank, una batteria di artiglieria, un caccia - a chi è aggredito e rischia di soccombere. E, angosciosamente, mi dico che il negoziato che tutte e tutti dicono di auspicare non verrà se non grazie alla resistenza. A farci differenti è un’opinione, o anche e ancora, il tuo esser donna e il mio essere, ed esser stato, uomo?" (Adriano Sofri, "Putin vuole uccidere l’infedele Ucraina", Il Foglio, 12.03.2022).
Io desidero dare un’arma di difesa - contro un tank, una batteria di artiglieria, un caccia - a chi è aggredito e rischia di soccombere. E, angosciosamente, mi dico che il negoziato che tutte e tutti dicono di auspicare non verrà se non grazie alla resistenza. A farci differenti è un’opinione, o anche e ancora, il tuo esser donna e il mio essere, ed esser stato, uomo?" (Adriano Sofri, "Putin vuole uccidere l’infedele Ucraina", Il Foglio, 12.03.2022).***
2) - "Caro Adriano Ti spiego perché il mio pacifismo è radicale: [...] il pacifismo, nel- la sua radicalità, non può essere applicato retroattivamente alle guerre del passato, ma va riportato all’oggi, alle consapevolezze che grazie a movimenti libertari come il femminismo sono approdate alla coscienza dei singole e dei popoli. La storia può cambiare? Mi verrebbe da dire che la storia è già cambiata dal momento che ha portato allo scoperto il dominio maschile, gli orrori della "virilità guerriera", i legami tra sessismo, razzismo, classismo, nazionalismo, ecc.
 “Pace” oggi per me, come per molte altre femministe, vuol dire porsi “su un altro piano”, andare alle radici di quel primo atto di guerra che è stata la sottomissione delle donne, considerate “natura inferiore”, “animalità”, il loro asservimento al sesso vincitore.
“Pace” oggi per me, come per molte altre femministe, vuol dire porsi “su un altro piano”, andare alle radici di quel primo atto di guerra che è stata la sottomissione delle donne, considerate “natura inferiore”, “animalità”, il loro asservimento al sesso vincitore.
 E’ da questa guerra mai dichiarata, e perciò più subdola, invisibile perché coperta dalla sua “naturalità”, che nasce il perverso connubio tra distruzione e salvezza, tra guerra e umanitarismo, guerra e religione. Se, come ho scritto più volte, “gli orrori hanno un genere”, è da questo fondamentale retroterra che dobbiamo partire per dar modo al pensiero e all’immaginazione di scoprire nuovi modi per uscire dalla barbarie che abbiamo ereditato. (Lea Melandri, "Lettera aperta ad Adriano Sofri", Il riformista, 16 marzo 2022).
E’ da questa guerra mai dichiarata, e perciò più subdola, invisibile perché coperta dalla sua “naturalità”, che nasce il perverso connubio tra distruzione e salvezza, tra guerra e umanitarismo, guerra e religione. Se, come ho scritto più volte, “gli orrori hanno un genere”, è da questo fondamentale retroterra che dobbiamo partire per dar modo al pensiero e all’immaginazione di scoprire nuovi modi per uscire dalla barbarie che abbiamo ereditato. (Lea Melandri, "Lettera aperta ad Adriano Sofri", Il riformista, 16 marzo 2022). -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- "UN DEBOLE FRULLO D’ALI" (A. CAMUS), L’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA (EURIPIDE/GIASONE), E DANTE (1321-2021).14 marzo 2022, di Federico La Sala
DANTE 2021:
L’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA E "UN DEBOLE FRULLO D’ALI" (A. CAMUS).
Se è vero, come è vero, che «Le grandi idee arrivano nel mondo con la gentilezza delle colombe. Se ascoltiamo bene, tra il frastuono degli imperi e delle nazioni, forse udiremo un debole frullo d’ali, il dolce fremito della vita e della speranza. Certi diranno, questa speranza risiede in una nazione; altri, in un uomo. Credo invece che essa sia ridestata, ravvivata, nutrita, da milioni di individui solitari, le cui azioni negano ogni giorno le frontiere e le implicanze più crude della storia» (come ha pensato e scritto Albert Camus), è altrettanto vero, perché gli "individui solitari" possano udire il debole frullo di ali, il dolce fremito della vita e della speranza, che è necessario riprendere e riconsiderare il tema della nascita (al di là della andrologia della tragedia tebana (Giocasta ed Edipo) e la riflessione e il lavoro su "l’una e l’altra Medea" (Pino Blasone) e, in prospettiva, riequilibrare il campo antropologico!
Venticinque secoli "a la ‘mpresa,/che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo": Dante (1321-2021) aveva ragione sul letargo (Par. XXXIII, 94-96) in cui l’umana società è ancora immersa. C’è solo da uscire dall’inferno e riprendere il cammino...
Il problema Medea è un nodo antropologico e filosofico più che millenario ed è un tentativo (come ha ben compreso e proposto Dante Alighieri) di uscire dall’inferno del gioco e giogo degli specchi.
Per venirne fuori (questione epocale) è bene ripercorre i passi dell’una e l’altra Medea e cercare di sciogliere l’enigma della sfinge e capire la tragica verita di "Euripide / Giasone"!
Ricordando che il padre di Ulisse, Laerte, era con gli Argonauti che andarono a riprendersi (questo sfugge a Christa Wolf) il vello d’oro dell’ariete, si può senz’altro pensare che dei versi sul tema (Par. XXXIII, 94-96) posti da Dante a conclusione del suo lavoro, della sua Commedia, ci sfugge proprio l’essenziale: che "esorcizzare la mitica Medea" non è possibile!
Tutta la teologia, la filosofia, l’antropologia è ancora ferma all’interpretazione dei sogni di Freud e non di Giuseppe! Michelangelo legando e collegando il "Laocoonte" e il "Tondo Doni" e il Mosè della Chiesa di San Pietro in Vincoli cosa ha pensato se non il problema Giuseppe?!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- UNA SOLLECITAZIONE A UNA "RICAPITOLAZIONE" ANTROPOLOGICA (NON ANDROLOGICA).26 febbraio 2022, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E QUESTIONE ANTROPOLOGICA: UT UNUM SINT... *
GIOVANNI PAOLO II
UDIENZA GENERALE
Mercoledì, 14 febbraio 2001
La “ricapitolazione” di tutte le cose in Cristo *
1. Il disegno salvifico di Dio, “il mistero della sua volontà” (Ef 1,9) concernente ogni creatura, è espresso nella Lettera agli Efesini con un termine caratteristico: “ricapitolare” in Cristo tutte le cose, celesti e terrestri (cfr Ef 1,10). L’immagine potrebbe rimandare anche a quell’asta attorno alla quale si avvolgeva il rotolo di pergamena o di papiro del volumen, recante su di sé uno scritto: Cristo conferisce un senso unitario a tutte le sillabe, le parole, le opere della creazione e della storia.
A cogliere per primo e a sviluppare in modo mirabile questo tema della ‘ricapitolazione’ è sant’Ireneo vescovo di Lione, grande Padre della Chiesa del secondo secolo. Contro ogni frammentazione della storia della salvezza, contro ogni separazione tra Antica e Nuova Alleanza, contro ogni dispersione della rivelazione e dell’azione divina, Ireneo esalta l’unico Signore, Gesù Cristo, che nell’Incarnazione annoda in sé tutta la storia della salvezza, l’umanità e l’intera creazione: “Egli, da re eterno, tutto ricapitola in sé” (Adversus haereses III, 21,9).
2. Ascoltiamo un brano in cui questo Padre della Chiesa commenta le parole dell’Apostolo riguardanti appunto la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose. Nell’espressione “tutte le cose” - afferma Ireneo - è compreso l’uomo, toccato dal mistero dell’Incarnazione, allorché il Figlio di Dio “da invisibile divenne visibile, da incomprensibile comprensibile, da impassibile passibile, da Verbo divenne uomo. Egli ha ricapitolato tutto in se stesso, affinché come il Verbo di Dio ha il primato sugli esseri sopracelesti, spirituali e invisibili, allo stesso modo egli l’abbia sugli esseri visibili e corporei. Assumendo in sé questo primato e donandosi come capo alla Chiesa, egli attira tutto in sé” (Adversus haereses III, 16,6). Questo confluire di tutto l’essere in Cristo, centro del tempo e dello spazio, si compie progressivamente nella storia superando gli ostacoli, le resistenze del peccato e del Maligno.
3. Per illustrare questa tensione, Ireneo ricorre all’opposizione, già presentata da san Paolo, tra Cristo e Adamo (cfr Rm 5,12-21): Cristo è il nuovo Adamo, cioè il Primogenito dell’umanità fedele che accoglie con amore e obbedienza il disegno di redenzione che Dio ha tracciato come anima e meta della storia. Cristo deve, quindi, cancellare l’opera di devastazione, le orribili idolatrie, le violenze e ogni peccato che l’Adamo ribelle ha disseminato nella vicenda secolare dell’umanità e nell’orizzonte del creato. Con la sua piena obbedienza al Padre, Cristo apre l’era della pace con Dio e tra gli uomini, riconciliando in sé l’umanità dispersa (cfr Ef 2,16). Egli ‘ricapitola’ in sé Adamo, nel quale tutta l’umanità si riconosce, lo trasfigura in figlio di Dio, lo riporta alla comunione piena con il Padre. Proprio attraverso la sua fraternità con noi nella carne e nel sangue, nella vita e nella morte Cristo diviene ‘il capo’ dell’umanità salvata. Scrive ancora sant’Ireneo: “Cristo ha ricapitolato in se stesso tutto il sangue effuso da tutti i giusti e da tutti i profeti che sono esistiti dagli inizi” (Adversus haereses V, 14,1; cfr V, 14,2).
4. Bene e male sono, quindi, considerati alla luce dell’opera redentrice di Cristo. Essa, come fa intuire Paolo, coinvolge tutto il creato, nella varietà delle sue componenti (cfr Rm 8,18-30). La stessa natura infatti, come è sottoposta al non senso, al degrado e alla devastazione provocata dal peccato, così partecipa alla gioia della liberazione operata da Cristo nello Spirito Santo.
Si delinea, pertanto, l’attuazione piena del progetto originale del Creatore: quello di una creazione in cui Dio e uomo, uomo e donna, umanità e natura siano in armonia, in dialogo, in comunione. Questo progetto, sconvolto dal peccato, è ripreso in modo più mirabile da Cristo, che lo sta attuando misteriosamente ma efficacemente nella realtà presente, in attesa di portarlo a compimento. Gesù stesso ha dichiarato di essere il fulcro e il punto di convergenza di questo disegno di salvezza quando ha affermato: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32). E l’evangelista Giovanni presenta quest’opera proprio come una specie di ricapitolazione, un “riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,52).
5. Quest’opera giungerà a pienezza nel compimento della storia, allorché - è ancora Paolo a ricordarlo - “Dio sarà tutto in tutti” (1Cor 15,28).
L’ultima pagina dell’Apocalisse - che è stata proclamata in apertura del nostro incontro - dipinge a vivi colori questa meta. La Chiesa e lo Spirito attendono e invocano quel momento in cui Cristo “consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza... L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa (Dio) ha posto sotto i piedi” del suo Figlio (1Cor 15,24.26).
Al termine di questa battaglia - cantata in pagine mirabili dall’Apocalisse - Cristo compirà la ‘ricapitolazione’ e coloro che saranno uniti a lui formeranno la comunità dei redenti, che “non sarà più ferita dal peccato, dalle impurità, dall’amor proprio, che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica, nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti, sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di reciproca comunione” (CCC, 1045).
La Chiesa, sposa innamorata dell’Agnello, con lo sguardofisso a quel giorno di luce, eleva l’invocazione ardente:“Maranathà” (1Cor 16,22), “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20).
* FONTE: VATICAN.VA, 14 FEBBRAIO 2001 (RIPRESA PARZIALE)
*
NOTA:
PER UNA RICAPITOLAZIONE ANTROPOLOGICAMENTE "INTERA" IN GESU’ ("ECCE HOMO"), NON ANDROLOGICAMENTE "DIMEZZATA" IN PAOLO ("ECCE VIR")!
- FILOLOGIA E FILOSOFIA: LEZIONE DI PROTAGORA. "Il frammento (1 Diels-Kranz) suona: «πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν», e cioè, letteralmente: «Di tutte le cose è misura l’uomo, di quelle che sono, in quanto sono, di quelle che non sono, in quanto non sono»".
- FILOLOGIA E DIRITTO: LEZIONE DI PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei : "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
- FILOLOGIA E RELIGIONE: LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
DUE SOLI IN TERRA E UNO SOLE IN CIELO. La Monarchia di Dante è una lezione di antropologia prima che di politica: il giardino dell’intera umanità (impero e chiesa) è uno solo - o l’aiuola della guerra o il paradiso terrestre
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Cosmologia, antropologia, e civilta: Nietzsche, Copernico, e il sorgere della Terra (Earthrise. 1968)..13 febbraio 2022, di Federico La Sala
Cosmologia, antropologia, cristianesimo e civiltà.
"IL FIGLIO DELL’UOMO": UNA QUESTIONE ANTROPOLOGICA E FILOLOGICA...
COSMOLOGIA. “Da Copernico in poi l’uomo rotola dal centro verso una X”. Così Nietzsche, nel 1886. Ma, per un filosofo nato filologo e, per di più, uno dei grandi maestri del sospetto, contrariamente a quanto si è sempre ripetuto in modo "umano, troppo umano", non è bene tornare a interrogarlo e cercare di avere ulteriori dati sulla destinazione "ignota"?
ANTROPOLOGIA. Nel 1888 pubblica "Ecce homo. Come si diviene ciò che si è": un Urlo contro la paolina religione del "Vir Dei", una critica radicale della cosmoteandria faraonica, e un aut aut epocale.
LA PUNTA DI UN ICEBERG BIMILLENARIO: PUGLIA (12 FEBBRAIO 2022). "Ecce Vir": il "caso serio" del quadro intitolato "Sabinus vir Dei".
Tracce per una seconda rivoluzione copernicana
- AL DI LÀ DELLA LEZIONE DI "ANDROLOGIA" DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ, ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3)
SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI E RINASCIMENTO, OGGI. Una ristrutturazione epocale e lo sgretolamento della cosmoteandria tradizionale (#cosmo, teologia/ #dio e #andrologia/uomo) è già da tempo in atto: la nascita di una antropologia annunciata già da Michelangelo nel suo "Tondo Doni", con le sue due sibille e i suoi due profeti - non "quattro profeti", come vuole la Galleria degli Uffizi, e da Galileo Galilei con il suo "Sidereus Nuncius" (1610), fondata sulla visione del sorgere della Terra, è già in cammino: un capovolgimento e una nuova ricapitolazione, una radicale inversione logico-storica!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- FILOSOFIA, PSICOANALISI, E PSICHIATRIA: ENZO PACI, L’ENIGMA DELLA NASCITA, E "AUT AUT". Quel gesto fenomenologico che ha fatto cultura (di P. A. Rovatti)..12 gennaio 2022, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI. LA CRISI DELLE SCIENZE: ENZO PACI, "AUT AUT", E L’ENIGMA DEL SOGGETTO. *
- "ECCE HOMO. Come si diventa ciò che si è" (Nietzsche, 1888).
- Franz Brentano: "La filosofia possiede al massimo grado la dignità di una scienza teoretica, ma perde completamente questo privilegio, quando dall’ambito della sua conoscenza viene esclusa l’esistenza di Dio" ("La prova dell’esistenza di Dio", 1915).
- Enzo Paci: Nicodemo o della nascita, 1944/1973.
- L’antropologia non è una andrologia: Come "è stata possibile un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, "Donna", 1978 - "Una voce", 1982)?!
Quel gesto fenomenologico che ha fatto cultura
di Pier Aldo Rovatti *
Se mi chiedessero di dire in una battuta che cosa ha prodotto il settantennio di vita della rivista “aut aut”, messa al mondo nel 1951 dal filosofo Enzo Paci e oggi tutt’altro che estinta, risponderei senza esitazione: “il gesto fenomenologico”.
A tale atteggiamento o pratica di pensiero è stato dedicato anche il fascicolo della rivista attualmente in circolazione, in cui si guarda tanto al lunghissimo passato quanto a un futuro ancora da realizzare: sì, perché siamo ancora lontani dall’avere ben compreso questo gesto e dall’essere riusciti a metterlo in atto.
Di cosa si tratta? È un tentativo di dar corpo alla parola “critica”, forse più facile da collegare a quella cultura che voleva prendere distanza dai dogmatismi e dagli ideologismi del ventennio fascista di quanto sia riconoscibile oggi in una situazione nella quale tutti ci riempiamo la bocca di un’idea di democrazia alquanto superficiale e di tanti propositi culturali che spesso risultano vuoti e dai piedi di argilla. Parliamo infatti di pensiero critico, di responsabilità e di etica pubblica, ma non sembra proprio che riusciamo a dare troppo peso a quello che diciamo, come se dalla bocca di molti intellettuali uscisse soltanto un esile vapore, un flatus vocis che si disperde subito nell’aria.
Il gesto fenomenologico avrebbe invece la pretesa di tenere i piedi ben piantati sulla terra e di non consumarsi subito in una vacua cortina fumogena, come capita alla gran parte dei prodotti dell’attuale mondo della comunicazione, frettolosi e dunque superficiali. Questo gesto è invece qualcosa che ci coinvolge integralmente: non un semplice pensiero, qualcosa che ci passa per la testa e che comunque si riduce all’ambito del mentale, al contrario riguarda la nostra intera soggettività. È un atteggiamento “concreto” che concentra l’insieme delle nostre facoltà e ci mette completamente in gioco.
Detto altrimenti, questo gesto ci espone agli altri, non è una postura comprimibile nella privatezza, perciò ha sempre una dimensione pubblica, nel senso appunto dell’esposizione e del confronto. Siamo lontani dall’idea di una filosofia come disciplina a sé, dotata di una sua autorevolezza, piuttosto siamo vicini a un impegno di pensiero che ci chiederebbe di uscire dal bozzolo di un “io” separato, vale a dire di tentare di liberarci dalla presa di qualunque egoismo (egologia, egolatria) e dunque anche di sospettare di ogni pervasiva psicologia.
Perciò il gesto fenomenologico, così difficile da mantenere, così facile da inquinare e infrangere, dunque raro, è innanzi tutto un atteggiamento autocritico: ciascuno di noi, ogni “soggetto”, dovrebbe cominciare con il togliersi di dosso la camicia di forza dell’egoismo, tentare almeno di farlo, se vuole che il suo gesto agisca come un gesto critico. Non è certo lo scenario che vediamo ogni giorno perché, invece, abbiamo costantemente davanti una scena opposta in cui non si scorge quasi nessuna traccia di tale necessaria critica di sé stessi.
Ma cosa significa quel parolone, “fenomenologico”, che accompagna la parola “gesto”? Qui compare la specificità filosofica che caratterizza i settant’anni della rivista. È chiaro che il rimando è a Husserl e soprattutto alla sua ultima opera La crisi delle scienze. Si parte da una diagnosi di perdita di senso, cioè appunto di “crisi”, che non investe soltanto il mondo scientifico e la sua tecnicizzazione, come aveva fatto negli anni Trenta lo stesso Heidegger (peraltro, inizialmente discepolo di Husserl), ma investe per intero la cultura poiché riguarda lo stile di vita di ciascuno. Il titolo preciso di quest’opera di Husserl, che davvero ha fatto testo per comprendere un’epoca, certo non ancora conclusa, è: La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (in italiano è stata pubblicata dal Saggiatore, lo stesso editore di “aut aut”).
“Fenomenologia” e in più “trascendentale”? Non è poi così difficile arrivare al nocciolo di una frase che potrebbe giustamente allarmare i non addetti (tra i quali, in questo caso, vorrei potermi collocare a mia volta): quel “trascendentale” è lì per dirci che non dobbiamo confondere fenomenologia con fenomeno (o con qualcosa di semplicemente fenomenico) perché ciò che viene messo in gioco è l’idea di soggetto e di soggettività nella sua concretezza non superficiale.
Per mantenere o ritrovare il suo carattere fenomenologico, questa idea non dovrà essere soltanto la meno idealistica, categoriale, metafisica possibile, perché non basta che la concretezza equivalga a ciò che è empirico, ma dovrebbe riuscire a dar corpo a una soggettività che non è mai fissabile attraverso un’etichetta. Perciò il termine fenomenologia risulta essenziale per mettere in primo piano proprio il problema del soggetto.
Aggiungo, per far capire l’importanza di tale problema, che il soggetto che viene così evocato non è mai traducibile in un concetto chiuso, di cui si possa costruire una scienza comunemente intesa. È piuttosto, come diceva lo stesso Husserl, un “enigma” che non possiamo cessare di sondare e di rilanciare, qualcosa che ha a che fare con l’insieme dei nostri vissuti e con la nostra stessa vita.
Qualcosa che fa tutt’uno con lo stile di vita di ognuno di noi, come ha mostrato con chiarezza Paci nelle pagine del suo personale Diario fenomenologico (ora riedito da Orthotes). E proprio da qui discende l’intero corredo critico di “aut aut”, cioè - per indicarne solo qualche aspetto - l’importanza della “sospensione del giudizio” (la famosa epoché, rilanciata anche da Franco Basaglia nella sua critica alla psichiatria ufficiale), l’importanza di non isolare mai il sapere dall’etica con il rischio di svuotare il “gesto” facendolo diventare unicamente una tecnica di pensiero, o anche l’importanza di conservare a ogni costo l’apertura del dubbio e la possibilità del “sempre di nuovo”.
Perché questo gesto non può essere mai considerato un atteggiamento esclusivamente individuale? La tonalità “politica” della rivista, presente fin dal suo inizio, può ritrovarsi nella risposta a quest’ultima domanda, nel senso che non si dà soggettività senza intersoggettività, cioè che nel vissuto personale è sempre presente e attiva l’esperienza dell’“altro” ed è quindi comunque decisiva un’esperienza del noi.
Senza il compito dello stare assieme in una comunità possibile e necessaria di soggetti, il gesto fenomenologico perde il suo significato, letteralmente si annulla nel suo senso e nei suoi obiettivi. Siamo ancora lontani da questo telos, dall’impegnarci seriamente nella pratica di una simile finalità, e allora si comprende perché il tragitto che “aut aut” ha iniziato fin dal primo fascicolo non sia affatto esaurito.
[articolo uscito in versione ridotta su “La Stampa” il 20 settembre 2021]
*Fonte: Aut Aut, 23/09/2021
NOTA:
L’ENIGMA DEL SOGGETTO E LA PROVA DELL’ESISTENZA DI DIO. Note su un dialoghetto "platonico" diffuso in rete:
- Nel pancione di una mamma c’erano due bambini.
 Uno chiese all’altro: "Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?"
Uno chiese all’altro: "Ma tu ci credi in una vita dopo il parto?"
 L’altro rispose: "Certo! Deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi". "Sciocchezze" disse il primo "non c’è vita dopo il parto! Che tipo di vita sarebbe quella?"
L’altro rispose: "Certo! Deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepararci per quello che verrà più tardi". "Sciocchezze" disse il primo "non c’è vita dopo il parto! Che tipo di vita sarebbe quella?"
 Il secondo riprese: "Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. Forse potremo camminare con le nostre gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora".
Il secondo riprese: "Io non lo so, ma ci sarà più luce di qui. Forse potremo camminare con le nostre gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi che non possiamo capire ora".
 Il primo replicò: "Questo è assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale è tutto quello di cui abbiamo bisogno...e poi è troppo corto. La vita dopo il parto è fuori questione".
Il primo replicò: "Questo è assurdo. Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale è tutto quello di cui abbiamo bisogno...e poi è troppo corto. La vita dopo il parto è fuori questione".
 Il secondo continuò ad insistitere: "Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo".
Il secondo continuò ad insistitere: "Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse diverso da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di questo tubo".
 Il primo contestó: "Sciocchezze, e inoltre, se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel postparto non c’è nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Il parto non ci porterà da nessuna parte".
Il primo contestó: "Sciocchezze, e inoltre, se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è mai tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel postparto non c’è nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Il parto non ci porterà da nessuna parte".
 "Beh, io non so" disse il secondo "ma sicuramente troveremo la mamma e lei si prenderà cura di noi".
"Beh, io non so" disse il secondo "ma sicuramente troveremo la mamma e lei si prenderà cura di noi".
 Il primo rispose: "Mamma? Tu credi davvero alla mamma? Questo si che è ridicolo. Se la mamma c’è, allora, dov’è ora?"
Il primo rispose: "Mamma? Tu credi davvero alla mamma? Questo si che è ridicolo. Se la mamma c’è, allora, dov’è ora?"
 Il secondo riprese: "Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere".
Il secondo riprese: "Lei è intorno a noi. Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere".
 Riprese il primo: "Beh, io non posso vederla, quindi, è logico che lei non esiste".
Riprese il primo: "Beh, io non posso vederla, quindi, è logico che lei non esiste".
 Al che il secondo rispose: "A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri ad ascoltare veramente, si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da lassù".
Al che il secondo rispose: "A volte, quando stai in silenzio, se ti concentri ad ascoltare veramente, si può notare la sua presenza e sentire la sua voce da lassù".
 Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l’esistenza di Dio.
Questo è il modo in cui uno scrittore ungherese ha spiegato l’esistenza di Dio.
USCIRE DALLA CAVERNA, E NON RICADERE NELL’ILLUSIONE DI “DIO” CONCEPITO COME “UOMO SUPREMO” (KANT).
COSA PENSANO I due BAMBINI nella pancia della madre "della VITA DOPO IL PARTO"? Ma l’autore "scrittore" di questo "bel" testo (sopra) ha mai sollecitato i "due bambini" a pensare sul come sono ’arrivati’ là dove sono, su come nascono i bambini?, e ha mai visto il Sole? O vive ancora nel pancione della Mamma-Terra, nella caverna di Platone (ama il mondo chiuso e la claustrofilia) e, per il trauma della nascita, si è sempre rifiutato di aprire gli occhi alla luce del Sole e vedere la Terra dalla Luna, dallo spazio?!
"ACHERONTA MOVEBO" (IL "MUOVERE LE ACQUE INFERNALI" DI FREUD) E AFFRONTARE IL TRAUMA DELLA NASCITA (OTTO RANK): SAPERE AUDE! ("IL CORAGGIO DI SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA" DI KANT) !
Senza la critica di Kant del sogno dell’amore cieco e zoppo della ragion pura (di Socrate/Platone) non si può riconoscere a Diotima piena cittadinanza né nell’Accademia né nella Polis. La logica della tragedia (Edipo) porta davvero la peste!
 La Sibilla Delfica (dell’oracolo di Apollo) a Socrate disse la verità, ma la storiografia ha preferito credere al sogno della nascita del cigno e alla storia di Platone, figlio di Zeus / Apollo!
La Sibilla Delfica (dell’oracolo di Apollo) a Socrate disse la verità, ma la storiografia ha preferito credere al sogno della nascita del cigno e alla storia di Platone, figlio di Zeus / Apollo!
 Nietzsche perché ha scavato nella nascita della tragedia? Freud cosa cercava a Tebe?! Come Edipo, già a partire dal caso Dora, chiarirsi le idee sulla morte e uccisione del padre ("Interpretazione dei sogni") e sul desiderio incestuoso nei confronti della #madre, fare luce su "L’uomo #Mosè" e sull’esistenza di "Dio"! Con Dante e come Dante ha avuto il coraggio di agitare le acque infernali e uscirne: a Londra, è arrivato!
Nietzsche perché ha scavato nella nascita della tragedia? Freud cosa cercava a Tebe?! Come Edipo, già a partire dal caso Dora, chiarirsi le idee sulla morte e uccisione del padre ("Interpretazione dei sogni") e sul desiderio incestuoso nei confronti della #madre, fare luce su "L’uomo #Mosè" e sull’esistenza di "Dio"! Con Dante e come Dante ha avuto il coraggio di agitare le acque infernali e uscirne: a Londra, è arrivato!LA QUESTIONE DEL SOGGETTO, IL TRAUMA DELLA NASCITA, E LA VITA DOPO IL PARTO.
"OTTO RANK, IL DOPPIO E LA PSICOANALISI" (alcune mie note, in "Psicoterapia e Scienze Umane", 4, 1980, pp. 75-79) ). Se Freud osò agitare e rompere le acque infernali ("Acheronta movebo) e riuscì a portare alla luce la psicoanalisi, è da dire, però, che non fu altrettanto attento a riconoscere il trauma della nascita e a portarsi oltre le colonne d’Ercole dell’Edipo.
Andando in America, nel 1909, Freud era ancora fiducioso e ottimista nella possibilità della psicoanalisi di affrontare il diffondersi della peste; ma nel 1924, con la sua parziale comprensione del complesso di Edipo, non riesce ad accogliere la sollecitazione di Otto Rank a riflettere sul trauma della nascita e l’avvenire della sua stessa creatura comincia a oscurarsi.
Elvio Fachinelli (1928-1989) ha saputo vincere la Claustrofilia (1983), si è portato "Sulla spiaggia" (1985), ma l’ Accademia platonica della Filosofia come della Psicoanalisi ha continuato a chiudere un occhio su come nascono i bambini. E il platonismo continua a oscurare il cielo...
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA: SAPERE AUDE! "DESIDERIO DI CONOSCERE E DIVIETO DI SAPERE " (di Paul C. Racamier)2 novembre 2021, di Federico La Sala
DESIDERIO DI CONOSCERE E DIVIETO DI SAPERE ∗
di Paul C. Racamier∗∗
Qualche disturbo di voce mi impedisce purtroppo di presentare direttamente il mio breve lavoro. Mi dispiace anche perché apprezzo molto queste Giornate di Studio. Tuttavia abbiamo la fortuna di ascoltare il mio contributo letto da una voce amica che sarà così gentile da utilizzare la sua voce per ringraziarvi dell’attenzione.
D’altra parte ho solo alcune annotazioni da presentarvi che spero non saranno troppo dispersive. Non stupitevi che questi appunti siano l’eco delle mie preoccupazioni attuali.
Sappiamo bene che il desiderio della conoscenza si alimenta ad una sorgente essenziale, cioè al desiderio di conoscere i segreti della sessualità, partendo da quella dei genitori. Tornerò alla fine sulla questione dei segreti.
Questa curiosità essenziale si origina quindi nella camera dei genitori. Tuttavia la fonte non basta. Essa necessita anche - permettetemi una o due immagini alla mia maniera - di uno spazio e di un letto. Lo spazio consiste in un’area di discrezione che avvolge l’attività sessuale dei genitori in maniera da svolgere una funzione di "para-eccitazione". Senza questa area di discrezione - che é quasi un’area di transizione - non ci sarebbe spazio nel bambino per fabbricare il fantasma e tesserlo; senza questa area di para-eccitazione la sessualità dei genitori sarebbe davvero solo una seduzione invadente, un’effrazione traumatica, come venne descritta da Freud e come la si può incontrare ancora oggi nella pratica clinica.
In tal caso la psiche del bambino viene portata, direi perfino trascinata nel temibile ambito dove il sessuale non psichizzato rimane allo stato grezzo; un ambito dove non rimane spazio per il lavoro dello psichico sul sessuale; un ambito la cui espressione ultima è costituita secondo me dall’incesto e in modo più ampio dall’incestualità, cioé dal corto-circuito e dall’esclusione di qualsiasi elaborazione lipidica, dato che l’incestuale non é altro che il colmo dell’anti-libidinale.
Non anticipiamo troppo. Ma vale la pena di porsi da adesso una domanda: se il desiderio di sapere è per l’uomo un’estensione del desiderio di conoscere i segreti del sesso, bisogna chiedersi a quale condizione tale estensione sia possibile. Come mai questa curiosità si estende ad altri tipi di sapere? Perché ciò avvenga è indispensabile che le sia lasciato lo spazio. Bisogna che quell’area di elaborazione a cui accennavo sia preservata. Ora, l’effrazione genitoriale, se avviene, è traumatica nel senso che invade o distrugge quest’area di discrezione. Perché si sviluppi la voglia di sapere, bisogna prima che il sapere non sia stato piantato come un chiodo nella testa e nel corpo del bambino. Il sapere, per crescere, ha bisogno di essere avvolto da un materasso di silenzio.
Una fonte, dicevo. A questa fonte serve un letto. Questo letto è quello che io chiamo il pensiero delle origini. Mi sembra che questo pensiero giochi una parte essenziale nello sviluppo armonico della vita psichica. Non si limita affatto alla conoscenza o al fantasma delle nostre origini; non consiste nella ricerca delle cause. Rappresenta un’intera modalità del funzionamento psichico e sono tentato di situarla al di sotto dei processi primario e secondario del pensiero senza i quali niente si può apprendere né sapere.
Con "pensiero delle origini" intendo la capacità fondamentale e indelebile di provare, fantasticare, concepire e pensare che ogni cosa, ogni conoscenza, ogni persona, abbiano delle origini che a loro volta hanno altre origini, e così di seguito. L’origine è quello che precede: è a monte. Non ci sono limiti alle origini ma il pensiero delle origini non corrisponde all’onnipotenza perché è riuscito a passare attraverso la strettoia del lutto originario che inaugura la rinuncia all’onnipotenza. E’ lì che inizia il filo della vita e questo filo sarà vissuto come una creazione personale, o piuttosto, secondo il mio vecchio amico Antœdipo, come una coproduzione dei genitori e di se stesso.
Perdonatemi questa escursione in concetti che sembreranno complessi, a meno che vi siano familiari. Tuttavia questa deviazione ci porta a due affermazioni molto semplici.
1. Il bambino o l’adulto che non è riuscito a confezionarsi un pensiero delle origini, che quindi non ha rinunciato alla conoscenza assoluta e alla padronanza onnipotente delle proprie origini e della propria vita, probabilmente non avrà né la voglia di sapere né la disponibilità interiore, area di silenzio di cui bisogna disporre nel proprio mondo interno, necessaria per investire in nuove conoscenze. Tale è il caso dei soggetti con patologia narcisistica grave. Non sopportano di imparare perché in ogni conoscenza nuova vedono meno quello che avrebbero da guadagnare di quello che, essendogli sconosciuto, gli fa difetto e ferisce il loro irresistibile fantasma di onnipotenza e onniscienza. Accettando di imparare sembrerebbe loro di derogare a questo fantasma; tant’è che per imparare bisogna prima ignorare. Ora l’ignoranza non è altro che una vergognosa debolezza quando la si guarda dall’alto di un narcisismo intollerante. I narcisisti più "accesi" hanno una vera anti-voglia di imparare.
2. L’altro punto è più temerario. Non mi sembra azzardato ritenere che l’imparare e il sapere costituiscano già un atto di creazione. Atto modesto, certo, ma fondamentalmente della stessa natura della creazione vera e propria, e che presenta alcune delle sue caratteristiche principali. Se non è una creazione vera e propria, fa parte almeno della stessa famiglia. Ogni cosa appresa ha infatti questo carattere sia personale che universale che nella sua ambiguità, è propria di ogni cosa creata.
 Come ogni creazione nuova, ogni sapere nuovo provoca un ampliamento ed
un’estensione dell’io. Non da ultimo, l’acquisizione del sapere e anche la sua trasmissione, è
creativa nel senso che è il frutto di una coproduzione. Per imparare bisogna prendere e offrire;
non per caso il verbo apprendere (in francese apprendre) può intendersi secondo due modi
diversi: si può insegnare a qualcuno e apprendere da qualcuno; due correnti pulsionali avverse e
complementari che si completano strettamente in questa attività.
Come ogni creazione nuova, ogni sapere nuovo provoca un ampliamento ed
un’estensione dell’io. Non da ultimo, l’acquisizione del sapere e anche la sua trasmissione, è
creativa nel senso che è il frutto di una coproduzione. Per imparare bisogna prendere e offrire;
non per caso il verbo apprendere (in francese apprendre) può intendersi secondo due modi
diversi: si può insegnare a qualcuno e apprendere da qualcuno; due correnti pulsionali avverse e
complementari che si completano strettamente in questa attività.Vediamo qui come le strade si incrociano. Se è vero che l’esistenza di ciascuno di noi è il frutto di una coproduzione, dato che la vita ci è stata data ma non cessa di sgorgare in noi stessi, se quindi questo fantasma di fondazione è il perno delle origini; e se questo pensiero delle origini è realmente il letto del desiderio e della capacità di apprendere; se infine l’atto di apprendere è in se stesso una sorta di creazione, allora si vede bene che i nostri concetti si raggiungono nel sapere.
Se mi dite che la conoscenza di se stesso attraverso la relazione psicoanalitica è in se stessa il frutto di una coproduzione, ne converrò sicuramente. Se dite che all’origine dei disturbi del sapere e, più in generale, all’origine delle occlusioni gravi della vita psichica c’è uno sbarramento di vecchia data sul pensiero delle origini, ne converrò anche.
Ma basta con queste grandi idee. Volevo parlarvi del piacere. E per quello vorrei parlarvi dei segreti. Esistono due tipi di segreti. Vi sono i segreti libidici, come i segreti dell’alcova e i segreti di corridoio, che parlano sempre del piacere e che presentano il felice paradosso di circolare tra le generazioni rimanendo nell’ambito del privato: quei segreti sono dei serbatoi di fantasmi, delle macchine per pensare e degli stimoli del sapere. Il culto della verità naviga nelle stesse acque di quello del sapere. Li sospetto entrambi di trarre una forza considerevole dall’auto-erotismo: è proprio quando la verità, che non si incontra comunemente per strada, diventa un oggetto di piacere che l’io le corre dietro: non è vero tra l’altro che la verità viene descritta solitamente come una signora che, quando esce, va in giro svestita?
Al contrario esistono dei segreti anti-libidici. Essi impediscono l’accesso alla conoscenza, alla comprensione, allo scambio e al pensiero così come alla parola. Sono dei segreti inibitori. Di generazione in generazione esercitano i loro effetti paralizzanti. Li incontrerete dappertutto dove regna l’impero incestuale. Ciò significa che li incontrerete spesso. Il regno del segreto esercita un’influenza della peggiore specie. Si tratta di un divieto molto crudele e molto primitivo che ostacola ogni sapere per impedire la scoperta di alcuni saperi. Questo divieto di dire, questo divieto di sapere, questo divieto di pensare si esercita non tramite l’Io ma direttamente sull’Io, nel cuore stesso dell’Io. Perciò penso che sia molto diverso dal Super Io edipico.
Si potrebbe dire che il Super Io edipico prende l’io da parte e gli ingiunge: "Tu, Io, dirai ai tuoi amichetti, i fantasmi erotici, di tenersi tranquilli e di non fare troppo baccano in fondo alla classe". E l’Io obbedisce più o meno. Ecco come si comporta un Super Io di buona compagnia.
In un regime incestuale e sotto l’impero di un narcisismo abusivo e perforante, come quello che abbiamo visto trasgredire le aeree di transizione e di para-eccitazione di cui l’Io ha bisogno per svilupparsi, succede tutt’altro; sembra che una forza pressante prema l’Io da tutte le parti, gli prenda la testa, gli tappi gli occhi e le orecchie e gli imponga gradualmente un divieto assoluto di imparare, e perfino di pensare. "Se sai, dice, se vuoi sapere, se pensi, allora mi fai morire e muori".
Il Super Io edipico vieta l’incesto ma ne lascia passare il desiderio e il fantasma; lascia anche passare il desiderio di sapere e il piacere di desiderare; all’opposto l’oppressione appena descritta e che chiamerei volentieri, usando un neologismo, un super-anti-io, questa oppressione crudele permette l’incesto ma non lascia spazio al desiderio nonché al sapere, alla conoscenza e al pensiero.
Così viene confermato dal suo contrario quello che sappiamo da sempre: che la conoscenza e il piacere sono legati tra di loro e con la vita. La mia lettrice ed io vi ringraziamo per l’attenzione.
∗ Desiderio di conoscere e divieto di sapere di Paul C. Racamier Gennaio - Giugno 2002. Ringraziamo la Sig.ra Racamier per la gentile concessione alla pubblicazione di questo lavoro e l’Editore del “Bulletin de l’ACIRP” che ha pubblicato gli Atti del Convegno “Envie de savoir, envie d’apprendre”, Besançon, 23 marzo 1996.
∗∗ Traduzione in italiano a cura di Josiane Lots.
Fonte: Quaderno di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (2002) Vol. 15, pp. 11-15. 2
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- PIANETA TERRA, FILOLOGIA, E G 20: RIPRENDERE IL CAMMINO DALLA LEZIONE DI LORENZO VALLA.30 ottobre 2021, di Federico La Sala
LA POLITICA DELL’EUCARESTIA ... E "LA QUARTA «P» (QUELLA DELLA «PACE») CHE MANCA ALL’AGENDA DEL G20"
- Francesco-Biden e la diplomazia dell’eucarestia. Il presidente Usa: "Il Papa mi ha detto che posso accedervi". A breve i vescovi americani avrebbero dovuto decidere se negargliela per la sua posizione sull’aborto
- "A pochi giorni dal momento in cui i vescovi americani dovevano decidere se negare la comunione al presidente degli Stati Uniti per la sua posizione su una legge - in questo caso quella sull’aborto - il papa è intervenuto, e ha compiuto un atto primaziale che ha importanti conseguenze ecclesiologiche e politiche: ha detto a Joe Biden di accedere alla eucarestia in pace e gli ha concesso di rendere nota questa parte del loro colloquio [...] Tutto bene anche per i nodi politici, che non sono quelli del clima e dei vaccini che sono ovvia materia G20 [...] Tant’è che alla fine Biden ha elogiato il Papa come «uomo della pace»: la quarta «P» che accanto a People Planet Prosperity manca all’agenda del G20" (di Alberto Melloni, La politica dell’eucarestia, 30 ottobre 2021)
- ALBERTO MELLONI: "Sai qual è la differenza fra uno storico e un grande storico? Uno storico è uno che offre risposte ai problemi storici. Un grande storico è uno che scopre problemi storici" (Arnaldo Momigliano a Massimo Firpo).
#ANTROPOLOGIA #TEOLOGIA #STORIA E #FILOLOGIA. "La #politica dell’#eu-#carestia" - #oggi (la @repubblica , #30ottobre2021) - "segnala" un #problema di #dottrina, di #interpretazione, e di #storiografia di #lungadurata... quello della #Grazia ("#Charis"). O no? Buon lavoro. Grazie.
Federico La Sala
Scheda
MEMORIA DI LORENZO VALLA:
- Presentazione volume - Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019
Lunedì 24 febbraio [2020], alle ore 11.00, verrà presentato il volume Laurentii Valle Sermo de mysterio Eucharistie, a cura di Clementina Marsico, con un saggio di Marco Bracali. Edizione Nazionale delle opere di Lorenzo Valla, II, Opere religiose, 3, Firenze, Polistampa 2019.
Interverranno:
Alberto Melloni, Segretario della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
Antonio Manfredi, Scrittore latino della Biblioteca Apostolica Vaticana
Daniele Conti, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento
Sarà presente la curatrice del volume.
L’incontro - aperto a tutti gli interessati - si terrà nella Sala dei Seminari dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento.
* Fonte: INSR. Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 24 febbraio 2020
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- QUESTIONE ANTROPOLOGICA E INTERPRETAZIONE ANDROLOGICA DI DIO. Le illusioni di una teologia femminista: chi prenderà il posto della vittima? (Ida Magli, 1995).26 settembre 2021, di Federico La Sala
Le illusioni di una teologia femminista: chi prenderà il posto della vittima?
di Ida Magli [1995]*
Questa, perciò, è la conclusione. Nessuna teologia femminista è possibile perché la struttura sacrificale che è stata posta alla base del cristianesimo da S. Paolo e, da allora, continuamente ribadita nei duemila anni di storia cristiana, pone alle donne un problema insolubile. Una religione sacrificale obbliga, prima di tutto, ad accettare di possedere una vittima, e subito dopo a stabilire chi debba essere il Sacrificatore e chi la Vittima. La vittima fino ad oggi è stata la Donna (le donne). Naturalmente questo significa anche che colui che ha designato la vittima - il Sacrificatore - è anche colui che detiene il Potere.
Come è chiaro, in queste brevi premesse si delinea la struttura di una società, anche se nel mondo moderno si continua a fare finta che esistano società «laiche», distinte dalle religioni. Il Protestantesimo è stato un tentativo implicito di scardinare il sistema del Potere legato al sacrificio della vittima. Ma non era ancora ben chiaro in Lutero che la discussione sul grado di realtà della presenza di Cristo nel «sacrificio della Messa» (si tende di solito a dimenticarsi che la Messa è appunto un «sacrificio») non era una polemica fra teologi e fra diverse interpretazioni delle Sacre Scritture, ma una domanda ben diversa: può sussistere una società senza sacrificio?
Interrogativi, questi, irrisolti, malgrado le diverse versioni del cristianesimo che si sono presentate lungo i secoli, perché in realtà, sotto le vesti della téologia, si discuteva(si discute) delle radici di fondazione della vita di gruppo.
Nel Protestantesimo, in teoria, la necessità della vittima è meno forte che nel Cattolicesimo, in quanto si tiene fermo il punto che il sacrificio vero, quello del Salvatore si è compiuto una volta per sempre; e la messa, di conseguenza, viene interpretata come «memoria», come semplice ricordo del sacrificio di Cristo. Nel Cattolicesimo, invece, con la riaffermata «transustanziazione» del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo, il sacrificio è altrettanto reale, si compie nuovamente come sulla Croce.
Di fatto, sia l’una sia l’altra posizione girano intorno al problema irrisolvibile della necessità, o meno, della vittima. Sotto questo aspetto il cattolicesimo è tragicamente realista. Le chiese cattoliche piene di crocifissi, di corpi di martiri, di scene sanguinanti, lo dicono ad alta voce: vittime, vittime, vittime.
Nel protestantesimo, invece, esistono contraddizioni e ambiguità che, forse, sono ancor più significative. Prima di tutto, la rivendicata continuità con l’Antico Testamento, ossia con la cultura sacrificale per eccellenza.
Il cristianesimo originario, invece, e poi il cattolicesimo, almeno fino a ieri, hanno messo l’accento sulla rottura con l’ebraismo, e benché la polemica violentissima sul non riconoscimento dell’avvento del Salvatore e sull’uccisione del Figlio di Dio da parte degli Ebrei si sia svolta in termini teologici (e nell’antisemitismo concreto), in realtà era dettata dal trauma non cancellabile dell’assoluta novità portata dai Vangeli. Di fatto, però, sia l’una che l’altra Chiesa si basano fondamentalmente su S. Paolo e non su Gesù, cosa che riporta il problema alle sue radici: l’affermazione di Paolo che ogni cristiano è e deve essere, alter Christus e che «senza spargimento di sangue non esiste perdono» (Lettera agli Ebrei, 9, 22). Dunque: la vittima è necessaria.
Se le cose stanno così, nulla di ciò di cui discutono le femministe ha un senso. La richiesta del sacerdozio per le donne, per esempio, non trova che giustificazioni superficiali di parità con gli uomini, se prima non si dice cosa si vuole fare di una religione sacrificale, e se si vuole, oppure no, conservare un’organizzazione di Potere del Sacrificatore. Chiedere il sacerdozio, infatti, significa questo: diventare Sacrificatori.
Nel protestantesimo, il sacerdozio è meno «forte» di quello cattolico a causa della mancanza reale del Sacrifìcio della vittima, ed è per questo che nelle Chiese riformate è stata più facile l’equiparazione delle donne nell’ufficio di Pastore. Ma il problema si sposta di poco. In realtà (e se ne hanno abbondanti prove nella storia del Calvinismo, del Giansenismo, del Puritanesimo, ecc.) le confessioni riformate sono più rigide e coercitive del cattolicesimo proprio perché, mancando un Potere forte che si assume la «rappresentanza» del gruppo davanti a Dio, e la valvola di sicurezza del «capro espiatorio», ossia di una vittima delegata al posto di tutti, l’ansia del singolo fedele, affidato soltanto a se stesso nei confronti della giustizia divina, aumenta a dismisura.
Dunque, le donne hanno di fronte a sé un problema irrisolvibile, se continuano a muoversi nelle religioni codificate sperando che siano possibili piccoli o grandi aggiustamenti, mirati in forma analogica sulle strutture maschili già esistenti. Dio è anche Madre, oltre che Padre? Sostituire alla grammatica maschile delle Sacre Scritture e della liturgia una corrispondente grammatica femminile? Oppure, inventare una grammatica «neutra»? Il Figlio è anche Figlia? Gesù non aveva sesso? Celebrare la Messa col miele al posto del vino? Tutte ipotesi, queste, già avanzate, con l’entusiasmo e con la spavalda sicurezza tipica del femminismo, da teologhe soprattutto statunitensi. Ma, come è evidente, prive di senso. Giochi da bambine.
È vero che i teologi hanno continuamente rielaborato, sollecitati dai cambiamenti culturali e sociali che si verificano nella storia, le interpretazioni delle Sacre Scritture, con una disinvoltura stupefacente. Ma oggi si è di fronte ad una trasformazione culturale che non può essere paragonata a nessuna di quelle, sia pure grandissime, che si sono già verificate nell’itinerario storico dell’Occidente. Né l’abolizione della schiavitù, né l’invenzione del metodo scientifico, né l’accelerazione tecnologica, né l’instaurarsi della democrazia hanno messo in luce, travolgendole, le radici della fondazione della cultura e dell’assetto sociale. È questo, invece, che sta avvenendo, mano a mano che saltano i punti fermi della collocazione delle donne. Se la prima organizzazione dei gruppi umani, in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo, è avvenuta attraverso 1o scambio matrimoniale (e su questo non ci sono dubbi da parte di nessun studioso, né biologo, né antropologo, né archeologo, né etnologo, né storico); se, come afferma Lévi-Strauss, la società è nata con la «circolazione» delle donne, è questa radice che oggi, almeno in Occidente, anche in base a quel primo seme gettato da Gesù in questa direzione, sta per essere strappata, divelta. Le donne si rifiutano di «circolare». La messa in crisi dello scambio matrimoniale è molto di più che questo: è messa in crisi (come la storia qui appena tracciata dovrebbe dimostrare) del ruolo assegnato alla «femminilità», prima ancora che alle donne. Ed è sulla «femminilità» che si gioca il concetto di vittima.
Si ritorna, perciò, al problema di partenza: è necessaria la vittima per la sopravvivenza di un gruppo? E, se è necessaria, c’è qualcuno che voglia prendere il posto della vittima che le donne stanno per lasciare?
* Cfr. Ida Magli, Storia laica delle donne religiose, Longanesi, Milano 1995, pp. 312-315.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- PENSARE L’EDIPO COMPLETO E USCIRE DALLA LOGICA DEL MENTITORE. Un ricordo di Ida Magli, l’antropologa scomoda (di Alessandra Pigliaru).25 settembre 2021, di Federico La Sala
CONTRO IL "PADRE NOSTRO", MA CON IL "PADRE NOSTRO": SENZA LA MESSA A FUOCO DELL’ EDIPO COMPLETO (FREUD) NON SI ESCE DALLA TRAPPOLA DEL MENTITORE STORICAMENTE ISTITUZIONALIZZATA ... *
L’antropologa scomoda
Ritratti. È morta a 91 anni Ida Magli. Scrisse testi fondamentali sul matriarcato, la sessualità, l’iconografia della Madonna e la storia laica delle donne religiose. Negli ultimi anni, aveva radicalizzato il suo pensiero, abbracciando posizioni reazionarie
di Alessandra Pigliaru (il manifesto, 23.02.2016)
Figura controversa e complessa del panorama italiano, l’antropologa e scrittrice Ida Magli è scomparsa a Roma all’età di 91 anni. Per chi ne abbia letto i numerosi testi, in particolare quelli pubblicati tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Novanta, dedicati ad argomenti liminari al femminismo - è difficile individuare la ragione che, negli ultimi venti anni, l’ha spinta verso un passo reazionario. Sarebbe tuttavia riduttivo collocarla alla svelta nella deriva antieuropeista che in tempi recenti ha abbracciato anche se, in tutta onestà, potrebbe essere questo uno dei motivi che l’ha resa poco attraente soprattutto alle generazioni di giovani studiose che, con i testi, si confrontano. Ma per capirne il quadro completo e l’eredità che ha lasciato a chi si misura con i senso parlante dei testi, bisogna fare un necessario passo indietro, ne sono convinte in molte che di Magli hanno ascoltato quelle mirabili lezioni di Antropologia culturale alla Sapienza di Roma fino al suo pensionamento nel 1988.
Tra quelle allieve spicca Loredana Lipperini che, quando la notizia della scomparsa della professoressa Magli è stata diffusa, ha affidato ai social network parole tanto affettuose quanto colme di gratitudine per averle insegnato una curvatura dello sguardo ineguagliabile. Ed è forse su questo che ci si potrebbe soffermare, non per espungere i testi dal portato biografico ma per evitare di renderla una intellettuale rubricata semplicisticamente e rapita dalle destre; perché cioè le vada riconosciuto ciò che ha fatto, ovvero individuare alcuni elementi essenziali e spesso scomodi al dibattito antropologico e femminista contemporaneo e che poi hanno retto la parte centrale della sua esistenza.
In realtà, la storia tra Ida Magli e il femminismo è stata piuttosto intermittente, e questo nonostante abbia avuto da sempre il chiaro desiderio di seguirne il passo a giudicare dai passaggi che le sono stati cari.
Basti pensare a volumi come Matriarcato e potere delle donne (1978), in cui compaiono alcuni passi sulle società matriarcali e una inedita traduzione del poderoso testo Das Mutterrecht di Bachofen. Solo due anni prima, aveva fondato la storica rivista dwf.
È del 1982 La femmina dell’uomo e poi c’è lo studio in cui si concentra su Santa Teresa di Lisieux. Una romantica ragazza dell’Ottocento (1994), quello su La Madonna (1987), fino a un’interessante edizione aggiornata, dieci anni dopo, La Madonna, dalla Donna alla Statua; cruciale è stato La sessualità maschile (1989) e il suo studio sulla Storia laica delle donne religiose (1995).
Insieme ai testi forse più conosciuti vi è stato l’impegno costante verso l’antropologia che ha percorso sempre con disinvoltura e originalità di posizioni. È suo il più generale manuale di Introduzione all’antropologia culturale (1983) così come si deve a lei la fondazione e direzione (dal 1989 al 1992) della rivista Antropologia culturale.
Il nodo sessualità-religione è stato per Magli uno dei più frequentati, là dove entrambi i punti sono stati sempre interpretati con una certa ritrosia anche nella discussione politica pubblica.
Ida Magli in realtà, come ricorda Lea Melandri, che abbiamo raggiunto per telefono, è stata precorritrice lucidissima di alcuni snodi fondamentali: «Certo, non si può leggere solo parzialmente, bisogna guardarla nel suo intero e in quanto è stata capace di offrirci alla lettura. È rimasta sempre abbastanza in disparte, ma il femminismo l’ha intersecato; forse non è stata così riconosciuta come avrebbe meritato, e molto ci possono raccontare ancora i suoi libri; vi sono per esempio frammenti folgoranti, coraggiosi che mettono in chiaro alcuni aspetti forti: sessualità, immaginario e fantasie maschili sui corpi delle donne e il grande nodo religioso». Melandri prosegue citando alcuni passaggi cruciali, per esempio quelli che attengono il corpo delle donne, la sessualità e il potere che disciplina i corpi fino a diventare violenza.
Su quest’ultimo punto, infatti, anche la stessa attenzione di Melandri si è soffermata. «Ho letto e riletto alcuni suoi frammenti perché penso ci siano preziosi. Non sono stati mai scontati e andrebbero ascoltati. Ma penso anche alla lezione sulla storia laica delle religiose, un lavoro straordinario che andrebbe accolto con maggiore generosità».
Addio al Padre *
"[...] Abbiamo ricostruito questo percorso per mostrare chiaramente come oggi non vi sia più spazio non soltanto per il cristianesimo, ma per tutti i valori che in questi duemila anni hanno concorso alla formazione e allo sviluppo della civiltà europea. Per quanto forse i credenti cristiani non se ne rendano del tutto conto, non può sussistere una religione fondata su un Dio «Padre» laddove la figura del padre ha perso qualsiasi rilevanza e autorità. Come abbiamo ormai più volte detto, le religioni sono specchio e proiezione di ciò che pensano e che desiderano i popoli. L’immagine di un Dio-Padre è ormai priva di senso.
Non può sussistere una religione fondata sull’importanza del «Figlio» laddove la procreazione è considerata un fatto personale e gravoso e la società provvede gratuitamente ai numerosissimi aborti confermando così che vuole la propria morte. D’altra parte il figlio è ormai inutile per il padre in quanto non gli serve più a garantirne la sopravvivenza. Non serve né per l’al di là né per il di qua. Le dinastie, le successioni, le eredità sono state quasi del tutto abolite, oppure vengono significativamente caricate di tasse. Nessun genitore conta sui figli per la propria vecchiaia. Alla vita nell’aldilà è ormai quasi impossibile credere e di fatto gli uomini in Europa preferiscono non pensarci.
La dichiarazione di «morte cerebrale», i trapianti d’organi hanno tolto concretamente e simbolicamente ogni trascendenza alla morte, di cui il cadavere, fino a questa orrida decisione, sembrava racchiudere il mistero; per non parlare di ciò che il corpo era (o meglio «è», visto che il dogma non è stato abolito) nella teologia cristiana con la fede nella resurrezione dei corpi, inclusa nel Credo, alla quale però nessuno evidentemente pensa più.
Sembra quasi impossibile che vi sia stato un tempo (oggi appare lontanissimo ma in realtà si tratta soltanto di pochi anni fa) in cui gli uomini si toglievano il cappello davanti a un morto a onorarne, appunto, la sacralità. Tutto questo è stato voluto dallo Stato e dalla Chiesa in modo ossessivo, come se la realizzazione dei trapianti d’organi costituisse il centro del loro potere e dei loro desideri.
Ma il trapianto d’organi significa l’annullamento delle specifiche individualità (oltre che il consenso e la legittimazione dell’istinto sempre presente nell’uomo di sopravvivere uccidendo, mangiando l’altro); significa avvicinarsi concretamente a quella nuova forma di uguaglianza che, invece di affermare l’esistenza del singolo, afferma la sua non-forma, la sua mancanza d’identità, la sua integrazione nell’identico. Passaggio indispensabile per giungere ad annullare la differenza posta dalla natura con il Dna maschile e femminile, la differenza di genere, e affermare la «normalità» dell’omosessualità.
Non si può trarne che una sola conclusione: hanno voluto che l’omosessualità vincesse su tutto e su tutti. Ma il primato dell’omosessualità non sarebbe stato proponibile fin quando fosse stato in vigore non soltanto il primato del «padre», dei legami di parentela, dei legami di sangue, ma anche e soprattutto l’assoluta «differenza» del genere maschile e femminile, ossia la differenza per antonomasia. L’interscambiabilità dei corpi l’ha annientata. Dunque: nessun «Genere», nessuna «Paternità», nessun «Figlio», nessuna «Famiglia», nessuna «Società», nessun «Futuro».
Naturalmente questo significa che si vuole la fine non soltanto del cristianesimo, ma di tutta la civiltà e della società europea, la fine dei «bianchi». L’omosessualità è strumentale soltanto a questa fine e il suo primato sparirà insieme ai bianchi".
* Cfr. Ida Magli Dopo l’Occidente, Rizzoli, Milano, 2012.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA "PESTE"!!! LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA E’ ZOPPA E CIECA: IL FIGLIO HA PRESO IL POSTO DEL PADRE "GIUSEPPE" E DELLO STESSO "PADRE NOSTRO" ... E CONTINUA A "GIRARE" IL SUO FILM PRE-EVANGELICO PREFERITO, "IL PADRINO"!!!
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- ANDROLOGIA E STORIA. Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne (di Tiziana Plebani).20 settembre 2021, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA PSICOANALISI E PSICHIATRIA. UNA QUESTIONE DI DIGNITÀ DI LUNGA DURATA.... *
Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne
Violenza maschile. Alla povertà di un gesto, opporre visioni diverse. Non c’è mai una un’unica scelta
- [Foto] Roma, manifestazione contro i femminicidi del movimento "Non una di meno"
di Tiziana Plebani (il manifesto, 17.09.2021)
Una donna uccisa quasi ogni giorno. Ma spostiamo la visuale e guardiamo dall’altra parte: quasi ogni giorno un uomo uccide una donna. Viene da pensare che sia divenuto un gesto imitativo, un modello da seguire, orrendamente, assurdamente, forse inconsapevolmente, ma che, tuttavia, si è imposto nell’immaginario, nel ventaglio di comportamenti e reazioni.
Nel momento della fragilità, della crisi, della necessità di riprogrammarsi, bisogna fare la fatica di trovare una soluzione, una via di uscita. Questa scelta costa. C’è bisogno di silenzio, pena, sofferenza. Cosa fare? Quello che hanno fatto tanti, che ogni giorno viene ripetuto dai media, che è visto di continuo in televisione. È un gesto che si insinua nella testa, e nel momento del bisogno emerge automatico, l’hanno fatto altri. È come se ci fosse una strada maestra di risposta che azzera l’infinità di opzioni a disposizione dell’umano per risolvere un dramma personale.
Ricordo che anni fa, durante la crisi economica del 2008, assistemmo a un’altra di queste associazioni a catena, tragicamente automatiche: più di 1600 imprenditori si tolsero la vita. Cominciò uno di loro a suicidarsi e in poco tempo anche questo gesto venne ripetuto di continuo: una risposta cieca che pure in questo caso si era imposta come l’unica percorribile.
Certo, quegli uomini che ammazzano le donne hanno alle spalle una pratica violenta, tengono armi in casa, hanno coltivato una confidenza con il linguaggio dell’offesa che non si inventa da un giorno all’altro. Sono tutte morti annunciate, come sappiamo.
Che fare dunque? Suggerisco due piani di azione, uno nell’ambito comunicativo, l’altro che riguarda le strategie di prevenzione.
I media ripropongono la sequela di omicidi e purtroppo imprimono e sedimentano questa risposta. Non si tratta ovviamente di tacere questi crimini bensì di accompagnare la notizia con commenti e interpretazioni che innanzitutto smentiscano l’idea che si tratti di raptus, di accecamento istintuale, di rabbia (rimando a questo articolo).
Quasi tutti questi delitti, avvengono dopo episodi di minacce e di brutalità. E soprattutto, come ci insegna la storia delle emozioni, esistono stili di comportamento che emergono rispetto ad altri in alcuni momenti storici, e che in questo caso ci parlano di un deserto e non di un eccesso emozionale, di un analfabetismo dei sentimenti (di cui la nostra società attuale è afflitta), e di un appiattimento delle risorse individuali e collettive ai drammi e alle fatiche della vita.
Televisioni, social media, carta stampata dovrebbero insistere piuttosto sul ventaglio di risposte al disagio, proponendo storie finite in altro modo (che poi sono la stragrande maggioranza). Si deve comunicare la possibilità di uscire da quella che appare in maniera distorta come una strada maestra ma che è invece un vicolo cieco e orrendo.
Opporre alla povertà di un gesto la visione di un paesaggio molteplice e vasto, di scelte multiple, di percorsi attraversati da mille sentieri. Non c’è mai un’unica scelta.
L’altro piano riguarda l’azione preventiva. Si tratta a parer mio di riprendere le modalità con cui si è affrontata la protezione dei testimoni di mafia, ma mutando direzione. Invece che far subire alla donna minacciata e che ha denunciato lo stalking o peggio, l’allontanamento dalla sua casa, dal suo ambiente, dal lavoro e dalle sue reti personali, si vada a trasferire l’uomo violento in un’altra città e almeno in un’altra regione, possibilmente molto distante. E che abbia l’obbligo di firma, come i mafiosi, in modo che si possano controllare i suoi spostamenti.
Perché ciò che non dobbiamo permettere è che le conseguenze di un comportamento violento maschile vengano pagate in qualità di libertà personale femminile. Affinché queste donne non siano viste solo come vittime ma come soggetti autonomi che perseguono le loro scelte di vita.
L’autrice è storica e scrittrice
*
NOTA:
- "Oltre il vicolo cieco degli uomini che uccidono le donne" : "Una donna uccisa quasi ogni giorno. Ma spostiamo la visuale e guardiamo dall’altra parte: quasi ogni giorno un uomo uccide una donna (...)" (Tiziana Plebani, il manifesto, 17 settembre 2021).
QUASI OGNI GIORNO UN #UOMO UCCIDE UNA DONNA (ma chi l’addestrò per la vittoria?). Forse non è ora di svegliarsi dal sonno dogmatico e venir fuori dalla edipica tragedia della cosmoteandria e laica e religiosa?!
ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA. Per uscire dal manicomio di una storia segnata (e raccontata, come Brecht ben illustra)) da una andrologia di lunga durata, dall’inferno della tragedia (Edipo), e vedere Lucifero a "gambe in sù" (Inf. XXXIV, 92) o, diversamente, la testa di Oloferne tagliata da Giuditta (Botticelli), oggi, è necessario non solo un radicale capovolgimento di ottica, ma soprattutto prendere coscienza della necessità di uscire da dentro un campo antropologico con la bilancia rotta (tutte le relazioni dell’intera società senza più giustizia)) e smetterla di continuare a fare "un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata" (come già denunciato da Franca Ongaro Basaglia). O, contro l’evidenza di Dante Alighieri, ogni speranza è ormai solo un’illusione?! E la storia è finita?!
COSTITUZIONE ("BIBBIA CIVILE") ED EPISTEMOLOGIA "BIBLICA"! . Benché sulla questione antropologica (Kant, "Logica", 1800) abbia richiamato tutta la sua attenzione, l’idealismo materialistico (o il materialismo idealistico) l’ha "conservata e negata" ("superata") nella grande "Scienza della Logica" dello Spirito Assoluto di Hegel (Napoleone). Recentemente, Gregory Bateson, benché (come egli stesso dice in una conferenza del 1979) abbia "all’enima della Sfinge" dedicato "cinquant’anni" della sua "vita di antropologo", non è riuscito a venir fuori dall’orizzonte della tragedia e dalla città di Edipo ed è ritornato sulla strada del "sacro"!
("DIGNITÀ DELL’UOMO". Non per sminuire nessuno, ma per uscire dalla "preistoria" (K. Marx), è bene ricordare che il "Dio" a cui guarda Gregory Bateson, è ancora il dio dell’antico patto, quello dell’andrologia di Paolo di Tarso: il cap. XIII di "Dove gli angeli esitano" (Adelphi,1989) è titolato "Il dio che non si può beffare" e mette in citazione la frase di san Paolo: "Non vi fate illusioni: Dio non lo si può beffare" (Gal., VI, 7)!!!
DIGNITÀ. Che dire?! l’antropologa Ida Magli non ha solo scritto "La femmina dell’uomo" (Laterza, 1982) ma anche scritto il libro "SULLA DIGNITA’ DELLA DONNA"; il sottotitolo è "La violenza sulle donne, il pensiero di Wojtyla". Che dire?! Continuare nello Spirito di Napoleone, Hegel, Bateson, Costantino?! Dopo Dante2021?!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- FILOLOGIA, COSTITUZIONE E DIVINA COMMEDIA: EUTANASIA.21 agosto 2021, di Federico La Sala
EUTANASIA: #FILOLOGIA #COSTITUZIONE E #DIVINACOMMEDIA.
Per una filosofia dell’#avvenire del pianeta (e non solo dell’Italia), sperando in "un clima di #dialogo costruttivo, di rispetto reciproco e non di scontro senza limiti" (Giovanni Maria Flick), forse, è bene
chiarire che
#EUTANASIA ("eu-tanasia") vale letteralmente "buona-morte", come
#EVANGELO ("ev-angelo" -"eu-angelo") vale letteralmente "buon-messaggio"), e non "#vangèlo" ("van-gèlo"), messaggio per andare nel #gèlo ("la ghiaccia") eterno!
Ricordando che il nostro presente storico è quello di #Dante2021 (proprio grazie al signor #DanteAlighieri del 1321 e alla sua #Monarchia dei #duesoli), dopo aver visto #Lucifero con le gambe all’aria (Inf. XXXIV), non è meglio uscire dall’#Inferno e, con l’aiuto di Beatrice (Maria e Lucia) e Virgilio e san #Bernardo (san #Giuseppe) andare avanti, in #Purgatorio e #Paradiso (Par. XXXIII, v. 145)? E uscire dal tragico orizzonte del generale planetario "cosmoteandrismo" laico e religioso?! E ripensare e riformulare (senza trucchi e senza inganni) lo stesso principio di carità?! O no?! Boh e bah!?
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Conquistadores, la storia di un grande «desencuentro»: Tenochtitlan 13 agosto 1521. C’è ancora tempo per un’altra modalità di relazione con l’alterità? (di Lucia Capuzzi).5 agosto 2021, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE... *
Tenochtitlan 13 agosto 1521. Conquistadores, la storia di un grande «desencuentro»
Forse quella dell’America non fu né scoperta né conquista, ma incontro mancato. C’è ancora tempo per un’altra modalità di relazione con l’alterità?
di Lucia Capuzzi (Avvenire, giovedì 5 agosto 2021)
- [Foto] “La conquista di Tenochtitlan”, dipinto anonimo del XVII secolo della serie “La conquista del Messico” conservata presso la Biblioteca del Congresso - Library of Congress/WikiCommons
«Il sole si alza dal tuo letto di ossa [...]. L’alba lacera la cortina. Città, pila di parole rotte». Cinquecento anni dopo la sconfitta dell’impero azteca con la caduta di Tenochtitlan, la lacerante attualità dei versi di Octavio Paz vibra nel corpo giunonico di Città del Messico. Un organismo vivente più che una città. La spugnosa carne coloniale copre viscere dell’antica capitale precolombiana, per essere a sua volta ricoperta da una sottile pelle ultra-moderna. Gli strati coesistono, a volte confliggono, sempre si alimentano a vicenda. In questo flusso incessante, la megalopoli palpita, respira, sussiste. Impossibile separarli senza ucciderla. Una consapevolezza che, però, la città è incapace di tradurre in parole, come dimostra la polarizzazione delle narrative per l’anniversario. Perché implica fare i conti con l’evento che l’ha generata. E che, in fondo, ha generato l’America Latina.
Più ancora del 12 ottobre 1492, fu l’entrata a Tenochtitlan dei conquistadores al seguito di Hernán Cortés a segnare la nascita del mondo nuovo. E con esso il principio dell’età moderna. Fu “scoperta” o fu “conquista”? Fu incontro o fu scontro? Di sicuro, come afferma Tzvetan Todorov, fu l’esperienza più radicale, estrema, intensa di «scoprimento dell’altro». A differenza degli africani o degli asiatici, gli indo-americani e la loro esistenza erano del tutto ignorati dagli europei. Il confronto, dunque, fu di forza inedita. Mai come allora, gli uni e gli altri dovettero affrontare dei “simili diversi”.
Quel 13 agosto 1521 diviene, dunque, in un certo senso, il “parto” - per parafrasare Amalia Podetti - del globo, inteso come totalità. E del nostro tempo. Con tutte le sue contraddizioni. Non per niente, secondo Todorov, nel XVI secolo si è perpetrato il più grande genocidio della storia umana. Il massacro fu inaudito, questo è incontestabile. La sua definizione aritmetica, invece, è oggetto di dibattito tra gli studiosi ma tutti parlano di decine di milioni di esseri umani ingoiati in un vortice di violenza, schiavitù, epidemie. Magari una simile proporzione non fu voluta e intenzionale. Magari la leggenda nera anglobritannica - non proprio neutrale e benintenzionata - ha esagerato dettagli e crudeltà. Magari numerosi leader politici hanno cavalcato e cavalcano la strage per opportunismo. In questo, l’enfasi posta dal presidente Andrés Manuel López Obrador sul cinquecentesimo come sconfitta dei «veri messicani» è emblematica. Peccato che il Messico è - nel bene e nel male - è figlio di Cortés quanto di Monteczuma. Non sono, tuttavia, gli intenti, più o meno raffinati, di minimizzazione ad accelerare l’uscita dall’impasse.
Oltre che oggetto di studio, la mattanza d’America è soggetto di una storia di dolore, impressa, tuttora, nella carne e nel sangue dei discendenti dei nativi. Per costoro gli abusi antichi non sono che l’eco di quelli presenti, poiché la discriminazione e il rifiuto non sono terminati con la colonizzazione né con l’indipendenza né con le rivoluzioni e controrivoluzioni del secolo scorso. Per questo, gli occhi degli attuali maya si sono velati di lacrime nell’ascoltare papa Francesco affermare, a San Cristóbal de las Casas, il 15 febbraio 2016: «Perdono, fratelli! Il mondo di oggi, spogliato dalla cultura dello scarto, ha bisogno di voi!». Curiosa, dunque, l’ostinata richiesta di López Obrador nel domandare delle “scuse” già fatte senza alcuna sollecitazione. Farsi carico della memoria ferita è la grande occasione offerta dall’anniversario. Non solo per riconciliare il passato. In fondo, cinque secoli dopo, l’essere umano si trova di fronte ancora l’enigma di Cortés. Esiste l’uguaglianza al di fuori dell’identità? C’è spazio per una differenza che non implichi la subordinazione? La distruzione di Tenochtitlan ci ha mostrato le conseguenze di una risposta negativa, come quella del conquistador.
Forse, più che scoperta o conquista, quella d’America fu un grande desencuentro, un incontro mancato. Eppure non è l’unica alternativa. Desencuentro, intraducibile in italiano come unica parola, contiene in se la dimensione dell’encuentro, l’incontro. Anche questo ci ha mostrato la storia del Continente. Dieci anni dopo la devastazione dell’impero azteca, non lontano dalle ceneri ancora fumanti di Tenochtitlan, a Tepeyac, una Madonna dalle fattezze indigene scelse il nativo Juan Diego come proprio testimone. Nello sguardo non assimilativo della Morenita si intuisce un’altra modalità di relazione possibile con l’alterità.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: «Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo» (Gal 1,11); "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- DANTE 2021: DOPO MARX, NIETZSCHE, E FREUD, "L’UOMO" CELEBRA ANCORA LA "DOTTA IGNORANZA" DELL’ORIZZONTE DELLA "TRAGEDIA".10 luglio 2021, di Federico La Sala
#COSTITUZIONE
#EDUCAZIONE CIVICA
#TRAGEDIA
E
#DIVINA COMMEDIA
#oggi.
Dopo #Dante (1321)
e la #rivoluzione delle #sfere celesti
(#Copernico 1543)
e terrestri
(#Giovanni Valverde, #Anatomia 1560),
celebra ancora la
#dotta ignoranza
di
Socrate
e
Niccolò Cusano
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- DANTE 2021: DOPO MARX, NIETZSCHE, E FREUD, "L’UOMO" CELEBRA ANCORA "IL GIOCO DELLA PALLA" SECONDO LE REGOLE DELLA "TRAGEDIA".10 luglio 2021, di Federico La Sala
"IL GIOCO DELLA PALLA", SECONDO LA LOGICA "ANDROLOGICA" DEL CATTOLICESIMO-COSTANTINIANO...:
- "Dico che questo gioco esprime il movimento della nostra anima che va dal suo regno al regno della vita in cui è la quiete e la felicità eterna. Nel centro di questo regno siede, come monarca, Gesù Cristo, nostro re, che ci ha donato la vita. In quanto è simile a noi, egli muove la sfera della sua persona in modo da riposare nel centro della vita. Poiché egli ci ha lasciato il suo esempio, facciamo come egli ha fatto. La nostra palla segua la sua, anche se è impossibile che una palla diversa raggiunga la quiete nel medesimo centro di vita in cui riposa la palla di Cristo. Dentro il circolo ci sono, infatti, infiniti luoghi e fermate. La palla di ognuno si ferma nel punto e nell’atomo suo proprio che nessun altro potrà mai raggiungere"(Niccolò Cusano, Opere filosofiche, Torino, Utet, 1972).
#DANTE2021
E
#ANTROPOLOGIA (#HOMO LUDENS):
IL #GIOCO DELLA #PALLA
(#De ludo globi) DI
#NICCOLO’ CUSANO
riguarda «un gioco scoperto da poco che tutti comprendono facilmente e giocano volentieri»
E
LA #DOCTA IGNORANTIA
-
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- MAGISTERO ANTROPOLOGICO E COSTITUZIONE: LA "DIVINA COMMEDIA" E LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI".2 luglio 2021, di Federico La Sala
#COSTITUZIONE:
#BIBBIA CIVILE
E
#MAGISTERO ANTROPOLOGICO:
#COME NASCONO I BAMBINI?
#Divina Commedia:
#Dante2021.
se #Maria è #madre e #maestra.. #Giuseppe non è #padre e #maestro?!
Per un’altra #fenomenologiadellospirito:
IO, dall’#AMORE di #Due IO.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- LIBERTA E NATALITA’. IL MIRACOLO CHE SALVA IL MONDO: HANNAH ARENDT E I DATI DELL’ISTAT.2 luglio 2021, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA. COME NASCONO I BAMBINI...*
- HANNAH ARENDT E IL PROBLEMA DELL’INIZIO, DELLA NASCITA: "Nella grande opera sulla Città di Dio Agostino enuncia, senza però darne spiegazione, ciò che avrebbe potuto divenire il sostegno ontologico di una filosofia della politica autenticamente romana o virgiliana. A suo dire, come sappiamo, Dio creò l’uomo come creatura temporale, homo temporalis; il tempo e l’uomo furono creati insieme, e tale temporalità era confermata dal fatto che ogni uomo deve la sua vita non semplicemente alla moltiplicazione della specie, ma alla nascita, l’ingresso di una creatura nuova che, come qualcosa di completamente nuovo, fa il suo ingresso nel mezzo del continuum temporale del mondo. Lo scopo della creazione dell’uomo fu di rendere possibile un inizio: «Acciocché vi fosse un inizio, fu creato l’uomo, prima del quale non ci fu nessuno», «Initium ... ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit» (Agostino, De civitate Dei, libro XII, cap. 21). La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità e non certo nella creatività, non in una dote o in un dono, ma nel fatto che gli esseri umani, uomini nuovi, sempre e sempre di nuovo appaiono nel mondo in virtù della nascita" (H. ARENDT, La vita della mente, Bologna 1987, p. 546).
È la nostra nascita il miracolo che salva il mondo
Quella postilla di Hannah Arendt che illumina i dati Istat sulla natalità
di Sergio Belardinelli (il Foglio, 24 apr 2021)
L’Istat ci ha comunicato di recente che, complice anche il Covid, in Italia nel 2020 i morti sono stati 746 mila e i nuovi nati 404 mila. Un dato agghiacciante nel suo significato sociale e culturale che a me, come una sorta di riflesso condizionato, richiama alla mente uno dei brani filosofici più intensi che abbia mai letto: “Il miracolo che salva il mondo, il dominio delle faccende umane dalla sua normale, naturale rovina è in definitiva il fatto della natalità in cui è ontologicamente radicata la facoltà dell’azione. È in altre parole la nascita di nuovi uomini, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana, che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo, che trova forse la sua gloriosa e stringata espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’avvento: ‘un bambino è nato per noi’”.
Con queste parole Hannah Arendt conclude il capitolo di Vita Activa dedicato all’azione. Si tratta di un brano che cito e commento ormai da quarant’anni, nel quale viene messo a tema un nesso, quello tra la libertà e la natalità, tra la libertà e la vita, col quale, che io sappia, soltanto la Arendt ha avuto l’acutezza e il coraggio di cimentarsi e che, a prima vista, può apparire persino paradossale. La vita infatti, almeno immediatamente, sembra richiamare non tanto la libertà, quanto piuttosto il gigantesco, immutabile ripetersi dei cicli naturali, l’ambito di quelli che il grande biologo Adolf Portmann, autore peraltro assai caro alla Arendt, definirebbe i “rapporti preordinati” - il contrario, quindi, di ciò che in genere intendiamo allorché parliamo di libertà. Quanto poi alla vita specificamente umana, essa, è certo impastata di libertà, ma è anche qualcosa che, a diversi livelli, non dipende da noi, qualcosa di cui, nonostante le tecnologie della riproduzione, non possiamo avere il completo controllo: la riceviamo semplicemente; non scegliamo i nostri genitori, né il luogo dove venire al mondo; dobbiamo fare continuamente i conti con gli altri, con le nostre passioni, i nostri istinti, le nostre inclinazioni, con quel coacervo di natura, ragione, sentimenti, usi e costumi che vanno a costituire appunto il “gran mare” della vita. La vita insomma pone una serie di condizioni e condizionamenti alla libertà che possono renderla persino impossibile. Eppure, rompendo in un certo senso questa grande catena, è proprio la libertà che dà sapore e specificità alla vita umana; solo la libertà impedisce che il mondo si riduca spinozianamente a “sostanza”, a qualcosa di omogeneo, a qualcosa come un continuo fluire; solo la libertà è capace di introdurre nel mondo un elemento di novità, qualcosa di imprevisto.
Pensieri non nuovi, si potrebbe dire. Ma proprio qui si inserisce la fondamentale postilla arendtiana, preziosa per leggere in una chiave forse inusuale ma certo illuminante anche i dati Istat sulla natalità in Italia da cui siamo partiti: è la stessa vita umana, il nostro venire al mondo, la nascita unica e irripetibile di ciascuno di noi, a rappresentare la prima e più immediata forma di novità, il primo scompaginamento, se così si può dire, della routine della vita.
La facoltà dell’azione, dice la Arendt, “è ontologicamente radicata” nel “fatto della natalità”. In entrambe le dimensioni - la libertà e la natalità - ritroviamo non a caso una costitutiva “novità”, un costitutivo essere insieme agli altri (non si nasce, né si agisce da soli), qualcosa che implica l’accettazione della realtà nella quale siamo e insieme fiducia nel futuro. In questo senso ogni bambino che nasce è un segno di speranza nel mondo; è l’irruzione nel mondo di una “novità”, la cui memoria, è il caso di dire, ritroviamo da adulti nell’esercizio della nostra libertà, nella nostra capacità di incominciare qualcosa che senza di noi non incomincerebbe mai.
Novità, pluralità (gli uomini, non l’uomo abitano la terra, ripete spesso Hannah Arendt) e speranza: questo ci schiude direttamente e in modo straordinario il discorso arendtiano sulla libertà radicata nella natalità. Ma indirettamente, specialmente oggi, tale discorso ci schiude molto di più. Ci fa capire, ad esempio, quale tragedia, anche simbolica, si consuma nel momento in cui un paese come l’Italia registra in un anno un saldo passivo tra morti e nuovi nati di 342 mila unità. È un po’ come se il mondo e la nostra libertà perdessero la speranza, ossia ciò che dà loro sapore, ciò che è insieme accettazione della realtà nella quale viviamo e fiducia nel futuro.
È vero, tutto passa. La vita non è altro che un eterno dissolversi nel gigantesco circolo della natura dove, propriamente, non esiste inizio né fine e dove tutte le cose e gli eventi si svolgono in un’immutabile ripetizione: la mors immortalis di cui parlava Lucrezio. Ma la Arendt non accetta questa mestizia, poiché a suo avviso “la nascita e la morte di esseri umani non sono semplici eventi naturali”; avvengono in un mondo dove vivono altri uomini; un mondo che acquista significato grazie alle loro azioni e ai loro discorsi; un mondo che per questo è sempre aperto alla novità.
Con la creazione dell’uomo, dice la Arendt, “il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo, naturalmente è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo”. Di nuovo l’inizio, dunque, diciamo pure, la natalità.
È proprio perché, in quanto uomini, siamo initium, nuovi venuti, iniziatori, per virtù di nascita che secondo la Arendt, siamo indotti ad agire. La definizione che più si addice agli uomini non è quella di “mortali”, ma piuttosto quella di “coloro che nascono”. In questo modo, quasi per una sottile ironia della sorte, la categoria della natalità diventa fondamentale proprio nel pensiero di un’allieva (e anche qualcosa di più) di Martin Heidegger, l’inventore dell’essere per la morte. Non che la Arendt ovviamente trascuri che la morte rappresenta l’ineluttabile fine di ogni vita umana, solo che, a suo avviso, gli uomini, anche se debbono morire, non nascono per questo, bensì per incominciare. E siamo di nuovo al passo da cui siamo partiti: “Il miracolo che salva il mondo....”.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI. --- "ESSERE E TEMPO" E FILOLOGIA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907 - con una nota introduttiva
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- USCIRE DALL’ORIZZONTE DELLA TRAGEDIA: IL MATRIMONIO FORZATO. Il Viminale ha pubblicato il primo rapporto sulle donne costrette a un’unione che non vogliono (di Silvia Guzzetti).29 giugno 2021, di Federico La Sala
Report . Ventiquattro matrimoni forzati in due anni. Un terzo ha coinvolto minorenni
Il Viminale ha pubblicato il primo rapporto sulle donne costrette a un’unione che non vogliono. Nove casi si sono verificati nei soli primi cinque mesi di quest’anno. In tante come Saman Abbas
di Silvia Guzzetti (Avvenire, lunedì 28 giugno 2021)
- [Foto] Saman Abbas la diciottenne di Novellara scomparsa dopo che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato - Ansa
Quante sono le Saman in Italia? Ovvero quante ragazze sono costrette a matrimoni forzati o uccise perché non vogliono accettarli? È questa una delle domande alle quali cerca di rispondere il primo "Report sulla costrizione o induzione al matrimonio in Italia", curato dal Viminale, secondo il quale dal 9 agosto 2019 al 31 maggio 2021 sono 24 i casi di matrimoni forzati registrati nel nostro Paese, 9 dei quali nei soli primi cinque mesi di quest’anno. È proprio al 9 agosto 2019, infatti, che risale l’entrata in vigore del "Codice rosso", che ha introdotto uno specifico reato con lo scopo di contrastare proprio il fenomeno delle "spose bambine",
Dietro la definizione un po’ arida di "matrimonio precoce" come di una "unione formale nella quale viene coinvolto un minorenne, considerato forzato se quest’ultimo non è in grado di esprimere compiutamente e consapevolmente il proprio consenso non solo per le responsabilità che ci si assume con quell’atto ma anche per il fatto che la sua età le impedisce il raggiungimento della piena maturità e capacità di agire", che è contenuta nel rapporto del Viminale, vi sono anche tante storie tragiche simili a quella di Saman Abbas. La diciottenne, di origine pakistana, abitante a Novellara, è scomparsa dalla fine di aprile e gli inquirenti, che stanno indagando per omicidio e occultamento di cadavere il padre e la madre della ragazza, sospettano che sia stata la famiglia a ucciderla e farla scomparire.
LA SCOMPARSA DI SAMAN
Saman è stata vista per l’ultima volta l’11 aprile quando si è allontanta dal centro protetto nei pressi di Bologna dove viveva dallo scorso dicembre. Aveva voluto tornare a casa sua, forse per prendere alcuni documenti, e non ha più fatto ritorno. Agli assistenti sociali che la stavano seguendo e le avevano garantito un rifugio lontano dall’ambiente oppressivo della sua famiglia, aveva raccontato che i genitori volevano costringerla a un matrimonio forzato con un cugino residente in Pakistan. Papà e mamma non riuscivano a perdonare alla figlia di volersi costruire un futuro diverso che comprendesse andare a scuola, viaggiare, lavorare. Le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nei pressi dell’azienda in cui lavorava il padre della ragazza mostrano, la sera del 29 aprile, tre persone provviste di un secchio, un sacco nero per la spazzatura e una pala dirigersi verso il campo che circonda l’abitazione di Saman.
CHE COS’E’ IL MATRIMONIO FORZATO
Storie simili vengono suggerite dalle parole usate dal Report del Viminale. "Il fenomeno del matrimonio forzato ha radici storiche, culturali e talvolta religiose. L’emersione di questo reato non è facile perché spesso si consuma tra le mura domestiche e le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, costrette ad abbandonare la scuola, talvolta obbligate a rimanere chiuse in casa nell’impossibilità di denunciare anche per paura di ritorsioni".
È sempre il Report ad ammettere che "i dati, inevitabilmente, fotografano una situazione sottodimensionata rispetto a quella reale".
Insomma le statistiche senz’altro sottostimano l’incidenza di questo reato. Il rapporto, che è stato curato dalla direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, parla di un 85% dei reati, sempre tra agosto di due anni fa e maggio scorso, riguardanti donne. In un terzo dei casi le vittime sono minorenni (il 9% hanno meno di 14 anni e il 27% hanno tra i 14 e i 17 anni). Ci sono poi le straniere, che sono il 59%, in maggioranza pachistane, seguite dalle albanesi mentre per Romania, Nigeria, Croazia, India, Polonia e Bangladesh si registra una sola vittima.
Nel 73% dei casi gli autori del reato sono stati uomini, anche in questo caso più frequentemente pachistani, seguiti da albanesi, bengalesi e bosniaci. Nel 40% dei casi i responsabili erano di età compresa tra 35 e 44 anni mentre il 27% aveva tra 45 e 54 anni. Il 15% aveva tra 25 e 34 anni.
LA PANDEMIA HA PEGGIORATO LA SITUAZIONE
Sempre il Report del Viminale getta anche uno sguardo globale su questo fenomeno, ricordando che, nel 2020, per effetto delle conseguenze economiche della pandemia, per la prima volta, dopo anni di progressi, si è registrato un peggioramento dell’incidenza dei matrimoni forzati che stanno coinvolgendo molte adolescenti, soprattutto nell’Asia meridionale, nell’Africa centrale e nell’America Latina.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- LA DERIVA STRUTTURALE. Humberto Maturana e la vita che scorre (di Pietro Barbetta - "Doppiozero"). )18 maggio 2021, di Federico La Sala
Humberto Maturana e la vita che scorre
di Pietro Barbetta (Doppiozero, 15.05.2021)
Chi era Humberto Maturana? Uno studioso particolare. Uno scienziato vero, lontano dalle pratiche “evidence based”, coltivate dagli odierni carrieristi. Un biologo, uno psicologo e un epistemologo; creatore di nuove lenti per osservare la natura e non solo, anche la mente e la società.
Uno di quegli epistemologi che traggono le proprie riflessioni dalle pratiche scientifiche che elaborano e dalle esperienze che creano, in laboratorio e attraverso l’osservazione della vita e dei suoi percorsi, negli organismi viventi, nei soggetti e nelle comunità.
Assieme a una vasta schiera di longevi - Gadamer, Ricoeur, Dorfles, Morin, che ancora vive a cent’anni, von Foerster e molti altri - Maturana è uno dei saggi della cultura occidentale. Ma è anche, insieme a Francisco Varela - suo allievo, morto prematuramente - un autore che ha pensato al legame profondo tra il corpo, la mente e le loro affezioni, uno Spinoza contemporaneo.
Autopoiesi
Autopoiesi e cognizione, l’opera chiave della sua vita, scritta con Francisco Varela, fu per noi, negli anni Ottanta, una lettura difficile: eravamo immersi nella cultura umanistica - letteratura, filosofia, psicologia e antropologia - e, allora, c’era una scissione radicale tra umanisti e scienziati naturali. Era una grande fatica comprendere il linguaggio di biologi che erano, al contempo, epistemologi.
Vado a memoria, senza citare con precisione, ma ricordo bene alcune frasi di difficile comprensione per noi: l’orientante orienta l’orientato nel dominio cognitivo dell’orientato; i sistemi sono strutturalmente aperti, ma organizzativamente chiusi. Lo stesso per alcuni concetti: deriva strutturale, autopoiesi, accoppiamento strutturale, cibernetica, cibernetica del second’ordine, ecc. Alcune parole sembravano ingegneristiche, altre legate agli studi sulla comunicazione, poi c’era questa “cibernetica”, la scienza dei nocchieri, infine il passaggio alla cibernetica del second’ordine.
Di che si trattava?
Cibernetica
La cibernetica nasce da Norbert Wiener e riguarda la creazione di dispositivi meccanici con retroazione. Significa che questi maccanismi ricevono informazioni dall’ambiente che li regola. Il classico esempio è il termostato, il feed-back è quello strumento che permette ai termostati di autoregolarsi verso una temperatura definita. All’inizio, per noi intellettuali umanisti, era quasi un’offesa: come si permettono costoro di parlare, a noi filosofi, di termostati? In realtà già Gregory Bateson, antropologo e cibernetico, su richiesta di Wiener, era riuscito a pensare, attraverso la cibernetica, una “macchina schizofrenica”. La macchina schizofrenica è una macchina che non rispetta i livelli logici. Usando quella macchina io posso collegarmi con un ipotetico fornitore designato come numero 135, per esempio, e chiedere numero 425 “maiali porto franco”.
La macchina si disconnette dal fornitore 135 e si connette con il fornitore 425.
In altri termini, la macchina mi confonde, mi impedisce di ottenere la soddisfazione del mio bisogno di “maiali porto franco”. In pratica, una macchina schizofrenica non può soddisfare i miri bisogni, è una macchina desiderante, priva di soluzione.
Anni dopo Gilles Deleuze e Felix Guattari fonderanno la schizo-analisi attraverso il concetto di inconscio come macchina desiderante, ispirandosi esplicitamente proprio alle riflessioni di Gregory Bateson.
Cibernetica del second’ordine
Di qui, per Maturana e altri, una riflessione sulla complessità, che dà vita alla cibernetica del second’ordine.
La cibernetica del second’ordine fornisce due principali considerazioni che cambiano in maniera radicale la scienza: innanzitutto l’osservazione delle relazioni e delle connessioni tra le cose, tra gli organismi, tra i soggetti, piuttosto che l’osservazione delle cose, degli organismi e dei soggetti, come enti isolati; in secondo luogo l’attenzione per le connessioni tra chi osserva le relazioni e le descrizioni che fornisce l’osservatore. Non possiamo non pensare a un altro grande autore francese che, in campo storico, fece la stessa operazione intellettuale chiamandola “metodo genealogico”: Michel Foucault.
Amore
Maturana scrisse con Francisco Varela diversi testi, eppure i due autori, fin dall’inizio, non avevano le stesse posizioni, la diversità fu una risorsa, pensavano la complessità, che è in primo luogo, appunto, differenza. L’amore era uno dei temi che li vedeva divergere.
Varela focalizza i suoi studi sperimentali sul tema dell’embodiment, che in italiano viene tradotto con mente incarnata, anche se sarebbe più preciso tradurre “incorporazione”. In questo senso Varela si avvicina ad autori come Gilbert Simondon, Bruno Latour, Bernard Stiegler: l’amore è, per Varela, una manifestazione corporea del campo affettivo.
Maturana invece sviluppa il tema dell’amore come collante nelle relazioni bio-psico-sociali. La psicopatologia potrebbe essere intesa come “corruzione dell’amore”, avvicinandoci al pensiero di Niklas Luhmann (in particolare al saggio L’amore come passione).
Per questo Maturana e Varela furono tra i grandi esponenti della “scienza romantica”, così definita da Alexander Lurjia e ripresa da Oliver Sacks.
Un amico
Ho incontrato varie volte Maturana, negli Stati Uniti, alle conferenze dell’American Society for Cybernetics e in Italia. L’ultima volta fu durante un convegno nell’ambito dell’Esposizione Universale, al padiglione del Cile, nel 2015. Venne a tenere un seminario con Ximena Davila.
 In quell’occasione, Maturana invitò il Centro Milanese di Terapia della Famiglia a un confronto, come era accaduto altre volte. Fu una mattina molto particolare, il suo rapporto con i colleghi italiani era disponibile e dolce, mentre negli Stati Uniti, davanti al pubblico, era decisamente più freddo. Forse non aveva chiuso i conti con quel paese che lo aveva ospitato, ma che aveva, attraverso il suo governo, portato al potere la dittatura di Pinochet.
In quell’occasione, Maturana invitò il Centro Milanese di Terapia della Famiglia a un confronto, come era accaduto altre volte. Fu una mattina molto particolare, il suo rapporto con i colleghi italiani era disponibile e dolce, mentre negli Stati Uniti, davanti al pubblico, era decisamente più freddo. Forse non aveva chiuso i conti con quel paese che lo aveva ospitato, ma che aveva, attraverso il suo governo, portato al potere la dittatura di Pinochet.Si racconta di lui che, durante il regime di Pinochet, prima di salvarsi riuscendo ad andare all’estero, fosse stato interrogato perché gli trovarono in casa opere di Marx. Lui rispose che si meravigliava di chi lo interrogava: criticavano Marx senza conoscerlo? Pare che, gli aguzzini, ignoranti e confusi, lo avessero rilasciato momentaneamente, ciò gli permise la fuga dalla sua culla, Santiago, dove era nato il 14 settembre del 1928.
Incontrai Maturana altre volte, per esempio, nel 2002, a un convegno a Torino per commemorare la scomparsa di un altro grande ispiratore della cibernetica del second’ordine: Heinz von Foerster.
In quell’occasione, quasi vent’anni fa, durante la parte della discussione con il pubblico, gli chiesi di spigarmi il concetto di “deriva strutturale”, che non avevo compreso. Lui rispose più o meno così: immaginate di essere su una barca in mezzo al mare e di avere perso i remi. Possedete solo una bussola e una ricetrasmittente. Chiamate, con la trasmittente, il faro più vicino per avere soccorso. Il faro chiederà la vostra esatta posizione per inviarvi una nave da salvataggio. La barca giunge sul posto, ma voi sarete da un’altra parte. La deriva strutturale è la vita che scorre.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD"."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- L’ABC DI WITTGENSTEIN. La dignità di un pensiero è data dal suo coraggio e dal coraggio che sa infondere. Il resto è vanità (di Federico Ferrari))..17 aprile 2021, di Federico La Sala
Del coraggio. L’abc di Wittgenstein
di Federico Ferrari *
- “Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri.
- Alcuni costano molto altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri?
- Credo con il coraggio.”
- Ludwig Wittgenstein
Pensare significa avere coraggio. Affrontare le proprie paure, il proprio fondo di inautenticità. Non farsi mai sconti e, indifferenti al quieto vivere, non farli nemmeno agli altri. C’è della crudeltà nel coraggio, una forma di doloroso accanimento. L’impossibilità di tacere, di non dire esattamente quel che va detto, costi quel che costi. Il coraggio si paga. Rovina i rapporti umani. Spinge nella solitudine. Ma il coraggio ci rende un po’ meno pagliacci di quel che naturalmente siamo. Ci offre l’opportunità di diventare uomini e donne decenti - ein anständiger Mensch, scrive Wittgenstein, concependo il pensiero come un impietoso autosmascheramento. Il coraggio e la decenza sono due facce di una medesima medaglia. L’indecenza di ogni tempo nasce dalla mancanza di coraggio. Politici senza coraggio, intellettuali senza coraggio, uomini senza coraggio: la fine di una civiltà.
Poco importa se la lotta coraggiosa per difendere la propria dignità, le proprie idee, la propria esistenza non porterà a nulla, non cambierà il mondo. Il mondo non cambierà mai davvero. Il mondo è solo l’eterno confronto e scontro tra pavidi e coraggiosi. Tra coloro che salgono sul carro dei vincitori, in cerca di consenso, e coloro che percorrono il tempo sempre controvento, in cerca di se stessi. Questo scontro avviene in ogni luogo, in ogni momento e sempre, anche, in noi stessi.
La cosa più difficile non è essere all’altezza del mondo, ma all’altezza di se stessi. E’ abbastanza semplice non deludere gli altri. Molto più complesso non deludere se stessi. Pensare, dire, a volte, tacere coraggiosamente è un modo di darsi dignità, un modo di riconoscere la propria irripetibile unicità.
La dignità di un pensiero è data dal suo coraggio e dal coraggio che sa infondere. Il resto è vanità.
Questo testo è solo un eco (e un ricordo riconoscente) della prefazione di Aldo G. Gargani ai Diari segreti di Ludwig Wittgenstein (Laterza, 1987), letti molti anni fa e mai dimenticati.
* Fonte: Antinomie, 24/11/2020 (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- WITTGENSTEIN E "IL MISTERO PROFONDO": UNA QUESTIONE TUTTA DA RIAPRIRE, SUL FILO DELL’ARCHIVIO RITROVATO.
NUOVO REALISMO E "GAIA SCIENZA": LA LEZIONE DI DANTE (E NIETZSCHE), OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- UNA DOMANDA SULL ’ORDINAMENTO DEL MONDO (di Anne Frank - 13 giugno 1944).10 aprile 2021, di Federico La Sala
UNA LETTERA DI ANNE FRANK (13 GIUGNO 1944) *
Carissima Kitty,
[...] piú volte mi sono posta una di quelle domande che non mi danno pace, e cioè perché un tempo, e spesso anche adesso, la donna nei popoli occupa un posto molto meno importante rispetto all’uomo. Chiunque può dire che è ingiusto, ma a me non basta, vorrei tanto conoscere il motivo di questa grande ingiustizia!
Si può immaginare che l’uomo, fisicamente piú forte, fin dall’inizio abbia avuto una posizione di supremazia rispetto alla donna; l’uorno che guadagna, che genera i figli, l’uomo che può tutto... È già stato abbastartza stupido da parte di tutte quelle donne che fino a poco tempo fa hanno permesso che fosse cosí senza protestare, perché quanti piú secoli questa regola ha resistito, tanto piú ha preso piede. Per fortuna la scuola, il lavoro e il progresso hanno un po’ aperto gli occhi alle donne, In molti paesi le donne hanno ottenuto gli stessi diritti degli uomini; molte persone, soprattutto donne, ma anche uomini, adesso capiscono quanto questa suddivisione fosse sbagliata e le donne moderne vogliono avere il diritto all’indipendenza totale!
Ma non è solo questo, è il rispetto della donna, quello che manca! In tutto il mondo l’uomo viene rispettato, perché non si può dire lo stesso della donna? Soldati ed eroi di guerra vengono onorati e festeggiati, gli scopritori hanno fama immortale, i martiri vengono osannati, ma di tutta l’umanità, quanti considerano la donna anche come un soldato?
Nel libro Guerrieri per la vita c’è scritta una cosa che mi ha molto colpita, e cioè piú o meno che le donne in generale già soltanto per i parti soffrono piú di qualsiasi eroe di guerra. E quale successo spetta alla donna, dopo avere sofferto tanto? Viene spinta in un angolo quando è sformata dalla gravidanza, i figli ben presto non sono piú suoi, la bellezza svanisce. Le donne sono molto piú stoiche, sono soldati piú coraggiosi che lottano e soffrono per la sopravvivenza dell’umanirà molto piú di tanti eroi che non sanno fare altro che vantarsi!
Con questo non voglio affatto dire che le donne debbano rifiurarsi di mettere al mondo bambini, anzi, cosí è per natura, e cosí è giusto che sia. Condanno solo gli uomini e tutto l’ordinamemo del mondo che non ha mai voluto rendersi conto del grande, pesante ma d’altronde anche bel fardello che la donna porta nella società.
Paul de Kruif, lo scrittore del libro sopraccitato, ha tutta la mia approvazione quando dice che gli uomini devono imparare che la nascita ha cessato di essere un fatto narurale e normale in tutte quelle zone del mondo che vengono definite civilizzate. Hanno un bel dire, gli uomini! Non hanno mai sopportato, né mai sopporteranno, le pene che toccano alle donne!
Secondo me il concetto che sia dovere della donna avere figli nel corso del prossimo secolo si modificherà e verrà sostituito da rispetto e ammirazione nei confronti di colei che si prende sulle spalle i pesi senza brontolare né darsi tante arie!
Tua Anne M. Frank
* Fonte: Dialogando con Anne..
* ANNE FRANK, "DIARIO. Edizione integrale", Einaudi, Torino 1993.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). ---- ANTROPOLOGIA E POLITICA: UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") COSTITUZIONALE.4 aprile 2021, di Federico La Sala
PER UN "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") COSTITUZIONALE ....
- Una nota a margine dell’art. di Sara Nocent e Davide Amato, "Draghi, un messia “tecnico”?", Sinistrainrete, 02 April 2021.
SE E’ VERO CHE, "ANCORA UNA VOLTA, chi trova soluzioni alternative al neoliberismo è bandito dalla stanza dei bottoni", è ALTRETTANTO VERO CHE RIPETERE CON Adorno e Horkheimer, che “la terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura”, porta tutti e tutte ancor di più nel buio dell’inferno.
Si è mai chiarito perché il Marx del "Capitale. Critica dell’economia politica", come il Marx della "Prefazione" a "Per la critica dell’economia politica", richiami Dante (è solo l’eco mnemonico di letture giovanili?) o, ancora, in un "banale" ritornello nei suoi lavori associ alla parola "economia politica" sempre la parola "critica"?! Non è perché il suo discorso ha qualche legame con il lavoro del Kant della "Critica della Ragion Pura", "Critica della Ragion Pratica", "Critica del Giudizio"!?
Se "Oggi tutti sono pazzi per Draghi", forse, c’è qualche motivo - per esempio, un motivo storico-costituzionale di lunga durata: "Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro" (Mario Draghi, discorso al Senato, 17.02.2021)!
DRAGHI, UN MESSIA "TECNICO"?! NON è TEMPO, FORSE, DI CHIARIRSI LE IDEE SU "CHI SIAMO IN REALTà" e, finalmente, riprendere con Marx la via della CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA. O no?!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- LA LEZIONE DI GIOVANNI VALVERDE (1560), LA FINE DELLA GRANDE INSTAURAZIONE ARISTOTELICA, E LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA.2 aprile 2021, di Federico La Sala
LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA, I “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO DI DANTE E LA PRESENTE STORICA CRISI DELLA CULTURA EUROPEA...
- Nota a margine dell’art. di Sergio Benvenuto, “La poca saggezza della filosofia”, "Le parole e le cose", 15 marzo 2021.
CONSIDERATO CHE UN FILOSOFO, “Anche quando sbaglia di grosso, se è un vero filosofo sbaglia con argomenti non banali, fino al punto che, grazie a lui, l’errore brilla della luce convincente della verità” (cf. S. Benvenuto, cit. - su), E VISTO CHE EGLI HA MESSO IL DITO NELLA PIEGA (e nella piaga) della storia della filosofia, nel gioco sofistico di Socrate: «Malgrado lo slogan “so di non sapere”, tutti ci rendiamo conto che Socrate in realtà sapeva tante cose. Ma il suo sapere squisitamente filosofico era proprio quello di non sapere, ovvero, il suo appello all’epistheme come “ricominciare tutto daccapo”» (op. cit. - su), VISTO IL PERSISTERE E , AL CONTEMPO, L’ESAURIRSI DELLA “GRANDE INSTAURAZIONE” ANTROPOLOGICA ED EPISTEMOLOLOGICA apollinea-socratica (su questo, si cfr. la grande analisi di Nietzsche!), forse, è bene e salutare riprendere alla radice (Marx!) la questione e, riaccogliendo l’indicazione di Sofocle, ripensare le «perversioni» di tremila e più anni (come sapeva Dante, meglio di Goethe), rileggere il cap. 15 del manuale di “Anatomia” (Roma, 1560) di Giovani Valverde, e ripensare l’«edipo completo», come voleva Freud e Fachinelli. Altro che continuare a menare la canna per l’aria. O no?!
Sul tema,nel sito, si cfr.:
Antropologia, Storia e Diritto. Donne e Uomini.... PER LA VERITA’ E LA RICONCILIAZIONE. RIMEDITARE LA LEZIONE DI ESCHILO. Dalla storia di Clitennestra, si arriva anche a immaginare una nuova giustizia, all’interno di nuovi rapporti sociali e politici
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Antropologia e politica.Note sulla "difficile eredità di Marx" (di Riccardo Bellofiore).29 marzo 2021, di Federico La Sala
MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".... *
- Una nota a margine del testo di Riccardo Bellofiore, La difficile eredità di Marx, Sinistra in rete, 24 marzo 2021.
"CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" , "CRITICA DELLA RAGION PRATICA" (E MEMORIA DI DANTE ALIGHIERI - ANNO 2021) . Alla luce del fatto che si è persa ogni cognizione dello "stato di cose presente", forse, è opportuno - come voleva Marx - riprendere il filo dalla indicazione delle note "Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione"): "La teoria è capace di impadronirsi delle masse non appena dimostra ad hominem, ed essa dimostra ad hominem non appena diviene radicale. Essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso".
Si dice:
- "[...] Vi sono delle lacune nella riflessione originaria di Marx che vanno superate. Marx vede bene un punto: che sotto il capitale il lavoro è prestazione erogata dalla forza-lavoro di ‘soggetti’ apparentemente liberi ed eguali. È di lì, da questi lavoratori che sono un ‘altro’ dal capitale che deve essere reso interno, ‘incorporato’ nella fabbrica produttiva, che viene estratto il lavoro vivo, dunque il nuovo valore di cui il plusvalore è parte: è per questo che le lotte sul lavoro sono centrali. Non presta però attenzione alla riproduzione sociale degli esseri umani che sono portatori viventi della forza-lavoro, dunque al lavoro domestico e al lavoro di cura. È questo uno dei fuochi del discorso del femminismo. C’è poi un ‘altro’ che è esterno al capitale, che è la natura, che viene anch’essa sfruttata e depredata nel suo corpo come gli esseri umani. Anche questo Marx lo vede, ma in qualche misura ne sottostima la gravità, che non può più sfuggirci" (R. Bellofiore, cit).
CONCORDO. Ma per ripartire bisogna riprendere il filo dalla "Logica" di Kant (non di Hegel, come si recita ancora oggi: http://www.leparoleelecose.it/?p=41116#comment-439785), dalla sua "quarta" (e prima!) domanda: "che cosa è l’uomo?", dalla sua "Critica della ragion pratica", e dal suo "imperativo categorico" (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5635)! La questione è antropologica (non andrologica né ginecologica)! O no?!
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. la "Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)": "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4198); su COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!, rileggere la lettera di Sigmund Freud (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=2923).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - LA GRAMMATICA E LA COSTITUZIONE. Donne al futuro (di Francesca Rigotti).20 marzo 2021, di Federico La Sala
Tweet
*
Controparola/
Donne al futuro
di Francesca Rigotti (Doppiozero, 20 marzo 2021)
Da quando ho scoperto che nella grammatica esistono termini marcati e termini non marcati - me li ha spiegati un illustre linguista amico di tastiera - non dico che non dormo di notte ma quasi. I termini non marcatI, se ho capito bene, sono dominanti e includenti: per esempio il termine «giorno», che comprende il giorno e la notte; notte invece è un termine marcato, giacché designa soltanto il tempo dell’oscurità. Non marcato è uomo (ci avviciniamo al tema) in quanto comprende se stesso e anche la donna, la quale invece, guardacaso, è marcata quale «soltanto» donna.
Dovevo ripensare a questa disparità grammaticale nel leggere Donne al futuro, raccolta di saggi di donne che parlano «soltanto» di altre donne, uscito per il Mulino a cura delle amiche di Controparola. Si tratta di un gruppo di scrittrici e giornaliste, nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini, che ha pubblicato diversi libri sulle donne tra i quali Donne del Risorgimento, Donne nella Grande Guerra, nella Repubblica, nel Sessantotto e ora al futuro. Sono Paola Cioni, Eliana Di Caro, Paola Gaglianone, Dina Lauricella, Lia Levi, Dacia Maraini, Cristiana Palazzoni, Maria Serena Palieri, Valeria Papitto, Linda Laura Sabbadini, Francesca Sancin, Cristiana di San Marzano, Mirella Serri, cui si deve Donne al futuro (il Mulino, Bologna 2021). Sempre e soltanto donne. O donne sole, si potrebbe anche dire, che è un’espressione un po’ deprimente ma anche molto divertente, a leggerla con ironia, e con la quale si intendono donne in compagnia di altre donne ma non di uomini. Mentre la dicitura per soli uomini sta per luoghi e/o attività in cui le donne non possono entrare e a cui non devono partecipare (e così è intitolata l’eccellente analisi statistica Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design, appena pubblicata da Codice Edizioni e condotta dalla giornalista Emanuela Griglié e del collega Guido Romeo).
Le donne al futuro di questo libro, soltanto donne marcate nella loro donnità, sono di fatto figure straordinarie, proiettate, come dice il titolo, al futuro o declinate al futuro, visto che siamo partiti dalla grammatica (che innocentemente mi costringe qui a scrivere al maschile benché io sia donna che scrive di donne che scrivono di donne. La lingua sarà anche colpevole ma non nel modo semplificato e a tratti oltraggioso che le attribuiscono le interpretazioni corrive, come spiega puntualmente l’amico linguista il cui nome adesso svelo, Nunzio La Fauci, ma la dice lunga). Donne giovani che lavorano per fabbricare il futuro con l’arte e la musica, l’architettura e l’astrofisica; con l’impegno civile e umanitario (donnitario?), con la ricerca medica, l’economia, la pratica sportiva e l’insegnamento.
 Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.
Le elenco qui tutte in fila in ordine alfabetico: Alice Pasquini (AliCè), Paola Antonelli, Marica Branchesi, Francesca Bria, Ilaria Capua, Silvia Colasanti, Ilaria Cucchi, Emma Dante, Sara Gama, Rita Giaretta, Giuseppina Multari, Eliana La Ferrara, Laila Abi Ahmed e Isabella Mancini, Barbara Riccardi, Fulvia Signani e le altre, Beatrice Vio. Un ricordo è dedicato alla cittadina del mondo Agitu Ideo Gudeta, uccisa nel dicembre scorso in Trentino, dove si era trasferita e portava avanti la sua attività di imprenditrice.Non potendo parlare di tutte ho scelto di citarne una sola, l’unica tra l’altro che mi era del tutto ignota, lo confesso e chiedo venia: Sara Gama. Sara Gama, classe 1989, madre triestina e padre congolese, capitana della Nazionale azzurra femminile di calcio nonché vicepresidente dell’Assocalciatori (termine non marcato che comprende anche le calciatrici mentre le calciatrici, marcate dall’essere soltanto donne, non comprendono i calciatori).
 Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Sara Gama, ho scoperto, non soltanto gioca al calcio femminile da quando era una bambinetta ma rivendica anche, per quel calcio di donne, assicurazione sanitaria, previdenze, stipendio e soprattutto dignità. Studentessa liceale, studentessa universitaria - sulla storia del calcio femminile in Europa ha anche scritto la tesi - Sara Gama, che nell’immagine di copertina sembra, coi suoi bei capelli ricci, l’Italia turrita, nel discorso del 4 luglio 2019 al Quirinale, di fronte al presidente Mattarella, ha ricordato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce la dignità di tutti i cittadini «senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
 E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia.
E questo grazie alle donne della Costituzione, le madri costituient, che contro l’opinione di alcuni padri della costituzione insistettero affinché nell’art. 3 venisse inserita la specificazione «di sesso», perché senza quella la conquista della parità sarebbe stata ancor più difficile di quanto già lo sia. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- La nostra "Bibbia civile", la parità di genere, e la memoria costituzionale di Mario Draghi.15 marzo 2021, di Federico La Sala
La #Costituzione è la nostra #Bibbiacivile.
Ricordiamo i nostri #Padri e le nostre #Madri #Costituenti:
"Una vera #paritàdigenere non significa un farisaico rispetto di #quoterosa richieste dalla #legge"
(#MarioDraghi).
***
#USCIAMO DAL #LETARGO
e
dall’#immaginario
di una zoppa e cieca #antropologia.
A #ContursiTerme (#Salerno), almeno del 1989 è ripreso
il dibattito sulla #paritadigenere
grazie alla #memoria
di #Michelangelo e di #TeresadAvila
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - LA LEZIONE DI FACHINELLI E CASSANO E LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO.13 marzo 2021, di Federico La Sala
SULLA SPIAGGIA. DINANZI AL MARE: MEMORIA , STORIA, E RICERCA ANTROPOLOGICA E FILOSOFICA...
- Una nota all’articolo di Stefano Modeo, “Ricordo di Franco Cassano: proseguire Il pensiero meridiano”, Le parole e le cose, 12 marzo 2021.
PER RIPRENDERE E PROSEGUIRE, SE SI VUOLE, IL LAVORO E LA RIFLESSSIONE DI ELVIO FACHINELLI ("LA MENTE ESTATICA", FEBBRAIO 1989) E DI FRANCO CASSANO ("APPROSSIMAZIONE", APRILE 1989), CREDO, SIA OPPORTUNO PARTIRE DALLE LORO OPERE: RISPETTIVAMENTE, dal libro "La mente estatica" di Fachinelli (pubblicato da Adelphi nel febbraio del 1989) e, insieme, dal libro "Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro" di Cassano (pubblicato dalla casa editrice "Il Mulino" nell’aprile del 1989) e, alla luce dei loro particolari programmi di ricerca volti a pensare e a superare "la frontiera", ricordare che la Caduta del Muro di Berlino avviene - senza violenza - nei primi giorni del mese di novembre del 1989.
"DEPORRE L’ELMO". Nel saggio dedicato all’analisi del lavoro di Fachinelli (http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1568), contro i vari tentativi di neutralizzare la sua proposta ("Né demonizzare, né omologare"), così annotai :
- "L’espressione è ripresa da quell’interessante e coraggioso libro che «cerca di muoversi nello spazio etico che si trova tra demonizzazione e omologazione sulla base dell’idea che entrambi gli atteggiamenti vivano male la trascendenza dell’altro» di F. Cassano (Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro, Bologna, II Mulino, 1989, p. 8). Il tema centrale della sua riflessione è molto prossimo al tema dell’accogliere: si tratta di «deporre l’elmo» (p. 9) dell’intelligenza astuta e armata, quello di Atena-Metis. L’invito a non demonizzare e a non omologare è rivolto, per quanto riguarda la ricerca di Fachinelli (ma la cosa vale anche per quella di Cassano, come qualcuno ha già fatto), a S. Vegetti Pinzi, che chiude una sua recensione de La mente estatica (cfr. Dalla psicoanalisi all’estasi un viaggio della conoscenza, «Corriere della sera», 30.4.1989) con la seguente considerazione: «Si tratta, come è evidente, di una indagine ad alto rischio dove la psicoanalisi, sganciata dalla pratica clinica e dalla referenza teorica, esplora i territori dell’immaginario e le potenzialità della suggestione»." (Cfr. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani Editore, Roma, 1991, nota 26, pp. 146-147).
A distanza di trenta e più anni, non sembrano esserci altre vie, se non quella di deporre l’elmo e uscire dall’orizzonte della dialettica hegeliana, e praticare "esercizi di esperienza dell’altro". O no?!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- MEMORIA: IL CORAGGIO DI ELVIO FACHINELLI E DI FRANCO CASSANO.6 marzo 2021, di Federico La Sala
Franco Cassano (1943-2021)
di Raffaele Rauty (Il Mulino, 01 marzo 2021)
Sollevare l’elmo * e aprirsi all’altro avendo attraversato il fiume sino alla riva che non è la nostra, mentre l’acqua, l’altro, il confine attraversato, la fronte scoperta segnano una soggettività che affronta un destino incerto ma necessario, che ridefinisce relazioni e futuro. Franco Cassano, autore di questa immagine, a lui molto cara, è stato intellettuale, sociologo, riformatore, cultore di teoria e democrazia, militante non settario: sempre idealmente dalla parte dei deboli, non ha concepito distacco o scissione da un impegno storicamente legato alla trasformazione sociale, in un pensiero non consolatorio e mai concluso.
 Dalla sezione universitaria comunista alla cittadinanza attiva di Città plurale, entrambe di Bari, città simbolo di tante città e di tanti Sud, in una realtà nella quale mezzogiorno, mediterraneo, meridionalismo, hanno assunto identità, significati, legami, consapevolezze, potenzialità diversi dal passato, Cassano ha segnato la strada di una lunga stagione i cui attori di volta in volta ne sono divenuti parte, rispondendo a una chiamata, come la vocazione di Matteo del Caravaggio, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma che Franco, quando poteva, amava visitare, simbolo di un Beruf fissato nella storia. Ma quella chiamata, quel Beruf non si concludevano in sé, ma erano solo l’inizio di una nuova lunga drammatica turbolenza, interiore ed esteriore.
Dalla sezione universitaria comunista alla cittadinanza attiva di Città plurale, entrambe di Bari, città simbolo di tante città e di tanti Sud, in una realtà nella quale mezzogiorno, mediterraneo, meridionalismo, hanno assunto identità, significati, legami, consapevolezze, potenzialità diversi dal passato, Cassano ha segnato la strada di una lunga stagione i cui attori di volta in volta ne sono divenuti parte, rispondendo a una chiamata, come la vocazione di Matteo del Caravaggio, nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma che Franco, quando poteva, amava visitare, simbolo di un Beruf fissato nella storia. Ma quella chiamata, quel Beruf non si concludevano in sé, ma erano solo l’inizio di una nuova lunga drammatica turbolenza, interiore ed esteriore.La lettura e le parole dei testi, con i quali lavorava come in una enigmistica continua, erano premessa di analisi libera e ininterrotta, anche se il suo debito con la tradizione sociologica lo aveva pagato appena nell’università con il lavoro su Weber, Mills, Habermas (1971), in una scelta di studio segnata, come dichiarato in un colloquio lontano, dal fatto che Weber era stato ed era per lui verifica continua, «il grande», «quello cui devo tanto e sento sempre di dover tornare».
Franco il suo esame di «ammissione» nella comunità scientifica non lo fece con un concorso universitario, metodo mai amato ma forse necessario di cooptazione, ma con Marxismo e Filosofia (1971) testo ormai dimenticato, di un’editrice meridionale anch’essa dimenticata, la De Donato, che riproponeva testi e discussioni svoltisi sulle pagine di riviste comuniste, di difficile memoria, «Rinascita» e «Il Contemporaneo». E Franco, a trent’anni osò riflettere e confrontarsi con il cuore del marxismo e della politica, aprendo una riflessione, ai limiti dell’eresia per i suoi caratteri, a un retroterra che a Gramsci e Marx sommava anche Della Volpe e Panzieri, e che in quella semplice aggregazione di testi, ristrutturava i termini dell’analisi sociale.
 Fu un esordio silenziosamente fragoroso, compreso, non so quanto condiviso, allora e nel seguito del percorso, da amici con i quali sarebbe rimasto un rapporto di affetto fraterno sempre, di stima reciproca continua, di distanza teorica frequente, Beppe (Vacca), Gino (de Giovanni), Giuseppe (Cotturi), Peppino (Caldarola), Franco (de Felice), tutti parte, individuale e collettiva, della storia del marxismo e della democrazia in Italia.
Fu un esordio silenziosamente fragoroso, compreso, non so quanto condiviso, allora e nel seguito del percorso, da amici con i quali sarebbe rimasto un rapporto di affetto fraterno sempre, di stima reciproca continua, di distanza teorica frequente, Beppe (Vacca), Gino (de Giovanni), Giuseppe (Cotturi), Peppino (Caldarola), Franco (de Felice), tutti parte, individuale e collettiva, della storia del marxismo e della democrazia in Italia.La sua ricerca appassionata, apparente tradimento o addirittura negazione di tradizioni profonde, quasi sacre, iniziava nelle librerie: avendo fatto della interdisciplinarità la madre delle sue categorie, frugava tra i libri con una curiosità che era strategia di costruzione della riflessione, dell’analisi e della comunicazione, dalla narrativa alle scienze sociali, alla letteratura e alla storia, piegando tutto, e raccogliendo, rigo dopo rigo, periodo dopo periodo, suggestioni per l’interpretazione della modernità in un contatto continuo tra senso comune e scienza. È stato un colloquio con autori emblematici del loro mondo, spesso inattesi, Pasolini, Fortini, Camus, Weil, Rossanda, Leopardi, passaggio simbolico il cui antecedente era stato un altro grande marxista a suo modo irregolare, Cesare Luporini, che aveva anche osato dialogare con «il mondo magico» meridionale, e poi altri e altri ancora.
In coerenza con questo, Franco Cassano, pur consapevole del suo ruolo, non amava definirsi sociologo; sentiva questa definizione, forse l’immanenza della disciplina, troppo stretta per la riflessione condotta e per una sensibilità che entrava in rapporto con universi spesso ancora lontani dai mondi più tradizionali che frequentava, il femminismo prima di tutti.
 E i suoi lavori, tutti, dal Teorema democristiano a Senza il vento della storia, sono in qualche modo costruiti in modo non tradizionale, ricchi di notazioni interne al testo, a inseguire il filo centrale del discorso e le sue connessioni a volte appena accennate, spesso tracce di culture lontane ma riconoscibili e da riconoscere. Molto prima della discussione sui migranti le rive del Mediterraneo e i popoli di quelle terre riacquisirono la connotazione di contesti comuni e di fratelli, in una idea di cittadinanza, presenza, partecipazione, che sovrastava ogni limite esclusivo.
E i suoi lavori, tutti, dal Teorema democristiano a Senza il vento della storia, sono in qualche modo costruiti in modo non tradizionale, ricchi di notazioni interne al testo, a inseguire il filo centrale del discorso e le sue connessioni a volte appena accennate, spesso tracce di culture lontane ma riconoscibili e da riconoscere. Molto prima della discussione sui migranti le rive del Mediterraneo e i popoli di quelle terre riacquisirono la connotazione di contesti comuni e di fratelli, in una idea di cittadinanza, presenza, partecipazione, che sovrastava ogni limite esclusivo.Franco Cassano, nelle aule universitarie di Bari, e nelle tante dove è stato chiamato a fare lezione, ha contribuito alla formazione di tanti studenti, in un lavoro mai divenuto consuetudine, e la sua sociologia lo aiutò in una rigorosa direzione de la «Rassegna Italiana di Sociologia», in una fase che, con l’avallo della sua casa editrice, raccolse nella redazione parte dei migliori esponenti della sociologia italiana, in una aggregazione che univa i percorsi teorici di sociologi come Franco Crespi, Margherita Ciacci, Pierpaolo Giglioli, Loredana Sciolla, Chiara Saraceno, con quelli di un gruppo di colleghi più giovani, miscelando esperienze e approcci analitici diversi, scienza, confronti, tutti cementati da stima reciproca, sensibilità, anche affetto.
La riflessione meridiana, centrale nella sua esistenza e nella sua attività, fu così la maturazione di premesse evidenti, in una riacquisizione di centralità e autonomia del Sud, risorsa struggente, carica di orgoglio e di impegno, di speranza e necessità, di opportunità e scelta, consapevole che molti, anche importanti, avevano trovato modo di abdicare a questo e che si trattava di una difficile ma necessaria operazione di riequilibrio, di riconquista di un lessico che aveva visto esaurirsi quello del meridionalismo storico e il suo soggetto politico naturale, di fatto sbiadito, spesso silenzioso, ormai lontano dai luoghi delle necessarie trasformazioni. In tanti volevano conferma che quel lessico e quel soggetto non fossero scomparsi, e che invece si stavano ristrutturando per poter tornare all’altezza dei tempi e delle necessità, in una presenza nuova in grado di raccogliere disponibilità antiche. Uno sguardo, un pensiero quelli di Franco che «andavano oltre», inseguendo l’equilibro drammatico dell’esistenza e da questo colpiti, irregolari rispetto a un senso comune teso alla tranquillità.
Avrebbe potuto essere un intellettuale aristocratico, è stato uomo popolare, amante del calcio, dei cani, del verde, in un rapporto di amore verso gli altri, tutti, forse alcuni in particolare, intoccabili: Bari, la Puglia, il mare, certo; e ancora di più, Luciana, Peppe, e Rossella, Linda, Elisa, tra presente, ricordi e futuro.
* SUL TEMA DEL "DEPORRE L’ELMO", DEL SOLLEVARE L’ELMO, DA NON DIMENTICARE, INSIEME AL LAVORO DI FRANCO CASSANO, "Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro", Il Mulino, Bologna, 1989 (aprile), il lavoro di Elvio Fachinelli, "La mente estatica", Adelphi, Milano, 1989 (febbraio)!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge" (Mario Draghi).18 febbraio 2021, di Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL (NOME E IL) COGNOME DA DARE AI FIGLI E LA COSTITUZIONE. La Consulta: "Il cognome del padre è retaggio patriarcale, basta disparità" (Ansa).12 febbraio 2021, di Federico La Sala
La Consulta: "Il cognome del padre è retaggio patriarcale, basta disparità"
"Non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna"
- [Foto] Una coppia con la loro figlia © ANSA
di Redazione ANSA*
ROMA L’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre? Con questo dubbio, la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio. L’ordinanza n. 18 depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato) spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano.
L’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli "è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", e di "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna". Lo sottolinea, riprendendo una sua pronuncia del 2006, la Consulta, nell’ordinanza con cui ha sollevato davanti a se’ stessa la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- MEDITAZIONI SUL "CANTICO DEI CANTICI" E SULLA FUGA DI "MARIA" E "GIUSEPPE" IN EGITTO (CARAVAGGIO).31 gennaio 2021, di Federico La Sala
#ANTROPOLOGIA #FILOSOFIA #ARTE. IL #CANTICODEICANTICI E LE #DUEALI DELLA CELESTE #MUSICA.
#Caravaggio: #MariaeGiuseppe con il loro #figlio in un momento di "#Riposo durante la #fugainEgitto"
***
#ARCHEOLOGIA #FILOSOFIA #FILOLOGIA #ARTE, #OGGI, NELL’ANNO #DANTE2021: "#AMORE è più’ FORTE DI #morte (Ct. 8.6).
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- Il corpo negato della democrazia (di Francesca Maffioli).14 gennaio 2021, di Federico La Sala
Il corpo negato della democrazia
Storia al bivio. Vinzia Fiorino analizza la realtà transalpina dal 1789 al 1915 in «Il genere della cittadinanza», per Viella. La Rivoluzione francese dichiarò la sovranità popolare, negando però l’uguaglianza alle donne. Le tesi che tendevano a mantenerle ai margini, o fuori, dalla sfera politica, erano sostenute anche da faziose expertises scientifiche dal carattere antropologico. Molte però anche le figure che misero in discussione quel modello. Da Olympe de Gouges, drammaturga, a Hubertine Auclert che nel 1882 parlò per la prima volta di femminismo
- [Foto] «Français: A Versailles, à Versailles. 5 Octobre 1789». Autore sconosciuto, fonte Bibliothèque nationale de France
di Francesca Maffioli (il manifesto, 14.01.2021)
Il volume di Vinzia Fiorino, Il genere della cittadinanza (Viella, pp. 260, euro 26) traccia i contorni di quella fase, cominciata al principiare della Rivoluzione francese e terminata nel 1915, che vedrà la definizione del concetto di civitas come spazio esclusivamente maschile di esercizio di diritti politici. Insieme alla cittadinanza sono delineate tutte quelle dinamiche di esclusione e marginalizzazione delle donne edificate nel corso dell’Ottocento francese.
FIN DALLE PRIME PAGINE Fiorino sottolinea (e anche altrove nel libro insisterà su questa questione essenziale) che tra i soggetti subordinati e esclusi dalla moderna sfera politica erano da annoverare anche «i neri, ma anche i domestici, i matti, i criminali», mettendo in rilievo l’intersezione tra le discriminazioni. Quando l’autrice scrive che «sulla base delle differenze di genere e di razza sono stati edificati, però, i principali criteri di esclusione dalla comunità politica, in quanto il loro carattere naturale ha reso tale esclusione immodificabile: i domestici avrebbero potuto emanciparsi, i matti rinsavire, i criminali pagare il debito con la giustizia; ma natura non facit saltus», vuole evidenziare anche la stretta di quel filo che ha legato la negazione del diritto di voto ai corpi delle donne con il pretesto della loro diversità rispetto alla norma, universale, maschile.
Come sostiene la storica Michelle Perrot, la rivoluzione francese ha rappresentato uno dei momenti fondativi della costruzione della moderna cittadinanza; tuttavia, come Fiorino riesce a dimostrare con argomentazioni solide e prove storiche, quando la Rivoluzione dichiara l’uguaglianza di tutti gli uomini nei diritti, e di fatto la sovranità popolare, sceglie di negare uguaglianza e sovranità a categorie considerate diverse - segnatamente le donne.
Pensando agli esiti della Rivoluzione francese, insieme allo smantellamento di quello che era l’Ancien Régime (che aveva trascinato per secoli l’ordinamento sociale per ceti e l’esercizio del potere a beneficio di quelli dominanti), spicca infatti la definizione di cittadinanza moderna. Bisogna fin da subito sottolineare che essa non aveva a che fare con il suffragio universale maschile, che in Francia sarà atteso per più di cinquant’anni dopo la Rivoluzione. Ancor meno la definizione di cittadinanza moderna ebbe a che vedere con il voto delle donne, per cui bisognerà aspettare il 1944.
I CENTOCINQUANT’ANNI che separano la Rivoluzione francese dall’acquisizione del diritto femminile di voto danno conto di un nuovo ordine che scelse di non far votare le donne francesi per ragioni diverse: spaziando dall’ordine naturale, per cui le donne sarebbero state caratterizzate da qualità fisiche (uno stato di inferiorità e debolezza) tali da non consentire loro qualunque riflessione intellettuale e quindi anche politica; fino alla negazione dell’esercizio di voto per il mantenimento di uno status quo necessario alla tutela dell’istituzione del nucleo familiare.
Fiorino sottolinea che per corroborare le tesi che premevano per il mantenimento delle donne al margine della sfera politica, erano fornite faziose expertises scientifiche dal carattere antropologico; cita in tal senso le conclusioni dei fisiologi Julien-Joseph Virey e Pierre Jean George Cabanis, che non a caso sono anche due idéologues attivi in quel contesto politico postrivoluzionario che premeva per lasciare le donne al margine dell’ambito politico.
Quando si parla di margine e di luoghi estrinsechi alla politica attiva, il rapporto gerarchico tra pubblico e privato è sancito dalla teorizzazione illuministica della politica e dall’approccio storico della sociologia positivista: il luogo privato, inteso come spazio domestico, sarebbe da situarsi a uno stadio inferiore rispetto a quello pubblico «collocato più innanzi lungo il percorso ideale che evolve da legami di tipo comunitario-religioso familistico verso una società moderna costruita sulla divisione del lavoro». Insieme a un modello di cittadinanza fortemente connotato sulla base del genere, per cui la dipendenza dal marito seguiva quella dal padre, si affermava come indiscutibile quel modello per cui lo status di minorità rendeva difficilmente accessibili alle donne i diritti di cittadinanza.
Nel saggio di Vinzia Fiorino è dato molto spazio proprio alla importante messa in discussione di questo modello ancorato a «quella sollecita preoccupazione per cui la partecipazione attiva delle donne nella sfera del mercato e della politica avrebbe comportato l’abbandono del lavoro di cura familiare fino alla loro mascolinizzazione». Ecco allora farsi avanti figure di donne che sono riuscite a mettere in discussione quel modello che le incastrava in quel luogo reale e simbolico in cui la loro parola, le esigenze e il loro pensiero erano ritenuti trascurabili e indegni di rappresentanza.
Mary Wollstinecraft, pensatrice britannica che nel 1792 partì alla volta di Parigi, la quale con magnifica lungimiranza affermava la necessità di trasformare il mondo iniziando da se stesse, convinta che senza quella che in Italia dagli anni Sessanta si chiamerà la pratica politica dell’autocoscienza femminista, la rivoluzione non sarebbe stata possibile. Olympe de Gouges, nota drammaturga e attivista francese, la quale nel 1791 pubblicò la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, non era partigiana di quella che definiremmo «l’uguaglianza identitaria», ma piuttosto di un’uguaglianza in termini di diritto. La pensatrice abbracciava il tema della libertà congiungendolo a quello di una giustizia sistemica - in una dimensione che comprendesse l’intero gruppo sociale: «La libertà non è più soltanto un diritto dei singoli, sia pur visti nella loro reciprocità, ma un terreno connesso alla giustizia condivisa».
Jeanne Deroin, candidata nel 1849 alle elezioni per l’Assemblea legislativa (la cui candidatura fu ritenuta incostituzionale!), insieme ad altre militanti sansimoniane fu in grado di distaccarsi dagli stereotipi legati alla natura femminile ma anche dal produttivismo. «Nonostante la cultura del socialismo utopistico contrassegni fortemente il pensiero di queste protagoniste, esse autonomamente mantengono ferma l’attenzione sui valori teoretici dell’individualità: proprio questo è il contenuto che la categoria di genere fa emergere con forza; questo è lo spazio da cui trae origine la politica delle donne. Le quali possono essere produttrici e possono condividere le critiche radicali al sistema di produzione capitalistico, ma in nessun caso la loro soggettività giuridica e la loro libertà politica saranno regolate dalla capacità di produrre».
INSIEME A LEI sono ricordate, in una geologia temporale lunga più di un secolo, Etta Palm d’Aelders, Théroigne de Méricourt, Claire Demar ma anche molte altre donne, anche provenienti dai ceti più umili. Due di loro furono anche autrici per una testata giornalistica la cui redazione era composta da donne e quelle che vi scrivevano avevano scelto di firmarsi con il solo nome proprio. Vinzia Fiorino, secondo la buona pratica del rendere visibili donne invisibilizzate, ci parla di queste due donne. Si tratta di due giornaliste, fondatrici di La Femme libre, chiuso dalle autorità nel 1834: Désirée Véret e Marie-Reine Guindorf, due giovani operaie tessili e sostenitrici di quello che nel 1882 Hubertine Auclert chiamò per la prima volta femminismo.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- "CHARITÉ": SOCIALISMO O BARBARIE. La realtà è più importante delle idee5 gennaio 2021, di Federico La Sala
CHARITÉ: SOCIALISMO O BARBARIE ....
La realtà è più importante delle ideeRiccardo Cristiano. Bergoglio o barbarie *
Riccardo Cristiano racconta il suo saggio Bergoglio o barbarie, pubblicato da Castelvecchi nel 2020. L’idea di scrivere questo libro è venuta a Cristiano dopo l’incontro con un teologo che lo invitava ad andare negli Stati Uniti d’America per verificare di persona che l’alternativa a Bergoglio è la barbarie. Un’alternativa che ricordava quella famosa di Rosa Luxemburg tra socialismo o barbarie. Sostituire l’ideologia socialista con una persona come Bergoglio ha mostrato che il problema non era l’idea ma la realtà, perché la realtà è più importante delle nostre idee e il sole è quello che brilla oggi non quello dell’avvenire.
- I comportamenti di Bergoglio si accompagnano alle proposte, anzi sono la traduzione fisica delle sue proposte, perché il Papa considera la forma meno importante della sostanza del messaggio.
I suoi atti pontificali principali sono stati, secondo Cristiano, il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza, che è l’antefatto dell’enciclica Fratelli tutti, l’accordo provvisorio con la Cina e il Sinodo per l’Amazzonia che è un po’ la sintesi del suo pontificato:
- lo sviluppo umano integrale, la difesa degli ecosistemi, della casa comune e la valorizzazione delle nostre diversità intese come dimostrazione del fatto che proprio perché siamo diversi siamo fratelli, cioè uguali, uguali nelle nostre diversità che sono parti del tutto che costruiamo insieme. Oggi solo Bergoglio può essere il punto di incontro tra universalismo e localismo.
Riccardo Cristiano, particolarmente attento al dialogo interreligioso, a lungo coordinatore dell’informazione religiosa di Radio Rai, è fondatore dell’Associazione Giornalisti amici di padre Dall’Oglio e collabora come vaticanista con «Reset» e «La Stampa». Ha pubblicato con Castelvecchi Medio Oriente senza cristiani? (2014), Bergoglio, sfida globale (2015), Siria. L’ultimo genocidio (2017) e ha curato il volume Solo l’inquietudine dà pace. Così Bergoglio rilancia il vivere insieme (2018).
* FONTE: RAI CULTURA/FILOSOFIA
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CHARITÉ: BERLINO RICORDA A PAPA RATZINGER IL NOME ESATTO DELL’ OSPEDALE E DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA.
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITÀ POMPOSA.
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- ANTROPOLOGIA E TESSITURA. Siamo fili dell’unico arazzo dell’essere (di Ermes Ronchi).2 gennaio 2021, di Federico La Sala
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA.... *
Siamo fili dell’unico arazzo dell’essere
di Ermes Ronchi (Avvenire, giovedì 31 dicembre 2020)
II Domenica dopo Natale
- In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. [...]
Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di noi le porte dell’infinito e dell’eterno. Giovanni non inizia raccontando un episodio, ma componendo un poema, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo.
In principio era il Verbo... e il Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. Non solo un lontano cominciamento temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Vannucci).
Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato accampamento umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle cose che sono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui.
«In principio», «tutto», «nulla», «Dio», parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti connessi insieme, nell’unico meraviglioso arazzo dell’essere. Senza di lui, nulla di nulla. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e la pietra e il passero intirizzito sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua carezza, sua lettera d’amore.
In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci un sistema di pensiero o una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande vita: «Sono venuto perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). E la vita era la luce degli uomini.
Cerchi luce? Contempla la vita: è una grande parabola intrisa d’ombra e di luce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intuire gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico a primavera.
Cerchi luce? Ama la vita, amala come l’ama Dio, con i suoi turbini e le sue tempeste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e abbine cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel mondo.
A quanti l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. L’abbiamo sentito dire così tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa significhi l’ha spiegato benissimo papa Francesco nell’omelia di Natale: «Dio viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a ciascuno di noi: tu sei una meraviglia».
Non sei inadeguato, non sei sbagliato; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce che ti sussurra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri alla vita, come fa Dio. E la domanda ultima sarà: dopo di te, dove sei passato, è rimasta più vita o meno vita?
(Letture: Siracide 24,1-4.12-16; Salmo 147; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18)
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PIANETA TERRA. Tracce per una svolta antropologica...
 MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours").
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: "LA VOCE DELLA SPOLETTA È NOSTRA" ("The Voice of the Shuttle is Ours")."NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- AVVENTO. Dispute teologiche intorno alla nascita (di Nadia Maria Filippini).23 dicembre 2020, di Federico La Sala
Dispute teologiche intorno alla nascita
AVVENTO. Il parto verginale di Maria. Tra esaltazione della maternità e rimozione. Per secoli il dibattito si è snodato intorno al modo in cui la ragazza di Nazareth ha «dato alla luce» Gesù. L’ostilità verso la materialità del corpo ha pesato sul vissuto femminile fino alla presa di parola del movimento delle donne
- [Foto] Antonio Veneziano, «Madonna del parto» (Pieve di San Lorenzo, Pontassieve)
di Nadia Maria Filippini (il manifesto, 23.12.2020)
Durante il periodo dell’Avvento, in vari luoghi dell’Occidente cristiano, tra Medioevo ed età moderna, si celebrava una festa particolare, successivamente scomparsa dal calendario liturgico: quella dell’attesa del parto di Maria, Expectatio partus Beatae Mariae Virginis. Il X Concilio di Toledo nel 656 l’aveva fissata nel giorno 18 dicembre, a pochi giorni dal Natale. Una vasta produzione artistica di statue e dipinti fissava questo momento dell’attesa, rappresentando Maria nella pienezza della sua gravidanza, spesso con in mano un libro (simbolo delle Sacre Scritture), o con la mano posata sul ventre, in una postura comune a tutte le donne incinte.
Ma in che modo la Madonna aveva messo al mondo Gesù? In che modo egli era uscito alla luce? Queste domande erano state al centro di un intenso dibattito teologico che si era snodato per secoli, ed avevano una rilevanza tutt’altro che secondaria, in quanto incrociavano frontalmente la questione della natura di Cristo: solo uomo (come sostenevano gli ariani) o solo Dio (come sostenevano i Nestestoriani)? Il Concilio di Efeso (431) aveva infine proclamato la sua duplice natura umana e divina, definendo di conseguenza Maria Theotòkos e Deipara (madre di Dio); il che rendeva ancor più complessa la questione del parto e della nascita: un inghippo esegetico intorno al quale continuarono ad arrovellarsi molti teologi, non senza dispute e conflitti.
IN QUANTO VERO UOMO egli avrebbe dovuto seguire le leggi della natura e venire al mondo attraverso le vie naturali, come sosteneva, ad esempio, Tertulliano. A far da ostacolo a questa ipotesi stavano però poderosi contenuti di natura sia culturale che religiosa. Innanzitutto il peso della religione ebraica che coniugava la punizione divina per il peccato originale proprio al parto, caricando l’evento di un’aurea che sanzionava con Eva tutte le sue discendenti. Vero è che la Vergine non era stata contaminata dal «seme immondo» della concupiscenza e in quanto Immacolata Concezione, cioè priva di peccato originale fin dal suo concepimento, era esonerata dalle sofferenze del travaglio; ma nei primi secoli della Chiesa, questa era solo un’ipotesi teologica controversa tra diverse correnti degli «immacolisti» e «macolisti»; non ancora una verità di fede, che verrà proclamata come dogma solo nel 1854.
 A creare problema era soprattutto una rappresentazione del parto carica di valenze negative che il Cristianesimo ereditava dal mondo antico. Il nascere nel sangue era visto dalla cultura classica e da quella ebraica come causa di impurità; al sangue impuro dei lochi era attribuito pure un potere malefico e corrosivo, analogo a quello mestruale, secondo un parere condiviso per secoli pure dalla medicina.
A creare problema era soprattutto una rappresentazione del parto carica di valenze negative che il Cristianesimo ereditava dal mondo antico. Il nascere nel sangue era visto dalla cultura classica e da quella ebraica come causa di impurità; al sangue impuro dei lochi era attribuito pure un potere malefico e corrosivo, analogo a quello mestruale, secondo un parere condiviso per secoli pure dalla medicina.AGLI DEI E AGLI EROI del mito classico erano attribuite infatti altre vie per la nascita, extra-ordinariae: ora dal fianco, come Asclepio o Dioniso, ora dalla testa, come Atena. Perfino il grande Giulio Cesare, secondo una falsa tradizione medioevale, era nato da taglio cesareo (da cui il nome). Questo sguardo disgustato sulla materialità della nascita si intrecciava, nei primi secoli del Cristianesimo, con il tema degli effetti della caduta del genere umano, di cui proprio le modalità del parto e della nascita (intra foeces et urinam) diventavano quasi simbolo, non solo nell’elaborazione degli gnostici o dei manichei, ma anche di molti teologi medioevali come Gregorio Magno e Lotario di Segni (papa Innocenzo III).
Come avrebbe potuto il figlio di Dio nascere nel sangue senza risultarne in qualche modo contaminato? Ed inoltre il suo stesso passaggio dalle vie naturali non comportava di per sé un’apertio vulvae, interrompendo la verginità di Maria, come appunto Tertulliano e altri sostenevano, ipotizzando una verginità della Madonna nel momento del concepimento, ma non durante o dopo il parto?
Sul parto della Madonna i Vangeli erano piuttosto vaghi: dicevano soltanto che mentre si trovava a Betlemme aveva «dato alla luce il suo figlio», avvolgendolo in fasce e ponendolo in una mangiatoria, perché non c’era posto per loro nell’albergo (Luca, 2,1). Solo due vangeli apocrifi, quello dello pseudo-Matteo e di Giacomo, rifacendosi al profeta Isaia, parlano esplicitamente del parto verginale di Maria, introducendo nel racconto la figura di una levatrice, Zelomi, chiamata da Giuseppe, che, arrivata troppo tardi quando il bambino era già nato, aveva avuto modo di verificare con la sua visita la verginità della Madonna, attestando l’evento miracoloso: Gesù «non aveva sofferto alcuna contaminazione di sangue»; la partoriente nessun dolore; essa, che aveva concepito vergine, aveva partorito vergine ed era rimasta tale.
FU PROPRIO questa versione dei vangeli apocrifi ad essere ripresa dalla Chiesa. Si ricorse a un’idea della verginità nel parto speculare a quella della fecondazione, che confermava l’evento della nascita di Cristo dal corpo della madre, ma modificava al contempo miracolosamente le leggi fisiologiche che normalmente lo regolano. Egli infatti «non era stato concepito dal piacere carnale, né era uscito alla luce attraverso i dolori» (come scriveva Gregorio di Nissa): era venuto al mondo lasciando intatto il sigillum; aveva attraversato il corpo della madre come un raggio di sole attraversa il vetro, con un’efficace immagine costantemente ripresa. In questo modo la nascita risultava assimilata con una specularità emblematica alla ri-nascita, all’uscita dal sepolcro che lasciava intatti i sigilli, come spiegava sant’Agostino nell’Enchiridion. Ne risultava rimarcata e arricchita di nuovi attributi anche la contrapposizione tra le due donne: Eva (origine e causa della morte) e Maria (origine e madre della vita).
Questa interpretazione divenne progressivamente maggioritaria a partire dal V secolo, sostenuta da autorevoli teologi come Efren Siro, il «poeta della Madonna», Zeno di Verona, Ambrogio, fino ad esser sancita da vari concili: quello di Calcedonia (451), di Costantinopoli II (553) e quello Lateranense (649). Maria venne dichiarata Aeiparthenos («sempre vergine») e questo appellativo fu inserito nella professione di fede del Concilio Lateranense IV (1215), ripreso poi anche da Paolo IV (1555) nella costituzione Cum quorundam, dove si riaffermava appunto che Maria era vergine «prima, durante e per sempre dopo il parto».
CI SI PUÒ CHIEDERE a questo punto quali conseguenze abbia avuto questa costruzione teologica sul piano del vissuto femminile, nella percezione del corpo, della gravidanza e del parto, per donne cristiane abituate a guardare alla figura della Madonna come modello assoluto. Non c’è dubbio che abbia introdotto elementi di profonda contraddizione nel vissuto della maternità, scindendone gli aspetti e attribuendovi significati e contenuti simbolici opposti. Se da un lato infatti, con il mistero dell’incarnazione, la nascita acquistava un rilievo speciale a livello simbolico; se la maternità risultava valorizzata sul piano spirituale e della relazione madre- figlio, con una rottura rispetto al mondo antico di cui è impossibile non cogliere la rilevanza; d’altro canto però il parto rimaneva confinato nel novero delle espressioni corporee indicibili e indegne della madre di Dio.
Questa svalorizzazione della maternità corporea era destinata ad accentuarsi ancor di più dopo il Concilio di Trento, quando le severe disposizioni controriformistiche in materia di raffigurazione delle immagini sacre portarono alla progressiva scomparsa di tutte quelle rappresentazioni artistiche che mettevano in mostra i segni della maternità corporea di Maria: le Madonne del parto andarono via via sparendo; nella rappresentazione della Natività la postura della Madonna puerpera fu abbandonata, a vantaggio di quella genuflessa, in adorazione del bambino (come più spesso si vede nei presepi) ed anche le mammelle di tante Madonne del latte rientrarono pudicamente nelle vesti.
QUESTA CANCELLAZIONE dei tratti corporei dal modello ideale di Madre e i contenuti teologici sottesi erano destinati a pesare non poco nell’autorappresentazione e nell’identità femminile, connotando l’esperienza materna di aspetti ambivalenti. Il tabù del parto, l’impurità della puerpera, che escludeva la madre perfino dal battesimo del figlio, non furono scalfiti dalla «rivoluzione cristiana», pesando, fino ad un passato molto prossimo, come un’ombra nera sul suo corpo fecondo.
In questo modo la forza, il coraggio e la capacità delle donne di mettere al mondo restavano avvolti in un alone di vergogna e impurità che solo in tempi recenti ha cominciato a esser rivisto, grazie al movimento delle donne.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "Il massimo necessario. L’etica alla prova dell’amore" (S. Biancu). Una rec. di Andrea Grillo8 novembre 2020, di Federico La Sala
Ripensare con cura il linguaggio della antropologia e della teologia....
Libero e non esigibile, ma dovuto: sull’ultimo libro di Stefano Biancu
di Andrea Grillo *
Con lo stile pacato che abbiamo imparato ad apprezzare nei suoi libri precedenti, e con grande finezza, in questo volume (Il massimo necessario. L’etica alla prova dell’amore, Milano, Mimesis, 2020) Stefano Biancu - che insegna Filosofia morale alla Lumsa di Roma - scandaglia con bella chiarezza un tema “minore” della tradizione della filosofia morale (le “azioni supererogatorie”), portandone alla luce non solo riletture recenti assai promettenti, ma facendolo diventare quasi il luogo di evidenza di una “diversa logica” nel pensare l’agire morale.
Il libro è costruito in modo lineare. Fin dalla Introduzione (“Per iniziare”), è posta la questione centrale: ci sono alcune azioni che la tradizione teologica e filosofica ha riconosciute come “esterne” all’ambito morale e giuridico, e che tuttavia qualificano in modo decisivo l’intelletto d’amore: è ciò che è stato chiamato “supererogatorio”. Così il libro, muovendo da una appassionata ed appassionante “storia del termine” (cap. 1: Il supererogatorio), lo valorizza come chiave di lettura di uno dei temi decisivi della “modernità”: la fraternità (cap. 2). Ciò permette di elaborare, mediante la traduzione della terminologia classica della filosofia morale in nuove categorie, aggiornate nel confronto con il pensiero contemporaneo, una comprensione delle tensioni che il pensiero moderno (etico, giuridico e politico) vive per giustificare non solo la libertà e l’uguaglianza, ma anche la fraternità. Il “massimo necessario” della fraternità non è solo fondato su una libertà ed eguaglianza originaria, ma sta pure all’origine della libertà e della uguaglianza. Questa sfida viene giocata in relazione a tre termini, che definiscono la “fraternità in atto”: l’ospitalità (cap. 3), il perdono (cap. 4) e la misericordia (cap. 5). Una lettura solo etica o giuridica di queste tre categorie è votata al fallimento. Per darne conto, occorre attingere ad una dimensione “previa” - che Biancu chiama “antropologica” - e che costituisce l’orizzonte nel quale il “soggetto di diritto” trova il fondamento della propria dignità.
Nel discorso di Biancu, che resta intenzionalmente e accuratamente un testo di carattere filosofico, appaiono discretamente, ma autoreveolmente, fonti teologiche. D’altra parte, per fare i conti con i temi della fratellanza, della ospitalità, del perdono e della misericordia non è possibile aggirare né il “grande codice” biblico, né la elaborazione che di esso ha fornito la tradizione teologica.
Per questo il libro di Biancu a me pare anche una buona guida per un lavoro esplicitamente teologico, che voglia arricchire la prospettiva di riflessione sulla libertà, sulla eguaglianza e sulla fratellanza, ponendo in luce un presupposto non solo “antropologico”, ma “teologico” delle categorie in gioco. E’ la genealogia del soggetto ad essere qui arricchita e problematizzata, nella sua relazione al prossimo e a Dio come costitutiva della sua identità. La differenza tra ciò che può essere “esigito” e ciò che è doveroso - in altri termini tra i diritti/doveri e i doni - costituisce un guadagno teorico che trova origine in una “esperienza della azione” più complessa di quella a cui siamo abituati.
 Non ci sono solo azioni “imposte, vietate o libere”. Ci sono anche “azioni supererogatorie”, che non sono riducibili a questa “triade”, ma che costituiscono l’orizzonte di fratellanza, di ospitalità, di perdono e di misericordia nel quale ogni soggetto può “venire al mondo”. Sono libere e non esigibili, ma necessarie e dovute. La non contraddittorietà tra queste due affermazioni - sulla libertà e sulla necessità - implica un “cambio di paradigma” che investe non solo la filosofia morale, ma anche la antropologia e la teologia. E il superamento delle “classiche opposizioni” di cui si è nutrita la tradizione filosofica e teologica che ci chiede la comprensione della misericordia - al di qua e al di là delle coppie interiore/esteriore, immanente/trascendente, necessario/possibile, pubblico/privato - dimostrano la bella fecondità della prospettiva assunta.
Non ci sono solo azioni “imposte, vietate o libere”. Ci sono anche “azioni supererogatorie”, che non sono riducibili a questa “triade”, ma che costituiscono l’orizzonte di fratellanza, di ospitalità, di perdono e di misericordia nel quale ogni soggetto può “venire al mondo”. Sono libere e non esigibili, ma necessarie e dovute. La non contraddittorietà tra queste due affermazioni - sulla libertà e sulla necessità - implica un “cambio di paradigma” che investe non solo la filosofia morale, ma anche la antropologia e la teologia. E il superamento delle “classiche opposizioni” di cui si è nutrita la tradizione filosofica e teologica che ci chiede la comprensione della misericordia - al di qua e al di là delle coppie interiore/esteriore, immanente/trascendente, necessario/possibile, pubblico/privato - dimostrano la bella fecondità della prospettiva assunta.In altri termini, per dar conto davvero delle “azioni supererogatorie”, occorre ripensare con cura il linguaggio della antropologia e della teologia. Comprendere davvero fraternità, ospitalità, perdono e misericordia implica una “intelligenza di sé e del mondo” di altra e alta qualità, che impegna il pensiero non solo dei filosofi, ma anche dei teologi.
All’inizio del libro Stefano Biancu ha posto una frase esemplare, tratta dai quaderni di A. Camus, che recita: “Se dovessi scrivere un libro di morale, esso avrebbe cento pagine e 99 sarebbero bianche. Sull’ultima scriverei: conosco un solo dovere ed è quello di amare”. Nel suo bel volume Stefano Biancu propone un serio tentativo di dar voce a quelle 99 pagine .
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’ULTIMO PAPA CEDE IL PASSO A ZARATHUSTRA: "CHI AMA, AMA AL DI LA’ DEL PREMIO E DELLA RIVALSA".
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- L’URLO DI ITALO CALVINO E I DIRITTI DELLE DONNE. Quel corpo è nostro (di Ilaria Romeo).8 novembre 2020, di Federico La Sala
I diritti delle donne
Quel corpo è nostro
di Ilaria Romeo (Collettiva, 08.11.2020)
L’8 novembre 1975 la Cassazione dichiara valido il numero di firme raccolte per il referendum abrogativo delle norme che vietano l’aborto. Il voto si terrà l’anno successivo tra polemiche e dibattiti spesso animati da una chiara misoginia come lo scontro tra Italo Calvino che difendeva la libertà femminile e Claudio Magris e Pier Paolo Pasolini, antiabortisti
Per stimolare ed affrettare il Parlamento all’approvazione di una legge sulla interruzione volontaria della gravidanza, nel 1975 il Partito Radicale e il Mld prendono l’iniziativa di raccogliere le firme per un Referendum abrogativo delle norme del Codice penale che vietano l’aborto.
L’8 novembre 1975 la Cassazione dichiara valido il numero di firme per il referendum (se non subentrerà una nuova legge le votazioni dovranno tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno 1976). Scriveva Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera il 19 gennaio di quell’anno:
- Io sono per gli otto referendum del partito radicale, e sarei disposto ad una campagna anche immediata in loro favore. Condivido col partito radicale l’ansia della ratificazione, l’ansia cioè del dar corpo formale a realtà esistenti: che è il primo principio della democrazia. Sono però traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio.
 Nei sogni, e nel comportamento quotidiano - cosa comune a tutti gli uomini - io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente. Mi limito a dir questo, perché, a proposito dell’aborto, ho cose più urgenti da dire. Che la vita è sacra è ovvio: è un principio più forte ancora che ogni principio della democrazia, ed è inutile ripeterlo. La prima cosa che vorrei invece dire è questa: a proposito dell’aborto, è il primo, e l’unico, caso in cui i radicali e tutti gli abortisti democratici più puri e rigorosi, si appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono alla prevaricazione “cinica” dei dati di fatto e del buon senso. Se essi si sono posti sempre, anzitutto, e magari idealmente (com’è giusto), il problema di quali siano i “principi reali” da difendere, questa volta non l’hanno fatto. Ora, come essi sanno bene, non c’è un solo caso in cui i “principi reali” coincidano con quelli che la maggioranza considera propri diritti. Nel contesto democratico, si lotta, certo per la maggioranza, ossia per l’intero consorzio civile, ma si trova che la maggioranza, nella sua santità, ha sempre torto: perché il suo conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente repressivo. Perché io considero non “reali” i principi su cui i radicali ed in genere i progressisti (conformisticamente) fondano la loro lotta per la legalizzazione dell’aborto? Per una serie caotica, tumultuosa e emozionante di ragioni.
Nei sogni, e nel comportamento quotidiano - cosa comune a tutti gli uomini - io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne: so che là io ero esistente. Mi limito a dir questo, perché, a proposito dell’aborto, ho cose più urgenti da dire. Che la vita è sacra è ovvio: è un principio più forte ancora che ogni principio della democrazia, ed è inutile ripeterlo. La prima cosa che vorrei invece dire è questa: a proposito dell’aborto, è il primo, e l’unico, caso in cui i radicali e tutti gli abortisti democratici più puri e rigorosi, si appellano alla Realpolitik e quindi ricorrono alla prevaricazione “cinica” dei dati di fatto e del buon senso. Se essi si sono posti sempre, anzitutto, e magari idealmente (com’è giusto), il problema di quali siano i “principi reali” da difendere, questa volta non l’hanno fatto. Ora, come essi sanno bene, non c’è un solo caso in cui i “principi reali” coincidano con quelli che la maggioranza considera propri diritti. Nel contesto democratico, si lotta, certo per la maggioranza, ossia per l’intero consorzio civile, ma si trova che la maggioranza, nella sua santità, ha sempre torto: perché il suo conformismo è sempre, per propria natura, brutalmente repressivo. Perché io considero non “reali” i principi su cui i radicali ed in genere i progressisti (conformisticamente) fondano la loro lotta per la legalizzazione dell’aborto? Per una serie caotica, tumultuosa e emozionante di ragioni.
Un mese dopo anche lo scrittore Claudio Magris interverrà sulle pagine del Corriere esprimendo una posizione fortemente antiabortista e a tratti misogina che arrivava a irridere le misure igieniche in un articolo intitolato Gli sbagliati (nel 1981, imperterrito, Magris, in occasione del referendum sull’aborto, scriverà un altro articolo per il Corriere, schierandosi con gli avversari dell’aborto, come aveva già fatto. In questo caso però la testata aspetterà a pubblicare il pezzo all’indomani del referendum).
 A Pasolini - e a Claudio Magris - risponde, a caldo, Italo Calvino:
A Pasolini - e a Claudio Magris - risponde, a caldo, Italo Calvino:- Caro Magris, con grande dispiacere leggo il tuo articolo Gli sbagliati. Sono molto addolorato non solo che tu l’abbia scritto, ma soprattutto che tu pensi in questo modo.
- Mettere al mondo un figlio ha un senso solo se questo figlio è voluto, coscientemente e liberamente dai due genitori. Se no è un atto animalesco e criminoso. Un essere umano diventa tale non per il casuale verificarsi di certe condizioni biologiche, ma per un atto di volontà e d’amore da parte degli altri. Se no, l’umanità diventa -come in larga parte già è- una stalla di conigli. Ma non si tratta più della stalla “agreste”, ma d’un allevamento “in batteria” nelle condizioni d’artificialità in cui vive a luce artificiale e con mangime chimico. Solo chi - uomo e donna - è convinto al cento per cento d’avere la possibilità morale e materiale non solo d’allevare un figlio ma d’accoglierlo come una presenza benvenuta e amata, ha il diritto di procreare; se no, deve per prima cosa far tutto il possibile per non concepire e se concepisce (dato che il margine d’imprevedibilità continua a essere alto) abortire non è soltanto una triste necessità, ma una decisione altamente morale da prendere in piena libertà di coscienza.
 Non capisco come tu possa associare l’aborto a un’idea d’edonismo o di vita allegra. L’aborto è una cosa spaventosa. Nell’aborto chi viene massacrato, fisicamente e moralmente, è la donna; anche per un uomo cosciente ogni aborto è una prova morale che lascia il segno, ma certo qui la sorte della donna è in tali sproporzionate condizioni di disfavore in confronto a quella dell’uomo, che ogni uomo prima di parlare di queste cose deve mordersi la lingua tre volte.
Non capisco come tu possa associare l’aborto a un’idea d’edonismo o di vita allegra. L’aborto è una cosa spaventosa. Nell’aborto chi viene massacrato, fisicamente e moralmente, è la donna; anche per un uomo cosciente ogni aborto è una prova morale che lascia il segno, ma certo qui la sorte della donna è in tali sproporzionate condizioni di disfavore in confronto a quella dell’uomo, che ogni uomo prima di parlare di queste cose deve mordersi la lingua tre volte.
 Nel momento in cui si cerca di rendere meno barbara una situazione che per la donna è veramente spaventosa, un intellettuale impiega la sua autorità perché la donna sia mantenuta in questo inferno. Sei un bell’incosciente, a dir poco, lascia che te lo dica. Non riderei tanto delle “misure igienico-profilattiche”; certo, a te un raschiamento all’utero non te lo faranno mai. Ma vorrei vederti se t’obbligassero a essere operato nella sporcizia e senza poter ricorrere agli ospedali, pena la galera. Il tuo vitalismo dell’“integrità del vivere” è per lo meno fatuo. Che queste cose le dica Pasolini, non mi meraviglia. Di te credevo che sapessi che cosa costa e che responsabilità è il far vivere delle altre vite.
Nel momento in cui si cerca di rendere meno barbara una situazione che per la donna è veramente spaventosa, un intellettuale impiega la sua autorità perché la donna sia mantenuta in questo inferno. Sei un bell’incosciente, a dir poco, lascia che te lo dica. Non riderei tanto delle “misure igienico-profilattiche”; certo, a te un raschiamento all’utero non te lo faranno mai. Ma vorrei vederti se t’obbligassero a essere operato nella sporcizia e senza poter ricorrere agli ospedali, pena la galera. Il tuo vitalismo dell’“integrità del vivere” è per lo meno fatuo. Che queste cose le dica Pasolini, non mi meraviglia. Di te credevo che sapessi che cosa costa e che responsabilità è il far vivere delle altre vite.
Non dimentichiamo che fino a non tantissimi anni fa in Italia le donne non potevano votare, non potevano abortire né divorziare, potevano essere licenziate in caso di matrimonio, non potevano - da sposate - usare il proprio cognome, e se venivano uccise non era poi così grave, almeno non se si erano macchiate della colpa di aver leso l’onore maschile. Non dimentichiamo “che sarà sufficiente una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne siano rimessi in discussione”. Non dimentichiamo e soprattutto rEsistiamo, ieri, oggi, sempre.
- Io sono per gli otto referendum del partito radicale, e sarei disposto ad una campagna anche immediata in loro favore. Condivido col partito radicale l’ansia della ratificazione, l’ansia cioè del dar corpo formale a realtà esistenti: che è il primo principio della democrazia. Sono però traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto, perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO - LA SCOPERTA DEL DUE-IN-UNO E LA SCONFITTA DI SOCRATE. La riflessione di Hannah Arendt, Michel Foucault e Jan Patočka (di Lavinia Peluso) .4 novembre 2020, di Federico La Sala
Recensione a:
- Hannah Arendt, Socrate, Raffaello Cortina, Milano 2015, pp. 124. (Lavinia Peluso) *
Sappiamo che Socrate amava intrattenere conversazioni con i concittadini nell’agorà di Atene, ponendoli ironicamente di fronte a insolite questioni e sollecitandoli a spiegare e giustificare le proprie affermazioni al riguardo. Il filosofo non intendeva insegnare qualcosa ai suoi interlocutori e introiettare in loro una qualche conoscenza dall’esterno, bensì condurli a trovare la verità nascosta in se stessi, portandola alla luce attraverso l’interrogazione e lo sradicamento delle false doxai. Lo scopo era, cioè, quello di aiutare il soggetto a partorire la propria verità, seguendo la celebre metafora della maieutica proposta dallo stesso Socrate. L’obiettivo è realizzabile nel corso di una vita fatta di riflessione, interrogazione continua e messa in discussione dei convincimenti più radicati, poiché proprio dietro la più proclamata sicurezza può nascondersi una subdola ignoranza della verità. Solo a partire dalla conoscenza di se stessi e dal riconoscimento dei propri limiti, risulta possibile dare alla luce la verità. Precisamente in virtù dell’attività socratica, la filosofia inizia a delinearsi come conversazione dialettica e come disciplina caratterizzata da lineamenti precisi.
Non è un caso che la personalità di Socrate attraversi e accompagni la totalità della riflessione di Hannah Arendt, fornendo all’autrice un vivo esempio per la formulazione di tesi che ruotano intorno al controverso rapporto tra filosofia e politica, alla coscienza individuale e al tema del male.
 Il saggio Socrate compare per la prima volta in traduzione italiana nel 2015, figurando in origine come terza e ultima parte di un corso tenuto presso la Notre Dame University nel 1954.
Il saggio Socrate compare per la prima volta in traduzione italiana nel 2015, figurando in origine come terza e ultima parte di un corso tenuto presso la Notre Dame University nel 1954.
 Il testo si apre con un’introduzione a cura di Ilaria Possenti, la quale contestualizza il contributo arendtiano nel contesto della produzione letteraria dell’autrice, e che nelle sue considerazioni prende avvio da una lettera indirizzata da Arendt a Karl Jaspers nell’estate del 1956, dove l’autrice individua nel processo a Socrate il principio del conflitto tra filosofia e politica. Ricostruendo la genesi di questa contrapposizione, Possenti spiega che Arendt non condanna la polis ateniese, bensì chiama in causa Platone, l’allievo di Socrate. Egli avrebbe lasciato in eredità alla storia del pensiero occidentale due convinzioni fondamentali: “che la politica, così come Atene l’aveva intesa, fosse una pericolosa fonte di ingiustizia; e che i criteri per porre rimedio all’ingiustizia dovessero essere trovati altrove, al di fuori e al di sopra della polis” (p. 9). Ciò è evidente se ci rivolgiamo alla Repubblica: la città ideale delineata nel dialogo si regge su un ideale statico di giustizia, definito a priori, che deve la sua realizzazione nel contesto sociale alla reggenza dei filosofi, coloro che, distanti dalla polis, hanno dedicato la loro vita al puro pensiero inteso come noein, come intuizione e contemplazione della verità.
Il testo si apre con un’introduzione a cura di Ilaria Possenti, la quale contestualizza il contributo arendtiano nel contesto della produzione letteraria dell’autrice, e che nelle sue considerazioni prende avvio da una lettera indirizzata da Arendt a Karl Jaspers nell’estate del 1956, dove l’autrice individua nel processo a Socrate il principio del conflitto tra filosofia e politica. Ricostruendo la genesi di questa contrapposizione, Possenti spiega che Arendt non condanna la polis ateniese, bensì chiama in causa Platone, l’allievo di Socrate. Egli avrebbe lasciato in eredità alla storia del pensiero occidentale due convinzioni fondamentali: “che la politica, così come Atene l’aveva intesa, fosse una pericolosa fonte di ingiustizia; e che i criteri per porre rimedio all’ingiustizia dovessero essere trovati altrove, al di fuori e al di sopra della polis” (p. 9). Ciò è evidente se ci rivolgiamo alla Repubblica: la città ideale delineata nel dialogo si regge su un ideale statico di giustizia, definito a priori, che deve la sua realizzazione nel contesto sociale alla reggenza dei filosofi, coloro che, distanti dalla polis, hanno dedicato la loro vita al puro pensiero inteso come noein, come intuizione e contemplazione della verità.
 Secondo Arendt, Platone definì “i termini del conflitto tra filosofia e politica” (p. 10), generando uno iato tra le due, di cui l’autrice lo accusa direttamente. L’allievo fallì così nel cogliere l’eredità del maestro, in cui filosofia e politica risultano invece coessenziali: “così facendo, Platone inaugura la ‘grande tradizione’ rendendo immortale la figura di Socrate e marginale il suo pensiero politico” (p. 11).
Secondo Arendt, Platone definì “i termini del conflitto tra filosofia e politica” (p. 10), generando uno iato tra le due, di cui l’autrice lo accusa direttamente. L’allievo fallì così nel cogliere l’eredità del maestro, in cui filosofia e politica risultano invece coessenziali: “così facendo, Platone inaugura la ‘grande tradizione’ rendendo immortale la figura di Socrate e marginale il suo pensiero politico” (p. 11).Arendt individua, invero, precisamente nella prospettiva socratica un’alternativa a una filosofia ormai esaurita, inserendola peraltro nella sua visione fenomenologica. Nell’ottica arendtiana, l’unica realtà è data dall’apparire e dal mondo comune, lo stesso mondo comune a cui si rivolgeva il filosofo greco. La sua concezione della “condizione umana, in qualche modo intesa come condizione ‘politica’, [...] dovrebbe aiutarci a ripensare da capo il senso della vita della polis [...] e l’oggetto stesso della ‘meraviglia’ filosofica - la pluralità che ci unisce, ci distingue e ci attraversa” (p. 18): è precisamente in ciò che possiamo individuare il fulcro delle riflessioni arendtiane contenute in Socrate.
Il saggio si apre con Il processo di Socrate e la replica di Platone. L’autrice inizia le sue considerazioni partendo dal contesto di appartenenza del filosofo, dominato dall’arte della persuasione, l’arte più elevata e più prettamente politica, che rappresenta ciò in cui fallì Socrate, non riuscendo a persuadere i giudici della sua innocenza. Il filosofo non avrebbe dovuto mirare a far partorire una verità che i giudici non erano disposti ad accogliere, bensì a persuaderli della validità del suo punto di vista.
 Nell’ottica platonica, la causa della sconfitta del maestro è da ricercare nel fatto che Socrate si rivolse ai giudici nello stesso modo in cui era solito conversare con gli Ateniesi, secondo il metodo dialettico, e non retorico: il dialeghesthai, però, risulta possibile solo come dialogo tra due soggetti, mentre peitho si rivolge sempre a una moltitudine, ragione per cui Socrate avrebbe dovuto ricorrere alla persuasione piuttosto che alla dialettica. Ciò condusse Platone a dubitare del valore del peithein e con esso anche della doxa, che il maestro cercava di far esprimere agli interlocutori: “è lo spettacolo di Socrate che sottopone la propria doxa alle opinioni irresponsabili degli Ateniesi, e che viene infine sconfitto da una maggioranza, a spingere Platone al disprezzo delle opinioni e a fare di lui un ardente fautore di criteri assoluti” (pp. 26-27).
Nell’ottica platonica, la causa della sconfitta del maestro è da ricercare nel fatto che Socrate si rivolse ai giudici nello stesso modo in cui era solito conversare con gli Ateniesi, secondo il metodo dialettico, e non retorico: il dialeghesthai, però, risulta possibile solo come dialogo tra due soggetti, mentre peitho si rivolge sempre a una moltitudine, ragione per cui Socrate avrebbe dovuto ricorrere alla persuasione piuttosto che alla dialettica. Ciò condusse Platone a dubitare del valore del peithein e con esso anche della doxa, che il maestro cercava di far esprimere agli interlocutori: “è lo spettacolo di Socrate che sottopone la propria doxa alle opinioni irresponsabili degli Ateniesi, e che viene infine sconfitto da una maggioranza, a spingere Platone al disprezzo delle opinioni e a fare di lui un ardente fautore di criteri assoluti” (pp. 26-27).
 L’adesione platonica a una normatività suprema è, dunque, motivata da Arendt in base alla delusione provata di fronte alla condanna del maestro. A una politica basata sull’opinione plurale, Platone sostituì principi univoci e inequivocabili che non possono essere oggetto di persuasione. Ma egli andò ben oltre la vendetta del maestro affidando il governo ai filosofi, a quei sophoi che per definizione esulano dalla sfera degli affari della città, ribaltando il vecchio aneddoto di Talete deriso dalla servetta perché caduto nel pozzo, in quanto troppo intento a guardare il cielo. Cionondimeno, se Socrate fu il primo filosofo a rivestire un ruolo politico, Platone fu l’ultimo.
L’adesione platonica a una normatività suprema è, dunque, motivata da Arendt in base alla delusione provata di fronte alla condanna del maestro. A una politica basata sull’opinione plurale, Platone sostituì principi univoci e inequivocabili che non possono essere oggetto di persuasione. Ma egli andò ben oltre la vendetta del maestro affidando il governo ai filosofi, a quei sophoi che per definizione esulano dalla sfera degli affari della città, ribaltando il vecchio aneddoto di Talete deriso dalla servetta perché caduto nel pozzo, in quanto troppo intento a guardare il cielo. Cionondimeno, se Socrate fu il primo filosofo a rivestire un ruolo politico, Platone fu l’ultimo.Nella seconda parte del saggio Arendt passa a discutere in maniera sistematica la posizione di Socrate. Nella ricostruzione arendtiana, egli fu indubbiamente il primo a ricorrere al dialeghesthai, ma senza considerarlo la controparte di peitho e della doxa, come arrivò invece a fare l’allievo.
 Nella prospettiva socratica, la doxa corrisponde alla comprensione che ognuno ha del mondo, della maniera in cui la realtà si apre e si mostra al soggetto particolare, a seconda del posto occupato in essa. È lo stesso mondo comune a rivelarsi, presentandosi però a ciascuno in modo diverso. Ciò spiega perché la dialettica socratica prenda avvio da una serie di domande attraverso le quali il filosofo cerca di capire quale sia la posizione del suo interlocutore nella realtà, al fine di aiutarlo poi a portare alla luce la propria verità: “Socrate voleva rendere la città più veritiera facendo partorire a ogni cittadino la propria verità. Il metodo per farlo è il dialeghesthai, ma quest’arte dialettica [...] non distrugge la doxa, l’opinione; al contrario, ne rivela la veridicità” (p. 35).
Nella prospettiva socratica, la doxa corrisponde alla comprensione che ognuno ha del mondo, della maniera in cui la realtà si apre e si mostra al soggetto particolare, a seconda del posto occupato in essa. È lo stesso mondo comune a rivelarsi, presentandosi però a ciascuno in modo diverso. Ciò spiega perché la dialettica socratica prenda avvio da una serie di domande attraverso le quali il filosofo cerca di capire quale sia la posizione del suo interlocutore nella realtà, al fine di aiutarlo poi a portare alla luce la propria verità: “Socrate voleva rendere la città più veritiera facendo partorire a ogni cittadino la propria verità. Il metodo per farlo è il dialeghesthai, ma quest’arte dialettica [...] non distrugge la doxa, l’opinione; al contrario, ne rivela la veridicità” (p. 35).
 La maieutica di Socrate assume dunque i tratti di un’attività politica, che mira a rendere migliori i cittadini, facendo di loro in ultima istanza degli amici, in contrasto con lo spirito agonale regnante nella polis, costituente una minaccia per il bene comune. In particolare, l’aspetto politico dell’amicizia risiede nel fatto che l’amico è capace di comprendere il modo in cui la realtà si apre all’altro, attraverso il dialeghesthai socratico: si tratta della stessa virtù dell’uomo politico, il quale dovrebbe dimostrarsi in grado di comprendere lo spettro più ampio possibile di realtà, al fine di rendere evidente l’essere-in-comune del mondo e formare su tale base una comunità, costruendola sulla comprensione propria degli amici.
La maieutica di Socrate assume dunque i tratti di un’attività politica, che mira a rendere migliori i cittadini, facendo di loro in ultima istanza degli amici, in contrasto con lo spirito agonale regnante nella polis, costituente una minaccia per il bene comune. In particolare, l’aspetto politico dell’amicizia risiede nel fatto che l’amico è capace di comprendere il modo in cui la realtà si apre all’altro, attraverso il dialeghesthai socratico: si tratta della stessa virtù dell’uomo politico, il quale dovrebbe dimostrarsi in grado di comprendere lo spettro più ampio possibile di realtà, al fine di rendere evidente l’essere-in-comune del mondo e formare su tale base una comunità, costruendola sulla comprensione propria degli amici.È sul tema della philia che Arendt struttura la parte più dinamica del saggio, La scoperta del “due-in-uno”. -Premessa indispensabile di questo capitolo è il precetto delfico “Gnôthi sautón”, esemplificato dalla personalità socratica. Nell’ottica arendtiana, l’invito alla conoscenza di se stessi comporta che il principio guida del soggetto deve tradursi nella comprensione veritiera della propria doxa e nell’accordo dell’individuo con se stesso, ossia nella philia interiore. La paura di incorrere in questo genere di contraddizione è giustificata in base al fatto che ognuno di noi può parlare con se stesso: nel pensiero ognuno di noi è due-in-uno, e l’armonia di questa dualità si pone come la condizione imprescindibile per l’accordo con l’altro; la paura della contraddizione, dunque, altro non è che timore della scissione e della perdita della coerenza. La pluralità si rivela così come una condizione ineliminabile della natura umana, dacché è sì possibile l’allontanamento da qualsiasi forma di organizzazione sociale, ma mai dall’altro dentro di noi.
 Ciò implica la convivenza con un testimone di tutte le azioni individuali, con uno spettatore giudicante a cui non è possibile sfuggire: è quel tribunale che la modernità chiamerà coscienza. L’io è così sdoppiato in imputato e testimone, in esecutore e pubblico.
Ciò implica la convivenza con un testimone di tutte le azioni individuali, con uno spettatore giudicante a cui non è possibile sfuggire: è quel tribunale che la modernità chiamerà coscienza. L’io è così sdoppiato in imputato e testimone, in esecutore e pubblico.
 Vista l’impossibilità della separazione da quest’ultimo, per il soggetto è preferibile essere in disaccordo con l’intera società piuttosto che con se stesso, col quale deve sempre convivere: si tratta precisamente della tesi affermata da Socrate nel Gorgia, dove egli dimostra peraltro con forza che è meglio subire un’ingiustizia piuttosto che commetterla (Gorg. 482b). Il compimento di un atto malvagio comporta la convivenza obbligata con un individuo che vorremmo invece evitare e col quale non è possibile essere in armonia, dacché nessuno sceglierebbe di accompagnarsi a un criminale. Ciò costituisce dunque una situazione di disaccordo interiore, accentuata dalla presenza di un testimone che giudica negativamente le nostre azioni malvagie.
La pluralità esterna può anzi distrarci dalla molteplicità più angosciante, rappresentata dal due-in-uno. Nella discussione, inoltre, l’altro ci riconosce come singolo, come una sola voce.
Vista l’impossibilità della separazione da quest’ultimo, per il soggetto è preferibile essere in disaccordo con l’intera società piuttosto che con se stesso, col quale deve sempre convivere: si tratta precisamente della tesi affermata da Socrate nel Gorgia, dove egli dimostra peraltro con forza che è meglio subire un’ingiustizia piuttosto che commetterla (Gorg. 482b). Il compimento di un atto malvagio comporta la convivenza obbligata con un individuo che vorremmo invece evitare e col quale non è possibile essere in armonia, dacché nessuno sceglierebbe di accompagnarsi a un criminale. Ciò costituisce dunque una situazione di disaccordo interiore, accentuata dalla presenza di un testimone che giudica negativamente le nostre azioni malvagie.
La pluralità esterna può anzi distrarci dalla molteplicità più angosciante, rappresentata dal due-in-uno. Nella discussione, inoltre, l’altro ci riconosce come singolo, come una sola voce.
 Poste queste premesse, abbiamo modo di comprendere in che modo le presenti considerazioni si pongano in stretta relazione con quanto affermato relativamente alla philia. Solo chi, vivendo l’esperienza del dialogo interiore, è in accordo con se stesso e una persona affidabile, che in quanto tale può diventare un amico, definito in termini aristotelici come un altro se stesso, secondo a quello che abbiamo dentro di noi. Se, cioè, l’individuo supera il giudizio del tribunale della coscienza presieduto da se medesimo, dimostrandosi un compagno leale, può rapportarsi con l’altro in quanto uno, in qualità di soggetto coerente con se stesso e degno di fiducia.
Poste queste premesse, abbiamo modo di comprendere in che modo le presenti considerazioni si pongano in stretta relazione con quanto affermato relativamente alla philia. Solo chi, vivendo l’esperienza del dialogo interiore, è in accordo con se stesso e una persona affidabile, che in quanto tale può diventare un amico, definito in termini aristotelici come un altro se stesso, secondo a quello che abbiamo dentro di noi. Se, cioè, l’individuo supera il giudizio del tribunale della coscienza presieduto da se medesimo, dimostrandosi un compagno leale, può rapportarsi con l’altro in quanto uno, in qualità di soggetto coerente con se stesso e degno di fiducia.Nella quarta parte, La sconfitta di Socrate, Arendt riflette sulle conseguenze tangibili della visione socratica analizzata nelle pagine precedenti. “Il conflitto tra la filosofia e la politica, tra il filosofo e la polis, esplose dopo che Socrate, più che svolgere un ruolo politico, aveva voluto rendere la filosofia rilevante per la polis” (p. 48): l’opposizione si concluse con la sconfitta della filosofia e determinò la separazione tra pensiero e azione, conducendo la figura del filosofo a disinteressarsi degli affari della polis.
 Nella lettura arendtiana, la filosofia venne così a trovarsi di fronte a un bivio: interpretare l’esperienza filosofica secondo le categorie degli affari umani, oppure giudicare quanto rientra nella sfera politica alla luce della visione filosofica. È in questa seconda direzione che è andato Platone, costruendo una polis retta dai filosofi. Nella parabola della caverna egli condensa la biografia del filosofo, il quale si trova ad attraversare emblematici momenti di ribaltamento del proprio essere.
Nella lettura arendtiana, la filosofia venne così a trovarsi di fronte a un bivio: interpretare l’esperienza filosofica secondo le categorie degli affari umani, oppure giudicare quanto rientra nella sfera politica alla luce della visione filosofica. È in questa seconda direzione che è andato Platone, costruendo una polis retta dai filosofi. Nella parabola della caverna egli condensa la biografia del filosofo, il quale si trova ad attraversare emblematici momenti di ribaltamento del proprio essere.Ma Platone non ci spiega perché il filosofo decida di intraprendere questo percorso. Per risolvere la questione, Arendt richiama quanto si legge nel Teeteto, dove Platone individua l’elemento alla base della nascita della filosofia: “la meraviglia è ciò che appassiona di più il filosofo, poiché non c’è altra origine della filosofia diversa dalla meraviglia” (Thaet. 155d). Ed è proprio con la questione del thaumazein che Arendt chiude questo scritto. A suo avviso, la meraviglia nell’ottica platonica consiste in un pathos, in qualcosa rispetto a cui il soggetto è passivo e che non può trovare espressione nelle parole, ma che consente al soggetto di cogliere l’autentico significato della formula socratica “So di non sapere”. Nel momento in cui l’individuo subisce il thaumazein, capisce cosa significa non sapere. Da tale consapevolezza deriva l’impulso alla filosofia e alla continua interrogazione socratica. Arendt conclude il saggio rivolgendosi ai filosofi contemporanei, i quali, se vorranno raggiungere una nuova filosofia politica in seguito al conflitto con la polis, dovranno “però assumere come oggetto del thaumazein la pluralità degli uomini, dalla quale sorge [...] l’intera sfera degli affari umani” (p. 62).
I due saggi critici di Adriana Cavarero e Simona Forti, in appendice al testo di Arendt, rappresentano un interessante ausilio alla riflessione sul saggio. Cavarero nel suo commento, Il Socrate di Hannah Arendt, si concentra sulla comparsa della personalità socratica in due particolari momenti della riflessione arendtiana, ripercorrendo anche le differenze originarie rispetto allo sviluppo platonico: la prima scena colloca Socrate all’origine di una “pratica filosofica e insieme genuinamente politica” (p. 73), e individua nell’antitesi tra il maestro e l’allievo la scissione della filosofia dalla sfera politica e la conseguente fuga del sophos da tale contesto; l’altra situazione riconosce in Socrate il fondatore di un modello di pensare critico, l’ideatore della coscienza moderna, intesa nei termini di un tribunale interiore in cui il soggetto si interroga e deve rendere conto di sé a se stesso.
 Se, però, nelle sue riflessioni Arendt ci ha convinto a difendere Socrate, Cavarero nel suo commento prende invece le parti di Platone, il quale è messo sotto inchiesta nel saggio arendtiano. Nelle pagine precedenti, infatti, ci siamo imbattuti nella disamina delle colpe metafisiche dell’allievo, che si possono riassumere in ultima analisi nel sacrificio di quella pluralità al cuore dell’insegnamento socratico a favore del totalitarismo dell’Uno, che si pone come l’oggetto supremo della conoscenza muta e contemplativa del filosofo. Cionondimeno, Cavarero ricorda al lettore che l’istante della contemplazione è sì presentato da Platone come la forma più elevata del pensiero, ma il filosofo ammette l’esistenza anche di altre articolazioni del conoscere, tra cui quella del “dialogo senza voce che l’anima fa con se stessa” (Soph. 263e). Tuttavia, Arendt sembra attribuire questo riconoscimento esclusivamente a Socrate, ma risulta evidente la presenza del dialogo silenzioso nell’interiorità dell’individuo anche nel contesto della riflessione platonica. La lezione che indubbiamente è doveroso trarre dall’insegnamento socratico, a discapito dell’allievo, è quella di “ripensare l’umanità, o forse pensarla per la prima volta nei suoi tratti concreti [...] registrare la pluralità che rende ciascun essere umano un essere unico, diverso da ogni altro” (p. 97).
Se, però, nelle sue riflessioni Arendt ci ha convinto a difendere Socrate, Cavarero nel suo commento prende invece le parti di Platone, il quale è messo sotto inchiesta nel saggio arendtiano. Nelle pagine precedenti, infatti, ci siamo imbattuti nella disamina delle colpe metafisiche dell’allievo, che si possono riassumere in ultima analisi nel sacrificio di quella pluralità al cuore dell’insegnamento socratico a favore del totalitarismo dell’Uno, che si pone come l’oggetto supremo della conoscenza muta e contemplativa del filosofo. Cionondimeno, Cavarero ricorda al lettore che l’istante della contemplazione è sì presentato da Platone come la forma più elevata del pensiero, ma il filosofo ammette l’esistenza anche di altre articolazioni del conoscere, tra cui quella del “dialogo senza voce che l’anima fa con se stessa” (Soph. 263e). Tuttavia, Arendt sembra attribuire questo riconoscimento esclusivamente a Socrate, ma risulta evidente la presenza del dialogo silenzioso nell’interiorità dell’individuo anche nel contesto della riflessione platonica. La lezione che indubbiamente è doveroso trarre dall’insegnamento socratico, a discapito dell’allievo, è quella di “ripensare l’umanità, o forse pensarla per la prima volta nei suoi tratti concreti [...] registrare la pluralità che rende ciascun essere umano un essere unico, diverso da ogni altro” (p. 97).Il saggio di Simona Forti, Letture socratiche. Arendt, Foucault, Patočka, è dedicato alle interpretazioni posteriori della figura di Socrate, in particolare, all’analisi dei tratti di quella “grande tribù del socratismo novecentesco della filosofia come forma di vita” (p. 100). Questa corrente individua in Socrate una testimonianza vivente di una condotta “che si singolarizza scegliendo per quanto possibile lo spazio indeterminato della libertà” (p. 100), distaccandosi da un’etica fondata su regole universali che definiscono a priori il bene e il male, delineandosi peraltro come una soggettività immanente che si assume la responsabilità delle azioni individuali di fronte all’altro e al soggetto stesso. In particolare, l’autrice individua un’affinità concettuale tra la prospettiva socratica sul daimon e la parresia e la riflessione di Hannah Arendt, Michel Foucault e Jan Patočka, commentatori novecenteschi del filosofo greco.
Se al centro della riflessione arendtiana vi è la scoperta del due-in-uno, al cuore dell’indagine di Foucault vi è, invece, la parresia, sulla quale Arendt non si sarebbe soffermata, secondo la lettura di Forti. La parresia può dischiudere uno spazio etico nuovo in cui l’interiorità si apre all’altro e alla collettività, delineandosi come una prassi politica in antitesi con l’adulazione e la retorica tipiche delle strutture di potere, dacché assume ad oggetto la verità.
 Per quanto concerne l’altra figura al centro del commento di Forti, Patočka, citato dallo stesso Foucault in un corso tenuto nel 1984, concepisce la cura di sé, dell’anima, come radice della cultura europea, nei termini di una pratica filosofica di continua riflessione e interrogazione del soggetto su se stesso, suscettibile di aprirsi alla prassi e così alla dissidenza nei confronti dei meccanismi di potere.
Per quanto concerne l’altra figura al centro del commento di Forti, Patočka, citato dallo stesso Foucault in un corso tenuto nel 1984, concepisce la cura di sé, dell’anima, come radice della cultura europea, nei termini di una pratica filosofica di continua riflessione e interrogazione del soggetto su se stesso, suscettibile di aprirsi alla prassi e così alla dissidenza nei confronti dei meccanismi di potere.
 In ultima analisi, ciò che unisce i tre volti novecenteschi nel loro confronto con Socrate è “la convinzione che l’azione politica [...] deve essere la manifestazione visibile di un’etica [...] l’effetto collaterale di un ethos, di una postura e di una condotta che si radicano saldamente nelle pieghe del ‘modo di vita’ del singolo” (p. 117). Ritornare a Socrate costituisce, dunque, un richiamo alla possibilità del soggetto di opporre resistenza alla forza delle circostanze, “è il nome della possibilità, del potere di ciascuno di resistere a un altro potere” (p. 123).
In ultima analisi, ciò che unisce i tre volti novecenteschi nel loro confronto con Socrate è “la convinzione che l’azione politica [...] deve essere la manifestazione visibile di un’etica [...] l’effetto collaterale di un ethos, di una postura e di una condotta che si radicano saldamente nelle pieghe del ‘modo di vita’ del singolo” (p. 117). Ritornare a Socrate costituisce, dunque, un richiamo alla possibilità del soggetto di opporre resistenza alla forza delle circostanze, “è il nome della possibilità, del potere di ciascuno di resistere a un altro potere” (p. 123).* Fonte: Discipline Filosofiche.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Io esisto perché tu esisti, per farla finita con il colonialismo (di Andrea Staid).1 ottobre 2020, di Federico La Sala
Io esisto perché tu esisti, per farla finita con il colonialismo
di Andrea Staid *
Come donne e uomini nati o cresciuti nella parte occidentale di questo mondo, quando guardiamo alle pratiche culturali e politiche degli “altri” dobbiamo porre molta attenzione a non comportarci da etnocentrici e pensare che la nostra visone di società, nel mio caso libertaria, sia unica ed esportabile in tutto il mondo. Credo che anche in questo caso, per affinare il nostro sguardo sull’alterità culturale, l’antropologia ci possa venire in aiuto con l’approccio relativista.
Ma cos’è il relativismo? È una teoria formulata a partire dal particolarismo culturale di Franz Boas e dall’antropologo statunitense Melville Jean Herskovits secondo i quali, considerato il carattere universale della cultura e la specificità di ogni ambito culturale, ogni società è unica e diversa da tutte le altre, mentre i costumi hanno sempre una giustificazione nel loro contesto specifico. Questo significa che i bisogni umani universali possono essere soddisfatti con mezzi culturalmente e politicamente diversi. Direi che su questo le lettrici e i lettori di Matrika non dovrebbero avere dubbi.
Quindi l’idea che gli elementi di una cultura debbano essere compresi e analizzati a partire dal contesto in cui agisce la specifica cultura porta alla conclusione che non si può considerare una cultura superiore o inferiore ad un’altra. Anche su questo non dovremmo avere dubbi.
È stato l’antropologo Melville Herskovits ad affermare, sulla scia dei precedenti fondamenti espressi da Franz Boas, che la specificità di ogni ambito culturale non consente analisi di carattere generale sul confronto tra culture.
Questa visione del mondo culturale degli “altri” ci mette in crisi e più che certezze fa nascere dubbi, ma questo non ci deve spaventare; l’importante è far diventare questi dubbi la possibilità di risposte nuove, la creazione di corpi politici ibridi e inediti.
Dobbiamo farla finita con il pericoloso e dannoso sguardo coloniale [1] che ancora ci attanaglia, dobbiamo essere in grado di fare i conti con il colonialismo e liberare i nostri sguardi troppo spesso eurocentrici e giudicanti. Per decostruire i nostri immaginari coloniali ci possono aiutare gli studi (post)coloniali, semplificando, potremmo dire che si raccolgono attorno a tre distinti filoni d’indagine critica: il primo, inaugurato da Orientalism di Edward Said nel 1978 ed ispirato alla teoria del discorso di Michel Foucault, si fonda sulla interpretazione del colonialismo come formazione discorsiva alimentato dalle istituzioni materiali dell’Impero; il secondo filone affonda nel pensiero decostruzionista e, come chiarisce Gayatri C. Spivak nel 1990 in The Post-colonial Critic, definisce il discorso coloniale come il prodotto retorico degli assiomi imperialistici che attengono in particolare alle questioni di razza e di genere; il terzo filone, il cui fondamento va ricercato nella psicoanalisi lacaniana che Homi K. Bhabha rilancia in The Location of Culture del 1994, è caratterizzato da una analisi della formazione del soggetto coloniale e dei processi di ibridazione nei quali colonizzati e colonizzatori sono coinvolti.
Anche le antropologhe e gli antropologi hanno sviluppato pratiche e teorie post-coloniali e non egemoniche, dove l’altro non era più una stranezza culturale da studiare ma un soggetto interlocutore con il quale rapportarsi.
Per questo ancora oggi dal mio punto di vista il concetto di relativismo culturale è imprescindibile sul campo. Trovo fondamentale ricordare che è stata una donna, Margaret Mead, che grazie alla sua attività divulgativa, la cui opera più celebre, L’adolescente in una società primitiva, può essere considerata paradigmatica dell’utilizzo di argomentazioni di carattere relativistico come strumento di critica della società occidentale.
 Il testo è frutto di una ricerca nelle isole Samoa, nella quale l’autrice sosteneva che le difficoltà personali incontrate dalle adolescenti occidentali, non sono universali e necessarie, ma contingenti e generate prevalentemente dalle costrizioni e dalle imposizioni che gli elementi più tradizionalisti e moralistici della cultura occidentale impongono. Le adolescenti samoane, al contrario, sarebbero lasciate libere di giungere alla maturità fisica, identitaria, sessuale, sociale, senza condizionamenti eccessivi e non soffrirebbero delle crisi e delle difficoltà incontrate dalle occidentali. Questo è un caso particolare, ma paradigmatico per capire il concetto relativista.
Il testo è frutto di una ricerca nelle isole Samoa, nella quale l’autrice sosteneva che le difficoltà personali incontrate dalle adolescenti occidentali, non sono universali e necessarie, ma contingenti e generate prevalentemente dalle costrizioni e dalle imposizioni che gli elementi più tradizionalisti e moralistici della cultura occidentale impongono. Le adolescenti samoane, al contrario, sarebbero lasciate libere di giungere alla maturità fisica, identitaria, sessuale, sociale, senza condizionamenti eccessivi e non soffrirebbero delle crisi e delle difficoltà incontrate dalle occidentali. Questo è un caso particolare, ma paradigmatico per capire il concetto relativista.L’impegno dell’antropologia, soprattutto nel periodo che va dai suoi esordi fino alla seconda guerra mondiale produce come conseguenza il superamento dell’antitesi tradizionale tra la superiorità della cultura europea e l’inferiorità degli altri popoli. Sono convinto che il pensiero libertario deve abbandonare completamente un approccio etnocentrico; non può pensarsi unico, giusto ed esportabile tout court nel pianeta, dobbiamo comprendere l’importanza di uno sguardo relativista. Il relativismo culturale è una risposta all’etnocentrismo e nega l’esistenza di un’unità di misura universale per la comprensione dei valori culturali e politici, poiché ogni cultura è portatrice di valori e norme che non hanno validità al di fuori della cultura stessa.
L’emergenza del relativismo culturale ha facilitato una comprensione più profonda e meno superficiale delle culture differenti da quella occidentale. Ma facciamo attenzione, quello che io propongo è un metodo per comprendere l’altro, non una sospensione totale del giudizio e del posizionamento politico dell’individuo. Per questo è molto importante fare una distinzione tra relativismo culturale e relativismo etico; il primo è quello che io propongo per meglio comprendere la cultura e la politica degli “altri”.
Il relativismo culturale (metodologico) va tenuto distinto dal relativismo etico: mentre il primo costituisce un approccio metodologico, indica cioè quale debba essere la metodologia corretta per analizzare i fenomeni culturali, il secondo si riferisce ad un atteggiamento di sospensione del giudizio etico e morale circa usanze, politiche e costumi presenti nelle varie culture.
 Per il relativismo etico, vale il principio di equivalenza di ogni prescrizione morale; se infatti non esiste una verità assoluta di riferimento in base a cui poter distinguere il bene dal male, allora tutto è lecito, affermazione che pretende di porsi a sua volta come una norma assoluta, a dispetto del presunto carattere “non prescrittivo” del relativismo. Non è tutto relativo, al contrario; ma per comprendere gli “altri” dobbiamo relativizzare il nostro sguardo. (Andrea Staid Blog)
Per il relativismo etico, vale il principio di equivalenza di ogni prescrizione morale; se infatti non esiste una verità assoluta di riferimento in base a cui poter distinguere il bene dal male, allora tutto è lecito, affermazione che pretende di porsi a sua volta come una norma assoluta, a dispetto del presunto carattere “non prescrittivo” del relativismo. Non è tutto relativo, al contrario; ma per comprendere gli “altri” dobbiamo relativizzare il nostro sguardo. (Andrea Staid Blog)1 Per colonialismo si intende la politica di conquista, invasione e depredazione di territori e risorse (materiali e umane) attuata dalle potenze europee a partire dal XV secolo. Indica inoltre l’insieme dei principi a sostegno di tale politica e, infine, l’organizzazione del sistema di dominio. Lo sviluppo del colonialismo può essere distinto in due fasi: la prima, che parte dal XV secolo fino alla metà del XIX secolo; la seconda, che parte dagli ultimi decenni del XIX secolo e termina a metà degli anni Settanta del Novecento con il crollo del sistema coloniale portoghese. Purtroppo la mentalità colonialista e i soprusi economici e politici colonialisti delle potenze occidentali sono ancora in atto anche se formalmente e storicamente il periodo coloniale dovrebbe essere concluso.
* Fonte: Matrika.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO -- Donna e libertà: il decalogo per la parità. Il manifesto per un nuovo femminismo (di Rossana Rossanda).24 settembre 2020, di Federico La Sala
Donna e libertà
Il manifesto per un nuovo femminismo di Rossana Rossanda
Tutte le sfide della maternità in una società che resta maschilista da una protagonista delle battaglie comuniste il decalogo per la parità
di Rossana Rossanda (l’Espresso, 13 maggio 2019).
Si può pensarla in modi molto diversi su sessualità e filiazione, ma un fatto è incontrovertibile, e cioè che per venire al mondo bisogna passare da un corpo di donna, che deve alimentare l’embrione per nove mesi. È dunque venuto il momento nel quale tutte le donne farebbero bene a esprimersi nel merito. Lo faccio anche io partendo dal presentarmi.
Sono sicuramente una donna, e un po’ qualunque, come milioni di altre donne da quando esistono le civiltà greca, romana e giudaica, che sono le principali dalle quali una donna qualunque europea soprattutto deriva.Di particolare c’è che ho sempre avuto una vera passione politica; in suo nome ho dato vita al “manifesto”, gruppo politico italiano, poi anche quotidiano autofinanziato assieme - fra altri - a Lucio Magri, a Luigi Pintor e Luciana Castellina, che esce ancora oggi. Posso aggiungere che sono una marxista ortodossa, adepta a suo tempo anche di quel marxismo-leninismo, che giustamente si accusa di essere “volgare”, ma che mi ha aiutato anch’esso a capire com’era fatto il mondo e a diventare comunista: lo sono rimasta, non sono dunque di formazione condivisa dai più né in onda con il tempo.
In quella posizione ho diretto il manifesto e in quella veste non ho goduto sempre della simpatia del movimento delle donne, che mi ha definito sovente “figura di potere”, invitandomi a mettermi in gioco, cosa che, a dire il vero, credevo di aver fatto, ma - si vede - non abbastanza; sono stata semplicemente espulsa a suo tempo dal Pci. Ora chi ha preso (e fatto vivere) il manifesto, mi permette di scriverci, ma non di aver voce in capitolo sui suoi indirizzi (e posso capirlo). Quanto al marxismo è una scelta personale e non pretende di essere condivisa: serve a spiegare perché ho esitato un attimo a definirmi “femminista” anche se credo di esserlo, non c’è battaglia delle donne che io non condivida, talvolta con qualche riserva. Non ne ho, ad esempio, nei confronti del testo fatto circolare da “Non una di meno” per convocare uno sciopero generale l’8 marzo scorso.
È importante che la battaglia per i diritti delle donne sia più estesa e condivisa possibile, contro una “cultura maschilista”, intesa anche nell’accezione di “senso comune” di derivazione greca, romana e giudaica, ma si dovrebbe dire anche egizia o cretese, culture che hanno in comune una visione binaria della sessualità, sulla quale si innesta il principio della famiglia patriarcale come “società naturale “, basata sulla divisione gerarchica fra maschio e femmina.
Non penso che questo schema sia da sottovalutare, esso conforma una parte rilevante degli esseri viventi, sia nella zoologia che fra i vegetali, ha determinato gran parte delle nostre culture ed arti, e penso sia utile tenerne conto, limitandomi a riproporre la tesi di un polimorfismo della sessualità, avanzata già da Freud, che non scaricherei così allegramente.
Ne fanno esperienza anche donne e uomini che si iscrivono nello schema binario, anche patendone, o forse appunto patendone; non è detto che la definizione di un terzo sesso non comporterebbe gli stessi inconvenienti della gerarchia binaria, una volta che fosse stabilita come tale (personalmente in genere propendo piuttosto per lo sdoganamento di incertezze e disordini più che di nuove leggi, sempre ultimative).
Forse dovremmo riflettere criticamente sul bisogno di avere o darci una o più leggi, per essere più certe e certi, ma sempre “modi” del potere, cui soggiacciono anche le donne.
 Il potere mi sembra sempre la tentazione più pericolosa: in verità anche quello che definiamo potere patriarcale si fonda su un patto con le donne, che nella famiglia si accontentano di un sottopotere cui però tengono moltissimo, e che non rinunciano allo stesso modo ad esercitare.
Il potere mi sembra sempre la tentazione più pericolosa: in verità anche quello che definiamo potere patriarcale si fonda su un patto con le donne, che nella famiglia si accontentano di un sottopotere cui però tengono moltissimo, e che non rinunciano allo stesso modo ad esercitare.Ecco dunque come la penso, sia in tema di libertà, sia di filiazione.
1. Ognuno deve essere libero nella scelta della sua sessualità e può praticarla, purché il suo partner sia assolutamente consenziente. Per “assolutamente” intendo che deve sapere di che si tratta ed essere in chiaro con se stesso oltre che con l’altra/o. (Si tratta quindi di regolare l’età in cui si è in grado di capire; e il come assicurarsi il consenso dell’altro/a).
2. Ogni violazione della libertà altrui sul punto 1 va punita come reato grave.
3. Anche la scelta della filiazione deve essere libera con precise garanzie per la creatura messa al mondo. Non mi appartiene perciò né l’attuale legislazione né l’assoluto rifiuto della gravidanza per altri. Non mi pare sostenibile che debba esistere il diritto ad avere un figlio proprio. Il bisogno di maternità non può essere un bisogno proprietario, mentre una donna può adottare uno dei molti bambini abbandonati anche se l’adozione comporta dei problemi. L’esperienza mi ha insegnato che la situazione dei maschi e delle femmine è nel merito molto diversa.
4. In particolare, la donna ha diritto di rivendicare il riconoscimento di paternità, che il maschio ha spesso rifiutato, scegliendo la propria figura di padre sotto il profilo sociale, economico, culturale piuttosto che nei confronti della donna che ha contribuito a mettere incinta. Allo stesso modo si è assicurato una libertà o responsabilità come padre: anche qui l’esperienza mi ha insegnato che in caso di continuazione o interruzione di una gravidanza il maschio di una coppia è perlopiù decisivo, soprattutto con l’argomento che il fare figli è un ruolo storicamente determinato e di interesse collettivo.
5. Anche se può essere non semplice, lo Stato deve assumersi il carico affinché la continuazione o interruzione di gravidanza possa essere libera.
6. Continuare o interrompere la gravidanza può essere difficile; ancora adesso legislazioni laiche, religioni e consuetudini sono lontane dal rispettare questa libertà.
7. Non è ammissibile nessun ostacolo a questa libertà: l’esistenza di coppie genitoriali omosessuali è una delle variabili della libertà stessa.
8. Per quanto riguarda la gravidanza per conto terzi (il cosiddetto utero in affitto), impedirla significa mettere un limite alla libertà della donna o dell’uomo che la vorrebbe, consentirla però comporta un pericolo permanente di mercificazione.
9. Va eliminata dalla Legge 194 la cosiddetta “obiezione di coscienza” da parte dell’operatore della sanità pubblica, che svuota di fatto la libertà di non continuare una gravidanza per le donne che non hanno i mezzi per ricorrere al privato.
10. Si deve considerare “famiglia”, e quindi avvalersi delle misure che la collettività stabilisce come aiuto o supporto, qualsiasi coppia, comunque formata che si proponga di mettere al mondo o crescere un bambino.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- ALTRO CHE LACAN, "RITORNARE" A FREUD E AD ALESSANDRO MANZONI.9 settembre 2020, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI, E POLITICA
ALTRO CHE LACAN, "RITORNARE" A FREUD E AD ALESSANDRO MANZONI...
FORSE è meglio riprendere il filo del discorso dalle riflessioni “fallimentari” di Freud sul “caso clinico di Dora” o, se si vuole e meglio, della “Madonna Sistina”(cfr. S. Freud, “Frammento di un’analisi d’isteria”, 1901/1905) e, rianalizzando la ‘possessione’ di Lacan per “L’origine del mondo” di Courbet, ripartire dalle indicazioni critiche di Alessandro Manzoni sul caso della monaca di Monza e di un’antropologia zoppa e cieca - edipica, appunto - fondata sull’ordine simbolico della madre. Vogliamo o non vogliamo uscire dalla caverna?! O no?! Sapere aude!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- NEL PIENO RIPETTO DELLA 194. Con le donne contro la clandestinità (di Giancarla Codrignani).6 settembre 2020, di Federico La Sala
Oltre la pillola.
Con le donne contro la clandestinità
di Giancarla Codrignani (Avvenire, martedì 1 settembre 2020)
Gentile direttore,
« Le nuove linee guida, basate sull’evidenza scientifica, prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana. È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà del nostro Paese». Ineccepibile : il ministro della Salute consente un aggiornamento della 194, imprevedibile solo da chi ha fatto conto di non capire che, se un farmaco è in grado di prevenire il concepimento, il tipo di procedimento farmacologico era in grado di arrivare a dosaggi tipo ’pillola del giorno dopo’ e pillola abortiva.
E siccome l’aborto chirurgico - tralasciando i risvolti psicologici che non possono mai essere dimenticati - significa pur sempre un intervento sanitario importante che rende ancor più traumatica la decisione della donna, sembra il minimo che le sia risparmiato un aggravio di sofferenza. D’altra parte le proteste dopo l’approvazione del testo ministeriale danno alle donne l’impressione di una volontà punitiva dei ’patriarchi’. Quindi, per una persona come me, credente e laica, che quando si rese conto del numero sterminato di aborti nel nostro Paese, in clandestinità, con interventi disperati e mortali, prese posizione favorevole a una regolamentazione per legge di una pratica disumana che vedeva colpevolizzata la donna, lasciata sola anche davanti al codice penale che voleva tale reato condannabile perché « contro l’integrità e la sanità della stirpe » (senza contare che lo stupro era reato non contro la persona, ma contro la morale ed era estinguibile con il ’matrimonio riparatore’), non ci sono obiezioni di merito. Tuttavia. Tuttavia, una pillola abortiva non è un analgesico o un integratore.
Non si può assumere un paio di volte all’anno. E mi sembra che, visto che non siamo ancora riusciti a conciliare la libertà e l’egoismo tra i due ’generi’, bisognerà porre in questione, laicamente, la relazione uomo-donna. L’art.1 della 194 dice che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Le parlamentari che votarono una legge difficile davano senso preciso a parole sostanzialmente inapplicate, ma poi non proseguì la discussione sulla cultura della legge. L’opposizione cattolica si curò solo di negarle legittimazione, nonostante la necessità di intervenire responsabilmente in una materia a cui nessuna donna ha mai dato valore positivo. Anche i più permissivi si fermano al ’sarebbe meglio non dovervi ricorrere’. Per giunta non è mai stata approvata l’educazione sessuale nelle scuole, anche se sappiamo che ormai i bambini di nove anni se la formano sui siti porno di internet : si suppone che, se una ragazzina di quindici anni è ’nei guai’, la famiglia la porti in un ambulatorio privato e non risulti nel conteggio della diminuzione degli aborti, praticati da sempre dalle coniugate, spesso anche recidive.
Quindi la pillola abortiva toglie dai problemi anche quanti vanno a pregare davanti alle cliniche ginecologiche. Ma a me, da cittadina, restano da chiarire i termini riferiti alla procreazione « cosciente e responsabile » e alla maternità libera e responsabile di cui parla la legge.
 Supponendo che tutti sappiano come nascono i bambini, sia per il matrimonio, sia per la convivenza, sia per rapporti occasionali, chiedo : come vanno le relazioni tra la donna e l’uomo ? Motivazioni biologiche, sentimentali, avventurose a parte, sono relazioni ’vere’, in cui la gente si parla, dice le proprie esigenze, i propri desideri, compresa la disponibilità o meno di restare incinta ? Perché chi straparla solo di bambini dovrebbe sapere che il bambino deve essere ’voluto’. Si può indulgere su qualcuno che arriva ’per caso’, ma quando una donna ritiene di ’dover’ abortire quel rapporto era davvero ’libero e responsabile’, la donna, la moglie era consenziente ? Perché la donna ha diritto a decidere anche ’prima’, non solamente ’dopo’. Ma prima, oltre a parlare di sé e del loro entusiasmo, qual è stata la ’qualità’ del loro incontro intimo ?
Supponendo che tutti sappiano come nascono i bambini, sia per il matrimonio, sia per la convivenza, sia per rapporti occasionali, chiedo : come vanno le relazioni tra la donna e l’uomo ? Motivazioni biologiche, sentimentali, avventurose a parte, sono relazioni ’vere’, in cui la gente si parla, dice le proprie esigenze, i propri desideri, compresa la disponibilità o meno di restare incinta ? Perché chi straparla solo di bambini dovrebbe sapere che il bambino deve essere ’voluto’. Si può indulgere su qualcuno che arriva ’per caso’, ma quando una donna ritiene di ’dover’ abortire quel rapporto era davvero ’libero e responsabile’, la donna, la moglie era consenziente ? Perché la donna ha diritto a decidere anche ’prima’, non solamente ’dopo’. Ma prima, oltre a parlare di sé e del loro entusiasmo, qual è stata la ’qualità’ del loro incontro intimo ?Stando alla gestualità di uomini che picchiano e ammazzano le donne e al linguaggio sessista nei confronti di esseri umani femmine, stando al fatto che cantanti, sindache o parlamentari si attirano volgarità da cura psicanalitica urgente non appena aprono bocca, a letto non ci deve essere grande spreco di preliminari e galanterie. Lo dico dalla parte delle donne che, non so se ancora, ma certo ai tempi di discussione della 194 raccontavano dei loro disagi e delle paure di ’restarci’ che non permettevano grande condivisione.
Ma lo dico soprattutto per la pochezza maschile, che si contenta, a sentire le favole da bar, di potenza e numeri. Ma la qualità ? Va bene che anche a tavola spesso non siete un gran che, ma vedete che l’avanzamento della civiltà dal tempo delle ghiande si è evoluta : il pranzo e la cena sono riti, si invitano gli amici e, anche se la nostra non è la tavola di Versailles, usiamo tovaglie con i pizzi, porcellane e cristallerie anche quando in realtà sono piatti di coccio e vetri colorati, imbandiamo il meglio e dalla cucina escono vivande curate che finiscono in piatti accompagnati da posate e tovaglioli, magari di carta.
Le donne tengono ai ricami anche nei letti, ’poi’ magari anche loro non sono questa gran finezza, ma la maggioranza ai preliminari ci tiene, fa parte del rito del piacere ; voi uomini troppo spesso vi contentate delle pulsioni, i cattolici - poi - pensano al buon Dio e credono di sapere che cosa vuole anche lì, tutti o quasi in genere non percepiscono differenze tra l’erotismo e la pornografia.
 Se ci fosse anche una semplice buona educazione non si verificherebbero ancora così tanti aborti. Perché la donna che non vuole un figlio vorrebbe essere rispettata se dice ’no’ a un uomo che la vuole ’prendere’. Perché un uomo deve anche domandarsi perché mai si sia sposato e non far prevalere il suo egoismo.
Se ci fosse anche una semplice buona educazione non si verificherebbero ancora così tanti aborti. Perché la donna che non vuole un figlio vorrebbe essere rispettata se dice ’no’ a un uomo che la vuole ’prendere’. Perché un uomo deve anche domandarsi perché mai si sia sposato e non far prevalere il suo egoismo.Se una donna resta incinta senza averlo voluto una qualche violenza ci sarà stata : anche solo di ignoranza della contraccezione. E da adesso in poi la Ru486 diventerà più ’facile’. Ma non è che d’ora in avanti si risparmiano le prevenzioni e, poi, la donna si mangia la sua pillola e l’uomo non ha più preoccupazione... Perché prendere un farmaco pesante tocca a lei : lui perde pure gli scrupoli morali, roba di lei, non me ne preoccupo. Perché potrebbe passare anche a lei una ’leggerezza’ per un problema sociale che tornerebbe a diventare clandestino. Come donne, come società, davvero ci sta bene ?
Giornalista, scrittrice direttrice di Server Donne già parlamentare della Repubblica italiana
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- AMARE NEL MARE DELLA VITA. Riprendere la navigazione..1 luglio 2020, di Federico La Sala
AMARE NEL MARE DELLA VITA. Riprendere la navigazione ...
Una nota *
SE è VERO CHE “La ricerca del grande amore si fa ormai soltanto on line” (Laura Vasselli, "InLibertà", 29 giugno 2020), e, al contempo, che “La truffa esiste anche in danno della vita sentimentale” (L. V., "InLibertà", 10 giugno 2020), in una società “liquida” - dove non c’è più né un Giardino per Adamo ed Eva né una Itaca per Ulisse e Penelope - il problema su cui fare chiarezza e “chiudere l’argomento” è : “se è vero che nella vita è necessario amare innanzitutto sé stessi, come si fa a lasciare posto all’amore per qualcun altro ?”.
CONOSCER-SI : IN PRINCIPIO ERA LA “PAROLA” (IL “LOGOS”). RICORDATO CHE “Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima : così profondo è il suo lògos" (Eraclito, fr. 45), E, insieme, RIGUARDATA LA FOTO (vedi sopra: accanto al titolo, sul dito “indice” di “due persone” l’immagine di “due ancore”), RIPARTIRE PROPRIO DA QUI : DAll’ancoraggio di “due navi”, di “DUE PERSONE CHE DISCORRONO” (Ferdinand De Saussure). Mi sembra proprio una (bella riflessione e una) buona indicazione!
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.).
LA "PROFEZIA" DI MARSHALL MCLUHAN: NARCISO E LA MORTE DELL’ITALIA. Il "rimorso di incoscienza" di Marshall McLuhan -
 LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.
LA CONCESSIONE PIU’ GRANDE. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una società l’atmosfera terrestre.FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO -- UN "MONOTEISMO" CIECO E ZOPPO E LA "COMUNITA’ CHE VIENE". "Il virus ha scoperchiato il tetto e ci ha rigettato nella storia. Si può dunque iniziare da qui".14 aprile 2020, di Federico La Sala
LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO, LA FEDELTA’ ALL’ AMORE DI HEIDEGGER ED HANNAH ARENDT, LA FINE DI UN MONOTEISMO CIECO E ZOPPO E LA COMUNITA’ CHE VIENE ... *
A) - UNA CASA DI CURA, UN OSPEDALE DA CAMPO: [...] Proprio un totalitarismo apolitico ed economico - fondato su una idea di soggetto come arbitrario e indefinito dispiegamento delle proprie potenzialità - ha impedito sinora di far fronte a tali questioni. Come la pandemia, si tratta di sfide che minano la sopravvivenza. Il virus ha scoperchiato il tetto e ci ha rigettato nella storia. Si può dunque iniziare da qui: dalla condizione storica in cui ci troviamo, che non è regredibile, e che è quella che la biopolitica analizza con acume. Se è vero che il potere sovrano si rivolge sempre più ai corpi, trovando un paradigma nell’oikos o nel campo, allora la “comunità che viene”, costituita da libertà non pure e astratte, ma malate e inchiodate a questi corpi, non potrà che iniziare a costituirsi nella forma di una casa di cura, o di un “ospedale da campo.” ( Francesco Valerio Tommasi, “Curarsi di. Una libertà inchiodata al corpo e alla storia”, Le parole e le cose, 14 aprile 2020);
B) - “UN NUOVO INIZIO”: “[...] Ma rimane altresì vero che ogni fine della storia contiene necessariamente un nuovo inizio; questo inizio è la promessa, l’unico «messaggio» che la fine possa presentare. L’inizio, prima di diventare avvenimento storico, è la suprema capacità dell’uomo; politicamente si identifica con la libertà umana. «Initium ut esset, creatus est homo», dice Agostino. Questo inizio è garantito da ogni nuova nascita; è in verità ogni uomo” (Hannah Arendt, “Le origini del totalitarismo”, Edizioni di Comunità, Milano 1996);
C) - ANTROPOLOGIA: KANT E LA RISCOPERTA DEL CORPO, LA RICERCA DI ENZO PACI SULLA NASCITA e la “fedeltà all’amore” di HEIDEGGER e ARENDT;
D) - CORONAVIRUS O SOVRANITA’ ( “CORONA VIRTUS”) ?! FILOLOGIA: ECCE HOMO! Ad evitare problemi di un cieco e zoppo monoteismo teologico-politico e biologico e uscire dal letargo e dalla caverna, ricordare che Ponzio Pilato disse: “«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)”;
E) - LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO: PER PER CARITÀ.3 aprile 2020, di Federico La Sala
MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO...
- “In questo senso, lo stato della musica (includendo in questo termine tutta la sfera che imprecisamente definiamo con il termine ‘arte’) definisce la condizione politica di una determinata società meglio e prima di qualsiasi altro indice e, se si vuole mutare veramente l’ordinamento di una città, è innanzitutto necessario riformarne la musica. La cattiva musica che invade oggi in ogni istante e in ogni luogo le nostre città è inseparabile dalla cattiva politica che la governa.” (Giorgio Agamben, Che cos’è la filosofia?, Quodlibet, Macerata, 2016 p. 140)
PER CARITÀ...
MUSICA, POLITICA, E PIFFERAIO MAGICO: RIATTIVARE LA MEMORIA della TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE, della “Wohl-tätigkeit”, della carità! “THE SHAWSHANK REDEMPTION” : LA “MOS-ART” (“arte di Mosé”)! Una breve sequenza dal film “Le Ali della Libertà”.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN.10 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ECCE HOMO, L’8 MARZO AL TEMPO DEL “CORONA VIRUS”, E LA MEMORIA DI CHRISTINE DE PIZAN ...
ALLA LUCE DEL CHIARIMENTO DEL SIGNIFICATO DELLE PAROLE DI PONZIO PILATO: “ECCE HOMO”(cfr. sopra : https://www.fondazioneterradotranto.it/2020/02/26/dialetti-salentini-piticinu/#comment-269838), si comprende meglio anche il significato delle parole di Christine de Pizan, l’autrice della “Città delle dame” : «Or fus jee vrais homs, n’est pa fable,/De nefs mener entremettable » (« Allora diventai un vero uomo, non è una favola,/capace di condurre le navi» - cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan), che dicono ovviamente non della “metamorfosi” in “vir” - uomo, ma della “metanoia” in “homo” - essere umano (su questo, in particolare, si cfr. Michele Feo, “HOMO - Metanoia non Metamorfosi”, “dalla parte del torto”, Parma, autunno 2019, numero 86, pp. 12-13).
***
ASTREA ! “IAM REDIT ET VIRGO” ...
CARO ARMANDO... RICORDANDO DI NUOVO E ANCORA IL TUO PREGEVOLISSIMO LAVORO SU- GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA (si cfr. https://www.fondazioneterradotranto.it/2019/07/08/gli-arcadi-di-terra-dotranto-premessa-1-x/#comment-238474), E LA TUA CONNESSIONE TRA LA “PIZANA” CAPACE DI “CONDURRE LE NAVI” CON LA FIERA E NOBILE Carola Rackete, A SUO E TUO OMAGGIO, riprendo qui una breve scheda su:
- ASTREA - L’Astraea Virgo, ” vergine delle stelle “, simbolo della giustizia, abitò la terra nell’età dell’oro e la lasciò per ultima nell’età del ferro, cedendo all’iniquità ormai dominante. Il ‛ritorno di A.‘ si identifica in Virgilio con il ritorno dell’età di Saturno (” magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. / iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, / iam nova progenies caelo demittitur alto “, Buc. IV 5-7). L’intero passo virgiliano è parafrasato in Pg XXII 70-72 Secol si rinova ; / torna giustizia e primo tempo umano, / e progenïe scende da ciel nova ; in Mn I XI 1 è riportato il v. 6 (cui segue la chiosa ‛ Virgo ‘... vocabatur iustitia, quam etiam ‛Astraeam‘ vocabant), ricordato anche in Ep VII 6 ; in Ep XI 15 il nome di A. è usato come metonimico di giustizia (http://www.treccani.it/enciclopedia/astrea_%28Enciclopedia-Dantesca%29/).
Buon 8 marzo 2020 - e buon lavoro...
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- L’ANTROPOLOGIA DI PONZIO PILATO E LA DIGNITA’ DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE, OGGI.1 marzo 2020, di Federico La Sala
L’ORAZIONE SULLA DIGNITA’ DELL’UOMO - A UNA DIMENSIONE.
Da Giovanni Pico della Mirandola* a Herbert Marcuse** e ...
CARO ARMANDO, PER IMPARARE "a vivere meglio senza lasciarci condizionare dalla paura della morte, cioè dalla religione, qualunque essa sia", CREDO CHE SIA NECESSARIO riconsiderare il problema di "come nascono i bambini" (a tutti i livelli)! Hai ragione: "Non possiamo permetterci, con le Sibille, Maria Vergine, Cristo come dio, Maometto ed altre favolette l’illusione di un altro Messia"! Ci siamo addormentati nella tradizione cattolico-costantiniana e illuministica acritica (contro Kant), e abbiamo finito per "concepire" noi stessi e noi stesse secondo la bio-logia e l’andro-logia “unidimensionale” dell’omuncolo!
L’«ECCE HOMO» di Ponzio Pilato, al contrario!, ci dice proprio questo - la fine delle "favolette" e di ogni "illusione di un altro Messia". Il discorso è di diritto e di fatto, romanamente universale, vale a dire, antropologico (non limitato all’«omuncolo» di qualche "uomo supremo" o “superuomo”!):
- PONZIO PILATO «disse loro: "Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa". Uscì dunque Gesù, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Pilato disse loro: "«Ecco l’uomo» (gr. «idou ho anthropos», vulg. «ecce homo»)". Vedendolo, i sommi sacerdoti e i loro inservienti gridarono: "Crocifiggi! Crocifiggi!" Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui colpa". Gli risposero gli Ebrei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio"» (Gv. 19, 4-7).
SE SIAMO ANCORA CAPACI DI LEGGERE, COSA VA SIGNIFICANDO NEL TEMPO LA LEZIONE DI PONZIO PILATO?! Non è una lezione critica contro i "sovranisti" laici e religiosi di ieri e di oggi?!
Che vogliamo fare? Continuare a riportare noi stessi e noi stesse davanti a Pilato e ripetere da scemi e da sceme la stessa scena, riascoltare il suo "Ecce Homo" e non capire una "H" (acca)?!
* Discorso sulla dignità dell’uomo.P.S. - RICORDANDO ... GLI ARCADI DI TERRA D’OTRANTO, VIRGILIO, E IL “VECCHIO DI CORICO”. A SOLLECITAZIONE E CONFORTO DELL’IMPRESA.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ANTROPOLOGIA, FILOLOGIA, E LOGICA: "IL PRINCIPIO DI CARITÀ".19 gennaio 2020, di Federico La Sala
FILOSOFIA E FILOLOGIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS: CHARITAS....
- LA CARITÀ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia), NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!) *
Tesi di Laurea
IL PRINCIPIO DI CARITÀ [2016]
Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica
a cura di Francesco Gandellini **
- La tesi si preoccupa di analizzare l’origine e il decorso storico del principio di carità o benevolenza, con particolare riferimento alla linea etico-ermeneutica e alla linea logico-ontologica, al fine di metterne in luce gli aspetti significativi che lo identificano e ne caratterizzano l’uso nella storia della filosofia.
SOMMARIO Introduzione .................................................................................................................
 1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
1 Sezione 1: il versante ermeneutico ....................................................................... 5
 1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
1.1 La genesi agostiniana del principio .................................................................... 7
 1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
1.2 L’illuminismo tedesco e il nesso linguaggio-mondo ................................. 23
 1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
1.2.1 Wilhelm von Humboldt: “Sprachansicht als Weltansicht” ................................................................... 27 -APPENDICE Georg Friedrich Meier e il “Versuch einer allgemeinen Auslegungkunst” .................................. 43
 1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
1.3 La linea ontologica dell’ermeneutica contemporanea .............................. 53
 1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
1.3.1 Martin Heidegger e l’analitica esistenziale di “Sein und Zeit” ................................................ 55
 1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
1.3.2 Hans-Georg Gadamer e l’ermeneutica ontologica di “Warheit und Methode“ ........................ 69
 Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
Sezione 2: la riflessione logica .............................................................................. 85
 2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
2.1 Fondamenti teorici della carità in logica ....................................................... 87
 α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
α ) La riflessione filosofica di Ludwig Wittgenstein ......................................... 89
 β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
β) L’ipotesi della relatività linguistica............................................................ 100
 2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
2.2 Willard van Orman Quine e l’argomento di “traduzione radicale” ............................................................... 113
 2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
2.3 Donald Davidson e l’interpretazione radicale ..................................................................................... 137
 Conclusione .............................................................................................................. 157
Conclusione .............................................................................................................. 157
 Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163
Bibliografia ............................................................................................................... 161 -Sitografia................................................................................................................... 163***
INTRODUZIONE
Il termine “carità” deriva etimologicamente dal latino caritas (acc. caritatem, «benevolenza», «amore», questo da carus, «caro», «costoso», «diletto», «amato»), e a sua volta dal greco χάρις, «grazia». Dal punto di vista dell’etimo, la parola cattura l’idea dell’amore disinteressato ma prezioso verso qualcuno, della benevolenza gratuitamente concessa al destinatario, senza riserve rispetto alla sua condizione.
 Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus
dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovverocareo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
 Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello»,kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
 Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
 La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano. Si tratta, perciò, di far riermegere agli occhi della coscienza i fondamenti troppo spesso dati per scontato e, proprio per questo, dimenticati, abbandonati e relegati a relitti a margine dell’edificio del sapere.
 È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
È compito primario della filosofia conferire dignità conoscitiva a quanto viene accolto come evidente, ovvio, lapalissiano perché in ciò, e nel suo oblio, si possono rinvenire “proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino”1, ossia quegli interrogativi umani centrali in cui ne va della quotidianità tanto quanto dell’esistenza intera, oltre che di una convivenza pacifica. Spingendo la riflessione in direzione di ciò che pare assodato e fuori di dubbio ai fini della riflessione stessa, si giunge a capire e a rendere ragione di una complessità nuova, nella quale si gioca qualcosa come la comprensione o il fraintendimento tra gli individui.
 Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
 Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
Lo scopo della presente trattazione è di portarne alla luce, in un percorso storico e tematico, le caratteristiche principali, in modo da scoprirne il capo e segnalarne i lineamenti distintivi. La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
 Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.
Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.1 E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, il Saggiatore 2008, pag. 35
** UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
 Dipartimento Lettere e Filosofia
Dipartimento Lettere e Filosofia
 Corso di Laurea in FILOSOFIA. Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco, Laureando: GANDELLINI Francesco.
Corso di Laurea in FILOSOFIA. Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco, Laureando: GANDELLINI Francesco.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- LA QUESTIONE DELLA "H"....SCIENZA E FILOSOFIA. "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia" (di Antonio Rainone)
SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
IL NOME DI DIO, SENZA GRAZIA ("CHARIS")! L’ERRORE FILOLOGICO E TEOLOGICO DI PAPA BENEDETTO XVI, NEL TITOLO DELLA SUA PRIMA ENCICLICA. Nel nome della "Tradizione"
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- Una metafisica per individui. Robert Nozick, "Invariances" (di Robert Casati).8 gennaio 2020, di Federico La Sala
Una metafisica per individui
di Roberto Casati (Il Sole-24 Ore, 19.02.2006)
Nella comunità intellettuale (considerata in senso ampio a includere chi si dedichi a una riflessione esplicita sui fondamenti concettuali e metodologici del proprio lavoro) non c’è un accordo sull’esistenza di fatti oggettivi. Il problema non riguarda soltanto una questione di conoscenza, ovvero del modo in cui potremmo accertarci di un fatto, e neppure riguarda soltanto discipline in cui sembra difficile convergere su ciò che conta come un fatto - come la teoria della letteratura (Manzoni voleva veramente esprimere una concezione del mondo giansenista?), della storia (che cosa ha determinato l’assassinio di Kennedy) o della giurisprudenza (Oswald ha agito davvero senza complici?)
È la nozione stessa di fatto oggettivo, di oggettività, a essere considerata discutibile (e a venire discussa). Le intenzioni degli autori o le cause degli omicidi sono davvero entità oggettive? Certo la discussione soffre di una certa vaghezza dei termini utilizzati. Il termine di contrasto principale è naturalmente con «soggettivo»; ma anche precisando il contrasto oggettivo/soggettivo, sostenere che non esistono fatti oggettivi può significare diverse cose. Per esempio, può significare che tutto è soggettivo nel senso che non ci sarebbero fatti se non ci fossero soggetti in grado di percepire o di pensare a tali fatti, o che c’è una componente soggettiva in ogni asserzione che facciamo sul mondo, o che la rappresentazione della realtà viene filtrata e distorta dai nostri sistemi cognitivi, o che ogni conoscenza inevitabilmente è un’azione, un intervento che modifica la cosa conosciuta, e via dicendo. La nozione di oggettività in gioco in questi diversi casi sarà di volta in volta differente.
Il filosofo Robert Nozick è noto al pubblico italiano per un grande libro di filosofia della politica, Anarchia, Stato e Utopia; e per un testo di filosofia più generale, Spiegazioni Filosofiche. L’ultimo lavoro pubblicato da Nozick prima della morte (avvenuta il 23 gennaio del 2002) è Invariances: The Structure of the Objective World (Harvard University Press, 2001, pp. 416, $ 24.50). Si tratta di un libro molto ambizioso, una summa metafisica che studia filosoficamente la nozione di oggettività alla luce delle trasformazioni della scienza. (Il capitolo introduttivo sul metodo filosofico è online sul sito di Harvard University Press)
Nozick distingue tre possibili ingredienti del modo di considerare l’oggettività. In primo luogo, quello appena menzionato dell’indipendenza dalla soggettività, da opinioni, speranze, misure soggettive. In secondo luogo, l’accesso multiplo: un fatto è oggettivo se vi si può accedere da prospettive differenti - attraverso sensi differenti, da punti di vista differenti, in momenti diversi (per esempio, vedo e sento la conversazione di Marco e Maria, o la vedo oggi e la rivedo in un film girato da un amico domani; o ancora, posso replicare un esperimento in momenti diversi). Infine, l’intersoggettività: un fatto è oggettivo se è possibile che soggetti diversi abbiano un accordo su di esso. Se sia io che voi contiamo i sassi in un mucchio e giungiamo al numero cinque, avremo ragione di pensare che è un fatto oggettivo che ci siano cinque sassi nel mucchio.
Accesso multiplo, intersoggettività e indipendenza sono elementi necessari, presi singolarmente, e sufficienti solo se presi nel loro complesso. Ma Nozick suggerisce che al di sotto di essi un quarto elemento, più profondo, permette di spiegare perché la nozione di oggettività includa proprio gli altri tre. L’elemento più profondo è l’idea di invarianza attraverso trasformazioni.
 Nozick riconosce un debito non solo linguistico ma anche concettuale nei confronti della matematica, della fisica e di altre discipline scientifiche. Il Programma di Erlangen (1872) di Felix Klein (1849-1925) era volto a unificare i diversi tipi di geometria con lo studio dell’invarianza all’interno dei gruppi di trasformazioni ammissibili per le entità geometriche. Per esempio, le rotazioni e le traslazioni nello spazio lasciano invarianti le proprietà metriche delle figure; la proiezione di una figura su un piano che è ad essa parallelo non lascia invarianti le proprietà metriche ma preserva gli angoli. In psicologia la nozione di invarianza viene associata al lavoro di J.J. Gibson (1904-1979), che riteneva che i sistemi percettivi abbiano come funzione l’“estrazione” di elementi invarianti nell’ambiente (un approccio per questa ragione detto “ecologico”). Non ci sembra che una sedia cambi di forma mentre le giriamo intorno: siamo per così dire “sintonizzati” sulla forma invariante della sedia, anche se l’immagine che ne abbiamo a ogni istante muta continuamente. La psicologia della percezione generalizza la nozione, a volte chiamata “costanza”; quello che vale per la forma della sedia vale anche per il suo colore: non ci sembra che la sedia cambi colore in diversi momenti del giorno.
Nozick riconosce un debito non solo linguistico ma anche concettuale nei confronti della matematica, della fisica e di altre discipline scientifiche. Il Programma di Erlangen (1872) di Felix Klein (1849-1925) era volto a unificare i diversi tipi di geometria con lo studio dell’invarianza all’interno dei gruppi di trasformazioni ammissibili per le entità geometriche. Per esempio, le rotazioni e le traslazioni nello spazio lasciano invarianti le proprietà metriche delle figure; la proiezione di una figura su un piano che è ad essa parallelo non lascia invarianti le proprietà metriche ma preserva gli angoli. In psicologia la nozione di invarianza viene associata al lavoro di J.J. Gibson (1904-1979), che riteneva che i sistemi percettivi abbiano come funzione l’“estrazione” di elementi invarianti nell’ambiente (un approccio per questa ragione detto “ecologico”). Non ci sembra che una sedia cambi di forma mentre le giriamo intorno: siamo per così dire “sintonizzati” sulla forma invariante della sedia, anche se l’immagine che ne abbiamo a ogni istante muta continuamente. La psicologia della percezione generalizza la nozione, a volte chiamata “costanza”; quello che vale per la forma della sedia vale anche per il suo colore: non ci sembra che la sedia cambi colore in diversi momenti del giorno.Alcune proprietà vengono conservate attraverso tutte le trasformazioni, altre resistono solo ad alcune trasformazioni. Questo inserisce un ordine di profondità tra le proprietà: le invarianze sono graduate. In geometria le proprietà topologiche sono più profonde di quelle metriche: bisogna alterare in profondità una figura per farle perdere la struttura topologica.
Nozick suggerisce per analogia che una differenza di profondità possa applicarsi alla nozione di oggettività. Ci sono proprietà che resistono a più trasformazioni di altre, e le prime saranno più oggettive delle seconde. La conoscenza di un oggetto si fonda sulla comprensione dell’interazione tra invarianza e la variazione: «Per comprendere qualcosa, non vogliamo soltanto conoscere le trasformazioni sotto le quali è invariante, ma anche quelle sotto le quali varia» (p. 78).
Il lavoro di Nozick tende a mostrare che i problemi metafisici non sono indipendenti dal contesto scientifico che li suscita. La nozione metafisica di oggettività che Nozick suggerisce di adottare non deriva da un’analisi filosofica apriori, ed è tributaria di nozioni che derivano dalle scienze. La metafisica progredisce, e può farlo anche perché la scienza pone problemi inediti ai filosofi e offre a volte strumenti per metterli a fuoco.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
KANT E SAN PAOLO. -- CARITÀ O EMPATIA?!: LA LEZIONE DI QUINE E DI NOZICK: "CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO" (di Antonio Rainone).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- L’IMMAGINARIO "COSMOTEANDRICO" E L’"ECCE HOMO" DELLA TRADIZIONE IMPERIALE. La parola biforcuta può tutto.4 gennaio 2020, di Federico La Sala
"ECCE HOMO": (ANTROPOLOGIA, NON "ANDROPOLOGIA" O "GINECO-LOGIA")!!! USCIRE DALL’ORIZZONTE COSMOTEANDRICO DA "SACRO ROMANO IMPERO"... *
- Dio creò l’uomo ("homo") ... e lo fece maschio ["masculum"] e femmina [" foeminam "] (Genesi, I.27).
- “Chi tene ‘a lingua, va ’n Sardegna" (antico proverbio campano)
La parola può tutto
di Ivano Dionigi (Avvenire, venerdì 3 gennaio 2020)
«Chiamo uomo chi è padrone della sua lingua». In questa sentenza fulminante di don Lorenzo Milani (Lettera a Ettore Bernabei 1956), ispirata a un deciso afflato di giustizia sociale, trovo il più bel commento al passo in cui Aristotele (Politica 1253 a) riconosce nella parola (logos) la marca che caratterizza l’uomo e lo distingue dagli animali, che ne sono privi (tà zóa á-loga). La parola: il bene più prezioso, la qualità più nobile, il sigillo più intimo. A una persona, a un gruppo, a un popolo puoi togliere averi, lavoro, affetti: ma non la parola. Un divario economico si ripiana, un’occupazione si rimedia, una ferita affettiva si rimargina, ma la mancanza o l’uso ridotto della parola nega l’identità, esclude dalla comunità, confina alla solitudine e quindi riduce allo stato animale. «La parola - continuava il profetico prete di Barbiana - è la chiave fatata che apre ogni porta»; tutto può, come già insegnava la saggezza classica: «spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione» (Gorgia, Elogio di Elena 8). Ma essa è di duplice segno, nella vita privata come in quella pubblica: con i cittadini onesti e i governanti illuminati si fa simbolica (syn-bállein), e quindi unisce, consola, salva; confiscata dai cittadini corrotti e dai demagoghi si fa diabolica (dia-bállein), e quindi divide, affanna, uccide.
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua".
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
- OBIEZIONE DI COSCIENZA !!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINIANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", 10.11.2019).
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020).
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL PROBLEMA DELL’UNO (E I MOLTI): IL CATTOLICESIMO ROMANO E L’ICONA UNIVERSALE DELLA "SANTA FAMIGLIA".29 dicembre 2019, di Federico La Sala
ECUMENISMO E PROBLEMA DELL "UNO" ... *
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Contemplando con fede la casa di Nazareth ogni credente può scorgervi un modello
di Matteo Liut (Avvenire, domenica 29 dicembre 2019)
La vita nasce da una relazione che si apre all’infinito, perché ogni essere umano che viene al mondo è segno dell’amore sconfinato di Dio. La famiglia è scrigno prezioso che ha la responsabilità di dare forma a questa continua promessa di futuro.
Oggi il rito romano pone la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, icona universale di un’intimità domestica portatrice di un messaggio rivoluzionario: Dio abita in mezzo a noi. Contemplando la casa di Nazareth ogni credente non può non scorgervi un’ispirazione e un modello: i piccoli gesti di cura e attenzione vissuti tra quelle mura testimoniano lo stile dell’agire di Dio nella storia. Ecco perché per i cristiani farsi compagni di strada degli ultimi significa prima di tutto essere luce di speranza e di amore per le persone più vicine: tutti abbiamo bisogno di aprirci continuamente alla vita attraverso relazioni d’amore.
 Altri santi. San Davide, re (X sec. a.C.); san Tommaso Becket, martire (1118-1170).
Altri santi. San Davide, re (X sec. a.C.); san Tommaso Becket, martire (1118-1170).
 Letture. Sir 3,3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
Letture. Sir 3,3-7.14-17; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
 Ambrosiano. Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14.
Ambrosiano. Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
- I TRE ANELLI E L’UNicO "PADRE NOSTRO".NATHAN IL SAGGIO: CHE ILLUSIONE AFFIDARSI ALLA CHIESA ’CATTOLICA’!!!
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FLS
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- «Rompere il muro della diseguaglianza tra donna e uomo nella Chiesa» (L’osservatore Romano - "Donna Chiesa Mondo")28 dicembre 2019, di Federico La Sala
La rivista.
«Rompere il muro della diseguaglianza tra donna e uomo nella Chiesa»
Il numero di dicembre di "Donna Chiesa Mondo", supplemento dell’Osservatore Romano, dedicato al rapporto di papa Francesco con il mondo femminile
di Gianni Cardinale (Avvenire, sabato 28 dicembre 2019)
- [Foto] Papa Francesco con una giovane donna nell’udienza del 30 gennaio 2019 - Ansa
“Le donne e Francesco”. È questo il titolo dell’ultimo numero di “Donna Chiesa Mondo”, il supplemento mensile dell’Osservatore Romano coordinato da Rita Pinci interamente dedicato all’universo rosa. Il fascicolo, in uscita oggi in allegato al quotidiano diretto da Andrea Monda, ospita interventi di donne - laiche e consacrate - che “dicono ciò che pensano di papa Francesco in rapporto alla questione femminile nella Chiesa”. E lo dicono in piena libertà. Numerosi i contributi, dal contenuto a volte pungente.
Stefania Falasca di Avvenire sottolinea che “al di là della formazione personale, la sollecitudine con la quale papa Francesco, fin dalla sua elezione, si è dedicato alla questione delle donne, del loro ruolo e accesso alle responsabilità ecclesiali, evidenzia l’urgenza di affrontare una realtà che riguarda la visione della Chiesa stessa e investe la sua natura gerarchica e comunionale”. È tale visione infatti “che spinge il Papa a percepire il monocolore maschile come un difetto, uno squilibrio, una minorazione della Chiesa considerato che senza le donne essa risulta deficitaria nell’annuncio e nella testimonianza e che dunque compromette la sua missione”.
Alla luce del recente Sinodo sull’Amazzonia la teologa Serena Noceti da parte sua ricorda che “nel quadro della visione del ministero ordinato consegnata dal concilio Vaticano II, la teologia sistematica è interpellata oggi per valutare la possibilità di ordinare donne diacono”. Così “sessanta anni dopo il votum di mons. de Uriarte Bengoa, ancora una volta dall’Amazzonia, la richiesta di donne diacono - come voce profetica? - raggiunge la chiesa intera e sollecita la teologia a ‘pensare in novità’”.
Mentre la “filosofa femminista” Luisa Muraro lamenta che anche la volontà di cambiamento di papa Francesco sarebbe però "un’eccezione" al livello "alto" della Chiesa dove prevale ancora "la preoccupazione di andare d’accordo con una tradizione che ha, fatalmente, l’impronta del tra-uomini di potere".
Tra i temi affrontati nel fascicolo anche lo spinoso problema della violenza contro le suore, sessuale e sotto forma di abuso di potere, da parte degli stessi uomini della Chiesa. "Il pontefice ha rotto il silenzio sulla violenza - sottolinea suor Jolanta Kafka, la nuova presidente della Uisg, Unione Internazionale Superiore Generali, che riunisce 1900 congregazioni per oltre 450.000 consacrate - e questo ci dà la possibilità di parlare, di essere, anche come Uisg, un luogo di ascolto e di aiuto non solo nei confronti della violenza sessuale, ma di ogni abuso di potere".
Da segnalare poi un appello al Papa a firma di Marinella Perroni, teologa e biblista al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo: "Date l’esempio al mondo, anche quello che si ritiene ’civilizzato’ e che invece fa ancora tanta fatica ad accettare che, tra uomo e donna, non c’è uno che è soggetto (anche di parola) e l’altra che è oggetto (anche di parola), ma che, ormai, la soggettualità non può che essere condivisa. E ognuno parli di sé. Abbiamo gran bisogno di ascoltare uomini che parlano di maschilità. Anche nella Chiesa".
Il supplemento si chiude con una paginetta dal titolo forte: “Rompere il muro della diseguaglianza”. In essa tre fondatrici dell’Associazione Donne in Vaticano - Romilda Ferrauto, Adriana Masotti, Gudrun Sailer - sostengono che "anche in Vaticano le donne sono a volte viste, da uomini, ma anche da altre donne, come persone di minor valore intellettuale e professionale, sempre disponibili al servizio, sempre docili ai comandi superiori". Di qui l’urgenza appunto di "rompere il muro della diseguaglianza fra donne e uomini nella Chiesa".
Sulla scia dell’insegnamento di Papa Francesco, per cui “l’alleanza dell’uomo e della donna è chiamata a prendere nelle sue mani la regia dell’intera società”. Con un invito “alla responsabilità per il mondo... e anche nella Chiesa”.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. --- «Costituente Terra»: una Scuola per un nuovo pensiero. Appello per una Costituzione della Terra.27 dicembre 2019, di Federico La Sala
«Perché la storia continui». Appello per una Costituzione della Terra
Proposte. Appello per un nuovo costituzionalismo globale, una bussola etica e politica per salvare il mondo e i suoi abitanti dalla distruzione.
di Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, Raffaele Nogaro, Paolo Maddalena, Mariarosaria Guglielmi, Riccardo Petrella (il manifesto, 26.12.2019)
Nel pieno della crisi globale, nel 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, Raniero La Valle, Luigi Ferrajoli, Valerio Onida, il vescovo Nogaro, Riccardo Petrella e molti altri lanciano il progetto politico di una Costituzione per la Terra e promuovono una Scuola, «Costituente Terra», che ne elabori il pensiero e prefiguri una nuova soggettività politica del popolo della Terra, «perché la storia continui». Pubblichiamo le parti essenziali del documento che esce domani, in data 27 dicembre 2019.
L’Amazzonia brucia e anche l’Africa, e non solo di fuoco, la democrazia è a pezzi, le armi crescono, il diritto è rotto in tutto il mondo. «Terra! Terra!» è il grido dei naufraghi all’avvistare la sponda, ma spesso la terra li respinge, dice loro: «i porti sono chiusi, avete voluto prendere il mare, fatene la vostra tomba, oppure tornate ai vostri inferni». Ma «Terra» è anche la parola oggi più amata e perduta dai popoli che ne sono scacciati in forza di un possesso non condiviso; dai profughi in fuga per la temperatura che aumenta e il deserto che avanza; dalle città e dalle isole destinate ad essere sommerse al rompersi del chiavistello delle acque, quando la Groenlandia si scioglie, i mari son previsti salire di sette metri sull’asciutto, e a Venezia già lo fanno di un metro e ottantasette. «Che si salvi la Terra» dicono le donne e gli uomini tutti che assistono spaventati e impotenti alla morte annunciata dell’ambiente che da millenni ne ospita la vita.
Ci sono per fortuna pensieri e azioni alternative, si diffonde una coscienza ambientale, il venerdì si manifesta per il futuro, donne coraggiose da Greta Thunberg a Carola Rackete fanno risuonare milioni di voci, anche le sardine prendono la parola, ma questo non basta. Se nei prossimi anni non ci sarà un’iniziativa politica di massa per cambiare il corso delle cose, se le si lascerà in balia del mercato della tecnologia o del destino, se in Italia, in Europa e nelle Case Bianche di tutti i continenti il fascismo occulto che vi serpeggia verrà alla luce e al potere, perderemo il controllo del clima e della società e si affacceranno scenari da fine del mondo, non quella raccontata nelle Apocalissi, ma quella prevista e monitorata dagli scienziati.
Il cambiamento è possibile
L’inversione del corso delle cose è possibile. Essa ha un nome: Costituzione della terra. Il costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra.
La Costituzione del mondo non è il governo del mondo, ma la regola d’ingaggio e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo. Nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, ad opera di un soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una Costituzione della Terra è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, ma l’unità umana che giunga ad esistenza politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità e la eserciti ai fini di far continuare la storia e salvare la Terra.
Salvare la Terra non vuol dire solo mantenere in vita «questa bella d’erbe famiglia e d’animali», cantata dai nostri poeti, ma anche rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo di tutte le persone umane.
 Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».
Il diritto internazionale è già dotato di una Costituzione embrionale del mondo, prodotta in quella straordinaria stagione costituente che fece seguito alla notte della seconda guerra mondiale e alla liberazione dal fascismo e dal nazismo: la Carta dell’Onu del 1945, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, i due Patti internazionali del 1966 e le tante Carte regionali dei diritti, che promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma non sono mai state introdotte le norme di attuazione di queste Carte, cioè le garanzie internazionali dei diritti proclamati. Non è stato affatto costituito il nuovo ordine mondiale da esse disegnato. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali che «di fatto la realizzino».È chiaro che in queste condizioni i diritti proclamati sono rimasti sulla carta, come promesse non mantenute. Riprendere oggi il processo politico per una Costituzione della Terra vuol dire tornare a prendere sul serio il progetto costituzionale formulato settant’anni fa e i diritti in esso stabiliti. E poiché quei diritti appartengono al diritto internazionale vigente, la loro tutela e attuazione non è soltanto un’urgente opzione politica, ma anche un obbligo giuridico in capo alla comunità internazionale e a tutti noi che ne facciamo parte.
Qui c’è un’obiezione formulata a partire dalla tesi di vecchi giuristi secondo la quale una Costituzione è l’espressione dell’«unità politica di un popolo»; niente popolo, niente Costituzione. E giustamente si dice che un popolo della Terra non c’è; infatti non c’era ieri e fino ad ora non c’è.
La novità è che adesso può esserci, può essere istituito; lo reclama la scena del mondo, dove lo stato di natura delle sovranità in lotta tra loro non solo toglie la «buona vita», ma non permette più neanche la nuda vita; lo reclama l’oceano di sofferenza in cui tutti siamo immersi; lo rende possibile oggi la vetta ermeneutica raggiunta da papa Francesco e da altre religioni con lui, grazie alla quale non può esserci più un dio a pretesto della divisione tra i popoli: «Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno» - hanno detto ad Abu Dhabi - non vuole essere causa di terrore per nessuno, mentre lo stesso «pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani»; non c’è più un Dio geloso e la Terra stessa non è una sfera, ma un poliedro di differenze armoniose.
Per molti motivi perciò è realistico oggi porsi l’obiettivo di mettere in campo una Costituente della Terra, prima ideale e poi anche reale, di cui tutte le persone del pianeta siano i Padri e le Madri costituenti.
Una politica dalla parte della Terra
Di per sé l’istanza di una Costituzione della Terra dovrebbe essere perseguita da quello strumento privilegiato dell’azione politica che, almeno nelle democrazie, è il partito - nazionale o transnazionale che sia - ossia un artefice collettivo che, pur sotto nomi diversi, agisca nella forma partito. Oggi questo nome è in agonia perché evoca non sempre felici ricordi, ma soprattutto perché i grandi poteri che si arrogano il dominio del mondo non vogliono essere intralciati dal controllo e dalla critica dei popoli, e quindi cercano di disarmarli spingendoli a estirpare le radici della politica e dei partiti fin nel loro cuore. È infatti per la disaffezione nei confronti della politica a cui l’intera società è stata persuasa che si scende in piazza senza colori; ma la politica non si sospende, e ciò a cui comunque oggi siamo chiamati è a prendere partito, a prendere partito non per una Nazione, non per una classe, non “prima per noi”, ma a prendere partito per la Terra, dalla parte della Terra.
Ma ancor più che la riluttanza all’uso di strumenti già noti, ciò che impedisce l’avvio di questo processo costituente, è la mancanza di un pensiero politico comune che ne faccia emergere l’esigenza e ne ispiri modalità e contenuti.
Non manca certamente l’elaborazione teorica di un costituzionalismo globale che vada oltre il modello dello Stato nazionale, il solo nel quale finora è stata concepita e attuata la democrazia, né mancano grandi maestri che lo propugnino; ma non è diventato patrimonio comune, non è entrato nelle vene del popolo un pensiero che pensi e promuova una Costituzione della Terra, una unità politica dell’intera comunità umana, il passaggio a una nuova e rassicurante fase della storia degli esseri umani sulla Terra.
Eppure le cose vanno così: il pensiero dà forma alla realtà, ma è la sfida della realtà che causa il pensiero. Una “politica interna del mondo” non può nascere senza una scuola di pensiero che la elabori, e un pensiero non può attivare una politica per il mondo senza che dei soggetti politici ne facciano oggetto della loro lotta. Però la cosa è tale che non può darsi prima la politica e poi la scuola, né prima la scuola e poi la politica. Devono nascere insieme, perciò quello che proponiamo è di dar vita a una Scuola che produca un nuovo pensiero della Terra e fermenti causando nuove soggettività politiche per un costituzionalismo della Terra. Perciò questa Scuola si chiamerà «Costituente Terra».
«Costituente Terra»: una Scuola per un nuovo pensiero
Certamente questa Scuola non può essere pensata al modo delle Accademie o dei consueti Istituti scolastici, ma come una Scuola disseminata e diffusa, telematica e stanziale, una rete di scuole con aule reali e virtuali. Se il suo scopo è di indurre a una mentalità nuova e a un nuovo senso comune, ogni casa dovrebbe diventare una scuola e ognuno in essa sarebbe docente e discente. Il suo fine potrebbe perfino spingersi oltre il traguardo indicato dai profeti che volevano cambiare le lance in falci e le spade in aratri e si aspettavano che i popoli non avrebbero più imparato l’arte della guerra. Ciò voleva dire che la guerra non era in natura: per farla, bisognava prima impararla. Senonché noi l’abbiamo imparata così bene che per prima cosa dovremmo disimpararla, e a questo la scuola dovrebbe addestrarci, a disimparare l’arte della guerra, per imparare invece l’arte di custodire il mondo e fare la pace.
Molte sarebbero in tale scuola le aree tematiche da perlustrare:
1) le nuove frontiere del diritto, il nuovo costituzionalismo e la rifondazione del potere;
2) il neo-liberismo e la crescente minaccia dell’anomia;
3) la critica delle culture ricevute e i nuovi nomi da dare a eventi e fasi della storia passata;
4) il lavoro e il Sabato, un lavoro non ridotto a merce, non oggetto di dominio e alienato dal tempo della vita;
5) la «Laudato sì» e l’ecologia integrale;
6) il principio femminile, come categoria rigeneratrice del diritto, dal mito di Antigone alla coesistenza dei volti di Levinas, al legame tra donna e natura fino alla metafora della madre-terra;
7) l’Intelligenza artificiale (il Führer artificiale?) e l’ultimo uomo;
8) come passare dalle culture di dominio e di guerra alle culture della liberazione e della pace;
9) come uscire dalla dialettica degli opposti, dalla contraddizione servo-signore e amico-nemico per assumere invece la logica dell’ et-et, della condivisione, dell’armonia delle differenze, dell’ «essere per l’altro», dell’ «essere l’altro»;
10) il congedo del cristianesimo dal regime costantiniano, nel suo arco «da Costantino ad Hitler», e la riapertura nella modernità della questione di Dio;
11) il «caso Bergoglio», preannuncio di una nuova fase della storia religiosa e secolare del mondo.
Naturalmente molti altri temi potranno essere affrontati, nell’ottica di una cultura per la Terra alla quale nulla è estraneo d’umano. Tutto ciò però come ricerca non impassibile e fuori del tempo, ma situata tra due kairòs, tra New Delhi ed Abu Dhabi, due opportunità, una non trattenuta e non colta, la proposta di Gorbaciov e Rajiv Gandhi del novembre 1986 per un mondo libero dalle armi nucleari e non violento, e l’altra che ora si presenta di una nuova fraternità umana per la convivenza comune e la salvezza della Terra, preconizzata nel documento islamo-cristiano del 4 febbraio 2019 e nel successivo Comitato di attuazione integrato anche dagli Ebrei, entrato ora in rapporto con l’ONU per organizzare un Summit mondiale della Fratellanza umana e fare del 4 febbraio la Giornata mondiale che la celebri.
Partecipare al processo costituente iscriversi al Comitato promotore
Pertanto i firmatari di questo appello propongono di istituire una Scuola denominata «Costituente Terra» che prenda partito per la Terra, e a questo scopo hanno costituito un’associazione denominata «Comitato promotore partito della Terra». Si chiama così perché in via di principio non era stata esclusa all’inizio l’idea di un partito, e in futuro chissà. Il compito è oggi di dare inizio a una Scuola, «dalla parte della Terra», alle sue attività e ai suoi siti web, e insieme con la Scuola ad ogni azione utile al fine «che la storia continui»; e ciò senza dimenticare gli obiettivi più urgenti, il risanamento del territorio, la rifondazione del lavoro, l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, la firma anche da parte dell’Italia del Trattato dell’ONU per l’interdizione delle armi nucleari e così via.
I firmatari propongono che persone di buona volontà e di non perdute speranze, che esponenti di associazioni, aggregazioni o istituzioni già impegnate per l’ecologia e i diritti, si uniscano a questa impresa e, se ne condividono in linea generale l’ispirazione, si iscrivano al Comitato promotore di tale iniziativa all’indirizzo progettopartitodellaterra@gmail.com versando la relativa quota sul conto BNL intestato a “Comitato promotore del partito della Terra”,
 IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR).
IBAN IT94X0100503206000000002788 (dall’estero BIC BNLIITRR).La quota annua di iscrizione, al Comitato e alla Scuola stessa, è libera, e sarà comunque gradita. Per i meno poveri, per quanti convengano di essere tra i promotori che contribuiscono a finanziare la Scuola, eventuali borse di studio e il processo costituente, la quota è stata fissata dal Comitato stesso nella misura significativa di 100 euro, con l’intenzione di sottolineare che la politica, sia a pensarla che a farla, è cosa tanto degna da meritare da chi vi si impegna che ne sostenga i costi, contro ogni tornaconto e corruzione, ciò che per molti del resto è giunto fino all’offerta della vita. Naturalmente però si è inteso che ognuno, a cominciare dai giovani, sia libero di pagare la quota che crede, minore o maggiore che sia, con modalità diverse, secondo le possibilità e le decisioni di ciascuno.
Nel caso che l’iniziativa non riuscisse, le risorse finanziarie mancassero e il processo avviato non andasse a buon fine, l’associazione sarà sciolta e i fondi eventualmente residui saranno devoluti alle ONG che si occupano dei salvataggi dei fuggiaschi e dei naufraghi nel Mediterraneo.
Un’assemblea degli iscritti al Comitato sarà convocata non appena sarà raggiunto un congruo numero di soci, per l’approvazione dello Statuto dell’associazione, la formazione ed elezione degli organi statutari e l’impostazione dei programmi e dell’attività della Scuola.
Roma, 27 dicembre 2019, 72° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana.
PROPONENTI E PRIMI ISCRITTI. Raniero La Valle, giornalista (Roma), Luigi Ferrajoli, filosofo del diritto (Roma), Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, Raffaele Nogaro, ex vescovo di Caserta, Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale, Mariarosaria Guglielmi, Segretaria generale di Magistratura Democratica, Riccardo Petrella, ecologo, promotore del Manifesto dell’acqua e dell’identità di “Abitante della Terra”, Domenico Gallo, magistrato, Francesco Carchedi, sociologo (Roma), Francesco Di Matteo, Comitati Dossetti per la Costituzione, Anna Falcone. avvocata, Roma, Pippo Civati, Politico, Piero Basso (Milano), Gianpietro Losapio, cooperatore sociale, direttore del Consorzio NOVA, Giacomo Pollastri, studente in Legge (Roma), Francesco Comina, giornalista (Bolzano), Roberto Mancini, filosofo (Macerata), Francesca Landini, informatica (Roma), Giancarlo Piccinni e la Fondazione don Tonino Bello (Alessano), Grazia Tuzi, antropologa, autrice di “Quando si faceva la Costituzione. Storia e personaggi della comunità del porcellino” (Roma), Guido Innocenzo Gargano osb cam., monaco (Roma), Felice Scalia, s. J, (Messina), Marina Graziosi, docente (Roma), Agata Cancelliere, insegnante, (Roma), Raul Mordenti, storico della critica letteraria, Politico (Roma), Salvatore Maira, scrittore (Roma), Marco Malagola, francescano, missionario, (Torino), Norma Lupi (Roma), Andrea Cantaluppi, sindacalista (Roma), Enrico Peyretti (Torino), Nino Mantineo, università di Catanzaro, Giacoma Cannizzo, già sindaca di Partinico, Filippo Grillo, artista (Palermo), Nicola Colaianni, già magistrato e docente all’Università di Bari, Stefania Limiti, giornalista (Roma), Domenico Basile (Merate, Lecco), Maria Chiara Zoffoli (Merate), Luigi Gallo (Bolzano), Antonio Vermigli, giornalista (Quarrata, Pistoia), Renata Finocchiaro, ingegnere (Catania), Liana D’Alessio (Roma), Lia Fava, ordinaria di letteratura (Roma), Paolo Pollastri, musicista (Roma), Fiorella Coppola, sociologa (Napoli), Dario Cimaglia, editore, (Roma), Luigi Spina, insegnante, ricercatore (Biella), Marco Campedelli, Boris Ulianich, storico, Università Federico II, Napoli, Gustavo Gagliardi, Roma, Paolo Scandaletti, scrittore di storia, Roma, Pierluigi Sorti, economista, Roma, Vittorio Bellavite, coordinatore di “Noi siamo Chiesa”, Agnés Deshormes, cooperatrice internazionale, Parigi, Anna Sabatini Scalmati, psicoterapeuta, Roma, Francesco Piva, Roma, Sergio Tanzarella, storico del cristianesimo, Tina Palmisano, Il Giardino Terapeutico sullo Stretto, Messina, Luisa Marchini, segretaria di “Salviamo la Costituzione”, Bologna, Maurizio Chierici, giornalista. Angelo Cifatte, formatore, Genova, Marco Tiberi, sceneggiatore, Roma, Achille Rossi e l’altrapagina, Città di Castello, Antonio Pileggi, ex Provveditore agli studi e dir. gen. INVALSI, Giovanni Palombarini, magistrato, Vezio Ruggieri, psicofisiologo (Roma) Bernardetta Forcella (insegnante (Roma), Luigi Narducci (Roma), Laura Nanni (Albano), Giuseppe Salmè, magistrato, Giovanni Bianco, giurista, Roma.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE E LA "FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO", OGGI.1 dicembre 2019, di Federico La Sala
 LETTERA APOSTOLICA
LETTERA APOSTOLICA
 Admirabile signum
Admirabile signum
 DEL SANTO PADRE
DEL SANTO PADRE
 FRANCESCO
FRANCESCO
 SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *
SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE *1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata.
2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe.
 Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.
 Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
Ma veniamo subito all’origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici con la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un’antica tradizione, le tavole della mangiatoia.
 Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
Le Fonti Francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario, secondo il desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti e arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. -La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, non c’erano statuine: il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti.[2]
È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.
 Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]
Il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte, alla scena semplice e toccante s’aggiunse anche il dono di una visione meravigliosa: uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia Gesù Bambino stesso. Da quel presepe del Natale 1223, «ciascuno se ne tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia».[3]3. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio.
 Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che Colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.
 Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali.
 In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).
In modo particolare, fin dall’origine francescana il presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. È un appello a incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr Mt 25,31-46).4. Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma anche per il significato che possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita. -Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti attraversano le tenebre della sofferenza (cfr Lc 1,79).
 Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.
Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario.5. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli, le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, come avevano preannunciato i profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore.
 «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15): così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. -A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe.6. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi.
 I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio di gioia. -Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato.
Spesso i bambini - ma anche gli adulti! - amano aggiungere al presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano...: tutto ciò rappresenta la santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condivide con noi la sua vita divina.
 7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv 2,5).
 Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.
Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica.8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque.
 La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita.
 «La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.
«La vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.
Il modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. -Che sorpresa vedere Dio che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio sconcerta, è imprevedibile, continuamente fuori dai nostri schemi. Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della vita.9. Quando si avvicina la festa dell’Epifania, si collocano nel presepe le tre statuine dei Re Magi. Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali hanno un significato allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; l’incenso la sua divinità; la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la sepoltura.
 Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
Guardando questa scena nel presepe siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia.
 I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.
I Magi insegnano che si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo. Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Davanti al Re Bambino li pervade una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a mettersi in ginocchio e ad adorarlo. Davanti a Lui comprendono che Dio, come regola con sovrana sapienza il corso degli astri, così guida il corso della storia, abbassando i potenti ed esaltando gli umili. E certamente, tornati nel loro Paese, avranno raccontato questo incontro sorprendente con il Messia, inaugurando il viaggio del Vangelo tra le genti.10. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.
Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato.
FRANCESCO
 [1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
[1] Tommaso da Celano, Vita Prima, 84: Fonti francescane (FF), n. 468.
 [2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
[2] Cf. ibid., 85: FF, n. 469.
 [3] Ibid., 86: FF, n. 470.
[3] Ibid., 86: FF, n. 470.
 [01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[01938-IT.01] [Testo originale: Italiano]
* Fonte: Lettera apostolica. Papa Francesco a Greccio: ecco il vero significato del presepe di Mimmo Muolo, Avvenire, 30.11.2019 (ripresa parziale).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- MEMORIA E CIVILTA’. LA LEZIONE DI FRANCA VIOLA: "2 GENNAIO 1966" (di Chia Saraceno).28 novembre 2019, di Federico La Sala
"FAMILISMO AMORALE" : IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.... *
Calendario civileLa liberazione di Franca Viola
2 gennaio 1966
di Chiara Saraceno (Il Mulino, 02.01. 2019)
Il 2 gennaio 1966 ad Alcamo, in Sicilia, la polizia fa irruzione nella casa in cui è tenuta prigioniera la diciassettenne Franca Viola, trascinata via a forza da casa sua il giorno di Santo Stefano, sequestrata e violentata da Filippo Melodia, con cui aveva tempo prima rotto il fidanzamento dopo che l’uomo era stato arrestato per furto e appartenenza a una banda mafiosa.
La ragazza viene liberata e Melodia arrestato con i suoi complici, con l’accusa di sequestro di persona e violenza carnale su minorenne. L’intervento della polizia era stato concordato con i genitori della ragazza che, proprio per consentire l’arresto in flagranza del Melodia, avevano fatto finta di accettare il fatto compiuto e l’inevitabilità del matrimonio cosiddetto riparatore. In quegli anni, infatti, e ancora fino al 1981 quando la norma venne definitivamente cancellata dal codice penale, il matrimonio non “rimetteva a posto” le cose solo agli occhi dell’opinione comune. Cancellava anche il reato di rapimento e di stupro. Facendo liberare la ragazza e consegnando il suo violentatore alla polizia, i genitori rifiutavano precisamente questa soluzione, restituendo a Franca, allora minorenne, la sua libertà di scelta e di vita.
 Una libertà che la giovanissima Franca esercitò fino in fondo, in contrasto con gli usi prevalenti a quel tempo e nella sua comunità, ribadendo anche in tribunale la propria indisponibilità a sposare il suo violentatore. Negando che si era trattato di una “fuitina”, fatta in accordo dai due per forzare il matrimonio contro il parere dei genitori di lei, come sosteneva la difesa. Nel clamore suscitato dal processo a livello nazionale, più per l’inaspettato rifiuto della ragazza che per la gravità dell’accaduto, Franca mantenne ferma la propria posizione, nonostante gli attacchi pesanti alla sua “moralità” e nonostante, secondo la morale del tempo, fosse stata “disonorata” pubblicamente - addirittura a livello nazionale a causa del
processo - dal rapimento e dallo stupro subito. Al suo fianco c’erano, appunto, i suoi genitori. Non volevano sacrificarla per sottostare al potere intimidatorio che aveva la famiglia di questi ad Alcamo, dove abitavano entrambe le famiglie, nonostante dopo la rottura del fidanzamento avessero subito minacce e aggressioni.
Una libertà che la giovanissima Franca esercitò fino in fondo, in contrasto con gli usi prevalenti a quel tempo e nella sua comunità, ribadendo anche in tribunale la propria indisponibilità a sposare il suo violentatore. Negando che si era trattato di una “fuitina”, fatta in accordo dai due per forzare il matrimonio contro il parere dei genitori di lei, come sosteneva la difesa. Nel clamore suscitato dal processo a livello nazionale, più per l’inaspettato rifiuto della ragazza che per la gravità dell’accaduto, Franca mantenne ferma la propria posizione, nonostante gli attacchi pesanti alla sua “moralità” e nonostante, secondo la morale del tempo, fosse stata “disonorata” pubblicamente - addirittura a livello nazionale a causa del
processo - dal rapimento e dallo stupro subito. Al suo fianco c’erano, appunto, i suoi genitori. Non volevano sacrificarla per sottostare al potere intimidatorio che aveva la famiglia di questi ad Alcamo, dove abitavano entrambe le famiglie, nonostante dopo la rottura del fidanzamento avessero subito minacce e aggressioni.Gli eventi del 2 gennaio, perciò, segnano una doppia sfida al potere. Una sfida a una morale, sancita dalla legge, che proteggeva il maschio aggressore mentre riduceva la donna a un corpo violabile impunemente, purché sotto la protezione, anche ex post, del matrimonio e alla prepotenza della malavita locale. Una sfida anche alla complicità corriva e ipocrita dell’opinione comune, pronta a condannare la vittima “disonorata” e ad ammirare il violento capace di prendersi ciò che vuole.
Ricordo negli stessi anni una situazione analoga per sequenza dei fatti - stupro seguito da offerta di matrimonio riparatore - ma non per finale. Infatti l’uomo, un giornalista, che aveva stuprato una zingara minorenne se l’era cavata sposandola, sotto lo sguardo divertito e un po’ compassionevole dei suoi colleghi (e di qualche collega) che avevano fatto reportage sulle nozze e sulla vestizione della zingara sposa.
 A differenza di Viola e invece come molte altre prima e dopo di lei, l’adolescente zingara non trovò nessuno che le aprisse la possibilità di rifiutare il bruto che l’aveva stuprata e lasciarlo alla sua giusta punizione. Purtroppo, nonostante allora l’episodio avesse avuto un certo clamore a causa della differenza sociale degli “sposi” e data la professione dell’uomo, non ne è rimasta traccia, almeno nel vasto mondo del web. Devo perciò affidarmi solo alla mia memoria, da cui non emergono ricordi di articoli a sostegno della ragazzina o di scandalo per l’ipocrisia di quel matrimonio probabilmente finito il giorno stesso, a meno che l’uomo non avesse deciso di abusare ancora un po’ della ragazza divenuta sua proprietà.
A differenza di Viola e invece come molte altre prima e dopo di lei, l’adolescente zingara non trovò nessuno che le aprisse la possibilità di rifiutare il bruto che l’aveva stuprata e lasciarlo alla sua giusta punizione. Purtroppo, nonostante allora l’episodio avesse avuto un certo clamore a causa della differenza sociale degli “sposi” e data la professione dell’uomo, non ne è rimasta traccia, almeno nel vasto mondo del web. Devo perciò affidarmi solo alla mia memoria, da cui non emergono ricordi di articoli a sostegno della ragazzina o di scandalo per l’ipocrisia di quel matrimonio probabilmente finito il giorno stesso, a meno che l’uomo non avesse deciso di abusare ancora un po’ della ragazza divenuta sua proprietà.
 In generale, i “matrimoni riparatori” che estinguevano il reato di stupro consegnavano legalmente la donna nelle mani di un uomo violento, privo di rispetto per lei, legittimandone la prepotenza a vita. È ciò che avviene ancora oggi, là dove il matrimonio riparatore è ancora permesso (non solo in alcuni Paesi in via di sviluppo, ma anche in alcuni Stati degli Stati Uniti, nonostante una legge federale lo vieti).
In generale, i “matrimoni riparatori” che estinguevano il reato di stupro consegnavano legalmente la donna nelle mani di un uomo violento, privo di rispetto per lei, legittimandone la prepotenza a vita. È ciò che avviene ancora oggi, là dove il matrimonio riparatore è ancora permesso (non solo in alcuni Paesi in via di sviluppo, ma anche in alcuni Stati degli Stati Uniti, nonostante una legge federale lo vieti).Oggi il gesto coraggioso di Franca viene giustamente ricordato come quello che aprì alla cancellazione dell’istituto del matrimonio riparatore, innanzitutto perché fece da detonatore per l’apertura di un dibattito pubblico sulla questione in un paese ancora fortemente misogino e regolato, per quanto riguardava le norme sulla famiglia e la sessualità, dal codice civile e penale fascisti. Ma ci sono voluti quindici anni, la rottura culturale del Sessantotto e soprattutto dei movimenti femministi, perché la sfida di Franca Viola e dei suoi genitori a una morale e a una legge ipocrite e fortemente maschiliste diventassero senso comune e portassero, appunto, all’abrogazione di una norma radicalmente incivile e biecamente maschilista.
 Neppure la riforma del diritto di famiglia nel 1975, che pure aveva cancellato l’asimmetria legale tra marito e moglie nel matrimonio rimasta in vigore in barba al dettato Costituzionale (art. 29), lo aveva eliminato come possibilità. Troppo tenace e radicata era l’idea, documentata anche da Pasolini nel suo documentario Comizi d’amore del 1965, che l’onore di una donna stesse, non solo, nel suo sesso, inteso come organo fisico, ma nel rapporto giuridico che aveva con l’uomo che ne faceva, letteralmente, uso, con o senza il suo consenso.
Neppure la riforma del diritto di famiglia nel 1975, che pure aveva cancellato l’asimmetria legale tra marito e moglie nel matrimonio rimasta in vigore in barba al dettato Costituzionale (art. 29), lo aveva eliminato come possibilità. Troppo tenace e radicata era l’idea, documentata anche da Pasolini nel suo documentario Comizi d’amore del 1965, che l’onore di una donna stesse, non solo, nel suo sesso, inteso come organo fisico, ma nel rapporto giuridico che aveva con l’uomo che ne faceva, letteralmente, uso, con o senza il suo consenso.
 Per questo si riteneva che l’onore di una donna fosse alla mercé del potere degli uomini, di tutti in quanto potenziali violentatori. Sempre per questo le donne dovevano condurre una vita “sorvegliata”, per non esporsi ad essere “disonorate”. La verginità al matrimonio non era il “dono” che la donna faceva allo sposo (per altro senza reciprocità), come sostenevano taluni manuali per le fidanzate e la posta del cuore delle riviste, ammantando di buoni sentimenti una concezione del matrimonio che legittimava qualsiasi prepotenza, sessuale e non, del marito sulla moglie. Piuttosto era la garanzia che si trattava di “merce non avariata”, che come tale, analogamente al tradimento anche solo sospettato della moglie, “disonorava” indirettamente anche l’uomo cui era legata come moglie, figlia o sorella. Era lo stesso concetto di onore che stava alla base del mostro giuridico che andava sotto la dizione “delitto di onore”, non a caso abrogato, troppo tardivamente, contestualmente al matrimonio riparatore dalla legge 442 del 5 agosto 1981.
Per questo si riteneva che l’onore di una donna fosse alla mercé del potere degli uomini, di tutti in quanto potenziali violentatori. Sempre per questo le donne dovevano condurre una vita “sorvegliata”, per non esporsi ad essere “disonorate”. La verginità al matrimonio non era il “dono” che la donna faceva allo sposo (per altro senza reciprocità), come sostenevano taluni manuali per le fidanzate e la posta del cuore delle riviste, ammantando di buoni sentimenti una concezione del matrimonio che legittimava qualsiasi prepotenza, sessuale e non, del marito sulla moglie. Piuttosto era la garanzia che si trattava di “merce non avariata”, che come tale, analogamente al tradimento anche solo sospettato della moglie, “disonorava” indirettamente anche l’uomo cui era legata come moglie, figlia o sorella. Era lo stesso concetto di onore che stava alla base del mostro giuridico che andava sotto la dizione “delitto di onore”, non a caso abrogato, troppo tardivamente, contestualmente al matrimonio riparatore dalla legge 442 del 5 agosto 1981.Ma ci vollero ancora altri quindici anni perché, sempre per la pressione del movimento delle donne, nel febbraio 1996, dopo un lunghissimo e controverso iter parlamentare, si modificasse la definizione del codice (fascista) Rocco secondo cui lo stupro era un reato non contro la persona, la sua integrità e la sua libertà, ma contro la moralità pubblica e il buon costume. Fino ad allora, la vittima dello stupro non era prioritariamente la donna, bensì, appunto, la moralità pubblica e l’onore della famiglia. Il gran rifiuto di Franca Viola e dei suoi genitori aveva già dimostrato l’inaccettabilità di questa definizione.
 Ci sono voluti tuttavia trent’anni e un mese e due diverse leggi perché il Parlamento italiano facesse propria una consapevolezza che era stata così chiara in una adolescente siciliana e nei suoi genitori contadini, al punto da essere disposti a pagarne il prezzo di dileggio ed emarginazione sociale. Trent’anni perché si desse seguito al gesto di sfida lanciato da una giovane ragazza di un piccolo paese del Sud.
Ci sono voluti tuttavia trent’anni e un mese e due diverse leggi perché il Parlamento italiano facesse propria una consapevolezza che era stata così chiara in una adolescente siciliana e nei suoi genitori contadini, al punto da essere disposti a pagarne il prezzo di dileggio ed emarginazione sociale. Trent’anni perché si desse seguito al gesto di sfida lanciato da una giovane ragazza di un piccolo paese del Sud.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA. Una nota di Chiara Saraceno
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaCREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- MITO, STORIA, E ANTROPOLOGIA: "METAMORFOSI". Cenis/Ceneo, quando uno stupro cancella l’identità (di Alba Subrizio).25 novembre 2019, di Federico La Sala
Antichi Ritorni
Cenis/Ceneo, quando uno stupro cancella l’identità
Oltraggiata dal dio Poseidone la fanciulla chiede di diventare uomo
di Alba Subrizio (il Mattino di Puglia e Basilicata, 10/09/2017)
La prima trasformazione female-to-male ma soprattutto il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita. Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Per cancellare quel dolore, Cenis ha bisogno di ripudiare se stessa, divenendo altro...
Lungi da me l’idea di fare politica, non posso tacere in merito agli stupri perpetrati nelle ultime settimane in tutta Italia e allo scempio mediatico a cui le vittime sono state sottoposte. In una società come la nostra, quasi assuefatta ai crimini della peggior specie (sic!), sembra che il ‘delitto’ commesso passi in secondo piano, il dolore, la vergogna subita, sono cose che non vogliamo vedere o che forse non ci interessano; ciò che invece interessa è sapere chi ha compiuto il misfatto: l’immigrato, l’italiano, il carabiniere finanche...
Soprattutto sui social network - ormai divenuti sempre più luogo di sfogo di personali frustrazioni da parte di individui che diversamente non saprebbero come esistere - leggo commenti insulsi, a dir poco da far accapponare la pelle: dopo i fatti di Firenze c’è chi inneggiava che a commettere l’abominio fossero stati esponenti dell’Arma (inneggiare sì, come se fosse una bella cosa, l’importante è che non fossero ancora una volta accusati cittadini extracomunitari); d’altra parte in seguito ai fatti di Rimini leggo gente “tutta contenta” utilizzare gli avvenimenti a sostegno delle loro teorie xenofobe... e poi numeri e numeri. Come se tutto ciò fosse un gioco: un gioco a calcolare quale ‘parte’ in gara ha compiuto più stupri.
Da questo quadro emerge solo un dato di fatto: il popolo italiano, di qualunque colore politico, ha perso ormai il senno. Ahinoi, non possiamo dire che i nostri antenati latini fossero poi così diversi; basti rileggere i miti antichi per accorgersi da quanti stupri e violenze sono disseminate queste storie: piccoli particolari senza valore all’interno di Storie ben più grandi, ben più importanti.
A convalida di ciò, si pensi solo a Zeus ed Apollo (i campioni dello stupro) per non parlare di altre divinità. Eh già, perché nell’antica Grecia i maggiori artefici di violenze erano gli dèi, proprio quelli che avrebbero dovuto proteggere gli uomini. Tra i tanti miti me ne viene in mente uno che, sebbene sconosciuto ai più, mi ha attratto per la forza delle immagini.
C’era una volta Cenis, una delle donne più belle di tutta la Tessaglia; nonostante decine e decine fossero i suoi pretendenti, lei non voleva concedersi e preferiva godere spensierata della sua fanciullezza. Ma un giorno, mentre passeggiava sulle rive del mare, il dio Poseidone, desiderandola, le usò violenza.
Dopo aver goduto di lei - così narra il poeta latino Ovidio nelle sue “Metamorfosi” - le disse che avrebbe realizzato per Cenis ogni suo desiderio. Così ella rispose: «L’ingiuria che ho patito provoca in me un desiderio grande: quello di non dover subire mai più alcunché di simile. Se farai in modo che io non sia più donna, mi avrai completamente accontentato». Fu così che il dio del mare trasformò Cenis in Ceneo.
Il mito non è una semplice metamorfosi come le altre: innanzitutto è la prima volta nella letteratura mondiale che leggiamo di una donna che diventa uomo (la prima trasformazione female-to-male), ma soprattutto è il rinnegamento della propria sessualità in virtù di una violenza subita.
Ovidio con questa storia spiega come lo stupro ferisca non solo fisicamente ma anche mentalmente, al punto che la ragazza sente il bisogno di cancellare per sempre quella femminilità oltraggiata; nulla potrà mai essere come prima. Scioccamente (da buon maschione) il dio crede di rimediare offrendo un dono, ma nulla può cancellare ciò che è stato. Lo sa bene Cenis, che pertanto, per cancellare quel dolore, ha bisogno di cancellare e ripudiare se stessa, divenendo altro.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
STORIA E MITO. GIASONE, "L’OMBRA D’ARGO", E “VENTICINCINQUE SECOLI” DI LETARGO: "SE NON RIDIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI" (Mt. 18, 3).
 DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiograficaFederico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- L’«ARCHIVIO SEGRETO VATICANO» "da ora in poi" «ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO».14 novembre 2019, di Federico La Sala
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
PER IL CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE
DA
- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO
AD
- ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO *
L’esperienza storica insegna che ogni istituzione umana, sorta pure con le migliori tutele e con vigorose e fondate speranze di progresso, toccata fatalmente dal tempo, proprio per rimanere fedele a se stessa e agli scopi ideali della sua natura, avverte il bisogno, non già di mutare la propria fisionomia, ma di trasporre nelle diverse epoche e culture i propri valori ispiratori e operare quegli aggiornamenti che si rendono convenienti e a volte necessari.
Anche l’Archivio Segreto Vaticano, al quale i Romani Pontefici hanno sempre riservato sollecitudine e cura in ragione dell’ingente e rilevante patrimonio documentario che conserva, tanto prezioso per la Chiesa Cattolica quanto per la cultura universale, non sfugge, nella sua storia ormai più che quattro volte centenaria, a tali inevitabili condizionamenti.
Sorto dal nucleo documentario della Camera Apostolica e della stessa Biblioteca Apostolica (la cosiddetta Bibliotheca secreta) fra il primo e secondo decennio del XVII secolo, l’Archivio Pontificio, che cominciò a chiamarsi Segreto (Archivum Secretum Vaticanum) solo intorno alla metà di tale secolo, accolto in confacenti locali del Palazzo Apostolico, crebbe nel tempo in consistenza notevolissima e fin da subito si aprì alle richieste di documenti che pervenivano al Pontefice Romano, al cardinale Camerlengo e poi al cardinale Archivista e Bibliotecario da ogni parte dell’Europa e del mondo. Se è vero che l’apertura ufficiale dell’Archivio ai ricercatori di ogni Paese si avrà soltanto nel 1881, è vero anche che fra il XVII e il XIX secolo molte opere erudite si poterono pubblicare con l’ausilio di copie documentarie fedeli o autentiche che gli storici ottenevano dai custodi e dai prefetti dell’Archivio Segreto Vaticano. Tanto che il celebre filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm von Leibniz, il quale pure vi attinse, scrisse nel 1702 che esso poteva considerarsi in certo modo l’Archivio centrale dell’Europa (quod quodam modo totius Europae commune Archivum censeri debet).
Questo lungo servizio reso alla Chiesa, alla cultura e agli studiosi di tutto il mondo ha sempre guadagnato all’Archivio Segreto Vaticano stima e riconoscenza, tanto più crescenti da Leone XIII ai nostri giorni, sia in ragione delle progressive «aperture» della documentazione resa disponibile alla consultazione (che dal prossimo 2 marzo 2020, per mia disposizione, si estenderà fino al termine del pontificato di Pio XII), sia in ragione dell’aumento di ricercatori che sono quotidianamente ammessi all’Archivio medesimo e aiutati in ogni modo nelle loro ricerche.
Tale meritorio servizio ecclesiale e culturale, così apprezzato, bene risponde agli intenti di tutti i miei predecessori, che secondo i tempi e le possibilità hanno favorito le ricerche storiche in così vasto Archivio, dotandolo, secondo i suggerimenti dei cardinali Archivisti o dei prefetti pro tempore, di persone, di mezzi e anche di nuove tecnologie. In tal modo si è provveduto alla graduale crescita della struttura dell’Archivio stesso per il suo sempre più impegnativo servizio alla Chiesa e al mondo della cultura, mantenendo sempre fede agli insegnamenti e alle direttive dei Pontefici.
Vi è tuttavia un aspetto che penso possa essere ancora utile aggiornare, ribadendo le finalità ecclesiali e culturali della missione dell’Archivio. Tale aspetto riguarda la stessa denominazione dell’istituto: Archivio Segreto Vaticano.
Nato, come accennato, dalla Bibliotheca secreta del Romano Pontefice, ovvero dalla parte di codici e scritture più particolarmente di proprietà e sotto la giurisdizione diretta del Papa, l’Archivio si intitolò dapprima semplicemente Archivum novum, poi Archivum Apostolicum, quindi Archivum Secretum (le prime attestazioni del termine risalgono al 1646 circa).
Il termine Secretum, entrato a formare la denominazione propria dell’istituzione, prevalsa negli ultimi secoli, era giustificato, perché indicava che il nuovo Archivio, voluto dal mio predecessore Paolo V verso il 1610-1612, altro non era che l’archivio privato, separato, riservato del Papa. Così intesero sempre definirlo tutti i Pontefici e così lo definiscono ancora oggi gli studiosi, senza alcuna difficoltà. Questa definizione, del resto, era diffusa, con analogo significato, presso le corti dei sovrani e dei principi, i cui archivi si definirono propriamente secreti.
Finché perdurò la coscienza dello stretto legame fra la lingua latina e le lingue che da essa discendono, non vi era bisogno di spiegare o addirittura di giustificare tale titolo di Archivum Secretum. Con i progressivi mutamenti semantici che si sono però verificati nelle lingue moderne e nelle culture e sensibilità sociali di diverse nazioni, in misura più o meno marcata, il termine Secretum accostato all’Archivio Vaticano cominciò a essere frainteso, a essere colorato di sfumature ambigue, persino negative. Avendo smarrito il vero significato del termine secretum e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola «segreto», in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l’accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi. Tutto il contrario di quanto è sempre stato e intende essere l’Archivio Segreto Vaticano, che - come disse il mio santo predecessore Paolo VI - conserva «echi e vestigia» del passaggio del Signore nella storia (Insegnamenti di Paolo VI, I, 1963, p. 614). E la Chiesa «non ha paura della storia, anzi la ama, e vorrebbe amarla di più e meglio, come la ama Dio!» (Discorso agli Officiali dell’Archivio Segreto Vaticano, 4 marzo 2019: L’Osservatore Romano, 4-5 marzo 2019, p. 6).
Sollecitato in questi ultimi anni da alcuni stimati Presuli, nonché dai miei più stretti collaboratori, ascoltato anche il parere dei Superiori del medesimo Archivio Segreto Vaticano, con questo mio Motu Proprio decido che:
da ora in poi l’attuale Archivio Segreto Vaticano, nulla mutando della sua identità, del suo assetto e della sua missione, sia denominato Archivio Apostolico Vaticano.
Riaffermando la fattiva volontà di servizio alla Chiesa e alla cultura, la nuova denominazione mette in evidenza lo stretto legame della Sede romana con l’Archivio, strumento indispensabile del ministero petrino, e al tempo stesso ne sottolinea l’immediata dipendenza dal Romano Pontefice, così come già avviene in parallelo per la denominazione della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Dispongo che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, così da essere subito recepita nei documenti ufficiali della Santa Sede, e che, successivamente, sia inserita negli Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 22 ottobre 2019, settimo del nostro Pontificato.
Francesco
* Fonte: http://w2.vatican.va/
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- UNA CRITICA RADICALE AL PRESENTE: "IL RACCONTO DELL’ANCELLA". Margaret Atwood ( di Cristina Gamberi).26 ottobre 2019, di Federico La Sala
Margaret Atwood
La vincitrice del Booker Prize 2019 insieme a Bernardine Evaristo
di Cristina Gamberi (il Mulino, 21 ottobre 2019)
Può un libro cambiare il mondo? Nonostante le illusioni di molti, la risposta è chiaramente no. Eppure esistono libri a cui è stato riservato il curioso destino di, se non proprio cambiare il mondo, farsi strumento del cambiamento politico. Sono libri che hanno il potere di offrire un vocabolario e degli strumenti teorici, ma soprattutto narrazioni e immagini che aiutano a comprendere una realtà fino a quel momento sommersa o taciuta, adottando prospettive inconsuete e denunciando la condizione di oppressione in cui vivono le persone. In questo senso, sono libri rivoluzionari.
Uno dei testi che ha saputo innescare una radicale critica al presente su scala globale è Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, la scrittrice canadese che è appena stata insignita del più prestigioso premio letterario britannico, il Man Booker Prize, per il romanzo The Testaments. Edito in Italia da Ponte alle Grazie, I testamenti è l’attesissimo sequel della distopia ambientata nella Repubblica di Galaad, di cui non sappiamo se condividerà lo stesso destino del romanzo originale. Di sicuro, però, sappiamo che si tratta già di un successo editoriale che si colloca al culmine della parabola letteraria di un’autrice che all’età di ottant’anni ha alle spalle una carriera di scrittrice molto letta, molto premiata e saldamente insediata nell’establishment letterario mondiale.
 Fin dagli esordi, negli anni Sessanta, Atwood si è infatti misurata con una molteplicità di linguaggi ed eterogeneità di generi letterari, iniziando a scrivere poesie e pubblicando successivamente romanzi, storie per bambini, graphic novel, libretti per opera da camera, saggi critici e contribuendo attivamente all’adattamento delle sue opere in serie televisive, film e documentari.
Fin dagli esordi, negli anni Sessanta, Atwood si è infatti misurata con una molteplicità di linguaggi ed eterogeneità di generi letterari, iniziando a scrivere poesie e pubblicando successivamente romanzi, storie per bambini, graphic novel, libretti per opera da camera, saggi critici e contribuendo attivamente all’adattamento delle sue opere in serie televisive, film e documentari.Una solida formazione accademica - iniziata a Toronto con il teorico della letteratura Northrop Frye e proseguita al Radcliffe College di Harvard - ha fatto di lei una scrittrice colta. Il misurarsi con i grandi classici della tradizione occidentale è infatti uno degli aspetti principali della sua opera.
 Succede in The Penelopiad (2005) riscrittura dell’Odissea dal punto di vista di Penelope; nel romanzo Hag-Seed ispirato alla Tempesta di Shakespeare (2016); in Morning in the Burned House (1995) in cui Elena e Cressida prendono parola; e nel Racconto dell’ancella (1985) che trae ispirazione da un versetto biblico del della Genesi. Si tratta di una poetica profondamente intrecciata a quella che Adrienne Rich chiamò re-vision, ovvero il necessario confronto che le scrittrici devono compiere con la tradizione letteraria del passato per rileggere e riscrivere l’immaginario profondamente cristalizzato dal punto di vista del genere con l’obiettivo di entrare nei testi con uno sguardo nuovo: lo sguardo di donna.
Succede in The Penelopiad (2005) riscrittura dell’Odissea dal punto di vista di Penelope; nel romanzo Hag-Seed ispirato alla Tempesta di Shakespeare (2016); in Morning in the Burned House (1995) in cui Elena e Cressida prendono parola; e nel Racconto dell’ancella (1985) che trae ispirazione da un versetto biblico del della Genesi. Si tratta di una poetica profondamente intrecciata a quella che Adrienne Rich chiamò re-vision, ovvero il necessario confronto che le scrittrici devono compiere con la tradizione letteraria del passato per rileggere e riscrivere l’immaginario profondamente cristalizzato dal punto di vista del genere con l’obiettivo di entrare nei testi con uno sguardo nuovo: lo sguardo di donna.
Sono infatti la centralità della narrazione al femminile e l’indagine dell’autrice intorno alla soggettività delle donne a costituire il secondo aspetto saliente della scrittura di Atwood. Fin dal primo romanzo The Edible Woman (1969), la sua opera si intreccia con i temi, le rivendicazioni e i desideri espressi dalla seconda ondata del movimento femminista nord-americano, di cui è sempre stata reticente a definirsi parte attiva.
 La stessa Atwood ha tuttavia riconosciuto come il movimento delle donne abbia contribuito a espandere i territori a disposizione della scrittura, fornendo un’analisi lucida dei meccanismi di potere che operano nelle relazioni fra i generi e permettendo di esplorare aspetti dell’esperienza delle donne che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.
La stessa Atwood ha tuttavia riconosciuto come il movimento delle donne abbia contribuito a espandere i territori a disposizione della scrittura, fornendo un’analisi lucida dei meccanismi di potere che operano nelle relazioni fra i generi e permettendo di esplorare aspetti dell’esperienza delle donne che altrimenti sarebbero rimasti nascosti.Il legame fra le istanze femministe e la narrativa di Atwood è tuttavia da ricercare nell’uso del genere distopico, scelto dall’autrice perché maggiormente libero dai vincoli imposti dal realismo e quale luogo ideale per esplorare (e far esplodere) la costruzione dei ruoli di genere e gli assetti sociali considerati "naturali". Come era successo prima di lei in Katharine Burdekin e Octavia E. Butler, nel Racconto dell’ancella Atwood usa la distopia come spazio letterario privilegiato in cui la riappropriazione della sessualità e dei corpi femminili è mezzo cruciale per ridefinire l’agency e la soggettività delle donne.
 Il disturbante racconto dell’ancella Difred, la donna-schiava che vive asservita all’uomo per scopi riproduttivi in un regime teocratico di ispirazione biblica in un futuro non tanto lontano dal nostro, rappresenta infatti una critica radicale al patriarcato e al totalitarismo. Il suo racconto diventa narrazione capace di rivelare l’indissolubile legame fra il culto della virilità, i regimi totalitari, il controllo della sessualità femminile e la violenza sul corpo delle donne.
Il disturbante racconto dell’ancella Difred, la donna-schiava che vive asservita all’uomo per scopi riproduttivi in un regime teocratico di ispirazione biblica in un futuro non tanto lontano dal nostro, rappresenta infatti una critica radicale al patriarcato e al totalitarismo. Il suo racconto diventa narrazione capace di rivelare l’indissolubile legame fra il culto della virilità, i regimi totalitari, il controllo della sessualità femminile e la violenza sul corpo delle donne.Il curioso destino di questo libro non è solo che a distanza di trent’anni il suo messaggio è diventato politicamente urgente, ma è anche che ha prodotto effetti di realtà imprevisti. La narrazione distopica di Atwood ha infatti innescato inaspettate pratiche di soggettivazione radicate nei corpi delle donne. Nel 2017, quando viene trasmessa la prima serie televisiva ispirata al romanzo, nel clima politico seguito all’elezione di Donald Trump e in concomitanza con il dilagare del movimento #MeToo e #TimesUp, l’Ancella da finzione si è trasformata in realtà. La sua iconografia, contraddistinta da una lunga tunica rossa e dal capo coperto da una cuffia bianca, è infatti diventata il simbolo di un movimento vero e proprio e da allora è stata usata dalle donne di tutto il mondo per denunciare le forme di controllo sui propri corpi e la propria sessualità.
Il perché il romanzo sia ritornato oggi così attuale può essere spiegato con le continue violazioni dei diritti riproduttivi e con l’aumento delle forme di violenza contro le donne. Ma ciò che ha permesso alla narrazione di travalicare i confini del successo letterario è stato un doppio movimento. Da una parte il cruciale passaggio dal testo romanzesco alla serie televisiva. Dall’altra il processo dal basso che ha portato alla riappropriazione dell’immaginario distopico dell’ancella come forma di soggettivazione politica femminista e che l’ha trasformata in un potente strumento di critica delle forme di subordinazione non solo sessuale, ma anche economica e sociale del presente.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI CHIMICI E UNA VISIONE ANTROPOLOGICA CAPACE DI RISALIRE AI FONDAMENTI DELLA CONOSCENZA.25 ottobre 2019, di Federico La Sala
SCIENZA, FILOSOFIA, E ANTROPOLOGIA. Non è il caso di ripensare i fondamenti?! *
Chimica.
I 150 anni della tavola di Mendeleev, il rivoluzionario degli elementi
Lo scienziato russo inventò la Tavola periodica degli elementi grazie alla sua passione per i giochi: la sua scoperta ha qualcosa di incredibile. Mendeleev scoprì anche l’origine minerale del petrolio
di Franco Gàbici (Avvenire, mercoledì 27 febbraio 2019)
- [Foto] Dmitrij Ivanovič Mendeleev nel 1890 circa (WikiCommons)
Il primo giorno di marzo del 1869, e dunque 150 anni fa, il chimico russo Dmitrij Ivanovic Mendeleev (1834-1907) presentava la sua famosa "Tavola periodica degli elementi", che oggi sotto forma di poster campeggia in tutte le aule di scienze del mondo e in omaggio a questa straordinaria invenzione l’Onu ha dichiarato il 2019 "Anno internazionale della tavola periodica degli elementi".
Per la creazione di questa ’tavola’ lo storico della scienza John D. Bernal definì Mendeleev «il Copernico della chimica» e in effetti il chimico russo fornì ai ricercatori uno strumento efficacissimo che non solo catalogava gli elementi fino allora conosciuti ma consentiva soprattutto di fare delle previsioni.
Al tempo di Mendeleev erano conosciuti 63 elementi e gli scienziati si erano posti il problema di dar loro una sistemazione secondo uno schema logico. Anche Mendeleev, ovviamente, stava studiando la questione e la scoperta della sua tavola è legata a una storia che ha dell’incredibile.
Come Mendeleev sognò la Tavola periodica degli elementi
Mendeleev, infatti, era un appassionato giocatore di carte e il gioco che maggiormente preferiva era il cosiddetto "solitario". E proprio inventando un "solitario chimico" gli venne l’idea che gli avrebbe dato fama e prestigio. Mendeleev trascrisse su cartoncini il simbolo degli elementi conosciuti e il loro peso atomico, vale a dire il numero che si ottiene facendo la somma dei neutroni e dei protoni contenuti nel nucleo di ogni atomo, e si mise a giocare con quei cartoncini ordinandoli e organizzandoli proprio come si usa fare con le carte da gioco.
Quello strano "solitario", però, non gli indusse nessuna soddisfazione e così dopo tre giorni e tre notti trascorsi davanti al tavolo gettò la spugna e se ne andò a dormire. E qui accadde il miracolo, perché in sogno ebbe la visione di quella "tavola" che stava cercando. In quella tavola gli elementi, ordinati in colonne, e raggruppati in gruppi di elementi simili, presentavano «una evidente periodicità di proprietà» e proprio a causa di questa particolarità chiamò la sua tavola con l’appellativo «periodica». Ed era talmente convinto che la sua idea fosse giusta che proprio pensando a questa periodicità lasciò nella sua tavola alcuni spazi vuoti che, secondo le sue previsioni, sarebbero stati occupati da elementi ancora da scoprire.
Una Tavola profetica
La tavola periodica degli elementi all’inizio non fu però accolta molto benevolmente ma sei anni dopo quanti nutrivano dubbi dovettero ricredersi. Nel 1875, infatti, esaminando un metallo proveniente dai Pirenei, il chimico Paul Émile Lecoq de Boisbaudran scoprì il Gallio, un metallo che andò a occupare, accanto all’alluminio, la casella vuota che Mendeleev gli aveva riservato e per il quale aveva pensato il nome di "Eka-alluminio". Il peso atomico del Gallio (69.7) era molto simile a quello previsto da Mendeleev (68) e ciò dimostrava che la tavola funzionava. Successivamente altri tre posti vuoti previsti dalla tavola furono occupati dall’Elio, dal Neon e dall’Argon e ribadirono la geniale intuizione di Mendeleev.
Ovviamente le moderne tavole contengono più elementi perché ora gli elementi conosciuti hanno superato il centinaio. Gli ultimi inseriti, che completano il "settimo periodo" della tavola, sono quattro. Si tratta però di elementi creati in laboratorio e non rintracciabili in natura: il Nihonio (113), il Moscovio (115), il Tennesso (117) e l’Oganesson (118).
- [Foto] Alcune visualizzazioni grafiche alternative della Tavola periodica degli elementi
Nel corso del tempo la tavola di Mendeleev ha subito una sorta di restyling che, pur lasciando integra la sostanza, ne ha cambiato invece la forma. Moltissime le versioni, secondo alcuni sarebbero addirittura 800 e dalle forme più svariate: circolari, cubiche, a elica, piramidali, a spirale, a triangolo... Una versione curiosa ha disposto gli elementi secondo uno schema che segue il tracciato della metropolitana di Londra! Insomma, come si dice, ce n’è per tutti i gusti.
I rivali di Mendeleev
Non è infrequente, sfogliando la storia della scienza, imbattersi nell’annosa questione della priorità di una scoperta e Mendeleev e la sua tavola non fecero eccezione. Già Johann Wolfgang Döbereiner, un autodidatta garzone di una farmacia, aveva raggruppato a tre a tre gli elementi che avevano proprietà chimiche simili, insiemi conosciuti come le "triadi di Döbereiner", e che in qualche modo possiamo considerare i progenitori della tavola periodica. Anche John Dalton e John Newlands si interessarono al problema e altri ancora si aggiunsero all’elenco dei presunti scopritori della tavola come John Newlands che dopo aver notato il ripetersi di certe proprietà a intervalli di 8, paragonò la periodicità alle ottave musicali formulando la "Legge delle ottave".
L’unico, forse, che potrebbe a ragione rivendicare un diritto di priorità è Julius Lothar Meyer che nel 1864, e dunque cinque anni prima della presentazione di Mendeleev, dopo aver pubblicato una tavola nella quale aveva sistemato 28 elementi col criterio del peso atomico crescente, presentò una tavola periodica molto simile a quella di Mendeleev. E secondo Van Spronsen, dunque, Mendeleev e Meyer si possono considerare scopritori indipendenti della stessa legge.
Le due tavole erano molto simili. In entrambe, infatti, gli elementi erano sistemati in righe e colonne seguendo l’ordine del peso atomico crescente, ma alla fine fu adottata quella di Mendeleev perché risultava più precisa, ma anche e soprattutto per quegli spazi vuoti inseriti che ipotizzavano elementi ancora da scoprire.
Va infine ricordato che Mendeleev non va identificato tout court con la sua tavola. Il chimico russo, infatti, scoprì l’origine minerale del petrolio e si dedicò allo sviluppo dell’industria petrolifera e anche carbonifera. Credeva, inoltre, nel grande significato sociale e culturale della scienza e, come si legge nella voce che gli ha dedicato la grande enciclopedia Scienziati e tecnologi (Mondadori, 1975), «considerò il progresso della scienza come una condizione assolutamente indispensabile di sviluppo dell’economia e della cultura», un tema a lui molto caro e al quale dedicò numerosi articoli e saggi.
Idee.
La scienza ha bisogno della filosofia
Senza una visione umanistica che risalga ai fondamenti della conoscenza il rischio è la dispersione. Ma l’attività delle scienze trova il suo presupposto nella dimensione personale del ricercatore
di Giuseppe Tanzella-Nitti (Avvenire, giovedì 24 ottobre 2019)
La formulazione della tavola periodica degli elementi chimici, scoperta 150 anni or sono dal chimico russo Dmitrij Ivanovic Mendeleev, ha suggerito al Festival della scienza di Genova di dedicare l’edizione dell’anno 2019 al tema degli “Elementi”. La scelta è senza dubbio opportuna. Il metodo scientifico, infatti, deve gran parte del suo successo alla capacità di “ridurre” i fenomeni a modelli matematizzabili, in base ai quali poter predire il comportamento di un sistema nel tempo. Tale processo consiste nello “scomporre” il suo oggetto di studio per cercare gli elementi e le proprietà elementari del reale fisico.
L’implicita persuasione che orienta questo metodo è l’idea che per conoscere davvero una cosa occorra saperla scomporre nei suoi elementi e capire come e perché funziona... È ciò che facciamo quando esaminiamo una scatola di costruzioni... Il ricercatore, tuttavia, si imbatte spesso in qualcosa di inaspettato. Nell’operare questa “scomposizione” e procedere lungo il suo cammino di comprensione dei fenomeni, si accorge talvolta che, per comprendere e rappresentare un fenomeno, occorre partire da alcuni presupposti, che non appartengono, in senso stretto, al metodo scientifico. Così facendo la scienza spinge la sua analisi fino al fondamento stesso del conoscere. Il tentativo rappresentarlo, al confine fra scienza e filosofia, viene chiamato il problema dei fondamenti.
Le discipline scientifiche colgono questo stato di cose in diversi ambiti della loro ricerca. La cosmologia contemporanea lo fa quando cerca di tematizzare l’universo come un “tutto”, in particolare la sua origine. La fisica e la chimica, quando si interrogano sul motivo delle specifiche formalità dei componenti della materia, sulla loro universalità, sui loro criteri di ordinamento e di simmetria. La biologia si chiede se a fondare il suo oggetto di studio siano gli elementi che compongono il vivente o non, piuttosto, l’organismo nel suo insieme. Anche la matematica e la logica si interrogano sui loro fondamenti, quando ricercano la completezza dei sistemi assiomatici e dei linguaggi formali in genere.
 In sostanza, per comprendere la realtà non basta conoscere gli elementi che la compongono (particelle elementari, elementi chimici), ma è necessario conoscere anche i processi di cui tali elementi sono oggetto e i loro rapporti con l’ambiente circostante. Si affacciano all’analisi delle scienze le nozioni di relazione e di informazione, proprietà che riguardano la totalità del sistema in esame e, grazie ad essa, aiutano a comprendere il comportamento delle parti che lo compongono. Ne risultano interessate, in particolare, la fisica (sistemi complessi, meccanica quantistica), la chimica (proprietà molecolari) e la biologia ( system biology). In questi fenomeni si converge ormai sulla conclusione che “il tutto è maggiore della somma delle parti”. Imbattersi nel problema dei fondamenti suggerisce che l’articolazione fra scienze e filosofia non sia solo quella del “limite” - immagine alla quale siamo abituati soprattutto nelle questioni di carattere etico - ma piuttosto quella dell’apertura e del trascendimento.
In sostanza, per comprendere la realtà non basta conoscere gli elementi che la compongono (particelle elementari, elementi chimici), ma è necessario conoscere anche i processi di cui tali elementi sono oggetto e i loro rapporti con l’ambiente circostante. Si affacciano all’analisi delle scienze le nozioni di relazione e di informazione, proprietà che riguardano la totalità del sistema in esame e, grazie ad essa, aiutano a comprendere il comportamento delle parti che lo compongono. Ne risultano interessate, in particolare, la fisica (sistemi complessi, meccanica quantistica), la chimica (proprietà molecolari) e la biologia ( system biology). In questi fenomeni si converge ormai sulla conclusione che “il tutto è maggiore della somma delle parti”. Imbattersi nel problema dei fondamenti suggerisce che l’articolazione fra scienze e filosofia non sia solo quella del “limite” - immagine alla quale siamo abituati soprattutto nelle questioni di carattere etico - ma piuttosto quella dell’apertura e del trascendimento.La riflessione filosofica non limita la scienza, impedendole di procede- re nella sua conoscenza, ma piuttosto la fonda e la trascende, offrendole i presupposti che la rendono possibile. Lungo questi percorso, la domanda dello scienziato sui fondamenti del conoscere può diventare apertura al mistero del Fondamento dell’essere. Nel suo volume La mente di Dio, Paul Davies scriveva: «Per quanto le nostre spiegazioni scientifiche possano essere coronate dal successo, esse incorporano sempre certe assunzioni iniziali. Per esempio, la spiegazione di un fenomeno in termini fisici presuppone la validità delle leggi della fisica, che vengono considerate come date. Ma ci si potrebbe chiedere da dove hanno origine queste leggi stesse. Ci si potrebbe perfino interrogare sulla logica su cui si fonda ogni ragionamento scientifico. Prima o poi tutti dobbiamo accettare qualcosa come dato, sia esso Dio, oppure la logica, o un insieme di leggi, o qualche altro fondamento dell’esistenza».
 Molti scienziati - nel passato come nel presente - hanno condiviso la visione che la natura fosse effetto di un Logos creatore. A motivare la loro ricerca è stata la convinzione che esistesse una verità oggettiva, riflesso di un Fondamento increato e meritevole di essere cercata con passione. Francis Collins dichiara di averlo compreso studiando il Dna e restandone tanto colpito da convertirsi da posizioni agnostiche ad un cristianesimo convinto, fino a fondare l’importante Fondazione Bio-Logos per studi su scienza e fede. Non sappiamo se Mendeleev, già cristiano ortodosso, osservando la sua Tavola degli elementi chimici abbia provato un sentimento analogo. Dobbiamo però a lui l’opportunità, 150 anni dopo, di poterlo provare noi.
Molti scienziati - nel passato come nel presente - hanno condiviso la visione che la natura fosse effetto di un Logos creatore. A motivare la loro ricerca è stata la convinzione che esistesse una verità oggettiva, riflesso di un Fondamento increato e meritevole di essere cercata con passione. Francis Collins dichiara di averlo compreso studiando il Dna e restandone tanto colpito da convertirsi da posizioni agnostiche ad un cristianesimo convinto, fino a fondare l’importante Fondazione Bio-Logos per studi su scienza e fede. Non sappiamo se Mendeleev, già cristiano ortodosso, osservando la sua Tavola degli elementi chimici abbia provato un sentimento analogo. Dobbiamo però a lui l’opportunità, 150 anni dopo, di poterlo provare noi.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
- GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- LA NASCITA E IL MITO DELLE ORIGINI. Mio nonno era un re (di Michle Feo).15 ottobre 2019, di Federico La Sala
MIO NONNO ERA UN RE
di Michele Feo *
Il filosofo Emanuele Severino parla spesso in interviste e ricordi autobiografici del fratello Giuseppe morto in guerra, dicendo che fu studente alla Scuola Normale Superiore di Pisa e lì ascoltò le lezioni di Giovanni Gentile; lo ripete con dovizia di particolari novellistici nel «Corriere della sera» del 31 dicembre 2018.
Ma il nome di Giuseppe è assente in tutti gli elenchi a stampa degli allievi della scuola pisana, da quello curato nell’immediato dopoguerra dal filologo e segretario della Scuola Alessandro Perosa all’ultimo del 1999. Poiché l’esempio del fratello sembra essere stato determinante per la scelta di vita di Emanuele, par di capire che la collocazione formativa di Giuseppe a Pisa, all’ombra di Gentile, debba riverberare su Emanuele un po’ di quella gloria.
Sempre, anche il figlio della lavandaia e del tavernaro, quando ha asceso la scala sociale, si crea antenati nobili; le povere ma belle donzellette alla fine della favola si scoprono figlie di regine e il tribuno popolare Cola di Rienzo rivelò di essere il risultato di una bassa avventura dell’imperatore nei quartieri bassi di Roma.
Corollario: o i repertori pisani devono essere emendati o il filosofo si è distratto e anche lui si è lasciato catturare dal mito delle origini favolose.
Michele Feo
NOTA:
"DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Una storia di lunga durata
MIO NONNO ERA IL IL PAPÀ DI ADAMO ED EVA...
“Se vogliamo andare avanti non è a Parmenide che dobbiamo pensare. Ma, se si vuole, a Talete. Egli sapeva che l’azzurro circondava la Terra. Che vuol dire questo? E’ presto detto (e poi chiudo). La chiave ce la fornisce l’altra recente polemica innescata da Paolo Rossi, e, in particolare, la risposta di [Emanuele] Severino alla provocazione dello stesso Rossi. La questione è quella della nascita. Chiariamo.
Con la sua costanza e con la sua testardaggine, Rossi - lo storico-segugio (Severino parla di cagnolini) - è riuscito a mettere alle strette il Leone, e, l’ha fatto uscire dalla foresta pietrificata o, che è lo stesso, dal campo (Essere=Verità) di Parmenide. Perseguitato per «vent’anni», Severino non ce l’ha fatta più e ha ceduto. E, costretto a scoprire le sue carte, ha dovuto ammetterlo: non è nato ad Elea (Parmenide) e nemmeno a «Como» (Heidegger). «Io sono nato - ha dichiarato Severino - a Brescia. Me lo ha detto mia madre e mio padre: è scritto sui documenti». Il giogo del Destino della Necessità è stato spezzato: HIC SUNT LEONES - a Brescia!. Era ora: Emanuele è solo un poco Severino, ma è con noi - come noi, semplici mortali.
Fuor di metafora: questo è il problema: La croce dei filosofi, per eccellenza. Ce n’è voluto per riportare a galla dalle profondità del mare dell’essere (altro che pantano o pozzanghera, entro cui era stato buttato da Parmenide e dai suoi edipici figli - i platonici di tutti i tempi) Talete: qual è il principio di tutte le cose? Questi sono i problemi: così nasce la filosofia [...] (cfr. Federico La Sala, "Per una nuova cultura all’altezza del Pianeta Azzurro", «La Critica Sociologica», n. 93, 1990, pp. 111-115; in: “Della Terra, il brillante colore”, Pref. di Fulvio Papi, Edizioni Nuove Scritture, Milano 2013, pp. 98-99, senza note).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- ANTROPOLOGIA E CONOSCENZA. "PERCHÉ L’UOMO HA DUE OCCHI?" (ERNST MACH).13 ottobre 2019, di Federico La Sala
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico...
- PERCHÉ L’UOMO HA DUE OCCHI?: «Se ora dunque mi riperete la domanda perché l’uomo ha due occhi, io vi risponderò così. Perché possa osservare attentamente la natura, e comprenda che egli stesso con le sue opioni vere o false con la sua alta ideologia, non è altro che un piccolo e fugace fenomeno della natura. E che, per dirla con Mefistofele, non è che "una parte di una parte". E che è cosa assai assurda "che l’uomo, piccola parodia del mondo,/ si illuda di essere un mondo egli stesso" (Goethe)»(Ernst Mach: cfr. Carlo Rovelli, "In principio c’era Ernst Mach", Corriere della Sera - La Lettura, 13.10.2019, pp. 14-15).
- CREATIVITÀ: «Cominciamo da noi stessi, esseri umani dotati di due mani, di due piedi, due occhi, due orecchi, una testa (con due emisferi cerebrali), una bocca ...
- Limitiamoci a considerare la questione partendo dagli organi della vista, dagli occhi. E’ esperienza comune vedere, ma non è affatto comune - né nella vita culturale né nella vita quotidiana degli esseri umani - pensare nel pieno senso della parola che noi vediamo ciò che vediamo grazie all’azione unitaria e combinata di tutti e due gli occhi; e continuiamo a vedere e a pensare come se - avendo una sola testa (e una sola bocca) - avessimo un solo occhio (un solo orecchio, una sola mano e un solo piede)!» (cfr. Federico La Sala, Creatività: Kant e la critica della società dell’uomo a "una" dimensione. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico).
SCHEDA EDITORIALE*
Ernst Mach
Perché l’uomo ha due occhi?
Nella seconda metà dell’Ottocento, il grande fisico e filosofo Ernst Mach, allora giovane professore alle università di Graz e Praga, organizza una serie di lezioni di «scienza popolare» rivolte a un pubblico non specialistico né accademico, perlopiù femminile.
Tra i temi proposti, spiccano per interesse e originalità le riflessioni sui concetti di simmetria, armonia e prospettiva, considerati secondo una lettura epistemologica in cui le intuizioni filosofiche si confrontano con l’osservazione empirica dei processi naturali. Attraverso esempi presi non solo dall’arte, dalle scienze e dalla storia, ma anche dalla vita quotidiana, Mach riesce a spiegare con ragionamenti scorrevoli e un linguaggio chiaro e diretto questioni classiche della tradizione filosofica e scientifica legate alla percezione visiva e all’esperienza spazio-temporale.
L’uomo, insegna Mach, deve tendere a una comprensione razionale della realtà che lo circonda, senza mai perdere la consapevolezza, però, di essere una piccola parte del tutto.
Ernst Mach
 (Brno-Chrlice, 1838 - Monaco di Baviera, 1916) Fisico e filosofo, insegna prima a Graz e a Praga per poi trasferirsi a Vienna, dove sarà docente di Filosofia della scienza fino al ritiro nel 1901. Sostenitore di un’indagine storico-critica delle idee scientifiche, sviluppa una filosofia empirica in cui i concetti servono a dare ordine ai dati dell’esperienza. La sua critica allo spazio assoluto di Newton ha anticipato la teoria della relatività di Einstein. Ha influenzato un’intera generazione di filosofi e scienziati, e le sue teorie sono state oggetto della tesi di laurea di Robert Musil.
(Brno-Chrlice, 1838 - Monaco di Baviera, 1916) Fisico e filosofo, insegna prima a Graz e a Praga per poi trasferirsi a Vienna, dove sarà docente di Filosofia della scienza fino al ritiro nel 1901. Sostenitore di un’indagine storico-critica delle idee scientifiche, sviluppa una filosofia empirica in cui i concetti servono a dare ordine ai dati dell’esperienza. La sua critica allo spazio assoluto di Newton ha anticipato la teoria della relatività di Einstein. Ha influenzato un’intera generazione di filosofi e scienziati, e le sue teorie sono state oggetto della tesi di laurea di Robert Musil. Prezzo 8.5
Prezzo 8.5
 Anno 2016
Anno 2016
 Pagine 64
Pagine 64* CASTELVECCHI EDITORE
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. --- Scalfari e il Papa sulla divinità di Gesù. Nota della Sala Stampa Vaticana.10 ottobre 2019, di Federico La Sala
Sulla divinità di Gesù. il Vaticano corregge Scalfari
Nota della Sala Stampa vaticana: dal fondatore di Repubblica libera e personale interpretazione. La precisazione dopo le sconcertanti e irreali frasi attribuite al Papa sulla divinità di Gesù Cristo
di Riccardo Maccioni (Avvenire, mercoledì 9 ottobre 2019)
Qualcuno stamattina leggendo “La Repubblica” avrà fatto un balzo sulla sedia. Nel suo commento al Sinodo intitolato “Francesco e lo spirito dell’Amazzonia” il fondatore del quotidiano Eugenio Scalfari attribuisce infatti al Papa riflessioni e opinioni quanto meno sconcertanti. In particolare Scalfari scrive: «Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo».
E a conferma di quanto appena detto, il giornalista e filosofo, passa in rassegna, modificandola anche un po’, la Passione di Gesù, soffermandosi in particolare sul grido di Cristo in croce, tratto dal Vangelo di Marco che riprende il Salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Un’invocazione che Scalfari riassume in “Signore mi hai abbandonato”. «Quando mi è capitato di discutere queste frasi - aggiunge Scalfari - papa Francesco mi disse: “Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio”». Davvero, quella di Scalfari, un’interpretazione troppo libera e palesemente irreale, al punto da meritarsi una “correzione”.
Arrivata con una nota del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: «Come già affermato in altre occasioni, le parole che il dottor Eugenio Scalfari attribuisce tra virgolette al Santo Padre durante i colloqui con lui avuti non possono essere considerate come un resoconto fedele di quanto effettivamente detto, ma rappresentano piuttosto una personale e libera interpretazione di ciò che ha ascoltato, come appare del tutto evidente da quanto scritto oggi in merito alla divinità di Gesù Cristo».
Del resto per capire che le espressioni attribuite al Pontefice non potevano essere reali sarebbe bastato recuperare le parole del Papa, ripetute in più occasioni. Poteva essere sufficiente anche solo riprendere pochi passaggi dell’udienza generale del 18 dicembre 2013: «Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane».
Concetti ribaditi a Caserta il 28 luglio 2014: «L’Apostolo Giovanni è chiaro: “Colui che dice che il Verbo non è venuto nella carne, non è da Dio! È dal diavolo”. Non è nostro, è nemico! Perché c’era la prima eresia - diciamo la parola fra di noi - ed è stata questa, che l’Apostolo condanna: che il Verbo non sia venuto nella carne. No! L’incarnazione del Verbo è alla base: è Gesù Cristo! Dio e uomo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, vero Dio e vero uomo».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Una verità che disturba: «Ogni buona conversazione presuppone il piacere della differenza» (di Timothy Radcliffe)..29 settembre 2019, di Federico La Sala
EVANGELO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ... *
Spiritualità.
Radcliffe: «Credere significa porsi in dialogo»
Cosa significa credere al tempo dei fondamentalismi? In un libro le riflessioni del domenicano: «Ogni buona conversazione presuppone il piacere della differenza E prende direzioni inaspettate»
di Timothy Radcliffe (Avvenire, giovedì 26 settembre 2019)
- [Foto] Padre Timothy Radcliffe (Christian Penocchio)
- Pubblichiamo un passaggio del nuovo libro di Timothy Radcliffe, teologo di Oxford, già Maestro generale dell’Ordine dei predicatori (domenicani), Una verità che disturba. Credere al tempo dei fondamentalismi (Emi, pp. 144, euro 15, in libreria da oggi). In questo saggio Radcliffe, indaga il rapporto tra la fede e la cultura attuale attraverso alcune tematiche (la parola di Dio, la vita religiosa, la speranza, i populismi) e alcune grandi figure della Chiesa, come Oscar Romero, san Domenico, Bartolomé de Las Casas, Marie-Dominique Chenu. In occasione della pubblicazione del libro, Radcliffe tiene alcuni incontri in Italia. Domani interviene a Torino Spiritualità (Chiesa di Gesù Nazareno, ore 21) sul tema «Perché la notte appartiene agli amanti»; sabato, sempre a Torino, svolge una lectio all’Università del Dialogo del Sermig (ore 18); domenica parla al Festival Francescano di Bologna (piazza Maggiore, ore 16) su «Il dialogo creativo: conversazioni tra cristiani e non credenti». «La gioia del dialogo con i non credenti» è il titolo del suo intervento martedì a Modena, presente il vescovo Erio Castellucci (Chiesa di S. Agostino, ore 20.45). Info su www.emi.it.
Ascoltare la parola di Dio non significa assorbirla passivamente. Secondo la Dei Verbum, vuol dire impegnarsi nel dialogo di Dio con l’umanità. «Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (n. 2). Nella Verbum Domini, papa Benedetto ha scritto: «La novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che Dio si fa conoscere nel dialogo che desidera avere con noi» (n. 6). La vita di Dio è un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio nello Spirito. La Rivelazione è l’invito che Dio ci rivolge a sentirci sempre a casa, in quell’eterna e amorevole conversazione, non è ricevere messaggi dallo spazio con gli esegeti che disperatamente cercano di decifrare strani segnali come faceva il matematico Alan Turing a Bletchley Park. La Rivelazione comporta di essere assorbiti in quell’eterno dialogo che è la vita di Dio. È quindi estremamente calzante affermare che la parola di Dio si fa carne nel dialogo con l’uomo. Il Vangelo di Giovanni, per esempio, è un succedersi di conversazioni - dal dialogo di Giovanni Battista con i sacerdoti e i leviti, fino alla conversazione finale di Gesù con Pietro sulla riva del lago. La notte prima di morire, si tenne quello che siamo soliti chiamare il «discorso d’addio », ma in realtà è l’ultimo dialogo che Gesù ha con i suoi amici. È Pilato a chiudere la conversazione con un «che cos’è la verità? ». La Parola viene silenziata. Ma la conversazione riprende quando Maria di Magdala incontra Gesù nel giardino. Non è una coincidenza che i primi documenti cristiani non fossero libri o professioni di fede, ma le lettere di san Paolo: l’altra metà delle sue conversazioni con le persone.
 Leggere Paolo è come ascoltare qualcuno che parla al telefono e cercare di immaginare che cosa l’interlocutore stia dicendo all’altro capo del filo.
Leggere Paolo è come ascoltare qualcuno che parla al telefono e cercare di immaginare che cosa l’interlocutore stia dicendo all’altro capo del filo.Perciò la parola di Dio non si rivolge a noi con una purezza immacolata che precede le nostre interpretazioni. Non possiamo risalire agli autori biblici alla ricerca della cruda verità, di una parola nuda. I sostenitori della Riforma dicevano: «Lasciate perdere, abbandonate la tradizione che la corrotta Chiesa cattolica ha aggiunto, tornate alla pura parola della Bibbia!». Poi, nel XIX secolo gli studiosi iniziarono a dire: «Attenetevi alla Bibbia, al falegname di Galilea... Attenetevi a Paolo che ha inventato il cristianesimo ». State agli evangelisti: ognuno ha la propria agenda. Tornate al puro messaggio, prima che venga distorto dalle nostre risposte. Ma in questo modo ciascuno ha trovato il Gesù che amava trovare. Lo storico ebreo Geza Vermes ci ha fatto tornare a un Gesù che era un rabbino ebreo. Teologi militanti latinoamericani scoprirono che era stato un politico rivoluzionario. I professori di Oxford vi riconobbero un altro professore che, come loro, avrebbe sicuramente apprezzato un bicchiere di sherry prima dell’Ultima Cena. I californiani invece scoprirono un hippy gentile, carino con tutti, che probabilmente avrebbe preferito la marijuana allo sherry. C’è poi il Gesù gay, il Gesù infatuato della Maddalena, il Gesù simil-Gandhi nonviolento... qualsiasi Gesù ti garbi! In realtà, se ti metti a pelare i vari strati della cipolla via via fino al centro, troverai sicuramente un Gesù che assomiglia giusto a te! Allora, invece di sbucciare la cipolla, dialoghiamo. Entriamo in dialogo con la parola di Dio e lasciamocene sconvolgere. Dialoghiamo con la tradizione. Gli uni con gli altri. La conversazione porta alla conversione.
 La chiave di tutto ciò che papa Francesco sta facendo è lo sforzo di riportare il dialogo nel cuore della chiesa. Ha nominato un consiglio dei cardinali, con i quali si incontra regolarmente per discutere delle questioni della chiesa. Sta cercando di trasformare il sinodo in una vera conversazione, invece di avere delle persone che s’incontrano semplicemente per leggere dei testi che avevano scritto prima di arrivare a Roma. Io sono stato a tre sinodi, e vi assicuro che possono essere lunghi momenti estremamente noiosi. Lui invece vuole che si instauri il dialogo nel cuore di ogni parrocchia, di ogni diocesi. Ma il fondamento di tutto è il nostro dialogo con Dio.
La chiave di tutto ciò che papa Francesco sta facendo è lo sforzo di riportare il dialogo nel cuore della chiesa. Ha nominato un consiglio dei cardinali, con i quali si incontra regolarmente per discutere delle questioni della chiesa. Sta cercando di trasformare il sinodo in una vera conversazione, invece di avere delle persone che s’incontrano semplicemente per leggere dei testi che avevano scritto prima di arrivare a Roma. Io sono stato a tre sinodi, e vi assicuro che possono essere lunghi momenti estremamente noiosi. Lui invece vuole che si instauri il dialogo nel cuore di ogni parrocchia, di ogni diocesi. Ma il fondamento di tutto è il nostro dialogo con Dio.La Dei Verbum cita sant’Ambrogio (IV secolo): «Quando preghiamo, parliamo con lui; lui ascoltiamo, quando leggiamo gli oracoli divini». Ogni buona conversazione presuppone il piacere della differenza. Non ha senso avere un dialogo con chi la pensa esattamente come te. È così noioso! Una buona conversazione prende direzioni inaspettate. Non può essere controllata. E la Bibbia è piena di dialoghi. Nell’Antico Testamento ci sono conversazioni litigiose tra i profeti e i re; e c’è un dialogo tra l’Antico e il Nuovo Testamento.
 Il Nuovo Testamento abbraccia le differenze con un entusiasmo temerario. Al suo centro sta il dialogo tra i quattro Vangeli. Come ha scritto il teologo Francis Watson: «È emerso lentamente un consenso sul fatto che i quattro Vangeli debbano essere letti l’uno accanto all’altro e che a nessun altro Vangelo debba essere permesso di condividere la loro conversazione intratestuale». Quattro Vangeli che non vanno d’accordo tra loro. Nel II secolo, la chiesa si oppose fermamente a quei timorosi che volevano ridurli a una singola e coerente narrazione. La nostra interpretazione della morte di Gesù è un dialogo senza fine, da una parte con i racconti di Marco e Matteo che parlano di un uomo che grida che Dio l’ha abbandonato, e dall’altra con le narrazioni dei più sereni Luca e Giovanni, nelle quali egli confida e si abbandona allo Spirito. È una conversazione che continuerà fino a che non avremo scoperto la verità di Dio che resta al di là di ogni parola.
Il Nuovo Testamento abbraccia le differenze con un entusiasmo temerario. Al suo centro sta il dialogo tra i quattro Vangeli. Come ha scritto il teologo Francis Watson: «È emerso lentamente un consenso sul fatto che i quattro Vangeli debbano essere letti l’uno accanto all’altro e che a nessun altro Vangelo debba essere permesso di condividere la loro conversazione intratestuale». Quattro Vangeli che non vanno d’accordo tra loro. Nel II secolo, la chiesa si oppose fermamente a quei timorosi che volevano ridurli a una singola e coerente narrazione. La nostra interpretazione della morte di Gesù è un dialogo senza fine, da una parte con i racconti di Marco e Matteo che parlano di un uomo che grida che Dio l’ha abbandonato, e dall’altra con le narrazioni dei più sereni Luca e Giovanni, nelle quali egli confida e si abbandona allo Spirito. È una conversazione che continuerà fino a che non avremo scoperto la verità di Dio che resta al di là di ogni parola.Ci poniamo in ascolto di questa conversazione e troviamo il coraggio di intervenire, come bambini che osano intromettersi nelle conversazioni degli adulti. E così, lentamente, essa ci trasforma. Smonta uno per uno i nostri pregiudizi, ci cura dalla violenza. Da una generazione all’altra, come il lievito nella chiesa. Ci sono voluti migliaia di anni prima che il Dio violento dei testi più antichi diventasse il Dio misericordioso, padre del figliol prodigo. Pensate solo alla schiavitù.
 Paolo scriveva che in Cristo «non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Ma nella sua Lettera a Filemone egli sembra tollerare la schiavitù. Considera Onesimo suo figlio, e vorrebbe che fosse trattato come un diletto fratello, ma non mette mai in discussione l’istituzione della schiavitù. Questa era universale all’epoca, non si sarebbe potuto immaginare una società senza di essa.
Paolo scriveva che in Cristo «non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Ma nella sua Lettera a Filemone egli sembra tollerare la schiavitù. Considera Onesimo suo figlio, e vorrebbe che fosse trattato come un diletto fratello, ma non mette mai in discussione l’istituzione della schiavitù. Questa era universale all’epoca, non si sarebbe potuto immaginare una società senza di essa.
 Solo con Bartolomé de Las Casas - come visto sopra - l’idea stessa di schiavitù iniziò ad essere ripudiata. I domenicani spagnoli riuscirono a persuadere il papa a denunciarla nell’enciclica Sublimis Deus del 1537. Spesso dimentichiamo che per secoli il papato ha denunciato qualsiasi forma di schiavitù. Ma abbiamo ancora molta strada da fare. Nel XIX secolo riconoscemmo la schiavitù dei lavoratori incatenati alle loro macchine. Oggi assistiamo alla riduzione in schiavitù delle donne dovuta alla tratta sessuale. Nonostante la Parola sia stata pronunciata da Gesù una volta per tutte e per sempre, la sua eco continua ad interrogarci, a sfidarci, a incalzarci ad andare oltre.
Solo con Bartolomé de Las Casas - come visto sopra - l’idea stessa di schiavitù iniziò ad essere ripudiata. I domenicani spagnoli riuscirono a persuadere il papa a denunciarla nell’enciclica Sublimis Deus del 1537. Spesso dimentichiamo che per secoli il papato ha denunciato qualsiasi forma di schiavitù. Ma abbiamo ancora molta strada da fare. Nel XIX secolo riconoscemmo la schiavitù dei lavoratori incatenati alle loro macchine. Oggi assistiamo alla riduzione in schiavitù delle donne dovuta alla tratta sessuale. Nonostante la Parola sia stata pronunciata da Gesù una volta per tutte e per sempre, la sua eco continua ad interrogarci, a sfidarci, a incalzarci ad andare oltre.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SINODO DEI VESCOVI 2008. L’ANNO DELLA PAROLA DI DIO: AMORE ("CHARITAS") O MAMMONA ("CARITAS")?!
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
LA PAROLA DI DIO, IL SINODO DEI VESCOVI, E UN OMAGGIO AI FRATELLI MAGGIORI E A SIGMUND FREUD. Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, dopo due anni, nessuno ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! E che confusione spirituale di lunga durata!!!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Il mito delle Danaidi, «una botte piena di buchi» (Kant), e l’ Alzheimer.22 settembre 2019, di Federico La Sala
Fili di pensiero e buchi di memoria. Immanuel Kant e l’Alzheimer
Nell’ultimo decennio della sua vita il filosofo fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria: l’intervento di Francesca Rigotti per l’Alzheimer Fest
di FRANCESCA RIGOTTI *
- A Treviso dal 13 al 15 settembre si svolge la terza edizione dell’Alzheimer Fest. Dal dolore nasce una festa, che coinvolge persone affette da demenza, famigliari, medici, operatori, artisti, liberi cittadini. Gli eventi previsti sono circa 150, tutti gratuiti (info su alzheimerfest.it). Qui pubblichiamo un estratto dell’intervento che la filosofa Francesca Rigotti terrà domenica 15 alle 11.30. Sul numero 405 del 1° settembre, «la Lettura» ha anticipato l’originale componimento in versi a staffetta realizzato per l’occasione da Vivian Lamarque, Roberta Dapunt, Flavio Pagano, Stefano Scateni, Giovanna Baglione e altri poeti (con un articolo di Michele Farina). Nel supplemento #406 in edicola fino a sabato 14 settembre, è disponibile l’intervento Donatella Puglia, docente di Lingua e letteratura latina all’università di Siena (anche lei ospite dell’evento).
Parleremo di Alzheimer e di filosofia concentrandoci sulla figura di un filosofo che fu presumibilmente colpito da questa sindrome. Un filosofo che alcuni hanno studiato a scuola, altri solo orecchiato: Immanuel Kant, che nell’ultimo decennio della sua vita fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria.
Kant visse tra il 1724 e il 1804, ottant’anni giusti tutti trascorsi a Königsberg, allora nella Prussia orientale, ora Kalinigrad, enclave russa. Alla locale università seguì le lezioni di filosofia, matematica, fisica e dogmatica. È l’autore delle tre critiche (della Ragion Pratica, della Ragion Pura, del Giudizio). Nel campo della morale ha elaborato una dottrina deontologica molto rigorosa basata sul dovere di comportarsi in modo tale che il proprio agire possa diventare massima dell’agire universale (in contrasto con l’utilitarismo e con la dottrina del male minore, capolavoro etico di Tommaso d’Aquino, quella che consiglia di ingoiare tu il rospo piccolo prima che il rospo grande ingoi te). Nel campo teorico-conoscitivo, la dottrina di Kant ha messo al centro della conoscenza il soggetto e le peculiarità del suo apparato conoscitivo categoriale attraverso il quale viene letto e interpretato il mondo.
Un grandissimo filosofo insomma, che proprio perché tale non sfugge allo sport preferito dai piccoli filosofi, che è quello di sparare al grande filosofo. È uno sport di tutti i tempi e di tutte le età, che ai nostri tempi è stato praticato contro Platone (trasformato in fautore dello stato autoritario); Marx (unisono o quasi: «in soffitta, in soffitta!»); Hegel e l’idealismo tedesco (che alcuni professori tedeschi vorrebbero cancellare dal programma di filosofia); Heidegger (ancora quasi un unisono: il bersaglio è facile data l’indulgenza di Martin verso il nazionalsocialismo). Ultimamente ci si è accaniti contro Kant, dapprima attaccando i suoi scritti gnoseologici cui si è voluto dare un bel «good bye», ora rivolgendosi anche alla roccaforte dei suoi scritti etici, troppo rigorosi per la nostra edonista società. Io però sono convinta che lassù, nel cielo dei filosofi, a Platone, Hegel, Marx, Kant, Heidegger e compagni quelle cannonate facciano il solletico.
Anche Kant, dicevo, è oggetto proprio in questi giorni di pesanti bordate che mirano a demolire nientemeno che il suo apparato etico, rigoroso e cogente, non adatto a un’epoca di grandi opportunisti e edonisti di bassa lega pronti a chinarsi a soluzioni di comodo. Ma che cosa c’entra tutto questo con l’Alzheimer? C’entra, c’entra, o almeno vorrei farcelo entrare io mostrando come, se un vero nemico di Kant ci fu, esso fu proprio questa malattia subdola e strisciante che venne a guastare gli ultimi anni di vita del grande pensatore di Königsberg.
Conosciamo bene la biografia di Kant e in particolare gli anni della vecchiaia grazie a ben tre biografie scritte da suoi conoscenti e amici, Borowski, Jachmann e Wasianski, e a un testo letterario del 1827 di Thomas de Quincey, Last days of Immanuel Kant, da cui è stata tratta la suggestiva versione cinematografica, del 1993, del regista francese Philipp Collin, Les derniers jours d’Emmanuel Kant, che purtroppo non posso mostrarvi, neanche un pezzettino. Se siete interessati potete guardarla integralmente su YouTube. Vedrete un anziano signore con parrucca, redingote e scarpini con la fibbia, dagli occhi azzurrissimi (che si possono soltanto immaginare perché il film è in bianco e nero), a volte ancora splendenti di intelligenza, più spesso offuscati dalla malattia che quell’intelligenza si stava portando via. Vedrete un uomo minuto e segaligno, anche se meno magro di come viene descritto nel libro (non portava mai calze nere per non far apparire i polpacci ancora più secchi), vittima del proprio rigore di abitudini di vita, che si autocostringeva a seguire rituali rigidissimi quanto ridicoli per quanto riguarda il dormire (impacchettato strettissimamente tra lenzuola e coperte), il vestirsi, il mangiare, lo scrivere, il fare le passeggiate...
Ma torniamo al Kant filosofo. Oltre che del pensiero critico Kant si interessò, tra l’altro, di estetica, di cosmologia, di antropologia. In relazione a quest’ultimo ambito scrisse nel 1798 una Antropologia dal punto di vista pragmatico, l’ultima opera pubblicata in vita anche se redatta nel corso di anni precedenti . Un’opera senile nella quale Kant tratta, forse non a caso, di memoria e oblio (e qui apro una parentesi per mandare un saluto ossequioso al grande Harald Weinrich, lo studioso autore del più bel libro sull’oblio che sia mai stato scritto e che qui mi ha molto aiutato: Lete. Arte e critica dell’oblio, chiusa parentesi).
Ebbene Kant, che aveva sempre goduto di ottima memoria, trattandone egli stesso teoricamente scriveva che la memoria è importante per prendere parte alle vicende della cultura e della scienza, e per questo la si deve esercitare fin dalla più tenera età. La collega poi ai principi della ragione, soprattutto quella che definisce la terza forma della memoria. La prima infatti, (memoria meccanica), è una specie di facoltà minore, quasi animalesca, con la quale si immagazzina materiale e basta; la seconda (memoria ingegnosa), è un metodo per ricordare attraverso associazioni che non hanno nulla a che fare con il concetto da memorizzare; al gradino più alto sta la memoria giudiziosa, che permette di esercitare scelte opportune e ragionate sui contenuti di memoria, tramite sistemi di classificazione, per es. dei libri delle biblioteche come delle specie naturali; scelte giudiziose perché basate su principi di ragione.
Eppure al teorico della memoria verranno a mancare, paradossalmente, tutte le forme di memoria, condizione che il suo maggior biografo, Wasianski, diacono della chiesa di Tragheim a Königsberg e amico personale e devoto di Kant, tentò di minimizzare e giustificare: «a poco a poco lo colsero le debolezze della vecchiaia, tra cui la mancanza di memoria...». E così continua la descrizione che l’amico diacono effettua delle trasformazioni del filosofo: cominciò a ripetere i suoi racconti più volte nello stesso giorno; vedeva le cose più lontane del suo passato vive e precise davanti a sé, ma il presente, come avviene nei vecchi, gli restava meno impresso; sapeva recitare lunghe poesie tedesche e latine, brani dell’Eneide, senza intoppo, mentre gli sfuggivano le cose apprese un momento prima. Si era accorto anche lui che la memoria gli si affievoliva, sicché annotava le cose su foglietti, buste usate, informi pezzetti di carta. Oltre alla perdita di memoria incominciò a elaborare teorie strampalate, per esempio attribuendo la morìa di gatti a Basilea, Vienna e Copenhagen, a una particolare elettricità dell’aria. Si sentiva debole, astenico. Si addormentava per fiacchezza sulle seggiole, fuori orario; non era in grado di badare al suo denaro, perse la nozione del tempo, talché un minuto gli sembrava esageratamente lungo; l’appetito era sregolato e degenerato (ingollava avidamente bocconi di pane spalmati di burro e premuti su formaggio inglese grattugiato). Si esprimeva in modo sempre meno adeguato e divenne incapace di scrivere il suo nome né riusciva più a figurarsi la forma delle lettere. Il suo linguaggio diventò improprio anche se cercava di spiegarsi con affinità e analogie (parlava di mare e scogli per intendere minestra e bocconi di pane); non riusciva a farsi capire su cose comunissime, poi cominciò a non riconoscere chi gli stava intorno. Non si raccapezzava e allora gridava con voce stridula. Si consumò, e morì il 12 febbraio 1804. La diagnosi di Alzheimer per la «debolezza senile» di Kant venne proposta da Alexander Kurz nel 1992, e poi ripresa e descritta da altri, in particolare Fellin, nel 1997.
Nella sua Antropologia, a proposito della smemoratezza, che Kant chiama obliviositas, il filosofo usa una immagine, per descriverla, con la quale sembra parlare di sè: la smemoratezza è lo stato in cui la testa è come «una botte piena di buchi» (ein durchlöchertes Fass). Per quanto la riempi, rimane sempre vuota, e questo è un grandissimo male (ein größeres Übel). I contenuti versati nella testa scorrono fuori dai buchi come fili d’acqua da un setaccio, e questa perdita rende la mente vuota, sterile.
 Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.
Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.Le Danaidi erano le cinquanta figlie di Danaos, re dell’Argolide, regione a nord del Peloponneso, che il padre aveva destinato spose, contro la loro volontà, ai cinquanta figli di Aigyptos, Egitto. Ma durante la prima notte di nozze le ragazze, tranne una, uccisero i loro sposi prima che il matrimonio venisse consumato. Nell’al di là le Danaidi dovevano riempire continuamente d’acqua un recipiente dal fondo bucherellato.
 Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.
Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.Nel caso del filosofo sono fili di ragionamento che il vecchio professore (Kant aveva insegnato Logica e metafisica nell’Università di Königsberg), non riesce più a annodare, a intrecciare, nemmeno a districare, come si si esprime Kant in un’altra metafora per parlare dello stesso problema. Scrivendo nel 1794 all’allievo Sigismund Beck, Kant così scriveva: «Neppure io riesco a capire...me stesso, e le farò le mie congratulazioni se sarà in grado di mettere in chiara luce uno a uno questi esili fili della nostra facoltà conoscitiva...Districare fili così sottili non fa più per me».
 Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).
Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).Che cosa succedeva nella mente bucherellata di Kant, da cui uscivano fili che non potevano più essere razionalmente intrecciati? Che essa continuava a lavorare e a pensare, ma in maniera bizzarra. Lo mostra l’episodio del licenziamento del domestico Lampe, Martin Lampe (Lampe è la lampada in tedesco), che aveva seguito e servito il filosofo per quarant’anni, assistendolo in tutte le occasioni, dalla sveglia al mattino alle 5 con il lume a candela, al servizio del pranzo (preparato da una cuoca), all’accompagnamento nelle sue passeggiate ossessive sulle quali la gente di Königsberg regolava le sue attività. Non che Kant fosse molto interessato alla vita privata di Lampe, tant’è che ignorava che fosse stato sposato per diversi anni, e il giorno che il domestico indossò la marsina gialla invece della livrea bianca (e Kant si arrabbiò moltissimo) era perchè andava a risposarsi.
 Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
 Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».
Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».Se consegno la nozione allo scritto, insomma, la tolgo dalla memoria, la dimentico, e in più indebolisco la memoria stessa. Dimentico, faccio cadere fuori dai buchi della testa, dalla mente, de-mente, demente.
Cent’anni dopo la morte di Kant il medico dei pazzi Alois Alzheimer diagnosticò il morbo che da lui prese il nome: un morbo preciso dunque, una malattia da curare. Non di generica debolezza senile soffriva Kant, quanto di una malattia specifica. Probabilmente qualcuno lo sospettò già prima, ma soltanto nel 1992 il sospetto venne scritto e assunse la forma di certezza. Cosa che apre un altro quesito filosofico riguardante l’attacco innescato pochi anni fa dai filosofi newrealisti contro i pensatori postmodernisti. Alcuni di questi (v. Bruno Latour) hanno sostenuto che il faraone Ramsete non potè morire di tubercolosi (come avrebbero provato alcune moderne autopsie) perchè il bacillo di Koch non era ancora stato isolato. Il che filosoficamente corrisponde a sostenere che «sapere che x» equivale a «essere costitutivo dell’essere x», ovvero afferma che Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora individuata e battezzata. Argomento che secondo alcuni discenderebbe direttamente dalla «rivoluzione copernicana» introdotta da Kant, il quale pose il soggetto/sole al centro della conoscenza/sistema solare, affermando che il soggetto comprende la realtà attraverso le proprie categorie e assegnando dunque al nostro intelletto un ruolo fortemente attivo nel metodo conoscitivo; sono i nostri schemi mentali che determinano il modo in cui un oggetto viene percepito. Ma mentre la prima conclusione (Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora inventata/scoperta), è assurda, non lo è per nulla la seconda conclusione (la centralità del soggetto nella comprensione dei fatti e l’idea che le proposizioni scientifiche in grado di ampliare il nostro sapere sul mondo non si limitano a recepire passivamente dei dati, ma sono di natura critica e deduttiva). Non possiamo però occuparci a fondo della diatriba perchè il discorso ci porterebbe troppo lontano. La lasciamo lì, insieme al marasma senile del povero Kant, e alle sue occupazioni delle ultime settimane di vita, quali togliere e riannodare continuamente la cravatta, abbottonare e sbottonare la veste, in uno stato di continua agitazione, finché, come scrive un altro biografo, Jachmann, «svanì a mano a mano il vigore del più grande filosofo fino alla sua completa impotenza intellettuale».
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- L’IO ROBOT, L’IO PERSONA, E LA COSTITUZIONE. «Nuovo umanesimo» in politica: è tempo di dirlo e di farlo!!!2 settembre 2019, di Federico La Sala
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI... *
Dopo il discorso di Conte.
«Nuovo umanesimo» in politica: è tempo di dirlo e di farlo
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, domenica 1 settembre 2019)
«Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un nuovo umanesimo. Non ho mai pensato che fosse lo slogan di un governo. Ho sempre pensato che fosse l’orizzonte ideale per un intero Paese». Questa frase, pronunziata giovedì al Quirinale da Giuseppe Conte nel discorso con cui ha accettato di verificare la possibilità di formare un nuovo esecutivo, è stata ripresa dai media in modo spesso superficiale e talvolta in maniera irridente, in alcuni casi come esclusivo supporto alla cultura dell’accoglienza, soprattutto verso i migranti, e tuttavia, ha bisogno di essere ulteriormente pensata e approfondita.
Non bisogna dimenticare che la Chiesa italiana, nel suo V convegno nazionale, celebrato a Firenze nel 2015, è stata chiamata a riflettere sul tema del ’nuovo umanesimo’ nel suo radicamento cristologico. Il titolo di quell’evento recitava ’In Cristo il nuovo umanesimo’. E papa Francesco nella riflessione che ha proposto ai vescovi italiani nell’Assemblea generale del maggio scorso ha richiamato, in particolare con riferimento alla sinodalità, il discorso che aveva pronunziato in quell’occasione.
 Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
 Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).
Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).Richiamando la Costituzione, si è fatto riferimento al ’primato della persona’, come radice antropologica di ogni azione sociale, politica, culturale. Come tutti sanno, o dovrebbero sapere - e qui il rammarico per averlo troppo spesso tralasciato e dimenticato -, la nozione di ’persona’, nella sua pregnanza ontologica, è stata consegnata (o, meglio, donata) all’Occidente dalle vicende delle dispute cristologiche e trinitarie dei primi secoli, messe in atto in ambito cristiano. Si è pensato l’umano a partire dall’identità di Cristo e dal mistero di Dio.
 Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
 Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
 Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.
Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.In questa prospettiva vanno letti gli autorevoli inviti - in particolare quello del presidente della Cei Gualtiero Bassetti - a fondare un’autentica prospettiva politica non su dei semplici contratti, spesso frutto di miopi compromessi, che prima o poi esplodono, determinando la catastrofe del rapporto, ma su una visione programmatica, basata appunto su vere e proprie alleanze.
Non possiamo non ricordare che la prospettiva rosminana si rifà alla definizione di Giovanni Duns Scoto, che a sua volta radicalizza la visione di Riccardo di San Vittore (per il quale la persona è intellectualis naturae incommunicabilis existentia) fino a definirla ultima solitudo. Il Roveretano infatti afferma che la persona è una sostanza spirituale dotata di un principio incomunicabile. Così possiamo cogliere la caratteristica fondamentale della persona, ossia la sua unicità.
Sonny, il protagonista artificiale del famoso film Io robot, allorché si scopre ’quasi umano’ e ne prende coscienza, afferma con stupore: «Io sono unico». La macchina si produce, la persona si genera. Questa unicità rende preziosa ogni persona e determina un’etica della sua salvaguardia a qualsiasi classe, cultura, religione, regione, cultura appartenga.
Ma, oltre che unicità, la persona dice anche ulteriorità. Un aforisma che ci giunge dall’antica sapienza (Seneca, Naturales quaestiones) recita: «Oh quam contempta res est homo, nisi supra humana surrexerit», che cosa misera è l’umanità se non si sa elevare oltre l’umano... In questa breve espressione si sintetizza in maniera mirabile l’ulteriorità della condizione umana, espressa peraltro col verbo (surrexerit) che fa riferimento alla risurrezione. Quell’«essere della lontananza » che è l’uomo, infatti, proprio a partire dalla sua distanza originaria e dal suo oltrepassamento realizza la più piena prossimità alle cose (Martin Heidegger). E da questo senso della ’trascendenza’ dell’umano il pensiero credente non è certo assente, anzi lo afferma, per esempio in un famoso frammento di Blaise Pascal, che viene a stemperare il facile ottimismo di un progresso ideologicamente mitizzato - allorché afferma che «La natura dell’uomo non è di avanzare sempre; ha i suoi alti e bassi» (fr. 318 ed. Brunschvicg) - e a mettere in guardia da una possibile deriva spiritualistica dell’antropologia: «L’uomo non è né angelo né bestia, e disgrazia vuole che chi vuol fare l’angelo fa la bestia» (fr. 325 ed. Brunschvicg).
Il nuovo umanesimo, che non intenda esprimersi nella forma di un acritico antropocentrismo, chiede così di declinarsi e di realizzarsi attraverso autentiche alleanze, spesso purtroppo infrante, fra uomo e natura, fra i generi, fra le generazioni, fra il cittadino e le istituzioni, fra emozione e ragione, fra popoli e religioni. Una saggia fatica che certo non può essere il risultato di un programma di Governo, ma quel quel programma può ben ispirare e illuminare. E che richiede una visione culturale e antropologica alla quale i cristiani possono efficacemente contribuire.
Teologo, Pontificia Università Lateranense
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO"
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Il buddhismo, il cattolicesimo, e "la malinconia meravigliosa" (di Michela Dall’Aglio).20 luglio 2019, di Federico La Sala
Giampiero Comolli
La malinconia meravigliosa
di Michela Dall’Aglio (Doppiozero, 19 luglio 2019)
La malinconia di cui parla Giampiero Comolli - giornalista, scrittore, presidente del Centro Culturale Protestante di Milano - nel saggio La malinconia meravigliosa (ed. Claudiana) è quella che pervade i discepoli di Siddharta Gautama della nobile famiglia dei Sakya, il primo Buddha, e di Gesù di Nazareth al momento del loro commiato in prossimità della morte. L’autore ripercorre i loro ultimi discorsi per cogliere attraverso di essi, i punti in cui le vie indicate dai maestri paiono avvicinarsi e quelli in cui decisamente divergono e lo fa utilizzando Il grande discorso del nirvana definitivo, per quanto riguarda il Buddha (i testi più antichi su cui si fonda la tradizione buddista sono raccolti nel canone Pali scritto attorno al 1° sec. a.C., pubblicati in italiano col titolo La rivelazione del Buddha. I testi antichi, Mondadori 2001) e i capitoli dal 14 al 17 del Vangelo di Giovanni, la cui formulazione definitiva risale alla fine del 1° sec. d.C.
 I primi capitoli sono dedicati dall’autore a una breve e necessaria sintesi della vita di Siddharta Gautama e del pensiero buddista - a chi volesse saperne di più suggerirei di leggere Il cuore dell’insegnamento del Buddha (ed. Neri Pozza) di Thich Nhat Hanh, monaco vietnamita di tradizione Zen Rinzai che ne offre una dissertazione approfondita e molto chiara - e poi prosegue con un’attenta disamina degli atteggiamenti dei due maestri e delle rispettive visioni della realtà che, non solo nelle parole, ma appunto anche negli atteggiamenti e nei gesti, si riveleranno radicalmente differenti.
I primi capitoli sono dedicati dall’autore a una breve e necessaria sintesi della vita di Siddharta Gautama e del pensiero buddista - a chi volesse saperne di più suggerirei di leggere Il cuore dell’insegnamento del Buddha (ed. Neri Pozza) di Thich Nhat Hanh, monaco vietnamita di tradizione Zen Rinzai che ne offre una dissertazione approfondita e molto chiara - e poi prosegue con un’attenta disamina degli atteggiamenti dei due maestri e delle rispettive visioni della realtà che, non solo nelle parole, ma appunto anche negli atteggiamenti e nei gesti, si riveleranno radicalmente differenti.Perché anche laddove sembra esserci una certa sintonia, tra le due vie in realtà c’è una strutturale inconciliabilità, chiaramente sottolineata dal Dalai Lama al quale fu chiesto, racconta Comolli, se in una stessa persona potrebbero convivere cristianesimo e buddismo visto che quest’ultimo è più propriamente una filosofia che una religione. Egli rispose che ciò sarebbe possibile, ma solo a un livello molto superficiale, perché nei loro elementi profondi e sostanziali si tratta di due visioni della realtà incompatibili. Cerchiamo di riassumerne le ragioni.
Per Buddha il risveglio inizia quando si comincia a comprendere che la vera natura del mondo sensibile è l’impermanenza. L’intero universo, materiale e immateriale è impermanente cioè, per così dire, fluido, mobile; le infinite forme assunte dalla materia - animali, vegetali, minerali - sono soltanto apparenza, perché la sostanza è una sola e sempre la stessa. Ciò che noi avvertiamo come cambiamento, compresa la morte, è semplicemente il passaggio da una forma a un’altra dell’unica sostanza. In questo processo continuo di trasformazione da uno stato a un altro, ciò che cambia non viene distrutto, ma appunto trasformato. In ogni elemento della realtà fisica è contenuto tutto ciò che esiste (nel fiore, ad esempio, è contenuta la terra da cui proviene, l’acqua e il sole che l’hanno nutrito, ciò che un animale ha mangiato e poi lasciato sul terreno sotto forma di concime e così via). Di conseguenza, la morte non è l’estinzione di una realtà, ma il suo passaggio da una condizione a un’altra. Da questa consapevolezza nasce il sentimento di equanimità, fondamento dell’etica buddista e da molti accostato, un po’ superficialmente, all’idea cristiana di compassione. L’equanimità informa l’atteggiamento pacifico e amorevole del monaco buddista verso ogni creatura. La via buddista stricto sensu è destinata ai monaci, ma è utile anche ai laici ai quali essi dimostrano, con il loro esempio, «che la via della libertà e della dolcezza esiste e può essere percorsa». Perciò tutti possono aspirare, di reincarnazione in reincarnazione, a percorrerla fino al compimento.
L’amore che il Buddha insegna è molto diverso da quello che vive e predica Gesù. Il cuore del monaco buddista è «amorevole verso tutti, ma vuoto perché mai "perdutamente innamorato" di qualcuno in particolare», sottolinea Comolli. E come potrebbe esserlo visto che, come ogni altra cosa, la persona stessa, l’io individuale è pura illusione? Il cuore è anatta, cioè vuoto, «privo di sostanza propria» «perché non esiste un nucleo, un’essenza stabile, un’identità precisa e definita di quel cuore stesso». Anche il cuore/l’io è maja, apparenza. Per Gesù, al contrario, nulla è più importante del cuore dell’uomo, nulla è più solido e vero dell’amore, e per il Dio in cui egli crede ogni essere è unico, irripetibile, speciale e merita che Dio diventi uomo e muoia proprio per lui. Dio non ama tutti, ama ciascuno, per questo per ogni singolo essere umano vale la pena di donare la vita. Come il Dio in cui credeva e che annunciava, Gesù non amava «in modo equanime e disinteressato, distaccato» ma «in modo appassionato, fino ai singhiozzi», e dall’amore «si lascia prendere fino alle viscere». Gesù piange, prega, si spaventa, si arrabbia. È tutt’altro che impassibile, è appassionato. Comolli sintetizza con una bella immagine la differenza tra i due maestri: «Se il discepolo del Buddha è riconoscibile grazie al suo passo delicato e lieve, capace di traversare un villaggio quasi fosse un’ape che passa di fiore in fiore, per converso, il discepolo di Gesù è riconoscibile grazie al suo passo amoroso e caldo, capace di rispondere con mansuetudine e premura anche a chi offende e maledice».
Se la fede in Dio, dal cristiano inteso come un essere vivente che si rapporta all’uomo come un padre e una madre si rapportano a un figlio, distingue nettamente buddismo e cristianesimo, ne consegue anche un modo del tutto diverso d’intendere e affrontare il dolore. Per Buddha l’individuo ha in se stesso la forza per liberarsene attraverso un costante esercizio di distacco da ogni passione e attaccamento. Per Gesù il liberatore è Dio; egli è sempre accanto all’uomo, soprattutto quando è misero e sofferente, e con la sua risurrezione testimonia che l’uomo non è destinato alla morte e all’estinzione, ma a una vita nuova nella dimensione di Dio. «La via del Buddha - sottolinea Comolli - fa a meno della fede; la via di Gesù, vive nella fede». Per questo egli che, a differenza del Buddha, morì ancora giovane di una morte orrenda e solitaria, accomiatandosi disse ai suoi amici: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me» (Gv 14,1), e ancora: «Voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia» (Gv 16, 22). L’esortazione di Buddha ai discepoli è molto diversa: «Prendete rifugio in voi stessi e non in altro», e le sue ultime parole furono: «Continuate ad esercitarvi, instancabilmente».
Riassumendo la diversità delle due concezioni spirituali, Giampiero Comolli le raccoglie in tre assunti. Alla base della ricerca del Buddha vi sono l’inconoscibilità di Dio, l’irrilevanza della questione per giungere alla liberazione dal dolore, la capacità dell’uomo di farlo con le proprie sole forze. Esattamente opposti sono i presupposti su cui si fonda il messaggio di Gesù, ovvero l’esistenza di Dio, l’importanza primaria e assoluta della questione, l’impossibilità per l’uomo di salvarsi da solo. Così si può anche dire che il cuore del buddismo è la pace che nasce dal sapersi liberare dal dolore, mentre al cuore del cristianesimo c’è una serenità diversa e, in un certo senso, più libera che sorge dalla fiducia nell’amore indefettibile di Dio. In un caso la pace è una conquista, nell’altro un dono. E la libertà in cui confida il seguace di Gesù non è nirvana, estinzione, uscita dal ciclo delle reincarnazioni, ma ingresso di ognuno con la sua propria personale storia e identità nella vita piena ed eterna di Dio. Cioè, risurrezione.
 La malinconia meravigliosa si chiude su questo tema, che quando Paolo lo affrontò spinse i razionali ateniesi, fino a lì attenti e interessati alle sue parole, a ridergli in faccia e a dirgli che su quello lo avrebbero ascoltato un’altra volta. Anch’io ve ne parlerei volentieri, ma forse anche voi come gli ateniesi vi mettereste a ridere di me... O mi sbaglio?
La malinconia meravigliosa si chiude su questo tema, che quando Paolo lo affrontò spinse i razionali ateniesi, fino a lì attenti e interessati alle sue parole, a ridergli in faccia e a dirgli che su quello lo avrebbero ascoltato un’altra volta. Anch’io ve ne parlerei volentieri, ma forse anche voi come gli ateniesi vi mettereste a ridere di me... O mi sbaglio?
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- GESÙ E IL CATTOLICESIMO-ROMANO. UNA LEZIONE DI JOYCE (da "FINNEGANS WAKE").
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
IL MESSAGGIO EVANGELICO, IL PARADOSSO ISTITUZIONALE DEL MENTITORE, E LA CATASTROFE DELL’EUROPA. “Come fu possibile la hitlerizzazione dell’Imperativo Categorico di Kant? E perché è ancora attuale oggi?” (Emil L. Fackenheim, Tiqqun. Riparare il mondo).
Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. --- Il pensiero "involontario". Ferrarotti nella società irretita dalla tecnica (di Simone D’Alessandro).8 luglio 2019, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO"... *
Ferrarotti nella società irretita dalla tecnica
Reminisco, ergo sum: il pensiero "involontario"
di Simone D’Alessandro (Doppioero, 25 giugno 2019)
- «La caratteristica fondante degli esseri umani è la loro imprevedibilità, qualità straordinaria, che li distingue radicalmente dagli animali non umani e si manifesta nel pensare involontario, non pre-condizionato da uno scopo prefissato, libero e anche, talvolta, del tutto gratuito».
Secondo Ferrarotti, decano della sociologia italiana, gli uomini oltrepassano la prevedibilità perché hanno memoria. Paradossalmente è la consapevolezza dei ricorsi storici che ci rende affatto stufi di ciò che è razionalmente prevedibile. A renderci sfuggenti è proprio ciò che siamo stati. Più precisamente: ciò che ricordiamo di essere stati.
L’assioma di Cartesio si rovescia: da Cogito ergo sum a Reminisco ergo sum.
In Il pensiero involontario nella società irretita, pubblicato quest’anno da Armando editore, egli affronta la memoria che costituisce l’essenza della nostra sopravvivenza sulla terra, tema che ricorre in altre sue opere precedenti. Il ricordo è, oggi, intaccato dalla comunicazione elettronica che lo rende superfluo.
Più che un saggio canonico è un pamphlet che analizza come la modernità dimentica, per citare il classico di Paul Connerton, in quanto funzionalmente portata verso questa fatalità.
La mancanza di memoria rende, infatti, l’umano sostituibile o impiegabile per altro.
Il suo agire meccanico e routinario viene preferito a quello imprevedibile dell’homo sapiens che coniuga la regola con l’emozione, direbbe de Masi.
Tanto vale sostituirlo con un’entità strumentale ben più efficiente, ma questo già accadeva con L’homme machine di de la Mettrie: utopia e distopia al tempo stesso.
Ferrarotti condanna la “ripetizione” come morte dell’invenzione radicale, perché la produzione si annulla nella cieca “riproduzione” e nell’incrementale “miglioramento” fine a se stesso.
Quando nulla cambia, quando tutto si dispiega in un eterno presente, l’unica cosa da fare è automatizzare l’esistente.
La memoria diventa, allora, strumento di resistenza verso tale deriva.
Essa non è semplicemente utile, né banalmente peculiare del nostro essere umani, detentori di un’identità personale da coltivare.
La memoria è molto di più, perché ci distoglie dalla retorica delle soluzioni facili che, proprio per questo, si rivelano sempre autoritarie giammai autorevoli.
La nostra società di Informatissimi idioti, altro fortunato titolo ferrarottiano di alcuni anni fa, viene algoritmicamente plagiata da un potere panoptico che riduce anche l’esercizio democratico in mero tecnicismo. Potere e autorità sono termini spesso utilizzati in modo intercambiabile, ma in questa facile analogia si nasconde una fallacia epistemologica.
Mentre il potere schiaccia, l’autorità permette la crescita.
La contrapposizione tra potere autoritario e proattività autorevole è un altro tema che assilla un intellettuale che è stato tra i primi frequentatori di Olivetti, addetto alla Presidenza per le Questioni Sociali nel 1949 e, successivamente, deputato per il Movimento di Comunità.
Ferrarotti appartiene a quella tradizione solida di intellettuali organici, resilienti e consapevoli del destino declinante dell’occidente.
In un momento in cui la filosofia e la sociologia vengono eliminate nelle università del Brasile, uno scienziato sociale rivendica il primato del pensiero umanistico, oggi costretto al suicidio dalle regole del profitto.
Applicazione disciplinata delle procedure o vocazione che metabolizza le tecniche rendendole apparentemente spontanee? Trasformazione di ciò che sei attraverso empowerment o attitudine che prevede miglioramento di ciò che già sei?
Questo è il dilemma nella società di oggi che deve scegliere se governare o essere governata dalla tecnica che elimina tutto ciò che ritiene disfunzionale.
Per maestri del pensiero quali Heidegger e Severino il destino sembrerebbe esser tracciato, ma in Ferrarotti vi è un imprevedibile vitalismo che disattiva ogni forma di disperazione.
Contestualmente alla pubblicazione del suo libro, la Luiss University Press dà alle stampe l’ultima fatica del filosofo francese Éric Sadin: Critica della ragione artificiale, nella quale si evidenzia il ruolo delle nuove tecnologie intelligenti che erodono le facoltà di giudizio e azione soggettiva. Forse non è un caso! Sadin, recuperando in senso letterale il ruolo politico della filosofia, svela il retro pensiero antiumanistico dei discorsi che sostengono l’indiscriminato sviluppo tecnologico.
Siamo giunti all’avveramento della profezia di Luhmann che negli ultimi suoi lavori annunciava l’avvento di una società senza persone?
Ferrarotti non cade nel tranello dei radicalismi. Evita di sposare la causa degli “apocalittici”, ma trova ingenuo l’atteggiamento ottimista degli “integrati”.
Ci ricorda che il vero pensiero non cede alle tentazioni della soluzione finale, piuttosto ci prepara a vivere quotidianamente con il problema: «l’atto filosofico più importante che oggi si possa compiere, è dato dal buon uso della crisi e dall’accettazione, pacata, del disagio. Non si tratta di contemplare rassegnati. Non è in gioco la Gelassenheit heideggeriana e neppure il “surrender”, la resa di Kurt H. Wolf. Si tratta di un’attesa vigile». Per questo bisogna contrastare la procedura, il modello come soluzione finale: il modello è un deja vù!
C’è sempre uno scienziato che crede di aver inventato un modello totalmente innovativo (ingenuità) che possiede qualcosa che altri modelli non hanno (propaganda) e che permette, una volta implementato, di risolvere tutti i problemi (utopia).
Un modello è una variabile dipendente da altre variabili: il contesto, i pregiudizi dell’epoca, le persone che trovi lungo il cammino, il ruolo effettivo che ricopri, la casualità.
L’allenamento mentale dell’uomo in grado di guidare il cambiamento, dovrebbe basarsi sulla capacità critica di falsificare tutti i modelli.
I modelli sono riduzionistici rispetto alle dinamiche del reale. Non si può governare la complessità rinunciando alla complessità. Di questo la sociologia critica è perfettamente consapevole.
Un modello che diventa procedura genera mostri, ostacolando il salto di qualità.
Più di cento anni fa, Max Weber lanciava un monito sulle conseguenze del processo di razionalizzazione della società occidentale, rinchiusa in una gabbia d’acciaio.
Quel monito è rimasto inascoltato!
Il XXI secolo ha spalancato le porte alla Dittatura del calcolo, come ci ricorda il matematico Zellini nella sua ultima pubblicazione del 2018.
Aumentano i libri sulla gestione automatica, cibernetica o per emulazione-memorizzazione di modelli. Eppure i livelli di criticità e di conflittualità - politica, organizzativa, economica, sociale, ambientale - sono aumentati rispetto al cosiddetto trentennio glorioso del secolo scorso.
Anche negli anni precedenti ai due conflitti mondiali, si erano imposti paradigmi di stampo positivistico finalizzati a modellizzare la realtà per ottimizzarne la funzionalità.
Risultato: le procedure generano mostri! Il positivismo ha creato sistemi autoritari.
Il modello migliora ciò che già sei, ma non cambia la natura di ciò che sei.
Allora vale la pena riscoprirsi imprevedibili e non farsi irretire dalla macchina.
L’uomo prende decisioni anche in assenza di informazioni. La macchina no!
Il 15 gennaio 2009, il pilota di linea Chesley Burnett “Sully” Sullenberger fa ammarare il volo US Airways 1549 sul fiume Hudson. Con la sua manovra, resa necessaria dall’impatto del velivolo con uno stormo di uccelli che manda in panne entrambi i motori, salva la vita a 155 persone.
Ciò nonostante l’aviazione lo sottopone a una commissione di inchiesta, perché ritiene che il pilota abbia agito in maniera pericolosa e avventata. La tesi sostenuta dagli ispettori era che avrebbe potuto fare ritorno presso l’aeroporto e atterrare con molti meno rischi. Solo dopo 15 mesi di indagini e decine di simulazioni, il NTSB convalida senza riserve la decisione di Sully.
Inizialmente una serie di test aveva sconfessato la scelta del pilota, ma si trattava di simulazioni che non tenevano conto dei 20 secondi che erano stati necessari a Sully per valutare la situazione dopo lo spegnimento dei motori. Includendo questo lasso di tempo nei test, la decisione del pilota si è dimostrata la più corretta.
Questa divagazione su una storia di vita era necessaria, perché consonante con il modo di osservare e interpretare la realtà di Ferrarotti.
L’analisi qualitativa della micro sociologia, fatta di esperienze singole e di “ricerche di comunità”, dalle quali emergono conoscenze non rilevabili con i dati statistici, fanno parte di quella tradizione della filosofia sociale e della sociologia qualitativa che non può essere cancellata, ma deve necessariamente coniugarsi con le metodologie di carattere quantitativo, accettando il problema dell’irriducibilità dei fenomeni sociali al mero dato misurabile.
Ferrarotti non dimentica la lezione ottocentesca, ancora attuale, di dover tenere assieme spiegazione (erklären) e comprensione (verstehen) , mantenendo una rotta scientifica alimentata da una tensione critica verso fenomeni che corrodono la coesione sociale.
Egli appartiene alla schiera di quei pensatori che vogliono incidere sulla realtà senza cadere in tentazioni ideologiche, preservando l’onesta dello scienziato sociale.
A lui si addice la frase che egli stesso cita in un’altra delle sue opere pubblicate quest’anno: Potere e autorità.
Nell’ultima pagina di questo lavoro, cita l’ultima opera di Charles Wright Mills, The Marxists, dove in esergo compare una frase che ogni sociologo dovrebbe far propria:
«I have tried to be objective, I do not claimed to be detached». Ho cercato di essere obiettivo. Non pretendo di essere distaccato.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
- PER LA STORIA DELLLA SCIENZA E PER LA SCIENZA DELLA STORIA, FORSE, E’ MEGLIO RI-DISCENDERE “SOTTO COVERTA DI ALCUN GRAN NAVILIO” E RIPRENDERE IL LAVORO GALILEANO DELLA CONVERSAZIONE E DELLA CONOSCENZA
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- GINECOLOGIA, ANDROLOGIA, E INVERNO DEMOGRAFICO. "L’Europa è unita dalle culle vuote: ecco la vera crisi che non si affronta".25 giugno 2019, di Federico La Sala
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA [2008[ "NON CLASSIFICATA"!!! *
Demografia.L’Europa è unita dalle culle vuote: ecco la vera crisi che non si affronta
I tassi di fecondità sono molto diversi tra Paese e Paese, tuttavia a partire dal 2008 il crollo delle nascite è diventata una tendenza che riguarda tutte le età e tutti i livelli di reddito
di Massimo Calvi (Avvenire, sabato 22 giugno 2019)
La recessione demografica che colpisce l’Italia, e che insieme al debito pubblico rappresenta uno dei maggiori elementi di preoccupazione per gli anni a venire, non è un fenomeno limitato ai confini nazionali. Nel lanciare l’ennesimo allarme, alla presentazione del rapporto annuale Istat, il presidente dell’istituto di statistica Giancarlo Blangiardo ha fatto un paragone con il crollo della popolazione registrato negli anni 1917-1918, quelli segnati dalla Grande Guerra oltre che dagli effetti dell’epidemia di Spagnola. Eppure il male italiano è anche un grande problema europeo. «L’inverno demografico che stiamo vivendo in Europa», di cui ha parlato anche papa Francesco a gennaio nell’Udienza generale per il viaggio a Panama in occasione della Giornata mondiale della gioventù 2019, merita di essere preso più seriamente di quanto la politica e le istituzioni non stiano facendo: l’immagine choc della Guerra non è così lontana dagli effetti che il Continente può dover sperimentare nei prossimi anni.
In Europa, i tassi di fecondità sono molto diversi tra Paese e Paese, tuttavia a partire più o meno dal 2008 il crollo delle nascite è diventata una tendenza strutturale comune, che riguarda un po’ tutte le età e tutti i livelli di reddito. Paesi come la Francia sono passati da tassi superiori ai 2 figli per donna a 1,87 nel 2018, la "mitica" Svezia è scesa a 1,75 (era a 1,91 nel 2008), la Gran Bretagna è arrivata al record negativo da 10 anni a 1,76, la Spagna è crollata a 1,25 figli (da 1,44 nel 2008), persino in Finlandia gli allarmi si ripropongono anno dopo anno perché si ritarda sempre di più la messa al mondo del primo figlio e nascono sempre meno secondi e terzi. L’Italia ha un tasso di fecondità oggi di 1,32, ma aggravato dal fatto che il calo delle nascite dura da molti più anni rispetto ad altri Paesi, e questo ha ormai compromesso le possibilità di compensare con nuove nascite l’emorragia della popolazione.
Il primo problema all’origine dell’inverno demografico ovunque in Europa è proprio il calo del numero di donne in età riproduttiva, fenomeno che ha origine attorno agli anni 90. Meno donne che mettono al mondo meno figli è il "dato grezzo" della questione. In realtà, lo choc del 2008 sembra aver tracciato una linea netta oltre la quale è entrato probabilmente in gioco un cambiamento di mentalità delle nuove generazioni, unita al venire meno di molte certezze su lavoro, abitazione, prospettive e soprattutto sulla possibilità di migliorare la propria situazione rispetto alla generazione precedente. Non è una mancanza di desiderio di famiglia, ma più di condizioni da soddisfare in un contesto di politiche pubbliche che tende a premiare comportamenti individualistici e a scoraggiare la formazione di una famiglia. È vero in Italia, ma lo si incomincia a registrare un po’ ovunque nelle politiche di bilancio.
Il cambio della composizione demografica porta infatti con sé anche decisioni di spesa che rischiano di accentuare il problema della denatalità. In un recente saggio pubblicato sulla rivista Population & Avenir, il demografo francese Gerard-Francois Dumont ha dimostrato come salvo rarissime eccezioni i Paesi che più spendono per sostenere la natalità registrano anche i maggiori tassi di fecondità. Tuttavia, oggi l’aumento della popolazione anziana e il calo di quella in età da lavoro sta spingendo gli Stati ad aumentare le risorse a favore della componente più rilevante anche elettoralmente per mantenere gli standard di welfare, inteso come sanità e pensioni.
Secondo un recente rapporto della Fondazione Leone Moressa l’Italia avrà il 17% in meno di popolazione tra 32 anni, e oltre il 35% dei cittadini con più di 65 anni. Altre previsioni che riguardano invece l’Europa indicano che entro il 2060 le persone tra i 15-64 anni caleranno dal 67% attuale al 56%, gli "anziani" saliranno invece dal 18 al 30%. Da 4 persone in età attiva per ogni over-65 si passerà a sole 2.
Guardando avanti, in un Continente che oggi conta poco più di 510 milioni di persone, e che dovrebbe incominciare a conoscere un calo di popolazione dal 2035, si può immaginare un gruppo di Paesi che continuerà ad avere un saldo naturale positivo della popolazione: Francia, Gran Bretagna, Svezia, Irlanda, Danimarca...; un altro caratterizzato da un deciso declino demografico: Portogallo, Spagna, Grecia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia...; l’Italia e la Germania presentano invece prospettive molto negative nel bilancio nati-morti, ma la possibilità di tenuta dei livelli resta appesa alla capacità di continuare ad attrarre popolazione giovane.
Culle vuote e migrazioni mal gestite sono una bomba a orologeria per il Vecchio Continente. L’Europa ha bisogno disperatamente di più bambini e di più persone al lavoro che possano sostenere gli anziani a riposo o bisognosi di cure. Crudamente, ha bisogno di far venire alla luce nuove risorse e di attrarne di già disponibili. Spendere e investire per favorire le nascite purtroppo è una scelta che non piace ai governi in virtù di un banale calcolo statistico, considerato che proprio la tendenza demografica declinante richiede sempre maggiori risorse a favore della parte elettoralmente più rilevante della popolazione. Ma la tentazione della rendita è di per sé un indicatore evidente di declino e sconfitta.
Il fatto è che la recessione demografica porta con sé anche recessione economica, problemi sul debito e sulla sostenibilità dei servizi, maggiori difficoltà di spesa per sostenere le aree depresse.
Tutti gli studi sull’effetto dello choc demografico indicano che per Paesi del Centro e dell’Est-Europa, per la Germania Orientale, l’Italia del Sud, il Nord della Spagna e la Grecia, la prospettiva è quella di un futuro fatto di poche nascite, invecchiamento, emigrazione. E’ un circolo vizioso, insomma. Esattamente come quello che chiama in causa la questione delle migrazioni. I Paesi che riusciranno a tenere la posizione saranno quelli in grado di garantire due tipi di condizioni: uno sviluppo così elevato in termini di qualità della vita, del lavoro, delle retribuzioni, degli incentivi, della sicurezza e della sostenibilità futura, in grado di sostenere il desiderio di figli e famiglia; la capacità di offrire alle persone che emigrano lavoro, integrazione, educazione e un ambiente favorevole e dignitoso.
Non è una partita semplice perché l’inverno demografico è già qui e le tensioni che comporta questa trasformazione sono in atto e ben visibili. Di certo se la sfida è anche culturale, la soluzione non è più individualismo, ma migliore capacità di interpretare la solidarietà tra le generazioni e tra i popoli.
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA - 2008 - "NON CLASSIFICATA"!!!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA "GIOIA DELLA VERITà" E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE21 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA "GIOIA DELLA VERITà". Intervento del Santo Padre Francesco all’Incontro sul tema: “La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli, 20-21 giugno 2019).21 giugno 2019, di Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- IL "CIELO STELLATO" DI DANTE E DI KANT O IL "CIELO STELLATO" DI COSTANTINO E NAPOLEONE?!14 giugno 2019, di Federico La Sala
L’EUROPA, LA COSTITUZIONE, E LA BANDIERA: LE RADICI CATTOLICHE DI MARIA ELENA (MADRE DI COSTANTINO) O LE RADICI CRISTIANE DI MARIA BEATRICE (MADRE DI DANTE)?! Al di là della trinità "edipica" e "mammonica" *
- UN "SEGNAVIA": DALLA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA ALLA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA. LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI"
Europa.
Le radici cattoliche e mariane della bandiera dell’Unione Europea
Un saggio di Enzo Romeo ricostruisce la complessa genesi e la simbologia legata a Maria del vessillo di colore blu con il cerchio di dodici stelle, adottato dal Consiglio europeo nel 1955
di Edoardo Castagna (Avvenire, venerdì 14 giugno 2019)
- [Foto] La bandiera dell’Unione Europa, un cerchio di dodici stelle in campo blu
Ogni identità ha bisogno di simboli ai quali guardare, per riconoscersi e per ispirarsi. Lo sanno bene i populisti di ieri e di oggi, che usano le identità come sciabole per dividere. In modo diametralmente opposto, tanto politicamente quanto moralmente, lo sapevano bene anche i padri fondatori dell’Unione Europea nella loro ricerca di una nuova identità capace di abbracciare, unire, includere.
L’identità europea si è costruita un poco alla volta negli ultimi sessant’anni e, anche se nell’ultimo periodo sembriamo a un punto di stallo, non possiamo non vedere quanto di grande e buono è stato fin qui costruito. Anche attorno ai simboli. Abbiamo un inno nella musica di Beethoven; e abbiamo una bandiera, ormai presenza famigliare sulle facciate degli edifici pubblici - e non solo, come le ultime elezioni europee hanno dimostrato: non pochi balconi hanno visto esporre il drappo azzurro con le dodici stelle.
Alla storia di questa bandiera ha dedicato il suo ultimo saggio Enzo Romeo (Salvare l’Europa. Il segreto delle dodici stelle; Ave, pagine 190, euro 12,00), nel quale la ricostruzione dei passaggi che portarono le istituzioni europee alla scelta definitiva si accompagna alla riscoperta del retroterra imprevisto che agì sui suoi creatori. Il disegno finale è attribuito a un lavoro collegiale, nel quale tuttavia spiccano i contributi del direttore dell’Ufficio d’informazione e stampa del Consiglio d’Europa, Paul Michel Gabriel Lévy, e soprattutto di Arsène Heitz, impiegato dell’Ufficio e autore di diversi bozzetti per la bandiera comune - tra i quali, con poche modifiche, quello infine adottato.
Cattolico e assai devoto alla Madonna, Heitz lavorò su simboli in apparenza del tutto laici: eppure l’azzurro, le dodici stelle come quelle della “medaglia miracolosa” che commemora le apparizioni mariane di rue du Bac a santa Caterina Labouré nel 1830, e che Heitz portava sempre con sé... una simbologia mariana agì, forse più come “mano invisibile” che come ispirazione cosciente, almeno fino a quando, molto più tardi, lo stesso Heitz non la esplicitò, forse prendendone consapevolezza egli stesso: «Mi sentii ispirato da Dio - avrebbe confidato Heitz a padre Pierre Caillon nel 1987, poco prima di morire - nel concepire un vessillo tutto azzurro su cui si stagliava un cerchio di stelle, come quello della medaglia miracolosa. Cosicché la bandiera europea è quella di Nostra Signora».
Quello di Heitz, d’altra parte, non fu l’unica delle proposte a contenere richiami alla simbologia cristiana, anche più espliciti: per esempio, l’austriaco Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi, fondatore nel 1922 dell’Unione Paneuropea, suggerì un drappo blu con una croce rossa cerchiata di giallo; lo stesso Heitz propose una croce rossa in campo verde. Il verde fu tra i colori più ricorrenti nelle prime bozze: il francese Robert Bichet lanciò l’idea di quindici stelle verdi su campo bianco, il Movimento federalista europeo chiedeva che fosse adottato direttamente il proprio emblema, una “E” verde su campo bianco. Il blu fu comunque il colore più proposto, così come le stelle ebbero facilmente la meglio su altri simboli come i cerchi (un bozzetto a cerchi intrecciati fu bocciato perché ricordava troppo, a detta della commissione, una catena o la bandiera olimpica, se non addirittura la ghiera di un telefono...).
Le dodici stelle disposte a cerchio su fondo blu furono adottate dal Consiglio d’Europa (la bandiera identifica tanto questa istituzione quanto la successiva Unione Europea) nel 1955, con argomentazioni apparentemente anodine: il blu è quello del cielo dell’Occidente, le dodici stelle rappresentano tutti i popoli d’Europa nella loro diversità, il cerchio la loro unità. -Nessun riferimento, nei documenti ufficiali, a richiami mariani: ma, come nota giustamente Romeo, in questi casi «bisogna procedere su un piano assolutamente aconfessionale, evitando polemiche di sapore religioso o ideologico. Non si tratta di nascondere ipocritamente i segni della propria fede, ma di proporli su un piano universale, perché in questo caso essi trascendono l’appartenenza a una Chiesa e si trasformano nell’allegoria di un quadro valoriale comune». E, in effetti, ormai per mezzo miliardo di persone quelle stelle in campo blu hanno acquisito un po’ il colore di casa.
 Anche se di una casa ancora in costruzione.
Anche se di una casa ancora in costruzione.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI. In memoria di Kurt H. Wolff.
"NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
Federico La Sala
- UN "SEGNAVIA": DALLA TRINITA’ DI ADAMO ED EVA ALLA TRINITA’ DI GIUSEPPE E MARIA. LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI"
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "MARGINI DELLA FILOSOFIA" (J. Derrida) E DELLA COSTITUZIONE (Italia)..13 giugno 2019, di Federico La Sala
MARGINI della filosofia. Intervento libero. In memoria di Jacques Derrida...
Siccome orientarsi nell’infinito è un problema meta-fisico e costituzionale, e - dopo Kant e la sua "rivoluzione copernicana" - non sappiamo ancora distinguere "dewey"anamente tra "prima di Cristo" e "dopo Cristo", tra Tolomeo e Copernico, tra il tutto e la parte, tra antropologia e andrologia - e ginecologia, tra Italia e "Italia", tra Costituzione e Partito, tra forza Italia e "Forza Italia", mi è sembrato opportuno fornire un piccolo banale (comune!) elemento per uscire dal sonnambulismo e dalla confusione! Siamo o non siamo "Dopo Dewey" !? O no?!
P. S. - SUL TEMA, MI SIA CONSENTITO, SI CFR.:
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?!Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Il gesto filosofico di Agamben (di Felice Cimatti).10 giugno 2019, di Federico La Sala
L’ordine dei discorsi
Il gesto filosofico di Agamben
di Felice Cimatti (fatamorganaweb, 10 Giugno 2019)
- Il Regno e il Giardino di Giorgio Agamben.
Ogni filosofo, e come è sempre più evidente non basta insegnare filosofia in una università per essere un filosofo, incarna un gesto peculiare. Un gesto che è il suo gesto, solo suo, inconfondibile (per converso, un filosofo privo di un simile gesto non è propriamente un filosofo). Un gesto del genere, la cui imperscrutabile origine si colloca al di qua della scelta soggettiva perché ha a che fare più con lo stile e il carattere che con la volontà, rende quell’essere umano un filosofo. Cioè qualcuno che, proprio con quel gesto, ci mostra la possibilità di un’azione che, prima di quello stesso gesto, nessuno immaginava fosse praticabile. In effetti quello che rimane, di un filosofo (ma anche di un artista, e in fondo di ogni essere umano che abbia fatto della sua esistenza un campo di sperimentazione), è proprio quel gesto.
In questo senso la storia della filosofia non è propriamente la storia delle idee di questo o quel filosofo: è piuttosto una scuola in cui si impara a muovere il corpo/pensiero in un modo particolare. Precisiamo questo punto, perché spesso si pensa che la filosofia sia un fatto prevalentemente, se non esclusivamente, cerebrale. Prendiamo, ad esempio, il caso delle tecniche yoga. Si tratta di imparare ad assumere posizioni apparentemente “innaturali”, come quella che si può vedere nell’immagine del celebre maestro indiano Iyengar. Tuttavia, una volta che tendini e muscoli hanno esplorato questa possibilità, è tutto il corpo/mente che acquista una elasticità che prima era semplicemente impensabile. Il gesto filosofico, come una posizione yoga, rende esplorabile un campo d’azione che, prima di quel gesto, non esisteva. O meglio, quel campo era da sempre virtualmente disponibile, tuttavia nessuno l’aveva ancora esplorato né tantomeno credeva che ci fosse ancora qualcosa da esplorare. Quindi di fatto era come se non ci fosse. In questo senso la filosofia rende liberi, perché ci mostra che laddove pensavamo pigramente che non ci fosse niente da fare, ebbene anche in quel caso c’è una azione possibile. Basta cercarla, e se non la troviamo, allora occorre inventarsela.
Il gesto filosofico, pertanto, è gesto in quanto contemporaneamente pensiero e azione; proprio per questo è filosofico. È quindi anche un gesto potenzialmente politico, benché non nel senso che propone una esplicita azione politica, piuttosto perché è un gesto che offre al corpo un’inaspettata opportunità di movimento. Perché pensare significa agire. Wittgenstein, nel § 11 della prima parte delle Ricerche Filosofiche, propone al riguardo un paragone divenuto celebre: «Pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili, c’è un martello, una tenaglia, una sega, un cacciavite, un metro, un pentolino per la colla, la colla, chiodi e viti. - Quanto differenti sono le funzioni di questi oggetti, tanto differenti sono le funzioni delle parole. (E ci sono somiglianze qui e là)». Ogni parola del linguaggio, cioè ogni operazione concettuale, dischiude un campo d’azione, che senza quella parola non sarebbe possibile. Ogni gesto filosofico è uno di quegli strumenti, cioè una di quelle possibilità di azione.
È importante sottolineare un punto, che una erronea rappresentazione dalla filosofia oggigiorno porta spesso a trascurare. Un falegname usa tutti quegli strumenti, anche se avrà una particolare predilezione per uno in particolare. Questo significa, per essere più espliciti, che un filosofo non smette mai di pensare insieme ad Aristotele e Platone, ad esempio, anche se non è uno specialista della filosofia aristotelica o platonica. Così come per un falegname il martello è sempre attuale, così per un filosofo Aristotele è sempre attuale. Questo significa che il filosofo, cioè chi propone gesti filosofici, non lavora come uno scienziato, per il quale, invece, una teoria scientifica antica è inutilizzabile.
In questo senso quello filosofico ha a che fare più con il gesto di un falegname, o di un pittore, che con quello di un neurologo che studi le connessioni cerebrali all’interno di una particolare area della neocorteccia. Ma solo “in un certo senso”, perché spesso il neurologo, che crede di avere a che fare solo con fatti, non si accorge che i fatti di cui si occupa sono impregnati di impensati gesti filosofici. Si pensi, per fare un solo esempio, a quegli scienziati che cercano nel cervello quella che chiamano la “base materiale” delle attività mentali. Ma siamo così sicuri che le “attività mentali” esistano davvero? La mente è un fatto, o un pregiudizio metafisico? Vale lo stesso per il corpo, ovviamente, che non è che l’altra faccia dello stesso dualismo originario.
Se ora ci chiediamo qual è il gesto filosofico di Giorgio Agamben, il gesto che ha consegnato alla filosofia, e che d’ora in poi nessun filosofo potrà ignorare, potremmo indicarlo nella paziente e tenace operazione con cui torna alle cesure fondamentali del pensiero (quelle che formano la nostra tradizione metafisica), come appunto quella fra mente e corpo, cercando di mostrarne le impensate possibilità di azione che ancora ci offrono. Ogni dualismo costringe il pensiero, e quindi il corpo, a scegliere fra opzioni precostituite, e quindi comunque insoddisfacenti. Perché ogni dualismo costringe a muoversi o così o così. Il dualismo pensa e agisce per noi.
Agamben non cerca di mostrare che il dualismo è sbagliato, o che è superabile scegliendo uno dei due versanti contrapposti, come il materialista che trascura la mente, o l’idealista che privilegia la mente. Cerca piuttosto di trovare in quel dualismo una via di fuga che finora non avevamo scorto. Una via di fuga che non avevamo intravista proprio perché noi siamo il prodotto di quel dualismo. Tuttavia in quello stesso dualismo è implicito un movimento di pensiero che non abbiamo ancora esplorato. Il gesto filosofico di Agamben consiste allora nel disattivare quel dualismo, cioè nell’impedirgli di pensare al posto nostro.
Pensiamo al dualismo che esplora nel suo ultimo libro, Il Regno e il Giardino. Il regno è il Regno di Dio, che ci aspetta alla fine dei tempi. Il giardino è quello del Paradiso terrestre che, come non facciamo che stancamente ripetere, è definitivamente perduto. La nostra condizione, così vuole il dualismo in cui siamo intrappolati, è sospesa fra un passato per sempre passato, ed un futuro per sempre futuro. In mezzo siamo noi, fra rimpianto e speranza, fra memoria e desiderio, fra una inattualità svanita e un’inattualità a venire. Agamben torna a questo dualismo, e attraverso un lavoro come sempre minuzioso e appassionante, ne mostra non solo i vicoli ciechi, ma anche e soprattutto le vie inesplorate che ancora contiene. Che ha sempre contenuto.
In questo senso si può leggere Agamben a partire dalla sesta tesi de Sul concetto di storia di Benjamin, quando scrive che si tratta di «riattizzare nel passato la scintilla della speranza» (Benjamin 1997, p. 27). Perché la speranza, l’unica speranza effettivamente praticabile, è nel passato, non nell’inesistente futuro. Un passato che continua ad essere operativo nel presente, perché determina il nostro modo di agire e di pensare, e che tuttavia non è mai chiuso in modo definitivo. «Il pensatore rivoluzionario», scrive Benjamin, lavora sul «potere delle chiavi che un attimo» presente «possiede su una ben determinata stanza del passato, fino ad allora chiusa» (ivi, p. 55). Agamben, nei suoi libri, così come un bravo fabbro, tira fuori dalla sua cassetta degli attrezzi delle chiavi di cui ignoravamo l’esistenza (i fabbri più bravi sono anche un po’ scassinatori), chiavi con cui possiamo aprire stanze del passato che non sapevamo di poter aprire.
Vediamo intanto, prima di entrare nel merito della proposta di Agamben, di capire qual sia la posta in gioco discussa ne Il Regno e il Giardino. Nell’alternativa fra regno e paradiso si perde la possibilità di una esistenza “felice” in questo mondo. Se infatti la beatitudine è possibile solo nel Regno di Dio, allora sicuramente non è possibile in questa esistenza. Vale lo stesso per il Paradiso, la cui felicità è perduta per sempre. Quindi, anche in questo caso è esclusa dal presente. Stretto in questo dualismo si pone la questione di come pensare una vita felice che non sia costretta fra un ieri che trapassa senza fine in un domani, e viceversa, senza mai soffermarsi in un oggi. La posta in gioco, allora, è «la scissione fra “natura e grazia”» (Agamben 2019, p. 87); quindi, o natura o grazia, o vita o salvezza, o corpo o spirito.
Agamben articola la sua operazione di disattivazione lavorando sulla nozione di peccato, che - da Agostino in poi - è stato considerato come l’evento che ha determinato la cacciata dell’umano dal paradiso: «In ogni caso, se il fattore decisivo del dispositivo è il peccato, si può dire allora che il vero senso della dottrina del peccato originale è quello di scindere la natura umana e di impedire che in essa natura e grazia possano mai coincidere in questa vita» (ivi, p. 96). A partire da questa scissione si determina un destino, anche politico, come quello alla base del fallimento disastroso dell’utopia comunista nel secolo scorso, che da un lato rinviava indefinitamente la realizzazione della società senza classi, dall’altro condannava ad una esistenza sotto un paranoico controllo poliziesco. Giorgio Agamben
- [foto] Particolare de Cacciata dei progenitori dall’Eden (Masaccio, 1426-1427).
Ma cos’è allora il paradiso? È davvero contemporaneamente perduto e rimandato, oppure è ancora misteriosamente operativo nelle nostre esistenze? «Il paradiso», scrive Agamben, «è ciò a cui l’uomo deve far ritorno senza esservi mai veramente stato. D’altra parte, il ritorno non va inteso in senso temporale, ma ha già sempre avuto luogo, in modo che uscita e ritorno siano compresenti» (ivi, p. 61). Il dualismo vorrebbe che o si è nel paradiso, o se ne è fuori. Si tratta invece di lavorare sulla possibilità di “abitare” entrambe le situazioni nello stesso tempo. Fare della vita un paradiso, ma anche fare del paradiso una vita. Ossia, per usare l’alternativa discussa più sopra, disattivare la distinzione fra grazia e natura. Questo significa, tornando a Benjamin, che in ogni momento c’è «una chance rivoluzionaria», ossia, c’è una via di fuga.
Agamben, contro il coro disfattista del nostro tempo, mostra come c’è sempre qualcosa da inventare, una mossa inattesa, uno scarto che può rovesciare la situazione. Il Regno non è domani, il Regno c’è sempre stato (il Paradiso era già il Regno); bisogna sempre di nuovo offrirgli una occasione per presentarsi. Bisogna stare nel presente come se ci si trovasse alla fine dei tempi, e quindi non si trattasse più di un presente cronologico. Stare nel tempo senza starci, così come stanno nel tempo un animale, una nuvola oppure un angelo. Riuscire a fare della vita un paradiso, cioè un luogo di grazia, senza tuttavia smettere d’essere un luogo vivente, terreno, qui ed ora:
- Il paradiso - la vita in tutte le sue forme - non è mai stato perduto: è sempre stato al suo posto e permane come modello intatto del bene anche nel continuo abuso che l’uomo ne fa, senza riuscire in nessun caso a corromperlo. Il paradiso celeste, che non si distingue da quello terrestre, in cui l’uomo non è ancora penetrato, coincide con il ritorno alla natura originaria, che, intatta e indelibata, attende fin dall’inizio dei tempi tutta l’umanità (ivi, p. 63).
Il paradiso non è altrove, e non è nemmeno in quella natura “incontaminata” che cercano i palati squisiti dell’ambientalismo. L’antropocene è paradisiaco così come la foresta amazzonica prima dell’arrivo dei conquistadores, o quanto l’immensa discarica che ci travolge nell’immagine seguente. Il paradiso - se c’è - c’è sempre stato. La sfida, immensa come quella discarica, è trovare il paradiso anche là dentro, oltre ogni ingenua idea di purezza, di natura e di bellezza. Perché la grazia non illumina il paradiso perché questo è un luogo meraviglioso; al contrario, è la grazia che rende paradisiaco qualunque luogo, anche e soprattutto una discarica. Ma che cos’è la grazia se non la capacità di vivere una discarica come se fosse un paradiso?
Il gesto filosofico di Agamben, in definitiva, non risolve il dualismo, piuttosto lo scioglie al suo stesso interno. Un gesto che, come scrive Wittgenstein nella Conferenza sull’etica (contenuta all’interno del libro Lezioni e conversazioni), ci offre la possibilità di vedere il mondo come un “miracolo”. E che cos’è un miracolo se non appunto il collasso della distinzione fra Giardino (dell’Eden) e Regno? Il “miracolo” appare quando si diventa capaci di abitare nella congiunzione che unisce e separa allo stesso tempo il giardino e il regno. Nel “miracolo”, il Paradiso è ora, ma questo significa che siamo infine nel Regno; ma siccome il Regno è alla fine dei tempi, quello del “miracolo” non è un tempo cronologico, un tempo misurabile. Al contrario, è un tempo, scrive Agamben sulla scorta di Benjamin, “messianico”, cioè appunto quel momento del tempo in cui si disattiva il tempo cronologico, quello della memoria e della speranza. Il tempo “messianico”, quindi, è il tempo della coincidenza di vita e grazia:
- In questione non sono, cioè, due momenti di una cronologia, ma una trasformazione messianica del tempo; si tratta, in ogni caso, di afferrare una presenza, ma questa è tale da implicare un’alterazione radicale dell’esperienza del tempo, che impedisce di collocarla soltanto in un punto cronologico determinato. Lo stesso può dirsi del Regno: esso è presente qui e ora, ma è, insieme, sempre in atto di venire, sempre ad-veniente, senza che questo possa implicare una dilazione (ivi, p. 118).
Torniamo, infine, alla discarica: se il Giardino è questa discarica, allora il Regno è questa stessa discarica. Ma questo significa che non è più semplicemente una discarica, perché è illuminata dalla grazia. Vederla come miracoloso apparire del Regno vuol dire infatti destituirla dalla condizione di puro evento del mondo. Così la grazia salva la discarica, ma allo stesso tempo la discarica permette alla grazia di mostrarsi: «Solo il regno dà accesso al Giardino, ma solo il Giardino rende pensabile il Regno» (ivi, p. 120).
Riferimenti bibliografici
 G. Agamben, Il Regno e il Giardino, Neri Pozza, Milano 2019.
G. Agamben, Il Regno e il Giardino, Neri Pozza, Milano 2019.
 W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino 1997.
W. Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino 1997. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- UNA CONFESSIONE (DA "IL MANCINO ZOPPO"). IN MEMORIA DI MICHEL SERRES.3 giugno 2019, di Federico La Sala
"Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere" (M. Serres, Distacco, 1986)
IN MEMORIA DI MICHEL SERRES *. UNA CONFESSIONE (DA "IL MANCINO ZOPPO"):
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
PER LA FILOSOFIA DI UN ALTRO SOCRATE. AL DI LA’ DI EDIPO...:
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
a) IL PUNTO DI SVOLTA. L’INDICAZIONE DI FACHINELLI E LA SUA IMPORTANZA.
b) LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.
c) CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
d) CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
*
Morto Michel Serres, il filosofo della scienza che amava l’Italia
Grande figura dell’epistemologia e fra i primi a pensare in modo sistematico la necessità di un nuovo approccio alla questione ecologica, aveva 88 anni. «I miei miglior amici sono italiani»
di Daniele Zappalà (Avvenire, sabato 1 giugno 2019)
Parigi. Era uno dei pensatori più ammirati a livello internazionale, oltre a rappresentare una figura centrale del mondo intellettuale francese. Il filosofo Michel Serres, grande figura dell’epistemologia e fra i primi a pensare in modo sistematico la necessità di un nuovo approccio alla questione ecologica, si è spento ieri a 88 anni. Accademico di Francia fin dal 1990, aveva insegnato a lungo negli Stati Uniti, all’Università di Stanford, oltre che in vari atenei transalpini. Autore di una cinquantina di volumi e di opere fondamentali sull’origine del pensiero scientifico, come Le origini della geometria (Feltrinelli) o Lucrezio e l’origine della fisica (Sellerio), aveva pure interpretato, nella lontana scia di Leibniz, la pregnanza della comunicazione nel mondo contemporaneo, come nei 5 volumi della serie Hermès (1969-1980).
Figura estremamente originale, aveva scelto come proprio motto «pensare significa anticipare», prevedendo e interpretando nei propri libri diverse rivoluzioni del nostro tempo. Una costante della sua riflessione è stata pure la grande attenzione alla tradizione culturale cristiana, come in La ricerca delle parole. Corpo, scrittura e messaggio evangelico (EDB), o in Darwin, Napoleone e il samaritano. Una filosofia della storia (Bollati Boringhieri).
Fra i volumi di Serres più citati, si può ricordare Il contratto naturale (Feltrinelli), all’origine di una riflessione sull’ambiente approdata poi a volumi più personali, come Biogea. Il racconto della terra (Asterios). Di recente, aveva pubblicato pure dei pamphlet con cui aveva riscosso un notevole successo, come Non è un mondo per vecchi. Perché i ragazzi rivoluzionano il sapere, o ancora Contro i bei tempi andati, entrambi tradotti da Bollati Boringhieri.
«Tutti i miei migliori amici sono italiani», ci aveva raccontato nella sua ultima intervista ad Avvenire, da grande innamorato del Belpaese. In proposito, aveva anche dedicato un volume a Carpaccio, edito in Italia da Hopefulmonster. Fra gli altri tratti della tradizione italiana reinterpretati a livello filosofico, spicca la figura di Arlecchino, nel volume Il mantello di Arlecchino (Marsilio). Profondamente segnato dal dramma della guerra, ha lasciato anche importanti riflessioni di stampo pacifista.
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA, POLITICA. "19 maggio 1975. La riforma del diritto di famiglia" (di Raffaella Sarti)20 maggio 2019, di Federico La Sala
IL LETARGO DI SECOLI E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI... *
La riforma del diritto di famiglia
19 maggio 1975
di Raffaella Sarti (Il Mulino, 17 maggio 2019)
“Storica riforma del diritto di famiglia: diventa assoluta la parità tra i coniugi”, titolava un articolo su “La Stampa” del 23 aprile 1975, commentando l’approvazione, il giorno prima, di quella che sarebbe divenuta la Legge 19 maggio 1975, n. 151. Dopo un iter di quasi nove anni, la riforma arrivava in porto. Senza dubbio, per molti versi la legge rappresentava una “rivoluzione in famiglia”, come recitava un altro articolo sullo stesso giornale. “Le famiglie italiane diventeranno più moderne e più libere”. “Ad essere ‘liberati’ saranno le donne e i figli, spiegava il giornalista: “l’‘oppressore’ del quale vengono limitati i diritti e i poteri, è il padre, finora capo famiglia assoluto”. La famiglia “non è più vista come piramide, che ha al vertice il marito, ‘capo’ e monarca assoluto”, gli faceva eco un articolo su “l’Unità”. In effetti, la legge cancellava quasi completamente il ruolo di capofamiglia, erede per tanti versi della figura plurimillenaria del paterfamilias del diritto romano.
La riforma modificava molti articoli del codice civile del 1942, e - a ventisette anni dalla sua entrata in vigore - faceva un deciso passo verso l’attuazione dell’art. 29 della Costituzione, secondo il quale “il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Fino ad allora le leggi, più che tale principio, avevano attuato quanto previsto nella parte finale dell’articolo che subordinava l’uguaglianza alla “garanzia dell’unità familiare”, prevedendo a tali fine limiti di legge. E i limiti, per decenni, erano stati molti e pesanti. Sino alla riforma, infatti, il marito-padre era “il capo della famiglia”: “la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”, recitava l’art. 144 del codice civile.
Con la riforma, l’obbligo di coabitazione tra coniugi non veniva meno. Si stabiliva, tuttavia, che la residenza della famiglia e l’indirizzo della vita familiare fossero decisi insieme da moglie e marito. Non solo: i coniugi avrebbero potuto avere ciascuno un proprio domicilio nella “sede principale dei propri affari o interessi” (nuovo art. 45 del codice civile). Insomma, si passava da una legislazione che aveva mantenuto una forte preminenza del marito a leggi che garantivano maggior parità tra i coniugi. Non era, però, una parità assoluta. Certo la riforma stabiliva che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri” (nuovo art. 143). Ma permanevano delle asimmetrie. Ad esempio, ora la moglie poteva mantenere il suo cognome. Doveva però aggiungervi quello del marito (art. 143-bis) mentre per il marito non era previsto nulla di simile. Né era previsto che i figli nati in seno al matrimonio potessero avere il cognome della madre. Senza dubbio, comunque, la legge rendeva la moglie meno dipendente dal coniuge: ad esempio, la donna che sposava uno straniero ora non perdeva più la cittadinanza italiana (art. 143-ter).
La riforma metteva i coniugi su un piano di maggiore parità anche grazie alle disposizioni economiche. Il codice del 1942 aveva stabilito che il marito avesse il dovere di “proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze”. La moglie doveva contribuire al mantenimento del marito solo se questi non aveva “ha mezzi sufficienti” (art. 145). In base alla riforma, invece, entrambi i coniugi erano “tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” (nuovo art. 143). Un’altra norma che appariva “rivoluzionaria” riguardava il regime patrimoniale. Fino ad allora era stata in vigore la separazione dei beni tra marito e moglie, mentre la nuova legge introduceva la comunione dei beni, a meno di diversa scelta da parte dei coniugi. Coerentemente, aboliva la dote che, seppur in disuso, per secoli aveva condizionato la vita delle ragazze e delle loro famiglie. Per quanto riguarda gli aspetti economici, la riforma riconosceva inoltre i diritti, fino ad allora disconosciuti, di moglie, figli e altri parenti che lavoravano stabilmente in famiglia o nell’impresa familiare: anzitutto il diritto al “mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia” e poi quello a partecipare “agli utili dell’impresa familiare”. Con una virata in senso democratico, prevedeva anche che le decisioni fossero “adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa”. E ridimensionava le gerarchie di genere: “il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo”, recitava l’art. 230-bis.
La tendenza a smussare le gerarchie di genere e generazionali riguardava anche il rapporto tra genitori e figli. La potestà esercitata dal padre veniva sostituita da una potestà “esercitata di comune accordo da entrambi i genitori” (nuovo art. 316). E i genitori non avevano più solo l’obbligo “di mantenere, istruire ed educare la prole”, ma dovevano farlo anche “tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (nuovo art. 147). D’altra parte, se permaneva l’obbligo, per la prole, di rispettare padre e madre, veniva meno quello di onorarli. Era poi previsto che i figli contribuissero “in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia” finché avessero convissuto con essa.
“Finiscono le crudeli discriminazioni tra bambini”, sosteneva uno degli articoli apparsi il 23 aprile 1975 su “l’Unità”. Un aspetto importante della legge riguardava, in effetti, le differenze tra figli legittimi e illegittimi, di cui ora si parlava solo come di figli “naturali”. L’art. 30 della Costituzione aveva stabilito che la legge dovesse assicurare “ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale”, ma aveva circoscritto la portata del principio alla tutela “compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”, prevedendo anche limiti per la ricerca della paternità.
 Di fatto, profonde differenze avevano continuato a caratterizzare la condizione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio. La riforma le avrebbe ridotte, non cancellate. Sino ad allora un genitore sposato non poteva riconoscere i figli nati da un rapporto adulterino; ora il riconoscimento era possibile (nuovo art. 252). Prima della riforma, i nati fuori del matrimonio che non potevano essere riconosciuti non avevano il diritto di sapere di chi fossero figli. A parte i casi di incesto, la nuova legge permetteva la ricerca della paternità e della maternità (nuovi artt. 269, 270, 278). Infine, la riforma cancellava molte delle discriminazioni, quanto a diritti successori, dei figli naturali, pur senza equipararli completamente ai figli legittimi.
Di fatto, profonde differenze avevano continuato a caratterizzare la condizione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio. La riforma le avrebbe ridotte, non cancellate. Sino ad allora un genitore sposato non poteva riconoscere i figli nati da un rapporto adulterino; ora il riconoscimento era possibile (nuovo art. 252). Prima della riforma, i nati fuori del matrimonio che non potevano essere riconosciuti non avevano il diritto di sapere di chi fossero figli. A parte i casi di incesto, la nuova legge permetteva la ricerca della paternità e della maternità (nuovi artt. 269, 270, 278). Infine, la riforma cancellava molte delle discriminazioni, quanto a diritti successori, dei figli naturali, pur senza equipararli completamente ai figli legittimi.Il nuovo diritto di famiglia, che interveniva su molti altri aspetti della vita familiare, recepiva l’orientamento favorevole alla democratizzazione dei rapporti di genere e generazionali di una parte crescente della società italiana. Per molti versi rappresentava davvero una discontinuità. Nelle pieghe della legge, tuttavia, si annidavano elementi di continuità. In base al nuovo art. 316, ad esempio, “se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili”. Insomma, “l’ultima parola spetta sempre al padre”, notava Danielle Turone sulla rivista femminista “Effe” già nel 1973, analizzando il progetto della legge in un articolo intitolato, significativamente, Dopo anni di gestazione nasce già vecchio il nuovo diritto di famiglia. Cacciato dalla porta, il capofamiglia rientrava, in alcune occasioni, dalla finestra.
Peraltro restava aperto il rapporto tra leggi e più vaste trasformazioni sociali e culturali. “Non basta togliere dal codice la parola ‘patria-potestà’ lasciando integro concetto, o concedere alla donna di mantenere il proprio cognome ‘aggiungendo quello del marito’, per credere di aver dato alle donne la parità”, continuava Danielle Turone. A suo avviso, la donna avrebbe potuto raggiungere la parità “solo quando, oltre ai rapporti inter-familiari, muterà tutta l’organizzazione sociale, quando le sue possibilità di studio, di lavoro saranno uguali a quelle degli uomini, quando il ‘costo’ di una maternità non verrà addebitato al solo nucleo familiare ma diverrà un costo ‘sociale’, quando alloggi, servizi sociali ed assistenziali organizzati, toglieranno la donna dal ghetto delle quattro mura domestiche”. “La nuova legge sulla famiglia dà alle donne nuovi diritti”, ammetteva. “Ma la parità è ancora lontana”. Era il 1973. Da allora le leggi hanno riconosciuto alle donne italiane numerosi altri diritti, importantissimi. Ma molti dei problemi che Turone elencava restano drammaticamente attuali e la parità resta, anch’essa, ancora lontana.
Sul tema, nel sito, si cfr.:- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETÀ. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
DANTE, IL LETARGO DI SECOLI, E LA CRISI DELL’EUROPA - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944)?!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Galilei, Foucault, Einstein, e il terrapiattismo. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana.12 maggio 2019, di Federico La Sala
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana...*
- IL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ GALILEIANA, 1632. «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza (...)
 Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma. » (Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano, 1632 - Salviati, giornata II) *
Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere così: fate muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma. » (Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano, 1632 - Salviati, giornata II) *
Terrapiattisti in raduno a Palermo: “Sveleremo il grande inganno”
di LAURA ANELLO (La Stampa, 11.05.2019)
PALERMO Dicono che la terra è piatta, un disco che volteggia nello spazio. Sostengono che le immagini della Nasa sono farlocche, che lo sbarco sulla Luna è una bugia, che gli astronauti sono abili attori, che il Gps funziona perché le antenne sono poste in cima a misteriosi grattacieli sparsi per il mondo e persino che a protezione di questo “disco volante” su cui vive l’umanità ci sono montagne di ghiaccio color smeraldo alte quattrocento chilometri sorvegliate da guardiani millenari.
Eppure, domani, il raduno nazionale dei “terrapiattisti” - così si chiamano gli alfieri di questa teoria - convocato all’albergo Garibaldi di Palermo, ha attratto cento persone e pure l’interesse di Beppe Grillo, che aveva annunciato la sua presenza in nome del libero pensiero. “Voglio stare in mezzo a un po’ di cervelli che non scappano davanti a nulla, nessun pregiudizio, nessuna legge della fisica è definitiva”. In realtà non si è ancora iscritto (quota di partecipazione 20 euro, senza sconti per nessuno) e lo staff di Grillo ha fatto sapere che non verrà. Ma gli organizzatori non escludono che possa arrivare a sorpresa: “Se è interessato alle nostre teorie, lo inviterò a confrontarsi mezz’ora con noi”, dice Agostino Favari, uno dei relatori. Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio Molinari
Di sicuro, i terrapiattisti sono, per così dire, molto oltre il grillismo inteso come sfiducia nel sistema, nelle “competenze” e nelle verità della scienza ufficiale. Ne ha fatto le spese il povero astronauta Umberto Guidoni che, invitato da Le Iene a un confronto con due esponenti di spicco del terrapiattisti, alla fine si è fatto cadere le braccia di fronte a una contestazione da pochade: “Se il pollo si brucia in forno sotto la carta argentata, perché un astronauta dovrebbe resistere al calore del sole dentro la navicella”? Sì, perché la teoria della terra piatta (e quindi dell’assenza della curvatura terrestre) trascina via pezzo a pezzo secoli di acquisizioni e di dimostrazioni scientifiche, cancellando con una spugna Galileo, Einstein e pure Darwin. Non esisterebbe neanche la forza di gravità e sarebbe una fandonia l’evoluzione umana. I dinosauri? Roba da Disneyland. Le ossa che sono state ritrovate apparterebbero ai giganti che hanno popolato la terra prima di noi, e che hanno realizzato costruzioni a loro misura come - ebbene sì - il porticato di San Pietro e gli archi del duomo di Milano.
Per non dire, come i relatori sosterranno domani a congresso, che in realtà siamo nel 1019, perché il calendario è stato mistificato con l’aggiunta di mille anni di storia e che forse Titania, Lusitania e Queen Elisabeth erano la stessa nave. A parlare dal palco del raduno, oltre a Favari che in tasca ha una laurea in Ingegneria (“Ma non dirò nient’altro di quello che faccio nella vita”), saranno Albino Galuppini (una laurea in Scienze agrarie, di professione agricoltore), Calogero Greco e Morena Morlini.
Domenica 12 maggio illustreranno relazioni e risponderanno alle domande per otto ore (dalle 9 alle 19 con una pausa pranzo dalle 13 alle 14.30) su argomenti come la differenza di pressione tra l’atmosfera e lo spazio siderale, l’astronomia zetetica, il dimenticato impero dei giganti - quelli oscurati da Bernini e Michelangelo, forse figure d’invenzione anche loro - l’orbita del sole sulla terra piatta, l’egocentrismo della stella polare. E naturalmente, sul “rifiuto dell’informazione”. Che, ahinoi, ancora non crede in queste nuove verità. Come non ci crede il Comune di Palermo, che ha negato il patrocinio e diffidato gli organizzatori dall’utilizzare il logo istituzionale nonostante loro abbiamo invitato “tutte le persone rappresentative delle organizzazioni di potere, a partire dal presidente della Regione siciliana, il capo della polizia di Stato della Sicilia, dei carabinieri e delle guardia di finanza, aggiungendo doverosamente il capo del servizio segreto interno e del servizio segreto militare della Sicilia. E pure il cardinale. Oltre che gruppi filosofici buddisti, steineriani, amici di Osho, yoga”. L’obiettivo è svelare il grande abbaglio (“Quanti danni fa la scuola”), l’impostura, l’inganno, il complotto. Squarciare il velo da Truman Show che da millenni oscura il cielo degli umani. Un velo piatto, s’intende.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI: LA CONVERSAZIONE CONOSCITIVA (IL NUOVO "CIRCOLO ERMENEUTICO").
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
- IL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ GALILEIANA, 1632. «Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza (...)
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "Resa e cattura"("Surrender and Catch). Ha ben visto Arlene Goldbard, la proposta di Kurt H. Wolff un nuovo paradigma (Roberto Cipriani)9 maggio 2019, di Federico La Sala
Sé come un altro ovvero “resa e cattura”: la prospettiva di Kurt Wolff
di Roberto Cipriani *
Premessa
Quando Francesca Sacchetti (2012) ha investigato i “percorsi della soggettività tra fenomenologia ed ermeneutica” ha individuato un filone preciso di pensiero che da Husserl (1922, 1929, 1963) conduce a Schütz (1932) e poi a Paul Ricoeur (2002). Ma altrettanto si può dire per quanto riguarda il percorso da Husserl (1922, 1929, 1956, 1963, 1973) a Kurt Wolff (1972a, 1976, 1984, 1984a) come punto di arrivo e di consonanza con Ricoeur stesso, vista la comune matrice fenomenologica e la conoscenza che il sociologo della Brandeis University ha delle opere di Ricoeur (1967, 1970), come si evince dal suo saggio sul rapporto fra “resa e cattura” e fenomenologia (Wolff 1984).
Surrender and Catch: Experience and Inquiry Today (Wolff (1976) è un testo che denota una chiara influenza dovuta all’insegnamento di Karl Mannheim, maestro di Kurt Wolff negli anni Trenta. L’origine della formula “resa e cattura” ha evidenti radici classiche greche nell’idea di ἐποχή, che riguarda l’attesa, la sospensione, una sorta di scetticismo metodologico, ma poi anche nell’espressione latina assensionis retentio (rinvio della decisione). “Surrender and catch” è pure una sorta di “sociologia comprendente” che risale alla nota verstehende Soziologie di matrice tedesca, distinguendo fra “surrender” (resa generica) e “surrender to” (resa a qualcuno o qualcosa). Detto altrimenti non si tratta solo di una teoria ma anche di una metodologia.
La valenza qualitativa della resa e della cattura
Kurt Wolff ha dedicato ben quattro pubblicazioni alla sua inestricabile connessione fra “resa e cattura”. Il primo libro è del 1972 ed ha come titolo Surrender and Catch: A Palimpsest Story (Wolff 1972). Il secondo (Wolff 1976) è pubblicato come volume di una serie di filosofia della scienza. Il terzo (Wolff 1978) è una riedizione in brossura del precedente. Il quarto (Wolff 1995) è una ripresa del tema di “resa e cattura” a suggello di 23 anni di rielaborazioni dal 1972 al 1995, che hanno visto l’autore impegnato su più fronti disciplinari.
 Soprattutto gli articoli pubblicati su riviste insistono specificamente sulla tematica della resa declinata sotto diverse angolature: fenomenologica (Wolff 1972a, 1984), filosofica (Wolff 1979), conoscitiva (Wolff 1982, 1982a, 1983) ed ermeneutica (Wolff 1984a). Appare difficile individuare un possibile ambito al quale Kurt Wolff non abbia tentato di applicare il suo strumento teorico, rappresentato principalmente dalla disponibilità alla resa, all’avere fiducia nell’altro e nella sua alterità sostanziale (Wolff 1994). Ne consegue che il taglio principale della sua epistemologia e metodologia di fondo rimane appunto la rinunzia ad esprimere posizioni in prima persona, da ricercatore, fatta eccezione ovviamente per la scelta operativa iniziale, che in maniera precipua appare un’opzione dichiaratamente qualitativa (Corradi 1987). Il che è ampiamente documentato anche nei Kurt Wolff Papers, Robert D. Farber University Archives della Brandeis University di Waltham (Massachusetts), che contengono un box intitolato Surrender as a Response to Our Crisis, datato 1962 (Wolff 1962), ed un altro denominato Surrender and Catch, Hermeneutics, Phenomenology, Critical Theory, senza indicazione di data.
Soprattutto gli articoli pubblicati su riviste insistono specificamente sulla tematica della resa declinata sotto diverse angolature: fenomenologica (Wolff 1972a, 1984), filosofica (Wolff 1979), conoscitiva (Wolff 1982, 1982a, 1983) ed ermeneutica (Wolff 1984a). Appare difficile individuare un possibile ambito al quale Kurt Wolff non abbia tentato di applicare il suo strumento teorico, rappresentato principalmente dalla disponibilità alla resa, all’avere fiducia nell’altro e nella sua alterità sostanziale (Wolff 1994). Ne consegue che il taglio principale della sua epistemologia e metodologia di fondo rimane appunto la rinunzia ad esprimere posizioni in prima persona, da ricercatore, fatta eccezione ovviamente per la scelta operativa iniziale, che in maniera precipua appare un’opzione dichiaratamente qualitativa (Corradi 1987). Il che è ampiamente documentato anche nei Kurt Wolff Papers, Robert D. Farber University Archives della Brandeis University di Waltham (Massachusetts), che contengono un box intitolato Surrender as a Response to Our Crisis, datato 1962 (Wolff 1962), ed un altro denominato Surrender and Catch, Hermeneutics, Phenomenology, Critical Theory, senza indicazione di data.A ben considerare, tutta l’esistenza stessa di Kurt Wolff si muove lungo le coordinate della resa da una parte e della cattura dell’altra (Stehr 1981) e dunque la sua sociologia esistenziale è anche un volere la resa prima e la cattura poi ma proprio per sfuggire specularmente, a posizioni rovesciate dunque, al rischio della resa incondizionata al nemico ideologico e politico ed altresì della cattura, cioè della privazione di ogni libertà di pensiero ed azione. Tutto ciò si tramuta per Wolff in una scelta epistemologica e metodologica insieme che riflette da presso il suo stesso itinerario biografico: un continuo arrendersi ad ogni possibile forma di sapere per poi impossessarsene, fosse una lingua straniera, la storia, la filosofia, la poesia e non ultima la sociologia e di conseguenza il pensiero di Mannheim - di cui fu studente attento ed assiduo (Wolff 1991, 57-79) -, Simmel e Durkheim.
La definizione di resa
Wolff è uno studioso poliedrico e quindi anche le sue concettualizzazioni risentono di tale caratteristica. Inoltre il modello della resa è qualcosa che si sperimenta esistenzialmente in vari campi: dalla natura all’indagine empirica, dall’arte alla riflessione teoretica, dalla politica alla poesia, dalla filosofia alla storia ed alla sociologia.
Da un punto di vista strettamente metodologico i dati vanno accettati per quelli che sono, quasi un fatto naturale, scontato, cui affidarsi senza remore. In pari tempo occorre rinunciare a formulare ipotesi previe ed aspettative di qualunque genere. Anzi l’unica aspettativa ha da essere quella dell’attesa degli sviluppi in corso. L’alterità non si coglie a prima vista. Non si può pretendere di capire, “catturare” l’altro appena al primo incontro esplorativo. Altrimenti prevalgono le esperienze dello studioso rispetto a quelle dell’intervistato, il quale a sua volta si lascia catturare solo assai lentamente, comunque parzialmente, anzi molto parzialmente. Pertanto non è lecito e non conviene fare supposizioni sulla natura, sul profilo degli altri.
La cattura arriva ben dopo, allorquando si è instaurato un dialogo che permette la conoscenza e l’esperienza comune fra intervistatore ed intervistato, in una nuova prospettiva reciproca che appare come un nuovo inizio, un nuovo modo di essere nel mondo. Wolff, per completezza di discorso, arriva pure a dire che la cattura non è necessariamente un concetto, perché può essere ben altro: da un’opzione ad un’opera d’arte, da un cambiamento di atteggiamento ad un chiarimento, come pure un avvicinamento alla resa.
La relazione fra resa e cattura è quanto mai complessa, perché ha un andamento senza fine, senza limite alcuno. Invero, come riconosce lo stesso Wolff (1994a, 371), lo spunto iniziale proviene da una distinzione mannheimiana fra interpretazione ideologica ed interpretazione sociologica (Mannheim 1926), poi divenuta rispettivamente, in chiave wolffiana, interpretazione intrinseca, che cioè usa i termini propri di quanto deve essere interpretato senza fare alcun ricorso a risorse esterne, ed interpretazione estrinseca che si serve dell’ausilio di tutto il contesto storico-sociale.
Successivamente, nello sviluppo del pensiero di Wolff, sono diventati cinque gli aspetti della resa. Il primo concerne la massima sospensione della socializzazione ricevuta, facendo tutto il possibile per potere capire qualcuno o qualcosa, un po’ come avviene per uno studente che si cala al massimo nella disciplina che studia, trascurando gran parte di quanto già sa.
Il secondo aspetto riguarda il fatto che la comprensione anche di un’esperienza unica non può esaurire tutta l’esperienza, che dunque è ancora da acquisire.
Il terzo ambito attiene alla duplice verità: scientifica ed esistenziale. Quest’ultima è la verità della resa, che è in linea con l’esame rigoroso delle più importanti esperienze.
In relazione con la verità esistenziale c’è l’estasi come quarta componente della resa, al di fuori della vita di ogni giorno e con uno spirito che non è molto diverso da quello poetico, nel suo lasciarsi condurre oltre la realtà.
La quinta caratteristica della resa è infine il rispetto per il mistero, nella dialettica fra interminabilità dell’analisi e riconoscimento indefettibile del misterioso. Ne deriva una labilizzazione, cioè un indebolimento o persino una scomparsa di norme, principi, orientamenti o tradizioni, ormai labili appunto. Da qui la necessità di un nuovo inizio della ricerca di ciò in cui credere, dopo aver messo da parte il precedente patrimonio culturale. Ma non ci si può affidare ad un’indagine senza fine senza accettare al contempo l’idea di un’inesauribilità del mistero. E dunque la cattura non pone termine al processo conoscitivo ma anzi presuppone che essa conduca ad un’altra resa e così via. Insomma resa e cattura sono indissolubilmente congiunte fra loro.
Sullo sfondo di questo itinerario è operante il pensiero di Mannheim, emergente anche nell’idea del Sich-Haben, cioè del possedere se stessi, che si realizza nell’azione della resa, la quale si coniuga altresì con il perdere se stessi (è in fondo anche il sé come un altro di Ricoeur). Pertanto il possedersi ed il perdersi fanno parte di un unico e medesimo processo. In tal modo grazie all’esperienza fatta si possono stabilire norme.
Ha ben visto Arlene Goldbard (arlenegoldbard.com/2008/12/13/surrene-and-catch/) nel definire la proposta di Wolff un nuovo paradigma, opera di uno studioso che pratica quel che predica. A suo parere la resa è arte, innovazione, che mira alla comprensione ed all’integrazione. Ma soprattutto si tratta di un “amore cognitivo, che fa vedere, non rende ciechi”, secondo l’espressione di Wolff stesso, che a sua volta individua cinque elementi: 1) il coinvolgimento totale, per cui chi ama si sente tutt’uno con chi è destinatario/destinataria del suo amore, in una situazione del tutto simile a quella della resa, che comporta uno stato di tensione o comunque di concentrazione; 2) il superamento di quanto si è appreso in precedenza; 3) la pertinenza di ogni aspetto che giunga all’attenzione del ricercatore, per cui l’amante si interessa ad ogni cosa che riguardi il suo amato o la sua amante; 4) l’identificazione, per cui chi ama si perde nel suo amore ma per ritrovare se stesso; 5) il rischio di dover subire qualche effetto dannoso, in quanto chi procede alla resa desidera il cambiamento, non senza conseguenze a livello relazionale, intersoggettivo, nonché di stima, per cui insieme con la resa si devono affrontare anche offese di vario tipo.
Il ricorso alla resa è stressante e va controcorrente rispetto alle tradizioni ed alle convenzioni, gestite da chi detiene il potere di controllo su di esse. La resa è secondo Wolff (1977) l’esercizio più radicale della ragione umana. La ribellione è al servizio dell’amore per una società più umana. In fondo l’amore per la conoscenza è la prosecuzione della plurimillenaria azione della filosofia nel corso della storia.
- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- "Resa e cattura"("Surrender and Catch). Ha ben visto Arlene Goldbard, la proposta di Kurt H. Wolff un nuovo paradigma (Roberto Cipriani)9 maggio 2019, di Federico La Sala
Sé come un altro ovvero “resa e cattura”: la prospettiva di Kurt Wolff
di Roberto Cipriani *
- CONTINUAZIONE E FINE
Una metodologia per l’analisi qualitativa
L’esperienza della resa e della cattura è totalizzante anche nel senso di abbracciare più dimensioni, da quella filosofica a quella psicologica, da quella fenomenologica a quella esistenziale, dalla critica radicale all’esistenzialismo e non da ultimo alla metodologia essenzialmente qualitativa.
I materiali di riflessione offerti da Wolff sono molteplici e non tutti riproponibili nel campo dell’analisi sociologica, ma servono a fornire un’aura, un’atmosfera, un atteggiamento di fondo che diventa asse portante, chiave di volta dell’approccio conoscitivo. Nondimeno è possibile rintracciare spunti significativi, suggerimenti operativi, che poi possono rifluire nell’attività di ricerca come veri e propri strumenti d’indagine. Così per esempio la modalità di scrivere riflessioni sui materiali di ricerca non può non rappresentare un prodromo, un’anticipazione di quella che sarà poi una caratteristica dell’analisi qualitativa: scrivere memos sui dati della ricerca in maniera tale da farli diventare ulteriori oggetti di ricerca, veri e propri dati da considerare a pieno titolo come suscettibili di approfondimento. Anche la diaristica, com’è noto, rientra giustamente fra gli elementi abituali sottoponibili ad indagine ed anzi ne costituisce un riferimento spesso imprescindibile e piuttosto fertile di risultati, come mostra fra l’altro, in Italia, il successo dell’iniziativa di una raccolta archivistica appunto di diari, ad opera di Saverio Tutino prima e di Duccio Demetrio (1996) ora ad Anghiari, con la Libera Università dell’Autobiografia, ed a Pieve Santo Stefano, con la Fondazione Archivio Diaristico.
Anche lo studio delle lettere, della documentazione personale, rientra nel filone classico della sociologia qualitativa, a partire dal classico e fondativo lavoro di Thomas e Znaniecki (1918-1920) sul contadino polacco in Europa ed in America. Ma forse il rinvio più emblematico e ricco di convergenze va fatto alla linea metodologica ed allo stile di ricerca contenuti nella Grounded Theory di Glaser e Strauss (1967), in cui la resa nei confronti del dato è altrettanto assoluta come in Wolff.
A dire il vero il taglio degli scritti del Nostro è largamente filosofico, ma anche sociologico in modo non convenzionale. Anzi, in questa scelta di fondo, è da mettere in evidenza lo spirito con cui l’autore affronta la problematica della conoscenza dell’alterità intersoggettiva: egli si serve di una esposizione letteraria, retorica quasi, per addurre prove convincenti sulla praticabilità e sull’affidabilità della sua opzione primigenia: sospendere i giudizi previi, rinunciare alle basi ed ai principi culturali di riferimento, ma con l’obiettivo di riuscire meglio a capire l’altro ed il mondo sociale circostante.
Se anche Wolff non fornisse alcuna indicazione di metodo - il che evidentemente non è - tuttavia il suo messaggio è chiaro: occorre fare tabula rasa dell’abituale modo di procedere (e dei criteri che l’orientano), al fine di rendersi disponibili all’accoglienza di qualunque indicazione provenga dal terreno di ricerca, dalle persone e dalle cose, dalla natura e dall’ambiente, dalle relazioni sociali e dai fenomeni sociali. Peraltro anche la forma scelta da Wolff per entrare in comunicazione con i suoi lettori, come già con i suoi allievi, è tipicamente evocativa più che esplicativa, allusiva più che esplicita, esistenziale più che accademica, colloquiale più che regolativa, aperta più che dogmatica.
Se Peter Berger e Thomas Luckmann (1966) con il loro lavoro sulla costruzione sociale della realtà hanno analizzato in modo sistematico l’influenza dei processi di socializzazione, Kurt Wolff (1976) ne ha stigmatizzato il peso impediente rispetto ad una conoscenza adeguata della realtà sociale. Gli uni e l’altro apportano contributi ormai divenuti classici, ma senza che la considerazione prestata ai primi pregiudichi l’attenzione da rivolgere al secondo. Invero entrambe le prospettive risultano strategiche per ogni impostazione relativa ad una sociologia di tipo qualitativo. Tuttavia è necessario dosare sapientemente i riferimenti alle due correnti di pensiero al fine di trovare un giusto equilibrio tra formule parimenti valide ed accettabili. Ove ve ne fosse bisogno, basterebbe richiamare la circostanza, non secondaria, del rifarsi di tutti e tre al pensiero magistrale di Alfred Schütz (1962-1966, 1996), con la sua fenomenologia di base, segnatamente in riferimento al rapporto con quel che si presenta o meglio si dà come “appresentazione” (Appräsentation) allo studioso-ricercatore (Schütz 1932).
Per un verso Berger e Luckmann segnalano la tendenza a “pensare come il solito” e per un altro verso Wolff proprio a ciò vorrebbe che si rinunziasse, onde permettere una più ampia comprensione dell’alterità, specialmente attraverso l’esperienza della discussione in comune, non a caso tipica di un’altra opzione metodologica di matrice qualitativa, secondo l’approccio ermeneutico di Oevermann (1979). Insomma tutto torna, il circolo virtuoso di una certa tradizione sociologica mitteleuropea si riaffaccia di continuo ed offre risorse essenziali per l’analisi sociologica basata sulla dimensione qualitativa.
Si può dire che quando Wolff pensa ad un’altra persona mette in atto la sua resa alla cattura, in quanto egli parte dal presupposto che la comprensione si raggiunge in misura adeguata solo e se si prescinde almeno inizialmente (e per un po’ di tempo ancora e fino ad un certo punto) dal proprio quadro di riferimento. Però una volta raggiunta la meta della comprensione mediante la cattura questa è da ritenere solo un’ulteriore tappa lungo un percorso mai esaurito e mai esauribile, in quanto rimane sempre sullo sfondo l’imperscrutabilità del mistero.
Questo procedimento di resa è accompagnato da presso da una sorta di “amore cognitivo” che aiuta a superare le difficoltà iniziali della resa e permette di raggiungere la presa, la conoscenza, la comprensione, grazie a dei risultati che sono cognitivi ed esistenziali allo stesso tempo. In altre parole la resa è anche una conversione (che consente peraltro l’estasi), come pure una ribellione verso il passato e la tradizione, per guardare piuttosto al futuro, in chiave creativa ed acquisitiva di ulteriori saperi. Si potrebbe pure dire che si tratta di un’ingenuità necessaria e foriera di esiti imprevedibili. Il “perdersi” nella resa prelude alla salvezza nel momento della cattura, anche se poi è solo una tappa lungo un tragitto ancora lungo.
La resa ha un carattere quasi artistico e religioso, in vista di una procedura cognitiva fatta di amore ed attenzione all’altro. A poco a poco in modo maieutico si fanno venire fuori dall’esperienza i concetti utili per la comprensione (non si può non vedere in questo un processo che appartiene anche ad altre soluzioni metodologiche: la Grounded Theory di Glaser e Strauss come l’ermeneutica oggettiva di Oevermann). L’alternativa è costituita da risultati solo approssimativi e probabili, mentre la “pretesa” di Wolff è di raggiungere ciò che è ineluttabilmente vero, o almeno - a giudizio di altri studiosi - più affidabile di quanto verificabile attraverso la strumentazione classica dell’approccio solo statistico-quantitativo. Sullo sfondo, come obiettivo finale, c’è il desiderio di mutare lo status quo. Dunque la resa non è uno stare fermi ma un altro modo di agire.
Inoltre la distinzione fra offerta ed accettazione della situazione data è solo fittizia, in quanto essa è strumentale per capire la realtà sociale. In effetti la stessa distinzione operata è frutto di quanto avvenuto, del che ci si accorge in un momento posteriore rispetto all’evento in questione.
Il significato della cattura
Alcune anticipazioni sulla dialettica fra resa e presa (o cattura) si trovano sparse in pubblicazioni antecedenti il 1976. Specificamente è il volume dal titolo Trying Sociology (Wolff 1974b, 44-45) che prelude a quello che sarà il libro successivo (Wolff 1976) completamente dedicato al tema della resa e della cattura, quale sviluppo di una particolare concezione della sociologia mannheimiana della conoscenza.
Il termine speculare, rispetto a quello di resa, è cattura (Wolff 1976, 20). Innanzitutto è bene precisare che meglio sarebbe stato da parte di Wolff risalire all’origine latina precisa del termine “concetto”, il quale ha come base il verbo all’infinito cum capere, che letteralmente significa “prendere con”, “prendere insieme”, che esprime compiutamente il pensiero wolffiano in quanto allude direttamente ad una presa congiunta, insieme con l’interlocuzione, l’incontro, l’intervista; ma il cogliere è anche un raccogliere insieme, che può sottendere e sottintendere una messa insieme dei risultati ottenuti con l’opzione iniziale costituita dalla resa, vera e propria finestra sul mondo altro, sull’altrui punto di vista, sui diversi pensieri in atto nella realtà sociale. Il con-prendere è una specie di sintonia creata fra l’io ed il tu, fra due soggetti generalizzati messi l’uno dinanzi all’altro e rispondenti con le loro reazioni, percezioni, attitudini, repliche, deduzioni.
 La novità delle concezioni, appunto del cum capere continuo messo in moto dalla relazione interpersonale, giustifica ampiamente la decisione iniziale (ed un po’ iniziatica) della resa, dell’affidamento, dell’accoglienza gratuita, senza ricatti né economici, né affettivi o di altra natura. L’esito finale difficilmente non è seguito da un apprezzamento positivo del percorso seguito, nonostante la sua imprevedibilità di fondo e l’assenza di eventuali esperienze previe rassicuranti. Le previsioni non rientrano in questa prospettiva epistemologica e metodologica insieme, altrimenti molto risulterebbe tanto scontato quanto inconcludente, perché non farebbe altro che confermare il già noto, rendendolo ancora più refrattario ad ogni discorso di cambiamento, di trasformazione, di miglioramento dell’esistente.
La novità delle concezioni, appunto del cum capere continuo messo in moto dalla relazione interpersonale, giustifica ampiamente la decisione iniziale (ed un po’ iniziatica) della resa, dell’affidamento, dell’accoglienza gratuita, senza ricatti né economici, né affettivi o di altra natura. L’esito finale difficilmente non è seguito da un apprezzamento positivo del percorso seguito, nonostante la sua imprevedibilità di fondo e l’assenza di eventuali esperienze previe rassicuranti. Le previsioni non rientrano in questa prospettiva epistemologica e metodologica insieme, altrimenti molto risulterebbe tanto scontato quanto inconcludente, perché non farebbe altro che confermare il già noto, rendendolo ancora più refrattario ad ogni discorso di cambiamento, di trasformazione, di miglioramento dell’esistente.Conclusione
In fondo la stessa proposta wolffiana mira all’innovazione, alla rivolta di stampo camusiano, al superamento dello status quo. Il sottosopra che è provocato dall’inversione fra resa e cattura prelude ad una trasformazione della società stessa e comunque indica un’alternativa almeno metodologica rispetto ai canoni abituali della ricerca sociologica. Si tratta pure di un cambiamento di mentalità, che comporta l’abbandono delle concezioni pregresse. La coppia resa-cattura funge quasi da vento liberatore e purificatore, che fa cadere pregiudizi inveterati ed apre nuovi orizzonti, anche per quel che riguarda, ad esempio, le relazioni fra ebrei e musulmani. Il ricorso alla soluzione pacifica della resa e cattura potrebbe costituire, fra l’altro, un suggerimento di tipo politico. Così, in definitiva, la resa e la cattura wolffiane portano assai lontano, ben oltre il contesto fenomenologico di origine, comune anche a Paul Ricoeur.
* Cfr. Roberto Cipriani, “Sé come un altro ovvero ‘resa e cattura’: la prospettiva di Kurt Wolff”, in Busacchi, Costanzo (a cura), Paul Ricoeur et ‘les proches’. Vivere e raccontare il Novecento., Effatà Editrice, Cantalupa (Torino), 2016, pp. 269-82 (ripresa parziale - senza bibliografia).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- SOCRATE. Filosofi: scomodi e amanti del sapere (Donatella Di Cesare).29 aprile 2019, di Federico La Sala
Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.... *
Filosofi: scomodi e amanti del sapere
Un’attività che nasce dallo stupore, una passione inquieta per la quale nulla è scontato
di DONATELLA DI CESARE *
- Vasilij Kandinskij (1866-1944), «Composizione VI Z»(1913), conservato all’Ermitage di San Pietroburgo
Che valore ha oggi la filosofia? A quale compito saranno chiamati le filosofe e i filosofi nell’età del tecnocapitalismo e della governance neoliberale? La Regina delle scienze, rimasta sola, dopo il distacco definitivo delle scienze naturali, appare caduta in un grave discredito. E se la senatrice Liliana Segre richiama i politici allo studio della storia, è altrettanto giusto richiamarli allo studio della filosofia.
Il ritmo accelerato sembra bandire ogni riflessione considerata un gioco improduttivo, una fuga irresponsabile in sogni evanescenti. Così il vecchio pregiudizio contro la filosofia si è andato rafforzando. Urgono risposte rapide, soluzioni definitive agli innumerevoli problemi di un’epoca tanto complessa. A che pro la filosofia? A che cosa serve? Che cos’è?
Rispondere implica già accogliere una sfida subdola, accettando i presupposti impliciti nella domanda: cioè che la filosofia sia un mezzo utile a un fine. Eppure la sua inattualità, che la rende così attuale, sta proprio nel sottrarsi all’economia del profitto. In tal senso non servirà forse a nulla. Si potrebbe allora cancellarla con un colpo di spugna - il che poi vorrebbe dire rimuovere il cuore stesso della tradizione occidentale. Tuttavia la filosofia non è solo un patrimonio di testi. È molto di più. Chi non filosofa, senza dubbio vive, ma sminuita è la sua esistenza, compromessa la sua partecipazione alla politica.
- Il primo volume della collana sulla filosofia è dedicato a Socrate (qui la copertina)
Sin dai suoi esordi, nell’antica Grecia, la filosofia è stata chiamata a dimostrare il proprio diritto a esistere. Sennonché anche chi la contesta, chi ne mette in dubbio la legittimità, è già immerso nel movimento del pensiero, già filosofa. Ecco perché il ritornello sulla fine della filosofia è banale e vacuo. Certo nessuno immagina che possano ancora edificarsi quei sistemi che miravano a collegare tutto il sapere in un’immagine unitaria. L’impero hegeliano dello Spirito assoluto si è dissolto. Ma ciò non ha decretato la fine della riflessione. La filosofia non va e non viene, non finisce. Immanuel Kant parla di «attitudine naturale» dell’essere umano. Seppur inconsapevolmente, tutti filosofano. E già i bambini si interrogano sulla morte, sul futuro, sulla felicità. La filosofia non è una disciplina (sebbene sia stata in parte istituzionalizzata), non è un sapere specialistico, né un mestiere, né un’occupazione. Vaga qui e là, anche sulla pubblica piazza, in forme diverse; a volte sembra filosofia, e non lo è, altre volte non sembra, e invece lo è - i filosofi la riconoscono.
Si potrebbe dire con Heidegger che «filosofia è filosofare». Se solo alcuni hanno il particolare destino di risvegliare gli altri al pensiero, la filosofia, lungi dall’essere privilegio di pochi, tocca al fondo l’esistenza di ciascuno. Studiare i classici vuol dire anzitutto imparare a interrogarsi. Ciò che contraddistingue la filosofia è la domanda radicale, quella che va alle radici, che non chiede per sapere, ma che, anzi, mette in questione ogni sapere. Non vengono fornite soluzioni definitive. La filosofia non avrebbe altrimenti una storia dove, in forma sempre diversa, si ripropongono le questioni che la assillano: sulla verità, sul bene, sulla libertà. I problemi fondamentali della filosofia sono piuttosto aporie per cui non si danno soluzioni - né ottimali, né univoche, né definitive. Le risposte sono molteplici, le indicazioni differenti. Ecco perché i filosofi tornano ai testi di più di 2.000 anni fa - quelli di Eraclito, di Platone, di Aristotele - e li leggono come se fossero stati scritti ieri.
Sta qui una differenza decisiva rispetto alla scienza. Circoscritte a un ambito del sapere, le scienze non danno conto dei loro presupposti. Kant esorta a non confondere la filosofia con la matematica che, pure, è una costruzione concettuale. Ma già solo interrogandosi sullo statuto della matematica, la filosofia ne valica i limiti, va oltre l’ovvietà dei principi. Così ciò che per la scienza è fuori questione viene innalzato alla dignità della domanda filosofica.
Non c’è fenomeno che sfugga. Neppure il nulla. «Perché esiste qualcosa e non piuttosto il nulla?». Formulata da Leibniz, questa è la domanda esemplare della filosofia, che scaturisce dallo stupore, una passione inquieta. Ciò che per gli altri è ovvio, lampante, scontato, perde agli occhi del filosofo l’aura di solenne gravità che lo metterebbe al riparo dalla domanda. Tutto è esposto all’interrogare. Persino l’interrogante, il filosofo stesso, che viene così deposto dal suo pulpito.
D’altronde l’inizio aporetico della filosofia è il non-sapere di Socrate, che ha inaugurato la ricerca introspettiva, il «conosci te stesso». Stupore, ma anche struggimento e smania per l’irraggiungibile sophía.
LEGGI ANCHE
- L’ambizione d’insegnare a pensare. Socrate, coraggioso e antipatico di Mauro Bonazzi
- Il sapere è sempre un’ipotesi: scienza e filosofia lo hanno capito di Stefano Gattei
- La rivoluzione di Socrate: al centro l’essere umano di Luciano Canfora
Ed eccolo quel cittadino, così strambo e fuori-luogo, uno straniero in patria. Chi lo vede da lontano scappa; altri ostentano disprezzo, lo deridono. Socrate mette in dubbio le idee più correnti, non riconosce nessuna autorità, si fa beffe persino del démos sovrano. Soprattutto mostra ai propri concittadini che non sanno quel che pretendono di sapere. Che democrazia potrebbe mai essere la loro? Il risentimento è tale che si traduce nella condanna a morte di quel singolare cittadino che aveva osato, con il dialogo, fare dello stupore una pratica pubblica insinuando il dissenso già nell’anima altrui, prima ancora che nella comunità.
Da allora si è aperto un abisso tra la filosofia e la politica e la tensione non è mai venuta meno. In esilio nella città, quasi stranieri residenti, i filosofi hanno resistito per secoli e millenni, testimoni critici di una pólis altra e migliore. Così questi sublimi migranti del pensiero hanno saputo convertire la perdita irreparabile in una conquista a venire.
* Corriere della Sera, 28 aprile 2019 (ripresa parziale - senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
AGONISMO TRAGICO: LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE
-
FILOSOFIA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO
 MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
MA DOVE SONO I FILOSOFI ITALIANI OGGI?! POCO CORAGGIOSI A SERVIRSI DELLA PROPRIA INTELLIGENZA E A PENSARE BENE "DIO", "IO" E "L’ITALIA", CHI PIÙ CHI MENO, TUTTI VIVONO DENTRO LA PIÙ GRANDE BOLLA SPECULATIVA DELLA STORIA FILOSOFICA E POLITICA ITALIANA
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- NEL REGNO DI EDIPO: "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE" (E DELLA SUA "DIADE").20 aprile 2019, di Federico La Sala
NEL REGNO DI EDIPO: "L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE", L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO. Come nascono i bambini e le bambine... *
- AUTOCTONIA E MITO DI EDIPO: "[...] il mito di Edipo [...] esprimerebbe l’impossibilità in cui si trova una società, che professa di credere all’autoctonia dell’uomo (si veda ad esempio Pausania, VII, XXIX, 4: il vegetale è il modello dell’uomo), di passare da questa teoria al riconoscimento del fatto che ciascuno di noi è realmente nato dall’unione di un uomo e una donna. La difficoltà è insuperabile. Ma il mito di Edipo offre una specie di strumento logico che permette di gettare un ponte tra il problema iniziale - nasciamo da uno solo o da due? - e il problema derivato che si può approssimativamente formulare così: il medesimo nasce dal medesimo o dall’altro? [...] Il problema posto da Freud in termini «edipici» non è più probabilmente quello dell’alternativa fra autoctonia e riproduzione bisessuata. Ma si tratta pur sempre di capire come uno possa nasce da due: come avviene che non abbiamo un solo genitore, ma una madre e in più un padre?" (C. Lévi-Strauss, "Antropologia strutturale", Il Saggiatore, Milano 2015).
- "MITIDEOLOGIA": "[...] È il concetto di Autoctonia, antica e moderna, che ha occupato gli ultimi anni dell’antropologo (Essere autoctoni. Come denazionalizzare le storie nazionali, Sansoni 2004). Un problema politico che Heidegger aveva evitato attribuendo a “polis” la falsa etimologia di “essere”. Per Detienne non c’era autoctonia in Atene e in Roma, e il concetto è l’esempio d’una “mitideologia” impiegata nella costruzione dei nazionalismi passati e, purtroppo, presenti e futuri (Paolo Fabbri, "Marcel Detienne: memorie felici e concetti indelebili", Alfabeta-2, 31.03.2019).
Appello di una femminista alle donne cristiane che sono contro il Congresso mondiale delle famiglie
di Luisa Muraro (Libreria delle donne, 29 Marzo 2019)
Care amiche, vorrei sottoscrivere il vostro Appello contro il Congresso delle famiglie a Verona. Sono d’accordo con quello che dite, in primo luogo che la famiglia non è un’entità naturale ma un’istituzione culturale, che quasi sempre mostra una forte impronta patriarcale.
A me e a voi, suppongo, è chiaro che prima della famiglia, comunque intesa, c’è la diade formata da una donna e dalla creatura che lei ha concepito e portato al mondo. È un rapporto molto speciale, che precede i dualismi tipici della cultura maschile: la donna che accetta di entrare nella relazione materna, alla sua creatura dà la vita e insegna a parlare, le due cose insieme. Ed è un “insieme” che si tende, come un ponte insostituibile, sopra l’abisso della schizofrenia umana.
Vorrei ma non posso sottoscrivere il vostro Appello perché, nella difesa delle nuove forme familiari, non c’è una critica di quelle che si costituiscono da coppie che, sfortunatamente o naturalmente sterili, invece di adottare, si fanno fare la creatura a pagamento.
Da donne cristiane, mi aspettavo una calorosa difesa dell’adozione e un’energica richiesta della sua estensione a persone e coppie finora escluse dalla legge. Ma, ancor più, essendo voi donne, mi aspettavo una difesa della relazione materna libera e responsabile così come oggi è diventata possibile. Invece, parlate solo di genitorialità, usate cioè una parola tipica del linguaggio neutro-maschile. E a voi che parlate del corpo femminile come luogo di spiritualità incarnata, chiedo: che famiglia è mai quella che nasce con il programma esplicito, messo nero su bianco, di cancellare la relazione materna che si sviluppa con la gestazione in un intimo scambio biologico e affettivo?
Voi, a differenza di tanti cattolici, leggete la Bibbia e sapete che la cosiddetta gravidanza per altri, ossia la donna che partorisce senza diventare madre, corrisponde pari pari ad antiche usanze del patriarcato, usanze che sembravano superate. Le ultime pagine del Contratto sessuale di Carole Pateman, parlano proprio di questo sostanziale arretramento. Detto alla buona, ci sono “nuove” famiglie che di nuovo hanno solo la tecnologia.
A proposito: che cosa pensano di tutto questo gli uomini vicini a voi, i vostri compagni di fede e d’impegno politico? Perché non compaiono nel vostro Appello? Mi è venuto un sospetto, di ritrovarmi davanti a quel noto comportamento maschile che è di nascondersi dietro a una o più donne quando si vuol far passare pubblicamente qualcosa che è contro le donne. Devo portare degli esempi? Ma, se questo non fosse vero, scusatemi.
(www.libreriadelledonne.it, 28 marzo 2019)
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. COME NASCONO I BAMBINI? - E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?!
Cultura e civiltà. L’ordine simbolico della madre.....
 NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima"
NEL REGNO DI EDIPO. L’ordine simbolico di "mammasantissima""L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE": L’ALLEANZA CATTOLICO-"EDIPICA" DEL FIGLIO CON LA MADRE!!!
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff - e alla sua "resa" a Karl Mannheim ... - Ernst R. Curtius e la crisi dell’Europa.10 aprile 2019, di Federico La Sala
CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. A che gioco giochiamo?!
Una nota *
Nel 1929, in un breve saggio dedicato a "Hugo Hofmannsthal. In memoriam" (op. cit., pp. 165-176), Curtius scrive: "La regalità era la figurazione più interiore nel rapporto tra Hofmannsthal e il mondo. La funzione di poeta non era per lui che una delle forme in cui essa si manifestava [...] tutte le opere di Hofmannsthal tendono verso la forma ideale di un theatrum mundi, un poema cosmico allegorico-simbolico che eleva il caso dell’esistenza all’ordine delle grandi leggi, che nel temporale, fanno apparire l’eterno. L’allegoria non è qui indebolita ricchezza di vita e la maschera non è apparenza, al contrario, soltanto quando riusciamo a vedere la deformazione, la maschera della nostra esistenza, ne comprendiamo il senso e la verità più profonda".
E poco oltre, condividendo il programma e lo spirito della sua “rivoluzione conservatrice”, così prosegue : "La nostra poesia ha molto sentimento del mondo (Weltgefuhl), ma poco mondo: ha molte visioni del mondo (Weltanschauungen), ma mediocre ne è la sua conoscenza. In Goethe esisteva la possibilità di unire i due aspetti e ristabilire le giuste proporzioni. Ha dovuto condurre il suo Faust alla corte dell’imperatore: era anzi ancora legato all’impero e colorate feste d’incoronazione avevano illuminato la sua infanzia. Non ha sentito più battere il cuore dell’impero [...] L’orizzonte universale del vecchio impero asburgico era stato dato in eredità a Hofmannsthal. Vienna e Madrid non ne facevano meno parte [...]". E, così chiude: “Hofmannsthal ha raccolto nel suo tesoro reale, i beni più preziosi del linguaggio e dell’anima dei paesi latini: noi lo conserviamo come la sua eredità, come «munus Austriacum»”.
Nel 1932 fa il passo “decisivo”: pubblica “Deutscher Geist in Gefahr “ (“Lo spirito tedesco in pericolo”), un libro (una raccolta di articoli di quegli anni), e nella postfazione, confidando nella “metafisica dello spirito”, chiude con il richiamo al “Veni creator spiritus” - “l’inno del franco-renano Rabano Mauro” (“Mille anni più tardi un altro franco-renano, Goethe, ha tradotto questo “splendido canto religioso” e lo ha definito un “appello al genio”) - e con l’auspicio che “sotto questo segno la fede nella Germania e la fede nello spirito possono trovarsi legate e confermate” (cfr. Ernst R. Curtius, “Lo spirito tedesco in pericolo”, in Annamaria Bercini, “Il discorso politico culturale del «Deutscher Geist in Gefahr» di Ernst Robert Curtius”, Bologna 2015)
Le illusioni di Curtius di diventare una guida spirituale della “rivoluzione conservatrice” sono infondate e vengono spazzate via in un baleno: “Il 24 marzo del 1933, subito dopo l’ascesa al Reichstag di Hitler, sul Beiblatt del «Völkischer Beobachter», il giornale ufficiale del partito nazista sin dal 1920, comparve un durissimo articolo di Hermann Sauter (che di lì a qualche anno diverrà direttore della Stadtbibliothek di Monaco), Deutscher Geist in Gefahr? , che era in effetti una stroncatura senza appello del libro di Curtius. L’assenso di Curtius alla missione tedesca è, come si può vedere, in realtà una negazione del nuovo, potente volere tedesco. Ma questo è il nostro credo: che il vero spirito tedesco otterrà nuovamente onore, e sarà capace di avere valenza mondiale, quando sarà ripulito dal peso accumulato nella cosiddetta libertà spirituale del decennio passato. Sauter concludeva con quello che appare un vero avvertimento da mafioso. Curtius può avere ancora un ruolo importante nella nuova Germania, ma a patto di non tentare più di fare il Kulturpolitiker, perché non capisce nulla dei fondamenti autentici - cioè biologici - della cultura tedesca.” (cfr. Carlo Donà, “Lo spirito tedesco e la crisi della mezza età: «Deutscher Geist in Gefahr» (1932)” ).
Dopo la catastrofe della Germania del “Terzo Reich”, Curtius ancora non capisce: continua il suo “sogno” calderonico e la “vacanza” nel suo “illuminato” (contro e) pre-illuministico “stato di minorità” (I. Kant, 1784). E nel 1947, come se niente fosse successo, alla fine del primo capitolo di “Letteratura europea Medio Evo latino”, intitolato “Letteratura europea”, con un “occhiolino” a Benedetto Croce (e alla memoria di Hegel), riprende il lavoro per il “nuovo ordine culturale”, già proposto nel “Deutscher Geist in Gefahr” del 1932, e ricomincia: “Della letteratura europea l’eroe fondatore (heros ktistes) è Omero, l’ultimo autore universale è Goethe. Ciò che questi rappresenta per la Germania lo ha riassunto Hofmannsthal [...] La letteratura del secolo XIX e dell’inizio del XX non è stata ancora scandagliata, in essa non è stato ancora distinto ciò che è vivo e ciò che è morto. Ciò potrà dare materia per molte dissertazioni, la parola decisiva sarà però pronunciata non dalla storia della letteratura, ma dalla critica letteraria. Per questo compito noi, in Germania, abbiamo Friedrich Schlegel - e seguaci” (op. cit., p. 24)!
Purtroppo, per Curtius, che è vissuto e cresciuto all’interno di coordinate storico-culturali da Sacro Impero (romano, spagnolo, e germanico), e nelle cui orecchie risuona ancora l’ordine dato a Maria Antonietta dalla Madre-Imperatrice (“Rimanete un buon tedesco!”), “la vita è sogno” e non c’e alcuna possibilità di riconsiderare critica-mente né il lavoro di Ernst H. Kantorowicz (anch’egli vicino al “cerchio” di Stefan George) sulla figura dell’Imperatore Federico II (1927/1931), né tantomeno “l’autunno del Medio Evo”, il “declino del simbolismo” e la lezione su Dante di Johan Huizinga ("L’autunno del Medio Evo" [1919, 1921, 1928]): “[...] per indicare il rapporto fra l’autorità spirituale e quella temporale il Medioevo si serviva costantemente di due similitudini simboliche [...] La forza del simbolo è tale da intralciare l’indagine sullo sviluppo storico dei due poteri. Dante, avendo riconosciuto la necessità e il valore decisivo di tale indagine, si vede costretto, nel suo Monarchia, a spezzare prima la forza del simbolo, contestando la sua applicabilità, ed aprendosi così la strada alla ricerca storica".
La totale incomprensione del “relazionismo” proposto di Karl Mannheim in “Ideologia e Utopia” (1929), esaminato e rigettato nel capitolo quarto dello “Spirito tedesco in pericolo”, impedisce a Curtius di aprire gli occhi su stesso e sul mondo, di uscire dal relativismo-assolutismo dogmatico in cui naviga, e di smetterla di sognare il “sogno dei visionari” (sul tema, mi sia lecito, cfr.: “Heidegger, Kant, e la miseria della filosofia - oggi”).
“Sogno o son desto?”: a che gioco si continua a giocare? Non è meglio cambiare gioco!? Per l’Europa - e per l’intero Pianeta? Boh? e bah!?
*
- Riprendo qui una nota allegata all’articolo di Paolo Fabbri, "Marcel Detienne: memorie felici e concetti indelebili", apparso su "Alfabeta-2", 31.03.2019).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA (di Cesare Beccaria).30 marzo 2019, di Federico La Sala
DELLO SPIRITO DI FAMIGLIA. Il cap. XXVI del "DEI DELITTI E DELLE PENE"
di Cesare Beccaria*
Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche piú illuminati, ed esercitate dalle repubbliche piú libere, per aver considerato piuttosto la società come un’unione di famiglie che come un’unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l’associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l’associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e nessuno schiavo.
 Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sonol’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; ei di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza.
Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sonol’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; ei di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza.
 Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a’ piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avezzi a piegare e da temere nell’età piú verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtú nella lan-guida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a’ piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avezzi a piegare e da temere nell’età piú verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtú nella lan-guida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
 Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l’età gli trae dalla dipendenza di natura, cheè quella della debolezza e del bisogno di educazione e didifesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società.
Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l’età gli trae dalla dipendenza di natura, cheè quella della debolezza e del bisogno di educazione e didifesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società.
 Nel primo caso i figli, cioè la piú gran parte e la piú utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano,quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi. Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell’animo di ciascun uomo.
Nel primo caso i figli, cioè la piú gran parte e la piú utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano,quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi. Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell’animo di ciascun uomo.
 La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il bene d’alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l’azione. Tali contrasti fanno chegli uomini si sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall’oscurità degli oggetti sí fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto!
La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il bene d’alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l’azione. Tali contrasti fanno chegli uomini si sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall’oscurità degli oggetti sí fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto!
 A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene piú piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de’ quali crescendo, l’economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo l’una e l’altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.
A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene piú piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de’ quali crescendo, l’economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo l’una e l’altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.
 Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d’edificare quant’egli n’ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt’i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de’ suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell’autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano,e però sotto il dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le virtú sempre mediocri di famiglia sono le piú comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei legislatori.
Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d’edificare quant’egli n’ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt’i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de’ suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell’autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano,e però sotto il dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le virtú sempre mediocri di famiglia sono le piú comuni o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei legislatori.* Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Letteratura italiana Einaudi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". Dalla democrazia della "volontà generale" alla democrazia della "volontà di genere". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA: LA LUNA (“LA SCIANA”), IL DESIDERIO (“LU SPILU”), E IL FILO DI ARACNE.12 marzo 2019, di Federico La Sala
MITO, FILOSOFIA, E TESSITURA...
LA LUNA (“LA SCIANA”), IL DESIDERIO (“LU SPILU”), E IL FILO DI ARACNE.
Quanti millenari pregiudizi ... *
CONSIDERATO CHE “SCIANA”, sinonimo di “umore”, «è in uso in locuzioni del tipo “osce sto ti sciana” (oggi “sto di umore giusto”, ho voglia di fare) ma anche in unione all’aggettivo che ne definisce esplicitamente il valore positivo (“sto ti bona sciana”) o negativo (“sto ti malesciana”). Il derivato “scianaru” (prevalentemente e, come dirò, non a caso, usato al femminile “scianara”) come sinonimo di “volubile” [...]» (cfr. Armando Polito, “Dialetti salentini: sciàna”, Fondazione Terra d’Otranto, 10.03.2019); E CHE “SCIANA” è «deformazione dell’italiano “Diana”, dea della luna e della prima luce del mattino oltre che della caccia, dal latino “Diàna(m)”, da dius=divino, connesso con dies=giorno e con Iùppiter=Giove [da Iovis=Giove (a sua volta dal greco Zeus/Diòs)+pater=padre]» (cfr. Armando Polito, “Lu spilu e la sciàna”, Fondazione Terra d’Otranto, 16.12.2011).
E’ BENE RICORDARE CHE «Diana, com’è noto era gemella di Apollo, entrambi figli di Zeus e Latona ...» (op. cit.).
MILLENARI PREGIUDIZI. Per non scivolare nel “terreno viscido” e perdersi nell’aria nebulosa di ingegnosi labirinti e, al contempo, riuscire a districarsi tra millenarie “incrostazioni irrazionali” , forse, è opportuno tenere ben aperti gli occhi dinanzi ai bagliori emessi “dalla rete dell’oro” del SOLE dell’OLIMPO (“Dalla rete dell’oro pendono - così epigrammaticamente Salvatore Quasimodo - ragni ripugnanti”). e riguardare con attenzione gli ARAZZI tessuti da Atena, da Aracne, e da Filomela (cfr. Ovidio, “Metamorfosi”: La tela di Aracne apre il libro sesto, la storia di Filomela lo chiude ... Prima che la dea adirata Atena (Minerva) stracci la stoffa tessuta da Aracne, la tessitrice, donna mortale, racconta su di essa una storia molto particolare).
FORSE solo così si potrà uscire dal labirinto, senza perdere il filo, senza abbandonare Arianna, e tornare ad Atene con le vele bianche - non nere!
*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- IL CREDO DI UNA DONNA. IL MIO DECALOGO CONTRO OGNI FORMA DI POTERE (Robin Morgan).10 marzo 2019, di Federico La SalaIL MIO DECALOGO CONTRO OGNI FORMA DI POTERE. Noi, esseri umani e donne, siamo la maggioranza della specie, ma abbiamo abitato nell’ombra. Noi le invisibili, le analfabete, le sfruttate, le profughe, le povere. E noi votiamo: mai più. Sospese sull’orlo del nuovo millennio, abbiamo alle spalle la rovina, davanti nessuna mappa, il sapore della paura acuto sulle nostre lingue.
 Eppure faremo il salto.
Noi siamo la continuità, intessiamo il futuro col passato, la logica con la poesia. Noi siamo le donne la cui anima nessuna gabbia fondamentalista può contenere. Noi siamo le donne che rifiutano di permettere che si semini morte nei nostri giardini, nell’ aria, nei fiumi, nei mari. Siamo stanche di enumerare le nostre sofferenze. Abbiamo fame d’ azione, dignità, gioia. Intendiamo fare di meglio che resistere e sopravvivere. Hanno tentato di negarci, definirci, piegarci, denunciarci. Ci hanno ridotte in schiavitù, esiliate, picchiate, stuprate, seppellite - e ci hanno annoiato. Noi siamo la bambina dello Zambia, la nonna della Birmania, le donne del Salvador e dell’ Afghanistan, della Finlandia...
Eppure faremo il salto.
Noi siamo la continuità, intessiamo il futuro col passato, la logica con la poesia. Noi siamo le donne la cui anima nessuna gabbia fondamentalista può contenere. Noi siamo le donne che rifiutano di permettere che si semini morte nei nostri giardini, nell’ aria, nei fiumi, nei mari. Siamo stanche di enumerare le nostre sofferenze. Abbiamo fame d’ azione, dignità, gioia. Intendiamo fare di meglio che resistere e sopravvivere. Hanno tentato di negarci, definirci, piegarci, denunciarci. Ci hanno ridotte in schiavitù, esiliate, picchiate, stuprate, seppellite - e ci hanno annoiato. Noi siamo la bambina dello Zambia, la nonna della Birmania, le donne del Salvador e dell’ Afghanistan, della Finlandia...
 (da ’Credo di una donna’ scritto da Robin Morgan con sette femministe di vari paesi’ -
(da ’Credo di una donna’ scritto da Robin Morgan con sette femministe di vari paesi’ -
 Laura Lilli, "Femministe europee siete arroganti", la Repubblica, 17.09.1996).
Laura Lilli, "Femministe europee siete arroganti", la Repubblica, 17.09.1996).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- 8 MARZO 2019: "IL GRADO DI CIVILTA’ CUI L’UOMO E’ GIUNTO" (K. MARX).8 marzo 2019, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. 8 MARZO 2019: IL GRADO DI CIVILTA’ CUI L’UOMO E’ GIUNTO .... *
"[...] Nel rapporto con la donna, in quanto essa è la preda e la serva del piacere della comunità, si esprime l’infinita degradazione in cui vive l’uomo per se stesso: infatti il segreto di questo rapporto ha la sua espressione inequivocabile, decisa, manifesta, scoperta, nel rapporto del maschio con la femmina e nel modo in cui viene inteso il rapporto immediato e naturale della specie.
Il rapporto immediato, naturale, necessario dell’uomo con l’uomo è il rapporto del maschio con la femmina. In questo rapporto naturale della specie il rapporto dell’uomo con la natura è immediatamente il rapporto dell’uomo con l’uomo, allo stesso modo che il rapporto con l’uomo è immediatamente il rapporto dell’uomo con la natura, cioè la sua propria determinazione naturale.
Cosi in questo rapporto appare in modo sensibile, cioè ridotto ad un fatto d’intuizione, sino a qual punto per l’uomo l’essenza umana sia diventata natura o la natura sia diventata l’essenza umana dell’uomo.
In base a questo rapporto si può dunque giudicare interamente il grado di civiltà cui l’uomo è giunto. Dal carattere di questo rapporto si ricava sino a qual punto l’uomo come essere appartenente ad una specie si sia fatto uomo, e si sia compreso come uomo; il rapporto del maschio con la femmina è il più naturale dei rapporti che abbiano luogo tra uomo e uomo.
In esso si mostra sino a che punto il comportamento naturale dell’uomo sia diventato umano oppure sino a che punto l’essenza umana sia diventata per lui essenza naturale, e la sua natura umana sia diventata per lui natura. In questo rapporto si mostra ancora sino a che punto il bisogno dell’uomo sia diventato bisogno umano, e dunque sino a che punto l’altro uomo in quanto uomo sia diventato per lui un bisogno, ed egli nella sua esistenza più individuale sia ad un tempo comunità [...]".
* K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844. Sul tema, si cfr.: CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- #LOTTOMARZO 2019. Preparativi per la prima passeggiata spaziale della storia completamente al femminile (Ansa).8 marzo 2019, di Federico La Sala
8 marzo, verso la prima passeggiata spaziale di sole donne
Protagoniste due astronaute e una donna controllore di volo
di Redazione ANSA *
- FOTO Sullo sfondo la passeggiata spaziale dell’astronauta della Nasa Sunita Williams; nei riquadri le protaginste della prima passeggiata spaziale al femminile: Anne McClain, a sinistra, e Christina Koch (fonte: NASA, Beth Weissinger) © Ansa
La giornata della donna quest’anno ha un sapore particolare sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) perché fervono i preparativi per la prima passeggiata spaziale della storia completamente al femminile: programmata per venerdì 29 marzo, avrà come protagoniste due astronaute della Nasa, Anne McClain e Christina Koch, che usciranno dalla Stazione spaziale per circa sette ore supportate da Terra da Kristen Facciol, controllore di volo donna dell’agenzia spaziale canadese Csa, pronta a seguire le operazioni dal Johnson Space Center della Nasa a Houston. Lo ha rivelato lei stessa con un tweet.
- [Foto] L’astronauta Christina Koch, della Nasa (fonte: NASA/Beth Weissinger)
"Ho appena scoperto che sarò alla console per dare supporto alla prima passeggiata spaziale tutta al femminile con @AstroAnnimal e @Astro_Christina e non posso trattenere la mia eccitazione!!!!", ha scritto ai suoi follower.
- [Foto] Kristen Facciol, dell’agenzia spaziale canadese Csa (fonte: CSA)
La prima attività extraveicolare (Eva) di sole donne cadrà a quasi 35 anni di distanza dalla prima passeggiata spaziale al femminile: fu compiuta il 25 luglio 1984 dalla russa Svetlana Savitskaya, uscita dalla stazione spaziale sovietica Salyut 7 per tre ore e 35 minuti. Da allora diverse donne hanno camminato nello spazio, compresa l’astronauta dei record Peggy Wilson, che nella sua lunga carriera ha condotto ben dieci Eva.
- [Foto] L’astronauta Anne McClain, della Nasa (fonte: NASA)
Entrambe le sue ’eredi’, McClain e Koch, arrivano dalla classe di candidati astronauti selezionata dalla Nasa nel 2013 e composta per metà proprio da donne. McClain è già a bordo della Iss da dicembre per la spedizione 58, mentre la collega Koch arriverà il 14 marzo.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- IL "DIO DI AMORE" DI OVIDIO E BRUNETTO LATINI E "L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" DI DANTE.20 febbraio 2019, di Federico La Sala
IL "DIO DI AMORE" DI (OVIDIO E) BRUNETTO LATINI E "L’AMORE CHE MUOVE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" DI DANTE.... *
Su Brunetto Latini, “Poesie”, a cura di Stefano Carrai
di Claudio Giunta (Domenicale del Sole 24 ore, 20 marzo 2016)
- Brunetto Latini, Poesie, a cura di Stefano Carrai, Torino, Einaudi 2016, euro 15.
Il Tesoretto di Brunetto Latini non è certamente quel misconosciuto «capolavoro della letteratura allegorica» che diceva Jauss (ma come mai lo abbiamo preso sul serio?), ma è un modo eccellente per avvicinarsi alla poesia dei primi secoli; e questa nuova edizione a cura di Stefano Carrai è un modo eccellente per avvicinarsi al Tesoretto.
Si tratta di un poemetto, 2944 versi in tutto, scritto da Brunetto Latini al principio degli anni Settanta del Duecento. È uno strano ibrido. Comincia come un racconto di viaggio (il poeta-protagonista si trova a Roncisvalle, e qui incontra uno studente bolognese che gli comunica la sconfitta dei guelfi a Montaperti), prosegue come un trattato didascalico (la Natura personificata illustra al poeta l’ordinamento del cielo e della terra), poi come un trattato morale (il poeta incontra in successione le virtù, il dio d’Amore, il poeta Ovidio), e finisce con una bizzarra ‘Penitenza’, circa 500 versi in cui Brunetto riflette sulla caducità delle cose umane ed esorta un amico a cambiare vita come lui l’ha cambiata («che sai che sén tenuti», scrive, «un poco mondanetti»); dopodiché il racconto riprende e il protagonista si trova sul monte Olimpo, dove incontra il grande Tolomeo, «maestro di storlomia». Qui il testo s’interrompe di colpo.
Al di là però del contenuto, né originale né profondo, e al di là dello stile, senza veneri (anche perché imprigionato in una gabbia metrica da filastrocca: coppie di settenari a rima baciata), il Tesoretto è un testo interessantissimo perché è davvero un repertorio di topoi immaginativi, un campione di medievalità: c’è il viaggio nella foresta, c’è un mondo fantastico all’interno del quale il personaggio-poeta può dialogare via via con la Natura, con Ovidio o con Tolomeo, ci sono le ipostasi delle virtù e delle percezioni, che pescano dall’identico immaginario da cui hanno pescato gli sceneggiatori di Inside Out (Desianza=Joy, Paura=Fear): «Desïanza ... sforza malamente / d’aver presentemente / la cosa disïata / ed è sì disvïata / che non cura d’onore / né morte né romore, / se non che la Paura / la tira ciascun’ora, / sì che non osa gire / né solo un motto dire».
Il commento di Carrai è un commento esatto e intelligente. Sembra poco, ma è tantissimo, perché i commenti alla poesia (e soprattutto alla poesia antica) sono spesso un po’ stupidi. Chi ha studiato per anni un autore o un testo non si rassegna facilmente a farsi da parte, cioè a tacere una volta chiarito ciò che nel testo c’è da chiarire, ed eventualmente a far riflettere il lettore su ciò che il testo può dire sul suo autore o sulla mentalità dell’epoca in cui venne scritto: non si rassegna, gli viene, come diceva il dottor Johnson, «la fregola di dire qualcosa anche quando non c’è nulla da dire», o peggio - e la cosa è specialmente frequente nel campo della medievistica - gli viene la fregola di trovare verità nascoste, di sciogliere gli enigmi, il che porta spesso a postulare enigmi là dove non ce ne sono, onde una ridda di ipotesi e contro-ipotesi da stancare un causidico. E poi, a riempire le pagine, valanghe di ‘riscontri intertestuali’, come se importasse qualcosa che il poeta X ha preso quella parola dal poeta Y o dal poeta Z. Carrai invece non scaraventa sul lettore tutto il contenuto delle sue schede, spiega il testo dove occorre, e dove non riesce a spiegare prospetta delle ipotesi d’interpretazione, appoggiandosi - per consentire o per dissentire - a chi del Tesoretto si è occupato prima di lui.
Al Tesoretto Carrai fa seguire, com’è consuetudine, il Favolello, che è un altro breve poemetto in settenari baciati, più pedestre nel contenuto (è uno scialbo trattatello sull’amicizia), ma interessante soprattutto perché cita come amici-destinatari due rimatori contemporanei, Rustico Filippi e Palamidesse di Bellindote. E al Favolello segue, nel volume (che appunto per questo s’intitola Poesie: è l’opera omnia in volgare italiano di Brunetto), l’unica canzone di Brunetto che ci venga tramandata dai manoscritti, S’eo son distretto, strana poesia d’amore e devozione che alcuni hanno interpretato come un documento dell’omosessualità dell’autore (con ovvi riflessi sull’interpretazione di Inferno XV) e altri, direi più plausibilmente, come canto nostalgico per la patria, Firenze, dal quale il guelfo Brunetto viene bandito dopo Montaperti.
Manca, e avrebbe invece dovuto esserci, la canzone responsiva di Bondie Dietaiuti (così, nel Medioevo, si dissolvevano le tenzoni poetiche: gli scribi copiavano i corpora personali degli autori obliterando i testi missivi e responsivi dei loro corrispondenti, che in questo modo si disperdevano; ma in un’edizione moderna non si vede perché le tenzoni non debbano essere date nella loro integrità).
Il discorso sul Tesoretto e sul Favolello non è chiuso. Sono testi facili solo all’apparenza, specie a causa delle contorsioni che il metro e lo schema delle rime impongono all’autore. Di certi hapax resta poco chiaro, nonostante lo sforzo degli interpreti, il significato. Altri termini sono ambigui (per esempio non parafraserei con ‘verità’, con Contini e Carrai, il drittura di Favolello 7 «e fàllati drittura»: ‘giustizia’, che è il senso che drittura ha usualmente, mi pare più aderente al contesto). E certi passi dovranno forse essere riconsiderati in una futura edizione critica. Per esempio, ai vv. 1275-79 tutti gli editori postulano un (credo inattestato altrove) ablativo assoluto: «E vidi ne la corte, / là dentro, fra le porte, / quattro donne reali / che corte principali / tenean ragione ed uso». Dove «corte principali» vorrebbe dire ‘nella prima corte’. Ma dato che le «donne» di cui si parla sono virtù, e che principales è l’aggettivo che nel Medioevo spesso si predica delle virtù, in genere le cardinali, ci si deve domandare se la lezione corretta non sia piuttosto, con minimo emendamento, «come principali», cioè ‘come signore, regine di quella corte di giustizia’ (e sarebbe un altro errore d’archetipo, da aggiungere a quelli registrati da Pozzi e Contini nei Poeti del Duecento).
Forse potremmo chiudere, invece, il discorso sui rapporti tra Brunetto e Dante, salvo che non saltino fuori nuovi testi che permettano di riconsiderare sotto nuova luce la questione. Questione che è nota ad ogni studente liceale: Dante mette Brunetto all’Inferno, tra i sodomiti, ma non dice nulla della sua colpa (il che sorprende fino a un certo punto, dato che non sempre Dante lo fa), né di questa colpa si parla nelle fonti che non dipendono da Dante (il che non sorprende per niente: ci si aspetta che l’omicidio o la simonia lascino traccia nelle cronache, non necessariamente le inclinazioni sessuali).
Sodomia va allora inteso figuratamente, come ‘peccato contro la propria lingua materna’ (perché Brunetto, fiorentino, ha scritto il suo Tresor in francese)? Oppure come peccato politico (perché Brunetto non avrebbe «riconosciuto la sacra autorità dell’Impero»)? Mi sembra che la soluzione proposta da Zanato e ora da Carrai resti la più sensata: dato che Brunetto ci appare in compagnia di «Prisciano, Francesco Accursio e Andrea de’ Mozzi, [cioè] del gruppo di intellettuali, perlopiù pedagoghi ed ecclesiastici, che si sono resi colpevoli di pratiche omosessuali», non c’è ragione di pensare che lui non si sia macchiato dello stesso - non metaforico - peccato.
Non andrei oltre; né speculerei, per le ragioni che ho già accennato, sulla ‘memoria’ della poesia brunettiana nel canto XV. Il poeta Brunetto non aveva niente da insegnare a Dante, perché il peggior Dante (per esempio quello un po’ lezioso di Inferno IV: «Venimmo al piè d’un nobile castello, / sette volte cerchiato d’alte mura, / difeso intorno d’un bel fiumicello...») è migliore del migliore Brunetto. E l’idea che quando Dante mette in scena un altro poeta si serva - attraverso accorte allusioni - delle parole che quel poeta ha adoperato nelle sue opere mi sembra davvero un’idea tutta nostra, un’idea da filologi moderni, che mettiamo a forza nella testa di scrittori molto meno sottili di noi.
E questo vale anche per la testimonianza che molti (anche Carrai) considerano più probante: l’avvio del canto XV, «Ora cen porta l’un de’ duri margini...», nel quale si condenserebbero «gli echi di mosse identiche del Tesoretto, vv. 1183-84 “Or va mastro Burnetto / per un sentiero stretto”, e 2181-82 “Or si ne va il maestro / per lo camino a destro”». Ma direi di no: è una formula di transizione che si trova molte volte nella poesia narrativa francese, per esempio nel Girart de Rossillon («Ere s’en vait Girarz egal solel / per un estreit sender...» (l’identica immagine del sentiero stretto che si trova in Brunetto Latini), nella chanson de toile Gaiete et Oriour («Or s’an vat Oriour stinte et marrie»), nel Macaire franco-veneto, «Ora se voit sor un corant destrer». Langue, insomma, non parole, come nella poesia medievale capita non dico sempre, ma quasi.
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DEI "DUE SOLI". DANTE "corre" fortissimo, supera i secoli, e oltrepassa HEGEL.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- TRE ARAZZI E LA "POLITICA" DELLA "TESSITURA". "The Voice of the Shuttle is Ours" (Patricia Klindienst).16 febbraio 2019, di Federico La Sala
ARACNE, FILOMELA, E TRE ARAZZI. Arte e resistenza: ascoltare la voce della spoletta ... *
- Il testo (Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, libro VI):
- Il commento (Patricia Klindienst, "The Voice of the Shuttle is Ours")
__________________________________________________________________________
Tessere come smascheramento: disfare la violenza dello stupro
- [...]
La tela di Aracne apre il libro sesto delle Metamorfosi, la storia di Filomela lo chiude.
Per entrambe queste donne, tessere rappresenta lo smascheramento dei "misteri sacri" e il disfare la violenza dello stupro. Prima che la dea adirata Atena (Minerva) stracci la stoffa tessuta da Aracne, la tessitrice, donna mortale, racconta su di essa una storia molto particolare: quella delle donne stuprate da dèi che si mutano in bestie. Prima dell’intervento della dea gelosa, Aracne è il centro di una comunità femminile.
Insuperabile nella sua arte, Aracne è così piena di grazia che donne da ogni luogo vengono da lei per vederla cardare, filare, tessere. Attorno a lei si radunano altre donne che guardano, parlano, lavorano, riposano. Qui il telaio rappresenta un’occasione per creare comunità e pace, un contesto in cui è possibile, per il piacere, essere non violento e non possessivo.
In questo Aracne ricorda Saffo, che pure era il centro di una comunità di donne e a cui similmente Ovidio riserva un vicolo cieco, adottando la tradizione che tenta di sminuire la poetessa facendola morire suicida poiché respinta da un uomo. Ciò che sopravvive del lavoro di Saffo e gli studi successivi respingono come falsa questa ipotesi.
E’ solo facendo uno sforzo di interpretazione che noi oggi possiamo suggerire che Aracne, la donna artista, non si impiccò come ci racconta la storia, ma fu linciata. Il suicidio è un surrogato dell’omicidio. Aracne è distrutta dal suo stesso strumento quando esso è nelle mani della dea irata.
Ma chi è Atena? Non realmente femmina, giacché emerge, priva di madre, dalla testa del padre, una fantasia maschile che si fa carne, che strangola la voce delle donne reali. Lei è la figlia vergine il cui scudo è la testa di un’altra vittima donna, Medusa. Atena è la pseudo-donna che racconta la storia del giusto ordine.
Centrali, nel suo arazzo, sono gli dei in tutta la loro gloria, ma ai quattro angoli della tela, all’interno del bordo di rami d’olivo, Atena tesse un ammonimento alla donna artista, affinché essa non resista all’autorità ed alla gerarchia: in colori brillanti, quattro figure dicono "Pericolo!".
L’errore di Aracne è solo apparentemente l’orgoglio per la propria arte (che è pienamente giustificato: Aracne vince la gara); in verità, lei è in pericolo perché racconta una storia pericolosa. Fra le donne rappresentate nel suo arazzo c’è la stessa Medusa.
Raccontare lo stupro di Medusa da parte di Poseidone è suggerire ciò che può nascondere il mito per cui la donna muta gli uomini in pietra. Il luogo del crimine era l’altare di un tempio di Atena. Il retroterra del crimine era la necessità della città di scegliere un dio per darsi nome e ciò che usualmente viene rappresentato come una rivalità fra Poseidone ed Atena per ottenere tale onore.
Medusa fu stuprata o sacrificata sull’altare di Atena? Fu la donna "punita" da Atena, o fu uccisa durante una crisi, come offerta della città di Atene ad una dea "adirata", proprio come Ifigenia fu sacrificata ad una Artemide assetata di sangue? Dietro alla testa decapitata della donna, che Perseo usa per mutare gli uomini in pietra, c’è l’antica Gorgone, la maschera apotropaica rituale che segnava gli angoli dei camini nelle case ateniesi.
La Medusa mitica può ricordare una reale vittima sacrificale: dietro la testa che tramuta in pietra gli uomini, potrebbe esserci una donna lapidata a morte dagli uomini. E, anche qui, la responsabilità deve cadere su un’altra "donna", Atena.
La storia viene erotizzata dal collocare la violenza fra uomini e donne, e Freud, nella sua equazione "decapitazione = castrazione" rinforza e sviluppa la misoginia presente nel sacrificio mitico. Se Medusa è divenuta una figura centrale con cui ogni donna artista deve fare i conti è perché, ella stessa ridotta al silenzio, Medusa è stata usata per ridurre al silenzio altre donne.
Aracne, narrando sulla tela le storie delle donne stuprate da dei mutati in bestie, demistifica gli dei (il sacro) e li rivela come bestie (la violenza). Ovidio può raccontare la sua versione della storia solo perché la versione della donna è stata strappata in pezzi e lei stessa ricondotta ad uno stato "naturale".
Proprio come Freud, terrorizzato dalla "donna-come-madre" e dalla donna tessitrice, usa la psicoanalisi per riportare le donne ad un’identificazione con la "natura", così il mito usa Atena affinché trasformi Aracne in un ragno repellente, che potrà tessere tele puramente letterali, disegni incomprensibili. La metamorfosi, così come la psicoanalisi nelle mani di Freud, rovescia la direzione della violenza: Medusa, come Aracne, spaventa e minaccia gli uomini.
Il ragno femmina intrappola e divora i maschi che si accoppiano con lei... Lo strumento della tessitrice, la spoletta, viene usato per ridurla al silenzio. Ma non viene usato per zittire l’artista maschio, che si appropria dell’abilità femminile quale metafora per la propria stessa abilità.
Quale strumento di violenza, Atena è un’estensione di Zeus. La vendetta sulla donna artista, che usa il telaio per raccontare storie che non ci è permesso di udire se non sono mediate dagli uomini, non è una vendetta degli dei, è una vendetta culturale.
Quando Filomela comincia a tessere durante il suo lungo anno di prigionia, non è solo la sua sofferenza che la muove ad un nuovo uso del telaio, ma lo specifico scopo di essere udita da sua sorella. Come strumento che lega e connette il telaio (o la spoletta che è una sua parte) ri-membra e aggiusta ciò che la violenza riduce in pezzi: il legame fra sorelle, il potere della donna di parlare, la forma della comunità, la comunicazione. La guerra ed il tessere sono antitetici.
Ma il mito ci chiede di credere che, dopo il suo lungo e paziente sforzo, Filomela sia disposta a trasformare il suo lavoro al telaio in vendetta immediata. Ci si chiede di credere, dopo che Filomela ha trasformato la prigione in laboratorio e la disciplina domestica in un anno di lotta, che tutto ciò l’ha lasciata immutata, che la sua scoperta non ha il potere di cambiare nulla.
E il mito ci chiede di credere che dopo un anno di pianto sulla tomba della sorella, Procne sia disposta non ad un rito di riunione, ma ad uno di omicidio. L’alternativa più importante suggerita dall’arazzo di Filomela non è mai stata considerata: il potere del testo di insegnare all’uomo a conoscere se stesso.
E’ il barbaro Tereo o è il cittadino greco che risponde alla storia tessuta dalla donna con la violenza? All’interno della tradizione greca, il mito è stato usato per insegnare alle donne il pericolo insito nella nostra capacità di vendicarci. Ma se il mito istruisce, così come è istruttivo l’arazzo di Filomela, allora ci dice anche che possiamo insegnare a noi stesse, all’interno del potere dell’arte, le forme della resistenza.
E’ il tentativo di negare che il tessere di Filomela poteva avere altri fini a parte la vendetta che rende il mito così pericoloso, perché esso tenta di persuaderci al considerare la violenza inevitabile e l’arte debole... ma è lo stesso mito a testimoniare contro se stesso, perché se l’arte di Aracne e Filomela fosse davvero stata così debole, non sarebbe stata repressa con violenza così estrema. [...]
*
- Il testo (Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, libro VI):
- Il commento (Patricia Klindienst, "The Voice of the Shuttle is Ours")
- PATRICIA KLINDIENST, The Voice of the Shuttle is Ours.
- This article originally appeared in earlier form in The Stanford Literature Review 1 (1984): 25-53, and is republished here on VoS by permission of Anma Libri Press. It has also appeared in Rape and Representation, ed. Lynn A. Higgins and Brenda A. Silver (New York: Columbia Univ. Press, 1991), pp. 35-64. Accompanying the article is an "Epilogue" (1996) by the author, here published for the first time. Responses to the essay and epilogue are welcomed by the author.
- Patricia Klindienst is an independent scholar. She wrote "The Voice of the Shuttle is Ours" while completing a dissertation on Virginia Woolf at Stanford U. She was an Asst. Prof. of English, Humanities, and Feminist Studies at Yale U. from 1984-1992, when she chose to leave the profession to write. Originally conceived as part of a book-length study of shifting representations of rape, the "Voice" essay was followed by two companion pieces, "Ritual Work on Human Flesh: Livy’s Lucretia and the Rape of the Body Politic" (Helios, 17:1 [1990], 51-70), and "Intolerable Language: Jesus and the Woman Taken in Adultery," in Shadow of Spirit: Postmodernism and Religion, ed. Berry and Wernick, (London & NY: Routledge, 1992), pp. 226-237. Responses to the essays are welcomed by the author. E-mail her at Klindienst@aol.com -(This page mounted August 1996; last revised 10/30/96)
- LA VOCE DELLA SPOLETTA E’ NOSTRA (trad. Maria G. Di Rienzo:
- ["Questo articolo apparve nella sua prima stesura nella rivista letteraria "The Stanford Literature Review", n. 1 del 1984, pp. 25-53; fu pubblicato anche nel libro Rape and Representation (Stupro e rappresentazione) edito da Columbia University Press, New York 1991, pp. 35-64.
- Patricia Klindienst è una studiosa indipendente. Scrisse La voce della spoletta e’ nostra quale completamento di una dissertazione su Virginia Woolf alla Stanford University. E’ stata assistente alle cattedre di Inglese, Studi Umanistici e Studi Femministi all’Universita’ di Yale dal 1984 al 1992, anno in cui ha scelto di lasciare la professione per dedicarsi a scrivere.
- Originariamente concepito come parte di uno studio sui cambiamenti della rappresentazione dello stupro, il presente saggio fu seguito da altri due testi che proseguivano l’analisi: Ritual Work on Human Flesh: Livy’s Lucretia and the Rape of the Body Politic (ed. Helios, 1990, pp. 51-70), e Intolerable Language: Jesus and the Woman Taken in Adultery, in Shadow of Spirit: Postmodernism and Religion, ed. Berry and Wernick, (Routledge, London and New York 1992), pp. 226-237"] ("La nonviolenza e’ in cammino", 458 - Centro di ricerca per la pace - Viterbo).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- IL MITO DI ARACNE E IL "RATTO DI EUROPA".12 febbraio 2019, di Federico La Sala
SULLE TRACCE DI EUROPA. ARACNE, PENELOPE, E "UN FALSO MITO"... *
- IL MITO DI ARACNE (Publio OVIDIO Nasone, Metamorfosi, VI, 1-145 (trad. a cura di Bernardini Marzolla P., Einaudi, Torino 1994)
Pàllade, la dèa del Tritone, aveva seguito con attenzione il racconto. Elogiò il canto delle dee d’Aònia, e trovò giusta la loro ira. Ma poi, tra sé: “Lodare va bene, ma anche io voglio essere lodata, nemmeno io permetterò che si disprezzi la mia divinità impunemente!” E decise di rovinare Aracne della Meònia, la quale - le era giunta voce - non intendeva considerarsi inferiore a lei nell’arte di lavorare la lana. Costei, non per ceto o lignaggio era famosa, ma perché era un’artista. Suo padre, Idomone di Colofonie, tingeva la lana spugnosa con porpora di Focèa; la madre era morta, ma anch’essa era una popolana, della stessa condizione del marito. Malgrado ciò, Aracne con la sua attività si era fatta n gran nome per le città della Lidia, benché, nata appunto da umile famiglia, abitasse nell’umile Ipèpe.
Per vedere i suoi meravigliosi lavori, spesso le ninfe del Timolo lasciarono i loro vigneti, le ninfe del Pactòlo lasciarono le loro acque. E non soltanto meritava vedere i tessuti finiti, ma anche assistere a quando li faceva, poiché era un vero spettacolo. Sia che agglomerasse la lana greggia nelle prime matasse, sia che lavorasse di dita e sfilacciasse uno dopo l’altro con lungo gesto i fiocchi simili a nuvolette, sia che con l’agile pollice facesse girare il liscio fuso, sia che ricamasse, si capiva che la sua maestria veniva da Pàllade. Ma Aracne sosteneva di no, e invece di essere fiera di una così grande maestra, diceva impermalita: “Che gareggi con me! Se mi vince potrà fare di me quello che vorrà”.
Pàllade si traveste da vecchia, si mette sulle tempie una finta capigliatura bianca e prende anche un bastone che sorregga le membra piene di acciacchi. Poi comincia a parlare così: “Non tutto è male nell’età avanzata. Più si invecchia più cresce l’esperienza. Dài retta a me: ambisci pure ad essere la più grande tessitrice, tra i mortali; ma non voler competere con la dèa,e chiedile con voce supplichevole di perdonarti per quello che hai detto, o temeraria; chiediglielo, e non ti rifiuterà il perdono”.
Aracne le lancia una torva occhiata, lascia andare i fili già cominciati e a stento trattenendosi dal percuoterla, con una faccia che tradisce l’ira, così dice di rimando a Pàllade che ancora non si è palesata: “O scimunita, smidollata dalla lunga vecchiaia, vivere troppo eccome se rovina! Queste cose valle a dire a tua nuora, valle a dire a tua figlia, se ne hai una! Io mi so regolare benissimo da me, e perché tu non ti creda di aver combinato qualcosa con i tuoi ammonimenti, sappi che io la penso come prima. Perché non viene qui? Perché non accetta la sfida?”
Allora la dèa: “È venuta!”, dice, e si spoglia della figura di vecchia e si rivela - Pàllade. Le ninfe e le donne della Lidia si prostrano dinnanzi alla divinità; soltanto la vergine non si spaventa. Tuttavia trasalisce, e un improvviso rossore le dipinge suo malgrado il viso e poi ridilegua, come l’aria s’imporpora al primo comparire dell’aurora e dopo breve tempo s’imbianca, quando sorge il sole. Insiste sulla via che ha preso, e per insensata bramosia di gloria corre verso la propria rovina.
E infatti la figlia di Giove non rifiuta, e non l’ammonisce più, e nemmeno rinvia più la gara. Subito si sistemano una da una parte, l’altra dall’altra, e con gracile filo tendono ciascuna un ordito. L’ordito in alto è legato al subbio, il pettine di canna tiene distinti i fili, la spola appuntita inserisce la trama, con l’aiuto delle dita, e i denti intagliati nel pettine, dando un colpo, comprimono la trama passata tra un filo e l’altro.
Lavorano tutte e due di lena, e liberate le spalle dalla veste muovono le braccia esperte, con tanto impegno che non sentono fatica. Mettono nel tessuto porpora che ha conosciuto la caldaia a Tiro, e sfumature delicate, distinguibili appena: così, quando la pioggia rifrange i raggi solari, l’arcobaleno suole tingere con grande curva, per lungo tratto, il cielo, e benché risplenda di mille diversi colori, pure il passaggio dall’uno all’altro sfugge all’occhio di chi guarda, tanto quelli contigui si assomigliano, sebbene gli estremi differiscano. Anche intridono i fili di duttile oro, e sulla tela si sviluppa un’antica storia.
Pàllade effigia il colle di Marte nella città della di Cècrope [ATENE] e l’antica contesa sul nome da dare alla contrada. Sei dèi più sei, e Giove nel mezzo, siedono con aria grave e maestosa su scanni eccelsi: ciascuno ha come impressa in volto la propria identità; l’aspetto di Giove è quello di un re. Poi disegna il dio del mare, mentre colpisce col lungo tridente il macigno di roccia e da questo squarciato fa balzare un cavallo indomito, perché la città gli venga aggiudicata. A sé stessa assegna uno scudo, un’asta dalla punta acuminata, un elmo e l’egida per proteggere il capo e il petto; e rappresenta la terra che percossa dalla sua lancia genera l’argentea pianta dell’ulivo con le sue bacche; e gli dei che guardano stupefatti; infine la propria vittoria. Ma perché la rivale capisca da qualche esempio cosa dovrà aspettarsi per così folle ardire, aggiunge ai quattro angoli quattro altre sfide, vivaci nei colori, ma nitide nei tratti minuti. In un angolo si vedono Ròdope di Tracia ed Emo, ora gelidi monti, un tempo esseri mortali, che avevano usurpato il nome degli dei maggiori. Dall’altra parte la sorte pietosa della madre dei Pigmei: avendola vinta in una gara, Giunone impose che diventasse una gru e s’azzuffasse col suo popolo. Poi effigia Antigone, che una volta osò competere con la consorte del grande Giove e che dalla regale Giunone fu mutata in uccello: né Ilio né il padre Laomedonte poterono impedire che, spuntatele le penne, come candida cicogna applaudisse sé stessa battendo il becco. Nell’angolo che rimane Cìnira, perdute le figlie, abbraccia i gradini di un tempio, già carne della sua carne, e, accasciato sulla pietra, si staglia in lacrime.
 Contorna i bordi con rami d’olivo, segno di pace, e con la pianta che le è sacra conclude l’opera sua.
Contorna i bordi con rami d’olivo, segno di pace, e con la pianta che le è sacra conclude l’opera sua.Aracne invece disegna Europa ingannata dalla falsa forma di toro: diresti che è vero il toro, vero il mare; la si vede che alle spalle guarda la terra e invoca le compagne, e come, per paura d’essere lambita dai flutti che l’assalgono, ritragga timorosa le sue gambe. E raffigura Asterie che ghermita da un’aquila si dibatte, raffigura Leda che sotto le ali di un cigno giace supina; e vi aggiunge Giove che sotto le spoglie di un satiro ingravida di due gemelli l’avvenente figlia di Nicteo; che per averti, Alcmena di Tirinto, si muta in Anfitrione; che trasformato in oro inganna Dànae, in fuoco la figlia di Asopo, in pastore Mnemosine, in serpe screziato la figlia di Cerere. Effigia anche te, Nettuno, mentre in aspetto di torvo giovenco penetri la vergine figlia di Eolo, mentre come Enìpeo generi gli Aloìdi, e inganni come ariete la figlia di Bisalte; te, che la mitissima madre delle messi dalla bionda chioma conobbe destriero, che la madre con serpi per capelli del cavallo alato conobbe uccello e Melanto delfino. Ognuno di questi personaggi è reso a perfezione e così l’ambiente. E c’è pure Febo in veste di contadino, e le volte che assunse penne di sparviero o pelle di leone, e che in panni di pastore ingannò Isse, figlia di Macareo. C’è come Libero sedusse Erìgone trasformandosi in uva, come Saturno in cavallo generò il biforme Chirone.
 Tutto intorno alla tela corre un fine bordo, con fiori intreccisti a rami d’edera flessuosi.
Tutto intorno alla tela corre un fine bordo, con fiori intreccisti a rami d’edera flessuosi.Neppure Pàllade, neppure la Gelosia poteva trovar qualcosa da criticare in quell’opera. Ma la bionda dèa guerriera ci rimase malissimo e fece a brandelli la tela che illustrava a colori le colpe degli dèi, e trovandosi in mano la spola di legno del Citoro, tre e quattro volte colpì con quella sulla fronte Aracne, figlia di Idmone. La poveretta non lo tollerò, e corse impavida a infilare il collo in un cappio.
Vedendola pendere, Pàllade ne ebbe compassione e la sorresse, dicendo così: “Vivi pure, ma penzola, malvagia, e perché tu non stia tranquilla per il futuro, la stessa pena sia comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti!” Detto questo, prima di andarsene la spruzzò di erbe infernali, e subito al contatto del terribile filtro i capelli scivolarono via, e con essi il naso e gli orecchi; e la testa diventa piccolissima, e tutto il corpo d’altronde s’impicciolisce. Ai fianchi rimangono attaccate esili dita che fanno da zampe. Tutto il resto è pancia: ma da questa, Aracne riemette del filo e torna a rifare - ragno - le tele come una volta.
NOTE...
RIANDANDO CON LA MEMORIA alla “poesia” della RAGAZZA e del RAGNO, della “TARANTATA”, di Pellegrino Scardino di San Cesario, e, RICORDANDO CHE il mito di ARACNE raccontato da OVIDIO (Metamorfosi, VI, 1-145) "narra della sfida tra Athena ed Aracne sull’arte della tessitura. E’ proprio Aracne a lanciare la sfida, e ne pagherà le tragiche conseguenze: non solo ha osato sfidare la dea, ma la rabbia che suscita in Athena è nel fatto che le sue tele si mostrano addirittura superiori a quelle della dea stessa. L’ira che la fanciulla provocherà in Athena sarà tale da costringerla al tentativo di suicidarsi: non poteva reggere difatti il peso della rabbia divina. Ma la dea fermerà il tentativo di suicidio di Aracne e la trasformerà in ragno" e, ANCORA, che sul tema - come ha ricordato lo stesso Gianfranco Mele (ARACNE, LE TARANTATE, E UN FALSO MITO - il prof. Armando Polito ha offerto brillanti contributi di approfondimenti iconografici, credo sia opportuno invitare ancora e di nuovo a una lettura attenta dell’intera narrazione ovidiana, per cercare possibili ragioni del "falso mito".
CONTRARIAMENTE a quanto si è pensato e si continua a pensare, c’è un filo doppio che lega Athena e Aracne - una identità speculare (uguale e opposta) che emerge chiara dal confronto della loro situazione "familiare" e e della loro “ideologia” emergente dalle "immagini" dei loro arazzi: quello di Athena che celebra la fondazione di Atene, sé stessa, e la punizione di chi osa sfidare soprattutto la sposa di Zeus, e, quello di Aracne che celebra le "avventure" di Zeus (e di altri déi) con donne mortali, a partire dal famoso "ratto di Europa" ...
ENTRAMBE, rimaste senza madre (quella di Aracne è morta, quella di Athena l’ha "ingoiata" Zeus) ed entrambe al "servizio" dei loro "Padri", SONO tutte e due collegate nelle varianti del mito a Penelope, come da scena di una xilografia del XVI sec.: Pallade e Penelope con le ancelle e Aracne indignata a tessere la tela - in attesa di un... Ulisse/Zeus, partito per le sue avventure “europee”. O, dato che ormai l’Europa è sulla via del tramonto, anche questa "variante" è da ritenersi "un falso mito"? O, in altro modo, che Athena, Aracne, Penelope, e la stessa Arianna tentano di offrire ancora la chiave per saper riconoscere un falso mito e riprendere il cammino? O no?
Federico La Sala
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- «Così in Francia combatto le mutilazioni genitali femminili». Parla L’avvocatessa Linda Well-Curiel (di E. Zuccalà).7 febbraio 2019, di Federico La Sala
La Giornata.
«Così in Francia combatto le mutilazioni genitali femminili»
Il 6 febbraio è la Giornata sulla tolleranza zero nei confronti delle mutilazioni genitali femmiinili. Parla l’attivista Linda Weil-Curiel: «In Europa le hanno subìte almeno 500mila immigrate»
di Emanuela Zuccalà (Avvenire,, Parigi domenica 3 febbraio 2019)
- Foto L’avvocatessa Linda Well-Curiel, presidente dell’associazione Cams. Dagli anni ’80 ha difeso le vittime in oltre 40 processi, facendo condannare più di cento fra tagliatrici e genitori di bambine mutilate
Si celebra il 6 febbraio in tutto il mondo la Giornata internazionale sulla tolleranza zero nei confronti delle mutilazioni genitali femminili. La Farnesina ribadisce in una nota il proprio «convinto impegno per l’eradicazione di questa inaccettabile pratica, gravemente lesiva dei diritti e della salute delle donne e delle bambine».
Hawa Gréou era la “maman” più rinomata dell’intera Île-de France. Centinaia di famiglie africane bussavano al suo appartamento di Parigi chiedendo alla matrona del Mali di “sistemare” le figlie con il rito che, per alcune etnie, è un necessario sigillo di purezza femminile: la mutilazione genitale. Hawa era rapida, abile: sotto il suo coltello nessuna bimba moriva d’emorragia. Un giorno la vicina di casa l’ha denunciata per disturbo della quiete pubblica: le grida che filtravano dalla sua porta erano strazianti. Ma non accadde nulla. Per arrestare Hawa ci volle il coraggio di una sua vittima, che per salvare le sorelline dal rito di sangue raccontò a un procuratore l’orrore che si svolgeva in quelle stanze. E ci volle la testardaggine di un’avvocatessa per condannare la“maman” a 8 anni di carcere, in un processo storico di cui quest’anno ricorre il ventennale, che scosse la Francia e aprì gli occhi sulle escissioni clandestine.
L’avvocatessa è Linda Weil-Curiel, presidente dell’associazione Cams: dagli anni ’80 ha difeso le vittime in oltre 40 processi, facendo condannare più di cento persone, fra tagliatrici e genitori di bambine mutilate. E sebbene la Francia sia l’unico Paese europeo, tra quelli a forte immigrazione africana, a non avere una legge specifica contro le mutilazioni genitali femminili, registra più condanne su questi casi: la maggior parte, grazie a Weil-Curiel. In Italia, dalla legge del 2006 sono state solo 5; in Spagna e in Svezia 2; nel Regno Unito un’unica condanna è arrivata due giorni fa, nonostante la norma esista dal 1985.
«Vengo invitata dai Parlamenti di mezza Europa a spiegare perché in Francia la giustizia contro l’escissione funziona» racconta Linda Weil-Curiel nel suo ufficio a Saint-Germain-des-Prés, nel cuore di Parigi, «e ogni volta ribadisco che una norma ad hoc è inutile e fuorviante: basta il Codice penale, che in qualsiasi Stato punisce le lesioni permanenti. Non solo: leggi ad hoc aprono al relativismo culturale, classificando la mutilazione sessuale tra gli africani come “tradizione” e non come puro e semplice crimine».
Secondo le stime del vostro ministero della Sanità francese, dal 2007 al 2015 le donne escisse residenti in Francia sono diminuite da 61mila a 53mila. Merito della sua linea dura?
In parte sì. Intendiamoci: la sensibilizzazione tra le comunità migranti è fondamentale, ma devono anche essere coscienti che andranno in prigione, se amputeranno le bambine.
Come ha iniziato ad appassionarsi a questo tema?
Nel 1982 un’amica femminista (era Annie Sugier, fondatrice con Simone de Beauvoir della Lega internazionale per i diritti delle donne) mi portò un articolo di giornale: una neonata era stata escissa dal padre e salvata per un soffio dalla morte. Con la mia associazione mi costituii parte civile al processo, e iniziò la prima battaglia: trasferire questi casi dai tribunali ordinari alla più alta giurisdizio- ne criminale, la Corte d’assise. I magistrati smussavano: «Sono immigrati, non parlano francese, è la loro tradizione...».
 Ma se recidessero i genitali a una bambina bianca, - ribattevo - non gridereste allo scandalo? La legge è uguale per chiunque risieda in Francia! Così ottenemmo la Corte d’Assise. In seguito, quando molte famiglie ormai tagliavano le figlie portandole nei Paesi d’origine per aggirare la giustizia francese, l’articolo 222 del Codice penale fu esteso alle mutilazioni commesse all’estero da residenti in Francia. Ma i casi erano complessi.
Ma se recidessero i genitali a una bambina bianca, - ribattevo - non gridereste allo scandalo? La legge è uguale per chiunque risieda in Francia! Così ottenemmo la Corte d’Assise. In seguito, quando molte famiglie ormai tagliavano le figlie portandole nei Paesi d’origine per aggirare la giustizia francese, l’articolo 222 del Codice penale fu esteso alle mutilazioni commesse all’estero da residenti in Francia. Ma i casi erano complessi.Perché?
I genitori non rivelano i nomi delle tagliatrici: c’è protezione, nelle comunità africane. Le madri dicono: «Una donna sull’autobus, vedendomi con la neonata in braccio, mi ha chiesto se la piccola era stata operata. Mi ha invitata a casa sua, ma non so il suo nome». Storie inverosimili.
Finché nel 1999 esplose il caso Gréou.
Un’inchiesta di 18 mesi e un grande processo durato 15 giorni. Dopo la denuncia della ragazza, la polizia sorvegliava la casa della tagliatrice, ma lei s’era fatta prudente e operava altrove. Quando le controllarono il telefono, emerse la verità: organizzava sedute di escissione di massa, spesso nei periodi di ferie quando c’erano meno orecchie in giro. Il procuratore chiese 7 anni di reclusione; io 8. Vinsi io.
Quando Hawa è uscita di prigione, siete diventate amiche e insieme avete scritto il libro Exciseuse (ed. City). Com’è stato possibile?
Al processo l’ho osservata molto: era una donna intelligente. Il mestiere di tagliatrice l’era stato imposto dalla nonna: le donne di famiglia lo praticavano da generazioni ed era di prestigio, poiché portava denaro, stoffe pregiate, sapone. Hawa non poteva sottrarsi. Uscì prima dal carcere per buona condotta, e mi telefonò: «Sono maman». Era sola, il marito aveva altre mogli e voleva rispedirla in Mali. Girava con un carrello da mercato zeppo di vestiti perché le altre mogli le rubavano tutto e, trascinandoselo dietro, in ciabatte e velo in testa, venne da me. Ero l’unica con cui potesse parlare con franchezza: sapeva che la comprendevo. Così ci siamo avvicinate. Ho persino fatto causa a suo marito, costringendolo a pagarle gli alimenti.
Perché in altri Paesi, che pure hanno leggi specifiche contro la mutilazione genitale femminile, si fatica a condannare?
Il Codice penale è più efficace di una proliferazione di nuove norme difficili da applicare. Serve forse una legge speciale per punire chi amputa una mano o un orecchio? Dunque perché per il taglio dei genitali dovrebbe essere diverso? Il Regno Unito, per esempio, ha leggi dall’85 ma piene di punti deboli, come il fatto che un’associazione non possa costituirsi parte civile. Negli Stati Uniti, di recente, c’è stato il caso di una clinica a Detroit dove una setta indiana praticava escissioni: il giudice non ha voluto applicare la legge federale sulle mutilazioni genitali, con argomenti che rivelano tutta la fragilità della norma.
In Europa si stima la presenza di 500mila donne immigrate che hanno subìto una mutilazione genitale. Oltre alle vie giudiziarie, quali azioni servono, secondo lei, per sradicare questa pratica?
Il pediatra deve controllare i genitali di una bimba con origini in Paesi a tradizione escissoria, tanto più se vi è appena stata in vacanza. Bisogna poi trasferire la gestione dei sussidi familiari ai servizi sociali: in Francia s’è rivelata una misura efficace in un centro per l’infanzia che l’ha attuata. Queste bambine hanno diritto a una crescita normale e la legge ci dà i mezzi per proteggerle: dobbiamo usarli.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. - Per la critica del "sogno d’amore" cattolico-hegeliano! "Dovremmo tutti leggere Aleramo" (di Lea Melandri).5 febbraio 2019, di Federico La Sala
Dovremmo tutti leggere Aleramo
di Lea Melandri (Comune-info, 17 Gennaio 2019)
Il 13 gennaio 1960 moriva Sibilla Aleramo. Alla studio e alla rilettura dei suoi Diari ho dedicato molti anni e grande è stato l’incidenza che i suoi “frammenti di lucida intuizione” hanno avuto nella mia vita e nel mio percorso femminista. A lei è dedicata la parte centrale del mio libro Come nasce il sogni d’amore (Rizzoli 1988, Bollati Boringhieri 2002) e molti saggi pubblicati in altri libri e riviste. Riporto qui una relazione (molto lunga, ma chi è interessata/o so che non si fa scoraggiare) destinata a un convegno a cui non ho potuto partecipare e mai pubblicata negli Atti che avrebbero dovuto fare seguito. Sibilla Aleramo. Una coscienza femminile anticipatrice
L’incontro con Sibilla Aleramo avviene alla fine degli anni Settanta, sulla spinta di un movimento di donne che aveva messo al centro della propria riflessione e della propria ricerca politica le problematiche del corpo, favorito anche da ragioni autobiografiche (l’inizio di un’analisi). Quindi:il mio non è un interesse strettamente letterario. Già la ripubblicazione di Una donna (Feltrinelli 1975) rientrava in questa riscoperta. Ma è soprattutto l’uscita dei diari (Diario di una donna, Feltrinelli 1978 e Un amore insolito, Feltrinelli 1979) a far emergere l’originalità dell’Aleramo: il carattere quasi esclusivamente autobiografico della sua opera, il particolare rapporto tra scrittura e vita, che viene da una coscienza anticipatrice, attenta alla costruzione di un’individualità femminile sottratta al suo destino storico di moglie e madre.
È l’Aleramo stessa a fornire questa chiave di lettura, quando, al di là dei suoi sforzi rivolti alla poesia, si rende conto che c’è in lei una “sotterranea seconda vita”, una corrente tacita di pensieri e sentimenti, che non può essere tradotta in poesia “se non violentandomi, disumandomi, forse uccidendomi”,(1) che chiede perciò un altro tipo di scrittura. Questa consapevolezza, con cui l’Aleramo torna a guardare le migliaia di pagine che si è lasciata dietro, appare esplicitamente nei diari, ma se ne possono trovare le tracce già nel romanzo Una donna. L’Aleramo è stata sicuramente buona interprete e profetessa di sé.
 “Nel futuro, nel futuro. La certezza di un tale avvenire mi si era andata formando inavvertitamente, forse dall’adolescenza, forse prima... A tratti un senso di ammirazione, quasi di estranea mi prendeva per il cammino da me percorso; avevo la rapida intuizione di significare qualcosa di raro nella storia del sentimento umano, d’essere tra i depositari di una verità manifestatesi qua e là a dolorosi privilegiati... E, pensosa, mi chiedevo se sarei riuscita un giorno ad esprimere per la salvezza altrui una parola memorabile”. (2)
“Nel futuro, nel futuro. La certezza di un tale avvenire mi si era andata formando inavvertitamente, forse dall’adolescenza, forse prima... A tratti un senso di ammirazione, quasi di estranea mi prendeva per il cammino da me percorso; avevo la rapida intuizione di significare qualcosa di raro nella storia del sentimento umano, d’essere tra i depositari di una verità manifestatesi qua e là a dolorosi privilegiati... E, pensosa, mi chiedevo se sarei riuscita un giorno ad esprimere per la salvezza altrui una parola memorabile”. (2)
 “E la mia poesia è stata tutta generata così. E le migliaia di pagine che ho scritto per narrarmi, per spiegarmi. Fino a questa d’oggi. Un furore d’autocreazione incessante.” (3)
“E la mia poesia è stata tutta generata così. E le migliaia di pagine che ho scritto per narrarmi, per spiegarmi. Fino a questa d’oggi. Un furore d’autocreazione incessante.” (3)
 “Tutto getto di me... e chi mai se n’è accorto? Nessuno realmente, quando il libro uscì... Chi lo scoprirà, quando sarò morta? ... Fra venti, cinquanta, cent’anni chi farà giustizia alla donna che in queste pagine, e in tante altre, s’è così immolata?” (4)
“Chi leggerà tutte queste pagine, dopo la mia morte? Deciderà di distruggerle tutte? O potrà ricavarne qualche frammento di lucida intuizione?” (5)
“Tutto getto di me... e chi mai se n’è accorto? Nessuno realmente, quando il libro uscì... Chi lo scoprirà, quando sarò morta? ... Fra venti, cinquanta, cent’anni chi farà giustizia alla donna che in queste pagine, e in tante altre, s’è così immolata?” (4)
“Chi leggerà tutte queste pagine, dopo la mia morte? Deciderà di distruggerle tutte? O potrà ricavarne qualche frammento di lucida intuizione?” (5)Quelle che per le altre scrittrici sono le vie secondarie, i viottoli della scrittura letteraria - lettere, diari, note sparse - per l’Aleramo diventano il tracciato portante che convoglia anche il testo della sua opera: il romanzo, la poesia. Niente letteratura, pochissima arte, piuttosto: un flusso irrefrenabile di vita. Non è nella storia della letteratura che l’Aleramo si pensa come “qualcosa di raro”, ma “nella storia del sentimento umano”.
La scrittura è il luogo in cui si rovescia una “somma enorme di vita”, ma anche quello in cui si interroga la vita (“per spiegarmi”,”per riconoscermi”), e in cui il percorso della vita e della scrittura, riletti a più riprese, operano una specie di svelamento. Per questo il narrarsi dell’Aleramo appare, più che un’autobiografia, un’autoanalisi: si parla di veli tutti da sollevare, di un “pudore selvaggio”, di “una selvaggia nudità”, di una “rappresentazione del mondo aprioristicamente ammessa, poi compresa per virtù d’analisi” (6).
L’analisi dei modelli interiorizzati sarà al centro del femminismo negli anni Settanta (la “violenza invisibile”), ma mentre i gruppi femministi si sono soffermati soprattutto sulla sessualità, l’Aleramo opera questo svelamento sul sogno d’amore. L’immagine dello svelamento ci aiuta a capire, innanzitutto, un tratto dominante, nella vita come nella scrittura: l’alternarsi di sogno e lucidità di analisi. Ma in qualche modo mostra anche le molteplici contraddizioni che lo accompagnano: nonostante la ridda dei suoi tentativi amorosi, non c’è, negli scritti, quasi nessuna traccia della sessualità. Spudorata, l’Aleramo lo è rispetto al sogno d’amore, portato sulla scena pubblica;
 molti sono gli amori, ma modellati su un unico amore, quello che prende forma dalla vicenda originaria (fusionalità, composizione degli opposti) e che viene riportato anche nella ricerca di interezza e nella creatività; la patina di romanticismo (letteratura rosa) e l’essere coscienza anticipatrice nella ricerca di autonomia dell’essere femminile;
molti sono gli amori, ma modellati su un unico amore, quello che prende forma dalla vicenda originaria (fusionalità, composizione degli opposti) e che viene riportato anche nella ricerca di interezza e nella creatività; la patina di romanticismo (letteratura rosa) e l’essere coscienza anticipatrice nella ricerca di autonomia dell’essere femminile;
 il pieno di presenze (amici, amanti) e la solitudine, intesa come il “fastidioso obbligo di vivere per sé”; la fama di cui godette e la sua povertà, il nomadismo; la partecipazione intensa alla vita culturale del suo tempo, e l’aspetto astorico della sua tematica dell’amore; il tratto comune e insieme eccezionale della sua esperienza: da cui il carattere immolatorio, l’idea di essere portatrice di una verità.
il pieno di presenze (amici, amanti) e la solitudine, intesa come il “fastidioso obbligo di vivere per sé”; la fama di cui godette e la sua povertà, il nomadismo; la partecipazione intensa alla vita culturale del suo tempo, e l’aspetto astorico della sua tematica dell’amore; il tratto comune e insieme eccezionale della sua esperienza: da cui il carattere immolatorio, l’idea di essere portatrice di una verità.Forse non è un caso che anche i giudizi che sembrano andare più vicino all’originalità dell’Aleramo non sono giudizi letterari, e neanche quelli benevoli:
 “... anche voi dovreste mutare fondamentalmente il vostro atteggiamento verso la vita. Non faccio il moralista a buon mercato; e intendo e scuso perfino il fallo commesso nell’impeto della giovinezza sensuale e fantastica quando avete abbandonato vostro marito e vostro figlio... Comunque il fatto era fatto; e voi avevate avuto un’ottima occasione per formarvi una nuova vita; quando stavate col Cena. Ma voi volevate amare il Cena, quando il vostro dovere era invece di aiutarlo e sacrificarvi a lui.” (Benedetto Croce) (7)
“... anche voi dovreste mutare fondamentalmente il vostro atteggiamento verso la vita. Non faccio il moralista a buon mercato; e intendo e scuso perfino il fallo commesso nell’impeto della giovinezza sensuale e fantastica quando avete abbandonato vostro marito e vostro figlio... Comunque il fatto era fatto; e voi avevate avuto un’ottima occasione per formarvi una nuova vita; quando stavate col Cena. Ma voi volevate amare il Cena, quando il vostro dovere era invece di aiutarlo e sacrificarvi a lui.” (Benedetto Croce) (7)
 “Allora perché non si decide ad accettare di essere sola, come un uomo silenzioso, chiuso, pronto agli incontri? Sola come una puttana intellettuale...pigli pure l’amore quando le viene ma senza amplificazioni, come un artista da un albero riceve un’immagine... Vergine e silenziosa come la Regina Elisabetta, essendo poi quanto le pare erotica: ma padrona di sé, sé sola: non quella che si pubblica, ora di questo ora dell’altro. Più carne e più cervello.”(Emilio Cecchi) (8)
“Allora perché non si decide ad accettare di essere sola, come un uomo silenzioso, chiuso, pronto agli incontri? Sola come una puttana intellettuale...pigli pure l’amore quando le viene ma senza amplificazioni, come un artista da un albero riceve un’immagine... Vergine e silenziosa come la Regina Elisabetta, essendo poi quanto le pare erotica: ma padrona di sé, sé sola: non quella che si pubblica, ora di questo ora dell’altro. Più carne e più cervello.”(Emilio Cecchi) (8)
 “È “un sogno” che voi perseguite! Un sogno irrealizzabile, mia cara Sibilla! Un sogno che voi avete avuto l’illusione di mutare in realtà, già più volte, e che s’è evaporato come una bolla di sapone. Il tempo della passione non dura. Non potrebbe durare.” (Marguerite Monclaire) (9)
“È “un sogno” che voi perseguite! Un sogno irrealizzabile, mia cara Sibilla! Un sogno che voi avete avuto l’illusione di mutare in realtà, già più volte, e che s’è evaporato come una bolla di sapone. Il tempo della passione non dura. Non potrebbe durare.” (Marguerite Monclaire) (9)Il sogno d’amore
Lo svelamento riguarda soprattutto il sogno d’amore. La definizione che ne dà l’Aleramo corrisponde all’idea che gli uomini hanno avuto da sempre della felicità e della perfezione: fusione di due esseri in uno, equilibrio dei contrari, armonia di sensi e ragione, “il miracolo che di due esseri complementari fa un solo essere armonioso”. Ma questa ideale ricomposizione, se per un verso richiama l’unità a due dell’origine (appoggiandosi perciò all’esperienza femminile della maternità), dall’altro è il mito che l’uomo ha costruito per ricongiungere ciò che la sua stessa storia ha diviso: natura-cultura, corpo-mente, maschile-femminile. La figura dell’androgino, presente nei miti e nelle fantasie originarie di ogni individuo, è congiungimento di maschile e femminile dove però il polo dominante è maschile, lo spirito che prende corpo (come del resto nel mito cristiano).
Lo svelamento che l’Aleramo opera rispetto al sogno d’amore è perciò doppiamente interessante: perché sottrae al silenzio e all’insignificanza storica, in cui è stata lasciata la vita intima, una vicenda come l’amore, che interessa tutti gli umani ma che è stata identificata con la donna, madre e amante (corpo erotico, corpo che genera). Calandolo nella mischia l’Aleramo lo sposta sulla scena storica, nella vita pubblica, lo può additare non più solo come fatto privato ma come sentimento umano. Nella vicenda autobiografica costringe a vedere il tracciato di una storia generale non ancora indagata come merita.
Mostrando il sentire della donna, le sue illusioni, le sue attese, nel rapporto d’amore, rivela contemporaneamente anche la parte che vi ha l’uomo; perché, portato alla luce, il sogno d’amore si lascia guardare, analizzare, e quello che si può vedere è che l’idea di felicità agisce su vari piani (non solo nella relazione amorosa), impronta esperienze diverse: i miti dell’infanzia, che vogliono ricomposti i volti di un padre e di una madre (la “divinità duplice”), l’idea di interezza del proprio essere (corpo e mente) e di interezza riportata sulla civiltà (riunificazione dei due rami divisi dell’umano) che finora è stata segnata solo dall’uomo; la rappresentazione del fare creativo. Ma soprattutto, quello che appare chiaro, è che il sentimento d’amore, in tutte le sue forme, se poggia per un verso sull’esperienza originaria (la nascita) è comunque dalla storia dell’uomo (dalle sue paure, dai suoi desideri, dalle separazioni, differenziazioni che ha imposto) che prende forma, come ricomposizione sul polo maschile. Questo spiega perché l’Aleramo dice di sé di sentirsi come Adamo che aspetta che gli sorga a fianco Eva; fa capire perché il suo incessante sforzo autocreativo diventi, per larga parte della sua vita, fino all’ultimo “amore” per Franco Matacotta, figlio e amante, impegno di energie proprie per far crescere l’individualità dell’altro, linfa vitale che si travasa nell’altro, lasciandola ogni volta senza vita propria. Finché non le diventa chiaro che la maternità come sacrificio di sé, impronta tutta l’esperienza delle donne: l’amore, l’impegno sociale, la creatività artistica, costringendole a riporre la loro grandezza e il loro potere nel rendersi indispensabile all’altro, illudendole di poter “foggiare se stesse foggiando l’altro”. (10)
Questo svelamento (o “presa di coscienza”) avviene ovviamente nella vita, ma è la scrittura dei Diari che lo trattiene e lo prepara. È lì che si dà, in modo evidente, questo andirivieni tra illusione, rapimento e lucidità di analisi, tra smarrimento nell’altro e ritorno a sé. Mentre nel romanzo Una Donna l’Aleramo costruisce l’immagine idealizzata di sé - umanità in cammino, terra fertile, fecondante per la sterile libertà dell’uomo - nei migliaia di foglietti che scrive a margine annota lucidamente la centralità dell’uomo, della sua visione del mondo, la sua incuranza per l’anima femminile, la riduzione della donna a equilibrio organico (il corpo che lo nutre, lo riscalda).
 “Poco fa guardavo lui che scriveva: egli non può darmi ciò che mi manca. Ma io posso dare a lui, che possiede il genio, la limpida pace che gli permetta di non smarrirsi mai nell’interpretazione della vita. Io debbo stargli accanto, io ho una ragione di esistere anche se non posso individualmente tradurre pensieri e sensazioni”. (11)
“Poco fa guardavo lui che scriveva: egli non può darmi ciò che mi manca. Ma io posso dare a lui, che possiede il genio, la limpida pace che gli permetta di non smarrirsi mai nell’interpretazione della vita. Io debbo stargli accanto, io ho una ragione di esistere anche se non posso individualmente tradurre pensieri e sensazioni”. (11)
 “Voi siete i forti perché tutto vi è facile, perché nulla vi costa sforzo, perché la vostra forza non la spendete... io che ho voluto dar voce alla mia lingua muta, che ho voluto portar fardelli, più gravi del mio stesso peso... io sono la debole, perché tutta questa lunga immane fatica mi mette infine alla vostra mercé, di voi... che ignorate l’atto del rialzarsi e del proseguire dopo essere stati colpiti”. (12)
“Voi siete i forti perché tutto vi è facile, perché nulla vi costa sforzo, perché la vostra forza non la spendete... io che ho voluto dar voce alla mia lingua muta, che ho voluto portar fardelli, più gravi del mio stesso peso... io sono la debole, perché tutta questa lunga immane fatica mi mette infine alla vostra mercé, di voi... che ignorate l’atto del rialzarsi e del proseguire dopo essere stati colpiti”. (12)
 “Non hai bisogno della mia anima... mi dicevo guardandolo dormire... e perché dovresti accorgerti che soffre? Hai la tua da alimentare, da conservare, da difendere. Ci credi uno e siamo due. Sei tu al centro del mondo, tu con la tua visione ormai immobile nella casa ben salda della tua mente. Ti mancava soltanto questo, povero bimbo grande, l’equilibrio organico, e con me l’hai ottenuto. Riposi così tutte le notti con la mano sul mio cuore: e ti basta il suo bel respiro. Tale è il tuo amore, senza struggente sete di dedizione, senza voluttà di sconfinamento. Non sai la vertigine di me che sono pronta a sparire se tu lo voglia, se debbo farlo, se lo esige la tua missione, il tuo maggior bene. Questo annegare lucido del mio essere... Confondermi volevo con il tutto e son da tutto così staccata!”. (13)
“Non hai bisogno della mia anima... mi dicevo guardandolo dormire... e perché dovresti accorgerti che soffre? Hai la tua da alimentare, da conservare, da difendere. Ci credi uno e siamo due. Sei tu al centro del mondo, tu con la tua visione ormai immobile nella casa ben salda della tua mente. Ti mancava soltanto questo, povero bimbo grande, l’equilibrio organico, e con me l’hai ottenuto. Riposi così tutte le notti con la mano sul mio cuore: e ti basta il suo bel respiro. Tale è il tuo amore, senza struggente sete di dedizione, senza voluttà di sconfinamento. Non sai la vertigine di me che sono pronta a sparire se tu lo voglia, se debbo farlo, se lo esige la tua missione, il tuo maggior bene. Questo annegare lucido del mio essere... Confondermi volevo con il tutto e son da tutto così staccata!”. (13)A un certo punto i due percorsi, quello che va più aderente al modello interiorizzato
 l’immagine androgina, il sacrificio materno, il potere del rendersi indispensabile - e quello che registra scostamenti, resistenze, insediamento in una individualità propria, quell’”autonomia dell’essere femminile”, che può apparire all’inizio “tragica”, perché allontana da tutto ciò che si è amato e in cui si è creduto, finiscono per convergere.
l’immagine androgina, il sacrificio materno, il potere del rendersi indispensabile - e quello che registra scostamenti, resistenze, insediamento in una individualità propria, quell’”autonomia dell’essere femminile”, che può apparire all’inizio “tragica”, perché allontana da tutto ciò che si è amato e in cui si è creduto, finiscono per convergere.Mentre sta scrivendo il secondo Diario, l’Aleramo costata di non riuscire più a scrivere poesia, perché in quello sforzo di convogliare tutta la sua esperienza nell’atto creativo - bruciare una materia di sentimenti, pensieri, per arrivare all’incandescenza della mente - si era sentita via via cancellare dalla vita.
 È a quel punto che parla di una “sotterranea seconda vita” che non può essere tradotta in poesia. È il diario invece che può raccoglierla, sopportando che l’altalena di estasi e gelo, che era stata la sua scrittura d’amore, diventi l’annotazione quotidiana di una “mestissima libertà”, un’armonia, un ordine che non ha più bisogno di appoggiarsi alle figure del maschile e del femminile.
È a quel punto che parla di una “sotterranea seconda vita” che non può essere tradotta in poesia. È il diario invece che può raccoglierla, sopportando che l’altalena di estasi e gelo, che era stata la sua scrittura d’amore, diventi l’annotazione quotidiana di una “mestissima libertà”, un’armonia, un ordine che non ha più bisogno di appoggiarsi alle figure del maschile e del femminile.Nell’Aleramo è evidente che il narrarsi è stato, forse è ancora, un percorso obbligato per la donna che non voglia affacciarsi alla scena storica come un duplicato dell’uomo; difficile è inoltre sottrarre la narrazione di sé alle vicende con cui è stato identificato il femminile - l’amore, la maternità, la sessualità. Ma è anche narrandosi, mostrandosi a se stessa e agli altri nei suoi sogni, nei suoi contraddittori desideri (“come s’io sognassi”) che la donna può cominciare a costruirsi come individualità, fuori dagli stereotipi di genere, da modelli imposti. Paradossalmente si può affermare che la narrazione di sé - come modulazione consapevole di un pensiero, delle sue radici in un corpo, in un sesso, in una storia personale - porta fuori dell’autobiografismo obbligato, ritenuto “connaturato” al femminile.
Il paradosso della ripetizione
La vicenda amorosa si modella sempre su due poli contrapposti: il rapimento (illusione, estasi), la delusione (il gelo) cui segue la lucidità dell’analisi. All’origine: il rapporto idealizzato di lei bambina col padre, e di lei donna col figlio (l’aspetto originario dell’amore come fusionalità). La “ridda” degli amori successivi appaiono come la ripetizione o la ripresa di quella vicenda originaria, fino all’ultimo amore che, riproponendo la figura della madre e del figlio, svela anche gli altri.
Alcuni passaggi
Una donna: dopo l’estasi, fusione col figlio, la constatazione di essersi immolata per lui; segue la rinascita di un sé ideale, la missione rigeneratrice della donna. Ma anche l’incontro con l’uomo che sostituisce nell’amore il figlio (Damiani, Cena ) la lascerà delusa. Alla passione subentra presto l’abitudine. Nella donna l’uomo cerca solo il suo equilibrio organico.
 “In verità, al di fuori della somma di energie ch’io spendevo attorno al bambino, era in me un’incapacità sempre maggiore di vedere, di volere, di vivere: come una stanchezza morale si sovrapponeva a quella fisica, lo scontento di me stessa, il rimprovero della parte migliore di me che avevo trascurata... In me la madre non si integrava nella donna”. (14)
“In verità, al di fuori della somma di energie ch’io spendevo attorno al bambino, era in me un’incapacità sempre maggiore di vedere, di volere, di vivere: come una stanchezza morale si sovrapponeva a quella fisica, lo scontento di me stessa, il rimprovero della parte migliore di me che avevo trascurata... In me la madre non si integrava nella donna”. (14)
 “Perché avevo pensato tanto naturalmente alla morte quando mio figlio era in pericolo? Non esistevo io dunque indipendentemente da lui, non avevo, oltre al dovere di allevarlo, oltre alla gioia di assisterlo, doveri miei altrettanto imperiosi? “(15)
“Perché avevo pensato tanto naturalmente alla morte quando mio figlio era in pericolo? Non esistevo io dunque indipendentemente da lui, non avevo, oltre al dovere di allevarlo, oltre alla gioia di assisterlo, doveri miei altrettanto imperiosi? “(15)
 “Perché nella maternità adoriamo il sacrificio? Donde è scesa a noi questa inumana idea dell’immolazione materna?”. (16)
“Perché nella maternità adoriamo il sacrificio? Donde è scesa a noi questa inumana idea dell’immolazione materna?”. (16)
 “Mia creatura, mi diceva, eppur talora si dissolveva come un bimbo fra le braccia della madre al buio”. (17)
“Sensazione costante della donna moderna della propria sopravvivenza: esteriore aggraziato che implica debolezza e schiavitù, impulsi intimi di dedizione, compiacenza nel donarsi e nel far felice l’essere amato anche senza gioia propria”. (18)
“Mia creatura, mi diceva, eppur talora si dissolveva come un bimbo fra le braccia della madre al buio”. (17)
“Sensazione costante della donna moderna della propria sopravvivenza: esteriore aggraziato che implica debolezza e schiavitù, impulsi intimi di dedizione, compiacenza nel donarsi e nel far felice l’essere amato anche senza gioia propria”. (18)-***CONTINUAZIONE, NEL POST SUCCESSIVO.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. - Per la critica del "sogno d’amore". "Dovremmo tutti leggere Aleramo" (di Lea Melandri).5 febbraio 2019, di Federico La Sala
- CONTINUAZIONE, E FINE.
- Dovremmo tutti leggere Aleramo
 di Lea Melandri (Comune-info, 17 Gennaio 2019)
di Lea Melandri (Comune-info, 17 Gennaio 2019)
[...]
Boccioni
Il rapporto con Boccioni è particolarmente rivelatore. L’”uomo forte” che rifiuta le sue spinte fusionali, che non si lascia plasmare, la costringe a ripensarsi, a reinterrogare il suo bisogno di gioia, il vuoto, la ferita d’amore, l’orfanità che si nasconde dietro la potenza materna. Ma rivelando se stessa rivela anche l’uomo che trova il suo equilibrio nella complementarità dei ruoli.
 “Avete passato molto, troppo tempo a comunicare forza e coraggio a esseri malcostrutti, corrosi all’interno e indecisi all’esterno... Vi siete cullata in un’introspezione, in un’analisi corrosiva cercando di comunicare ciò che non è comunicabile cercando di condividere ciò che deve restare indivisibile personale individuale fino alla ferocia. Avete creduto che aggiungendo la vostra personalità a un’altra scaturisse un’unità... Errore gravissimo... Ci vuole una grande idea e lavorare per quella unilateralmente. Mentre vi scrivo mi vengono a fior di mente mille problemi di vita interna, angoscie, possibilità, fusioni, affinità, passione, sacrificio ed altre belle cose... Butto tutto dalla finestra con disgusto”. (19)
“Avete passato molto, troppo tempo a comunicare forza e coraggio a esseri malcostrutti, corrosi all’interno e indecisi all’esterno... Vi siete cullata in un’introspezione, in un’analisi corrosiva cercando di comunicare ciò che non è comunicabile cercando di condividere ciò che deve restare indivisibile personale individuale fino alla ferocia. Avete creduto che aggiungendo la vostra personalità a un’altra scaturisse un’unità... Errore gravissimo... Ci vuole una grande idea e lavorare per quella unilateralmente. Mentre vi scrivo mi vengono a fior di mente mille problemi di vita interna, angoscie, possibilità, fusioni, affinità, passione, sacrificio ed altre belle cose... Butto tutto dalla finestra con disgusto”. (19)
 “C’eravamo visti, avevamo chiacchierato, c’eravamo amati, andava finché andava... senza altre complicazioni... tu invece vedi doppio, vedi fantastico, terribile quello che è chiaro limpido sereno, transitorio... Vedi che ti parlo sinceramente come non ti hanno parlato forse tutti gli altri. O forse lo hanno fatto, ma in loro cuore avevano il bacillo dell’amore unico, turbinoso, che fonde, innalza, e al quale io non credo. Infatti Papini ha moglie, Gerace la prende e tentativi di collage hanno fatto altri che tu sai e che io non nomino. Io non posso amare nessuna donna. Ho delle grandi tenerezze ma mi guardo bene di entrare nella vita della donna che incontro. Se vi entrassi sarebbe troppo da padrone, insaziabile e ingiusto senza risultato... tutte le donne che ho amato appartenevano ad altri... Che cosa può interessarmi tutta la complicazione interna quando in questi giorni le forme e i colori mi appaiono incerti?“. (20)
“C’eravamo visti, avevamo chiacchierato, c’eravamo amati, andava finché andava... senza altre complicazioni... tu invece vedi doppio, vedi fantastico, terribile quello che è chiaro limpido sereno, transitorio... Vedi che ti parlo sinceramente come non ti hanno parlato forse tutti gli altri. O forse lo hanno fatto, ma in loro cuore avevano il bacillo dell’amore unico, turbinoso, che fonde, innalza, e al quale io non credo. Infatti Papini ha moglie, Gerace la prende e tentativi di collage hanno fatto altri che tu sai e che io non nomino. Io non posso amare nessuna donna. Ho delle grandi tenerezze ma mi guardo bene di entrare nella vita della donna che incontro. Se vi entrassi sarebbe troppo da padrone, insaziabile e ingiusto senza risultato... tutte le donne che ho amato appartenevano ad altri... Che cosa può interessarmi tutta la complicazione interna quando in questi giorni le forme e i colori mi appaiono incerti?“. (20)
 “Hai parlato sul serio della mia troppa aderenza alla vita... Sì, sono donna, sono umana. Tutto ciò che la mia intelligenza ha riconosciuto dacché s’è destata, tutto ciò che il mio spirito ha dominato, non impedisce alle mie fibre di mantenersi materne, non impedisce che io abbia un senso di calore e di tenerezza e di rispetto per tutto quanto è vita semplice, vita genuina... Può darsi che ci sia davvero qualcosa alla fin fine di ripugnante in questo mio pertinace naturalismo... O questo risultato tocca i tuoi nervi più che altro per un di quegli apriorismi che in altre circostanze condanni? Disprezzo della natura? Amico mio! Ma il giorno in cui io entro nel tuo studio e trovo la tua giovinezza creatrice e ti ascolto parlarmi di forme... e tu mi conduci davanti a tua madre, bella mentre ti prepara la cena, e l’abbracci perché ti dico che è bella, amico, dove pensi tu che io distingua fra arte e natura, fra spirito e sangue? Io ho in quel giorno di te un senso totale... E tu mi hai amata proprio per la mia sensibilità, per la mia assurda passionalità, per il mio ingenuo, credulo e mai stanco cuore. E le mie virtù sono forse due sole, la sincerità e il coraggio”. (21)
“Hai parlato sul serio della mia troppa aderenza alla vita... Sì, sono donna, sono umana. Tutto ciò che la mia intelligenza ha riconosciuto dacché s’è destata, tutto ciò che il mio spirito ha dominato, non impedisce alle mie fibre di mantenersi materne, non impedisce che io abbia un senso di calore e di tenerezza e di rispetto per tutto quanto è vita semplice, vita genuina... Può darsi che ci sia davvero qualcosa alla fin fine di ripugnante in questo mio pertinace naturalismo... O questo risultato tocca i tuoi nervi più che altro per un di quegli apriorismi che in altre circostanze condanni? Disprezzo della natura? Amico mio! Ma il giorno in cui io entro nel tuo studio e trovo la tua giovinezza creatrice e ti ascolto parlarmi di forme... e tu mi conduci davanti a tua madre, bella mentre ti prepara la cena, e l’abbracci perché ti dico che è bella, amico, dove pensi tu che io distingua fra arte e natura, fra spirito e sangue? Io ho in quel giorno di te un senso totale... E tu mi hai amata proprio per la mia sensibilità, per la mia assurda passionalità, per il mio ingenuo, credulo e mai stanco cuore. E le mie virtù sono forse due sole, la sincerità e il coraggio”. (21)
 “Grazie di tutte le vostre lettere... anche troppe... siete incorreggibile! Non fate la donna cataclisma o ciclone o epidemia... Siate ragionevole e non infantilmente e letterariamente esaltata”. (22)
“Grazie di tutte le vostre lettere... anche troppe... siete incorreggibile! Non fate la donna cataclisma o ciclone o epidemia... Siate ragionevole e non infantilmente e letterariamente esaltata”. (22)
 “Tu sei al mondo per dipingere e per scolpire, io sono al mondo per comprendere... La sola realtà è che esistiamo io e te... io e te, soli”. (23)
“Tu sei al mondo per dipingere e per scolpire, io sono al mondo per comprendere... La sola realtà è che esistiamo io e te... io e te, soli”. (23)
 “Nessuno mi ha mai vista dormire. Ho vegliato io tanti sonni...quante vite ho respirato! Lo sai che sei il solo uomo forte che ho incontrato? Era necessario che io mi foggiassi illudendomi di foggiare altrui, ch’io mi accanissi come tu mi hai scritto, a costruire su sabbie mobili: cercavo unicamente me stessa”. (24)
“Nessuno mi ha mai vista dormire. Ho vegliato io tanti sonni...quante vite ho respirato! Lo sai che sei il solo uomo forte che ho incontrato? Era necessario che io mi foggiassi illudendomi di foggiare altrui, ch’io mi accanissi come tu mi hai scritto, a costruire su sabbie mobili: cercavo unicamente me stessa”. (24)
 “Ho tanto bisogno di gioia!Mi tendo alla gioia come una appena nata...In queste ultime settimane m’ero riaggrappata alla vita, perché speravo di ritrovarti..-Che vale l’orgoglio? Perché mentire? Senza amore non si vive. Ti amo...Ho bisogno di te...Tu non piangi, è vero, mentre io ho ore come queste...Ma non è inferiorità la mia...sono donna, sono una madre che ha perduto il figlio, sono la bambina che è stata violata inconsapevolmente...quando piango è tutto il mio passato ch’io ho -vinto che si vendica”. (25)
““La mia amicizia vi deve bastare non so cosa dirvi mia buona amica se non: lavorate”. (26)
“Ho tanto bisogno di gioia!Mi tendo alla gioia come una appena nata...In queste ultime settimane m’ero riaggrappata alla vita, perché speravo di ritrovarti..-Che vale l’orgoglio? Perché mentire? Senza amore non si vive. Ti amo...Ho bisogno di te...Tu non piangi, è vero, mentre io ho ore come queste...Ma non è inferiorità la mia...sono donna, sono una madre che ha perduto il figlio, sono la bambina che è stata violata inconsapevolmente...quando piango è tutto il mio passato ch’io ho -vinto che si vendica”. (25)
““La mia amicizia vi deve bastare non so cosa dirvi mia buona amica se non: lavorate”. (26)Matacotta
Il sogno d’amore si può porre come fusionalità, unione di due esseri in uno, osmosi reciproca, solo finché è tenuto fuori della storia, nel sogno. Portato nei rapporti reali diventa evidente il sacrificio materno. È nel rapporto col giovane Matacotta che il sogno d’amore, proprio perché torna a modellarsi sui protagonisti dell’origine (madre e figlio), sembra per un verso avvicinarsi di più alla fusione con l’altro, per l’altro invece lascia allo scoperto la “schiavitù” che si nasconde dietro l’istinto di grandezza della donna madre, la pretesa di infanzia per sé che si nasconde dietro il prodigarsi per l’altro. Al “gelo” e all’”estasi” della passione amorosa subentra il “mesto e lucido sguardo”, Sibilla comincia a ricostruire la sua individualità, il “fastidioso obbligo di vivere per sé”.
Negli ultimi anni a sorreggerla sarà “l’amore per l’idea”, la “lotta insieme ai compagni”, ma l’impegno politico di Sibilla resta sfocato. Nel Diario Sibilla parla di una “sensazione di ordine, di intima onestà e armonia”, di una “vecchiaia limpida e serena”, che richiama la sua giovinezza “limpida e gagliarda”. Ma l’armonia non è più il frutto dell’istinto di grandezza, dello sforzo titanico di comporre gli opposti; al contrario è un senso di “ricchezza” e di “verità” che si dà solo decantando i poli della dualità.
 “Che cosa vuoi tu, per me... Ch’io mi liberi da tutte le contingenze e mi dissolva infine negli spazi come musica e come luce... O prepari per me, in codesto silenzio sacro come quello che precede l’alba nei cicli, un nuovo stato inaudito, dov’io appena mi riconoscerò, tanto sarò alleviata da ogni ansia?“. (27)
“Che cosa vuoi tu, per me... Ch’io mi liberi da tutte le contingenze e mi dissolva infine negli spazi come musica e come luce... O prepari per me, in codesto silenzio sacro come quello che precede l’alba nei cicli, un nuovo stato inaudito, dov’io appena mi riconoscerò, tanto sarò alleviata da ogni ansia?“. (27)
 “Cos’è quest’affetto per lui più forte del mio istinto vitale? Il mio istinto mi dice che devo riconquistarmi, che devo avere la forza di lasciarlo mentre ancora m’ama... Ma l’immagine dei giorni che verranno per me senza di lui... di libertà totale, libertà, silenzio, lenta creazione in me stessa di vita esclusivamente mia, questa immagine mi atterra, mi stempera, come dinanzi a un cadavere”. (28)
“Cos’è quest’affetto per lui più forte del mio istinto vitale? Il mio istinto mi dice che devo riconquistarmi, che devo avere la forza di lasciarlo mentre ancora m’ama... Ma l’immagine dei giorni che verranno per me senza di lui... di libertà totale, libertà, silenzio, lenta creazione in me stessa di vita esclusivamente mia, questa immagine mi atterra, mi stempera, come dinanzi a un cadavere”. (28)
 “Ho bisogno di essere necessaria a un’altra creatura viva per vivere. Questa è la mia verità. Quando Franco era qui, fino a quell’ultima settimana di esasperazione crudele, mi pareva a tratti, l’ho già detto, che la sua partenza mi sarebbe stata di sollievo, mi pareva d’anelare alla solitudine e alla libertà, e che ritrovandole, quelle mie antiche compagne, avrei ripreso a lavorare... Ma appena rimasta sola ho compreso. Ecco, l’amore è questo: l’attaccamento a una persona alla quale ci si crede necessari. L’amore nella donna, almeno, e in quegli uomini nei quali predomina l’elemento femminile. Per otto anni io ho dato tutto di me a Franco... ho compiuto quest’atto, sacrilego dal punto di vista della individualità, perché amavo quel fanciullo che cresceva della mia sostanza... morivo e rinascevo in lui ogni giorno, felice e infelice, ma ubbidendo a una sorte, a una legge, e anche, sì, a una musica, a un’armonia misteriosa, di là d’ogni contrasto”. (29)
“Ho bisogno di essere necessaria a un’altra creatura viva per vivere. Questa è la mia verità. Quando Franco era qui, fino a quell’ultima settimana di esasperazione crudele, mi pareva a tratti, l’ho già detto, che la sua partenza mi sarebbe stata di sollievo, mi pareva d’anelare alla solitudine e alla libertà, e che ritrovandole, quelle mie antiche compagne, avrei ripreso a lavorare... Ma appena rimasta sola ho compreso. Ecco, l’amore è questo: l’attaccamento a una persona alla quale ci si crede necessari. L’amore nella donna, almeno, e in quegli uomini nei quali predomina l’elemento femminile. Per otto anni io ho dato tutto di me a Franco... ho compiuto quest’atto, sacrilego dal punto di vista della individualità, perché amavo quel fanciullo che cresceva della mia sostanza... morivo e rinascevo in lui ogni giorno, felice e infelice, ma ubbidendo a una sorte, a una legge, e anche, sì, a una musica, a un’armonia misteriosa, di là d’ogni contrasto”. (29)
 “Ero tornato, ma potevo anche ripartire o soltanto scendere, senza dirle più dove andavo, andare sulla strada, o più lontano per una mia cosa qualunque, forse una donna. Quant’era facile questa parte di figlio. E che agio estremo muoversi come figlio in quella stanza piena della sua intelligenza serena di madre, solo che lei madre si rassegnasse a riconoscersi”. (30)
“Ero tornato, ma potevo anche ripartire o soltanto scendere, senza dirle più dove andavo, andare sulla strada, o più lontano per una mia cosa qualunque, forse una donna. Quant’era facile questa parte di figlio. E che agio estremo muoversi come figlio in quella stanza piena della sua intelligenza serena di madre, solo che lei madre si rassegnasse a riconoscersi”. (30)Sibilla e il femminismo
Anticipatore è anche il giudizio che Aleramo dà sul femminismo di inizio secolo, un giudizio a posteriori, poiché ai primi del Novecento è ancora orientata a cercare l’armonia fra i rami divisi del tronco umano, “divina funzione della donna”. Il femminismo nasce dalla coscienza di un “malessere diffuso e oscuro”, ma subito per fretta e per paura sceglie altre strade. L’emancipazione viene intesa come gara materiale con l’uomo, imitazione ed emulazione dell’uomo. Sibilla riconosce che è “logico e giusto” che la donna pretenda “un uguale compenso ed un uguale rispetto”,”gli stessi diritti civili e politici”, visto che ha dimostrato di saper resistere come l’uomo alle “fatiche manuali e intellettuali”. Ma sa anche che tutto questo “avviene specialmente per forza di cose, e forse spesso contro lo stesso desiderio intimo della donna”, “è il prodotto dei tempi, della civiltà industriale e democratica, non della rivoluzione”. (31)
È interessante allora capire che cos’è questo desiderio intimo della donna, se non è proprio da lì che nasce il malessere oscuro e quindi la spinta al cambiamento. Sicuramente ha a che fare con “l’atavismo muliebre”, la difficoltà a rinunciare a “prerogative antiche” (quella, per esempio, che l’ha vista al centro della casa), ma va messo in relazione anche col fatto che la donna si è accontentata finora di una rappresentazione del mondo fornita dall’intelligenza maschile, aprioristicamente ammessa, poi compresa per virtù d’analisi. Questo sforzo per adattare la propria intelligenza a quella dell’uomo ha impedito alla donna di ascoltare se stessa, di dire ciò che sentiva, intuiva, di ascoltare i comandi del suo organismo e della sua psiche, trovare in sé elementi di genialità.
L’individualità femminile - sensi e ragione - è perciò ancora da costruire, come ricerca di una “interiore autonomia”, sapendo che questo risveglio sarà molto doloroso perché vuol dire prendere distanza da tutto ciò che esse hanno amato e in cui hanno creduto: “tragicamente autonome”. Tanto che l’Aleramo si chiede se “l’esser desta” non si prospetti più triste del “lungo sonno”. Per questa costruzione di sé era necessario però non avere fretta né paura, ma “saper sostare prima alquanto e interrogarsi”.
Infine, una notazione sul linguaggio: i nomi, dice Sibilla, di cui ci serviamo per tutte le cose sono stati creati da altri, tutti i nomi, per sempre, ma quel che importa non è nominare, è mostrare le cose, con il linguaggio che ci è dato. Si potrebbe dire che Sibilla ha mostrato l’”innominabile”.
Note
 1) Sibilla Aleramo, Un amore insolito, Feltrinelli 1979, pag.125.
1) Sibilla Aleramo, Un amore insolito, Feltrinelli 1979, pag.125.
 2) Sibilla Aleramo, Una donna, Feltrinelli 1979, p. 183.
2) Sibilla Aleramo, Una donna, Feltrinelli 1979, p. 183.
 3) Sibilla Aleramo, Un amore insolito, cit., pag.21.
3) Sibilla Aleramo, Un amore insolito, cit., pag.21.
 4) Sibilla Aleramo, Diario di una donna, Feltrinelli 1980, pag.263.
4) Sibilla Aleramo, Diario di una donna, Feltrinelli 1980, pag.263.
 5) Ibidem, pag. 441.
5) Ibidem, pag. 441.
 6) Sibilla Aleramo, Andando e stando, Mondadori 1942, pag.126.
6) Sibilla Aleramo, Andando e stando, Mondadori 1942, pag.126.
 7) Sibilla Aleramo e il suo tempo. Vita raccontata e illustrata a cura di Bruna Conti e Alba Morino, Feltrinelli 1981, pag. 84.
7) Sibilla Aleramo e il suo tempo. Vita raccontata e illustrata a cura di Bruna Conti e Alba Morino, Feltrinelli 1981, pag. 84.
 8) Ibidem, pag. 142.
8) Ibidem, pag. 142.
 9) Ibidem, pagg. 179-180.
9) Ibidem, pagg. 179-180.
 10) Sibilla Aleramo e il suo tempo, cit.,pag. 100.
10) Sibilla Aleramo e il suo tempo, cit.,pag. 100.
 11) Sibilla Aleramo. La donna e il femminismo.,Editori Riuniti 1978, pag.170.
11) Sibilla Aleramo. La donna e il femminismo.,Editori Riuniti 1978, pag.170.
 12) Ibidem, pag.178.
12) Ibidem, pag.178.
 13) Sibilla Aleramo, Il Passaggio, Mondadori 1932, pagg.115-116-117.
13) Sibilla Aleramo, Il Passaggio, Mondadori 1932, pagg.115-116-117.
 14) Sibilla Aleramo, Una donna, cit., 74-75.
14) Sibilla Aleramo, Una donna, cit., 74-75.
 15) Ibidem, pag.143.
15) Ibidem, pag.143.
 16) Ibidem, pag. 182.
16) Ibidem, pag. 182.
 17) Sibilla Aleramo, Il passaggio, cit., pag.95.
17) Sibilla Aleramo, Il passaggio, cit., pag.95.
 18) Sibilla Aleramo. La donna e il femminismo, cit., pag.176.
18) Sibilla Aleramo. La donna e il femminismo, cit., pag.176.
 19) Sibilla Aleramo e il suo tempo, cit., 89.
19) Sibilla Aleramo e il suo tempo, cit., 89.
 20) Ibidem, pag.89-90.
20) Ibidem, pag.89-90.
 21) Ibidem, pag.83.
21) Ibidem, pag.83.
 22) Ibidem, pag. 90.
22) Ibidem, pag. 90.
 23) Ibidem, pag.100.
23) Ibidem, pag.100.
 24) Ibidem, pag.100.
24) Ibidem, pag.100.
 25) Ibidem, pag. 10-103.
26) Ibidem, pag.104.
25) Ibidem, pag. 10-103.
26) Ibidem, pag.104.
 27) Sibilla Aleramo, Amo dunque sono, Mondadori 1982, pag.42.
27) Sibilla Aleramo, Amo dunque sono, Mondadori 1982, pag.42.
 28) Sibilla Aleramo, Un amore insolito, cit., pag.46.
28) Sibilla Aleramo, Un amore insolito, cit., pag.46.
 29) Ibidem, pag. 291.
29) Ibidem, pag. 291.
 30) Sibilla Aleramo e il suo tempo, cit., pag.283.
30) Sibilla Aleramo e il suo tempo, cit., pag.283.
 31) Sibilla Aleramo. La donna e il femminismo, cit., pag.181.
31) Sibilla Aleramo. La donna e il femminismo, cit., pag.181.
-
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- TROIA: "IL SOGNO DELLA BELLEZZA". La guerra dei primordi è la perversione di un sogno umanamente comprensibile (di Roberto Mussapi)30 gennaio 2019, di Federico La Sala
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. In principio era il Logos ... *
Il sogno della Bellezza
di Roberto Mussapi (Avvenire, mercoledì 30 gennaio 2019)
«Un tempo mi stupivo perché una guerra così lunga/ d’Europa e d’Asia davanti a Pergamo/ fosse stata causata da una donna./ Adesso vi comprendo, siete stati saggi,/ Paride e Menelao, tu a rivolerla, / Paride a non volerla cedere. / Fu così bella che valse la pena// che in suo onore Achille morisse, / e Priamo lodasse le cause della guerra.»
Molteplici le cause delle guerre. Spesso economiche, a volte mascherate da valori civili, patriottici o religiosi. Qui però non ci riferiamo a una delle tante tragiche guerre storiche, ma alla prima, che, anche se realmente avvenuta, diviene mito di fondazione del nostro mondo. Troia esiste e fu assalita e arsa dalla lega dei greci.
Ma pur se storica, quella vicenda è mitica, oltre il tempo della storia e del calendario: un poeta, Properzio, il primo ma non l’unico, intuisce il mistero e il segreto di quella terribile contesa: Elena, moglie di un nobile greco, fuggita con un principe troiano: Elena sarà dell’uno e dell’altro, e mai di nessuno definitivamente. È la bellezza assoluta, irraggiungibile, che nessuno potrà mai definitivamente possedere.
La guerra dei primordi è la perversione di un sogno umanamente comprensibile: ognuno di noi vuole la Bellezza, e non comprende che non può essere solo sua. Ci preesiste.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
 TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
TROIA, L’OCCIDENTE, E IL PIANETA TERRA. PER LA PACE PERPETUA.
L’EUROPA, LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
- Doomsday Clock.... Fine della Storia o della "Preistoria"?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- ALLA RICERCA DELLA TERZA VIA. Lou Salomé e "a materia erotica". Cruciale il suo apporto alla picoanalisi con lo studio del narcisismo (di D. Di cesare).28 gennaio 2019, di Federico La Sala
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.... *
Lou von Salomé
Esplorò la forza dell’eros
L’incontro imponderabile che unisce due estraneità
Bellissima e spregiudicata visse l’amore con trasporto fisico e con slancio intellettuale seducendo Rilke e Nietzsche
Cruciale il suo apporto alla picoanalisi con lo studio del narcisismo
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, La Lettura, 27.01.2019)
L’amore è stato il filo della sua esistenza turbolenta e frammentata, scandita da innumerevoli legami appassionati e drammatici, dai quali lei sembrava ogni volta uscire quasi illesa. Non si contano invece le vittime, più o meno consenzienti, di quei rapporti. Intellettuali, pittori, filosofi, poeti: da Friedrich Nietzsche a Rainer Maria Rilke.
 Bellissima e piena di fascino, tenera e volitiva, eccentrica e indomabile, Lou (diminuitivo di Louise) von Salomé rappresenta una figura emblematica che si staglia nell’orizzonte del Novecento europeo agitato da rivolgimenti politici ed esistenziali. Qualsiasi giudizio si voglia emettere su questa donna spregiudicata e anticonformista, certo è che a lei toccò in sorte di esplorare, nei suoi meandri più oscuri, non tanto l’anima della donna, quanto la passione erotica femminile.
Bellissima e piena di fascino, tenera e volitiva, eccentrica e indomabile, Lou (diminuitivo di Louise) von Salomé rappresenta una figura emblematica che si staglia nell’orizzonte del Novecento europeo agitato da rivolgimenti politici ed esistenziali. Qualsiasi giudizio si voglia emettere su questa donna spregiudicata e anticonformista, certo è che a lei toccò in sorte di esplorare, nei suoi meandri più oscuri, non tanto l’anima della donna, quanto la passione erotica femminile.Nata a San Pietroburgo nel 1861, trascorse gran parte della sua vita in Germania, nella piccola città universitaria di Gottinga, dove morì nel 1937, in tempo per osservare da vicino la catastrofe. Poco tempo dopo la sua scomparsa, gli agenti della Gestapo ne confiscarono la biblioteca. Ai loro occhi quella specie di strega aveva più di una colpa: soprattutto si era occupata di psicoanalisi, la «scienza ebraica» per eccellenza. Non l’aveva forse escogitata Sigmund Freud?
Pur considerando la scrittura un’attività quasi secondaria, che accompagnava la sua sete di vivere, la sua curiosità intellettuale, il fervore con cui si abbandonava ai rapporti umani, Lou Salomè ha lasciato venti libri e oltre cento saggi, articoli, recensioni. Potrebbe essere definita una scrittrice, se non fosse che ciò che ne contraddistingue il lascito sono proprio gli scritti di stampo psicoanalitico, in cui le esperienze biografiche si coniugano con una introspezione originale.
 Con il titolo La materia erotica. Scritti di psicoanalisi, la casa editrice Mimesis ha pubblicato di recente una raccolta, curata da Jutta Prasse. L’arco di tempo va dal 1900, data d’uscita del primo saggio Riflessioni sul problema dell’amore, al 1921, anno a cui risale Il narcisismo come doppio orientamento, dove non è difficile scorgere le tracce del dialogo serrato con Freud.
Con il titolo La materia erotica. Scritti di psicoanalisi, la casa editrice Mimesis ha pubblicato di recente una raccolta, curata da Jutta Prasse. L’arco di tempo va dal 1900, data d’uscita del primo saggio Riflessioni sul problema dell’amore, al 1921, anno a cui risale Il narcisismo come doppio orientamento, dove non è difficile scorgere le tracce del dialogo serrato con Freud.Perché quell’interesse proprio per la scuola di Freud e non, ad esempio, per l’indirizzo rappresentato da Gustav Jung? La risposta sta nel valore che la psicoanalisi attribuiva alla pulsione sessuale. Lou vedeva così confermata un’idea di cui si era andata convincendo già prima di conoscere personalmente Freud a Weimar, nel 1911, nel Congresso della Società psicoanalitica Internazionale. Quell’incontro fu per lei decisivo perché le fornì i mezzi per sbrogliare l’intrigo della materia erotica che la teneva avvinghiata sin dalla giovinezza.
La forza misteriosa dell’amore era sconvolgente, inebriante, ma anche demoniaca e distruttiva. Affine alla creazione artistica del genio, poteva innalzare a vette supreme o spingere negli abissi più meschini. Di questo aveva già narrato la grande letteratura ottocentesca immortalando i ritratti di Emma Bovary e Anna Karenina, eroine tragiche le cui storie avrebbero dovuto provare l’impossibilità di conciliare amore sessuale e serenità coniugale.
 Per Lou era tempo di cercare una terza via, senza rinunciare al rifugio di un compagno, ma senza neppure abdicare alla rigenerazione dell’amore. Il che non voleva dire abbandonarsi ad una facile promiscuità, consegnarsi all’avventura fortuita e banale.
Per Lou era tempo di cercare una terza via, senza rinunciare al rifugio di un compagno, ma senza neppure abdicare alla rigenerazione dell’amore. Il che non voleva dire abbandonarsi ad una facile promiscuità, consegnarsi all’avventura fortuita e banale.Proprio perché scorgeva nell’amore la forza vitale per eccellenza, scelse di viverlo fino in fondo, con trasporto fisico, ma anche con slancio intellettuale, consapevole della transitorietà di quell’energia che cessava inspiegabilmente, così come nascostamente era sgorgata. Occorreva solo essere pronti e prendere a piene mani la felicità nell’attimo, senza arrovellarsi troppo sul dopo. Pretendere di dare durata a quella passione avrebbe significato essere del tutto irrealistici. Non si può promettere di essere fedeli quando è in gioco l’amore. Di questo aveva discusso a lungo con Nietzsche, che per anni aveva eletto a maestro. Si intuisce perché quella sua irrequieta disinvoltura disorientava i partner, conducendoli talvolta a gesti estremi, in taluni casi teatrali.
Nonostante i conflitti interiori, quello in particolare tra un cuore impulsivo e una volontà imperiosa, Lou superò una dopo l’altra anche le rotture più drammatiche, persuasa della necessità di addentrarsi nel mistero della vita, di esplorarne le vie tortuose, fino ad elevare quella sfera sepolta dell’inconscio alla dignità della coscienza. Quasi in un estenuante esperimento, amava come viveva, viveva come amava. Con spontaneità, ma anche con serietà.
In questa indagine dell’eros, nel suo significato più ampio e profondo, Lou non poteva non votarsi alla vita altrui, perché l’amore è anzitutto il bisogno impellente dell’altro. Si interrogò perciò anche sulla modalità e il valore della fusione, che nell’uomo, in cerca di un’identità rafforzata, rischia di diventare esigenza di possesso, smania di appropriazione, volontà di sottomissione. Questo non avviene nella donna, che - osserva nel saggio Il tipo femmina - sperimenta già sempre l’altro in sé, che è sempre già duale e divisa in sé stessa, laddove «il maschio permane univocamente aggressivo».
 Forse si può dire che il suo contributo più rilevante alla psicoanalisi sia lo studio sul narcisismo, che è senza dubbio amore di sé, egocentrismo spinto all’estremo, capace di cancellare del tutto l’altro, ma che a ben guardare ha mille sfaccettature spesso trascurate. Il narcisismo può comprendere persino la sottomissione.
Forse si può dire che il suo contributo più rilevante alla psicoanalisi sia lo studio sul narcisismo, che è senza dubbio amore di sé, egocentrismo spinto all’estremo, capace di cancellare del tutto l’altro, ma che a ben guardare ha mille sfaccettature spesso trascurate. Il narcisismo può comprendere persino la sottomissione.Se qualche decennio fa i testi di Lou von Salomé, con le sue osservazioni provocatorie e talvolta parossistiche, hanno avuto un effetto dirompente, scardinando vecchi luoghi comuni e stimolando il pensiero femminista, oggi non possono non essere lette con occhi diversi. Resta, però, l’originalità della sua riflessione e di quel suo modo di considerare il rapporto erotico non come l’eterna inimicizia tra i sessi, bensì come l’incontro imponderabile tra due estraneità. Ed è proprio ciò che spinge all’unione.
L’amore, forma intermedia tra l’ipseità del singolo e la fraternizzazione comunitaria dei molti, tra egoismo e altruismo, dischiude dunque una sfera che ciascuno è chiamato a esplorare, ma che in nessun modo può essere sottovalutata, ritenuta inferiore, cancellata nell’esistenza umana.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
LA MENTE ACCOGLIENTE: L’EUROPA, LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE, E LA LEZIONE DI NIETZSCHE.
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali.24 gennaio 2019, di Federico La Sala
COME IL BUON-GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").... *
- "[...] alla nascita di Cristo nella capanna semiaperta era subito presente il mondo intero, i pastori e i savi d’Oriente" (F. Kafka, Lettera a Helli Hermann, autunno 1921)
- "L’immagine del corpo mistico di Cristo è molto seducente, ma l’importanza che si annette oggi a questa immagine mi pare uno dei sintomi più gravi della nostra decadenza. La nostra vera dignità infatti non sta nell’essere membra di un corpo, anche se mistico, anche se quello di Cristo, ma in questo: nello stato di perfezione, al quale tutti aspiriamo, noi non viviamo più in noi stessi, ma è Cristo che vive in noi; in questa condizione, Cristo nella sua integrità, nella sua unità indivisibile, diviene, in certo senso, ognuno di noi, come è tutto intero nell’ostia. Le ostie non sono frammenti del suo corpo. L’importanza attuale dell’immagine del corpo mistico dimostra quanto i cristiani siano miseramente esposti alle influenze esterne. Certo inebriante sentirsi membro del corpo mistico del Cristo: ma oggi molti altri corpi mistici, che non hanno Cristo come capo, procurino alle proprie membra un’ebbrezza, a mio parere, della stessa natura" (Simone Weil, 1942.)
Messaggio.
Il Papa: ecco la Rete che vogliamo. Per liberare, non intrappolare
Oggi, memoria di san Francesco di Sales, pubblicato il Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali che sarà celebrata il 2 giugno
di Gianni Cardinale (Avvenire, giovedì 24 gennaio 2019)
Internet «rappresenta una possibilità straordinaria di accesso al sapere», ma è anche «uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla distorsione consapevole e mirata dei fatti e delle relazioni interpersonali, che spesso assumono la forma del discredito». La rete poi «è un’occasione per promuovere l’incontro con gli altri», ma «può anche potenziare il nostro autoisolamento, come una ragnatela capace di intrappolare». Ecco quindi che il web deve essere fatto non «per intrappolare, ma per liberare».
Lo scrive papa Francesco nel Messaggio, diffuso oggi, per la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che quest’anno si celebra, in molti Paesi, domenica 2 giugno, Solennità dell’Ascensione del Signore.
Il Messaggio del Pontefice è pubblicato come da tradizione nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Ed ha come titolo «’Siamo membra gli uni degli altri’ (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità umana» (IL TESTO INTEGRALE).
Nel testo il Pontefice denuncia l’uso dei social per fomentare "spirali di odio" e "ogni tipo di pregiudizio", nonché i rischi del cyberbullismo, del narcisismo e dell’autoisolamento che porta al fenomeno degli "eremiti sociali". Papa Francesco inoltre ribadisce che la rete deve fondarsi "sulla verità" e non "sui like".
Per Papa Francesco «le reti sociali, se per un verso servono a collegarci di più, a farci ritrovare e aiutare gli uni gli altri, per l’altro si prestano anche ad un uso manipolatorio dei dati personali, finalizzato a ottenere vantaggi sul piano politico o economico, senza il dovuto rispetto della persona e dei suoi diritti». Senza contare che «tra i più giovani le statistiche rivelano che un ragazzo su quattro è coinvolto in episodi di cyberbullismo».
Usando la metafora della rete come comunità, il Pontefice osserva come «nello scenario attuale, la social network community non sia automaticamente sinonimo di comunità». Infatti «nei casi migliori le community riescono a dare prova di coesione e solidarietà, ma spesso rimangono solo aggregati di individui che si riconoscono intorno a interessi o argomenti caratterizzati da legami deboli».
Come ritrovare allora «la vera identità comunitaria nella consapevolezza della responsabilità che abbiamo gli universo gli altri anche nella rete online?».
Una possibile risposta, scrive papa Francesco, «può essere abbozzata» a partire da un’altra metafora, quella del corpo e delle membra, che san Paolo usa nella Lettera agli Efesini «per parlare della relazione di reciprocità tra le persone, fondata in un organismo che le unisce». Infatti «l’essere membra gli uni degli altri è la motivazione profonda, con la quale l’Apostolo esorta a deporre la menzogna e a dire la verità: l’obbligo a custodire la verità nasce dall’esigenza di non smentire la reciproca relazione di comunione».
Per il Pontefice «l’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è complementare all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro». Così quando «la rete è usata come prolungamento o come attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la comunione». Quando «una famiglia usa la rete per essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli occhi, allora è una risorsa». Quando «una comunità ecclesiale coordina la propria attività attraverso la rete, per poi celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa». Quando “la rete è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da me, per pregare insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una risorsa”.
La «rete che vogliamo» conclude papa Francesco è «la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla carezza...». Una rete insomma «non fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire una comunione di persone libere». E la Chiesa stessa «è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si fonda sui ‘like’, ma sulla verità, sull’’amen’, con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri».
Il Messaggio del Pontefice ha raccolto il plauso di Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione della Stampa: "È un’esortazione e un invito alla riflessione".
Vedi anche: Ecco la nuova App Cei per restare informati sulla vita della Chiesa e non solo
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"Dominus Iesus": RATZINGER, LO "STERMINATORE DI ECUMENISMO". Un ’vecchio’ commento del teologo francescano Leonard Boff
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- SALOMONE E IL SEGRETO DELLA REGINA DI SABA.22 gennaio 2019, di Federico La Sala
Il segreto di Saba
di Roberto Mussapi (Avvenire, martedì 22 gennaio 2019)
«Non c’è uomo né donna sotto i cieli/ che possa osare competere/ in conoscenza e sapere con noi due,/ e noi per tutto il giorno abbiamo trovato/ che niente al mondo può fare del mondo/ uno stretto recinto, se non l’amore».
Versi di uno dei massimi poeti, William Butler Yeats. Il lettore ora conosca il titolo della poesia, Salomone a Saba, e i primi due versi: «Salomone cantò a Saba,/ baciandole il volto bruno»: il poeta immagina l’incontro tra il re più sapiente degli Ebrei e la maga, la donna regina di Saba depositaria del sapere antico, magico.
Le parole di Salomone sono quelle di Yeats che intuisce la fusione di magia e sapienza, le introduce con due versi: «Salomone cantò a Saba,/ baciandole gli occhi da araba». Salomone ha trovato la comprensione definitiva dell’essere umano, solo dopo avere baciato gli occhi d’araba di Saba: scopre che l’essenza della vita è fusione tra sapienza (che non è erudizione) e magia (che è senso creaturale, non occultismo): sapienza e magia si baciano e abbracciano, per trovare il segreto e l’ origine di tutto: l’amore. Che crea un impercettibile ai sensi ma reale recinto: senza amore tutto si disperde, anche le parole e i sospiri di chi ama. L’amore crea recinto, confine libero, spazio ordinato e definito, armonia.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- FILOSOFIA E MEDICINA. I medici nascono senza frontiere (di Roberto Mussapi).18 gennaio 2019, di Federico La Sala
I medici nascono senza frontiere
di Roberto Mussapi (Avvenire, venerdì 18 gennaio 2019)
«In quante case io entri mai, vi giungerò per il giovamento dei pazienti tenendomi fuori da ogni ingiustizia e da ogni altro guasto, particolarmente da atti sessuali sulle persone sia di donne che di uomini, sia liberi sia schiavi». Siamo all’inizio di uno scritto che segna una tappa fondamentale della civiltà: il Giuramento di Ippocrate, il medico che fonda il compito e traccia le basi della sua arte. «Io giuro su Apollo medico e Asclepio e Igieia e Panacea, e su tutti gli dei e le dee, prendendoli a miei testimoni...».
Il giuramento di Ippocrate, su cui si fonda la medicina, è fatto agli dèi, il compito del medico non riguarda esclusivamente il mondo della polis, ma è vincolato a quello sacro del divino. Studi recenti datano il giuramento intorno al V secolo a. C, il secolo che vede nascere la tragedia come genere teatrale di poesia, e la filosofia, pensiero come logos. Alle spalle il rito dionisiaco tragico, e il pensiero dei presocratici, i baldi e travolgenti scienziati-poeti. Prodigioso momento di creazione dei Greci che fondano l’Occidente.
Cittadini di una democrazia, non servi di un Re come gli Egizi o i Persiani. Ma civiltà non ancora compiuta. Le donne non godono di diritti civili, né considerazione, meno ancora degli schiavi. Insomma molestare una donna, o uno schiavo, non è, per il greco del tempo, così grave. Non sono cittadini, maschi.
Per Ippocrate invece è la stessa cosa. Supera i limiti della sua civiltà. Va oltre: giuro di non fare violenza a nessuno, perché tutti, comprese donne e schiavi, sono, siamo uguali. Supera i pensatori del suo tempo. È un medico. I medici nascono senza frontiere.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) -- NON UNA DI MENO. Una ribellione diversa. Una giornata di sciopero delle donne (di Lea Melandri).11 gennaio 2019, di Federico La Sala
UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".... *
Una ribellione diversa
di Lea Melandri *
Sabato 12 gennaio si terrà a Milano, nella Casa della donne, l’assemblea di “Non una di meno” in preparazione dello “sciopero delle donne dell’8 marzo“.
Una giornata di sciopero delle donne ha un evidente significato forte per diversi motivi.
Sovverte un ordine che, dato come “naturale”, ha permesso di protrarre per secoli il dominio di un sesso sull’altro, la consegna delle donne al ruolo di madri, mogli, figlie, sorelle “di”, custodi della famiglia e della continuità della specie; la cura e il lavoro domestico possono finalmente essere visti per quello che sono sempre stati: “un grande aggregato dell’economia” (per dirla con Antonella Picchio), il sostegno materiale, psicologico, affettivo all’impegno “civile” dell’uomo.
“Per secoli - come scrive Virginia Woolf - le donne sono state gli specchi magici in cui si rifletteva la figura dell’uomo raddoppiata. Senza questa facoltà, la terra probabilmente sarebbe ancora palude e giungla”. Questi specchi sono stati “indispensabili ad ogni azione violenta ed eroica”.
Favorisce la presa di coscienza che “vivere per l’altro e attraverso l’altro” è stata la conseguenza dell’espropriazione di esistenza propria che le donne hanno subito, asservimento dei loro corpi e dei loro pensieri, cancellazione del loro tempo, confuso con l’immobilità delle leggi naturali.
Afferma visibilmente, con migliaia di presenze nelle strade e nelle piazze, che le “porte di casa”, le solitudini “private”, si aprono solo attraverso la costruzione di una socialità inedita tra donne, fatta di amicizia, amore, azione, intelligenza di sé e del mondo sottratta a modelli imposti e interiorizzati;
Lo sciopero delle donne, inoltre, porta allo scoperto la cultura e le pratiche politiche che fanno del femminismo la “rivoluzione più lunga”, ma anche la più “radicale” nello svelamento del sessismo - eterosessismo, superiorità maschile, ecc.- come fondamento di tutte le forme di dominio, servitù, violenza, disuguaglianza, che la storia ha conosciuto finora.
Denunciare, infine, la violenza maschile contro le donne in tutte le sue forme manifeste o invisibili, non deve impedirci di fare dell’8 marzo 2019 una giornata di lotta “creativa”.
Per tutte queste ragioni, mi sembra importante che ci poniamo alcune domande.
Su che posto riusciamo a dare nel nostro agire politico alla soggettività - l’esperienza, il vissuto delle singole donne (ragioni, ma anche sentimenti, sogni, pregiudizi, ecc.) - senza la quale è difficile avviare processi di identificazione necessari all’allargamento della rete e della sua azione.
Su come riprendere, in quella giornata, alcuni punti essenziali del Piano contro la violenza, in modo particolare per quanto riguarda la violenza in ambito domestico e il rapporto della cultura femminista con la scuola.
Su come evitare la sorte toccata ad altri movimenti, quando hanno creato un linguaggio e modalità di militanza chiusi e comprensibili a poche attivisti, finendo per diventare “fortezze nel deserto”.
Su come mantenere e approfondire i collegamenti internazionali senza perdere la specificità della situazione italiana.
* Insegnante, giornalista, scrittrice e saggista, riferimento per il movimento delle donne italiano. Tra i suoi libri: L’infamia originaria; Come nasce il sogno d’amore; Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia; La perdita; Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà. Altri suoi articoli sono leggibili qui.
* Comune Info, 10 gennaio 2019 (riproduzione parziale - senza immagini).
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO ---- UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 - LE PAROLE DEL SESSANTOTTO: RIVOLUZIONE (di Guido Mazzoni).31 dicembre 2018, di Federico La Sala
LE PAROLE DEL SESSANTOTTO: RIVOLUZIONE
di Guido Mazzoni (Le parole e le cose)
Il Sessantotto è stato due cose diverse, due cose che per circa un decennio sono apparse indistinguibili, ma che in seguito si sono progressivamente separate.
1. È stato l’ultimo episodio dell’età delle rivoluzioni sociali moderne, quelle fondate sull’idea di giustizia distributiva e sulla secolarizzazione della teodicea, cioè sull’idea che il male abbia una causa storica e umana sulla quale la politica può intervenire costruendo una società nuova.
 È un’epoca scandita da una sequenza di date allegoriche: 1789, 1848, 1871, 1917. Il 1968 rappresenta l’ultima cifra della serie; chi è sceso in piazza e ha occupato le università dell’Europa occidentale lo ha fatto con bandiere, striscioni e slogan che rimandavano a quella sequenza. L’utopia di fondo cui questo Sessantotto si richiama è il comunismo. Contro il modello fallito del socialismo reale il movimento recupera il mito della Comune, dei Soviet, dei consigli operai. A queste forme alternative di gestione della cosa pubblica, a queste scene deliberative del passato si ispira la più importante scena deliberativa del Sessantotto: l’assemblea. Benché il movimento sia nato come mobilitazione di studenti di origine borghese, il soggetto politico cui questa parte del Sessantotto guarda rimane lo stesso del comunismo storico: il proletariato, e in particolare l’operaio maschio.
È un’epoca scandita da una sequenza di date allegoriche: 1789, 1848, 1871, 1917. Il 1968 rappresenta l’ultima cifra della serie; chi è sceso in piazza e ha occupato le università dell’Europa occidentale lo ha fatto con bandiere, striscioni e slogan che rimandavano a quella sequenza. L’utopia di fondo cui questo Sessantotto si richiama è il comunismo. Contro il modello fallito del socialismo reale il movimento recupera il mito della Comune, dei Soviet, dei consigli operai. A queste forme alternative di gestione della cosa pubblica, a queste scene deliberative del passato si ispira la più importante scena deliberativa del Sessantotto: l’assemblea. Benché il movimento sia nato come mobilitazione di studenti di origine borghese, il soggetto politico cui questa parte del Sessantotto guarda rimane lo stesso del comunismo storico: il proletariato, e in particolare l’operaio maschio.
 Nel corso degli anni Settanta la concezione del proletariato cambia; alla classe operaia di fabbrica si affianca il proletariato sociale, diffuso, ma il significante-guida non muta. Il proletariato è la classe universale, come dice Marx, quella che, difendendo i propri interessi particolari, lavora per abolire lo sfruttamento di tutti, la divisione in classi, l’alienazione, e per consentire a ognuno di esprimere pienamente la natura umana nella sua interezza. Scopo ultimo è l’uscita della specie dalla preistoria, dall’epoca millenaria nella quale gli individui hanno agito come automi mossi da un potere estraneo, e non come soggetti liberi.
Nel corso degli anni Settanta la concezione del proletariato cambia; alla classe operaia di fabbrica si affianca il proletariato sociale, diffuso, ma il significante-guida non muta. Il proletariato è la classe universale, come dice Marx, quella che, difendendo i propri interessi particolari, lavora per abolire lo sfruttamento di tutti, la divisione in classi, l’alienazione, e per consentire a ognuno di esprimere pienamente la natura umana nella sua interezza. Scopo ultimo è l’uscita della specie dalla preistoria, dall’epoca millenaria nella quale gli individui hanno agito come automi mossi da un potere estraneo, e non come soggetti liberi.
 Gli elementi preistorici che il Sessantotto vuole abbattere sono la gerarchia (l’idea che ogni sistema sociale comporti necessariamente dei rapporti di subalternità), l’alienazione del lavoro (il lavoro salariato moderno come equivalente capitalistico del lavoro degli schiavi) e l’isolamento (l’idea che il capitalismo spezzi ogni forma di solidarietà separando le persone e mettendole le une contro le altre). Le più importanti parole d’ordine del Sessantotto - il rifiuto dell’autorità, il rifiuto del lavoro alienato, il rifiuto dell’individualismo borghese - provengono da questo nucleo.
Gli elementi preistorici che il Sessantotto vuole abbattere sono la gerarchia (l’idea che ogni sistema sociale comporti necessariamente dei rapporti di subalternità), l’alienazione del lavoro (il lavoro salariato moderno come equivalente capitalistico del lavoro degli schiavi) e l’isolamento (l’idea che il capitalismo spezzi ogni forma di solidarietà separando le persone e mettendole le une contro le altre). Le più importanti parole d’ordine del Sessantotto - il rifiuto dell’autorità, il rifiuto del lavoro alienato, il rifiuto dell’individualismo borghese - provengono da questo nucleo.2. Il Sessantotto è stata una rivoluzione interna alle società capitalistico-liberali. Ha ridefinito i rapporti fra le età della vita, il rapporto con l’autorità genitoriale e pastorale, il rapporto fra i sessi, il rapporto col sesso e col corpo, l’ethos, l’habitus, i costumi, la relazione fra Super-io e Es. Lo spirito di questa rivoluzione è libertario, privato, individualistico e anarchico: anarchico nel senso lato e etimologico di an archè: assenza di governo, di autorità originaria. Il Sessantotto segna il passaggio da una società borghese superegotica, ancora legata a un ethos religioso palese o secolarizzato, fondata sull’ascesi intramondana, sul controllo di sé e degli altri, sull’etica del sacrificio, su un a priori in cui le norme collettive di comportamento contano molto e l’individuo vive sotto lo sguardo degli altri, a una società che funziona bene, anzi meglio, senza questa corazza - una società che ha ancora una struttura di fondo di tipo borghese, ma che ha reso autonomi alcuni comportamenti privati. Se il tempo di lavoro resta organizzato secondo i principî severi della razionalità strumentale, gli stessi che dominano il capitalismo, l’esercito o la burocrazia, il tempo libero sfugge a un occhio collettivo regolatore e diventa sempre meno disciplinato nelle scelte personali e nei costumi. Questa rivoluzione è stata per lo più vissuta come un’emancipazione: pochi vorrebbero tornare indietro, sicuramente non io.
 Per alcuni aspetti tutto questo coincide con l’immagine dell’emancipazione presente nei testi fondamentali del marxismo, e tuttavia è molto diversa dall’idea marxista classica di giustizia sociale: si articola in modo diverso, parla a soggetti sociali diversi, ma soprattutto è compatibile col capitalismo, ne è anzi un portato, una conseguenza. Se si definiscono la destra e la sinistra sulla base dei parametri che valgono per l’età delle rivoluzioni sociali, la rivoluzione libertaria non è, in linea di principio, né di destra né di sinistra - e infatti, a partire dagli anni Ottanta, circola in versioni di sinistra e in versioni di destra. -La tesi che Berlusconi sia il compimento del Sessantotto (Perniola, Magrelli, e prima di loro Žižek), provocatoria quanto si vuole, coglie un dato reale. Il Sessantotto annuncia una metamorfosi interna alle società capitalistiche, la sostituzione della vecchia borghesia perbenista con una nuova middle class obbediente sul lavoro ma anarcoide nel privato. Aron, Lasch e Pasolini in tempo reale, Houellebecq e Boltanski-Chiapello trent’anni dopo l’hanno detto molto chiaramente. Lo spirito del Sessantotto è diventato parte della nuova società di massa nata dalla mutazione antropologica e parte del nuovo spirito del capitalismo, che concede, in forma privata e diluita, alcune di quelle conquiste che il comunismo prometteva come risultato di una rivoluzione sociale collettiva. Le concede a patto che non si tocchino il funzionamento del sistema, che non si immagini una società diversa.
Per alcuni aspetti tutto questo coincide con l’immagine dell’emancipazione presente nei testi fondamentali del marxismo, e tuttavia è molto diversa dall’idea marxista classica di giustizia sociale: si articola in modo diverso, parla a soggetti sociali diversi, ma soprattutto è compatibile col capitalismo, ne è anzi un portato, una conseguenza. Se si definiscono la destra e la sinistra sulla base dei parametri che valgono per l’età delle rivoluzioni sociali, la rivoluzione libertaria non è, in linea di principio, né di destra né di sinistra - e infatti, a partire dagli anni Ottanta, circola in versioni di sinistra e in versioni di destra. -La tesi che Berlusconi sia il compimento del Sessantotto (Perniola, Magrelli, e prima di loro Žižek), provocatoria quanto si vuole, coglie un dato reale. Il Sessantotto annuncia una metamorfosi interna alle società capitalistiche, la sostituzione della vecchia borghesia perbenista con una nuova middle class obbediente sul lavoro ma anarcoide nel privato. Aron, Lasch e Pasolini in tempo reale, Houellebecq e Boltanski-Chiapello trent’anni dopo l’hanno detto molto chiaramente. Lo spirito del Sessantotto è diventato parte della nuova società di massa nata dalla mutazione antropologica e parte del nuovo spirito del capitalismo, che concede, in forma privata e diluita, alcune di quelle conquiste che il comunismo prometteva come risultato di una rivoluzione sociale collettiva. Le concede a patto che non si tocchino il funzionamento del sistema, che non si immagini una società diversa.
 In questo senso lo spirito del Sessantotto libertario è diventato parte fondamentale del sistema di governo contemporaneo. Ciò non significa che le sue conquiste non siano tali: lo sono. Lo sono all’ombra di una struttura di potere che, nelle sue grandi architetture, rimane intonsa. Sono conquiste, ma non portano là dove il primo lato del Sessantotto pensava che portassero.
In questo senso lo spirito del Sessantotto libertario è diventato parte fondamentale del sistema di governo contemporaneo. Ciò non significa che le sue conquiste non siano tali: lo sono. Lo sono all’ombra di una struttura di potere che, nelle sue grandi architetture, rimane intonsa. Sono conquiste, ma non portano là dove il primo lato del Sessantotto pensava che portassero.
 E tuttavia hanno cambiato la vita di miliardi di persone, hanno permesso alle donne e alle persone omosessuali di acquisire libertà e diritti, hanno prodotto la più grande ridefinizione dei rapporti fra i sessi e fra le generazioni che la storia umana abbia conosciuto. Sono oggettivamente rivoluzionarie, producono forme di giustizia, ma rimangono estranee al progetto di una rivoluzione fondata sull’idea di giustizia sociale che era alla base del primo Sessantotto, sia perché frantumano le solidarietà universali valorizzando le differenze, sia perché esaltano gli individui e rendono difficile accettare quella componente di alienazione che è necessaria per agire collettivamente, sia soprattutto perché accettano il capitalismo, danno ragione alla sua capacità di creare spazi di libertà privata, di emancipazione individuale. La versione liberal di questo secondo Sessantotto ha rinunciato a un’idea che per il primo Sessantotto era ovvia e decisiva: che la rivoluzione vera è quella che abolisce lo stato di cose presente, non quella che si limita a creare spazi di autonomia al suo interno.
E tuttavia hanno cambiato la vita di miliardi di persone, hanno permesso alle donne e alle persone omosessuali di acquisire libertà e diritti, hanno prodotto la più grande ridefinizione dei rapporti fra i sessi e fra le generazioni che la storia umana abbia conosciuto. Sono oggettivamente rivoluzionarie, producono forme di giustizia, ma rimangono estranee al progetto di una rivoluzione fondata sull’idea di giustizia sociale che era alla base del primo Sessantotto, sia perché frantumano le solidarietà universali valorizzando le differenze, sia perché esaltano gli individui e rendono difficile accettare quella componente di alienazione che è necessaria per agire collettivamente, sia soprattutto perché accettano il capitalismo, danno ragione alla sua capacità di creare spazi di libertà privata, di emancipazione individuale. La versione liberal di questo secondo Sessantotto ha rinunciato a un’idea che per il primo Sessantotto era ovvia e decisiva: che la rivoluzione vera è quella che abolisce lo stato di cose presente, non quella che si limita a creare spazi di autonomia al suo interno.La prima rivoluzione ha perso. O meglio: è stata usata, in Francia, in Italia e in Germania, da forze che il movimento del Sessantotto non amava, i sindacati e i partiti della sinistra tradizionale, per ottenere alcune classiche conquiste socialdemocratiche, per raggiungere risultati straordinari che col tempo si sono rivelati insostenibili nel nuovo assetto neoliberale generato dal capitalismo negli stessi anni del lungo Sessantotto. La verità è che il primo Sessantotto doveva fallire, era necessario che fallisse o che diventasse altro. La sua utopia, che poi è l’utopia comunista, contrasta con i meccanismi di funzionamento delle società moderne, estese nei numeri e nello spazio, differenziate, culturalmente plurali, fondate su una divisione del lavoro capillare e su una costitutiva alienazione. Gli unici meccanismi di gestione degli aggregati umani che società simili ammettono sono lo Stato e il mercato. Questi ultimi sono forme della tecnica, dispositivi della razionalità strumentale consustanziali alla modernità. Il sogno delle comuni, dei soviet, delle assemblee è illusorio. Il campo delle possibilità politiche reali, durevoli, oscilla fra gli estremi del liberismo puro e del socialismo reale, con in mezzo svariate forme di Welfare State, di socialdemocrazia o di cristiano-democrazia. Tutto il resto non può durare. Nessuno potrà mai eliminare la gerarchia implicita nei meccanismi statuali e mercantili, o la divisione del lavoro, o la separazione del mondo comune in mondi particolari, o l’antitesi fra interesse pubblico e interesse privato, o la necessità del lavoro obbligato, il ponos, il labor, il lavoro che, potendo scegliere, non si vorrebbe fare. Nessuno potrà governare uno Stato (o un comune, o un quartiere) in modo assembleare o pianificare l’economia in ogni suo aspetto, o abolire le mille forme di comando, di soggezione, che sono necessarie perché ci sia ordine e le forze produttive si sviluppino.
Invece la seconda di queste rivoluzioni ha vinto. Ha cambiato la vita delle masse, ha portato con sé delle conquiste cui oggi non vorremmo rinunciare. Ha anche comportato la crisi della politica come utopia, la fine dell’illusione che si potesse uscire dalla preistoria. La prima rivoluzione andava contro lo Zeitgeist, che è poi il nome con cui indichiamo la connessione impersonale delle cose; l’altra lo assecondava. Tutta la mia simpatia va alla prima. La gerarchia, l’alienazione, l’isolamento che abbiamo accettato dopo la fine dell’età delle rivoluzioni, in cambio di una sfera preziosa di benessere e autonomia privata, frustrano alcuni desideri umani profondi e non meno reali del principio di realtà che ce li fa considerare delle illusioni. Una volta fallita l’utopia, la scissione fra desiderio e realtà rimane aperta e lascia spazio a tonalità emotive cariche di realismo, disincanto, rinuncia e impliciti segni-meno: la felicità o più spesso la tranquillità privata, l’ironia, il fatalismo, il cinismo, il disagio, il risentimento, la malinconia, la nostalgia, la tragedia o una disperata vitalità. Oggi siamo attraversati da queste Stimmungen, ne adottiamo una o un’altra a seconda di come siamo collocati nello spazio sociale o a seconda del temperamento, le sovrapponiamo e le cambiamo nel corso degli anni o della giornata. Possiamo immaginare che lo stato di cose presente crolli nel disordine, come nei racconti della nostra fantascienza distopica, ma non abbiamo più alcuna utopia paragonabile a quella che animava l’età delle rivoluzioni. Nessuno pensa che un altro mondo sia possibile. Nessuno ci crede più veramente.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- LA VERA STORIA DEL PRESEPIO. Un libro di Maurizio Bettini (di Marco Belpoliti).31 dicembre 2018, di Federico La Sala
LA VERA STORIA DEL PRESEPIO .... *
“[...] Che cos’è esattamente il presepio? Come nasce? Perché ci sono quei personaggi? Che senso ha farlo oggi? Sono tante le domande che s’affollano in questo libro del classicista Maurizio Bettini, Il presepio (Einaudi, pp. 189, € 19). Il suo non è solo un libro di studio, ma anche un libro di memoria. Meglio: un’autobiografia in forma di studio e di racconto. Tutto comincia con una dichiarazione ad apertura di volume: “Non saprei dire da quanti anni ho smesso di fare il presepio. Venti, trenta, anzi molto di più”. Perché interrogarsi oggi su questo “oggetto” tanto da scrivere un libro dotto e complesso? La risposta non viene subito. Prima bisognerà intraprendere un cammino, per quanto una definizione l’autore la dà subito: il presepio è “una finzione fragile, per questo incantevole”.
[...] Corro alla fine, là dove c’è la risposta ai tanti perché di questo viaggio nella storia e nell’antropologia del presepio. De te fabula narratur. Perché mi occupo del presepio?, si chiede l’autore. Perché ho un patto di fedeltà nei confronti di me stesso. Non quello con la religione in cui sono stato allevato, il Cristianesimo - Bettini ha scritto vari libri per manifestare la “superiorità” del politeismo sul monoteismo. La fedeltà a se stessi è quella all’infanzia, alla propria infanzia. Il presepio, non è solo l’infanzia della Divinità, che ha dominato la nostra storia occidentale per due millenni, ma proprio l’infanzia di Maurizio Bettini, e il presepio è il ritorno al proprio Io bambino...”
* Cfr. Marco Belpoliti, “La vera storia del presepio”, “Doppiozero”, 24.12.2018 (https://www.doppiozero.com/materiali/la-vera-storia-del-presepio).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. - di Federico La Sala24 dicembre 2018, di Federico La Sala
CREATIVITÀ. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.... *
Abbiamo visto la sua gloria
di Mario Delpini (Avvenire, sabato 22 dicembre 2018)
- L’arcivescovo di Milano parte dalla frase di san Giovanni, «Abbiamo visto la sua gloria» (Gv 1,14), per esortarci a imparare a vivere come figli di Dio
- [Foto/Quadro] Oggi è nato per voi un Salvatore
Se il Verbo, Parola eterna del Padre,
 deve imparare a parlare
deve imparare a parlare
 per dire “mamma”, “papà”, “amici”, “fratelli”,
per dire “mamma”, “papà”, “amici”, “fratelli”,
 per dire “sì” e per dire “no”,
per dire “sì” e per dire “no”,
 per dire “acqua” e “fuoco”, “campo”, “pecore”,
per dire “acqua” e “fuoco”, “campo”, “pecore”,
 allora abbiamo visto la sua gloria
allora abbiamo visto la sua gloria
 nella parola d’uomo che chiama e consola e illumina i figli degli uomini.
nella parola d’uomo che chiama e consola e illumina i figli degli uomini.Se colui che ha fatto il cielo e la terra,
 deve imparare a lavorare
deve imparare a lavorare
 nella bottega del falegname
nella bottega del falegname
 per guadagnarsi il pane, per dare forma e bellezza e utilità
per guadagnarsi il pane, per dare forma e bellezza e utilità
 e sentire la fatica nelle braccia e le mani indurite dai calli,
e sentire la fatica nelle braccia e le mani indurite dai calli,
 allora abbiamo visto la sua gloria
allora abbiamo visto la sua gloria
 nella fatica quotidiana che rende abitabile il mondo,
nella fatica quotidiana che rende abitabile il mondo,
 la casa dei figli degli uomini.
la casa dei figli degli uomini.Se Gesù, che è la vita del mondo,
 deve vedere la morte e imparare il soffrire
deve vedere la morte e imparare il soffrire
 e piangere la morte degli amici e delle persone care,
e piangere la morte degli amici e delle persone care,
 e consolare le lacrime degli afflitti
e consolare le lacrime degli afflitti
 e condividere lo strazio degli affetti spezzati,
e condividere lo strazio degli affetti spezzati,
 allora abbiamo visto la sua gloria
allora abbiamo visto la sua gloria
 nella compassione che abita in cuore d’uomo.
nella compassione che abita in cuore d’uomo.Se il Figlio Unigenito, che è nel seno del Padre,
 deve imparare la strada per Gerusalemme
deve imparare la strada per Gerusalemme
 e camminare insieme al popolo per cantare le antiche preghiere
e camminare insieme al popolo per cantare le antiche preghiere
 ed esultare alle porte della città santa
ed esultare alle porte della città santa
 e commuoversi per la devozione e per il peccato,
e commuoversi per la devozione e per il peccato,
 allora abbiamo visto la sua gloria
allora abbiamo visto la sua gloria
 nell’abitare del Figlio nel seno del Padre
nell’abitare del Figlio nel seno del Padre
 per preparare un posto per ogni figlio d’uomo.
per preparare un posto per ogni figlio d’uomo.La terra è piena della gloria di Dio,
 il Figlio di Dio ha imparato a essere figlio dell’uomo,
il Figlio di Dio ha imparato a essere figlio dell’uomo,
 i figli degli uomini possono imparare a vivere come figli di Dio.
i figli degli uomini possono imparare a vivere come figli di Dio.Auguri!
Santo Natale 2018
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo" -
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- Non solo di cose d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità ( Pietro Del Soldà).2 dicembre 2018, di Federico La Sala
Intorno all’amore. Pietro Del Soldà ne individua una dimensione pubblica contro l’immagine dominante che ne dà invece una lettura privata. L’eros non va inteso solo in senso sentimentale e di coppia, ma soprattutto politico
Una visione plurale di felicità
di Remo Bodei (Il Sole-24 Ore, Domenica, 02.12.2018)
- Non solo di cose d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità Pietro Del Soldà Marsilio, Venezia, pagg. 191, € 17
Nell’inflazione di pubblicazioni che trattano della felicità e delle ricette per raggiungerla o tra le numerose applicazioni del pensiero antico all’attualità, la prima cosa da dire è che questo libro riserva una gradita sorpresa: non è banale e, malgrado la perfetta conoscenza dei testi platonici utilizzati, non ha neppure un taglio didascalicamente accademico.
In quanto conduttore della rubrica radiofonica Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà gode, infatti, professionalmente del vantaggio di praticare una sorta di quasi quotidiano dialogo socratico nell’agorà tecnologica di RAI 3, di misurarsi, in maniera garbata ed equilibrata, con le questioni poste dal pubblico, con le sue preoccupazioni e inquietudini. Senza offrire soluzioni prefabbricate, egli utilizza Socrate come un reagente e non come un modello cui adeguarsi.
Il problema della felicità è trattato contropelo, a partire dalle radici dell’infelicità e delle sue cause e dalla domanda che oggi s’impone: perché tanta infelicità, se il mondo, rispetto al passato, è incomparabilmente migliore, se le aspettative di vita, di libertà e di sicurezza sono così aumentate? Contro l’immagine dominante di una felicità esclusivamente privata, Del Soldà ne mostra l’inscindibile con la dimensione pubblica. Sostiene poi la tesi che l’amore (eros) non debba essere inteso in senso sentimentale o di coppia, ma anche, e soprattutto, politico. In tale prospettiva, esso consiste nella ricerca di un legame in grado di dare «armonia alle “voci del coro”, cioè di governare se stesso e la città senza escludere nessuna delle parti che la compongono». Eros è la forza che abbatte il muro di separazione tra l’Io e il Noi.
Notevole è la parte del volume che, ripercorrendo la polemica di Socrate contro i sofisti (in dialoghi come il Protagora, il Gorgia, il Lachete, il Fedro, la Repubblica e le Leggi), Del Soldà indica in essi gli antesignani delle attuali forme d’individualismo narcisistico, caratterizzato dalla mancanza di pudore, dalla «spettacolarizzazione dell’intimità», dall’insofferenza alle regole e dalla ricerca del successo a qualsiasi costo. Nessuno si mette realmente in gioco nel dialogo, ma aggiunge addirittura nuovi mattoni al «muro» che lo divide, oltre che da se stesso, anche dagli altri, con cui intrattiene rapporti unicamente strumentali. Si è perciò soli pur vivendo in mezzo a una pluralità di persone, perché s’intessono con loro relazioni non vincolanti (quelle che il filosofo americano Robert Nozick aveva teorizzato come no binding committments).
L’esistenza è concepita da questi sofisti come una competizione senza quartiere, analoga alla corsa della vita descritta da Hobbes, che parafrasa San Paolo, della: «Guardare gli altri che stanno dietro, è gloria. [...] Esser superato continuamente, è infelicità. / Superare continuamente quelli davanti, è felicità / E abbandonare la pista, è morire».
L’ipertrofia dell’io conduce al paradosso per cui, più ci separiamo da noi stessi e dagli altri, più ci omologhiamo, in quanto egoismo e conformismo sono due facce della stessa medaglia. Come abbattere dunque la barriera che ci divide da noi stessi e dagli altri? La soluzione suggerita è quella che si trova nell’Alcibiade Maggiore, dove il precetto delfico «Conosci te stesso!» non va inteso come un invito a sprofondare nell’asfittica interiorità individuale, bensì a rispecchiare se stesso nella pupilla dell’altro: «Se un occhio vuole vedere se stesso, deve guardare in un altro occhio e in quella parte in cui nasce la forza visiva».
 Ciascuno deve perciò uscire da sé proprio per andare verso se stesso, anche perché conoscere se stessi significa conoscere gli altri, ossia anche fare politica. Ma, per rovesciare l’ottica consueta dell’introspezione e ritrovarsi nella pluralità degli altri, per rimettere a posto i frammenti di se stessi in qualcosa di coerente, si richiede coraggio.
Ciascuno deve perciò uscire da sé proprio per andare verso se stesso, anche perché conoscere se stessi significa conoscere gli altri, ossia anche fare politica. Ma, per rovesciare l’ottica consueta dell’introspezione e ritrovarsi nella pluralità degli altri, per rimettere a posto i frammenti di se stessi in qualcosa di coerente, si richiede coraggio.Riferendosi più direttamente alle vicende del presente, ciò implica non solo l’abbandono della retorica dell’identità autosufficiente, basata sull’esclusione dell’altro, ma anche - e questo, in tempi di fake news, è un suggerimento prezioso - il non limitarsi a smontare le falsità evidenti attraverso il fact checking. Occorre, piuttosto, sforzarsi di capire l’eros, l’irrefrenabile bisogno, in chi si è sentito abbandonato e sminuito, di entrare a far parte di una comunità che lo rappresenti e per cui si è disposti ad accettare, come tassa d’inclusione, tutto quanto asserito dall’opinion leader.
 Tale adesione ha tanto più valore in una fase in cui si assiste a una enorme crescita delle diseguaglianze o, come direbbe la sociologa Sakia Sassen, a una «secessione dei patrizi», al ritirarsi nelle loro dorate posizioni di quei pochi che posseggono le risorse di metà del genere umano (e che, nella rivendicazione di una eroica ignoranza, vengono spesso accomunati alla detestata casta dei detentori ufficiali del sapere).
Tale adesione ha tanto più valore in una fase in cui si assiste a una enorme crescita delle diseguaglianze o, come direbbe la sociologa Sakia Sassen, a una «secessione dei patrizi», al ritirarsi nelle loro dorate posizioni di quei pochi che posseggono le risorse di metà del genere umano (e che, nella rivendicazione di una eroica ignoranza, vengono spesso accomunati alla detestata casta dei detentori ufficiali del sapere).Vi è un solo, difficile. rimedio all’attuale ribollire delle «passioni tristi» (odio, invidia, risentimento) e di quelle irruenti (ira, gelosia, aggressività) non sufficientemente orientate dal pensiero cosciente. Nelle Leggi tutte sono paragonate da Platone a rigidi e indeformabili fili di ferro, che muovono l’uomo come una marionetta. A esse bisogna sottrarsi, opponendo resistenza al loro potere, per «farsi guidare sempre da uno solo di questi fili, senza mai lasciarlo [...]. Si tratta del sacro filo d’oro del logos». Occorre, in altri termini, fare affidamento su una «ragione malleabile» come l’oro, capace di condurre a una «felicità plurale» e condivisa, al cui culmine «assaporare la gioia indicibile di un canto comune».
__________________________________________________________
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SPIRITO CRITICO E TEOLOGIA POLITICA DEL "MENTITORE". PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO, CHE GIA’ DANTE SOLLECITAVA ...
 IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei.
IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei.
 "Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
"Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
FILOSOFIA IN STATO COMATOSO. IL PARADOSSO DELL’IDENTITA’: IO E GLI ALTRI. REMO BODEI CERCA DI SVEGLIARSI E SI RIATTACCA AL VECCHIO E LOGORO FILO POPPERIANO. Ecco le tesi del suo "manifesto per vivere in una società aperta"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- MISOXENIA, MISOGENIA, E FILOLOGIA. La parola ’misoxenia’ non è in uso, peccato (di F. Camon).1 dicembre 2018, di Federico La Sala
«Xenofobia» è parola sbagliata: è «misoxenia».
Quando dire paura non fa vedere l’odio
di Ferdinando Camon (Avvenire, sabato 1 dicembre 2018)
«Ennesimo femminicidio: trovata uccisa con un colpo di pistola alla testa, arrestato l’ex marito»: ma se arrestano l’ex marito, perché lo si chiama ’femminicidio’ e non ’uxoricidio’? L’ex marito l’ammazza in quanto genericamente donna, o in quanto specificamente sua moglie o ex moglie?
 Ho scritto su questo giornale che molti casi di femminicidio, quasi tutti, sono in realtà uxoricidi: si punisce con la morte una donna non perché è donna, ma perché è o è stata moglie, compagna, madre dei nostri figli. Non si punisce la sua vita, ma la spartizione della sua vita con la nostra. È troppo usato il termine ’femminicidio’, e troppo poco il termine ’uxoricidio’. Ma molto spesso il termine ’femminicidio’ è sviante.
Ho scritto su questo giornale che molti casi di femminicidio, quasi tutti, sono in realtà uxoricidi: si punisce con la morte una donna non perché è donna, ma perché è o è stata moglie, compagna, madre dei nostri figli. Non si punisce la sua vita, ma la spartizione della sua vita con la nostra. È troppo usato il termine ’femminicidio’, e troppo poco il termine ’uxoricidio’. Ma molto spesso il termine ’femminicidio’ è sviante.Com’è sviante il termine ’xenofobia’. Etimologicamente, vuol dire ’paura dello straniero’. Ma molto spesso non è paura, è odio. Non è difesa, è aggressione. L’ultimo caso in cui i giornali usano (a sproposito) il termine xenofobia è di questi giorni, e viene dal profondo nord dell’Inghilterra. Accade in ambito scolastico, tra ragazzi di 15-16 anni. Nativi inglesi picchiano e umiliano un coetaneo siriano. E poi mettono in rete un filmato. I telegiornali riportano qualche sequenza: l’inglese sbarra la strada al compagno siriano, allunga una mano sulla sua faccia, il ragazzo siriano cerca di tirar dritto, tiene gli occhi bassi, l’inglese lo scaraventa a terra, quello è menomato, ha un braccio rotto e ingessato, l’altro gli rovescia una bottiglia d’acqua in faccia, dice ’t’annego’, il siriano non vede l’ora di tirarsi su e sgattaiolare via. Certo, in questa scena c’è paura dello straniero, ma ad aver paura è la vittima, che subisce le angherie per più giorni, senza dire niente in casa. I giornali parlano di bullismo più razzismo. È possibile, ma anche nei casi di razzismo non è corretto parlare di xenofobia, anche quello non è paura, è odio.
L’odio vuole più cose: far male e far scappare. Infatti qui il ragazzo siriano non voleva più tornare a scuola, la sua sì che è paura, ed essendo paura di tutti diventa paura dell’ambiente. Il siriano confessa: «Ormai avevo paura anche ad entrare nei negozi». La paura costante scende nell’inconscio, avvelena i sogni: «Mi svegliavo di notte e piangevo». La paura ininterrotta rende impossibile vivere, fa preferire la morte alla vita. Sembra una scelta irrazionale, e lo è, ma nasce da un calcolo del vantaggio, sceglie un male ritenuto minore (morire) per evitare un male ritenuto maggiore (essere umiliato). Qui è la sorella del ragazzo siriano a cercare la morte, tagliandosi le vene con una scheggia di vetro, che come si sa è più affilata di un coltello. I giornali che ho sott’occhio non mi autorizzano a tirar questa conclusione, ma evidentemente qui c’è la persecuzione non di un ragazzo o due ragazzi e non di una famiglia, ma di una (non trovo altro termine) razza. C’è odio.
 Le donne parlano spesso, giustamente, di ’misogenia’ per indicare l’atteggiamento degli uomini che disprezzano, offendono e umiliano le donne: e quel termine non significa ’paura delle donne’, ma ’odio per le donne’.
Le donne parlano spesso, giustamente, di ’misogenia’ per indicare l’atteggiamento degli uomini che disprezzano, offendono e umiliano le donne: e quel termine non significa ’paura delle donne’, ma ’odio per le donne’. Così il concetto ’paura dello straniero’, che ha generato il termine ’xenofobia’, andrebbe sostituito dal concetto di ’odio per lo straniero’. Sparirebbe l’idea giustificatoria di autodifesa che è insita nella paura: hanno paura, perciò si difendono. Ma qui in Inghilterra il persecutore si nascondeva davanti alla scuola del perseguitato, lo aspettava, lo aggrediva d’improvviso. Quello che lo spinge è proprio l’odio per lo straniero.
Così il concetto ’paura dello straniero’, che ha generato il termine ’xenofobia’, andrebbe sostituito dal concetto di ’odio per lo straniero’. Sparirebbe l’idea giustificatoria di autodifesa che è insita nella paura: hanno paura, perciò si difendono. Ma qui in Inghilterra il persecutore si nascondeva davanti alla scuola del perseguitato, lo aspettava, lo aggrediva d’improvviso. Quello che lo spinge è proprio l’odio per lo straniero.
 La parola ’misoxenia’ non è in uso, peccato, perché sarebbe utile.
La parola ’misoxenia’ non è in uso, peccato, perché sarebbe utile. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- "Partorire con la testa". Il Socrate che non t’aspetti svelato da Dorella Cianci (di Mirella Fortis)29 novembre 2018, di Federico La Sala
Il Socrate che non t’aspetti svelato da Dorella Cianci
La rigorosa ricostruzione della figura del pensatore nel suo “Partorire con la testa. Alle origini della maieutica” (Marsilio)
di Mirella Fortis (Leggere:tutti, 28 novembre 2018)
Un lungo minuzioso lavoro di analisi della letteratura greca, ma anche di tanti testi successivi, dell’antichità e del Medioevo. Da questo scaturisce il Socrate che non ti aspetti. Con rigore scientifico è Dorella Cianci a ricostruire in modo anche imprevisto uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi nel suo libro “Partorire con la testa. Alle origini della maieutica” pubblicato da Marsilio. La figura di Socrate si allontana così non solo dai luoghi comuni ma anche dalla descrizione praticamente monopolizzata da Platone.
Antichista e filologa, docente nell’Università Lumsa di Filosofia con i bambini e assegnista di ricerca in storia della filosofia medievale, Dorella Cianci è risalita alle origini della maieutica, parola che deriva dal greco con un richiamo all’arte ostetrica, e che fu adoperata da Platone nel “Teeteto” per definire il metodo attribuito a Socrate: il dialogo ottenuto con il susseguirsi di domande e risposte per sollecitare l’interlocutore, come una levatrice, a partorire la verità.
Stanno proprio così le cose? Attenzione: “E’ Platone che vuol far diventare Socrate un vero filosofo!” esclama la Cianci. Che avverte come Socrate operi con convinzione e agilità “nella paradossalità dei suoi nuovi valori di insegnamento, quegli stessi valori che erano balzati agli occhi di un semplice comico, Aristofane, molto più di quanto il fedele Platone li avesse notati!”.
Ed ecco la conseguenza ricavata dall’esame di un’ampia gamma di fonti: “Socrate abortiva e partoriva idee negli allievi, dicendo poi che questi allievi facevano tutto da sé, ma a ben vedere - da bravo maestro - sapeva tirare da burattinaio colto i fili del suo discorso esattamente dove voleva e anzi,,, in alcuni casi era totalmente proiettato su di sé, tanto da creare idee esclusivamente a sua immagine e somiglianza”.
I primi importanti e qualificati apprezzamenti all’originalità dell’impostazione di Dorella Cianci sono espressi già nella prefazione al libro “Partorire con la testa” scritta dal grecista e filologo Giulio Guidorizzi: “Seguo con un certo agio la strada segnata dalla Cianci” riconosce Guidorizzi. In particolare osserva: “Nel "Menone" Socrate non attua alcun parto, non fa nascere ciò che è dentro il ragazzino, in relazione a concetti complessi a lui estranei. È l’atteggiamento
di un maestro che si propone come induttore di idee, pur dichiarando nel "Teeteto", in senso paradossale, di non sapere partorire saperi”. La Cianci, pertanto, entra nel vivo della “pedagogia del maestro Socrate” che, con il suo “paradosso educativo, si è elevato a potente comunicatore, usando una strategia difensiva che lo mettesse al riparo dall’accusa di corruzione dell’animo giovanile”. Così ha mirato a “creare naturalmente allievi grazie alla sua autorità dialettica, pur affermando di non essere un maestro e chiarendo, già nell’"Apologia", che cosa intende con l’essere o meno maestri”.
A proposito di comunicazione, spicca nella prima citazione di “Partorire con la testa” la constatazione di Diogene Laerzio secondo cui “di fatto Platone ha messo per iscritto un numero importante di discorsi che Socrate non ha tenuto”. Sembra quasi una traccia per arrivare al paragrafo di pagina 28 dedicato a una “Postilla sul fake” anzitempo. Le falsificazioni delle informazioni hanno dunque un cuore antico, fa sapere questo libro.
__
Dorella Cianci
Partorire con la testa. Alle origini della maieutica
Marsilio, 2018
Euro 13,00, pp. 160
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. - SOCRATE, LEDA, E IL CIGNO: AL DI LA’ DEL "PARTO MASCHIO DEL TEMPO".21 novembre 2018, di Federico La Sala
AL DI LA’ DEL PARTO MASCHIO (O FEMMINA) DEL TEMPO. La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica... *
- L’EROS SENZA "FEMMINA" DI SOCRATE: "Si narra che Socrate abbia sognato di avere sulle ginocchia un piccolo cigno che subito mise le ali e volò via e dolcemente cantò e che il giorno dopo, presentatosi a lui Platone come alunno, abbia detto ch e il piccolo uccello era appunto lui" (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III 5, cfr.: Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma, 1991, pp.182-183)
- Leda e il cigno, Pompei a luci rosse
- ESCLUSIVA ANSA/ Osanna, "Ritrovamento eccezionale e unico"
Mitologia
L’eros senza maschio di Leda e il cigno
Il dipinto ripropone il simbolo della donna che dall’antichità ai grandi artisti del Rinascimento afferma la propria indipendenza
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 20.11.2018)
Ed ecco che a Pompei la sempre imponderabile cabala dei crolli e dei controlli fa riemergere una variante ancora più antica, pittorica, di un episodio amoroso da sempre simbolo, nella storia della pittura e della letteratura, dell’autoerotismo femminile: del piacere che la donna può darsi senza la cooperazione del maschio, anzi, di alcun umano. Nella scultura adrianea, copia di un originale ellenistico, il corpo di Leda, completamente nudo, è contratto nell’amplesso, la mano celata nel grembo premuto alle piume, stretto fra le unghie di un onirico cigno dotato di doppio fallo, dove quello proteso nel lungo collo, cui le labbra si accostano in un’appena dissimulata fellatio, prevale sull’altro che si insinua fra le cosce tremanti - per citare i versi di Yeats - della ragazza che è in piedi e barcolla. Nell’altrettanto esplicito erotismo dell’affresco pompeiano, Leda, i drappeggi dell’abito appena scostati, ancora cinta di diadema e calzari, è abbandonata su una sedia ed è al seno scoperto che si protende il becco del bianco fantasma erotico avvinghiato alle sue cosce.
Nelle grandi Lede della storia dell’arte successiva c’è sempre qualcosa di ineffabile dipinto sul viso della donna da cui non a caso nascerà Elena, e con lei la guerra di Troia, e dunque Roma, con la fuga di Enea. Perfino il sorriso leonardesco del dipinto della Galleria Borghese è solo uno dei tanti misteriosi, allusivi, indecifrabili sorrisi che Leda, moltiplicata nel suo sogno in infinite immagini pittoriche, regala prima, durante o spesso dopo l’amplesso all’empatia dei pittori.
Del resto, della meno censurata tra le Lede dei grandi maestri, quella di Michelangelo, non sopravvive l’esecuzione finale, smarrita o censurata in un giro di corti che dalla committenza estense si arenerà in quella di Francia, ma la copia di Rosso Fiorentino della National Gallery dà un’idea di quanto meno pudica della Leda post coitum di Leonardo fosse l’idea che Michelangelo aveva di quell’amplesso.
Il cigno non è una bestia. È la figurazione simbolica dei desideri repressi e insieme delle paure erotiche femminili. Tutta l’imponderabilità e irrefrenabilità dell’erezione maschile è richiusa e dischiusa in quelle grandi ali frementi, che nell’iconografia assumono, come sempre le immagini dei sogni, proporzioni vertiginosamente variabili, ora ridotte alla sensualità del passer della Lesbia di Catullo, ora talmente gigantesche da far intravedere nel corpo a corpo erotico delle Lede avviluppate nelle loro piume qualcosa di simile alla lotta di Giacobbe con l’angelo. In effetti, se a qualcosa la loro tradizione iconografica può essere accostata, è quella di una vertigine del volo - pensiamo allo slancio di Icaro - che il mondo greco, attingendo alla tradizione orientale, consegnerà all’angelologia cristiana e islamica.
Che siano di chimera, di fenice o di cigno, che richiamino Eros o Ermes dal piede alato, e con lui la natura stessa del sogno, le ali, tipico oggetto di fobia sessuale femminile, sono un altro potente simbolo di hybris fallica. Creato dalla fantasia, dalla forza del sogno, dall’urgenza del simbolo, il cigno di Leda è quanto di più lontano da una concreta presenza animale.
Nulla a che fare con gli accoppiamenti bestiali della mitologia greca, come quello di Pasifae col nero, potente toro dall’immenso membro, che non a caso farà sorgere alle fondamenta dell’edificio psicologico greco una creatura - il Minotauro - che simboleggia nella mitologia l’assoluto irrazionale, la parte bestiale che è in noi, tanto avida quanto sapiente, tenuta a guardia del grande labirinto dell’inconscio.
Ma neanche quel figlio, per i greci, è il male, anzi. Sarà la sua uccisione da parte dell’infido eroe Teseo a produrre la combinazione di eventi che porterà a un’ancora più potente compensazione simbolica: a consegnare Arianna, sorella del Minotauro e suo esatto contrario, sacerdotessa della razionalità della dea Atena, a farsi sposa, abbandonata a Nasso, di Dioniso, il dio della natura scatenata e dell’ebbrezza.
Il prodotto dell’accoppiamento di Leda non sarà meno inquietante. Elena incarnerà la femminilità più potente di tutto il mito greco, quella cui non si resiste, capace di addormentare con il suo nepente il cuore degli uomini, di scatenare le loro guerre, di disseminare, con la sua forza di donna creata dal puro piacere di una donna, il massimo disorientamento nel mondo dei maschi. Elena dalle bianche braccia, candida e onirica come "il bianco tumulto" che la fa nascere, sarà la femme fatale per eccellenza, la splendida strega capace di scardinare ognuno degli aspetti dell’egemonia maschile.
Il mito di Leda è dunque il mito d’origine dell’autonomia femminile, del suo desiderio sessuale emancipato dal maschio, delle sue non solo erotiche ma anche concrete paure - poiché certo essere ingravidate da un sogno è da sempre nelle donne uno dei più irrazionali e archetipi timori, non a caso esorcizzato nelle storie di maghe e di streghe. È forse questo solo, nel mito di Leda, l’intervento di Zeus.
 Per una volta assolviamolo dalla sua fama di stupratore. Quello di Leda è il contrario di uno stupro. E la vasta fortuna della sua iconografia è uno dei tanti segni nascosti, sotterranei, carsici che la psiche femminile ha lasciato, indecifrati dai molti, còlti dagli artisti e dai poeti, serbati e sussurrati nel segreto delle corti, della sua indipendenza e della sua libertà.
Per una volta assolviamolo dalla sua fama di stupratore. Quello di Leda è il contrario di uno stupro. E la vasta fortuna della sua iconografia è uno dei tanti segni nascosti, sotterranei, carsici che la psiche femminile ha lasciato, indecifrati dai molti, còlti dagli artisti e dai poeti, serbati e sussurrati nel segreto delle corti, della sua indipendenza e della sua libertà.
*
SUL TEMA, IN RETE E NEL SITO, SI CFR.:
"PARTORIRE CON LA TESTA. Alle origini della maieutica" (Dorella Cianci, Marsilio, Venezia, 2018).
SOCRATE, "LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Se il capitale diventa una seconda natura (di Lea Melandri).17 novembre 2018, di Federico La Sala
Se il capitale diventa una seconda natura
Non Una Di Meno. Si è aperta una breccia nell’economicismo della vulgata marxista, che ha resistito al movimento delle donne e alla progressiva femminilizzazione del lavoro. La garanzia di poter contare su un tempo liberato dall’aziendalismo potrà venire da quello che oggi Non Una di Meno ha definito un «reddito di auto-determinazione»
di Lea Melandri (il manifesto, 16.11.2018)
Una volta che si riconosce che l’economia si è imposta in tutte le sfere dell’agire e del pensiero umano, che cosa significa parlare di forza lavoro come «facoltà che appartiene agli individui», espressione di libertà e autodeterminazione di uomini e donne, che lavorino o non lavorino? «La forza lavoro - scrive Roberto Ciccarelli nel suo Capitale Disumano (manifestolibri, 2018) - diventa una merce a seguito della sua vendita. Ma - prosegue - resta comunque una facoltà del suo possessore». E aggiunge che, in quanto tale, «è universale e comune». Difficile non vedere l’analogia con la definizione marxiana della «passione dell’uomo», intesa come il bisogno di una «totalità di manifestazione di vita umana» di ogni vivente.
VIENE immediata l’osservazione che, finché resta una potenza indipendente dalle offerte di mercato che risuona nel fondo di ogni vita come semplice diritto all’esistenza la forza lavoro così distinta dalla sua oggettivazione in merce, assomiglia allo stato di natura di Rousseau, e al concetto di inesistenza delle donne, da cui è partito il femminismo degli anni Settanta: in entrambi questi casi, si era evidentemente ritenuto necessario restituire all’individuo la consapevolezza che, dietro le imposizioni e i modelli, a cui ha dovuto assoggettarsi, non si era mai eclissata la possibilità di esercitare le diverse funzioni del corpo, della ragione, dell’immaginazione.
VERREBBE da dire che finalmente, anche nell’analisi del lavoro, si è aperta una breccia nell’ombra lunga dell’economicismo che ha segnato la vulgata marxista, resistendo all’urto della rivoluzione culturale e politica del movimento delle donne e, in tempi più recenti, alla progressiva femminilizzazione del lavoro. Forse non è un caso che lo scarto, rispetto a una critica dell’economia catturata dal suo stesso oggetto, avvenga in un momento in cui è saltata la divisione tra il lavoro produttivo e tutta la somma di vita che, riduttivamente, impropriamente, è stata così a lungo collocata sotto la voce «riproduzione», nel senso che Marx stesso gli ha dato, e cioè come riproduzione della forza lavoro in quanto merce. Assenti le donne e la materialità di esperienze corporee e intellettuali ritenute «naturali» del genere femminile.
LA CADUTA dei confini, che hanno tenuto separate e in guerra tra loro la «potenza dell’amore» e la «coercizione al lavoro» (Freud), non ha segnato solo la femminilizzazione della sfera pubblica - la vita in quanto tale messa a produrre valori economici, sociali, cognitivi, attività di cura malpagate o gratuite, l’economia che diventa oikonomia, economia domestica -, ma un passaggio più inquietante a quel perverso connubio di autoimprenditorialità e autosfruttamento che ha preso corpo, pur nella sua astrazione, nel figura del capitale umano». In corrispondenza con la crisi del lavoro da tempo si moltiplicano gli inviti a diventare imprenditori di noi stessi. Il nuovo imperativo è pensare la vita come se fossimo tutti manager.
L’IO DIVENTA, al medesimo tempo, datore di lavoro e lavoratore di se stesso, viene a ricoprire un doppio ruolo: quello di chi comanda e di chi obbedisce. La libera scelta diventa la manifestazione di una subordinazione.
Con questo ultimo cambiamento nei rapporti che ci sono sempre stati tra sfere tra loro divise e contrapposte, il divoramento avviene su un versante e sull’altro: il capitale ingurgita la forza lavoro separandola dal vivente, ma il vivente, a sua volta, incorpora il capitale e le sue leggi, si fa oggetto e attore della propria alienazione.
SE IL FEMMINISMO degli anni Settanta aveva messo a tema le problematiche del corpo e contrastato l’economicismo dominante nella sinistra extraparlamentare, con l’idea che si dovessero cercare o nessi tra sessualità e politica, sessualità e economia, oggi la naturalizzazione del sistema capitalistico, neoliberista, è avanzata a tal punto da assomigliare alla sorte toccata nel corso di secoli alla donna: l’interiorizzazione, sia pure forzata e inconsapevole, della rappresentazione maschile del mondo, e compresa, per usare le parole di Sibilla Aleramo, «solo per virtù di analisi».
QUANDO i rapporti di potere toccano la vita intima - intreccio, confusione, sovrapposizione-, entrano fatalmente nella vita psichica. È accaduto per le donne, legate a un dominatore che era anche figlio, marito, padre, fratello, amante, piegate per ragioni di sopravvivenza o per amore al sacrificio di sé, alla dedizione all’altro, costrette a considerare malattia, colpa, inadeguatezza propria gli effetti della colonizzazione del loro sesso. Oggi, pur con qualche differenza, può toccare a chi è spinto, fin dagli anni della scuola, a interiorizzare la dialettica servo-padrone, a reinventare la subordinazione, che non trova nella società, come fatto psicologico. Non molto diversa è la richiesta che è fatta alle donne - e che le donne stesse sono tentate di vedere come un riconoscimento e una occasione di far valere la loro «differenza»- di investire le loro «risorse», i loro «talenti» per rivitalizzare un’economia in crisi. Non vittime, ma soggetti che oggettivizzano il loro corpi, come corpi erotici corpi materni.
CONTRO un’emancipazione che vuole oggi uomini e donne attori del loro asservimento, e li ritiene responsabili quando falliscono, non resta che aprire la strada a quella ricerca di autonomia e libertà, su cui si erano incamminati il movimento non autoritario nella scuola e il femminismo. La garanzia di poter contare su un tempo liberato dall’aziendalismo potrà venire da quello che oggi Non Una di Meno ha definito un «reddito di auto-determinazione». Per scostarsi da una illusoria onnipotenza figlia dello sfruttamento capitalistico, ci vorranno comunque modi nuovi e più incisivi dell’agire politico.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- LA LEZIONE DI CESARE BECCARIA E LA SCOPERTA DELLA LIBERTA’.9 novembre 2018, di Federico La Sala
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .... *
- NOTERELLE SUL MACHIAVELLI (1932-34): "Il Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume" (A. Gramsci, Quaderni del carcere)
- "IN OGNI MODO OCCORRE STUDIARE KANT E RIVEDERE I SUOI CONCETTI ESATTAMENTE" (A. Gramsci, Quaderni del carcere)
Dello spirito di famiglia
di Cesare Beccaria ("Dei delitti e delle pene", 1764)
Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche piú illuminati, ed esercitate dalle repubbliche piú libere, per aver considerato piuttosto la società come un’unione di famiglie che come un’unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l’associazione è fatta per le famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l’associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini e nessuno schiavo.
Nel primo caso vi sarà una repubblica, e ventimila piccole monarchie che la compongono; nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l’effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s’introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl’interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a’ piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii generali, vede i fatti e gli condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte.
Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avezzi a piegare ed a temere nell’età piú verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtú nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?
Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto, e i figli, quando l’età gli trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia, per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande società.
Nel primo caso i figli, cioè la piú gran parte e la piú utile della nazione, sono alla discrezione dei padri, nel secondo non sussiste altro legame comandato che quel sacro ed inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessari soccorsi, e quello della gratitudine per i benefici ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.
Tali contradizioni fralle leggi di famiglia e le fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente di altre contradizioni fralla morale domestica e la pubblica, e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell’animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore, la seconda coraggio e libertà; quella insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta, questa a stenderla ad ogni classe di uomini; quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano, che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il bene d’alcuno che la compone; questa insegna di servire ai propri vantaggi senza offendere le leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l’azione. Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtú che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dall’oscurità degli oggetti sí fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di trovarsi malonesto!
A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene piú piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno come i corpi umani i loro limiti circonscritti, al di là de’ quali crescendo, l’economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone, altrimenti, crescendo l’una e l’altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che hanno prodotto.
 Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative.
Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative.Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio d’edificare quant’egli n’ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutt’i secoli lo aspetta, se sarà filosofo, le benedizioni de’ suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell’autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ci circondano, e però sotto il dispotismo piú forte le amicizie sono piú durevoli, e le virtú sempre mediocri di famiglia sono le piú comuni o piuttosto le sole.
 Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei legislatori.
Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della piú parte dei legislatori.
La scoperta della libertà
di Maurizio Viroli (Il Fatto, 18 aprile 2017)
Per molti della mia generazione la lettura degli scritti di Antonio Gramsci ha avuto l’effetto di una liberazione dal marxismo-leninismo banale e dogmatico che teneva banco, alla fine degli anni Sessanta, fra i movimenti della sinistra extraparlamentare. Non ho prove storiche da offrire, ma credo che molti giovani si siano avvicinati al Pci anche perché quel partito si proclamava erede di Gramsci e si impegnava attivamente a farne conoscere gli scritti.
Nel 1975 esce infatti per Einaudi, sotto l’egida dell’Istituto Gramsci, la prima edizione critica dei Quaderni del carcere, a cura di Valentino Gerratana. Su quei quattro volumi furono promosse molte iniziative e si aprì un importante dibattito culturale e politico sul concetto di egemonia, sul rapporto fra democrazia e socialismo, sul ruolo e la natura del partito, sulla Rivoluzione d’Ottobre, sugli intellettuali, sulla storia d’Italia, sulla questione meridionale.
A Gramsci va riconosciuto il merito storico di aver avviato nel mondo comunista la consapevolezza che non era possibile in Italia seguire la via della Rivoluzione d’Ottobre. Lo ha fatto con l’unico argomento che poteva essere efficace, vale a dire la considerazione realistica delle condizioni storiche.
Sarebbe sbagliato sostenere che Gramsci aveva capito che la trasformazione socialista della società deve avvenire soltanto nel pieno rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche. Ma una volta dichiarato che la via sovietica non poteva essere percorsa, che il proletariato “può e deve essere dirigente [vale a dire ottenere il consenso degli altri gruppi sociali] già prima di conquistare il potere governativo”, e che deve continuare a essere dirigente anche dopo la conquista del potere, restava aperta, di fatto, soltanto la via democratica.
L’intuizione più felice di Gramsci è, a mio giudizio, l’idea della “riforma intellettuale e morale”. In un passo delle Noterelle sul Machiavelli, la descrive come “elevamento civile degli strati depressi della società”, simile, per la sua capacità di coinvolgere ampi strati delle classi subalterne, alla Riforma protestante e all’Illuminismo, ma capace di conservare e rielaborare “i caratteri di classicità della cultura greca e del Rinascimento italiano”.
E giustamente sottolinea che la riforma intellettuale e morale “non può non essere legata a un programma di riforma economica, anzi, il programma di riforma economica è appunto il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e morale”.
“Banditore” della riforma intellettuale morale doveva essere per Gramsci, il “moderno Principe”, il partito comunista, che diventa, nella sua visione, non più un’avanguardia volta esclusivamente al lavoro di agitazione e organizzazione in vista della conquista del potere politico, ma un partito educatore e formatore di coscienze, una vera e propria scuola dove gli elementi migliori delle classi subalterne imparano a dirigere il complesso della vita sociale alla luce di ideali di emancipazione.
Il limite dell’idea gramsciana della riforma intellettuale e morale non risiede nella sua concezione del partito politico come educatore e formatore di coscienze, ma nella sua convinzione che il partito della classe operaia debba essere il punto di riferimento del giudizio morale e politico: “Il moderno Principe sviluppandosi sconvolge tutto il sistema dei rapporti intellettuali e morali in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni atto viene concepito come utile o dannoso, come virtuoso e scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno principe stesso e serve a incrementare il suo potere o a contrastarlo”.
Il Principe, conclude Gramsci, “prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico” (Quaderni del carcere, vol. III, p. 1561). Ma la coscienza personale è e deve rimanere rigorosamente individuale: può accogliere l’imperativo morale o la divinità, ma mai lasciare entrare come sua guida suprema un soggetto collettivo, non importa se è lo Stato, o il partito o una chiesa. Se la coscienza personale accetta la guida o l’autorità di un soggetto collettivo non è più pienamente libera e non può costruire né uno Stato né una società liberi.
In quegli stessi anni, nel confino di Lipari, Carlo Rosselli scriveva su Socialismo liberale: “Non esistono fini della società che non siano, al tempo stesso, fini dell’individuo, in quanto personalità morale; anzi questi fini non hanno vita se non quando siano profondamente vissuti nell’intimo delle coscienze. [...] Uno Stato libero vuole prima e soprattutto uomini liberi. E uno Stato socialista spiriti socialisti. Io non esito a dichiarare che la rivoluzione socialista sarà tale, in ultima analisi, solo in quanto la trasformazione della organizzazione sociale si accompagnerà a una rivoluzione morale, cioè alla conquista, perpetuamente rinnovantesi, di una umanità qualitativamente migliore, più buona, più giusta, più spirituale”. Carlo Rosselli partiva da Giuseppe Mazzini; Gramsci da Karl Marx e da Lenin.
Per arrivare all’idea del socialismo come trasformazione sociale sorretta da una riforma intellettuale e morale capace di realizzare l’elevamento civile delle classi subalterne, aveva percorso una lunga strada grazie alla libertà morale e intellettuale che gli diede la forza di andare contro le idee prevalenti nel suo stesso partito, senza paura di affrontare, anche nelle terribili condizioni del carcere, l’ostilità degli stessi compagni comunisti che lo giudicavano un traditore della causa. La sua è una testimonianza di libertà, per tutti i tempi.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"FAMILISMO AMORALE" E SOCIETA’. LA FAMIGLIA CHE UCCIDE: IL LATO OSCURO DELLA FAMIGLIA.
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!! FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- "Non c’è fede che tenga. Manifesto contro il multiculturalismo" (Cinzia Sciuto). Nota di Marco Aime.31 ottobre 2018, di Federico La Sala
Non c’è fede che tenga
Manifesto contro il multiculturalismo
di Marco Aime (Doppiozero, 31.10.2018) *
Un libro coraggioso quello di Cinzia Sciuto, tagliente e spigoloso, che non fa sconti e mette il dito nella piaga di un atteggiamento sempre più diffuso, l’elogio del multiculturalismo, che però nasconde un dono avvelenato, che lo porta ad assomigliare a una forma di razzismo capovolto, seppure animato da lodevoli intenzioni. La critica dell’autrice parte dalla necessità di esercitare sempre e in modo coerente una determinata laicità, che conduca a prestare sempre più attenzione ai diritti degli individui, piuttosto che a quelli dei gruppi, di qualunque specie essi siano: etnici, religiosi, politici, ecc. Laicità come fondamento della democrazia, laicità che non si oppone alla/le religione/i, ma che rifiuti ogni principio di autorità e di ingerenza e non solo quelli religiosi. Essere laici significa, per Sciuto, “non invocare nessuna tradizione per giustificare una limitazione, se non addirittura una violazione, dell’autonomia e della libertà di ciascun essere umano”.
Nei paesi come la Gran Bretagna, dove da decenni si segue la linea del multiculturalismo, sono venute a formarsi comunità etniche o religiose che vivono una accanto all’altra, ciascuna secondo dei dettami della sua tradizione. Questo ha fatto sì che, per esempio, siano nate scuole confessionali, dove si insegna la tradizione islamica o induista e solo quelle. Questo, ci avverte l’autrice, porta a chiusure reciproche e non alla costruzione di una reale società, capace di contenere delle differenze. Ogni tradizione poi, e qui a volte Sciuto sembra essere un po’ eccessiva, finisce per limitare le possibilità di scelta del singolo individuo, pena l’esclusione o la marginalizzazione della società. Se poi lo Stato agisce nei confronti delle comunità culturali in quanto tali, finisce che l’attenzione si sposta dalle persone al gruppo, per cui un individuo diventa degno di protezione o di qualche altra azione solo in quanto appartenente a tale gruppo.
Ampio spazio è dedicato alla questione del velo a proposito della quale Sciuto è molto critica anche sulla possibile libera scelta per una donna di indossarlo, in quanto ogni scelta è condizionata da una tradizione culturale e da un senso di appartenenza. In parte è vero, ma è vero che anche la laicità, che condivido pienamente, è il prodotto di una tradizione culturale, la nostra. L’autrice però, giustamente, afferma che se “loro” vivono qui, non sono più “loro” ma parte di “noi”. Forse il paragone tra il velo e le mutilazioni genitali femminili appare un po’ eccessivo, ma pone il giusto problema del limite di accettazione che ogni comunità può sopportare e soprattutto di chi stabilisce questo limite.
Ovviamente questo discorso implica anche una riflessione sul concetto di identità, che pervade gran parte del dibattito politico-culturale attuale e su come tale identità venga sempre più spesso rappresentata in modo essenzialista e fissista, per poi essere strumentalizzata politicamente. Riprendendo una distinzione proposta da Seyla Benhabib tra ethnos e demos si sottolinea come debba essere il secondo a prevalere, cioè una comunità a cui si sceglie di appartenere e non a cui si “deve” appartenere secondo una logica di discendenza o in nome di una tradizione. La critica non risparmia neppure una certa sinistra, che sempre più spesso si è dedicata al riconoscimento dei diritti di gruppi particolari, dimenticando la sua vocazione universalista.
Tutto il percorso di Cinzia Sciuto è teso al raggiungimento si una società laica, che riconosca i diritti agli individui per ciò che sono e non perché appartenenti a una comunità di qualche tipo. Un percorso che serva a elaborare urgentemente “una prospettiva solidale, laica, libertaria e universalista: perché i diritti, se non sono universali, si chiamano privilegi”.
*
C. Sciuto, Non c’è fede che tenga. Manifesto contro il multiculturalismo, Feltrinelli, 2018.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Nelle viscere della storia. la lezione della rivista “L’erba voglio" (di Lea Melandri).14 settembre 2018, di Federico La Sala
Nelle viscere della storia
di Lea Melandri*
Nelle “viscere della storia” non c’è solo la barbarie o la disumanità. Ci sono anche “prospettive impensate”, “tesori di cultura”. Basta cercarli. È questa la lezione della rivista “L’erba voglio”.
Il pericolo che molti vedono incombere sulla democrazia nel nostro Paese raramente viene associato alla crisi, più generale e più datata della politica: la modificazione lenta ma inarrestabile dei confini che per secoli hanno circoscritto e confuso lo spazio pubblico con il suo governo, le sue istituzioni, le sue leggi, i suoi linguaggi, e, prima ancora, con il dominio di un sesso solo.
Se la nostra cultura non si fosse dimostrata finora così ottusamente refrattaria ad accogliere analisi attente ai nessi tra corpo e politica, tra virilità e costruzione storica della sfera pubblica, risulterebbe evidente che la norma e la trasgressione, l’ordine e la perdita di controllo, la legge e la sua sistematica violazione, il bene collettivo e l’egoismo individuale, la civiltà e la barbarie, non hanno mai smesso di affrontarsi e confondersi nello spazio pubblico, sotto la spinta di contesti economici e politici mutevoli, ma ubbidendo nel medesimo tempo a quella “invariante” della storia che è l’identificazione dell’umano perfetto con la maschilità, e tutte le contrapposizioni che ha prodotto tra l’amico e il nemico, il cittadino e lo straniero
L’irruzione del “femminile” nella vita pubblica - inteso non solo come presenza quantitativa delle donne nel luogo da cui sono state tradizionalmente escluse, ma come protagonismo e rivalsa di tutto ciò che è stato identificato col “sesso debole” - non poteva non intaccare i fondamenti della politica, mettere in discussione i concetti di libertà, democrazia, uguaglianza, fraternità, diritto, ridefinire in modo meno astratto la figura del cittadino.
Se l’occasione di portare al centro della responsabilità collettiva la vita nella sua interezza si sta trasformando in “antipolitica” - rovesciamento dei rapporti tra ordine e caos, realtà e immaginario, ragione e sentimenti - è perché si continuano ad ignorare i percorsi di liberazione e di allargamento dell’impegno politico aperti dalle culture alternative degli anni Settanta, in particolare dal femminismo, e oggi dalle associazioni di uomini che si interrogano sulla storia dal punto di vista del sesso che ne è stato protagonista.
Quello che molti di noi scoprirono allora, come insegnanti, operatori sociali, studenti, operai, nel momento in cui si abbandonavano gli strumenti tradizionali del controllo e della repressione, avrebbe dovuto allarmare molto più delle forze conservatrici che ci fecero guerra.
Le pratiche non autoritarie nella scuola, negli asili autogestiti, nelle assemblee autonome sorte all’interno delle fabbriche, che generalmente vengono additate da destra e da sinistra come la causa remota del degrado attuale, sono state, al contrario, il primo svelamento della massificazione precoce, la denuncia del caos che si cela dietro i sistemi istituzionali di controllo e sicurezza.
- “Eludendo la figura dell’adulto - annotava Elvio Fachinelli in Masse a tre anni (L’erba voglio, Einaudi, 1971) -, astrattamente considerata ‘autoritaria’, si vede sorgere una gerarchia di ferro, basata sulla forza e la prepotenza, che impronta di sé i rapporti dei bambini tra loro (...) sembra di trovarsi in una società violenta, tra il fascista e il mafioso”.
Erano segnali piccoli ma inequivocabili, portati allo scoperto dalla consapevolezza delle mutilazioni che si era inflitta la politica, e dall’idea che bisognasse partire da lì, da quei corpi che arrivano all’asilo “già rattrappiti e coartati”, per trovare nuove forme d’amore e di convivenza umana.
La crisi dell’autorità paterna nell’ambito famigliare, e il declino delle istituzioni della vita pubblica, avrebbero poi subìto un’accelerazione imprevista sotto l’urto della società dei consumi, della sua potenza invasiva e divorante, della sua indifferenza per norme e limiti di ogni specie. Così è accaduto che, quando ancora le donne muovevano i primi passi da cittadine sotto tutti gli effetti, a farla da vincitore fosse il “femminile” costruito dall’uomo, la visceralità che la storia si è portata dietro e che insidia da sempre il suo processo di incivilimento.
Oggi si scopre che l’inconscio collettivo, che si è espresso “democraticamente” nel voto della maggioranza, è reazionario. Non era poi così difficile da immaginare: tutto ciò che è stato sepolto nella zona più oscura della vita dei singoli, identificato con la natura o con la parola rivelata di un Dio, per potersi modificare ha bisogno innanzi tutto di essere riconosciuto, narrato e analizzato, restituito alla cultura e alla politica con cui è sempre stato in rapporto, sia pure un rapporto alienato, strumentale, distruttivo della politica stessa e delle sue conquiste democratiche.
L’“immensa esperienza negativa” che si è accumulata nelle “viscere della storia” nel corso dell’ultimo secolo, come conseguenza del fatto che sono stati considerati condizione quasi esclusiva del cambiamento i rapporti di produzione, oggi esce allo scoperto attraverso la retorica populista delle destre occidentali. Ma, se non ne abbiamo paura e, soprattutto se non abbiamo fretta di cancellarla o imitarla, forse è l’occasione per dare finalmente cittadinanza a “esperienze essenziali del vivere umano”.
L’esperienza della rivista “L’erba voglio” ha significato fare cultura attraverso tutto ciò che la cultura tradizionale considera “rifiuti”, “scarti”, “tabù”, prendere distanza dalla continuità del “noto”, dal rapporto ottimistico che la cultura occidentale ha intrattenuto con le sue mete tecno scientifiche, non aver paura di addentrarsi nel “caotico mondo dell’antiragione”, aprirsi a “prospettive impensate”.
Prima che la barbarie, come ritorno a forme arcaiche di violenza, prenda il sopravvento, dovremmo tentare - come è stata per la generazione “imprevista” di giovani e donne nel Sessantotto -, a farci noi “barbari”, estranei e creativi, rispetto a una civiltà esaurita e sempre più disumanizzante.
*Insegnante, giornalista, scrittrice e saggista, riferimento per il movimento delle donne italiano. Tra i suoi libri: L’infamia originaria; Come nasce il sogno d’amore; Le passioni del corpo. La vicenda dei sessi tra origine e storia; La perdita; Amore e violenza. Il fattore molesto della civiltà. Altri suoi articoli sono leggibili qui.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- La cooperazione come terzo principio fondamentale dell’evoluzione (Vittorio Lingiardi)..12 settembre 2018, di Federico La Sala
I dialoghi. Vittorio Lingiardi e Benedetto Farina
Dottor Freud aiutaci a cooperare
La psicoterapia è una forma di cooperazione e la cooperazione è una forma di psicoterapia
di Vittorio Lingiardi (la Repubblica, 12.09.2018)
- Vittorio Lingiardi è uno psichiatra e psicoanalista italiano, professore ordinario di psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. Wikipedia
La psicoterapia è una forma di cooperazione e la cooperazione è una forma di psicoterapia. Sono giunto a questa conclusione dialogando con un collega che ha una formazione diversa dalla mia. Non che parlare di "scuole" abbia sempre senso, ma la mia educazione, psicoanalitica, e quella del mio interlocutore cognitivista Benedetto Farina, docente all’Università Europea di Roma e allievo di Giovanni Liotti, uno dei padri del cognitivismo italiano, sono oggettivamente diverse. Cose importanti però ci uniscono: siamo entrambi clinici e ricercatori. Benedetto fa ricerca soprattutto da una prospettiva neuroscientifica; io parto dai trascritti delle sedute di psicoterapia per valutare la qualità dell’alleanza terapeutica: rotture, riparazioni, negoziazioni...
Entrambi siamo cresciuti studiando la teoria dell’attaccamento di Bowlby, che pone basi etologiche e motivazionali all’origine delle relazioni e dello sviluppo della personalità. Forse l’unica teoria che ha saputo raccogliere attorno a sé, mettendole in dialogo, discipline tra loro diverse e litigiose. «Oggi - dice Farina - potremmo metterla così: la tua psicoanalisi e il mio cognitivismo considerano la relazione con il paziente il principale strumento terapeutico. Ma non è forse questo il fattore comune che secondo la ricerca spiega l’efficacia di tutti i trattamenti?».
Vittorio Lingiardi: Sì, l’esito di una terapia è in gran parte associato alla qualità della relazione che si stabilisce tra paziente e terapeuta. Detto questo, le variabili in gioco sono molte. Anche perché molte sono le psicoanalisi e molti i cognitivismi. Nonostante il marchio di fabbrica, un paziente in cerca di terapia non sa mai esattamente quello che trova. E poi ci sono le diverse tipologie, anche caratteriali, di terapeuta. Un terapeuta riservato e uno espansivo funzionano nello stesso modo? Con tutti i pazienti? Per tornare alla relazione come fattore terapeutico, mi domando se è più in gioco l’accudimento o la cooperazione, pur sapendo che il bravo clinico sa dosare il loro contributo.
Benedetto Farina: È un tema che appassionava Liotti, il quale ha sempre sostenuto che è più efficace impostare la terapia sul piano cooperativo, soprattutto con pazienti gravi che hanno alle spalle un’infanzia traumatica. Stimolare troppo il sistema dell’attaccamento è rischioso, può riattivare memorie traumatiche di accudimenti mancati o distorti. Molte ricerche dimostrano che la promozione di un clima di cooperazione favorisce invece la capacità di provare empatia, di sintonizzarsi con i pensieri degli altri, di comprendere il funzionamento della mente propria e altrui e di lavorare sugli aspetti che portano a soffrire.
VL: È quello che in psicologia viene chiamato mentalizzare, una funzione che inizia a svilupparsi nei primi anni e ci accompagna tutta la vita. Ed è il pane quotidiano di molte terapie. La sua complessità sta nel riuscire a "tenere in mente" i nostri stati mentali e quelli degli altri. Sofisticate tecniche di registrazione simultanea dell’attività cerebrale di due individui che interagiscono mostrano che l’attività elettrica dei loro cervelli, nelle aree evolutivamente più recenti come la corteccia frontale, si sincronizza quando devono compiere azioni coordinate e cooperative.
BF: Molte discipline indicano che l’eccezionale espansione del cervello e lo sviluppo delle funzioni cognitive e culturali di cui l’uomo è capace sono il risultato di una traiettoria evolutiva finalizzata alla relazione e alla cooperazione. La spinta motivazionale alla cooperazione ha richiesto lo sviluppo di capacità cognitive sempre più sofisticate come il linguaggio, l’empatia, la condivisione di scopi e decisioni, l’insegnamento.
VL: E dunque delle strutture cerebrali per sostenerle. Ma se la capacità di instaurare legami cooperativi è così fondata sul piano etologico e biologico, come può essere tanto in disgrazia sul piano sociale? Il discorso va affrontato sul piano dell’evoluzione. Proprio Liotti ci insegnava a non perdere di vista la tripartizione evolutiva e gerarchica del nostro cervello e dei nostri sistemi motivazionali. Il livello più arcaico presiede le condotte non-sociali legate alla regolazione delle funzioni fisiologiche, alla difesa dai pericoli, al controllo del territorio, ecc. Quando è molto attivato può avere la meglio. Il secondo livello corrisponde all’attività delle reti neurali che definiscono le condotte di attaccamento, accudimento, richiesta/offerta di cura, ecc. Il terzo livello, prerogativa della specie umana, è nella neo-corteccia e riguarda le dimensioni cognitive dell’intersoggettività e della costruzione di significati. Regola i livelli più arcaici ed è influenzato dalla cultura di appartenenza.
BF: Ed è proprio qui che poggia il sistema cooperativo paritetico. La spinta a cooperare non solo ha promosso le nostre capacità empatiche e intellettuali, ma ha anche favorito la nascita della cultura. Il vantaggio di condividere ciò che si è appreso dall’esperienza individuale è alla base delle capacità culturali che caratterizzano la nostra specie.
VL: Ha dunque ragione l’antropologo Robert Boyd quando sostiene che il nostro successo nell’adattamento è dovuto alla capacità di imparare dagli altri, una capacità che ci permette di accumulare informazioni tra le generazioni e sviluppare strumenti, credenze e pratiche che sarebbe troppo complesso per il singolo individuo concepire durante l’arco della vita. La cosiddetta social brain hypothesis ci spiega infatti che, nei primati, l’espansione del cervello è avvenuta per gestire rapporti sociali sempre più complessi e cooperare al meglio. Un fatto che ci aiuta a capire lo sviluppo di tutte quelle relazioni non finalizzate alla riproduzione, "cognitivamente" impegnative e specificamente umane, come quella psicoterapeutica. Se la mente umana si è sviluppata per cooperare non sorprende che, quando si ammala o soffre, la sua cura non possa che basarsi su una relazione cooperativa.
 L’aspetto più "miracoloso" dell’evoluzione è forse proprio l’abilità di generare cooperazione in un mondo competitivo. Al punto che c’è chi sostiene che, alla mutazione e alla selezione naturale, andrebbe aggiunta la cooperazione come terzo principio fondamentale dell’evoluzione.
L’aspetto più "miracoloso" dell’evoluzione è forse proprio l’abilità di generare cooperazione in un mondo competitivo. Al punto che c’è chi sostiene che, alla mutazione e alla selezione naturale, andrebbe aggiunta la cooperazione come terzo principio fondamentale dell’evoluzione. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Lo "scippo" del Nobel e, 44 anni dopo, la rivincita dell’astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell12 settembre 2018, di Federico La Sala
CULTURE
Scoprì le stelle pulsar ma il Nobel andò al suo professore: 44 anni dopo, l’astrofisica si prende la sua rivincita
Jocelyn Bell Burnell era solo una studentessa di Cambridge negli anni ’70 e, per di più, donna. Come "risarcimento" riceverà un premio da 3 milioni di dollari
di Huffington Post (07.09.2018)
Per la scoperta delle stelle pulsar - merito suo - l’astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell non ricevette alcun premio. Anzi, il Nobel per la Fisica, che le spettava, invece che a lei andò al suo professore. D’altronde lei era solo una studentessa di Cambridge, giovane e per di più donna. Oggi, però, la scienziata si è presa una rivincita: in USA le è stato assegnato lo "Special Breaktrough Prize", un premio finanziato dai miliardari della Silicon Valley, del valore di 3 milioni di dollari.
Basterà questo risarcimento tardivo a compensare lo "scippo" del Nobel? "Sono rimasta assolutamente senza parole", ha affermato Jocelyn ai media dopo aver appreso la notizia, "e chiunque mi conosce sa che non sono mai senza parole. Non era mai entrato neppure nei miei sogni più bizzarri".
- [Foto] Acclaimed Northern Irish astrophysicist Jocelyn Bell Burnell, pictured at the Edinburgh International Book Festival where she talked about her work which included the discovery of the pulsar. The three-week event is the world’s biggest literary festival and is held during the annual Edinburgh Festival. The 2011 event featured talks and presentations by more than 500 authors from around the world. (Photo by Colin McPherson/Corbis via Getty Images)
Jocelyn Bell Burnell fu autrice di una delle maggiori conquiste scientifiche del XX secolo. Nata nel 1943 in Irlanda del Nord, Jocelyn era arrivata all’università di Cambridge per un dottorato. Fu proprio durante il periodo di studio, precisamente nel 1967, che fece l’importante scoperta: mentre esaminava i dati provenienti da un radiotelescopio che aveva aiutato a costruire, si accorse di un segnale insolito, onde radio che pulsavano a intervalli regolari. "Me ne sono accorta perché ero molto attenta, molto precisa, a causa della ’sindrome dell’impostore’", ha raccontato al Guardian. Il riferimento è a quella sensazione di essere sempre in errore: Jocelyn dubitava delle proprie capacità e temeva di poter essere cacciata da Cambridge.
Fu il professore il primo a "smontarla": le disse che quel segnale era semplicemente un’interferenza, di origine umana.
Lei non si arrese: raccolse ulteriori dati e rilevò tre diversi impulsi radio provenienti da diverse parti della galassia. Questi provenivano da stelle pulsar, le quali, quando ruotano su se stesse, emettono onde radio che si diffondono nello spazio come da un faro cosmico.
La scoperta fu talmente sensazionale da guadagnarsi il Nobel, che però non andò a Jocelyn ma al suo professore. "Ero soltanto una studentessa", commenta oggi la scienziata. Come per riscattare il torto subito, l’astrofisica donerà i 3 milioni vinti per finanziare gli studi scientifici delle giovani donne.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) - AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE".18 agosto 2018, di Federico La Sala
AUTOSTRADE PER IL CIELO: CARTE TRUCCATE E "PONTE PERICOLANTE". L’*AMORE* Di MARIA E GIUSEPPE E LA "PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018" :
- Preghiera dei bambini (1870): “Cristo lo voglio io per Padre/ la Madonna la voglio per Madre/ S. Giuseppe lo voglio per fratello,/ I Santi tutti li voglio per parenti / Affinché mi scampino da tutti i cimenti” (http://www.fondazioneterradotranto.it/2018/07/06/ggimentu-gimmientu-e-ggimintare/#comment-96032)
- Dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio: "Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio"(la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35).
- "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16).
PREGHIERA UFFICIALE PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 *
 Dio, nostro Padre,
Dio, nostro Padre,
 Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,
 Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.
 Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.
 Rendici pazienti e gentili,
Rendici pazienti e gentili,
 Amorevoli e generosi,
Amorevoli e generosi,
 Accoglienti con i bisognosi.
Accoglienti con i bisognosi.
 Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.
 Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,
 Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:
 [facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia e altre
 persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome].
 Aumenta la nostra fede,
Aumenta la nostra fede,
 Rendi forte la nostra speranza,
Rendi forte la nostra speranza,
 Conservaci nel tuo amore,
Conservaci nel tuo amore,
 Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.
 Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, Amen
Amen Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
Maria, madre e guida nostra, prega per noi.
 San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.
 Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.
 San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.*Fonte: https://www.worldmeeting2018.ie/WMOF/media/downloads/prayerA4-IT.pdf
* L’Incontro mondiale. «Famiglia, sfida globale». Ecco il senso dell’incontro di Dublino. L’arcivescovo Martin, primate della Chiesa d’Irlanda: Amoris Laetitia, messaggio di misericordia nella complessità. Uno spazio dedicato anche al soloroso tema degli abusi (di Luciano Moia, Avvenire, venerdì 17 agosto 2018: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/famiglia-sfida-globale-ecco-il-senso-di-dublino).
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
GESU’ "CRISTO", GESU’ DI NAZARET. MA CHI ERA COSTUI?! CERTAMENTE IL FIGLIO DELL’AMORE ("CHARITAS") DI GIUSEPPE E DI MARIA!!! NON IL FIGLIO DEL "DIO" ("CARITAS") DELLA CHIESA AF-FARAONICA E COSTANTINIANA !!!
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala (18.08.2018)
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Dialettica della solitudine e labirinti della soggettività: "L’arcisenso" di Aldo Masullo. Note.10 agosto 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA.
- L’Arcisenso. Dialettica della solitudine
La solitudine come humus del bisogno di comunicare
di Giorgio Agnisola («Avvenire», 24 luglio 2018)
I1 titolo, peraltro suggestivo, dell’ultimo libro di Aldo Masullo, L’Arcisenso, può far supporre una disamina attorno ai disperanti sensi dell’incomunicabilità. In realtà il novantaseienne filosofo italiano declina nella sua opera una differente definizione della solitudine, essendo al centro della sua riflessione i concetti di relazione e intersoggettività, da sempre suoi luoghi di approfondita indagine. Nello specifico il libro raccoglie scritti di epoche differenti opportunamente rivisti, puntando l’autore, in definitiva, a una sintesi del suo pensiero.
In principio Masullo pone il significato di "paticità". Essa muove, secondo il filosofo, ogni atto e sentire umani. «Nulla si compie, nulla avviene nella coscienza se non nel segno del patire». In questo senso gioia e dolore sono facce di una stessa essenza umana; «sicché questo patire, diciamo sentire profondamente implicato col sentirsi, con il sensus sui, è unico e inviolabile. Io posso dire al mio simile ciò che penso, posso spiegarmi e spiegare, posso in sostanza comunicare, ma non posso trasmettere a chi mi ascolta, pur desiderandolo, il mio personale sentire». «Toccare un altro non è toccarlo ma sentirsi mentre lo si tocca».
 In sostanza non si esiste, scrive Masullo, se non si sente di esistere, ma il sentire dell’altro mai io posso sentirlo. Il mio sentire resta incomunicabile, ostinatamente e imprescindibilmente legato al mio sé: dunque «Il sentir-si, l’Arcisenso, è l’Intoccabile».
In sostanza non si esiste, scrive Masullo, se non si sente di esistere, ma il sentire dell’altro mai io posso sentirlo. Il mio sentire resta incomunicabile, ostinatamente e imprescindibilmente legato al mio sé: dunque «Il sentir-si, l’Arcisenso, è l’Intoccabile».Da qui la solitudine di leopardiana memoria (a Leopardi l’autore dedica un affascinante capitolo), il sentire la solitudine del sentirsi. Che non è dunque solo una condizione dello spirito, ma anche un’esperienza del corpo. L’attitudine morale e lo stesso valore della politica, afferma Masullo, derivano da questo principio. Ora questa solitudine può condurre al male, può corrompersi nell’odio e cedere alla castrante paura dell’intimità. Ma può essere una preziosa chance.
 La solitudine infatti, scrive ancora il filosofo, può dirsi in definitiva una condizione positiva della natura umana, giacché dalla solitudine deriva il bisogno di comunicare, di cercare strategie di convivenza, di operare nel sociale, di condividere.
La solitudine infatti, scrive ancora il filosofo, può dirsi in definitiva una condizione positiva della natura umana, giacché dalla solitudine deriva il bisogno di comunicare, di cercare strategie di convivenza, di operare nel sociale, di condividere.
 Con questa premessa Masullo rilegge temi fondanti della filosofia contemporanea, come il relativismo, a cui assegna un valore politico. Il relativismo, afferma il filosofo, viene sovente letto in termini negativi. Viceversa «è proprio dalla certezza del relativo che può nascere la volontà, il bisogno di una strategia di adattamento e di mediazione».
Con questa premessa Masullo rilegge temi fondanti della filosofia contemporanea, come il relativismo, a cui assegna un valore politico. Il relativismo, afferma il filosofo, viene sovente letto in termini negativi. Viceversa «è proprio dalla certezza del relativo che può nascere la volontà, il bisogno di una strategia di adattamento e di mediazione».Il conclusivo capitolo del libro dal titolo «Nei labirinti della soggettività» ha un valore emblematico. In esso il filosofo recupera la storia della sua ricerca in una prospettiva autobiografica. Sembrerebbe un capitolo eccentrico rispetto al contesto dell’opera. In realtà scorrendolo si comprende che esso fa da legante al testo, in qualche misura ne spiega i nessi, tra tema e tema, e li riassume nel profondo della straordinaria storia umana del maestro.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Questione antropologica
 IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA"."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
- L’Arcisenso. Dialettica della solitudine
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --FILOSOFIA, BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA. "LA FINE DEL SESSO" E I SUCCESSI DELLE BIOTECNOLOGIE. Note5 agosto 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E SOCIETA’..... *
Confini. L’elmento maschile, in una panoramica generale, si presenta in modo sporadico e occasionale, e dunque accessorio
La fine del sesso
I successi delle biotecnologie interrogano su una questione: declino e limiti di «rapporti naturali» e riproduzione sessuata
di Carlo Alberto Redi (Corriere della Sera, La Lettura, 05.08.2018)
Una delle domande trabocchetto negli esami del corso di laurea in Scienze biologiche è quella relativa alla definizione di sesso. Lo studente impreparato cade nell’errata semplificazione antropocentrica di definire il sesso come potrebbe fare la mitica casalinga di Voghera (Arbasino docet): l’insieme delle contrastanti e complementari caratteristiche (anatomiche, fisiologiche, psicologiche) che mostrano gli individui delle specie a riproduzione sessuata, dissertando poi di sesso genetico, cromosomico, gonadico e precisando tutti i caratteri apprezzabili, primari (ovaio e testicolo), secondari (peli, barba e mestruazioni), terziari (aspetti psicologici e di genere). La corretta definizione fa riferimento al processo della ricombinazione genetica dei caratteri ereditari: nella produzione dei gameti, uova e spermatozoi, la molecola di Dna viene tagliata e ricucita, mescolando i caratteri genetici e creando variabilità nell’assortimento degli stessi. Il grande vantaggio evolutivo della riproduzione sessuata consiste così nel creare un’alta variabilità genetica, sulla quale si esercita la selezione darwiniana; gli individui che hanno ereditato le associazioni di caratteri più favorevoli per l’ambiente in cui vivono sono in grado di accedere con maggiore successo alle risorse ambientali e quindi di riprodursi (fitness).
Due le grandi ipotesi che tentano di spiegare l’origine della riproduzione sessuata, la tangled bank e la «Regina rossa». La prima fa riferimento a Charles Darwin, che nell’ultimo paragrafo della sesta e ultima edizione dell’Origine delle specie, usa l’espressione tangled bank per descrivere l’ambiente come una «banca ingarbugliata», ricco di un enorme assortimento di tante e diverse creature tutte in competizione tra loro; creando alta variabilità genetica tra gli individui, la riproduzione sessuata assicura loro un vantaggio nella competizione per le risorse. La critica più ovvia è legata al fatto che i batteri presentano una scarsissima variabilità, pur essendo sul pianeta Terra da miliardi di anni.
Anche l’ipotesi della «Regina rossa» incontra difficoltà teoriche. La formula è di Leigh van Valen, che nel 1973 la riprese dal romanzo di Lewis Carroll Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, quando la «Regina rossa» spiega che «se si vuole andare da qualche altra parte, si deve correre almeno due volte più veloce».
 Fu William Donald Hamilton a esplicitare la metafora in lavori scientifici che sono veri capisaldi concettuali della teoria genetica dell’evoluzione del sesso (e dell’altruismo, della sociobiologia, in particolare per le relazioni preda/predatore e parassitato/parassita): gli individui delle varie popolazioni che compongono una specie debbono sempre «correre», evolvere in continuazione, per sopravvivere; in altre parole, la ricombinazione genetica (il sesso) assicura al parassitato di evolvere rapidamente caratteristiche capaci di difenderlo dall’attacco del parassita, ma... anche il parassita, grazie al sesso, è in grado di evolvere nuove combinazioni di caratteri tali da permettergli di parassitare di nuovo, così perpetuando in continuazione l’infinita rincorsa.
Fu William Donald Hamilton a esplicitare la metafora in lavori scientifici che sono veri capisaldi concettuali della teoria genetica dell’evoluzione del sesso (e dell’altruismo, della sociobiologia, in particolare per le relazioni preda/predatore e parassitato/parassita): gli individui delle varie popolazioni che compongono una specie debbono sempre «correre», evolvere in continuazione, per sopravvivere; in altre parole, la ricombinazione genetica (il sesso) assicura al parassitato di evolvere rapidamente caratteristiche capaci di difenderlo dall’attacco del parassita, ma... anche il parassita, grazie al sesso, è in grado di evolvere nuove combinazioni di caratteri tali da permettergli di parassitare di nuovo, così perpetuando in continuazione l’infinita rincorsa.La riproduzione asessuata è molto diffusa sia tra gli animali sia tra i vegetali; associata a un’alta capacità di rigenerazione dell’individuo, assicura la procreazione di cloni genetici. Si realizza per scissione binaria o per frammentazione e rigenerazione del corpo: chi tra i lettori non ha mai compiuto un’operazione di riproduzione asessuata di un vegetale strappando un pezzo di foglia, ramo, radice per riprodurlo, tramite talea rigenerativa, a casa propria? Negli animali è presente in moltissimi gruppi, dai Protozoi unicellulari ai Metazoi pluricellulari come i Poriferi (le spugne).
È materia del contendere se la riproduzione sessuata si sia originata da quella asessuata o viceversa. Oggigiorno si tende a preferire l’ipotesi che sia la riproduzione asessuata a essersi originata dalla primigenia sessuata (in molti libri di testo è ancora favorito il caso inverso), considerando il fatto che tutta la macchina enzimatica che assicura il taglia-e-cuci del Dna nel corso della ricombinazione genetica è essenzialmente quella impiegata nei meccanismi molecolari del taglia-e-cuci utili alla riparazione della doppia elica del Dna; questi erano già attivi nel mantenere l’integrità della molecola di acido nucleico dell’ultimo antenato universale comune di tutti gli esseri viventi (in sigla Luca, Last Universal Common Ancestor).
Comunque originato, il sesso è determinato da specifici geni che nel corso dell’evoluzione si sono raccolti su singoli cromosomi, i cromosomi sessuali X e Y (Mammiferi) oppure Z e W (Uccelli). Anche l’ambiente (temperatura, durata del periodo d’illuminazione giornaliera, densità di popolazione, risorse trofiche...) influenza la determinazione del sesso, come nelle tartarughe ove una temperatura superiore ai 30°C determina la nascita di femmine. Il sesso primario nell’uomo si stabilisce intorno alla quinta settimana di sviluppo, quando l’embrione indifferenziato sviluppa i testicoli con l’accensione del gene Sry (sul cromosoma Y) o l’ovario grazie al gene Wnt4 (sul cromosoma 1). Si intuisce chiaramente che un processo così altamente complesso possa alterarsi e produrre uno spettro di caratteristiche sessuali (intersessualità) che trascende rigide categorizzazioni. L’intersessualità non va confusa con l’ermafroditismo, ove un solo tipo di individui è portatore delle gonadi dei due sessi e produce sia uova sia spermatozoi (sebbene a fasi alterne e quindi gli ermafroditi debbono comunque accoppiarsi).
Un aspetto assai curioso e paradossale della riproduzione sessuata è che il sesso maschile, in una panoramica biologica generale, si presenta qui e là in modo sporadico e occasionale. Pur tralasciando la visione sociobiologica che assegna un «costo» al mantenimento dei maschi (costituiscono la metà della popolazione, non partecipano in modo significativo all’allevamento dei piccoli, non li generano direttamente), il sesso maschile risulta dunque un sesso accessorio e non obbligatoriamente presente, non indispensabile nell’accadere della riproduzione sessuata, che può essere tranquillamente portata a termine dalle sole femmine grazie alla partenogenesi, una modalità di riproduzione sessuata uniparentale.
- Senza fecondazione.
- La partenogenesi è una forma di procreazione portata a termine dalle sile femmine: è possibile anche provocarla artificialmente, con stimolazioni chimiche dell’oocita così da indurlo a riassorbire un globulo polare (un falso spermatozoo) er ricostruire l’integrità del genoma
La partenogenesi può produrre solo femmine oppure solo maschi o entrambi i sessi e può essere un modo obbligatorio di riproduzione oppure può comparire accidentalmente ed essere del tutto facoltativa; le varie modalità sono in relazione ai contesti di variazione delle condizioni ambientali e negli insetti stecco (Fasmidi) e negli Imenotteri sociali (api, vespe...) viene studiata in dettaglio. È possibile anche indurre la partenogenesi, artificialmente, con stimolazioni chimiche dell’oocita così da indurlo a riassorbire un piccolo globulo polare (un falso spermatozoo!) e ricostituire l’integrità del genoma.
L’intervento delle biotecnologie in ambito riproduttivo risale all’abate Lazzaro Spallanzani e al 1786, con la prima fecondazione artificiale realizzata nel cane (il clamore fu mondiale) per giungere alla nascita del primo baby in provetta (Louise Brown, nel 1978 ad opera del Nobel sir Robert Edwards). Se la fecondazione artificiale è pratica accettata, con gli attuali circa 400 mila bimbi che ogni anno nascono in provetta, di fatto la sessualità umana si interroga dinanzi alle attuali possibilità e pratiche di selezione del sesso con risvolti drammatici in alcune società orientali (Cina, India) ove è abitudine diffusa l’aborto delle femmine, al punto di aver prodotto un eccesso di maschi nella società degli adulti.
Di grande interesse l’analisi di questi problemi a livello internazionale realizzata dalla banca mondiale in relazione alle cause che li influenzano (guerre, migrazioni, politiche riproduttive). In che termini le biotecnologie riproduttive possano ridisegnare l’umanità e rendere obsoleto il sesso, permettendo di eliminare patologie e scegliere caratteristiche fisiche e mentali del nuovo individuo (il «bambino disegnato») è un fatto ancora tutto da sviluppare, poiché, mentre avanzano le conoscenze scientifiche, resta da decidere quale possa essere il limite delle loro applicazioni. Oggi da una semplice biopsia di cellule della pelle si possono ottenere, in vitro, cellule staminali pluripotenti e differenziarle in spermatozoi e uova; la gran parte dei benestanti potrà avere figli geneticamente propri in un ampio spettro di possibilità, inclusa la uniparentalità, grazie alla produzione di gameti artificiali e alla produzione incrociata di gameti (uova da maschi e spermatozoi da femmine). Tralasciando ectogenesi, per lo sviluppo dell’individuo al di fuori dell’utero, e clonazione, ancora proibita in ambito umano in tutte le legislazioni, già oggi la multigenitorialità è assicurata dalle pratiche di gestazione surrogata (utero in affitto) e la omogenitorialità dagli scambi di gameti.
È tempo che su questo quasi inevitabile futuro i decisori politici (in fatto di eguaglianza), i giurisperiti (per gli aspetti di responsabilità) e i filosofi (in relazione al post-umanesimo) diano il via alla discussione per capire se abbiamo già imboccato l’autostrada che porta alla fine del sesso con un totale investimento sociale sulla cura corpo, sui problemi della senescenza e sul godimento ormonale grazie al sesso virtuale. Tanta parte della filosofia è ancora attardata a riflettere sulle conquiste della fisica e non a sviluppare nuove visioni e pensieri su chi è oggi un individuo, sul destino del singolo, sulla genitorialità come progetto affettivo di legame sociale consapevole ed elettivo, non sessual-riproduttivo (quindi ascrittivo, non voluto), sulla costituzione del nucleo familiare, sul significato delle storie, dei miti e della psicoanalisi circa i «legami di sangue».
- L’errore di Freud
- Si prova smarrimento dinnanzi alla meravigliosa capacità delle donne di trasmettere la vita. La teoria dell’invidia del pene non regge, semmai esiste un’invidia del parto
Tutte queste opportunità legate allo svolgersi della sessualità interrogano sulla obsolescenza del sesso «naturale» e sui limiti della riproduzione sessuata, sulle possibili pratiche odierne di sesso assicurate dalla realtà virtuale: la sezione della mostra Human+. Il futuro della nostra specie (chiusa a Roma il 1º luglio al Palazzo delle esposizioni) dedicata a questo tema impressionava coloro che (come lo scrivente) ancora sono amanti di inviti e corteggiamenti. La psicologia evolutiva potrebbe aiutare a dipanare lo smarrimento e lo stupore che i maschi provano dinnanzi alla meravigliosa capacità femminile di generare, a capire la genesi dei meccanismi di costrizione del fisico femminile messi in atto storicamente dai maschi per controllare quel corpo generante: e se Sigmund Freud avesse preso una cantonata con la storia dell’invidia del pene da parte femminile? E se fosse invidia del maschio della capacità riproduttiva delle femmine? Altri aspetti, forse meno impegnativi, attendono di essere chiariti: esiste una base chimica per l’attrazione sessuale? La bellezza è davvero negli occhi di chi guarda o nelle ghiandole sudoripare delle femmine? Sono soprattutto le femmine selettive nella scelta sessuale?
La risposta a quest’ultima domanda è la più facile: sì, in tutte le specie a fecondazione interna, dalle mosche all’uomo, la femmina è ben più discriminativa dei maschi nella scelta del partner sessuale. Ne conseguono alcuni avvertimenti, soprattutto per i maschi più giovani: i fiori non si mandano mai prima, ma solo dopo aver vinto la mitica «battaglia dei sessi». Con alcuni corollari: se la corteggiata è una biologa fate attenzione, i fiori sono organi genitali. State regalando ovari e testicoli... prudenza!
Il «testo sacro»
De Beauvoir spezzò le catene delle donne
di Cristina Taglietti (Corriere della Sera, La Lettura, 05.08.2018)
Nel 2019 saranno passati 70 anni dalla pubblicazione de Il secondo sesso di Simone De Beauvoir (in basso). Il testo della scrittrice di cui quest’anno ricorrono i 110 anni dalla nascita è una poderosa riflessione spesso ridotta allo slogan «Donna non si nasce, lo si diventa» perché - scrive Simone de Beauvoir - «nessun destino biologico, psichico, economico definisce l’aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell’uomo; è l’insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna».
 Testo sacro del femminismo che un editto Vaticano nel 1956 mise nell’indice dei libri proibiti (in Italia lo pubblicò il Saggiatore nel 1961), Il secondo sesso è una riflessione filosofica che, a partire dalla dialettica hegeliana, applica l’esistenzialismo di Sartre ai temi dell’emancipazione femminile, sottraendo la donna a un destino biologico che la esclude dalla storia, ma anche all’interpretazione fallocentrica di Freud e a quella del materialismo storico che pone la categoria economica al di sopra di tutte le altre.
Testo sacro del femminismo che un editto Vaticano nel 1956 mise nell’indice dei libri proibiti (in Italia lo pubblicò il Saggiatore nel 1961), Il secondo sesso è una riflessione filosofica che, a partire dalla dialettica hegeliana, applica l’esistenzialismo di Sartre ai temi dell’emancipazione femminile, sottraendo la donna a un destino biologico che la esclude dalla storia, ma anche all’interpretazione fallocentrica di Freud e a quella del materialismo storico che pone la categoria economica al di sopra di tutte le altre.Il secondo sesso, libro dal forte impianto filosofico, letto da migliaia di donne, passa in rassegna i ruoli attribuiti dal pensiero maschile alla donna mettendoli in relazione con i miti ancestrali, i costumi, i tabù, la sessualità studiata in ogni fase della vita femminile, dall’infanzia all’iniziazione sessuale, dalla maturità alla vecchiaia.
Il settantesimo anniversario sarà ancora un’occasione di dibattito tra chi vorrebbe rinchiudere quel testo, insieme alla sua autrice, nel recinto dell’inattualità e chi ritiene che sia stato ingiustamente messo da parte. Di certo Il secondo sesso fu un libro rivoluzionario: oggi si può metterlo in discussione, non ignorarlo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- A PARTIRE DA KANT, NON DA FICHTE. Arcisenso di Aldo Masullo. La bellezza della paticità e la sapienza del relativo. Così ogni storia va ’sentita’.27 luglio 2018, di Federico La Sala
Arcisenso di Aldo Masullo. La bellezza della paticità e la sapienza del relativo. Così ogni storia va ’sentita’
di Silvia Lanzani (Nuova AGENZIA RADICALE, 18 Febbraio 2018)
Gli scenari si costruiscono sempre insieme, al plurale, sapendo tuttavia - come insegnava il Nolano - che ogni punto è ‘centro’. «Patico» è il modo umano della coscienza. Esso è in atto in ogni momento del Sentir-si. Le emozioni vi si umanizzano ed entrano nella “e-sistenza”. Così avviene il sempre nuovo cadere della coscienza fuori del proprio attuale con-sistere. In questo atto si coinvolgono non soltanto le emozioni ma qualsiasi vissuto. Ce lo insegna uno dei più grandi filosofi del nostro tempo, Aldo Masullo, 95 anni il prossimo 12 aprile, che firma uno straordinario testo filosofico, ‘L’Arcisenso. Dialettica della solitudine’ (Quodlibet, pp. 194, euro 17), nel quale il Professore emerito di Filosofia morale alla Federico II di Napoli reimpagina e approfondisce, con nuove e potenti riflessioni, i temi di una intera vita di ricerca filosofica, lasciando una traccia profonda, potremmo dire lavica amando la sua Napoli, negli studi sulla paticità.
Il percorso, infatti, da ’Paticità. L’intoccabile tocco’, a ’Grazia. Il repentino della poesia’, passando per ’Dolore. La scelta di Chirone’, ’Eraclito. il desiderio eroico’, ’Leopardi. Sentire corporalmente il pensiero’, ’Silenzio. L’indecenza della parola’ e ’Sapienza. Nel relativo è la salvezza’. Preziosa anche l’Appendice ’Nel labirinto della soggettività. Appunti per un’autobiografia filosofica’ e, non ultimo, un autentico ’tocco’ di stile con il ’ringraziamento’ ai suoi allievi migliori - migliaia nel tempo - a iniziare da Giuseppe Cantillo e Bianca Maria d’Ippolito, fino ai dialoghi con amici come Matteo Palumbo e Gerardo Picardo.
Per Masullo non solo non vi sono piacere o dolore, ma neppure ragionamento o azione, immaginazione o ricordo, che siano umani, se non sono sentiti, se non recano, sia pure nascosti ma sempre pronti a saltar fuori o almeno a far capolino tra le pieghe del vivere, «lo stupore con cui si manifesta il sé» e «l’angoscia dell’esser toccati da eventi, senza perché». Ogni accadere tocca a me, proprio a me, senza che io sappia perché, così come non so questo me donde venga né dove vada, anzi neppure perché mai proprio a me questo me sia toccato.
Con l’accadermi, la coscienza di me ancora una volta cade fuori del suo con-sistere, e proprio in ciò io e-sisto. Sensus non c’è, se non è sensus sui. Lo stesso sé in nient’altro consiste che nel sensus sui, nel sentimento di sé, nella tensione verso sé come verso l’unità che si ha l’impressione di essere. Esso non è né «prima» né «dopo» questo o quel sentire, ma è sempre di ogni sentire la condizione originaria. Un filosofo tedesco lo chiamerebbe Ursinn. Masullo lo definisce «Arcisenso».
L’avvertimento del sé muove dall’intimo della vita, che nell’individuo umano, sentendo-si, vive. La vita ogni volta accade, e accade in quanto accade al sé che la vita allucina - ad un sé a cui l’accadere tocca, quasi il sé fosse prima dell’accadere, il vissuto fosse prima e non a partire dalla vita vivente. Se una differenza non colpisse, il sé non apparirebbe; né il colpo della differenza, il tempo, apparirebbe senza un sé colpito. Si tocca così la falda più profonda della fenomenalità di ogni fenomeno, il fenomeno primario con cui s’inaugura la possibilità stessa dell’apparire e senza di cui nessun altro fenomeno sarebbe possibile. «Fenomeno» è il calco italiano del greco φαινόμενον, participio del verbo deponente φαίνεσθαι, che in greco vuol dire «apparire», «manifestarsi».
Il φαινόμενον è l’«apparente», il «manifestantesi», cioè l’apparire, il manifestarsi, nel momento stesso in cui appare, si manifesta. È impersonale, senza soggetto, atto con cui tutto appare, tutto si manifesta, il mondo delle cose e di chi le vede e le usa. Il manifestarsi è tutto. L’apparire, il manifestarsi, è puro accadere o, come pur si dice, evento.
Nel vissuto del tempo e del sé, l’emozione di sorpresa nel sentire come contingente l’accadere e l’emozione di angoscia nel sentire come precario il sé strettamente si tengono. Senza il dolore che l’infallibile arciere del tempo infligge, non emergerebbe il sé come il vivente bersaglio di questa offesa. Ma, se il sé non emergesse, il colpo del tempo cadrebbe nel vuoto o riuscirebbe frustrato.
La vita fa come una piega - si «ri-piega su di sé» - . In ciò sta il punto d’origine della fenomenalità, là dove il vivente si converte in umano e si apre a se stesso, si fa soggettivo. La vita stessa si duplica (si complica nel «vivere il proprio vivere», come letteralmente suona il tedesco er-leben), e vivendo prova l’emozione di sé.
Avviene appunto quel che si esprime con il verbo πάσχειν, che vuol dire «patire», non necessariamente nel senso della sofferenza, ma in quello ampio del «provare», cioè del «vivere» usato transitivamente, come nelle espressioni «ho vissuto un brutto momento» e «ho vissuto una bella esperienza». Radice del verbo πάσχειν è παθ, da cui si forma il sostantivo πάθος: il calco italiano ne è «pathos» o più correntemente «patos». Il primo significato di πάθος è «ciò che si prova di bene o di male», in breve il vissuto. Si designa con ciò un’emozione sofferta, umanizzata dalla coscienza del sé.
Al fondo di ogni vissuto sta una rottura. La vita è un incessante rompersi, anche se abitualmente inavvertito. Quando il rompersi è violento e inabituale, l’in-differenza dell’essere esplode nella differenza dell’e-sistere. E’ questo il «repentino» (il platonico ἐξαίφνης). Esso scopre l’inarrestabile passo del cambiamento, ciò che «noi per abitudine chiamiamo tempo».Si mostra qui l’umanità originaria dell’emozione, la falda profonda di ogni emozione propriamente umana. Ci si trova, per essa, presi nella dinamica esistenziale, in cui non soltanto le emozioni occasionali, ma tutti i vissuti, anche quelli intenzionali e semantici, cioè gli sguardi sulle cose e la nominazione di queste, si costituiscono nella loro fenomenalità, nella loro umanità di vissuti. Solamente nel patico si e-siste.
Il sentir-si non è soltanto dell’emozione, ma di qualsiasi vissuto. Non solo non vi sono piacere e dolore, ma neppure percezione e ragionamento, immaginazione e ricordo, che siano tali, umani, se non sono intrisi di sentir-si, se non recano, sia pure nascosti ma sempre pronti a saltar fuori o almeno a far capolino tra le pieghe di qualsiasi atto del vivere, «lo stupore con cui si manifesta il sé» e «l’angoscia dell’esser toccati da eventi, senza perché». Ogni accadere tocca a me, proprio a me, senza che io sappia perché, così come non so questo me donde venga né dove vada, e neppure perché proprio a me questo me sia toccato.
Con l’«accadermi» la coscienza di me ogni volta salta fuori del suo con-sistere, e proprio in ciò io e-sisto. Essa qualifica il vissuto, il riferimento esplicito o implicito a un sé, coscienza riflessiva, autocentrata ancora prima che nella pubblicità della forma linguistica «io» e nella determinazione dialogico-concettuale. Insomma, se il vissuto è l’evento propriamente umano, la paticità è il nucleo intimo del vissuto, la fenomenalità di ogni fenomeno, l’arcisenso.
All’autocentramento però concorrono non soltanto la folgorante emozione del tempo, sofferto trauma della differenza, con la sua oscura figura del sé, ma pure la bruciante inquietudine dell’incontro con l’altro, il tacitamente interpellante, a me familiare o estraneo, seducente o minaccioso, comunque sempre enigmatico, tra me e lui reciprocità interiormente vissuta di speculari rimandi simpatetici o antipatetici. Nell’incontro, in ogni uomo l’immagine dell’altro lo anima del suo sé, e questa a sua volta intanto corrobora il sé di lui e lo arricchisce di tocchi. In questo vivo gioco di reciprocità ognuno si sovradetermina, enfatizzando sé come io e l’altro come tu.
L’emozione, in cui consiste il tempo, l’avvertimento «destabilizzante» di repentini cambiamenti, l’irrompere della differenza in noi, frantuma l’inerte identità dell’ente, ne distrugge l’apaticità, mette in moto la dialettica dell’altro nel sé di ognuno, e di ognuno nel sé dell’altro. La paticità è costitutiva dell’e-sistenza. Nella vertigine patica, sotto l’imperio del tempo, ci si ritrova comunque sempre da capo presso ad una soglia del nuovo, soli nel deserto di un assoluto «inizio». Tutto si ripete, nulla dura. Si danno infinite repliche, ma nessuna identica.
Il vissuto di tempo si rifrange nei molteplici cromatismi emotivi: nella sofferenza per l’identità perduta e l’abitualità sconvolta, nel tremore del destino incombente, nella insicurezza del rapporto con l’altro. Ma esso intero fiammeggia nell’inquietante sfida dell’inizialità, nel muoversi verso il nulla, il vuoto del futuro, a partire dal nulla, dal vuoto del passato. Nella paticità ogni volta, al centro della vita, le occasionali emozioni si “umanizzano”, da fatti naturali si ri-generano in prove umane. In umana anzi si ri-genera la vita tutta, da semplice vita vivente convertendosi in vita vissuta.
Nell’esplosa drammaticità dell’e-sistenza, l’oscuro avvertire che l’identità della coscienza di sé dura solo attraverso la difficile prova del suo incessante perdersi scatena l’emozione originaria, il vissuto decisivo. La morte non è che il caso estremo, la chiusura di partita, di tutte le infinite morti per cui la vita, che è «tempo» ma più propriamente l’incessante cambiamento delle cose (il sempre nuovo irrompere della differenza), fatalmente patisce la sua intrinseca precarietà non solo, dalla parte del dopo, nella straordinaria tragicità della catastrofe finale quanto pure, dalla parte del prima, in certa ordinaria catastroficità del quotidiano.
L’Arcisenso è impenetrabile, ma penetra di sé ogni esperienza. Esso contrasta l’intersoggettività, la relazione d’ogni singolo con gli altri, e tuttavia è condizione necessaria della sua possibilità. È evidente che il principio antropologico - l’idea con cui si comprende il senso di essere «uomo» -, si muove in un circolo. Punto di partenza e punto d’arrivo è sempre la relazione, ma in due versioni diverse. Tra il primo e il secondo funziona una cerniera, un medio: la solitudine. Questa può essere puro sentire o ragionata consapevolezza, ma è comunque paticità del sentir-si. Essa non sarebbe chiaramente e dolorosamente presente senza l’io, che si costituisce nella relazione, a cominciare dalla simbiosi bambino-madre.
A sua volta, senza la patita coscienza della solitudine, della propria separante differenza e unicità, cioè dell’irriducibile esclusività del proprio punto di vista, neppure esisterebbero la pluralità degli individui e la relazione sociale che ognuno d’essi strenuamente e in vari modi persegue, affaticandosi a costruire sistemi di comunicazione con altri soggetti-persone.
Senza l’incontro di un vivente con altri, nessun vissuto si avrebbe. I fenomeni patici e le fenomeno-patie non si originerebbero senza il gioco di una pluralità di viventi. L’ «universalità» della «verità» e dei «valori» in genere non se ne potrebbe generare nell’indifferenza. Essa può dischiudersi soltanto con il crescere dei vissuti nell’assidua e vivente reciprocità della «cura», nell’illimitato complicarsi delle relazioni sin-patetiche; nel sempre nuovo incrociarsi di Aufforderungen («appelli», «pro-vocazioni», «inviti»), come genialmente proponeva Fichte nel dedurre il fondamento intersoggettivo della soggettività e nell’annunziare con esso il significato nuovo dell’universalità dello «spirito».
Pensare l’assoluto non della morte, il nulla, ma della vita, è pensare la relazione, l’illimitata relazione di relazioni. Etico, o più propriamente ’path/ethico’, è il pensiero che, coltivando la sapienza del relativo, ci mantiene nella vita. Liberi.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO - Walter Benjamin e le pietre dell’apocatastasi (di Raffaele K. Salinari).21 luglio 2018, di Federico La Sala
ALIAS
Walter Benjamin e le pietre dell’apocatastasi
Ultraoltre. La salvezza di tutti gli esseri attraverso il ritorno allo stato originario
- [Foto] Schema alchemico del V.I.T.R.I.O.L.
di Raffaele K. Salinari (il manifesto, 21.07.2018)
Ad un certo punto del folgorante saggio sull’opera di Nikolaj Leskov, Walter Benjamin ci introduce alla sua originalissima idea di apocatastasi: la salvezza universale attraverso il ritorno di tutti gli esseri alla pienezza originaria. Il sentiero che invita a percorrere da quel momento è, come spesso nel suo stile, notturno e sotterraneo: pieno di oscure analogie minerali e necriche metafore che però, alla fine, seguendo la mappa tracciata dal suo immaginario messianico, ci porteranno alla luce di una splendente verità.
Come guida naturale del tortuoso cammino, Benjamin staglia dai racconti di Leskov quella particolarissima figura che egli chiama «il giusto». Incarnazione complessa perché estremamente sfaccettata, maschera di volta in volta diversa - il buffone, lo scemo del villaggio, il viaggiatore, l’artigiano, il briccone - il giusto ha, però, un’essenza costante che si trasmette di personaggio in personaggio come in quelle Pathosformel che Warburg cercò di incasellare nel suo favoloso atlante Mnemosyne.
Per distillare questa essenza Benjamin parte da Bloch - che come lui aveva difficili rapporti con i francofortesi - citandone l’interpretazione del mito di Filemone e Bauci, nel quale si descrive la figura del giusto come colui, o colei, che portando con sé un tocco gentile, lo fa amico di tutte le cose. La madre di Leskov stesso ad esempio «che non poteva infliggere una sofferenza a nessuno, neppure agli animali. Non mangiava carne né pesce, tanta era la sua compassione per le creature viventi». Il giusto, conclude Benjamin, è allora il portavoce delle creature ed insieme la sua più alta incarnazione. E così vediamo che la sua essenza immutabile è quella di un essere «favolosamente scampato alla follia del mondo» e che, proprio mercé questa sua caratteristica, è in grado, attraverso i suoi racconti, di portare un annuncio di salvezza, di apocatastasi.
«Apocatastasi» è un termine dalle molteplici accezioni a seconda degli ambiti in cui viene usato. Letteralmente significa «ritorno allo stato originario», oppure «reintegrazione». Nella filosofia stoica, ad esempio, si collega alla «dottrina dell’eterno ritorno»: quando gli astri assumeranno la stessa posizione che avevano all’inizio dell’universo. Per il neoplatonismo, invece, l’apocatastasi è qualcosa di più spirituale, cioè il ritorno dei singoli enti all’unità originaria, all’Uno indifferenziato da cui l’intero insieme delle cose manifestate proviene; è ciò che gli gnostici chiamerebbero il Pleroma. Questa idea si inserisce appieno all’interno del tema, prettamente religioso, della Caduta: l’allontanamento dell’uomo dalla sua originaria comunione con l’Assoluto, col Divino, ma anche di un suo possibile ritorno alla pienezza edenica originaria. Nella teologia dei primi Padri della Chiesa il suo teorico è Origene.
Dice allora Benjamin: «Una parte importante, in questa dogmatica [della chiesa greco-ortodossa], è svolta, com’è noto, dalle teorie di Origene, respinte dalla chiesa romana, sull’apocatastasi: l’ingresso di tutte le anime in paradiso. Leskov era molto influenzato da Origene. Egli si proponeva di tradurre la sua opera Sulle cause prime. In armonia con la fede popolare russa, egli interpretava la resurrezione più che come una trasfigurazione, come la liberazione da un incantesimo, in senso affine a quello della favola». Benjamin, dunque, è qui teso a mettere in rilievo, anzi diremmo a dispiegare pienamente, non tanto il senso teologico, escatologico, del termine, quanto il suo potenziale immaginale, evocativo, metaforico, grazie al quale egli può farci vedere, nei personaggi della narrativa leskoviana, «l’apogeo della creatura» ed allo stesso tempo «un ponte fra il mondo terreno e ultraterreno», costruito attraverso l’atto creativo, poietico, del racconto.
Ma, per la nota verità metafisica secondo cui «ciò che è in alto è come ciò che è in basso», «il giusto» collega sia le vette, gettando un ponte tra il modo terreno e quello ultraterreno, sia le voragini nascoste nelle viscere della terra con ciò che avviene in superficie. «La gerarchia creaturale, che ha nel giusto la sua cima più alta, sprofonda in gradini successivi nell’abisso dell’inanimato. Dove bisogna tener presente un fatto particolare. Tutto questo mondo creaturale non si esprime tanto, per Leskov, nella voce umana, ma in quella che si potrebbe chiamare, col titolo di uno dei suoi racconti, la voce della natura». E dunque eccolo presentarci una di quelle intuizioni che collegheranno la figura del giusto, inteso come interprete della «voce della natura» e della salvezza, alle sue rappresentanze più elementari e sotterranee. «Quanto più Leskov discende lungo la scala della creature, tanto più chiaramente la sua concezione si avvicina a quella dei mistici». Ed a questo punto, con uno dei suoi scarti spettacolari, Benjamin passa a parlare del racconto di una pietra che racchiuderebbe una profezia: l’Alessandrite.
L’Alessandrite e la pulce di acciaio
Il racconto di Leskov citato da Benjamin, si intitola come la pietra che ne è protagonista. Narra di un tagliatore di pietre di nome Wenzel che ha raggiunto nel suo lavoro vette eccelse, paragonabili a quelle degli argentieri di Tule che ferrarono la famosa «pulce di acciaio» capitata nelle mani dello zar Nicola I. Qui una breve digressione è d’obbligo poiché questa pulce, questa «ninfosoria» come viene definita nel racconto, caricabile a molla e di grandezza naturale, pare esista davvero e sarebbe ammirabile nel Museo delle armi in città. Uno scrittore italiano contemporaneo dice di averla vista.
 Chi ama Tolstoj conosce Tule, dato che la sua famosa residenza, Jasnaja Poljana e la sua tomba, si trovano da quelle parti. La storia è semplice ma suggestiva: il fratello della zar Nicola I, Aleksàndr Pàvlovic, riceve in dono dagli «inghilesi» questo manufatto, una «ninfosoria» appunto, fatta di acciaio brunito che, mercé una piccola chiavetta inserita nella pancia, può essere caricata e dunque muoversi come una vera. Alla morte del fratello la pulce meccanica passa all’Imperatrice vedova Elisavéta Alekséevna che però, stretta nel suo lutto inconsolabile, decide di inoltrarla al nuovo sovrano. Il novello zar Nicolàj Pàvlovic in un primo tempo la trascura, per impellenti questioni di stato, poi si impunta e cerca di trovare il modo di eguagliare, o meglio, superare la bravura degli odiati «inghilesi». E dunque ordina ad un suo uomo di fiducia di raggiungere i famosi argentieri di Tule, rinomati per la loro maestria, e vedere cosa potessero fare per surclassare l’arte britannica. Dopo qualche tempo la ninfosoria di acciaio brunito torna a palazzo. In apparenza è immutata e lo zar si adira ma, ad una più attenta osservazione microscopica, ecco apparire il prodigio tecnologico: su ogni zampetta della pulce di acciaio è stato addirittura apposto come un ferro di cavallo e, su ognuno, è inciso il nome del mastro argentiere che l’ha forgiato!. L’orgoglio russo è salvo.
Chi ama Tolstoj conosce Tule, dato che la sua famosa residenza, Jasnaja Poljana e la sua tomba, si trovano da quelle parti. La storia è semplice ma suggestiva: il fratello della zar Nicola I, Aleksàndr Pàvlovic, riceve in dono dagli «inghilesi» questo manufatto, una «ninfosoria» appunto, fatta di acciaio brunito che, mercé una piccola chiavetta inserita nella pancia, può essere caricata e dunque muoversi come una vera. Alla morte del fratello la pulce meccanica passa all’Imperatrice vedova Elisavéta Alekséevna che però, stretta nel suo lutto inconsolabile, decide di inoltrarla al nuovo sovrano. Il novello zar Nicolàj Pàvlovic in un primo tempo la trascura, per impellenti questioni di stato, poi si impunta e cerca di trovare il modo di eguagliare, o meglio, superare la bravura degli odiati «inghilesi». E dunque ordina ad un suo uomo di fiducia di raggiungere i famosi argentieri di Tule, rinomati per la loro maestria, e vedere cosa potessero fare per surclassare l’arte britannica. Dopo qualche tempo la ninfosoria di acciaio brunito torna a palazzo. In apparenza è immutata e lo zar si adira ma, ad una più attenta osservazione microscopica, ecco apparire il prodigio tecnologico: su ogni zampetta della pulce di acciaio è stato addirittura apposto come un ferro di cavallo e, su ognuno, è inciso il nome del mastro argentiere che l’ha forgiato!. L’orgoglio russo è salvo.Alla stessa dinastia zarista è invece legata la vicenda, anche questa in bilico tra storia e leggenda, dell’Alessandrite. Qui si tratta della scoperta di una pietra singolare che prende il nome dal futuro zar Alessandro II, figlio di Nicola I. La pietra venne, infatti, cavata per la prima volta il giorno della sua nascita, nel 1818. Questo è lo zar dell’epoca in cui si svolge il romanzo Anna Karenina di Tolstoj, un periodo burrascoso e denso di avvenimenti storici rilevanti. Ecco che allora la caratteristica peculiare di questa pietra diviene una sorta di profezia sulla vita e la morte dell’omonimo sovrano. Essa, infatti, è verde alla luce del sole e rossa a quella artificiale. Il fenomeno è dovuto alle inclusioni di cromo, presenti anche nel corindone e nello smeraldo. Ora, nel racconto di Leskov, la casuale scoperta della pietra nel giorno natale del futuro zar, e le sue caratteristiche cromatiche, fanno intessere al narratore la profezia che la vuole metafora della vita di Alessandro II. Verde alla luce del mattino, dunque nella giovinezza e nella maturità dell’imperatore di tutte le Russie, essa diviene color sangue al calar delle tenebre, simboleggiando così la tragica fine che, effettivamente, subì il sovrano.
Il 13 marzo del 1881, infatti, lo Zar si disse disposto a prendere in considerazione le modalità dell’abolizione della servitù della gleba. Ma era già troppo tardi. Lo stesso giorno alcuni cospiratori guidati da Sofja Perovskaja misero in atto un astuto piano per eliminarlo. Alessandro II era già sfuggito più volte alla morte per attentato, ma quella volta il disegno riuscì. Mentre faceva ritorno al Palazzo d’Inverno, la sua carrozza fu colpita da una bomba lanciata da Nikolaj Rysakov, ma egli rimase illeso. Sceso per accertarsi dei danni fu investito dall’esplosione di una seconda bomba. Lo scoppio lo colpì ferendolo mortalmente. La profezia dell’Alessandrite si era avverata.
V.I.T.R.I.O.L.
Ma la poetica di questi elementi naturali, secondo la visione di Benjamin, emana ancor più potentemente da ciò che rimane nella profondità della terra, dando loro addirittura il potere di ricombinare il destino dei vivi con quello dei morti, di salvare eternamente e al tempo stesso gli uni e gli altri. E d’altronde il pensiero dell’eternità non ha sempre avuto la sua fonte principale nella morte? Per attivare questa operazione favolosa egli utilizza allora come Prima Materia del suo athanor immaginale uno degli autori preferiti l’«indimenticabile Johann Peter Hebel». «La morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare» afferma icasticamente e aggiunge, «dalla morte egli attinge la sua autorità. O, in altre parole, è la storia naturale in cui si situano le sue storie». La morte dunque è l’origine del racconto, la matrice della sua eternità. Come non vedere in questa affermazione la sanzione dell’opera al nero, primo gradino del processo alchemico?
Per Benjamin allora la pietra filosofale, cioè l’incanto salvifico della narrazione, la sua funzione come strumento di una vera e propria apocatastasi, nasce nel crogiolo della storia naturale formandosi da un compost affatto speciale. Ecco l’atmosfera nella quale ci vengono presentati i due grandi protagonisti del racconto di Hebel Insperato incontro: il tempo che dissolve i corpi, ed il suo comprimario che qui, paradossalmente, li coagula, il vetriolo.
La parola vetriolo, dal latino vetriolum, compare per la prima volta intorno al VII-VIII secolo d.C., e deriva dal classico vitreolus. Con questa radice etimologica possiamo pensare che il nome trovi origine dall’aspetto vetroso assunto dai solfati di rame e di ferro cristallizzati. Per quelli di rame è di colore azzurro intenso (per questo detto anche vetriolo azzurro o di Cipro o di Venere, la dea portata verso l’isola dalle azzurre onde del mare, ma anche il pianeta di riferimento del rame) mentre nel solfato di ferro è di colore verde azzurro (vetriolo verde o marziale, perché Marte è il pianeta di riferimento del ferro). Sarà quest’ultimo, lo vedremo tra poco, il vetriolo protagonista del racconto.
Sia il vetriolo di rame che il vetriolo di ferro erano conosciuti ed utilizzati dagli Egizi e dai Greci, anche se non sotto questo nome. Forse il famoso natron, che serviva ad imbalsamare i corpi, ne conteneva una certa quantità. L’immancabile Plinio il Vecchio, nella sua Historia Naturalis, menziona una sostanza che chiama «vetriolo« e ne descrive l’estrazione «dalle acque ramifere». Questo nome comprende, e confonde, in realtà, una vera e propria famiglia di composti. Ecco allora che bisogna chiamare in causa anche l’alchimia poiché esso, chiamato vetriolo filosofico, indica nulla di meno che il Solvente Universale, e cioè tutti quei composti chimici che consentono di avviare la procedura condensata nella nota formula «solve et coagula». Per questo le sue origini si perdono nella notte dei tempi, essendo indicato come tale, ma anche con tantissimi altri nomi, in tutti i trattati di Arte Regia. La prima sintesi del vetriolo come Solvente Universale, cioè come acido solforico, la si deve all’alchimista islamico Ibn Zakariya al-Razi che lo ottenne per distillazione a secco di minerali contenenti ferro e rame.
Per completezza simbolica bisogna citare anche l’acronimo, V.I.T.R.I.O.L., che compare nell’opera Azoth del 1613 dell’alchimista Basilio Valentino. Il suo svolgimento è: «Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem», cioè «Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta». La frase simboleggia la discesa all’interno dell’essere per operare con rettitudine alla ricerca del proprio gioiello interiore.
E allora concludiamo la parabola dell’apocatastasi benjaminiana, con il bel racconto di Hebel di cui il vetriolo marziale è protagonista. Siamo a Falun, in Svezia, presso le miniere di ferro. Due giovani sono innamorati e presto si sposeranno. Lui però è un minatore ed un giorno non torna più: la miniera è crollata. Passano gli anni e la fidanzata gli rimane fedele. Dopo decenni, in cui il tempo lavora sulla materia vivente, ecco che dalla vecchia miniera riemerge il corpo del minatore: è intatto poiché il vetriolo lo ha imbalsamato nel momento della giovinezza. Mentre lo seppellisce esclama: «Dormi in pace adesso, un giorno ancora o forse dieci, in questo fresco letto nuziale, e non ti sembri lungo il tempo. Mi restano soltanto poche cose da fare, e presto verrò, presto sarà di nuovo giorno. Ciò che la terra ha già una volta reso, una seconda non lo tratterrà». Tutto è giusto e perfetto.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo (di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola).18 luglio 2018, di Federico La Sala
Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo
di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola (Le parole e le cose, 18 luglio 2018)
- Il 21 giugno scorso per DeriveApprodi è uscito Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo, di Gianfranco Pellegrino e Marcello Di Paola. Ne pubblichiamo l’inizio.
Alla fine di febbraio del 2018, mentre eravamo impegnati a scrivere questo libro, a Roma ha nevicato. Per due o tre giorni, la temperatura media è stata di - 4°C. Le medie stagionali a Roma fra febbraio e marzo oscillano fra 4-5°C e 13-14°C. L’ultima neve era caduta nel 2011 e 2012, e prima ancora nel 2005 e nel 2001. Negli stessi giorni, in altre parti dell’Europa del nord faceva molto più freddo che nei tre anni precedenti nello stesso periodo. Una settimana prima della neve romana, ancora più a nord, in Groenlandia, la stazione meteorologica di Capo Morris Jesup aveva registrato per quasi un giorno una temperatura superiore allo zero. Il picco è stato di 6,1°C, circa sette gradi sopra le massime stagionali. In realtà già nei tre anni precedenti al Polo nord c’erano state temperature massime superiori alla media.
I due fenomeni potrebbero essere collegati. Il cosiddetto vortice polare - un’area di bassa pressione che di solito separa i venti gelidi del Polo Nord da quelli temperati che soffiano più a sud - sta diventando meno stabile. Per questa ragione al Polo Nord si accumula aria calda, che spinge a sud quella fredda.
Ma non è sicuro che la neve a Roma e il caldo al Polo Nord siano legati: potrebbe essere ancora troppo presto per dirlo - dobbiamo aspettare altre osservazioni, altri inverni. Forse la neve a Roma ci ha sorpreso tanto perché gli inverni a queste latitudini sono ormai molto più caldi di prima.
È molto probabile che il clima globale stia mutando. Sta cambiando non tanto, o non solo, il tempo di una giornata o di una stagione, ma la media statistica del tempo di molti giorni e stagioni (secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, il clima è la media statistica del tempo atmosferico in una certa zona nell’arco di trent’anni). Il 2016 e il 2017 sono stati gli anni più caldi da quando abbiamo iniziato a misurare la temperatura globale del nostro pianeta - nel 1880.
Secondo una schiacciante maggioranza di scienziati (il 97%), il cambiamento climatico è causato dall’uso di combustibili fossili (carbone e petrolio, per lo più). Il clima sta cambiando perché i gas immessi nell’atmosfera in conseguenza della combustione di risorse energetiche fossili (i cosiddetti gas serra) funzionano come uno schermo che impedisce di disperdersi nello spazio a parte del calore che arriva dal Sole e viene riflesso dalle superfici del nostro pianeta. Ciò vuol dire che la nevicata a Roma del 2018 non è naturale. A differenza di altre nevicate, per esempio quella del 1956, non è stata causata dalle forze della natura. La neve di Roma del 2018 è un prodotto umano: è neve artificiale, insomma, come quella sparata sulle piste per gli sciatori.
Sarebbe più corretto dire che la neve di Roma del 2018 è stata causata dall’interazione fra forze naturali e una forza non naturale - l’attività umana che produce gas serra. Di conseguenza, la neve caduta a Roma non è né naturale né artificiale, è un prodotto dell’interazione fra attività umana e processi naturali - è ibrida. E si dovrebbe pure dire che interazioni di questo genere non producono sempre le stesse conseguenze - i loro effetti non si possono prevedere in maniera deterministica, ma solo probabilistica. Dato quello che stava succedendo al Polo Nord nel 2018, era molto probabile che la neve quell’anno arrivasse sino a Roma. Ma avrebbe anche potuto andare diversamente, e non è detto che accadrà di nuovo.
C’è un aspetto paradossale di questa nevicata artificiale, o ibrida. La neve sparata su una pista da sci è conseguenza dell’intenzione dei gestori della pista di garantire un manto nevoso adeguato ai propri clienti. La neve caduta su Roma nel 2018 non è una conseguenza voluta dell’azione di nessuno. Piuttosto si tratta dell’effetto collaterale, non voluto e non previsto, di miliardi di azioni di tutti, nessuna delle quali da sola sarebbe bastata a causare questo risultato. Per arrivare alla neve di Roma ci vuole l’interazione fra gli effetti a lungo termine di cose come la prima macchina a vapore, l’attività economica fervente descritta nei Buddenbrook di Thomas Mann, l’aumento dei viaggi in aereo prodotto dalle compagnie low cost e l’incremento del trasporto su gomma favorito dalla costruzione di autostrade, l’elettrificazione progressiva dell’Europa e degli Stati Uniti a partire dagli anni Cinquanta, e miriadi di altri fattori storici, economici, politici e culturali. Detto altrimenti, la neve di Roma è una conseguenza non voluta delle nostre vite nel loro complesso - della vita che abbiamo vissuto negli ultimi tre secoli, in particolare nei paesi occidentali industrializzati ma ormai sempre più anche in paesi come Cina e India. E però, paradossalmente, non c’è nulla nel nostro modo di vivere attuale che avrebbe potuto evitare la nevicata che abbiamo causato.
Per via dell’escursione termica fra giorno e notte, in quei giorni di febbraio alcuni alberi di limoni nei giardini di Roma hanno perso le foglie, e non produrranno frutti. In un certo senso, chiunque stia leggendo questo libro a bordo di un treno, o di un aereo, sta contribuendo alla catena di cause ed effetti che ha compromesso il raccolto di limoni e ha dissolto il profumo delle zagare. La produzione stessa e la distribuzione di questo libro ha un impatto, dal momento che richiede energia elettrica e combustibili fossili e dunque produce emissioni di gas serra a ogni parola scritta. Ma smettere di scrivere queste parole non sarebbe servito a evitare la nevicata.
Nel 1962, apparve l’Angelo sterminatore di Luis Bunuel. Il film racconta di una cena organizzata da una famiglia dell’alta borghesia. All’alba, dopo esser stati a chiacchierare in salotto per quasi tutta la notte, i protagonisti si rendono conto che, nonostante la porta sia aperta, non possono più uscire - e chi è all’esterno non può entrare. Passano le ore e i giorni, la situazione degenera, le liti e i conflitti divampano, uno degli ospiti muore.
Probabilmente, Bunuel criticava la classe borghese e voleva far intendere che i suoi esponenti fossero prigionieri dei loro stessi privilegi. Il mondo privilegiato dell’Occidente industrializzato in cui viviamo potrebbe essere un delizioso salotto che sta andando in rovina e da cui non possiamo allontanarci.
Per molti, i paradossi descritti sin qui sono il marchio di un’epoca nuova in cui ci troviamo a vivere: l’Antropocene, l’epoca in cui l’azione degli esseri umani può cambiare il corso naturale delle cose. [...] L’Antropocene è un’idea difficile da accettare, perché ci richiede di vedere il mondo diversamente. Le concezioni del mondo naturale e del mondo umano ereditate dal passato sono del tutto inadeguate alla nuova condizione. Prima la natura era lo sfondo immutabile dell’azione umana - era fonte di risorse, ma non incarnava valori, il mondo della cultura era il luogo dell’etica e della politica, dell’agire intenzionale degli esseri umani. Questo quadro è adesso contraddetto da fatti nuovi. Rimanere aggrappati alla vecchia concezione è impossibile o poco utile; ma una concezione nuova è ancora da costruire.
[...] Molti sono indifferenti all’Antropocene - perché non ne sanno nulla, o pur essendone a conoscenza, non se ne curano. Tanti altri ne sono spaventati, perché per la prima volta non siamo di fronte a una minaccia e a un nemico esterni, ma siamo noi stessi il nemico e la vittima. E parecchi si preoccupano del fatto che la maggioranza di noi non s’interessa affatto all’Antropocene. Recentemente, Amitav Ghosh si è chiesto come mai nella letteratura contemporanea non si dia lo spazio che merita al cambiamento climatico che sta avvenendo (ma lo stesso si può dire dell’inquinamento globale, della scarsità di risorse naturali e, forse in misura minore, della perdita di biodiversità). Nella nostra epoca l’arte e la letteratura nascondono la realtà, suggerisce Gosh: viviamo nell’ «epoca della Grande Cecità».
[...] Altri invece vedono l’Antropocene come una grande opportunità - finalmente dominiamo completamente il pianeta, e ce lo potremo modellare a nostra immagine e somiglianza. Con l’Antropocene non siamo più creature ma creatori, non siamo più soggetti alle leggi della natura ma siamo noi i legislatori. A lungo la natura ha amato nascondersi e il sogno è stato di penetrarne i segreti, prima per difendersi e poi per dominarla e trarne profitto. Ora la natura la scopriamo cambiandola, o costruendola. Tutto è chiaro nella natura, come è chiaro il funzionamento di una macchina per il costruttore. Può esserci un ‘buon Antropocene’ - da cui possiamo trarre vantaggi e opportunità inaspettate.
[...] Parte di questo libro, soprattutto il primo capitolo, si dedicherà a ricostruire le molte facce dell’Antropocene e le tante reazioni che ha destato. Il nostro obiettivo è incoraggiare la discussione, rompere il grande silenzio e uscire dalla cecità. Sosterremo che la maniera migliore di cogliere la natura dell’Antropocene è adottare il punto di vista delle scienze della Terra - cioè di quelle discipline scientifiche che considerano il funzionamento del pianeta nel suo complesso come un sistema unitario - e concepirlo come una vera e propria rottura del corso della storia del pianeta Terra e della storia umana - il momento in cui la Terra come sistema complessivo e gli esseri umani come specie iniziano a interagire in maniera co-dipendente e ricorsiva e la storia e la geologia si intrecciano.
La reazione alla nuova epoca cui daremo voce è di cauta preoccupazione e di risoluto impegno: l’Antropocene non è necessariamente una catastrofe, ma non è neanche una meravigliosa opportunità. Piuttosto, l’Antropocene richiede scelte nuove, su cui è necessario riflettere e discutere, e pratiche nuove, che è necessario rendere possibili e perseguire. Abbiamo un’influenza senza precedenti sul corso futuro del nostro pianeta: potremo prendere decisioni buone o cattive, vivere in modo migliore o peggiore - per noi stessi, per gli animali e le piante, per il pianeta intero. Quindi servono criteri che ci guidino nelle nostre scelte nelle nostre pratiche.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO -- "Simone de Beauvoir. La rivoluzione del femminile". Quando la donna diventò soggetto17 giugno 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE... *
Julia Kristeva
De Beauvoir. Quando la donna diventò soggetto
di Francesca Rigotti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.06.2018)
- Julia Kristeva,Simone de Beauvoir. La rivoluzione del femminile, trad. di Alessandro Ciappa, Donzelli, Roma, pagg. 140, € 19.
Il prossimo anno ricorrerà il settantesimo dalla pubblicazione di Il secondo sesso, di Simone de Beauvoir (1949), ma non è una cattiva idea cominciare fin d’ora a celebrarlo. Perché quel libro ha rappresentato un evento culturale, una svolta antropologica, una rivoluzione copernicana: con esso, grazie ad esso il soggetto donna si afferma sulla scena dalla quale non sarà più possibile cacciarlo via. E questo per merito di una filosofa e scrittrice, aristocratica, esistenzialista e comunista nonché femminista dell’uguaglianza, il cui status di autrice originale, col suo approccio che è una sintesi di esistenzialismo, hegelianesimo, marxismo e antropologia, si è finalmente consolidato dopo decenni di alterna fortuna.
Lo riconosce Julia Kristeva, migrante venuta da lontano non normalista francese, a sua volta femminista differenzialista e teorica della psicoanalisi, disciplina verso la quale Simone de Beauvoir non nascondeva la propria antipatia e diffidenza. Eppure la vita e l’opera di De Beauvoir (1908-1986) hanno rivoluzionato mentalità e costumi, imprimendo «un’accelerazione all’emancipazione del secondo sesso dopo millenni di dominazione patriarcale e maschile» - riconosce Kristeva in questa raccolta di saggi che invita a rileggere le pagine di una filosofa dalla scrittura romanzesca e di una scrittrice dall’argomentazione filosofica proprio nella nostra epoca polverizzata, nella quale parecchie donne sembrano riadagiarsi nel conformismo sociale.
Alcune correnti femministe rimproverano a De Beauvoir di aver insistito sul registro universale dell’eguaglianza finendo per non vedere, se non negare, il corpo femminile con le sue caratteristiche specifiche tra cui la maternità e l’omosessualità femminile. Eppure ciò non è sufficiente - ribatte proprio Kristeva - a cancellare l’importanza del pensiero di De Beauvoir oggi, non come passaggio storico superato ma in quanto presentificazione degli atti di affermazione del soggetto donna. Operazione che Simone de Beauvoir conduce, sottolinea Kristeva, nei saggi come pure attraverso i romanzi, nei quali la singolarità individuale dei personaggi si trasforma in universalità collettiva politica. Una sfida raccolta anche da Il secondo sesso, ove si invita a singolarizzare il politico e a politicizzare il singolare.
Il lascito di De Beauvoir a tutte le donne è in ogni caso il culto della libertà: la libertà è la sua stella polare, la libertà di Socrate, di Pascal, dell’Illuminismo, di Hegel, di Marx, di Arendt. La libertà che spetta alle donne se riusciranno a uscire dalla condizione di minorità per ottenere la piena eguaglianza, nella polifonia delle posizioni delle donne, femministe o meno, universaliste, differenzialiste, #me too, femen, non una di meno, e se non ora quando. Si potrebbe credere che per riconoscere questo ruolo fondamentale a Simone de Beauvoir Kristeva la spinga verso criteri differenzialisti che non erano i suoi; a me sembra invece che Kristeva rimanga sempre rispettosa e attenta alle peculiarità del pensiero di De Beauvoir di cui affronta persino i sogni, quelli di cui la scrittrice fa dono al lettore in A conti fatti: sogni di cadute e voli, di maternità e fughe e di fughe dalla maternità, nei quali si mostra la geniale capacità dell’autrice di svelare ciò che è più intimo conciliandolo con i disagi dell’epoca per trasformarli in priorità politiche.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA...
 IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
 DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud)
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- SINODO SULL’AMAZZONIA E MESSAGGIO EVANGELICO. "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio.11 giugno 2018, di Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE....
"Le donne non possono essere prete": lo stop di Ladaria
Il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio: "La dottrina è definitiva, sbagliato creare dubbi tra i fedeli. Cristo conferì il sacramento ai 12 apostoli, tutti uomini"
di PAOLO RODARI (la Repubblica, 29 maggio 2018)
CITTÀ DEL VATICANO - Si tratta "di una verità appartenente al deposito della fede", nonostante sorgano "ancora in alcuni paesi delle voci che mettono in dubbio la definitività di questa dottrina". A ribadire il "no" del Vaticano all’ipotesi dell’ordinazione presbiterale femminile è il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il neo-cardinale gesuita Luis Ladaria, in un lungo e argomentato articolo pubblicato sull’Osservatore Romano. Intitolato "Il carattere definitivo della dottrina di ’Ordinatio sacerdotalis’", il testo è scritto per fugare "alcuni dubbi" in proposito.
Evidentemente, il ritorno di proposte aperturiste circa le donne-prete avanzate soprattutto in alcuni paesi sudamericani in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre dedicato all’Amazzonia, ha allarmato la Santa Sede che attraverso la sua massima autorità gerarchica ha voluto ribadire ciò che anche per Francesco sembra essere assodato: "Sull’ordinazione di donne nella Chiesa l’ultima parola chiara è stata data da Giovanni Paolo II, e questa rimane", ha detto Papa Bergoglio tornando nel novembre del 2016 dal suo viaggio lampo in Svezia.
Durante il Sinodo sull’Amazzonia uno dei temi centrali sarà quello della carenza di preti. Come superare il problema? In proposito, da tempo, si parla dell’opportunità di ordinare i cosiddetti viri probati, uomini sposati di una certa età e di provata fede che possano celebrare messa nelle comunità che, appunto, hanno scarsità di sacerdoti e dove è difficile che un prete possa recarsi con regolarità. Altri uomini di Chiesa fanno altre proposte: propongono, come ad esempio ha recentemente fatto monsignor Erwin Krautler della prelatura territoriale di Xingu in Amazzonia, che oltre ai viri probati si proceda con l’ordinazione delle diaconesse. Mentre altri ancora, invece, hanno parlato direttamente di donne-prete.
Ladaria ricorda che "Cristo ha voluto conferire questo sacramento ai dodici apostoli, tutti uomini, che, a loro volta, lo hanno comunicato ad altri uomini". E che per questo motivo la Chiesa si è riconosciuta "sempre vincolata a questa decisione del Signore", la quale esclude "che il sacerdozio ministeriale possa essere validamente conferito alle donne".
Già Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis del 22 maggio 1994, disse che "la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa". Mentre la Congregazione per la dottrina della fede, in risposta a un dubbio sull’insegnamento di Ordinatio sacerdotalis, ha ribadito che "si tratta di una verità appartenente al deposito della fede".
Chi vuole le donne-prete argomenta che la dottrina in merito non è stata definita ex cathedra e che, quindi, una decisione posteriore di un futuro Papa o concilio potrebbe rovesciarla. Dice, tuttavia, Ladaria che "seminando questi dubbi si crea grave confusione tra i fedeli" perché, Denzinger-Hünermann alla mano (l’autorevole volume che raccoglie simboli di fede, decisioni conciliari, provvedimenti di sinodi provinciali, dichiarazioni e scritti dottrinali dei Pontefici dalle origini del cristianesimo all’epoca contemporanea) la Chiesa riconosce che l’impossibilità di ordinare delle donne appartiene alla "sostanza del sacramento" dell’ordine. Una sostanza, dunque, che la Chiesa non può cambiare. "Se la Chiesa non può intervenire - dice ancora Ladaria - è perché in quel punto interviene l’amore originario di Dio".
Ladaria parla anche dell’infallibilità e del suo significato. Essa non riguarda solo pronunciamenti solenni di un concilio o del Papa quando parla ex cathedra, "ma anche l’insegnamento ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, quando propongono, in comunione tra loro e con il Papa, la dottrina cattolica da tenersi definitivamente". A questa infallibilità si è riferito Giovanni Paolo II in "Ordinatio sacerdotalis?, un testo che Wojtyla scrisse dopo un’ampia consultazione portata avanti a a Roma "con i presidenti delle conferenze episcopali che erano seriamente interessati a tale problematica". "Tutti, senza eccezione - ricorda Ladaria - hanno dichiarato, con piena convinzione, per l’obbedienza della Chiesa al Signore, che essa non possiede la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- API MATEMATICHE. Anche le api riconoscono lo zero, come delfini e scimpanzè.9 giugno 2018, di Federico La Sala
MATEMATICA, TEOLOGIA POLITICA, E ANTROPOLOGIA...
Api matematiche, riconoscono lo zero
Come delfini, pappagalli e scimpanzè
di Redazione Ansa*
- Anche le api riconoscono lo zero, come delfini e scimpanzè (fonte: Bob Peterson, Wikipedia) © ANSA/Ansa
Anche le api entrano a far parte del club molto esclusivo di animali che sanno cos’è lo zero, insieme a delfini, pappagalli, scimpanzè e bambini in età prescolare: si tratta di una scoperta sorprendente, considerata la complessità del concetto matematico astratto del nulla, e apre a nuovi e più semplici approcci per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, è stato coordinato dall’Università di Melbourne in Australia (Rmit), in collaborazione con l’Università francese di Tolosa.
La scoperta solleva non poche domande su come una specie così diversa e lontana dagli esseri umani, con meno di un milione di neuroni a confronto degli 86 milioni del cervello umano, possa condividere un’abilità così complicata: infatti lo zero è un concetto molto difficile che i bambini impiegano anni ad imparare e che era assente in alcuni sistemi numerici di antiche civiltà.
I ricercatori guidati da Scarlett Howard hanno attirato gli insetti verso una parete con piccoli fogli bianchi, ognuno con un numero da due a cinque di forme nere disegnate. Dopo aver addestrato le api tramite ricompense di cibo a scegliere i fogli con un minore o un maggior numero di forme, i ricercatori hanno introdotto due numeri nuovi, uno e zero: a quel punto gli insetti hanno dimostrato di sapere che lo zero è minore di uno.
"Se un’ape riesce a riconoscere lo zero con meno di un milione di neuroni", dice Adrian Dyer dell’Università di Melbourne, uno degli autori, "allora devono esserci modi più semplici ed efficienti per insegnare lo stesso concetto ai sistemi di Intelligenza Artificiale. Ad esempio - prosegue - per noi è semplice attraversare la strada quando non passa nessuno, ma per un robot risulta un compito molto più difficile".
Sul tema, nel sito, si cfr.:
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
MATEMATICA, TEOLOGIA POLITICA, E ANTROPOLOGIA: CONTIAMO E PENSIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- ANTROPOLOGIA E MEDICINA. L’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)27 maggio 2018, di Federico La SalaFILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA...
 IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
 DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO - Storia e memoria. Non basta dire “io c’ero” per ricostruire che cosa è stato il ’68 (di Giovanni De Luna).25 maggio 2018, di Federico La Sala
Storia e memoria
Non basta dire “io c’ero” per ricostruire che cosa è stato il ’68
di Giovanni De Luna (La Stampa, 25.05.2018)
I protagonisti del ’68 furono tutti giovani o giovanissimi. È logico quindi che molti siano presenti nel dibattito pubblico che si è acceso in occasione del 50° anniversario, proponendo una memoria che affida la propria autorevolezza a due frasi simbolicamente efficaci: «io c’ero» e «mi ricordo perfettamente». Si tratta di testimonianze che - come è successo in questi mesi - rischiano di entrare in conflitto con le ragioni di una ricostruzione storica meno emotiva e più consapevole.
Le ragioni per diffidare di quei ricordi e di quelle memorie sono molte: «io c’ero», ad esempio, rischia di produrre testimonianze che spesso sconfinano in un narcisismo fine a sé stesso, incapace di comunicare quell’esperienza a chi, appunto, «non c’era»; così come «mi ricordo perfettamente» può nascondere le giravolte di una memoria selettiva, che vuole trattenere solo qualcosa e non tutto, che cambia così come cambiano le fasi che scandiscono le biografie dei protagonisti, man mano sempre più indulgenti verso i ricordi della propria giovinezza.
“Vele attorcigliate ma distinte”
Pure, opporre semplicemente le ragioni della storia a quelle della memoria sarebbe riduttivo, anche perché da quella stagione è affiorata un’agguerrita generazione di storici così che spesso ci si confronta con posizioni e tesi interpretative elaborate da chi è contemporaneamente sia storico sia testimone.
In realtà, come ha scritto Paul Ricoeur, storia e memoria, «alberi maestri dalle vele attorcigliate ma distinte», appartengono «alla stessa imbarcazione, destinata a una sola e unica navigazione» e a una meta comune, «rappresentare il passato e permetterci di conoscerlo». Il testimone ci propone l’immediatezza delle sue percezioni, restituendoci lo spirito del suo tempo e svelandoci il ’68 così come è stato vissuto e rielaborato a caldo dai suoi protagonisti; lo storico arriva dopo, con il senno di poi, sa «come è andata a finire» ed è in grado, attraverso le fonti e i documenti, di far emergere quello che allora non era possibile sapere. Alla fine, però, una storia senza le testimonianze diventa un esercizio astratto, un racconto del passato esangue, aridamente nozionistico; e una testimonianza, non inserita in un contesto storiografico, diventa prigioniera di due stereotipi ampiamente presenti in questo 50° anniversario: da un lato «anni formidabili», dall’altro una folla di figli di papà, scansafatiche, pronti a imboccare qualsiasi scorciatoia pur di far carriera.
La sintesi tra storia e memoria è particolarmente efficace se si guarda al ’68 come a uno dei classici eventi globali della nostra contemporaneità, eventi, cioè, con una spazialità non riconducibile a un singolo luogo o a una specifica realtà, ma che rimbalzano in simultanea da tutti gli angoli del mondo, in una cronologia affollata di date. La dimensione geografica del ’68 (dalla Cina agli Usa, da Praga a Berlino, da Parigi all’America del Sud, da Roma a Berlino) fu così straripante da sottrarsi, proprio per questo, a ogni interpretazione riduttiva e obbligare chiunque voglia studiarlo a confrontarsi con un corpus di fonti altrettanto vasto, eterogeneo, multiforme.
I mezzi di comunicazione di massa, ad esempio, «costruiscono» il ’68, lo fanno parlare e ci permettono di conoscerlo più dei tanti documenti politici prodotti allora dal movimento. La rottura generazionale che allora spaccò le famiglie della borghesia fu anticipata e descritta dai film di Bertolucci (Prima della rivoluzione, 1964) e Bellocchio (I pugni in tasca, 1965); il rifiuto della forma partito tradizionale e l’accento posto sulla dimensione individuale dell’agire politico si trovano già tutti in Godard (La chinoise, 1967); il confronto con la violenza della polizia è raccontato in Fragole e sangue di Stuart Hagmann (1970).
Dalla forza alla fragilità
E poi. Le fotografie di Tano D’Amico e di Uliano Lucas; le canzoni di Paolo Pietrangeli; le vignette di Buonfino o di Zamarin; i manifesti che colorarono i muri di Parigi e di Torino; i grandi concerti, primo fra tutti quello di Woodstock (agosto 1969): su quel prato si discuteva di politica, si ballava, si consumavano le prime droghe «di gruppo», soprattutto marijuana e Lsd e una comunità giovanile si autorappresentava come altra e separata rispetto al resto del mondo, scegliendo una dimensione esistenziale fondata sulla libertà (intesa come trasgressione) e sull’assenza di regole (come principio normativo).
Ecco, solo dopo essersi immerso nello spirito di quel tempo, lo storico può lasciare il testimone al proprio destino emergendo dall’oceano delle percezioni di allora per proporre una compiuta storicizzazione di quell’evento. Ed è proprio Woodstock a suggerirne i termini: il ’68 fu un evento globale; ebbe come protagonista una generazione che visse la propria giovinezza non come una tappa di passaggio ma come il punto più alto della propria biografia; una generazione che fece della disobbedienza il tratto unificante di quell’esperienza e che sul rifiuto delle regole costruì dapprima la sua forza, poi la sua fragilità.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- IL SESSANTOTTO. Intervista ad Agostino Giovagnoli (di Giovanna Pasqualin Traversa).24 maggio 2018, di Federico La Sala
50 anni dopo
Il Sessantotto. Agostino Giovagnoli (storico): “Profondo legame con il Concilio che ne ha anticipato alcuni tratti”
 diGiovanna Pasqualin Traversa (Agenzia SIR, 26 aprile 2018)
diGiovanna Pasqualin Traversa (Agenzia SIR, 26 aprile 2018)I legami tra Concilio Vaticano II e Sessantotto sono più profondi di quanto si sia portati a ritenere. Il Concilio ha infatti "preparato" in certa misura il terreno al grande movimento di contestazione. Intervista a tutto campo con lo storico Agostino Giovagnoli
Gli anni Settanta hanno rappresentato un passaggio cruciale nella vita della Chiesa in Italia. Sono gli anni della recezione del Concilio e sono al tempo stesso attraversati da tensioni e polarizzazioni legate al Sessantotto. Fede e politica intrecciate fra loro? Se sì su quali premesse e con quali sviluppi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all’Università cattolica di Milano
Fra le trasformazioni della Chiesa cattolica legate al Vaticano II e gli eventi del ‘68 c’è stato un intreccio?
Sì; più profondo, soprattutto in Italia, di quanto abitualmente si ritenga.
 La contestazione del 1968 si è intersecata in modi diversi con un’evoluzione del mondo cattolico italiano già in corso da tempo.
La contestazione del 1968 si è intersecata in modi diversi con un’evoluzione del mondo cattolico italiano già in corso da tempo.
 Non è strettamente sul livello politico che si è sviluppato l’influsso del Concilio sulla società e sulle sue trasformazioni. Il Concilio ha in realtà toccato questioni di grande rilievo, ha aperto una riflessione di fondo sull’organizzazione istituzionale della Chiesa cattolica all’interno di un’ampia trasformazione della società europea e occidentale che stava mettendo in discussione le proprie istituzioni ecclesiastiche, politiche, sociali e familiari. Il ‘68 è stato soprattutto una contestazione anti-istituzionale ed è su questo terreno che è ravvisabile il nesso che lega i due fenomeni.
Non è strettamente sul livello politico che si è sviluppato l’influsso del Concilio sulla società e sulle sue trasformazioni. Il Concilio ha in realtà toccato questioni di grande rilievo, ha aperto una riflessione di fondo sull’organizzazione istituzionale della Chiesa cattolica all’interno di un’ampia trasformazione della società europea e occidentale che stava mettendo in discussione le proprie istituzioni ecclesiastiche, politiche, sociali e familiari. Il ‘68 è stato soprattutto una contestazione anti-istituzionale ed è su questo terreno che è ravvisabile il nesso che lega i due fenomeni.Il Concilio ha dunque “preparato in qualche modo il terreno” al Sessantotto?
La Chiesa cattolica ha anticipato una trasformazione che poi si è presentata in modo convulso nel 1968, nel senso di un ridimensionamento del peso delle istituzioni all’interno della società. Da questo punto di vista il dissenso cattolico ha rappresentato un fenomeno specifico e forse anche marginale. Ha ripreso alcune modalità della contestazione studentesca ma non è qui il cuore più profondo del rapporto che investe aspetti più globali.
Qual è stata l’intuizione di Giovanni XXIII?
L’avere compreso che la Chiesa aveva bisogno di mettersi in ascolto del mondo e di se stessa. Nella modalità conciliare ha in qualche modo superato la rigidità istituzionale che l’aveva caratterizzata per cinque secoli sul modello tridentino. In questo senso il Concilio ha avviato un processo di cui ravviso alcuni tratti anche nel 1968.
 Lo storico gesuita Michel de Certeau, che ha partecipato al “maggio francese” a Parigi, ha scritto che nel ’68 “è stata presa la parola come nel 1789 è stata presa la Bastiglia”. Un’immagine metaforica che sottolinea la liberazione della parola, tipica di quel movimento. L’analogia è profonda perché il Vaticano II ha a modo suo “liberato” la parola, in questo caso la Parola di Dio, da una Chiesa che l’aveva rinserrata all’interno di schemi organizzativi e istituzionali che la rendevano in certa misura marginale e l’ha riportata al centro della vita ecclesiale. E’ dalla Parola di Dio che rinasce la Chiesa.
Lo storico gesuita Michel de Certeau, che ha partecipato al “maggio francese” a Parigi, ha scritto che nel ’68 “è stata presa la parola come nel 1789 è stata presa la Bastiglia”. Un’immagine metaforica che sottolinea la liberazione della parola, tipica di quel movimento. L’analogia è profonda perché il Vaticano II ha a modo suo “liberato” la parola, in questo caso la Parola di Dio, da una Chiesa che l’aveva rinserrata all’interno di schemi organizzativi e istituzionali che la rendevano in certa misura marginale e l’ha riportata al centro della vita ecclesiale. E’ dalla Parola di Dio che rinasce la Chiesa.In che modo il ’68 ha influito su associazioni e movimenti del laicato cattolico?
Per l’Azione cattolica un cambiamento importante è cominciato con il pontificato di Giovanni XXIII e soprattutto con l’elezione di Paolo VI nel 1963. La nomina di mons. Franco Costa quale assistente ecclesiastico generale e di Vittorio Bachelet quale presidente nazionale segnano il definitivo distacco dal modello geddiano. Il rinnovamento si è realizzato pienamente con il nuovo statuto (1969) che ha prodotto una vasta riorganizzazione e ha soprattutto affermato “la scelta religiosa” dell’Ac, espressione che sottolinea la fine di ogni collateralismo con qualsiasi partito politico. L’impatto del Sessantotto sull’Ac è stato soprattutto indiretto e probabilmente ha influito sul calo degli iscritti che dal 1964 al 1974 passano da 3,5 milioni a 600mila.
E per quanto riguarda le Acli?
Anche qui si deve parlare di un impatto indiretto. La trasformazione delle Acli era cominciata all’inizio degli anni Sessanta, in stretto rapporto con l’evoluzione economico-sociale della realtà italiana e il nuovo ruolo assunto dai sindacati. Un’ulteriore svolta è avvenuta a seguito dell’“autunno caldo” nelle grandi fabbriche italiane del 1969 con l’adozione della cosiddetta ipotesi socialista alla quale seguì una richiesta di chiarimenti da parte della presidenza della Cei, una presa di posizione critica del Pontefice e il ritiro dell’assistente ecclesiastico. La contestazione del ’68 ha invece riguardato in modo più diretto Gioventù studentesca, ramo dell’Ac che aveva iniziato un percorso originale, soprattutto in Lombardia, a seguito dell’iniziativa assunta da don Luigi Giussani nel 1954. In questo contesto nasce Comunione e Liberazione.
Il Sessantotto ha dunque interferito con un’evoluzione in atto nell’associazionismo cattolico degli anni Sessanta?
Sì. Forse l’impatto maggiore ha riguardato le grandi questioni internazionali con particolare riferimento al terzo mondo: guerra in Vietnam, Cuba, Biafra, lotte per i diritti civili degli afroamericani negli Usa. I membri dell’associazionismo cattolico, soprattutto giovani, furono molto sensibili a queste cause e, più in generale, a quella della pace.
Su questo terreno maturarono una sensibilità simile a quella di molti altri giovani di altra provenienza culturale e ideologica, che fece cadere molti steccati tradizionali.
Ci furono infine esperienze nuove che nacquero al di fuori dall’associazionismo cattolico o del rapporto con la Dc, nel clima del Sessantotto, come la Comunità di Sant’Egidio a Roma, segnata fin dall’inizio da un forte rapporto con il Vangelo e i poveri.
Che giudizio ha del Sessantotto?
Ha avuto peso non tanto quale fenomeno politico, ma piuttosto come istanza culturale e sociale di “inventare” un mondo nuovo affrontando le grandi sfide del tempo, le sfide di un mondo terrorizzato dall’arma atomica e in cerca di pace, che vuole dare la parola a tutti, che affronta le gravi disuguaglianze economiche e sociali. Si è disperso di fronte a forze più grandi; in fondo è stato un movimento di studenti, non avrebbe potuto cambiare il mondo, però ci ha provato ed è questa la sua eredità più preziosa.
Pensare al ’68 ci fa bene perché ci ricorda che possiamo anche non subire il mondo in cui viviamo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
IL PAPA [GIOVANNI XXIII, 1962] HA DECISO DI DARE IL VIA AD UN NUOVO CONCILIO, AL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II. PACE E E DIALOGO SU TUTTA LA TERRA, TRA TUTTI GLI ESSERI UMANI, TUTTE LE RELIGIONI, TUTTI I CREDENTI E I NON CREDENTI. QUESTA LA DICHIARAZIONE DI APERTURA
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
 UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI. Il cardinale Martini, da Gerusalemme, dalla “città della pace”, lo sollecita ancora!!!
UNA MEMORIA DI "VECCHIE" SOLLECITAZIONI. Il cardinale Martini, da Gerusalemme, dalla “città della pace”, lo sollecita ancora!!!GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Sessantotto. La festa della contestazione (di Agostino Giovagnoli)24 maggio 2018, di Federico La Sala
SCHEDA EDITORIALE *
Sessantotto. La festa della contestazione
di Agostino Giovagnoli
C’è chi esalta il Sessantotto, identificandolo con la propria gioventù, e chi gli imputa colpe pesanti, compreso il terrorismo rosso degli anni di piombo. In realtà la stagione della contestazione fu molto breve, dal Free Speech Movement di Berkeley nel 1965 al maggio francese del 1968.
 In questo libro se ne raccontano alcuni momenti significativi: la mobilitazione per i diritti civili negli Stati Uniti, le lotte degli studenti di Sociologia a Trento, la "battaglia" di Valle Giulia a Roma, l’occupazione della Sorbona... E se ne ricostruiscono le radici. Attraverso i canali sotterranei delle avanguardie artistiche come i beat o il rock’n’roll ballato da milioni di persone, i giovani percepirono che, grazie ai nuovi processi di globalizzazione, ’The times they are a-changin’, come cantava Bob Dylan. Dal conflitto nucleare alla decolonizzazione, dalla lotta contro il razzismo in America del Nord alle rivoluzioni in America del Sud, dalla guerra del Vietnam alla corsa alla conquista dello spazio.
In questo libro se ne raccontano alcuni momenti significativi: la mobilitazione per i diritti civili negli Stati Uniti, le lotte degli studenti di Sociologia a Trento, la "battaglia" di Valle Giulia a Roma, l’occupazione della Sorbona... E se ne ricostruiscono le radici. Attraverso i canali sotterranei delle avanguardie artistiche come i beat o il rock’n’roll ballato da milioni di persone, i giovani percepirono che, grazie ai nuovi processi di globalizzazione, ’The times they are a-changin’, come cantava Bob Dylan. Dal conflitto nucleare alla decolonizzazione, dalla lotta contro il razzismo in America del Nord alle rivoluzioni in America del Sud, dalla guerra del Vietnam alla corsa alla conquista dello spazio.
 Il Sessantotto è stato un movimento antiautoritario e anti-istituzionale che ha scosso il mondo degli adulti. Ma se ha potuto farlo è perché quel mondo era già in crisi.
Il Sessantotto è stato un movimento antiautoritario e anti-istituzionale che ha scosso il mondo degli adulti. Ma se ha potuto farlo è perché quel mondo era già in crisi.
 La contestazione non fu una rivoluzione ma, anzitutto, una festa. Una travolgente esperienza collettiva di incontri con l’"altro" che superavano barriere sociali e culturali o differenze etniche e ideologiche, confini rigidi tra sanità e malattia o separazioni secolari tra pubblico e privato. Fu una reazione al progressivo svuotamento di legami familiari, sociali, istituzionali e una risposta alle ardue sfide dell’individualismo radicale imposto dalla società consumista. Preparato da mutamenti profondi, come quelli fatti emergere dal Vaticano II all’interno del cattolicesimo, il Sessantotto rivelò anche un’apertura al trascendente che però non venne compresa e ascoltata.
La contestazione non fu una rivoluzione ma, anzitutto, una festa. Una travolgente esperienza collettiva di incontri con l’"altro" che superavano barriere sociali e culturali o differenze etniche e ideologiche, confini rigidi tra sanità e malattia o separazioni secolari tra pubblico e privato. Fu una reazione al progressivo svuotamento di legami familiari, sociali, istituzionali e una risposta alle ardue sfide dell’individualismo radicale imposto dalla società consumista. Preparato da mutamenti profondi, come quelli fatti emergere dal Vaticano II all’interno del cattolicesimo, il Sessantotto rivelò anche un’apertura al trascendente che però non venne compresa e ascoltata. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - Quarant’anni di legge 194. Sui diritti bisogna vigilare (di Paola Govoni).21 maggio 2018, di Federico La Sala
Quarant’anni di legge 194
di Paola Govoni (Il Mulino, 21 maggio 2018)
I dati del Guttmacher Institute indicano che, ovunque ci siano leggi che consentono l’interruzione volontaria della gravidanza (Ivg), questa è in calo, anche in Italia. Eppure, negli ultimi anni in molti di quei Paesi, inclusa l’Italia, si sono accese polemiche sull’aborto e le leggi che lo regolamentano.
 Basta una rapida occhiata alla letteratura per vedere che a dimostrarsi preoccupati - ossessionati? - da questioni relative all’aborto sono più spesso uomini che donne. L’interesse nei confronti del tema sembra infatti nascere soprattutto da campagne denominate pro-life o “teoria gender”, i cui portavoce sono spesso uomini.
Basta una rapida occhiata alla letteratura per vedere che a dimostrarsi preoccupati - ossessionati? - da questioni relative all’aborto sono più spesso uomini che donne. L’interesse nei confronti del tema sembra infatti nascere soprattutto da campagne denominate pro-life o “teoria gender”, i cui portavoce sono spesso uomini.
 D’altra parte, anche in ambito storiografico, nonostante nell’ultimo secolo e mezzo la storia delle donne a opera di donne sia diventata via via più ricca, i testi importanti (o più citati) su questioni di donne e sessualità restano quelli degli uomini. Su qualsiasi tema gli uomini sono più citati delle donne, ma su questioni di sesso sono imbattibili, anche quando si tratta di allattamento, come già nel caso del botanico Linneo.
D’altra parte, anche in ambito storiografico, nonostante nell’ultimo secolo e mezzo la storia delle donne a opera di donne sia diventata via via più ricca, i testi importanti (o più citati) su questioni di donne e sessualità restano quelli degli uomini. Su qualsiasi tema gli uomini sono più citati delle donne, ma su questioni di sesso sono imbattibili, anche quando si tratta di allattamento, come già nel caso del botanico Linneo.
 Si tratta di una tradizione colta antichissima che ha spesso condiviso con la società, anche la meno acculturata, l’equazione donna = sesso. Questo spiega come sia possibile che ancora oggi e ovunque nel mondo il sesso resti il principale strumento di controllo delle donne: una responsabilità che è sociale, che ci coinvolge tutti e tutte e che non possiamo delegare, come molti ancora fanno, alla scienza.
Si tratta di una tradizione colta antichissima che ha spesso condiviso con la società, anche la meno acculturata, l’equazione donna = sesso. Questo spiega come sia possibile che ancora oggi e ovunque nel mondo il sesso resti il principale strumento di controllo delle donne: una responsabilità che è sociale, che ci coinvolge tutti e tutte e che non possiamo delegare, come molti ancora fanno, alla scienza.Come racconta in Una stanza tutta per sé, una mattina dell’autunno del 1928 Virginia Woolf si recò alla British Library per preparare alcune lezioni su creatività e indipendenza economica delle donne. Una scorsa al catalogo le bastò per rendersi conto che ogni anno veniva pubblicato a firma di uomini un numero impressionante di libri sul “sesso - e cioè le donne”. In dialogo con le ragazze del Newnhan e del Girton College per le quali stava preparando lezioni divenute memorabili, esclamò: “Vi rendete conto di essere, forse, l’animale più discusso dell’universo?”. -Woolf si accorse subito che a scrivere del tema non erano tanto biologi e medici, quanto gli autori più disparati, spesso senza alcuna qualificazione. Scelta una dozzina di quei volumi “in maniera assolutamente arbitraria”, ne cercò di analoghi di donne su uomini. Non ne trovò e il lavoro proseguì spedito.
Quel vuoto è un sollievo anche per le storiche che, come me, coltivano un certo orgoglio di categoria. Restando in ambiti di privilegio, sono diverse le umiliazioni che ci sono state inflitte, per esempio una secolare esclusione dalle università. Ma nonostante la nostra ignoranza, ci è risparmiato almeno l’imbarazzo di doverci occupare di autrici di libri su uomini e sesso analoghi a quelli incrociati da Woolf.
 Bertrand Russell seppe ammettere con ironia il problema quando osservò che “Aristotele maintained that women have fewer teeth than men; although he was twice married, it never occurred to him to verify this statement by examining his wives’ mouths” (The Impact of Science on Society, 1952). Vero o meno che fosse il dettaglio dei denti, Aristotele, come molti altri filosofi naturali e scienziati, resta utile per indagare i pregiudizi in cui gli uomini più intelligenti e colti possono cadere quando si tratta di donne.
Bertrand Russell seppe ammettere con ironia il problema quando osservò che “Aristotele maintained that women have fewer teeth than men; although he was twice married, it never occurred to him to verify this statement by examining his wives’ mouths” (The Impact of Science on Society, 1952). Vero o meno che fosse il dettaglio dei denti, Aristotele, come molti altri filosofi naturali e scienziati, resta utile per indagare i pregiudizi in cui gli uomini più intelligenti e colti possono cadere quando si tratta di donne.Sebbene la tentazione sia forte, le considerazioni rapide fatte fin qui non vogliono portare a conclusioni del tipo: quando uomini come quelli a capo dei movimenti pro-life parlano di aborto, conviene sorridere e occuparsi d’altro. L’aborto è una questione che, ancorché flaianamente seria, è drammatica. Penso tuttavia che sia salutare considerare con distacco chi (per ragioni che lascio alla psicoanalisi), oggi come nell’Ottocento, sente il bisogno di scrivere di aborto sostituendo dati verificati e approcci pragmatici a un problema sociale, con invettive moraleggianti contro le donne: antico strumento di battaglia ideologica (non politica) che dire scomposta è poco. Ho l’impressione che nei confronti di quelle prese di posizione convenga mantenere bassi i toni per evitare fenomeni cosiddetti di backslash, cioè un inasprirsi di atteggiamenti negativi nei confronti delle donne. In ambito accademico è per esempio probabile che certe derive costruzioniste degli anni Settanta e Ottanta, coltivate da élite prive di contatti con il mondo sociale reale, non abbiano giovato alle battaglie delle donne per la parità, ma semmai alimentato confusione tra i/le giovani (la vaghezza di certe argomentazioni può solo diventare gergo da ipse dixit) e insoddisfazione in chi è esclusa/o dai privilegi di cui godono quelle élite.
Il mio invito a mantenere bassi i toni non significa subire in silenzio. Tutt’altro. Bisogna parlare e molto di questi temi, soprattutto in ambito educativo, dal nido all’università. Per esempio, gli/le adolescenti dovrebbero conoscere i vantaggi sociali concreti che porta un’educazione alla piena parità di diritti e di doveri (già, ci sono anche quelli), per non dire dell’educazione sessuale che, come mostrano i dati del Guttmacher Institute, è cruciale perché cali il ricorso all’aborto. Un’educazione che in Italia è trascurata o osteggiata (per ragioni che pure lascio alla psicoanalisi). D’altra parte, l’ignoranza è la realtà con la quale il Paese si confronta (su questo punto, è noto, c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra i dati Pisa, i bassi investimenti in educazione terziaria, il posizionamento problematico delle università nelle diverse classifiche internazionali e così via). E le ripercussioni sociali sono pesanti, si tratti di corruzione, di diritti dei carcerati o delle donne: nella classifica che misura i diritti di queste ultime, l’Italia è passata dal 72° posto nel 2006 all’82° su 144 Paesi nel 2017.
La storia delle donne è ricca di esempi che mostrano che posizioni o diritti conquistati restano comunque precari. In ambito scientifico, nel 1984 fu Margaret Rossiter, dati quantitativi alla mano, a parlare di backslash nei confronti delle scienziate americane dopo la Prima guerra mondiale. Oppure, si pensi al caso più clamoroso, quello della computer science, il sapere che ormai regge le società e le economie mondiali. Nella Silicon Valley le donne sono sottorappresentate, benché siano state pioniere nel mondo dell’informatica, nella ricerca come nell’imprenditoria. La storia non è progressiva e sui diritti bisogna vigilare.
L’aborto va prevenuto con l’educazione, impedirlo porta le povere a ricorrervi in clandestinità, le abbienti a ottenerlo in un Paese confinante. Ogni decisione che riguardi la vita e la morte dovrebbe a mio parere essere possibile in un contesto normativo il più possibile flessibile che tutela le libertà. Su morte e vita non abbiamo dati e/o argomentazioni sufficienti per stabilire con certezza quei confini che alcune/i pretendono per demandare la scelta: chi alla scienza, chi alla religione, chi alla giurisprudenza. In dialogo con quelle culture, la scelta su vita e morte può solo essere nostra, libera, responsabile e valutata caso per caso.
 Rimettere in discussione la legge che consente l’Ivg è pericoloso per la libertà di tutte/i. Come la scienza, anche la storia ci offre dati utili su cui meditare: ogni volta che si è preteso di limitare le libertà di qualcuna/o, fossero avversari politici, scientifici o religiosi, donne, ebrei o sinti, prima o poi sono state limitate anche le libertà di chi aveva iniziato a gridare.
Rimettere in discussione la legge che consente l’Ivg è pericoloso per la libertà di tutte/i. Come la scienza, anche la storia ci offre dati utili su cui meditare: ogni volta che si è preteso di limitare le libertà di qualcuna/o, fossero avversari politici, scientifici o religiosi, donne, ebrei o sinti, prima o poi sono state limitate anche le libertà di chi aveva iniziato a gridare. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. - DONNE E POTERE. L’Occidente è colpevole. Ma l’Occidente è la salvezza. Interv. a Rita El Khayat (di L. Cremonesi).18 maggio 2018, di Federico La Sala
PENSARE L’«EDIPO COMPLETO» (S. FREUD). UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO... *
L’Occidente è colpevole. Ma l’Occidente è la salvezza
Psichiatra e antropologa marocchina, Rita El Khayat parla in questa intervista di colonialismo, migrazioni e Primavere Arabe. «In certi momenti storici è meglio un regime forte. Tra Assad e Isis scelgo Assad».
di Lorenzo Cremonesi (Corriere della Sera, La Lettura, 13.05.2018)
Non si tira indietro nell’accusare «il colonialismo e i danni gravissimi che ha causato ai Paesi arabi e nelle province del mondo islamico». Però è anche profondamente innamorata della cultura occidentale, della sua difesa per i diritti umani e delle donne in particolare. «La mia salvezza intellettuale e civile è cominciata quando giovanissima ho studiato la lingua francese», non si stanca di ripetere. E ai migranti che attraversano il Mediterraneo per approdare in Europa non lesina critiche. «Mi stupisce la caparbietà con cui restano attaccati ai valori e alle tradizioni dei loro Paesi d’origine. Proprio non li capisco!», esclama. «Hanno rischiato la vita per venire in Occidente. Ma se non vogliono cambiare ciò che hanno lasciato, allora perché non se ne rimangono a casa loro? Se credono che a Roma o a Parigi si possono uccidere le figlie che rifiutano di sposare i mariti scelti per loro dalle famiglie non hanno compreso davvero nulla di questo nuovo mondo, meglio che tornino da dove sono partiti».
Il coraggio intellettuale di Rita El Khayat sta anche nella sua aperta disponibilità ad affrontare la complessità delle contraddizioni di un pensiero libero come il suo. Nata nel 1944 a Rabat, marocchina legata alle tradizioni del Maghreb profondo, è scrittrice (ha pubblicato una quarantina di saggi, di cui 14 tradotti in italiano), ma anche psichiatra, antropologa, ha scelto di esercitare a Casablanca la professione di «antropo-psichiatra». Il prossimo 18 maggio parteciperà a Milano a un convegno promosso dall’Asla (Associazione studi legali associati) in un seminario dedicato a Donne e potere.
Partiamo dal tema che tratterà in Italia: non crede vi siano ben poche differenze tra donne e uomini di potere?
«Assolutamente sì. Non cambia niente. Le donne al comando si comportano esattamente come hanno sempre fatto gli uomini, con le stesse ingiustizie, le stesse prevaricazioni e nepotismi, lo stesso sistema di privilegi per chi obbedisce e di punizioni per chi si oppone. Semmai le donne sono ancora più dure, più spietate e più forti degli uomini, proprio per il fatto che hanno dovuto faticare molto di più per imporsi. Lo noto in Francia come in Marocco e nel resto del Maghreb. Ma sono in atto mutamenti epocali. Dove le donne sono diventate economicamente indipendenti avvengono importanti processi di adattamento reciproci tra i due sessi; necessiteranno decenni per trovare nuovi equilibri».
In Medio Oriente ci eravamo illusi che le Primavere Arabe portassero giustizia e libertà. Ma alle vecchie dittature laiche si sono contrapposti i radicalismi islamici oscurantisti e fanatici. Ci siamo trovati a dover scegliere tra la repressione di Bashar Assad e gli orrori di Isis. Lei cosa sceglierebbe?
«Nel 2011, all’inizio delle cosiddette Primavere arabe, stavo con le piazze della rivoluzione. Consideravo Assad uno spietato e sanguinario dittatore. Ma poi, quando ho visto cosa Isis faceva alle donne, lo scempio dei diritti umani, le ragazze yazide vendute in piazza come schiave sessuali, mi sono detta: “Mio Dio, meglio Bashar. Se vince Isis torneremo al Medio Evo”. Ho scritto un libro su questo mio ripensamento. Al caos preferisco un regime ordinato che garantisca la crescita economica e la scolarizzazione diffusa. In certi periodi storici un regime forte come quelli di Franco o Salazar può rivelarsi utile. Più tardi potranno arrivare le riforme in senso democratico ed emergere quelle che Karl Marx definiva le sovrastrutture volte a migliorare la qualità della vita umana».
Dunque, in Egitto, meglio Hosni Mubarak e il regime ancora più duro di Abdel Fattah al Sisi? Un Libia meglio Gheddafi, meglio la vecchia nomenklatura corrotta in Tunisia?
«Le Primavere arabe sono state un movimento di protesta elitario esaltato dalla stampa occidentale, che però non era una vera rivoluzione per il fatto che mancava di leader e di chiare ideologie. Le minoranze che manifestavano in piazza sapevano cosa volevano abbattere, ma non avevano alcuna idea su come e con cosa sostituirlo. Così sono arrivati i movimenti islamici ben organizzati. Alcune conseguenze sono stati i peggioramenti dei diritti civili, inclusi quelli delle donne. Però poi ogni Paese va visto e compreso nella sua storia particolare».
Per esempio?
«Molti anni fa visitai l’Iraq di Saddam Hussein. Era una dittatura, certo. Ma il livello delle scuole era buono, il Paese funzionava. Gheddafi però non lo pongo sullo stesso piano: era un pazzo, uno psicopatico, una personalità con gravissimi disturbi psichici. Aggiungo che il Maghreb è una realtà diversa dai Paesi arabi. In Marocco, dopo gli attentati terroristici di Casablanca nel 2003, abbiamo avuto riforme radicali, è stato cambiato il diritto di famiglia. -Nel 2012, dopo il caso di Amina Filali, la sedicenne suicida perché secondo le nostre vecchie leggi costretta a sposare il suo violentatore, abbiamo riformato ulteriormente i nostri codici. Ora sono vietati i matrimoni ai minorenni e le ragazze hanno diritto di scelta. Però resta il problema dell’ignoranza diffusa. Per i poveri che non vanno a scuola in realtà cambia ben poco. Se non conosci i tuoi diritti non sai neppure come difenderti. È una legge universale.
 Noi oggi abbiamo una donna a capo del ministero della Famiglia che ha avuto il coraggio di affermare che le famiglie che hanno un reddito quotidiano pari a 1,80 euro non sono povere. Quando le è stato chiesto cosa farebbe se sua figlia fosse violentata lei ha risposto che la cosa è impossibile, lasciando intendere che le violenze sessuali accadono solo tra poveri. Può anche essere vero. Ma i poveri costituiscono la maggioranza della popolazione dall’India all’Afghanistan al Medio Oriente allargato».
Noi oggi abbiamo una donna a capo del ministero della Famiglia che ha avuto il coraggio di affermare che le famiglie che hanno un reddito quotidiano pari a 1,80 euro non sono povere. Quando le è stato chiesto cosa farebbe se sua figlia fosse violentata lei ha risposto che la cosa è impossibile, lasciando intendere che le violenze sessuali accadono solo tra poveri. Può anche essere vero. Ma i poveri costituiscono la maggioranza della popolazione dall’India all’Afghanistan al Medio Oriente allargato».Nel suo libro «Il complesso di Medea», dopo aver trattato delle ingiustizie subite dalle donne nelle società mediterranee dove imperano le tre religioni monoteiste, affronta anche un tema molto delicato: sovente sono le donne anziane a comportarsi nel modo più duro e intransigente nei confronti delle ragazze, specie se belle e vergini. Tra l’altro spesso nelle società tribali sono le anziane a effettuare l’infibulazione sulle bambine e sono prima di tutti le madri a costringere le figlie nei matrimoni combinati. Donne vecchie contro giovani?
«In Marocco diciamo che il paradiso è sotto i talloni delle madri. In un mio libro del 1986 ho analizzato il vecchio sistema patriarcale giungendo alla conclusione che senza un forte matriarcato non può esistere il patriarcato. Parliamo di un sistema sociale che privilegia il gruppo, la tribù, il nucleo familiare allargato. Il maschio anziano domina, ma alle sue fondamenta sta la madre, la donna che da giovane ha rispettato le regole, ha generato figli funzionali al gruppo e nella maturità assurge a pilastro fondamentale della casa perpetuando le leggi che stanno alla radice di quel modo di essere. In quel mondo gli anziani non saranno mai abbandonati. I vecchi sono come i totem freudiani, rappresentano il potere e la sua continuità. Si tratta di un sistema sociale chiuso, assolutamente diverso dall’individualismo liberale occidentale, dove le giovani donne devono stare in casa a generare e curare i bambini. I figli maschi sono formalmente più liberi delle sorelle, però la loro dipendenza dalla madre è molto più forte».
Ovvio che lei abbia sempre scelto l’individualismo occidentale al tribalismo orientale, vero?
«Sempre. Non ho mai avuto dubbi! La mia libertà di donna, di intellettuale, di individuo con diritti e doveri non poteva esprimersi in altro modo se non nei canoni culturali e sociali occidentali. Mia madre non ebbe la mia libertà, sognava di studiare francese, ma le fu vietato, fu una vittima. Io amo scrivere negli aeroporti, viaggiare, essere sola a pensare. Se avessi dovuto sacrificare le mie aspirazioni personali alle regole sociali tribali non sarei mai diventata ciò che sono».
*
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Per un nuovo romanzo di formazione, pensare l’ "edipo completo".14 maggio 2018, di Federico La Sala
Pensare l’ "edipo completo"....
PLAUDENDO al lavoro e alla sollecitazione delle Autrici di "ripensare le figure della maternità", e, al brillante saggio introduttivo di Daniela Brogi, "Nel nome della madre. Per un nuovo romanzo di formazione", mi sia lecito ricordare che il programma di Freud, al di là dei molteplici e "interessati" riduzionismi (in nome del padre o in nome della madre), era quello di = Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico kantiano: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio"; e, possibilmente e ’finalmente’, uscire fuori dalla "caverna", dalla "preistoria", e portarci (tutte e tutti) DAL "CHE COSA" AL "CHI".
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- La legge 180 compie 40 anni, la Costituzione 70. Bisognerà conservare gelosamente la memoria (di Peppe Dell’Acqua).13 maggio 2018, di Federico La Sala
La legge 180
Compie 40 anni la legge Basaglia, che rese i matti «cittadini»
di Peppe Dell’Acqua *
È il 16 novembre 1961 quando il giovane Basaglia entra nel manicomio di Gorizia. Vede non solo la violenza delle porte chiuse e delle contenzioni. Vede “da filosofo” una violenza più grande: gli uomini e le donne non ci sono più. Ci sono più di 600 internati, senza più volto senza più storia. Vede la mostruosità dell’istituzione totale: i cancelli, le chiavi, le porte chiuse, i letti di contenzione ma, quello che angoscia più di ogni altra cosa Basaglia, è l’orrore dell’assenza. Non c’è più nessuno.
- Oggi scade il termine per la chiusura 31 marzo 2015
- Ospedali psichiatrici giudiziari, un addio soltanto a metà
Gli internati sono tutti appiattiti nella stessa grigia identità, tutti invisibili. Basaglia è costretto a mettere tra parentesi la malattia, la diagnosi, il grigiore di anni d’internamento. Messa tra parentesi la malattia, persone, storie, relazioni, memorie riaffiorano. I cittadini compaiono sulla scena.
Per incontrare le persone bisognò aprire le porte, abolire tutte le forme di contenzione, i trattamenti più crudeli. Tutti cominciarono a chiamarsi per nome. Divennero cittadini, persone, individui. Da allora fu possibile un altro modo di curare e di ascoltare: il malato e non la malattia, le storie singolari e non la diagnosi, la possibilità di vivere e di abitare la città.
- L’ANNIVERSRIO 09 maggio 2018
- Delitto Moro, tre Papi e un presidente-partigiano: com’era l’Italia nel 1978
Sabato 13 maggio 1978: Aldo Moro è stato ucciso da pochi giorni dalle BR. Una giovanissima partigiana, Tina Anselmi, democristiana, presiede con autorevolezza i lavori della commissione che sta discutendo la legge dei manicomi. Si interroga se i malati di mente siano cittadini, se possano godere dei diritti costituzionali. La legge che avrebbe chiuso i manicomi restituisce così prima di tutto diritto, cittadinanza, dignità alle persone che hanno la ventura di vivere una malattia mentale. Non più la pericolosità, ma la cura nel rispetto della libertà di ognuno. Tina Anselmi, quel giorno, affermò “semplicemente” che l’articolo 32 della Costituzione valeva per tutti, anche per i matti. A maggior ragione per i matti.
Quaranta anni di Legge Basaglia
Il giovane Aldo Moro aveva fatto parte della Costituente. Aveva discusso con Calamandrei, con Togliatti, con La Pira l’art. 32 e ne era stato l’estensore. Al secondo capoverso così recita: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». L’attenzione alla persona umana avrà formidabili conseguenze nel garantire i diritti fondamentali nella nostra democrazia. In quei giorni terribili Aldo Moro, prigioniero senza diritti e condannato a morte, costruiva la via d’uscita.
 I matti diventavano cittadini. La legge 180 compie 40 anni, la Costituzione 70. Bisognerà conservare gelosamente la memoria.
I matti diventavano cittadini. La legge 180 compie 40 anni, la Costituzione 70. Bisognerà conservare gelosamente la memoria.Arriviamo all’ottobre 2010. Una Commissione parlamentare denuncia la condizione di vita dei sei Ospedali psichiatrici giudiziari del nostro Paese. Che fare dopo aver visto tanto orrore? Chiesero consiglio al Presidente Napolitano, tornarono in quei luoghi, documentarono tutto e mostrarono il video al Presidente. Di fronte a tanta violenza i corazzieri non riuscirono a trattenere le lacrime.
- “Se qualcuno mi avesse detto, quando ho cominciato a lavorare, che i manicomi criminali sarebbero stati chiusi lo avrei preso per pazzo”
Il vecchio Presidente, inaspettatamente, nel messaggio di Fine anno del 2012 parlò degli Ospedali psichiatrici giudiziari, pronunciando parole dolorose: «Luoghi orrendi non degni di un Paese appena civile». Così ricominciò il viaggio di Marco Cavallo, la scultura di legno e cartapesta che aveva abbattuto le mura del manicomio di Trieste nel 1977, diventando emblema della liberazione. Marco Cavallo arrivò nelle periferie degli OPg: non c’era più tempo. Bisognava liberare tutti da quel tormento. Il 30 maggio 2014 la legge per chiudere tutti gli istituti fu approvata. Il 27 gennaio 2017 l’ultimo internato lasciava l’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto.
Se qualcuno mi avesse detto, quando ho cominciato a lavorare, che i manicomi criminali sarebbero stati chiusi lo avrei preso per pazzo.
Maggio 2018, sono passati 40 anni dalla riforma Basaglia. Di fronte a conquiste luminose e a tante persone che riescono a farcela, ancora capita di dover fronteggiare l’abbandono, le porte chiuse, le contenzioni, le morti per psichiatria. Ma questa, lo sappiamo, è una storia senza fine. È utopia, ci hanno sempre detto.
 Utopia é qualcosa che si può solo sognare. Ma, come recitava il Cantastorie collettivo nato nel ’77 per i Centri di Salute mentale h24 a Trieste, «utopia è che il ghetto più non ci sia, che muri e reti buttiamo via. E quante cose possiamo ancora fare se ci mettiamo tutti insieme a sognare?».
Utopia é qualcosa che si può solo sognare. Ma, come recitava il Cantastorie collettivo nato nel ’77 per i Centri di Salute mentale h24 a Trieste, «utopia è che il ghetto più non ci sia, che muri e reti buttiamo via. E quante cose possiamo ancora fare se ci mettiamo tutti insieme a sognare?».* Il Sole-24 Ore, Domenica, 13 maggio 2018 (ripresa parziale, senza immagini e allegati).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- La rivoluzione non è finita. Intervista a Edgar Morin (di Mario Baudino).13 maggio 2018, di Federico La Sala
MAGGIO 68. LA BRECCIA. E. Morin: «una breccia sotto la linea di galleggiamento di quel transatlantico magnifico che sembrava avviato verso un radioso futuro ... una delle rare estasi della storia, in cui tutti improvvisamente stanno benissimo...»
Edgar Morin
Torno a raccontare il Sessantotto. La rivoluzione non è finita
dii Mario Baudino (La Stampa, 13.05.2018)
Edgar Morin pubblica per Cortina una raccolta di scritti sul ’68 e la intitola La breccia. È la metafora che il grande sociologo francese usò fin da subito, cronista in diretta del Maggio, antropologo della rivolta studiata dall’interno, in due lunghi articoli su Le Monde. Ora, a distanza di cinquant’anni, lui che nato Edgard Nahoum nel 1921 ha vissuto adolescente il ’36 e la esaltante vittoria delle sinistre nella Francia pre-bellica, ha combattuto nella Resistenza (trasformano il suo nome di battaglia in cognome anagrafico), ha partecipato ai movimenti che contestavano la guerra d’Algeria e soprattutto non ha mai smesso di studiare le dinamiche sociali e culturali, è convinto che quella breccia non si è ancora chiusa.
In che senso, professore?
«Nel senso che il Maggio francese non fece certo crollare la società borghese e forse non la cambiò di molto, ma aprì una breccia sotto la linea di galleggiamento di quel transatlantico magnifico che sembrava avviato verso un radioso futuro. La nave della società pareva solidissima, e invece scoppiò una rivolta generazionale. Gli adolescenti rivendicarono un’utopia libertaria, che contagiò tutti, gli operai, i borghesi, gli intellettuali. Finì presto, con la ricomposizione del vecchio sistema sociale e la deriva marxista leninista, ma quel che accadde fra il 3 e il 13 maggio rappresenta una delle rare estasi della storia, in cui tutti improvvisamente stanno benissimo, nessuno va da più dallo psicanalista o dal medico, nessuno ha più problemi nervosi».
Una sospensione improvvisa, ludica e fragilissima, del freudiano disagio della civiltà?
«Le cui tracce, oggi, si vedono però nel volontariato, nel mondo dell’economia solidale, nella volontà di una vita migliore senza inquinamento e senza sopraffazione. Questa è la breccia ancora aperta, la vera eredità, anche se la società è cambiata da allora. Pensi al mito del progresso».
In quel momento, non solo in Francia ma un po’ in tutto il mondo, una generazione di giovanissimi cominciò a dubitarne.
«Negli Anni Sessanta si era formata una bio-classe, con una cultura comune, valori condivisi, persino un certo modo di vestire. La loro fu una rivolta contro gli adulti, che coinvolse e trascinò con sé gli adulti. Il fenomeno non si è più ripetuto. E oggi, in tutti i Paesi, sappiamo che la legge del progresso non è più vera. Il futuro non significa automaticamente un miglioramento, ma semmai incertezza e angoscia. Le conquiste sociali di un tempo non esistono più, il dubbio coinvolge persino l’idea di democrazia e dei suoi valori. Tutto questo, senza che i più ne avessero la percezione, è cominciato allora».
Nostalgia?
«No, nostalgia mai. Ma ricordo la prima delle giornate del Maggio, il clima di festa, di libertà, di originalità. Il Super-Io dello Stato e della società si erano paralizzai, erano spariti. Sono momenti speciali, rarissimi. Ne ho vissuti anche altri: la liberazione di Parigi nel ’44, la rivoluzione dei garofani in Portogallo nel ’74, la caduta del Muro nell’89»
Le primavere arabe?
«Nei primi giorni, anche se poi, a differenza di questi altri momenti storici, si sono drammaticamente trasformate nel loro contrario».
Una lettura in prospettiva dal ’68 a oggi sembra dirci che l’utopia libertaria è destinata a essere sconfitta dal ritorno della politica e dell’ideologia.
«Oggi c’è la necessità di ripensare la politica, di lavorare alla ricostruzione di un pensiero politico: guardi i nostri due Paesi. Macron, con la sua avventura personale, ha decomposto la vecchia politica, ma non è riuscito nella ricomposizione di un pensiero nuovo. In Italia siete alla compiuta decomposizione dei partiti storici, e anche qui la necessità di una ricomposizione è evidente, anche se al momento non se ne vede la prospettiva. In gran parte dell’Europa trionfano forze di destra, revansciste, nazionaliste, populiste».
Nel suo Insegnare a vivere (uscito due anni fa sempre per Cortina) lei punta sull’insegnamento. Non su una ennesima riforma della scuola o dell’Università, ma su un nuovo orizzonte che superi la barriera tra saperi tecnologico-scientifici e formazione umanistica.
«Ci sono molte vie d’uscita dalla nostra attuale situazione, ma questa resta per me la principale».
Anche contro chi rivendica la propria ignoranza come un valore?
«Viviamo in una società di illusioni, come quella che ha appena citato. Un solo fatto è certo: la vera educazione per vivere non esiste ancora. Neppure io so quale sia. Ho scritto un libro. Spero che la si scopra insieme».
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- MAGGIO 68. LA BRECCIA (E. Morin).Io Lenin, tu Lennon. Non fu rivoluzione ma rivolta generazionale (di Marino Niola).13 maggio 2018, di Federico La Sala
Io Lenin, tu Lennon
A rimettere ordine nei miti del ’68 ci voleva un signore di 97 anni che ripubblica, mezzo secolo dopo, le riflessioni di allora. Non fu rivoluzione ma rivolta generazionale. E quel magma di istanze antitetiche, tra politica e pop, brucia fino a noi
di Marino Niola (la Repubblica, 13.05.2018)
Il Sessantotto non ha cambiato la politica, ma ha rivoluzionato le nostre esistenze. A dirlo è il filosofo e sociologo Edgar Morin in Maggio 68. La breccia, in uscita da Raffaello Cortina. Il libro si compone di testi in presa diretta, usciti su Le Monde nel maggio 1968 arricchiti da una illuminante riflessione scritta nel gennaio scorso. Sono pagine traboccanti di passione e di emozione. Dove si avverte l’incandescenza magmatica del sommovimento, colta in tutta la sua virtualità generatrice di futuro. Morin, che l’8 luglio compirà novantasette anni, individua le conseguenze di lunga durata di quella grande marea, la cui onda di ritorno arriva fino a noi. In effetti quel fremito prolungato che attraversa la schiena dell’Occidente borghese e non solo, dalla rivolta di Berkeley al Maggio francese, da Valle Giulia a Woodstock, da Piazza San Venceslao al Cairo di Nasser, ha finito per aprire una breccia al di sotto della linea di galleggiamento della nostra civiltà. E ad assestare il primo colpo è stato un movimento transnazionale e trans-ideologico di adolescenti inquieti. Antiliberisti libertari, terzomondisti atrabiliari, situazionisti incendiari, maoisti conseguenziari, leninisti dottrinari, trotzkisti visionari, che non reclamavano un posto al tavolo dei grandi.
Volevano rovesciare il tavolo. Rifiutavano di vivere come i genitori, disprezzavano l’idea stessa di carriera. Aborrivano il mondo adulterato degli adulti, con la sua ragionevolezza fatta solo di calcolo, di economia, di interesse, di utile. “Siate ragionevoli, chiedete l’impossibile!” era uno degli slogan. Il marxismo è stato il connettivo che ha permesso di tenere insieme questo patchwork multicolore e multivalore, più surrealista che leninista. E ha fornito un linguaggio in grado di unificare la molteplicità di istanze parricide che sono il vero minimo comune denominatore di quella che è stata, prima di tutto, una rivolta contro i genitori.
Contro il “seminirvana consumistico”. E contro i simboli e le istituzioni che davano corpo e anima all’autorità. Dalla famiglia allo stato, dalla scuola all’esercito, dalla Chiesa alla scienza, fino all’università dei baroni. Destinata a diventare il vero epicentro del terremoto sessantottino. Assestando “un colpo profondo al basso ventre di una società che aveva schierato dappertutto le sue difese, salvo che nella sua nursery sociologica”. A dire il vero, nell’immaginario della contestazione, più che il Capitale e i Grundrisse c’erano Rousseau, Rimbaud e perfino Thoreau, sapientemente amalgamati con il placebo comunista da una coorte di maître- à- penser che nel magnetismo pulsionale, emozionale, libidinale di quel momento hanno trovato una seconda giovinezza. Un elisir di lunga vita che ha fatto del forever young la sola, vera classe d’età della società postmoderna. All’immagine tradizionale dell’adulto-padre, dice Morin, il movimento “contrappone l’immagine incompiuta di un’adolescenza permanente”.
Non una stagione anagrafica, dunque, ma un’eterna primavera del corpo e dell’anima, del desiderio e della libertà. Nel vortice della contestazione globale, la parola d’ordine lanciata da Jean-Paul Sartre, “ribellarsi è giusto”, diventa una chiamata al levantamiento generazionale. Non solo contro genitori e professori. Si rivoltano anche gli operai contro dirigenti e padroni, i medici contro la casta dei primari, gli scrittori contro gli editori paternalisti. E i ragazzi ebrei contro i vecchi rabbini per “farsi riconoscere il diritto di trattare le questioni religiose”. È più ebollizione che rivoluzione. E dietro il mantra marxiano dell’intellettuale organico, affiora l’antifona reichiana dell’intellettuale orgonico. Che risuona tra le performance estreme del Living Theater che portano in scena il tramonto dell’Occidente e le tracce di un oriente dell’anima che molti vanno a cercare a Benares e a Katmandu. Una generazione in cerca di altro, qualunque sia quest’altro. Basta che non somigli a quel che ci hanno tramandato papà e mamma. Così il rifiuto del proprio mondo porta alla costruzione di universi utopici, di autentici ready made mitologici che vedono nella differenza l’antidoto contro la familiarità dalla quale ci si vuole emancipare. Ecco perché la rivoluzione, il socialismo, il sol dell’avvenire, più che un progetto politico sono un mito fusionale, spesso confusionale, sospeso tra istanze antitetiche. Marcuse e il Che, Mao e Hailé Selassié, guardie rosse e pantere nere, Gramsci e Krishna, Lenin e Lennon, pacifismo e lotta di classe, revival folk e femminismo, nuove spiritualità e stati alterati di coscienza, figli dei fiori e minigonne, la comune di Parigi e il Ristorante di Alice.
Da quel magma nascono molte scelte di vita che hanno a che fare più con il personale che con il politico e che oggi sfociano spesso nell’antipolitica.
Perché molte delle idee che sono alla base di fenomeni attuali come populismo, antiglobalismo, neotradizionalismo, revival identitario, antiscientismo, antiautoritarismo, ambientalismo e persino il rousseauvianesimo digitale, sono il frutto tardivo della contestazione. Come dire che il movimentismo attuale non è figlio di NN. Né nasce solo dai new media. Ma è l’ultimogenito, non riconosciuto, della controcultura, di quel protagonismo disseminato e degerarchizzato del “Non ho niente da dire, ma lo voglio dire”. Che nella rete e attraverso la rete riesce a piazzare il colpo vincente e trasformare la demagogia in egemonia. O almeno ci prova.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 --- AFFERRARE LA VITA. Una nota di Nicola Fanizza.10 maggio 2018, di Federico La Sala
Afferrare la vita
di Nicola Fanizza *
Sono passati quasi cinquant’anni da quel lontano settembre del 1969, in cui il «Comitato Marinai Studenti» si fece promotore un’azione di lotta contro gli armatori che coinvolse l’intera marineria del mio Paese, Mola di Bari. Ciò che mi resta dell’atmosfera di quel crepuscolo dell’estate è il sapore del tempo. Si trattava di un tempo qualitativamente diverso, insolito, dilatato e, insieme, sospeso.
Una nuova socialità
A noi studenti e ai giovani marinai venne offerta la possibilità di vivere una seconda infanzia: proprio perché non avevamo niente da fare o da progettare, ci abbandonavamo all’istinto e all’effervescenza magmatica del momento; vivevamo una dimensione di tempo senza tempo. Le nuove forme di socialità come le assemblee, il fumare assieme la stessa sigaretta e, in modo coestensivo, l’antico rituale dei giochi di birra, contribuivano ad addomesticare la distanza fra noi studenti e i marinai.
Molti allora presero la parola per la prima volta, altri, invece, ascoltavano. Nondimeno eravamo comunque tutti convinti di poter cambiare il mondo! L’esito di quella lotta fu positivo. I pescatori ottennero un nuovo contratto che prevedeva: una nuova e più equa ripartizione del pescato fra armatori e marinai; il salario minimo garantito; e, infine, il diritto di fruire delle ferie.
In quell’inedito spazio sociale il filo dei rapporti amicali consentì la produzione di un tessuto di relazioni che continuò per alcuni anni. Di fatto a quella lotta avevano partecipato - accanto ai pescatori che erano imbarcati sui pescherecci che operavano nel Canale di Sicilia e ai pescatori dediti alla pesca locale - un cospicuo numero di giovani marittimi che in seguito si tennero in contatto con i membri più anziani del comitato. I leader del «Comitato Marinai Studenti» - Carlo Moccia e Rodolfo Vaccarelli - avevano rapporti epistolari con molti marinai imbarcati sulle navi nonché con i pescatori presenti sui pescherecci che operavano a Siracusa, Mazara del Vallo, Ancona, ecc. Tuttavia col passare del tempo quel filo si spezzò soprattutto per la difficoltà di individuare l’identità del nemico da combattere, poiché il mondo dei pescatori è un mondo composito e variegato: accanto agli armatori possessori di molte barche, vi sono piccoli proprietari di natanti a gestione familiare.
La partecipazione a quell’evento fu per me e per i miei compagni l’occasione per afferrare la vita.
Più che prendere il potere, volevamo perderlo
Il movimento del ’68 era composto per lo più da studenti che non volevano studiare solo ciò che stava nei programmi e da operai che rifiutavano ogni forma di lavoro che non fosse opera viva. Era un movimento «impolitico» che negava l’esistente nel senso che dava voce a tutto ciò che si agitava sull’esergo del sistema, alle forme di socialità che stazionavano nell’atmosfera del dono. Lo slogan «Il privato è politico» esprimeva per l’appunto l’esigenza di porre all’ordine del giorno alcuni temi - gli affetti, il senso della vita - che la politica non riconosceva. Da qui la contestazione nei confronti dell’autoritarismo dei docenti e dei loro programmi. La filosofia - si diceva allora - doveva essere non solo amore della scienza, bensì anche e soprattutto scienza dell’amore, poiché gli affetti erano importanti allo stesso modo dei concetti.
Eravamo giovani ribelli - anticonformisti, stravaganti e originali - che avevamo troppa fame per essere critici nei confronti della società dei consumi. Più che prendere il potere, volevamo perderlo. Volevamo nutrire il nostro desiderio, volevamo tutto. Eravamo affamati di sesso, di sigarette, di cose buone. Volevamo vivere la nostra vita come una festa, come una festa senza fine.
Di fatto nel movimento italiano del ’68, come in tutti i movimenti, vi erano diverse anime. Si trattava di un movimento composito e anche contraddittorio. La sua cifra va individuata nella sua capacità di proporsi come una festa. E, come tutti sappiamo, la festa è il momento dell’effervescenza magmatica, della creatività, dell’esuberanza, ed è anche il momento in cui si portano i doni. Tuttavia il potere di allora, si rifiutò di riconoscere e accogliere le nuove istanze di liberazione - i doni - e scatenò la repressione.
Chi è integrato è perduto
Tutto ciò - dopo la strage di Piazza Fontana del dicembre 1969 - favorì il ritorno del «vitello d’oro». Il vecchio immaginario dei marxisti leninisti - divenuto più tardi delirio con la deriva della lotta armata - prese subito il sopravvento sulle istanze movimentistiche che volevano cambiare la vita e da allora quelli che prima erano gli «integrati» - i padri di famiglia, gli operai che non si ribellavano, ecc. - cominciarono a essere stigmatizzati con l’epiteto di «piccolo borghesi».
A tale proposito, è opportuno tener presente che Luciano Bianciardi nel 1959 aveva pubblicato il romanzo autobiografico L’integrazione, in cui aveva stigmatizzato la deriva che, partendo da Milano, stava per investire l’intera società italiana: «Bastano pochi mesi perché chiunque si trasferisca qui si svuoti dentro, perda linfa e sangue, diventi guscio: tra 20 anni tutta Italia si ridurrà come Milano».
Da qui la connotazione negativa della parola integrazione. Di fatto, a partire dalla metà degli anni Sessanta, il termine «integrato» cominciò a essere utilizzato nel linguaggio giovanile per indicare gli individui che si riconoscevano nel discorso canonizzato della polis. Si trattava di individui conformi ai valori dominanti, di individui che per lo più appartenevano ai diversi ceti.
Nondimeno, oggi, quelli che rivendicano l’integrazione per gli immigrati - ossia l’obbligo di svuotarsi completamente della loro cultura, delle loro radici - fino a che punto - quando fosse loro richiesto - sarebbero disposti a rinunciare alle loro tradizioni, alle loro radici, alla loro cultura?
Si può essere felici soltanto tutti insieme
Ritornando a alle dinamiche del ‘68, possiamo dire che a un’esplosione libertaria, che modificava lo spazio sociale - i rapporti fra le persone, il ruolo della donna -, seguì un irrigidimento dogmatico di una parte non trascurabile del movimento.
Ciò nondimeno è pur sempre vero che attraverso il ’68 siamo pervenuti a una maggiore consapevolezza di noi stessi, alla nostra autonomia. Dopo di allora il Mondo non è più stato lo stesso. Fu allora che i «senza storia» presero per la prima volta la parola; fu allora che si cominciò a coltivare l’idea che si poteva afferrare la vita, che si poteva essere felici soltanto tutti assieme, coniugando, diversamente, la vita con la politica!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Come nascono i bambini. Lettera aperta ai dirigenti della Rai TV (di Luisa Muraro)-7 maggio 2018, di Federico La Sala
Lettera aperta ai dirigenti della Rai TV
"Pago il canone e pretendo che i giornalisti della tivù pubblica sappiano come nascono i bambini".
di Luisa Muraro
Le sindache (e i sindaci) d’Italia, possono credere nella cicogna che porta i bambini, ma quelli che preparano i telegiornali, no, loro no. Pago il canone e pretendo che i giornalisti della tivù pubblica sappiano come nascono i bambini. Nel telegiornale delle ore19 di sabato 28 aprile, hanno dato la notizia di un bambino che ha due padri, anzi “due papà”, e come tale è stato regolarmente iscritto all’anagrafe di Roma. Non sembrava l’annuncio di un qualche miracolo della scienza medica. La signora che ha letto la notizia, se, come dobbiamo supporre, era incredula, l’ha nascosto molto bene. E così dovranno fare, suppongo, le segretarie, le maestre, i parenti, i nonni, i pediatri, e via via, fino a quando l’interessato, reso consapevole, smetterà di annunciare che lui ha due papà. Che commedia sia questa, se questo è tutto il progresso in cui possiamo sperare, io non so. Dico solo una cosa ai dirigenti della Rai tivù: c’è un sacco di posto per la finzione, per la fantapolitica, per la finta realtà, per la pubblicità e la propaganda; evitate, per favore, di usare lo spazio delle notizie per raccontare certe storie. Prima ho detto “pretendo”, ma ho sbagliato, scusate, nei vostri confronti non ho diritti, pago il canone e ho l’obbligo di pagarlo in ogni caso.
*www.libreriadelledonne.it, 29 aprile 2018
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Due secoli di Marx. Un dio chiamato Capitale.2 maggio 2018, di Federico La Sala
Due secoli di Marx
Un dio chiamato Capitale
Non è stata l’economia politica il cuore della rivoluzione del grande pensatore. Ma l’Economico come categoria dello spirito. La vera potenza che mette all’opera il mondo
di Massimo Cacciari (l’espresso, 29.04.2018)
Tacete economisti e sociologi in munere alieno. Marx non è affare vostro, o soltanto di quelli di voi che ne comprendano la grandezza filosofica, anzi: teologico-filosofica. Marx sta tra i pensatori che riflettono sul destino dell’Occidente, tra gli ultimi a osare di affrontarne il senso della storia. In questo è paragonabile forse soltanto a Nietzsche. Ma “Il Capitale”, si dirà? Non è l’economia politica al centro della sua opera? No; è la critica dell’economia politica. Che vuol dire? Che l’Economico vale per Marx come figura dello Spirito, come espressione della nuova potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo. L’Economico è per Marx ciò che sarà la Tecnica per Heidegger: l’energia che informa di sé ogni forma di vita, che determina il Sistema complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un nuovo tipo di uomo. Nessuna struttura cui si aggiungerebbe una sovra-struttura a mo’ di inessenziale complemento - l’Economico è immanente in tutte le forme in cui l’agire e il pensare si determinano; ognuna di esse è parte necessaria dell’intero.
Marx è pensatore del Tutto, perfettamente fedele in questo al suo maestro Hegel. Il Sistema è più delle parti, irriducibile alla loro somma. Chi intende l’Economico come una struttura a sé, autonoma, che determinerebbe meccanicisticamente le altre, non ha capito nulla di Marx. Marx non è pensatore astratto, e cioè non astrae mai l’Economico dall’intero sistema delle relazioni sociali, culturali, politiche.
La sua domanda è: quale potenza oggi governa l’Intero e come concretamente essa si esprime in ogni elemento dell’Intero? L’Economico è infinitamente più che Economico. Esso rappresenta nel contemporaneo la potenza che mette all’opera il mondo.
 Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.
Il mondo della “morte di Dio”. Ogni opera deve essere valutata sul metro del lavoro produttivo di ricchezza e ogni uomo messo al lavoro per questo fine. Non è concesso “ozio”; nessuno può essere “lasciato in pace”. Il processo stesso di specializzazione del lavoro viene compreso in questo grandioso processo: più avanza la forma specialistica del lavoro, più l’Opera appare complessiva e distende il proprio spirito sull’intero pianeta; più il lavoro appare diviso, più in realtà esso funziona come un unico Sistema, dove ogni membro coopera, ne sia o meno consapevole, al fine universale dell’accumulazione e riproduzione. Fine che si realizza soltanto se al lavoro è posto prioritariamente il cervello umano. La vera forza del lavoro sta infatti nell’intelligenza che scopre, inventa, innova. La differenza tra teoretico e pratico si annulla nella potenza del cervello sociale, Intelletto Agente dell’intero genere, che si articola in lavori speciali soltanto per accrescere sempre più la propria universale potenza.Per Marx è questo il “nuovo mondo” che il sistema di produzione capitalistico crea, non certo dal nulla, ma certo sconvolgendo dalle radici forme di vita e relazioni sociali, insomma: l’ethos dell’Occidente, la “sede” in cui l’Occidente aveva ino ad allora abitato È il mondo dove il Logos della forma-merce si incarna in ogni aspetto della vita, per diventarne la religione stessa. E Marx ne esalta l’impeto rivoluzionario. È questo impeto che per lui va seguito, al suo interno è necessario collocarsi per comprenderne le contraddizioni e prevederne scientificamente l’aporia, e cioè dove la strada che esso ha aperto è destinata a interrompersi - per il salto a un altro mondo. Qui bisogna intendere bene: la contraddizione non viene da fuori, da qualcosa che sia “straniero” al Sistema.
Contraddittorio in sé è il capitalismo stesso. Il capitalismo è crisi, è fatto di crisi. Funziona per salti, che ogni volta mettono inevitabilmente in discussione gli equilibri raggiunti. Non vi è riproduzione senza innovazione. Questo è noto anche agli economisti.
 Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
Ma Marx aggiunge: il capitalismo è crisi perché si costituisce nella lotta tra soggetti antagonisti. Il capitale è la lotta tra capitalisti e classe operaia. In quanto forza-lavoro la classe operaia è elemento essenziale del capitale stesso - ma quell’elemento che ha la possibilità di assumere coscienza di sé e lottare contro la classe che detiene l’egemonia sull’intero processo, che lo governa per il proprio profitto, metro del proprio stesso potere.
 È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.
È anche e soprattutto in forza di questa intrinseca contraddizione che il capitalismo è innovazione continua, produzione di merci sempre nuove e produzione del loro stesso consumo (la produzione più importante, quest’ultima, dice Marx). Tuttavia, ecco la metamorfosi: proprio diventando cosciente di questa sua funzione la forza-lavoro si fa soggetto autonomo rispetto al capitale, autonomo rispetto al carattere rivoluzionario di quest’ultimo. La lotta di classe di cui parla Marx è lotta tra rivoluzionari. Vera guerra civile.Questa contraddizione muove tutto. E ognuno è imbarcato in essa. L’idea di poterne giudicare “dall’alto” costituisce per l’appunto quella ideologia, che Marx sottopone a critica in dalle prime opere. Se la realtà dell’epoca è contraddizione inscindibilmente economica e politica, ogni interpretazione che la riduca a fatti naturalisticamente analizzabili la mistifica. Non è possibile cogliere la realtà del Sistema che collocandosi in esso, e dunque collocandosi nella contraddizione. Soltanto in questa prospettiva l’Intero è afferrabile. Non si comprende la realtà del presente se non in prospettiva e perciò a partire da un punto di vista determinato. Impossibile oggi un sapere astrattamente neutrale. La pretesa all’avalutatività è falsamente scientifica; l’epoca costringe a prender-parte, all’aut-aut. A porsi in gioco, alla scommessa anche. Il momento, o il kairòs, della decisione politica viene cosi a far parte della stessa potenza dell’Economico, resta immanente in essa.
 È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.
È l’ideologia propria del pensiero liberale, per Marx, che cerca di convincere a una visione de-politicizzante dell’Economico, a separare Economico e Politico, conferendo appunto all’Economico l’aspetto di un sistema naturale di relazioni.Poiché concepisce la storia dell’Occidente come conflitto, e conflitto determinato dal suo carattere di classe, e poiché intende il presente alla luce dell’intrinseca contraddittorietà della stessa potenza rivoluzionaria del Sistema tecnico-economico, Marx pensa di aver posto saldamente sui piedi il pensiero dialettico dell’idealismo. Le epoche della Fenomenologia hegeliana dello Spirito non trovano conclusione in un Sapere assoluto che tutte accoglie e accorda, in una suprema Conciliazione, ma nella insuperabile contraddizione tra la potenza universale del Lavoro produttivo divenuto cosciente di sé e la sua appropriazione capitalistica. Si tratta di ben altro che di calcoli su valore e plusvalore.
 L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
L’analisi del meccanismo dello sfruttamento, tanto bombardata dagli economisti e da filosofi dilettanti, sarà pure la parte caduca della grande opera di Marx. Ciò che conta in essa è la questione: il prodotto di questa umanità al lavoro (e questo significa “classe operaia”, altro che semplice “operaismo”!), di questo cervello sociale che inventa e innova, appartiene a chi? Come se ne determina la distribuzione? Chi la comanda? Può la sua potenza rinunciare a esigere potere? E se essa funziona riducendo sempre più il lavoro necessario per unità di prodotto o di prestazione, non si dovrebbe pensare nella prospettiva di una liberazione tout-court da ogni forma di lavoro comandato?
 Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
Il comunismo risponde per Marx a queste domande. È l’idea della suprema conciliazione del soggetto col suo prodotto; il compito di superare nella prassi ogni estraneità. Comunismo significa la stessa “missione dell’uomo”. In questo senso, il capitalismo opera per il suo stesso superamento, poiché il suo sistema si fonda su quel cervello sociale-classe operaia che per “natura” è destinato a non sottostare ad alcun comando. Che deve diventare libero. Il comunismo è il Sistema della libertà.
 Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
Marx sembra non avvedersi che tale “risoluzione” dell’aporia del capitalismo riproduce esattamente la conclusione della Fenomenologia hegeliana e, forse ancor più, del Sistema della scienza di Fichte. Ed è l’idea di un potere assoluto sulla natura, in cui la “comunità degli Io” sottopone al proprio dominio tutto ciò che le appaia “privo di ragione”.
 La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
La quintessenziale volontà di potenza dell’uomo europeo ispira perciò in tutto anche Marx e la sua violenza rivoluzionaria. Marx appartiene all’Europa “rivoluzione permanente”, all’Europa “leone affamato” (Hegel). Il suicidio di questa Europa lungo il tragico Novecento spiega lo spegnersi dell’energia politica scaturita dal marxismo assai più di quelle colossali trasformazioni sociali e economiche che hanno segnato il declino del soggetto “classe operaia”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
RIPENSARE L’EUROPA!!! CHE COSA SIGNIFICA ESSERE "EU-ROPEUO". Per la rinascita dell’EUROPA, e dell’ITALIA. La buona-esortazione del BRASILE. Una "memoria"
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MISTICISMO. Uscire dallo Stato di minorità (superiorità).30 aprile 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MISTICISMO. Uscire dallo Stato di minorità (superiorità) ...
 LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.
LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
 IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".
IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- La critica radicale del presente: l’eredità di Marx (di Maurizio Viroli).28 aprile 2018, di Federico La Sala
La critica radicale del presente: l’eredità di Marx
di Maurizio Viroli (Il Fatto, 28.04.2018)
Non saprei dire quanti altri giovani della mia generazione misero in soffitta Karl Marx dopo aver letto l’articolo Esiste una teoria marxista dello Stato? che Norberto Bobbio pubblicò nel 1975 su Mondoperaio, e ripubblicò nel 1976 nel libro Quale socialismo?, ma sospetto siano stati molti.
La risposta di Bobbio era netta: negli scritti di Marx e di Friedrich Engels, “una vera e propria teoria socialistica dello Stato non esiste”. A nulla valsero le centinaia di pagine scritte dagli intellettuali ‘organici’, come si diceva allora, al Partito comunista per confutare Bobbio e salvare Marx. Se Marx non aveva fornito una teoria dello Stato, come poteva essere guida intellettuale di un partito che aspirava a guidare lo Stato democratico?
Messo da parte Marx, cercammo altri maestri che potessero aiutarci a credere nel socialismo senza essere marxisti. Trovammo per nostra fortuna Carlo Rosselli e il suo Socialismo liberale che proprio Bobbio aveva curato in una bella edizione Einaudi del 1973. La prima pagina di quel libro aveva il valore di una rivelazione o di una conferma di quanto già pensavamo, vale a dire che il limite maggiore della teoria sociale e politica di Marx era la pretesa (rafforzata e popolarizzata dal buon Friedrich Engels) di essere dottrina scientifica : “L’orgoglioso proposito di Marx fu quello di assicurare al socialismo una base scientifica, di trasformare il socialismo in una scienza, anzi nella scienza sociale per definizione [...] Doveva avverarsi, non poteva non avverarsi; e si sarebbe avverato non per opera di una immaginaria volontà libera degli uomini, ma di quelle forze trascendenti e dominanti gli uomini e i loro rapporti che sono le forze produttive nel loro incessante svilupparsi e progredire.”
Rosselli capì che il Manifesto del Partito comunista aveva immensa forza d’ispirazione perché era profezia travestita da scienza: “Quale pace, quale certezza dava il suo linguaggio profetico ai primi apostoli perseguitati! “
Ma già agli inizi del Novecento, dopo la disputa sul revisionismo aperta dal libro di Eduard Bernstein, uscito nel 1899 (che Laterza ha pubblicato in traduzione italiana nel 1974 con il titolo I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia), i più intelligenti giudicarono la scienza di Marx del tutto incapace di spiegare la realtà economica e sociale, e non trovarono più né conforto né guida nella profezia ormai irrigidita in stanche formule ripetute meccanicamente. Eppure, molte pagine di Marx, soprattutto del giovane Marx, offrono ancora, se le leggiamo senza i vecchi condizionamenti ideologici, elementi per una teoria dell’emancipazione sociale.
La lettera che Marx spedisce ad Arnold Ruge da Kreuznach, nel settembre del 1843, poi pubblicata nei Deutsch-Französische Jahrbücher del 1844, ad esempio, è un testo che ci insegna i lineamenti di una critica sociale e politica intransigente: “Costruire il futuro - scrive Marx - e trovare una ricetta valida perennemente non è affar nostro, ma è certo più evidente ciò che dobbiamo fare nel presente: la critica radicale di tutto l’esistente”. Critica radicale perché senza riguardi, senza paura né dei suoi risultati né del conflitto coi poteri attuali. E ci insegna che la lotta per la libertà e per la giustizia deve essere in primo luogo lavoro paziente di educazione delle coscienze: “Indi il nostro motto sarà: riforma della coscienza, non con dogmi, bensì con l’analisi della coscienza mistica, oscura a se stessa, in qualunque modo si presenti (religioso o politico)”.
L’emancipazione politica e sociale non era per il giovane Marx risultato di tendenze oggettive della storia, ma conquista di coscienze emancipate che sanno riscoprire il sogno o la profezia di giustizia che l’umanità ha coltivato in varie forme nella sua lunga storia: “così si vedrà che da tempo il mondo sogna una cosa, di cui deve solo aver la coscienza per averla realmente. Si vedrà che non si tratta di tracciare una linea fra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità non inizi un lavoro nuovo, bensì attui consapevolmente il suo antico lavoro”.
Nello stesso fascicolo (l’unico che vide la luce) Marx pubblicò anche un’Introduzione a Per la critica della Filosofia del diritto di Hegel, dove sostiene che il proletariato è la sola classe sociale che emancipando se stessa emancipa l’intera società e che la filosofia può trovare nel proletariato “le sue armi materiali”. La filosofia (ovvero gli intellettuali) è dunque la “testa di questa emancipazione”; “il suo cuore è il proletariato”. Due illusioni nobili, queste del giovane Marx, ma pur sempre illusioni.
Il proletariato, allora come oggi, è una classe oppressa e umiliata, ma resta una classe particolare che nella sua storia ha lottato e sofferto per finalità di emancipazione generale, ma ha anche sostenuto demagoghi autoritari. Attribuire al proletariato il semplice ruolo di cuore e forza materiale dello sforzo di emancipazione e agli intellettuali quello di cervello, significa aprire la strada, come la storia ha abbondantemente dimostrato, a freddi professionisti della rivoluzione e del governo, incapaci di condividere le sofferenze e le speranze degli oppressi e dunque pronti a diventare non compagni di lotta, ma nuovi dominatori.
In questo saggio, nato in un contesto segnato da appassionati dibattiti su religione e emancipazione sociale (ben documentato dalla recente biografia scritta da Gareth Stedman Jones, Karl Marx. Greatness and Illusion, Harvard University Press, 2016) Marx ha consegnato alla storia la sua celebre critica dell’alienazione religiosa: “L’uomo fa la religione, e non la religione l’uomo. [...] Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana non possiede una realtà vera. La lotta contro la religione è dunque mediatamente la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l’aroma spirituale. La miseria religiosa è insieme l’espressione della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo”. Sarebbe facile osservare che la religione, in particolare la religione cristiana, ha sostenuto importanti esperienze di liberazione politica e sociale.
Ma dalla critica alla religione, Marx trae due conclusioni di straordinario valore morale e politico: la prima consiste nel principio che “l’uomo è per l’uomo l’essere supremo”; la seconda nell’“imperativo categorico di rovesciare tutti i rapporti nei quali l’uomo è un essere degradato, assoggettato, abbandonato, spregevole”. Un principio e un imperativo da riscoprire in questo nostro tempo che ha completamente perso l’idea stessa, e anche la speranza, dell’emancipazione sociale.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Eugen Rosenstock-Huessy e il ruolo della prima persona. Chi è il numero uno? (di Damion Searls).6 aprile 2018, di Federico La Sala
Chi è il numero uno?
Eugen Rosenstock-Huessy e il ruolo della prima persona.
di Damion Searls (Il Tascabile, 03.04.2018) *
Può essere sconvolgente rendersi conto, all’improvviso, che qualcosa a cui non avevi mai pensato - qualcosa che avevi sempre accettato come reale - è solo un articolo di fede. Spesso è il linguaggio a far accendere la lampadina: qualcuno ridefinisce la realtà con una nuova parola (mansplaining, Rebecca Solnit) o mostrando i poteri nascosti e le interconnessioni di una parola antica (debito, David Graeber). Raramente la rivelazione riguarda il linguaggio in sé.
- Tra tutti i dogmi dell’antichità classica, solo la grammatica non ha perso terreno. La geometria Euclidea, l’astronomia Tolemaica, la medicina Galenica, la legge Romana, la dottrina Cristiana - tutte sono state radicalmente smantellate dalle Scuole. Ma ancora oggi, la grammatica Alessandrina continua a regnare.
La citazione è di Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973), un teorico del Cristianesimo dell’età moderna molto particolare. (Tutte le traduzioni sono dal volume The Language of the Human Race: An Incarnate Grammar in Four Parts [Die Sprache des Menschengeschlechts: Eine leibhafte Grammatik in vier Teilen].) Rosenstock-Huessy ha ispirato alcuni connoisseur, tra cui W. H. Auden e Peter Sloterdijk, ma possiamo dire in tutta tranquillità che è ancora poco conosciuto. È difficile capire cosa pensare di lui. Di sicuro trovo fastidiosa la palese importanza della nascita di Cristo - o della Missione Divina - che inserisce regolarmente nei suoi ragionamenti filosofici. (Auden: “Chi lo legge per la prima volta può trovare, come è capitato a me, certi aspetti della sua scrittura un po’ difficili da accettare... Per quanto mi riguarda, posso solo dire che ascoltando Rosenstock-Huessy, io sono cambiato”). Il dogma grammaticale a cui fa riferimento - e contro cui si è battuto a morte in un libro di oltre 1.900 pagine - è la lista all’apparenza innocente che risale ai Greci: la prima persona, la seconda persona, la terza persona. Io amo, tu ami, egli ama, o, se avete studiato Latino, amo, amas, amat.
- “Tutti impariamo le lingue seguendo quelle liste. Cosa possono avere di tanto significativo? ...Nell’ordine Alessandrino, ogni persona è soggetta alla stessa trafila. Ogni persona sembra parlare allo stesso modo. Da qui ha origine l’errore fatale. Tanta della nostra confusione sui rapporti sociali e tanta della nostra ignoranza sul linguaggio può derivare direttamente da questo singolo errore. Mettere in fila amo, amas, amat, amamus, ecc, dà adito all’impressione che tutti questi “giudizi” possano e debbano essere trattati con lo stesso significato interpersonale. L’effetto, su chiunque impari questa sequenza, è l’idea che ogni frase all’indicativo sia pronunciata con lo stesso livello di “passione”. La mia rivendicazione è che amat e amo e amas sono agli antipodi, da un punto di vista sociale, e che quindi non debbano essere insegnati come simili. La lista Alessandrina non è affidabile.”
Non sta dicendo che dovremmo aggiungere una forma per la “quarta persona”, come per esempio la distinzione tra terze persone in Ojibwe, oppure una “persona zero” per le costruzioni impersonali come in Finlandese. Sta dicendo che rendere “io” la prima persona è il peccato originale non solo della linguistica, ma della filosofia, della scienza e della stessa vita sociale. E lo intende davvero. Teoricamente, appiattisce l’esperienza vissuta in resoconti freddi e asettici, assimilando tutto all’“affermazione” di un “dato” in terza persona che non richiede alcun coraggio personale, non ha alcuna rilevanza sociale.
- Amat è pronunciato come un fatto, senza nessun coinvolgimento interiore. Dà delle informazioni su qualcosa. Amo e amas, al contrario, non possono essere pronunciati senza conseguenze sociali importanti. Amo è un’ammissione, confessa un segreto. Amas dichiara qualcosa. Entrambi presuppongono passione, e quindi dobbiamo studiare che cosa significano passione ed enfasi in quanto elementi sociali della grammatica.
Empiricamente, la lista Greca commette un errore: la “prima persona” infatti non arriva per prima. L’io di un bambino si sviluppa quando gli viene rivolta la parola, da un genitore o da un’altra persona che si prende cura di lui. Qualcuno deve dire “tu” nel modo giusto perché un “io” non folle possa di fatto esistere. (Vedi Neither Sun Nor Death di Peter Sloterdijk, p. 30, dove ho sentito parlare di Rosenstock-Huessy per la prima volta). Dal punto di vista psicologico, neurocognitivo e dello sviluppo, “io” è l’ultima persona. Sei un bravo bambino. La bottiglia è lì. Ho fame.
- “Tutte le nostre esperienze insegnano esattamente l’opposto di questa dottrina greca rispetto al primato dell’“io” individuale! Il bambino inizia a definirsi gradualmente come un essere indipendente in seguito alle migliaia di attenzioni e impressioni e influssi che lo avvolgono, lo circondano, lo premono da ogni parte. La prima cosa che scopre è di non essere il mondo, né la madre o il padre, né Dio, ma qualcosa d’altro.
 La prima cosa che succede a ogni bambino, a ogni persona, è che gli o le si rivolge la parola: gli si sorride, gli si domanda qualcosa, gli si dà qualcosa, si culla, si conforta, si punisce, si nutre. Il bambino è prima un Tu per un essere esterno potente, soprattutto i genitori... Sentire che esistiamo per gli altri, che vogliono qualcosa da noi, precede qualsiasi affermazione che noi siamo noi o qualsiasi affermazione di che cosa siamo. Ricevere ordini ed essere giudicati dall’esterno è quello che ci dà consapevolezza di noi stessi.”
La prima cosa che succede a ogni bambino, a ogni persona, è che gli o le si rivolge la parola: gli si sorride, gli si domanda qualcosa, gli si dà qualcosa, si culla, si conforta, si punisce, si nutre. Il bambino è prima un Tu per un essere esterno potente, soprattutto i genitori... Sentire che esistiamo per gli altri, che vogliono qualcosa da noi, precede qualsiasi affermazione che noi siamo noi o qualsiasi affermazione di che cosa siamo. Ricevere ordini ed essere giudicati dall’esterno è quello che ci dà consapevolezza di noi stessi.”
È questa la rivelazione che mi ha tanto colpito. La prima persona non è la prima. Non esiste nessuna lista, a parte quelle che inventiamo. Che aspetto avrebbe il mondo se potessi vedere al di fuori di questo schema? Se prima venisse un legame tanto forte da darti l’autorità di giudicare l’esperienza di qualcun altro - tu ami, tu hai fame, sei carino oggi, ti stai comportando male - e poi venisse una visione condivisa del mondo, e solo successivamente un’espressione di sé? L’idea Cartesiana, “penso dunque sono”, e tutte le distinzioni tra mente/corpo/io/altro avrebbero potuto non emergere mai se Cartesio non fosse stato indottrinato con l’idea che “io” viene per primo. Esistono romanzi in prima e in terza persona, ma la seconda è un’anomalia, proprio come nella vita reale non possiamo prenderci la libertà di parlare per una seconda persona come faremmo di noi stessi in quest’era dell’espressione di sé. Quanto altro ancora della natura del romanzo, e della percezione della mia vita, risale essenzialmente alla grammatica greca di duemila anni fa?
- Nella nostra società moderna, amo e amas sono trattati alla stregua di semplici affermazioni come amat. E la spudoratezza della psicologia, delle classificazioni sociali, della tirannia dei fisici e degli analisti, sono alcuni dei risultati di questa mancanza di saggezza e autorità nello schema grammaticale. Ognuno è portato a pensare a se stesso o se stessa come parte di una sequenza di fatti, come se lui o lei fossero una Terza Persona.
Vale la pena notare che scrisse questi pensieri sulla tirannia nel 1945. E che l’uso del “lui o lei”, ben avanti sui tempi, è suo.
- “Questo fa poggiare i rapporti umani su una falsa base, una base obiettiva, che li svilisce. Perché parliamo in modo obiettivo di chi è assente e quindi non arrossirà per quello che diciamo o non si arrabbierà o in ogni caso non dovrà stare ad ascoltare. I rapporti umani prosperano quando possiamo conservare un legame segreto e un desiderio intimo di ascoltare. I rapporti umani muoiono quando tutte le nostre affermazioni si riducono a un semplice dato di fatto. Perché a quel punto ci stiamo solo insultando l’un l’altro. L’esercito, le fabbriche, le scuole, gli ospedali - insultano così spesso.”
Rosenstock-Huessy fa risalire tutto a questo peccato, dai conflitti con l’autorità a scuola alla schizofrenia, e avanza delle rivendicazioni impressionanti per un proprio “metodo grammaticale” che riconfiguri il linguaggio. Come dicevo, non so cosa pensare al riguardo. Ma è qui, presentato per voi sotto forma di paragrafi alternati da me e da lui. Voi siete la prima persona. Fatene quello che volete.
- “Possiamo studiare la grammatica avanzata così come si studia la matematica avanzata. Quando ancora bruciavamo le streghe sul rogo, la matematica avanzata ci ha guariti illuminando l’universo in modo così completo da non lasciare più spazio alle streghe. La matematica avanzata, abbracciando l’infinito, ci ha permesso di carpire i segreti della massa e dell’energia, del tempo naturale e dello spazio. Il mondo non è più magico e stregato. Il suo ordine atomico è diventato trasparente, con l’aiuto della matematica avanzata. Una grammatica avanzata, che si occupi del tipo di enfasi che il discorso pone sulle nostre parole e sulle nostre azioni, ci permetterebbe di carpire i segreti dei movimenti sociali, delle masse e degli individui, delle patologie e della guarigione della vita politica. La grammatica base ha degradato il linguaggio fino a renderlo uno strumento arbitrario dello spirito umano; la grammatica avanzata lo aggiusterà.”
 Traduzione di Alessandra Castellazzi. Si ringraziano l’autore e The Paris Review per la pubblicazione dell’articolo.
Traduzione di Alessandra Castellazzi. Si ringraziano l’autore e The Paris Review per la pubblicazione dell’articolo.* Damion Searls traduce dal tedesco, dal norvegese, dal francese e dall’olandese. Ha tradotto classici come Proust, Rilke, Nietzsche, e Ingeborg Bachmann. Il suo ultimo libro è Macchie d’inchiostro - Storia di Hermann Rorschach e del suo test.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Eugen Rosenstock-Huessy: un pensatore impuro (di Filiberto Battistin).6 aprile 2018, di Federico La Sala
Eugen Rosenstock-Huessy: un pensatore impuro
di Filiberto Battistin *
Eugen Rosenstock-Huessy (1888 - 1973) è pensatore pressoché sconosciuto in Italia. Eppure è stato uno dei protagonisti, insieme a Franz Rosenzweig, Martin Buber, Karl Barth del nobile tentativo di offrire nella Germania degli inizi del Novecento, una prospettiva filosofica e religiosa, fondata sul riconoscimento dell’Altro, capace di porsi come alternativa al positivismo, all’idealismo e allo storicismo dominanti nel mondo accademico tedesco.
Tutti questi pensatori avevano, con spirito profetico, intuito che la filosofia della “ragione pura” non sarebbe stata in grado di opporsi alla barbarie del nazismo, in quanto tale dottrina sostiene una visione semplificata e mutilata dell’umanità: l’uomo non è solo puro pensiero, ma carne, cuore, passioni e sentimenti.
Se l’uomo nella sua interezza non viene vivificato dalla Parola di Dio - “Amerai il prossimo tuo come te stesso” -, diventa facilmente preda di ideologie politiche secolarizzate, che facendo perno sui miti del sangue, della razza, della nazione, si impadroniscono del cuore degli uomini, trasformandoli in micidiali strumenti di guerra e di morte. “Tutti gli uomini uccidono, perché i viventi sono obbligati a scannarsi a vicenda, per sopravvivere. E tutti gli uomini muoiono. Allora lo stesso svolgersi della storia non sarebbe potuto accadere, se contro la morte non fosse stato creato alcun rimedio.
La storia della specie umana è per questo motivo composta da un unico tema: come rendere l’amore più forte della morte?” (Rosenstock - Huessy, La trasformazione della Parola di Dio nel linguaggio dell’umanità). In tal senso, la vita di Eugen è stata determinata dalla sua partecipazione come ufficiale dell’esercito tedesco alla prima guerra mondiale, e, più precisamente, dall’aver vissuto in prima persona l’evento più tragico del conflitto, la battaglia di Verdun, che costò la vita a più di ottocento mila soldati nel corso di un anno di feroci combattimenti.
Rosenstock, di famiglia ebraica, ma convertito in giovane età al cristianesimo, esce dal conflitto scosso nelle fondamenta del suo essere, ma con la ferma convinzione che suo dovere di uomo e di cristiano è di impiegare tutte le sue energie per “rendere l’amore più forte della morte”, e ritiene che questo compito richieda in primo luogo l’educazione degli uomini, perché la filosofia è educazione e l’educazione è filosofia, e la vera filosofia è amore per la sopravvivenza materiale e spirituale dell’umanità.
“Filosofi” sono tutti gli uomini di buona volontà che operano per realizzare la pace fra gli uomini e le nazioni. Rosenstock, di conseguenza, non si chiude nel mondo ovattato dell’accademia, ma è uno dei pionieri dell’educazione permanente degli adulti sul territorio.
Sebbene non sia marxista, Rosenstock viene invitato dal Partito Social-Democratico Tedesco a fondare e a dirigere nel 1921 l’Akademie der Arbeit, che offriva agli operai tedeschi corsi e seminari. E’ importante ricordare che alcuni dei lavoratori che parteciparono ai seminari tenuti da Rosenstock saranno protagonisti di un nobile tentativo di resistenza attiva contro il nazismo, che pagheranno con il sacrificio delle loro vite.
Nel 1933, dopo l’avvento al potere di Hitler, Rosenstock emigrò negli Stati Uniti, che divennero la sua seconda patria; anche in America, Eugen continua la sua attività di educazione degli adulti, con la ferma fiducia che lavoratori e pensatori debbano condividere le loro esperienze di sapere.
Due sono i centri attorno ai quali si sviluppa la sua instancabile attività di pensiero: il linguaggio e la storia. Il grande miracolo che sta all’origine della creazione è il linguaggio, che è la struttura fondante le relazione tra Dio e uomo, tra uomo e natura e fra gli uomini all’interno di una comunità. L’autentico linguaggio nasce dall’Ascolto: non si può parlare se prima non si è ascoltato: solo allora il linguaggio diventa risposta che implica responsabilità amorosa nei confronti di tutti i viventi. In tal senso, secondo Rosenstock, è possibile riassumere il cammino dell’uomo occidentale negli ultimi mille anni della sua storia, in tre formule:
 “Credo ut intelligam”, credo per comprendere
“Credo ut intelligam”, credo per comprendere
 “Cogito ergo sum”, penso dunque sono
“Cogito ergo sum”, penso dunque sono
 “Respondeo etsi mutabor”, Rispondo sebbene cambierò
“Respondeo etsi mutabor”, Rispondo sebbene cambieròLa prima formula esprime il modo di vivere dell’uomo medioevale, che si pone sì sul piano dell’Ascolto, ma finisce con l’irrigidirsi e con il negare il mutamento: l’esito tragico è l’Inquisizione.
La formula cartesiana, che ha dato origine alla modernità, si pone al di fuori della dimensione dell’Ascolto, e afferma l’assoluta indipendenza, autonomia, autosufficienza dell’Io dell’uomo ridotto a pura ragione. Il mondo cartesiano, secondo Rosenstock, fa naufragio nella prima guerra mondiale. Per questo motivo è necessario entrare in una nuova dimensione dell’umanità, che Rosenstock sintetizza con la terza formula: l’umanità deve rimanere fedele alla Parola, nella piena consapevolezza che “tutto scorre”, che la vita è continuo e necessario movimento. Ti rispondo, assumo la mia responsabilità, ma so che cambierò, che dovrò cambiare perché soltanto cambiando potrò rimanerti fedele. La fedeltà, infatti, richiede la capacità di trovare ogni giorno una nuova risposta e il futuro è lo spazio ancora vuoto che spetta a ciascuno di noi riempire con un agire fedele alla verità.
In tal senso, il suo capolavoro è il libro pubblicato nel 1938 “Out of Revolution. Autobiography of Western Man”, nel quale Rosenstock mostra come il concetto di Rivoluzione sia il grimaldello per comprendere la storia dell’uomo occidentale. L’idea di Rivoluzione diventa distruttiva e porta al disfacimento dell’umanità, quando ha la pretesa di creare “nuovi mondi” e “nuovi uomini” senza più porsi in Ascolto della Parola originaria della creazione e con le precedenti Rivoluzioni che l’hanno interpretata nel corso del tempo.
Il “lealista-rivoluzionario” è l’uomo che vive rimanendo fedele alla Parola originaria: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”.
* Fonte: http://www.nicolasaba.it/, n. 22, settembre 2012.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Dalla parte della storia: "Il giovane Karl Marx". Note sul film di Raoul Peck (di A. Illuminati e di P. Bianchi).5 aprile 2018, di Federico La Sala
Il giovane Marx. Come si diventa rivoluzionari
Esce sugli schermi italiani in questi giorni di aprile il film di Raoul Peck sulla turbolenta giovinezza di Karl Marx e il suo decisivo incontro con Friedrich Engels: tutto nel segno del “comune” dalla polemica sui furti di legna alla stesura del Manifesto
di Augusto Illuminati (Dinamo Press, Cult, 5 aprile 2018)
Il bel film (2017) del regista haitiano, autore di Lumumba (2000) e I Am Not Your Negro (2016), tratta gli anni giovanili di Marx (Augusto Diehl) ed Engels (Stefan Konarske) e delle loro compagne, l’aristocratica Jenny von Westphalen (Vicki Krieps) e l’operaia irlandese Mary Burns (Hannah Steele) - dai primi articoli marxiani del 1842-1843 sulla “Rheinische Zeitung” di Colonia e sui “Deutsch-franzősische Jahrbücher” editi da A. Ruge a Parigi fino alla stesura a quattro mani del Manifesto del partito comunista nel 1847-1848, passando per tutte le peripezie degli anni di Parigi, Bruxelles, Londra: espulsioni, censure, polemiche, congressi fondativi, scissioni e vicende familiari.
Peck, che è anche sceneggiatore insieme a P. Bonitzer e P. Hodgson, non tratta Marx ed Engels come “personaggi concettuali” - riservando tale veste piuttosto al “comunismo” nelle sue varie e contraddittorie declinazioni (dal “furto” di legna iniziale all’umanitarismo della Lega dei Giusti, dalle astrazioni proudhoniane alle pratiche di lotta operaia e alla definizione del Manifesto) - ma ne restituisce un’immagine pubblica e privata molto sciolta e bohémienne, mostrandoli come esponenti di una controcultura romantica in via di rapida politicizzazione.
 Tale era infatti la cerchia dei giovani hegeliani e dei loro corrispondenti europei. Approccio che risalta nei dettagli aneddotici - la ribellione contro la censura prussiana, le fughe dai controlli polizieschi di Guizot, la partita a scacchi di Marx con Courbet, le turbolente riunioni nelle osterie del Fbg. Saint-Antoine, le incursioni dell’innamorato Engels nei bassifondi di Manchester, il sogno schilleriano in cui i contadini della Mosella rimossi dagli usi civici ritornano in sogno come briganti alla notizia dell’attentato a re di Prussia - e naturalmente colorisce anche i rapporti dei due protagonisti con le donne, segnandoli in modo diverso.
Tale era infatti la cerchia dei giovani hegeliani e dei loro corrispondenti europei. Approccio che risalta nei dettagli aneddotici - la ribellione contro la censura prussiana, le fughe dai controlli polizieschi di Guizot, la partita a scacchi di Marx con Courbet, le turbolente riunioni nelle osterie del Fbg. Saint-Antoine, le incursioni dell’innamorato Engels nei bassifondi di Manchester, il sogno schilleriano in cui i contadini della Mosella rimossi dagli usi civici ritornano in sogno come briganti alla notizia dell’attentato a re di Prussia - e naturalmente colorisce anche i rapporti dei due protagonisti con le donne, segnandoli in modo diverso.Qui subentra un elemento più analitico e sostanziale, così come nel rapporto fra le due donne, la moglie Jenny e la compagna Mary - che implica in sottinteso anche quello fra Jenny e la fedele cameriera e altro, Lenchen, abbreviativo di Helene Demuth.
Entrambe le donne (e pure Lenchen) furono prodighe non solo di cure ma anche di informazioni e consigli politici ai due redattori del Manifesto e il ruolo di Mary nell’ideazione stessa nel 1845 della Situazione della classe operaia in Inghilterra di Engels (fondamentale per la svolta di Marx dalla filosofia all’economia) è stata ampiamente riconosciuto, in primo luogo dallo stesso autore. Engels non mancò di tributare un elogio, nel 1890 in occasione dei funerali, anche al contributo di Lenchen, che aveva preso in casa dopo la morte di Marx. Per di più, nel 1851, aveva riconosciuto come proprio il figlio che Lenchen aveva avuto da Marx, Freddy rinnegato per non rovinare con uno scandalo l’armonia e il prestigio familiare...
Nel film la complicità fra Jenny e Lenchen addolcisce una brutta storia patriarcale, così come vengono forse migliorati i rapporti fra Karl e Mary, occultando l’egoismo marxiano, che si manifestò in modo penoso alla notizia della morte di Mary - ben oltre i limiti cronologici del film. Che in compenso insiste molto anche sui suggerimenti di Jenny, omaggio di stagione al femminismo su una materia che certamente Marx si guardò bene dal documentare. -Nel grande dialogo d’invenzione sulla spiaggia di Ostenda fra Jenny e Mary, la prima esprime una prospettiva tradizionale su figli e famiglia, mentre la seconda rivendica il suo diritto alla libertà da quei vincoli e vuole restare povera come è nata per essere rivoluzionaria (la prima, invece, accetta di impoverirsi per amore di Karl).
Passano sullo schermo Ruge, Hess, il sarto Weitling, profeta della fratellanza mistica della Lega dei Giusti, Proudhon, Bakunin e tanti altri, vediamo la fabbrica della famiglia Engels che è insieme la fonte di reddito di Marx e il modello reale della sua teoria economica - decisiva fu infatti la spinta di Friedrich per far passare Karl dalla critica filosofica della società e dello stato alla critica dell’economia politica borghese. Das Kapital restituisce gli esborsi di capitali dell’amico e compensa storicamente (non individualmente) la parte egocentrica e convenzionale della personalità dell’autore.
Nel film il passaggio decisivo (l’effetto Manchester, l’effetto Friedrich e Mary) è il congresso del giugno 1847, quando Marx ed Engels trasformano a forza la Lega dei Giusti in Lega dei Comunisti, di cui il Manifesto sarà il programma. Non più fratellanza egualitaria ma rapporti di produzione e lotta di classe, non più “umanità” ma “proletariato”: comunismo è il movimento reale che sopprime lo stato di cose esistenti e dunque si rinnova ogni volta contro ogni stato di cose, contro ogni processo di accumulazione per recinzione del comune ed estrazione del valore dalla cooperazione sociale. Da allora a oggi, mai ripetendosi. Dunque si passa dai volti dei proletari d’epoca alle scene delle lotte del Novecento su scala mondiale, mentre in colonna sonora, dopo le citazioni salienti del Manifesto e i titoli di coda, scorre il dylaniano Like a Rolling Stone, un susseguirsi sempre aperto, di rimbalzo in rimbalzo, delle immagini di Vietnam, ’68, Allende, Mandela, riots Usa, Lumumba, Guevara...
Dalla parte della storia
La giovinezza di Marx ed Engels, raccontata in un film solo all’apparenza biografico, ma che si concentra sulla congiuntura per mostrare il punto singolare dell’emergenza di una storia, individuale e collettiva
di Pietro Bianchi (Dinamo Press, Cult, 5 aprile 2018)
Bruxelles, 1848, ovvero il momento in cui Karl Marx e Friedrich Engels scrivono il manifesto del Partito Comunista. È così che finisce Il giovane Karl Marx di Raoul Peck: un biopic atipico, sentimentale, fatto da un regista haitiano tra i più intelligentemente politici degli ultimi anni e che riprende giusto una manciata di anni nella vita di Marx durante gli anni Quaranta dell’Ottocento fino appunto alla redazione del più famoso manifesto programmatico della storia moderna.
Fare un film su una figura così ingombrante come Marx è un progetto che metterebbe paura a chiunque (Ėjzenštejn, per dire, non c’era riuscito) eppure Raoul Peck riesce a passare dalla porta stretta che vi è tra la fedeltà alla ricostruzione storica (il racconto è molto più meticoloso, anche nei dettagli secondari, di quanto ci si potrebbe attendere da una produzione del genere) e un racconto di estrema semplicità e efficacia su un giovane intellettuale e militante che attraversa uno dei momenti cruciali della storia europea. L’idea è proprio quella di togliere a Marx quelle sembianze da icona che ci sono state tramandate dalla celebre fotografia con la barba lunga e di ricollocarlo invece nella contingenza della storia.
 Ecco che allora Marx e Engels - il centro del film è la storia della loro amicizia - sono due giovani bohémiens che passano da Parigi a Londra, da Bruxelles alla Germania per organizzare e conoscere quel proletariato che per la prima volta si era affacciato in quegli anni sulla scena della storia e stava cambiando definitivamente la realtà che si aveva di fronte agli occhi. Ma nel film non ci sono solo le fabbriche di Manchester o le assemblee della Lega dei Giusti, i dibattiti con Proudhon e quelli con Wilhelm Weitling: ci sono anche i bar frequentati dagli operai tra risse e fiumi di alcol, le burrascose relazioni sentimentali e le improvvise colluttazioni con le autorità di giustizia.
Ecco che allora Marx e Engels - il centro del film è la storia della loro amicizia - sono due giovani bohémiens che passano da Parigi a Londra, da Bruxelles alla Germania per organizzare e conoscere quel proletariato che per la prima volta si era affacciato in quegli anni sulla scena della storia e stava cambiando definitivamente la realtà che si aveva di fronte agli occhi. Ma nel film non ci sono solo le fabbriche di Manchester o le assemblee della Lega dei Giusti, i dibattiti con Proudhon e quelli con Wilhelm Weitling: ci sono anche i bar frequentati dagli operai tra risse e fiumi di alcol, le burrascose relazioni sentimentali e le improvvise colluttazioni con le autorità di giustizia.Perché come è stato scritto da Lorenzo Rossi su Cineforum il rischio di un film che vuole rappresentare dei personaggi tanto rilevanti dal punto di vista storico è quello di pensare che abbiano avuto una sorta di incontro inevitabile con il proprio destino. È il tipico inganno di vedere le cose après-coup, a partire dai loro effetti: ed ecco che allora l’impressione che abbiamo è che quello che è accaduto non poteva non accadere. Se noi però portiamo il nostro sguardo sul presente della scelta - come avviene in questo film - le cose acquistano un aspetto molto diverso, perché tutto “sarebbe potuto essere diverso da quello che poi è stato”.
 Vedere allora Marx seduto a un tavolo che scrive “un fantasma si aggira per l’Europa” ha l’effetto non tanto celebrativo di illustrare un momento che poi si rivelerà storico, quanto quello di far vedere che la storia si costruisce sempre a partire da una radicale contingenza. Insomma, le cose sarebbero anche potute andare diversamente e in ogni singolo momento la scelta si è sempre compiuta sullo sfondo di una sospensione radicale di ogni garanzia o necessità. Ecco che allora lo sguardo che Peck ci spinge ad adottare non è quello di chi ha costruito la storia perché “non poteva che andare così”, ma di chi è stato in grado di farlo solo perché vi era immerso completamente.
Vedere allora Marx seduto a un tavolo che scrive “un fantasma si aggira per l’Europa” ha l’effetto non tanto celebrativo di illustrare un momento che poi si rivelerà storico, quanto quello di far vedere che la storia si costruisce sempre a partire da una radicale contingenza. Insomma, le cose sarebbero anche potute andare diversamente e in ogni singolo momento la scelta si è sempre compiuta sullo sfondo di una sospensione radicale di ogni garanzia o necessità. Ecco che allora lo sguardo che Peck ci spinge ad adottare non è quello di chi ha costruito la storia perché “non poteva che andare così”, ma di chi è stato in grado di farlo solo perché vi era immerso completamente.È per questo che Il giovane Karl Marx è un film tanto riuscito, nonostante la difficile restituzione della ricchezza del dibattito filosofico di quegli anni (che rimane quasi sempre sullo sfondo), nonostante il “vero” Marx - quello che ha davvero innovato la modernità con un’analisi inedita nel metodo e nel merito del modo di produzione capitalistico - inizi soltanto dopo il 1848, quando cioè il film finisce. Nel film quello che emerge è molto più semplicemente il fatto che Marx e Engels volessero qualcosa che andasse oltre a una prospettiva blandamente egualitaria di fratellanza tra gli uomini, come veniva espressa ne La lega dei Giusti (organizzazione socialista-utopista di cui il film ricostruisce splendidamente il momento del Congresso del giugno 1847 in cui cambia il nome in Lega dei Comunisti) e che il comunismo dovesse porre il problema di un soggetto sociale che per la prima volta mostrava nella storia i paradossi e i limiti dell’egualitarismo borghese: il proletariato.
 Alla fine, quando la lettura di alcuni passi de Il Manifesto del Partito Comunista si sovrappone a dei tableau vivant di proletari del 1848 che guardano in macchina, il film termina con uno splendido cartello che dice quella che è forse la verità più decisiva del film: Marx dopo il 1848 inizia a lavorare alla sua opera più importante, Il Capitale, che rimarrà incompiuta, proprio perché l’oggetto di cui si occupa è costantemente in movimento nella storia.
Alla fine, quando la lettura di alcuni passi de Il Manifesto del Partito Comunista si sovrappone a dei tableau vivant di proletari del 1848 che guardano in macchina, il film termina con uno splendido cartello che dice quella che è forse la verità più decisiva del film: Marx dopo il 1848 inizia a lavorare alla sua opera più importante, Il Capitale, che rimarrà incompiuta, proprio perché l’oggetto di cui si occupa è costantemente in movimento nella storia.
 L’opera di Marx insomma non è una dottrina, ma un’opera aperta, e ciò che Il giovane Karl Marx ci spinge a fare è di non ridurre la vita Marx a un’agiografia ma di essere fedeli allo spirito della sua vita: cioè, pensare quell’oggetto storico che chiamiamo capitalismo non con la freddezza e il distacco del ricercatore, ma con la partecipazione di qualcuno che sa che di quella storia è inevitabilmente parte.
L’opera di Marx insomma non è una dottrina, ma un’opera aperta, e ciò che Il giovane Karl Marx ci spinge a fare è di non ridurre la vita Marx a un’agiografia ma di essere fedeli allo spirito della sua vita: cioè, pensare quell’oggetto storico che chiamiamo capitalismo non con la freddezza e il distacco del ricercatore, ma con la partecipazione di qualcuno che sa che di quella storia è inevitabilmente parte.__________________________________________________________________________________
Sul tema, nel sito, si cfr.:
"SCORPIONE E FELICE". RIDENDO E SCHERZANDO, MARX TROVA "LA PIETRA FILOSOFALE" DEL SUO CAMMINO.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. - Freud, Lacan, e il tratto “femminista” della psicoanalisi: i "Ritratti del desiderio" (di M- Recalcati)27 marzo 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..... *
Inconscio ergo sumChi dice che è morta? Prima che terapeutica l’invenzione freudiana è una rivoluzione etica. E la scommessa più ardita si chiama “desiderio”. Da assecondare così
di Massimo Recalcati (la Repubblica, Robinson, 25.03.2018)
- Il libro. Ritratti del desiderio di Massimo Recalcati (172 pagine, 14 euro, con le fotografie di Giancarlo Fabbri) è pubblicato da Raffaello Cortina Editore. E’ uscita da pochi giorni una ristampa con una nuova prefazione dell’autore
Che cosa resta della grande lezione di Freud? Cosa resiste della esperienza sovversiva dell’inconscio? Cosa della grande rivoluzione culturale rappresentata dalla psicoanalisi è destinato a non essere cancellato? Il progresso delle neuroscienze, l’affermazione delle psicoterapie cognitivo-comportamentali, la potenza chimica dello psicofarmaco, la promessa di terapie brevi ed efficaci centrate sul cosiddetto “ sintomo bersaglio”, sembra abbiamo messo definitivamente all’angolo la psicoanalisi riducendola a uno spettro condannato a circolare solo nel museo delle cere del Novecento. Lo si grida da più parti e ormai da molto tempo: la psicoanalisi è morta, le sue categorie teoriche irrimediabilmente compromesse da un irrazionalismo di fondo che rifiuta di confrontarsi con la valutazione scientifica, la sua efficacia terapeutica dubbia, la proverbiale lunghezza delle sue cure assolutamente sfasata rispetto al ritmo performativo richiesto dallo spirito del nostro tempo e indice di una fumisteria epistemologica e clinica priva di fondamenti.
Perché allora dovremmo insistere nel difendere tenacemente l’invenzione di Freud? Il nucleo di questa invenzione è etico prima che terapeutico. Se il Novecento è stato il secolo del sacrificio della singolarità schiacciata sotto il peso inumano dell’universale ideologico della Causa, la teoria e la pratica della psicoanalisi, sin dalla sua origine, si è posta al servizio del carattere insacrificabile della singolarità. Non certamente della natura borghese dell’Io o dell’individualismo liberista, ma di quella singolarità assai più ampia che sconfina in zone dell’essere che eccedono la coscienza e la sua illusione (cartesiana) di padronanza. La singolarità irregolare e anarchica dell’inconscio impone infatti di ripensare innanzitutto il concetto stesso di identità. Certamente questo riguarda la sessualità umana che Freud rivela essere sempre parzialmente contaminata da quella infantile e pregenitale come se non esistesse una sessualità cosiddetta “matura”, “genitale”, perché essa vive e si nutre di fantasmi che provengono dalle esperienze infantili del corpo pulsionale.
 Ma la prima vera e grande sovversione etica imposta da Freud è quella che ci costringe a modificare la nostra ordinaria concezione della malattia e della sofferenza psichica. Questo è un contributo ancora attualissimo e nevralgico della psicoanalisi: l’eccessivo compattamento identitario del soggetto non è una virtù da salvaguardare, ma è la vera malattia da curare. La divisione multipla interna al soggetto - tra coscienza, preconscio e inconscio, tra Es, Io e Super- io - ci costringe infatti a ridisegnare la nostra idea della vita umana. L’Io non è mai padrone in casa propria: l’alterità non è innanzitutto esperienza dello straniero che viene dal di fuori, ma del nostro stesso essere, della nostra più propria intimità.
Ma la prima vera e grande sovversione etica imposta da Freud è quella che ci costringe a modificare la nostra ordinaria concezione della malattia e della sofferenza psichica. Questo è un contributo ancora attualissimo e nevralgico della psicoanalisi: l’eccessivo compattamento identitario del soggetto non è una virtù da salvaguardare, ma è la vera malattia da curare. La divisione multipla interna al soggetto - tra coscienza, preconscio e inconscio, tra Es, Io e Super- io - ci costringe infatti a ridisegnare la nostra idea della vita umana. L’Io non è mai padrone in casa propria: l’alterità non è innanzitutto esperienza dello straniero che viene dal di fuori, ma del nostro stesso essere, della nostra più propria intimità.
 L’inconscio freudiano è infatti “uno stato nello stato” - un “territorio straniero interno” - che obbedisce a una legislazione che eccede radicalmente quella che governa il funzionamento normativo dell’Io. Nei sogni, nelle nostre più quotidiane sbadataggini, nei lapsus, nei sintomi di una singolarità eccedente l’Io parla, manifesta la propria voce dissonante disturbando il funzionamento diurno della coscienza e del pensiero. Ne deriva, appunto, un’inedita concezione della malattia e della sofferenza psichica che scaturirebbe non tanto da una assenza o da una debolezza dell’Io, ma da una sua postura troppo rigida, da una mancanza di democrazia interna che vorrebbe escludere la voce dell’inconscio dal parlamento interno del soggetto. Se queste procedure egoico-narcisistiche di esclusione si rafforzano, se il soggetto persegue una rappresentazione solo ideale di sé stesso finalizzata a scongiurare l’esistenza di quelle parti di sé giudicate “incompatibili” con questo stesso Ideale, la vita si atrofizza e si ammala. È un principio clinico che riguarda tanto la vita individuale quanto quella collettiva: i confini che disegnano la nostra identità devono essere plastici, capaci più di integrare lo straniero interno che di scindere e segregare. La psicoanalisi incoraggia una politica anti-segregativa.
L’inconscio freudiano è infatti “uno stato nello stato” - un “territorio straniero interno” - che obbedisce a una legislazione che eccede radicalmente quella che governa il funzionamento normativo dell’Io. Nei sogni, nelle nostre più quotidiane sbadataggini, nei lapsus, nei sintomi di una singolarità eccedente l’Io parla, manifesta la propria voce dissonante disturbando il funzionamento diurno della coscienza e del pensiero. Ne deriva, appunto, un’inedita concezione della malattia e della sofferenza psichica che scaturirebbe non tanto da una assenza o da una debolezza dell’Io, ma da una sua postura troppo rigida, da una mancanza di democrazia interna che vorrebbe escludere la voce dell’inconscio dal parlamento interno del soggetto. Se queste procedure egoico-narcisistiche di esclusione si rafforzano, se il soggetto persegue una rappresentazione solo ideale di sé stesso finalizzata a scongiurare l’esistenza di quelle parti di sé giudicate “incompatibili” con questo stesso Ideale, la vita si atrofizza e si ammala. È un principio clinico che riguarda tanto la vita individuale quanto quella collettiva: i confini che disegnano la nostra identità devono essere plastici, capaci più di integrare lo straniero interno che di scindere e segregare. La psicoanalisi incoraggia una politica anti-segregativa.
 La prima grande lezione etica della psicoanalisi consiste nel favorire una concezione indebolita della soggettività che consenta il transito e l’apertura in alternativa a ogni sua illusione identitaria di padronanza che finisce per irrigidire i propri confini contribuendo alla loro chiusura.
La prima grande lezione etica della psicoanalisi consiste nel favorire una concezione indebolita della soggettività che consenta il transito e l’apertura in alternativa a ogni sua illusione identitaria di padronanza che finisce per irrigidire i propri confini contribuendo alla loro chiusura.Quale è il volto dello straniero che si tratta di accogliere? Innanzitutto quello del desiderio che esprime la dimensione radicalmente insacrificabile della singolarità. Si tratta di un’altra grande e ardita scommessa della psicoanalisi: non contrapporre la ragione al desiderio - come la luce all’ombra - ma fare della “ voce del desiderio” la voce stessa della ragione. È questo un punto nevralgico presente nel pensiero di Freud, ripreso con forza da Lacan: non solo la vita si ammala per un eccesso di solidificazione dell’identità, ma anche quando essa volta le spalle alla chiamata del desiderio, quando tradisce la sua attitudine, la sua vocazione, il suo talento fondamentale. Questo desiderio - assimilato kantianamente da Freud alla “voce della ragione” - non può essere normalizzato, irreggimentato, assoggettato da nessun principio, compreso quello di realtà. La difesa della singolarità comporta l’opzione per un pensiero laico, anti-dogmatico, anti-fondamentalista, critico nei confronti di ogni tentativo di assimilazione del singolare nelle procedure anonime dell’universale.
 È il tratto, se si vuole, irriducibilmente “femminista” della psicoanalisi: la cura è cura per il particolare, per la sua differenza assoluta, per l’incomparabile, per la vita non nel suo statuto generico e biologico ma nel suo nome proprio, nel suo volto unico e irriproducibile. Questo comporta un attrito fatale nei confronti di tutte le pratiche di normalizzazione autoritaria e di medicalizzazione disciplinare della vita. La vita del desiderio - la vita della singolarità - è sempre vita storta, difforme, deviante, bizzarra, anomala.
La psicoanalisi opta per l’accoglienza di questo “straniero interno” come condizione di possibilità per l’accoglienza della vita in tutte le sue forme più divergenti. Essa contrasta politicamente ogni conformismo del pensiero, ogni attitudine all’adattamento passivo, ogni ideale moralistico di normalità. Non esiste infatti mai un “rapporto giusto col reale”, affermava Lacan. Ciascuno ha il compito di trovare la propria misura della felicità.
È il tratto, se si vuole, irriducibilmente “femminista” della psicoanalisi: la cura è cura per il particolare, per la sua differenza assoluta, per l’incomparabile, per la vita non nel suo statuto generico e biologico ma nel suo nome proprio, nel suo volto unico e irriproducibile. Questo comporta un attrito fatale nei confronti di tutte le pratiche di normalizzazione autoritaria e di medicalizzazione disciplinare della vita. La vita del desiderio - la vita della singolarità - è sempre vita storta, difforme, deviante, bizzarra, anomala.
La psicoanalisi opta per l’accoglienza di questo “straniero interno” come condizione di possibilità per l’accoglienza della vita in tutte le sue forme più divergenti. Essa contrasta politicamente ogni conformismo del pensiero, ogni attitudine all’adattamento passivo, ogni ideale moralistico di normalità. Non esiste infatti mai un “rapporto giusto col reale”, affermava Lacan. Ciascuno ha il compito di trovare la propria misura della felicità.
 La psicoanalisi è una teoria critica della società: il potere che impone una misura unica della felicità diviene necessariamente totalitario. La sua vocazione è antifascista nel senso più radicale e militante del termine: veglia affinché la tentazione autoritaria che spinge l’uomo verso il padrone o verso il suo carnefice che promette la tutela autoritaria da ogni rischio che la libertà della vita fatalmente impone, sia avvistata per tempo.
La psicoanalisi è una teoria critica della società: il potere che impone una misura unica della felicità diviene necessariamente totalitario. La sua vocazione è antifascista nel senso più radicale e militante del termine: veglia affinché la tentazione autoritaria che spinge l’uomo verso il padrone o verso il suo carnefice che promette la tutela autoritaria da ogni rischio che la libertà della vita fatalmente impone, sia avvistata per tempo.
 La psicoanalisi svela che esiste nell’uomo una tendenza pulsionale ad amare più le catene della propria libertà, a disfarsi del proprio desiderio, a consegnarsi nelle mani di una autorità che, in cambio della cessione della propria libertà, assicurerebbe la protezione della vita. È la dimensione “fascista” della psicologia delle masse che costituisce un grande capitolo della ricerca sociale e politica della psicoanalisi oggi più che mai attuale.
La psicoanalisi svela che esiste nell’uomo una tendenza pulsionale ad amare più le catene della propria libertà, a disfarsi del proprio desiderio, a consegnarsi nelle mani di una autorità che, in cambio della cessione della propria libertà, assicurerebbe la protezione della vita. È la dimensione “fascista” della psicologia delle masse che costituisce un grande capitolo della ricerca sociale e politica della psicoanalisi oggi più che mai attuale.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
 CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLIPSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Sana rivolta verso una sessualità miserrima. Habemus Corpus (di Mariangela Mianiti)20 marzo 2018, di Federico La Sala
USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. Basta - con la connivenza all’ordine simbolico della madre!!!
Sana rivolta verso una sessualità miserrima
Habemus Corpus. Un appunto e una considerazione sulle parole di Papa Francesco sulla prostituzione
di Mariangela Mianiti (il manifesto, 20.03.2018)
«Chi va con le prostitute è un criminale. Questo non è fare l’amore, questo è torturare una donna. È uno schifo! Alcuni governi cercano di fare pagare multe ai clienti. Ma il problema è grave, grave, grave. E qui in Italia, parlando di clienti, è verosimile che il 90% siano battezzati, cattolici. Vorrei che voi giovani lottaste per questo. Se un giovane ha questa abitudine la tagli. La tratta e la prostituzione sono crimini contro l’umanità, delitti che nascono da una mentalità malata secondo cui la donna va sfruttata».
Così ha parlato Papa Francesco, ieri, durante il colloquio con i giovani nella riunione pre-Sinodo al pontificio collegio internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma. Più chiaro di così non poteva essere e questo vale sia per chi sogna di cancellare la legge Merlin, sia per chi vorrebbe regolamentare la prostituzione, magari copiando la legge approvata in Germania nel 2002 dal governo guidato dal socialdemocratico Gerhard Shröder. Tuttavia, a Francesco è scappata una frase piuttosto infelice quando ha detto: «Non c’è femminismo che sia riuscito a togliere questa mentalità dalla coscienza maschile, dall’immaginario collettivo».
Benché io sia atea, stimo questo Papa che in tanti ritengono ormai l’unico in Italia, e non solo, a dire cose di sinistra, laddove per sinistra si intende ragionare in termini di bene comune e non solo di interesse individuale. Proprio in virtù di questa stima, mi permetto di sottolineare che, se la prostituzione è così viva e vegeta, non è per debolezza del femminismo. Non sono state le donne ad avere inventato, introdotto e alimentato la pratica del sesso a pagamento, ma gli uomini. Sono gli uomini che hanno incrementato, e incrementano, la domanda.
Sono gli uomini a volere pagare per avere a disposizione dei pezzi di corpo femminile. Ora, dire che nessuna forma di femminismo è mai riuscita a sradicare questa mentalità, è un po’ come affermare che le donne, nonostante ci abbiano provato, non sono riuscite a eliminare il problema della prostituzione. Qui bisogna fare un appunto e una considerazione.
L’appunto. Visto che il commercio del sesso esiste perché esiste una domanda maschile, perché dovrebbero essere le donne a farsi carico di tutto il lavoro di rieducazione e lotta? Perché non si chiede agli uomini di farsi un esame di coscienza sul perché hanno bisogno di pagare una donna per poter infilare il loro pene in un orifizio? Per quale ragione il maschio non deve interrogarsi sulla sua idea di desiderio, eros, piacere? Perché non si domanda, e non gli si domanda, dove mai stia la soddisfazione nel comprare sesso? E poi, che cosa sanno del proprio corpo? Che cosa capiscono del corpo altrui? Provano, sentono qualcosa? O sono solo dei poveracci in cerca di un contenitore eiaculatorio?
Se è così, come è molto probabile, gli uomini che pagano per avere sesso soffrono di una malattia gravissima che si chiama Miseria Sessuale.
La considerazione. Nel suo libro Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi e nella sua intervista concessa di recente a Caterina Peroni per il blog Studi sulla questione criminale, Ida Dominijanni spiega molto bene come il movimento #MeToo, e prima ancora le denunce delle escort contro Berlusconi, abbiano svelato un dispositivo sessuale poverissimo, lo scambio di potere per briciole di sesso, che il «fare sesso adesso è proprio un fare, è un fare una cosa, è molto neoliberale, un’attività!», e come «dal MeToo trapeli una sana rivolta contro una sessualità miserrima». Caro Francesco, il femminismo è vivo, vegeto e lotta. Sono certi maschi a essere molto arretrati.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA. L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- "NUOVA ALLEANZA"?!: A CONDIZIONE CHE ACCANTO A "MARIA" CI SIA "GIUSEPPE"!!!
 Uscire dallo "stato di minorità" non significa mangiare un "piatto di lenticchie" ... né "sposare" il Figlio!!!
Uscire dallo "stato di minorità" non significa mangiare un "piatto di lenticchie" ... né "sposare" il Figlio!!!
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus!!! O, meglio, che progetto!!!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta ... sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. - "Maria Maddalena. Esercizi spirituali" tenuti dal cardinale Martini in Israele tra la fine del 2006 e l’inizio del 200716 marzo 2018, di Federico La Sala
Il Vangelo dalla parte della Maddalena
Escono in un libro gli esercizi spirituali che il cardinale Carlo Maria Martini tenne in Israele tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007. Sono dedicati alla figura della santa peccatrice
di Vito Mancuso (la Repubblica, 16.03.2018)
La simpatia del cardinal Martini per Maria Maddalena appare evidente dalla prima all’ultima parola degli esercizi spirituali da lui tenuti in Israele tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, come evidente è la sua simpatia per le consacrate dell’Ordo Virginum della diocesi di Milano per le quali aveva preparato gli esercizi e alle quali diceva: «Vi riconosco nella vostra bellezza interiore ed esteriore, perché quando l’anima rimane nella sua costante proposta di servizio a Dio, rimane bella e questa bellezza si diffonde».
 Io penso sia proprio così, e penso che Martini sia stato a sua volta un esempio di questa misteriosa connessione tra etica ed estetica avvertita già dagli antichi greci con l’ideale della kalokagathía, perché il morbo di Parkinson contro cui già allora combatteva, e che l’avrebbe portato alla morte il 31 agosto 2012, non giunse mai a privarlo della sua originaria e nobile bellezza.
Io penso sia proprio così, e penso che Martini sia stato a sua volta un esempio di questa misteriosa connessione tra etica ed estetica avvertita già dagli antichi greci con l’ideale della kalokagathía, perché il morbo di Parkinson contro cui già allora combatteva, e che l’avrebbe portato alla morte il 31 agosto 2012, non giunse mai a privarlo della sua originaria e nobile bellezza.
 Cosa siano gli esercizi spirituali lo spiega lo stesso Martini dicendo che non sono un corso di aggiornamento, né una lettura spirituale della Bibbia, né un’occasione di preghiera; sono invece “un ministero dello Spirito Santo”, nel senso che “è lo Spirito Santo che parla al mio cuore per dirmi ciò che vuole da me adesso”.
Cosa siano gli esercizi spirituali lo spiega lo stesso Martini dicendo che non sono un corso di aggiornamento, né una lettura spirituale della Bibbia, né un’occasione di preghiera; sono invece “un ministero dello Spirito Santo”, nel senso che “è lo Spirito Santo che parla al mio cuore per dirmi ciò che vuole da me adesso”.Gli esercizi spirituali sono quindi un tempo di ascolto e di raccoglimento per capire la propria situazione qui e ora, e come tali prevedono «un silenzio assoluto a tavola e anche negli altri momenti», perché, avverte Martini, «soltanto una parola detta qua e là disturba tutti».
Maria Maddalena è «il segno dell’eccesso cristiano, il segno dell’andare al di là del limite, il segno del superamento»: nell’eccedere della sua vita travagliata ma sempre dominata dall’amore, si dà per Martini la chiave privilegiata per «essere introdotti nel cuore di Dio».
Il cuore di Dio. Mediante la storia della Maddalena, Martini giunge a parlare di Dio, e parlando di Dio giunge a illuminare la logica e il ritmo dell’essere, cogliendo nell’amore il suo segreto più profondo: «Dio è tutto dono, è tutto al di là del dovuto e questo è il segreto della vita».
 Individuare “il cuore di Dio” significa quindi per Martini individuare “il segreto della vita”. In questa prospettiva egli illumina magistralmente il paradosso dell’esistenza segnalando la dinamica profonda secondo cui ci si compie superandosi, ci si arricchisce svuotandosi, si raggiunge l’equilibrio perdendolo.
Individuare “il cuore di Dio” significa quindi per Martini individuare “il segreto della vita”. In questa prospettiva egli illumina magistralmente il paradosso dell’esistenza segnalando la dinamica profonda secondo cui ci si compie superandosi, ci si arricchisce svuotandosi, si raggiunge l’equilibrio perdendolo.
 È la pazzia evangelica. La quale però, in quanto verità dell’essere, è universale, e quindi è avvertita anche al di là del cristianesimo, per esempio già da Platone che coglieva la medesima logica di eccedenza scrivendo che «la mania che proviene da un dio è migliore dell’assennatezza che proviene dagli uomini» ( Fedro 244 d). Maniaca in senso platonico, la Maddalena è definita da Martini “amante estatica”, cioè letteralmente “fuori di sé” e in questo modo è indicata quale via privilegiata per accedere al cuore di Dio.
È la pazzia evangelica. La quale però, in quanto verità dell’essere, è universale, e quindi è avvertita anche al di là del cristianesimo, per esempio già da Platone che coglieva la medesima logica di eccedenza scrivendo che «la mania che proviene da un dio è migliore dell’assennatezza che proviene dagli uomini» ( Fedro 244 d). Maniaca in senso platonico, la Maddalena è definita da Martini “amante estatica”, cioè letteralmente “fuori di sé” e in questo modo è indicata quale via privilegiata per accedere al cuore di Dio.
 Per lui è infatti evidente che «non può comprendere Dio chi cerca solo ragioni logiche», mentre lo può comprendere «chi vive qualche gesto di uscita da sé, di dedizione al di fuori di sé, al di fuori del dovuto», perché Dio, simbolo concreto del mistero dell’essere, “è uscita da sé”, “dono di sé”.
Per lui è infatti evidente che «non può comprendere Dio chi cerca solo ragioni logiche», mentre lo può comprendere «chi vive qualche gesto di uscita da sé, di dedizione al di fuori di sé, al di fuori del dovuto», perché Dio, simbolo concreto del mistero dell’essere, “è uscita da sé”, “dono di sé”.
 In questa prospettiva la Maddalena, perfetta esemplificazione della logica evangelica, fa capire che “solo l’eccesso salva”. Per “eccesso” Martini intende “uno squilibrio dell’esistenza”. E proprio questo è il punto: che la vita si alimenta di tale squilibrio. Il nostro universo non viene forse da un eccesso, cioè dalla rottura di simmetria all’origine del Big Bang? E la vita non è a sua volta squilibrio, essendo la morte, come disse Erwin Schrödinger nelle lezioni al Trinity College di Dublino, “equilibrio termico”? E cosa sono l’innamoramento e le passioni di cui si nutre la nostra psiche, se non, a loro volta, squilibrio?
In questa prospettiva la Maddalena, perfetta esemplificazione della logica evangelica, fa capire che “solo l’eccesso salva”. Per “eccesso” Martini intende “uno squilibrio dell’esistenza”. E proprio questo è il punto: che la vita si alimenta di tale squilibrio. Il nostro universo non viene forse da un eccesso, cioè dalla rottura di simmetria all’origine del Big Bang? E la vita non è a sua volta squilibrio, essendo la morte, come disse Erwin Schrödinger nelle lezioni al Trinity College di Dublino, “equilibrio termico”? E cosa sono l’innamoramento e le passioni di cui si nutre la nostra psiche, se non, a loro volta, squilibrio?
 Afferma Martini: «Quando definisco me stesso, mi definisco di fronte al mistero di Dio e mi definisco come qualcuno che è destinato a trovarsi nel dono di sé... e tutto questo si dà perché Dio è dono di sé». Prosegue dicendo che molti non capiscono Dio perché non lo collegano a questa dinamica di uscita da sé, visto che «soltanto quando accettiamo di entrare in questa dinamica della perdita, del dare in perdita, possiamo metterci in sintonia con il mistero di Dio».
Afferma Martini: «Quando definisco me stesso, mi definisco di fronte al mistero di Dio e mi definisco come qualcuno che è destinato a trovarsi nel dono di sé... e tutto questo si dà perché Dio è dono di sé». Prosegue dicendo che molti non capiscono Dio perché non lo collegano a questa dinamica di uscita da sé, visto che «soltanto quando accettiamo di entrare in questa dinamica della perdita, del dare in perdita, possiamo metterci in sintonia con il mistero di Dio».
 In questa prospettiva Martini giunge a parlare di Dio secondo una teologia della natura che avrebbe fatto felice il confratello gesuita Pierre Teilhard de Chardin, riferendosi a «quella forza che potremmo dire trascendente, perché è in tutta la natura fisica, morale, spirituale ed è la forza che tiene insieme il mondo... la forza che si può concepire come una lotta continua contro l’entropia e il raffreddamento».
In questa prospettiva Martini giunge a parlare di Dio secondo una teologia della natura che avrebbe fatto felice il confratello gesuita Pierre Teilhard de Chardin, riferendosi a «quella forza che potremmo dire trascendente, perché è in tutta la natura fisica, morale, spirituale ed è la forza che tiene insieme il mondo... la forza che si può concepire come una lotta continua contro l’entropia e il raffreddamento».
 Anche il voto di verginità delle consacrate alle quali rivolgeva i suoi esercizi appare a Martini un segno di quell’eccesso di amore che fa sì che nel mondo non vi sia solo la forza di gravità che tira verso il basso, ma anche «una forza che tira verso l’alto, verso la trasparenza, la complessità e anche verso una comprensione profonda di sé e degli altri fino ad arrivare a quella trasparenza che è la rivelazione di ciò che saremo». Ovvero, conclude Martini, “la vita eterna”.
Anche il voto di verginità delle consacrate alle quali rivolgeva i suoi esercizi appare a Martini un segno di quell’eccesso di amore che fa sì che nel mondo non vi sia solo la forza di gravità che tira verso il basso, ma anche «una forza che tira verso l’alto, verso la trasparenza, la complessità e anche verso una comprensione profonda di sé e degli altri fino ad arrivare a quella trasparenza che è la rivelazione di ciò che saremo». Ovvero, conclude Martini, “la vita eterna”.
La categoria dell’eccesso
Maria Maddalena secondo il cardinale Martini *
L’eccesso è per Martini la “categoria” che ci consente non solo di comprendere il mistero di Dio adombrato nella passione, morte e risurrezione di Gesù, ma ciò che esprime il senso profondo dell’essere cristiano, della maturità cristiana.
Ancora una volta è attraverso i personaggi di Giovanni che Martini costruisce questa sua visione, in particolare è Maria di Magdala a guidarci in questo ultimo tratto di cammino. «Maria di Magdala è una figura particolarmente importante nei Vangeli, è il prototipo della persona che accede alla fede nel Risorto. Se gli altri due episodi narrati da Giovanni rappresentano piuttosto una comunità che accoglie il mistero della Risurrezione, l’episodio che ha per protagonista la Maddalena è piuttosto dedicato al singolo credente o meglio al non credente che diventa credente».
Chi è Maria Maddalena? Tutti i vangeli la annoverano tra le donne che si recano al sepolcro. Forse, dice Martini, tale menzione indica «una qualche funzione di leadership», ma non abbiamo elementi sufficienti. Compare inoltre nei racconti della passione e nella vita pubblica di Gesù, dove è messa «sullo stesso piano dei discepoli». La sua figura però si può comprendere anche grazie al confronto con altre figure femminili presenti nel vangelo. Per esempio la peccatrice in casa di Simone, le «Marie di Betania» e, infine, la sposa del Cantico; come lei, la Maddalena «ha cercato Gesù con una passione inesausta, con una perseveranza invincibile e di conseguenza è una figura della ricerca di Gesù e del Signore risorto». Tutte rimandano in qualche modo a un «eccesso d’amore».
Nel testo si legge che il primo giorno dopo il sabato Maria si reca al sepolcro «di buon mattino», quando era ancora buio. Un atteggiamento inusuale e anche un po’ rischioso, che la dipinge fin da subito come una «donna che supera le convenzioni». Esce di casa perché non si dà pace e non si preoccupa di ciò che può capitarle o di ciò che può pensare la gente. Quando arriva al sepolcro ha una prima intuizione degli eventi, ma ancora parziale, distorta. -Sconvolta, va da Simon Pietro e dagli altri discepoli, ma, fa notare Martini, riferisce una sua versione dei fatti. In fondo cosa ha visto? La pietra ribaltata e il sepolcro vuoto; su questi elementi costruisce una storia; il corpo di Gesù è stato rubato. L’inquietudine di non sapere dove lo hanno portato non le dà pace.
* L’Osservayore Romano, 17 luglio 2017
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- EU-ANGELO, BUONA-NOTIZIA. "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
 "DIO NON E’ CATTOLICO". "Dio è al di là delle frontiere che vengono erette". Accorato appello del Cardinale Carlo M. Martini alla Chiesa per una sua rapida e profonda riforma
"DIO NON E’ CATTOLICO". "Dio è al di là delle frontiere che vengono erette". Accorato appello del Cardinale Carlo M. Martini alla Chiesa per una sua rapida e profonda riforma
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA .... DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
Federico La Sala
- EU-ANGELO, BUONA-NOTIZIA. "CHARISSIMI, NOLITE OMNI SPIRITUI CREDERE... DEUS CHARITAS EST" (1Gv., 4. 1-16). «Et nos credidimus Charitati...»!!!!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - LA LEGGE DELLA GIUSTIZIA. N. Fraser, "Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World" (di Brunella Casalini).9 marzo 2018, di Federico La Sala
N. Fraser, Scales of Justice. Reimagining Political Space in a Globalizing World, Polity Press, Cambridge (UK) 2008, pp. 224, ISBN 978-07456-4486-8 *
di Brunella Casalini (Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale)
Giocando sulla plurivocità semantica del termine inglese "scales", con il titolo Scales of Justice Nancy Fraser evoca due immagini: la bilancia come simbolo classico della capacità della giustizia di agire in modo imparziale e lo spazio cui necessariamente deve far riferimento qualsiasi teoria della giustizia. Sia il concetto di imparzialità sia la dimensione spaziale della giustizia sono oggi oggetto di una contestazione radicale. La contrapposizione tra paradigma redistributivo e paradigma del riconoscimento si è mossa oltre la problematica della risoluzione equa dello scontro tra rivendicazioni conflittuali; è infatti la sostanza stessa dell’idea di giustizia ad essere messa in discussione da coloro che si dividono sulla priorità di redistribuzione e riconoscimento, presentandole come istanze incommensurabili che non possono trovare risposta semplicemente pesandole sulla stessa bilancia.
 Una teoria della giustizia che tenga conto delle diverse concezioni sostantive della giustizia oggi presenti nel dibattito politico, qualora ritenga che ciascuna di esse colga aspetti importanti e diversi del fenomeno dell’ingiustizia, secondo la Fraser, deve rispondere a due sfide: la prima consiste nel vedere cosa possa essere salvato dell’ideale dell’imparzialità e come esso possa essere riformulato, la seconda nel decidere contestualmente, accettando l’esistenza di una pluralità di prospettive, a quale visione della giustizia dare di volta in volta maggiore attenzione.
Una teoria della giustizia che tenga conto delle diverse concezioni sostantive della giustizia oggi presenti nel dibattito politico, qualora ritenga che ciascuna di esse colga aspetti importanti e diversi del fenomeno dell’ingiustizia, secondo la Fraser, deve rispondere a due sfide: la prima consiste nel vedere cosa possa essere salvato dell’ideale dell’imparzialità e come esso possa essere riformulato, la seconda nel decidere contestualmente, accettando l’esistenza di una pluralità di prospettive, a quale visione della giustizia dare di volta in volta maggiore attenzione.Da Justice Interruptus (1997) all’acceso confronto con Axel Honneth, contenuto in Recognition or Redistribution?, la Fraser ha tentato di superare la contrapposizione tra paradigma del riconoscimento e paradigma redistributivo, mediante due operazioni principali: 1) una teorizzazione del riconoscimento incentrata sulla differenza di status, che tende a separare la politica del riconoscimento dalla politica dell’identità, e a vedere nel mancato riconoscimento un’ingiustizia, un impedimento alla parità partecipativa, e non un ostacolo all’autorealizzazione e una ferita psichica (come nei modelli di Honneth e Taylor); e 2) la formulazione di un dualismo di prospettiva capace di cogliere analiticamente tanto le dinamiche di esclusione connesse alle caratteristiche intrinseche del sistema economico capitalistico quanto quelle legate al sistema simbolico-culturale, così da poter proporre soluzioni di volta in volta diverse a seconda delle specifiche condizioni di particolari gruppi sociali e dei presupposti necessari a garantire la parità partecipativa.
Accusata di aver dimenticato il ruolo autonomo della sfera politico-giuridica e l’importanza delle discriminazioni che avvengono sul piano prettamente giuridico e politico, a cominciare dal saggio Redefining Justice in a Globalizing World (2005, qui ripubblicato), Nancy Fraser ha posto accanto alla dimensione culturale del riconoscimento e alla dimensione economica della redistribuzione, una terza dimensione specificamente politica: la dimensione della rappresentanza. Il criterio della rappresentanza risponde a una questione decisiva oggi nei dibattiti intorno alle diverse teorie della giustizia, dibattiti che non vertono più sul "che cosa" la giustizia deve riconoscere, ma sempre più su "a chi" deve riconoscerlo, su quali sono e come si determinano i confini della comunità cui una teoria della giustizia intende applicarsi.
La theory of justice as parity of participation della Fraser viene così a configurarsi come una teoria tridimensionale, che costituisce una sorta di ripresa e revisione della triade weberiana di classe, status e partito - cui, del resto, l’autrice esplicitamente si è richiamata fin dall’inizio nella sua ridefinizione del paradigma del riconoscimento.
 L’aggiunta della terza dimensione appare inscindibile dall’attenzione per la questione del framing, dell’inquadratura dello spazio entro cui si pongono problemi di giustizia. In un contesto post-socialista, post-fordista e soprattutto post-westphaliano le ingiustizie sono insieme incentrate su questioni di misrecognition, misredistribution e misframing. Distribuzione e riconoscimento potevano essere considerate come le due dimensioni cruciali della giustizia finché il quadro di riferimento dello stato-nazione era dato per scontato.
L’aggiunta della terza dimensione appare inscindibile dall’attenzione per la questione del framing, dell’inquadratura dello spazio entro cui si pongono problemi di giustizia. In un contesto post-socialista, post-fordista e soprattutto post-westphaliano le ingiustizie sono insieme incentrate su questioni di misrecognition, misredistribution e misframing. Distribuzione e riconoscimento potevano essere considerate come le due dimensioni cruciali della giustizia finché il quadro di riferimento dello stato-nazione era dato per scontato.
 Con la globalizzazione e la contestazione della cornice keynesiano-westphaliana, la dimensione politica emerge come la terza dimensione fondamentale nell’ambito delle teorie della giustizia. Domanda cruciale diviene infatti se la teoria della giustizia debba continuare a muoversi nello spazio della cittadinanza nazionale, se debba divenire cosmopolitica o se debba venire a riguardare le "comunità transnazionali del rischio".
Con la globalizzazione e la contestazione della cornice keynesiano-westphaliana, la dimensione politica emerge come la terza dimensione fondamentale nell’ambito delle teorie della giustizia. Domanda cruciale diviene infatti se la teoria della giustizia debba continuare a muoversi nello spazio della cittadinanza nazionale, se debba divenire cosmopolitica o se debba venire a riguardare le "comunità transnazionali del rischio".
 La Fraser si è sentita inizialmente vicina alle posizioni di coloro che - come Iris Marion Young - hanno cercato di arrivare alla formulazione di una concezione transazionale mediante l’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia in base al c.d. "all affected principle", ovvero in base ad un principio che fa riferimento alla possibile co-implicazione oggettiva di soggetti anche lontani tra loro in una rete di relazioni causali che può scavalcare i confini nazionali. Ora, Fraser riconosce due limiti a questa soluzione teorica: da un lato, il rimando a reti causali oggettive sembra delegare alle scienze sociali l’individuazione dei soggetti interessati; dall’altro, a causa del paradosso prodotto dal c.d. butterfly principle, per cui siamo tutti influenzati da tutto, rischia di non riuscire a delimitare lo spazio di relazioni sociali rilevanti.
La Fraser si è sentita inizialmente vicina alle posizioni di coloro che - come Iris Marion Young - hanno cercato di arrivare alla formulazione di una concezione transazionale mediante l’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia in base al c.d. "all affected principle", ovvero in base ad un principio che fa riferimento alla possibile co-implicazione oggettiva di soggetti anche lontani tra loro in una rete di relazioni causali che può scavalcare i confini nazionali. Ora, Fraser riconosce due limiti a questa soluzione teorica: da un lato, il rimando a reti causali oggettive sembra delegare alle scienze sociali l’individuazione dei soggetti interessati; dall’altro, a causa del paradosso prodotto dal c.d. butterfly principle, per cui siamo tutti influenzati da tutto, rischia di non riuscire a delimitare lo spazio di relazioni sociali rilevanti.
 Per ovviare a questi inconvenienti, l’autrice propone quale alternativa il c.d. all subjected principle, in base al quale chi è soggetto ad una data struttura della governance (concepita in senso lato in modo da poter comprendere non solo gli stati, ma anche, per esempio, le organizzazioni non governative e agenzie come il WTO e il IMF), ha diritto ad essere riconosciuto come destinatario di giustizia da parte di quella medesima struttura. Il principio all subjected individua non un unico "chi" destinatario della giustizia, ma una pluralità di "chi" collocati a livello locale, nazionale, regionale e, in alcuni casi, globale.
Per ovviare a questi inconvenienti, l’autrice propone quale alternativa il c.d. all subjected principle, in base al quale chi è soggetto ad una data struttura della governance (concepita in senso lato in modo da poter comprendere non solo gli stati, ma anche, per esempio, le organizzazioni non governative e agenzie come il WTO e il IMF), ha diritto ad essere riconosciuto come destinatario di giustizia da parte di quella medesima struttura. Il principio all subjected individua non un unico "chi" destinatario della giustizia, ma una pluralità di "chi" collocati a livello locale, nazionale, regionale e, in alcuni casi, globale.L’individuazione dei soggetti destinatari della giustizia transazionale può avvenire soltanto lasciando voce alla contestazione e al dialogo ai diversi livelli e creando canali istituzionali formali che consentano di arrivare a decisioni vincolanti. In questa direzione, la Fraser guarda al ruolo che rivestono oggi i movimenti sociali globali: la loro contestazione del quadro westphaliano è insieme un modo per rivendicare il diritto a determinare il "chi" della giustizia e il "come" arrivare alla sua definizione.
 Sbagliano tuttavia, secondo la Fraser, i sostenitori delle visioni populiste, à la Negri e Hardt, che collocano il nesso contestazione/decisione nella società civile, perché le formazioni presenti nella società civile non sono da sole capaci di trasformare le loro proposte in decisioni politiche stringenti e perché esse mancano di rappresentatività e democraticità per poter rivendicare il diritto a ridisegnare i confini della giustizia. Una giustizia transnazionale richiede adeguati canali istituzionali che rispondano alla società civile, ma funzionino al tempo stesso secondo eque procedure e un sistema di rappresentanza che ne assicuri il carattere democratico dando legittimità alle decisioni prodotte. I tratti delle nuove sfere pubbliche transnazionali e delle nuove istituzioni democratiche globali rimangono, tuttavia, al momento, estremamente vaghi nel disegno della Fraser, che evita qui, per altro, di confrontarsi criticamente con le istituzioni sovranazionali esistenti, con i loro limiti e le loro possibilità di riforma.
Sbagliano tuttavia, secondo la Fraser, i sostenitori delle visioni populiste, à la Negri e Hardt, che collocano il nesso contestazione/decisione nella società civile, perché le formazioni presenti nella società civile non sono da sole capaci di trasformare le loro proposte in decisioni politiche stringenti e perché esse mancano di rappresentatività e democraticità per poter rivendicare il diritto a ridisegnare i confini della giustizia. Una giustizia transnazionale richiede adeguati canali istituzionali che rispondano alla società civile, ma funzionino al tempo stesso secondo eque procedure e un sistema di rappresentanza che ne assicuri il carattere democratico dando legittimità alle decisioni prodotte. I tratti delle nuove sfere pubbliche transnazionali e delle nuove istituzioni democratiche globali rimangono, tuttavia, al momento, estremamente vaghi nel disegno della Fraser, che evita qui, per altro, di confrontarsi criticamente con le istituzioni sovranazionali esistenti, con i loro limiti e le loro possibilità di riforma.* La bilancia della giustizia. Ripensare lo spazio politico in un mondo globalizzato di Nancy Fraser edito da Pensa Multimedia, 2012
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- LA FINE DELLA CURA. Le contraddizioni sociali del capitalismo (di Nancy Fraser).9 marzo 2018, di Federico La Sala
Le contraddizioni sociali del capitalismo
di Nancy Fraser (che fare, 24 marzo 2017
Come il regime liberale prima di esso, così anche l’ordine statal-capitalistico si dissolse nel corso di una crisi prolungata. A partire dagli anni Ottanta, gli osservatori lungimiranti potevano vedere emergere i lineamenti di un nuovo regime, destinato a diventare il capitalismo finanziario dell’epoca presente.
Globale e neoliberale, sta promuovendo tagli pubblici e privati del welfare nello stesso momento in cui recluta le donne nella forza lavoro salariata. Sta dunque scaricando il peso del lavoro di cura sulle famiglie e sulle comunità, mentre diminuisce la loro capacità di svolgerlo. Il risultato è una nuova organizzazione dualistica della riproduzione sociale, mercificata per coloro che possono permettersela e privatizzata per quanti non possono farlo, visto che alcune componenti della seconda categoria forniscono lavoro di cura per coloro che appartengono alla prima in cambio di (bassi) stipendi. Nel frattempo, la combinazione della critica femminista e della deindustrializzazione ha definitivamente privato il “salario familiare” di ogni credibilità. capitalismo
- Pubblichiamo un estratto da La fine della cura (Mimesis)
Quell’ideale ha fatto così posto all’attuale e più moderno principio del “doppio reddito familiare”.
Il vettore principale di tali sviluppi e la caratteristica distintiva di questo regime è l’inedita centralità del debito. Il debito è lo strumento con cui le istituzioni finanziarie globali fanno pressione sugli stati affinché taglino la spesa sociale, applichino misure di austerity e, in generale, colludano con gli investitori nell’estrarre valore da popolazioni indifese.
È in larga misura attraverso il debito, inoltre, che i coltivatori del sud del mondo vengono espropriati da una nuova serie di annessioni di suolo da parte di aziende che mirano ad accaparrarsi provviste energetiche, acqua, terra coltivabile ed “emissioni di carbonio”. È sempre più attraverso il debito, inoltre, che l’accumulazione prosegue nel suo centro storico. Così come il lavoro sottopagato e precario nel settore dei servizi sostituisce quello industriale sindacalizzato, i salari scendono al di sotto dei costi socialmente necessari alla riproduzione; in questa “economia del precariato” [“gig economy”], la spesa duratura da parte del consumatore richiede un debito diffuso, che aumenta esponenzialmente.
È sempre più attraverso il debito, in altre parole, che il capitale oggi cannibalizza il lavoro, colpevolizza gli stati, trasferisce ricchezza dalla periferia al centro ed estrae valore dalla sfera domestica, dalle famiglie, dalle comunità e dalla natura.
L’effetto è quello di intensificare le contraddizioni intrinseche al capitalismo tra produzione economica e riproduzione sociale.
Mentre il regime precedente spronava gli stati a subordinare gli interessi a breve termine delle società private all’obiettivo di lungo termine di un’accumulazione duratura, stabilizzando la riproduzione attraverso investimenti pubblici, quello attuale autorizza il capitale finanziario a vincolare gli stati e l’opinione pubblica in funzione degli interessi immediati degli investitori privati, richiedendo anche tagli pubblici alla riproduzione sociale. E mentre il regime precedente aveva sancito un’alleanza tra mercatizzazione e protezione sociale contro l’emancipazione, questo genera uno scenario ancora più perverso, nel quale l’emancipazione si allea con la mercatizzazione per indebolire la protezione sociale.
Il nuovo regime emerse dalla decisiva intersezione di questi due gruppi di lotte. Un gruppo contrappose un partito in ascesa di liberisti, determinati a liberalizzare e globalizzare l’economia capitalistica, contro il movimento operaio in declino nei paesi del centro; la più forte base di sostegno della democrazia sociale di un tempo è oggi sulla difensiva, se non del tutto sconfitta.
L’altro gruppo di lotte contrappose i “nuovi movimenti sociali” progressisti, avversi alle gerarchie di genere, di sesso, “razza”, etnia e religione contro le popolazioni intente a difendere mondi di vita e privilegi consolidati, oggi minacciati dal “cosmopolitismo” della nuova economia. Al di là della collisione di questi due gruppi di lotte, emerse un risultato sorprendente: un neoliberalismo “progressista” che celebra la “diversità”, la meritocrazia e l’“emancipazione” proprio mentre smantella le protezioni sociali ed esternalizza nuovamente la riproduzione sociale. Il risultato non comporta soltanto l’abbandono delle popolazioni indifese alle predazioni del capitale, ma ridefinisce anche l’emancipazione in termini mercatisti.
I movimenti di emancipazione hanno preso parte a questo processo. Tutti, incluso l’anti-razzismo, il multiculturalismo, il movimento di liberazione LGBT e l’ecologismo, hanno dato vita a correnti neoliberali favorevoli al mercato.
La traiettoria femminista si dimostrò tuttavia decisiva più di altre in tale processo, dato il consueto intreccio di questioni di genere e di riproduzione sociale nel capitalismo. Al pari di ogni regime precedente, il capitalismo finanziario istituzionalizza la divisione fra produzione e riproduzione sulla base del genere. A differenza dei precedenti, però, il suo immaginario dominante è liberal-individualista ed egualitario dal punto di vista del genere - le donne sono considerate alla pari degli uomini in ogni sfera, degne di eguali opportunità di realizzare i propri talenti, inclusi - forse soprattutto - quelli nella sfera produttiva. La riproduzione, al contrario, appare un residuo arretrato, un ostacolo al progresso che deve essere estirpato in un modo o nell’altro lungo la strada verso la liberazione.
A dispetto - o forse a causa - della sua aura femminista, questa concezione compendia l’attuale forma della contraddizione sociale del capitalismo, che assume un’inedita intensità.
Non pago di ridurre gli aiuti pubblici mentre recluta le donne nel mondo del lavoro salariato, il capitalismo finanziario ha cioè anche ridotto i salari reali, aumentando il numero di ore di lavoro casalingo pagato necessario a supportare una famiglia e inducendo a fare i salti mortali per trasferire su altri il lavoro di cura.
Per colmare il “vuoto di cura” [care gap], il regime importa lavoratrici migranti dai paesi più poveri a quelli più ricchi. Generalmente si tratta di donne connotate dal punto di vista razziale e/o provenienti da regioni rurali e povere, che accettano di svolgere il lavoro riproduttivo e di cura precedentemente eseguito da donne più privilegiate. Per fare questo, tuttavia, le migranti devono trasferire le loro responsabilità familiari e comunitarie ad altre badanti, ancora più povere, che a loro volta devono fare lo stesso - e così via, in “catene della cura globale” sempre più lunghe. Lungi dal colmare il “vuoto di cura”, l’effetto finale consiste dunque nella sua dislocazione dalle famiglie più ricche a quelle più povere, dal nord al sud del pianeta.
Questo scenario si adatta alle strategie basate sul genere degli stati postcoloniali indebitati, con problemi finanziari soggetti ai piani di “aggiustamento strutturale”. Alla ricerca disperata di una valuta forte, alcuni di essi hanno attivamente promosso l’emigrazione delle donne per svolgere all’estero un lavoro di cura pagato in vista delle rimesse, mentre altri, attraverso la creazione di zone di trasformazione per l’esportazione, hanno attratto investimenti esteri diretti, spesso in industrie - come quelle che assemblano tessuti e materiali elettronici - che preferiscono impiegare lavoratrici donne. In entrambi i casi, le capacità socio-riproduttive sono ulteriormente compresse.
Due recenti tendenze negli Stati Uniti compendiano la gravità della situazione.
La prima è la crescente popolarità del “congelamento di ovuli”, una procedura il cui costo normalmente si aggira intorno ai 10.000 dollari, ma che ora viene offerta gratuitamente da imprese informatiche come benefit per impiegate altamente qualificate. Desiderose di attrarre e trattenere queste lavoratrici, imprese come Apple e Facebook forniscono loro un forte incentivo a posticipare la gravidanza, di fatto dicendo: “aspetta e avrai i tuoi figli a 40, 50 o anche 60 anni; dedica a noi i tuoi anni più energici e produttivi”.
Un secondo sviluppo, egualmente sintomatico della contraddizione tra riproduzione e produzione negli Stati Uniti, consiste nella proliferazione di distributori meccanici costosi e altamente tecno- logici, per tirare e conservare latte materno. Tale è la “dose” di scelta in un paese con un alto tasso di partecipazione della forza lavoro femminile, senza maternità pagata o congedi parentali, e infatuato della tecnologia. Un paese, inoltre, in cui l’allatta- mento resta la prassi, ma è cambiato radicalmente. Non essendo più necessario allattare il bambino al seno, oggi molte donne “allattano” tirandosi meccanicamente il latte e mettendolo da parte perché in seguito una qualche bambinaia possa allattare dalla bottiglia. In una congiuntura storica di acuta povertà, tiralatte doppi che funzionano senza bisogno delle mani sono considerati la cosa più desiderabile, poiché consentono di tirare il latte da entrambi i seni in una volta sola, mentre si sta guidando la macchi- na in autostrada per andare al lavoro.
Alla luce di pressioni come queste, non c’è da stupirsi se, in questi ultimi anni, sono esplose lotte su questioni relative alla riproduzione sociale. Le femministe del nord descrivono spesso il loro punto di vista all’insegna di un “equilibrio tra famiglia e lavoro”.
I conflitti sulla riproduzione sociale, tuttavia, comprendono molto di più - i movimenti locali per la casa, la salute, la sicurezza alimentare e un reddito di base incondizionato; le lotte per i diritti dei migranti, dei lavoratori domestici e dei lavoratori pubblici; campagne per sindacalizzare coloro che svolgono un lavoro di assistenza sociale in residenze per anziani, ospedali e centri di assistenza all’infanzia; le lotte per i servizi pubblici come l’assistenza diurna e l’assistenza per gli anziani, per una settimana lavorativa più corta e per una maternità e congedi parentali generosamente remunerati. Nel loro insieme, tali rivendicazioni equivalgono alla richiesta di una riorganizzazione massiccia della relazione tra produzione e riproduzione, a favore di assetti sociali che potrebbero dare la possibilità a persone di ogni classe, genere, orientamento sessuale e colore della pelle di combinare attività socio-riproduttive con un lavoro sicuro, interessante e ben remunerato.
Le lotte di confine sulla riproduzione sociale sono centrali per l’attuale congiuntura, quanto lo sono i conflitti di classe sulla produzione economica.
Rispondono anzitutto a una “crisi della cura” che è radicata nelle dinamiche strutturali del capitalismo finanziario.
Globalizzato e mosso dal debito, il capitalismo neoliberale sta sistematicamente espropriando le capacità necessarie a sostenere le relazioni sociali. Proclamando il nuovo e più moderno ideale del “doppio reddito familiare”, recupera il favore dei movimenti per l’emancipazione, che si uniscono ai fautori della mercatizzazione per contrapporsi ai sostenitori della protezione sociale, oggi sempre più in preda al risentimento e allo sciovinismo. Cosa potrebbe emergere da questa crisi?
[...] Cosa si profila all’orizzonte della congiuntura presente? Le attuali contraddizioni del capitalismo finanziario sono abbastanza gravi da segnalare una crisi generale; dovremmo perciò aspettarci un’altra mutazione della società capitalistica?
L’attuale crisi innescherà lotte di un’ampiezza e di una radicalità sufficienti a trasformare il regime presente? Una nuova versione di “femminismo socialista” potrebbe riuscire a interrompere l’infatuazione della corrente dominante del movimento per la mercatizzazione e plasmare al tempo stesso una nuova alleanza fra emancipazione e protezione sociale? E se così fosse, in vista di quale fine? Come potrebbe essere reinventata oggi la divisione fra riproduzione e produzione e cosa potrebbe sostituire il doppio reddito familiare?
[...] Gettando le basi che consentono di porre queste domande, ho però tentato di fare luce sulla congiuntura attuale. Nello specifico, ho suggerito che le radici dell’attuale “crisi della cura” risiedono nelle contraddizioni sociali intrinseche al capitalismo - o, piuttosto, nella forma acuta che la contraddizione assume oggi, nel capitalismo finanziario. Se ciò è corretto, allora questa crisi non sarà risolta tentando di aggiustare le politiche sociali. La via per risolverla può passare solo attraverso una profonda trasformazione strutturale dell’ordine sociale. Ciò che è necessario, prima di tutto, è il superamento dell’avida sottomissione, da parte del capitalismo finanziario, della riproduzione alla produzione - ma questa volta senza sacrificare né l’emancipazione, né la protezione sociale. A sua volta, ciò richiede di reinventare la distinzione fra produzione e riproduzione e di re-immaginare l’ordine di genere. Resta da vedere se il risultato sarà compatibile o meno con il capitalismo.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "Del femminismo liquido". Riprendere il filo di un altro discorso (di Rossella Ghigi - Il Mulino).8 marzo 2018, di Federico La Sala
IL MAGGIORASCATO (NON "PATRIARCATO"!). La crisi epocale dell’ordine simbolico di "mammasantissima" (alleanza Madre-Figlio) *
Del femminismo liquidodi Rossella Ghigi (Il Mulino, 08 marzo 2018)
Le vicende elettorali offuscheranno solo parzialmente lo spazio mediatico ogni anno occupato dalla Giornata della donna. Anche quest’anno, infatti, alcuni must non potranno mancare all’appuntamento dell’otto marzo: chi celebrerà le virtù delle donne, ricordando quanto esse “sappiano farcela” anche in condizioni difficili perché “hanno una marcia in più” (per non dire, con le solite espressioni, quanto siano mirabili se hanno “gli attributi” maschili anche propriamente detti, il che è tutto dire sul sessismo di questa figura retorica).
 Chi vorrà ricordare l’importanza di una giornata nata con un martirio, quello di operaie americane bruciate vive in un incendio perché il proprietario della fabbrica newyorkese dove questo avvenne (la Triangle? La Cotton? Le versioni non combaciano mai) le teneva lì rinchiuse. E chi osserverà come sono cambiati i tempi, quanto lontani fossero i cortei delle donne sulle strade a rivendicare diritti e libertà e come oggi sembri svuotata questa ricorrenza dalle allegre cene tra amiche, magari corredate dalla artificiosa ironia dello spogliarello maschile (perché “le giovani generazioni non sanno, hanno trovato tutto già pronto”).
Chi vorrà ricordare l’importanza di una giornata nata con un martirio, quello di operaie americane bruciate vive in un incendio perché il proprietario della fabbrica newyorkese dove questo avvenne (la Triangle? La Cotton? Le versioni non combaciano mai) le teneva lì rinchiuse. E chi osserverà come sono cambiati i tempi, quanto lontani fossero i cortei delle donne sulle strade a rivendicare diritti e libertà e come oggi sembri svuotata questa ricorrenza dalle allegre cene tra amiche, magari corredate dalla artificiosa ironia dello spogliarello maschile (perché “le giovani generazioni non sanno, hanno trovato tutto già pronto”).Il riferimento agli scandali sessuali e a forme più o meno glamourizzate o addomesticate del femminismo d’oltreoceano probabilmente sarà la novità mediatica di quest’anno, con riferimenti spesso immemori di una riflessione quasi secolare su questi temi. Sono tutti discorsi a cui siamo ormai assuefatti. E non si tratta, in fondo, semplicemente di decostruirne le basi - osservando, per esempio, che il mantra per cui le donne “ce la fanno” può finire per giustificare le lacune del welfare, o che il mito dell’incendio è stato contestato dalla storiografia (si veda il lavoro di Tilde Capomazza e Marisa Ombra a questo riguardo) ed è un’origine che “non impegna”, o che contraddizioni proprie di un contesto di circolazione di merci, informazioni e di persone globale, di catene transnazionali della cura e di digitalizzazione del dissenso vedono sì l’articolazione dei temi di genere in modalità nuove, intersezionali, attente alle istanze del Sud del mondo, ma anche il rifiorire di forme più tradizionali di contestazione di piazza (a cominciare dallo sciopero globale di oggi).
 Si tratta di capire, piuttosto, quanto del femminismo sia oggi effettivamente patrimonio comune, superando le facili critiche all’emancipazionismo da tastiera, al commercialismo del femvertising o alla spettacolarizzazione hollywoodiana, per aprirsi a una riflessione sulle potenzialità di forme inedite di condivisione delle esperienze come il #metoo o il movimento Non una di meno. Quanto di esso sia invece sdoganato - purché lo si annacqui un po’ e non lo si chiami con questo nome - e quanto sia invece tradito, laddove ormai nessuno, a destra come a sinistra, sembra sottrarsi all’elogio dell’uguaglianza nella differenza, della parità nella meritocrazia, della libertà nell’autoaffermazione individuale.
Si tratta di capire, piuttosto, quanto del femminismo sia oggi effettivamente patrimonio comune, superando le facili critiche all’emancipazionismo da tastiera, al commercialismo del femvertising o alla spettacolarizzazione hollywoodiana, per aprirsi a una riflessione sulle potenzialità di forme inedite di condivisione delle esperienze come il #metoo o il movimento Non una di meno. Quanto di esso sia invece sdoganato - purché lo si annacqui un po’ e non lo si chiami con questo nome - e quanto sia invece tradito, laddove ormai nessuno, a destra come a sinistra, sembra sottrarsi all’elogio dell’uguaglianza nella differenza, della parità nella meritocrazia, della libertà nell’autoaffermazione individuale.
 La filosofa Nancy Fraser si è pronunciata in proposito con una lettura molto chiara: i temi del femminismo sono stati fagocitati dal neoliberismo, allo stesso modo in cui, secondo Slavoj Žižek o Luc Boltanski, l’ambientalismo o la critica sociale del 68 lo sono stati dal capitalismo, trasformando cioè istanze di autenticità e giustizia in merci da consumare e in sistemi da riprodurre. Tuttavia, aggiunge Fraser, alcune condizioni strutturali emergenti possono permettere di non rimanere vittime delle seduzioni individualiste del capitalismo e di riprendere il filo di un altro discorso del femminismo di seconda ondata per molti versi abbandonato: quello della solidarietà sociale, della politicizzazione del personale e del rifiuto dell’economicismo.
La filosofa Nancy Fraser si è pronunciata in proposito con una lettura molto chiara: i temi del femminismo sono stati fagocitati dal neoliberismo, allo stesso modo in cui, secondo Slavoj Žižek o Luc Boltanski, l’ambientalismo o la critica sociale del 68 lo sono stati dal capitalismo, trasformando cioè istanze di autenticità e giustizia in merci da consumare e in sistemi da riprodurre. Tuttavia, aggiunge Fraser, alcune condizioni strutturali emergenti possono permettere di non rimanere vittime delle seduzioni individualiste del capitalismo e di riprendere il filo di un altro discorso del femminismo di seconda ondata per molti versi abbandonato: quello della solidarietà sociale, della politicizzazione del personale e del rifiuto dell’economicismo.Riprendere quel filo significa ripartire dalla struttura, dal tessuto economico e sociale, tralasciando affermazioni di principio più o meno liquide, ma osservando la materialità delle asimmetrie nel loro farsi quotidiano. Le dimensioni in cui questo avviene sono molte. Rielaborando la proposta di un classico testo degli anni Settanta, La condizione della donna di Juliet Mitchell (Einaudi, 1972), Raewyn Connell (2011) propone ad esempio di analizzare la asimmetria tra uomini e donne secondo quattro dimensioni.
 La prima, quella della produzione, del consumo e della accumulazione. La divisione sessuale del lavoro, la segregazione occupazionale, la discriminazione, i vari soffitti e labirinti di cristallo che separano uomini e donne lungo assi verticali e orizzontali della gerarchia lavorativa rappresentano la principale dimensione delle asimmetrie di genere riconosciuta nelle scienze sociali.
La prima, quella della produzione, del consumo e della accumulazione. La divisione sessuale del lavoro, la segregazione occupazionale, la discriminazione, i vari soffitti e labirinti di cristallo che separano uomini e donne lungo assi verticali e orizzontali della gerarchia lavorativa rappresentano la principale dimensione delle asimmetrie di genere riconosciuta nelle scienze sociali.
 La seconda, quella del potere, è stata un elemento cruciale nella analisi del funzionamento del sistema patriarcale elaborata dal femminismo radicale. Il potere dei mariti sulle mogli e dei padri sulle figlie è stato al centro di una riflessione critica dell’esperienza di sopraffazioni e violenze vissuta entro le mura di casa, riflessione che si è poi estesa ad ambiti extradomestici e forme più tacite di subordinazione, anche simbolica.
La seconda, quella del potere, è stata un elemento cruciale nella analisi del funzionamento del sistema patriarcale elaborata dal femminismo radicale. Il potere dei mariti sulle mogli e dei padri sulle figlie è stato al centro di una riflessione critica dell’esperienza di sopraffazioni e violenze vissuta entro le mura di casa, riflessione che si è poi estesa ad ambiti extradomestici e forme più tacite di subordinazione, anche simbolica.
 La terza, la dimensione emotiva, comprende le asimmetrie nelle aspettative che una società costruisce intorno all’espressione e alla gestione delle emozioni sulla base del genere, da cui discendono anche le attribuzioni di una diversa attitudine alla cura e alla dipendenza dagli altri: a seconda che siamo uomini o donne veniamo socializzati non soltanto a comportamenti e stati emotivi diversi, ma a una diseguale considerazione in termini di controllo di sé, degli altri e dell’ambiente.
La terza, la dimensione emotiva, comprende le asimmetrie nelle aspettative che una società costruisce intorno all’espressione e alla gestione delle emozioni sulla base del genere, da cui discendono anche le attribuzioni di una diversa attitudine alla cura e alla dipendenza dagli altri: a seconda che siamo uomini o donne veniamo socializzati non soltanto a comportamenti e stati emotivi diversi, ma a una diseguale considerazione in termini di controllo di sé, degli altri e dell’ambiente.
 La quarta, infine, è la dimensione culturale e discorsiva: in contesti che vanno dal linguaggio alle rappresentazioni visive, dal diritto alla religione, maschilità e femminilità vengono continuamente evocate e riprodotte, ribaltate e contestate, in condizioni di visibilità e accesso alle risorse che sono però asimmetriche e discriminanti (basti spesso invertire mentalmente i ruoli di donne e uomini per far emergere elevazioni e degradazioni simboliche degli uni e delle altre).
La quarta, infine, è la dimensione culturale e discorsiva: in contesti che vanno dal linguaggio alle rappresentazioni visive, dal diritto alla religione, maschilità e femminilità vengono continuamente evocate e riprodotte, ribaltate e contestate, in condizioni di visibilità e accesso alle risorse che sono però asimmetriche e discriminanti (basti spesso invertire mentalmente i ruoli di donne e uomini per far emergere elevazioni e degradazioni simboliche degli uni e delle altre).Liberamente ispirandoci a questa classificazione, proviamo qui a ricordare alcuni elementi che possano far riflettere sul senso di una Giornata della Donna in un Paese come il nostro, in cui molti indicatori suggeriscono che molta strada c’è ancora da fare. Per la prima dimensione, tratteremo delle diseguaglianze nel mercato del lavoro. Abbiamo già avuto modo, in questa rivista, di conoscere le difficoltà della conciliazione dovute alle carenze nei servizi (si veda Naldini e Santero); si tratta di osservare qui quali difficoltà le donne incontrino in termini di entrata e permanenza nel mercato del lavoro, specie quando decidono di essere madri.
 Per la seconda dimensione, ricorderemo i dati sulla violenza di genere e sulle forme che essa sta prendendo in un Paese dove una donna ogni due giorni viene uccisa per mano del partner o dell’ex partner (e il contrario non accade, è bene ricordarlo) e dove c’è ancora una forte carenza e disomogeneità nelle strutture di accoglienza e rifugio contro la violenza.
Per la seconda dimensione, ricorderemo i dati sulla violenza di genere e sulle forme che essa sta prendendo in un Paese dove una donna ogni due giorni viene uccisa per mano del partner o dell’ex partner (e il contrario non accade, è bene ricordarlo) e dove c’è ancora una forte carenza e disomogeneità nelle strutture di accoglienza e rifugio contro la violenza.
 Per la terza, si vedranno i dati riguardanti il permanere delle asimmetrie nella cura e nel lavoro domestico anche in epoca di “nuove paternità” e di “padri affettivi”, all’interno di un quadro della divisione del lavoro domestico particolarmente disequilibrato rispetto ad altri Paesi europei.
Per la terza, si vedranno i dati riguardanti il permanere delle asimmetrie nella cura e nel lavoro domestico anche in epoca di “nuove paternità” e di “padri affettivi”, all’interno di un quadro della divisione del lavoro domestico particolarmente disequilibrato rispetto ad altri Paesi europei.
 Per la quarta, infine, proporremo i dati di una recente indagine internazionale sulle donne nell’informazione di tv, radio e giornali, dalla quale emerge come l’Italia sia ancora lontana da una rappresentazione di genere fedele alla distribuzione delle competenze riconosciute in seno alla società.
Per la quarta, infine, proporremo i dati di una recente indagine internazionale sulle donne nell’informazione di tv, radio e giornali, dalla quale emerge come l’Italia sia ancora lontana da una rappresentazione di genere fedele alla distribuzione delle competenze riconosciute in seno alla società.Tutti i dati, naturalmente, risentono sempre dei limiti del contesto per cui sono prodotti e gli elementi che qui si mettono sul piatto non sono esenti dalle ambivalenze su cui ci allertava Fraser. Ma rappresentano dei tasselli per una presa d’atto del modo in cui, in questo paese, la differenza si fa disuguaglianza. Una consapevolezza da cui partire il nove marzo, liquidando facili enunciazioni di principio.
* Sul tema nel sito, si cfr.:
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO". Una riflessione di Massimo Cacciari su "cosa significa ereditare il passato"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - Quando la storia è sessuata. Un’intervista a Michelle Perrot (di Francesca Maffiol).2 marzo 2018, di Federico La Sala
Michelle Perrot, quando la storia è sessuata
Un’intervista con la militante, attivista e intellettuale francese. Cruciale la sua «Storia delle donne in Occidente», insieme a Georges Duby per Laterza nel 1990
di Francesca Maffioli (il manifesto, 02.03.2018)
Nel 1973 Michelle Perrot, insieme a Pauline Schmidt e Fabienne Bock intitolano il loro primo corso all’Università Paris-Diderot: Les femmes ont-elles une histoire? (Le donne hanno una storia?). Tale interrogativo, provocatorio, rappresentava il mezzo per affermare l’esistenza di un campo di conoscenza e di studio pressoché sconosciuto. La seconda generazione della scuola storiografica delle Annales aveva rinnovato le prospettive d’osservazione e d’analisi della storia, comprendendo la storia economica, quella sociale e la considerazione delle categorie oppresse, tra le quali spiccavano le donne. Tuttavia, nei primi anni Sessanta la storia insegnata anche in ambito universitario restava una disciplina tendenzialmente asessuata.
L’INTERROGATIVO delle giovani studiose aveva messo a fuoco la questione dell’invisibilità delle donne nella storia e aveva condotto a domande sui tempi, i luoghi e le modalità dell’oppressione e della dominazione maschile. La storia di questa dominazione aveva cominciato a mettere in risalto la place degli uomini attraverso i secoli, guardando al loro ruolo in quanto soggetti non universali né neutri, ma maschili. In tal senso era stato necessario esaminare e riflettere sul confronto e lo studio della differenza tra i sessi, al fine di consentire una visione più ampia, rinnovata, diremmo più completa, della storia.
Negli anni Novanta la pubblicazione dei cinque volumi della Storia delle donne in Occidente, opera curata dalla stessa Michelle Perrot e da Georges Duby, costituisce uno spartiacque di riconoscenza della legittimità di una storia delle donne. È da ricordare che tale pubblicazione venne proposta e sostenuta dall’editrice italiana Laterza, solo a seguito della quale l’opera venne editata anche in Francia. La riflessione epistemologica attorno alla storia delle donne resta ancora valida, sebbene da una storia in cui le donne sono le protagoniste assenti si è passati a una storia sessuata del mondo intero. Ne chiediamo conto proprio a Michelle Perrot, oggi professoressa emerita all’Università Paris-Diderot, autrice di numerosi testi sulla storia delle donne, tra i quali Mon histoire des femmes (Seuil, 2006) e direttrice, con Georges Duby, del già citato Histoire des femmes en Occident, (Plon, 1991-1992).
La sua opera sulla storia delle donne in occidente ha conosciuto un grande successo. Si tratta di un frutto monumentale - sulla storia della rappresentazione delle donne e sulla storia dei rapporti tra i sessi attraverso i secoli. Quale il legame, quale la connessione, nella storiografia femminile, tra la storia della vita privata e quella pubblica?
È doveroso riconoscere la lungimiranza della casa editrice italiana Laterza, la quale chiese a Georges Duby, ed egli a me, di scrivere una storia delle donne. In realtà l’equipe che lavorò all’opera si era formata molto prima, circa 10 anni, e le nostre riflessioni erano già arrivate a un certo livello di maturazione. Per me e l’equipe (una settantina di persone) fu prioritario che il titolo portasse il sostantivo «donne» al plurale, per rappresentare un panorama tanto composito.
Bisogna tener conto che Duby codiresse precedentemente un’opera a più volumi che trattava della «storia della vita privata», dall’impero romano fino ai giorni nostri; questo aspetto dimorava ampiamente nella sua prospettiva di ricerca. Certo, quando si pensa alla storiografia femminile l’aspetto «del privato» non può essere trascurato, in ordine al legame intrinseco, secolare, tra donne-famiglia-casa; tuttavia a me interessava descrivere in che modo il legame tra le donne e la dimensione pubblica poteva costituirsi come dispositivo per rendere visibili le donne e la loro parola alla luce di una «storia pubblica» che le ignorava. Significava andare oltre la questione privata dei legami e delle strutture della parentela ad esempio, significava distaccarsi da Lévi-Strauss. Per me si trattava anche di una sorta di evoluzione rispetto al debutto dei miei studi: sono stata allieva di Ernest Labrousse, storico e militante anarchico, poi socialista e con lui mi ero specializzata sulla questione degli scioperi in seno al movimento operaio. Non senza stupore da parte del mio maestro sono passata a occuparmi della storia delle donne. Nonostante le polemiche a tal proposito, in particolare mi riferisco a quelle che hanno visto il femminismo degli anni Sessanta «traditore» delle istanze della lotta operaia, sono convinta che le due prospettive non siano da considerarsi in opposizione o inconciliabili. Anzi il contrario.
Fare la storia delle rappresentazioni e dei discorsi maschili riguardo le donne può rischiare di farci dimenticare le donne in quanto soggetto?
Non posso negare che il rischio sia presente, anche in misura piuttosto decisiva. In effetti la storia delle rappresentazioni e dei discorsi maschili mette in luce una prospettiva parziale e circoscritta. Tuttavia possiamo analizzare lo stesso attraverso la differenza dei sessi, possiamo cercare di interrogarlo, di decostruirlo. Faccio un esempio: invece di studiare il tema della «bellezza femminile» attraverso i secoli, secondo la prospettiva dello sguardo maschile, si può farlo chiedendosi come le donne hanno reagito a tale sguardo e qual è il loro. Si tratta di essere in grado di capovolgere delle prospettive attraverso la consapevolezza della loro parzialità. Credo che il recente movimento del #me too possa a tutti gli effetti rappresentare un esempio del capovolgimento di prospettiva e una rideterminazione del ruolo delle donne, a fronte dell’invisibilizzazione e del silenziamenento forzato. Non esito a ribadire che protestare contro le violenze, le più subdole, vuol dire rideterminare il proprio ruolo e reimpossessarsi della propria voce e del proprio corpo in quanto soggetti.
Da quale momento, nella storia delle donne in occidente, possiamo cominciare a parlare di «svolte storiche» per i rapporti tra i sessi? E a partire da quale momento si comincia a percepire il mondo e la storia come sessuate?
Questo interrogativo mi consente di dichiarare a piena voce che il mio punto di vista riguardo a queste svolte storiche coincide con quello di Michel Foucault esposto nella sua Histoire de la Sexualité (1976-1984). Credo infatti che una grande svolta sia stata quella che ha coinciso con la maturazione del pensiero sulla sessualità sviluppato nei testi dell’antichità cristiana; non il pensiero sessuato greco-romano ma soprattutto quello dei padri della Chiesa, in particolare S. Agostino. L’incisività di quest’ultimo limitatamente alla peccaminosità dell’atto sessuale o all’imposizione del velo definiscono la sua auctoritas sul pensiero del rapporto tra i sessi. Tengo a sottolineare quest’ultimo aspetto, per ribadire «il primato» della patristica a fronte delle polemiche che da anni si susseguono a tal proposito. Anche il XVII secolo, di prospettive sorprendentemente egualitarie, rappresenta una svolta storica: penso a François Poullain de La Barre e a Marie de Gournay - in che misura il loro razionalismo ha prodotto delle svolte di pensiero sull’eguaglianza dei sessi. Bisogna sottolineare che si può assistere anche a regressi in tal senso: un esempio è stato il secolo successivo, il XVIII, che ha rimesso in discussione quanto sembrava acquisito, con un ritorno al biologismo più basilare e alla «re-naturalizzazione».
Che ne pensa della tendenza a concepire una storia delle donne attorno alle grandi figure, secondo «un sostenersi» alle singolarità, alle biografie di donne più o meno celebri? Mi riferisco in tal senso alla recentissima traduzione francese di «Storie della buonanotte per bambine ribelli» (Mondadori), ma anche a «Ni vues ni connues» (Hugo doc-Les Simone) del collettivo Georgette Sand...
È un modo come un altro di scrivere la storia delle donne. Tuttavia io trovo che facilmente possa incorrere nel rischio di integrarsi a una tradizione decisamente datata. Mi riferisco a quel biografismo che si attiene a fatti curiosi: penso al biografismo «delle regine, delle sante e delle cortigiane». In questo senso si rischia di perdere la ricchezza della complessità e la storia delle donne rischia di diventare aneddotica.
Cosa ci resterebbe della «Nouvelle Histoire» e della scuola delle «Annales»?
Credo che tale formula possa funzionare solo nella misura in cui l’orizzonte di osservazione delle storiche e degli storici sia aperto. Intendo dire che lo studio delle biografie e degli avvenimenti rivela certi limiti; penso che invece di soffermarsi su individui o eventi eccezionali sarebbe auspicabile studiare le «strutture» e recuperare nuovi soggetti storici, più ribelli e dimenticati.
Non voglio essere troppo severa, anche a me è capitato di redigere capitoli o testi in cui un certo biografismo predominava, tuttavia l’ho sempre fatto col beneficio degli apporti delle scienze umane, che considero espedienti irrinunciabili. La storia dovrebbe avere priorità collettive e problematizzare lo studio sulle differenze tra i sessi, come fanno ad esempio gli studi femminili e di genere.
DAL MOVIMENTO OPERAIO AL FEMMINISMO
Storica e militante femminista, MIchelle Perrot nasce nel 1928 a Parigi. Nel 1947 comincia i suoi studi alla Sorbona; la sua tesi, diretta da Ernest Labrousse, tratta il tema degli scioperi operai. Fin dalla pubblicazione de «Il Secondo sesso» di Simone de Beauvoir desidera avvicinarsi alle scritture delle donne, fino a creare (nel 1974) insieme a Françoise Basch il Ged (Gruppo di studi femministi), sui temi dell’aborto, della violenza sessuale, del lavoro domestico, dell’omosessualità. Professoressa emerita di storia contemporanea all’università Paris VII - Denis Diderot, ha contribuito in maniera decisiva alla nascita degli studi sulle donne e sul genere ed è stata insignita nel 2014 del Prix Simone-de-Beauvoir per la libertà delle donne. Tra le sue opere tradotte in italiano figurano i cinque volumi della «Storia delle donne in occidente» (Laterza), «Immagini delle donne» (Laterza e «Storia delle camere» (Sellerio).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- BASTA CON LE ROBINSONATE. "Per una filosofia affermativa". Il negativo è il limite che attraversa la vita.1 marzo 2018, di Federico La Sala
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE.... *
Il negativo è il limite che attraversa la vita
Storia delle idee. «Politica e negazione. Per una filosofia affermativa» di Roberto Esposito, pubblicato da Einaudi. Il filosofo si interroga su un’inarrestabile deriva nichilista e esplora le radici dell’alternativa di un pensiero affermativo. Una riflessione che porta la vita alla sua massima espansione senza sottrarsi a nessun conflitto. La scoperta di Spinoza per il quale la sapienza è una meditazione sulla vita, non un pensiero sulla morte. Quello del filosofo non è incauto ottimismo, né cieco volontarismo. Conosce la potenza che ci abita
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 28.02.2018)
In giorni oscuri torniamo a interrogarci sulla negazione. L’avevamo rimossa, avevano detto che la storia era finita e avremmo vissuto in un eterno presente pacificato. Ci siamo risvegliati in una specie di guerra civile mondiale dove la negazione è intesa come distruzione della vita: il terrorismo jihadista che rivendica il potere di dare la morte in maniera indiscriminata. Oppure lo stragismo fascista e razzista contro gli immigrati, rovescio diabolico di una risposta uguale e terribile.
ABBIAMO PERSO il contatto con l’idea per cui il negativo sia l’anima del reale, ciò che lo spinge a rovesciare la contraddizione e affermare la vita. Il negativo è invece inteso come una negazione senza rimedio. Oltre il suo «non» c’è il niente. Il «negare» ritrova la sua lontana origine latina: «necare», uccidere. Tutto sembra essere stato assorbito da un dominio di un potere assoluto che non salva, ma uccide anch’esso. Sfumano così le distinzioni che hanno costruito la politica moderna: quella tra guerra e pace, tra il militare e il civile, tra il criminale e il nemico. Anche davanti a fenomeni meno estremi - il lutto, l’afasia, il dolore, la precarietà, la contraddizione più acuta - sembriamo incapaci di afferrare il negativo con categorie diverse dalla distruzione della differenza che abita l’essere.
SIAMO IN UN’«INARRESTABILE deriva nichilista di una negazione sfuggita di mano a chi l’ha teorizzata - scrive Roberto Esposito nel suo ultimo libro Politica e negazione. Per una filosofia affermativa (Einaudi, pp. 207, euro 22) - La logica del nichilismo si traduce in un’ontologia dell’inimicizia». E «l’annientamento diventa auto-annientamento». L’altro va distrutto per affermare un’identità tanto autentica, quanto fittizia e mortifera: l’identità nazionale e «sovrana», oppure la proprietà e la concorrenza tra individui atomici e disperati.
C’E’ STATO UN TEMPO in cui si è ritenuto che il nemico fosse chiaro, almeno dal punto di vista della razionalità politica. Questa logica, in realtà, non era così ferrea, tanto è vero che lo stesso Carl Schmitt in Teoria del partigiano ne ha indicato i limiti. Se a Lenin è stata riconosciuta una superiorità politica per avere trasformato il Capitale da «vero nemico» in «nemico assoluto» (ricambiato dall’altra parte), la deriva nichilistica dell’annientamento non è stata fermata. Anzi, si è intensificata.
POLITICA E NEGAZIONE è alla ricerca di un’alternativa. Esposito riparte dal significato di «negazione» e conduce un corpo a corpo con Hegel, il grande pensatore di questa categoria. Non c’è dubbio che il negativo sia l’essere altro da sé, il superamento verso qualcosa che non ritorna all’identico. Il punto è che non è l’espressione di una negatività di fondo dell’essere, un divenire privo di determinazioni che non siano quelle rispetto a se stesso. Il negativo fa parte della vita: è la sua necessità. Per questo va contestualizzato, non generalizzato. È una forma dell’affermazione, non l’elemento originario che annulla l’essere.
IL NEGATIVO RIGUARDA anche l’azione, il modo in cui concepiamo le relazioni e la politica. Non è un ostacolo o una forza contraria che si oppone alla libera volontà di chi vuole affermare qualcosa. Il «non» - ovvero il conflitto, la contraddizione - non è esterno al soggetto, ma è interno ad esso. Il negativo è il limite che attraversa la vita costretta tra necessità e finitezza. E tuttavia non è la fine di qualcosa, ma l’indice di ciò che potrebbe essere. Non è l’annichilimento della vita, ma «il punto vuoto che spinge il presente oltre se stesso», scrive Esposito. Lo scopo di questo approfondimento vertiginoso è modificare la nostra disposizione verso la vita. Se la vita è imprigionata nel negativo, allora è immobile povera e paranoica. Se invece è un momento determinato di un divenire storico che si sporge oltre se stesso, allora diventa una pratica.
PER AFFRONTARE questa impresa Esposito si è rivolto a Spinoza, l’unico filosofo che ha dato una definizione affermativa della negazione. Spinoza, il grande eretico aggredito da Hegel e sistematicamente travisato dai suoi posteri. Per lui la sapienza è una meditazione sulla vita, non un pensiero sulla morte. È una meditazione su ciò che può fare una vita, non su ciò a cui deve rinunciare per sopravvivere. Questa è ancora oggi la sua gloria: avere una grande fiducia nella vita e denunciare tutti i fantasmi del negativo.
OGGI POSSIAMO INTUIRE quanto contro-corrente possa essere un simile atteggiamento. Ma questa è la vocazione «inattuale» del filosofo. Il suo non è incauto ottimismo, né cieco volontarismo. Conosce la potenza che ci abita, a dispetto del negativo che ci circonda. Ha fiducia nelle potenzialità della vita, come nell’amore per il mondo e per chi lo vive.
L’APPRODO ALLO SPINOZISMO di un filosofo importante come Esposito non è improvvisato. Già in passato aveva parlato di «biopolitica affermativa». Oggi parla di «filosofia dell’affermazione». Una definizione rilevante in un panorama culturale come quello italiano dove prevale un «pensiero del negativo» che porta ad esiti impolitici, elitari o addirittura teologici. Il pensiero affermativo non è un positivismo del fatto compiuto, né una stanca decostruzione. Indica la strada per una nuova forma di materialismo, istanza che sembrava remota, o riservata a poco, fino a poco tempo fa.
SUL PIANO POLITICO questa filosofia mette in discussione la «sovranità», il fantasma di tutti i dibattiti politici o economici. Con «sovranità» si allude a uno Stato che nega l’inimicizia degli uomini e impone il monopolio della violenza. Esiste, invece, un’altra concezione dello «Stato» che incanala la potenza istituzioni capaci di salvaguardarne l’esistenza. In questo modo «il governo degli uomini non passa per una denaturazione della vita», ma da una forma immanente di auto-governo che mira al raggiungimento del «punto massimo della propria espansione». È la differenza che passa tra una politica sulla vita e una politica della vita, per usare le categorie di Esposito.
UNA «FILOSOFIA DELL’AFFERMAZIONE» non nega l’esistenza del conflitto - il negativo - né allude a una pacificazione come fa la retromania che devasta il dibattito pubblico attuale. Il conflitto è un elemento della relazione, oltre che della creazione di nuove istituzioni. Per renderla concreta è necessaria una politica dell’amicizia.
NELLA POLITICA novecentesca l’amicizia è stata considerata una categoria parassitaria dell’inimicizia. O amici, non ci sono amici in questo mondo. E così il mondo si scopre popolato solo da nemici. Davanti a questo paradosso va sperimentata una prassi politica che metta insieme corpo e intelletto, materia e spirito, vita e forma, e non rifugga ma abbracci il conflitto. Una politica dell’amicizia consiste nel costruire opere comuni, nel saperle difendere e nell’affermarle.
LA SOLIDARIETA’ E LA FRATELLANZA vanno riscoperti come strumenti affermativi, non come mezzi per attaccare il diverso. Creano legami, non impongono vincoli. Se intesi come strumenti del conflitto servono a liberarsi da ciò che impedisce di godere insieme di quello che abbiamo: la carne, la nascita, il corpo, la differenza e, più in generale, l’idea che la norma (giuridica, politica, sociale) nasca dalla vita in comune. L’amicizia è capace di affermare qualcosa che è in potenza e a disposizione di tutti. È tempo di imparare a coglierne i frutti.
*SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
 "Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
"Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero". Si può smontare il meccanismo teologico di sudditanza all’Uno su cui si fondano i rapporti di potere?
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE. A partire da due, e non da uno!!! Una nota su una polemica tra "esportatori di democrazia" e di "libertà" (Giovanni Sartori e Gian Maria Vian) e la proposta di una Fenomenologia dello Spirito di "Due Soli". Con Rousseau, Kant, Marx, Freud e Dante, oltre Hegel, per una seconda rivoluzione copernicana.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. MARX, IL "LAVORO - IN GENERALE", E IL "RAPPORTO SOCIALE DI PRODUZIONE - IN GENERALE".Federico La Sala
- IL "DUE" DI SAUSSURE VINCE IL "DUE" DI ROBERTO ESPOSITO. Un commento di Remo Bodei sul suo ultimo lavoro
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - Una nota a "Guerra di genere. Una modesta proposta" (Paolo Fabbri)21 febbraio 2018, di Federico La Sala
GUERRA DI GENERE... E CONVERSAZIONE INFINITA. Una modesta considerazione....
Una nota a "Guerra di genere. Una modesta proposta" (di Paolo Fabbri, Alfabeta2)
Se non ricordiamo più "(...) la prima messa in italiano dopo due millenni di *latinorum* e la distruzione della statua del padrone illuminato Marzotto ad opera di scioperanti iconoclasti(...)" e non sappiamo più e nemmeno distinguere tra chi grida "forza Italia" e chi grida «"forza Italia"», come è possibile venir fuori dalla "fattoria degli animali" e accedere allo Spazio *neutro* e alla Terra *neutra*?! *
Abbiamo dimenticato della connivenza tra *grammatica* e *metafisica* e che , rispetto alla *lingua*, la coscienza «arriva dopo, zoppicando»; che "non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza"?!
"Come sarebbe questo italiano neutro?". Per andare oltre *Scilla* e *Cariddi*, forse, non potremmo e dovremmo chiedere ancora (e di nuovo) consulenza al mondo greco e alla società greca, quello e quella di Omero, Ulisse e Penelope?! O vogliamo continuare ancora (e sempre?) il vecchio *gioco* dell’ «io parlo, io mento» e dell’«io mento, io parlo»?!
Federico La Sala
* Sul tema, mi sia lecito, si cfr. "Paolo Fabbri, la conversazione infinita" (Maria Pia Pozzato, Alfabeta2).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - OSSERVARE "SE STESSO COME UN ALTRO". "Lo spettacolo di sé. Filosofia della doppia personalità"(Barbara Chitussi)..16 febbraio 2018, di Federico La Sala
UN PASSO AL DI LÀ DEL NARCISISMO E DELL’EDIPO: "SE’ COME UN ALTRO". OSSERVARE SE STESSI, SE STESSE ... CON "SIMPATIA"! *
- PER "un’etica della non-coincidenza con sé quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”». nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”» (Paolo Godani).
Il tizio che mi guarda dallo specchio
di Paolo Godani (Alfabeta-2, 11.02.2018)
- Barbara Chitussi, Lo spettacolo di sé. Filosofia della doppia personalità, Meltemi, 2018, 298 pp., € 16
L’attuale eclissi della psicanalisi, cioè la marginalizzazione della sua posizione epistemologica e della sua funzione sociale in favore delle scienze cognitive, è un’ottima notizia per almeno due ragioni. Innanzitutto perché, come alcuni segni già invitano a immaginare, c’è la possibilità che la psicanalisi stessa, da una posizione di minorità, torni a produrre qualcosa di interessante. Ma anche perché può ora riapparire, in tutto lo splendore che la bolla psicanalitica aveva lungamente offuscato, l’immenso patrimonio della ricerca psichiatrica, soprattutto francese, cresciuta nella seconda metà del XIX secolo.
Jean-Martin Charcot, Théodule Ribot, Alfred Binet, Pierre Janet, solo per nominare gli autori un tempo più celebri di questa età dell’oro della psicologia francese, non sono stati soltanto curiosissimi ricercatori sperimentali, ma anche e soprattutto inventori di ipotesi, spiegazioni, concetti che ancora sfidano l’asfissia della cultura contemporanea.
 Lo dimostra brillantemente Barbara Chitussi che in un saggio appena uscito da Meltemi non solo, quasi come in un romanzo, mette in scena i casi clinici, le storie fantastiche di personalità multiple di cui si sono occupati gli psichiatri francesi, ma ne trae il materiale teorico per costruire una vera e propria filosofia della personalità. «Se mi sono occupata dell’analisi di questi casi - spiega l’autrice fin dall’introduzione - è stato per studiare in una prospettiva filosofica le strategie con le quali il soggetto si è pensato e costruito nella forma di un rapporto con sé, accettando di essere un personaggio, assumendo l’inautenticità della propria immagine, aprendosi al dominio della finzione attraverso l’imitazione dell’altro, o meglio osservandosi come uno spettatore osserva uno spettacolo».
Lo dimostra brillantemente Barbara Chitussi che in un saggio appena uscito da Meltemi non solo, quasi come in un romanzo, mette in scena i casi clinici, le storie fantastiche di personalità multiple di cui si sono occupati gli psichiatri francesi, ma ne trae il materiale teorico per costruire una vera e propria filosofia della personalità. «Se mi sono occupata dell’analisi di questi casi - spiega l’autrice fin dall’introduzione - è stato per studiare in una prospettiva filosofica le strategie con le quali il soggetto si è pensato e costruito nella forma di un rapporto con sé, accettando di essere un personaggio, assumendo l’inautenticità della propria immagine, aprendosi al dominio della finzione attraverso l’imitazione dell’altro, o meglio osservandosi come uno spettatore osserva uno spettacolo».Tutto è iniziato, si potrebbe dire, negli anni che seguono il 1875, quando la Francia sembrava attraversata da un’epidemia di personalità multipla. Tra i casi anonimi, raccolti dal dottor Krishaber e analizzati da Émile Littré, c’è chi «voleva parlare, ma fu costretto a interrompersi, tanto il suono della sua voce lo stordiva», chi credeva di «non essere di questo mondo», chi sentiva in sé stesso «un io che pensa e un io che esegue». Ma, come accade spesso, il brusio delle voci senza volto finisce per raccogliersi nel fulgore di un nome che quelle voci, tutte, le fa risuonare assieme. «Racconterò - spiega in un articolo del 1876 il chirurgo-psicologo Eugène Azam - la storia di una giovane donna la cui esistenza è tormentata da un’alterazione della memoria che non ha precedenti nella scienza; l’alterazione è tale che è lecito chiedersi se questa giovane donna non abbia due vite». La ragazza di cui parla Azam si chiama Félida, è «bruna, di statura media», molto intelligente e piuttosto istruita, seria, taciturna, grande lavoratrice, «di carattere triste e persino cupo». O meglio, triste e cupa Félida appare di solito sino al momento della sua crisi. Le accade infatti, talvolta, di cadere improvvisamente nel sonno e di risvegliarsi in uno stato che non è più quello nel quale si era addormentata: «solleva la testa e aprendo gli occhi saluta sorridendo i nuovi arrivati, la sua fisionomia si illumina emanando allegria». Dopo il sonnellino o la catalessi, insomma, «il suo carattere è completamente cambiato; da triste è diventata allegra e la sua vivacità raggiunge l’impetuosità, la sua immaginazione è più esaltata». Per spiegare che cosa significhi e come possa accadere che la malinconica Félida-1 lasci il posto all’estroversa Félida-2, gli psicologi si lanciano nell’invenzione di nomi e concetti: amnesia periodica, raddoppiamento o sdoppiamento della vita, doppia coscienza o doppia esistenza, per arrivare alla nozione più carica di conseguenze: sdoppiamento della personalità.
Come nota con finezza Barbara Chitussi, gli psicologi che a proposito del caso di Félida iniziano a parlare di doppia personalità, operano a loro volta uno sdoppiamento dello stesso termine di personalità. Non più sinonimo di coscienza o di vita, la personalità torna ora a riavvicinarsi al significato originario del latino persona: avere una personalità significa ormai «indossare una maschera, avere un particolare modo di essere». Passaggio decisivo, con ogni evidenza, che consentirà a Pierre Janet di verificare la distinzione tra un moi interiore e un moi esteriore, tra un sentimento della pura esistenza di sé, cioè di un’esistenza indipendente da qualsivoglia attributo, qualità o maschera, e un sentimento della propria personalità, che come tale è complessa e variabile, nonché esteriore rispetto al mero sentimento dell’esistenza. Ma passaggio decisivo, questo, lo è soprattutto perché stabilisce che la personalità di ognuno non è un che di sostanziale, ma semmai un modo, una maniera di essere, una postura, un’immagine che può essere assunta o rigettata, un abito che si può indossare, ma anche cambiare e sostituire.
Da qui in avanti, il percorso dell’autrice attraversa una molteplicità di campi all’interno dei quali la questione della personalità, confrontata con problematiche diverse come lo sdoppiamento nel sogno, la costruzione immaginaria di un sé ideale in quello che si chiamerà «bovarismo», le questioni della co-coscienza e della doppia moralità, assume nuove connotazioni. Ma questa varietà di campi problematici - ognuno con i suoi casi singolari che rendono Lo spettacolo di sé così avvincente (fra cui non si può passare sotto silenzio l’affascinante e riottosa Sally, una delle personalità della «famiglia Beauchamp», analizzata da Morton Prince) - non toglie nulla alla compiutezza filosofica del testo.
La sua tesi fondamentale è che il soggetto è un rapporto, cioè che la formazione soggettiva di ognuno avviene sempre e soltanto attraverso lo sdoppiamento di sé, prendendo distanza da ciò che si è o si crede di essere, trattando se stessi come altri. In questo senso, il sé figura come una contrattazione continua, come un campo sul quale si alternano una pluralità di caratteri o personaggi, nessuno dei quali può affermare di essere l’autentico rappresentante del soggetto.
 «Ripensare il paradigma della personalità-maschera - spiega di conseguenza
l’autrice - significa [anche] disancorare nuovamente la vita personale [...] dall’ottusa identità della vita biologica». Infine, è ancora un’etica della non-coincidenza con sé, quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”».
«Ripensare il paradigma della personalità-maschera - spiega di conseguenza
l’autrice - significa [anche] disancorare nuovamente la vita personale [...] dall’ottusa identità della vita biologica». Infine, è ancora un’etica della non-coincidenza con sé, quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- DIFFIDO DEL’ISTRUZIONE DI "PIGMALIONE".6 febbraio 2018, di Federico La Sala
"PIGMALIONE", UNA "FIGURA" NARCISISTICA ED EDIPICA, ANCORA MODELLO DI ESSERE UMANO E DI MAESTRO?!
- L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore. Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale (...) Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi (Alessandro D’Avenia)
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
Diffido dell’istruzione
di Alessandro D’Avenia (Corriere della Sera, 05.02.2018)
«Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. Ho visto ciò che nessuno dovrebbe vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti, bambini avvelenati da medici ben formati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati e laureati. Diffido - quindi - dell’istruzione. Aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri formati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani».
 Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.
Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.Il divorzio tra istruzione ed educazione è uno dei mali peggiori della scuola, frutto del luogo comune secondo cui esisterebbe un’istruzione neutra. Invece sempre si educa mentre si istruisce, perché la prima comunicazione è quella dell’essere, e solo dopo arrivano le parole, altrimenti non sarebbe necessaria la relazione viva con i ragazzi, ma basterebbe caricare le lezioni sulla rete. In senso stretto non esiste insegnamento in differita , ma solo in diretta.
Insegnare è una branca della drammaturgia. È l’essere dell’insegnante che genera la conoscenza, perché apre la via al desiderio dello studente, che scorge nel docente una vita più viva e libera grazie alla cultura e al lavoro ben fatto, e la vuole anche per sé. Lo ricordava con precisione il Nobel Canetti nella sua autobiografia: «Ogni cosa che ho imparato dalla viva voce dei miei insegnanti ha conservato la fisionomia di colui che me l’ha spiegata e nel ricordo è rimasta legata alla sua immagine. È questa la prima vera scuola di conoscenza dell’uomo».
Le nozioni più raffinate da sole non rendono umani, tutto dipende da come gli insegnanti si relazionano tra loro e con i ragazzi, perché, prima delle nozioni, sono le relazioni a essere generative dell’io e del sapere. È nella relazione che si impara a sentire il valore del sé come destinatario del dono del sapere. Quali insegnanti siete tornati a ringraziare e per cosa? Per la lezione sulle leggi della termodinamica e su Leopardi, o per come vivevano e offrivano la termodinamica e Leopardi proprio a voi?
Qualche tempo fa mi scriveva uno studente: «Le racconto due esperienze. La prima: la faccia polverosa della scuola. Un professore, che aveva esordito in prima liceo con “siete troppi: vi ridurremo”, pochi giorni fa ha condensato l’amore per il suo lavoro in questa frase: “Un insegnante non deve avere cuore, deve avere un cuore di pietra... altrimenti farà preferenze”. Uno scherzo, pensavamo. Un mio compagno ribatte: “Ma no, prof! Un insegnante deve avere un cuore talmente grande da non fare nessuna preferenza!”. “No, no: un cuore di pietra”. Parlava seriamente. La seconda: la faccia luminosa della scuola. Quest’anno ho scoperto la poesia grazie al gesto straordinario di un ordinario professore di filosofia, che un giorno ci ha parlato della sua giovinezza e di come la poesia ai tempi occupasse la sua vita e impegnasse la sua fantasia. Interessato anche io dal momento che non avevo letto nessun grande poeta ho chiesto un consiglio. Il giorno seguente lo vedo estrarre dalla sua ventiquattrore un libricino invecchiato. Viene verso di me. “Questo è per te”. Mi ha regalato una delle sue copie di Elegie duinesi, di R.M. Rilke, il suo libro di poesia preferito. Il libro della sua giovinezza!».
La differenza tra le due impostazioni è proprio quella che corre tra chi si illude si possano separare istruzione ed educazione e chi invece le tiene naturalmente unite. Nel primo caso si pensa che il docente sia un distributore di nozioni, nel secondo la didattica è conseguenza della relazione. Il primo professore educa all’insensibilità di cuore, a non sentire l’unicità del tu, il secondo rende Rilke interessante prima di averne letta una riga. Il nesso che tiene unite istruzione ed educazione è nella realtà, e nessuna presa di posizione teorica le può nei fatti separare. L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore.
Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale. Non si può aumentare la conoscenza di qualcosa senza che prima aumenti l’interesse nei confronti del soggetto in questione (vale per l’amicizia come per la chimica). L’amore genera conoscenza e la conoscenza ampliata rinnova l’amore: se il docente non «erotizza» la materia, la materia per quanto ben conosciuta resta inerte, come spiega Massimo Recalcati.
Non esistono cose poco «interessanti», ma uomini e donne poco «interessati», perché le emozioni (la neurobiologia qui ci conforta) sono le guide che aprono la strada allo sviluppo cognitivo. Solo così gli studenti diventano soggetti di possibilità e non oggetti al peggio da ridurre o al meglio da riempire. È questa la rivoluzione copernicana chiesta a ogni docente: non sono gli alunni a ruotare attorno a lui ma il contrario. Un professore - il letto da rifare oggi lo suggerisce lo studente della lettera - è chiamato ad avere un cuore tale da non far preferenze perché preferisce tutti e ciascuno diversamente: sfida difficilissima (quanti errori, quante gioie...) ma decisiva.
È la stessa sfida narrata da Ovidio, nelle sue Metamorfosi, a proposito del mito di Pigmalione. Uno scultore che, deluso da tutte le donne, si innamora della donna ideale che ha scolpito nel marmo. Il suo trasporto è tale che gli dei trasformano la statua in una donna in carne e ossa. Il mito viene usato per descrivere lo sguardo educativo, il cosiddetto effetto-Pigmalione, per il quale se un docente (ma vale per ogni educatore) guarda un alunno convinto che farà bene, genererà in lui una fiducia in sé tale che, nella quasi totalità dei casi, anche a fronte di un’inadeguata disposizione iniziale, otterrà risultati positivi.
L’effetto vale anche in negativo: se sono convinto che non vali, l’effetto sui risultati sarà coerente, anche a fronte di buone capacità. Lo sguardo educante non è mai neutro ma sempre profetico, nel bene e nel male. Ne abbiamo conferma quotidiana nel bambino che, appena caduto, si volge verso i genitori: se si mostrano allarmati ne provocano il pianto, se sorridenti il sorriso, quasi che il dolore, pur oggettivo, venga trasformato nello e dallo sguardo.
I ragazzi non hanno bisogno di insegnanti amiconi né aguzzini, ma di uomini e donne capaci di guardarli come amabili soggetti di inedite possibilità a cui non fare sconti. E non è questione di missione o di poteri magici, ma di professionalità. Per questo l’appello è il momento chiave della giornata scolastica: segna il tono della relazione e fa sì che ognuno senta su di sé lo sguardo profetico che spinge a far bene come conseguenza dell’ esser bene. Il contrario del «siete troppi, vi ridurremo», sterile autoritarismo, è il fecondo «sei unico, ti aumenterò».
La parola autorità viene da augeo (aumentare): la esercita non chi ha il cuore molle o sprezzante, ma chi si impegna ad aumentare la vita che ha di fronte, per quanto fragile, difficile, resistente possa sembrare. Questa è l’istruzione di cui non diffido, perché ispirata da un umanesimo maturo, l’umanesimo dell’altro uomo, come lo chiama il filosofo Lévinas, che fa del tu il cuore dell’etica e smaschera il falso umanesimo dell’istruito incapace di sentire il tu, tanto da distruggerlo proprio attraverso l’istruzione.
Non è facile però essere educatore in un sistema scolastico che asfissia di burocrazia e svilisce la dignità sociale ed economica, e in un contesto culturale che spesso attacca dall’alto (genitori) e dal basso (studenti). Ma questi elementi possono anche diventare scuse per non fare ciò che è alla portata di un uomo libero: prendersi cura di chi gli viene affidato.
Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
- "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- #Metoo. Parlano le donne parlano (di Ida Dominijanni - #ViaDogana3)3 febbraio 2018, di Federico La Sala
Parlano le donne parlano - Ida Dominijanni
Introduzione all’incontro di Via Dogana 3: Parlano le donne parlano domenica 14 gennaio 2018
Ida Dominijanni
1.Il movimento #metoo - slogan inventato dieci anni fa da una donna nera, Tamara Burke - esplode negli Stati uniti il 15 ottobre dell’anno scorso, a seguito dello scandalo Weinstein, e si diffonde a macchia d’olio su scala pressoché planetaria: due settimane dopo, a inizio novembre, il Newsweek conta due milioni e trecentomila tweet in 28 paesi - ai primi posti Usa, Canada, Brasile, Messico, Gran Bretagna, Svezia, Francia, Italia, Germania, Australia, India, Giappone, Sudafrica[1]. L’11 gennaio il New York Times elenca 78 uomini “high profile” - appartenenti ai circuiti della politica, dei media, dell’intrattenimento, dell’accademia - accusati dalle loro vittime di molestie o “cattiva condotta sessuale” (sexual misconduct) e licenziati, o sospesi, o costretti a dimettersi: tra loro sei esponenti politici, parlamentari o uomini di partito, e tra questi l’ex comico democratico Al Franken, il caso forse più controverso e Roy Moore, candidato repubblicano al Senato, cha ha perso le elezioni in Alabama anche in seguito alle denunce femminili di sexual harassment e pedofilia[2]. Parzialmente diverso il quadro in altri paesi. In India ad esempio - uno dei casi di #metoo più interessanti - il campo più colpito è quello accademico; sotto accusa, in particolare, alcuni tra gli esponenti più amati dei post-colonial studies, da cui un dibattito incentrato soprattutto sullo scarto fra ideologie rivoluzionarie professate in pubblico e comportamenti privati[3]. In Francia invece - altro esempio - il dibattito sul caso più esplosivo, le accuse di molestie e stupro a Tariq Ramadan, è “deragliato” su quello sui rapporti fra cultura occidentale e cultura islamica[4].
Come sempre accade, un movimento femminile transnazionale con contenuti sostanzialmente omogenei acquista pieghe e accentuazioni diverse a seconda dei contesti nazionali, e domanda perciò uno sguardo comparativo. Il mio si poserà soprattutto sulla comparazione fra Stati uniti e Italia, per una ragione precisa: molto di quanto sta accadendo nell’America trumpiana - compresa la scoperta, grazie alla presa di parola pubblica femminile, di un sistema diffuso di scambio fra sesso e potere - è stato anticipato nell’Italia berlusconiana; ma con effetti in parte simili, in parte - sembra - assai diversi. Da qui la strana sensazione di stare assistendo a un déjà vu da una parte, a qualcosa di inedito dall’altra.
2.Negli Stati uniti il #metoo è stato/è un enorme e contagioso movimento femminile di presa di parola pubblica, potentemente aiutato dai social network, appoggiato dalla stampa illuminata, sostenuto sia dall’autorizzazione reciproca delle donne coinvolte sia da una forte autorizzazione dell’opinione pubblica, che è riuscito a ribaltare una congiuntura che pareva svantaggiosa per le donne - l’elezione di Trump e la sconfitta di Hillary Clinton - in una situazione di protagonismo femminile socialmente riconosciuto e supportato. La congiuntura politica è di estrema rilevanza e dà risposta alla domanda che è imperversata sui media italiani: “Perché parlano adesso e non hanno parlato prima?”.
Le donne, lo sappiamo, parlano quando possono parlare: quando si può aprire una crepa nel regime del dicibile e dell’indicibile, e l’autorizzazione a dire la verità soggettiva prevale sul silenzio-assenso femminile necessario al mantenimento dell’ordine patriarcale. Dopo la vittoria di Trump e la sconfitta di Hillary - una candidata che il femminismo radicale riteneva non idonea perché moderata e neoliberale, ma che tutto il femminismo ha difeso dagli attacchi misogini del suo avversario - negli Stati uniti le donne hanno reagito con un salto di prospettiva politica, ben visibile fin nella women’s march del 21 gennaio 2017, che con i suoi due slogan principali, inclusività e intersezionalità, già annunciava un femminismo determinato a prendere in mano le redini di un movimento di opposizione più vasto. A distanza di un anno scrive infatti il NYT: “Allora non era chiaro se si trattasse di un momento o di un movimento, ma ora è chiaro che le donne sono diventate le leader emergenti di una doppia scommessa: sostenere l’opposizione a Trump e lanciare una sfida culturale più ampia al potere maschile, com’è accaduto con il #metoo”[5].
La presa di parola individuale che ha fatto esplodere il caso Weinstein non sarebbe stata possibile, dunque, senza l’autorizzazione simbolica del movimento già sceso in campo contro il Presidente che si vanta di “prendere le donne per le parti intime”. Vale la pena di notare che questa congiuntura politica conquista al femminismo la generazione di donne nata e cresciuta sotto le insegne dell’individualismo neoliberale che ne era rimasta fin qui più estranea, come fanno notare nelle loro testimonianze molte protagoniste del #metoo che raccontano la loro scoperta della dimensione collettiva dell’agire politico[6]. Di questa congiuntura, infine, fa parte il “divenire minoranza” degli uomini (bianchi), sotto i colpi della globalizzazione, della crisi economica, dei cambiamenti demografici e della perdita di privilegi innescata mezzo secolo fa dal femminismo storico: una condizione declinante del tutto compatibile tanto con i colpi di coda del suprematismo bianco che ha portato Trump alla presidenza quanto con i colpi di coda dell’aggressività sessuale “virile” disvelata dal #metoo.
A fronte di questo “divenire minoranza” degli uomini bianchi, c’è il “divenire maggioranza” delle donne: per la prima volta, in una società come quella americana abituata a rappresentarsi per segmenti, le donne non sono percepite come una minoranza da tutelare ma come una potenziale maggioranza vincente, una forza di cambiamento da sostenere e di cui fidarsi. All’autorizzazione femminile si aggiunge quindi un’autorizzazione sociale più vasta, ben percepibile attraverso il racconto incoraggiante e positivo che del #metoo hanno fatto i media mainstream liberal: il New York Times, il New Yorker, il Guardian, il Washington Post, The Nation - per citare solo quelli che ho cercato di seguire da qui.
3.Questo sostegno dell’opinione pubblica americana è il dato che stride di più con l’esperienza italiana. L’Italia non avrebbe dovuto restare sorpresa daI #metoo, avendo sperimentato, solo pochi anni fa, l’analogo fenomeno di una imprevista presa di parola pubblica femminile contro il “dispositivo di sessualità” dominante. Mi riferisco, ovviamente, all’esplosione del Berlusconi-gate, dovuta alla denuncia, da parte di Veronica Lario e Patrizia D’Addario (e altre dopo di loro, tra le quali Ambra Battilana, che ritroviamo oggi fra le donne che negli Usa hanno denunciato Weinstein), del sistema di scambio fra sesso, danaro e potere che vigeva nelle residenze dell’ex premier e decideva la distribuzione di lavori e di candidature alle donne nelle sue televisioni e nelle sue liste elettorali. Anche allora questa presa di parola si avvalse di una parte dei media, o perché contrassegnati dalla sensibilità di opinioniste femministe o perché, più semplicemente e strumentalmente, anti-berlusconiani. Ma subì anche e soprattutto una fortissima dose di incredulità, discredito e ostracismo, non solo da parte dei media berlusconiani (oggi in prima fila anche contro il #metoo, e con gli stessi argomenti di allora) ma anche negli ambienti della sinistra, e perfino in quella parte del femminismo che considerava “poco degne” le donne che si erano ribellate al sistema berlusconiano dal suo interno. Che fosse in atto, anche allora, una scossa tellurica che investiva verticalmente i rapporti fra donne e uomini, dalla sessualità al mercato del lavoro alle istituzioni della rappresentanza, lo si capì forse solo di fronte alla manifestazione del febbraio 2011 - le manifestazioni di piazza essendo la sola forma in cui l’esistenza del femminismo viene tuttora registrata. La risposta del circuito politico e mediatico mainstream fu tuttavia, anche nel campo della sinistra, momentanea, strumentale all’abbattimento di Berlusconi e inadeguata[7]. Soprattutto, non pare abbia seminato consapevolezza alcuna della crisi e della domanda di trasformazione di cui quei fatti erano il segno: lo si vede benissimo oggi che Berlusconi torna in campo come simulacro di se stesso, per ironia della storia contemporaneamente all’esplosione del #metoo, e nessuno, nei circuito mediatico, ricorda che a farlo cadere nel 2011 furono le donne prima dello spread, né associa la rivolta femminile italiana di allora a quella planetaria di oggi. Si potrebbe anzi sostenere, io sostengo, che la scarsa considerazione di cui il #metoo ha goduto in Italia è figlia diretta della rimozione della vicenda del 2009-2011.
A commento dei fatti di allora e di oggi, resta vero quello che Luisa Muraro aveva scritto ben prima, in tempi non sospetti: “Ci sono numerosi indizi che il regime di verità abbia fin qui funzionato, nelle sue succcessive forme storiche, sulla mutezza femminile. Se una donna si mette a dire la verità, diventa una minaccia per l’altro sesso e per la civiltà, insieme. ‘Virilità’ è un nome, o forse il nome, di questo insieme”. La verità soggettiva femminile detta in pubblico ha una forza dirompente della quale noi stesse non siamo forse abbastanza consapevoli. La comparazione fra le due vicende dimostra però anche che questa dirompenza, per essere efficace, ha bisogno di una qualche risonanza, e deve dunque dotarsi di una strategia mediatica. La differenza fra l’Italia e gli Usa si sta rivelando, da questo punto di vista, abissale, fin nell’uso del linguaggio e negli stili che connotano il racconto giornalistico, e non può essere attribuita solo al diverso valore che nella cultura americana e nella nostra ha il “dire la verità al potere”: attiene anche alla peculiare misoginia dell’establishment intellettuale e giornalistico italiano, e alla capacità o all’incapacità di associare mutamento femminile e mutamento sociale, e di fidarsene. Dedicando la copertina della “persona dell’anno” alle silence breakers, il Time ha acutamente osservato che il #metoo ha mostrato che i due principali obiettivi polemici di Trump, le donne e il giornalismo, hanno reagito, e sono in qualche modo “risorti”, insieme. Si può ragionevolmente sostenere che finché non avrà imparato a trattare sensatamente di donne e di femminismo, il giornalismo italiano continuerà a precipitare nell’abisso di ignoranza, pressapochismo, autoreferenzialità in cui vivacchia da anni.
4.La rimozione dei fatti del 2009-2011 spiega anche la ripetizione, in Italia, di molti argomenti contro le silence breakers di allora e di oggi. Riassumo qui brevemente i principali, maschili ma anche femminili, talvolta presenti in modo ben più pacato anche nel dibattito americano, proponendo per ciascuno di essi un rovesciamento di prospettiva.
a) L’(auto)vittimizzazione. Si va dal “fanno le vittime, ma sono state conniventi per anni”, scagliato contro Asia Argento soprattutto ma non solo da uomini, al timore, soprattutto femminile e femminista, che il #metoo possa risolversi in un processo regressivo di vittimizzazione e infantilizzazione delle donne. Alla prima obiezione ho già risposto: le donne parlano quando possono parlare. La seconda è più comprensibile, ma a mio avviso è infondata. È vero che il #metoo condivide con il femminismo di ultima generazione la tendenza a una soggettivazione basata sulla denuncia della violenza subìta piuttosto che sull’affermazione di un desiderio positivo, com’è stato invece per il femminismo degli anni Settanta; ed è vero che questa accentuazione della condizione di vittima rischia di riprodurla, nonché di riportare indietro il discorso, dal paradigma della libertà a quello dell’oppressione femminile. Ma nel caso del #metoo a me pare che il rischio di un attaccamento alla condizione di vittima sia decisamente inferiore alla spinta collettiva a uscirne, anche con una buona dose di allegria. Faccio inoltre notare che in Italia il fronte che accusa di vittimismo ritardato le attrici oggi, è lo stesso che ieri accusava le escort e le olgettine di non rappresentarsi come vittime e di rivendicare il loro lavoro come una scelta: a dimostrazione che il victim blaming è sempre attivo, nell’un caso e nell’altro.
b) Il fantasma della “caccia alle streghe”, ovvero il panico da rischio di reazione “maccartista” contro i maschi sospettati di “comportamenti inappropriati, a Hollywood e altrove. Il ricorso alla evocazione della caccia alle streghe per esprimere il terrore di una caccia agli orchi ha qualcosa di comico, e dice quanto sia radicata la fantasia di una simmetria fra i sessi e di una vocazione ritorsiva della rivoluzione femminista. Storicamente, la caccia alle streghe (donne) l’hanno fatta gli uomini, e oggi, casomai, sono di nuovo uomini a farla su altri uomini. Con modalità talvolta violente e discutibili, come la cancellazione dai titoli dei film di attori fino a ieri osannati, o la “maledizione” di opere d’arte che dovrebbero sopravvivere ai comportamenti sessuali dei loro autori. Queste modalità però segnalano che una crepa si è davvero aperta nell’omertà maschile, e questo è un fatto positivo.
c) Invocazione/scongiuro della legge e delle regole. Vasta e contraddittoria gamma di posizioni. Da una parte il #metoo viene attaccato perché agisce sulla base di una denuncia pubblica ma non giudiziaria dei comportamenti maschili, impedendo così l’esercizio del diritto di difesa: si invocano insomma i tribunali, temendo - come di recente Margareth Atwood[8] - la sostituzione dello stato di diritto con di una giustizia “immediata” o con quello che in Italia chiamiamo “giustizialismo”. Oltre a non tener conto della storica - e giustificata - diffidenza femminile per l’esercizio maschile della giustizia, questo tipo di obiezioni occulta quello che è il pregio, non il limite del #metoo: il suo carattere eminentemente politico, basato sulla presa di parola e sulla solidarietà collettiva, e non sull’uso dei tribunali. La questione che il #metoo pone è politica, non penale.
Dall’altra parte però, e contraddittoriamente, lo stesso fronte paventa che l’esito del #metoo possa essere quello di una regolamentazione forzata e di un controllo moralista e normativo dei comportamenti sessuali[9] - esito peraltro da non escludere, data la tendenza alla codificazione dei comportamenti propria della società americana. Va detto però che questa regolamentazione, talvolta fin troppo rigida, negli Usa vigeva già prima del #metoo, ad esempio nelle università; il #metoo, casomai, ne segnala l’inutilità. C’è un eccesso della sessualità maschile che sfugge, evidentemente, a ogni regola e a ogni codice di comportamento: merito del #metoo è l’averlo messo in luce, riportando il fuoco del discorso dalle forme del politicamente corretto alla sostanza delle cose.
Più in generale, l’altalena fra invocazione e scongiuro delle norme è sintomatica di una condizione tutta maschile, che sembra non poter fare a meno delle norme per regolamentare le pulsioni: le invoca mentre le scongiura, e le scongiura mentre le invoca. Vale sulla sessualità, dove gli uomini sembrano voler delegare a un codice di comportamento quello che non riescono a regolare relazionalmente, come vale, lo sappiamo bene, per tutti i campi della vita associata, la politica in primis.
d) Il fantasma della fine della seduzione e della morte della sessualità, con la correlata confusione fra seduzione e violenza, “avance” e molestia. Su questa confusione, impugnata come una bandiera in Italia dal Foglio e dalla stampa di destra e fatta propria in Francia dal testo firmato da Catherine Deneuve di cui tanto si è parlato, ho poco da dire: a differenza di Deneuve non conosco donna alcuna che non sappia distinguere fra l’una e l’altra cosa, mentre mi arrendo alla constatazione che tale confusione c’è davvero nella testa di molti uomini, che infatti la rivendicano come se il confine fra sesso e violenza fosse effettivamente poroso e facilmente valicabile.
Il punto tuttavia a me non pare questo, palesemente strumentale, ma un altro. Rebecca Traister ha sostenuto, con buoni argomenti, che puntare il discorso sul terreno della sessualità significa evadere la questione principale posta dal #metoo, che a suo avviso riguarda la ricattabilità delle donne nel lavoro più che il sesso[10]. Si tratta a mio avviso di una falsa alternativa: la questione riguarda, direi, la ricattabilità delle donne nel lavoro attraverso il sesso, ovvero l’uso della sessualità come moneta di scambio nel mercato del lavoro. E dunque il #metoo, esattamente come in Italia gli “scandali sessuali” di qualche anno fa, dice qualcosa del “dispositivo di sessualità” della nostra epoca. Esattamente come allora, anche stavolta colpisce la miseria della sessualità maschile che risulta dalle testimonianze femminili: uomini che scambiano potere con briciole di sesso come un massaggio sotto un accappatoio o una masturbazione all’aperto. Se è così, il #metoo non annuncia la fine della seduzione e della sessualità, ma la registra, per aprire, si spera, una pagina più ricca e più felice. Nella ricontrattazione dei rapporti fra i sessi che la presa di parola femminile domanda, io credo che ci sia anche la rivolta contro questa miseria dello scambio eterosessuale.
(Via Dogana 3, 30 gennaio 2018)
 [1] www.newsweek.com/how-metoo-has-spread-wildfire-around-world
[1] www.newsweek.com/how-metoo-has-spread-wildfire-around-world [2] www.nytimes.com/interactive/2017/11/10/us/men-accused-sexual-misconduct-weinstein
[2] www.nytimes.com/interactive/2017/11/10/us/men-accused-sexual-misconduct-weinstein [3] www.dinamopress.it/news/abusi-silenzi-nellaccademia-postcoloniale-la-necessita-lettura-femminista-dei-saperi
[3] www.dinamopress.it/news/abusi-silenzi-nellaccademia-postcoloniale-la-necessita-lettura-femminista-dei-saperi [4] www.newyorker.com/news/news-desk/how-the-tariq-ramadan-scandal-derailed-the-balancetonporc-movement-in-france?
[4] www.newyorker.com/news/news-desk/how-the-tariq-ramadan-scandal-derailed-the-balancetonporc-movement-in-france? [5] www.nytimes.com/newsletters/2018/01/21/gender-metoo-moment
[5] www.nytimes.com/newsletters/2018/01/21/gender-metoo-moment [6] www.nytimes.com/2017/12/12/magazine/the-conversation-seven-women-discuss-work-fairness-sex-and-ambition.html
[6] www.nytimes.com/2017/12/12/magazine/the-conversation-seven-women-discuss-work-fairness-sex-and-ambition.html [7] Per la ricostruzione dell’intera vicenda e dei suoi effetti rimando al mio Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, Ediesse, Roma 2014.
[7] Per la ricostruzione dell’intera vicenda e dei suoi effetti rimando al mio Il trucco. Sessualità e biopolitica nella fine di Berlusconi, Ediesse, Roma 2014. [8] www.theguardian.com/books/2018/jan/15/margaret-atwood-feminist-backlash-metoo
[8] www.theguardian.com/books/2018/jan/15/margaret-atwood-feminist-backlash-metoo [9] www.newyorker.com/news/our-columnists/sex-consent-dangers-of-misplaced-scale
[9] www.newyorker.com/news/our-columnists/sex-consent-dangers-of-misplaced-scale [10] www.thecut.com/2017/12/rebecca-traister-this-moment-isnt-just-about-sex.html
[10] www.thecut.com/2017/12/rebecca-traister-this-moment-isnt-just-about-sex.html -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- DISSENSO COMUNE. Le donne del cinema italiano contro le molestie: "Contestiamo l’intero sistema".1 febbraio 2018, di Federico La Sala
Le donne del cinema italiano contro le molestie: "Contestiamo l’intero sistema" *
- Oltre 120 attrici, registe, produttrici, donne che lavorano nella comunicazione dello spettacolo, hanno sottoscritto una lettera che muove dal caso Weinstein. Un testo che non vuole puntare il dito contro un singolo ’molestatore’ ma l’intero sistema di potere
- Si chiama Dissenso comune ed è una lettera manifesto firmata da 124 attrici e lavoratrici dello spettacolo. Due mesi di incontri e confronti tra un gruppo sempre più largo di donne, per intervenire con la forza di un collettivo e non lasciare che le testimonianze dei mesi scorsi restassero solo voci isolate. Il primo passo verso una serie di iniziative per cambiare il sistema, non solo nel mondo dello spettacolo: “Unite per una riscrittura degli spazi di lavoro e per una società che rifletta un nuovo equilibrio tra donne e uomini”.
DISSENSO COMUNE
Dalle donne dello spettacolo a tutte le donne. Unite per una riscrittura degli spazi di lavoro e per una società che rifletta un nuovo equilibrio tra donne e uomini.
Da qualche mese a questa parte, a partire dal caso Weinstein, in molti paesi le attrici, le operatrici dello spettacolo hanno preso parola e hanno iniziato a rivelare una verità così ordinaria da essere agghiacciante. Questo documento non è solo un atto di solidarietà nei confronti di tutte le attrici che hanno avuto il coraggio di parlare in Italia e che per questo sono state attaccate, vessate, querelate, ma un atto dovuto di testimonianza. Noi vi ringraziamo perché sappiamo che quello che ognuna di voi dice è vero e lo sappiamo perché è successo a tutte noi con modi e forme diverse. Noi vi sosteniamo e sosterremo in futuro voi e quante sceglieranno di raccontare la loro esperienza. Quando si parla di molestie quello che si tenta di fare è, in primo luogo, circoscrivere il problema a un singolo molestatore che viene patologizzato e funge da capro espiatorio. Si crea una momentanea ondata di sdegno che riguarda un singolo regista, produttore, magistrato, medico, un singolo uomo di potere insomma. Non appena l’ondata di sdegno si placa, il buonsenso comune inizia a interrogarsi sulla veridicità di quanto hanno detto le “molestate” e inizia a farsi delle domande su chi siano, come si comportino, che interesse le abbia portate a parlare. Il buon senso comune inizia a interrogarsi sul libero e sano gioco della seduzione e sui chiari meriti artistici, professionali o commerciali del molestatore che alla lunga verrà reinserito nel sistema. Così facendo questa macchina della rimozione vorrebbe zittirci e farci pensare due volte prima di aprire bocca, specialmente se certe cose sono accadute in passato e quindi non valgono più.
Insomma, che non si perda altro tempo a domandarci della veridicità delle parole delle molestate: mettiamole subito in galera, se non in galera al confino, se non al confino in convento, se non in convento almeno teniamole chiuse in casa. Questo e solo questo le farà smettere di parlare! Ma parlare è svelare come la molestia sessuale sia riprodotta da un’istituzione. Come questa diventi cultura, buonsenso, un insieme di pratiche che noi dovremmo accettare perché questo è il modo in cui le cose sono sempre state, e sempre saranno.
La scelta davanti alla quale ogni donna è posta sul luogo di lavoro è: “Abituati o esci dal sistema”.
Non è la gogna mediatica che ci interessa. Il nostro non è e non sarà mai un discorso moralista. La molestia sessuale non ha niente a che fare con il “gioco della seduzione”. Noi conosciamo il nostro piacere, il confine tra desiderio e abuso, libertà e violenza.
Perché il cinema? Perché le attrici? Per due ragioni. La prima è che il corpo dell’attrice è un corpo che incarna il desiderio collettivo, e poiché in questo sistema il desiderio collettivo è il desiderio maschile, il buonsenso comune vede in loro creature narcisiste, volubili e vanesie, disposte a usare il loro corpo come merce di scambio pur di apparire. Le attrici in quanto corpi pubblicamente esposti smascherano un sistema che va oltre il nostro specifico mondo ma riguarda tutte le donne negli spazi di lavoro e non.
La seconda ragione per cui questo atto di accusa parte dalle attrici è perché loro hanno la forza di poter parlare, la loro visibilità è la nostra cassa di risonanza. Le attrici hanno il merito e il dovere di farsi portavoce di questa battaglia per tutte quelle donne che vivono la medesima condizione sui posti di lavoro la cui parola non ha la stessa voce o forza.
La molestia sessuale è fenomeno trasversale. È sistema appunto. È parte di un assetto sotto gli occhi di tutti, quello che contempla l’assoluta maggioranza maschile nei luoghi di potere, la differenza di compenso a parità di incarico, la sessualizzazione costante e permanente degli spazi lavorativi. La disuguaglianza di genere negli spazi di lavoro rende le donne, tutte le donne, a rischio di molestia poiché sottoposte sempre a un implicito ricatto. Succede alla segretaria, all’operaia, all’immigrata, alla studentessa, alla specializzanda, alla collaboratrice domestica. Succede a tutte.
Nominare la molestia sessuale come un sistema, e non come la patologia di un singolo, significa minacciare la reputazione di questa cultura.
Noi non siamo le vittime di questo sistema ma siamo quelle che adesso hanno la forza per smascherarlo e ribaltarlo.
Noi non puntiamo il dito solo contro un singolo “molestatore”. Noi contestiamo l’intero sistema.
Questo è il tempo in cui noi abbiamo smesso di avere paura.
 1. Alessandra Acciai
1. Alessandra Acciai
 2. Elisa Amoruso
2. Elisa Amoruso
 3. Francesca Andreoli
3. Francesca Andreoli
 4. Michela Andreozzi
4. Michela Andreozzi
 5. Ambra Angiolini
5. Ambra Angiolini
 6. Alessia Barela
6. Alessia Barela
 7. Chiara Barzini
7. Chiara Barzini
 8. Valentina Bellè
8. Valentina Bellè
 9. Sonia Bergamasco
9. Sonia Bergamasco
 10. Ilaria Bernardini
10. Ilaria Bernardini
 11. Giulia Bevilacqua
11. Giulia Bevilacqua
 12. Nicoletta Billi
12. Nicoletta Billi
 13. Laura Bispuri
13. Laura Bispuri
 14. Barbora Bobulova
14. Barbora Bobulova
 15. Anna Bonaiuto
15. Anna Bonaiuto
 16. Donatella Botti
16. Donatella Botti
 17. Laura Buffoni
17. Laura Buffoni
 18. Giulia Calenda
18. Giulia Calenda
 19. Francesca Calvelli
19. Francesca Calvelli
 20. Maria Pia Calzone
20. Maria Pia Calzone
 21. Antonella Cannarozzi
21. Antonella Cannarozzi
 22. Cristiana Capotondi
22. Cristiana Capotondi
 23. Anita Caprioli
23. Anita Caprioli
 24. Valentina Carnelutti
24. Valentina Carnelutti
 25. Sara Casani
25. Sara Casani
 26. Manuela Cavallari
26. Manuela Cavallari
 27. Michela Cescon
27. Michela Cescon
 28. Carlotta Cerquetti
28. Carlotta Cerquetti
 29. Valentina Cervi
29. Valentina Cervi
 30. Cristina Comencini
30. Cristina Comencini
 31. Francesca Comencini
31. Francesca Comencini
 32. Paola Cortellesi
32. Paola Cortellesi
 33. Geppi Cucciari
33. Geppi Cucciari
 34. Francesca D’Aloja
34. Francesca D’Aloja
 35. Caterina D’Amico
35. Caterina D’Amico
 36. Piera De Tassis
36. Piera De Tassis
 38. Matilda De angelis
38. Matilda De angelis
 39. Orsetta De Rossi
39. Orsetta De Rossi
 40. Cristina Donadio
40. Cristina Donadio
 41. Marta Donzelli
41. Marta Donzelli
 42. Ginevra Elkann
42. Ginevra Elkann
 43. Esther Elisha
43. Esther Elisha
 44. Nicoletta Ercole
44. Nicoletta Ercole
 45. Tea Falco
45. Tea Falco
 46. Giorgia Farina
46. Giorgia Farina
 47. Sarah Felberbaum
47. Sarah Felberbaum
 48. Isabella Ferrari
48. Isabella Ferrari
 49. Anna Ferzetti
49. Anna Ferzetti
 50. Francesca Figus
50. Francesca Figus
 51. Camilla Filippi
51. Camilla Filippi
 52. Liliana Fiorelli
52. Liliana Fiorelli
 53. Anna Foglietta
53. Anna Foglietta
 54. Iaia Forte
54. Iaia Forte
 55. Ilaria Fraioli
55. Ilaria Fraioli
 56. Elisa Fuksas
56. Elisa Fuksas
 57. Valeria Golino
57. Valeria Golino
 58. Lucrezia Guidone
58. Lucrezia Guidone
 59. Sabrina Impacciatore
59. Sabrina Impacciatore
 60. Lorenza Indovina
60. Lorenza Indovina
 61. Wilma Labate
61. Wilma Labate
 62. Rosabell Laurenti
62. Rosabell Laurenti
 63. Antonella Lattanzi
63. Antonella Lattanzi
 64. Doriana Leondeff
64. Doriana Leondeff
 65. Miriam Leone
65. Miriam Leone
 66. Carolina Levi
66. Carolina Levi
 67. Francesca Lo Schiavo
67. Francesca Lo Schiavo
 68. Valentina Lodovini
68. Valentina Lodovini
 69. Ivana Lotito
69. Ivana Lotito
 70. Federica Lucisano
70. Federica Lucisano
 71. Gloria Malatesta
71. Gloria Malatesta
 72. Francesca Manieri
72. Francesca Manieri
 73. Francesca Marciano
73. Francesca Marciano
 74. Alina Marazzi
74. Alina Marazzi
 75. Cristiana Massaro
75. Cristiana Massaro
 76. Lucia Mascino
76. Lucia Mascino
 77. Giovanna Mezzogiorno
77. Giovanna Mezzogiorno
 78. Paola Minaccioni
78. Paola Minaccioni
 79. Laura Muccino
79. Laura Muccino
 80. Laura Muscardin
80. Laura Muscardin
 81. Olivia Musini
81. Olivia Musini
 82. Carlotta Natoli
82. Carlotta Natoli
 83. Anna Negri
83. Anna Negri
 84. Camilla Nesbitt
84. Camilla Nesbitt
 85. Susanna Nicchiarelli
85. Susanna Nicchiarelli
 86. Laura Paolucci
86. Laura Paolucci
 87. Valeria Parrella
87. Valeria Parrella
 88. Camilla Paternò
88. Camilla Paternò
 89. Valentina Pedicini
89. Valentina Pedicini
 90. Gabriella Pescucci
90. Gabriella Pescucci
 91. Vanessa Picciarelli
91. Vanessa Picciarelli
 92. Federica Pontremoli
92. Federica Pontremoli
 93. Benedetta Porcaroli
93. Benedetta Porcaroli
 94. Daniela Piperno
94. Daniela Piperno
 95. Vittoria Puccini
95. Vittoria Puccini
 96. Ondina Quadri
96. Ondina Quadri
 97. Costanza Quatriglio
97. Costanza Quatriglio
 98. Isabella Ragonese
98. Isabella Ragonese
 99. Monica Rametta
99. Monica Rametta
 100. Paola Randi
100. Paola Randi
 101. Maddalena Ravagli
101. Maddalena Ravagli
 102. Rita Rognoni
102. Rita Rognoni
 103. Alba Rohrwacher
103. Alba Rohrwacher
 104. Alice Rohrwacher
104. Alice Rohrwacher
 105. Federica Rosellini
105. Federica Rosellini
 106. Fabrizia Sacchi
106. Fabrizia Sacchi
 107. Maya Sansa
107. Maya Sansa
 108. Valia Santella
108. Valia Santella
 109. Lunetta Savino
109. Lunetta Savino
 110. Greta Scarano
110. Greta Scarano
 111. Daphne Scoccia
111. Daphne Scoccia
 112. Kasia Smutniak
112. Kasia Smutniak
 113. Valeria Solarino
113. Valeria Solarino
 114. Serena Sostegni
114. Serena Sostegni
 115. Daniela Staffa
115. Daniela Staffa
 116. Giulia Steigerwalt
116. Giulia Steigerwalt
 117. Fiorenza Tessari
117. Fiorenza Tessari
 118. Sole Tognazzi
118. Sole Tognazzi
 119. Chiara Tomarelli
119. Chiara Tomarelli
 120. Roberta Torre
120. Roberta Torre
 121. Tiziana Triana
121. Tiziana Triana
 122. Jasmine Trinca
122. Jasmine Trinca
 123. Adele Tulli
123. Adele Tulli
 124. Alessandra Vanzi
124. Alessandra Vanzi -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- Gennaio 2018: Women’s March. La più grande protesta di piazza nella storia Usa.21 gennaio 2018, di Federico La Sala
Società & Diritti
Le donne in marcia a Washington? La più grande protesta di piazza nella storia Usa
Ricercatori incrociano stime, 2,5 mln battono Luther King e anti-Vietnam
- Women’s March in Washington DC © EPA
- Guarda le foto...
(di Agnese Ferrara) *
La voce delle donne in marcia negli Stati Uniti, con adesioni da New York a Los Angeles a Washington, ma anche in altri paesi del mondo, sembra essere diventata la più forte degli Stati Uniti.
L’affluenza alla ‘Women’s march on Washington’ , che globalmente si stima intorno ai 2.5 milioni, sembra avere superato quella di tutte le altre manifestazioni della durata di un giorno svolte sul suolo americano. Contro razzismo e sessismo del neo presidente Trump si è riunita una immensa comunità di donne. La partecipazione non è mai stata così alta secondo i calcoli di Jeremy Pressman, professore alla facoltà di scienze politiche dell’Università del Connecticut, e di Erica Chenoweth della Josef Korbel School of International Studies dell’università di Denver.
I due ricercatori hanno confrontato le adesioni alla marcia delle donne su Washington usando come fonte i dati di Google, facebook, twitter e gli articoli di cronaca che riportavano i dati dei dipartimenti di polizia, pubblicati sui principali giornali dei vari Stati americani ma anche nelle altre città del mondo. Hanno quindi assemblato le stime in un documento Google (messo a disposizione di chiunque, si legge qui ).
Ad Atlanta 60.000 persone, 250.000 a Chicago, idem a Boston. Oltre 200.000 a Denver, fra i 200 e i 500 mila a New York. I dati ufficiali riportano 500.000 partecipanti a Washington e fra i 200 e i 750 mila a Los Angeles. 60.000 ad Oakland, 50.000 a Philadelphia, 100.000 a Madison, 20.000 a Pittsburgh, stessa cifra a Nashville e 60.000 a St.Paul. Adesioni capillari, le donne si fanno sentire sempre di più e la notizia sta facendo il giro del mondo, rimbalzando sui social e sui principali media.
Il portale economico Business Insider, riprendendo la ricerca di Pressman e Chenoweth, fa l’elenco delle più grandi manifestazioni accadute sul suolo USA in passato e dalle stime risulta che la marcia di ieri le batta tutte. Dello stesso avviso Politcs Usa.
Approssimativamente 250,000 persone parteciparono nel 1963 alla marcia per i diritti civili a Washington, quella in cui Martin Luther King Jr. fece il suo storico discorso "I have a Dream" contro le discriminazioni razziali. Quella contro il nucleare, svolta nel 1982 a New York, ebbe 1 milione di partecipanti, quella sui diritti civili a Washington 250.000. la marcia anti-Vietnam del 1969 di Washington contò fra i 500 e i 600.000 partecipanti, la ‘Million men’ del 1995, ancora a Washington, ritenuta la più grande manifestazione afroamericana di tutti i tempi registra stime di partecipanti che vanno dai 400.000 a 1.1 milioni e quella del 1993 sulla parità dei diritti LGBT fra gli 800.000 e il milione di persone presenti.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Cosa potremmo imparare dalle donne? (di Raúl Zibechi)12 gennaio 2018, di Federico La Sala
DONNE, UOMIMI, E VIOLENZA: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO...
Cosa potremmo imparare dalle donne?
di Raúl Zibechi *
- Un grande e straordinario movimento di donne si è imposto negli ultimi anni a scala planetaria e sta cambiando il mondo. Pone degli interrogativi anche al mondo dei maschi che guardano alla critica del potere espressa dal femminismo e rifiutano il patriarcato? Non si tratta, naturalmente, di adottare comportamenti politicamente corretti ma di mettersi in relazione, in modo semplice, concreto e con umiltà, affinché si possa contribuire al processo di emancipazione collettiva dei popoli.
- Raúl Zibechi propone tre punti di vista complementari: arginare la proliferazione dei grandi e piccoli cosiddetti “maschi alfa” e delle loro relazioni di dominio.
- Assumere finalmente in pieno la prospettiva della riproduzione, cioè della cura della vita, un punto cieco delle rivoluzioni del passato, impegnandosi in un forte esercizio di limitazione dell’ego, specialmente se si tratta di un ego rivoluzionario. Imparare dai movimenti femministi e delle donne come sia possibile sollevarsi senza necessariamente occupare il governo dello Stato - organizzandosi tra uguali - senza apparati gerarchici, avanguardie, comitati centrali. E, soprattutto, senza riprodurre gli stessi ruoli che si combattono
di Raúl Zibechi *
Prendersi cura dell’ambiente o della Madre Terra, è cosa di donne, secondo un recente studio della rivista Scientific American pubblicato a fine dicembre, dove si sottolinea che “le donne hanno superato gli uomini nel campo dell’azione ambientale; in tutte le fasce di età e in tutti i paesi”.
L’articolo intitolato “Gli uomini resistono al comportamento verde in quanto poco maschile”, giunge a questa conclusione dopo aver realizzato un’ampia indagine tra duemila uomini e donne statunitensi e cinesi. Lo studio afferma che, per i maschi, comportamenti tanto elementari come quello di utilizzare borse di tela per fare la spesa invece che quelle di plastica, è considerato “poco maschile”.
Il lavoro è incentrato sul marketing, con l’obiettivo di conseguire un risultato per il quale i maschi si sentano virili anche comprando articoli “verdi”, e arriva a conclusioni penose come quella secondo cui “gli uomini che si sentono sicuri nella loro virilità si sentono più a loro agio comprando verde”.
Tuttavia, riesce a tracciare alcuni comportamenti che consentono di andare un po’ oltre, nel senso di comprendere come il patriarcato sia una delle principali cause del degrado ambientale del pianeta. Donald Trump non è un’eccezione, nel negare il cambiamento climatico e incoraggiare comportamenti distruttivi, dalle guerre al consumismo.
Propongo tre punti di vista che possono essere complementari e che riguardano il mondo dei maschi, non affinché adottiamo comportamenti politicamente corretti (con la loro dose di cinismo e di ambiguità), bensì per contribuire al processo di emancipazione collettiva dei popoli.
Il primo è correlato al capitalismo di guerra o accumulazione per spoliazione/quarta guerra mondiale che attualmente subiamo. Questa virata del sistema, che nell’ultima decade ha avuto un’accelerazione, non solo provoca più guerre e violenze ma un profondo cambiamento culturale: la proliferazione dei “maschi alfa”, dai pezzi grossi dei grandi e potenti Stati, fino ai boriosi machos dei quartieri che pretendono di marcare il loro territorio e, ovviamente, i “loro” dominati e, soprattutto, le dominate.
Mostrare forza muscolare geopolitica consente di avere una posizione in questo periodo di decadenza dell’impero egemonico, che viene integrata dalla comparsa di un’infinità di piccoli maschi alfa nei territori dei settori popolari, dove i narcos e i paramilitari vogliono sostituire il prete, il commissario e il “padre di famiglia” nel controllo della vita quotidiana degli abajo (quelli che stanno sotto, ndt).
Il secondo punto di vista viene insinuato dallo studio citato, quando conclude che “le donne tendono a vivere uno stile di vita più ecologico” poiché “sprecano di meno, riciclano di più e lasciano un’impronta di carbonio più piccola”.
Questo è direttamente correlato con la riproduzione, che è il punto cieco delle rivoluzioni, impegnate in un produttivismo a oltranza per, presumibilmente, superare i paesi capitalisti. La produzione manifatturiera e l’operaio industriale sono stati elementi centrali nella costruzione del mondo nuovo, da Marx in poi. In parallelo, la riproduzione e il ruolo delle donne non sono mai stati considerati.
Non possiamo combattere il capitalismo né il patriarcato, né prenderci cura dell’ambiente o dei nostri figli e figlie, senza assumere la prospettiva della riproduzione che è, precisamente, la cura della vita. Capisco che la riproduzione possa essere anche una questione degli uomini, ma questo richiede una politica esplicita in questa direzione, come sottolineano le comandantas che convocano l’incontro delle donne nel caracol Morelia.
Come dice il comunicato di convocazione del Primo Incontro Internazionale, Politico, Artistico, Sportivo e Culturale delle Donne che Lottano, gli uomini zapatisti “si occuperanno della cucina e di pulire e di tutto il necessario”.
Forse queste mansioni sono meno rivoluzionarie che stare in piedi su un palco “dando istruzioni sulla linea” (come diciamo nel sud)? Ci danno meno visibilità, ma sono i compiti oscuri che rendono possibili le grandi azioni. Per coinvolgerci nella riproduzione, noi maschi abbiamo bisogno di un forte esercizio per limitare il nostro ego, specialmente se si tratta di un ego rivoluzionario.
Il terzo è forse il più importante: cosa possiamo imparare noi, maschi eterosessuali e di sinistra, dai movimenti femministi e dalle donne?
La prima cosa sarebbe riconoscere che le donne, nelle ultime decadi, sono andate più avanti di noi. Quindi, essere un po’ più umili, ascoltare, chiedere, imparare a farci da parte, a stare in silenzio affinché altre voci possano essere ascoltate. Una delle questioni che possiamo imparare è come loro si siano sollevate senza avanguardie né apparati gerarchici, senza comitati centrali e senza la necessità di occupare il governo statale.
Come hanno fatto? Forse organizzandosi tra di loro, tra uguali. Lavorando sul patriarca interiore: il padre, il dirigente ben educato, il leader. Questo è molto interessante, perché le donne che lottano non stanno riproducendo gli stessi ruoli che combattono, poiché non si tratta di sostituire un oppressore uomo con un oppressore donna, né un oppressore di destra con un oppressore di sinistra. Per questo dico che sono andate molto avanti.
- Una marcia delle donne indigene in Argentina.
La seconda questione che possiamo apprendere è che la politica, in grande, in scenari ben illuminati e mediatici, con programmi, strategie e discorsi magniloquenti, non è altro che la riproduzione del sistema dominante. Loro [le donne], hanno politicizzato la vita quotidiana, il preparare il cibo, la cucina, il prendersi cura di figli e figlie, le arti della tessitura e della guarigione, tra le tante altre. Credere che tutto questo sia poco importante, che esistano gerarchie tra l’una e l’altra dimensione, è come continuare a cercare maschi alfa che ci emancipino.
Sicuramente ci sono molte altre questioni che possiamo apprendere dai movimenti delle donne, che ignoro o che dobbiamo ancora scoprire. Quello che importa non è avere la risposta già pronta, bensì predisporci con semplicità e umiltà a imparare da questo meraviglioso movimento di donne che sta cambiando il mondo.
Pubblicato su La Jornada con il titolo Patriarcado, Madre Tierra y feminismos
Traduzione per Comune-info: Daniela Cavallo
* Comune-info,->https://comune-info.net/2018/01/cosa-possiamo-provare-imparare-dalle-donne/] 11 gennaio 2018 (ripresa parziale senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- "CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. Relazioni chiasmatiche e civiltà. Lettera da ‘Johannesburg’ a Primo Moroni (in memoriam)
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO DONNE, UOMINI E VIOLENZA
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - POTERE, SESSUALITA’, E LIBERT’ DI IMPORTUNARE. Je ne suis pas Catherine Deneuve (di Ida Dominijanni).11 gennaio 2018, di Federico La Sala
FEMMINISMO
Je ne suis pas Catherine Deneuve
di Ida Dominijanni, giornalista *
La scoperta delle molestie e dei ricatti sessuali in uso a Hollywood e in tutto il mondo del lavoro americano dimostra che questi non sono tempi buoni né per il desiderio né per l’esercizio della sessualità fra donne e uomini. Com’era già accaduto in Italia con gli scandali sessuali d’epoca berlusconiana, quello che viene alla luce non è solo la tentazione maschile perenne all’abuso di potere, che riduce le donne a oggetto da possedere e la libertà femminile a disponibilità di concedersi. È anche, forse soprattutto, una diffusa miseria della sessualità maschile, che scambia potere, favori, assunzioni in cambio di briciole come un massaggio sotto un accappatoio, una masturbazione a cielo aperto, un assoggettamento a una virilità incerta. Una miseria sessuale che è parente stretta di una miseria relazionale, ovvero di una altrettanto diffusa incapacità maschile di relazionarsi all’altra, al suo desiderio e ai suoi dinieghi, alla sua forza e alla sua vulnerabilità, alla sua libertà e alle sue necessità.
Precisamente il cinema hollywoodiano, a ben guardare, ci aveva lentamente abituato, nell’ultimo decennio, a questo progressivo immiserimento, per non dire scomparsa, della sessualità nelle relazioni fra uomini e donne, con un sottile ma percettibile scivolamento dalle scene di sesso passionale degli anni novanta a quelle quasi sempre giocate successivamente su un ambiguo confine fra sesso e violenza, sesso e possesso, sesso e performance. E del resto basterebbe il successo sorprendente, e non a caso contemporaneo al #metoo, di un racconto come Cat person per farsi un’idea dello stato delle cose: in questo caso non c’è ombra di violenza né di molestie, ma la miseria sentimentale è la stessa, l’alfabeto della seduzione è precipitato nel dimenticatoio e ogni passione è spenta.
Quello che sta saltando con il #metoo e il Time’s up è il tappo di silenzio-assenso femminile che copriva questa situazione. A un primo sguardo, certo, si tratta di movimenti contro le molestie e i ricatti sessuali, e contro l’abuso di potere maschile che c’è dietro. Ma com’era già avvenuto in Italia pochi anni fa, la presa di parola femminile ha l’effetto di svelare qualcosa di più profondo, un “dispositivo di sessualità”, per dirlo con l’espressione di Foucault, in cui il desiderio non ha più posto e il sesso è ridotto a contrattazione, ricatto, performance. E da cui è urgente uscire, se i destini della sessualità come espressione libera e creativa della specie umana ci stanno a cuore.
- La Francia è la Francia, e pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”
Perciò è del tutto fuori campo e fuori fuoco la reazione, finora prevalentemente maschile nonché prevalentemente italiana, di chi ulula che all’esito del #metoo ci sarebbe l’oscurantismo politically correct di un totalitarismo (sic!) proibizionista e sessuofobico.
 È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
 Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.
Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.Stupisce di più - ma in fondo neanche tanto - che a usare gli stessi argomenti sia adesso un gruppo di donne francesi - intellettuali, artiste, attrici, psicoanaliste, giornaliste, fra le altre una campionessa riconosciuta della seduzione doc come Catherine Deneuve - le quali si lanciano nella difesa della “libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale”, come se il #metoo avesse già instaurato un regime del divieto dove nessuno può sporgersi sull’altra e nessuna sull’altro, il nemico delle donne sono gli uomini nella loro totalità, la parola femminile, altro che liberarsi, si autoimprigiona in un codice politically correct autoinibitorio, e le donne, altro che guadagnarci qualcosa, si auto-segregano nel ruolo di “eterne vittime dominate da demoni fallocrati”. Potenza dei fantasmi maschili interiorizzati anche dalla mente femminile, o “differenza culturale” francese vs egemonia “puritana” americana? L’una e l’altra cosa, probabilmente, e la seconda non meno influente della prima.
Non c’è donna al mondo che non sappia distinguere un “corteggiamento insistente e maldestro” da uno stupro, come le firmatarie dell’appello francese temono: esse stesse non possono non saperlo. Non c’è persona sana di mente che non possa aver registrato, seguendo le vicende del #metoo o più semplicemente la recente cerimonia dei Golden Globe sotto il segno del Time’s up, che tutto circola fra le silence breakers americane tranne un’autovittimizzazione inerziale e passiva: tutta la faccenda sembra al contrario parecchio empowering, e parecchio liberatoria anche per quegli uomini che la guardano con curiosità e fiducia invece che attaccarsi come Francesca Bertini alle tende di una virilità decadente. E anche questo le consorelle francesi non possono non averlo notato.
 Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
 Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.
Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.- L’attrice Catherine Deneuve a Berlino, il 14 febbraio 2017. (John Macdougall, Afp)
* Internazionale, 10 gennaio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
Ragione ("Logos") e Amore ("Charitas"). Per la critica dell’economia politica ..... e della teologia "mammonica" ( "Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)
 L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana" -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - QUESTO E IL MIO SANGUE. Il tabù delle mestruazioni: quello che le donne ora dicono (di Silvia Bencivelli)7 gennaio 2018, di Federico La Sala
PIANETA TERRA. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
- "Un dato di fatto è che, oltre alle donne giudice, oggi possiamo avere le donne astronauta, come Samantha Cristoforetti, che considera gli assorbenti l’ultima delle sue preoccupazioni, terrestri ed extraterrestri" (Silvia Bencivelli, 2017)
- Questione antropologica - Life out of Balance!!! "I soggetti sono due, e tutto è da ripensare" (Laura Lilli, 1993).
Il tabù delle mestruazioni: quello che le donne ora dicono
Un evento naturale che è da sempre circondato da imbarazzi e superstizioni. Ma dall’Europa al Nepal le cose stanno cambiando. Abbiamo cercato di capire quanto
di Silvia Bencivelli *
Questo articolo parla di mestruazioni. Non di “cose”, fiori, zie, marchesi, baroni rossi, visite da Roma, cardinali, nature, giacomine e caterine varie. Tantomeno di impurità, immondizie, affari schifosi, mostruosi e oscuri. Parla semplicemente di mestruazioni: quell’evento poco meno che mensile che tra il menarca (la prima volta) e la menopausa (l’ultima) segna senza particolari patemi la vita delle donne in età fertile.
Oggi, tolti di mezzo i pudori, sappiamo che la segna senza macchiarla, per circa 2.400 giorni nel corso di una vita. E sappiamo anche perché avvenga, cioè perché quattro o cinque giorni ogni ventotto le donne in età fertile perdano sangue dalla vagina. Lo si trova persino nei libri di terza media: è il ciclo mestruale, che dipende dall’equilibrio tra alcuni ormoni che regolano la produzione di una cellula uovo al mese. Se questa non viene fecondata (ed è la cosa largamente più frequente) l’epitelio dell’interno dell’utero, che era pronto ad accogliere l’embrione, si sfalda, quindi si ha il sanguinamento e cioè la mestruazione.
 Prima di capirlo, però, consideravamo quei giorni un momento spaventosamente misterioso. Così le vite delle nostre antenate, delle nostre nonne, delle nostre madri, e un po’ anche le nostre, sono state afflitte da leggende secondo le quali in quei giorni facevamo appassire i fiori e impazzire la maionese, mandavamo il vino in aceto e rendevamo acida la conserva di pomodoro.
Prima di capirlo, però, consideravamo quei giorni un momento spaventosamente misterioso. Così le vite delle nostre antenate, delle nostre nonne, delle nostre madri, e un po’ anche le nostre, sono state afflitte da leggende secondo le quali in quei giorni facevamo appassire i fiori e impazzire la maionese, mandavamo il vino in aceto e rendevamo acida la conserva di pomodoro.Ce lo ricordano due libri che raccontano superstizioni e tabù di un passato non troppo passato. Il primo è di Marinella Manicardi, attrice e regista che sulle mestruazioni ha fatto uno spettacolo teatrale dal titolo Corpi impuri per il Festival della Filosofia di Modena, e oggi ha scritto un libro dallo stesso titolo per la casa editrice Odoya. Il secondo è in uscita per Einaudi: Questo è il mio sangue, della giornalista francese Élise Thiébaut, che sarà in libreria dal 23 gennaio.
L’idea di fondo dei due libri è simile: di mestruazioni non si parla, e questo ha contribuito, e contribuisce ancora, alla discriminazione di genere. Thiébaut annuncia una prossima e necessaria “rivoluzione mestruale”, che darà alle donne consapevolezza del proprio corpo e della propria identità. Manicardi parte invece dalla letteratura: Anna Karenina non ha mai le mestruazioni e non le ha mai neppure Emma Bovary. -C’è un’unica eccezione: Margherita, la signora delle camelie. Ma era una prostituta. E la ragione per cui, ogni mese, le sue camelie erano cinque giorni rosse e gli altri bianche Alexandre Dumas la lascia solo intuire. «Se i tempi sono cambiati? Beh, mica tanto» dice Manicardi. Quanto alla nuova pubblicità in cui il sangue viene finalmente rappresentato da un liquido di colore rosso, invece dell’azzurro alieno degli spot precedenti, c’è poco da festeggiare. «È la prima, appunto, e siamo nel 2017».
Oltre agli spot e ai libri, ci sono però anche le provocazioni artistiche, come quella della tedesca Elone, che ha riempito le vie di Karlsruhe di assorbenti con scritte frasi contro la violenza sulle donne, o quella della portoghese Joana Vasconcelos, che ha costruito un lampadario con 14 mila assorbenti interni. E soprattutto ci sono le provocazioni politiche, come il movimento free bleeding, che propone di non usare assorbenti e di lasciare che il sangue si mostri.
 Nel 2015 l’attivista statunitense di origine indiana Kiran Gandhi ha corso così la maratona di Londra (quindi 42 chilometri), e ha spiegato: «L’ho fatto per le mie sorelle che non hanno accesso agli assorbenti e per quelle che li nascondono». In India, infatti, una ragazza su dieci considera il ciclo una malattia e una su quattro al raggiungimento della pubertà è costretta a lasciare la scuola. Mentre in Nepal solo ad agosto di quest’anno è approvata una legge che punisce la pratica millenaria del chhaupadi, cioè la reclusione delle donne mestruate in capanne isolate, in cui non mangiano e non bevono, e possono essere morse dai serpenti.
Nel 2015 l’attivista statunitense di origine indiana Kiran Gandhi ha corso così la maratona di Londra (quindi 42 chilometri), e ha spiegato: «L’ho fatto per le mie sorelle che non hanno accesso agli assorbenti e per quelle che li nascondono». In India, infatti, una ragazza su dieci considera il ciclo una malattia e una su quattro al raggiungimento della pubertà è costretta a lasciare la scuola. Mentre in Nepal solo ad agosto di quest’anno è approvata una legge che punisce la pratica millenaria del chhaupadi, cioè la reclusione delle donne mestruate in capanne isolate, in cui non mangiano e non bevono, e possono essere morse dai serpenti.Anche da noi il pregiudizio antimestruazioni è antico: «Dai tempi di Ippocrate in poi il corpo femminile è sempre stato considerato la versione imperfetta di quello maschile» racconta Francesco Paolo de Ceglia, storico della scienza all’Università di Bari. «Gli organi della generazione sono introflessi, e il tutto viene descritto come umido, molle». Questa “umidità” femminile si credeva destinata a nutrire il bambino, «e si diceva che venisse espulsa con le mestruazioni, una specie di liberatorio salasso naturale». L’idea dell’impurità arriva dalla religione. Ma, prosegue de Ceglia, «la scienza la assorbe. Così si giunge al concetto per cui le mestruazioni sono un po’ come escrementi».
Però poi la scienza è avanzata, vero? «Sì, certo» concede Carlo Flamigni, ginecologo, scrittore e saggista, «ma mica tanto tempo fa». Sono solo sessant’anni che conosciamo la questione dell’utero e dell’ovaio. Flamigni si è laureato nel 1959 e racconta che anche nei libri universitari su cui ha studiato «le mestruazioni servivano a espellere le sostanze tossiche accumulate nel corpo femminile, e segnatamente una che si chiamava menotossina». Quindi, aggiunge, «se il tabù esiste ancora, credo che per superarlo debba scomparire un’intera generazione, la mia».
 Solo sessant’anni significa che le nostre nonne venivano considerate così pericolosamente instabili da non avere accesso alla magistratura. Fino al 1963 lo diceva proprio la legge italiana, nero su bianco: «Fisiologicamente tra un uomo e una donna ci sono differenze nella funzione intellettuale, e questo specie in determinati periodi della vita femminile». Indovinate quali.
Solo sessant’anni significa che le nostre nonne venivano considerate così pericolosamente instabili da non avere accesso alla magistratura. Fino al 1963 lo diceva proprio la legge italiana, nero su bianco: «Fisiologicamente tra un uomo e una donna ci sono differenze nella funzione intellettuale, e questo specie in determinati periodi della vita femminile». Indovinate quali.Alla fine della fiera è difficile dire se qualcosa degli antichi pregiudizi rimanga anche nelle nostre teste, o se siamo vicini alla fine del tabù. «Che io sappia non ci sono dati o rilevazioni affidabili che ci permettano di esprimerci sull’esistenza del tabù» commenta Paola Borgna, sociologa dell’Università di Torino. Ognuno potrà avere le proprie impressioni: «La mia è che il tabù a sfondo religioso sia stato sostituito dalla medicalizzazione. Ed è un aspetto di un processo di medicalizzazione del corpo e delle società più generale, che dà origine a nuove forme di controllo delle nostre vite».
 Un dato di fatto è che, oltre alle donne giudice, oggi possiamo avere le donne astronauta, come Samantha Cristoforetti, che considera gli assorbenti l’ultima delle sue preoccupazioni, terrestri ed extraterrestri: «Se mi chiedono come si viva con le mestruazioni nello spazio? A dire il vero non tanto spesso». Un giorno però Carla ha mandato la domanda al suo blog avamposto42, e Samantha ha risposto così: «Beh, non vorrei fare a cambio con la necessità di radermi il viso tutte le mattine in assenza di peso!». Come dire: l’età adulta e gli ormoni della fertilità propongono modeste seccature. Per i maschi si tratta di farsi
barba e baffi più o meno ogni mattina. Le femmine in fondo se la cavano con quattro o cinque giorni al mese, e nel 2017 non devono più nemmeno fare la fatica di inventarsi giri di parole: sono mestruazioni, semplicemente mestruazioni.
Un dato di fatto è che, oltre alle donne giudice, oggi possiamo avere le donne astronauta, come Samantha Cristoforetti, che considera gli assorbenti l’ultima delle sue preoccupazioni, terrestri ed extraterrestri: «Se mi chiedono come si viva con le mestruazioni nello spazio? A dire il vero non tanto spesso». Un giorno però Carla ha mandato la domanda al suo blog avamposto42, e Samantha ha risposto così: «Beh, non vorrei fare a cambio con la necessità di radermi il viso tutte le mattine in assenza di peso!». Come dire: l’età adulta e gli ormoni della fertilità propongono modeste seccature. Per i maschi si tratta di farsi
barba e baffi più o meno ogni mattina. Le femmine in fondo se la cavano con quattro o cinque giorni al mese, e nel 2017 non devono più nemmeno fare la fatica di inventarsi giri di parole: sono mestruazioni, semplicemente mestruazioni.* la Repubblica, 15 dicembre 2017
SUL TEMA NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione!!!
- L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!! E CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI E CITTADINE D’ITALIA!!!
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - PSICOANALISI E INSEGNAMENTO. Dove e come si perde il ruolo del professore (e dello psicoanalista)..5 gennaio 2018, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
Al liceo.
Chat con studentesse
Dove e come si perde il ruolo del professore
di Ferdinando Camon (Avvenire, venerdì 5 gennaio 2018)
Non illudiamoci: noi parliamo raramente, con reticenza e malvolentieri delle simpatie (per usare un termine neutro) che nascono nelle classi tra professori e studentesse, ovviamente delle superiori, tendiamo a minimizzare, ma loro, le studentesse, ne parlano sempre, e le commentano, con tendenza ad esagerare. La conseguenza è che per loro la loro versione è quella vera, e resterà nel loro cervello per tutta la vita. E se c’è una relazione immaginaria tra un prof e una studentessa, che per loro diventa una relazione vera, corredata di chissà quali e quanti incontri di cui nessuno sa niente, quella storia sarà per loro il marchio che contrassegnerà per sempre quella scuola e quegli anni, e per tutta la vita, a ogni rimpatriata, ne riparleranno. Quella storia, quelle storie, saranno più importanti di Hegel e Kant, che pure le hanno tanto impressionate.
Più importanti di Nietzsche, che oggi va per la maggiore. Quando qualcuna di queste storie trapela sui giornali, diventa subito la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia. In questo momento la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia è certamente l’accusa di rapporti inopportuni del prof di filosofia di un liceo romano con alcune studentesse, quattro delle quali hanno presentato denuncia. Due sono minorenni. Ci sarà una causa. Il prof sarà interrogato e sapremo le sue risposte. Finora non c’è una sentenza, e quindi non parliamo di un reato e di una condanna. Parliamo del fenomeno carsico, sempre negato e tuttavia presente in tutte le scuole, dei legami sentimentali che nascono tra insegnanti e allievi.
Anticipo subito, qui ad apertura, una mia vecchia tesi, ma non obbligo nessuno ad accettarla: il professore, di cui le studentesse non s’innamorano, è un cattivo professore; il professore, che s’innamora delle studentesse, è un cattivo professore. Perciò qui, nel caso del liceo romano, per quel che ne sappiamo finora, il problema non è che le studentesse si scambiavano tra loro email sospirose (o anche esplicite) sul professore, il problema è che email sospirose, anzi esplicite e audaci (parole degli studenti) le scambiava il prof con loro.
La difesa del prof sostiene che i messaggi del prof non sono molestie o violenze, perché hanno sempre ottenuto risposta. Da parte delle ragazze (nel caso delle minorenni, potremmo parlare di bambine) c’è insomma il consenso. Ma, a parte il fatto che il consenso delle minorenni non è valido (per questo son dichiarate minorenni), se la relazione vien corrisposta, vuol dire che è andata molto avanti e che è diventata stabile. Per la ragazza, e per la bambina, innamorarsi del prof è un fenomeno di crescita: si sente più grande, diventa più grande.
Per il prof, innamorarsi di una ragazza o una bambina è un fenomeno di de-crescita, e nel caso della bambina di rimbambimento. Il rapporto del prof con i suoi studenti e studentesse non è diverso dal rapporto dell’analista con i suoi e le sue pazienti. In questo caso, come insegna Freud, è inevitabile, utile, necessario che nasca un trasporto affettivo, che Freud chiama transfert. Il transfert è un grosso problema analitico. Per anni Freud lo intese come un ostacolo all’analisi, il paziente s’innamora del suo analista e va in transfert perché vuole uscire dall’analisi, il transfert va dunque combattuto e ignorato, affinché l’analisi prosegua.
Ma alla fine Freud si convinse che il transfert è un nuovo terreno sul quale il paziente replica i suoi problemi e i suoi bisogni, e che dando importanza al transfert e analizzandolo si favorisce l’analisi, e la si porta a compimento. Posso sbagliare (sono uno scrittore, non uno psicanalista), ma ho sempre guardato con sospetto lo psicanalista che si mette con una sua paziente, e la sposa. Mi sembra un rapporto analitico interrotto e deviato. Per la stessa ragione guardo con sospetto il prof che scambia email erotiche con le sue alunne, ancora minorenni o appena maggiorenni: mi sembra un rapporto didattico perduto e non più recuperabile.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPOCHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - La Costituzione non è mai al sicuro, occhio ai programmi elettorali (di Anna Falcone).28 dicembre 2017, di Federico La Sala
La Costituzione non è mai al sicuro, occhio ai programmi elettorali
1947-2017. La Carta come una bussola nella sfida del voto
di Anna Falcone (il manifesto, 28.12.2017)
Sarà la cifra tonda, sarà che questo compleanno della Costituzione arriva dopo la schiacciante vittoria referendaria del 4 dicembre, fatto sta che mai come quest’anno la ricorrenza della firma è stata fortemente sentita dagli italiani, che hanno partecipato in tanti alle iniziative organizzate per l’occasione in tutta Italia. E non solo per rinnovare il ricordo: questa celebrazione e il messaggio che ne scaturisce assumono un valore cruciale per le prossime elezioni politiche.
Lo hanno giustamente sottolineato Felice Besostri ed Enzo Paolini nell’articolo pubblicato ieri sulle pagine di questo giornale. Perché chi ha vinto la battaglia referendaria, e continua a difendere davanti alle Corti le ragioni della legittimità costituzionale delle leggi elettorali, o a sostenere chi lo fa, non potrà sottrarsi, al momento del voto, a un giudizio di coerenza fra schieramenti politici e rispetto del voto referendario.
Il fatto che a 70 anni dalla sua entrata in vigore la Costituzione è e rimane, in gran parte, inattuata rappresenta - per chi voglia raccoglierla seriamente - la sfida politica per eccellenza delle prossime elezioni. Non a caso, molti elettori ed elettrici, che non si rassegnano all’esistente, chiedono agli schieramenti in campo di ripartire proprio dall’attuazione della Costituzione e dalla implementazione dei diritti già riconosciuti dalla Carta quale antidoto alle inaccettabili diseguaglianze del nostro tempo. Un passaggio necessario, se non indispensabile, per rafforzare la credibilità dei programmi politici e, auspicabilmente, ricucire quel rapporto di fiducia fra politica e cittadini mai così in crisi. Un vulnus democratico tradotto in un astensionismo che sfiora ormai il 55% dell’elettorato: dato più che allarmante a cui non ci si può e non ci si deve rassegnare.
Rilanciare il messaggio della necessaria difesa e attuazione della Costituzione - in particolare delle norme che garantiscono il pieno e trasparente esercizio della democrazia e attribuiscono alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che alimentano e aggravano le condizioni di diseguaglianza fra cittadini - diventa, allora, cruciale, soprattutto alla vigilia di una tornata elettorale le cui regole saranno scandite dall’ennesima legge elettorale ad alto rischio di incostituzionalità.
Pur nella piena consapevolezza che la Costituzione non delinea un programma univoco, capace di blindare le scelte dei diversi governi - è necessario riconoscere, infatti, e una volta per tutte, che esiste un nucleo duro di principi e diritti fondamentali inderogabili che ogni forza politica deve impegnarsi ad attuare, nelle forme e nei modi che ritiene più opportuni, per rispettare quella fedeltà alla Costituzione che li lega indissolubilmente alla Repubblica e ai suoi compiti costituzionali. Un patto democratico di diritti e obiettivi programmatici, inequivocabilmente vincolanti, che deve tornare ad essere il cuore di ogni programma elettorale. Soprattutto a Sinistra.
Sia chiaro: non è un’indicazione di voto, ma il suggerimento a una riflessione suppletiva sul voto e su chi auspicabilmente si impegnerà in maniera chiara e credibile a difendere e attuare la Costituzione. Nella piena consapevolezza che un tale ambizioso obiettivo, per essere concreto, deve essere condiviso da tanti, e non è monopolizzabile da pochi o da forze marginali. Perché la Costituzione non è perfetta, né intoccabile, ma è l’unico punto certo che abbiamo, il primo “bene comune” in cui si riconoscono gli italiani in questa difficile fase di transizione democratica. Se questa virerà verso il restringimento progressivo degli spazi di partecipazione e di democrazia o verso modelli più avanzati dipenderà anche dal se e come eserciteremo il nostro diritto di voto.
In tal senso, l’astensionismo, anche come forma estrema di protesta, più che sortire un ‘ravvedimento’, rischia di favorire le destre nel prossimo Parlamento, e con esse la formazione di uno schieramento largo e più ampio della compagine del futuro governo che, se non arginato, potrebbe trovare i numeri per unire le forze di quanti - avendo fallito le riforme del 2006 e del 2016 - potrebbero convergere su un progetto analogo, se non peggiore. Un’operazione che, (ipotesi remota, ma non impossibile) qualora dovesse raccogliere il sostegno dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera potrebbe non dare spazio neppure alla raccolta delle firme per chiedere il referendum costituzionale e, con esso, il pronunciamento popolare.
Per questo è necessario sollecitare le forze politiche in campo affinché si pronuncino, tutte, sul loro programma costituzionale: sul se e come intendano intervenire sulla Costituzione; sul se e come intendano dare attuazione al suo nucleo duro di principi e diritti inderogabili; sul se e come intendano metterla “in sicurezza” da possibili incursioni di future maggioranze gonfiate. Perché non ci si debba più trovare in futuro a contrastare una riforma o, peggio, una riscrittura della Carta, di parte e neppure menzionata nei programmi elettorali e adeguatamente dibattuta nel Paese. Ai tanti italiani che si sono recati al voto il 4 dicembre, almeno questo, è dovuto.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- DAL MEDIOEVO AL #METOO, QUANT‘È DURA ESSERE DONNE (di Simonetta Fiori).15 dicembre 2017, di Federico La Sala
#MeToo: cos’è il movimento premiato dal Time. *
Me too, anch’io. Sono bastate appena due parole usate da migliaia di donne in tutto il mondo per dare il via al movimento contro le molestie sessuali premiato oggi dal Time come persona dell’anno. Un movimento nato sulla scia dello scandalo Weinstein e divenuto ben presto valvola di sfogo di quanti, almeno una volta nella vita, sono stati vittime di violenze sessuali e hanno scelto di denunciarle pubblicamente dopo averle tenute nascoste per anni. Da qui l’uso dell’ormai celebre hashtag #MeToo, lanciato per la prima volta dall’attivista Tarana Burke e condiviso poi dall’attrice americana Alyssa Milano, proprio per condividere via social i drammatici racconti delle molestie subite.
Tra le cinque "Silence Breakers" che compaiono sulla copertina del settimanale vi sono invece l’attrice Ashley Judd, tra le prime star a puntare il dito contro il produttore statunitense Weinstein, e la cantante Taylor Swift, che lo scorso agosto ha vinto il primo round della causa per molestie sessuali in corso a Denver contro il dj David Mueller, accusato di averle palpato il sedere dopo un suo concerto nel 2013. E ancora, tra le donne in copertina sul ’Time’ anche Adama Iwu, la lobbysta 40enne che ha lanciato il sito ’We said enough’ per denunciare le molestie nel mondo del lavoro e della politica, Susan Fowler, l’ex ingegnere informatico di Uber la cui denuncia di molestie sessuali lo scorso giugno ha portato al licenziamento del Ceo e di altri venti dipendenti e Isabel Pascual(nome di fantasia), la 42enne raccoglitrice di fragole del Messico che ha raccontato pubblicamente le minacce ricevute per aver denunciato gli abusi.
* ADNKRONOS, Pubblicato il: 06/12/2017
DAL MEDIOEVO AL #METOO QUANT‘È DURA ESSERE DONNE
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 14 dicembre 2017)
Ci voleva proprio un libro come questo sulla violenza contro le donne. Perché per la prima volta inquadra il problema nella storia, nella profondità del tempo, dall’età moderna all’evo contemporaneo. E solo uno sguardo storico così lungo può aggiustare il tiro, correggere il significato delle parole, introdurre bussole fondamentali nel caotico flusso di coscienza che deborda sui social e nei media (La violenza contro le donne nella storia, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Viella).
Che casa ci insegna la storia? La prima lezione e che non bisogna restare inchiodati alla prima, elementare evidenza che la brutalità maschile è sempre esistita: a qualsiasi latitudine, in epoche e culture diverse, in ogni ordine e grado della classe sociale. Tutto vero, tutto giusto.
Ma la storia ci insegna che molto è cambiato dai tempi in cui l’aristocratico o il borghese esercitavano legittima violenza sulla moglie riparandosi dietro lo ius corrigendi. Molto è cambiato da allora perché è mutato il mondo in cui la violenza maschile è stata socialmente percepita. Ed è cambiato il modo in cui la violenza è stata riconosciuta e sanzionata dalla cultura giuridica.
Parliamo di tempi biblici, questo sì. Ed è questa la seconda lezione che scaturisce dalle ricerche delle storiche. Nella vita domestica degli italiani la pratica dello ius corrigendi è sopravvissuta di fatto fino agli anni Settanta del secolo scorso, e anche oltre. È sopravvissuta nella permanenza del delitto d’onore (abolito soltanto nel 1981) o nel potere di indirizzo che il pater familias ha potuto imporre alla moglie fino alla riforma del diritto di famiglia (1975). E per fermarci alla più turpe delle violenze - lo stupro - fa ogni volta impressione imbattersi nella penosa circostanza che fino al 1996 è stato giudicato come reato contro la morale e non contro la persona.
Mutamenti significativi, certo, che però hanno richiesto il tenace contributo del femminismo. E a proposito di cesure storiche, un traguardo è stato raggiunto anche da quest’ultima seppur confusa campagna di denunce.
Ce lo fanno capire le storiche quando lamentano un lungo resistente vuoto nelle pubblicità progresso o nella stessa informazione sulla violenza contro le donne. E questa clamorosa assenza ha riguardato finora il volto dell’aggressore. Oggi gli artefici delle molestie hanno una faccia. È la prima volta che accade. E non è un caso che Time abbia dedicato la copertina dell’anno proprio a quelle donne che l’hanno disegnata. Con mano ferma, senza ambiguità. Solo nel nitore del segno c’è la conquista.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- "Liberi e uguali". Uguali a chi? Il caso "Mdp" fa particolarmente impressione.4 dicembre 2017, di Federico La Sala
Di donne non ne abbiamo?
di Roberta Carlini (Lunedì, 04 Dicembre 2017)
Liberi e uguali, avete un problema. Non mi dite che quella foto non ha urtato anche voi. Piero Grasso, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni, Pippo Civati. Quattro su quattro, foto evento della nascita di un partito, tutta al maschile - persino nel presentatore, un giornalista. Compagni, amici, fondatori, fratelli. Qualche pagina più avanti, o un altro clic, e spunta la foto della rielezione di Giorgia Meloni alla presidenza di Fratelli d’Italia, insieme a Daniela Santanché che passa con lei - c’è anche Isabella Rauti, a fare politica nella dirigenza di quel partito.
Perché? L’ascesa delle donne nei movimenti di destra, estrema destra, populisti, xenofobi, è un fenomeno a sé che merita e ottiene grande attenzione. Mentre abbiamo accettato, digerito, sepolto nell’irrilevanza la scomparsa delle donne dalla leadership dei partiti progressisti, di sinistra, socialdemocratici, democratici.
Il caso Mdp fa particolarmente impressione. Perché è un movimento al quale guarda, con interesse o rabbia, con passione o sconforto, chi non accetta l’ordine delle cose. Fa impressione non solo che non ci sia una donna nella prima foto di gruppo, ma anche e soprattutto che la cosa non faccia problema per nessuno dei quattro, o dei 5000 che erano lì.
Di nuovo: perché? Non si risponda - come fece Monti, dicono, quando formò un governo ipermaschile e dovette rimediare all’ultimora - “di donne non ne abbiamo”; perché tra i fondatori di Mdp ce n’è una seria, preparatissima, nientemeno che un’economista, addirittura proveniente dalla società civile (università), ossia Maria Cecilia Guerra. Che magari, come molte donne e al contrario di molti uomini, non ama andare in giro a parlare di cose che conosce poco, ma può dire molto di quelle che conosce bene (qui il suo lavoro politico): politica economica, occupazione, sicurezza sociale... cosette importanti, diciamo, per un soggetto di “liberi e uguali”. Uguali a chi?
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- DITTATURA DELLA X DI AFFARI - AFFETTI E PERDITA DELLA MEMORIA FILOLOGICA E TEOLOGICA.1 dicembre 2017, di Federico La Sala
PERDITA DELLA MEMORIA FILOLOGICA E TEOLOGICA: LA “X” (“CHI”, GRECO) DIVENTA “X” (“ICS”, LATINO; E, SEMPLICEMENTE, "C", IN ITALIANO) E GESU’, IL FIGLIO DELLA GRAZIA EVANGELICA ("CHARITAS") DIVENTA IL "TESORO" DI "MAMMONA" ("CARITAS") E DI "MAMMASANTISSIMA" DEI FARAONI ...
- "IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS": LA CARITA’ dal GRECO (χάρις - χάριτος: "chàris" - "chàritos"; accusativo pl.: " χάριτας" - “chàritas” - dono, grazia) NON dal LATINO (“Caritas” - da “carus”, che - come nell’ italiano, "caro" - ha il doppio senso di “affetto” e "caro-prezzo" ... e richiama le "carenze" affettive ed economiche e la "carestia" - e non l’eu-charis-tia"!!!).
opinioni
La dittatura della X fra affetti e affari
di Vittorio Zucconi (la Repubblica D, 25.11.2017)
Il Medioevo italiano la mise al bando, ma ora si usa ovunque, perché, evidentemente, attira l’attenzione. Che si tratti di business o di baci
ATTESO DA ALMENO cento milioni di esseri umani, molti dei quali in fila da giorni, è arrivato l’ultimo totem per il villaggio globale: l’iPhone X della Apple. Niente di misterioso in quella X, solo la celebrazione in numeri romani del decimo anniversario dell’iPhone lanciato da Steve Jobs: così dicono dalla Mela, ma mentono sapendo di mentire. Per segnalare il decennale, avrebbero potuto benissimo chiamarlo iPhone 10, come i predecessori 6, 7 o 8.
I geni del marketing hanno scelto la X per lo stesso motivo che ha spinto i concorrenti della Microsoft a chiamare la loro scatola da giochi XBox e (nell’ultima edizione diffusa negli stessi giorni dell’iPhone X, per tormentarci il Natale) addirittura XBoxOneX. Tre X al prezzo di una. Non è necessario essere geni dell’enigmistica e dei cruciverba per notare la fissazione per una lettera-simbolo che, da secoli e mai come ora, è uscita dal recinto dell’algebra per invadere i territori del commercio, dell’immaginazione, del calcio e del sesso, pardon, del sex.
La X vende, piace, intriga, nella sua invadenza. L’epidemia di questa lettera (che, nel Medioevo, l’alfabeto italiano aveva escluso, insieme con K e Y, presenti invece nell’alfabeto latino) è naturalmente partita dagli Stati Uniti ed è un indizio del dominio culturale anglofono. È ovunque e le femmine ne hanno pretese addirittura due nei propri cromosomi, XX, lasciando a noi maschi l’umiliazione di quella Y solitaria.
S’insinua nella vita di ogni paziente, che ha sicuramente inghiottito una pillola il cui nome conteneva una X o è stato esposto ai raggi X. Ci sono almeno 50 farmaci da ricetta che la esibiscono, dal tranquillante Xanax, che raddoppia per sembrare più efficace, all’antibiotico Ciprofloxacina, somministrato a milioni di persone afflitte da infezioni delle vie urinarie.
Qualche linguista Usa ha cercato di spiegare l’attrazione con il Cristianesimo, partendo dalla croce che i Romani usavano per uccidere i nemici più pericolosi e che era fatta appunto a X, e non a T come nell’iconografia ufficiale. Ma non c’è nulla di mistico in banali varietà musicali come X Factor, copiato anche in Italia. Dubbi religiosi riaffiorano in dicembre, quando gli americani, sempre impazienti, abbreviano Christmas, Natale, in XMas. Ma poi si sprofonda nel prosaico esercizio del voto, che utilizzò quel segno affinché anche gli analfabeti potessero manifestare sulle schede le scelte politiche.
Resta in esso sempre il brivido del mistero, dell’incognita, come nelle equazioni o nella fantascienza della serie X-Files. Sa di frutto proibito, nei film porno classificati come XXX o nei commerci erotici, in quei Sex Shop che, se si chiamassero "botteghe del sesso", farebbero ancora più schifo. Diventa il richiamo alla morte e alla ferocia dei pirati, con le ossa incrociate a forma - che altro? - di X sotto il teschio. È uno dei molti simboli satanici, ma anche di tenerezza, nella stenografia da chat o da sms, dove sta per "baci", insieme con O, per "abbracci": XOXO, "ti mando baci e abbracci". Tende a essere estremista nell’abbigliamento, con le taglie XS, XL o addirittura, aiuto!, XXL. Anche l’immagine che guardiamo sul televisore, sul computer o sullo schermo dello smartphone paga un tributo, essendo formata da pixel.
Non ha colpe, né meriti questa lettera prepotente, immigrata senza autorizzazione fra di noi, ma qualche segreta e scaramantica influenza negativa forse sì. Soltanto uno, fra i 45 presidenti degli Stati Uniti in 200 e più anni, ha osato avere una X nel proprio nome, Richard Nixon. Finì infatti, primo e unico dimissionario nella storia, crocefisso alla vergogna delle proprie colpe.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori - a c. di Federico La Sala
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA.
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 -- ROBINSON, LE ROBINSONATE, E "IL PROCESSO DI PUTREFAZIONE DELLO SPIRITO ASSOLUTO.28 novembre 2017, di Federico La Sala
IL MITO DELL’AUTONOMIA INTELLETTUALE, ROBINSON, E LE ROBINSONATE ....
DOPO 170 ANNI DALLA BRILLANTISSIMA “Introduzione del ’57”, ove Marx scrive parole assolute e definitive (“La produzione dell’individuo isolato al di fuori della società è una rarità che può capitare ad un uomo civile sbattuto per caso in una contrada selvaggia, il quale già possiede in sé potenzialmente le capacità sociali - è un tale assurdo quanto lo è lo sviluppo di una lingua senza individui che vivano insieme e parlino tra loro”), è più che lodevole ricordare ai cittadini e alle cittadine della Repubblica non solo quello che Marx, nel 18 Brumaio e ne L’ideologia tedesca, chiama “il processo di putrefazione dello spirito assoluto”, e, quello che Lukàcs, sulle orme di Marx, chiama “la prassi dell’individuo isolato” (cfr. Mimmo Cangiano, Il mito dell’autonomia intellettuale, "Le parole e le cose", 28.11.2017), ma anche quello che gli intellettuali di "la Repubblica" si preparano a fare per festeggiare il fatto che “Robinson compie un anno (: hai tutti i numeri? Mandaci una foto della tua collezione. Domenica 10 dicembre inviteremo uno dei lettori a visitare l’Arena Robinson, lo stand del nostro settimanale a "Più libri più liberi"”).
Federico La Sala
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
In principio era il Logos, non il "logo" ...
 DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE. A partire da due, e non da uno!!! Una nota su una polemica tra "esportatori di democrazia" e di "libertà" (Giovanni Sartori e Gian Maria Vian) e la proposta di una Fenomenologia dello Spirito di "Due Soli" - Con Rousseau, Kant, Marx, Freud e Dante, oltre Hegel, per una seconda rivoluzione copernicana
DIO, MONDO, UOMO - OLTRE!!! BASTA CON LE ROBINSONATE. A partire da due, e non da uno!!! Una nota su una polemica tra "esportatori di democrazia" e di "libertà" (Giovanni Sartori e Gian Maria Vian) e la proposta di una Fenomenologia dello Spirito di "Due Soli" - Con Rousseau, Kant, Marx, Freud e Dante, oltre Hegel, per una seconda rivoluzione copernicanaFederico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- Alle origini della politica: "Stato d’innocenza. Adamo, Eva e la filosofia politica medievale"( Gianluca Briguglia).26 novembre 2017, di Federico La Sala
Alle origini della politica
Poteri ispirati dal peccato
I teologi del Medioevo si interrogarono a lungo
su Adamo ed Eva, e sulla necessità di leggi e strutture sociali dopo la cacciata dall’Eden
di Massimo Firpo (Il Sole-24 Ore, Domenica, 26.11.2017)
- Gianluca Briguglia, Stato d’innocenza. Adamo, Eva e la filosofia politica medievale , Carocci, Roma, pagg. 158, € 17
Narrata all’inizio del Genesi, la disobbedienza di Adamo ed Eva nel mangiare il frutto proibito assunse un significato cruciale nel cristianesimo, che individuò in essa il peccato originale, evento fondante del percorso di redenzione del genere umano dalla perfezione edenica alla caduta, dal vecchio al nuovo Testamento. Ma per secoli i teologi ne sottolinearono anche il ruolo decisivo nella storia terrena dell’umanità, perché proprio dalla corruzione provocata dalla caduta avrebbero avuto origine la proprietà, il diritto, l’esigenza di norme, poteri, istituzioni, strutture sociali chiamate a mettere un freno alla violenza, a regolare i conflitti, a reprimere i delitti, a mantenere la pace: ebbe cioè origine la storia, e con essa la politica.
Fu su questo presupposto che sant’Agostino costruì il grandioso disegno del De civitate Dei, fondato sulla dicotomia tra città divina e città terrena, affrontando specificamente la questione del peccato originale nei commenti al Genesi, in cui spiegava come esso avesse reso «inevitabile la jacquerie di tutte le debolezze, le passioni, le violenze e le sopraffazioni che assediano la natura umana e che fanno di ogni individuo al tempo stesso uno schiavo e un tiranno», uno schiavo del suo brutale egoismo e un tiranno nell’imporlo agli altri. Oltre a esporlo alla fame, alla fatica, alla malattia, alla morte, il suo disordine ontologico lo rende incapace «di perseguire il bene, che pure in certa misura vorrebbe». Per questo egli ha bisogno di un potere che freni le forze distruttive del male che è in lui e imponga le norme di una convivenza civile, che nascono quindi da quel male ma al tempo stesso ne costituiscono un rimedio. Ha bisogno per esempio di governare quella concupiscenza che secondo Agostino ha trascinato la riproduzione nel gorgo di una sessualità aggressiva e viziosa, della quale la famiglia rappresenta un pur precario strumento di controllo e regolamentazione.
Molte del resto erano le inquietanti domande che si collegavano a quella primigenia rottura. Perché Adamo ed Eva, pur creati a immagine e somiglianza di Dio, avevano peccato? Perché ai loro figli e discendenti era stata addebitata una colpa di cui non erano responsabili? Tale corruzione ereditaria era totale e assoluta o qualcosa di buono era restato, consentendo quindi agli uomini l’esercizio del libero arbitrio e le scelte morali che ne conseguivano, oppure le loro possibilità di salvarsi dipendevano solo dagli insondabili decreti della predestinazione? E quale sarebbe stata la società umana se i primi progenitori non avessero mangiato il frutto proibito?
«Quando Adamo zappava e Eva filava dov’erano i nobili?», si chiedevano i contadini inglesi in rivolta nel ’300. Quando e perché era nata la servitù? Ed era lecito combatterla e liberarsene? Quale era il fondamento del diritto di coercizione? Quesiti tutt’altro che oziosi, tali da suggerire una ricostruzione alternativa - “controfattuale” - della storia umana, volta a recuperare una razionalità perduta e a indicare una strada da seguire, una meta cui tendere, un obiettivo da raggiungere.
Su tali quesiti, spesso frammisti alle più varie leggende, si interrogarono grandi teologi e canonisti del Medioevo, consapevoli «del nesso produttivo tra immaginazione e ragione» che essi generavano. Di essi, e dell’implicito realismo politico che ne conseguiva, la ricerca di Briguglia ricostruisce con analisi sottili i percorsi tutt’altro che univoci, inoltrandosi con dotta perizia in una selva oscura di Summae e trattati che affrontavano quel garbuglio di problemi.
Dalla lucida «fenomenologia del potere» di Agostino si passa alle distinzioni scolastiche nel definire le origini, gli ambiti di legittimità, le forme di esercizio del potere, e alla raffinata riflessione di san Tommaso, secondo il quale già nell’Eden esistevano differenze tra le creature: tra uomo e donna anzitutto, tra complessioni fisiche diverse, tra gradi disomogenei di bellezza, santità, attitudini, capacità. Differenze che non inficiavano la libertà di ciascuno (anzi, nascevano proprio da essa), ma creavano distinzioni e con ciò davano vita a spazi di azione politica tali da smentire che quest’ultima fosse solo una conseguenza del peccato originale. Anche il mondo edenico, insomma, sarebbe stato un mondo da governare e governato, e pertanto «la politica non è frutto del peccato», ma scaturisce da un ordine divino delle cose.
Il fatto che ogni autorità, ogni istituzione e forma di governo, ogni diritto di punire, ogni dovere di obbedienza derivi dalla corruzione e dal disordine prodotti dal peccato originale, non significa legittimare la tirannia, poiché nella tutela dell’ordine sociale il potere politico deve pur sempre rispettare criteri di razionalità. Anch’esso nasce da Dio, insegna san Paolo (Rom. XIII, 1). Per questo gli uomini devono accettarlo non solo per paura o mancanza di libertà, ma «con un’adesione interiore», cui solo in rari casi di iniqua tirannia è lecito sottrarsi.
Ci si poteva quindi chiedere se fosse possibile restaurare la politica che aveva retto gli uomini prima della caduta, abbandonare il diritto positivo per ristabilire nella sua pienezza il diritto naturale. Secondo i teologi francescani, per esempio, la vocazione alla povertà del loro ordine era un modo per tornare al primitivo stato di innocenza di cui anche Cristo e gli apostoli erano stati un esempio.
«Idee incendiarie», a ben vedere, dal momento che davano vita a una contestazione radicale della Chiesa come corpo giuridico e struttura di potere quale si era venuta costituendo in Occidente. E ancor più incendiarie furono quelle espresse a metà Trecento da John Wyclif, che dalla restaurazione della grazia per tramite della fede giungeva alla definizione della vera Chiesa come comunità dei predestinati, dalla quale anche il papa poteva essere escluso.
Idee poi riprese dalla Riforma protestante, mentre le grandi scoperte geografiche imponevano di interrogarsi sulle misteriose origini dei nuovi popoli al di là degli oceani, che sembravano mandare in pezzi la monogenesi biblica. E infine Robert Filmer che nel suo trattato Patriarca, o del potere naturale dei re, apparso postumo nel 1680, affermava contro Francisco Suarez e la seconda scolastica l’idea di un Adamo che non era stato solo padre ma anche re della sua discendenza, e quindi archetipo dell’intangibile diritto divino dei sovrani.
 Fu contro di lui che John Locke scrisse il primo dei Due trattati sul governo, con i quali - sviluppando il contrattualismo hobbesiano - avrebbe costruito le fondamenta di un potere assoluto che scaturiva dal basso e non proveniva più da Dio. L’era di Adamo ed Eva era ormai finita per sempre.
Fu contro di lui che John Locke scrisse il primo dei Due trattati sul governo, con i quali - sviluppando il contrattualismo hobbesiano - avrebbe costruito le fondamenta di un potere assoluto che scaturiva dal basso e non proveniva più da Dio. L’era di Adamo ed Eva era ormai finita per sempre.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ADAMO, EVA ... E L’EDEN? Archeologia, preistoria, e storia
L’ITALIA, LA CHIESA CATTOLICA, I "TESTICOLI" DELLE DONNE E LA "COGLIONERIA" DEGLI UOMINI OVVERO ANCHE LE DONNE HANNO LE "PALLE". L’ammissione di Giovanni Valverde, del 1560!!! E CHE COSA SIGNIFICA ESSERE CITTADINI E CITTADINE D’ITALIA!!!
"GENESI" E GENERE SESSUALE. MUTAMENTI "BIBLICI" IN CORSO.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Pace, giustizia, e libertà nell’aiuola dei mortali DANTE: IL PARADISO TERRESTRE, UN PROGRAMMA PER I POSTERI.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 -- L’esploratore di esopianeti Michael Gillon: «Cari ragazzi, una rivoluzione vi aspetta» (di Nicla Panciera).22 novembre 2017, di Federico La Sala
L’esploratore di esopianeti Michael Gillon:
«Cari ragazzi, una rivoluzione vi aspetta»
di Nicla Panciera (La Stampa, 22.11.2017)
«Ci sono innumerevoli Soli e innumerevoli terre, tutte ruotanti attorno ai loro soli, esattamente allo stesso modo dei sette pianeti del nostro Sistema Solare», scriveva Giordano Bruno nel 1584. Per dare conferma scientifica a quest’ipotesi visionaria sull’esistenza di pianeti orbitanti intorno a stelle come il Sole ci sono voluti tre secoli. Ma sono bastati 20 anni dalla scoperta del primo esopianeta extrasolare, 51 Pegasi b, per arrivare a contarne oltre 3 mila.
«Queste cifre suggeriscono che quasi tutte le stelle della nostra galassia e, quindi, dell’intero Universo ospitano un sistema planetario. Nei vari mondi fin qui osservati è emersa un’inaspettata diversità e ora ne stiamo studiando le diverse architetture, la loro formazione ed evoluzione», ci spiega Michael Gillon dell’Università di Liegi in Belgio. Per i suoi contributi alla fondazione della disciplina che studia gli «altri mondi», l’esoplanetologia, gli è stato assegnato il Premio Balzan 2017, riconoscimento di 750 mila franchi svizzeri.
È suo il primo nome sul lavoro pubblicato da «Nature» sulla scoperta di sette pianeti simili alla Terra intorno alla nana rossa Trappist-1. Cacciatore di pianeti fin da quando ha deciso di volgere lo sguardo al cielo, il giovane ricercatore ha già incontrato molti studenti intelligenti e brillanti. A loro dice di non farsi spaventare dai piccoli ostacoli iniziali, ma di concentrarsi sulla magia dell’astrofisica: «Imbarcarsi in quest’avventura non li deluderà, viviamo in un momento entusiasmante in cui c’è spazio per grandi scoperte. La passione deve, però, essere così dirompente da sovrastare gli altri bisogni»: parola di un ex militare che ha trascorso sette anni in fanteria prima di decidere di riprendere gli studi e di dedicare il suo rigore e la sua tenacia alle battaglie scientifiche.
È molto riconoscente verso l’amata Wendy e i figli Amanda e Lucas per il supporto ricevuto e ammette di non rappresentare la norma: «Dopo il post-dottorato, a Ginevra, sono tornato a Liegi, ma la maggior parte degli scienziati si sposta per acquisire competenze da un ateneo all’altro, di continente in continente, e spesso finisce per stabilirsi molto lontano dal proprio Paese e dai propri cari».
L’astrofisica - conferma - sta vivendo un momento di grande fermento. Sta per partire il progetto che Gillon ha nominato come i celebri biscotti belgi, «Speculoos» e, nel 2019, Esa e Nasa lanceranno il gigantesco telescopio spaziale «James Webb». Intanto, in Cile, è in via di installazione il telescopio europeo E-Elt, il più grande mai realizzato finora. Assistiamo poi ad un moltiplicarsi di missioni per la ricerca di nuovi mondi: «Tess» della Nasa, al via la prossima primavera, e «Cheops» e «Plato» che l’Esa lancerà rispettivamente nel 2019 e 2025.
Le aspettative sono pari agli sforzi messi in campo: «Ci stiamo attrezzando per esplorare una terra incognita, dove mai abbiamo messo piede e neppure gettato lo sguardo», assicura il cacciatore di esopianeti e, muovendo le mani davanti a sé come afferrando una torcia, ribadisce: «Illuminiamo i territori bui con i nostri telescopi, che ci restituiranno un sacco di sorprese». Come accadde a Galileo con il suo cannocchiale: «È difficile dire che cosa otterremo dai vari programmi in partenza, in pratica tutto è possibile. A guidarci non è solo la teoria ma l’osservazione. Non puntiamo solo, come un tempo, alla conferma sperimentale delle ipotesi fisiche. Stiamo spingendo al massimo le capacità tecnologiche, che costituiscono, di fatto, i limiti delle nostre conoscenze».
E, infine, la grande questione che affascina da sempre l’umanità: la vita. «Cercando tracce chimiche di attività biologica, vogliamo scoprire la prevalenza della vita nello spazio, non avendo alcuni a priori sulla frequenza di questo evento. Questo ci aiuterà a capire meglio le nostre origini e a mettere la nostra esistenza in una prospettiva galattica. Le implicazioni vanno oltre la scienza e invadono i reami della filosofia. Sono gli aspetti sociali e culturali a rendere questo interrogativo fondamentale».
Quanto ci vorrà? «Potrebbero bastare uno o due decenni. Il meglio deve ancora venire. Una rivoluzione scientifica è alle porte». La generazione di giovani scienziati che dichiarerà l’eppur c’è vita, dall’impatto travolgente come l”eppur si muove” galileiano, è già nata.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO - Il lungo silenzio che ferisce le donne (di .Elisabetta Rasy).20 novembre 2017, di Federico La Sala
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne... *
Verso il 25 novembre
Il lungo silenzio che ferisce le donne
La denuncia di violenze è stata messa a tacere nel corso della storia. Solo da poco ha ottenuto uno spazio pubblico e un accenno di ascolto
di Elisabetta Rasy (Il Sole-24 Ore, Domenica, 19.11.2017)
Di fronte al cupo e regolare rimbombo degli omicidi, quello che si chiama sbrigativamente femminicidio, cioè vite femminili spezzate con violenza e furore da persone contigue e non da criminali occasionali, spesso si tende a dire che si tratta della reazione dei maschi sviliti di fronte al nuovo potere e alla nuova libertà femminile che essi, i maschi impauriti, non sarebbero in grado di accettare.
Ma le cose stanno davvero così? Basta uno sguardo alla cronaca per rendersi conto che la violenza contro le donne è orizzontale: dagli stupri indiani a quelli dell’Isis, dalle bambine forzate al matrimonio alle punizioni corporali per le colpevoli di adulterio secondo la legge islamica, dalle pratiche di aborto selettivo - selettivo cioè dei feti femminili - alle figlie femmine chiuse in orfanotrofi lager in Cina e ai dati dell’obitorio di Ciudad Suarez con le migliaia di ragazze brutalizzate e uccise, è impossibile non rendersi conto che la mappa delle violenze non conosce confini e riguarda il mondo occidentale evoluto come quelle aree più remote dove lo sviluppo economico e sociale fatica ad arrivare. E basta poi dare uno sguardo al passato, ai libri di storia e di letteratura, per capire che la violenza femminile è anche verticale, comincia dal mito, per esempio il sacrificio di Dafne per sfuggire ad Apollo, come lo racconta magnificamente Ovidio o come superbamente l’ha scolpito Bernini: uno stupro fatto ad arte, potremmo definirlo.
Poiché sono molti gli equivoci in materia, vorrei insistere contro l’idea che possa esserci una sorta di prezzo da pagare per la (ancora poca) libertà conquistata: Yara Gambirasio aveva tredici anni quando è stata barbaramente aggredita e lasciata morire, l’unica libertà che aveva era di andare a far ginnastica in palestra. Proprio questo scampolo di libertà, questa libertà da bambina, le è stato fatale. Fortuna Loffredo, del derelitto Parco Verde di Caivano, aveva sei anni quando è stata buttata dal settimo piano e da un anno veniva regolarmente abusata: aveva la libertà che hanno le bambine di cui nessuno si occupa e che possono diventare il giocattolo della crudeltà del mondo.
Pure a qualcuno viene ancora in mente, vedi il parroco del quartiere San Donato di Bologna, di mettere in relazione la violenza maschile con la libertà delle donne che spesso non è altro che fiducia, voglia di allegria. (Chissà se quel parroco tanto impegnato su Facebook ha avuto il tempo di leggere la notizia delle ventisei giovani nigeriane trovate morte su un gommone partito dalle coste libiche verso l’Italia, sui corpi delle quali sono stati trovati lividi, segni di percosse, ossa rotte, forse brutalizzate prima della partenza o forse dopo, per lasciarle indietro come merce avariata al momento del tentativo di salvataggio: sono state sventate?). E, dal momento che è il tema del giorno, viene in mente a qualcun altro, una bellissima e ammiratissima attrice, di richiamare alla prudenza (prudenza? e di chi verso chi?) e di invitare a non confondere avances e molestie, quando anche una adolescente sa che le avances sono tali quando lei le gradisce e quando c’è reciprocità nel desiderio e smettono immediatamente di esserlo quando invece sono atti subiti.
Il caso Weinstein ha un merito: ha messo in campo, oltre a uno smodato desiderio di dire la propria opinione e di creare tifoserie contrapposte, un interessante pregiudizio basato sostanzialmente su un unico capo d’accusa: se molestie ci sono state andavano smascherate subito e invece, arrivando anni e anni dopo i fatti, la denuncia delle donne è in colpevole ritardo.
Vero, giusto, proprio così, non si potrebbe mettere meglio a fuoco la situazione: la parola delle donne è in ritardo. Solo che non si tratta di quei venti anni dai fatti, cioè dalla prepotenza sessuale del produttore americano. Gli anni sono molti di più: sono secoli e millenni. La parola femminile sconta un ritardo infinito per essere stata tacitata da un inviolabile obbligo di silenzio lungo tutto il corso della storia. È davvero da molto poco che ha conquistato uno spazio pubblico, e solo qua e là nel mondo uno spazio di ascolto. Ed è un ritardo certamente colpevole, essendo la colpa però non di chi non può parlare ma di chi impedisce all’altro di farlo: non è un silenzio qualsiasi, è l’impossibilità di parola che sempre si verifica quando c’è uno sbilanciamento dei poteri, uno squilibrio dei diritti.
In materia di donne è proprio ritardo la parola chiave. Lo incontriamo in ogni campo della vita femminile e non è difficile scorgere il nesso tra questo ritardo e la violenza. Dai ritardi del passato (siamo sicuri di ricordare che solo nel 1981 vengono abrogate nel norme del codice penale relative al delitto d’onore?) a quelli di oggi la situazione non è meno grave.
Di violenza parlano chiaramente le cifre. Per esempio quelle di una recente ricerca del World Economic Forum sul divario di genere nel mondo, i cui parametri non sono la ridda delle opinioni contrapposte ma elementi precisi, cioè economia, politica, salute, formazione. Ci vorranno, secondo le previsioni, cento anni per colmarlo, questo divario.
L’Italia, rispetto ai quattro parametri, è all’ottantaduesimo posto (dopo Burundi, Bolivia, Mozambico...), ma se si considerano invece solo i parametri della situazione economica e della salute scende al centodiciottesimo posto. Salute e denaro, cioè utensili della sopravvivenza. Come è possibile che chi sia in una posizione così precaria possa difendersi dagli agguati della violenza? La precarietà crea dipendenza, fragilità, sottomissione, cioè potenziale esposizione alla violenza. E non riguarda soltanto le più sfortunate e le più derelitte: è vero, c’è anche chi guadagna bene e chi può curarsi, ma se non c’è parità diffusa che possa penetrare nelle menti e nei cuori e nel corpo collettivo della società, non c’è sicura difesa dalla violenza. E non c’è sicurezza senza giustizia, se non sono tutelate tutte le donne non lo è nessuna.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
 Uomini e donne, per un "cambio di civiltà" - al di là del Regno di "Mammasantissima": l’alleanza edipica della Madre con il Figlio, contro il Padre, e contro tutti i fratelli e tutte le sorelle.
Uomini e donne, per un "cambio di civiltà" - al di là del Regno di "Mammasantissima": l’alleanza edipica della Madre con il Figlio, contro il Padre, e contro tutti i fratelli e tutte le sorelle.
 USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE.
USCIAMO DAL SILENZIO: UN APPELLO DEGLI UOMINI, CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE."CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
GIAMBATTISTA VICO: OMERO, LE DONNE, E I "NIPOTINI" DI PLATONE
 PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --Tutta la verità sull’amore secondo Wojtyla e il filosofo Semen14 novembre 2017, di Federico La Sala
Il filosofo Semen.
Tutta la verità sull’amore secondo Wojtyla
Il filosofo francese Yves Semen spiega la teologia di Giovanni Paolo II su sessualità e matrimonio: «Le sue catechesi sono armi della luce per contrastare oggi l’ideologia del gender»
di Antonio Giuliano (Avvemire, martedì 7 novembre 2017)
Chiamatela pure “teologia del sesso”. Nessuna reticenza, nessun imbarazzo. L’ha definita proprio così il suo autore, un papa, un santo della Chiesa. La “scandalosa” Teologia del corpo di san Giovanni Paolo II è un tesoro prezioso che pur affermando verità scomode non ha alcuna soggezione nei confronti della cultura dominante. Sono ben 129 discorsi sull’amore umano che il pontefice polacco pronunciò nelle sue udienze del mercoledì dal 1979 al 1984. Una raccolta che spiazza ancora oggi come testimonia da anni un laico francese, il filosofo Yves Semen, presidente- fondatore dell’Istituto di Teologia del corpo a Lione e professore presso la Libera Facoltà di Filosofia a Parigi.
Appassionato e competente divulgatore delle lezioni di Karol Wojtyla, Semen ha curato ora un nuovo Compendio della teologia del corpo di Giovanni Paolo II (Ares, pagine 216, euro 15). Oltre a rivedere la traduzione dei testi, lo studioso ha tenuto conto del manoscritti originali di queste catechesi redatte in polacco ben prima dell’elezione al soglio pontificio. Non è dunque casuale che Wojtyla più che la sua firma personale abbia voluto mettere quella da pontefice: «Si tratta del più vasto insegnamento mai proposto da un Papa su uno stesso argomento ed è significativo che abbia voluto presentarlo all’inizio del suo pontificato come a farne il pilastro di tutto il suo magistero». A corredo del compendio, Semen inserisce anche un utile glossario che riprende parole e concetti dirompenti, come “godimento”: «Nella Teologia del corpo il piacere legato al godimento è talvolta considerato in senso positivo in quanto piacere erotico nobile conforme al disegno divino sulla sessualità umana, talvolta in senso negativo quando è ricercato per sé stesso e mediante l’uso e la strumentalizzazione dell’altra persona a servizio di un piacere egocentrico». Un manuale controcorrente che, smentendo i soliti pregiudizi, esalta il corpo e la sessualità umana, mettendo in luce un desiderio di infinito che nessun “consumo” o possesso può appagare.
George Weigel, biografo di Giovanni Paolo II, l’ha definita «una sorta di bomba ad orologeria teologica». Ma i cattolici hanno compreso la Teologia del corpo?
«Solo da qualche anno sono stati pubblicati libri di buona divulgazione e iniziative per farla conoscere. Adesso si stanno per diffondere anche all’estero i Forum Wahou (www.forumwahou. fr) che dal 2015 in Francia hanno già radunato migliaia di persone: nel corso di un week end la gente scopre la grandezza e la bellezza dell’amore nel piano divino. L’Istituto che presiedo dal 2014 ha già formato più di 120 persone in grado di insegnare questa teologia. Formiamo anche i genitori perché a loro spetta la responsabilità primaria dell’educazione sessuale dei ragazzi. Il successo che stiamo riscontrando, è il segno che qualcosa di nuovo sta nascendo nella Chiesa».
Difensore energico dell’Humanae vitae, Giovanni Paolo II ha detto che: «La prima, ed in certo senso la più grave difficoltà è che anche nella comunità cristiana si sono sentite e si sentono voci che mettono in dubbio la verità stessa dell’insegnamento della Chiesa». Crede che un giorno la Chiesa possa rivedere il magistero di Wojtyla?
«Non è la Chiesa che può cambiare la Teologia del Corpo ma è la Teologia del corpo che può cambiare la Chiesa! Bisogna lavorare alla sua larga e fedele diffusione perché la visione della persona e dell’amore che promuove è liberatrice e permette di comprendere la dimensione “profetica e sempre attuale” dell’ Humanae vitae, per usare le parole di Benedetto XVI».
La società oggi dà al “corpo” un significato diverso da quello di Giovanni Paolo II che risale al principio, all’uomo creato a immagine di Dio.
«La cultura contemporanea ha reso il corpo un materiale privo di senso che può essere manipolato in tanti modi. Fino alle affermazioni deliranti del transumanesimo. Per Wojtyla invece il corpo è stato fatto per realizzarsi nel dono di sé e per rivelare il divino: “Il corpo, e soltanto esso, è capace di rendere visibile ciò che è invisibile: lo spirituale e il divino. Esso è stato creato per trasferire nella realtà visibile del mondo il mistero nascosto dall’eternità in Dio, e così esserne segno”».
La Teologia del corpo insiste tanto sulla persona creata maschio e femmina. Un ammonimento profetico contro la diffusione del gender che oggi vuole annullare le differenze sessuali.
«Sì è una teologia della mascolinità e della femminilità che dimostra come il sesso non sia un semplice attributo, ma un dato fondamentale antropologico che qualifica la persona. È in questo senso che il cardinale Ouellet disse che la teologia di Giovanni Paolo II è l’unico vero “antidoto” all’ideologia del gender. Le catechesi di Wojtyla sono armi della luce per affrontare la corruzione antropologica del gender».
Niente contraccettivi, niente rapporti prematrimoniali... Spesso la Chiesa è stata accusata di dire sempre di “no”.
«Ma la Chiesa dice “sì”. Sì alla verità dell’amore come dono di sé. Sì alla verità del corpo fatto per essere donato. Sì alla nobiltà e alla dignità della sessualità. Sì alla grandezza del dono della vita. Sì al matrimonio come vocazione autentica alla santità. Sì al celibato offerto come annuncio profetico del Regno».
Perché i metodi naturali, che non sono contraccettivi, sono ancora poco conosciuti?
«Non se ne parla abbastanza, sebbene essi permettono di esercitare una maternità e una paternità realmente responsabili nel rispetto dell’integrità del corpo della donna. Molti però lo stanno comprendendo: in Francia, in dieci anni, la percentuale di donne che utilizzano la pillola è scesa dal 46% al 33%».
La teologia del corpo riprende un passo del Discorso della Montagna che Wojtyla stesso ammoniva dal considerarlo solo un divieto, ma come chiave per uno sguardo puro che ci permetterà un giorno di godere in anima e corpo il “sommo piacere” della visione di Dio.
«Quando Gesù dice: “Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” rivolge un appello al cuore dell’uomo, a non farsi dominare dalla concupiscenza che mira ad usare l’altro e a considerarlo oggetto di godimento e possesso. Ecco perché Giovanni Paolo II non ha esitato a affermare che uno può essere adultero anche con la propria moglie se la considera come oggetto per appagare il proprio istinto sessuale. Quando gli è stato obiettato che era “troppo esigente”, ha semplicemente risposto: “Non sono io che sono esigente, è Cristo”».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla, Marietti 1968/1978).
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - Quando la Chiesa amava tutti gli uomini esclusi gli africani (di Rita Monaldi - Francesco Sorti)12 novembre 2017, di Federico La Sala
Quando la Chiesa amava tutti gli uomini esclusi gli africani
Il libro di un prete nigeriano svela il ruolo dei papi nella pratica dello schiavismo fino al 1839
di Rita Monaldi Francesco Sorti (La Stampa, 12.11.17
I papi hanno abusato della Bibbia per lucrare sul traffico di schiavi». Queste parole non vengono da qualche autore di thriller trash a base di scandali vaticani, ma da uno storico serio che sul tema vanta una doppia legittimazione. È nigeriano (quindi partie en cause) e soprattutto è un prete cattolico. Si chiama Pius Adiele Onyemechi ed esercita da 20 anni il suo ministero in Germania, nella regione del Baden-Württemberg.
La sua innovativa indagine The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans 1418-1839 (pp. XVI/590., €98 Olms, 2017), che tra gli storici già suscita discussioni, capovolge il vecchio dogma secondo cui il Papato è stato sostanzialmente estraneo alla più grande strage di tutti i tempi: la tratta degli schiavi. Una tragedia secolare che - come ricorda il grande scrittore danese Thorkild Hansen nella sua classica trilogia sullo schiavismo - ha seminato oltre 80 milioni di morti.
Una sorpresa
Proprio in questi mesi la prestigiosa Accademia delle Scienze di Magonza ha concluso un colossale progetto di ricerca sulla storia della schiavitù durato ben 65 anni, con la collaborazione di studiosi di primo piano come il sociologo di Harvard Orlando Patterson (egli stesso discendente di schiavi) e lo storico dell’antichità Winfried Schmitz. Quasi a suggello è arrivato il libro di don Onyemechi: una radiografia minuziosa del ruolo dei papi nel commercio di schiavi in Africa dal XV al XIX secolo, l’epoca dorata del business schiavistico.
Per la prima volta a suon di date, fatti e nomi don Onyemechi punta il dito su responsabilità morali e materiali, avviando un regolamento di conti col passato proprio nel momento in cui la Chiesa di Roma, nella sua tradizione secolare di sostegno ai più deboli, chiama alla solidarietà verso i migranti. Come riassume l’autore, i risultati «fortemente sorprendenti» venuti alla luce «affondano un dito nelle ferite di questo capitolo oscuro della Storia, e nella vita della Chiesa cattolica».
«La Chiesa», spiega il religioso, «ha abusato del passo biblico contenuto nel capitolo 9 della Genesi», in cui si afferma che tutti i popoli della terra discendono dai figli di Noè: Sem, Cam e Iafet. Dopo il diluvio, Cam rivelò ai fratelli di aver visto il padre giacere ubriaco e nudo. Noè maledisse Cam insieme a tutti i suoi discendenti, condannandoli a diventare servi di Sem e Iafet. La Chiesa allora affermò che gli africani sarebbero i discendenti di Cam. Pio IX, ancora nel 1873, inviterà tutti i credenti a pregare affinché sia scongiurata la maledizione di Noè pendente sull’Africa.
Documenti scomparsi
Nel nostro romanzo Imprimatur abbiamo reso noto il caso di Innocenzo XI Odescalchi (1676-1689), che possedeva schiavi, era in affari con mercanti negrieri e vessava i forzati in catene sulle galere pontificie. I documenti che lo provano, pubblicati nel 1887, sono poi misteriosamente scomparsi. Certo, nel Seicento i moderni diritti umani erano di là da venire, ma poi papa Odescalchi è stato beatificato nel 1956, e in predicato per la canonizzazione nel 2002.
Di simili contraddizioni don Onyemechi ne ha scovate a migliaia. Il commercio di schiavi in origine toccava Cina, Russia, Armenia e Persia; mercati internazionali si tenevano a Marsiglia, Pisa, Venezia, Genova, Verdun e Barcellona. Col tempo queste rotte sono tutte scomparse, tranne quelle africane. Come mai? Sarebbe stata la Chiesa a giocare il ruolo decisivo, raccomandando a sovrani e imperatori di «preferire» schiavi africani. Lo fecero vescovi e perfino Papi come Paolo V.
La giustificazione veniva non solo dalla Bibbia ma anche da Aristotele, per il quale alcuni popoli erano semplicemente «schiavi per natura». Una visione poi ripresa da San Tommaso e dall’influente facoltà teologica di Salamanca nel XV e XVI secolo. Padri della Chiesa come Basilio di Cesarea, Sant’Ambrogio, Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo e lo stesso Sant’Agostino invece giustificavano la schiavitù come frutto del peccato originale.
Il Portogallo
A metà del XV secolo il portoghese Niccolò V concesse al suo Paese di origine il diritto di evangelizzare, conquistare e deportare «in schiavitù perenne» gli africani, bollati come nemici della Cristianità insieme ai saraceni (che in verità erano ben più pericolosi e martoriavano, loro sì, i regni cristiani). I successori Callisto III, Sisto IV, Leone X e Alessandro VI non fecero altro che confermare e ampliare i diritti concessi al Portogallo. Altri Pontefici (Paolo III, Gregorio XIV, Urbano VIII, Benedetto XIV) nelle loro Bolle ufficiali si schierarono contro la schiavitù degli Indiani d’America, ma non contro quella degli africani.
Dallo schiavismo la Chiesa ha avuto un concreto ritorno economico. Attivissimi i missionari portoghesi e soprattutto i gesuiti, che compravano gli schiavi per impiegarli nelle loro piantagioni in Brasile e nel Maryland. Oppure li rivendevano con la loro nave negriera «privata», che trasportava la merce umana da Congo, Luanda e São Tomé verso il Brasile.
Don Onyemechi cita il contratto con cui nel 1838 il Provinciale dei Gesuiti del Maryland, Thomas Mulledy, vendette 272 schiavi africani. Prezzo: 115.000 dollari al «pezzo». L’evangelizzazione consisteva per lo più nel battezzare in fretta e furia gli schiavi prima di imbarcarli. Anzi, tutto il meccanismo faceva sì che essi venissero tenuti ben lontani dalla parola di Cristo. I profitti venivano reinvestiti in nuove campagne di aggressione e deportazione.
Riconoscimento tardivo
«Solo nel 1839 la Chiesa ha riconosciuto gli africani come esseri umani al pari di tutti gli altri», ricorda lo storico di origine nigeriana. Lo sancì una Bolla di Gregorio XVI, in verità piuttosto tardiva: i commerci di schiavi erano stati già aboliti da quasi tutti gli Stati tra 1807 e 1818 e gli Inglesi ne avevano preso le distanze sin dalla fine del Settecento. Don Onyemechi ha lavorato su fonti originali nell’Archivio Segreto Vaticano e negli archivi di Lisbona (per decifrare i manoscritti lusitani ha imparato da zero il portoghese) e ha dato un contributo duraturo (realizzato con routine teutonica ogni giorno dalle 3 alle 8 del mattino) alla ricerca della verità storica. A Roma non dovrebbe riuscire sgradito, vista l’attenzione di papa Francesco - anche lui gesuita - per i popoli d’Africa.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - "AMISTAD" (1839): JOHN QUINCY ADAMS, ABRAHAM LINCOLN, NELSON MANDELA.13 novembre 2017, di Federico La Sala
Nota aggiunta.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
ABRAHAM LINCOLN E GLI STATI UNITI DI AMERICA, OGGI: LA LEZIONE DI STEVEN SPIELBERG.
UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone".
 "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO.
"CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO.
-
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "Credo fermamente che ciascuno di noi debba innanzi tutto amare se stesso". Laura Mesi, la prima sposa single d’Italia.23 settembre 2017, di Federico La Sala
CONOSCI TE STESSO, CONOSCI TE STESSA!!! Dopo millenni di riflessione, la nostra identità ("tautòtes" - greco) ancora nella culla ...
Abito bianco, bomboniere e 70 invitati alla festa: in Brianza la prima sposa single d’Italia
"Se a 40 non ho ancora il fidanzato faccio il matrimonio con me stessa": Laura Mesi ha mantenuto la promessa. E ha organizzato un mega party costato 10mila euro, viaggio di nozze compreso. "Ecco la mia fiaba senza principe azzurro"
di LUCIA LANDONI *
- Dal taglio della torta alle bomboniere: il fotoracconto del matrimonio della sposa single di Lissone Laura, la prima sposa single: ’’Non divorzierò mai da me stessa, nemmeno per l’uomo della mia vita"
Abito bianco, bomboniere, taglio della torta, lancio del bouquet, familiari e amici commossi. Quello di Laura Mesi, 40enne istruttrice di fitness di Lissone (in provincia di Monza e Brianza), è stato un matrimonio tradizionale in tutto e per tutto, salvo per un particolare: mancava lo sposo.
"Sono la prima sposa single d’Italia. Qualche mese fa l’ha fatto anche un uomo di Napoli, ma a me l’idea era già venuta due anni fa. Avevo detto a parenti e amici che se entro il quarantesimo compleanno non avessi trovato la mia anima gemella mi sarei sposata da sola - spiega - Credo fermamente che ciascuno di noi debba innanzi tutto amare se stesso. Si può vivere una fiaba anche senza il principe azzurro. Se un domani troverò un uomo con cui progettare un futuro ne sarò felice, ma la mia felicità non dipenderà da lui".
- Dal taglio della torta alle bomboniere: il fotoracconto del matrimonio della sposa single di Lissone
Laura si è data da fare e ha organizzato in totale autonomia la sua cerimonia dei sogni: "Ho speso un po’ più di 10mila euro, pagando tutto di tasca mia. Ho fatto una piccola follia per il vestito e per le fedi, che sono due intrecciate in un unico anello. Grazie ai regali dei 70 invitati sono riuscita a coprire le spese del pranzo nuziale. Mi sono concessa anche il viaggio di nozze. Il giorno dopo la cerimonia, che si è tenuta in un ristorante di Vimercate, sono partita per Marsa Alam, sempre da sola".
Il matrimonio, celebrato da un amico che per l’occasione ha indossato una fascia tricolore, non ha alcun valore legale né religioso, ma la sposa garantisce che le emozioni provate sono state assolutamente reali: "Ho promesso di amarmi per tutta la vita e di accogliere i figli che la natura vorrà donarmi. Anche i miei familiari sono stati molto felici, compreso mio fratello che all’inizio era scettico sulla mia idea e invece poi ha finito per commuoversi accompagnandomi verso il celebrante".
Un’esperienza che la sposa single - seguita sull’omonima pagina Facebook da circa 1300 persone - ammette non essere per tutti: "Per portate avanti un progetto del genere servono una certa disponibilità economica, il sostegno di chi si ha intorno e soprattutto un pizzico di follia"
* LA REPUBBLICA, 21 SETTEMBRE 2017 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- NUOVO REALISMO: LA LEZIONE DI DANTE, OGGI. CONOSCERE SE STESSI E CHIARIRSI LE IDEE, PER CARITÀ!
 Per ben agire e ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!!
Per ben agire e ben comunicare (anche solo con se stessi o con stesse!), come insegna Dante, ci vogliono TRE SOLI (la cosiddetta - impropriamente - teoria dei "due soli")!!!
CONOSCI TE STESSO!!! Dopo millenni di riflessione, la nostra identità ("tautòtes" - greco) ancora nella culla o, meglio, nella bara ("taùto" - napoletano)
 LA FILOSOFIA E IL NARCISISMO "DIALOGICO". AMORE DELL’ALTRO O AMORE DI SE’? E’ LO STESSO. Una "risposta" di Umberto Galimberti
LA FILOSOFIA E IL NARCISISMO "DIALOGICO". AMORE DELL’ALTRO O AMORE DI SE’? E’ LO STESSO. Una "risposta" di Umberto GalimbertiFederico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). - “Maschio e femmina Dio li creò” (di Enzo Bianchi - FestivalFilosofia).19 settembre 2017, di Federico La Sala
"DEUS CHARITAS EST" (1 Gv.): LO SPIRITO CHRISTICO, LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO... *
“Maschio e femmina Dio li creò”
di Enzo Bianchi *
- dalla lectio al FestivalFilosofia di Modena
Nel libro della Genesi, il primo libro della bibbia, il libro dell’in-principio (be-re’shit: Gen 1,1) troviamo due racconti della creazione, composti da autori e redattori umani, dunque segnati da una precisa cultura, in un tempo definito della nostra storia. Appartengono a un genere letterario che qualifichiamo come mitico: il mito è un racconto situato culturalmente, dotato di una visione specifica, ma che vuole significare ciò che è universale, costitutivamente antropologico; ovvero, nel nostro caso, cosa ne è dell’’adam, dell’essere umano, il “terrestre”. Sono redazioni diverse e non contemporanee della creazione, ma sono stati posti intenzionalmente l’uno dopo l’altro dai redattori finali della Torah: non giustapposti, ma collocati in successione, in modo che apparisse la dinamica dell’umanizzazione.
Nel primo racconto (Gen 1,1-2,4a), un vero e proprio inno, una narrazione ritmata e ripetitiva, è contenuta la creazione dell’’adam, dell’umano, descritta con un testo che nella sua armonia poetica scandisce il cuore del messaggio biblico su Dio e l’umanità nei suoi rapporti con Dio e con gli animali. Ascoltiamola in una versione calco dell’ebraico: “Ed ’Elohimdisse: Facciamo ’adam in nostra immagine, come nostra somiglianza: dominino i pesci del mare, i volatili dei cieli, il bestiame, tutta la terra e ogni strisciante sulla terra. Ed ’Elohim creò ha-’adam in sua immagine, in immagine di ’Elohim lo creò, maschio e femmina li creò” (Gen 1,26-27).
Chi è l’umano creato “in immagine di Dio”, chi è rispetto a Dio e rispetto agli animali? E cosa comporta quel singolare “lo creò”, ripetuto nel duale “maschio e femmina li creò”? Gli esseri umani, l’umanità immagine di Dio è in relazione con Dio stesso e con le altre creature. L’essere umano è in sé relazione, e ciò che lo attesta in modo paradigmatico è la differenza sessuale, perché l’umano esiste in quanto maschio e femmina, con tutte le possibili varianti e intersecazioni di questa polarità. Gli umani sono immagine di Dio, ciascuno di loro nell’umanità di cui fa parte, in sé sono uniti e si completano accettando la differenza reciproca. In questo testo vi è un’immensa valorizzazione del rapporto uomo-donna, valorizzazione della completezza: non c’è una svalutazione della sessualità né una visione cinica o angosciata della differenza sessuale! La sessualità è positiva e Dio vuole che l’uomo e la donna insieme portino a compimento l’opera di umanizzazione: creati a immagine di Dio, devono diventargli conformi, somiglianti.
Ciò deve avvenire nel vivere: nella vita e solo nella vita! Vivere significa venire al mondo, abitarlo, stare tra co-creature di cui gli umani devono assumersi una responsabilità. Gli umani hanno un corpo come gli animali, sono animali, ma sono anche diversi da loro, innanzitutto nella responsabilità. L’umano è e deve farsi responsabile della terra e dell’ambiente, non è la terra che deve essere responsabile dell’umanità.
Nel secondo racconto (Gen 2,4b-25), più antico di secoli, o forse addirittura di più di un millennio confluiscono elementi mitologici di diverse culture e intende collocare l’umano nel mondo e metterlo in relazione, riaffermare attraverso un altro percorso che l’umano è relazione, è alterità. Ora, la differenza sessuale è parabola di ogni alterità, in nome della quale l’altro, “gli altri - come diceva Jean-Paul Sartre - sono l’inferno”, o meglio, possono esserlo. L’umano è veramente tale quando vive la relazione, ma ogni relazione di differenza comporta tensione e conflitto. Il rapporto uomo-donna è l’epifania della differenza e della reciproca alterità. Solo nella relazione l’umano trova vita e felicità, ma la relazione va imparata, ordinata, esercitata, perché in essa occorre dominare l’animalità presente in ciascuno, che nel rapporto si manifesta come violenza.
Ecco dunque l’umano, un essere in relazione con la terra da cui è tratto, con gli animali in quanto animale, con l’altro da sé che ha il suo stesso soffio di vita ricevuto da Dio e infine con Dio stesso . È in questo fascio di relazioni che l’umano, uomo e donna, si umanizza. E quando il terrestre, uscito dal torpore in cui Dio lo aveva posto, vede l’altro lato, il partner, allora parla con stupore. Ecco l’accesso alla parola, possibile quando c’è di fronte l’altro: finalmente un partner degno, che accende la parola, che abilita all’io-tu, al dialogo, alla relazione! Finalmente - dice l’uomo - un essere che è “osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. La si chiamerà ’isshah perché da ’ish è stata tratta” (Gen 2,23). La relazione ormai è inaugurata: ecco l’uomo e la donna.
Ma se oggi riusciamo a fare questa lettura delle prime due pagine della Bibbia, occorre però ricordare che l’interpretazione non è sempre stata questa. Né si dimentichi che già nell’ultima parte del secondo racconto vi sono in luce tutti i segni del dramma che attraversa la storia fino a noi, fino al femminicidio che purtroppo tante volte appare ancora nei nostri giorni. In verità l’umano, ha-’adam, già qui si rivela in tutta la sua problematicità. Infatti, non appena l’uomo vede la donna, non parla alla donna, non imbocca la strada dell’io-tu, ma parla a se stesso: “Questa sì che osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne”. In tal modo esprime una verità, e cioè che la donna ha la stessa natura e perciò la stessa dignità e vocazione dell’uomo, ma la dice male, esprimendo subito la sua possessività: osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. Parla a se stesso e parla del suo possesso. La donna tace, è ridotta al silenzio e per l’uomo appare una cosa. Egli dice: “È stata tratta da me, è mia carne”, e così nega ogni alterità, quell’alterità che richiede che la donna sia un soggetto di fronte a lui. Subito la volontà e il progetto di Dio sono traditi, e il dramma che seguirà immediatamente è già abbozzato qui, nell’emergere della differenza negata!
Scriveva Thomas Stearns Eliot in uno dei suoi Quattro quartetti : “Nel mio principio è la mia fine ... Nella mia fine è il mio principio” (East Coker, inizio e fine del testo). In queste prime pagine dell’in-principio c’è già tutta la storia dell’umanità, c’è già il misconoscimento dell’altro partner, c’è già la pretesa che l’altro sia un possesso omologo, che l’altro non sia altro, differente, diverso! Culture patriarcali e rare culture matriarcali manifestano la lotta tra i sessi, manifestano la ferita che ognuno di noi sente di fronte alla differenza: ne è attratto ma ne ha paura, vuole relazione ma ne vuole il possesso, vuole comunione ma anche guerra.
Queste pagine tentano allora di dirci come le singolarità di ciascuno di noi, dovute a molte differenze, a partire da quella sessuale, devono coniugarsi affinché vi siano vita e felicità, seppur segnate dal limite. La differenza sessuale maschio-femmina è paradigma di ogni differenza, ma tutte le differenze sono legate a quel tragitto che ognuno umano compie, tra la nascita e la morte, quando ognuno di noi ritornerà alla terra da cui è stato tratto (cf. Gen 3,19), dunque ritornerà a colui che l’ha creato. Allora ciascuno darà una risposta personalissima alla domanda sul cammino di umanizzazione rivoltagli da Dio. Mi riferisco alla prima domanda di Dio, narrata subito dopo nella Genesi, domanda rinnovata in ogni giorno della nostra vita: “’Adam, dove sei?” (Gen 3,9). Nella nostra fine è la risposta alla domanda dell’in-principio, alla responsabilità dell’umanizzazione. (fonte: Monastero di Bose)
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Chiesa. Il comandamento dell’amore e la norma personalistica .... Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!
FEDE E CARITÀ ("CHARITAS"): CREDERE "ALL’AMORE" ("CHARITATI"). Enzo Bianchi si domanda "come si può credere in Dio se non si crede nell’altro?", ma non si rende conto che è il quadro teologico costantiniano e mammonico che va abbandonato!
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"!
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO -- FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. PER UNA NUOVA ERMENEUTICA E UN NUOVO PRINCIPIO DI CARITA’.6 settembre 2017, di Federico La Sala
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. AMORE, RESPONSABILITÀ, E SESSUALITÀ... *
IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").
- Considerazioni a margine dell’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò (elevata a Basilica minore nel 1980, da papa Giovanni Paolo II, durante l’episcopato di Antonio Rosario Mennonna)
- "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS"), DALLA GRAZIA ("gr.: "XAPIS", lat.: "CHARIS") DI DIO AMORE ("CHARITAS"), NON DI DIO MAMMONA ("CARITAS") ...
Lode a Marcello Gaballo per questa bellissima e preziosa nota su "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/#_ftn1) - e il lavoro di De Giorgi: la sua trascrizione della scritta sul cartiglio (ormai scomparsa) "iuste/et cas/te viv/ere et/ xarita(te)" - contrariamente alla protervia che ha portato allo "sproposito maiuscolo" e alla brutta abitudine instauratasi almeno a partire da Ludovico A, Muratori di una "caritas" latina! - conserva ancora la memoria del legame della tradizione dell’evangelo (non: "vangelo"!) con la lingua greca ("charis", "charites"... "charitas").
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. Giambattista Vico ("De constantia iurisprudentis", 1721) giustamente e correttamente e onestamente così pensava e scriveva: "Solo la carità cristiana insegna la prassi del Bene metafisico"("Boni metaphysici praxim una charitas christiana docet"). Sapeva che Gesù ("Christo") aveva cacciato i mercanti FUORI dal tempio, e non aveva autorizzato i sacerdoti a vendere a "caro-prezzo" (lat.: "caritas") la "grazia" (gr.: "Xapis", lat.: "Charis") di Dio (lat.: "Charitas")!!! Due padroni: Dio "Charitas" o dio "Caritas"?!, Dio Amore o dio Mammona?! In questo bivio ("X") ancora siamo, oggi - e ancora non sappiamo sciogliere l’incognita (""x")!
Sul tema, mi sia consentito, si cfr. la seguente nota:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori.
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori.
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!- SANT’AGOSTINO E L’ECUMENISMO UMANISTICO-RINASCIMENTALE ...
ALLA LUCE DEL lavoro di ARMANDO POLITO e MARCELLO GABALLO SU "SANTA MARIA DI CASOLE E LE SUE SIBILLE" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/24/santa-maria-casole-copertino-le-sue-sibille/), all’affresco di Sant’Agostino (databile forse più precisamente nella seconda metà del sec. XV), mi augurerei una rinnovata e maggiore attenzione non solo a tutta la figura dell’affresco ma, in particolare, all’immagine del bastone-pastorale con i suoi DUE SERPENTI. Essa richiama, con chiarezza, non solo la figura di Mosè ma anche e soprattutto la figura di ERMETE TRISMEGISTO con il suo caducèo (e, con essa, della Sibilla Pizia, di Apollo, e di Delfi).
L’affresco di Sant’Agostino nella cattedrale di Nardò, a mio parere, è un luminosissimo segno "manifesto" della diffusione della concezione umanistico-rinascimentale nella Terra d’Otranto e, insieme, del grande lavoro che porterà infine la Chiesa e Michelangelo a celebrare le Sibille (5) insieme ai Profeti (7) nella Volta della Cappella Sistina: ovvero, dice chiaramente del ruolo "giocato" dalla figura di Agostino nella costruzione dell’ orizzonte ecumenico umanistico e rinascimentale.
Sul tema, si cfr., unitamente al già citato lavoro di A. Polito e M. Gaballo, la mia nota sul
 RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.- AGOSTINO, LE SIBILLE, LA LETTERA DELL’ALFABETO GRECO "X", E IL "PESCE"!
NEL LIBRO DI Marcello Gaballo e Armando Polito, "Santa Maria di Casole a Copertino (Lecce) ed altri repertori di Sibille" (Fondazione Terra d’Otranto 2017), è ripreso l’intero capitolo 23 del Libro XVIII del "De civitate Dei" (per eventuali approfondimenti, si cfr. sant’Agostino, "La città di Dio": http://www.augustinus.it/italiano/cdd/index2.htm)
- ... IL PASTORALE DI SANT’AGOSTINO CON *UN SOLO SERPENTE* E IL PASTORALE DI BARTOLOMEO I CON *DUE SERPENTI*
PER MEGLIO CAPIRE il filo che lega l’ecumenismo umanistico-rinascimentale (Niccolò Cusano, "La pace della fede", 1453) con l’ecumenismo del presente attuale (nuovo Concilio di Nicea, 2025) e, insieme, la portata simbolica del particolare PASTORALE di sant’Agostino nell’affresco della Cattedrale di Nardò, mi sia consentito rinviare all’immagine del pastorale del Patriarca di Costantinopoli e all’intervista relativa all’ INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5791).
Federico La Sala
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto...
MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. PER UNA NUOVA ERMENEUTICA E UN NUOVO PRINCIPIO DI CARITÀ ... *
Chi ha paura di Jorge Mario Bergoglio
di Riccardo Cristiano (Articolo 21, 1 settembre 2017)
Le anticipazioni di un libro intervista che contiene la trascrizione di dodici dialoghi con il sociologo Dominique Wolton (titolo: “Politique et sociétéˮ, edizioni L’Observatoire) riferiscono che Papa Francesco ha detto di essere andato per alcuni mesi da una psicanalista. In queste ore non sono pochi i giornali che riferiscono le condanne preconciliari della psicanalisi. Forse è il bisogno di trovare qualcosa di “inaudito” in quanto ha detto Bergoglio. Eppure a partire da Pio XII, passando attraverso gli apprezzamenti positivi del Vaticano II nei confronti della psicologia del profondo, si è giunti al riconoscimento di Paolo VI - nella Sacerdotalis coelibatus (1967) - della possibile necessità di un aiuto psicanalitico per i sacerdoti in difficoltà. Questa evoluzione è stata facilitata da una schiera di psicoanalisti dichiaratamente cattolici.
 C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”
C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”Passa in ombra così l’usuale coraggio di Jorge Mario Bergoglio, che anche in questa “confessione” di essere andato per sei mesi da una psicanalista ebrea, che lo ha molto aiutato, sembra stare in questo: anch’io sono un uomo, e tutti gli uomini hanno bisogno di aiuto. Lo dice lui, noi lo diciamo molto più difficilmente. -L’epoca buia dello scontro tra religione e psicanalisi è andata in soffitta da tempo. Ma siccome siamo in un’epoca che si fa nuovamente buia, intrisa di odio per l’altro, di pregiudizio, fondamentalmente di paura, sono moltissime le affermazioni fatte da Papa Francesco che colpiscono. E che per leggere bene dovremmo avere il suo stesso coraggio, cioè quello di toglierci il paraocchi e leggere per quel che sono. Un invito ad andare oltre gli steccati di oggi, oltre quei confini che ci chiudono in ghetti tanti asfittici quanto rassicuranti.
Leggiamo alcuni altri passaggi fondamentali delle sue riflessioni, partendo dall’ Africa e i migranti.
 “[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”
“[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”Per un uomo come Papa Francesco generalizzare è sempre difficile, ma se proprio deve farlo non generalizza sulle “razze”, ma sulle azioni degli Stati e le loro conseguenze. Per condannare? No, per esortare a invertire tendenza, a non cercare scorciatoie, a non vedere nelle vittime degli esseri inferiori, ma delle vittime.
Passiamo a Laicità e religioni. “Lo stato laico è una cosa sana. C’è una laicità sana. [...] Credo che la Francia - questo è il mio parere personale, non quello ufficiale della Chiesa - dovrebbe “elevareˮ un po’ il livello della laicità, nel senso che deve dire che anche le religioni sono parte della cultura. Come esprimerlo in modo laico? Attraverso l’apertura alla trascendenza. Ognuno può trovare la sua forma di apertura.” Come si vede, come si legge, qui non c’è una pretesa di superiorità del credente, ma la rivendicazione della spiritualità dell’uomo, del suo bisogno “naturale” di trascendenza.
Quarto punto, l’Europa. “Non vedo più Schumann, non vedo più Adenauer... L’Europa, in questo momento, ha paura. Chiude, chiude, chiude... L’Europa ha una storia di integrazione culturale, multiculturale come dice lei, molto forte. I Longobardi, i nostri Longobardi oggi, sono barbari che sono arrivati molto tempo fa... E poi tutto si fonde e abbiamo la nostra cultura. Ma qual è la cultura europea? Come definirei oggi la cultura europea? Sì, ha importanti radici cristiane, è vero. Ma non è sufficiente per definirla. Ci sono tutte le nostre capacità. Queste capacità per integrarsi, per ricevere gli altri. C’è anche la lingua nella cultura. Nella nostra lingua spagnola, il 40% delle parole è arabo. Perché? Perché erano lì per sette secoli. E hanno lasciato il segno... Credo che l’Europa abbia delle radici cristiane, ma non sono le uniche. Ci sono altre che non possono essere negati. Tuttavia, credo che sia stato un errore non citare le “radici cristianeˮ nel documento dell’Unione europea sulla prima Costituzione, e questo è stato anche commesso dai governi. Era un errore non vedere la realtà. Questo non significa che l’Europa debba essere interamente cristiana. Ma è un patrimonio, un patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto.”
C’è qualcosa di enorme in queste parole, in questa capacità di ricordarci che quel che è stato vero ieri è vero anche oggi. Non esiste purezza, esiste contaminazione. La purezza è delle pietre, la contaminazione è della vita. Anche se non vogliamo più capirlo qualcuno, per fortuna, ce lo ripete.
L’insistenza sulla morale «sotto la cintura». “Ma noi cattolici, come insegniamo la moralità? Non puoi insegnarla con precetti del tipo: “Non puoi farlo, devi farlo, devi, non devi, puoi, non puoiˮ. La morale è una conseguenza dell’incontro con Gesù Cristo. È una conseguenza della fede, per noi cattolici. E per altri, la moralità è una conseguenza dell’incontro con un ideale, o con Dio, o con se stessi, ma con la parte migliore di se stessi. La morale è sempre una conseguenza... C’è un grande pericolo per i predicatori, quello di cadere nella mediocrità. Condannare solo la morale - la prego di perdonare l’espressione - “sotto la cinturaˮ. Ma degli altri peccati, quali l’odio, l’invidia, l’orgoglio, la vanità, l’uccisione dell’altro, prendere la vita, non se ne parla. Entrare nella mafia, fare accordi clandestini...”
Il Vaticano, se posso dir così, è apparso a lungo strabico: l’etica vista dalla Città del Vaticano sembrava riguardare l’inizio e la fine della vita, la morale limitata alla sfera sessuale... Ora l’etica torna a riguardare tutta la vita, dal momento in cui si concepisce a quando si muore, passando però per tutti i momenti della nostra esistenza: da quando sfruttiamo a quando veniamo sfruttati, da quando siamo vittime a quando facciamo nostra vittima un altro. Poco?
Amoris laetitia e rigidità. “La tentazione è sempre quella dell’uniformità delle regole... Prenda ad esempio l’esortazione apostolica Amoris laetitia. Quando parlo di famiglie in difficoltà, dico: “Dobbiamo accogliere, accompagnare, discernere, integrare...ˮ e poi ciascuno vedrà le porte aperte. Quello che sta realmente accadendo è che le persone sentono dire la gente: “Non possono fare la comunione”, “Non possono farlo”: la tentazione della Chiesa è lì. Ma “noˮ, “noˮ e “noˮ!”
Papa Francesco parla di uniformità delle regole, si potrebbe dire che allora la sua Chiesa non si pensa un giudice eterno ed esterno alla storia. Poco?
«L’aborto rimane un peccato grave». “ L’estensione del potere di assolvere il peccato dell’aborto a tutti i sacerdoti, «attenzione, questo non significa banalizzare l’aborto. L’aborto è grave, è un peccato grave. È l’omicidio di un innocente. Ma se c’è peccato, è necessario facilitare il perdono.” Un papa non poteva fare un esempio più rilevante e drammatico per indicare la portata rivoluzionaria della misericordia. Che non è “cancellare il peccato”, ma rigenerare la vita del peccatore. La misericordia così appare la vera cultura alternativa all’odio e, quindi, al terrorismo.
Reciprocità con i musulmani. “Non accettano il principio della reciprocità. Alcuni paesi del Golfo sono aperti e ci aiutano a costruire chiese. Perché sono aperti? Perché hanno lavoratori filippini, cattolici, indiani... Il problema in Arabia Saudita è che è davvero una questione di mentalità. Con l’Islam, comunque, il dialogo sta andando bene, perché non so se lo sa, ma l’Imam di Al-Azhar è venuto a trovarmi. E ci sarà incontro: vado. Penso che farebbe bene a loro fare uno studio critico sul Corano, come abbiamo fatto con le nostre Scritture. Il metodo storico e critico di interpretazione li farà evolvere.”
E’ questo il punto per me più importante, più forte. Senza nessuna pretesa di superiorità, né religiosa né culturale, Bergoglio indica la strada della salvezza dell’islam, in una parola: ermeneutica. Non esita a far presente ai suoi interlocutori il punto decisivo, il punto “critico”, ma lo fa per il bene dell’islam, dei musulmani. E questo, francamente, è commovente.
*
SUL TEMA, BEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006). Materiali per riflettere
EUROPA ED EVANGELO. LA ’CROCE’ DI CRISTO ("X" = lettera alfabeto greco) NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL "CROCIFISSO" DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA.
Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto.
 INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.
INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.- Per una nuova antropologia e una nuova pedagogia - quella dell’Amore (Deus charitas est), non quella di "Mammasantissima" e di "Mammona" ("Deus caritas est") della Chiesa Cattolico-romana!!!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- IL FASCISMO non è mai morto. Il presente che nutre il fascismo.12 luglio 2017, di Federico La Sala
INDIVIDUO E SOCIETÀ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITÀ, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" .....
Il presente che nutre il fascismo
di Nadia Urbinati (la Repubblica, 12.07.2017)
IL FASCISMO non è mai morto. Rappresenta il bisogno di certezza comunitaria e gerarchica in una società individualistica. E nonostante i simboli sbandierati, non è un ritorno al passato. L’ombra del fascismo si stende sulla democrazia, anche quando, come la nostra, è nata nella lotta antifascista. La ragione della sua persistenza non può essere spiegata, semplicisticamente, con il fatto che non ci sia sufficiente radicamento della cultura dei diritti. Si potrebbe anzi sostenere il contrario. Ovvero, che sia proprio la vittoria della cultura dei diritti liberali (e senza una base sociale che renda la solitudine dell’individuo sopportabile) ad alimentare il bisogno di identità comunitaria. Un bisogno che il fascismo in parte rappresenta, tenendo conto che non è solo violenza e intolleranza per i diversi (anche se questi sono gli aspetti più visibili e preoccupanti).
Il fascismo rinasce un po’ dovunque nell’occidente democratico e capitalistico - le fiammate xenofobiche e nazionalistiche che gli opinionisti si ostinano a chiamare blandamente “populismo” sono il segno di una risposta, sbagliata, alla recrudescenza di un sistema sociale che funziona bene fino a quando e se esistono reti associative, capaci di attutire i colpi di un individualismo che è apprezzato solo da chi non ha soltanto le proprie braccia come mezzo di sussistenza. Senza diritti sociali i diritti individuali possono fare il gioco contrario.
La democrazia nata nel dopoguerra su una speranza di inclusione dei lavoratori si è arenata di fronte al totem di un ordine economico che non ne vuol più sapere di riconoscere limiti solidaristici alla propria vocazione accumulatrice. È nata sulle macerie di una guerra mondiale, ma non probabilmente sulle macerie dell’etica comunitaria che aveva cementato la società nazionale nel ventennio.
Nei paesi di cultura cattolica, dove il liberalismo dei diritti si è fatto strada con grande difficoltà, la dimensione corporativa è ben più di un residuo fascista. È il cardine di una struttura sociale retta su luoghi comunitari, come la famiglia o la nazione. Questi luoghi sono diventati gusci vuoti con la penetrazione dei diritti individuali. I quali sono certo un progresso morale, ma non sufficienti, da soli, a garantire una vita esistenziale appagata.
I diritti sono costosi, non solo per lo Stato che deve farli rispettare, ma anche per le persone che li godono. Un diritto è un abito di solitudine - definisce la relazione di libertà della persona in un rapporto di opposizione con gli altri e la società. Senza relazioni sociali strutturate - senza quei corpi intermedi associativi, dalla famiglia al mutualismo locale - essi sono sinonimo di una libertà troppo faticosa. Ecco perché i nostri padri fondatori più lungiumiranti, i liberalsocialisti, erano attenti a mai dissociare la libertà dalla giustizia sociale, dalla dimensione etica che riannoda i fili spezzati dai diritti individuali.
Non si vuole con questo giustificare la rinascita del fascismo e dell’esaltazione dei simboli del passato. Quel che si vuol dire, invece e al contrario, è che quel che sembra un ritorno nostalgico al passato è un fenomeno nuovo e tutto presente, dettato da problemi che la società democratica incontra nel presente. Sono tre i luoghi dove questi problemi si toccano con mano e che sarebbe miope non vedere.
 Il primo corrisponde al declino di legittimità della politica, che ha smarrito il senso etico e di servizio per diventare, a destra come a sinistra, un gioco di personalismi, con i partiti che fanno cartello per blindare leadership e lanciare candidati, cercando consenso retorico ma senza voler includere i cittadini nella vita politica - la rappresentanza assomiglia sempre di più a un notabilato.
Il primo corrisponde al declino di legittimità della politica, che ha smarrito il senso etico e di servizio per diventare, a destra come a sinistra, un gioco di personalismi, con i partiti che fanno cartello per blindare leadership e lanciare candidati, cercando consenso retorico ma senza voler includere i cittadini nella vita politica - la rappresentanza assomiglia sempre di più a un notabilato.
 Il secondo luogo corrisponde al declino delle associazioni di sostegno che hanno accompagnato la modernità capitalistica opponendo alla mercificazione del lavoro salariato e alla disoccupazione (che è povertà) reti di solidarietà e di sostengo, ma anche alleanze di lotta, di contrattazione, e di progetto per una società più giusta.
Il secondo luogo corrisponde al declino delle associazioni di sostegno che hanno accompagnato la modernità capitalistica opponendo alla mercificazione del lavoro salariato e alla disoccupazione (che è povertà) reti di solidarietà e di sostengo, ma anche alleanze di lotta, di contrattazione, e di progetto per una società più giusta.
 Il terzo luogo è il mondo largo e complesso abitato dalla solitudine esistenziale connessa alla scomposizione della vita comunitaria.
Il terzo luogo è il mondo largo e complesso abitato dalla solitudine esistenziale connessa alla scomposizione della vita comunitaria.In altre parole, il pericolo numero uno della società orizzontale è rappresentato dall’atomizzazione individualistica, dalla solitudine delle persone, dall’isolamento perfino cercato di soggetti che ritengono di poter dare, per citare Ulrick Beck, «soluzioni biografiche a contraddizioni sistemiche». Con la conseguenza, questa palpabile a seguire i social e a sentire molti nostri politici, di veder cadere ogni rapporto con la storia, con la memoria, con l’eredità proveniente dalle generazioni che ci hanno preceduto, come se il futuro potesse avere gambe sue proprie. Il rischio, è stato detto molto spesso, è quello di vivere in un eterno presente, che può anche significare riciclare simboli del passato fuori del loro contesto di significato.
Ora, se le cose stanno così, se la nostra società ha questa forma orizzontale innervata nei diritti, pensare di rimediare ritornando ai modelli gerachici fascisti e al vecchio ordine di sicurezza del comando patriarcale non solo si rivela anacronistico, ma in aggiunta oscura tutti questi nuovi rischi; non ci fa vedere quel che dovremmo riuscire a vedere bene per comprenderlo e correggerlo: l’erosione dell’eguaglianza economica, dell’integrazione sociale e del potere politico dei cittadini democratici.
*
RIPENSARE L’UNO E I MOLTI ("UNO"), L’IDENTITA’ E LA DIFFERENZA!!! CONTIAMO ANCORA COME SE FOSSIMO NELLA CAVERNA DI PLATONE. NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN ....
UNITÀ D’ITALIA E FOLLIA: EMERGENZA LOGICO-POLITICA EPOCALE.
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- SARTRE: L’ESSERE, IL NULLA, E LA CARNE DEL DESIDERIO.22 giugno 2017, di Federico La Sala
"GRATIA PLENA": LA CARNE DEL DESIDERIO - SARTRE, E IL TEMA CRISTIANO (NON CATTOLICO-ROMANO) DELLA CARNE. Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
La carne del desiderio
di Paolo Godani (Le parole e le cose, 22 giugno 2017)
La filosofia francese del Novecento ha ripreso in vario modo il tema cristiano della carne. Talvolta, come in Michel Henry, ci si è limitati a rivendicare la carnalità come arma da opporre ad una presunta smaterializzazione del corpo avvenuta in età moderna e post-moderna. In altri casi, per esempio quando Merleau-Ponty, nel Visibile e l’invisibile, fa della nozione di chair un concetto fondamentale della sua ultima fenomenologia, della carne è rimasta poco più che la metafora: la “carne delle cose” è solo un sinonimo di “essere grezzo”, di un essere che si dà solo in una pienezza opaca, prima della separazione di un soggetto che percepisce e di un oggetto percepito, in un’esperienza al contempo originaria e impura. Oppure, ancora, si denuncia, come accade a Deleuze, il “carnismo” cristiano a cui sembra approdata certa estetica fenomenologica francese, opponendo provocatoriamente, a una chair pia e devota, l’immagine pietosa della carne macellata (viande, meat) che popola le opere di Francis Bacon.
 In mancanza delle Confessioni della carne, ultimo volume programmato della Storia della sessualità che Foucault non è riuscito a portare a compimento, si può dire che l’unico autore del XX secolo capace di fare un utilizzo al contempo letterale e nuovo della nozione di carne sia stato probabilmente Jean-Paul Sartre, quando nell’Essere e il nulla descrive l’incarnazione di sé e dell’altro che si realizza grazie al desiderio sessuale.
In mancanza delle Confessioni della carne, ultimo volume programmato della Storia della sessualità che Foucault non è riuscito a portare a compimento, si può dire che l’unico autore del XX secolo capace di fare un utilizzo al contempo letterale e nuovo della nozione di carne sia stato probabilmente Jean-Paul Sartre, quando nell’Essere e il nulla descrive l’incarnazione di sé e dell’altro che si realizza grazie al desiderio sessuale.
 In pagine profondamente ispirate, Sartre spiega che nel momento in cui desideriamo un corpo si produce una trasformazione radicale nei modi in cui normalmente ci rapportiamo all’altro: non vogliamo fare uso del corpo altrui per giungere al nostro godimento, né limitarci a possederlo, riducendolo semplicemente a un oggetto in sé, ma entriamo nel campo di una relazione assoluta, nella quale il nostro corpo e il corpo dell’altro si mutano simultaneamente in corpi di carne.
In pagine profondamente ispirate, Sartre spiega che nel momento in cui desideriamo un corpo si produce una trasformazione radicale nei modi in cui normalmente ci rapportiamo all’altro: non vogliamo fare uso del corpo altrui per giungere al nostro godimento, né limitarci a possederlo, riducendolo semplicemente a un oggetto in sé, ma entriamo nel campo di una relazione assoluta, nella quale il nostro corpo e il corpo dell’altro si mutano simultaneamente in corpi di carne.L’estasi del puro desiderio sessuale, che sarà presto sopraffatta dal bisogno di entrare nel corpo altrui facendo uso di forze e movimenti che riportano inesorabilmente la relazione nel contesto di un rapporto tra mezzi e fini, sospende per un tempo indeterminato l’esercizio volontario delle facoltà e consente così l’accesso a una sorta di sentire puro. Le nostre capacità senso-motorie naturalmente restano intatte, ma la loro funzionalità è ridotta all’unico fine del sentire. Perché ciò accada è però necessario che il corpo dell’altro si sia a sua volta immerso in quello stato nascente, simile al sonno, nel quale tutto viene sentito, mentre nulla sta accadendo. Perché io riduca il mio corpo al suo sentire, è necessario che la relazione assoluta abbia portato anche l’altro a uscire da sé, per fare del suo stesso corpo un essere meramente senziente. È questa estasi relazionale che Sartre chiama incarnazione.
Posso guardare, conoscere e amare una donna in molti modi; posso osservarla per qualche sua stranezza più o meno attraente o perché è una vera bellezza, posso ammirarla per il modo di vestire o per un certo modo trattenuto di parlare, per un gesticolare nervoso o per l’intelligenza delle sue considerazioni, posso amare la sua tenerezza o la sua indecisione, i tratti del suo volto o le situazioni nelle quali perde la testa, ma nel momento in cui la sto desiderando la desidero in quanto corpo di carne.
- Il desiderio - scrive Sartre - è un tentativo di svestire il corpo dei suoi movimenti come di vestiti, e di farlo esistere come pura carne; è un tentativo di incarnazione del corpo dell’altro (EN, p. 451).
Una carezza (termine che non deriva da caro, carne, ma da carus, che a sua volta si riferisce alla radice sanscrita ka, da cui kama, amore, e kamana, desiderabile) o uno sguardo che siano già situati in questo campo del desiderio sono uno sguardo o una carezza che si rivolgono alla carne dell’altro, e lo sono in quanto effetti del mio stesso corpo carnale.
Non si tratta solo del corpo nudo, della sua epidermide o della morbida consistenza della pelle: la carne non è un dato, non è già là, sotto i vestiti che sarebbe sufficiente sfilare.
- Carezzando l’altro, io faccio nascere la sua carne con la mia carezza, sotto le mie dita. La carezza fa parte dell’insieme di cerimonie che incarnano l’altro. Ma, si può obiettare, non era forse già incarnato? No. La carne dell’altro non esisteva esplicitamente per me, perché percepivo il corpo dell’altro in situazione; non esisteva per lui perché la trascendeva verso le sue possibilità e verso l’oggetto. La carezza fa nascere l’altro come carne per me e per lui (EN, p. 452).
È possibile non solo guardare o accarezzare, ma anche denudare l’altro e denudarsi, senza che questo abbia nulla a che vedere con il desiderio e senza che dunque produca in alcun modo un essere di carne. Ma quando una carezza inaugura l’accesso al mondo parallelo del desiderio, quando si sfiora con uno lo sguardo il volto o con una mano il fianco della donna desiderata o si lascia che le labbra facciano sentire la propria fantasmatica presenza prima di scivolare per un momento, quasi impercettibili, sulla superficie del collo, allora l’atmosfera che circonda i corpi muta improvvisamente, rendendo perfettamente irreali tutti i movimenti di cui pure ancora siamo gli attori.
Ogni gesto è come circonfuso del suo stato potenziale, sta avvenendo come pura possibilità; ogni mio atto, pur essendo io a compierlo, è come se si svolgesse fuori dal mio dominio, in quella zona senza giurisdizione che è costituita solo in virtù della vicinanza e dell’attrazione di due corpi. Fuori da quell’attrazione, i gesti riprendono il loro senso ordinario e tornano a essere segni, i movimenti rientrano nel campo d’azione del mio corpo, l’altro torna a essere l’in sé che è sempre stato, un po’ familiare un po’ estraneo, ma comunque ormai privo dell’atmosfera a cui soltanto la relazione di desiderio può dar luogo.
È per questo che i gesti del desiderio sessuale non possono essere volontari, perché non sono i miei gesti o quelli dell’altro a poter far nascere la relazione, ma questa si istituisce precisamente quando sono proprio e solo i gesti stessi ad appropriarsi di me e dell’altro. L’incontro di un desiderare e di un essere desiderati è il modo in cui si analizza, a posteriori, una relazione nella quale non ci sono propriamente né io né l’altro. Non sono io che desidero, né è l’altro a desiderarmi. Siamo su un terreno nel quale la correlazione neutralizza l’intenzionalità. Il carattere involontario dell’erezione e delle secrezioni non sono che le modalità fisiologiche nelle quali si traduce questo esser parte di una situazione che ci reclama e a cui per un lungo momento veniamo interamente affidati.
Il luogo che viene a costituirsi tra i corpi desideranti, un luogo che in realtà appare come un “frammezzo” solo a una osservazione esteriore, non è che il divenire carne di quei corpi. Solo nei momenti in cui si desidera si è effettivamente corpi di carne, perché la carne è l’unica sostanza attraverso cui due corpi istituiscono una relazione che non sia di mera esteriorità. Al limite, si dirà che la carne che nasce nella relazione di desiderio non è mai semplicemente la carne di questo mio corpo in contatto con la carne dell’altro, ma che il contatto desiderante dei corpi produce una zona di indeterminazione, alla quale soltanto possiamo dare il nome di “carne”.
In verità, Sartre resta ancora per molti versi impigliato in una concezione tradizionale, specialmente quando fa della carne la “contingenza pura della presenza” (EN, p. 403) dell’altro, e quando sembra voler opporre alla fatticità del corpo di carne la grazia per la quale il corpo appare come “uno psichico in situazione” (EN, p. 462). Quando Sartre dice che normalmente la fatticità è rivestita e nascosta dalla grazia, e dunque la nudità della carne, per quanto sia sempre presente, è tuttavia costantemente invisibile (cfr. EN, p. 463), sembra tornare a fare della carne una sostanza naturale e pre-esistente, anziché un prodotto effettivo del desiderio; e sembra concepire la carne come il puro esserci di un corpo privato della grazia, anziché come uno stato alterato del corpo stesso, dovuto al suo essere in relazione. La carne non è là per nulla, ma c’è solo in quanto effetto di desiderio. Qui, non si può dire che la carne dell’altro ci sia, nella mera contingenza della sua presenza, come se l’incarnazione dell’altro non implicasse la mia stessa incarnazione; la mia carne e la sua esistono solo nel mezzo dei nostri corpi, anzi quella carne che propriamente non appartiene a nessuno è la sostanza stessa di quell’essere tra i corpi. Lo stesso Sartre, del resto, riconosce che
- non si può percepire il corpo d’altri come carne a titolo di oggetto isolato che ha con gli altri questi dei puri rapporti di esteriorità. Questo sarebbe vero solo per il cadavere. Il corpo d’altri, in quanto carne, mi è immediatamente dato come centro di riferimento di una situazione che si organizza sinteticamente attorno a esso e che è inseparabile da questa situazione” (EN, p. 404).
Questo significa che anche il corpo di carne non è mai semplicemente un corpo ridotto alla pura apparenza naturale o alla sussistenza fisiologica. Essere sempre in situazione significa, per il corpo carnale, essere già sempre quella certa maniera d’essere che in esso si incarna.
Così, da una parte, la stessa carne del desiderio, per quanto possa essere priva degli abiti, dei movimenti e delle espressioni che governano per lo più il corpo funzionale, resta nondimeno vestita, abitata e percorsa da cima a fondo da una potenza espressiva. I tremiti interiori, la lentezza dei gesti, gli spasmi improvvisi che definiscono il campo del desiderio sono le forme proprie della vita della carne, sono le espressioni di una carnalità, non semplicemente “naturale”, che ha luogo solo in quella sospensione dell’ordinario istituita dalla relazione sessuale.
E, d’altra parte, un corpo può farsi corpo di carne pur in un contesto del tutto ordinario o addirittura formale, nel quale il vestiario, le pose, gli atti e le parole continuino a figurare come meri segni sociali. Un modo di guardarsi, di salutarsi o sorridersi mentre, legati nell’eleganza dell’abito, ci si scambiano parole di circostanza può già istituire la tensione di un campo carnale - la cui eterogeneità rispetto al territorio dell’agire intenzionale è testimoniata dalla nostra incapacità di sapere se quelle forze di attrazione che all’occasione di un’espressione stranamente magnetica ci hanno trasportato nelle estreme vicinanze dell’altro sussistano realmente o se non siano solo l’effetto della nostra immaginazione.
In entrambi i casi, la carne del desiderio è sempre gratia plena. La cosmesi o la cosmicità della grazia non le sopravviene, ma costituisce il suo unico modo di apparizione.
È il sadico, invece, che immaginando la grazia come un abito, come un segno estrinseco e supplementare, pretenderebbe di sfilarlo via per fare apparire la carne dell’altro in quanto tale, per ridurre l’altro al suo essere nient’altro che carne.
- L’ideale del sadico sarà di cogliere il momento in cui l’altro sarà già carne senza cessare di essere uno strumento, carne da far carne; quando, per esempio, le cosce si offrono già in una passività oscena e sfiorita e sono ancora degli strumenti che si maneggiano, si aprono, e si curvano, per far risaltare di più le natiche e per incarnarle a loro volta (EN, p. 465).
Così facendo, il sadico in realtà non ottiene nulla dall’altro, e tantomeno accede al suo proprio divenire carne. Trattando “l’altro come uno strumento” (EN, p. 465), sottoponendo il proprio corpo e l’altrui al prelievo forzoso di quella grazia immanente che li fa essere carnali, non entrerà mai nel campo d’apparizione del desiderio. La sua ricerca di una carne senza trucco si rivela impossibile, in fondo, anche solo per il fatto stesso di essere una ricerca volontaria. Volere la carne dell’altro è il modo più sicuro di mancarla.
Il fatto è che la passività oscena e sfiorita con cui le cosce possono offrirsi alla visione sadica non può che restare ai margini dell’esperienza propriamente carnale. Non certo perché questa esperienza abbia qualcosa a che vedere con qualche amenità del corpo, ma solo per il fatto che essa, trovando il suo unico compimento nel sentire la comunanza della “propria” attrazione con l’attrazione dell’altro, non ammette la distanza che è invece necessaria a ogni osservazione come a ogni volontà cosciente. La passività oscena e sfiorita è il modo in cui la carne si presenta allo sguardo sadico, dal momento in cui quest’ultimo, nel suo pathos per la distanza, implica una sorta di giudizio estetico capovolto. Quello del sadico, però, resta appunto un giudizio, che come tale impedisce proprio quell’affondare della coscienza del corpo (cfr. EN, p. 459), necessario a ogni esperienza carnale.
In fondo, ciò che il sadico vorrebbe vedere incarnato non è che la malignità del corpo, l’essere ripugnante che, ai suoi occhi, si nasconde dietro le ingannevoli apparenze della grazia. In questo senso, lo sguardo sadico non è che il rovescio di quello cristiano: mentre quest’ultimo intende liberare il corpo di carne da quelli che riconosce come istinti peccaminosi, il primo vuole spogliare il corpo dei suoi belletti, per “dimostrare” la carne stessa in tutta la sua malvagia oscenità.
Non che la vista sia esclusa dal sentire propriamente carnale. Solo che il vedere in stato di desiderio è un vedere esclusivamente aptico. Non diversamente dalla mano, che non è mobilizzata per afferrare, anche l’occhio, divenuto carne, non fa che sorvolare a una distanza infinitesima il corpo dell’altro. Solo questo sguardo di carne, che scivola sul corpo come una carezza, è in grado di mantenersi nel campo del desiderio. La carnalità del piacere prende la sua consistenza propria solo dal momento in cui la tensione di uno sguardo aptico vibra del tremore della carne dell’altro. A distanza di giudizio, invece, la carne dell’altro non può essere sentita. Lo sguardo panoramico del voyerista e quello altrettanto globale anche se ravvicinato del sadico posso certo produrre eccitazione e godimento, ma nessun essere di carne.
Il mero godimento, così come si presenta in maniera esemplare nell’esperienza sadica, si distingue dal piacere carnale non per il suo essere immediatamente pulsionale, bensì, proprio al contrario, per la distanza strumentale che in esso si conserva. Un godimento che non è dell’ordine della pulsione acefala, ma è semmai il correlato di un comando volontario. Mentre il piacere che si accompagna al desiderio implica l’accesso a una relazione capace di sospendere l’intenzionalità personale, e solo in questo senso è propriamente carnale, il godimento è sempre e solo il godimento di un Io. Non solo di un Io che tiene a distanza l’altro, riducendolo a un fantasma di cui potersi cibare, ma di un Io che pretende di governare il proprio stesso modo di rapportarsi all’altro.
Anche lo sguardo fisso e ossessivo che gli amanti si rivolgono talvolta nei momenti che precedono il piacere è uno sguardo di carne, benché in un senso peculiare. Con gli occhi negli occhi, cercano di trattenersi entro il campo del desiderio, mettendo tra parentesi il senso meccanico dei movimenti con i quali sono tornati a utilizzare il corpo come uno strumento; cercano di portare dentro il campo d’attrazione della carne anche ciò che, per sua stessa natura, sembra sfuggirgli.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- DON MILANI, LA SCUOLA DI BARBIANA, E PAPA FRANCESCO. A BARBIANA.20 giugno 2017, di Federico La Sala
MESSAGGIO EVANGELICO E COSTITUZIONE. L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!:
- OBIEZIONE DI COSCIENZA !!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
- Don Lorenzo Milani, la Scuola di Barbiana, e la "Lettera a una professoressa". Un "ricordo" di Francesco Erbani
Papa Francesco: «Pregate perché io prenda esempio da don Milani»
Nelle parole del Papa l’abbraccio della Chiesa che don Lorenzo Milani ha desiderato fino alla morte, il riconoscimento del suo essere sacerdote, non solo maestro non solo pacifista. Un fatto storico, ecco perché
di Elisa Chiari *
«Pregate per me perché anche io sappia prendere esempio da questo bravo prete». Quel bravo prete è don Lorenzo Milani e più chiaro e diretto di così Papa Francesco non avrebbe potuto essere. Non c’era questa frase nel discorso preparato, non c’era la frase finale rivolta ai sacerdoti: "Prendete la fiaccola e portatela avanti». Le ha aggiunte a braccio.
Don Milani aveva ragione, quando nel suo tono sempre un po’ provocatorio diceva: «Mi capiranno tra 50 anni». Forse faceva un numero, per dirla con parole sue, «per dar forza al discorso». Ma la contingenza della storia ha voluto che fosse una cifra esatta, che servissero davvero 50 anni - don Milani è morto il 26 giugno del 1967 - perché un papa venisse quassù, a Barbiana - una Barbiana restaurata con la vasca azzurra come allora non era-, al margine del margine del mondo, nella parrocchia che doveva chiudere e che fu tenuta aperta per isolare un sacerdote che allora si diceva "scomodo" e che oggi papa Francesco dice «ha lasciato una traccia luminosa».
Per molto tempo, don Lorenzo Milani è stato raccontato come l’educatore, il maestro, l’obiettore di coscienza - non senza distorsioni e strumentalizzazioni da parti assortite -: quasi che fosse marginale nella sua presenza storica il suo essere prete. Lo si è raccontato lasciando nell’ombra il lato che a don Milani premeva di più, perché fondava il senso della sua esistenza cristiana: il riconoscimento del suo sacerdozio da parte della Chiesa.
Cinquant’anni dopo Papa Francesco sana, dichiarandolo esplicitamente, questa mancanza. Mette il punto più importante alla fine, Papa Francesco, quasi per lasciarne il significato scolpito - come a segnare un passaggio che chi studierà il rapporto tra don Lorenzo Milani e la Chiesa di qui in poi non potrà ignorare -: «Non posso tacere che il gesto che ho oggi compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. In una lettera al Vescovo scrisse: "Se lei non mi onora oggi con un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato apparirà come un fatto privato...". Dal Cardinale Silvano Piovanelli, di cara memoria, in poi gli Arcivescovi di Firenze hanno in diverse occasioni dato questo riconoscimento a don Lorenzo. Oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di don Milani - non si tratta di cancellare la storia o di negarla, bensì di comprenderne circostanze e umanità in gioco -, ma dice che la Chiesa riconosce in quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa. Con la mia presenza a Barbiana, con la preghiera sulla tomba di don Lorenzo Milani penso di dare risposta a quanto auspicava sua madre: "Mi preme soprattutto che si conosca il prete, che si sappia la verità, che si renda onore alla Chiesa anche per quello che lui è stato nella Chiesa e che la Chiesa renda onore a lui... quella Chiesa che lo ha fatto tanto soffrire ma che gli ha dato il sacerdozio, e la forza di quella fede che resta, per me, il mistero più profondo di mio figlio... Se non si comprenderà realmente il sacerdote che don Lorenzo è stato, difficilmente si potrà capire di lui anche tutto il resto"».
Non per caso nelle parole del Papa emerge più di tutto il don Milani sacerdote: le definizioni che dà di don Milani lungo tutto lo snodo del discorso non sono scelte a caso. «Sono venuto a Barbiana» esordisce papa Francesco «per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve». Agli allievi dice: «Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione, nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato, con piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena fedeltà a ciascuno di voi, che il Signore gli aveva affidato». E ancora: «La scuola, per don Lorenzo, non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con una fede consapevole».
Papa Francesco sottolinea l’attualità di don Milani: «Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, in cui solo possedere la parola può permettere di discernere tra i tanti e spesso confusi messaggi che ci piovono addosso». Il papa parla esplicitamente di "umanizzazione", facendo riferimento a un concetto milaniano: la parola ai poveri non per farli diventare più ricchi, ma per farli diventare più uomini. Non per caso c’è più di Esperienze pastorali sotteso al discorso di don Milani a Barbiana di quanto non ci sia di Lettera a una professoressa. La cita, certo, quando parla agli educatori: ma al centro c’è il sacerdote non il maestro. «La vostra è una missione piena di ostacoli ma anche di gioie. Ma soprattutto è una missione. (...) Questo è un appello alla responsabilità. Un appello che riguarda voi, cari giovani, ma prima di tutto noi, adulti, chiamati a vivere la libertà di coscienza in modo autentico, come ricerca del vero, del bello e del bene, pronti a pagare il prezzo che ciò comporta. E questo senza compromessi».
Ai sacerdoti papa Francesco ricorda che «la dimensione sacerdotale di don Lorenzo Milani è alla radice di tutto quanto sono andato rievocando finora di lui. Tutto nasce dal suo essere prete. Ma, a sua volta, il suo essere prete ha una radice ancora più profonda: la sua fede. Una fede totalizzante, che diventa un donarsi completamente al Signore e che nel ministero sacerdotale trova la forma piena e compiuta per il giovane convertito. Sono note le parole della sua guida spirituale, don Raffaele Bensi, al quale hanno attinto in quegli anni le figure più alte del cattolicesimo fiorentino, così vivo attorno alla metà del secolo scorso, sotto il paterno ministero del venerabile Cardinale Elia Dalla Costa. Così ha detto don Bensi: "Per salvare l’anima venne da me. Da quel giorno d’agosto fino all’autunno, si ingozzò letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito per l’assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo. Trasparente e duro come un diamante, doveva subito ferirsi e ferire". Essere prete come il modo in cui vivere l’Assoluto. Diceva sua madre Alice: "Mio figlio era in cerca dell’Assoluto. Lo ha trovato nella religione e nella vocazione sacerdotale". Senza questa sete di Assoluto si può essere dei buoni funzionari del sacro, ma non si può essere preti, preti veri, capaci di diventare servitori di Cristo nei fratelli". Don Lorenzo ci insegna anche a voler bene alla Chiesa, come le volle bene lui, con la schiettezza e la verità che possono creare anche tensioni, ma mai fratture, abbandoni».
E ancora: «La Chiesa che don Milani ha mostrato al mondo ha questo volto materno e premuroso, proteso a dare a tutti la possibilità di incontrare Dio e quindi dare consistenza alla propria persona in tutta la sua dignità».
Quelle ultime parole: «prendete e portate la fiaccola» sono l’abbraccio che don Lorenzo Milani ha desiderato una vita. Chi stava ascoltando sulle seggiole bianche di Barbiana lo sapeva, per aver vissuto con lui il dolore dell’incomprensione, e non per caso ha applaudito proprio i passaggi in cui ha sentito il riconoscimento atteso dal Priore per mezzo secolo.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LEGGERE CON L’ORECCHIO. Un’esperienza che è vita (di nadia Fusini).1 giugno 2017, di Federico La Sala
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA.
 COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. Crisi dei fondamenti di una civiltà....
COSTITUZIONE ED EDUCAZIONE CIVICA. Crisi dei fondamenti di una civiltà....
Leggere con l’orecchio
di Nadia Fusini *
Se esiste la letteratura non possono non esistere la storia e la critica della letteratura. E dunque, chi si applica a mettere in sequenza i suoi frutti, e chi si dedica al loro giudizio. Alla loro interpretazione. Chi opera per coglierne il senso nascosto, o profondo. O per decifrare nel suo specchio le verità dell’epoca con la quale la letteratura intrattiene rapporti più o meno indiretti.
Se esiste la letteratura non può non esistere una visione, e dunque una teoria della medesima. Nel senso puro e semplice che nei suoi frutti si dà a vedere un mondo. E comunque, al di là del suo valore di intrattenimento, di divertimento - che sia in versi o in prosa, che sia un poema, un romanzo o unracconto - l’opera letteraria condensa in sé un pensiero, un’idea del mondo. Come ogni manufatto linguistico.
Esistono dunque a buon diritto il critico, lo storico, il teorico della letteratura. Ora, tali professioni, anche nel senso di fede - di fede e fiducia nella parola: che possa produrre conoscenza - si esplicano in vari modi. C’è il critico accademico, c’è il critico militante, c’è lo storico, e c’è l’interprete, e c’è il recensore di libri sui quotidiani. Chi insegna dall’alto di una cattedra e chi lodevolmente e quotidianamente si impegna a guidare il lettore comune nella scelta di un romanzo, di un libro di poesie, orientandolo con onestà in un panorama assai vasto di esperienze possibili, ben sapendo che esiste un’industria culturale, la cui volontà espansiva non arretra di fronte alle colpevoli sopraffazioni della buona fede del lettore comune. Appunto, il lettore comune, il destinatario reale e ideale del libro.
Ora a me pare che affinché esista una buona letteratura, è necessario che esista un buon lettore. O, per non ripetere il vecchio adagio dell’uovo e della gallina, un buon lettore e una buona letteratura si danno la mano.
La lettura, è questo l’atto da indagare. Come ci arriviamo. Come lo eseguiamo. Intanto, vari sensi e organi vi sono implicati. C’è l’ occhio, e c’è lo sguardo. Non sono la stessa cosa. C’è l’orecchio, e c’è l’ascolto. Non sono la stessa cosa. Leggere, non è solo una questione di occhio. Sì, certo, si legge con l’occhio la parola scritta. Ma si legge anche con l’orecchio.
Mi assumo a cavia, e rivelo che quando leggo, io ascolto. Ascolto la voce, o quel che resta della voce in quel che è scritto. Come fa Leopardi - ricordate?, quando “porgea gli orecchi al suon della tua voce", dice a Silvia. "Sonavan le quiete stanze, e le vie dintorno", in virtù di quella voce. E lui ne ha nostalgia. Potremmo dire con Leopardi che la poesia nasce così, come un’immensa nostalgia della voce viva. Voce viva, viva voce: voce che è appunto segno vivente, fiato, respiro, anima. È il segno di vita che cerca Lear sulle labbra di Cordelia - la più laconica delle sue figlie. La voce viva, la vita. Nelle parole scritte, o morte (è la stessa cosa, insegna Socrate), quando leggiamo, cerchiamo la voce viva.
Questo fa il lettore che ha orecchio: attende alla parola viva. Ascolta nell’enunciazione umana la lotta per l’espressione. Porge l’orecchio per sentire qualcuno in duello con se stesso, coi propri grovigli espressivi, con il mondo che vuole specchiare, rappresentare, svelare... Insomma, in lotta con la volontà di afferrare nella parola, quand’anche per la coda, un’esperienza che è di un altro ordine, rispetto al linguaggio.
 Un’esperienza che è vita.
Un’esperienza che è vita.L’orecchio in quanto organo presenta però una caratteristica particolare: è l’unico orifizio del corpo umano che non si chiude. Si può chiudere la bocca, si possono chiudere gli occhi, si può serrare l’ano, per quanto riguarda la vagina è protetta per un certo tempo almeno dall’imene, e anche dopo si può quanto meno contrarla, se non si vuole far passare qualcosa; ma l’orecchio no. Di suo e per natura, l’orecchio non ha difese contro la penetrazione. Proprio per questo è estremamente vulnerabile. E temo che l’acustica roboante di un’industria editoriale sciatta e volgare contribuisca a corrompere l’udito. E così anche chi vorrebbe tenere le orecchie aperte per accogliere il suono della vita, finirà per non sentire più nulla. E non saprà più intonarsi all’esperienza di conoscenza e di piacere che offre una parola autentica, che con il suono della vita si confronta.
A questa educazione dovrebbero attendere la scuola, l’università, la critica e l’estetica. Accade invece - è sotto gli occhi di tutti - che a fronte di una alfabetizzazione universale, corrisponda una ignoranza epocale, frutto di una ideologia dell’istruzione sempre più marcatamente piegata all’utile e all’immediato impiego delle risorse umane e sempre più estranea, quasi non sapesse più che cos’è, alla cura dello sviluppo della coscienza critica.
Assistiamo sconcertati a istituzioni che assecondano la pigrizia e programmano la volontà di lasciar cadere un patrimonio letterario e culturale, di cui il nostro contemporaneo è l’erede, defraudando in realtà il nostro contemporaneo delle antenne che dovrebbe sviluppare per comprendere la sua propria vita. Così chi avesse nel proprio orizzonte ancora tali fini per se stesso, singolarmente dovrà farsi carico della volontà di conoscenza: volontà di conoscenza che non può non passare attraverso la lettura, in un rapporto dinamico tra la tradizione e il presente.
Il fatto è che o leggere ha questo risvolto esperienziale, o non è nulla: non ha nessun valore. Se non di evasione. Mentre io - di nuovo mi offro come cavia - avanzo nella lettura non in fuga, ma a caccia del reale. Non leggo per evadere. Non sono un disertore. O se leggo per fuggire dalla realtà, è perché credo che la lettura mi permetta di entrare in un altro mondo né falso, né vero, ma per l’appunto “reale”.
Questo me l’ha insegnato una donna filosofa, Rachel Bespaloff. Per la quale “la lettura è la messa alla prova spirituale di un’opera.” Mentre un’altra donna filosofa, Simone Weil, mi ha insegnato l’esercizio della lettura come ‘attenzione’. Che siano Camus o Omero, la Bibbia o Kafka, chi legge, insegnano le due donne filosofe, chi legge cerca il senso dell’esistenza umana.
In modo indiretto, sospeso, per niente enfatico, chi legge ritorna a farsi le domande essenziali: da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo? È una ginnastica essenziale alla formazione umana dell’uomo. E della donna. È un training a cui la letteratura allena. In questo senso, il lettore mette alla prova l’opera che ha di fronte. E l’opera esisterà, sarà grande, rimarrà viva nei secoli dei secoli, se chi vi si abbevera, almeno un poco, estingue la sua sete di verità spirituale.
Simone Weil insegna che al cuore della lettura v’è un’esperienza etica. Si legge per conoscere, si legge per trasformarsi, per cambiare. Perché come nella muta del serpente, il vecchio Adamo decada e il novello Adamo nasca, e con lui naturalmente una nuova Eva... Si legge perché riconosciamo allo scrittore la capacità di operare in noi una metamorfosi. Sì, certo, è alla realtà, è al mondo vero, che lo scrittore attinge per costruire il suo mondo irreale; ma è del mondo reale, che vuole parlare - per cogliere oltre la sua opacità, oltre il suo capriccio, un’apertura all’essere più profonda, più radicale, che si dà soltanto così, perché lui la inventa. Cioè, la trova. E cioè, la crea. È un momento davvero miracoloso quello in cui trascendenza e invenzione si confondono. E il lettore se ne fa testimone, perché è nel lettore che questo processo si incarna.
Chi risponde così dell’atto della lettura, si fa lui stesso scrittore. A simbolo risponde simbolo, sentenziò anni fa in uno scambio privato il grande Roland Barthes. Aveva assolutamente ragione. Ma perché questo accada, il lettore dovrà farsi deuteragonista attivo e esigente. E coraggiosamente, con ostinazione mettersi alla ricerca - sarà il suo proprio Graal - dei libri che gli offrano tale esperienza.
Allontanando da sé la cattiva influenza di tutti quei mediatori che della letteratura fanno commercio, e con i lacci seduttivi di una perniciosa arte della retorica lo dissuadono dallo sviluppare le antenne che servono a distinguere la parola autentica da quella falsa. Siamo diventati così sofisticati nel palato, tanto da distinguere prelibate vivande di raro gusto, e non vogliamo diventare altrettanto capaci di godere della parola?
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- I "PROMESSI SPOSI" E QUEL "RAMO D’ORO" DEL LAGO DI COMO!23 maggio 2017, di Federico La Sala
I "PROMESSI SPOSI": DON RODRIGO, DON ABBONDIO, E QUEL "RAMO D’ORO" DEL LAGO DI COMO! Liberare gli studenti dalla "boria" dei "sapientissimi" proff. e dalle sapientissime proff.!!!
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
 Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
Italo Calvino aveva capito la lezione di Collodi e perciò cercò di mettere in salvo le "Fiabe italiane"! Nella *fiaba*, infatti, è nascosta la chiave stessa della nostra dignità di esseri umani, della nostra sovranità, della sovranità di cittadini e di cittadine di una sana e robusta Costituzione (art. 3)!!! (Federico La Sala)
- DONNE, UOMINI E VIOLENZA. L’importanza della lezione dei "PROMESSI SPOSI", oggi.
- "ERODE" E LE GERARCHIE CATTOLICO-ROMANE CONTRO CRISTO E "CONTRO CESARE. Cristianesimo e totalitarismo nell’epoca dei fascismi". Il lavoro di Emilio Gentile, recensito da Riccardo Chiaberge
“Liberiamo gli studenti dai Promessi sposi”
La noia di leggere Manzoni a quindici anni
I "Promessi sposi" sono testo obbligatorio dal 1870. Ora docenti come Giunta e Gardini, e scrittori come Camilleri, Terranova e Trevi chiedono di cambiare. Per salvare le prossime generazioni di lettori
di Marco Filoni ("pagina 99", 19 maggio 2017)
Facciamo un esperimento. Provate a immaginare una sensazione, un’immagine che vi torna alla mente dei Promessi sposi. D’accordo, a tutti più o meno risuona il famoso incipit Quel ramo del Lago di Como... Ma provate a far emergere dai vostri ricordi qualcosa che più che a mezzogiorno “volge” alle vostre emozioni. -Siate sinceri: pensate a un misto di noia e fastidio? Bene, la cosa non deve preoccuparvi. Fatti salvi gli studiosi, rientrate nella quasi totalità della popolazione italiana che, a scuola, ha letto le pagine dei Promessi sposi. Lo chiamano “effetto-Manzoni” e, secondo molti, sarebbe alla base di una successiva ripulsa verso la letteratura di molti giovani.
C’è però una considerazione che forse è arrivato il momento di fare. Ovvero: quanto questo romanzo ottocentesco (la prima versione è del 1827, la sua edizione definitiva uscì fra il 1840 e il 1842) è davvero costitutivo del carattere nazionale dell’Italia?
La domanda non suoni peregrina. Se la sono posta allo scoccar d’ogni decennio funzionari ministeriali, scrittori e insegnanti dal 1870 in poi - alternando elogi delle pagine manzoniane a severi giudizi sulla loro utilità, proponendo alternative (le Confessioni di un ottuagenario di Ippolito Nievo nel 1922, fra gli altri) e netti rifiuti (come Giosuè Carducci «perché dalla lingua dei Promessi sposi a certa broda di fagioli non c’è traghetto e dall’ammagliamento logico dello stile e discorso manzoniani alle sfilacciature di calza sfatta di cotesti piccoli bracaloni c’è di mezzo un abisso di ridicolo»).
Sul nuovo numero di pagina99, in edicola e in versione digitale, pubblichiamo una lista dei libri che sono le letture obbligatorie in differenti Paesi del mondo (compilata da Daryl Chen e Laura McClure per il sito dei Ted Talks). Perché sapere cosa un Paese fa leggere ai suoi giovani ci dice qualcosa di quel Paese. Prendiamo la Germania, dove si legge Il diario di Anna Frank (scritto in olandese, non in tedesco). Per non dire dei molti Paesi che fanno leggere romanzi scritti negli ultimi decenni: per esempio il Pakistan che propone Il fondamentalista riluttante di Mohsin Hamid (2007).
Verrebbe da chiedersi, con Italo Calvino, cos’è oggi un classico... E nel rispondere a questa domanda ci vorrebbe forse un po’ di coraggio per superare un certo familismo culturale che investe la nostra società: i nostri padri vogliono che studiamo le stesse cose che hanno studiato loro, così come noi vogliamo che i nostri figli studino quello su cui siamo incappati noi stessi. Una sorta di immobilismo che ritroviamo esplicitato nelle così dette riforme della scuola italiana, alla cui crisi si accompagna una mancanza di coraggio (ricordate don Abbondio?) forse insita nel nostro patrimonio culturale...
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
(federico la sala)
- Già ai suoi tempi, Collodi aveva capito che gli italiani e le italiane non sapevano più di cosa parla una *fiaba* (Vladimir Ja. Propp) e non sapevano più nemmeno raccontarla... E CE LO GRIDAVA IN FACCIA!!!
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Biennale d’Arte di Venezia 2017. Le artiste: Maghe, streghe, sciamane, guaritrici.21 maggio 2017, di Federico La Sala
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITÀ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. "X"- FILOSOFIA. LA FIGURA DEL "CHI": IL NUOVO PARADIGMA...
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
- LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI.
Maghe, streghe, sciamane, guaritrici: le artiste alla Biennale d’Arte di Venezia 2017
Aperta ai Giardini e all’Arsenale la 57esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, diretta dalla francese Christine Macel
inserito da Flavia Matitti *
Sono maghe, streghe, sciamane, guaritrici. Consolano, curano, condividono, ma quando svelano ansie e minacce dei nostri giorni diventano perturbanti. Appaiono così le artiste presenti alla 57esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, aperta ai Giardini e all’Arsenale dal 13 maggio al 26 novembre 2017.
L’edizione 2017 della Biennale di Venezia, del resto, conta su una marcata presenza femminile. A cominciare dalla direzione artistica, affidata alla storica dell’arte parigina Christine Macel (n.1969), curatrice capo al Centre Pompidou, convinta che: “L’arte di oggi, di fronte ai conflitti e ai sussulti del mondo, testimonia la parte più preziosa dell’umanità, in un momento in cui l’umanesimo è messo in pericolo”. Nella sua mostra intitolata “Viva Arte Viva” (una programmatica dichiarazione di fiducia nel potere rigenerante dell’arte) Christine Macel ha inserito oltre quaranta artiste su un totale di 120 nominativi.
Tra queste vi sono alcune figure leggendarie come Maria Lai (1919-2013), sarda, custode del bagaglio culturale della sua isola, autrice di poetici lavori incentrati sull’uso del filo. Qui è rievocata anche la performance collettiva “Legarsi alla montagna”, realizzata dall’artista con gli abitanti del suo paese, Ulassai, l’8 settembre del 1981, un esempio di come l’arte possa innescare un processo di partecipazione e condivisione.
 Singolare la coincidenza con il lavoro della coreografa americana Anna Halprin (n.1920), attiva dalla fine degli anni ’30, che nel 1981, in seguito allo shock provocato dall’assassinio di sette donne sui sentieri del Monte Tamalpais, vicino San Francisco, sviluppa una danza rituale di gruppo, per riconciliare la montagna con la comunità, poi divenuta la “Planetary Dance”, una danza per la pace che viene ripetuta annualmente ed eseguita in mostra nei giorni del vernissage.
Singolare la coincidenza con il lavoro della coreografa americana Anna Halprin (n.1920), attiva dalla fine degli anni ’30, che nel 1981, in seguito allo shock provocato dall’assassinio di sette donne sui sentieri del Monte Tamalpais, vicino San Francisco, sviluppa una danza rituale di gruppo, per riconciliare la montagna con la comunità, poi divenuta la “Planetary Dance”, una danza per la pace che viene ripetuta annualmente ed eseguita in mostra nei giorni del vernissage.Tra i tanti lavori esposti spicca ai Giardini la bella sala dedicata a Kiki Smith (n.1954), popolata di sculture e delicati disegni a inchiostro su carta nepalese, mentre all’Arsenale si segnalano la vivace installazione, fatta di balle colorate, dell’americana Sheila Hicks (n.1934), che ama definire le sue opere “tessiture senza pregiudizi” e il lavoro della polacca Alicja Kwade (n.1979), attiva a Berlino, una raffinata installazione che sfida le nostre capacità percettive.
Numerose sono anche le artiste chiamate a rappresentare il loro Paese attraverso progetti individuali concepiti appositamente per i rispettivi padiglioni nazionali, che quest’anno sono 86, sparsi tra i Giardini, l’Arsenale e il resto della città. Per il Padiglione della Germania, ad esempio, Anne Imhof (n. 1978) ha ideato “Faust”, un lavoro cupo sul tema del controllo e della sicurezza, col quale il padiglione tedesco si è aggiudicato il Leone d’oro per la migliore partecipazione nazionale.
 L’artista ha trasformato lo storico edificio ai Giardini in un bunker recintato e sorvegliato all’esterno da guardie accompagnate da cani feroci, mentre l’interno appare come un carcere, in cui un team di performer mette in scena episodi di arbitrio e autorità, resistenza e libertà.
L’artista ha trasformato lo storico edificio ai Giardini in un bunker recintato e sorvegliato all’esterno da guardie accompagnate da cani feroci, mentre l’interno appare come un carcere, in cui un team di performer mette in scena episodi di arbitrio e autorità, resistenza e libertà.
 La sensazione di trovarsi in un luogo minaccioso si avverte anche nel Padiglione del Brasile (premiato con una menzione speciale), dove Cinthia Marcelle (n.1974) ha realizzato il progetto “Hunting Ground”, sostituendo al pavimento delle grate metalliche disposte secondo piani inclinati.
La sensazione di trovarsi in un luogo minaccioso si avverte anche nel Padiglione del Brasile (premiato con una menzione speciale), dove Cinthia Marcelle (n.1974) ha realizzato il progetto “Hunting Ground”, sostituendo al pavimento delle grate metalliche disposte secondo piani inclinati.
 Il Padiglione della Gran Bretagna appare invece invaso da sculture informi e colorate, festose e inquietanti, secondo il progetto “Folly” di Phyllida Barlow (n.1944).
Il Padiglione della Gran Bretagna appare invece invaso da sculture informi e colorate, festose e inquietanti, secondo il progetto “Folly” di Phyllida Barlow (n.1944).
 Kirstine Roepstorff (n.1972) vorrebbe al contrario rassicurare e dal Padiglione della Danimarca invita, tramite un’esperienza immersiva, ad accettare la precarietà, l’ignoto e la trasformazione come componenti naturali del processo di crescita. L’artista ha allestito un teatro nel quale il visitatore si impegna a trascorrere mezz’ora, al buio, in un’oscurità mistica evocatrice dell’utero materno, del cosmo o dell’aldilà, mentre una voce sussurra: “Hai tutto dentro di te, devi essere disposto a cambiare completamente dal vecchio sistema di orientamento al nuovo: l’oscurità è il vuoto gravido da cui sorge e nasce ogni cosa”. -Tracey Moffatt (n.1960), la prima artista indigena a rappresentare l’Australia con una mostra individuale, presenta il progetto “My Horizon”, che attraverso fotografie, filmati e video affronta, tra realtà e finzione, il tema dei migranti e dello spaesamento quale condizione esistenziale.
Kirstine Roepstorff (n.1972) vorrebbe al contrario rassicurare e dal Padiglione della Danimarca invita, tramite un’esperienza immersiva, ad accettare la precarietà, l’ignoto e la trasformazione come componenti naturali del processo di crescita. L’artista ha allestito un teatro nel quale il visitatore si impegna a trascorrere mezz’ora, al buio, in un’oscurità mistica evocatrice dell’utero materno, del cosmo o dell’aldilà, mentre una voce sussurra: “Hai tutto dentro di te, devi essere disposto a cambiare completamente dal vecchio sistema di orientamento al nuovo: l’oscurità è il vuoto gravido da cui sorge e nasce ogni cosa”. -Tracey Moffatt (n.1960), la prima artista indigena a rappresentare l’Australia con una mostra individuale, presenta il progetto “My Horizon”, che attraverso fotografie, filmati e video affronta, tra realtà e finzione, il tema dei migranti e dello spaesamento quale condizione esistenziale.
 Tra l’altro si può vedere un vecchio filmato (Tracey Moffatt dice di averlo recentemente riscoperto) girato dai popoli indigeni australiani nel 1788, quando le prime navi della flotta britannica entrarono nel porto di Sidney.
Tra l’altro si può vedere un vecchio filmato (Tracey Moffatt dice di averlo recentemente riscoperto) girato dai popoli indigeni australiani nel 1788, quando le prime navi della flotta britannica entrarono nel porto di Sidney.
 La Romania dedica per la prima volta a una donna, Geta Brătescu (n.1926), una mostra individuale, offrendo così l’occasione per conoscere il lavoro di quest’artista, che attraverso disegni, collage, fotografie, oggetti e film conduce una riflessione affascinante sulla soggettività femminile.
La Romania dedica per la prima volta a una donna, Geta Brătescu (n.1926), una mostra individuale, offrendo così l’occasione per conoscere il lavoro di quest’artista, che attraverso disegni, collage, fotografie, oggetti e film conduce una riflessione affascinante sulla soggettività femminile.
 Vale la pena ricordare, infine, Jesse Jones (n.1978) col suo progetto video “Tremble, tremble” per il Padiglione dell’Irlanda in cui recupera, con la straordinaria performer Olwen Fouéré, la figura della strega quale archetipo femminista ed elemento di rottura in grado di trasformare la realtà. Il titolo riprende lo slogan delle femministe italiane degli anni ’70 “Tremate, tremate, le streghe son tornate!” e invoca una trasformazione dei rapporti tra Chiesa e Stato nell’Irlanda di oggi.
Vale la pena ricordare, infine, Jesse Jones (n.1978) col suo progetto video “Tremble, tremble” per il Padiglione dell’Irlanda in cui recupera, con la straordinaria performer Olwen Fouéré, la figura della strega quale archetipo femminista ed elemento di rottura in grado di trasformare la realtà. Il titolo riprende lo slogan delle femministe italiane degli anni ’70 “Tremate, tremate, le streghe son tornate!” e invoca una trasformazione dei rapporti tra Chiesa e Stato nell’Irlanda di oggi.Spesso anche la direzione artistica dei padiglioni nazionali è donna, come nel caso del Padiglione Italia, senza dubbio uno dei migliori di questa edizione. Da notare che la curatrice, Cecilia Alemani, ha voluto richiamare il tema della magia fin dal titolo della sua mostra - “Il mondo magico” (dal libro di Ernesto de Martino) - un tema che i tre artisti invitati (Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Husni-Bey) hanno declinato magnificamente, ciascuno a suo modo.
Su proposta di Christine Macel, inoltre, il Leone d’oro alla carriera è andato quest’anno all’americana Carolee Schneemann (n.1939), pioniera della performance femminista fin dagli anni ’60. “Schneemann - si legge nella motivazione - ha utilizzato il corpo nudo come forza primitiva e arcaica in grado di unificare le energie”.
Come sempre, durante la Biennale, sono innumerevoli gli eventi organizzati in città, ma sulle artiste si segnalano in particolare: la piccola mostra-dossier sulla pittrice surrealista danese Rita Kernn-Larsen (1904-1998), una riscoperta promossa dalla Collezione Peggy Guggenheim (fino al 26/6); l’esposizione “The Home of My Eyes”, che presenta 26 fotografie e il toccante video “Roja” (2016) dell’iraniana Shirin Neshat al Museo Correr (fino al 26/11); i raffinati progetti site specific realizzati da Marzia Migliora, in collaborazione con la Fondazione Merz, per le sale di Ca’ Rezzonico (fino al 26/11) e da Elisabetta Di Maggio (fino al 24/9) e Maria Morganti per gli spazi della Querini Stampalia.
 Da non perdere, infine, la mostra collettiva “Intuition” a Palazzo Fortuny (fino al 27/11), che spazia da Hilma af Klint a Marina Abramovic, e “Future Generation Art Prize@Venice 2017” a Palazzo Contarini Polignac (fino al 13/8).
Da non perdere, infine, la mostra collettiva “Intuition” a Palazzo Fortuny (fino al 27/11), che spazia da Hilma af Klint a Marina Abramovic, e “Future Generation Art Prize@Venice 2017” a Palazzo Contarini Polignac (fino al 13/8).
 In quest’ultima spiccano la misteriosa installazione rituale dell’artista sudafricana Dineo Seshee Bopape, vincitrice di questa quarta edizione del premio istituito dal mecenate ucraino Victor Pinchuk, e la fiabesca opera multisensoriale “Mutumia” (donna in Kikuyu) dell’artista kenyota Phoebe Boswell, vincitrice del premio speciale.
In quest’ultima spiccano la misteriosa installazione rituale dell’artista sudafricana Dineo Seshee Bopape, vincitrice di questa quarta edizione del premio istituito dal mecenate ucraino Victor Pinchuk, e la fiabesca opera multisensoriale “Mutumia” (donna in Kikuyu) dell’artista kenyota Phoebe Boswell, vincitrice del premio speciale.Biennale di Venezia 2017- didascalie
1. Sheila Hicks, Scalata al di là dei terreni cromatici, 2016-17, Arsenale, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Viva Arte Viva (Photo Flavia Matitti)
2. Alicja Kwade, WeltenLinie, 2017, Arsenale, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Viva Arte Viva (Photo Flavia Matitti)
3.Tracey Moffatt, Madre con bambino, dalla serie Traversata, 2017, Padiglione dell’Australia, Giardini, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia (Photo courtesy the Artist, Australia Council for the Arts).
4. Una veduta esterna del Padiglione della Germania trasformato da Anne Imhof, Giardini, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia (Photo by Flavia Matitti).
*
LA BIENNALE DI VENEZIA - Noi Donne, 15 Maggio 2017 (ripresa parziale).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- “Stiamo cambiando pelle”. Intervista a Remo Bodei (di E. Lepore - "La chiave di Sofia).15 maggio 2017, di Federico La Sala
- RENZO DE FELICE E LA STORIA DEL FASCISMO: LA NECESSITÀ DI RICOMINCIARE DA "CAPO"!
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
“Stiamo cambiando pelle”. Intervista a Remo Bodei
di Emanuele Lepore *
- Abbiamo incontrato il Professore Remo Bodei in occasione del Festival Filosofia, le cui attività si articolano entro lo spazio delle tre città di Modena, Carpi e Sassuolo.
 Il professore è stato per molto tempo docente di Storia della filosofia ed Estetica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è stato visiting professor in molti atenei internazionali ed attualmente insegna filosofia allo UCLA di Los Angeles. Ha inoltre pubblicato numerosi libri e saggi dei quali gli ultimi due nel 2016. I suoi studi si sono concentrati sull’idealismo tedesco, per poi ampliare gli orizzonti alla filosofia della storia e alla cultura filosofico-letteraria romantica, dalla quale emerge in particolare il binomio antitetico ragione-passioni, tema che ha spesso coinvolto il pensiero filosofico.
Il professore è stato per molto tempo docente di Storia della filosofia ed Estetica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è stato visiting professor in molti atenei internazionali ed attualmente insegna filosofia allo UCLA di Los Angeles. Ha inoltre pubblicato numerosi libri e saggi dei quali gli ultimi due nel 2016. I suoi studi si sono concentrati sull’idealismo tedesco, per poi ampliare gli orizzonti alla filosofia della storia e alla cultura filosofico-letteraria romantica, dalla quale emerge in particolare il binomio antitetico ragione-passioni, tema che ha spesso coinvolto il pensiero filosofico.
 Nel corso dell’intervista che segue, abbiamo cercato di approfondire alcuni dei preziosi spunti contenuti nella lectio magistralis che ha tenuto nell’ultima edizione del Festival.
Nel corso dell’intervista che segue, abbiamo cercato di approfondire alcuni dei preziosi spunti contenuti nella lectio magistralis che ha tenuto nell’ultima edizione del Festival.
Professore Bodei, vorremmo iniziare da una suggestione che arriva dal suo ultimo libro Limite (Mulino, Bologna 2016), in cui riferisce che la filosofia moderna, da Locke fino a Kant, si interroga incessantemente sui limiti dell’intelletto umano, cercando di stabilire quali siano i limiti tra il conoscibile e l’inconoscibile. Secondo lei la filosofia contemporanea attorno a quali limiti si interroga?
I limiti variano col tempo: da Locke a Kant erano quelli dell’intelletto umano, si ricercava fin dove l’uomo potesse conoscere, avendo come base l’esperienza e la scienza. Fin dove la metafisica o la fede potessero estendersi. Oggi i problemi sono diversi e sono costituiti dall’incontro tra le varie culture e civiltà del mondo, in quanto si è rinunciato ad un’idea che valga per tutti, che poteva essere rappresentata dalla stessa forma di conoscenza.
 Un altro limite è segnato dalle biotecnologie: com’è che l’uomo si trasforma? Come si possono scoprire degli aspetti della natura umana che prima non c’erano? È la questione dell’artificialità e del post-umano. Un altro limite è segnato dalla comunicazione e dalle tecnlogie dell’informazione e di come queste possano trasformare persone e culture.
Un altro limite è segnato dalle biotecnologie: com’è che l’uomo si trasforma? Come si possono scoprire degli aspetti della natura umana che prima non c’erano? È la questione dell’artificialità e del post-umano. Un altro limite è segnato dalla comunicazione e dalle tecnlogie dell’informazione e di come queste possano trasformare persone e culture.
 Per certi aspetti si cerca il superamento dei limiti, per altri si cerca invece di stabilire dei confini che sono stati incautamente violati e che bisogna ricostruire: non siamo sicuri di avere una morale saldamente condivisa e per questo si cerca, ad esempio, di evitare che tutto sia permesso: da attraverso la spesso fraintesa espressione della morte di Dio, Nietzsche s’è accorto che non possono più sussistere regole insindacabili perché espresse da Dio: sono gli uomini che devono darsi regole credibili e solide, e di
questo - Nietzsche lo capiva - non siamo stati capaci. Viviamo in una morale provvisoria permanente, che non è di per sé un male ma ci pone in una situazione difficile.
Per certi aspetti si cerca il superamento dei limiti, per altri si cerca invece di stabilire dei confini che sono stati incautamente violati e che bisogna ricostruire: non siamo sicuri di avere una morale saldamente condivisa e per questo si cerca, ad esempio, di evitare che tutto sia permesso: da attraverso la spesso fraintesa espressione della morte di Dio, Nietzsche s’è accorto che non possono più sussistere regole insindacabili perché espresse da Dio: sono gli uomini che devono darsi regole credibili e solide, e di
questo - Nietzsche lo capiva - non siamo stati capaci. Viviamo in una morale provvisoria permanente, che non è di per sé un male ma ci pone in una situazione difficile.Un’altra posizione indubbiamente difficile e complessa è quella da lei evocata durante la sua lectio magistralis di Modena: la lotta contro se stessi pare essere un confronto drammatico per ritagliarsi un proprio spazio nel mondo. Secondo lei tra le sfide che l’uomo contemporaneo deve affrontare c’è anche quella che lo vede in cerca del suo posto nel mondo? Se sì, a che prezzo?
Trovare il proprio posto nel mondo è sempre stata un’impresa che ha riguardato gli uomini sin dall’età della preistoria: semplicemente cambiano questioni e limiti. Orientarsi oggi in un mondo così complesso e cangiante rispetto a quello della tradizione è più difficile o - per meglio dire - diversamente difficile: bisogna muoversi su d’un piano globale interconnesso e, d’altro canto, in un mondo che cambia continuamente e pone un problema di adattamento.
A proposito della complessità del nostro mondo: uno dei suoi tratti generalmente più riconosciuti è la liquidità, la quale - più di ogni altro - sembra dare un’illusione di libertà. In che modo la fluidità delle relazioni sociali e personali può aver compromesso la stabilità del tessuto sociale contemporaneo?
Questa caratteristica di liquidità egregiamente messa in luce da Bauman, per cui dall’inizio degli anni ’80 ad oggi sembra che non vi sia nulla di solido è una proposizione enunciata da Marx e Engels nel Manifesto del Partito Comunista: tutto ciò che è solido si squaglia. In questa situazione, con le difficoltà del terrorismo e della crisi finanziaria, stiamo scoprendo che il mondo è molto più duro e molto meno liquido di quanto pensavamo. Anzitutto abbiamo la necessità di trovare i limiti, di riconoscerli e comprendere come far fronte alla nuova rigidità della nostra esistenza.
In questo contesto sociale e politico così complesso, che ruolo crede abbiano le passioni umane, calate in un’epoca dominata da una tecnica che, sempre più a fondo, modifica i contesti e i soggetti che vi abitano?
Le passioni hanno sempre costituito un valore per il vivere comune: bisogna tuttavia distinguere tra le varie forme di passione. Noi viviamo in un’epoca in cui le passioni sono state sostituite dai desideri: questi non sono altro che passioni declinate al futuro, quindi passioni che non sono legate a qualcosa che, tradizionalmente, ha dei limiti. Abbiamo delle passioni che, in quanto proiettate verso il futuro, sono elastiche e procedono avanti. C’è poi una dimensione legata alle passioni private come l’amore (messe in risalto dalla modernità e dal Romanticismo) a cui fa da contraltare un declino della dimensione pubblica: in parte ci si richiude in se stessi davanti alla durezza dell’esistenza, in parte c’è una crisi delle passioni democratiche legate agli ideali di uguaglianza tra gli individui.
Secondo lei l’assenza di una bussola per l’agire comune piò dipendere dalla perdita di senso della nozione di bene comune? Se sì, crede che sia oggi possibile ricostruire tale nozione?
La nozione di bene comune è sempre stata da un lato un’aspirazione ideale e dall’altro una sorta di ingannevole prospettiva con cui si sono mascherate tutte le forme di soppressione: i totalitarismi del ‘900 hanno predicato un bene comune che, in realtà, si è rivelato un bene per certi tipi di classi, di individui. L’esistenza di un orizzonte che superi l’individuo segna il problema di trovare la strada per cui esso diventi effettivo e non diventi una maschera che serve a legittimare dei comportamenti che perseguono beni non comuni ma parziali.
Questo è un problema che sembra ripercuotersi anche nella dimensione individuale; nel suo libro Immaginare altre vite: realtà, progetti, desideri (Feltrinelli, Milano 2013) ricostruisce il ruolo fondamnetale che ideali e modelli hanno giocato nelle dinamiche di costruzione di sé. Secondo lei a quali ideali, modelli si può ricorrere? Ve ne sono?
In generale questi modelli sono cambiati abbastanza recentemente perché in precedenza il nostro mondo (limitato, occidentale, europeo) questi ideali erano legati alla realizzazione di se stessi, alla possibilità di avere una soddisfazione in un mondo che, per certi versi, ha rinunciato all’al di là e richiede dunque che si possa trovare godimento nell’arco dell’esistenza fisica degli individui.
 Dopo il fallimento di certi regimi completamente laici, i quali ritenevano che l’uomo potesse, nell’arco dell’esistenza storica, trovare il proprio compimento, questi modelli si sono indeboliti ed è tronato il bisogno di trascendente e anche delle religioni: talvolta è tornato in forme piuttosto violente, come nel caso degli islamisti. Stiamo cambiando pelle: c’è un tentativo di ritrovare una soddisfazione che non è solo di questo mondo, non solo secondo una matrice religiosa ma anche estetica, secondo la maniera di Foucault per cui si fa di se stessi un’opera d’arte e si ha un’estetica dell’etica, si diventa come statue, si cerca di far vivere la bellezza nell’etica.
Dopo il fallimento di certi regimi completamente laici, i quali ritenevano che l’uomo potesse, nell’arco dell’esistenza storica, trovare il proprio compimento, questi modelli si sono indeboliti ed è tronato il bisogno di trascendente e anche delle religioni: talvolta è tornato in forme piuttosto violente, come nel caso degli islamisti. Stiamo cambiando pelle: c’è un tentativo di ritrovare una soddisfazione che non è solo di questo mondo, non solo secondo una matrice religiosa ma anche estetica, secondo la maniera di Foucault per cui si fa di se stessi un’opera d’arte e si ha un’estetica dell’etica, si diventa come statue, si cerca di far vivere la bellezza nell’etica.Lei da anni conduce parallelamente un’opera di ricerca filosofica e un’azione di divulgazione molto importante. Crede che il rinnovato e generalizzato interesse per le questioni della filosofia sia connesso con i bisogni del senso comune a cui si riferiva prima?
Penso che nell’esistenza delle persone, da quando ciascuno di noi è un bambino, ci si pone delle domande sul perché si esiste. Sono domande alle quali, a un certo punto, ci si rifiuta di rispondere: talvolta le domande diventano tarli fastidiosi. In forza di ciò ci si costruisce una visione del mondo fatta in casa, non suffragata da riflessioni profonde e perciò in genere non viene poi sviluppata dalla scuola, dalgi studi che guardano ad un sapere tecnico-professionale. Il bisogno di filosifa è una fame di senso che procura una sorta di esame di riparazione in età adulta di messa a fuoco di cose che non si sono osservate lungo la propria esistenza.
Quanto ha appena detto si sposa con la missione ideale de La Chiave di Sophia, che si propone di stimolare la comprensione di quanto la filosofia sia presente nella vita dell’umano, nella sua quotidianità, contrariamente a chi ritiene che essa sia - e, in certa misura, - debba rimanere una disciplina di nicchia, ristretta quanto a temi e pubblico cui si rivolge.
Fare filosofia significa cercare di capire il tessuto connettivo e orizzonte di senso entro cui noi ci situiamo, che non è appunto qualcosa di specifico. Rispetto alla frantumazione dei saperi e delle pratiche la filosofia è un tentativo continuamente rinnovato di trovare un orizzonte entro cui muoverci e situarci, perché essa non è un sapere specialistico. Si potrebbe dire che la filosofia è uno specialismo dell’universale: la filosofia ci riguarda tutti ma è molto difficile orientarsi filosoficamente perché si rischia di creare delle generalizzazioni astratte. Per questo si innesta in un sapere che riguarda un’acquisizione: per esempio, 2500 anni in cui nel nostro occidente si è pensato. Noi siamo debitori nei confronti di queste forme di ricerca che rappresentano una sorta di palestra mentale. Essa serve a tutti: senza di essa saremmo come automi. Essa è una forma di vivere in maniera consapevole. Se facessimo un esperimento mentale in cui la filosofia non avesse fecondato la nostra cultura, noi ci ritroveremmo certamente più creduloni, più stupidi e manipolabili e quindi meno liberi. È un valore per la democrazia, in quanto ci permette di vivere più consapevolmente e in maniera meno dogmatica.
*
Emanuele Lepore
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- Perché Dio viene presentato al maschile?13 maggio 2017, di Federico La Sala
RIPENSARE COSTANTINO ... *
Perché Dio viene presentato al maschile?
risponde il teologo Pino Lorizio (Famiglia Cristiana, 11/05/2017)
- GIOVANNA Perché Dio è al maschile? E perché si è incarnato in un uomo, Gesù, e non in una donna?
La Bibbia ci autorizza a pensare Dio anche nel suo volto “materno”. E ci dice che se anche una donna si dimenticasse di suo figlio, il Signore non potrà mai dimenticarsi di noi, né abbandonarci. In tempi nei quali assistiamo a episodi inauditi di violenza non solo di padri, ma anche di madri, su bambini inermi, ricordarcelo non è fuori luogo.
 Né dobbiamo dimenticare che pensare Dio come sessuato è un antropomorfismo, che potrebbe risultare fuorviante, se inteso in termini esclusivi. Dio è oltre le differenze sessuali, perché è fuori del tempo e delle contingenze mondane.
Né dobbiamo dimenticare che pensare Dio come sessuato è un antropomorfismo, che potrebbe risultare fuorviante, se inteso in termini esclusivi. Dio è oltre le differenze sessuali, perché è fuori del tempo e delle contingenze mondane.
 Quando però il Figlio si incarna, entra in questa differenza e non può che assumere una delle modalità in cui l’umano si esprime. Se si fosse incarnato al femminile, si sarebbe potuta avanzare la stessa obiezione dal punto di vista maschile. E allora, siccome la storia non si fa con i se e i ma, stiamo dentro l’evento, non alimentiamo inutili fantasie ispirate a machismo o femminismo, e lasciamoci guidare dalla tenerezza materna di Dio, incarnata in Cristo Gesù e vissuta nella madre Chiesa.
Quando però il Figlio si incarna, entra in questa differenza e non può che assumere una delle modalità in cui l’umano si esprime. Se si fosse incarnato al femminile, si sarebbe potuta avanzare la stessa obiezione dal punto di vista maschile. E allora, siccome la storia non si fa con i se e i ma, stiamo dentro l’evento, non alimentiamo inutili fantasie ispirate a machismo o femminismo, e lasciamoci guidare dalla tenerezza materna di Dio, incarnata in Cristo Gesù e vissuta nella madre Chiesa.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
MESSAGGIO EVANGELICO E SANTO PADRE?! ABUSO DEL TITOLO E MENZOGNA.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "Hidden Figures". Donne: Matematici nell’ombra (di Michelle Emmer).27 marzo 2017, di Federico La Sala
Matematici nell’ombra
di Michele Emmer (Alfabeta2, il 26 marzo 2017 · in AlfaDomenica · 1 Commento)
“Mi sento un matematico” dichiara il protagonista del film. Si dirà che non è una novità, oramai di film sui matematici se ne sono realizzati tanti e alcuni nomi di matematici sono diventati noti agli spettatori di cinema. Però chi formula quella frase è una donna. E questa è una bella novità, perché - se non si considera quel polpettone di Agorà realizzato qualche anno fa sulla incredibile storia della matematica greca Ipazia, impersonata da Rachel Weisz - di donne matematici al cinema se ne sono viste pochissime, e in ruolo marginali o inesistenti, come in The Imitation Game. Senza voler sollevare la questione che sino al ventesimo secolo le matematiche importanti si contavano sulle dita di una mano. Il nesso tra personalità femminile e pensiero astratto: non ho mai creduto a queste differenze di genere e gli ultimi cento anni hanno dimostrato che ci sono tante matematiche donne di eccezionale livello. Dunque, “mi sento un matematico” lo dice la protagonista donna matematico in un film candidato all’Oscar come miglior film, Octavia Spencer per attrice non protagonista.
Dunque una donna matematico, nera. E questa sì che è una grande novità al cinema. Se poi la storia si svolge negli USA dell’inizio della corsa spaziale - siamo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta -, ecco allora che la novità emerge in tutta la sua importanza. Una storia sconosciuta, ma non per questo meno esemplare e importante, con il film che è uscito in coincidenza in Italia con quella festa della donna del tutto ingiustamente criticata (anche su Alfabeta2). Ma non vorrei divagare.
Scopriamo così che i matematici donne nere USA in quegli anni non erano solo tre, come le protagoniste del film Hidden Figures ("Persone nell’ombra", tradotto in italiano Diritto di contare con un banale gioco di parole. Tanto i matematici che fanno? Calcolano numeri!). In realtà erano decine e decine, donne e uomini, che lavoravano alla NASA. Negli anni Settanta gli ingegneri neri negli Stati Uniti erano il 1%, solo nel 1984 saliranno al 2%. Ma nel 1984 alla NASA gli ingegneri neri erano lo 8,4%. Lo scrive in Hidden Figures (Harper Collins Publishers, Londra, 2016) Margot Lee Shetterly, anche lei donna nera, figlia di ingegneri neri che lavoravano alla NASA, al National Aeronautics and Space Administration’s Langley Research Center a Hampton, nello stato della Virginia. La Shetterly quando era bambina pensava che la grande maggioranza dei neri americani, uomini e donne, si occupassero di scienza, di matematica, di ingegneria. La Shetterly voleva raccontare quella storia e lo avrebbe fatto anche se la storia fosse cominciata con le prime cinque donne nere che andarono a lavorare al centro di ricerca a Langley, in uno stato, la Virginia, segregazionista, nel maggio del 1943. “Posso citare i nomi di almeno 50 donne nere che hanno lavorato come computers (a fare calcoli a mano), matematici, ingegneri a Langley dal 1943 al 1980, e cercando meglio almeno altri 20 nomi si potrebbero aggiungere.”
L’autrice del libro è del tutto sensibile alla dissonanza cognitiva evocata dalla frase “black female mathematicians at NASA”. Ha incontrato di persona la favolosa Katherine Johnson (nel film Taraji P. Henson), colei che ha controllato la traiettoria di rientro dallo spazio per l’astronauta John Glenn, una delle protagoniste del film. Le altre due sono Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), Mary Jackson (Janelle Monae). Alla NASA devono essere fischiate le orecchie quando hanno saputo del libro, e poi del film, con un titolo che suona “Chi ha fatto dimenticare queste persone?”, e nel sito ufficiale c’è una pagina in cui si afferma che negli anni questa storia è sempre stata ricordata. Certo, un libro ed un film di successo hanno una eco molto maggiore. E probabilmente allora la NASA non voleva troppi problemi.
Nel sito della IBM ci sono pagine dedicate al famoso IBM Data Processing System 7090, il cui primo esemplare viene installato nel 1959. Chi è stato allora studente universitario di matematica ricorda bene i primi corsi di Fortran per programmare quegli enormi bestioni con pile di schede perforate che non facevano altro che incastrarsi. Il grande computer è uno dei personaggi centrali del film. È una delle tre ragazze nere ad avere l’idea di imparare il Fortran, il linguaggio di programmazione, e di insegnarlo alle altre decine di ragazze per essere pronte per l’arrivo del grande computer.
Il primo Sputnik viene lanciato dai Sovietici il 4 ottobre 1957, Jurij Gagarin è il primo uomo a volare nello spazio il 12 aprile 1961. Gli USA erano alla rincorsa per cercare di riprendere il ritardo, che aveva ovvie implicazioni militari. La crisi dei missili di Cuba, dopo l’invasione tentata nell’aprile 1961 e i missili nucleari a Cuba, inizia il 15 ottobre 1962. Allora la guerra nucleare sembrava possible, e chissà che non torni di attualità, considerando i geni che ci governano oggi. La risposta USA è il progetto spaziale Mercury, il primo programma USA (attivo tra il 1958 e il 1963) a prevedere missioni spaziali con equipaggio.
La storia incredibile delle tre matematiche nere si inserisce in una storia altrettanto incredibile. Le tre ragazze non sono eguali. Katherine è la più geniale matematica delle tre. All’inizio del film, ancora bambina, declama i numeri interi positivi segnalando i numeri primi (molto fotogenici al cinema e in letteratura). Poi le figure geometriche, i solidi platonici. E risolve il sistema di due equazioni algebriche di secondo grado moltiplicate tra loro. È lei la teorica, quella che si “sente un matematico”.
Interessante che la parola mathematics della versione inglese viene quasi sempre tradotta in italiano con calcoli . La frase inglese due to math (grazie alla matematica, è tradotto 2 + 2 = 4). Comunque la matematica che compare nel film è accurata e non banale, tipo le formule di Frenet, formule che consentono con tecniche differenziali di studiare la geometria delle curve, le loro proprietà qualitative. Ed è Katherine che deve eseguire i calcoli, pur dovendo bere da una macchina da caffè diversa dagli altri che lavorano con lei e avendo il bagno in un altro edificio, a quasi un chilometro di distanza. Un matematico bianco, appena la vede, afferma che lui non ha mai lavorato con una donna nera.
I calcolatori in quegli anni non ci sono, bisogna calcolare a mano le orbite: in particolare, calcolare i parametri per mettere in orbita la capsula Mercury in modo che prenda una orbita ellittica intorno alla terra. Bisogna calcolare a mano la trasformazione dall’orbita ellittica intorno alla terra a una parabolica discendente sulla terra che abbia una giusta inclinazione in modo che la capsula arrivi nell’oceano dove saranno presenti le navi per il recupero (pena l’affondamento). Quando arriva, il grande IBM non è ancora utilizzabile per fare questo calcolo e Katherine ha l’idea di utilizzare il metodo di Eulero, grande matematico tedesco del Ottocento. Permette di trattare equazioni differenziali di cui non si conoscono le soluzioni in modo numerico, approssimato, e ad oggi è alla base di alcuni dei metodi più usati in matematica applicata, con opportuni aggiustamenti.
La scena finale del film in cui John Glenn che sta per salire sulla Mercury 7 chiede che sia the Girl a verificare i dati delle orbite e di ritorno sulla terra è ovviamente inventata nei tempi. Come si legge nel sito della NASA i conti furono controllati da Katherine, ma una decina di giorni prima del lancio. E dirà Katherine: La matematica è solo numerica. Non è così, ma la vera Katherine lo sa di sicuro. È ancora viva, ha 97 anni. Così come le sue due compagne, una andrà a dirigere un settore di software all’IBM, l’altra diventa la prima ingegnere donna nera nella Virginia.
Nel film il ruolo di Al Harrison, ingegnere capo, burbero ma intelligente, capace e cordiale, è costruito su diversi personaggi veri della NASA di allora, come si legge sempre nel sito NASA. Nei giornali italiani interviste solo a lui, che ha una parte secondaria, afferma subito di non capire nulla di numeri e dice: “Non ho mai capito la nostra ossessione per la matematica. Pochi di noi usano nella vita quotidiana equazioni o numeri negativi. Eppure al liceo venivamo giudicati per quello". Da non commentare, avrà letta la sceneggiatura? In un film con tutte matematiche!
Il film è una commedia, brillante a volte, con pochissima tensione, non ci sono veri cattivi, la tensione razziale è molto sullo sfondo. È stato scelto il tono brillante e le tre matematiche sono spiritose, pieni di battute, piace loro essere corteggiate. Insomma una vera rivoluzione al cinema, ma non solo. Un film del genere colpirà molto le nuove generazioni alle prese con Trump, si spera. Era l’anno del cinema nero. È giusto abbia vinto Moonlight (e non La La Land che è stato anche beffato agli Oscar!), ma anche questa commedia era candidata. Era giusto.
Un’ultima cosa: un nero matematico USA Rudy Jr. Horne, University of Boulder, Colorado, ha fatto da consulente per il film, insegnando anche a Katherine a ricordare le formule da scrivere nell’ordine giusto.
- Il diritto di contare (Hidden Figures)
 regia di Theodore Melfi
regia di Theodore Melfi
 basato sul libro Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race di Margot Lee Shetterly
basato sul libro Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race di Margot Lee Shetterly
 con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner
con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner
 sceneggiatura di Theodore Melfi e Allison Schroeder
sceneggiatura di Theodore Melfi e Allison Schroeder
 USA (2016), 127 m.
USA (2016), 127 m.
- Il diritto di contare (Hidden Figures)
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- 8 marzo 2017. Una generazione, nuova e globale, sulla scena politica (di Bia Sarasini)11 marzo 2017, di Federico La Sala
Una generazione, nuova e globale, sulla scena politica
8 marzo. Uno sciopero guidato e pensato da donne, una mobilitazione internazionale come non succedeva dai tempi dei social forum. Si comincia da qui, dalle giovani femministe
di Bia Sarasini (Il manifesto, 10 marzo 2017)
Ha fatto un bel po’ paura, lo sciopero delle donne, l’8 marzo. Tutte quelle ragazze, ragazzi, donne, uomini, persone lgbt in piazza. Rumorosamente assenti dal lavoro. Un milione? Bisognerà fare le mappe e i conti delle mille iniziative sparse nel pianeta.
Il punto è che un’enorme quantità di persone si sono mobilitate. Un popolo che sciopera, cioè si prende e mostra la propria forza. Che si muove non contro i nemici additati dalla propaganda di destra, i migranti, gli stranieri, o una casta politica diventata ormai metafisica, fantasma di un potere che rimane invisibile.
No, la mobilitazione, proprio perché era uno sciopero, era contro un’organizzazione del sociale, della divisione sessuale del lavoro e del lavoro stesso. Insomma, contro il potere reale, le sue radici violente, arcaiche e contemporanee, di cui il femminicidio è la forma estrema e paradigmatica.
Uno sciopero guidato e pensato da donne, poi. Un fatto inaudito. La visione delle donne si allarga, mostra di sapere e potere riorganizzare la vita sociale e il mondo. A partire dalla propria esperienza, dal dominio subito e dalla lotta per ribaltarlo. Non succedeva dal tempo dei social forum, una mobilitazione internazionale nella stessa giornata. Non si era più abituate neanche a un 8 marzo che non fosse un rito, di presidenti che elogiano l’indispensabilità delle donne, multinazionali che creano premi, sindaci che danno le medaglie. E la leadership femminile, è una novità assoluta. Tutte e tutti a invocarla, e quando te la trovi squadernata davanti, cosa si finisce per dire? Che è stato un successo, ma alla fine è un disastro.
Dispiace che una femminista autorevole come Alessandra Bocchetti, invece di chiedersi perché tante, tantissime sono scese in strada, evochi un’autonomia delle donne che questo 8 marzo, con la sua proposta inclusiva e intersezionale, avrebbe messo a a rischio. Più conseguente Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, che critica lo sciopero come strumento arcaico, visto che il lavoro è precario.
E dire che proprio questa è la forza di questo otto marzo 2017. Donne che proclamano uno sciopero. Avere rotto una barriera. Avere buttato all’aria quella compartimentazione prima di tutto mentale in cui è imprigionata la società. Quella frammentazione per cui ai sindacati spettano gli scioperi, quelli veri, che riguardano i lavoratori veri che stanno nei posti di lavoro riconosciuti come tali. Cosa ne sanno le donne? Cosa c’entrano le case, o i femminicidi, i lavori precari e qualificati, che puoi fare perfino in autobus e sulla metro, visto che quello che conta è la connessione? Che cosa si sono messe in testa le femministe, di proclamare lo sciopero? Il maschilismo ha molte facce. Questa rigidità ne è senz’altro un aspetto.
Eppure spero che proprio il successo dell’8 marzo globale apra gli occhi. Perché l’inerzia misogina rischia di farsi complice della passivizzazione di chi lavora, rischia di coltivare l’impotenza prodotta dalla svalorizzazione del lavoro, invece di combatterla. Dispiace che la Fiom, che pure ha incontrato la rete organizzatrice dello sciopero in Italia, NonUnaDiMeno, non abbia colto l’occasione.
Perché lasciare che sia il mercato a mettere al lavoro migranti, donne povere e impoverite in attività malpagate e sfruttate, tutto delegato all’iniziativa individuale? Perché non pensare a un nuovo welfare, a nuovi lavori da unire a un reddito minimo, da garantire quando necessario?
Si comincia da qui, dalle giovani femministe, una nuova generazione politica, che hanno preso la guida. È un progetto, una speranza. Si rivolge a tutti coloro che subiscono il potere neocapitalista, le conseguenze di una globalizzazione violenta che, lasciandosi noncurante alle spalle i propri detriti, defluisce in una de-globalizzazione addirittura più barbara.
In tante abbiamo cercato la strada, da donne libere e sempre impreviste, come diceva Carla Lonzi. Ora possiamo. Partiamo da qui.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 -- Lo sciopero dell’8 marzo: «non saremo una di meno» (di Benedetta Verrini)4 marzo 2017, di Federico La Sala
Pianeta Terra. Sull’uscita dallo stato di minorità, oggi......
- CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Lo sciopero dell’8 marzo: «non saremo una di meno»
Dallo storico NiUnaMenos argentino fino alla Women’s March, il movimento delle donne si mobilita per uno sciopero che, in 40 Paesi, porterà, come dice Lea Melandri, una «seconda rivoluzione culturale, a un ’68 delle donne»
di Benedetta Verrini *
- Per conoscere tutti i luoghi e gli appuntamenti: https://nonunadimeno.wordpress.com
«Strabiliata da queste ragazze» dice Lea Melandri, femminista storica, giornalista e fondatrice della Libera Università delle Donne, ammirando le giovani donne che stanno animando e si preparano all’8 marzo più combattivo degli ultimi decenni. Dallo storico NiUnaMenos argentino fino alla Women’s March, che negli States ha visto molte donne riaggregarsi e trovare voce contro l’elezione alla presidenza di Donald Trump, Non Una Di Meno è un movimento femminile nato come un’onda sismica, scatenato dal trauma della violenza sulle donne - fisica, economica, sociale - che accomuna l’Italia a tutti i Paesi del mondo.
Il risultato, in occasione della Festa della Donna, sarà una manifestazione globale, con uno sciopero proclamato in contemporanea in quaranta Paesi per una «seconda rivoluzione culturale, un ’68 delle donne, in cui vedo forza di intenti e contenuti, orgoglio, radicalità, intelligenza» commenta Melandri. «Ho assistito a quarant’anni di femminismo, ma questa generazione è diversa, ha un potenziale inatteso. Sono giovanissime, universitarie e anche liceali, e in molti casi non conoscono molto delle battaglie del femminismo storico, eppure hanno saputo farle proprie con un vigore e una prospettiva completamente nuova. La nostra era stata una battaglia “contro”: contro le generazioni delle nostre madri, contro gli uomini su un terreno privato di sessualità e ruoli. Queste giovani si sono invece riappropriate del femminismo senza cliché, rinnovandolo dall’interno, portando il tema della parità in tutti gli ambiti sociali, dalla salute riproduttiva alla libertà di movimento delle migranti, dalla formazione a un nuovo modello di economia, che ci affranchi da quella forma di “patriarcato” che è il capitalismo».
Per l’8 marzo NonUnaDiMeno ha proposto a tutte le organizzazioni sindacali uno sciopero, sia del settore pubblico che privato. Diverse realtà del sindacalismo di base lo hanno accolto e proclamato formalmente. «Si tratta di uno sciopero di 24 ore perché l’esperienza della violenza si propaga in tutta la giornata di una donna» spiega Simona Ammerata, di NonUnaDiMeno Roma.
 Lo strumento dello sciopero arriva anche alle tante che sperimentano la precarietà lavorativa? «Lo sciopero è internazionale, si svolgerà in 40 diversi Paesi e mette dolorosamente in luce la difficoltà attuale di tante donne che non hanno un rapporto di lavoro stabile, che sono precarie o autonome. Stiamo organizzando delle casse di solidarietà per le precarie che desiderano aderire alla giornata ma non possono permetterselo» aggiunge. «E abbiamo organizzato spazi di nursery e chiesto agli uomini di mettersi a disposizione per accudire i bambini nel tempo in cui le donne saranno in assemblea o in corteo».
Lo strumento dello sciopero arriva anche alle tante che sperimentano la precarietà lavorativa? «Lo sciopero è internazionale, si svolgerà in 40 diversi Paesi e mette dolorosamente in luce la difficoltà attuale di tante donne che non hanno un rapporto di lavoro stabile, che sono precarie o autonome. Stiamo organizzando delle casse di solidarietà per le precarie che desiderano aderire alla giornata ma non possono permetterselo» aggiunge. «E abbiamo organizzato spazi di nursery e chiesto agli uomini di mettersi a disposizione per accudire i bambini nel tempo in cui le donne saranno in assemblea o in corteo».
 Oltre allo sciopero lavorativo, sottolineano le organizzatrici, è possibile aderire anche trovando un momento della giornata per partecipare agli eventi della città, oppure non esercitando, a titolo esemplificativo, una delle tante attività domestiche o di cura che non vengono riconosciute né retribuite.
Oltre allo sciopero lavorativo, sottolineano le organizzatrici, è possibile aderire anche trovando un momento della giornata per partecipare agli eventi della città, oppure non esercitando, a titolo esemplificativo, una delle tante attività domestiche o di cura che non vengono riconosciute né retribuite.La manifestazione dell’8 marzo arriva dopo un cammino durato circa otto mesi, con un’assemblea a Bologna in cui, i primi di febbraio, oltre duemila donne hanno sviluppato diversi tavoli di discussione: dal tema della violenza di genere a quello della salute riproduttiva, dal gender pay gap alla formazione. Per l’8 marzo, queste elaborazioni sono culminate in otto punti di discussione. «L’obiettivo è stato quello di impegnarsi a elaborare un Piano femminista antiviolenza che racchiuda ogni aspetto della vita di una donna» conclude Ammerata. «Come dicevo, il tema della violenza è trasversale: è troppo facile, anche sul piano politico, affrontarlo in modo settoriale».
«Le donne affrontano la violenza maschile in ogni momento e in ogni situazione: dai banchi di scuola alle pareti di casa, dal luogo di lavoro a quel luogo virtuale che sono i social» aggiunge Carlotta Cossutta, del Collettivo Ambrosia e di NonUnaDiMeno Milano. «Stiamo mettendo tutte le nostre energie, intelligenze, passione a cambiare per sempre questa situazione, in ogni contesto e in tutti i Paesi del mondo. Non siamo sole, la nostra rete è già attraversata da molti uomini che condividono questa battaglia: ciò che domandiamo loro è di mettersi in ascolto e appoggiare il cambiamento”.
L’8 marzo sono previsti presidi, mobilitazioni, flash mob in tante città italiane, con una convergenza oraria dei cortei intorno alle ore 18. A Roma il corteo inizia invece alle ore 17, appuntamento al Colosseo. La Casa delle Donne di Milano organizza, con il patrocinio del Comune, una performance artistica presso l’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele: a partire dalle 15 sarà realizzato un gigantesco Mandala a rappresentare un momento di meditazione, condivisione, aggregazione femminile.
Per conoscere tutti i luoghi e gli appuntamenti: https://nonunadimeno.wordpress.com
- CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. - di Federico La Sala14 febbraio 2017, di Federico La Sala
- STORIA D’ITALIA. STATO E CHIESA .... E STORIA DELLE DONNE.
 I PATTI LATERANENSI, MADDALENA SANTORO, E LA PROVVIDENZA.
I PATTI LATERANENSI, MADDALENA SANTORO, E LA PROVVIDENZA.
- MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
L’invisibilità delle donne
di Chiara Saraceno (Il Mulino, 13 febbraio 2017)
Quando le mie figlie avevano cinque anni mi chiesero di aiutarle a scrivere una lettera alla Rai perché si erano accorte che «al telegiornale parlano solo uomini e nei cartoni le donne o sono cattive o devono essere salvate da un uomo». A quasi quarant’anni di distanza le cose non sembrano cambiate di molto, nonostante oggi ci siano molte più giornaliste, anche nei telegiornali. L’ultimo esempio viene dall’iniziativa di un grande giornale nazionale.
Per festeggiare i propri 150 anni «La Stampa» ha chiesto a 51 «personalità di rilievo internazionale» di scrivere come vedono il futuro.
La prima cosa che balza all’occhio è che tra questi magnifici 51 solo quattro sono donne: le «ovvie» Angela Merkel e Hillary Clinton più Lindsey Vonn e Bebe Vio, due politiche e due sportive. Punto. Nessuna giornalista, scrittrice, economista, filosofa, scienziata, imprenditrice.
È normale che la scelta di chi selezionare per questo compito sia largamente discrezionale e guidata da criteri di notorietà. Meno normale è che ancora nel 2017, quando si individua tra «le personalità» cui vale la pena dar voce su come va o dovrebbe andare il mondo, si «vedano» pressoché solo uomini. Come se nulla fosse mutato in questi anni, come se le donne, salvo qualche rara eccezione, fossero sempre e solo in cucina o a fare i bassi servizi o la spalla a uomini potenti. Come se non avessero nulla da dire su questo mondo che, questo sì, è ancora troppo governato da uomini, con risultati certamente non ottimi.
Me lo ha fatto rilevare indignata una mamma che avrebbe voluto utilizzare l’inserto per parlarne con i suoi bambini, un maschio e una femmina, e si rifiuta di proporre loro una immagine in cui quasi solo uomini sono presentati come importanti, e perciò degni di ascolto. Eppure non mancano donne «di rilievo internazionale» che potrebbero dire e dicono cose interessanti su molti aspetti del presente e del futuro: da Fabiola Gianotti ed Elena Cattaneo per la scienza, a Martha Nussbaum e Seyla Benhabib per la filosofia e la politologia, Christine Lagarde, Melania Mazzuccato e Loretta Napoleoni per l’economia, Svetlana Aleksievic e Alice Munro per la letteratura, Marissa Mayer e Sheryl Sandberg per il settore del digitale, Inge Feltrinelli per l’editoria - per fare solo alcuni nomi ovvi. Ma la lista sarebbe lunga.
Non si tratta di un banale infortunio. Piuttosto è la dimostrazione di quanto persista nel nostro Paese l’invisibilità delle donne nella scena pubblica quando si tratta di fornire analisi e dare opinioni. Chi controlla la comunicazione e quindi contribuisce alla narrazione e all’immagine della società è ancora in larga misura di sesso maschile. Anche se il 48% dei conduttori dei Tg in prima serata è donna, come documenta l’ultimo rapporto dell’Osservatorio di Pavia, le direttrici delle news si contano sulla punta delle dita e così le conduttrici di talk show non di intrattenimento. E uno dei ruoli in cui le donne sono meno visibili è proprio quello degli opinionisti, nonché dei portavoce di associazioni e partiti. Ad esempio, il 30% di donne in Parlamento scende al 17% di presenza in televisione. La figura dell’esperto resta un appannaggio quasi esclusivamente maschile. Solo come vittime o come rappresentanti dell’«opinione comune» (la «casalinga di Voghera») le donne trovano ampio spazio nella narrazione pubblica e in pubblico: sono il 51% fra le persone interpellate come voce dell’opinione popolare, il 45% dei narratori di esperienze personali, il 42% dei testimoni di eventi, e appaiono come vittime più del doppio degli uomini (16% rispetto al 7% degli uomini, nei Tg).
Va detto che l’Italia è in buona compagnia. Secondo i dati dell’Osservatorio di Pavia anche in Inghilterra, Francia e Germania le cose non vanno molto bene, ma stanno migliorando più in fretta che in Italia, dove la situazione sembra invece in stallo. Del resto, è passato del tutto sotto silenzio il fatto che l’AgCom, che dovrebbe controllare la correttezza dell’informazione, è composta esclusivamente da uomini. Difficile che si accorgano dello squilibrio di genere non solo in chi comunica ciò che avviene in società, ma in che cosa è comunicato.
Del resto, anche tra gli studiosi le cose non vanno molto meglio. Nell’Accademia dei Lincei le donne sono pochissime ed entrano con il contagocce. Non molto diversa la situazione nelle Accademie delle Scienze. Quando di tratta di riconoscere il merito e la qualità della ricerca, i guardiani dei cancelli sono sempre singolarmente ciechi rispetto al genere. Non perché non ne tengano conto, ma perché vedono quasi solo il proprio.
Per quella mamma indignata, come per me quarant’anni fa, la strada per comunicare ai suoi figli una visione diversa delle donne è ancora molto in salita.
- STORIA D’ITALIA. STATO E CHIESA .... E STORIA DELLE DONNE.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO --- SOLIDARIETÀ: ONE BILLION RISING DEL 14 FEBBRAIO 2017! (#riseinsolidarity #1billionrising)12 febbraio 2017, di Federico La Sala
SCOPRI LE ASSOCIAZIONI CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO ONE BILLION RISING DEL 14 FEBBRAIO 2017!
Il 14 febbraio si avvicina e sarà una giornata che vedrà gli attivisti One Billion Rising ancora una volta affermare, sulle note di “Break The Chain”, il proprio NO alla violenza su donne e bambine e l’urgenza di una rivoluzione che scardini mentalità e pratiche basate su abuso, omertà e sopraffazione.
Ci stiamo muovendo verso una presa di coscienza collettiva che ci auguriamo porti nuovi risultati a fronte di un’emergenza che non può essere rinviata oltre, a livello globale e locale.
Quest’anno la parola d’ordine di One Billion Rising è SOLIDARIETÀ: solidarietà contro lo sfruttamento delle donne, solidarietà contro il razzismo e il sessismo ancora presente in tutto il mondo. Infatti non c’è nulla di più potente della solidarietà globale, perché questa ci fa sentire più al sicuro nell’esprimere quello che pensiamo e ci dà più coraggio nell’intraprendere quello che ci impegniamo a fare. L’obiettivo diventa quindi ottenere l’attenzione, il coinvolgimento e l’impegno delle istituzioni affinché attuino forme di prevenzione e controllo oltre che politiche sociali ed educative per contrastare il fenomeno della violenza in ogni sua declinazione.
Ancora quest’anno, alla sua quinta edizione, il 14 Febbraio diventa una giornata che One Billion Rising e le sue sostenitrici e sostenitori dedicano ad un impegno concreto per raggiungere questo obiettivo e il tuo sostegno è fondamentale .. più siamo, meglio è!
Alcune associazioni in diverse città italiane hanno iniziato ad organizzarsi. Puoi unirti a loro o scegliere di partecipare insieme ad un gruppo di persone!
Cosa puoi fare? Qui trovi l’elenco, in costante aggiornamento, degli eventi che avranno luogo nella giornata del 14 febbraio (o nei giorni prima o dopo). Clicca sui vari link per sapere cosa fanno, dove e quando e, perché no, unisciti a noi, diffondi la notizia o crea il tuo evento! Qui scopri le linee guida per aiutarti a realizzarne uno: http://bit.ly/partecipa_a_OBR2017 e per ogni necessità puoi contattarci all’indirizzo email obritalia@gmail.com .
ASCOLTA! AGISCI! PARTECIPA!
Ti aspettiamo per danzare insieme contro la violenza sulle donne!
ELENCO ASSOCIAZIONI/GRUPPI CHE ORGANIZZERANNO EVENTI IL 14 FEBBRAIO (in continuo aggiornamento)
*
Il Coordinamento One Billion Rising Italia
Nicoletta B., Nicoletta C., Silvia, Elena
http://www.onebillionrising.org/
https://www.facebook.com/obritalia
http://onebillionrisingitalia.tumblr.com/
email: obritalia@gmail.com
twitter: @OBRItalia
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- MADDALENA SANTORO, ARNALDO MUSSOLINI, E I LIBRI DI STORIA.24 gennaio 2017, di Federico La Sala
:
SU ***NAZIONE INDIANA*** sotto il titolo di "Infanzia salentina" è stato ripreso il primo capitolo di un libro di grande interesse: Nicola Fanizza, Maddalena Santoro e Arnaldo Mussolini. La storia d’amore che il duce voleva cancellare, Ediziioni Dal Sud, Bari 2016.
NON è CHE L’INIZIO! BENE! CONTINUARE LA LETTURA!!! E non fermarsi al primo "libro"! Il "carteggio" della seconda parte (pp. 109-154), è un altro "libro": le 32 lettere che Maddalena Santoro, invia, dal 1919 al 1938, all’amica di Mola di Bari, Caterina Tanzarella, sono dei documenti storici di grande rilevanza, per sapere di più e meglio sia di questa donna salentina, intellettuale e scrittrice, fedele a se stessa e alla sua amica (e alla sua famiglia), sia del fratello del Duce, "il fratello di un Grande Fratello" (che, se "preferì restare nell’ombra", come scrive Indro Montanelli nel novembre del 2000 - cfr. "Il fascino di Arnaldo Mussolini": http://www.corriere.it/solferino/montanelli/00-11-09/01.spm, non per questo deve continuare a restarvi).
Il coraggioso e originale lavoro di Fanizza, sia per la qualità della sua scrittura sia della sua preziosa documentazione storica sulla "storia d’amore che il duce voleva cancellare", è una formidabile occasione per riprendere una "vecchia" indicazione di Luisa Passerini(in una sua relazione nel convegno a Bologna nel 1993, su "Il regime fascista. Bilancio e prospettive di studio"): "coniugare la tradizione della storiografia antifascista sul fascismo con gli studi storici che adottano le categorie di genere e di generazione" e superare definitivamente la obsoleta prospettiva storiografica che voleva e vuole ancora "le questioni di genere e la storia delle donne come questioni separate e secondarie o come questioni che hanno a che fare più col sociale che col politico"(cfr.: AA.VV, "Il regime fascista. Storia e storiografia", a c. di Angelo Del Boca, Massimo Legnani e Mario G. Rossi, Laterza, Bari 1995, pp. 498-506). E riguardare l’intera storia della società (e dell’umanità intera!) con due occhi, non con un occhio solo!
DA NOTARE che in quello stesso Convegno (e si riconsideri il titolo e il tema) una - e dicesi: una! - sola volta è citato Arnaldo Mussolini e solo per problemi relativi al "connubio tra affari e politica" (op. cit., p. 133), e una e una sola volta (e proprio da Luisa Passerini) è citata Rosa Maltoni (p. 504), la madre sua e del "Grande Fratello", oggetto di "un culto molto ampio" durante il fascismo...
Federico La Sala
Una Risposta a Bertolt Brecht, l’intellettuale nell’epoca del mercato *
BRECHT E IL RITORNELLO DEI “TUI” DI IERI E DI OGGI. «Abbiamo appena salvato la cultura» ...
 «Un vecchio riccone muore, soffrendo per la miseria del mondo nel testamento lascia una grossa somma per la fondazione di un istituto che studi la causa di questa miseria. La causa è ovviamente il vecchio riccone stesso» (B. Brecht).
«Un vecchio riccone muore, soffrendo per la miseria del mondo nel testamento lascia una grossa somma per la fondazione di un istituto che studi la causa di questa miseria. La causa è ovviamente il vecchio riccone stesso» (B. Brecht).IN OMAGGIO A “L’ORMA”, A FRANCESCO FIORENTINO, E AD “ALFABETA2”, CONTRO UN MONDO CONCEPITO COME “IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE” DEL *MACROANTROPO* (“UOMO SUPREMO”, “SUPERUOMO”, “DOMINUS IESUS”), CON TUTTA LA SUA FILOSOFIA, TEOLOGIA POLITICA, E “ANDRO-PO-LOGIA” ATEA E DEVOTA.... ho ripreso in collegamento con LA RISATA DI KANT (si cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028) la brillante recensione di Fiorentino e sottolineato con alcune note (si cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5028#forum3119870) l’importanza del discorso di Brecht sul ritornello dei “TUI” di ieri e di oggi.
Federico La Sala (Alfabeta2, 15 gennaio 2017).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- ‘La morte nera’, Walter Benjamin, e il fascista che è in noi (Iside Gjergji).12 gennaio 2017, di Federico La Sala
Psicoanalisi, Storia e Politica....
- L’ITALIA, IL VECCHIO E NUOVO FASCISMO, E "LA FRECCIA FERMA". La lezione sorprendente e preveggente di Elvio Fachinelli
- FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
‘La morte nera’ e il fascista che è in noi
di Iside Gjergji *
Il recente libro di Fabrizio Denunzio, La morte nera. La teoria del fascismo di Walter Benjamin (Ombre Corte 2016) è uno dei testi più interessanti pubblicati in Italia nel 2016. L’opera prosegue e, forse, conclude una elegante e seducente lettura di Walter Benjamin, già avviata da Denunzio con L’uomo nella radio. Organizzazione e produzione della cultura in Walter Benjamin (Giulio Perrone 2012) e, prima ancora, con Quando il cinema si fa politica. Saggi su “L’opera d’arte” di Walter Benjamin (Ombre Corte 2010).
Il libro tratta un tema attuale - il fascismo - e lo fa attraverso le parole e i silenzi del filosofo berlinese. La morte nera non è solo un testo di critica e, senza dubbio, non è uno di quei lavori che - come va di moda - si accaniscono sul “corpo” di un autore, nella speranza di ricavarne un lembo, al fine di assicurarsi un posto nella koinè culturale che conta.
Al contrario, il testo ha un obiettivo ambizioso: vuole realizzare uno schizzo multidimensionale del fascismo, vuole mostrare il suo cuore segreto, ancora palpitante, per farci sentire anche nella vigna dei testi il suono inquietante del “duro metallo della violenza” (Baudelaire). Obiettivo riuscito.
Inoltre, come si può intuire già dal titolo (per gli amanti di Guerre stellari, la Morte Nera è l’arma potente e segreta dell’Impero, che, da sola, può annientare interi pianeti, cosi come “Morte Nera” è l’espressione con la quale si definisce la peste che sterminò più di un terzo della popolazione europea nel XIV secolo), il lavoro ha un carattere ibrido. Vi si trova la critica più rigorosa attraversata da intuizioni, collegamenti storici e biografici, rimandi a frammenti letterari, epistolari, trasmissioni radiofoniche e film.
Nella prima parte si svolge come una sceneggiatura in tre atti (fasi), denominata “Il fascismo”, il cui prequel, nella seconda parte, è dedicato a “Il fascista”.
Ma andiamo con ordine. Denunzio, come anticipato, individua tre fasi nello sviluppo del pensiero benjaminiano sul fascismo. Nel periodo compreso tra il 1924 e il 1930, Benjamin pensa a un modello di fascismo a partire da una analisi “giornalistico-informativa”, anche come diretta conseguenza del suo girovagare in Europa.
La sua attenzione è catturata pressoché interamente dalla figura del “duce”. L’autore coglie in questa fase lo sguardo critico di Benjamin sull’Illuminismo e la sua conseguente spiegazione della legittimazione popolare del “duce” attraverso il conflitto tra ragione e religione. Il collegamento è da ricercare nel “vuoto che si viene a creare quando la ragione abolisce ogni collegamento con la trascendenza”, creando spazio a “personaggi che, contrabbandando un soprannaturale di scarto, [...] vengono investiti di un potere che sicuramente useranno contro quanti gliel’hanno conferito” (p. 34).
 La soggettività a cui Benjamin pensa in questo periodo non coincide con l’uomo razionale, ma con l’uomo religioso, capace di esperire la trascendenza.
La soggettività a cui Benjamin pensa in questo periodo non coincide con l’uomo razionale, ma con l’uomo religioso, capace di esperire la trascendenza.La seconda fase, secondo l’autore, coincide con gli anni 1934-36 e si caratterizza per l’approccio “politico-combattente” del filosofo. Benjamin perviene, infatti, a un modello di fascismo fondato su elementi strutturali, tenendo conto della composizione delle classi e delle strategie di dominazione del capitalismo. È in questo passaggio che il filosofo tedesco accantona la coppia concettuale “ragione-religione” e abbraccia un’altra, anch’essa oppositiva, ovvero “natura-tecnica”.
La riflessione più matura sull’Illuminismo e sulla modernità spinge Benjamin a pensare un rapporto inedito tra natura e tecnica, in quanto egli riesce a immaginare la tecnica “liberata dal fine strumentale di dominare la natura e finalmente impiegata per fare giocare e divertire gli uomini” (p. 63).
 La soggettività dominante nel pensiero benjaminiano di questa fase non è l’individuo, ma la classe lavoratrice. È il lavoro a mediare le relazioni e, di conseguenza, la trascendenza finisce in secondo piano (senza però scomparire del tutto) per lasciare maggiore spazio alla Ragione.
La soggettività dominante nel pensiero benjaminiano di questa fase non è l’individuo, ma la classe lavoratrice. È il lavoro a mediare le relazioni e, di conseguenza, la trascendenza finisce in secondo piano (senza però scomparire del tutto) per lasciare maggiore spazio alla Ragione.L’ultimo e terzo atto della sceneggiatura denunziana sulla teoria del fascismo di Benjamin si consuma nel 1940, che è anche l’ultimo anno di vita del filosofo, ormai esule e solitario nelle strade d’Europa, nelle quali imperversa la “follia”. Il modello di fascismo delineato in questa fase conserva il nesso struttura/sovrastruttura sviluppato nelle fasi precedenti, ma questa volta l’elemento (strutturale) economico trova un perfetto rispecchiamento nella sovrastruttura ideologica del fascismo: “La conservazione millenaria della prima si rispecchia fedelmente nell’eternità della seconda” (pp. 72-73). Benjamin perviene così a una riflessione sul tempo nella modernità, sui momenti temporali dell’eternità e dell’istante.
La chiave di lettura dell’intera sceneggiatura è, però, nascosta nel prequel, ovvero nella seconda parte del libro, laddove Denunzio, in modo raffinato, sviluppa un’analisi sociologica e psicoanalitica, setacciando il tempo, la vita e le parole del filosofo tedesco, a caccia di lapsus, di non detti e del rimosso. È nella seconda parte, infatti, che le parole e i silenzi abitano corpi che ci consentono di interpretare e comprendere comportamenti, testi, dottrine ed eventi narrati nella prima parte. E nondimeno ci consegnano un ritratto completo di Benjamin, con le sue luci e le sue (non poche) ombre nere. Qui il fascismo diventa una silhouette autoritaria e tirannica, una presenza che si produce in fasi storiche e passaggi biografici caratterizzati da “vuoti” di autorità e che si manifesta sotto molteplici sembianze: padri sostituivi con simpatie naziste, personaggi letterari che evocano tiranni, poeti vicini alle SS.
L’autore sottolinea, dunque, quanto già evidenziato dalla migliore tradizione della Scuola di Francoforte, ovvero l’imprescindibilità della teoria freudiana nella comprensione del fascismo come fenomeno sociale, in quanto pone l’urgenza di comprendere, accanto a tutto il resto, anche i condizionamenti e le tirannie interne (IL fascista interno) al soggetto. Curiosamente, però, Fabrizio Denunzio attribuisce l’ulteriore sviluppo di tale riflessione, nella seconda metà del Novecento, ad alcuni illustri autori francesi, quali Foucault, Deleuze, Guattari, i quali notoriamente si sono ispirati a pensatori come C. Schmidt, Nietzsche e Heidegger, tutti, almeno a parere di chi scrive, reazionari, anti-dialettici e immersi nel tunnel dell’irrazionale. La lotta contro i residui del “fascista” (morte nera) dentro di noi, a quanto pare, non può mai dirsi conclusa. Che la Forza sia con noi!
*
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO - "La morte nera. La teoria del fascismo di Walter Benjamin" (Fabrizio Denunzio)11 gennaio 2017, di Federico La Sala
- Sul concetto di presente storico. Note per le "Tesi" di W. Benjamin (cfr. pdf allegato).
- LA RINASCENZA DEL SOGGETTO. SULLE TRACCE DI BENJAMIN, AL DI LA’ DELL’EDIPO.
Walter Benjamin, l’inquilino in nero
di Massimo Palma (alfapiù, 11 gennaio 2017)
- Fabrizio Denunzio, La morte nera. La teoria del fascismo di Walter Benjamin, ombre corte, 2016, 119 pp., € 10
A Fabrizio Denunzio la taccia di eresia non importa. Collocarsi al di fuori di ogni corrente degli studi su Benjamin è in sé un merito, dati i successi di questo loser nelle mode filosofiche, editoriali e culturali di questi anni.
L’angolatura è originale - evidente sin da Quando il cinema si fa politica (2010). Ancor più nella Morte nera. Lo stile è assertorio, didascalico, deduttivo. Denunzio avvicina testi notissimi come fosse la prima volta, li incrocia con frammenti poco visitati e propone un mash up che costringe immancabilmente a leggerlo due volte: quando affianca al celebre saggio su Kraus la poco nota recensione di Haecker, la chiosa è cristallina: «non volendo essere affatto raffinati, anzi, volendo peccare di rozzezza». Lo stesso accade quando impiega concetti inventati con indubbia capacità plastica (l’Illuminismo «compresso»), quasi fossero concetti benjaminiani. In più, Denunzio incrocia temi forti: l’arte politica, l’uso della radio.
Brillante, oggi, la scelta di affrontare una variante della Germania segreta, lemma che Benjamin mutua da Stefan George (chissà perché assente nel libro), e delle tante letture dell’intima affinità tra l’Intelligenz tedesca e le idee naziste, che da Kantorowicz e Lukács a Jesi e Lacoue-Labarthe, hanno attraversato l’incompiuta seduta di autocoscienza europea.
Qui si tocca un capitolo inedito: Benjamin e il fascismo. Fascismo che, ben mostra Denunzio, Benjamin ha visto di persona - nel 1924, nel mitico viaggio a Capri, vede Mussolini, restando colpito da una fisicità goffa e inarticolata -, ha intervistato nella sua versione francese (Georges Valois), ha recensito nella sua variante tedesca prenazionalsocialista (il libro di Ernst Jünger e soci, stroncato nel 1930), per poi farne un oggetto teorico, sicuramente avversario, ma - questa la tesi dirompente - altresì abitante nel corpo biografico e nell’armamentario teorico benjaminiano.
Non solo, quindi, Benjamin studia, avversa e teorizza il fascismo, ma Benjamin ha un fascista dentro di sé: nel senso pasoliniano, deleuziano, che è sempre il caso di riattivare. E Denunzio si cimenta con zelo sull’ipotesi di un Benjamin abitato. Lo mostrerebbero ricordi infantili sedimentati nella Cronaca berlinese, il rapporto negli anni Dieci con Gustav Wyneken, «guida» autoritaria e guerrafondaia del Movimento giovanile, ma anche il ruolo del tiranno nello studio sul barocco tedesco, la cui coincidenza con la «visione» di Capri viene usata come detonatore onniesplicativo, la lettura di Kafka e dei suoi funzionari sadici.
Che i due punti biografici (il padre e Wyneken) ricorrano teoricamente in chiave psicanalitica in due dei suoi scritti maggiori è assunto problematico, ma va a sostanziare la tesi di un inquilino imprevisto nel Benjamin teoreta del fascismo: Benjamin fascista.
Esattamente questo afferma Denunzio: «la coerenza sistemica della teoria del fascismo benjaminiana può essere assicurata solo postulando che il suo autore si sia profondamente identificato con esso. Dal momento che non si può dare fascismo senza l’uomo fascista, allora, la validità di questa teoria di Benjamin sta nel fatto che ad averla pensata è il fascista che lo abitava, ma che, per fortuna, non lo possedeva».
Questo postulato d’inizio libro resta tale. Tutto lo studio ne consegue. Questa premessa-conclusione - «il fascismo intrapsichico di Benjamin», il «padre compensativo interiorizzato da Benjamin per rispondere alla crisi d’autorità paterna: guerrafondaio, criminale e sadico» - si dirama, serpe in seno al lettore, in parallelo alla formula dell’«ebreo comunista esule e perseguitato» che, assieme all’intellettuale antifascista precario declassato non-accademico, classifica WB nel casellario vittimario. Paria come tanti.
Eppure, tale premessa-conclusione per esser presa sul serio deve celare una sottaciuta rilettura del concetto di immedesimazione o empatia, che Benjamin individua come una dannazione operativa della storiografia e della «tecnica» artistica in generale e che legge in questi termini sin dall’Origine del dramma barocco tedesco, per demolirlo nella tesi VII Sul concetto di storia come funzione «fascista» della scrittura.
Ma il libro sul barocco viene ignorato da Denunzio fin quasi alla fine: non lo menziona riguardo alla ricostruzione iper-cattolica, à la Schmitt, della «filosofia» del primo Benjamin (schiacciato sul Programma della filosofia futura e definito «non rassegnato a vivere in un mondo senza dei e trascendenza»), ma solo per affrontare il tiranno. E certo, nel momento in cui si affronta la teoria della storia di Benjamin, la decostruzione dell’Einfühlung deve emergere, perché è una decostruzione politica che modula il concetto anti-fascista di storia che Benjamin lascia ai posteri.
Dobbiamo quindi supporre che Denunzio la dia per scontata, nel momento in cui la sua tesi verte sul consentire col fascismo e sull’identificazione di Benjamin nel capo fascista («Benjamin si trova ad aver interiorizzato proprio una figura di Capo di questo tipo»). Un’immedesimazione il cui precipitato, nel critico che usa fonti tedesche già compromesse col regime, è esposto senza infingimenti: «li si disponga tutti assieme in un’unica immagine, i Kommerell, gli Obenauer e gli Schmitt, a mo’ di foto dell’epoca, semmai con tanto di divise e di fasce al braccio, e si vedrà in tutta la sua crudezza una costante dell’atteggiamento di Benjamin nei confronti di questi gerarchi del sapere fascista idealmente fotografati: la complicità».
Crudo, insinuante, il libro di Denunzio usa una bibliografia parca ed equilibrata (undici titoli di Benjamin, undici di Denunzio, articoli di giornale inclusi, poi altri diciotto testi, poi basta), ed è pieno di intuizioni. Eppure, il tessuto argomentativo rapido, apodittico, oltre al fuoco del libro, lascia colare anche omissioni (dov’è Georges Sorel, menzionato di corsa in un libro sul fascismo e Benjamin?, dove Bachofen?), inutili parafrasi di Habermas (utilizzato a piene mani in un excursus per un riassuntino di storia della filosofia), slalom speciali su temi-chiave: dell’empatia si è detto, ma si pensi al concetto fascista di natura, sfiorato e mai analizzato, ma centralissimo proprio nelle Teorie del fascismo tedesco e possibile volano per sfuggire alla rilettura proposta, iper-francofortese, del bivalente illuminismo benjaminiano; si pensi infine a come, figlio dell’alta borghesia ebraica assimilata, Benjamin della borghesia ha marxianamente mostrato l’ambigua, contraddittoria grandezza.
Restano gli affondo, la profondità abissale del tema, la libertà di ricerca esibita, ma anche l’incedere di un libro pesantissimo che vola da un fiore all’altro dell’orto benjaminiano, decontestualizzando un singolo riferimento epistolare del 1924, un passo di diario del 1938 e passaggi di opere complesse (decenni di ricezione non solo «idealista» né «teologico-politica» sarebbero lì a testimoniarlo), per attribuire all’autore l’inconscia «richiesta di uno Stato forte» e un «desiderio» di fascismo», senza dialogare con alcuno se non i suoi testi.
In questa sua singolare forma anti-scientifica, l’intenzione davvero profonda che abita il saggio, e forse lo possiede, risulta difficilmente comprensibile al di fuori del moto d’identificazione spiegato nelle Memorie di famiglia dell’Introduzione (il lignaggio fascista dell’autore, naturalmente ripudiato). Un tratto, questo, che rende sì il testo una ricerca di antidoti, ma anche una requisitoria senza contraddittorio, perché in sostanza autoaccusa. Raccolta di intuizioni talora lancinanti, La morte nera è un libro da integrare, argomentare, arredare, senz’altro abitare col rigore necessario. Per poi magari espropriarlo di ogni immedesimazione.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO - Marx e Kierkegaard giornalisti (di Fabrizio Denunzio)11 gennaio 2017, di Federico La Sala
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
Marx e Kierkegaard giornalisti
di Fabrizio Denunzio (DoppioZero, 21 giugno 2016)
Cosa hanno in comune due autori così radicalmente diversi come Karl Marx e Søren Kierkegaard? Cosa accomuna il padre del comunismo a quello dell’esistenzialismo? In cosa convergono filosofie che hanno come protagonisti agenti sociali antitetici come quello oggettivo, massificato del proletariato industriale e quello soggettivo, isolato del credente cristiano?
Un’autorevole risposta la troviamo in un classico del pensiero filosofico, Da Hegel a Nietzsche (1941) di Karl Löwith. A parere dell’autore il terreno comune su cui si fondano le riflessioni di Marx e di Kierkegaard è rappresentato dal comune nemico contro cui entrambi combattono: Hegel. Lì dove quest’ultimo, dovendo legittimare lo Stato prussiano, spinge ad accettare la realtà esistente sostenendone l’intrinseca razionalità, di conseguenza mettendo fuori gioco la dialettica oppositiva che anima il conflitto sociale, Marx e Kierkegaard insorgono, di fronte a questa conciliazione reazionaria tornano a separare proprio ciò che Hegel ha unito: la ragione dalla realtà. Lì dove Hegel assicura unità e saldezza al mondo borghese, capitalista e cristiano, tanto Marx, per ciò che riguarda il sistema di produzione, quanto Kierkegaard, per ciò che concerne il sistema della credenza, provvedono a dissolverlo. Il primo con la rivoluzione comunista, il secondo con un profondo rinnovamento della cristianità.
All’autorevole risposta di Löwith ne vogliamo affiancare un’altra, non filosofica ma di ordine comunicativo in grado questa di farci sentire tutta l’attualità di questi autori, un’attualità che spesso, purtroppo, la sola filosofia non riesce a evidenziare in tutta la sua potenza. Ciò che a nostro parere hanno in comune Marx e Kierkegaard è l’aver assistito e l’essere stati travolti dalla nascente industria culturale del loro tempo incarnata dal giornalismo.
Come nel caso di Marx è possibile ripercorrere oggi una significativa parte della sua produzione giornalistica attraverso Dal nostro corrispondente a Londra. Karl Marx giornalista per la New York Daily Tribune (traduzione e cura di G. Vintaloro, Corpo60, ebook, euro 6,99), così anche in quello di Kierkegaard è possibile fare un’operazione del genere grazie ai suoi Scritti sulla comunicazione (a cura di Cornelio Fabbro, pp. 363, euro 25) ripubblicati di recente dalla casa editrice Orthotes.
Il volume, sebbene non raccolga gli articoli scritti dal 1854 al 1855 per il giornale “La Patria”, e debitamente sottratto a una mera lettura specialistica, ci permette di ricostruire nelle sue linee generali il rapporto di Kierkegaard con la stampa: dallo sgomento provato di fronte alla standardizzazione della lettura, quindi alla trasformazione della massa in pubblico prodotta dall’avvento delle testate giornalistiche, alla sua risposta operativa in termini di strategia comunicativa.
Volendo riportare tanto la reazione emotiva quanto la sua corrispondente elaborazione razionale alle teorie sociali del Novecento, diremo che la prima verrà confermata dalla visione apocalittica dell’industria culturale elaborata dalla Scuola di Francoforte, mentre la seconda echeggerà nella concezione del giornalismo di Gramsci. Partiamo dallo sgomento.
L’esistenza della stampa impone un cambiamento di funzione allo scrittore. Dal momento che essa per vivere ha bisogno di una significativa quantità di lettori, il contenuto e la qualità della scrittura si abbassano notevolmente: la prosa giornalistica si caratterizza per astrattezza, impersonalità e superficialità. Questa omologazione verso il basso ha come conseguenza più negativa quella di imporre allo scrittore che non è giornalista, ma che, a suo pari, ha la necessità di essere letto, di adeguarsi allo stato di cose esistenti soprattutto perché, oramai, il pubblico, educato alla lettura secondo le modalità della stampa, si intestardisce nel volere quel tipo di ‘letteratura’. Lo sgomento di Kierkegaard, allora, sta nel fatto che la “letteratura giornalistica abbandona la critica e scrive per la massa”, per la folla, ossia, per “la falsità”.
Sebbene apocalittico, questo sgomento non solo non è estraneo alla storia della cultura - Raymond Williams in Cultura e rivoluzione industria culturale (1958) ha magistralmente dimostrato quanto in realtà esso fosse tipico tra scrittori e poeti inglesi dell’Ottocento e quanto fosse indicativo della loro reazione di fronte all’industrializzazione del mondo sociale - ma ha anche una sua certa lucidità. Permette, ad esempio, guardando attentamente nella sua filigrana, di individuare, allo stato nascente, tratti fondanti dell’industria culturale: “l’interesse finanziario dell’editore”; il “non parlare ad un singolo o a singoli uomini, ma al mondo intero”; “si stampa sempre più in fretta”; “la potenza del momento e la potenza della diffusione”. Capitale culturale, pubblico di massa, alta velocità dei consumi, moda e grande distribuzione. Come dicevamo, quello di Kierkegaard è uno sgomento molto produttivo per capire il momento genetico dell’industria culturale, quei suoi elementi fondativi che, diversamente dosati, continuano ancora oggi a organizzarne il funzionamento.
La cosa molto interessante del filosofo danese è che non lascia questo sgomento a se stesso. Consapevole dello stato in cui si trova la scrittura in seguito all’avvento della stampa, quindi informato dei nuovi termini in cui si configura il rapporto autore/pubblico, decide di elaborarlo razionalmente: “chiunque debba attuare qualcosa, deve conoscere il suo tempo - e così avere il coraggio di affrontare il pericolo d’impiegare il mezzo più sicuro”.
Affrontare il problema del pubblico nell’era del giornalismo, che non sarebbe altro da quello della falsità della folla, significa porre la questione della verità. Anche in questo caso Kierkegaard si ritrova con Marx: infatti il ‘moro’ nel corso della sua attività giornalistica, tanto alla “Gazzetta renana” (1842-1843) quanto alla “New York Daily Tribune” (1852-1861), non aveva fatto altro che praticare un modello di giornalismo animato dal dire la verità che, nel suo caso, significava fare prendere coscienza ai dominati della loro condizione e ribaltarla. Come Marx collegava il suo dire la verità alla critica del sistema produttivo capitalistico, così Kierkegaard la connette a quella della cristianità del suo tempo, con una differenza sostanziale, ammette come possibile l’inganno: “Si può ingannare un uomo per la verità e si può ingannarlo, come faceva il vecchio Socrate, per portarlo alla verità. In fondo non c’è che un modo per portare alla verità un uomo, ch’è preda della fantasticheria: ingannandolo”.
Con una spregiudicatezza inaudita Kierkegaard, fermo nella convinzione che nulla sia più difficile dello scardinare un uomo dalle illusioni in cui vive e che nulla paghi di meno di un attacco frontale a questo mondo illusorio, pratica un modello del dire la verità che fa sue le potenze dell’inganno. Ai simulacri della cristianità in cui crede la folla, Kierkegaard non oppone una verità superiore, tutt’altro, pensa di poterli rovesciare solo con la forza di altri simulacri, per questo motivo, sceso sul mercato editoriale, fa ricorso a una serie infinita di pseudonimi: Victor Eremita, Johannes de Silentio, Frater Taciturnus e così via. Ciò che l’autore si ripromette da un modello di verità di questo tipo, perseguito con il mascheramento, è di collocarsi “esattamente” nel “posto dove si trova l’altro” e, proprio come in seguito farà Gramsci con le nozioni popolari del senso comune (da qui l’affinità tra i due), iniziare a lavorare dall’interno della situazione illusoria per dissolverne, diciamo così, l’illusorietà, in modo tale da “condurlo”, l’altro, “dove ti trovi tu”, che nel caso di Kierkegaard vuol dire in un cristianesimo radicale.
Se in Marx la critica dell’economia politica presuppone la critica dell’ideologia della classe dominante nelle forme (anche giornalistiche) della presa di coscienza, in Kierkegaard la critica della cristianità istituzionale si basa a sua volta su una critica della falsità portata avanti con la forza (anche giornalistica) del simulacro.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- MILEVA MARIC E ALBERT EINSTEIN. L’universo a cavallo di un raggio di luce.12 dicembre 2016, di Federico La Sala
ALBERT EINSTEIN, LA MENTE ACCOGLIENTE. L’universo a cavallo di un raggio di luce (non di un manico di scopa!).
- Mileva Einstein, nata Marić - Милева Марић (Titel, 19 dicembre 1875 - Zurigo, 4 agosto 1948), è stata una scienziata serba compagna di studi di Albert Einstein, di cui divenne anche prima moglie (...) Dal 1990 si è aperta la discussione sulla sua partecipazione ai lavori sulla teoria della relatività di Einstein.
LA LUCE, LA TERRA, E LA LINEA DELLA BELLEZZA: LA MENTE ACCOGLIENTE. "Note per una epistemologia genesica"
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- UN MOVIMENTO. Il femminismo non è morto. L’abbiamo visto in piazza a Roma (di Lea Melandri)29 novembre 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
Il femminismo non è morto. L’abbiamo visto in piazza a Roma
di Lea Melandri *
Valeva la pena aspettare dieci anni per ritrovarci di nuovo in tante e poter dire che siamo un movimento, anche solo per un giorno, e non solo una rete virtuale, anche se le reti ci sono state di aiuto come spinta a uscire dalla carsicità. Confluire in massa in una storica piazza di tutte le proteste, quale è piazza San Giovanni a Roma, è stato sicuramente il modo più felice per rispondere a una ricorrenza, come il 25 novembre, che felice non è.
Una manifestazione come quella di sabato 26, come quelle che si sono succedute da quarant’anni a questa parte, deve darci il coraggio di dire che il femminismo, in tutta la varietà delle sue pratiche, dei suoi gruppi, collettivi, associazioni, ecc... - o forse proprio per questa varietà - è l’unico movimento sopravvissuto agli anni ’70, l’unico che nonostante la messa sotto silenzio, l’ostilità che incontra nel nostro Paese in particolare, non ha mai smesso di riempire le piazze con donne di generazioni diverse, che non ha mai smesso, pur con tante contraddizioni, di ripresentarsi con la radicalità dei suoi inizi.
Non mi soffermerò sulle tante ragioni che ci hanno portato qui. Sulla violenza sappiamo molto, molto abbiamo detto e scritto e analizzato, sia sulle sue forme manifeste - stupri, omicidi, maltrattamenti - sia su quelle meno visibili e perciò più subdole, più ambigue, che passano nella «normalità», nel senso comune, nei gesti e nelle parole della quotidianità, e dell’amore così come lo abbiamo inteso o male inteso finora.
Non si uccide per amore, ma l’amore c’entra, c’entrano quei vincoli di indispensabilità reciproca presenti anche là dove non ce n’è bisogno, c’entra l’infantilizzazione dei rapporti all’interno delle famiglie. Di quanto sia complesso liberarsi di rapporti di potere che si sono confusi con le esperienze più intime, sappiamo molto e molto dovremo ancora scoprire, analizzare.
Ma c’è un altro modo per parlare della violenza, che viene visto meno. È il fatto che da mezzo secolo a questa parte, le donne hanno dato vita a una cultura e a pratiche politiche per contrastare la violenza maschile in tutte le sue forme, a partire da quei segni profondi che ha lasciato dentro di noi, costrette a incorporare quella stessa visione del mondo che ci ha segregate fuori dalla vita pubblica, identificate con la natura, il corpo, la conservazione della specie.
Abbiamo scritto e detto più volte che il sessismo è l’atto di nascita della politica, intendendo con questo sottolineare che il rapporto di potere tra i sessi è l’impianto originario di tutte le oppressioni e disuguaglianze che la storia ha conosciuto. Forse è il momento di dire con chiarezza quello che non siamo più disposte a tollerare:
 che questo patrimonio di sapere, consapevolezze, studi, battaglie vinte venga messo sotto silenzio, lasciato negli archivi e che qualcuno ancora si permetta di dire che il femminismo è morto o silenzioso;
che questo patrimonio di sapere, consapevolezze, studi, battaglie vinte venga messo sotto silenzio, lasciato negli archivi e che qualcuno ancora si permetta di dire che il femminismo è morto o silenzioso;
 che quando interviene una «parola pubblica» a istituzionalizzare pratiche nate dal femminismo, come i consultori, i centri antiviolenza, ciò significhi emarginare le persone che vi hanno dato vita, cancellare l’autonomia delle pratiche che li ha caratterizzati. Mi riferisco al Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere dove i centri antiviolenza finiscono per essere confusi con il Terzo settore, i servizi sociali;
che quando interviene una «parola pubblica» a istituzionalizzare pratiche nate dal femminismo, come i consultori, i centri antiviolenza, ciò significhi emarginare le persone che vi hanno dato vita, cancellare l’autonomia delle pratiche che li ha caratterizzati. Mi riferisco al Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere dove i centri antiviolenza finiscono per essere confusi con il Terzo settore, i servizi sociali;
 che si parli tanto di educazione di genere e si lascino le donne che insegnano, quasi tutte precarie, a dover affrontare campagne denigratorie da parte di presidi e famiglie, rischiare il posto di lavoro, affrontare temi che richiedono una formazione, senza avere la certezza di finanziamenti al riguardo.
che si parli tanto di educazione di genere e si lascino le donne che insegnano, quasi tutte precarie, a dover affrontare campagne denigratorie da parte di presidi e famiglie, rischiare il posto di lavoro, affrontare temi che richiedono una formazione, senza avere la certezza di finanziamenti al riguardo.Siamo qui per dire che non dimentichiamo le donne che la violenza l’hanno subita nella sua forma più selvaggia, ma che non vogliamo più leggere su un giornale o sentire in un commento televisivo che sono «vittime» della passione o della gelosia di un uomo. Sono donne che hanno pagato il prezzo di una affermazione di libertà: quella, inconsueta per un dominio maschile secolare, della donna che dice «Io decido» della mia vita, della mia sessualità, di avere o non avere figli.
Vorrei che ci portassimo a casa questi due bellissimi slogan - «Io decido», «Non una in meno» - per dire che continueremo a batterci contro imposizioni esterne, controlli, divieti, intimidazioni, ma anche per la liberazione da modelli, pregiudizi, leggi non scritte che ci portiamo dentro e che ci impediscono di trovare la forza collettiva di cui abbiamo bisogno. Se non possiamo condividere la varietà delle nostre pratiche, teniamoci almeno disponibili a momenti come questo e forse riusciremo a trovare quei «nessi» che legano la specificità dei nostri interessi, delle nostre esperienze, delle nostre storie.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "RIFLESSIONI SUL TRAGICO".Teatro classico. Salvatore Natoli: «Edipo, l’enigma all’interno di ognuno di noi»27 novembre 2016, di Federico La Sala
- LE "REGOLE DEL GIOCO" DELL’OCCIDENTE E IL DIVENIRE ACCOGLIENTE DELLA MENTE.. Memoria della libertà....:
Teatro classico.
Salvatore Natoli: «Edipo, l’enigma all’interno di ognuno di noi»
Tra libertà e destino: il filosofo Salvatore Natoli rilegge la figura centrale della tragedia antica, in scena a Milano con Glauco Mauri
di Alessandro Zaccuri (Avvenire, 25.11.2016)
Uccide il padre, sposa la madre, trasmette la maledizione ai figli concepiti in quell’unione colpevole. Eppure, nonostante tutto, Edipo è tra le figure del mito non solo maggiormente indagate (il proverbiale “complesso” teorizzato da Sigmund Freud è la più celebre, non la più convincente tra molte interpretazioni elaborate nei secoli), ma anche maggiormente disponibili a una rilettura in prospettiva cristiana. Una stranezza, almeno in apparenza.
Ma il filosofo Salvatore Natoli suggerisce una spiegazione più che motivata. «Il punto è - osserva - che la storia di Edipo ci è nota in particolare attraverso Sofocle e Sofocle è il più religioso fra i tragici greci, il più aperto alla dimensione della pietà e del perdono». Edipo ritorna, dunque, ma in effetti non se n’è mai andato. In questi giorni al Teatro Franco Parenti di Milano va in scena il dittico composto dalle opere sofoclee di cui il personaggio è protagonista, Edipo re ed Edipo a Colono, e contestualmente viene proposto un ciclo di conferenze, Riflessioni sul tragico, che prevede la partecipazione di studiosi quali Maurizio Bettini (30 novembre) ed Eva Cantarella (2 dicembre). A inaugurare gli incontri, questa sera alle 18, è appunto Natoli, al quale è affidato un tema più che impegnativo: Libertà e destino nella tragedia greca. Ma lo studioso non si scompone e ribadisce che è proprio da lui, da Edipo, che occorre partire.
Perché, professore?
«Perché la sua è la tragedia per eccellenza, come già sosteneva Aristotele - risponde -. Una peripezia in senso tecnico, ossia un vagare da un luogo all’altro, che però non coinvolge un dio o un semidio, ma quello che saremmo tentati di definire l’uomo medio. L’umanità media, anzi. Qualcuno che ci assomiglia e che, come capita a ciascuno di noi, trova ad affrontare i dilemmi e le contraddizioni dell’esistenza. Per i greci, del resto, la realtà intera si presenta sotto la cifra dell’antinomia, dell’enigma, addirittura della doppiezza: tutti elementi che richiedono una costante decifrazione da parte dell’uomo».
In questo Edipo è un esperto, no?
«Fino a un certo punto. Non c’è dubbio che lui e lui soltanto riesca a risolvere il famoso indovinello della Sfinge, ma è una vittoria parziale. Edipo è a conoscenza della profezia che lo destina a uccidere il padre e sposare la madre. Anche a questo enigma prova a tenere testa, d’accordo, ma senza mai interrogarsi su se stesso. Ed è per questo che, fuggendo da colui che crede sia suo padre, finisce per imbattersi nel vero padre. Uccidendolo, sposandone la vedova, realizzando la profezia che si illudeva di aver aggirato».
Da dove viene questo fraintendimento?
«Dal fatto che l’enigma del tragico non si situa sul piano esclusivamente logico, è invece un conflitto tra potenze esterne all’uomo, dalle quali l’uomo stesso rischia sempre di essere schiacciato. Nella sua espressione più radicale, l’enigma è quello che ciascuno di noi ignora di se stesso. Il tragico esprime questa lacerazione profonda dell’esistenza, questo destino di morte insito nella vicenda umana fin dal momento della nascita. Così considerata, la vita non può essere se non sfida, battaglia, agone».
Si tratta di una condizione universale?
«Con una distinzione necessaria. Il tragico si manifesta anche nel mondo contemporaneo, ma in un orizzonte post-cristiano, di perdita e smarrimento. Il tragico greco, al contrario, scaturisce dalla natura. Fa perno sulla mancanza di identità e nello stesso tempo la ricostituisce attraverso la peripezia. Edipo conosce finalmente se stesso grazie al viaggio, altrimenti erratico, che da Tebe lo porta a Colono, alle porte di Atene, dove lo attende l’accoglienza ospitale di Teseo, ovvero la svolta capace di dare soluzione alla contraddizione del tragico».
Vuol dire che l’enigma arriva a uno scioglimento?
«Sì, è un’altra caratteristica che differenzia il tragico antico dal moderno. La struttura della trilogia greca prevede che, alla fine, una soluzione ci sia. Meglio ancora, che nell’esperienza della contraddizione l’uomo scopra la misura che gli è propria, secondo una dinamica già intuita da Nietzsche. La catarsi scaturisce da questa consapevolezza e, per compiersi, prende sempre una via obliqua, un detour alternativo al concatenarsi degli eventi. Può accadere per diretto intervento degli dèi, come nell’Orestea di Eschilo, oppure per iniziativa dell’uomo».
È il caso dell’Edipo di Sofocle?
«Esattamente. La figura decisiva è Antigone, il cui atteggiamento non rappresenta semplicemente la rivincita dell’arcaico nei confronti del diritto, come sosteneva Hegel. La mia personale convinzione è che Antigone, in quanto personificazione della pietas, indichi una via d’uscita laterale, e niente affatto arcaica, dalle strettoie della legge: tanto quest’ultima può essere implacabile, tanto la pietà dell’essere umano verso il suo simile si pone sotto il segno della comprensione. Grazie alla pietà, che sostiene le ragioni umane contro la durezza del diritto, la città stessa rivela il suo volto più accogliente, quello che permette a Teseo di prendersi carico dello straniero».
Ma come si realizza allora il rapporto fra libertà e destino?
«Se guardiamo a Edipo, dobbiamo rispondere che per essere liberi occorre conoscere il proprio destino. Il quale, a sua volta, non si colloca nel futuro, custodito magari da un’ambigua preveggenza. No, a condizionare ciascuno di noi è semmai il passato, che è la vera fonte della necessità. Qualcosa che ci spinge, non da cui siamo attratti. In questa chiave, il passato viene a costituirsi come premonizione di un futuro che si presenta sotto la forma della ripetizione, della reiterazione obbligata. Per scardinare questo meccanismo c’è un solo modo».
Quale?
«Fare chiarezza sulle proprie intenzioni. Gnòthi seautòn, il detto delfico solitamente tradotto come “conosci te stesso”, andrebbe inteso nel senso di “sappi che cosa stai domandando”. Affronta l’enigma che tu stesso sei ai tuoi occhi, prima di provare a risolvere l’enigma del mondo. Ma questo Edipo lo comprende solo al termine delle sue peripezie».
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- Il futuro del mondo? Dipende dalle bambine (di Michela Canzio)12 novembre 2016, di Federico La Sala
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
Il futuro del mondo? Dipende dalle bambinedi MICHELA CANZIO (La Stampa, 12/11/2016)
È stato lanciato l’ultimo rapporto sullo Stato della popolazione nel mondo 2016 di UNFPA (Fondo Nazioni Unite per la popolazione) “Avere 10 anni: il nostro futuro dipende da queste bambine”, la cui versione italiana è a cura di AIDOS. L’atteso report demografico analizza annualmente la situazione della popolazione mondiale, attraverso una specifica angolazione, che solitamente vede al centro la salute e i diritti di donne e bambine. Quest’anno il grande framework di riferimento non poteva non essere l’Agenda 2030 e i suoi relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs nel più conosciuto acronimo inglese).
Questi ultimi, definiti ormai una anno fa, nel settembre 2015 a New York, presso le Nazioni Unite e sottoscritti da ben 193 paesi, sono la meta a cui il pianeta vuole arrivare per realizzare uno sviluppo mondiale sostenibile. Ciò che si propone in sintesi è un modello di sviluppo diverso che non sia più solo economico ma che comprenda anche la dimensione ambientale, sociale e umana. Soprattutto la crescita del pianeta non può più permettersi di trascurare la parte svantaggiata di umanità che ancora non era stata raggiunta dai cosiddetti precedenti Obiettivi di sviluppo del millennio. Tra coloro che sono state lasciate indietro ci sono sicuramente, dati delle Nazioni Unite alla mano, le donne e la ragazze, in particolare le giovanissime. Fascia particolarmente fragile è rappresentata da coloro che si affacciano alla pubertà, una zona liminale tra l’infanzia e l’adolescenza vera e propria. Sono queste bambine la chiave della nuova strategia di sviluppo mondiale secondo UNFPA, non solo perché sono il potenziale del pianeta ma perché osservare e progettare per chi ha oggi l’età cruciale di 10 anni ci permetterà tra 15 anni, al termine degli SDGs, di valutare il successo o il fallimento dell’Agenda di sviluppo 2030. Nel 2015 si è raggiunto il più alto numero mai registrato di giovani, 1,8 miliardi e di questi ben 125 milioni hanno dieci anni. Le bambine sono 60 milioni.
“Quando una bambina compie 10 anni il suo mondo cambia. La vita la spinge in tante direzioni, quale strada prenderà dipende dal supporto che riceverà e dalla possibilità di scegliere il proprio futuro. In alcuni posti del mondo, una bambina ha infinite possibilità davanti a sé e inizia a fare scelte importanti per quando sarà adulta. Ma in altre parti del mondo l’orizzonte si restringe. All’ingresso nella pubertà, una combinazione di fattori e discriminazioni possono ostacolare il suo cammino. A soli 10 anni ci sono bambine forzate a sposarsi. Costrette ad abbandonare la scuola a causa di gravidanze precoci”, come si legge nella premessa del Rapporto. Il documento UNFPA quindi non fornisce solo gli ultimi dati demografici ma lancia anche la sfida di seguire la vita di dieci bambine di dieci anni di età, provenienti da diversi paesi, per vedere cosa accadrà nelle loro vite. Ci si concentra quindi in particolar modo sull’obiettivo 5 che è il raggiungimento della parità di genere, meta specifica ma anche obiettivo trasversale per la realizzazione di tutti gli altri.
Le bambine che oggi hanno 10 anni - più della metà in paesi dell’Asia e del Pacifico - sono il punto di partenza per la realizzazione dell’Agenda 2030. I dati che UNFPA ci fornisce sono evidenze che non possiamo più trascurare: ogni giorno circa 47.700 ragazze che hanno meno di 17 anni si sposano, andando incontro a un alto rischio di gravidanze precoci. Circa 9 bambine su 10 abitano in regioni poco sviluppate del mondo e nonostante i passi avanti fatti in questi anni, il numero di quelle escluse dall’educazione primaria è più alto di quello dei coetanei maschi. Un divario che aumenta esponenzialmente se si considera l’educazione secondaria. Inoltre, indipendentemente dal continente in cui è nata, una bambina di 10 anni ha il doppio delle possibilità di suo fratello di doversi occupare di lavori domestici non remunerati. Condizioni di disparità che concorrono ad alimentare un altro altro dato allarmante: oggi, nel mondo, il suicidio è la principale causa di morte tra le adolescenti comprese tra i 15 e i 19 anni.
“Queste bambine sono il volto del nostro futuro - spiega Mariarosa Cutillo, Chief of Strategic Partnerships di UNFPA - La piega che le loro vite prenderanno dipenderà dalle potenzialità che potranno esprimere se noi, organizzazioni internazionali e non governative, attori pubblici e privati e soprattutto i governi del mondo, le metteremo in condizioni di farlo. La loro storia misurerà l’efficacia dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Non avremo una seconda opportunità. È un appuntamento che non possiamo mancare “.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 -- ELEZIONI USA E "L’UOMO A UNA DIMENSIONE". Quelle urne sommerse da sessismo e razzismo.10 novembre 2016, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DELLA FACOLTÀ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITÀ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT):
- UNA DOMANDA: MA COME AVETE FATTO A RIDURVI COSI’?! Una nota di Maurizio Viroli (dagli Usa) - e una risposta (agli americani, dall’Italia)
- SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH. LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO
- LA STATUA DELLA LIBERTA’ DEGLI U.S.A. - CON LA SPADA SGUAINATA: "GUAI AI VINTI"!!! LA LEZIONE DI FRANZ KAFKA, IL MAESTRO DELLA LEGGE: RIPENSARE L’AMERICA. E il sogno del "nuovo mondo"!!!
- L’abbraccio di Hillary e Bush La foto che può turbare la campagna elettorale [14 marzo 2016]
- http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_marzo_14/abbraccio-hillary-bush-foto-che-puo-turbare-campagna-elettorale-0af58d74-e9e6-11e5-9549-2d2df3bd31ee.shtml
- È la foto che in queste ore sta facendo il giro della rete e che potrebbe avere rilevanti conseguenze sulla campagna elettorale dei democratici. Siamo ai funerali di Nancy Reagan e lo scatto ritrae un abbraccio e due facce sorridenti. I protagonisti, però, sono l’ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, repubblicano doc, e la candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton. Una foto che, in piena campagna elettorale, non passerà certo inosservata (Foto tratta dal profilo @DavidChalian su Twitter)
- Stati Uniti: l’abbraccio «materno» di Michelle Obama a George W. Bush scatena la Rete [25 settembre 2016]
- http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/16_settembre_25/stati-uniti-l-abbraccio-materno-michelle-obama-george-w-bush-scatena-rete-124c290c-833d-11e6-879e-4c7914542a03.shtml
- L’immagine c’è da ammetterlo non è di quelle più consuete: la first lady Michelle Obama che abbraccia l’ex presidente americano George W. Bush. Succede all’inaugurazione del primo museo della storia afroamericana a Washington. Presenti appunto l’ex capo di Stato Usa con la moglie, e Obama con Michelle. E durante la cerimonia, ecco che i fotografi immortalano l’abbraccio di lei a Bush. Immagine che rimbalza subito in Rete e scatena ironia e fotomontaggi. (Afp)
Quelle urne sommerse da sessismo e razzismo
Elezioni Usa. Un commento inedito della filosofa statunitense a proposito dell’elezione presidenziale di Donald Trump. «Con quali condizioni abbiamo a che fare se l’odio più scatenato e la più sfrenata smania di militarizzazione riescono a ottenere il consenso della maggioranza?»
di Judith Butler (il manifesto, 10.11.2016)
Due sono le domande che gli elettori statunitensi che stanno a sinistra del centro si stanno ponendo. Chi sono queste persone che hanno votato per Trump? E perché non ci siamo fatti trovare pronti, davanti a questo epilogo? La parola «devastazione» si approssima a malapena a ciò che sentono, al momento, molte tra le persone che conosco. Evidentemente non era ben chiaro quanto enorme fosse la rabbia contro le élites, quanto enorme fosse l’astio dei maschi bianchi contro il femminismo e contro i vari movimenti per i diritti civili, quanto demoralizzati fossero ampi strati della popolazione, a causa delle varie forme di spossessamento economico, e quanto eccitante potesse apparire l’idea di nuove forme di isolamento protezionistico, di nuovi muri, o di nuove forme di bellicosità nazionalista. Non stiamo forse assistendo a un backlash del fondamentalismo bianco? Perché non ci era abbastanza evidente?
Proprio come alcune tra le nostre amiche inglesi, anche qui abbiamo maturato un certo scetticismo nei riguardi dei sondaggi. A chi si sono rivolti, e chi hanno tralasciato? Gli intervistati hanno detto la verità? È vero che la vasta maggioranza degli elettori è composta da maschi bianchi e che molte persone non bianche sono escluse dal voto? Da chi è composto questo elettorato arrabbiato e distruttivo che preferirebbe essere governato da un pessimo uomo piuttosto che da una donna? Da chi è composto questo elettorato arrabbiato e nichilista che imputa solo alla candidata democratica le devastazioni del neoliberismo e del capitalismo più sregolato?
È dirimente focalizzare la nostra attenzione sul populismo, di destra e di sinistra, e sulla misoginia - su quanto in profondità essa possa operare.
Hillary viene identificata come parte dell’establishment, ovviamente. Ciò che tuttavia non deve essere sottostimata è la profonda rabbia nutrita nei riguardi di Hillary, la collera nei suoi confronti, che in parte segue la misoginia e la repulsione già nutrita per Obama, la quale era alimentata da una latente forma di razzismo.
Trump ha catalizzato la rabbia più profonda contro il femminismo ed è visto come un tutore dell’ordine e della sicurezza, contrario al multiculturalismo - inteso come minaccia ai privilegi bianchi - e all’immigrazione. E la vuota retorica di una falsa potenza ha infine trionfato, segno di una disperazione che è molto più pervasiva di quanto riusciamo a immaginare.
Ciò a cui stiamo assistendo è forse una reazione di disgusto nei riguardi del primo presidente nero che va di pari passo con la rabbia, da parte di molti uomini e di qualche donna, nei riguardi della possibilità che a divenire presidente fosse proprio una donna? Per un mondo a cui piace definirsi sempre più postrazziale e postfemminista non deve essere facile prendere atto di quanto il sessismo e il razzismo presiedano ai criteri di giudizio e consentano tranquillamente di scavalcare ogni obiettivo democratico e inclusivo - e tutto ciò è indice delle passioni sadiche, tristi e distruttive che guidano il nostro paese.
Chi sono allora quelle persone che hanno votato per Trump - ma, soprattutto, chi siamo noi, che non siamo state in grado di renderci conto del suo potere, che non siamo stati in grado di prevenirlo, che non volevamo credere che le persone avrebbero votato per un uomo che dice cose apertamente razziste e xenofobe, la cui storia è segnata dagli abusi sessuali, dallo sfruttamento di chi lavorava per lui, dallo sdegno per la Costituzione, per i migranti, e che oggi è seriamente intenzionato a militarizzare, militarizzare, militarizzare? Pensiamo forse di essere al sicuro, nelle nostre isole di pensiero di sinistra radicale e libertario? O forse abbiamo semplicemente un’idea troppo ingenua della natura umana? Con quali condizioni abbiamo a che fare se l’odio più scatenato e la più sfrenata smania di militarizzazione riescono a ottenere il consenso della maggioranza?
Chiaramente, non siamo in grado di dire nulla a proposito di quella porzione di popolazione che si è recata alle urne e che ha votato per lui. Ma c’è una cosa che però dobbiamo domandarci, e cioè come sia stato possibile che la democrazia parlamentare ci abbia potuti condurre a eleggere un presidente radicalmente antidemocratico. Dobbiamo prepararci a essere un movimento di resistenza, più che un partito politico. D’altronde, al suo quartier generale a New York, questa notte, i supporter di Trump rivelavano senza alcuna vergogna il proprio odio esuberante al grido di «We hate Muslims, we hate blacks, we want to take our country back».
 (traduzione di Federico Zappino)
(traduzione di Federico Zappino) -
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff --- Primo Levi e i tedeschi (di Martina Mengoni)26 ottobre 2016, di Federico La Sala
Kurt Heinrich Wolff e Primo Levi ...
- SUL PENSIERO DI KURT H. WOLFF, SI CFR. IL CAP.
4. NICODEMO
O
DELLA
NASCITA.
SULLA
STRADA
DI
ENZO
PACI della Parte III del lavoro "Della Terra, il brillante colore".
 LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. (qui disponibile) è il cap. 6 della Parte III.
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. (qui disponibile) è il cap. 6 della Parte III.
Primo Levi e i tedeschi
Fino all’ultimo cercò di capire
Le lettere che gli arrivavano dalla Germania nel Dopoguerra dovevano far parte di un libro che non vide mai la pubblicazione
di Martina Mengoni (La Stampa, 26.10.2016)
Sopravvissuto ad Auschwitz, Primo Levi non tronca i suoi rapporti con i tedeschi. Nell’ultimo dopoguerra, il confronto con quel popolo sarà una storia di incontri, letture, scambi epistolari, tentativi editoriali, elaborazioni letterarie e, soprattutto, di domande che attendono una risposta. Che i tedeschi abbiano rappresentato un rovello per Primo Levi (uomo, scrittore, testimone, perfino chimico) è un dato di fatto. Come questa relazione difficile, ondivaga, a tratti entusiasta, a tratti frustrante, si sia modificata nel tempo, dentro e fuori la sua scrittura, è quanto occorre ricostruire. Oggi lo si può fare contando su una mole di documenti poco noti o inediti, provenienti da archivi di tutta Europa.
Fin dal 1962 Levi si era creato una rete di corrispondenti dalla Germania Ovest: i primi lettori della traduzione tedesca di Se questo è un uomo, apparsa nel novembre del 1961. [...]
Sempre in quegli anni, Levi avviò uno scambio epistolare con Hermann Langbein, storico austriaco, ex triangolo rosso (comunista) in Lager, segretario generale del Comitato Internazionale di Auschwitz; Langbein lo coinvolse nel progetto di una grande antologia di testimonianze di vittime e carnefici di Auschwitz. Doveva uscire in contemporanea con la prima istruttoria del processo di Francoforte contro i responsabili del campo; ma il libro fu pubblicato già nel 1962 e vi furono inclusi due capitoli di Se questo è un uomo.
Nel 1964 un ulteriore capitolo di Se questo è un uomo uscì in un volume-strenna che le acciaierie Hoesch di Dortmund distribuirono ai loro dirigenti e dipendenti. Nella Germania di Hitler le grandi industrie avevano dato un sostegno decisivo al regime. Ora una di quelle industrie pubblicava un volume sulla fratellanza, di ispirazione cattolico-liberale, curato dallo stesso Albrecht Goes. In un contesto di invito all’accoglienza e all’ecumenismo cristiano, Levi aveva scelto il capitolo Ottobre 1944 che si concludeva con la ben nota sentenza «Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn».
Per sua stessa ammissione, Levi riceve in quegli anni «una quarantina di lettere» di tedeschi. Nel 1963 annuncia in due interviste che Einaudi intende pubblicarle. È una non-notizia, perché il libro non si farà, ma è anche una notizia: apprendiamo che per Levi, fin da allora, le lettere dei lettori tedeschi possedevano una dignità editoriale e di contenuto autonoma rispetto al libro che le aveva originate.
Più tardi, Levi avrebbe affidato quelle corrispondenze (denominandole «progetto tedesco») a Kurt Heinrich Wolff, un sociologo tedesco naturalizzato statunitense. Wolff era un «tedesco anomalo». Fuggito dalla Germania perché ebreo, rifugiatosi in Italia negli Anni Trenta, emigrò infine negli Stati Uniti diventando professore alla Brandeis University.
 Nei primi Anni Cinquanta, invitato da Max Horkheimer, partecipò ai Gruppen-Experimenten dell’Istituto di Sociologia di Francoforte, che aveva appena riaperto dopo la guerra, redigendo due studi: uno sull’autorappresentazione della popolazione tedesca dopo la guerra (German attempts at picturing Germany), l’altro sulla denazificazione della Germania (The American Denazification of Germany).
Nei primi Anni Cinquanta, invitato da Max Horkheimer, partecipò ai Gruppen-Experimenten dell’Istituto di Sociologia di Francoforte, che aveva appena riaperto dopo la guerra, redigendo due studi: uno sull’autorappresentazione della popolazione tedesca dopo la guerra (German attempts at picturing Germany), l’altro sulla denazificazione della Germania (The American Denazification of Germany).Nel 1963, Wolff ottenne una borsa Fulbright in Italia, e Levi entrò in contatto con lui proprio in quei mesi, probabilmente tramite la sorella Anna Maria e il sociologo Franco Ferrarotti. Sono queste le premesse in base alle quali gli affidò le lettere del «progetto tedesco».
Che cosa comportò, in termini di auto-percezione, di riflessione su Auschwitz, di progressione creativa di Levi, il fallimento di quel progetto, cioè di un libro fatto di dialoghi epistolari con tedeschi? Così come la pubblicazione di un libro, anche la sua mancata pubblicazione può cambiare la vita, l’opera e l’autocoscienza di uno scrittore. In molte interviste dei suoi ultimi anni Levi ha parlato di Se questo è un uomo come una memoria-protesi: i ricordi che aveva messi per iscritto tendevano a sovrapporsi ai ricordi ricordati: «una memoria esterna che si interpone tra il mio vivere di oggi e quello di allora».
La mancata pubblicazione delle lettere di tedeschi negli Anni 60 ebbe l’effetto opposto: quelle corrispondenze, rimaste chiuse nella loro cartellina, continuarono nel corso degli anni a esercitare la loro carica interrogativa dall’interno, in maniera regolare e persistente, senza che Levi avesse avuto la possibilità di oggettivarne i significati attraverso la scrittura. Sarebbero così diventate l’ultimo capitolo del suo ultimo libro, I sommersi e i salvati: dove ebbero il titolo Lettere di tedeschi, inevitabile quanto il dialogo che le aveva propiziate.
- SUL PENSIERO DI KURT H. WOLFF, SI CFR. IL CAP.
4. NICODEMO
O
DELLA
NASCITA.
SULLA
STRADA
DI
ENZO
PACI della Parte III del lavoro "Della Terra, il brillante colore".
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO -- FEMMINISMO, RIVOLUZIONE SESSUALE, E MATERNITA’. IL TEMPO DELLE DONNE: UN BILANCIO (MILANO).9 settembre 2016, di Federico La Sala
FEMMINISMO
Le donne, il piacere: cosa è successo
La pillola, legale in Italia da 45 anni, ha rivoluzionato la sessualità femminile. Ma la strada è ancora lunga, tra conquiste ed errori . Quanto ha contribuito il movimento femminista alla liberazione sessuale? Ne parleremo in Triennale l’11 settembre
di Elena Tebano (Corriere della Sera, 05.09.2016)
[...]
L’APPUNTAMENTO IN TRIENNALE
Elena Tebano affronterà l’argomento al Tempo delle Donne cercando di rispondere alla domanda: Quanto ha contribuito il movimento femminista alla liberazione sessuale delle donne? Oggi il loro piacere è davvero più diffuso e riconosciuto nelle relazioni come nella cultura comune?
L’appuntamento è al Triennale Lab, domenica 11 settembre, alle ore 11.30
LA DONNA CLITORIDEA AI TEMPI DI YOUPORN
Il Femminismo e la rivoluzione sessuale: un bilancio
Con Barbara Mapelli, coautrice di Infiniti amori (EDS), Barbara Bonomi Romagnoli, autrice di Irriverenti e libere (EIR), e Yasmin Incretolli, autrice di Mescolo tutto (Tunuè)
Kristeva: uniti, non sottomessi Come rifondare il matrimonio
di Stefano Montefiori (Corriere della Sera, 08.09.2016)
Una 25enne borsista bulgara arriva a Parigi, nel 1966, con cinque dollari in tasca, una non comune padronanza del francese e «idee tanto coraggiose quanto vaghe». La brillante studiosa Julia Kristeva chiede un incontro a Philippe Sollers, di pochi anni più grande e già fondatore della rivista Tel Quel, quella di Roland Barthes, Umberto Eco e alcuni altri monumenti. Julia e Philippe non si lasceranno più, l’estate prossima festeggeranno cinquant’anni di matrimonio. Allo loro unione hanno dedicato «Del matrimonio considerato come un’arte», non una ricetta ma una riflessione su «come vivere insieme, senza sottomissione dell’uno all’altro e senza negare le differenze».
Intanto, Julia Kristeva non crede nella coppia fusionale. «Nella storia recente della cultura francese abbiamo due o tre esempi di coppie date come modello, coppie surrealiste come Nadja e André Breton, dove la donna è allo stesso tempo mito, strega e vittima, oppure la coppia contestataria Beauvoir e Sartre, e poi ancora Elsa Triolet e Aragon, incensati dal partito comunista. Poi si è capito che questi miti si fondavano su errori, abbiamo conosciuto la sofferenza di Beauvoir rispetto alla mancata maternità, o la fuga di Aragon verso l’omosessualità. Non c’è un modello possibile, quel che conta è mettersi in discussione. Io e Philippe abbiamo subito preso la misura delle nostre singolarità ed estraneità, e abbiamo provato a fare della vita di coppia uno spazio di pensiero. Che ciascuno prosegua nella la sua creatività, che si discuta insieme. Coesistenza di due estraneità, rispetto dell’alterità dell’altro, e malgrado tutto cura, cioè preoccupazione dell’altro».
Sulla fedeltà, Kristeva ha delle frasi fulminanti: «Il sentimento di fedeltà risale all’infanzia e al suo desiderio di sicurezza. Personalmente ho ricevuto i miei pegni di fedeltà quando ero bambina». E ancora: «Ci possono essere “all’esterno” delle relazioni sessuali e sensuali che rispettano il corpo e la sensibilità del partner principale. È questa la fedeltà. E non stare sempre insieme, o non conoscere alcun altro uomo o alcuna altra donna». Qual è il ruolo del narcisismo? «Un incontro si basa sempre su un magnetismo sessuale e su una fascinazione, e in questa fascinazione c’è anche la capacità di tendere all’altro uno specchio gratificante. Tu ti vedi in me, io mi vedo in te e i nostri ideali, i nostri narcisismi si incrociano e si incontrano».
Guardando al suo matrimonio, secondo Kristeva «c’era una possibilità su non so quanti miliardi che una donna nata nell’Europa comunista percorresse una linea di pensiero che incrociava l’intelletto di un giovane borghese di Bordeaux. Ma in quella Francia che usciva dalla guerra d’Algeria alcuni intellettuali si interessavano allo strutturalismo, al formalismo russo, alla filosofia post-marxista. Sollers ha incontrato in me una ragazza che veniva dal comunismo del disgelo, l’era di Krusciov contro Stalin, l’apertura all’umanesimo dell’Illuminismo, la rivalutazione di Diderot, Voltaire, Rousseau, il nuovo romanzo dopo Sartre e Beauvoir sul quale avevo appena fato una tesi. Questa corrispondenza intellettuale si è tradotta nella realtà grazie anche al caso. Non ci saremmo mai incontrati se il capo del mio istituto in Bulgaria, un comunista puro e duro, non si fosse assentato permettendo a un altro professore di presentarmi all’Ambasciata di Francia per farmi assegnare la borsa di studio».
Nei giorni scorsi in Italia si è molto parlato di maternità, dopo una discussa campagna della ministra per la Salute. «La maternità ha scosso le femministe, le ha divise. Simone de Beauvoir diceva che un bambino era un tumore che divora la donna, che avere un bambino significa sottomettersi al patriarcato. All’estremo opposto c’è l’idea di sottomettere la donna al ruolo di riproduttrice della specie.
 Bisognerebbe evitare entrambi gli estremi e indagare a fondo la questione della passione materna. Ma non abbiamo abbastanza strumenti, l’umanesimo secolarizzato non ha un discorso sulla maternità, siamo vittime sia del rigetto, sia del discorso religioso, con il modello della Vergine Maria, il burqa o non so che altro. È la prossima sfida delle scienze umane accompagnare le donne nel loro desiderio di maternità, o di non maternità».
Bisognerebbe evitare entrambi gli estremi e indagare a fondo la questione della passione materna. Ma non abbiamo abbastanza strumenti, l’umanesimo secolarizzato non ha un discorso sulla maternità, siamo vittime sia del rigetto, sia del discorso religioso, con il modello della Vergine Maria, il burqa o non so che altro. È la prossima sfida delle scienze umane accompagnare le donne nel loro desiderio di maternità, o di non maternità».
- UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
Le donne e il femminismo al bivio della maternità
di Lucetta Scaraffia (Corriere della Sera, 08.09.2016)
Questo articolo si inserisce nel confronto - suscitato dall’inchiesta giornalistica «Sesso e amore» sviluppata dal Corriere - che sarà al centro della manifestazione «Il Tempo delle Donne» in programma alla Triennale di Milano da domani all’11 settembre.
M i è capitato di recente: una ragazza bella, intelligente, molto impegnata nella sua professione, raccontandomi la situazione che stava vivendo, mi ha detto: «sono tre mesi che non batto chiodo» alludendo cioè all’assenza di rapporti sessuali recenti. Un linguaggio che un tempo - ma neanche poi tanti anni fa - avrebbe usato solo un soldato con un commilitone. E, dal momento che la conosco bene, so che è una ragazza che sognerebbe solo un amore vero, e una famiglia con dei figli, ma sa bene che la cultura post-rivoluzione sessuale non le permette di esprimere pubblicamente - ma forse neppure a se stessa - questa aspirazione, se non a costo di vedersi definita come una retrograda antiquata.
Proprio lei è l’esempio più chiaro della situazione delle giovani donne a rivoluzione sessuale realizzata: possono fare di tutto, nessuno si permette un giudizio su di loro partendo dal loro comportamento sessuale - e questo è senza dubbio un bene - ma questa libertà le rende veramente libere? O - se ancora è possibile parlare in questi termini - più felici? Per esempio più felici delle loro nonne, che vivevano in mezzo alle proibizioni ma che potevano dire a se stesse e agli altri che aspiravano all’amore e alla famiglia? Con la pillola, le donne hanno potuto vivere una libertà sessuale fino ad allora sperimentata solo dagli uomini, ma si sono trovate a vivere un tipo di rapporti modellati sulla sessualità maschile. Promiscuità, leggerezza, superficialità di relazioni. Rapporti che forse non erano poi così congeniali alla sessualità femminile.
Per di più si sono dovute assumere, con la pillola, tutto il peso della contraccezione, anche a costo di pagarne un prezzo non irrisorio per la loro salute. Non è un caso che oggi, in Francia e in area anglosassone, molte giovani donne si rifiutino di utilizzare la pillola per salvaguardare la loro salute, e preferiscano ricorrere a metodi naturali. Sì, proprio quei metodi naturali che proponeva Paolo VI nell’ Humanae Vitae, suscitando al tempo sghignazzi e irrisione.
Del resto, bisogna anche considerare che i profeti della «liberazione sessuale» erano tutti uomini - da Reich a Kinsey - mentre alle donne era stato lasciato solo il compito di confermare le loro teorie con libri autobiografici. Le donne, probabilmente, non avrebbero mai sviluppato un programma utopico di tal portata sulla sessualità, conoscendone troppo da vicino anche gli aspetti negativi - che ovviamente non consistono solo nel timore di una gravidanza - che non sono certo stati cancellati in questi decenni di liberazione. Ma certo il femminismo degli anni Settanta ha in grande misura fatto propria questa utopia, travestendola da utopia di liberazione della donna. Di liberazione da cosa? In primo luogo liberazione dalla maternità, attraverso due strade che sono state pagate dalle donne sul loro corpo, cioè la pillola e l’aborto.
Oggi le giovani donne, che hanno tutta la libertà sessuale che vogliono, non hanno quella di fare figli, soprattutto di fare figli da giovani. E non solo perché il mercato del lavoro non glielo permette, ma anche perché non trovano facilmente giovani maschi che abbiano il desiderio di assumersi la responsabilità di fare i padri.
In passato, i maschi diventavano padri nel matrimonio, che coincideva più o meno con l’inizio della loro vita sessuale: oggi non hanno certo bisogno di sposarsi per avere rapporti sessuali, e in più non hanno problemi di tempo. Per loro infatti non esiste l’orologio biologico che invece continua a condizionare la possibilità di diventare madri per le donne, che non è superato neppure grazie ai progressi della procreazione assistita. I tempi della fecondità femminile sono rimasti invariati, infatti, ma la società sembra non tenerne conto, non vuole vedere questa nuova occasione di differenza fra i sessi che penalizza le donne.
In sostanza le donne, nei Paesi occidentali, stanno pagando il mancato riconoscimento culturale e sociale attribuito alla procreazione. Proporre il dilemma fra creazione di qualsiasi tipo (la creazione di una linea di abbigliamento, di un nuovo piatto o di un marchio pubblicitario...) e procreazione - e svalutando la seconda a favore della prima - significa, infatti, negare valore al ruolo biologico della donna e spingerla ad assumere un ruolo maschile. Mentre la procreazione dovrebbe essere considerata una ricchezza essenziale per tutta la comunità umana.
L’antitesi alla libertà sessuale, intesa sempre, in fondo, come libertà dalla procreazione, non è solo il Fertility day proposto dalla ministra della salute Lorenzin. In Francia ci sono filosofe femministe che stanno elaborando una visione nuova e critica del femminismo cercando di affrontare la questione fondamentale: come rinnovarsi senza perdere il senso profondo e ricco delle relazioni femminili tradizionali? Senza condannarci a una società fredda e dominata dall’utile, dall’utopia del piacere?
Come fare perché le donne, anche dal punto di vista del comportamento sessuale, non diventino «un uomo come un altro» ma possano restare se stesse? C’è ancora molto lavoro da fare, molto da riflettere senza lasciarsi incantare dalle ideologie del passato, che ormai hanno fatto il loro tempo, e in sostanza hanno fallito la loro promessa utopica di felicità.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). -- La pillola, legale in Italia da 45 anni. Le donne, il piacere: cosa è successo (di Elena Tebano)5 settembre 2016, di Federico La Sala
- DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali).
Le donne, il piacere: cosa è successo
La pillola, legale in Italia da 45 anni, ha rivoluzionato la sessualità femminile. Ma la strada è ancora lunga, tra conquiste ed errori
di Elena Tebano (Corriere della Sera, 05.09.2016)
La sessualità femminile in Italia ha una data di nascita ufficiale (e recente): 1971. È il 16 marzo di 45 anni fa quando la contraccezione smette di essere un reato - contro la stirpe, per altro: la Corte costituzionale dichiara illegittimo l’articolo 553 del Codice penale introdotto dal Fascismo che puniva chiunque incitasse all’uso degli anticoncezionali. La pillola, comparsa nelle borse delle donne già dagli anni 60, diventa legale e permette alle italiane di far sesso per il piacere di farlo senza rischiare di avere figli che non vogliono.
L’estate di quello stesso anno Carla Lonzi, raffinata (e oggi spesso dimenticata) teorica del femminismo, pubblica «La donna clitoridea e la donna vaginale» per la casa editrice del gruppo Rivolta femminile. Sessantaquattro pagine in cui sostiene che il vero orgasmo è quello che si ottiene con la stimolazione del clitoride e non quello che deriva dalla penetrazione, e afferma che la cultura maschile ha intrappolato le donne in un mito per molte irraggiungibile. Una distinzione che fornisce un grimaldello psicologico alla lotta delle donne: il clitoride «diventa l’organo in base al quale “la natura” autorizza e sollecita un tipo di sessualità non procreativa», scrive Lonzi, che denuncia «nella colonizzazione sessuale la condizione di base dell’indebolimento e dell’assogettamento della donna». La critica della sessualità e la ricerca di una sua espressione autentica diventano uno dei cardini del movimento femminista, articolate e rivissute quotidianamente nei gruppi di autocoscienza. È una rivoluzione copernicana.
«Prima del femminismo una donna per bene non doveva provar piacere: doveva adeguarsi a quello maschile e magari diventare madre. Se perseguiva il proprio piacere era considerata perduta. La generazione di mia madre parlava del sesso come un fastidio inevitabile che si poteva superare perché ci si voleva bene - racconta Barbara Mapelli, studiosa e scrittrice che a quella stagione ha preso parte -. Per noi, che avevamo tutte tra i 20 e i 30 anni e avevamo già avuto figli, era ovvio partire da lì: ci rendevamo conto che la sessualità socialmente e culturalmente imposta negava il nostro desiderio».
Quarantacinque anni sono poca cosa nella storia dell’umanità, eppure quei tempi non potrebbero sembrare più lontani. Che cosa resta adesso di quel tentativo? Il movimento femminista ha davvero contribuito alla liberazione sessuale delle donne? E c’è ancora bisogno di una riflessione sulle forme e i modi della sessualità?
Se da un lato nessuno (almeno in Italia e in Occidente) può più mettere in discussione il diritto delle donne al piacere nel sesso, dall’altro sembrano ormai altrettanto inaccettabili alcuni eccessi di quegli anni. «Il nostro errore - spiega ancora Mapelli - è stato pensare che con il pensiero si possano immediatamente mutare i comportamenti. Noi li cambiavamo ma così finivamo per esasperarli e perdevamo autenticità».
Oggi è dunque scomparsa l’idea che esista un tipo più vero (o libero) di orgasmo. Ed è sparita anche quella - sostenuta dalle teoriche radicali americane degli anni 70 Catharine MacKinnon e Andrea Dowrkin - che le donne nel sesso vengano inevitabilmente ridotte a oggetti del piacere maschile, una reificazione che le priverebbe di umanità e da lì finirebbe per definire tutta la condizione femminile.
Su questo tema ha scritto pagine bellissime la filosofa Martha Nussbaum che in un saggio del 1995 «Persona oggetto» (pubblicato in Italia due anni fa da Erickson) spiega come in condizioni di parità e di rispetto reciproco uno degli aspetti «meravigliosi» del sesso sia trattarsi a vicenda come oggetti di desiderio e piacere e perdere l’autosufficienza e il controllo che caratterizzano gli altri ambiti della nostra esistenza.
Ma se le donne godono di maggiore libertà non significa che la sessualità sia «finalmente» libera o autentica. Il problema è soprattutto quello che Roberto Todella, sessuologo e presidente del Centro interdisciplinare per la ricerca e la formazione in sessuologia chiama «modello prestazionale» su cui uomini e donne tendono a valutare se stessi e ciò che fanno a letto.
«L’attenzione al piacere, anche da parte delle donne, è diventata centrale, ma sempre più spesso viene misurata sull’immaginario della pornografia con la sua insistenza su posizioni, intensità, ruoli stereotipati - dice Todella -. In questo scenario la donna è sempre disponibile e sembra godere qualunque cosa le venga fatta, l’uomo deve essere prima di tutto forte, prestante, impositivo. Se il sesso diventa imitazione di un repertorio precostituito, però, non è più un’esperienza, non passa attraverso la conoscenza di sé e si deforma per aderire a un copione scritto da altri. Smette di rappresentarci».
Una tendenza evidentissima secondo Yasmin Incretolli, scrittrice 22enne che in «Mescolo tutto» (Tunuè, 2016) ha raccontato anche la centralità del sesso (spesso mal vissuto) nella sua generazione. «La rivoluzione sessuale ormai è sdoganata - afferma -, ma spesso il sesso viene vissuto come se fosse un mantra, in modo ritualistico ed estremizzato». Anche perché manca una vera educazione alle sessualità a scuola e da parte di molti genitori: «L’insegnante per i maschi è Internet, la pornografia. I maestri delle ragazze sono i ragazzi che si scelgono: anche per loro c’è un nesso con il porno, filtrato però dai gusti del loro compagno, che è anche peggio. Il sesso dovrebbe essere scoperta di sé, non un’ospitata nel mondo maschile».
Non è un caso che tra i temi dei nuovi femminismi ci sia la riappropriazione in chiave emancipatoria della pornografia: «I movimenti del post porno hanno dimostrato che è possibile una pornografia diversa, che non riproduca le medesime strutture di potere della società che mette a nudo, in cui l’uomo sta sopra e la donna sotto, in tutti i sensi», dice Barbara Bonomi Romagnoli, autrice di «Irriverenti e libere. Femminismi nel nuovo millennio» (Eir, 2014).
È solo uno dei tentativi delle nuove generazioni femministe di riprendere la questione sessuale, «che rimane rilevante e viene declinata da vari punti di vista - rileva Bonomi Romagnoli -, dalle ragazze del Sexishock che nel 2001 mettono al centro del loro discorso politico la parola “desiderio” e aprono il primo sexy shop autogestito da donne per donne in Italia, ai femminismi più radicali che pongono in maniera problematica la questione dell’identità sessuale, sostenendo che è fluida e non classificabile una volta per sempre.
Il femminismo d’altronde non può non occuparsi di sesso, perché di fatto un sesso ha ancora potere su un altro, perché si continua a voler dettare norme sulle sue pratiche (vedi il «fertilityday») e perché le relazioni e i rapporti sociali ci sono a partire dai rapporti di forza fra i generi. Affinché siano sane è necessario che la sessualità attenga alla consapevolezza e autodeterminazione dei singoli». Con una consapevolezza nuova rispetto agli anni 70: la ricerca di una sessualità più autentica è una liberazione non solo per le donne ma anche per gli uomini.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA QUERELLE sul divieto del burkini e la polemica sulle suore in spiaggia. Nota di Vito Mancuso.26 agosto 2016, di Federico La Sala
- LA RISATA DI KANT: SCHOPENHAUER (COME RATZINGER) A SCUOLA DEL VISIONARIO SWEDENBORG.
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
L’Islam, il cristianesimo e la polemica sul burkinidi Vito Mancuso (la Repubblica, 26.08.2016)
LA QUERELLE sul divieto del burkini e la polemica sulle suore in spiaggia ha avuto di certo il merito di richiamare la comune radice di cristianesimo e islam in ordine alla questione dell’abbigliamento cui devono essere tenuti i corpi delle donne. Ha avuto quindi una felice intuizione l’imam di Firenze, Izzedin Elzir, nel pubblicare sulla sua pagina facebook, come commento, una foto di alcune religiose al mare?
Per giudicare basta leggere ciò che al riguardo ordinava san Paolo (in questo articolo mi si scuseranno le lunghe citazioni, ma credo sia importante): «Voglio che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, manca di riguardo al proprio capo. Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto, manca di riguardo al proprio capo, perché è come se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole coprirsi, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. L’uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell’uomo. E infatti non è l’uomo che deriva dalla donna, ma la donna dall’uomo; né l’uomo fu creato per la donna, ma la donna per l’uomo. Per questo la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli» (Prima lettera ai Corinzi 11,3-10, versione ufficiale Cei).
Qui san Paolo dice tre cose precise: 1) che la donna è sottoposta all’uomo, così come l’uomo è sottoposto a Cristo, e Cristo è sottoposto a Dio, secondo una netta gerarchia ascendente; 2) che la donna non solo è sottoposta ma è addirittura finalizzata all’uomo, nel senso che è stata creata per l’uomo, di cui è chiamata a essere la “gloria”; 3) che la donna deve coprire la sua testa in segno di accettazione dell’autorità cui è sottoposta.
L’islam ripresenta la medesima impostazione. La superiorità dell’uomo rispetto alla donna è affermata chiaramente dal Corano: «Gli uomini sono un gradino più in alto» (sura 2,228, trad. di Ida Zilio-Grandi). Nella stessa prospettiva la sura 4 intitolata Le donne afferma: «Gli uomini sono preposti alle donne perché Dio ha prescelto alcuni di voi sugli altri e perché essi donano parte dei loro beni per mantenerle. Le donne buone sono devote a Dio e sollecite della propria castità così come Dio è stato sollecito di loro, e quanto a quelle di cui temete atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti e poi battetele, ma se vi ubbidiranno non cercherete pretesti per maltrattarle, Dio è grande e sublime » (4,34).
Quanto alla finalizzazione della donna rispetto all’uomo, così scrive il Corano: «Agli occhi degli uomini è stato abbellito l’amore dei piaceri, come le donne, i figli e le misure ricolme d’oro e d’argento, e i cavalli di razza, e il bestiame e i campi» (3,14). Ed è sufficiente pensare alla concezione islamica del paradiso in cui donne giovani e belle saranno sempre a disposizione dei credenti maschi, per ritrovare confermata tale innegabile centralità maschile.
Da qui, come già per san Paolo, per il Corano discende il tipo di abbigliamento cui deve conformarsi il corpo femminile: «Profeta, di’ alle tue moglie e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si coprano con i loro mantelli; questo sarà meglio per distinguerle dalle altre donne affinché non vengano offese, ma Dio è indulgente e compassionevole » (33,59).
Appare quindi chiaro che, sia per il cristianesimo sia per l’islam, l’abbigliamento femminile comandato non è una semplice questione di tradizione né tanto meno di gusto, ma suppone una precisa concezione del rapporto uomo-donna all’insegna della subordinazione di quest’ultima.
Non è certo un caso che in Occidente l’affermazione della piena parità giuridica uomo-donna abbia avuto come conseguenza la mutazione dell’abbigliamento femminile da cui è scomparso ogni segno di subordinazione, compreso il velo in testa a cui, stando alle severe disposizioni di san Paolo, erano tenute tutte le donne in chiesa fino a solo qualche decennio fa.
Dietro il burkini quindi, e in genere dietro ogni tipo di velatura più o meno ampia (con fascia, scialle, foulard, velo semplice, velo totale incluso il viso), c’è l’idea che la donna sia inferiore all’uomo e a lui sottomessa. Per questo a mio avviso non ha torto il premier francese Manuel Valls ad affermare che il burkini «è la traduzione di un progetto politico, di contro-società, fondato notoriamente sulla sottomissione della donna » e che quindi «non è compatibile con i valori della Francia e della Repubblica». E dato che la parità uomo-donna è anche un nostro valore, io penso che quel costume, e in genere l’abbigliamento che esso traduce, non sia compatibile neppure con il nostro paese.
È semplicistico dire che alla libertà di andare in spiaggia con il bikini deve corrispondere quella di andarvi con il burkini: nel primo caso infatti si assiste a un movimento di liberazione del corpo, mentre nel secondo di asservimento. E la libertà, se la si intende seriamente, non è mai solo astratta, cioè fare quello che si vuole, ma sempre concreta, cioè fare quello che è giusto e fa bene, e non ci sono dubbi che la liberazione del corpo sia un bene, anche per la liberazione della mente che ne consegue.
Il cristianesimo e l’islam, così come l’ebraismo e le altre religioni, sono quindi uno strumento di oppressione? Lo possono essere, non ci sono dubbi, c’è la storia a dimostrarlo, come del resto la storia mostra che possono diventare anche strumento di liberazione se vissuti correttamente: una liberazione dall’oppressione sociale (si pensi alla teologia della liberazione in America Latina) e una liberazione dal proprio egocentrismo e dalle proprie cattiverie, si pensi alla storia della santità e della mistica.
Il punto essenziale è comprendere che siamo inseriti tutti in un processo di cui nessuno, neppure ovviamente la laicità francese, detiene il punto di vista assoluto e alla cui evoluzione tutti sono chiamati a contribuire.
Diceva il grande teologo Raimon Panikkar che «le religioni si devono convertire ». È vero: le religioni si devono convertire all’idea di non rappresentare il punto di arrivo dell’umanità, ma di essere uno strumento a servizio del bene e della giustizia, i quali sono i veri punti di arrivo cui continuamente tendere.
L’imam di Firenze ha accostato le suore cristiane alle donne musulmane, ma ha dimenticato che le suore rappresentano un gruppo particolare di donne che ha liberamente scelto di vivere in povertà, castità e obbedienza, e il cui abbigliamento richiama il loro stile di vita alternativo. Sono ben lontane però dal rappresentare tutte le donne occidentali, le quali hanno altrettanto liberamente orientato se stesse secondo ben altri stili di vita e di abbigliamento.
L’islam, che non ha suore, in un certo senso tende a rendere un po’ suore tutte le donne che vi aderiscono. Il che però non è compatibile con l’idea di donna cui l’Occidente è giunto. E di questo i musulmani e le musulmane che vogliono vivervi dovrebbero, a mio avviso, prendere atto.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- OLIMPIADI 2016. Cento metri di libertà, la saudita Kariman Abuljadaye ha già vinto (di Alberto Caprotti)17 agosto 2016, di Federico La Sala
La storia
Cento metri di libertà, la saudita Kariman ha già vinto
di ALBERTO CAPROTTI,
INVIATO A RIO DE JANEIRO *
Kariman è lì, un po’ incerta. Ai blocchi dei cento metri. Le altre esibiscono braccia lucide, sguardi aggressivi, body sgargianti. Lei invece è una tartarugona impacciata, che non sa dove mettere piedi e mani. Addosso lo hijab d’ordinanza. Tutto nero, da capo a piedi, senza sponsor ovviamente, senza scritte. La sola ad essere coperta, a non mostrare le gambe, a chinare gli occhi.
Si chiama Kariman Abuljadayel, la sua bandiera è quella dell’Arabia Saudita. E a guardarla viene in mente che, piaccia o meno, è lei il simbolo del futuro, della donna musulmana che si mette a correre. Ma anche del passato, che ti permette di arrivarci ai Giochi ma vietandoti di vestirti come le altre, negandoti la cultura, l’informazione.
Non era una batteria importante la sua: la terza dei 100 metri donne. Quella delle meno attrezzate, diciamo così. Kariman parte lenta, passi pesanti, un fagotto nero che resta indietro. A metà pista è ultimissima, poi rimonta, fuori dall’inquadratura della tv. Bisogna alzare gli occhi dallo schermo per trovarla: quando la Wingfield, che è di Malta, lei pure terzo mondo della velocità, taglia il traguardo prima, Kariman è quasi 5 secondi dietro. Un secolo su questa distanza. Ma non arriva ultima: risale, e si lascia di poco alle spalle la Tewaaki, atleta del piccolo stato del Kiribati.
Geografie lontane, donne di un altro mondo. Quelle saudite, Kariman e altre tre, a Rio ci sono venute solo grazie a un invito speciale da parte del Cio. Le norme religiose in Arabia Saudita non consentono alle donne di praticare sport e, quindi, partecipare a eventi di qualificazione. L’unico modo per competere alle Olimpiadi è su invito del Comitato olimpico, che richiede da alcuni anni che ogni delegazione abbia almeno una donna. I sauditi hanno accettato, controvoglia. Assicurando che in nessun caso saranno violate le leggi religiose. «Continueremo ad agire in accordo con le norme governative e religiose. E così faranno anche le nostre atlete», hanno comunicato alla vigilia dei Giochi. Fissando tre condizioni: indossare un adeguato abbigliamento per la religione, l’approvazione da parte del marito della loro presenza; non entrare in contatto con gli uomini.
Questo c’è dietro quella corsa impacciata e splendida. Che anche per questo ha un senso enorme. Peccato solo che chi gareggiava con lei, non l’ha capito. Tagliato il traguardo, nessuna si è fermata ad abbracciare Kariman. Sarebbe stato favoloso se anche le altre avessero perso qualche istante con un fagotto che non correrà mai veloce, ma che è stata costretta da un governo fatto da uomini, a non partecipare in maniera indipendente alla vita. Avrebbe voluto dire che questa atletica è anche capace di ricordare i traumi, le difficoltà, le arretratezze del mondo. E di farsene carico, almeno per cento metri di strada.
* Avvenire, 13/08/2016 (ripresa parziale - senza foto).
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. - di Federico La Sala17 agosto 2016, di Federico La Sala
- CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Burka e burkiniCoprire una donna vuol dire calpestare la dignità di tutte
Una comunità dove manca lo sguardo femminile, dove il volto è consegnato alla irrealtà, non può non essere sminuita e lesa. Proprio questo non si può accettare: l’esclusione dallo spazio pubblico
di Donatella Di Cesare (Corriere della Sera, 17.08.2016)
Si chiama burkini la versione meno castigata del burka, concepita per le donne musulmane che vanno in spiaggia. Si vede qualcosa in più: i piedi, le mani, parte del volto. Sarebbe troppo definirlo un costume da bagno. Il nome fa pensare ovviamente al bikini. E forse non è azzardato vedere nel burkini una risposta identitaria ai due pezzi conquistato a fatica dalle donne occidentali: voi vi scoprite - noi ci lasciamo coprire.
Può darsi che un burkini sia anche bello. Alcuni sono perfino colorati. E c’è chi non ha mancato di ironizzare sulla forte carica erotica di quei drappeggi che, una volta nell’acqua, fanno trapelare le forme del corpo. Viene in mente l’immagine di Ursula Andress quando, nel film 007 Licenza di uccidere, esce dal mare con la muta da sub. Non è un classico dei fantasmi maschili? Come la t-shirt bagnata. Perché questa ipocrisia?
Certo è, però, che l’immagine di una donna in burkini sulla spiaggia può inquietare e irritare per numerosi motivi. Non stupiscono, dunque, le ordinanze emesse dai sindaci che lo hanno vietato, prima a Cannes, poi a Villeneuve-Loubet, sulla Costa Azzurra. Vietare, si sa, è sempre un gesto odioso. Ma a poco più di un mese dalla strage di Nizza il burkini viene percepito da molti francesi come una provocazione inopportuna che potrebbe contribuire a esasperare gli animi. Da un canto la nudità disarmata dei bagnanti, che nonostante tutto vanno in spiaggia, dall’altro quel costume-armatura che copre, fin quasi a nascondere, la donna che lo indossa.
Alla provocazione si aggiunge inoltre il segno di un’appartenenza ostentata in un modo che, nella Francia repubblicana, non può non apparire indisponente (ma lo sarebbe anche da noi). Un costume integrale che richiama immediatamente l’integralismo. Questa è la differenza rispetto ad altri simboli religiosi, dalla kippàh alla croce, che vengono invece consentiti. Si intuiscono, poi, i motivi di sicurezza, sia perché non sarebbe difficile nascondere armi, sia perché basterebbe un paio di occhiali da sole per rendere completamente irriconoscibile l’identità.
È allora difficile comprendere le proteste sollevate da quelle organizzazioni, a cominciare dalla Ligue des Droits de l’Homme e dal Collectif contre l’islamophobie en France, che vorrebbero leggere nel divieto del burkini un caso di razzismo islamofobo. Stanno difendendo il diritto delle donne o non, piuttosto, il dovere che è loro imposto dagli uomini? La risposta viene dalle immagini di Manbij, la città siriana appena liberata, dove le donne si strappano gioiosamente il velo del burka, lo calpestano o lo danno addirittura alle fiamme. In questo periodo, inquietante e drammatico, in cui da uno sfondo di violenza, a stento immaginabile, riemergono le ragazze rapite da Boko Haram, l’abbraccio tra una donna velata e una soldatessa curda è, in tutto il suo contrasto paradigmatico, il sigillo di una speranza a cui non vogliamo rinunciare.
Resta la questione del burka, che la Francia ha vietato nel 2010 e su cui, invece, la Germania si mostra titubante rinviando per ora ogni decisione. Non si tratta solo di sicurezza. Né di diversi stili di vita.
Piuttosto è il corpo della donna che, secondo l’ottica integralista, non deve comparire pubblicamente, perché è «carne scoperta», esposta, e potrebbe provocare, fuorviare gli uomini. Tanto più insopportabile è il velo che abolisce il volto della donna. Una donna coperta dal burka è protetta, difesa, venerata? O non è forse mortificata? Esclusa soprattutto dalla reciprocità del «faccia a faccia»?
A essere danneggiata non è solo la donna, la cui dignità viene calpestata, ma tutta la comunità che sul «faccia a faccia» reciproco si fonda. Una comunità dove manca lo sguardo delle donne, dove il loro volto è consegnato alla irrealtà, non può non essere sminuita e lesa. Proprio questo non si può accettare: l’esclusione delle donne dallo spazio pubblico.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO -- ANTROPOLOGIA CULTURALE NELLE SCUOLE (di Marino Niola)13 agosto 2016, di Federico La Sala
- ANTROPOLOGIA come ANTROPOLOGIA o come "ANDROPOLOGIA" E "ANDRAGATIA"?! L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE (E DEL FIGLIO), DI "MAMMASANTISSIMA":
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Miti d’oggi
Insegnare l’antropologia nelle scuole, arma contro fondamentalismo e razzismo
di Marino Niola (la Repubblica, Venerdì, 12.07.2016)
Insegnare l’antropologia culturale nelle scuole per sconfiggere integralismo, radicalismo e razzismo. Lo hanno chiesto alle Istituzioni della Ue i rappresentanti delle associazioni antropologiche europee che si sono riuniti nei giorni scorsi a Milano rispondendo all’appello delle due sigle italiane, Anuac e Aisea. È singolare che in un mondo sempre più globalizzato e multiculturale, dove forme di vita, tradizioni, identità e religioni diverse convivono gomito a gomito, manchi totalmente nelle nostre scuole una qualsiasi educazione alla differenza. Che sarebbe invece il presupposto indispensabile per costruire un dialogo interculturale pacifico.
Insomma conoscenza contro diffidenza. E contro violenza. Che spesso nascono dall’ignoranza reciproca. E dalla paura dell’altro. È paradossale, secondo Cristina Papa, presidente dell’Anuac, che in uno scenario del genere la scuola, che avrebbe il compito di formare i cittadini di domani, non preveda l’insegnamento dell’antropologia, l’unica scienza che studia proprio le differenze, ma anche le compatibilità tra culture, modi di vita, usi e costumi dei diversi popoli. E che oggi sarebbe fondamentale sia per i ragazzi europei sia per i migranti di seconda e terza generazione che, sempre più spesso, reagiscono negativamente all’impatto con il paese ospitante. Col risultato, che è sotto i nostri occhi, di rinchiudersi nella propria apartheid identitaria. E di radicalizzare la propria origine, o la propria religione, trasformandole in un’arma a disposizione del fondamentalismo. È indispensabile che la scuola e l’università colmino questo anacronistico ritardo formativo. E facciano della competenza antropologica la chiave di volta di un nuovo umanesimo.
-
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Scienza, cultura e natura dell’uovo. Storia di una cellula fantastica (di Carlo Alberto Redi - Manuela Monti).8 luglio 2016, di Federico La Sala
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
- Cogliere le cose alla radice non è facile. E la radice dell’uomo non è l’uomo stesso. Si ricordi quanto la completa conoscenza scientifica del fenomeno della procreazione sia recente nella scienza occidentale. E si ricordi che «dopo l’antica credenza nella sola responsabilità del maschio, la questione viene riveduta, diventa argomento di polemiche e resta a lungo incerta», e che, «fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società pre-patriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme»(Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, pref. di Fulvio Papi, pp. 140-141).
SIRONI EDITORE
- Storia di una cellula fantastica
 Scienza, cultura e natura dell’uovo
Scienza, cultura e natura dell’uovo
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio! Carlo Alberto Redi torna in libreria per raccontare la storia di questa cellula fantastica. Dalla conservazione degli oociti, alla produzione artificiale dei gameti, alla regolamentazione della ricerca pubblica e privata: dove vogliamo andare e con quali regole?
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio!
Il “biologo furioso” Carlo Alberto Redi torna in libreria, questa volta insieme a Manuela Monti, per raccontare la sorprendente storia di questo oggetto fondamentale della biologia che da sempre esercita un fascino speciale sulle culture di ogni epoca.
A partire dalla loro esperienza di scienziati impegnati sul campo, gli Autori ci guidano in un viaggio meraviglioso alla scoperta di noi stessi che dalla biologia passa per l’arte, la letteratura, la sociologia e - poteva mancare? - la gastronomia.
Una lettura divertente e documentata, che non si sottrae a riflessioni sui temi caldi dell’attualità scientifica.
 Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
 Pagine: 224
Pagine: 224
 Prezzo di copertina: € 19,80
Prezzo di copertina: € 19,80
 Prezzo scontato 10%: € 17,82
Prezzo scontato 10%: € 17,82 Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).
Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).Manuela Monti è biologa. Lavora alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Collabora con iisitituti di ricerca negli USA e in Giappone. È coautrice con Redi di Staminali. Dai cloni alla medicina rigenerativa (Carocci).
-
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Siamo liberi? Yes, Edipo, we can. Il vero complesso è quello dell’uomo di fronte a se stesso e alla storia: ciò che ci fa grandi non sono le risposte, ma le domande che ci poniamo (di Mauro Bonazzi)3 luglio 2016, di Federico La Sala
Siamo liberi? Yes, Edipo, we can
Il vero complesso non è quello indagato dalla psicoanalisi e definitivamente entrato nel nostro immaginario con Freud
Il vero complesso è quello dell’uomo di fronte a se stesso e alla storia: ciò che ci fa grandi non sono le risposte che troviamo ma le domande che ci poniamo
Al di là delle scoperte delle neuroscienze
di Mauro Bonazzi (Corriere della Sera, La Lettura, 03.07.2016)
Perché Edipo, subito dopo che si è strappato gli occhi con le sue proprie mani, accusa Apollo, lo incolpa di tutto quello che gli è successo? Sono lontani i tempi in cui il romanzo giallo era considerato un genere minore. Di sicuro è quello più adatto alla filosofia: in entrambi i casi si tratta di ricomporre una trama, di cercare il disegno che si cela dietro al disordine apparente. L’ordine magari non sarà quello auspicato ma comunque esiste, come ne Il giorno della civetta di Sciascia, in cui il commissario Bellodi riporta alla luce il sistema di corruzione e connivenze che permette ai tanti don Mariano Arena di prosperare sul «bosco di corna» dell’umanità.
A volte invece il giallo serve a mettere in crisi l’illusione dell’ordine, rivelando che il mondo è dominato dalla confusione. Come ne La promessa di Friedrich Dürrenmatt: paziente, meticoloso, ostinato il commissario Matthäi ha capito tutto, sa dove l’assassino colpirà la prossima volta: si apposta, ma l’attesa durerà tutta la vita (il commissario si licenzia e si mette a fare il benzinaio in una sperduta piazzola di servizio perché sa che è lì che tutto deve accadere), inutilmente, perché la sua preda, l’assassino in viaggio per il delitto, è morta in un banale incidente automobilistico. Era tutto giusto, il commissario aveva compreso, il disegno era quello, ma la realtà è governata dal caso: ogni tentativo di controllo razionale del disordine, ogni progetto di riduzione del caos a cosmo, è destinato allo scacco. Matthäi però continua ad aspettare, mentre la luce del sole si dispiega su un mondo sempre più incomprensibile.
Il dio della luce, in Grecia, era Apollo. Edipo, invece, è l’archetipo del detective, e la tragedia di Sofocle che racconta la sua vicenda, l’ Edipo re, è il modello ineguagliato del romanzo giallo. Un investigatore, intelligente, caparbio, implacabile, è sulle orme di un assassino. Laio, il re di Tebe, è stato ucciso, e Edipo, il nuovo re, vuole fare giustizia. Raccoglie gli indizi, ascolta i testimoni, ricostruisce i fatti. Alla fine scopre che il colpevole è lui stesso. È la trama più semplice, quella perfetta. L’investigatore è l’assassino: tutto si concentra in un unico personaggio, il resto non conta, fa da contorno.
Ma Sofocle non si accontenta, vuole di più. I romanzi gialli si reggono sull’incertezza. L’ Edipo re invece non fa nulla per nascondere l’identità dell’assassino, fin dall’inizio: il pubblico lo sapeva prima ancora che la tragedia cominciasse (il mito era noto) e Tiresia lo rivela subito allo stesso Edipo. L’oracolo di Delfi aveva predetto a Edipo che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre; Edipo era subito fuggito da Corinto, ignorando che Polibo e Merope non erano i suoi veri genitori. E durante la fuga aveva prima ucciso il suo vero padre e poi sposato la madre, Laio e Giocasta, i sovrani di Tebe.
La tragedia - l’indagine del commissario Edipo - svela una storia che conoscevano tutti. Come si spiega allora quella suspence che inchioda al testo qualunque lettore, che impedisce di distogliere lo sguardo dal palcoscenico? Perché Edipo non sta cercando soltanto un assassino. E noi stiamo cercando con lui. Sperando che abbia successo, ma allo stesso tempo terrorizzati da quello che lo attende in fondo al tunnel in cui si è addentrato, come in un vortice, lento all’inizio e poi sempre più impetuoso, che avvolge tutto.
Edipo è definitivamente entrato nell’immaginario collettivo nel 1900, con L’interpretazione dei sogni . Freud aveva visto bene: le vicende di Edipo ci appassionano perché in lui vediamo qualcosa di noi. Ma nella tragedia c’è molto di più che la semplice scoperta delle pulsioni (desiderio della madre, conflitto con il padre) che si annidano dentro di noi. Edipo era partito alla ricerca di un assassino e si era poi messo a indagare sui suoi genitori. Ma il vero obiettivo dell’indagine è un altro ancora, più profondo: come Diogene (quello che girava con la lanterna in pieno giorno), Edipo è in cerca dell’uomo, della sua libertà.
L’indagine riguarda tutti.
Quando era arrivato a Tebe, la città era oppressa da un mostro terribile, la Sfinge, che uccideva chiunque non rispondesse al suo enigma. Edipo aveva trovato la soluzione, salvando la città. Il mondo, quello degli antichi non meno del nostro, è opaco, oscuro, ambiguo, sempre rischioso: questo significa la Sfinge. Edipo è colui che porta la luce, con la forza della sua intelligenza. È l’eroe dell’età di Sofocle, dell’illuminismo trionfante ad Atene, «la scuola della Grecia». Come Protagora sa che l’uomo è misura di tutte le cose, come Pericle sa che possiamo rispondere alle sfide dell’esistenza. Ha insegnato che la nostra vita e la nostra felicità dipendono da noi, dalla nostra capacità di comprendere la realtà, di metterla in ordine. È un «modello» per tutti, riconosce il coro. Quando si mette in cerca dell’assassino è questo che vuole dimostrare, una volta di più.
Il momento decisivo è in uno scambio di battute con Giocasta. Edipo ha finalmente trovato un testimone decisivo. Il testimone parla e Giocasta inizia a capire: che Edipo è l’assassino di Laio; che Laio era il padre di Edipo e che lei ha sposato suo figlio. Che niente è come sembrava. Prega Edipo di smettere con le indagini, di fermarsi prima che sia troppo tardi. Scappa. Edipo si irrita, non comprende la reazione di Giocasta. Equivoca: pensa che provi vergogna all’idea di aver sposato il figlio di uno schiavo. Ma a lui questo non importa. Lo grida gonfio d’orgoglio: non era nessuno ed è diventato il re di Tebe, grazie alla sua pazienza, alla sua intelligenza, al suo coraggio. Lui è «figlio del destino», le sue origini non contano. We can . Ha mostrato di cosa è capace un essere umano.
Non ha capito nulla. Infaticabile e ostinato, Edipo, l’uomo più intelligente, per tutta la tragedia non capisce mai nulla, ha sempre vissuto nel buio dell’ignoranza. Poi, finalmente capisce: precipita nella verità come in un abisso, è stato detto. L’indagine è conclusa. Maledice Apollo. Dopo non resta che l’orrore, e il dolore.
Il figlio del destino: Edipo credeva di essere libero, padrone e responsabile per le sue scelte. Credeva che la sua vita dipendesse da lui. Ha scoperto che un destino più grande incombeva sulla sua testa, dominandolo. La libertà è un’apparenza; la vita di Edipo, il «modello» degli uomini, era già da sempre costretta in un disegno su cui lui non aveva nessuna possibilità di controllo. Si è scoperto ingranaggio di un meccanismo: un meccanismo, imperscrutabile ma implacabile, che ha il sorriso beffardo di Apollo - i Greci scolpivano le statue dei loro dèi con un sorriso enigmatico - il dio che illumina, che mostra come stanno le cose. Sul tempio di Apollo, a Delfi, campeggiava una scritta celebre: «Conosci te stesso». Edipo ha seguito l’esortazione del dio, ha indagato se stesso. Quello che ha trovato riguarda tutti.
In effetti, i problemi con cui ci confrontiamo oggi non sono diversi. Che cos’è l’uomo? Quale controllo abbiamo sulle nostre azioni, decisioni, scelte? Quanto di ciò che ci accade è dovuto a cause che non dipendono da noi - eventi del passato, condizionamenti sociali, situazioni impreviste, predisposizioni del carattere? Tanto più conosciamo, di noi e delle cose che ci circondano, tanto più le domande si fanno pressanti.
Il parallelo più interessante è con le neuroscienze. Conosciamo come non mai il funzionamento del nostro cervello: e quello che sembra emergere è che non abbiamo un controllo effettivo, consapevole e razionale, delle nostre decisioni e azioni. «Il tuo senso d’identità personale e di libero arbitrio in realtà non sono niente più che il comportamento di un’ampia organizzazione di cellule nervose e delle molecole loro associate»: questo è Francis Crick, scopritore del Dna e premio Nobel.
Tutti i nostri stati mentali sono epifenomeni, spiegano altri scienziati, non esercitano alcun impatto causale sulla realtà. Che senso ha allora parlare di libertà o responsabilità? Sarà incredibile, ma è così. E poi, a pensarci bene, non è neppure incredibile. La rivoluzione scientifica, fin dal Seicento, ha rivelato che tutto l’universo si muove secondo leggi necessarie di cause ed effetto.
E Kant aveva posto il problema, con la consueta chiarezza: per quale ragione gli esseri umani non dovrebbero essere vincolati a queste stesse leggi di natura? Cambiano i modi per dire le cose, ma l’ironia è la stessa: tanto più conosciamo tanto più ci pensiamo grandi; fino a scoprire la nostra irrilevanza. Come tutto il resto siamo parte di un meccanismo, di cui ci sfugge il senso, fuori dal nostro controllo.
Ma proprio dove maggiore sembra la miseria, lì è la nostra grandezza. È vero: ci crediamo forti e non lo siamo, pensiamo di vedere e non capiamo nulla. Ma non per questo ci arrendiamo. Siamo sempre in cerca. E in questa continua ricerca di un significato, nel coraggio con cui affrontiamo le domande più scomode, costi quello che costi, emerge qualcosa che è nostro e solo nostro, che ci distingue e ci fa unici nell’universo immenso che ci circonda. L’uomo, l’animale che fa domande, che vuole capire.
Fino a che come Edipo non smetteremo di interrogarci su quello che ci circonda senza accontentarci delle apparenze; fino a che come Matthäi e Bellodi continueremo a stare lì, in una piazzola abbandonata, su un pianeta insignificante, in attesa, cercando di capire e cercando la giustizia: fino ad allora dimostreremo che siamo qualcosa di speciale. È buffo, forse folle, ma è così. Ciò che ci fa grandi non sono le risposte che troviamo, ma le domande che poniamo. È questo il vero complesso di Edipo.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "Judith Shakespeare, vittima di due millenni di pregiudizi". I maestri del disprezzo per le donne (di Daniela Monti).8 giugno 2016, di Federico La Sala
I maestri del disprezzo per le donne
di Daniela Monti (Corriere della Sera, 08.06.2016)
Nel 1929 Virginia Woolf, nel saggio Una stanza tutta per sé, inventa una storia: quella di Judith, ipotetica sorella di William Shakespeare, stessa genialità, stessa irrequietezza, stessa voglia di fare del fratello. Per seguire il proprio talento, Judith si istruisce come può, leggendo il poco che trova per casa (ma appena i genitori se ne accorgono, le tolgono i libri e le mettono in mano delle calze da rammendare), rifiuta il matrimonio spezzando il cuore al padre, scappa per inseguire il sogno di fare teatro e viene accolta da un impresario che la schernisce e da un agente teatrale che, impietosito, la mette incinta. Alla fine, non trova altra via di uscita che uccidersi.
Mentre il talento del fratello è celebrato, il suo non vale niente: ha sfidato l’ordine naturale delle cose che la vuole debole, inferiore, indegna di ricevere un’istruzione e, insieme, selvaggia e ingestibile, una a cui mettere fin da subito il guinzaglio; si è illusa di potersi esprimere da donna e artista, senza neppure ricorrere all’espediente di camuffarsi da uomo, che pure è una strada battuta; ha sbagliato tutto, è andata fuori ruolo e infatti non c’è nessuno disposto ad ascoltarla. Così Judith «giace sepolta a un certo incrocio, lì dove ora gli autobus si fermano nei pressi di Elephant and Castle». Potessimo posare una lapide mortuaria, sopra ci sarebbe scritto: coraggiosa e ingenua Judith Shakespeare, vittima di due millenni di pregiudizi contro le donne.
Perché quello contro il genere femminile, «a conti fatti, appare come il più antico, radicato, diffuso pregiudizio che la vicenda umana è stata in grado di produrre», scrive Paolo Ercolani nel suo Contro le donne (Marsilio, pp. 318, e 17,50), resoconto dettagliato di come, dalle origini della società occidentale, scrittori, filosofi, intellettuali abbiano alimentato un dibattito «tutto fra uomini» - le donne sembrano assenti dalla filosofia, se non come oggetto del discorso dei filosofi maschi - «per arrivare a stabilire l’inferiorità inemendabile e irrecuperabile dell’essere femminile». I grandi filosofi greci, i padri della Chiesa, gli illuministi, i rivoluzionari, i filosofi idealisti, persino quel campione della causa femminile che fu John Stuart Mill: un’operazione culturale a senso unico che affonda le radici nella presunta «deficienza fisica» delle donne per poi esportare tale mancanza in altri campi, quelli dell’etica, della morale, dell’organizzazione politica della società.
Fu nell’Atene democratica, «tanto esaltata dalla tradizione occidentale, che si diffuse il costume di imporre alle donne il velo di fronte a situazioni pubbliche e a uomini scapoli, al contrario di quello che accadeva a quel tempo in Persia o in Siria», scrive Ercolani, aprendo il fronte della globalizzazione del pregiudizio, il quale, come le malattie contagiose, è riuscito a infettare culture lontane e all’apparenza inconciliabili, stringendole in un unico blocco misogino.
E loro, le donne? «Molto spesso sono le donne stesse a sminuirsi rispetto al maschio, in una sorta di autofobia indotta da secoli di indottrinamento», scrive Ercolani. Il femminismo, che pure è una delle grandi narrazioni della modernità, resta ai margini del lungo excursus, diventando esso stesso un bersaglio quando «negando l’esistenza di una specificità femminile (differente dal maschio) e prefigurando irrealistici scenari di individui a-sessuati ha finito con il fare da sponda al pensiero misogino».
La via d’uscita proposta sta nel ridefinire i canoni dell’identità e soggettività umana, al di là del «narcisismo di genere». Come scriveva Caterina Botti nel suo Prospettive femministe (Mimesis), «fino a relativamente poco tempo fa l’assenza delle donne dalla filosofia non era considerata una questione degna di nota. Oggi invece lo è».
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
- DAL "CHE COSA" AL "CHI" ... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant
- IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "PUISSANCE DE LA PENSEE". "IL MANCINO SOPPO" M. SERRES RIPRENDE LA LEZIONE DI VICO E LIBERA LA VIA DEL "CON-NAITRE"23 maggio 2016, di Federico La Sala
MICHEL SERRES "DENUNCIA" CARTESIO ("Dal metodo non nasce niente") E FA "UNA CONFESSIONE". "Pietà per il mondo, venga il nuovo sapere"(M. Serres, Distacco, 1986):
- "Paranoico, questo Io-Sole!" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, p. 18)
- "Una confessione. La filosofia, si dice, conduce alla saggezza [sagesse]. Secondo un altro significato della parola, prima di morire vorrei diventare levatrice - che in francese diciamo sage-femme, cioè letteralmente, «saggia donna» -, vorrei aiutare a partorire il mondo nuovo.
 La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
La mia vita intera mi ci ha preparato, attraverso l’ascolto attento degli scricchiolii emessi dal vecchio. Sento le crisi che attraversiamo, le inquietudini che suscitano, come dei lamenti emessi nel travaglio del parto. Amo la madre, accolgo il bambino.
 Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
Possa migliorare incessantemente la mia attività di medico ostetrico, il mio diventare sage-femme" (Michel Serres, Il mancino zoppo. Dal metodo non nasce niente [Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée], Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pp. 48-49).
- LA FILOSOFIA "MODERNA" E LA "SCIENZA NUOVA". "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio... Prima che vi fosse un uomo in Irlanda c’era un Lord in Lucania" (James Joyce, "Finnegans Wake")
 PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
Federico La Sala, La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-189 (capp. II e III):
CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- «Il contratto sessuale» di Carole Pateman. Storie congetturali che raccontano l’inaudito14 maggio 2016, di Federico La Sala
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Storie congetturali che raccontano l’inaudito
SAGGI. «Il contratto sessuale» di Carole Pateman pubblicato per Moretti&Vitali. I fondamenti nascosti della società moderna in un libro che dopo quasi trent’anni fa ancora discutere
di Alessandra Pigliaru (il manifesto, 14.05.2016)
Dare conto di ciò che Carole Pateman ha prodotto in relazione al pensiero politico moderno è decisivo. Al centro di numerose discussioni pubbliche, sia accademiche come docente al dipartimento di Scienze Politiche dell’università della California, sia politiche per le sue caustiche critiche alla democrazia liberale, tra i molti volumi e interventi che ha scritto nel corso della sua lunga vita soltanto uno è stato tradotto in italiano. Unico però, in tanti sensi - di cui il primo è l’aver costituito un punto di non ritorno. Si tratta di The sexual contract, pubblicato nel 1988 (Stanford U.P.) e tradotto per la prima volta in Italia nove anni dopo (Editori riuniti). Ormai nel dimenticatoio dei tanti «fuori commercio», è allora più che lodevole la sua recente ristampa.
Il contratto sessuale (Moretti&Vitali, pp. 339, euro 21, traduzione di Cinzia Biasini, collana «Pensiero e pratiche di trasformazione») è pietra miliare della teoria politica contemporanea, così scrive Olivia Guaraldo nell’ottima introduzione di questa nuova edizione, inquadrando il lavoro che Carole Pateman ha condotto non solo sotto il rilievo del dibattito femminista, ma anche nel senso di inaggirabilità che ha assunto nella scolarship internazionale da parte di chi si occupa di contrattualismo. A osservare la diversità di ricezione in Italia e all’estero, non potrà sfuggire che in altri paesi del mondo le ristampe sono proseguite costanti in questi decenni. L’inganno iniziale
La discontinua ricezione de Il contratto sessuale ne perimetra tuttavia la circolazione, tracciando il terreno in cui hanno attecchito le tesi di Pateman, ovvero quasi esclusivamente nell’ambito della riflessione del pensiero della differenza sessuale (di cui l’esito più recente in merito è Sovrane, di Annarosa Buttarelli per Il Saggiatore). Avere l’occasione di rileggere un testo simile significa oggi ribadire con forza intanto la tesi iniziale, e cioè che esiste un momento precedente al contratto sociale - così chiaro nello stesso titolo - che non è stato compreso dai teorici sei-settecenteschi (Hobbes, Locke, Rousseau e poi lo stesso Kant) quando si sono prodigati dapprima a stabilire l’esistenza di quel patto secondo loro originario - e poi a descrivere con minuziosa tenacia le forme della vita associata. Tornare a Pateman non è solo consigliabile a chi desidera rispolverarne il tenore teorico-pratico.
Assistere allo svelamento dell’inganno iniziale vuol dire stanare il rimosso, misurarsi con una radicalità che può costruire un ragguardevole equipaggiamento per leggere il presente. La storia «congetturale» a cui si affida Pateman serve certo all’avanzamento rivoluzionario della sua tesi; al contempo e per converso, dispone anche la cifra di ciò che è stato «il racconto più autorevole dell’età moderna».
Molti sono allora gli elementi da rimarcare della conquistata libertà civile. Intanto non è universale, visto che il contratto originario istituisce sia la libertà che il dominio, bensì ha un attributo maschile e dipende dal diritto patriarcale.
E se massiccia è stata la decostruzione operata da Pateman intorno alla radice democratica moderna, individualista e proprietaria, la narrazione ha a che fare con la genesi del diritto politico inteso come «diritto patriarcale o diritto sessuale, ossia in quanto potere che gli uomini esercitano sulle donne»; da qui viene proposta la tesi secondo cui il contratto sessuale si mantenga su un patto tra fratelli, un «fratriarcato». Seguendo la lezione di Adrienne Rich, anche Pateman si posiziona nella certezza che esista una «legge del diritto sessuale maschile». Tale diritto è, sostanzialmente, quello coniugale.
Assunzioni materiali
Eppure, se nella separazione tra contratto sociale e contratto sessuale si viene a delineare una precisa rappresentazione (il primo è tangente alla sfera pubblica e il secondo alla sfera privata), ignorando la metà della storia si cade facilmente in equivoco. Alla fine degli anni ‘80, cioè quando Pateman scrive, ha in mente di fare luce sulle strutture istituzionali di Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti per chiarire come, attraverso l’interezza della storia del contratto originario, si verifichino comunanze patriarcali insospettabili.
In questa direzione, l’autrice analizza diversi tipi di contratto, da quello di matrimonio, disossato in verità da numerosi contributi soprattutto da parte di teoriche femministe, a quello di lavoro, come anche quello che viene a definirsi tra prostituta e cliente. Tutte assunzioni che andrebbero discusse, e che infatti lo sono state possibilmente piegandole ai vari contesti, transitori e pur sempre materiali. Se i contratti presi in esame sono connotabili da iter che ne prevedono regolamentazioni o proibizioni da parte della legge, è chiaro come si tratti di particolari forme ascrivibili alla proprietà che si ritiene ciascuno e ciascuna abbiano sulle proprie persone. Ciò nonostante, «il contratto sessuale è il mezzo attraverso il quale gli uomini trasformano il proprio diritto naturale sulle donne nella sicurezza civile patriarcale».
Contingenze complesse
A restituire gradi di attualità che il testo non solo conserva ma intuisce con puntuale efficacia, il riferimento è a una clausola su cui Pateman si sofferma alla fine del settimo capitolo e che è da tenere presente nel contratto sessuale: la maternità surrogata, definita «una nuova forma di accesso e di uso del corpo femminile da parte degli uomini».
Questo per dire come il dibattito intorno alla «surrogazione», fosse il caso di tenerlo a mente quando imperversa spesso non privo di strumentalità e costruzione di blocchi identitari, aveva assunto già alla fine degli anni ‘80 una declinazione cruciale. Il caso sollevato da Pateman accenna alla celebre sentenza disposta dalla corte del New Jersey (1986 ma in due fasi e l’una contraddittoria rispetto l’altra) passata poi alla storia come «il caso Baby M.» in cui la «madre surrogante» cambiò idea e decise di non separarsi più dalla bambina. Se il carattere vincolante dello statuto giuridico di questi contratti poneva infatti delle questioni complesse in uno scenario come quello in cui già diverse erano le agenzie aperte per la surrogazione, venivano già dettagliati numeri rispondenti a profitti precisi, differenziando circa il legame tra accordi commerciali o non commerciali con la relativa soglia di legalità e liceità o meno secondo i paesi.
Ciò che viene messa a tema è però la domanda iniziale, quella secondo cui a essere in gioco sia una semplice prestazione. Da un punto di vista contrattuale infatti è puramente accidentale che la prestazione attenga o meno a questo o a quell’oggetto, così come trascurabile è il fatto che ciò che viene prodotto sia un bambino, una bambina. Su questo punto, come per altri su cui Pateman si sofferma, Il contratto sessuale è un volume ancora incandescente che vale la pena di essere rimeditato.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Prendere l’uomo alla radice. Le domande di Elvio Fachinelli (di Marina Montanelli, Francesco Raparelli).12 maggio 2016, di Federico La Sala
OperaViva Magazine un’arte del possibile
Prendere l’uomo alla radice
Le domande di Elvio Fachinelli
Il maestro ignorante
di Marina Montanelli, Francesco Raparelli (Opera viva, 09 maggio 2016)
- Alla borghesia i propri figli si presentano come eredi;
 ai diseredati come soccorritori, vendicatori, liberatori
ai diseredati come soccorritori, vendicatori, liberatori
 Walter Benjamin
Walter Benjamin
La nostra è una generazione sfortunata, deve ammetterlo anche Mario Draghi, e sta diventando superfluo ripeterlo. Così sfortunata che, oltre alla disoccupazione, al working poor, gli tocca in sorte la psicoanalisi di Stato, Massimo Recalcati e molto altro. Non bastavano il primato delle neuroscienze, il trionfo della psicologia al servizio della «mediazione», pure la riscoperta dei tabù, della Legge e del Nome del Padre: non c’è che dire, un vero e proprio accanimento.
Un volume da poco in libreria, edito da DeriveApprodi, ci ricorda che la psicoanalisi italiana ha vissuto momenti decisamente migliori: si tratta degli scritti politici di Elvio Fachinelli, dal titolo, bello quanto i testi raccolti, Al cuore delle cose (DeriveApprodi, 2016). Una penna affilata, quella di Fachinelli, che ha trasformato, tra gli anni Sessanta e Settanta, la psicoanalisi in un campo di battaglia; di più, l’ha resa arma utile per farla finita con la famiglia e il Leviatano. Psicoanalista, giornalista, militante politico: una grandissima figura del Novecento italiano ed europeo, di cui, neanche a dirlo, è stata in buona parte smarrita la memoria.
Di certo è ricordato da una parte delle istituzioni psicoanalitiche, di certo non sanno chi sia, o quasi, i giovani militanti del nostro tempo, e la filosofia accademica continua a non leggere i suoi testi fondamentali sul tempo, la ripetizione, l’estasi. Al cuore delle cose, completando e arricchendo la nota raccolta, Il bambino dalle uova d’oro, edito nel 1974 da Feltrinelli e oggi di nuovo disponibile per i titoli di Adelphi, rende finalmente possibile la «rammemorazione», lascia finalmente scoccare «l’ora della leggibilità» di questo autore, consegnandoci con forza l’attualità della sua ricerca, della sua lingua.
I blocchi tematici che articolano il volume sono davvero molti, proviamo a indicare, perciò, i più rilevanti: la riflessione sul Sessantotto e la rottura generazionale; la centralità, politica e psicoanalitica, dell’infanzia e l’«educazione proletaria»; la droga; le nuove «istituzioni d’amore»; le «estasi metropolitane». Prima di addentrarci tra i testi, preferiamo individuare le domande utili per orientare la nostra fugace esplorazione. Non è quella di Fachinelli d’altronde, così come segnalato nel suo testo programmatico del 1970, Cosa chiede Edipo alla sfinge, una «psicoanalisi interrogante»? Un «processo» aperto, un «lavoro», piuttosto che un sapere corporativo, cristallizzato nel feticcio positivistico dell’obiettività dei dati?
Ebbene sono due le domande che, a nostro avviso, attraversano per intero queste pagine di Fachinelli - la loro ricerca pratica oltre che teorica. La prima compare nelle battute introduttive de L’Erba voglio (il libro, 1971), nel volume DeriveApprodi titolate Quale autorità nella scuola?: «ma allora, conviene impegnarsi in esperienze scolastiche autonome, fuori dall’apparato istituzionale, come gli asili autogestiti - oppure in un’azione nella e contro l’istituzione scolastica esistente»? La seconda, esplicita in un articolo breve e potente dal titolo Single, ripete la domanda arrogante che i vincitori (siamo ormai negli anni Ottanta) non smettono di ripetere ai vinti: «dove siete finiti? Siete falliti, non è vero?».
La prima questione nasce in primo luogo dall’esperimento, straordinario, dell’asilo autogestito di Porta Ticinese a Milano. Momento di lotta, condiviso con Lea Melandri e Luisa Muraro, ma anche di istituzione alternativa. L’interrogazione, posta nel mezzo di una pratica situata, colpisce per la sua attualità e, come un taglio, segna tanto la psicoanalisi quanto la politica, indicandone la più intima delle giunture. D’altronde, già nella traduzione e commento, per Quaderni piacentini (1969), dell’allora inedito benjaminiano, Programma per un teatro proletario di bambini, il punto dirimente di tale interrogazione viene scorto e chiarito: seguendo le parole di Benjamin, è nel «gesto infantile» che bisogna individuare il «segnale segreto dell’avvenire», quello «veramente rivoluzionario».
E Fachinelli, che usa il Sessantotto e Benjamin (non casualmente riscoperto dal movimento studentesco tedesco) per ripensare la psicoanalisi, approfondisce: «se infatti è vero, come ritengo, che la crisi della psicoanalisi della risposta sia cominciata, e sia destinata ad aggravarsi, a livello della secessione giovanile, allora il primo e unico luogo privilegiato della psicoanalisi interrogante sarà dato dalla giovane generazione. Penso innanzitutto ai punti in cui, appena superato il rapporto biologico, tra virgolette, con la madre, comincia una fase di socializzazione che in realtà è di apprendimento, precocissimo, delle regole vigenti nella nostra società in via di massificazione». Allora l’infanzia diventa il luogo che fa la differenza.
Allora la prassi sovversiva non può che essere anche, e soprattutto, auto-formazione, educazione non autoritaria, discontinuità antropologica, proliferazione istituzionale oltre e contro le istituzioni dello Stato. Allora la psicoanalisi deve smettere di essere «istituzione tabù» normativa, semplice «sistema genitoriale accessorio», per farsi, invece, «lavoro senza fissa dimora», per rompere la sua immagine più consolidata, «quella della segregazione in un rapporto duale socialmente e culturalmente privilegiato», quella di un «settore specializzato [...] detentore di un sapere-potere separato, la psicologia» appunto.
Proseguendo nella direzione indicata da Benjamin, la possibilità della rivoluzione è indissolubilmente legata con la costruzione di un’altra pedagogia e, quindi, di un’altra antropologia: prestar fede all’infanzia, muoversi e lavorare all’interno del suo «continente», significa assumere fino in fondo il gesto davvero sovversivo di Freud, quello che - secondo le parole del bellissimo testo sul fondatore del movimento psicanalitico (Adelphi, 2012) - cercava nelle «tracce del banale, del comune a tutti» le condizioni del cambiamento, della trasformazione dell’esistente. In altri termini e, soprattutto, riscoprendo in tutta la sua serietà l’ispirazione antropologica marxiana, «politica radicale» vuol dire «prendere l’uomo alla radice», là dove «la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso». Soltanto dall’interno del processo medesimo di costruzione dell’umano è possibile immaginare l’uomo nuovo.
La seconda domanda riguarda le nuove «istituzioni d’amore» degli anni Sessanta e Settanta, in primo luogo; più in generale, a nostro avviso, i movimenti, le grandi rotture esistenziali e politiche. Ci si avvicina alla fine degli anni Ottanta, risuona con forza la boria dei vincitori, la paccottiglia postmoderna che dichiara finita la Storia, e Fachinelli tenta di riannodare i fili del «desiderio dissidente». Contro la famiglia («luogo chiuso, coatto, defecatorio»), negli anni della lunga Comune italiana sono spuntati ovunque i «gruppi di affinità, di simpatia, di bizzarria o anche solo di intolleranza per gli altri, che vanno avanti per un po’, poi si dissolvono, spariscono per ricomparire eventualmente un po’ più in là».
Simili - ed ecco una eccellente definizione di istituzioni non statali - «a quelle strutture chiamate cristalli liquidi». La voce odiosa degli anni Ottanta non si fa attendere, interrompe il ricordo: «siete falliti, non è vero»? La risposta di Fachinelli è netta: «non c’è fallimento, non c’è scacco, non può esserci, dal momento che quelli lì andavano secondo un altro ritmo, seguivano un’altra logica, piuttosto enigmatica, a volte tragica, quella del desiderio, o della libertà». Ma cosa sia questa logica, e come costituisca i gruppi, nella loro proliferazione libera, ostile all’unificazione sovrana, Fachinelli lo aveva chiarito proprio nel Sessantotto, facendo i conti - lui sì seriamente - con la «secessione giovanile».
L’esodo dalle forme di vita consolidate, per un’intera generazione, prende le sembianze di una sorta di gruppo-processo dove «ciò che conta non è la meta, non è la proposta in sé, più o meno reale [...] non è l’oggetto del desiderio, ma lo stato del desiderio». Se c’è morte del gruppo, quella è la morte del desiderio. E un desiderio morto, per dirla col filosofo, è una potenza interamente incarnata, senza resti. In una potenza che sa rimanere inattuale, in una richiesta che non smette di chiedere ancora, lì c’è il movimento, nonostante la sconfitta, nonostante l’inverno.
- Alla borghesia i propri figli si presentano come eredi;
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- "Al cuore delle cose". Fachinelli: il ’68 senza paraocchi (di Goffredo Fofi).12 maggio 2016, di Federico La Sala
Fachinelli: il ’68 senza paraocchi
di Goffredo Fofi (Avvenire, 06/05/2016)
Nel non piccolo numero dei nostri miti intellettuali il nome di Elvio Fachinelli, noto ormai a pochi, meriterebbe un posto d’onore. Ho avuto la fortuna di esserne amico, trovandomi vicino a lui in molte convinzioni e battaglie ma leggendo con più passione i suoi interventi pedagogici e politici che non i suoi, per me ostici, saggi di psicoanalisi (tentò una volta di convincermi a tradurre con lui i saggi di Lacan, ma dopo un mese di accanito lavoro ero riuscito a metterne a punto solo tre o quattro pagine...)
Ci si rende nuovamente conto della solidità del suo pensiero leggendo Al cuore delle cose. Scritti politici 1967-1989, raccolti con scrupolo e amore per Derive Approdi da Dario Borso, cui devo, anni fa, anche un’ottima traduzione dell’«intraducibile» Arno Schmidt. Sono interventi anche lunghi, articoli veloci e veri e propri saggi legati all’attualità intensissima degli anni in cui furono scritti. Uscirono soprattutto sui Quaderni piacentini e su L’erba voglio, la rivista che fondò e diresse insieme all’omonima casa editrice anche in reazione alla piega che prendeva il ’68 fossilizzatosi in gruppi e gruppetti d’impronta neo-leninista.
Fachinelli si interroga sui comportamenti umani dentro la società del tempo e sui grandi conflitti in atto (erano gli anni del Vietnam, della delusione maoista, della violenza terrorista, dei disorientamenti intellettuali). I suoi scritti più nuovi restano quelli su infanzia e giovinezza: quanta forza troviamo in questa raccolta, che si confronta con il presente storico dei suoi anni senza paraocchi, in ostinato sforzo di capire e interpretare, e anche pacatamente giudicare, esprimendo con decisione i dubbi più motivati sui comportamenti generazionali e sui modelli di potere.
Al centro c’è sempre un interesse non solo scientifico, soprattutto «politico» per un’idea di maturità ben diversa da quella d’allora e ovviamente di oggi. Confrontandosi con la cronaca ma anche con le opere che hanno segnato quegli anni (da Salò a L’albero degli zoccoli, per esempio), Fachinelli cercava ostinatamente una verità a partire dall’uomo e non dalle ideologie. Per questo ha ancora tanto da insegnare rispetto ai simil-profeti che proliferano oggi nel vasto mare dell’opportunismo mediatico.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta (di Massimo Recalcati).1 maggio 2016, di Federico La Sala
I tabù del mondoSi fa presto a dire famiglia
 La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
 Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
 Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?
Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?di Massimo Recalcati (la Repubblica, 01.05.2016)
Famiglia è ancora una parola decente che può essere pronunciata senza provocare irritazione, fanatismi o allergie ideologiche? Famiglia è ancora una condizione fondamentale e irrinunciabile del processo di umanizzazione della vita oppure è un tabù da sfatare? Se c’è stato un tempo nel quale essa appariva circondata da un alone di sacralità inviolabile non rischia forse oggi di essere condannata come una sopravvivenza ottusa della civiltà patriarcale? Sono solo i cattolici più intransigenti a sostenere la sua esistenza come indispensabile alla vita umana?
Dal punto di vista laico della psicoanalisi la famiglia resta una condizione essenziale per lo sviluppo psichico ed esistenziale dell’essere umano. La vita umana ha bisogno di casa, radici, appartenenza. Essa non si accontenta di vivere biologicamente, ma esige di essere umanamente riconosciuta come vita dotata di senso e di valore. Lo mostrava “sperimentalmente” un vecchio studio di Renè Spitz sui bambini inglesi orfani di guerra che dovettero subire il trauma della ospedalizzazione ( Il primo anno di vita del bambino, Giunti 2009).
La solerzia impeccabile delle cure somministrate dalle infermiere del reparto nel soddisfare tutti i bisogni cosiddetti primari dei bambini non erano sufficienti a trasmettere loro il segno irrinunciabile dell’amore. Effetto: cadute depressive gravi, anoressia, abulia, marasma, stati di angoscia, decessi. Se la vita del figlio non è raccolta e riconosciuta dal desiderio dell’Altro, resta una vita mutilata, cade nell’insignificanza, si perde, non eredita il sentimento della vita. Non è forse questa la funzione primaria e insostituibile di una famiglia? Accogliere la vita che viene alla luce del mondo, offrirle una cura capace di riconoscere la particolarità del figlio, rispondere alla domanda angosciata del bambino donando la propria presenza.
La clinica psicoanalitica ha riconosciuto da sempre l’importanza delle prime risposte dei genitori al grido del figlio. Non si tratta solo di soddisfare i bisogni primari perché la vita umana non è la vita di una pianta, né quella dell’animale, non esige solo il soddisfacimento dei bisogni, ma domanda la presenza del desiderio dell’Altro; vive, si nutre del desiderio dell’Altro. La vita umana non vive di solo pane, ma dei segni che testimoniano l’amore.
L’attualità politica ci impone a questo punto una domanda inaggirabile: tutto questo concerne la natura del sesso dei genitori? Essere capaci di rispondere alla domanda d’amore del figlio dipende dalla esistenza di una coppia cosiddetta eterosessuale? La famiglia come luogo dove la vita del figlio viene accolta e riconosciuta come vita unica e insostituibile - ogni figlio è sempre “figlio unico”, afferma Levinas, - è un dato naturale, un evento della biologia? Siamo sicuri che l’amore di cui i figli si nutrono scaturisca, come l’ovulo o lo spermatozoo, dalla dimensione materialistica della biologia? Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni che riflettono una concezione naturale della famiglia contengono una profonda e insuperabile contraddizione in termini?
Se, infatti, quello che nutre la vita rendendola umana non è il “seno”, ma il “segno” dell’amore, possiamo davvero ridurre la famiglia all’evento biologico della generazione? Non saremmo invece obbligati a considerare, più coerentemente, che un padre non può essere mai ridotto allo spermatozoo così come una madre non può mai essere ridotta ad un ovulo?
La domanda si allarga inevitabilmente: cosa significa davvero diventare genitori? Lo si diventa biologicamente o quando si riconosce con un gesto simbolico il proprio figlio assumendosi nei suoi confronti una responsabilità illimitata? Le due cose non si escludono ovviamente, ma senza quel gesto la generazione biologica non è un evento sufficiente a fondare la genitorialità. In questo senso Françoise Dolto affermava che tutti i genitori sono genitori adottivi.
Generare un figlio non significa già essere madri o padri. Ci vuole sempre un supplemento ultra-biologico, estraneo alla natura, un atto simbolico, una decisione, un’assunzione etica di responsabilità. Un padre e una madre biologica possono generare figli disinteressandosi completamente del loro destino. Meritano davvero di essere definiti padri e madri? E quanti genitori adottivi hanno invece realizzato pienamente il senso dell’essere padre e dell’essere madre pur non avendo alcuna relazione biologico-naturale coi loro figli?
Questo ragionamento ci spinge a riconsiderare l’incidenza del sesso dei genitori. Ho già ricordato come l’amore sia a fondamento della vita del figlio. Ma l’amore ha un sesso?
Prendiamo come punto di partenza una formula di Lacan: “l’amore è sempre eterosessuale”. Come dobbiamo intendere seriamente l’eterosessualità? Questa nozione, per come Lacan la situa a fondamento dell’amore, non può essere appiattita sulla differenza anatomica dei sessi secondo una logica elementare che li differenzia a partire dalla presenza o meno dell’attributo fallico.
L’amore è eterosessuale nel senso che è sempre e solo amore per l’Altro, per l’eteros. E questo può accadere in una coppia gay, lesbica o eterosessuale in senso anatomico. Non è certo l’eterosessualità anatomica - come l’esperienza clinica ci insegna quotidianamente - ad assicurare la presenza dell’amore per l’eteros! È invece solo l’eterosessualità dell’amore a determinare le condizioni migliori affinchè la vita del figlio possa trovare il suo ossigeno irrinunciabile.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- L’incanto spezzato della dialettica: «Hegel e Spinoza», il saggio (1979) di P. Macherey (di Giso Amendola)15 aprile 2016, di Federico La Sala
- PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA".
 CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
L’incanto spezzato della dialettica
«Hegel e Spinoza» è il saggio di Pierre Macherey scritto intorno all’operazione compiuta da Hegel tesa a neutralizzare l’anomalia rappresentata dal filosofo olandese. Un esempio di limpida battaglia politica condotta attraverso un rigoroso lessico filosofico
di Giso Amendola (il manifesto, 15.04.2016)
Crea uno strano effetto avere oggi a disposizione in traduzione, grazie alla preziosa cura editoriale di Emilia Marra, un libro importante come l’Hegel ou Spinoza di Pierre Macherey, uscito nel 1979, quasi come ultimo frutto di lotte teoriche le cui coordinate sono oggi decisamente inattuali (Hegel o Spinoza, ombre corte, euro 19). Ma un testo teoricamente densissimo continua evidentemente a porre questioni, anche se probabilmente in direzioni molto diverse da quelle all’interno delle quali era nato.
Nella premessa all’edizione italiana, Macherey indica subito al lettore questo sfasamento temporale, almeno dal punto di vista del clima generale dell’epoca: scritto quando la trasformazione radicale dell’esistente sembrava ancora un ovvio terreno di impegno per la teoria, il libro incontra oggi lettori per cui la rivoluzione non sembra essere all’ordine del giorno, o, almeno, non allo stesso modo. E certo questo cambia il tipo di lettura che il testo riceve. Probabilmente, però, non si tratta solo della temperatura più o meno calda dell’epoca, parametro poi sempre piuttosto discutibile. Quello che davvero fa la differenza, è il fatto che il libro è concepito quasi come una mossa strategica compiuta all’interno di una serie di battaglie filosofiche molto precise.
La forza dell’astrazione
Ricostruiamo allora il campo in cui Hegel o Spinoza si collocava: Macherey veniva dal lavoro in comune con Louis Althusser che aveva portato al Lire le Capital, e alcune questioni lì aperte si andavano riproponendo e radicalizzando. Soprattutto, rimane in primo piano l’obiettivo principale di portare la «lotta di classe nella teoria», stabilendo un nuovo rapporto tra pratica teorica e pratica politica. Su questo versante, il testo di Macherey è un esempio magistrale di lotta «dentro» la filosofia: una modalità di affrontare i grandi classici calandoli in un preciso campo di battaglia teorico.
Leggere i testi per quello che dicono e per quello che non dicono, nei loro buchi, nei loro silenzi e nei loro errori, secondo un altro evidente apporto althusseriano, quello della lettura «sintomatica»: in questo, l’incrocio delle interpretazioni, l’inseguimento delle forzature e dei veri e propri imbrogli che Hegel gioca con il testo spinoziano, offrono un’immagine affascinante di lotta nella teoria. Certo, il prezzo da pagare è un apparente retrocedere della storia sullo sfondo: ma proprio la forza dell’astrazione mette in luce l’importanza cruciale di queste battaglie concettuali.
E la posta in gioco in realtà è altissima, e politicamente assai concreta: anch’essa legata evidentemente a un preciso snodo del progetto althusseriano. Si tratta di far saltare tutto quel che aveva sempre ricondotto ad una sintesi pacificata il conflitto dialettico, tutto quanto aveva trasportato la dialettica nei cieli dell’«Assoluto» idealistico, eliminando proprio quel «negativo» motore del processo e relegandolo ad una semplice «stazione» della riconquista del perfetto coincidere dell’origine con se stessa. L’obiettivo fondamentale è farla finita con il finalismo già iscritto da sempre nella dialettica idealistica: solo liberando la storia dalla teleologia si libererà il pensiero dall’incantesimo idealistico e lo restituirà alla lotta di classe.
In gioco, ovviamente, c’era la separazione di Marx da Hegel, dalla filosofia della storia, dalla dialettica idealistica, e la rivendicazione del Marx del «Capitale», il passaggio a una dialettica materialista, la rottura con lo storicismo. La perfetta macchina filologica, ma nel segno di una filologia che funziona come arma di lotta, messa a punto da Macherey con questo testo, si inserisce in uno snodo successivo di questa battaglia: quando la rivendicazione althusseriana del Marx maturo contro il Marx «idealista» incontrerà finalmente lo spinozismo. Per la riflessione ultima di Althusser, è la scoperta della corrente sotterranea del materialismo aleatorio e dell’atomismo: nel testo di Macherey, questa conquista si traduce nell’immagine di uno Spinoza che offre una resistenza anticipata al rapimento idealistico della dialettica operato da Hegel.
Discesa verso l’evanescenza
Hegel non può evitare la forza di questa resistenza, l’unica a portare la sfida direttamente all’origine, al problema del cominciamento filosofico, o, in termini hegeliani, del fondamento. E proprio perché non può ignorare la resistenza di Spinoza, deve falsificarla, occultarne i passaggi critici, inventarne di sana pianta altri.
Nasce così la fin troppo celebre immagine dello Spinoza «orientale»: la sostanza spinoziana è rappresentata come un assoluto senza capacità di articolazione, «una rigida immobilità», come Hegel scrive nelle Lezioni sulla storia della filosofia, «la cui unica operazione è di spogliare ogni cosa dalla sua determinazione, della sua particolarità, e ricacciarla nell’unica sostanza assoluta, dove non fa che dileguarsi». Ma, per sostenere questa famigerata tesi sull’«acosmismo» spinoziano, Hegel deve forzare all’inverosimile il sistema, e Macherey, fedele al metodo della lettura sintomatica, illustra gli «errori» palesi che deve commettere.
Così, Hegel costretto a rappresentare il processo di espressione della sostanza negli attributi e nei modi come un processo di progressiva degradazione, fin quasi a farne una sorta di «discesa» neoplatonica verso l’evanescenza, verso il caos di una finitudine abbandonata a una negatività senza possibilità di ritorno e di riscatto. O più precisamente: proprio perché gli attributi restano «esterni» alla sostanza, si riducono a una sorta di semplici punti di vista formali sulla sostanza stessa. A una sostanza chiusa nel suo assoluto isolamento, corrisponderebbe allora un’opposizione formale e astratta di realtà e pensiero. Il monismo di Spinoza, secondo Hegel, si rovescerebbe così nell’accettazione del dualismo di Cartesio. È quella che, con grande efficacia, Macherey definisce come «interpretazione negativista» di Spinoza.
Tutto è però troppo lineare in questo Spinoza hegeliano: a partire dalla «processione» dalla sostanza agli attributi che si presenta come un rapporto discendente e privativo dall’assoluto ad una realtà umbratile che si «determina» solo per separazione e negazione. Ma per costruire quest’immagine tutta ricalcata sulla caduta, Hegel deve cancellare ogni dismisura del pensiero spinoziano: deve cioè letteralmente far fuori ogni riferimento al conatus.
Proprio attraverso il conatus, la sostanza come potenza è e resta tutta presente in ciascuno dei modi, la determinazione qui è tutta nell’affermazione della potenza, ben lungi dall’immagine evanescente del «negativismo» dell’interpretazione hegeliana. Ma per il conatus non può esservi posto nella lettura di Hegel, proprio perché non può esservi posto per l’affermazione.
La negazione assoluta
La determinazione affermativa, la potenza del conatus, costituiscono appunto il vero nucleo forte della resistenza anticipata alla riconciliazione dialettica verso cui muove Hegel: è invece la negazione assoluta, la «negazione della negazione» che dovrebbe, per Hegel, salvare la realtà dallo scivolare verso il nulla. Sono negando dialetticamente se stessa, la realtà assume autentica consistenza. O, in altri termini: la sostanza acquista movimento e si salva dal decadere a fantasma solo se, autonegandosi, ritorna a sé come Soggetto. È la trappola hegeliana: occultare l’affermazione, la positività, l’immanenza tra ordine del finito e ordine dell’infinito, insomma tutta la vera lezione spinoziana, per affermare la dialettica idealistica del «Soggetto» quale negazione della negazione.
La sostanza è soggetto, esiste solo in quanto coscienza di sé, solo in quanto tutta finalisticamente già orientata al movimento verso la coscienza: ed è proprio tutto questo che Spinoza rifiuta in anticipo. Non c’è negazione della negazione, e non c’è soggetto, il quale, scrive significativamente Macherey, è solo un altro nome della negazione che ritorna su di sé. Non c’è, per Spinoza, nessuna necessità che la sostanza si muova verso il soggetto. La vita della sostanza si esprime fuori dall’orientamento teleologico alla coscienza o al soggetto: «applicando la nozione di conatus alle essenze singolari, Spinoza elimina la concezione di un soggetto intenzionale, che non è appropriato né per rappresentare l’infinità assoluta della sostanza, né per comprendere come essa si esprima nelle determinazioni finite». Questo non significa - può concludere Macherey - che non vi sia dialettica. Si apre, anzi, la possibilità di una dialettica materialista: nessun finalismo, nessuna contraddizione autorisolventesi, ma lotta aperta tra forze e tendenze, senza nessuna conclusione garantita.
Le determinazioni finite
La dialettica idealistica è finalmente spezzata: una rottura che avviene, in questa impresa potentemente liberatoria messa in piedi da Macherey, nel segno di una felice conquista di una dinamica aperta, aleatoria, secondo il tracciato di Althusser. Letto oggi il libro apre altri interrogativi, percorsi diversi. La distruzione della teleologia è sacrosanta: ma il conatus delle esistenze singolari ci parla non solo dell’incontro/scontro di forze e tendenze, ma in modo sempre più marcato dell’apertura del campo della produzione di soggettività. Oltre il Soggetto, senza nostalgia per la «coscienza di sé», ma anche oltre quel «processo senza soggetto» attorno al quale sembra ancora girare la pur straordinaria macchina montata da Macherey.
Macherey si tiene, infatti, piuttosto lontano dallo spingere la resistenza spinoziana su strade pienamente affermative e produttive: costruisce, per esempio, un gioco di specchi, un po’ troppo scopertamente simmetrico, tra l’interpretazione «negativista» hegeliana e quella «positivista» di Deleuze, per rigettarle simultaneamente. Ma il libro, appunto, arrivò come ultimo frutto di uno straordinario tentativo di liberarsi dalla cattiva dialettica, dall’orrore di un marxismo sequestrato dal «Dia-Mat».
Oggi, per un verso, i morti hanno seppellito i morti, e possiamo finalmente occuparci d’altro. E, per altro verso, è lo stesso dispiegarsi della sussunzione reale, è lo stesso capitalismo contemporaneo che mobilita e attraversa la produzione di soggettività e sfrutta direttamente la cooperazione sociale. Rotto ogni incanto finalistico e dialettico, è quindi proprio nel cuore di un’ontologia produttiva che ci troviamo già completamente collocati. Lo Spinoza della dialettica materialista e dell’aleatorio ci liberò dagli incubi peggiori, e aprì lo spazio del conflitto e della lotta senza false promesse per l’indomani e catture dialettiche: lo Spinoza della gioia della produzione e della pienezza ontologica ci può accompagnare a riappropriarci di autonomia e di democrazia assoluta nell’oggi.
- PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA".
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Ludwig Feuerbach e i "Princìpi della filosofia dell’avvenire" (di G. Bedeschi)10 aprile 2016, di Federico La Sala
Ludwig Feuerbach (1804-1872)
L’antropologo materialista
La sua grande fortuna grazie a Karl Marx ha messo in ombra il tema fondamentale del ritorno all’uomo e ai suoi bisogni di fondo
di Giuseppe Bedeschi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 10.04.2016)
- Ludwig Feuerbach, Princìpi della filosofia dell’avvenire, a cura di Piergiorgio Bianchi, Orthotes Editrice, Nocera Inferiore (SA), pagg. 86, € 14
Feuerbach ha goduto di una grande fortuna, che però è stata per lui anche una grande maledizione: in una delle sue opere più celebri, L’ideologia tedesca, Karl Marx gli ha reso un importante omaggio, e al tempo stesso gli ha rivolto una severa critica: l’uno e l’altra hanno assicurato larga fama a Feuerbach presso i posteri nei paesi europei nei quali il marxismo ha avuto una presenza massiccia. Ma è legittimo chiedersi se il giudizio del grande rivoluzionario tedesco abbia reso piena giustizia a Feuerbach.
Questi - diceva Marx - aveva avuto sì il merito di concepire l’uomo essenzialmente come un ente naturale (contro Hegel che lo concepiva come autocoscienza, cioè come pura spiritualità), e dunque di sottolineare il rapporto uomo-natura (ignorato dall’idealismo), ma non aveva visto che quel rapporto uomo-natura non era solo un rapporto interno alla natura, bensì era al tempo stesso un rapporto dell’uomo con gli altri uomini nella produzione della vita: un rapporto materiale-sociale, che modifica profondamente e «produce» la natura (nel senso che la lavora e la trasforma continuamente). Sicché, affermava Marx, «fin tanto che Feuerbach è materialista, per lui la storia non appare, e fin tanto che prende in considerazione la storia, non è materialista. Materialismo e storia per lui sono del tutto divergenti».
Il giudizio di Marx su Feuerbach era certamente acuto, ma, come dicevamo, è legittimo chiedersi se esso non perdesse di vista alcuni aspetti fondamentali della filosofia feuerbachiana. E che sia così ce lo conferma un grande saggio del filosofo tedesco, i Princìpi della filosofia dell’avvenire (1844), che viene ora riproposto da Orthotes a cura di Piergiorgio Bianchi. Già Norberto Bobbio, curatore della prima edizione italiana dei Princìpi (presso Einaudi, nel 1946, all’indomani dell’atroce guerra mondiale), riteneva che in essi si trovasse appagata una esigenza fondamentale, dopo tante ubriacature “speculative”: quella di un ritorno all’uomo nella complessità e nella concretezza della sua natura, dei suoi bisogni e delle sue ideologie.
In effetti, nei Princìpi maturano e trovano una splendida espressione i motivi fondamentali del pensiero di Feuerbach, il quale giudica la filosofia di Hegel come «un idealismo teologico», in quanto Hegel ha concepito Dio o l’Assoluto come il complesso dei concetti (da lui esposti dialetticamente nella logica) che costituiscono la trama metafisic a della realtà. Inoltre, nell’opera di Hegel, l’uomo scompare come ente finito, dotato di bisogni materiali, e diventa pura autocoscienza, così come la natura diventa alienazione dell’idea. Perciò Hegel svaluta irrimediabilmente le scienze naturali, in quanto scienze del finito e dell’empirico: di quell’empirico che in realtà non è, in quanto si contraddice in se stesso e si annulla: per Hegel, dunque, le scienze naturali sono pseudoscienze, e a esse va contrapposta la filosofia della natura.
Per Feuerbach, invece, l’uomo è un ente naturale finito, un essere sensibile. «Infatti - egli dice - accade soltanto a un essere sensibile di aver bisogno per esistere di cose che stanno al di fuori di lui. Io ho bisogno di aria per respirare, di acqua per bere, di luce per vedere, di sostanze vegetali e animali per mangiare»... Il mondo naturale ha quindi una importanza vitale per gli uomini, e la conoscenza per eccellenza è la conoscenza di quel mondo, data dalle scienze empiriche o naturali.
D’altro canto, solo se si concepisce l’uomo come ente naturale finito si possono cogliere in tutte le loro multiformi espressioni i suoi rapporti con i suoi simili: che sono rapporti di continuo scambio e arricchimento intellettuale (dunque l’uomo è un ente naturale finito sociale) e di ricerca di amore (il sentimento più nobile ed elevato della specie umana).
Feuerbach ha proposto una filosofia che fosse essenzialmente una antropologia, la quale doveva basarsi su un processo di umanizzazione. Umanizzazione di Dio, in primo luogo. Poiché nella religione l’uomo distacca da sé le proprie qualità più alte (intelligenza, spiritualità, creatività) e le attribuisce a Dio. Questa alienazione delle qualità essenziali della specie umana in Dio comporta un vero e proprio rovesciamento dei rapporti fra uomo e Dio. Il soggetto vero, l’uomo, viene trasformato in un predicato di Dio, mentre Dio, che è creazione dell’uomo, diventa il soggetto, l’elemento creatore. Tutto ciò avviene perché l’uomo, non trovando appagamento nella realtà, crea al di fuori di essa, al di fuori del mondo concreto, una realtà sovrannaturale. Questo rovesciamento dei rapporti fra Dio e uomo - che da soggetto attivo diventa oggetto passivo - ha per effetto di diminuire e umiliare l’uomo, onde, dice Feuerbach, «per arricchire Dio l’uomo deve impoverirsi; affinché Dio sia tutto, l’uomo deve essere nulla».
Come si vede, il programma di Feuerbach mirava a una grande rivoluzione filosofica, che inquadrasse nella natura e nella realtà empirica gli uomini, coi loro pensieri e coi loro sentimenti.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Caro maschio ci fai ridere (di Naqtalia Aspesi)15 marzo 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO.
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- Resta un problema più vasto del misero maschilismo dei politici, che dovrebbero avere la furbizia di pensare ogni nequizia ma di non dirla. Se le femmine sono femministe coscienti di esserlo in gruppi privilegiati ma non oceanici, i maschi sono per natura da sempre maschilisti. Lo sono stati per secoli, per legge, religione, natura, cultura, storia, denaro, potere e mamme adoranti (Natalia Aspesi).
Caro maschio ci fai ridere
di Natalia Aspesi (la Repubblica, 15.03.2016)
E se il vecchio e scaltro Bertolaso avesse ragione? Se a ogni donna incinta, operaia, amministratrice delegata, mendicante, diva, escort, quindi anche sindaca, fosse consigliato di lasciare il lavoro, con un bello stipendio da parte ovviamente dello Stato?
PER fare solo la pre-mamma e la mamma, non per qualche mese soltanto ma almeno per qualche anno, ritrovando poi il suo lavoro e il suo stipendio? Permesso anche alla casalinga stessa, che smettendo di cucinare, rifare i letti, fare il suo dovere di sposa, sostituita da una casalinga statale in tutte le mansioni, potesse dedicarsi solo a questo mestiere solo a lei femmina consentito, per seguirlo a tempo pieno.
In questo caso essere donna e madre potrebbe essere in sé una libera professione al servizio della Patria e anche l’incinta Meloni potrebbe usufruirne senza infastidire Bertolaso e compagni, evitando di vomitare durante la campagna elettorale e di perdere le acque durante una manifestazione di piazza. Ma soprattutto togliendo all’aspirante sindaco almeno un motivo per dichiarazioni sceme, che purtroppo lo aiuterebbero a vincere le elezioni, con ovvi danni alla città già molto danneggiata. Un sindaco che allatta durante una accesa battaglia in giunta renderebbe invece la Meloni sempre vincente, perché anche i suoi più duri antagonisti maschi arrossirebbero guardando altrove: ma anche in questo caso a perdere sarebbe di nuovo Roma, e non a causa di mamma Meloni, ma semplicemente della Meloni.
Essendo da almeno cinquant’anni femminista, non vorrei essere giudicata maschilista se oso dichiarare che la signora Patrizia Bedori ha fatto molto bene a ritirare la sua candidatura, che non avrebbe neppure dovuto proporre, per molte ragioni. Perché se una può diventare sindaco perché in 74 l’hanno votata online, non pare proprio un furor di popolo, anche nel suo stesso noiosissimo movimento già molto antiquato. Perché ha smascherato definitivamente il finto giovanilismo democratico dei suoi compagni elettronici che l’hanno insultata perché “casalinga e disoccupata” come milioni di altre donne e ormai molti uomini disoccupati e casalinghi in quanto soli. Che l’hanno definita «brutta, grassa e obesa», come molti rispettati onorevoli maschi, quindi di meritare di essere «buttata fuori a calci in culo». Bastava dire che, come la maggior parte dei suoi compagni, non sembrava preparata al difficilissimo ruolo di sindaco di Milano, soprattutto dopo Pisapia.
Del resto, anche in passato i ragazzi Cinque Stelle avevano dimostrato la loro paura delle donne, come Massimo De Rosa che ha onorato le colleghe del Pd con un complimento forse invidioso: «Voi siete qui solo perché siete brave a fare i pompini!». Brutte non le vogliono quegli incontentabili, ma neanche belle. Nicola Morra, senatore M5S: «La ministra Boschi sarà ricordata più per le forme che per le riforme» (per saperne di più c’è il libro Stai zitta e va’ in cucina di Filippo Maria Battaglia).
Resta un problema più vasto del misero maschilismo dei politici, che dovrebbero avere la furbizia di pensare ogni nequizia ma di non dirla. Se le femmine sono femministe coscienti di esserlo in gruppi privilegiati ma non oceanici, i maschi sono per natura da sempre maschilisti. Lo sono stati per secoli, per legge, religione, natura, cultura, storia, denaro, potere e mamme adoranti.
Da anni cercano di correggersi, da quando negli anni Settanta si misero persino a fare autocoscienza come le ragazze. Ma non ce la fanno sino in fondo. Ogni tanto il maschio militante salta fuori, lancia un’ingiuria sempre fisica e sessuale, o, se è molto nervoso, taglia la gola della donna che non fa finta di adorarlo comunque e di essere certa della sua superiorità. Che fare? Niente, stare zitte, ridere a ogni bertolasata, che più o meno sempre ci sarà, e prendersi tutto quello che ci spetta non tanto come donne quanto come esseri umani.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- Angela Davis: "Ho fatto un sogno, cambiare il mondo". Intervista (di Antonio Gnoli)14 marzo 2016, di Federico La Sala
- SCUOLA DI FRANCOFORTE. Teoria critica....
 MARCUSE. Herbert Marcuse, il filosofo mito del ’68: un’eredità controversa. Una riflessione di Gian Enrico Rusconi
MARCUSE. Herbert Marcuse, il filosofo mito del ’68: un’eredità controversa. Una riflessione di Gian Enrico Rusconi
Angela Davis: "Ho fatto un sogno, cambiare il mondo"I pregiudizi, il carcere, la lotta per la difesa dei diritti civili dei neri e delle donne. Parla l’intellettuale americana, che arriva a Roma
di ANTONIO GNOLI (la Repubblica, 14 marzo 2016)
È STATA una delle leggende politiche degli anni Sessanta e Settanta. Una figura di spicco del movimento americano per la difesa dei diritti civili, in particolare dei neri e della donne. Angela Davis è oggi a Roma invitata dall’Università degli studi di Roma Tre. Terrà stamane una lezione cui seguirà una discussione sui temi legati al femminismo nero nell’ambito della "Women’s Liberation".
La sua maestosa e inconfondibile capigliatura è diventata brizzolata. È la sola cosa che è cambiata in una donna che continua a conservare la passione e la sicurezza dei suoi giudizi morali. La sua vita è costellata da episodi durissimi e a volte drammatici. Un’infanzia trascorsa nella segregazione di uno stato del Sud, l’Alabama. I pregiudizi e le ingiustizie subite a opera dei bianchi. Gli anni del carcere, con l’accusa di terrorismo. L’isolamento, ma anche i movimenti di opinione sorti in suo favore nel mondo. L’impegno politico e culturale. L’incontro con un maestro come Herbert Marcuse. Gli anni passati in Europa, tra la Francia e la Germania. L’insegnamento all’università.
Angela Davis ha attinto alle contraddizioni della storia americana sposando sempre la causa dei deboli. Oggi che l’America è impegnata in un’aspra campagna per le presidenziali le chiedo per prima cosa un giudizio su quanto sta accadendo nelle primarie. È indignata per i toni. "È sicuramente la campagna per le primarie più sconcertante che abbia mai visto. Non è concepibile che un candidato alla presidenza possa associarsi a delle parole pronunciate da Mussolini e giustificarsi poi, commentando che era una buona citazione. Donald Trump fa leva sui settori più razzisti e politicamente più arretrati della popolazione. È un pericolo contro cui bisognerà lavorare per assicurarci che in futuro non nuoccia più al paese".
Ritiene sia diversa l’attuale situazione dagli anni ’70, quando scrisse "Autobiografia di una rivoluzionaria"?
"È cambiato il quadro internazionale, con l’affacciarsi di nuove potenze e conflitti. Ma il razzismo non è stato sconfitto".
Perché decise di scrivere un’autobiografia? Era giovane, con delle esperienze tutt’altro che compiute.
"È un problema che allora mi posi. Per un po’ fui incerta se parlare della mia vita. Fu Toni Morrison, nel suo ruolo di editor alla Random House, a convincermi che sarebbe stato possibile scrivere un libro al cui centro ci fosse una storia collettiva di movimenti e di lotte, più che il racconto privato di una donna, allora trentenne".
Per quasi due anni lei è stata rinchiusa in una prigione, con l’accusa di terrorismo. Seguì il processo e la piena assoluzione. Con che sentimenti ha vissuto quel periodo: paura, noia, disperazione?
"Le emozioni che lei elenca le ho provate durante tutta la prigionia. Ma nello stesso tempo sentivo crescere la speranza. Molta gente si mobilitò, ritenendo un’ingiustizia la mia detenzione. La cosa più dura che mi toccò allora subire fu l’isolamento nel quale venni tenuta per la gran parte del tempo".
Oggi come ripensa a quell’esperienza?
"Oggi ritengo sia stato importante conoscere la realtà carceraria. Tanto più perché mi ha consentito di lavorare contro l’istituzione delle carceri. È stata un’esperienza che tra l’altro mi ha messo in contatto con le donne detenute e doppiamente discriminate: sia nella vita che nelle prigioni".
L’ha sorpresa che anche fuori dai confini americani ci fosse un movimento per la liberazione di Angela Davis?
"In un certo senso direi di sì. Seguivo con molto coinvolgimento le manifestazioni a mio favore. Ho visto foto di manifestanti in Europa, particolarmente Francia, Italia, Germania e Regno Unito; ma anche in Asia, in Africa, in America latina e in Australia".
È stata, in fondo, la prima globalizzazione in difesa dei diritti di una persona.
"E la cosa mi fa pensare che c’è molta più gente contro il razzismo che a favore".
Lei ha vissuto in Europa?
"Sì, arrivai la prima volta in Francia nel 1962. Ricordo che stava finendo la guerra contro l’Algeria. Ero cosciente che un razzismo, diverso da quello americano, veniva praticato sotto la forma del colonialismo. Il memoriale La question di Henri Alleg, che denunciava le torture contro i resistenti algerini, mi aprì gli occhi. Fu allora che conobbi anche lo straordinario lavoro di Frantz Fanon I dannati della terra ".
Ha conosciuto Sartre e Camus?
"Purtroppo no. Camus morì nel 1960. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo. Ricordo che nell’estate del 1961 lessi il suo libro L’homme révolté . Il mio viaggio a Parigi era funzionale alla decisione di laurearmi in letteratura francese. Mentre leggevo i classici Corneille, Moliére, Racine, scoprii la forza di seduzione di Sartre e Merleau-Ponty. Anche se non ho mai incontrato Sartre, sono orgogliosa per la sua adesione alla campagna in mia difesa. I suoi libri mi hanno aiutato a spostare i miei interessi dalla letteratura alla filosofia.
 Ma la persona che in questo campo è stata decisiva fu Herbert Marcuse".
Ma la persona che in questo campo è stata decisiva fu Herbert Marcuse".Come lo ha conosciuto?
"Durante una lezione alla Sorbona e poi in America, dove ha insegnato a lungo. Marcuse mi ha convinto a prendere molto sul serio la filosofia continentale. Trovavo affascinante il modo in cui parlava del primo Marx. La sua tesi era che non si poteva capire l’economia politica senza aver affrontato la parte filosofica di Marx. Ho avuto il privilegio, nel corso del mio ultimo anno di studi universitari, di lavorare fianco a fianco con lui. Fu Marcuse a consigliarmi di continuare a studiare a Francoforte con Adorno, Horkheimer, Habermas e Negt".
E il consiglio lo ha seguito?
"Sono stata per due anni a Francoforte. Durante quel periodo partecipavo allo SDS, un movimento studentesco di estrazione socialista, che lottava contro la guerra in Vietnam, contro lo Scià in Iran e contro i rigurgiti neonazisti tedeschi".
Adorno non era molto contento della contestazione.
"Adorno non amava la figura dell’intellettuale impegnato ed era molto critico verso ogni forma di attivismo politico. D’altro canto Marcuse era la personificazione di tutto ciò che Adorno detestava. Il suo impegno intellettuale era per tutti noi il modello culturale in cui credevamo".
In cosa credeva?
"Che il nostro compito, in quanto studiosi, fosse di cambiare il mondo sociale nel quale vivevamo".
Ammetterà che le cose più interessanti sul piano dell’interpretazione arrivarono proprio da Adorno.
"La sua acutezza come pensatore è indiscutibile. Continuo a leggere e a insegnare ai miei studenti la sua opera. In particolare La dialettica negativa e la Teoria estetica. Come studentessa, seguii le sue lezioni, partecipai ai suoi seminari e parlai con lui per discutere il lavoro della tesi. Fu in quel momento che mi resi conto che avrei dovuto operare una scelta".
Quale?
"Tra il desiderio di usare la mia formazione filosofica per cambiare il mondo e quella solo di interpretarlo. Decisi allora di interrompere la collaborazione con lui e di tornare in America".
Ritiene che la sua Teoria critica abbia ancora validità?
"Assolutamente sì! Nella versione che ne diede Marcuse si capisce che gli approfondimenti della filosofia riguardo alla libertà, l’uguaglianza e la giustizia, spesso ci obbligano a lasciare l’arena filosofica. L’eredità della "teoria critica" è di averci fatto abbracciare uno sguardo interdisciplinare".
Che cosa pensa del postmoderno?
"È un concetto ormai talmente largo che è difficile sappia fornire risposte convincenti su ciò che accade. Detto questo, credo che le teorie di Derrida e Foucault, sebbene i due abbiano poco in comune, siano di estremo interesse. Ma sono davvero dei postmoderni?".
Preferisce ancora Marx?
"Come si fa a buttarlo a mare? È ancora di grande aiuto consultarne i libri per capire i limiti dell’attuale neoliberismo. A questo proposito anche l’opera di Antonio Gramsci riveste un’importanza particolare in questo momento".
Gli anni della protesta contro il razzismo sono stati accompagnati da un clima culturale straordinario. Intellettuali come James Baldwin, scrittori della Beat generation, artisti come Bob Dylan hanno secondo lei interpretato lo spirito di quel tempo?
"I movimenti di massa che reclamano un cambiamento influenzano sempre il mondo culturale. Baldwin seppe dare una direzione al movimento e continua a essere per i giovani una spinta verso l’impegno. Quanto alla musica di Dylan, era il barometro che segnò il cambio di temperatura nel movimento culturale. Ha saputo indirizzare la coscienza popolare nella direzione progressista".
A proposito di musica, John Lennon e Yoko Ono le dedicarono una canzone. Che cosa ha provato?
"Ho un grande rispetto per Lennon e per la sua opera. E un rispetto ancora più vivo per Yoko Ono. Sono grata per avermi dedicato una canzone e per il fatto che hanno scelto di onorare la memoria di George Jackson".
Jackson fu un importante esponente delle Pantere nere. Venne ucciso nel carcere di Saint Quentin.
"Era il 1971. Fu ucciso per le idee in cui credeva e per le quali lottava".
Che ricordo ha di Angela Davis bambina?
"Non credo che la mia infanzia sia stata molto diversa da quella di altri bambini neri cresciuti nel sud segregazionista. Ma sono grata ai miei genitori per avermi aiutato ad avere una visione del mondo infinitamente più vasta del chiuso universo del Sud di "Jim Crow". Ancora oggi ho molti contatti con gli amici della mia infanzia e ritorno spesso a Birmingham, in Alabama, dove molti di loro vivono tuttora".
Chi è oggi Angela Davis?
"Una persona che crede che il mondo nel quale viviamo possa diventare un posto migliore per tutti. L’ho sempre pensato e ho sempre lottato per questo".
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- Angela Davis. All’università Roma Tre. L’incontro (di Luciana Castellina)16 marzo 2016, di Federico La Sala
La profezia della pantera Davis: «Rimpiangeremo Obama»
L’incontro. All’università Roma Tre e poi a cena con Angela Davis
di Luciana Castellina (il manifesto, 16.03.2016)
Ma qualcuno di questi studenti nati negli anni ’90 lo saprà chi è Angela Davis? Parteciperanno all’incontro promosso a Roma 3 dal rettore, il professor Panizza, e dal preside di filosofia Giacomo Marramao (che con lei ha addirittura studiato a Francoforte un secolo fa)? Saranno curiosi di conoscere quella che per noi, già maturi negli anni ’60 e ’70, è stata un mito? Quando arrivo all’Ostiense mi assale la preoccupazione che siano pochi quelli che verranno ad ascoltarla. Penso ai sondaggi che ci dicono che nessuno sa più chi era Berlinguer e crede che a vincere la seconda guerra mondiale sia stata, oltre l’America, anche la Germania.
Mi sbaglio di grosso: l’immensa aula magna dell’Università è stracolma, decine in piedi e a sedere per terra. Ci sono leader politici importanti, ma i miti sono un’altra cosa, non a caso continuano ad apparire sulle t-shirt di tutti i continenti. Angela è uno di questi miti: bella, nera, intelligente, coraggiosa, combattente del Black Panther Party, sicura di sé, oltretutto anche comunista, vittima del più orrendo razzismo, che l’ha portata in carcere senza alcuna prova imputata di omicidio, liberata dopo due anni grazie a una delle più vaste mobilitazioni innescate dal neonato ’68. Non a tutti è toccato di vedersi dedicare canzoni, diventate famose, dai più grandi: Sweet black Angela dai Rolling Stones, Angela da John Lennon, e da Noah, e da Perret, solo per nominarne alcuni. «Persino dal Quartetto Cetra» - ci informa il rettore, e questo significa davvero la popolarità.
Oggi la sua famosa capigliatura afro portata come un vessillo è grigia - di anni ne ha ormai 73 - ma la grinta le è restata tutta. I più di mille che affollano la sala dominano a stento la loro emozione, fra loro, oltre gli studenti, una quantità di femministe militanti arrivate da ogni dove, che vogliono sentire lei, solo lei, non gli importa niente di quanto diremo noi, invitati a interloquire dal palco. Vogliono dialogare loro con lei, un’occasione così non vogliono sprecarla, e si capisce. Il programma previsto salta subito - riuscirà a parlare solo la professoressa Rossini perché deve parlare del femminismo - e poi, alla fine, si formerà una lunghissima fila in attesa di prendere la parola. Ci riusciranno in poche, quasi tutte nere-italiane, e una straordinaria ragazza kurda, accolta da emozione e applausi incontenibili.
Angela parla naturalmente in inglese e non c’è traduzione, ma con mio grande stupore scopro che tutti seguono e infatti applaudono e ridono al momento giusto. Ci racconta di quanto il razzismo sia ancora esteso, non solo in America, ma ovunque: «Da voi in Europa - dice - solo ora, con i rifugiati, state facendo i conti col vostro colonialismo». E poi si sofferma molto sui palestinesi colpiti dal più indecente razzismo. («Ma da noi - avverte per ogni buon conto - chi brucia le chiese dei neri brucia anche le sinagoghe»).
Parla molto anche del femminismo nero, Angela; e comincia col dare una cifra terribile: un terzo delle donne incarcerate nel mondo, sebbene la popolazione statunitense rappresenti solo il 5%, è chiusa nelle carceri americane ed è costituita da nere. «Il genere non sta in piedi da solo» - ripete. «Questa categoria non è sufficiente a spiegare, occorre inserire anche la classe e la razza». «Guai a cadere nella trappola di un certo femminismo bianco borghese (ma anche guai a restare ciechi di fronte al maschilismo nero, comprese quello dei compagni ’pantere’)». «Hillary non ha capito - aggiunge - che il femminismo è cambiato: la questione di identità non è oggi la più importante, conta la politica di genere, non il genere in sé ormai scontato. C’è oggi un femminismo più radicale che capisce che la questione va contestualizzata, posta in rapporto al sistema dominante in cui si vive.
Per questo, del resto - dice - le donne operaie nere erano restate lontane dal femminismo, oggi non è più così». Il genere e la razza sono dunque meno importanti dell’appartenenza sociale? «No, sono contraddizioni che si intrecciano, ma che sono cambiate perché è oramai emersa una borghesia nera, frutto di una lotta contro la segregazione e che però ha significato integrazione dentro la nave del capitalismo». Molti applausi per una sua frase: «Non c’è un solo femminismo, ce ne sono molti».
L’assemblea finisce in un tripudio che accoglie le sue parole conclusive: «Qualche volta dobbiamo dire anche quello che pure ci appare irrealistico. Il ruolo della filosofia è anche questo: guardare oltre. Proprio ora dobbiamo ricominciare a immaginare cosa potrebbe essere un mondo diverso da quello in cui ora viviamo».
In queste sue parole sento l’eco forte di Herbert Marcuse, che è stato suo maestro, prima, negli anni ’60, a Francoforte, con Adorno e Oskar Negt, poi negli Stati Uniti. Dico Marcuse perché ricordo quanto ripeteva sempre: oggi l’utopia ha perduto il suo carattere irrealistico, la scienza e la tecnica permetterebbero a tutti di realizzare quanto sognava Marx, una vita in cui ci fosse il tempo liberato per far musica - aveva scritto nell’Ideologia Tedesca - preparare buoni cibi e addobbare la propria casa. Sono i rapporti sociali di produzione che ce lo impediscono.
Angela, a San Diego, dove il filosofo tedesco aveva trovato il suo rifugio, è poi andata a insegnare per molto tempo. Quando andai a passare da lui un weekend e lo intervistai per il manifesto (che lui amava molto, pur non riuscendo a leggerlo) proprio di Angela mi parlò a lungo. Perché lui non era un intellettuale separato, si sentiva parte del movimento di contestazione, che non a caso in quegli anni aveva come emblema «i tre M»: Marx, Mao, Marcuse. «Durante gli anni ’60, grazie a Marcuse - mi dice Angela - ho capito che un intellettuale può essere, anzi deve essere, parte del movimento».
Di questo e di altro chiacchieriamo a assemblea terminata, al tavolo del ristorante Biondo Tevere, in fondo al tratto urbano di via Ostiense, quello dove andava Pasolini e Visconti girò una indimenticabile scena di Bellissima. Le chiedo perché i nuovi movimenti che pur hanno animato la scena politica americana in questi anni sono rimasti bianchi o neri, poco mischiati. Per esempio Occupy Wall Street. Le ricordo la testimonianza di una militante nera che resta a disagio perché a Zuccotti Park vede tutti bianchi. E poi - la incalzo ancora - la grande mobilitazione dei neri contro la catena di assassini della polizia cominciata con l’omicidio di Mike Brown a Ferguson, il Black lives matters: quasi tutti neri. Un dato confermato dai sondaggi: la solidarietà con le lotte dei neri da parte dei bianchi era molto più forte negli anni ’60.
E ancora: le nuove importantissime lotte che si sviluppano a livello locale ma poi si estendono a macchia d’olio, sembrano essere, anche queste, o bianche o nere. Penso - la interrogo - al movimento dei lavoratori dei fast food per i 15 dollari all’ora, un salario minimo e il diritto a darsi un sindacato, che ha per slogan «non mi importa chi sia il candidato alla presidenza, voglio i miei diritti»: un movimento quasi tutto nero. E poi penso a quello cresciuto invece nelle università, animato da un milione di studenti-lavoratori che chiedono di esser pagati meglio e di aver una clausola di «giusta causa» (la scoperta dell’art.18!): quasi tutto bianco. E che è tutto per Bernie Sanders, mentre le comunità nere votano massicciamente per Hillary. Cosa succede?
«In realtà - mi risponde Angela - i neri in Occupy sono stati molto più numerosi di quanto non sia apparso, anche se la scena è stata presa dai militanti bianchi. Ma è vero che c’è separatezza: per culture, per abitudine, per luoghi in cui si abita, per condizioni lavorative. Il razzismo penetra tutto e tutti, ne siamo tutti in un modo e nell’altro infiltrati. Pensa al voto tedesco - mi dice - Non è forse effetto del razzismo?».
«Quanto a Bernie Sanders -mi spiega - devi tener conto che gioca anche il fatto che tradizionalmente i neri sono restati estranei alla politica elettorale, non ne sono mai stati davvero coinvolti. E poi Bernie Sanders è espressione della cultura politica del nord, di uno stato molto speciale come il Vermont, che è come dire ’Trentino in Sicilia’. Lui non sa parlare ai neri, è daltonico, non ha incorporato la problematica razziale, solo quella sociale, ma il suo universalismo, deve capire, è falso. E però devo dire che sta imparando, ora è già molto meglio di quanto era all’inizio».
Come gioca in questo scenario il presidente nero, Obama? «Io - risponde - penso che lo rimpiangeremo. Lo stesso movimento Occupy non avrebbe potuto svilupparsi se ci fosse stato un altro presidente. Ma, proprio perché nero, le aspettative fra i neri erano molto alte, forse troppo rispetto a quanto poteva concretamente fare, e quindi ci sono molti delusi e risentiti, cui il presidente appare solo come l’esponente della nuova borghesia nera. Mentre da Clinton non si aspettavano niente, proprio perché era bianco. E gli sono grati. Così ora votano per sua moglie. Invece che per un socialismo che sentono come cultura estranea».
Ci sarebbero milioni di cose di cui discutere. Mi piacerebbe parlare con lei, che è stata militante di un partito comunista molto ortodosso come quello americano, di cosa sia oggi il comunismo per lei, di cosa pensa dell’esperienza sovietica. Proprio lì l’avevo conosciuta, a Mosca, nel 1986, in occasione di una conferenza per la pace. C’era Gorbachev e tutte e due eravamo speranzose che qualcosa di nuovo potesse accadere in quel paese. Non è andata così. Vorrei parlarne. Ma non c’è tempo: Angela deve prendere il treno perché l’aspetta l’università di Bologna.
- SCUOLA DI FRANCOFORTE. Teoria critica....
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. - di Federico La Sala3 febbraio 2016, di Federico La Sala
- "TEBE": IN VATICANO NON C’E’ SOLO LA "SFINGE" - C’E’ LA "PESTE"!!! LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA E’ ZOPPA E CIECA: IL FIGLIO HA PRESO IL POSTO DEL PADRE "GIUSEPPE" E DELLO STESSO "PADRE NOSTRO" ... E CONTINUA A "GIRARE" IL SUO FILM PRE-EVANGELICO PREFERITO, "IL PADRINO"!!!
Il lungo (e incompiuto) processo verso la famiglia fondata su amore e accoglienza
Si discute molto di famiglia e di figli in questo periodo. Ma troppo spesso si dimentica che di “naturale” la famiglia ha poco o nulla, che nella storia e nelle varie culture essa ha assunto connotati molto diversi, e molto spesso violenti nei confronti di donne e bambini. In questo contesto, che significa che “i figli non sono un diritto”?
di Chiara Saraceno *
“I figli non sono un diritto”. Vero, non c’è dubbio. Vale per tutti: per le coppie formate da persone di sesso diverso come per le coppie formate da persone dello stesso sesso, per le coppie come per i/le single. Ma che cosa significa esattamente che non sono un diritto? Che chi non è fertile, o ha un partner non fertile, non ha diritto di provare e viceversa che basta essere fertili (e in un rapporto di coppia eterosessuale) per avere automaticamente il diritto di avere un figlio? Quando si discute di diritti e li si aggancia ad una idea di “natura” e di “normalità” si intraprende una strada molto scivolosa. Una strada lungo la quale si incontrano molte violenze, in particolare contro le donne e i bambini, ma talvolta anche contro gli uomini.
Qualche secolo fa in Italia le donne nubili sospette di essere incinte venivano imprigionate per evitare che abortissero, salvo togliere loro i figli perché “indegne” di essere madri. In Irlanda, come ci ha ricordato il film Le Maddalene, la cosa è durata fino a qualche decennio fa con il beneplacito della Chiesa Cattolica. In nome della protezione della “paternità legittima” i figli nati da un uomo sposato fuori dal matrimonio non potevano essere riconosciuti da quello. E una madre coniugata che avesse un figlio con un uomo diverso dal marito, magari lontano o da cui era separata, aveva di fronte a sé solo due scelte: o non riconoscerlo affinché il padre, se non a sua volta sposato, potesse farlo lui, oppure tacere, attribuendone la paternità al marito. Il tutto con buona pace dell’oggi tanto sbandierato principio che i bambini hanno bisogno di un padre e di una madre, possibilmente biologici.
Nella legge 40, fortemente voluta da una grossa fetta dei parlamentari cattolici e la cui abrogazione per via referendaria è stata attivamente impedita dalla gerarchia cattolica, si è vietata sia la riproduzione artificiale con donatore o donatrice, sia il ricorso all’esame pre-impianto degli embrioni nel caso di aspiranti genitori portatori di malattie genetiche gravi, che avrebbero comportato sofferenze atroci all’eventuale nascituro. Ci sono volute sentenze delle Corti italiane ed europea per cancellare questa mostruosità voluta da parlamentari ottusi e arroganti che, con la benedizione della Chiesa, si arrogavano il diritto di dire chi può e in quali condizioni fare figli e chi no. Se dovessero poter avere figli solo coloro che sono fertili, e in coppia eterosessuale, dovremmo non solo condannare ogni forma di riproduzione assistita, inclusa quella con gameti della coppia, ma anche vietare l’adozione.
Nella nostra società e cultura da lungo tempo si è passati da un’idea che si facessero figli - in proprio o tramite adozione - vuoi perché “venivano”, come non sempre benvenuta conseguenza di un rapporto sessuale, vuoi perché utili alla dinastia o all’impresa famigliare, ma perché danno gioia e aprono al futuro. Come ha ammesso, con un lapsus involontario, lo stesso cardinal Bagnasco, la famiglia non è un fatto ideologico, bensì antropologico. Appunto, l’antropologia, e la storia, ci mostrano che qualunque sia la “famiglia voluta da Dio”, secondo la sorprendente e astorica definizione di papa Francesco, le famiglie umane vengono in forme e contenuti diversi.
Non c’è un’unica “famiglia umana”. Ed alcune forme di famiglia anche del nostro recente passato erano intrinsecamente violente nei rapporti di genere e generazione, non solo a livello individuale, ma proprio di conformazione istituzionale.
C’è voluto un lungo processo, non del tutto compiuto, perché la dimensione fondamentale, autenticamente generativa, della genitorialità fosse l’accoglimento e l’assunzione di responsabilità e perché la cifra della relazione genitori-figli (come per la coppia) fosse l’amore E’ su questo che si gioca il “diritto ad avere figli” o, meglio, a provarci, non di fronte alla legge, ma di fronte alla propria coscienza.
Le tecniche di riproduzione assistita, e più ancora la possibilità di ricorrere ad una madre gestante per altri, acuiscono ed esplicitano la necessità di effettuare - ciascuno nel proprio foro interiore - questa valutazione: non solo perché la scelta di diventare genitori è necessariamente più esplicitamente intenzionale, ma perché coinvolge più soggetti e modifica di poco o tanto il nesso tra coppia, sessualità, generazione. Di nuovo, vale per tutti, non solo per le persone omosessuali.
Quando si smetterà di pretendere di possedere la verità e il monopolio della definizione di chi può fare famiglia e chi può avere figli, finalmente si potrà aprire una riflessione in cui tutte le parti possano trovare voce e ascolto, con rispetto e pazienza, per fare un passo ulteriore nel processo di civilizzazione della famiglia e dei rapporti di sesso e generazione.
-
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ARISTOTELE E FILLIDE: UNA "STORIELLA" DI LUNGA DURATA. Una nota di Donatella Cianci.28 gennaio 2016, di Federico La Sala
- A PARTIRE DA PLATONE E ARISTOTELE, L’INTERA TRADIZIONE FILOSOFICA ha sempre sostenuto “per diritto naturale che la materia obbedisca alla forma, il corpo all’anima, l’appetito alla ragione, i bruti all’uomo, la moglie al marito, l’imperfetto al perfetto, il peggiore al migliore, per il bene dell’uno e l’altro dei due”
Fillide, la donna che volle cavalcare Aristotele
di Donatella Cianci (Il Sole-24 Ore, Domenica, 21/07/2013)
Aristotele ha parlato dell’akrasia, della debolezza della volontà rispetto alla virtù rafforzata dall’etica e probabilmente ne aveva fatto esperienza nella sua quotidianità con le donne. Una leggenda poco nota, forse la più stravagante di tutta l’iconografia aristotelica, lo raffigura anziano e piegato, mentre si fa cavalcare sulle sue spalle da una giovane donna.
La ragazza probabilmente era Fillide, “primadonna” esempio della debolezza filosofica, come ricorda lo studioso Infurna in un volumetto pubblicato per i tipi di Carocci, il quale sottolinea che i primi a parlare di questa vicenda, in Occidente, son stati Jacques de Vitry e Henri d’Andeli, quest’ultimo in un poemetto dei primi del Duecento, nel quale si dice: «Quella donna è bella davvero. Mi piacerebbe vedere come sta addosso. Rendimi questo servizio! Se presto arriverò alla fonte, volentieri ti concederò di baciare all’istante la mia bocca». La donna desiderava “cavalcare” uno dei più importanti filosofi dell’Occidente e ci sarebbe riuscita, probabilmente mentre il giovane Alessandro (poi divenuto Magno) se la spassava a guardare quanto l’anziano maestro avesse perso il senno per quella sua follia d’amore.
Un prezioso e originale volumetto a cura di Marco Infurna (Henri d’Andeli, Il Lai di Aristotele, Carocci, 2005) ricostruiva le origini di questa storiella, forse di origine orientale, poi approdata in area francese. In Italia l’episodio è ricordato da Brunetto Latini nei Livres dou tresor, da Paolo Zoppo e da Enea Silvio Piccolomini, fonti che raramente si menzionano. Nel XIV secolo la leggenda è invece citata da Francesco da Barberino nel suo trattato Del reggimento e dei costumi delle donne.
In ambito iconografico, come mostra un’ampia ricerca non ancora pubblicata, le raffigurazioni sono centinaia, una molto nota è quella che si vede a San Gimignano.
- Memmo di Filippuccio, Fillide e Aristotele - particolare dagli affreschi dal Palazzo Comunale di San Gimignano (Siena) - inizio XIV secolo.
Ma come mai l’episodio ha avuto una tale ricezione? Certamente l’eccitazione e la passione amorosa del severo filosofo colpì i più curiosi, tanto che Bedier, nel 1926, pensò che Aristotele fosse impazzito a causa del suo intenso lavoro. Invece, come ricordato anche ne Il lancio del nano da Armando Massarenti (Come smettere di fumare, Aristotele vs Platone), Aristotele era conscio e tollerante verso la debolezza umana, verso la passione, concetto ribadito in studi degli anni ’90 di ambito anglosassone, che evidenziano una discrepanza fra il livello normativo e l’effettivo agire.
Infurna non fa riferimento alle fonti greche, ma è interessante notare come nella biografia aristotelica spunti il nome di una certa “Erpillide”, che fosse proprio Fillide? Il retore Alcifrone scrisse che lo Stagirita si stava facendo dilapidare il patrimonio da quella ragazzina: «Sei diventato matto Eutidemo, non sai dunque chi è in realtà quel saggio dall’aria così arcigna, che vi espone tutti quei discorsi elevati, ma quanto tempo credi che sia passato da quando mi ha dato il tormento perché vuole uscire con me? Tra l’altro, si fa consumare il patrimonio da Erpillide, la sua favorita di Megara». Dalla donna probabilmente Aristotele ebbe anche un figlio. Il nome torna anche in Eusebio, nel lessico Suda e persino nel biografo dei filosofi, Diogene Laerzio.
Per saperne di più:
 Henri d’Andeli, Il Lai di Aristotele, a cura di Marco Infurna, Firenze, Carocci, 2005;
Henri d’Andeli, Il Lai di Aristotele, a cura di Marco Infurna, Firenze, Carocci, 2005;
 Raffaele di Cesare, Di nuovo sulla leggenda di Aristotele cavalcato: in margine ad una recente edizione del Lai d’Aristote di Henri de Andeli, Milano, Vita e Pensiero, 1956;
Raffaele di Cesare, Di nuovo sulla leggenda di Aristotele cavalcato: in margine ad una recente edizione del Lai d’Aristote di Henri de Andeli, Milano, Vita e Pensiero, 1956;
 Id., Due recenti studi sulla leggenda di Aristotele cavalcato, Milano, Università Cattolica del S. Cuore, 1957;
Id., Due recenti studi sulla leggenda di Aristotele cavalcato, Milano, Università Cattolica del S. Cuore, 1957;
 Laura Dal Prà, Roberto Perini, Artigianelli, Il ciclo pittorico di Castel Pietra al tramonto dell’età cortese, Trento, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 1992;
Laura Dal Prà, Roberto Perini, Artigianelli, Il ciclo pittorico di Castel Pietra al tramonto dell’età cortese, Trento, Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali, 1992;
 Le vie del gotico: il Trentino fra Trecento e Quattrocento, a cura di Laura Dal Prà, Ezio Chini, Marina Botteri, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni culturali, Ufficio beni storico-artistici, 2002.
Le vie del gotico: il Trentino fra Trecento e Quattrocento, a cura di Laura Dal Prà, Ezio Chini, Marina Botteri, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni culturali, Ufficio beni storico-artistici, 2002. -
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Del femminile come oggetto (di Nicla Vassallo)26 gennaio 2016, di Federico La Sala
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
- ESTETICA (E NON SOLO) E DEMOCRAZIA. PER LA CRITICA DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO E DELLA CREATIVITA’ DELL’ "UOMO SUPREMO" (KANT).
 CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
Del femminile come oggettodi Nicla Vassallo (SCENARI, 25.01.2016)
Presso i Musei Vaticani, al cospetto della Scuola di Atene di Raffaello, la presenza di maschi/uomini risulta netta, netta se non fosse per un “ambiguo” individuo, a fianco di Parmenide: forse si tratta di Ipazia - non tutti concordano. Ipazia, certo, non era una donna oggetto, e così l’hanno brutalmente uccisa. Anche Diotima, prima di Ipazia, non raffigura, unica donna nel Simposio di Platone, nient’affatto una donna oggetto. Tuttavia, di tali donne la storia della filosofia ne ricorda ben poche: le donne sono state martoriate dai filosofi, con qualche eccezione a parte - Cartesio e John Stuart Mill, ad esempio.
Prendiamo Aristotele: le donne rimangono maschi menomati o mutilati; il loro essere femmine si deve alla mancanza di potenza; la loro femminilità coincide con la passività, e da passive vanno trattate, al pari di oggetti. E via di seguito con le generalizzazioni: rispetto agli uomini, le donne si attesterebbero impulsive, doppie, gelose, petulanti, spudorate. Avremmo potuto confidare in Tommaso, il santo, che invece in proposito si fa anche lui portatore dei pregiudizi aristotelici. Pregiudizi che si replicano, con variazioni sul tema, nei cosiddetti “grandi” filosofi: stando a Kant, le donne non risultano in grado di azioni genuinamente etiche per carenza di senso del dovere (del resto, che etica può possedere un oggetto?); per Hegel, esse debbono venir rinchiuse in casa, in quanto prive di ragionamento universale, che si esige invece in ambito politico e pubblico (del resto, di quale ragionamento universale dispone un oggetto?); secondo Schopenhauer le donne permangono “per natura” inferiori rispetto ai maschi, in quanto, decretate perennemente infantili, manipolatrici e bugiarde, esse mancano di intelligenza e senso di giustizia (donne, pur sempre, oggetti); a parere di Nietzsche le donne sono un gingillo, utile solo a procreare e a rappresentare un mero passatempo per gli uomini (sono strumenti, proprio come alcuni oggetti).
Le donne simboleggiano dunque irrazionalità, o, se va bene, una razionalità che dipende dagli uomini. Non ritengo infatti causale che tra le filosofe si esaltino (con o senza ragione?) donne legate a filosofi di sesso maschile: basti menzionare Eloisa (con Abelardo), Simone de Beauvoir (con Jean-Paul Sartre), Hannah Arendt (con Martin Heidegger).
Alle emozioni, invece, specie se emozioni legate alla follia, le donne, poetesse, non filosofe, vengono destinate. Saffo (solo per menzionare qualche esempio) canta amori sublimi, per poi gettarsi da una rupe. La timida e sensibilissima Antonia Pozzi, divisa tra amori, sceglie la morte con barbiturici, a ventisei anni; scrive di eros e thanatos, con selvagge siepi/di amori: morire è questo/ ricoprirsi di rovi/ nati in noi. Sylvia Plath si uccide a trent’anni, con la testa nel forno (la testa della poetessa e il forno della moglie-madre) dopo aver cantato la morte:
 Morire è un’arte, come qualsiasi altra cosa.
Morire è un’arte, come qualsiasi altra cosa.
 Io lo faccio in un modo eccezionale
Io lo faccio in un modo eccezionale
 io lo faccio che sembra un inferno
io lo faccio che sembra un inferno
 io lo faccio che sembra reale.
io lo faccio che sembra reale.
 Ammetterete che ho vocazione.
Ammetterete che ho vocazione.Anne Sexton “sopravvive” più a lungo, ma a quarantacinque anni in un garage si intossica col monossido di carbonio. E, infine, non posso che menzionare lei, Virginia Woolf, non poetessa, bensì scrittrice poetica e folgorante, che opta a cinquantanove anni per una morte “tecnicamente” difficile: con le tasche ricolme di sassi, si lascia annegare nel fiume Ouse. Lei che aveva scritto Al Faro, e di acqua s’intendeva.
Se le filosofe prima menzionate si accoppiano e associano a uomini, con le poetesse il tutto non è immediato. Di Saffo si narra che amasse le donne. Sylvia Plath cosa c’entrava davvero con Ted Hughes? E chi si ricorda di Alfred Muller Sexton? Mentre di Virginia Woolf diremmo che nutrisse una reale passione per il marito Leonard, o per Vita Sackville-West?
Le donne che rifiutano categoricamente di essere considerate donne oggetto non hanno forse alcuna scelta se non il suicidio?
E, invece, gli omicidi? Si uccide, come distruggono gli oggetti. Prendiamo Dante che nel Canto V del Purgatorio, con Pia De’ Tolomei, ci porta nel girone di coloro che, a causa di una morte violenta, trovano il pentimento, una sorta di riabilitazione, in fin di vita. Che tipo di pentimento? Di Pia De’ Tolomei, uccisa dal marito, entro un contesto familiare, ci viene comunicata la dolcezza, insieme alla volontà di venir ricordata per una qualche sua fede. Benché in relazione al mondo terreno la sua indifferenza e il suo autocontrollo rimangano sospetti, perlomeno agli occhi odierni, il suo “ricorditi di me” ci addolora: Pia suscita in noi un desiderio, una necessità di protezione. Pia De’ Tolomei invoca aiuto, così come si dovrebbe fare. Anche se non fosse mai esistita e la sua fama si dovesse solo a Dante, la Pia rimane l’emblema di un entusiasmo divorato dalla violenza. Quante e quali Pie incontriamo quotidianamente senza saper nulla di loro, e senza che nulla ci raccontino? Le sconcertanti violenze degli uomini sulle donne, nel mondo, specie all’interno delle mura domestiche, si traducono raramente in denunce. Quali le loro cause e i loro significati? Se non sei una persona, bensì un oggetto di mio possesso, mi è lecito far di te quanto mi pare. E le donne sono persone?
A rispondere negativamente è una «femminista immutata», Catharine MacKinnon, che si domanda proprio se le donne siano oggetti o esseri umani, per concludere seccamente che non sono esseri umani.
Perché? Semplice la ragione. Se le donne fossero esseri umani, non sarebbero spedite in container dalla Tailandia ai bordelli di New York, o rapite in sperduti villaggi nigeriani e gettate poi sulle strade italiane; non sarebbero sessualmente schiavizzate; non lavorerebbero tutta la vita senza salario o con salari indecenti, costrette a svolgere mansioni pesanti, pericolose o avvilenti per troppe ore al giorno; non verrebbero infibulate, percosse, stuprate; non si pretenderebbe che sposino il proprio stupratore, né sarebbero accusate di rapporti sessuali fuori del matrimonio quando denunciano l’uomo in questione; non sarebbero indotte a suicidarsi per riparare l’onore della propria famiglia; non dovrebbero nascondersi dietro burka o simili indumenti; non sarebbero costrette nelle loro case come in prigioni; non subirebbero molestie sessuali e mutilazioni genitali (nella sola Africa vi sono tuttora tre milioni di bambine ancora a rischio di subirle, nonostante l’ONU abbia recentemente e finalmente bandito dette mutilazioni); non verrebbero messe a tacere, torturate, lapidate, decapitate, o uccise appena nate (l’infanticidio delle figlie femmine è ancora praticato). La lezione che occorre ricavare da questo elenco non è onorevole: le donne rimangono sotto più punti di vista oggetti, mentre gli obiettivi femministi e delle filosofie femministe non sono stati conseguiti. «Una stanza tutta per sé» e «cinquecento sterline annue» rimangono chimere.
MacKinnon si riferisce a cosa accade nel mondo in generale. Dando un’occhiata a cosa accade solo nel mondo cosiddetto occidentale, le immagini di donne da cui si viene bombardati/e sul piano mediatico si condensano troppo spesso in donne “leggere”, la cui reale consistenza è il corpo, non una mente ragionante; sono immagini normative che esplicitano chiaramente “questo è come la donna deve essere”; sono immagini che certo possono mutare e, difatti mutano, ma che rimangono sempre centrate sul corpo. Sull’oggetto.
Difficile fuggire dalla trappola. Non tutte le donne sono intelligenti, d’accordo. Ma molte tendono effettivamente a esaltare un’apparenza fisica “femminile”. E se ci pone come “cattiva ragazza”, ovvero si trasgredisce la norma maschile eterosessuale, nel non corrispondere (almeno in qualche senso) al concetto di donna vigente, si corre il rischio dell’esclusione, e l’esclusione non è facile da sostenere.
Il concetto di donna vigente nella nostra civiltà, specie in Italia, da una parte regala in effetti mere illusioni di stabilità e d’identità, e dall’altra è rigidamente monolitico: deve così essere in una società androcentrica, razzista, eterosessista, votata alla “normalità”. Come è sostenuto, giustamente a mio avviso, il rimedio alla donna oggetto non può che consistere nel delegittimare «a priori l’esplorazione della continuità esperienziale e della base strutturale comune tra le donne» (cfr. Bordo 1990, p. 142). Del resto, molte donne, ma non tutte, cedono a venir meticolosamente assoggettate sotto diversi profili: economico, legale, politico, professionale, psichico, religioso, sessuale, sociale, e via dicendo. In modo diretto o indiretto, in misura maggiore o minore, ogni donna eterosessuale subisce commerci, devianze, etiche, leggi, identità, molestie, pratiche, politiche, violenze sessuali, oltre a doveri erotici, procreativi e riproduttivi, all’insegna di schemi rappresentazionali dettati da interessi sessuali. Ancora oggi. Che cosa specificare di più sulle donne oggetto?
Una certa normatività rimane deleteria e si converte comodamente in forme di vero e proprio autoritarismo sulla sessualità, in cui a rannuvolarsi rimane la sessualità delle donne. Diviene allora quasi scontato affermare con Monique Witting che, per esempio, le lesbiche non sono donne, perché il concetto di donna giunge a una piena elaborazione e assume un valore determinato solo nell’ambito di un atteggiamento normativo che obbliga la sessualità entro i rigidi schemi di un’eterosessualità in cui le donne vengono categorizzate, all’unico scopo di essere vessate (cfr. Wittig 1992). Si può anche concedere che si vessino gli oggetti, non le persone o gli esseri umani.
Ben si sa che, nel caso in cui non ci si comporti da donne oggetto o ci si consideri con consapevolezza donne non eterosessuali, sbalordisca sentirsi dire “tu non sei una donna”. Inquieta perché “tu non sei una donna” equivale spesso a “tu non sei una vera donna”, ove il termine “vero” maschera approvazione e disapprovazione. Proprio come quando affermiamo “la verdura di oggi non è vera verdura” intendiamo dire che tale verdura non è buona, quando diciamo “Valeria non è una vera donna” intendiamo dire che Valeria non è una donna “buona”: biasimiamo certi suoi atteggiamenti, comportamenti, ruoli che non rientrano nel concetto di donna “valido” e in uso in una certa cultura, a un determinato tempo (cfr., per esempio, Austin 1962, per considerazioni simili sul termine “real”). “Tu non sei una vera donna” comporta essere disapprovate, e lo si è perché non si corrisponde al concetto di donna vigente, di cui fanno parte parecchi pregiudizi (e allora che concetto è?) sulle differenze tra donna e uomo, a partire dalle differenze sessuali. È possibile che tu non sia una vera donna solo a causa dei tuoi desideri sessuali, che non corrispondono a quelli che la donna dovrebbe normativamente nutrire. Dunque, tu non sei una vera donna poiché rifiuti di oggettificarti.
È allora errato decretare, se non si esigono donne oggetto, che la differenza sessuale sia una componente essenziale del desiderio sessuale, è cioè errato consentire il desiderio sessuale solo tra donna e uomo, o tra femmina e maschio - tra la donna e l’uomo, tra il maschio e la femmina. Eppure è forse proprio il fine di circoscrivere il desiderio sessuale al rapporto eterosessuale che rende la differenza sessuale necessaria al desiderio sessuale, a partire dal presupposto che il rapporto sessuale deve essere finalizzato alla riproduzione, piuttosto che all’amore e alle varie rappresentazioni vissute che dell’amore si possono offrire (cfr. Vassallo 2015).
Il punto è che il maschio e la femmina, l’uomo e la donna hanno poca ragione d’essere, se con l’articolo determinativo intendiamo richiamarci a entità universali, al fine di catturare essenze maschili e femminili, che proseguono a incidere sulle donne rendendole oggetti. Tali entità/essenze possono trasformarsi in fonti di veri e propri azzardi, nell’azzerare la comprensibilità tra le tante differenze che corrono tra femmine e tra donne, così come le tante differenze che corrono tra maschi e tra uomini. La logore banalità dovrebbe venir sempre denunciata dalla buona filosofia, a partire dalle differenze tra femmine e maschi, tra donne e uomini, che la società rischia vieppiù di enfatizzare indebitamente, allo scopo di condizionare comportamenti e competenze declinate al “maschile” e al “femminile”, con donne oggetto in primo piano (cfr. Amoretti e Vassallo).
In fondo la donna rimane pura apparenza, una finzione al servizio dell’androcentrismo, del razzismo, dell’eterosessismo, della “normalità”, uno strumento normativo utile per imporre agli esseri umani di comportarsi in determinati modi, per avallare determinate pratiche e delegittimarne altre. L’idea che tutte le donne presentino similarità essenziali serve, per esempio, a legittimare il fatto che alle donne e agli uomini vengano assegnati ruoli culturali, professionali, sessuali e sociali distinti, che le donne debbano attenersi a canoni di genere cognitivamente diversi rispetto a quelli degli uomini, che i tratti fisici e psicologici delle donne debbano essere femminei, mentre quelli degli uomini mascolini. L’essenzialismo ha senz’altro legittimato un certo convenzionalismo femminile, costringendo le donne al perbenismo, vietando loro la realizzazione completa delle loro potenzialità. Del resto, le donne rimangono oggetti. Ma esso ha soprattutto ratificato il dualismo uomo/donna, da cui sono aristotelicamente zampillati altri pericolosi dualismi: mascolino/femmineo, razionale/irrazionale, attivo/passivo, culturale/naturale, oggettivo/soggettivo, e così via.
Torno ancora, in conclusione, a MacKinnon sulle donne oggetto, una conclusione dura, eppure realistica, che tratta di pornografia:
- «We define pornography as the graphic sexually explicit subordination of women through pictures and words that also includes
 (i) women are presented dehumanized as sexual objects, things, or commodities;
(i) women are presented dehumanized as sexual objects, things, or commodities;
 or (ii) women are presented as sexual objects who enjoy humiliation or pain;
or (ii) women are presented as sexual objects who enjoy humiliation or pain;
 or (iii) women are presented as sexual objects experiencing sexual pleasure in rape, incest or other sexual assault;
or (iii) women are presented as sexual objects experiencing sexual pleasure in rape, incest or other sexual assault;
 or (iv) women are presented as sexual objects tied up, cut up or mutilated or bruised or physically hurt;
or (iv) women are presented as sexual objects tied up, cut up or mutilated or bruised or physically hurt;
 or (v) women are presented in postures or positions of sexual submission, servility, or display;
or (v) women are presented in postures or positions of sexual submission, servility, or display;
 or (vi) women’s body parts-including but not limited to vaginas, breasts, or buttocks-are exhibited such that women are reduced to those parts;
or (vi) women’s body parts-including but not limited to vaginas, breasts, or buttocks-are exhibited such that women are reduced to those parts;
 or (vii) women are presented being penetrated by objects or animals;
or (vii) women are presented being penetrated by objects or animals;
 or (viii) women are presented in scenarios of degradation, humiliation, injury, torture, shown as filthy or inferior, bleeding, bruised, or hurt in a context that makes these conditions sexual».
or (viii) women are presented in scenarios of degradation, humiliation, injury, torture, shown as filthy or inferior, bleeding, bruised, or hurt in a context that makes these conditions sexual».
 (Non traduco, poiché questo inglese possiede una forza che in italiano si smarrirebbe.)
(Non traduco, poiché questo inglese possiede una forza che in italiano si smarrirebbe.)
Alle donne la scelta, in quei luoghi, societari e civili, in cui la ragione è concessa.
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL VANGELO DEL CONFLITTO, LA MISERICORDIA, E LA "MEDIAZIONE" (di Asor Rosa)20 gennaio 2016, di Federico La Sala
Il Vangelo del conflittodi Alberto Asor Rosa (la Repubblica, 20 gennaio 2016)
Nelle settimane passate è apparso in Italia un testo di Papa Bergoglio, che a me sembra di grande importanza. Si tratta dell’intervento da lui pronunciato a un Congresso internazionale di teologia (da lui stesso voluto e preparato), svoltosi a San Miguel in Argentina dal 2 al 6 settembre 1985, sul tema “Evangelizzazione della cultura e inculturazione del Vangelo”.
L’intervento, nella forma pubblicata da Civiltà cattolica, porta il titolo “Fede in Cristo e Umanesimo”. Ritengo però che il suo vero tema sia più esemplarmente testimoniato da quello del convegno.
Andrò per accenni, limitandomi a segnalare quello che, dal mio punto di vista, spicca per novità e intelligenza del discorso. In effetti, trovo, per cominciare dagli inizi, che ipotizzare questa doppia missione - che è anche un doppio movimento di andata e ritorno per ognuno dei due elementi che lo compongono, e cioè: “evangelizzazione della cultura” e “inculturazione del Vangelo”- significa offrire una visione nuova dei rapporti tra la “fede cristiana” e “il mondo”.
Bergoglio, infatti, non dice: “questa” o “quella cultura”. Dice: “cultura”. A chiarimento della tesi scrive: «Stiamo rivendicando all’incontro tra fede e cultura, nel suo duplice aspetto di evangelizzazione della cultura e di inculturazione del Vangelo, “un momento sapienziale”, essenzialmente mediatore, che è garanzia sia dell’origine (movimento di creazione) sia della sua pienezza e fine (movimento di rivelazione)». «Un momento sapienziale, essenzialmente mediatore...»: se la traduzione dallo spagnolo in italiano non ha deformato qualche senso, questo vuol dire che tra “fede” e “cultura” si può stabilire un confronto, i cui momenti di reciprocità sono destinati a influenzare sia l’una sia l’altra parte, producendo, attraverso la “mediazione”, un accrescimento di sapere e di conoscenza per tutti.
Bergoglio chiama in causa una parola-concetto tipicamente laica o quanto meno mondana: “mediatore”, mediazione. Tale impressione però si accentua, in misura significativa, nella lettura di un brano seguente, che qui riporto per intero, perché lo trovo denso di parole-concetti sorprendenti: «La base di questo sforzo è sapere che nel compito di evangelizzare le culture e di inculturare il Vangelo è necessaria una santità che non teme il conflitto ed è capace di costanza e pazienza. Innanzi tutto, la santità implica che non si abbia paura del conflitto: implica parresia, come dice San Paolo. Affrontare il conflitto non per restarvi impigliati, ma per superarlo senza eluderlo. E questo coraggio ha un enorme nemico: la paura. Paura che, nei confronti degli estremismi di un segno o di un altro, può condurci al peggiore estremismo che si possa toccare: l’ “estremismo di centro”».
In questo caso, la parola-concetto centrale è: “conflitto”. Si deve ammettere che siamo di fronte a una acquisizione inedita nel campo della cultura cristiano-cattolica. Il termine infatti ricorre nel pensiero e nelle problematiche del pensiero dialettico e sociologico europeo e americano degli ultimi due secoli: da Hegel a Marx, e poi Simmel, von Wiese, Dahrendorf... -Nessun equivalente, almeno della stessa portata, nel pensiero cristiano-cattolico dello stesso periodo, e si capisce perché: la predicazione evangelica sembrerebbe escludere una virata di tale natura.
Ma la sorpresa è destinata persino ad aumentare se si procede nell’analisi del ragionamento. «Affrontare il conflitto», scrive Bergoglio, «per superarl », ma «senza eluderlo»; si misura con «un enorme nemico: la paura». Paura di che? Paura dei possibili estremismi, che dal conflitto possono scaturire. Ma tale paura, se incontrollata, è destinata a condurre «al peggiore estremismo che si possa toccare: l’“estremismo di centro”, che vanifica qualsiasi messaggio». L’“estremismo di centro”! -In un paese come l’Italia, spesso arrivato a catastrofiche conclusioni proprio a causa di un sistematico e prevaricante “estremismo di centro”, tale messaggio dovrebbe risultare più comprensibile che altrove. Anche il riferimento alla parresia s’inserisce in questo contesto: solo chi parla alto e libero può vincere la paura.
Quali considerazioni si possono fare su posizioni, di questa natura? Su Bergoglio sono stati scritti molti articoli (bellissimi quelli di Eugenio Scalfari). Pochi, però, si sono soffermati sulla scaturigine storica delle sue prese di posizione, che è inequivocabilmente gesuitica. I gesuiti, nel corso della loro lunga storia, ne hanno combinate di tutti i colori, nella difesa perinde ac cadaver della Chiesa di Roma. E però...
 Molti anni or sono ho studiato a lungo la cultura gesuitica del Seicento in Italia. Mi risultò chiaro allora che carattere perspicuo della cultura gesuitica, nei momenti migliori, è sempre stato il tentativo «di operare la saldatura fra cultura laica e cultura ecclesiastica, fra tradizione e rinnovamento... »; e questo su base mondiale.
Molti anni or sono ho studiato a lungo la cultura gesuitica del Seicento in Italia. Mi risultò chiaro allora che carattere perspicuo della cultura gesuitica, nei momenti migliori, è sempre stato il tentativo «di operare la saldatura fra cultura laica e cultura ecclesiastica, fra tradizione e rinnovamento... »; e questo su base mondiale.Se le cose stanno così, la domanda (provvisoriamente) finale di questa ricostruzione è: quale rapporto esiste fra la centralità della parola-concetto “conflitto” e la centralità della parola-concetto “misericordia”, alla quale Papa Francesco ha voluto dedicare il Giubileo?
La risposta più semplice è: nessuno. “Misericordia” è parola evangelica, pochissimo usata in ambito laico, come pochissimo “conflitto” in ambito ecclesiale.
Sono passati trent’anni dalla prima formulazione, padre Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco, ha ripensato radicalmente le sue posizioni, rientrando nell’ambito più tradizionale della cultura ecclesiastica.
Come tutte le soluzioni troppo semplici, anche questa però si presta a un’obiezione di fondo. Una noticina al testo pubblicato da Civiltà cattolica informa infatti che il testo è stato ripresentato «in forma rivista dal Santo Padre». -Questo ci rende lecito pensare che nel pensiero di Papa Francesco “conflitto” e “misericordia” possano stare insieme. Cioè: il prodotto di una cultura laica può stare insieme con il prodotto tipico di una cultura evangelico-cristiana.
Non può esserci “misericordia” se non c’è stato “conflitto”; il “conflitto” è buono, anzi, addirittura indispensabile, se è necessario per superare la paura, e superare la paura è necessario per arrivare alla “misericordia”. Sarebbe troppo pretendere che Bergoglio, divenuto Pontefice, dopo averci additato come il conflitto sia necessario per attivare la misericordia, ci additi come la misericordia sia necessaria per attivare il conflitto, motivo quest’ultimo inesauribile - e positivo, quando c’è - delle azioni umane.
 Però la connessione possibile - il prima e il dopo, insomma, che però è anche o può essere anche, un dopo e un
prima - almeno a noi laici e non credenti, risulta - credo - ben chiara.
Però la connessione possibile - il prima e il dopo, insomma, che però è anche o può essere anche, un dopo e un
prima - almeno a noi laici e non credenti, risulta - credo - ben chiara. -
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. E La ricerca di un Nuovo Umanesimo per la Società Ipercomplessa (di Piero Dominici).14 gennaio 2016, di Federico La SalaCREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. ---
 La ricerca di un Nuovo Umanesimo per la Società Ipercomplessa (di Piero Dominici)
La ricerca di un Nuovo Umanesimo per la Società Ipercomplessa (di Piero Dominici)
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO --- "TOTEM E TABU’. Se dopo il Padre viene uccisa anche la Legge, "rivalorizzare il tabù" (di Massimo Recalcati).12 gennaio 2016, di Federico La Sala
FILOSOFIA E PSICOANALISI: A GLORIA ETERNA DI FREUD. Con l’aiuto di Edipo, ha gettato una grande luce su Mosè e con l’aiuto di Mosè ha gettato una grande luce su Edipo. Con questo doppio movimento, egli ha liberato il cielo - e la terra....
- PSICOANALISI, FASCISMO, E INCOMPRENSIONI DEL PERCORSO E DELLA LEZIONE DI FREUD, DA "L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" A "L’UOMO MOSE’ E LA RELIGIONE MONOTEISTICA" ....
 FREUD E MUSSOLINI (E HEIDEGGER E HITLER). "All’eroe della cultura Mussolini, Con rispetto, Sigmund Freud".
FREUD E MUSSOLINI (E HEIDEGGER E HITLER). "All’eroe della cultura Mussolini, Con rispetto, Sigmund Freud".
I tabù del mondo /1Se dopo il Padre viene uccisa anche la Legge
All’inizio il capofamiglia sedeva sul trono e governava per il suo godimento. Poi i figli presero il potere e il loro rimorso creò le regole-totem del nuovo ordine. Nacque così il patto sociale con il suo tabù: nessuno occuperà in modo arbitrario il trono vuoto. Ora quel vuoto non solo non è riempito ma ha perso ogni significato
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 03.01.2016)
Il nostro tempo sembra cancellare ogni forma di tabù. La disinibizione e l’assenza di vergogna e di senso di colpa trionfano alla faccia del vecchio uomo del Novecento ancora preso dai grandi dissidi morali tra il bene ed il male, le ragioni individuali e quelle della Storia, il progresso e la tradizione, gli Ideali e la pulsione.
Le lacerazioni tragiche del Novecento hanno lasciato il posto ad un disincanto generalizzato che sembra aver annullato l’esperienza angosciata del tabù. Una vignetta clinica può darci il senso di quello che sta accadendo. È il caso di un giovane che, insieme a dei suoi compagni, nel corso di una rapina, ha ucciso brutalmente un anziano. Nel colloquio in carcere con lo psicologo dichiara che dopo aver commesso il crimine non ha avvertito alcun senso di colpa. La sua giornata è scivolata via come se niente fosse. Ha dormito profondamente, la mattina ha fatto colazione e si è recato normalmente a scuola. Tutto era come prima. Non siamo di fronte alla lacerazione dostoevskijana tra il senso della Legge e la sua trasgressione colpevole. Il delitto non sembra più in rapporto all’esigenza morale del castigo; la colpa non divora il criminale, non lo costringe all’insonnia, non lo tormenta.
Mentre l’uomo dostoevskijano vive il dramma dell’infrazione della Legge, il giovane criminale, dopo aver compiuto il delitto, si reca tranquillamente a scuola ridendo e scherzando con i suoi amici. Egli vive un altro genere di angoscia. Quale? La confida allo psicologo: la vertigine che lo ha assalito il giorno successivo al crimine - dopo essere stato arrestato - scaturisce dalla sensazione della inesistenza della Legge; ovvero, dalla percezione che tutto, senza la Legge, è diventato possibile; anche l’uccisione spietata di un uomo per qualche euro. Diversamente dall’uomo dostoevskijano che sprofonda nell’abisso del senso di colpa di fronte al volto severo e inflessibile della Legge, per questo giovane assassino l’angoscia scaturisce dalla dimensione totalmente inconsistente della Legge.
Siamo di fronte a un’esperienza che rovescia la genesi del tabù così come Freud l’aveva concepita nel 1913 in uno dei suoi testi più visionari qual è Totem e Tabù. In quel libro, sulle orme di Darwin, il padre della psicoanalisi aveva immaginato che la prima forma organizzata di vita umana avesse come protagonista un padre titanico, geloso e crudele, possessore di tutte le donne (il Padre dell’orda), che confondeva arbitrariamente la Legge col proprio godimento. Di fronte a questa tirannia permanente i figli-fratelli, ai quali era proibito l’accesso alle donne, decidono di allearsi uccidendo il padre e divorando il suo corpo in un pasto tribale. Il fatto che i fratelli si cibino delle carni del padre manifesta tutta l’ambivalenza del loro legame al padre: ucciso in quanto oggetto d’odio, ma sbranato in quanto oggetto d’amore affinché la sua potenza illimitata possa essere incorporata dai suoi figli.
 Il termine “rimorso” trova qui il suo significato più profondo: divorando il corpo del padre temuto ma amato, i figli si sentono morsi dalla colpa. L’esito del rimorso è l’instaurazione del totem: il padre morto continua a vivere sebbene non più nella forma della tirannia capricciosa, ma in quella dell’autorità simbolica incarnata nel totem.
Il termine “rimorso” trova qui il suo significato più profondo: divorando il corpo del padre temuto ma amato, i figli si sentono morsi dalla colpa. L’esito del rimorso è l’instaurazione del totem: il padre morto continua a vivere sebbene non più nella forma della tirannia capricciosa, ma in quella dell’autorità simbolica incarnata nel totem.
 La sua morte è, dunque, all’origine del senso stesso della Legge; il totem diviene, al tempo stesso, oggetto di venerazione e di angoscia, commemorando l’assassinio del padre e il rimorso che esso ha suscitato. Da quel momento in poi, si instaura il divieto dell’incesto che obbliga tutti i figli all’esogamia. Il senso della Legge sorge come effetto retroattivo dell’atto parricida: mentre in Edipo il parricidio infrange la Legge conducendo il figlio verso l’abisso dell’incesto e della distruzione, in Totem e Tabù esso genera la Legge.
La sua morte è, dunque, all’origine del senso stesso della Legge; il totem diviene, al tempo stesso, oggetto di venerazione e di angoscia, commemorando l’assassinio del padre e il rimorso che esso ha suscitato. Da quel momento in poi, si instaura il divieto dell’incesto che obbliga tutti i figli all’esogamia. Il senso della Legge sorge come effetto retroattivo dell’atto parricida: mentre in Edipo il parricidio infrange la Legge conducendo il figlio verso l’abisso dell’incesto e della distruzione, in Totem e Tabù esso genera la Legge.La vita democratica della Comunità si rende possibile solo attraverso il tabù che sorge in seguito all’uccisione del padre. È solo la morte del padre che pretende di essere la Legge, di fare coincidere la Legge con la sua volontà di godimento, a costituire la condizione della nascita di una Legge più umana e della Cultura stessa. Il patto sociale sostituisce il caos della violenza; la pulsione deve sublimarsi nel riconoscimento di una Legge che, trovando il suo fondamento nel padre morto, vale per tutti, non è più Legge ad personam. Nessuno può occupare il posto del padre morto perché si tratta di un posto destinato a rimanere vuoto. I totalitarismi del Novecento e i fondamentalismi di ogni genere mostrano, a rovescio, l’inferno che può generarsi dal suo riempimento fanatico.
Nel nostro tempo il rischio però non è quello di riempire il vuoto lasciato dal padre morto, ma, nella dissoluzione neo-libertina di ogni tabù, di fare venire meno il rispetto verso la Legge. È la vertigine che assale il giovane assassino: non esiste un argine, un limite, una barriera che possa contenere il suo atto. In questo modo l’assenza della Legge sembra diventare l’unica forma della Legge; se tutto diventa possibile, se dopo aver compiuto un crimine efferato tutto resta come prima - senza senso di colpa e senza rimorsi - non sarebbe forse necessario rivalorizzare il tabù come effetto della Legge?
- PSICOANALISI, FASCISMO, E INCOMPRENSIONI DEL PERCORSO E DELLA LEZIONE DI FREUD, DA "L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI" A "L’UOMO MOSE’ E LA RELIGIONE MONOTEISTICA" ....
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- «Diritto d’amore» (Rodotà) e il divenire universale dell’autonomia individuale (di Roberto Ciccarelli)7 gennaio 2016, di Federico La Sala
Rodotà, il divenire universale dell’autonomia individuale
Saggi. «Diritto d’amore» di Stefano Rodotà per Laterza. Dalle unioni civili alla laicità dell’istruzione. Un libro che segnala come la legge non può colonizzare la vita affettiva e la sessualità di uomini e donne. L’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 07.01.2016)
È arduo per un giurista parlare del diritto di amare, dato che la disciplina che rappresenta ha usato l’amore come premessa di un progetto di controllo delle donne, ridotte a proprietà del coniuge, mentre la politica continua a decidere sulla vita di uomini e donne. E tuttavia, scrive Stefano Rodotà nel suo ultimo libro Diritto d’amore (Laterza, pp.151, euro 14), l’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica.
Proprietà, credito e obbedienza: questa è la triade usata dal «terribile diritto», il diritto privato, per assoggettare l’amore - e la vita delle persone - alla razionalità dello Stato e al dominio della legge. Rodotà conduce da sempre una critica instancabile a questo modello. Per lui il diritto d’amore, come tutti i diritti, non nasce dall’arbitrio soggettivo, né da un fondamento naturalistico, ma dal legame tra il diritto e la realizzazione di un progetto di vita. Il diritto è legittimato dalle persone che decidono di riconoscerlo e lo usano per affermare l’autonomia e la libertà di tutti, non solo la propria.
Ciò non toglie che il diritto e l’amore, il desiderio di unirsi a un’altra persona, indipendentemente dal suo sesso, mantengano una distanza irriducibile. Quasi mai, infatti, il diritto è un complice della vita. Anzi, esiste per disciplinare gli affetti e per creare il modello del cittadino laborioso, maschio, proprietario. L’amore, invece, non sopporta regole o norme. Preferisce crearle da sé, nell’esperienza delle relazioni, seguendo un divenire che difficilmente può essere contenuto in un’unica disciplina valida per tutti. Per questa ragione il diritto ha preferito confinare «l’amore senza legge in uno stato di eccezione», come ha scritto un grande giurista francese, Jean Carbonnier.
L’autonomia irrinunciabile
In questo stato di eccezione prevale l’originaria ispirazione del diritto privato - cioè la riduzione della passione a cosa e della persona a proprietà di qualcuno. Orientamenti presenti ancora oggi in alcune sentenza della Corte Costituzionali o in fatali decisioni come quella sulla legge 40 sulla fecondazione assistita approvata dal governo Berlusconi.
A tutela dell’autonomia e della libertà delle persone, Rodotà usa la Costituzione e dai suoi articoli fondamentali traccia un uso alternativo del diritto che distrugge i valori di cui la stessa carta fondamentale è espressione. A questo punto è quasi inevitabile per il giurista raccontare la storia dei movimenti che hanno fatto esplodere il perimetro formalizzato dei poteri e della legge nel secondo Dopoguerra. Prima il movimento femminista, oggi i movimenti Lgbtq a cui Rodotà dedica un intero capitolo. Il diritto di amare è diventato una questione politica di rilievo perché alimenta la ricerca dell’autonomia delle persone. Il conflitto è emerso, fortissimo, sulle unioni civili come, di recente, hanno dimostrato i movimenti Lgbtq che hanno organizzato una «marcia dei diritti» per criticare l’insufficienza, addirittura le potenziali discriminazioni presenti nel disegno di legge Cirinnà che il governo intende approvare.
Storia di un incontro
In questa partita rientra anche il conflitto sull’educazione alle differenze nelle scuole: da una parte, c’è un movimento vasto che sostiene la laicità dell’istruzione pubblica e la critica dei ruoli sessuali per tutelare la libertà dei bambini e degli insegnanti. Dall’altra parte, c’è una reazione furibonda che attraverso il meme dell’«ideologia del gender» - una narrazione tossica strumentale e infondata - ha saldato un ampio movimento conservatore con le istanze più reazionarie del cattolicesimo e mira a colpire la laicità dell’istruzione e la libertà nelle scelte d’amore.
Come accade nei suoi libri, Rodotà unisce la storia dei movimenti a quelle della Costituzione italiana e della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea alla quale ha contribuito. L’incontro con i movimenti serve al diritto per «conoscere se stesso, il proprio limite, l’illegittimità di ogni sua pretesa di impadronirsi della vita - scrive Rodotà -. Emerge così uno spazio di non diritto nel quale il diritto non può entrare e di cui deve farsi tutore, non con un ruolo paternalistico, ma con distanza e rispetto». Dal punto di vista dei movimenti, il diritto serve a riconoscere e a coltivare una tensione nel darsi regole che possono cambiare, seguendo una geometria delle passioni interna alle relazioni tra il soggetto e la sua vita.
In questo quadro è fondamentale il ruolo delle minoranze: il movimento omosessuale, insieme a quello femminista, quello Lgbtq, interpretano lo stesso modo di fare politica: per vincere i movimenti si coalizzano con altri soggetti attivi nella società al fine di ottenere un riconoscimento sociale e istituzionale. Le conquiste sulle libertà personali sono valide per tutti, come hanno dimostrato l’aborto e il divorzio. Il diritto d’amore si inserisce in questa nobile vicenda e risponde a un’esigenza che ha dato il titolo a un altro, notevole, libro di Rodotà: il diritto ad avere diritti.
Tensioni singolari
Auspicio, affermazione performativa, atto di cittadinanza: il diritto ad avere diritti è una formula che caratterizza l’azione coordinata delle minoranze e afferma i diritti universali di tutti: il welfare state, l’ambiente, i beni comuni, per esempio. L’universalismo singolare dei diritti si pratica sottraendosi dall’identità maggioritaria fissata per legge (Deleuze la definiva «divenire minoritario») e, allo stesso tempo, nella creazione di un diritto all’esistenza che sfugge ai principi della morale dominante e agli assetti del potere organizzato dal diritto. Questa duplice azione rivela l’esistenza di uno spazio rivoluzionario. Rodotà lavora alla sua riapertura, in un momento non certo felice di arretramento generale.
Diritto d’amore è infine un libro che va letto insieme a quello dedicato da Rodotà alla solidarietà. Da tempo il giurista è impegnato in una ricostruzione genealogica delle passioni e delle pratiche volte alla costituzione di una soggettività caratterizzata da un rapporto di reciprocità, irriducibile al narcisismo o alla naturalizzazione dei ruoli. Parla di uguaglianza e ne rintraccia la storia nelle pratiche della solidarietà e nella dignità della persona. In questa fittissima tessitura, l’amore è un «rapporto sociale», mentre la sua tensione singolare «a bassa istituzionalizzazione» spinge a creare mondi nuovi. Questa può essere considerata una risposta all’invocazione di Auden: «La verità, vi prego, sull’amore».
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. --- Il rabdomante e il tribunale (di Nicola Fanizza)14 novembre 2015, di Federico La Sala
Il rabdomante e il tribunale
di Nicola Fanizza (Nazione, indiana, 14 novembre 2015)
Vitantonio Ruggeri era un individuo oltremodo stravagante, era un folle particolare, un matto che diceva il vero. La madre, piccola di statura, era una donna colta e intelligente, aveva studiato e sapeva declinare a memoria tutti gli articoli del codice civile. Uno sviluppo esteriore modesto caratterizzava anche il figlio, il quale aveva ereditato dalla madre la mania per la lettura. A differenza di quest’ultima, però, non rivolgeva la sua attenzione al passato, bensì al presente. Era attento alla vita, era attento a tutto ciò che resisteva alla morte, ai flussi di energia che animavano le forze in campo, agli equilibri instabili e coglieva in ogni attimo il non ancora. Ogni istante per lui conteneva una sorta di potenza, una potenza che non si esauriva mai completamente nell’atto.
Ruggeri si guadagnava da vivere facendo il rabdomante. Si era accorto di avere la capacità di avvertire la presenza dell’acqua nel sottosuolo allorquando, improvvisamente, sentì una scossa proveniente dal basso. Raccontò questo episodio a suo padre, il quale lo invitò a individuare una vena d’acqua nel fondo di famiglia.
L’aspirante rabdomante impugnò i lembi laterali di un ramo d’ulivo che aveva la forma di Y e attraversò per diversi giorni in lungo e in largo il podere di circa tre ettari. Si fermò solo quando si convinse di aver trovato il punto in cui aveva avvertito più volte un flusso di energia che aveva spostato la bacchetta verso l’alto. Si dice, però, che in quell’occasione non doveva essere molto convinto di aver trovato l’acqua, poiché invitò suo padre a reiterare l’esperimento. Il padre impugnò la bacchetta biforcuta ..., ma asserì di non aver avvertito alcun flusso di energia. Nondimeno quest’ultimo di lì a poco si convincerà che Vitantonio era un autentico rabdomante. Fece scavare il pozzo proprio nel punto che gli era stato indicato dal figlio e trovò una ricca vena d’acqua.
E’ accaduto allo scrivente di riflettere non tanto sulle presunte doti dei rabdomanti, quanto sui luoghi che essi indicavano per scavare i pozzi. Ebbene, questi luoghi si trovavano sempre a monte e mai a mare: ossia sempre nella parte più alta dei poderi e giammai nella parte bassa. I rabdomanti sceglievano tale punto poiché era congeniale per l’irrigazione del fondo medesimo. Dalla cisterna, alimentata dalle norie e coestensiva al pozzo, l’acqua poteva arrivare, attraverso appositi canali, in qualsiasi parte del terreno!
Allo stesso modo in cui fiutava la presenza dell’acqua, Ruggeri prefigurava gli eventi che in un futuro più o meno prossimo avrebbero riguardato il suo Paese. E quando ciò accadeva, avvertiva l’esigenza e, insieme, l’obbligo di dire il vero agli altri. Tuttavia Ruggeri viveva in un mondo che da tempo aveva consumato la sua rottura con la verità del discorso profetico. Si esprimeva con delle oscure profezie che la sua città - Mola - non era disposta a recepire. Per i molesi non aveva che parole di sdegno e ricorreva nei loro riguardi allo scherno e all’invettiva. Diceva che non credevano alle sue profezie, avevano la capa tosta, erano troppo sensibili alle sirene del potere di turno.
Dal suo fascicolo personale* - conservato presso il Casellario politico centrale -, apprendiamo che tre mesi dopo l’entrata del nostro Paese nella seconda guerra mondiale, Ruggeri andava dicendo in giro che l’Italia avrebbe perso la guerra e profetizzava la fine del fascismo. Per di più nella notte del 12 ottobre 1940 scrisse sulla fontana monumentale, che signoreggia al centro della piazza del paese, alcune frasi disfattiste e denigratorie nei confronti del regime fascista.
Sulla scorta delle soffiate dei delatori, il giorno dopo Ruggeri fu arrestato. I dirigenti dell’Ovra di Bari si resero subito conto che non ci sarebbe stato bisogno di una perizia per sincerarsi in merito alla sua fragilità mentale. Ciò nondimeno, nascondendo la sua pazzia, lo denunciarono al Tribunale speciale per difesa dello Stato per «disfattismo politico», ossia con l’accusa di «aver tracciato iscrizioni antinazionali e disfattiste su una fontana pubblica».
Tre mesi dopo si tenne a Roma il processo a suo carico, presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il reato di cui Ruggeri era stato accusato era oltremodo grave, poiché prevedeva molti anni di carcere. Nondimeno il tribunale accolse solo in parte le richieste dell’accusa. Ecco qui di seguito il dispositivo argomentativo della sentenza: «Il Tribunale, in considerazione della menomata responsabilità dell’imputato (...) dimostrata da attestazioni mediche e da testimonianze a discarico, ha ritenuto - accogliendo la richiesta del P. M. - che nelle circostanze del fatto si integrassero gli estremi del reato meno grave di propaganda sovversiva, applicando il minimo della pena in mesi sei di reclusione». Di fatto quel Tribunale fu più crudele dell’Ovra poiché, pur non nascondendo la follia dell’imputato, lo ritenne comunque colpevole di un reato minore.
Il giorno dopo la sua condanna, Ruggeri chiese di poter tenere la corrispondenza con i suoi genitori e solo a partire dal mese successivo gli fu consentito lo scambio epistolare. Il Nulla Osta fu concesso solo quando le autorità di polizia appurarono che i suoi genitori erano «di buona condotta morale e politica, immuni da precedenti pendenze penali, di razza ariana e di religione cattolica». Questi ultimi cercarono in tutti i modi di ottenere le libertà del loro figlio e in questo senso si attivarono per rivolgere un’istanza di grazia al Tribunale speciale. Ma il 30 marzo 1941 il Ministero degli Interni respinse l’istanza di grazia in merito alla residua pena, tenendo presenti sia le «risultanze degli atti» sia il «parere contrario concordemente espresso dall’Autorità di P. S. e dall’Arma dei Carabinieri Reali».
Le dinamiche che portarono all’arresto e alla successiva condanna del Ruggeri le troviamo ottant’anni prima anche nella rivolta che ebbe luogo a Bronte nell’agosto del 1860, dopo lo sbarco dei Mille in Sicilia. Una jacquerie che Giovanni Verga ricostruisce, insieme alla successiva repressione, nella novella Libertà, mettendo in atto, però, una vera e propria mistificazione letteraria.
Ecco il passo della novella da cui questo particolare vien fuori: «Il generale fece portare della paglia nella chiesa, e mise a dormire i suoi ragazzi come un padre. La mattina, prima dell’alba, se non si levavano al suono della tromba, egli entrava nella chiesa a cavallo, sacramentando come un turco. Questo era l’uomo. E subito ordinò che gliene fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, i primi che capitarono». Abbiamo messo in corsivo il nano: poiché è questo il punto.
Qui lo scrittore siciliano trasforma il matto, fatto fucilare da Nino Bixio dopo un processo sommario, in un ridicolo nano. Leonardo Sciascia dice che Verga non voleva turbare la sensibilità del lettore scrivendo «il pazzo»; e scrisse «il nano», dissimulando così in una «minorazione fisica la minorazione mentale». Eppure Verga sapeva benissimo che non si trattava di un nano ma di un pazzo: il pazzo del paese, un innocuo pazzo colpevole di aver vagato per le strade del paese con la testa cinta da un fazzoletto tricolore profetizzando, prima che la rivolta esplodesse, sciagura ai galantuomini e la fine del regime borbonico. I delatori lo avevano denunciato, proprio perché era un folle, era il più debole e, pertanto, correvano meno rischi.
Le motivazioni che spinsero i delatori a denunciare «il nano» sono - come abbiamo già visto - in larga parte identiche a quelle che porteranno ottant’anni dopo a promuovere l’arresto e poi la condanna del Ruggeri. In ambedue i casi ci troviamo di fronte alla medesima mistificazione messa in atto nei confronti del folle che dice il vero e, insieme, nei confronti di chi è più debole.
Ciò che sappiamo con certezza è che, dopo la fine della guerra, nessuno chiese conto ai giudici del Tribunale speciale in merito alle loro nefaste sentenze. Sappiamo altresì che uno di quei giudici, Gaetano Azzariti, che era stato Presidente del tribunale della razza, divenne nel 1957, addirittura, Presidente della Corte costituzionale.
I delatori che avevano denunciato Ruggeri continuarono a spiare i potenziali sovversivi non più per conto delle istituzioni fasciste, bensì per conto delle istituzioni repubblicane.
Per quel che riguarda Ruggeri, sappiamo che, dopo aver scontato la pena, tornò nel suo paese. Negli anni successivi - finita la guerra e caduto il regime fascista - continuava a rammaricarsi per il fatto che, benché dicesse il vero, nessuno credeva alle sue profezie!
* Vedi Archivio centrale dello Stato, Casellario politico centrale, Ruggeri Vitantonio, busta 4488.
Nota:
UN TESTO NON SOLO BELLO PER SCRITTURA, MA SORPRENDENTE E RICCO DI IMPLICAZIONI ANTROPOLOGICHE, FILOSOFICHE, E POLITICHE. A FIANCO DEL RABDOMANTE E COME IL RABDOMANTE, IL SUO E’ IL FRUTTO DI UNO STRAORDINARIO ESERCIZIO DI “PARRHESIA”! L’Autore, evidentemente, ha avuto il coraggio di accogliere le CONNESSIONI emerse dalla sua ricognizione (“SAPERE AUDE!”. Ricordiamoci di “che cosa è l’Illuminismo?” di Kant e... di Foucault) e ha saputo trovare il modo di parlarne in prima persona, e in spirito di verità o, meglio, di “spirito critico” (Barrington Moore Jr.) e di “amore conoscitivo”(Kurt H. Wolff).
Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Il circolo degli uomini: "l’ultimo paradosso" (di Lea Melandri).27 ottobre 2015, di Federico La Sala
PER LA CRITICA DEL CAPITALISMO E DELLA SUA TEOLOGIA "MAMMONICA" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006).
 CON MARX, OLTRE:
CON MARX, OLTRE:
Il circolo degli uomini
di Lea Melandri (Comune-info, 26 ottobre 2015)
Nel libro L’ultimo paradosso (Einaudi 1986), presentato come “un quaderno di appunti, note, osservazioni, pensieri sui problemi fondamentali dell’esistenza”, Alberto Asor Rosa scrive:
“Uomini. Sediamo da secoli in gruppo intorno ad una tavola - non importa se rotonda o quadrata - impartendo il comando cui la nostra funzione ci abilita, distribuendo il potere che il nostro ruolo ci assegna. Anche fra amici indossiamo corazza: i momenti più intimi della nostra conversazione passano tra celate accuratamente abbassate. Le nostre mani sono chele in riposo. Gli orgogliosi sanno fare tutto questo con dignità e fierezza, i vili lo ostentano codardamente per incutere timore: ma gli uni e gli altri stanno diritti solamente perché c’è una corazza a sostenere il filo della schiena o una spada a cui appoggiare il fianco stanco. Il nostro volto, il nostro corpo sono pur là, dietro quelle biancheggianti, livide spoglie. Ma non oseremmo pensare di rinunciare al nostro circolo e alle sue leggi neanche se ci fosse promessa in cambio una libertà sconfinata, una gioia senza pari. Sediamo, intenti a noi stessi, alla nostra forma, al nostro decoro, al nostro eroismo, alla nostra dignità: al nostro essere-per-sé, custodito da un simulacro d’acciaio e da una maschera di ferro. Intorno a noi ci sono soltanto o subalterni o buffoni: e tra essi mettiamo le donne, alle quali per giunta presumiamo di piacere e di dar piacere ostentando le virtù cavalleresche, ossia tutto ciò che più ci allontana da loro. A forza di tenere il corpo in armatura, ne risultiamo un poco rattrappiti, le giunture scricchiolano e nel muovere ci procurano dolore. Talvolta ci sorge il sospetto che il nostro sacrificio, offerto a divinità tanto astratte quanto crudeli come quelle che compongono la religione dell’ascetismo guerriero, sia scontato ed inutile, e persino oggi un poco patetico: ed aspiriamo ad uscire da qualche crepa della vecchia armatura, a scivolare furtivi sotto quel tavolo, per guadagnare la porta della riunione a uscire a respirare aria pura.
 Ma appena fissiamo lo sguardo nello sguardo dei nostri compagni, attraverso la fessura della celata... e vi scorgiamo la nostra stessa disperazione, la nostra prigionia, il nostro dolore, il nostro stesso smisurato orgoglio, il nostro disprezzo per tutti gli estranei alla cerchia - non appena sguardo con sguardo di nuovo s’incatena, subito il desiderio di libertà, l’ansia di gioia ci abbandonano -, e scopriamo che non potremo mai lasciarli... L’unico passo in avanti nella cultura degli uomini da due millenni a questa parte è stato la soppressione del re: ma questa soppressione non ha cancellato il circolo, se mai lo ha rafforzato, liberandolo della maglia più debole. Sono secoli che gli esseri umani maschili vivono così; e con questo modo di vita affonderanno”.
Ma appena fissiamo lo sguardo nello sguardo dei nostri compagni, attraverso la fessura della celata... e vi scorgiamo la nostra stessa disperazione, la nostra prigionia, il nostro dolore, il nostro stesso smisurato orgoglio, il nostro disprezzo per tutti gli estranei alla cerchia - non appena sguardo con sguardo di nuovo s’incatena, subito il desiderio di libertà, l’ansia di gioia ci abbandonano -, e scopriamo che non potremo mai lasciarli... L’unico passo in avanti nella cultura degli uomini da due millenni a questa parte è stato la soppressione del re: ma questa soppressione non ha cancellato il circolo, se mai lo ha rafforzato, liberandolo della maglia più debole. Sono secoli che gli esseri umani maschili vivono così; e con questo modo di vita affonderanno”.Se le donne hanno dovuto faticosamente, tra mille inganni e ostacoli, “prendere coscienza” di un’oppressione, peraltro evidente, e sopportare che questa lucidità si rivelasse estremamente fragile, pronta a scomparire dopo ogni piccola conquista, gli uomini, ragionando su una rappresentazione del mondo prodotta dalla storia dei loro simili hanno evidentemente una via di accesso più facile alla messa a nudo del sessismo, delle logiche d’amore e di violenza che lo sostengono, nonostante i progressi della civiltà. Perché allora quella difesa estrema, sempre meno convinta eppure ostinata, della neutralità, che si esprime non solo nel cancellare dalle analisi politiche il rapporto tra i sessi, ma anche in quella copertura che è la sua distorta collocazione tra le questioni sociali: emarginazione, cittadinanza incompleta, sfruttamento economico, beni comuni, ecc.?
Le donne sembra che stentino a “sapere” quanto è profonda l’espropriazione che hanno subito, quanto siano ancora lontane dalla percezione di sé come individualità intere, corpo e pensiero, quanto siano propense ad accontentarsi di una emancipazione che le porta sulla scena del mondo con le stesse attribuzioni per cui ne sono state allontanate: corpo, sessualità, maternità. Anche sulla violenza che subiscono quotidianamente, e che risulta essere ancora la causa prima della loro morte, cala spesso l’invisibilità, frutto di paure, intimidazioni, così come di desideri e fantasie amorose mal riposte.
Per quanto riguarda gli uomini, viene invece il sospetto che “sappiano” e che sia proprio l’evidenza del privilegio toccato loro storicamente e diventato “destino”, copione di comportamenti obbligati, a dover essere in qualche modo aggirata, perché colpevolizzante e quindi innominabile.
La comunità storica maschile ha visto cadere imperi, muraglie, confini, odi che sembravano irriducibili, eppure esita a far cadere le fragili pareti che separano la sua civiltà dalla porta di casa, l’immagine della sua “virilità” pubblica dalla posizione di figlio,fratello, padre, marito, amante.
Ma tutto ciò che scorre innominato sotto la storia rischia di diventare col tempo la galassia che la conduce a sua insaputa, che la ricopre via via di macerie e la tiene con lo sguardo rivolto all’indietro, cosicché la speranza finisce per confondersi con la nostalgia, e il corpo femminile, su cui ancora si pretende di esercitare un possesso indiscusso, diventa, immaginariamente, la terra feconda, incontaminata, di rinascite a venire.
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- La cultura, la genetica e il benessere degli altri. L’equilibrio tra egoismo e altruismo (di Gillo Dorfles)10 settembre 2015, di Federico La Sala
L’equilibrio tra egoismo e altruismo
di Gillo Dorfles (Corriere della Sera, 10.09.2015)
Fare e desiderare il bene degli altri è una delle azioni più lodevoli e convincenti da parte dell’uomo di oggi e di sempre; naturalmente non sempre il proprio desiderio corrisponde a quelle che sono le nostre aspettative, perché molte volte ragioni etiche, estetiche, sociologiche si sovrappongono tra quello che è il nostro desiderio e quella che è la sua meta. Non è sempre possibile che il nostro altruismo corrisponda alle migliori conseguenze possibili. Molto spesso prevale nell’uomo un atteggiamento egoistico e questo fa sì che tutte le tendenze altruistiche vengano contaminate e contraddette da questo comportamento. Tra l’altruismo e l’egoismo che di solito prevalgono nella nostra costituzione, non c’è dubbio che il primo dovrà avere ogni tipo di privilegio, perché agire a favore del prossimo è uno dei dettami evangelici e una delle fondamentali prerogative dell’umanità.
Le due contrapposte tendenze psicologiche dell’altruismo e dell’egoismo vengono indubbiamente a costituire la duplice base della nostra affettività; che sarà a seconda dei casi rivolta verso il prossimo o verso noi stessi. Non dobbiamo dimenticare che tanto il primo che il secondo movente possono essere modificati se l’individuo ne è cosciente e riesce ad arginare gli impulsi coattivi, separandoli da quelli che sono i suoi atteggiamenti verso se stesso o verso il prossimo.
Bisognerà sempre tenere conto che nella parola e nel concetto di altruismo non si cela solo la prassi del bene altrui, ma si celano anche molti dei compromessi del nostro carattere e quindi della nostra tendenza a proiettare su di noi quelli che dovrebbero essere gli affetti riservati al prossimo. Esistono diverse forme di altruismo dovute ad elementi psicologici, patologici e persino etnici e religiosi; per questo, molto spesso quella scissione tra altruismo e egoismo è più frequente di quanto non si creda.
Così non bisogna scordare che esiste un «altruismo patologico», ossia quello che potremmo identificare con un vero e proprio sadismo. In altre parole, il desiderio del male altrui viene a sostituire il desiderio del bene, secondo una prassi ideativa che può condurre a dei pessimi risultati. Lo stesso fenomeno del sadismo, infatti, non solo è patologico se osservato nella comune situazione affettiva; ma può costituire un germe creativo di cui l’artista si è servito e può servirsi; per cui il contrasto tra altruismo e sadismo viene a costituire una sorte di rete affettiva che può trasformarsi quale vero messaggio letterario.
Un interessante e complesso saggio sull’altruismo è quello di David Sloan Wilson L’altruismo. La cultura, la genetica e il benessere degli altri (Bollati Boringheri, traduzione di Andrea Migliori, pp. 162, e 19,50), il quale prende in considerazione quest’atteggiamento dell’uomo nelle sue più sottili ramificazioni. Non si dimentichi che, mentre l’altruismo viene costantemente «aiutato» e incoraggiato pubblicamente attraverso i più svariati mezzi persuasivi, dalla letteratura alla televisione agli altri mass media, compresi quelli della religione e persino della razza, l’egoismo in realtà non viene mai ufficialmente «promosso». L’altruismo dunque gode di un aureola di «gloria» mentre l’egoismo non possiede altro che la sua efficacia soggettiva.
In definitiva nella lotta impari tra altruismo e egoismo, come viene ben rilevata nel testo di Wilson, non ci saranno mai né vinti né vincitori; e non è detto che gli sconfitti siano effettivamente svantaggiati. Forse, i veri vincitori saranno quelli dove il «braccio della bilancia» dell’egoismo sarà identico a quello dell’altruismo, poiché le due fazioni si saranno strette equilibratamente la mano.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- "May ’68 and its afterlives", un saggio dello storico statunitense Kritin Ross (di Mario Pezzella - Il revisionismo storico investe il Sessantotto). -30 maggio 2014, di Federico La Sala
Il revisionismo storico investe il Sessantotto
di Mario Pezzella (il manifesto, 29 Maggio 2014)
È abbastanza diffusa un’interpretazione del Sessantotto come modernizzazione del capitalismo: questo sarebbe il suo merito o al contrario il suo peccato originale. Da un Sessantotto certo un po’ pervertito qualcuno fa discendere perfino il berlusconismo, con la sua caricatura di libertà sessuale e oltraggio alle istituzioni. Il libro di Kristin Ross May ’68 and its afterlives (University of Chicago Press) considera queste intepretazioni come il prodotto di una revisione storica, prodotta dalla «tradizione dei vincitori», come avrebbe detto Walter Benjamin. La vittoria del neocapitalismo è proiettata all’indietro nel tempo, torcendo in suo favore la consistenza del passato, riducendo il Sessantotto a un suo prologo.
L’evento indeciso, in cui la pluralità dei possibili in sospeso ancora si apriva a esiti divergenti, viene ridotto univocamente alla visione neoliberista: l’esito determinato di un conflitto sociale, che vede il prevalere del capitale, viene ri-esposto come legge storica. Le «comuni» antagoniste del Maggio diventano poco a poco astrazioni, utopie, poi sono definite velleitarie, minoritarie, infine mai esistite; come è avvenuto per la Comune ed altre brecce di libertà.
Ross propone una «lettura a contrappelo» di questo revisionismo storico. La sua non è una cronaca del Maggio, ma un’analisi del modo in cui è stato rappresentato, prima dai suoi attori e poi dai suoi interpreti presunti. Risalendo con il recupero di documenti e testimonianze fino al cuore indeciso dell’evento, Ross rintraccia gli elementi irriducibili al concetto di modernizzazione ed ad esso antagonisti: la ricerca di relazioni sociali comuni, costituive di un noi che rifiuta ogni principio gerarchico e rapporto di padronanza; la critica della separazione spaziale della città in settori estraniati, distruggendo i vecchi quartieri popolari; la critica della partizione del sensibile.
Ross riprende quest’ultimo termine dal filosofo francese Jacques Rancière. Esso indica una netta contrapposizione tra polizia (uno stato gerarchicamente ordinato) e vera democrazia e segnala la divisione tra chi ha cittadinanza e chi è respinto al di fuori di essa (i «senza parte»). La partizione del sensibile non riguarda solo i ruoli economici, ma il simbolico, il quotidiano, lo psichico, le relazioni personali e sentimentali, lo spazio urbano: si decide ciò che «può essere oggetto di percezione e ciò che non lo è», «ciò che può essere visto», o inteso, e ciò che è espulso dalla parola e dall’immagine. Nel Sessantotto «l’apertura politica all’alterità ha permesso... di rompere con quest’ordine, di sconvolgere... i ruoli asseganti dalla polizia, di rendere visibile ciò che non lo era», criticando in primo luogo la separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e proponendo invece una costante ibridazione delle eterogeneità sociali.
Quanto alla critica della separazione urbana, essa fu probabilmente il contributo più specifico dei situazionisti alle giornate di Maggio: essi rifiutarono l’idea che lo spazio dovesse essere compartimentato e diviso secondo le stesse linee delle gerarchie sociali. L’urbanesimo neocapitalista divide i settori sociali invece di unirli e stabilisce i confini concreti dell’estraniazione, stabilendo una corrispondenza tra l’articolazione dello spazio e quella del dominio. Nella confusione e nella trasgressione degli ordini estraniati e della separazione, si concretizzava il piacere e il desiderio di vivere da parte dei militanti del Maggio: «Il piacere di violare la compartimentazione, fisica o sociale, è proporzionale alla durezza della segregazione sociale urbana dell’epoca; i dialoghi intrecciati a dispetto di tale segregazione veicolano un sentimento di trasformazione urgente». Questo piacere sovversivo di vivere oltre l’ordine simbolico del capitale, abbattendo le barriere dello spazio e del tempo dominati, lasciando emergere un nuovo spazio sociale, è stato poi reinterpretato come «edonismo» dai cantori della modernizzazione.
Altro decisivo elemento di distorsione dell’evento è per Ross il così detto «generazionismo», ben descritto da una citazione di Hocquenghem (si tratta di una lettera aperta ai vecchi compagni passati «da Mao al Rotary Club»): «Si diviene una “generazione” quando ci si ritrae come una lumaca nella conchiglia o il pentito nella sua cella: il fallimento di un sogno, la stratificazione dei rancori, il residuo di un’antica insurrezione, si chiamano “generazione”». Il generazionismo dissolve in un dato biologico il conflitto dei possibili e lo spazio-tempo imprevedibile dell’evento, il ritmo dello sviluppo storico è ridotto - come diceva Mannheim - a legge positivista della «durata di vita». L’essere per l’inizio, da cui balza il tempo-ora del presente, ponendo in discussione ogni precedente mediazione e scansione del tempo, viene così risolto in «fase della vita», destinata a passare. La lotta e il conflitto tra chi ha parte e chi è «senza parte», si riducono a una inevitabile lacerazione tra padri e figli, e in una altrettanto inevitabile, successiva, conciliazione.
D’altra parte, anche l’idea che il Maggio sia stato un tumulto effimero e improvviso è contestata da Ross. L’evento è il culmine di una durata lunga del conflitto storico; la breccia è solo l’atto finale di una lenta erosione del muro del dominio, che comincia in Francia con la guerra d’Algeria.
Una rivoluzione passiva ha distorto l’ultimo tentativo novecentesco di scuotere l’ordine del capitale. Lo sciopero generale, che portò nei giorni di Maggio al collasso del governo gollista, è certo uno dei dati più importanti della memoria collettiva che Ross cerca di restituirci: per pochi giorni milioni di persone compirono l’esperienza che vivere senza il peso del potere sulle spalle è difficile e possibile
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin (di Nicola Fanizza)14 aprile 2014
 UOMINI E DONNE: ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA FILOSOFICA: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE"
UOMINI E DONNE: ANTROPOLOGIA E STORIOGRAFIA FILOSOFICA: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE"
 LA RINASCENZA DEL SOGGETTO. SULLE TRACCE DI BENJAMIN, AL DI LA’ DELL’EDIPO. Una nota di Nicola Fanizza sul libro di Federico La Sala
LA RINASCENZA DEL SOGGETTO. SULLE TRACCE DI BENJAMIN, AL DI LA’ DELL’EDIPO. Una nota di Nicola Fanizza sul libro di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITA’ POMPOSA8 aprile 2014, di Federico La Sala
 "PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ...
"PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA" DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA ...
 VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITA’ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
VICO E MARX CONTRO LA PRASSI (ATEA E DEVOTA) DELLA CARITA’ POMPOSA. Alcune note su un testo del Muratori
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA.23 dicembre 2013, di Federico La Sala
 SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. A scuola di Dante, Bruno, Galilei, Kant ... e Kurt H. Wolff
SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ E SULLO SPIRITO CRITICO, OGGI. A scuola di Dante, Bruno, Galilei, Kant ... e Kurt H. Wolff
 DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. Materiali
DAL "CHE COSA" AL "CHI": TRACCE PER UNA NUOVA ERMENEUTICA. Materiali
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. Jacques Lacan e l’inconscio visto da vicino20 dicembre 2013, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr. - di Federico La Sala9 dicembre 2013
Della Terra, il brillante colore
2013, nov 27 *
Della terra, il brillante colore
Il libro di Federico La Sala offre un punto di vista raro. Quello di un pensiero maschile che osserva e riflette e su alcuni pilastri del pensero filosofico occidentale in modo non neutro ma a partire dal riconoscimento della propria parzialità - di individuo e di genere.
Il libro si compone di più saggi che affondano nel profondo delle nostre radici culturali come “carotaggi” a campione. La sensazione all’inizio spaesante di saltare da un frammento all’altro in campi diversi del sapere e in momenti diversi della storia è ricomposta nel filo conduttore che pian piano si manifesta. Più che un filo conduttore teorico, la tensione etica, intellettuale, di cuore, di un essere umano in ricerca.
Nella prima parte del testo l’autore si spinge in regioni dove la religione cattolica si intreccia con la tradizione ermetica. Incontriamo Ermete Trismegisto e la grande stagione Rinascimentale poi affogata nel rigore censorio della Controriforma. Incontriamo diverse manifestazioni delle Sibille, qui visibili nella riproduzione di xilografie di Filippo Barberi (1481) - una versione inedita. Percorsi incrociati tra Kabbalah, carmelitani e profeti islamici.
Sembra di navigare su un fiume sotterraneo che congiunge Oriente e Occidente. Così arriviamo alle note su Parmenide, Freud, Kant, Rousseau - tra gli altri. L’autore offre spunti e visioni prendendoli da un bagaglio di conoscenze che spazia dalla storia della religione alla filosofia alla psicoanalisi. Si alternano luce solare e lunare. Tra le tante le citazioni, il ritmo conciso e il gesto schietto, senza pose accademiche, rendono la lettura scorrevole. Nella pennellata di Fulvio Papi nell’introduzione, sulla spinta della lettura di questo “testo in piena”:
La Sala, con una mossa certamente ad effetto e piena di provocazione, dice: “guardiamo il nostro ombelico”, riconosciamoci come figli di una maternità e di una paternità che siano la terra del nostro fiorire e non i luoghi delle nostre scissioni.
*
 Della terra, il brillante colore. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri (1481) e la domanda antropologica
Della terra, il brillante colore. Parmenide, una “Cappella Sistina” carmelitana con 12 Sibille (1608), le xilografie di Filippo Barbieri (1481) e la domanda antropologica di Federico La Sala,
di Federico La Sala,
 Edizioni Nuove Scritture, Milano, 2013
Edizioni Nuove Scritture, Milano, 2013
 156 p., 15€
156 p., 15€ -
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- MICHELANGELO: DOPO 500 ANNI, I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA ANCORA UN GROSSO PROBLEMA!!!3 ottobre 2013, di Federico La Sala
 MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- VICO E LA BARBARIE DELLA RIFLESSIONE.18 maggio 2013, di Federico La Sala
VICO E I NIPOTINI DI PLATONE (CARTESIO, HEGEL, E HEIDEGGER)
C’era un lord in Lucania.... *
Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” (“Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che Vico per circa nove anni decisivi per la sua vita ha abitato a Vatolla, nell’antica Lucania (in particolare, nell’attuale Cilento, a poca distanza dall’antica Elea-Velia, Ascea, Paestum, Palinuro, Agropoli) e, al contempo, e che James Joyce a Giambattista Vico ha reso l’omaggio più grande che mai poeta potesse fare a un filosofo: "La strada di Vico gira e rigira per congiungersi là dove i termini hanno inizio. Tuttora inappellati dai cicli e indisturbati dai ricorsi, sentiamo tutti sereni, mai preoccupati al nostro doveroso compito... Prima che vi fosse un uomo in Irlanda c’era un lord in Lucania".
C’era un lord in Lucania (Italia): "The Vico road goes round and round to meet where terms begin. Still anappealed to by the cycles and onappaled by the recourses, we fill all serene, never you fret, as regards our dutyful cask... before there was a man in Ireland there was a lord in Lucan " (Cfr.: AA. VV., Introduzione a Finnegans Wake, trad. di Francesco Saba Sardi, Sugar Editore, Milano 1964. La citazione è ripresa dal saggio di Samuel Beckett, "Da Dante a Bruno, da Vico a Joyce", pp. 9-26. La precisazione sulla Lucania e Vatolla è mia). E, ancora: nessuno sa che Giambattista Vico, stampata la sua prima “Scienza Nuova”, inviò a Londra, a Isaac Newton una copia del suo capolavoro.
Dopo quasi due secoli, nei confronti di colui che ha osato disubbidire alle Leggi della Repubblica di Platone e riammettere a pieno titolo nello Stato Omero, i “poeti”, e restituire alle donne tutta loro dignità, la rimozione continua: la cecità dei nipotini di Platone (come di Cartesio, Hegel, e Heidegger), i sacerdoti della casta atea e devota, è totale! Di fronte all’impresa e alla dipintura della Scienza Nuova perdono subito (e ancora) la loro ‘magistrale’ lucidità e ripiombano nella notte della loro “barbarie della riflessione”!
Quanto segue vuol essere solo una sollecitazione e un invito a rileggere tutta l’opera di Vico e, possibilmente, a valutare al meglio il suo grande contributo, a gloria dell’Italia, per la dignità dell’intero genere umano. Non altro.
* Cfr., Federico La Sala, Vico e la barbarie della riflessione (cliccare su RILEGGERE VICO)
-
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- FILIAZIONE DIVINA E "PRATICA DELLA SCIENZA NUOVA". VICO: "LA MENTE EROICA".12 maggio 2013, di Federico La Sala
 Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
 LA MENTE ACCOGLIENTE. Una traccia per la rilettura della "Scienza Nuova". All’alta fantasia e al grande lavoro di Giambattista Vico, un omaggio
LA MENTE ACCOGLIENTE. Una traccia per la rilettura della "Scienza Nuova". All’alta fantasia e al grande lavoro di Giambattista Vico, un omaggio -
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- PAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.19 aprile 2013, di Federico La SalaPAROLA DI VICO. SULLA MODERNITA’ DI CARTESIO, RICREDIAMOCI.
 Cartesio va avanti mascherato, senza verità e senza grazia (“charis”): Renato, ambiziosissimo di gloria“, è un cattivo storico dell’“altro”, di “se medesimo” e, come cattivo storico, anche un cattivo filosofo! E’ un filosofo narcisista (...)
Cartesio va avanti mascherato, senza verità e senza grazia (“charis”): Renato, ambiziosissimo di gloria“, è un cattivo storico dell’“altro”, di “se medesimo” e, come cattivo storico, anche un cattivo filosofo! E’ un filosofo narcisista (...)
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E --- L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima".30 marzo 2013, di Federico La SalaRIVOLUZIONE SCIENTIFICA E RIVOLUZIONE COPERNICANA IN FILOSOFIA ....
 L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima"
L’ERRORE DI CARTESIO: VICO A FIANCO DI GALILEI E NEWTON. Note per una (ri)lettura del "De antiquissima"
-
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- VICO (E KANT), PER LA CRITICA DELLE VERITA’ DOGMATICHE E DELLE CERTEZZE OPINABILI.6 marzo 2013, di Federico La SalaL’ITALIA AL BIVIO. LA LEZIONE DI GIAMBATTISTA VICO, OGGI: "LEMURUM FABULA" (LA STORIA DEI LEMURI)
 PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI.
PER UNA NUOVA CITTA’ DELLA SCIENZA, UN OMAGGIO A VICO E LA MASSIMA SOLIDARIETA’ A NAPOLI E A BAGNOLI.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89) --- E DEL 2013. CONTRO LA "BORIA DEI DOTTI" (G. VICO), IL PROGRAMMA DI GRILLO E LA LEZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE.26 febbraio 2013, di Federico La Sala
 CRISI COSTITUZIONALE (1994-2013). GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN PRIVATO. Che male c’è?!
CRISI COSTITUZIONALE (1994-2013). GLI APPRENDISTI STREGONI E L’EFFETTO "ITALIA". LA CLASSE DIRIGENTE (INCLUSI I GRANDI INTELLETTUALI) CEDE (1994) IL "NOME" DEL PAESE AL PARTITO DI UN PRIVATO. Che male c’è?!
 BEPPE GRILLO E IL SUO PROGRAMMA: "RIPRENDIAMOCI QUELLE PAROLE"! 2004-2013: otto, nove anni di lavoro culturale e un grande successo politico. Un suo intervento su "la Repubblica" (2004)
BEPPE GRILLO E IL SUO PROGRAMMA: "RIPRENDIAMOCI QUELLE PAROLE"! 2004-2013: otto, nove anni di lavoro culturale e un grande successo politico. Un suo intervento su "la Repubblica" (2004)
 Non è grottesco che proprio chi per vent’anni ha corrotto la forza, l’intelligenza e la reputazione di questo Paese prenda ancora in giro gli italiani al grido di "Forza Italia"?
Non è grottesco che proprio chi per vent’anni ha corrotto la forza, l’intelligenza e la reputazione di questo Paese prenda ancora in giro gli italiani al grido di "Forza Italia"?
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- VICO, FACHINELLI, E LA BRUTTURA DELLA DIPINTURA "TUTTA CONTRARIA" DELLA "SCIENZA NUOVA".21 febbraio 2013, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- VERSO UN’ERA COLLEGIALE. CRISI DEL PAPATO: UN’EMERGENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA.20 febbraio 2013, di Federico La SalaCRISI DEL PAPATO: UN’EMERGENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA. AI CARDINALI, PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA, NELLA CAPPELLA SISTINA: GUARDARE IN ALTO! Andiamo "verso un’era collegiale"! Una nota di Franco Cardini - con appunti
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- SAN PAOLO E IL ’PARTITO’ SACERDOTALE RICOSTITUITO29 gennaio 2013, di Federico La SalaARMIAMOCI E PARTITE: CONQUISTATE LA TERRA! SAN PAOLO, IL ’PARTITO’ SACERDOTALE RICOSTITUITO E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO ROMANO.
 LA "DONAZIONE DI PIETRO" - PAOLO: "come Platone (...), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli, delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo dei pagani e, da cittadino romano, la porta e consegna nelle mani di Roma (...).
LA "DONAZIONE DI PIETRO" - PAOLO: "come Platone (...), afferra l’anima della vita evangelica degli apostoli, delle cristiane e dei cristiani, approfittando delle incertezze e dei tentennamenti di Pietro, si fa apostolo dei pagani e, da cittadino romano, la porta e consegna nelle mani di Roma (...).
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- E LA DEMOCRAZIA "REALE".24 gennaio 2013, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE.25 gennaio 2013, di Federico La Sala
 IL CATTOLICESIMO COME TRADIMENTO STRUTTURALE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, DEL CRISTIANESIMO. UN’OBBEDIENZA CIECA DI LUNGA DURATA: TUTTI AGGIOGATI AL DIO-VALORE, AL DIO-MAMMONA ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)!
IL CATTOLICESIMO COME TRADIMENTO STRUTTURALE DEL MESSAGGIO EVANGELICO, DEL CRISTIANESIMO. UN’OBBEDIENZA CIECA DI LUNGA DURATA: TUTTI AGGIOGATI AL DIO-VALORE, AL DIO-MAMMONA ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)!
 LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE. "Dio sempre dalla parte dell’uomo". Una nota di Ermes Ronchi - con appunti
LA SCONVOLGENTE LIBERAZIONE. "Dio sempre dalla parte dell’uomo". Una nota di Ermes Ronchi - con appunti
-
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- A PARIGI ACCOLTA E APPLAUDITA LA VERITA’ RIVELATA AGLI ESSERI UMANI DAL PAPA E DAI VESCOVI.16 gennaio 2013, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- NASCERE HA SEMPRE UN SENSO.23 dicembre 2012, di Federico La Sala
 Nascere ha sempre senso
Nascere ha sempre senso
 Già prima di Cristo gli stoici negavano che fosse meglio non esistere
Già prima di Cristo gli stoici negavano che fosse meglio non esistere
 In tempi di crisi ritorna il pessimismo cosmico ma conviene seguire Pirandello e non Leopardi
In tempi di crisi ritorna il pessimismo cosmico ma conviene seguire Pirandello e non Leopardi di Marco Rizzi (Corriere della Sera-La Lettura, 23.12.2012)
di Marco Rizzi (Corriere della Sera-La Lettura, 23.12.2012)Pur nel mezzo della pesante crisi che stiamo attraversando, un calendario del prossimo anno non mancherà di certo anche nei più smilzi pacchi dono che ci saranno recapitati in questi giorni di Natale. Tuttavia, a differenza di qualche tempo fa, il futuro verso cui ci farà alzare lo sguardo appare segnato dall’incertezza e dal dubbio; quanto riusciremo a conservare del benessere acquisito sino a oggi? Soprattutto: potremo sperare ancora in un futuro migliore, in un progresso comune in cui ciascuno possa inserirsi e lasciare qualcosa di significativo a chi verrà dopo di noi?
Il pensiero ritorna ai banchi di scuola, alla lettura - immancabile nella scuola italiana di ogni ordine e grado - del Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere di Leopardi, quello in cui un passante smonta, con diabolica abilità dialettica, l’offerta di acquistare un calendario per l’anno nuovo, perché, nonostante le promesse del venditore, nessuno vorrebbe ricominciare daccapo la vita che ha sin lì vissuto: «Ciascuno è d’opinione che sia stato di più o di più peso il male che gli è toccato, che il bene».
L’idea compariva già in un passo dello Zibaldone di qualche anno precedente; comunemente si pensa che Leopardi l’abbia derivata dai suoi amati autori antichi: è celebre il detto attribuito a Sileno secondo cui «non essere mai nati è la cosa migliore e la seconda, una volta venuti al mondo, tornare da dove si è venuti» - così nella forma in cui lo riporta Sofocle. Non tutti gli antichi, però, condividevano un simile pessimismo cosmico; i filosofi stoici, ad esempio, non solo ritenevano che la presenza nel mondo di ogni uomo facesse parte di un mirabile disegno provvidenziale, ma addirittura giungevano a sostenere che gli eventi di questo mondo e la vita di ciascuno si sarebbero ripetuti identici nel corso di una infinita successione di ere cosmiche sempre eguali tra loro.
Dal canto loro, i primi cristiani affermavano che nascere era una fortuna, proprio (o solo) perché permetteva di rinascere alla vita eterna; in questo modo, era ribadito il disegno della provvidenza, ma il ciclo degli eterni ritorni veniva definitivamente infranto e il destino dell’uomo posto nell’amore misericordioso di Dio. Anche quando l’attenzione al destino ultraterreno si verrà attenuando, la rottura cristiana della ciclicità del tempo antico lascerà aperto lo spazio della speranza e del fattivo impegno per un futuro migliore già in questo mondo.
È con l’Illuminismo che si opera un decisivo cambio d’orizzonte; nel Dictionnaire historique et critique di Pierre Bayle, pubblicato nel 1697, il rifiuto di rinascere una seconda volta poggia sull’esperienza del singolo, su di un pessimismo personale, non più su una visione cosmica: è nella vicenda di ciascuno che si rivela drammaticamente l’assenza della provvidenza e di un qualsiasi disegno che diriga la vita dell’uomo, ancor prima che il corso della storia. Non il nascere in quanto tale è un male, come voleva Sileno, bensì il concreto andamento dell’esistenza umana che indica, a chi la osserva con ragione, come non valga la pena di riviverla - salvo invidiare quella degli altri, che illusoriamente appare meno infelice.
Il vasto dibattito illuministico su questi temi, ricostruito da Stefano Brogi (Nessuno vorrebbe rinascere. Da Leopardi alla storia di un’idea tra antichi e moderni, Ets, pp. 216, 22), suscitò ovviamente la reazione dei teologi e dei pensatori cristiani in difesa della provvidenza e dell’azione di Dio nella storia; ma persino Leibniz, che pure sosteneva che quello presente fosse il migliore dei mondi possibili, dovette ammettere che, in fondo, chiunque accetterebbe di rinascere solo a condizione di avere una vita diversa da quella vissuta - diversa, non necessariamente migliore.
Questo è il retroterra su cui si innesta il Dialogo di Leopardi: un testo, a sua volta, presente alle riflessioni di Schopenhauer, che riconosce come «lo scherno e lo strazio di questa esistenza... egli (Leopardi) lo dichiara in ogni pagina della sua opera, e però con una tale molteplicità di forme e di giri, con una tale ricchezza di immagini, da non ingenerare mai fastidio, riuscendo anzi sempre dilettoso e stimolante».
È con Nietzsche che l’idea leopardiana subisce una torsione sorprendente e inaspettata: il giudizio sulla vita dell’uomo resta sconfortante e negativo, ma proprio perché non vi è alcuna provvidenza, e in fondo nessun senso nell’esistenza, l’unica speranza che ci è data è la vita che viviamo, a cui occorre dire di sì in tutti i suoi aspetti, compresa la sua identica riproposizione. Tale si rivela il significato ultimo della dottrina dell’eterno ritorno proclamato dallo Zarathustra nietzschiano: una prova sovrumana, alla quale potrà rispondere solamente l’Übermensch, il superuomo, colui che è «il vero senso della terra». Il mito stoico dell’eterno ritorno non risulta più legato all’azione della provvidenza o alla promessa di Dio, ma diviene trasparente metafora della condizione umana, condannata a consumarsi nel fallimento di questa vita.
A ben vedere, questo esito risulta insostenibile. Lo riconosce un altro insospettabile pessimista incontrato sui banchi di scuola, Pirandello. Nel racconto Notizie dal mondo, Tommaso tiene un monologo sulla tomba dell’amico morto, Momino; interrogandosi proprio sull’origine del mito dell’eterno ritorno, conclude che solo due amici felici - o due innamorati - potevano aver sognato una cosa simile: «Quanto mi piacerebbe, se ci facessero tornare tutti e due assieme! Sono sicuro che, pur non avendo memoria della nostra vita anteriore, noi ci cercheremmo sulla terra e saremmo amici come prima». Siamo ormai consapevoli che non ci è dato scegliere se rinascere o no; né ci è facile cogliere quale sia la direzione in cui l’umanità si muove; proprio questo, però, ci rende liberi di dare un senso al nostro nascere e rinascere ogni giorno, alzando lo sguardo da noi stessi e cercando quello degli altri.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ESSERE GIUSTI CON KANT.20 novembre 2012, di Federico La SalaKANT: L’INTERPRETAZIONE DEI "SOGNI" (1766) E L’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’ (1784) DEL FARAONE-DIO
 ESSERE GIUSTI CON KANT. La lezione di Michel Foucault e la sorpresa di Habermas.
ESSERE GIUSTI CON KANT. La lezione di Michel Foucault e la sorpresa di Habermas.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- RECALCATI RIPETE oggi e ancora LA LEZIONE DEL PADRE-LACAN. La società orizzontale (di Massimo Recalcati)26 novembre 2012, di Federico La Sala
- INDIVIDUO E SOCIETA’ E COSTITUZIONE, IERI COME OGGI. USCIRE DALLO STATO DI MINORITA’, APRIRE GLI OCCHI: C’E’ DIO E "DIO", PATRIA E "PATRIA", E FAMIGLIA E "FAMIGLIA" ..... - ROMOLO AUGUSTOLO: L’ITALIA NON E’ NUOVA A QUESTI SCENARI. C’E’ CAPO E "CAPO" E STATO E "STATO": MUSSOLINI E LENIN A CONFRONTO. L’analisi di Gramsci (già contro derive staliniste!), una bussola per non naufragare e una lezione di vita e di libertà
- PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
La società orizzontale
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 25 novembre 2012)
Nel nostro tempo spira un vento forte in direzione contraria alla funzione sociale delle istituzioni. Gli esempi sono molteplici e investono anche la nostra vita collettiva: dalla famiglia alla Scuola, dai partiti ai sindacati, dall’editoria alla vita affettiva, assistiamo ad una caduta tendenziale della mediazione e della sua funzione simbolica.
Di fronte ad una bocciatura i genitori tendono ad allearsi con i loro figli più che con gli insegnanti; possono cambiare scuola o impugnare la loro causa rivolgendosi ai giudici del Tar; il ruolo educativo da parte di un adulto suscita spesso il sospetto di un abuso di potere; la Rete offre la possibilità a chi ritiene di essere uno scrittore di farsi il proprio libro online senza passare dal giudizio degli editori; la figura del critico, che faceva da ponte tra opera e pubblico, è oramai azzerata; le amicizie non passano più dalla mediazione indispensabile dell’incontro dei volti e dei corpi, ma si coltivano in modo immateriale sui social networks;di fronte alla dimensione necessariamente snervante del conflitto politico si preferisce l’opzione della violenza o dell’insulto.
Anche i sintomi che affliggono la vita delle persone hanno cambiato di segno; mentre qualche decennio fa apparivano centrati sulle pene d’amore, sull’importanza irrinunciabile del legame sociale, oggi non è più la rottura del legame a fare soffrire, ma è l’esistenza del legame che viene avvertita come fonte di disagio.
Un disagio diffuso soprattutto tra i ragazzi. Milioni di giovani vivono, nel mondo cosiddetto civilizzato, come prigionieri volontari. Hanno interrotto ogni legame con il mondo, si sono ritirati nelle loro camere, hanno abbandonato scuola e lavoro. Questa moltitudine anonima preferisce il ritiro, il ripiegamento su di sé, alla difficoltà della traduzione imposta dalla legge della parola.
È un segno dei nostri tempi. Il Terzo appare sempre più come un intruso. Eppure non c’è vita umana che non si costituisca attraverso la mediazione simbolica dell’Altro. Il pianto angosciato di un bambino nella notte ci chiama alla risposta, alla presenza, ci convoca nella nostra responsabilità di accogliere la sua vita. Il mito del farsi da se stessi, dell’autogenerazione, come quello del farsi giustizia da sé, è un mito che il liberismo contemporaneo ha assunto come un suo stemma.
In realtà nessuno è padrone delle sue origini, come nessuno può essere salvatore del mondo. Non esiste comunità umana senza mediazione istituzionale, senza mediazione simbolica, senza il lavoro paziente della traduzione della lingua dell’Altro.
Divento ciò che sono solo passando dalla mediazione dell’Altro (famiglia, istituzioni, società, cultura, lavoro, ecc.) e non solo attraverso le esperienze personali che ho fatto. Nel nostro tempo questa mediazione necessaria alla vita è in crisi.
Nel nome di una società orizzontale che esalta i diritti degli individui senza dare il giusto peso alle loro responsabilità evapora la dimensione della mediazione simbolica: fare gli interessi della collettività è percepito come un abuso di potere contro la libertà dell’individuo.
Questo declino della mediazione simbolica non significa solo che il nostro tempo ha smarrito la funzione orientativa dei grandi ideali della modernità e scorre privo di bussole certe al di fuori dei binari solidi che le grandi narrazioni ideologiche del mondo (cattolicesimo, socialismo, comunismo, ecc) e le sue istituzioni disciplinari (Stato, Chiesa, Esercito) assicuravano, ma manifesta una sorta di mutazione antropologica della vita.
L’individualismo si afferma nella sua versione più cinica e narcisistica investendo la dimensione della mediazione simbolica di un sospetto radicale: tutte le istituzioni che dovrebbero garantire la vita della comunità non servono a niente, sono, nella migliore delle ipotesi, zavorre, pesi arcaici che frenano la volontà di potenza dell’individuo o, nella peggiore delle ipotesi, luoghi di sperpero e di corruzione osceni. Ma come? Non è compito delle istituzioni, come dichiarava Lacan, porre un freno al godimento individuale rendendo possibile il patto sociale, la vita in comune?
La violenza di questa crisi economica ha prodotto giusta indignazione e sfiducia verso tutto ciò che agisce in nome della vita pubblica, verso tutto ciò che sfugge al controllo diretto del cittadino. Le istituzioni non l’hanno saputa avvertire, frenare, governare.
Il caso della politica si impone come esemplare. Il luogo che secondoAristotele deve riuscire a determinare l’integrazione pubblica delle differenze individuali sotto il segno del bene dellapolis- il luogo più eminente della traduzione simbolica - si è rivelato corrotto dalla affermazione più scriteriata degli interessi individuali.
Il politico liberato dal peso dell’ideologia si è ridotto a un furfante che ruba per se stesso. Eppure non si può rinunciare così facilmente alla politica, l’arte della mediazione.Perché i rischi sono evidenti, li abbiamo visti in questi anni, tra leadership carismatiche e fondazioni mitiche. Li vediamo oggi quando avanza un nuovo populismo che si appoggia sulla democrazia tecnologica garantita dalla Rete per evitare la “truffa” della mediazione politica.
Ma il populismo non è forse una forma radicale di pensiero anti-istituzionale che rigetta la mediazione simbolica affermando l’illusione di una democrazia diretta puramente demagogica?In questo senso il liberale conservatore Lacan replicava alle critiche degli studenti del ’68 che gli rimproveravano di non autorizzare la rivolta contro le istituzioni che non esiste alcun “fuori” dalla mediazione imposta dal linguaggio. Il destino degli esseri parlanti è infatti quello della traduzione.
Lacan disillude l’impeto rivoluzionario degli studenti: non esiste possibilità che una rivolta animata dalla rottura con il campo istituzionale del linguaggio non ricada nella stessa violenza dalla quale avrebbe voluto liberarsi. La rivoluzione porta sempre con sé un nuovo padrone.
L’invocazione di una democrazia diretta che reagisca in modo anti-istituzionale alla debolezza e alla degenerazione insopportabile delle istituzioni rischia di spalancare il baratro di un populismo che finisce per gettare via insieme all’acqua sporca anche il bambino.
Il grillismo sbandiera una forma di partecipazione diretta del cittadino che rifiuta, giudicandola un ferro vecchio della democrazia, la funzione sociale dei partiti. Ma è un film che abbiamo già visto. È una legge storica e psichica, collettiva e individuale insieme: chi si pone al di fuori del sistema del confronto politico e della mediazione simbolica che la democrazia impone,finisce per rigenerare il mostro che giustamente combatte.
Non è solo un insegnamento della storia ma anche, più modestamente, della pratica della psicoanalisi. La rabbia verso i padri, il puro rifiuto di tutto ciò che si è ricevuto, il disprezzo dell’eredità, rischia sempre di generare una protesta sterile, che impedisce di discriminare l’oro dal fango, che fa di tutta l’erba un fascio, e,dulcis in fundo,che mantiene legati per sempre al padre di cui ci si voleva liberare, rieditandone il volto mostruoso e autoritario.
-
>RECALCATI RIPETE oggi e ancora LA LEZIONE DEL PADRE-LACAN. --- "La Legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi": il nuovo saggio di Massimo Recalcati (di Roberto Esposito).20 giugno 2022, di Federico La Sala
Dalla Bibbia alla psicoanalisi: il nuovo saggio di Massimo Recalcati
In "La legge della parola", lo psicoanalista rilegge alcuni episodi del Vecchio Testamento con gli strumenti di Freud e Lacan, facendo incontrare due linguaggi
di Roberto Esposito (la Repubblica, 15 giugno 2022).
- [Foto] Eugène Delacroix: La lotta di Giacobbe con l’angelo (1853-1861)
- Il libro. "La legge della parola" di Massimo Recalcati è edito da Einaudi (pagg. XIV - 386, euro 21)
Nella prima cappella a destra della Chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi, vi è una pittura murale di Eugène Delacroix che ritrae la figura biblica della lotta di Giacobbe. L’identità del personaggio con cui si batte è misteriosa. Chi è l’essere che affronta in un corpo a corpo mortale? Un uomo, un angelo, un dio? Chiunque sia, in termini simbolici Giacobbe lotta contro se stesso, con la propria immagine speculare, col fantasma del proprio narcisismo. Secondo il racconto biblico, quando il combattimento finalmente termina, Giacobbe resta ferito all’anca. Quella ferita alla propria identità lo muta profondamente, dandogli un nuovo nome. Reciso un legame troppo vincolante con se stesso, egli adesso è pronto a incontrare l’Altro, ad aprirsi alla relazione.
È la lettura, profonda e suggestiva, che nel suo nuovo libro, La Legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi, edito da Einaudi, Massimo Recalcati fornisce di quell’episodio e, più in generale, del Libro. Come egli stesso spiega, non si tratta di un’interpretazione psicoanalitica della Bibbia e neanche di una declinazione religiosa della psicoanalisi. Ma di un incontro tra linguaggi diversi, che tali restano, reso possibile da un presupposto comune: esiste una legge non al servizio della morte - della colpa e del castigo -, ma destinata a generare nuova vita.
Si tratta della legge della parola. Essa chiede all’uomo di non volersi fare Dio, di ammettere la propria finitezza, di riconoscere la tensione che attraversa la sua esperienza, umanizzandola. La stessa che per Freud articola pulsione di vita e pulsione di morte e per Lacan distingue desiderio e godimento. Solo superando l’identificazione narcisistica con la propria immagine, come fa Giacobbe, l’uomo può riconoscere il ritmo dell’esistenza nell’alternanza tra pienezza e mancanza, gioia e dolore, vittoria e sconfitta. La rinuncia al godimento assoluto - comunque non alla nostra portata - apre la porta al desiderio. Soltanto l’esperienza di una lesione profonda - abbandono, perdita, lutto - può rendere di nuovo generativa la vita umana.
Da questa prospettiva - maturata in una rivisitazione particolarmente creativa della psicoanalisi lacaniana - Recalcati rilegge gli episodi più intensi della Bibbia. Al centro di tutti torna, declinato in modi diversi, il rapporto costitutivo tra desiderio e divisione. Il rifiuto della fusione con se stessi a favore dell’alterità. Da parte dell’uomo, ma anche di Dio. Che, nella genesi, crea il mondo separandolo da sé. La luce di cui lo inonda coincide con la forza simbolica di una parola che rompe la notte dell’indifferenziato, generando l’infinita molteplicità della vita. Come anche nella psicoanalisi freudiana e lacaniana, la parola che Dio rivolge all’uomo non è solo comunicazione, ma rivelazione. Luce e taglio. Creando il mondo Dio si ritira, rinuncia all’onnipotenza, come hanno diversamente sostenuto Lévinas, Bonhoeffer, Simone Weil. Con un secondo taglio immette la differenza, anche sessuale, nelle forme viventi. Separa la vita umana dalla nuda vita biologica.
Ma, contro ogni retorica umanistica, la vita umana non nasce integra. Sperimenta l’odio prima dell’amore, la vendetta prima del perdono. Il fratricidio di Caino apre la storia dell’uomo nel segno della violenza assoluta. Egli uccide il fratello per essere solo, per essere tutto.
Come sostiene Lacan, Caino è l’altro nome di Narciso. Riconosce in Abele la propria immagine irraggiungibile e la distrugge. Dio lo condanna, per poi salvarlo, spezzando la catena della violenza reciproca. La violenza divina non è mai cieca. Il diluvio che scatena sul mondo corrotto consente a Noè di rigenerarlo. Così come il crollo della torre di Babele e del suo sogno di monolinguismo ripristina la molteplicità delle lingue. Perfino nell’episodio, in prima istanza incomprensibile, del sacrificio di Isacco, la mano di Dio si arresta, si ritira, sostituendo un montone al figlio prediletto di Abramo. Dio rinuncia al dominio, interrompendo la spirale del sacrificio.
Il rapporto dell’uomo con Dio resta problematico. Il racconto biblico non nasconde la tensione. Al contrario, come farà la psicoanalisi, la rivela. Il grido di Giobbe, a metà tra blasfemia e preghiera, reclama una spiegazione da Dio per la sofferenza ingiusta. Anch’egli non è una figura della rassegnazione, della pazienza, ma della lotta. In termini psicoanalitici, la sua vicenda attesta che, se la sofferenza umana è ineliminabile, attraverso il sintomo la si può interpretare, tradurre, decifrare. Il libro sapienziale di Qohelet spinge al culmine la consapevolezza dell’inaggirabilità della morte e dunque della vanità della vita. Il suo eterno oscillare tra splendore e polvere. Ma invita, proprio perciò, a godere di quanto si ha. Non nell’attesa, ma ora, adesso.
Per questo Recalcati collega Qohelet al Cantico dei cantici. In questo esplode la gioia dell’amore, la festa degli amanti. Che, però, non infrange la legge del desiderio, non s’inscrive nella logica del godimento assoluto. Anzi lo dichiara impossibile. Impossibile è la fusione in Uno di coloro che restano Due, differenziando la disponibilità femminile dal sogno di possesso maschile. La Bibbia rivela la problematicità, ma anche la necessità, del rapporto. Come insegna il racconto paradossale di Giona, il più umano dei profeti, è difficile rispondere alla chiamata di Dio, ma tale difficoltà custodisce il mistero dell’esistenza.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA NASCITA DELL’ESSERE UMANO E IL GIOCO DEL ROCCHETTO. Al di là del giogo di Edipo e Giocasta.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- L’Anti-Edipo: il desiderio onnipotente di Deleuze e Guattari (di Massimo Recalcati).17 novembre 2012, di Federico La Sala
 L’epoca senza Edipo
L’epoca senza Edipo
 Il desiderio onnipotente di Deleuze e Guattari
Il desiderio onnipotente di Deleuze e Guattari
 Quarant’anni fa il testo dei due studiosi che ha fatto storia
Quarant’anni fa il testo dei due studiosi che ha fatto storia
 Ma quelle tesi così decisive hanno avuto anche effetti negativi
Ma quelle tesi così decisive hanno avuto anche effetti negativi di Massimo Recalcati (La Repubblica, 17.11.2012)
di Massimo Recalcati (La Repubblica, 17.11.2012)Quest’anno ricorre il quarantennale dell’uscita di un libro che fece epoca: l’Anti- Edipo di Deleuze e Guattari che uscì a Parigi nel 1972. Si tratta della più potente critica alla pratica e alla teoria della psicoanalisi mossa da “sinistra”. Oggi, come sappiamo, imperversa la critica conservatrice: contro la psicoanalisi vengono invocati la psicologia scientifica, il potere chimico dello psicofarmaco, l’autorità esclusiva della psichiatria nel trattamento del disagio mentale. Invece gli autori dell’Anti- Edipo (un filosofo già molto noto e un brillante psichiatra analizzante di Lacan con il quale ruppe bruscamente) non rimproverano affatto alla psicoanalisi di non essere sufficientemente scientifica nella sue affermazioni teoriche e nella sua pratica clinica, ma qualcosa di assai più radicale. Le rimproverano di essere al servizio del potere e dell’ordine stabilito.
La loro accusa è che la psicoanalisi dopo aver scoperto il “desiderio inconscio” ha volutamente ridotto la portata rivoluzionaria di questa scoperta mettendosi al servizio del padrone. Su cosa si reggerebbe il culto psicoanalitico dell’Edipo se non sull’obbedienza cieca alla Legge repressiva e mortificante del padre? Nonostante la violenza spietata degli Anti-Edipo gli psicoanalisti dovrebbero leggere e rileggere ancora oggi la loro opera come un grande vento di primavera.
Sotto la retorica rivoluzionaria della liberazione del corpo schizo, fuori-Legge, del “corpo senza organi” come macchina desiderante, come fabbrica produttiva del godimento pulsionale, questo libro contiene una serie di rilievi alla psicoanalisi che non si possono accantonare: la critica relativa all’uso paranoico e violento dell’interpretazione (se un paziente dice X vuole dire Y), una rappresentazione dell’inconscio come teatrino familaristico, chiuso su se stesso, che perderebbe di vista il suo carattere sociale e i suoi infiniti concatenamenti collettivi, una apologia conformista e moralista del principio di realtà e dell’adattamento come fine ultimo della pratica analitica, l’uso tutto politico del denaro che seleziona i pazienti in base al loro reddito, una valorizzazione del-l’Io e del suo principio di prestazione, eccetera.
Eppure questo libro va molto al di là di questo, perché ha mobilitato alla rivolta una intera generazione, quella del ’77. Quest’opera è una critica politica alla psicoanalisi che non promuove tanto una improbabile teoria alternativa a quella psicoanalitica (la schizoanalisi) ma una vera e propria teoria della rivoluzione dove “tutto è possibile”.
A questa teoria si sono abbeverati con entusiasmo i giovani della mia generazione. Foucault aveva dichiarato che il nostro secolo forse sarebbe stato deleuziano. Aveva ragione ma in un senso probabilmente molto diverso da quello che auspicava. Il deleuzismo è sfuggito dalle mani di Deleuze (come spesso accade per tutti gli “ismi”).
L’Anti- Edipo ha dato involontariamente la stura ad un elogio incondizionato del carattere rivoluzionario del desiderio contro la Legge che ha finito paradossalmente per colludere con l’orgia dissipativa che ha caratterizzato i flussi - non delle macchine desideranti come si auspicavano Deleuze e Guattari - ma di denaro e di godimento che hanno alimentato la macchina impazzita del discorso del capitalista.
Lacan aveva provato a segnalare ai due questo pericolo. In una intervista rilasciata a Rinascita nel maggio del 1977 a chi gli chiedeva un parere sull’Anti- Edipo rispose che «L’Edipo costituisce di per se stesso un tale problema per me che non penso che ciò che Deluze e Guattari hanno voluto intitolare l’Anti- Edipo possa avere il minimo interesse».
Lacan avverte che non bisogna premere il grilletto troppo rapidamente sul padre. La contrapposizione rivoluzionaria tra le macchine desideranti e la Legge, tra la spinta impersonale e de-territorializzante della potenza del desiderio e la tendenza conservatrice alla territorializzazione rigida del potere e delle sue istituzioni (Chiesa, Esercito, famiglia, psicoanalisi...) rischiava di dissolvere il senso etico della responsabilità soggettiva.
Per Deleuze e Guattari la parola soggetto è infatti una parola da mettere al bando, così come Legge, castrazione, mancanza. L’Anti-Edipo compie un elogio a senso unico della forza della pulsione che lo fa scivolare fatalmente in una prospettiva di naturalizzazione vitalistica dell’umano.
La liberazione dei flussi del desiderio reagisce giustamente al culto rassegnato del principio di realtà al quale sembra votarsi la psicoanalisi, senza accorgersi di generare un nuovo mostro: il mito della schizofrenia come nome della vita che rigetta ogni forma di limite. Il mito del corpo schizo come corpo anarchico, a pezzi, pieno, senza organi, costruito come una macchina pulsionale che gode ovunque, antagonista alla gerarchia dell’Edipo, si è tradotto nei flussi della macchina cinica e perversa del discorso capitalista.
Eppure l’Anti-Edipo a rileggerlo oggi è anche molto più di questo. Non è solo la celebrazione di un desiderio che non riesce a fare i conti con la Legge della castrazione. C’è una linea più sottile che attraversa questo libro e che la nostra generazione non è riuscita probabilmente a cogliere sino in fondo. È un grande tema dell’Anti-Edipo anche se non il tema centrale. Deleuze e Guattari lo ripropongono attraverso le parole dello psicoanalista Reich: «perché le masse hanno desiderato il fascismo? ». Problema che ritroviamo intatto già in Spinoza: perchè gli uomini combattono per la loro servitù come se si trattasse della loro libertà?
In Millepiani Deleuze e Guattari, quasi dieci anni dopo l’Anti- Edipo, devono ritornare sull’opposizione tra desiderio e Legge con una precisazione che avrebbe dovuto essere presa più sul serio. Attenzioni ai micro-fascismi, ai micro-edipi che s’insediano proprio là dove pensavamo ci fosse il flusso liberatorio del desiderio. «La madre - scrivono i due - può credersi autorizzata a masturbare il figlio, il padre può diventare mamma». Un’autocritica che suona anticipatrice dei nostri tempi.
Come Nietzsche avvertiva gli uomini che vivevano nell’annuncio liberatorio della morte di Dio del rischio di generare nuovi idoli (lo scientismo, il fanatismo ideologico, l’ateismo stesso, ogni specie di fondamentalismo), allo stesso modo Deleuze e Guattari avvertono che esiste un pericolo insidioso inscritto nella stessa teoria del desiderio come flusso infinito, come “linea di fuga” che oltrepassa costantemente il limite. Attenzione, sembrano dirci, che questa linea «non si converta in distruzione, abolizione pura e semplice, passione d’abolizione». Attenzione che questa “linea di fuga” che rigetta il limite non diventi una “linea di Morte”.
-
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- DOBBIAMO VIVERE INSIEME. Razzismo e multiculturalità (di Ernesto Balducci, 1992 - don Aldo Antonelli).14 novembre 2012, di Federico La Sala
DOBBIAMO VIVERE INSIEME
di Ernesto Balducci (Il Secolo XIX, 26 gennaio 1992) *
Il moltiplicarsi degli episodi di «razzismo» in tutta l’area occidentale (ma bisogna prepararsi: ne avremo presto anche nell’Est europeo, in fase rapida di omologazione) pone uno dei problemi radicali con cui deve confrontarsi ogni progetto politico, da quello di una semplice amministrazione civica a quello della Comunità europea. Non bisogna lasciarsi ingannare dalle simbologie e dalle fraseologie, spesso antisemitiche, che rimandano al razzismo ideologico hitleriano. Niente di strano che gli automatismi del razzismo prebellico continuino a funzionare: essi forniscono l’orizzonte immaginario di maniera a cui ricorre preferibilmente l’incultura. Ma l’impianto della nuova forma di razzismo, che io chiamo «fascismo etnologico», e, a mio giudizio, del tutto diverso.
Esso ha radici nell’ancestrale paura del diverso, e trova le sue ragioni immediate nella difesa della condizione di privilegio minacciata dall’arrivo di nuovi ospiti, gli immigrati dal ,Sud. Essi non sono più gli immigrati di altri tempi, destinati prima o poi all’assimilazione dentro la cultura che li accoglieva. Quando essi arrivano, trovano già uno spazio culturale omogeneo a quello d’origine. Il fatto nuovo è che la società capitalistica, in forza della stessa legge di mercato che ha fatto la sua fortuna, è costretta a ospitare vere e proprie comunità etnicamente aliene dalla sua cultura. [...]
Io sono tra quelli che ritengono inevitabile e, alla fine, provvidenziale un’Europa multietnica, ma mi rendo conto che questa previsione è un lusso da intellettuale, che rischia di mettere a pié pari la drammaticità del processo che la metamorfosi presuppone. E infatti il processo non avviene all’interno di una cultura della solidarietà, come quella che, grazie a Dio, sta crescendo negli ambienti cristiani; avviene dentro una cultura della competizione, giunta al massimo della sua diffusione.
I protagonisti degli atti di neorazzismo sono infatti quasi sempre dei «balordi», che recepiscono e trasmettono a livello istintuale una provocazione che andrebbe mediata da una cultura illuminata. Sono i prodotti tipici della «pedagogia» televisiva, in cui dominano i forti e i bravi; in cui, per dirla tutta (penso agli spot televisivi), il modello d’uomo è un mammifero vorace, dai muscoli efficienti, pronto al successo quale che sia.
Questa ideologia, svuotata di ogni lume di ragione, fa presa con la voglia di affermazione il cui sbocco preferito appunto, l’atto aggressivo contro il diverso. Infatti, se si spoglia l’uomo di ogni struttura culturale resta in lui la paura dell’altro, la percezione che la propria identità e messa in rischio dalla presenza dell’alterità.
Che siano, in molti casi, i poveri, i disoccupati, i sottoproletari, gli emarginati di casa nostra a farsi protagonisti di gesti deplorevoli non deve far meraviglia: sono proprio gli incolti a subire i riflessi di insicurezza causati dalla presenza dei diversi. Con una proiezione elementare essi riversano su chiunque rappresenti la diversità, magari con il colore della pelle, la brutale aggressività con cui scongiurare la paura, capovolgendola nel trionfo. La bravata li solleva subito al rango degli uomini di successo, i veri eroi della cultura dominante.
Detto questo, mi si permetta di definire col massimo della semplicità la questione etico-politica sollevata dalla cronaca del neorazzismo in un momento come questo, in cui l’Europa, a dispetto dei suoi trionfi, soffre di una drammatica assenza di progettazione del proprio futuro. Dato per scontato che la presenza dei gruppi etnici diversi dal nostro si farà più massiccia, si aprono due vie: quella della lenta assimilazione, di modo che in una o due generazioni gli immigrati diventino in tutto come noi, fuori che nel colore della pelle; o quella della convivenza tra gruppi etnicamente e culturalmente diversi.
Come ho detto, io credo che la via giusta - una via che ci porta oltre il mondo moderno, in una postmodernità dal profilo inafferrabile - sia quella della convivenza. Ma se questo è vero, dobbiamo affrettarci a predisporre gli strumenti necessari - a cominciare dalla scuola - perché questo futuro si avveri senza traumi. Sarà anche giusto mettere in prigione i balordi dalla testa rapata, ma quel che occorre è una rapida instaurazione della cultura della diversità. Le culture che si chiudono su di se sono condannate a morire. La nostra non fa eccezione.
* Il neorazzismo di casa nostra
Carissimi,
di fronte alle tristi cronache di eggressione e di pestaggi di cui hanno riferito le cronache locali di questi giorni, penso sia doveroso fermarsi a riflettere e interrogarci.
Per aiutarvi allego un bellissimo articolo di Padre Balducci che fu pubblicato dal giornale Il Secolo XIX nel 1992.
Io l’ho trovato molto profondo ed ATTUALE.
E’ intitolato "Dobbiamo vivere insieme"!
Un abbraccio a tutte e tutti.
Aldo [don Antonelli]
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. -- LA LEZIONE DI BERTRAND RUSSELL E LA LEZIONE DI ENRICO BERTI10 novembre 2012, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA E POLITICA. IL PENSIERO DELLA COSTITUZIONE E LA COSTITUZIONE DEL PENSIERO ....
 STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione - con una nota
STATO DI MINORITA’ E FILOSOFIA COME RIMOZIONE DELLA FACOLTA’ DI GIUDIZIO. Una ’lezione’ di un Enrico Berti, che non ha ancora il coraggio di dire ai nostri giovani che sono cittadini sovrani. Una sua riflessione - con una notaCOSTITUZIONE E PENSIERO. ITALIA: LA MISERIA DELLA FILOSOFIA ITALIANA E LA RICCHEZZA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO ...
 BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO".
BERTRAND RUSSELL: LA LEZIONE SUL MENTITORE (IGNORATA E ’SNOBBATA’), E "L’ALFABETO DEL BUON CITTADINO". -
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- VOLTA SISTINA (1512-2012). DOPO 500 ANNI, I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA ANCORA UN GROSSO PROBLEMA1 novembre 2012, di Federico La Sala
 MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
MICHELANGELO E LA SISTINA (1512-2012). I PROFETI INSIEME ALLE SIBILLE PER LA CHIESA UN GROSSO PROBLEMA ....
 DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
DOPO 500 ANNI, PER IL CARDINALE RAVASI LA PRESENZA DELLE SIBILLE NELLA SISTINA E’ ANCORA L’ELEMENTO PIU’ CURIOSO. Materiali sul tema, per approfondimenti
-
>LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- AL DI LA’ DEL VECCHIO E INCESTUOSO CATTOLICESIMO COSTANTINIANO.26 ottobre 2012, di Federico La Sala
 PSICOANALISI E CRISTIANESIMO:IN MEMORIA DI SIGMUND FREUD. LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA NON HA NIENTE A CHE FARE CON LA FAMIGLIA DI GESU’, DI GIUSEPPE E MARIA ...
PSICOANALISI E CRISTIANESIMO:IN MEMORIA DI SIGMUND FREUD. LA "SACRA FAMIGLIA" DELLA GERARCHIA CATTOLICO-ROMANA NON HA NIENTE A CHE FARE CON LA FAMIGLIA DI GESU’, DI GIUSEPPE E MARIA ...
 UNA COPPIA UN PO’ INCESTUOSA: LA MADRE ELENA E L’IMPERATORE COSTANTINO, IL "SIGNORE DEL MONDO" E LA MADRE DI "DIO". Tre donne «forti» dietro tre padri della fede. Una nota di Marco Garzonio - con appunti
UNA COPPIA UN PO’ INCESTUOSA: LA MADRE ELENA E L’IMPERATORE COSTANTINO, IL "SIGNORE DEL MONDO" E LA MADRE DI "DIO". Tre donne «forti» dietro tre padri della fede. Una nota di Marco Garzonio - con appunti
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- ALIENAZIONE: L’"ODISSEA" INCOMPIUTA DELLO SPIRITO. "Alienati di tutto il mondo unitevi".22 ottobre 2012, di Federico La Sala
 "DIO E’ VALORE" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006). PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA
"DIO E’ VALORE" (Benedetto XVI, "Deus caritas est", 2006). PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA
 ALIENAZIONE: L’"ODISSEA" INCOMPIUTA DELLO SPIRITO. "Alienati di tutto il mondo unitevi". Una nota di Marcello Musto - a c. di Federico La Sala
ALIENAZIONE: L’"ODISSEA" INCOMPIUTA DELLO SPIRITO. "Alienati di tutto il mondo unitevi". Una nota di Marcello Musto - a c. di Federico La Sala
-
> LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".21 ottobre 2012, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- IL LABORATORIO DI FREUD E LA LEZIONE DI FACHINELLI.4 ottobre 2012, di Federico La Sala
 AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
 FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica”
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica”
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- IL PAPA ATEO: COME E’ STATO ED E’ ANCORA POSSIBILE - OGGI?!27 settembre 2012, di Federico La Sala
 IL PONTEFICE MASSIMO - IL PAPA ATEO: COME E’ STATO ED E’ ANCORA POSSIBILE - OGGI?!
IL PONTEFICE MASSIMO - IL PAPA ATEO: COME E’ STATO ED E’ ANCORA POSSIBILE - OGGI?!
 Due note storiche: una di Leonard Boff e una di Luciano Canfora
Due note storiche: una di Leonard Boff e una di Luciano Canfora
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA.21 settembre 2012, di Federico La Sala
 DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
 GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA. Una nota di Federico La Sala
GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA. Una nota di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- I MANAGER GLOBALI E L’APOCALLISSE CULTURALE. Uomini e no (di Marco Revelli)21 settembre 2012, di Federico La Sala
 "FABBRICA ITALIA", "AZIENDA ITALIA": "FORZA ITALIA" (1992-2012)!!! Luciano Gallino, nel suo splendido "La lotta di classe dopo la lotta di classe" calcola che nel corso del ventennio a cavallo tra il novecento e il nuovo secolo lo spostamento di ricchezza dal monte salari al monte profitti sfiori i 250 miliardi di euro all’anno
"FABBRICA ITALIA", "AZIENDA ITALIA": "FORZA ITALIA" (1992-2012)!!! Luciano Gallino, nel suo splendido "La lotta di classe dopo la lotta di classe" calcola che nel corso del ventennio a cavallo tra il novecento e il nuovo secolo lo spostamento di ricchezza dal monte salari al monte profitti sfiori i 250 miliardi di euro all’anno
 IL CASO FIAT, I MANAGER GLOBALI, E L’APOCALISSE CULTURALE. Uomini e no. Un’analisi di Marco Revelli
IL CASO FIAT, I MANAGER GLOBALI, E L’APOCALISSE CULTURALE. Uomini e no. Un’analisi di Marco Revelli
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- RIFARE I CONTI CON KANT. Al di la’ della "tragedia" e della "commedia degli equivoci". Materiali sul "nuovo realismo".18 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- IL SOGNO DI UNA "COSA" DI BENEDETTO XVI15 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- PIRANDELLO E LA BUONA-NOVELLA. UN "URLO" MAGISTRALE PER BENEDETTO XV ... E BENEDETTO XVI.13 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- UN’EREDITA’ AL DI LA’ DELLA MITOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL MAGGIORASCATO.8 settembre 2012, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- RELIGIONE E POLITICA: UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO30 agosto 2012, di Federico La Sala
 Religione e Politica di "Mammona", del Dollaro e del "caro-prezzo" ("Deus caritas est")!!!
Religione e Politica di "Mammona", del Dollaro e del "caro-prezzo" ("Deus caritas est")!!!
 SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH.
SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH.
 LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO - con aggiornamenti.
LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO - con aggiornamenti.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- LEGGE 40 E VESCOVI. Spento il "Lumen Gentium", e confuso Dio ("Charitas") con Mammona ("Caritas"), confondono anche "bambino" con "embrione", e attaccano la Corte di Strasburgo che invita a distinguere (prima di unire). Un editoriale dell’Avvenire29 agosto 2012, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- GIOVANNI BOCCACCIO. Dopo 700 anni (dalla nascita), tutta viva la sua sacrosanta indignazione e tutto libero il suo spirito critico.25 agosto 2012, di Federico La Sala
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ---- LA RIVOLUZIONE NECESSARIA. La sfida femminista nel cuore della politica. Incontro nazionale: Paestum 5,6,7 ottobre 2012.20 agosto 2012, di Federico La Sala
 A PAESTUM, DONNE "SULLA SPIAGGIA. DAVANTI AL MARE" (E.F.), A POCHI PASSI DA VELIA- ELEA (LUOGO DELLE "FIGLIE DEL SOLE") E DA CONTURSI TERME ( LUOGO DELLE "12 SIBILLE"), PER RIPENSARE OGGI LA DEMOCRAZIA...
A PAESTUM, DONNE "SULLA SPIAGGIA. DAVANTI AL MARE" (E.F.), A POCHI PASSI DA VELIA- ELEA (LUOGO DELLE "FIGLIE DEL SOLE") E DA CONTURSI TERME ( LUOGO DELLE "12 SIBILLE"), PER RIPENSARE OGGI LA DEMOCRAZIA...
 DONNE E CRISI: LA RIVOLUZIONE NECESSARIA. La sfida femminista nel cuore della politica. Incontro nazionale: Paestum 5,6,7 ottobre 2012.
DONNE E CRISI: LA RIVOLUZIONE NECESSARIA. La sfida femminista nel cuore della politica. Incontro nazionale: Paestum 5,6,7 ottobre 2012.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- Il filosofo Th. W. Adorno, la contestazione delle studentesse tedesche nel ’60, e "il corpo delle donne come bandiera" (di Chiara Saraceno)15 agosto 2012, di Federico La Sala
Il corpo delle donne come una bandiera
di Chiara Saraceno (la Repubblica, 14 agosto 2012)
Usare il (proprio) corpo femminile come manifesto politico. Rovesciare l’ossessione voyeuristica per il corpo femminile che va di pari passo con la marginalizzazione delle donne come cittadine e come esseri pensanti, a vantaggio non dei propri interessi individuali, ma di obiettivi di denuncia politica. È quanto fanno gruppi di donne femministe, soprattutto dell’Est Europeo.
Usando le tecniche del flash mob, le Femen ucraine usano letteralmente il proprio seno nudo per rendere platealmente visibili le proprie denunce contro il governo, contro la trasformazione del loro paese in una sorta di bordello per consumatori internazionali in occasione degli europei di calcio, contro la Sharia, persino contro Berlusconi nel novembre 2011.
Le giovani donne russe della punk band Pussy Riot, quando irrompono con le loro canzoni di denuncia in contesti “sacri al potere” - il Kremlino, la cattedrale ortodossa - si limitano ad esibire minigonne. Ma le maschere che celano il volto alludono ironicamente alla spersonalizzazione delle donne da parte di chi le rappresenta, appunto, solo come corpi fungibili, purché attraenti per chi li guarda e consuma.
L’ultima di queste azioni - una “preghiera” anti-Putin nella cattedrale ortodossa di Mosca durante una cerimonia religiosa - è costata loro molto cara, con una denuncia da parte del patriarca moscovita, e conseguente arresto. Possono essere condannate ad anni di carcere. Ahimè per loro, non avrebbero potuto essere più efficaci nel dimostrare lo stretto filo che nella Russia di oggi lega il potere politico alla Chiesa ortodossa.
L’uso del proprio corpo da parte di donne femministe, come strumento ed insieme atto comunicativo a fini di disvelamento e denuncia, non è un fenomeno nuovo, né limitato all’Est europeo. Più che l’episodio delle studentesse tedesche che attorniarono a seno nudo il filosofo Adorno durante un episodio di contestazione studentesca nel 1969, per umiliarlo alludendo in pubblico alle sue non sempre represse tentazioni di allungare le mani, è nel settore artistico che se ne può trovare ampia testimonianza.
Le artiste di quella che è stata chiamata l’avanguardia femminista degli anni settanta hanno tutte, in un modo o nell’altro, usato fotografia, film, video e performance per affermare che “il personale è politico” e contro “l’obbligo d’essere belle”. Invece di limitarsi a documentare, certo meritoriamente, l’abuso e la strumentalizzazione del corpo femminile nella comunicazione pubblica, o anche a denunciare come irrispettosa e denigratoria questa o quella pubblicità o spettacolo, queste artiste hanno rovesciato il tavolo, mettendosi esse stesse nella parte del soggetto che comunica con il corpo. Hanno riempito di un’intenzionalità insieme critica e autonoma la messa in scena del corpo femminile, a partire dal proprio.
I “corpi piatti” ed evanescenti di Francesca Woodman, le bambole di carta nell’armadio dei vestititi di Cindy Sherman, le performance di Valie Export, che, in quelle che oggi chiameremmo flash mob, provocava passanti e pubblico mostrandosi di volta in volta come un teatro ambulante da cui emergevano solo le tette o il sesso, che invitava ironicamente a toccare - queste ed altre ancora erano forme di espressione che rifiutavano la pura documentazione e andavano oltre la denuncia, per aprire ad uno sguardo, e ad una comunicazione, diversa.
Né le Femen né le Pussy Riot sono artiste sofisticate come quelle dell’avanguardia femminista. Sembra, però, che ne abbiano ereditato la lezione comunicativa: diventare soggetti anche nella comunicazione del, e con il corpo. Certo, non è l’unico modo, né necessariamente il più efficace, per contrastare il potere (le suore statunitensi, ad esempio, ne stanno mettendo in opera altri per contrastare i diktat del Vaticano).
Ma vedere delle donne che usano allegramente, anche se rischiosamente, il proprio corpo per sbeffeggiare il potere ha un che di liberatorio, specie dall’osservatorio italiano. Ove sembriamo strette tra il dover prendere posizione sul diritto a fare la escort e il perbenismo moralista e ipocrita che vorrebbe le donne “per bene” e competenti tutte seriose, accollate, possibilmente anziane, meglio se nonne, comunque de-sessualizzate
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- PUSSY RIOT: MOBILITAZIONE INTERNAZIONALE PER IL GRUPPO PUNK DI MOSCA.16 agosto 2012, di Federico La Sala
iL CASO
Pussy Riot, sale la tensione alla vigilia della sentenza
Cinque arresti per la manifestazione a sostegno del gruppo femminista. Aumentano gli appelli di solidarietà e si preparano una serie di mobilitazioni in attesa del verdetto. Minacce al giudice. Il governo teme disordini e rafforza le misure di sicurezza. *
MOSCA - Sono accusati di aver violato la nuova legge sulle manifestazioni i cinque attivisti arrestati ieri per l’ennesima protesta a sostegno delle Pussy Riot, le tre donne, in carcere per la loro opposizione alla politica di Vladimir Putin. Lo ha reso noto via Twitter una di loro, Alexandra Anfilova, mentre di fronte all’aumento degli appelli di solidarietà per il gruppo punk, crescono anche i timori di disordini che possano dare alla polizia russa l’opportunità di nuovi arresti. Le artiste sono accusate di teppismo motivato da odio religioso, contro i credenti ortodossi, e rischiano tre anni di detenzione. Tutto questo per aver cantato, indossando un passamontagna, una "preghiera punk" contro Putin nella cattedrale di Cristo Salvatore. La sentenza è attesa per venerdì.
"Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo". Violetta Volkova, avvocato di Nadejda Tolokonnikova, 22 anni, Ekaterina Samoutsevitch, 30 anni, e Maria Alekhina, 24 anni, ha annunciato che si rivolgerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo per protestare contro "le torture subite" dalle sue assistite. "Non le fanno dormire, non le fanno mangiare in modo normale e vengono continuamente umiliate". L’avvocato ha anche denunciato il fatto che le sia stato impedito di difendere i suoi assistiti, anche impedendole di portare in aula alcuni testimoni.
La protesta. Con il passamontagna colorato, simbolo della band, e cartelli con scritto "beati i misericordiosi", ieri una ventina di sostenitori delle ragazze si sono riuniti sul sagrato della cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, per protestare. Un responsabile della sicurezza della chiesa, li ha aggrediti. Secondo le nuove regole adottate la primavera scorsa, che ha inasprito le pene e le sanzioni per proteste non autorizzate, i manifestanti rischiano ora una multa fino a 20.000 rubli (630 dollari) o una sentenza di massimo 40 ore di servizi sociali.
Minacce al giudice. Il giudice che presiede la Corte che sta giudicando il gruppo punk, Marina Syrova, ha ricevuto minacce. Per questo motivo è stata decisa l’assegnazione di una scorta. Aspettando la sentenza, si moltiplicano anche le iniziative di sostegno da parte della società civile.
La mobilitazione internazionale. La vicenda del collettivo femminista russo ha suscitato scalpore e diversi politici e artisti di vari Paesi sono scesi in campo per chiederne la liberazione. L’ultimo appello è quello di Paul McCartney. In una lettera, resa pubblica oggi, l’ex Beatle ha chiesto alle autorità russe di liberare le artiste e poi si è rivolto loro incitandole "a rimanere forti". Ieri è stata diffusa una petizione di Peaches, Simonne Jones e tanti altri musicisti, artisti, attivisti che si sono uniti per produrre un video. 4Martedì un gruppo di intellettuali russi, tra cui il politico Leonid Gozman e il famoso economista Mikhail Dmitriev, hanno scritto una lettera aperta al presidente Putin con la richiesta di grazia. Anche il Consiglio europeo degli Artisti ha mandato una lettera a Poutin per chiedere la liberazione delle tre donne. Dal suo blog, lo scrittore russo, Boris Akunin ha chiamato a raccolta per domani, davanti al tribunale Khamovniki di Mosca, tutti i supporter delle pussy. Bisogna uscire dalla "protesta virtuale" su internet e scendere in strada, ha scritto.
La giornata. Domani è stata indetta una giornata mondiale a favore delle femministe arrestate. Se verrà accolta la richiesta del pubblico ministero, le tre componenti della band dovranno passare tre anni in carcere. Anche le componenti del gruppo che non sono in carcere stanno organizzando una serie di eventi per la giornata di domani. Proprio per timore di manifestazioni spontanee e disordini, la polizia ha fatto sapere di aver potenziato i controlli intorno al tribunale e nelle piazze del centro.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- RUSSIA: "FREE PUSSY RIOT": MOBILITAZIONE INTERNAZIONALE. Proteste in tutta Europa.17 agosto 2012, di Federico La Sala
RUSSIA
 Pussy Riot, oggi il verdetto
Pussy Riot, oggi il verdetto
 proteste in tutta Europa
proteste in tutta EuropaLe tre cantanti punk diventate il simbolo del dissenso contro Vladimir Putin verranno giudicate alle 13 ora italiana. In tutta Europa manifestazioni per chiedere il rilascio *
MOSCA - "Free Pussy Riot": questo lo slogan diffuso in queste ore in manifestazioni in tutta Europa per difendere le tre cantanti punk, ormai simbolo del dissenso contro Vladimir Putin dopo aver cantato una "preghiera" contro il presidente russo dentro la cattedrale Cristo salvatore di Mosca.
Il verdetto del processo è atteso per oggi e l’udienza inizierà alle 13 ora italiana. Nadezhda Tolokonnikova, 23 anni, Maria Alekhina, 24 anni, e Yekaterina Samutsevich, 29 anni, sono in custodia da cinque mesi e per loro la procura ha chiesto una pena di tre anni di carcere.
Una tragica prospettiva che non ha scalfito la grinta delle giovani musiciste. La Tolokonnikova ha infatti rilasciato un’intervista al giornale indipendente Novaya Gazeta - dove lavorava Anna Politkovskaya - fugando ogni ipotesi di pentimento. "Siamo felici di essere diventate involontariamente l’epicentro di un enorme evento politico che coinvolge diverse forze. E non credo in una sentenza come questa. Questo non è un processo: è un’illusione".
"Davvero non ci aspettavamo un processo - ha aggiunto - perché non abbiamo mai commesso alcun reato. Non sospettavamo neanche che le autorità sarebbero state così stupide da perseguitare delle femministe punk anti-putin, dandoci legittimità nello spazio sociale".
Tra le star internazionali scese in campo in favore delle tre artiste, Madonna, Bjork e l’ex Beatle Paul McCartney, e marce di protesta sono previste anche in Svezia, Francia e Germania.
Il provocatorio gruppo femminista ucraino Femen ha inscenato nel centro di Kiev una manifestazione in sostegno delle colleghe russe, segando una croce in memoria dei milioni di vittime dello stalinismo e chiedendo alla Chiesa di "fermare il sostegno alla dittatura e sostenere lo sviluppo della democrazia e della libertà delle donne".
A Mosca invece diverse statue sono state incappucciate con "balaclava" - i cappucci spesso usati dai corpi speciali - colorati alla maniera di quelli indossati dalle Pussy Riot. Tra i monumenti, quelli dei poeti Alexander Pushkin e Abai Qunanbaiuli, quello dello scienziato Mikhail Lemonosov e statue di eroi della seconda guerra mondiale.
* la Repubblica, 17 agosto 2012
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). --- Verdetto Pussy Riot: "Colpevoli". Le tre cantanti punk diventate il simbolo del dissenso contro Vladimir Putin giudicate colpevoli di teppismo e incitamento all’odio religioso. In tutta Europa manifestazioni di protesta.17 agosto 2012, di Federico La Sala
RUSSIA
Verdetto Pussy Riot: "Colpevoli" manifestazioni in tutta Europa
Le tre cantanti punk diventate il simbolo del dissenso contro Vladimir Putin giudicate colpevoli di teppismo e incitamento all’odio religioso. In tutta Europa manifestazioni di protesta. Arresti davanti al tribunale *
MOSCA - Colpevoli. Per il tribunale Khamovnichesky di Mosca, le tre cantanti punk, ormai simbolo del dissenso contro Vladimir Putin dopo aver cantato una "preghiera" contro il presidente russo dentro la cattedrale Cristo salvatore di Mosca lo scorso 21 febbraio, hanno commesso un reato di teppismo e incitamento all’odio religioso.
Secondo la corte presieduta da Marina Syrova, le tre ragazze hanno suonato una canzone "blasfema, insultante" nella cattedrale, commettendo una "grave violazione dell’ordine pubblico, disturbando la quiete dei cittadini e insultando profondamente le convinzioni del fedeli ortodossi", si legge nella sentenza.
Per i giudici, il testo "esprimeva chiaramente l’odio basato su affiliazione religiosa" e l’obiettivo delle ragazze, mosse da "odio religioso", era quello di raggiungere "il circolo più vasto possibile di fedeli, dando pubblicità" al proprio gesto.
Davanti al tribunale, nel distretto di Jamovniki, già diversi arresti, tra cui anche il coordinatore del Fronte di sinistra, Serghei Udaltsov, che, insieme ad altre centinaia di manifestanti, chiedeva la liberazione delle giovani.
In loro sostegno, manifestazioni anche in tutta Europa. "Free Pussy Riot" è lo slogan diffuso in queste ore in decine di piazze per difendere Nadezhda Tolokonnikova, 23 anni, Maria Alekhina, 24 anni, e Yekaterina Samutsevich, 29 anni, in custodia in carcere da cinque mesi.
Una situazione che non ha scalfito la grinta delle giovani musiciste, tutte in aula per assistere alla lettura della sentenza. Una di loro, la Tolokonnikova , indossa una maglietta azzurra con un pugno chiuso e la scritta: "No pasaran", e ha rilasciato un’intervista al giornale indipendente Novaya Gazeta - dove lavorava Anna Politkovskaya - fugando ogni ipotesi di pentimento. "Abbiamo già vinto - ha detto - Noi (russi) abbiamo imparato ad arrabbiarci con le autorità e a parlare ad alta voce di politica".
Le ragazze si dicono felici di essere diventate, involontariamente, l’epicentro di un enorme evento politico che coinvolge diverse forze. "Non credo in una sentenza come questa - ha precisato Tolokonnikova - Questo non è un processo: è un’illusione".
"Davvero non ci aspettavamo un processo - ha aggiunto - perché non abbiamo mai commesso alcun reato. Non sospettavamo neanche che le autorità sarebbero state così stupide da perseguitare delle femministe punk anti-putin, dandoci legittimità nello spazio sociale". Due delle ragazze sono giovani madri e lo stesso Putin aveva detto di sperare che la sentenza non fosse "troppo severa".
Il caso ha scatenato critiche internazionali e da molti è stato visto come l’ennesimo esempio del pugno di ferro del governo e delle autorità statali contro il dissenso. Tra le star scese in campo in favore delle tre artiste, Madonna, Bjork e l’ex Beatle Paul McCartney, e marce di protesta sono previste anche in Svezia, Francia e Germania.
Il provocatorio gruppo femminista ucraino Femen ha inscenato nel centro di Kiev una manifestazione in sostegno delle colleghe russe, segando una croce 1 in memoria dei milioni di vittime dello stalinismo e chiedendo alla Chiesa di "fermare il sostegno alla dittatura e sostenere lo sviluppo della democrazia e della libertà delle donne".
A Mosca invece diverse statue sono state incappucciate 2 con "balaclava" - i cappucci spesso usati dai corpi speciali - colorati alla maniera di quelli indossati dalle Pussy Riot. Tra i monumenti, quelli dei poeti Alexander Pushkin e Abai Qunanbaiuli, quello dello scienziato Mikhail Lemonosov e statue di eroi della seconda guerra mondiale.
-
-
-
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- EROS (CUPIDO) E PSICHE, E "CHARITE DULCISSIMA". LE METAMORFOSI O L’ASINO D’ORO, IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI.17 giugno 2012, di Federico La Sala
 UNA QUESTIONE MORALE EPOCALE. SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
UNA QUESTIONE MORALE EPOCALE. SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
 "CHARITE DULCISSIMA": IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!
"CHARITE DULCISSIMA": IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!
-
> Un omaggio a Kurt H. Wolff ---- Primo Levi e il destinatario della missiva ritrovata, Kurt H. Wolff. Levi lo aveva probabilmente conosciuto fra il 1963 e il ’64, quando il professore della Brandeis University aveva trascorso un anno sabbatico in Italia (di Sergio Luzzatto - Primo Levi su «un oceano dipinto»)..19 giugno 2011, di Federico La Sala
Primo Levi su «un oceano dipinto»
di Sergio Luzzatto (Il Sole-24 Ore, 19 giugno 2011)
Primo Levi ha parlato molto di sé, nei quarant’anni compresi fra la pubblicazione di Se questo è un uomo e l’abbreviata fine della sua vita. Tuttavia, c’è una dimensione del suo racconto che noi continuiamo a ignorare per la maggior parte: è la dimensione duale (e intima, o comunque più privata che pubblica) del Levi scrittore di lettere. Fino a oggi l’epistolario è rimasto disperso, e quasi interamente inedito. Da qui l’importanza delle trouvailles, i rinvenimenti fortunosi. Come la lettera pubblicata in questa pagina, risalente al maggio 1965 e collegata a una precisa circostanza editoriale: la pubblicazione in Gran Bretagna e negli Stati Uniti della traduzione inglese de La tregua.
Due anni prima, nel 1963 (sedici anni dopo l’esordio ben poco fragoroso di Se questo è un uomo, e cinque anni dopo la più fortunata riedizione Einaudi), l’uscita della Tregua aveva dischiuso a Levi le porte del riconoscimento letterario: terzo classificato al premio Strega, vincitore del premio Campiello. Il racconto dell’avventuroso ritorno da Auschwitz - oltre sei mesi nel 1945 per ritrovare l’Italia, dopo un periplo attraverso la Polonia, la Russia, l’Ucraina, la Romania e l’Ungheria - aveva conferito a Levi, chimico di professione, lo status non più soltanto di un memorialista del Lager ma di un narratore a pieno titolo. E non soltanto in Italia, anche all’estero. Mentre le edizioni britannica e americana di Se questo è un uomo erano uscite, fra 1959 e 1961, per due editori di nicchia, a tradurre La tregua nel ’65 erano ormai due case di prima grandezza, Bodley Head e Little Brown.
Nonostante questo, entrambe le edizioni conobbero un fiasco: per sfondare presso il pubblico anglosassone Levi avrebbe dovuto attendere gli anni Ottanta, con la traduzione del Sistema periodico. Invece, fin dal 1961 aveva sfondato in Germania con la traduzione tedesca di Se questo è un uomo: cinquantamila copie vendute in pochi mesi... E un dialogo diretto con decine di lettori tedeschi, che avevano voluto scrivere all’autore e ai quali l’autore aveva risposto, inaugurando scambi epistolari anche distesi nel tempo.
Tale essendo il contesto d’origine della lettera ritrovata, in che cosa la missiva partita da Torino il 23 maggio 1965 verso un indirizzo postale del Massachusetts può contribuire significativamente alla nostra conoscenza di Primo Levi? L’inedito si rivela prezioso sia per documentare il rapporto con uno scrittore-chiave del suo pantheon letterario, il poeta romantico inglese Samuel T. Coleridge, sia per illuminare la genesi di un progetto editoriale che Levi coltivò nei primi anni Sessanta e che - dopo essere fallito in quanto progetto a sé stante - sarebbe sfociato nell’ultimo capitolo dell’ultimo suo libro.
Che Coleridge sia stato, con la tardosettecentesca Ballata del vecchio marinaio, un autore-feticcio di Primo Levi, è cosa nota. Più volte Levi ha descritto il se stesso del 1946, straziato reduce di Auschwitz, come «simile al Vecchio Marinaio di Coleridge, che abbranca in strada i convitati che vanno alla festa per infliggere loro la sua storia di malefizi». Quando Levi avesse letto la Ballata per la prima volta non è dato di sapere con esattezza. Di sicuro, nel 1984 il sentimento di identificazione con il personaggio di Coleridge lo avrebbe spinto a intitolare con un verso del poemetto la principale sua raccolta di poesie, Ad ora incerta. E nel 1986 lo avrebbe spinto a riprendere (nell’originale inglese) l’intera strofa di quel verso come esergo del suo libro fondamentale e testamentario, I sommersi e i salvati.
La lettera del 1965 pubblicata qui per la prima volta offre un complemento d’informazione tanto suggestivo quanto istruttivo alla storia del rapporto di Levi con Coleridge. Attesta infatti come già all’epoca della traduzione inglese della Tregua lo scrittore torinese avesse immaginato di intitolare un suo libro con parole tratte dalla Ballata del vecchio marinaio. A fronte dei due titoli scelti rispettivamente dall’editore britannico e dall’editore statunitense - il letterale, ma «sofisticato» The Truce e il «molto insipido» The Reawakening, il risveglio - l’autore ne avrebbe preferito un terzo che trovava «molto bello», Upon a painted Ocean: «sopra un oceano dipinto», il verso n. 118 del poemetto di Coleridge. Così, già nel ’65 l’odissea del ritorno da Auschwitz si presentava a Primo Levi nella forma di una navigazione (il titolo italiano da lui inizialmente pensato per la Tregua era Vento alto) che attribuiva al marinaio il ruolo insieme fatidico e fatale dell’unico superstite.
Non meno notevole la seconda parte dell’inedito, quella relativa al «progetto tedesco». In pratica, si trattava dell’idea di raccogliere in volume le lettere che l’autore aveva ricevuto dai lettori tedeschi di Se questo è un uomo, unitamente alle sue proprie lettere di risposta. Era questo un progetto che Levi aveva presentato all’Einaudi nel gennaio 1963 e che la casa editrice aveva sottoposto all’attenzione del suo germanista di riferimento, Cesare Cases. Il quale Cases, benché fosse da sempre un estimatore di Levi, aveva poi dimostrato (apprendiamo dall’inedito) ben poco interesse. Da qui - «il campo è libero, e le lettere sempre a Sua disposizione» - la scelta di Levi di rimettere il «progetto tedesco» nelle mani di un suo interlocutore d’oltreoceano: il destinatario della missiva ritrovata, Kurt H. Wolff.
Ecco un nome che fa capolino per la prima volta, o quasi, nella ricostruzione del paesaggio biografico di Primo Levi. Nome peraltro assai noto agli studiosi di sociologia, se è vero che Wolff, nato in Germania nel 1912 ed emigrato in America nel 1939, fu esponente fra i maggiori della scuola sociologica tedesca in esilio, e sarebbe giunto negli anni Settanta a occupare la carica di presidente dell’American Sociological Association. Levi lo aveva probabilmente conosciuto fra il 1963 e il ’64, quando il professore della Brandeis University aveva trascorso un anno sabbatico in Italia: quell’Italia dove era emigrato ventunenne nel 1933, dopo la presa al potere di Hitler, e dove si era laureato a Firenze con una pioneristica tesi di sociologia della cultura.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). ----- LA CULTURA DEL ’68 NON E’ INDIVIDUALISTA... Se un elemento di connessione tra la cultura del Sessantotto, qualunque cosa si intenda con questo termine, e il presente c’è, non è l’individualismo narcisistico o l’assenza di una cultura del limite (di Guido Viale).19 maggio 2011, di Federico La Sala
La cultura del ’68 non è individualista
di Guido Viale (il manifesto,19.05.2011)
Gli stereotipi sulla deriva narcisistica di quella esperienza sono vecchi di trent’anni. E scambiano un movimento enorme con la parabola di pochi Nessuna esperienza storica è stata più pronta a recepire la cultura del limite elaborata dai teorici ambientalisti. Contro lo sviluppo a ogni costo
I trent’anni che la pubblicistica ha definito «gloriosi» erano stati caratterizzati in Occidente dall’egemonia del fordismo: la concentrazione dei lavoratori in grandi stabilimenti integrati, l’omogeneizzazione delle loro condizioni, la parcellizzazione e il degrado del loro lavoro, l’impiego a tempo indeterminato, la localizzazione degli stabilimenti nei paesi "sviluppati". Parallelamente all’organizzazione del lavoro fordista, la scolarizzazione di massa era stata proposta e vissuta come un "ascensore sociale" in grado di trasformare, nell’avvicendarsi delle generazioni, i contadini in lavoratori dell’industria, gli operai in impiegati e gli impiegati in quadri, manager o in o liberi i professionisti: per alcuni decenni era stata questa la risposta del sistema alle aspettative di emancipazione sociale delle classi sfruttate. Fabbrica, scuola e welfare avevano costruito nei paesi dell’Occidente un contesto di relativa stabilità e sicurezza per tutti. Ma i costi del welfare, la crescita dei salari e, soprattutto, la modificazione, "concertata" o conflittuale, dei rapporti di forza nelle fabbriche avevano finito per erodere i profitti delle imprese, mentre la saturazione dei posti qualificati offerti dall’organizzazione del lavoro aveva messo in crisi il mito della scuola come ascensore sociale, aprendo le porte a una conflittualità studentesca che dalla Cina agli Stati Uniti, dall’Europa all’America latina, aveva contrassegnato tutta la seconda metà degli anni Sessanta.
I trenta e più anni successivi hanno visto il sistematico frazionamento delle grandi unità produttive, la progressiva differenziazione dei rapporti di lavoro, la delocalizzazione di attività sia manifatturiere che terziarie, la precarizzazione non solo dell’impiego, ma di tutti gli aspetti dell’esistenza nel quadro di una crescente finanziarizzazione del capitale. Il meccanismo della concorrenza si è così progressivamente esteso dalle imprese, soggetto ormai unico della scena e dell’attenzione sociale, ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, in una lotta darwiniana di tutti contro tutti che ha trasformato i problemi creati dalla società in vicende biografiche da risolvere individualmente. Questa trasformazione è stata accompagnata da un processo di sostanziale descolarizzazione, pur salvaguardando in alcuni paesi - non nel nostro - i contenuti tecnici e professionali della formazione; ma sempre nel quadro di una svalutazione dei contenuti culturali, sociali e civili dell’educazione. Così l’organizzazione della produzione ha smantellato una delle conquiste più importanti del periodo precedente, la sicurezza del lavoro, del reddito e dell’esistenza, instaurando nel mondo un clima di paura di tutti per tutti e di tutto.
Un approccio materialistico a quella inversione di rotta non può evitare di vedervi una reazione del capitale e dei governi alle conquiste delle lotte operaie, studentesche, e di molte altre categorie sociali, che avevano sconvolto tutta la seconda metà degli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta. Ma anche, e soprattutto, l’avvento di una nuova tecnologia, quella della "Rete", che ha avuto e ha sulla storia del mondo un’influenza non inferiore a quella della macchina a vapore nel promuovere la rivoluzione industriale. Oggi la rete ha un ruolo decisivo nel promuovere collegamenti, organizzazione e rivolta in molti dei processi sociali che attraversano l’alba del nuovo secolo. Ma ha avuto - e da tempo - un’influenza assai più profonda nel disegnare i caratteri della globalizzazione degli ultimi decenni del secolo scorso e del primo decennio di questo; che non è concepibile senza la Rete, come mera estensione a gran parte del mondo di rapporti di produzione fondati sul lavoro salariato. Internet ha da tempo immesso ogni unità produttiva del pianeta all’interno di linee di fornitura (supply chain) che ne plasmano e riplasmano in continuazione dimensioni, posizione gerarchica, localizzazione e struttura organizzativa. Se Detroit, Mirafiori o Volksburg sono state l’emblema del fordismo, Walmart, Auchan e - perché no? - le Coop, con la loro rete di fornitori, lo sono dell’odierna organizzazione della produzione.
Per questa incapacità di guardare ai processi materiali, e per quanto prevedibile, lascia sconcertati l’ultimo intervento di Luigi Cavallaro su questo giornale (13.5.2011) che riprende stereotipi vecchi di almeno trent’anni (le tesi di Christopher Lash sulla deriva narcisistica della cultura del Sessantotto), peraltro largamente saccheggiate nel corso del tempo da chi, dalle posizioni più diverse e anche contrapposte, imputa a quegli anni il degrado - anche questo inteso in modi diametralmente opposti - del tempo presente. Il meccanismo di questa operazione è sempre lo stesso. Assume le vicende biografiche di alcuni personaggi vistosamente presenti sulla scena mediatica a emblema del percorso esistenziale di decine o centinaia di migliaia di persone, che nei conflitti di quegli anni si erano impegnate e formate; dimenticando migliaia e migliaia di insegnanti che in tutti questi anni hanno tenuto insieme la scuola; di impiegati pubblici che hanno cercato di far funzionare i servizi; di cooperanti impegnati nel welfare a diretto contatto con gli utenti; di operatori che, soprattutto in provincia, hanno costruito e tenuto in piedi i pochi spazi di confronto culturale esistenti; di operai migrati in po’ dappertutto, perché cacciati dalle fabbriche dove avevano sovvertito i rapporti di forza aziendali. Tutti quelli che hanno scelto o sono stati costretti a operare nell’ombra, e che Cavallaro, come molti come lui, non riescono a scorgere. Per completare l’opera, tutte queste vicende esistenziali, differenziate e complesse, Cavallaro le proietta sull’intera generazione dei baby boomer, per attribuire alla cultura del Sessantotto fatti e misfatti di politici e manager privati e di stato, di giornalisti e opinionisti che dalle vicende del Sessantotto si erano tenuti ben lontani; e che proprio per questo hanno potuto percorrere con facilità carriere rese sgombre, soprattutto in Italia, dalla loro criminalizzazione: una resa dei conti che, come si è visto, si protrae e ripropone fino a giorni nostri.
Quello che non riescono capire tanti nemici del Sessantotto come, da opposti versanti, sia Luigi Cavallaro che Mariastella Gelmini (un buon esempio di mediocrità quanto a studi, esami, rapporti personali e cariche politiche in cui acquiescenza e servilismo hanno sostituito il merito) è la differenza tra la ricerca di una autonomia personale, e anche di una propria individualità che ne esalti le differenze, perseguita all’interno di un processo condiviso, nel rapporto con un collettivo e un movimento aperto a ogni nuovo apporto - che è stato in tutto il mondo il tratto comune dei movimenti antiautoritari e antidisciplinari di quegli anni, nelle fabbriche come all’università e un po’ in tutte le istituzioni - da un lato; e, dall’altro, invece, l’inseguimento di un’affermazione personale a scapito del prossimo, perseguita nel contesto di una competizione di tutti contro tutti; che è la strada maestra del servilismo: dell’asservirsi per fare carriera o anche solo per non essere retrocesso.
Se un elemento di connessione tra la cultura del Sessantotto, qualunque cosa si intenda con questo termine, e il presente c’è (e in varie sedi mi sono sforzato di individuarla) non è l’individualismo narcisistico o l’assenza di una cultura del limite, come sostiene Cavallaro: nessun movimento storico è stato forse meno individualista del Sessantotto; e nessuna esperienza storica è stata più pronta a recepire la cultura del limite, elaborata dai teorici dell’ambientalismo in aperta contrapposizione con la logica dello «sviluppo delle forze produttive» a ogni costo, che accomuna invece Cavallaro ai più tetragoni economisti borghesi. A spianare la strada al passaggio dalla ricerca di una realizzazione personale all’interno di una prassi collettiva alla scelta - o all’obbligo - di cercare un’affermazione in una competizione darwiniana ha contribuito sicuramente l’insufficienza dei presidi culturali messi in campo dai movimenti del Sessantotto: cioè l’incapacità di sviluppare saperi pratici in grado di individuare dei punti di applicazione a quel desiderio di cambiare il mondo che ne costituiva l’afflato comune.
Oggi quei saperi in parte ci sono: per alcuni versi sono il frutto di un impegno pionieristico e a volte solitario di studiosi e organizzatori di buone pratiche che hanno perseguito con pertinacia una strada controcorrente; in parte sono il frutto di un’elaborazione collettiva di movimenti ed esperienze che nel corso degli anni più recenti hanno animato la scena sociale; senza peraltro alcun riscontro a livello di establishment, sia politico che culturale e mediatico e, meno che mai, economico. Per questo la prospettiva di un’alternativa può ritrovare le gambe su cui marciare e il desiderio di un mondo diverso - che il servilismo non ha soffocato, soprattutto in persone che il limite lo vivono ogni ora della loro vita nella condizione della precarietà - può tornare a orientare un agire condiviso.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Più che il ’68 È l’89 che ci ha cambiati (di TIMOTHY GARTON ASH).9 maggio 2008, di Maria Paola Falqui
Più che il ’68 È l’89 che ci ha cambiati
di TIMOTHY GARTON ASH (la Repubblica, 09.05.2008, p. 41)
È già stato versato più inchiostro sull’anniversario del 1968 di quanto sangue sia sgorgato dalle ghigliottine di Parigi dopo il 1798. In Francia risultano i pubblicati più di 100 libri solo per richiamare alla memoria lo scenario rivoluzionario del maggio ’68. La Germania ha avuto la sua festa della birra versione intellettuale; Varsavia e Praga hanno rivisitato le ambiguità agrodolci delle rispettive primavere; persino in Gran Bretagna è uscita una retrospettiva su Prospect, la principale rivista culturale del paese.
Non è difficile capire i motivi di quest’orgia di pubblicazioni. I sessantottini sono una generazione straordinariamente ben definita in tutta Europa, probabilmente la meglio definita dopo quella che potremmo chiamare dei "ragazzi del ’39", segnati a vita dall’esperienza della seconda guerra mondiale. Gli ex studenti del 1968, oggi sessantenni o giù di lì, sono ai vertici della produzione culturale in gran parte dei paesi europei. Pensate forse che perdano l’occasione di parlare della loro gioventù? Scherzate? E io non conto?
Non esiste una classe dei novantottini paragonabile. I protagonisti di quell’anno di prodigi erano diversi: più eterogenei e, si potrebbe dire, più sérieux. Navigati dissidenti, apparatchik, capi religiosi, uomini e donne di mezz’età in piazza, pazienti, a dire basta. In qualche occasione gli studenti hanno avuto un ruolo, non da ultimo a Praga, dove fu una manifestazione studentesca a dare il via alla rivoluzione di velluto e, vent’anni dopo, alcuni di loro sono personaggi di spicco della vita pubblica del loro paese. Ma i leader del ’98 in genere erano più vecchi e molti, in realtà, sessantottini. Persino gli "eroi della ritirata" sovietici vicini a Mikhail Gorbaciov erano plasmati dalla memoria del 1968.
È regola generale che si ricordino con più intensità le esperienze vissute da giovani. L’alba vista a vent’anni con una ragazza/ragazzo tra le braccia magari in seguito si rivelerà fasulla, quella che vedi a 50 anni può cambiare il mondo per sempre, ma la memoria, astuta imbrogliona, privilegerà sempre la prima. Inoltre mentre il 1968 in Europa c’è stato sia a ovest che a est, a Parigi e a Praga, il 1989 c’è stato sul serio solo a est. La maggior parte degli europei dell’ovest erano affascinati spettatori dell’89, non i protagonisti.
Sotto il profilo politico l’89 ha prodotto molti più cambiamenti. Le primavere di Praga e Varsavia del 1968 finirono in sconfitta; le primavera di Parigi, Roma e Berlino finirono in parziali restaurazioni, o produssero cambiamenti solo marginali. Probabilmente la più grande manifestazione di piazza che si tenne a Parigi il 30 maggio 1968 fu una manifestazione della destra politica, che l’elettorato francese riportò al potere per un altro decennio. In Germania ovest parte dello spirito del ’68 si riversò con maggior successo nella socialdemocrazia riformista di Willy Brandt. Ovunque in occidente il capitalismo sopravvisse, si riformò e prosperò. Il 1989, invece, ha posto fine al comunismo in Europa, all’impero sovietico, alla divisione della Germania e ad una lotta ideologica e geopolitica, la guerra fredda, che aveva caratterizzato l’intera politica mondiale per mezzo secolo. È stato, quanto a esiti geopolitici, importante come il 1945 o il 1914. A confronto il ’68 fu una bazzecola.
Vista con gli occhi di oggi gran parte della retorica marxista, trozkista maoista o anarchico-liberazionista del ’68 appare ridicola, infantile e moralmente irresponsabile. Citando George Orwell, è un giocare col fuoco da parte di persone che non sanno neppure che il fuoco brucia. Evocando l’avvio di un «periodo di transizione cultural-rivoluzionaria» - così la brutale rivoluzione culturale di Mao che distrusse tante vite veniva assurta a modello da imitare in Europa - e definendo i Viet Cong «forze rivoluzionarie di liberazione contro l’imperialismo Usa», Rudi Dutschke disse al congresso sul Vietnam a Berlino ovest che queste verità liberatorie erano state scoperte grazie al "particolare rapporto di produzione dei produttori studenti". Produzione di cazzate, cioè. Alla London School of Economics scandivano questo slogan: «Cosa vogliamo? Tutto. Quando lo vogliamo? Subito». Narciso con la bandiera rossa.
Quelli che nel 1968 erano tanto duri nei confronti di alcuni appartenenti alla generazione dei loro genitori (i ragazzi del ’39) che avevano simpatizzato con il terrore fascista e stalinista forse in occasione di questo anniversario vorranno fare un piccolo esame di coscienza per aver spensieratamente simpatizzato con il terrore in lontani paesi che conoscevano ben poco. Ma in quell’esame di coscienza va messo anche che molti rappresentanti di spicco della generazione del ’68 hanno imparato in seguito da questi errori e leggerezze. Nel migliore dei casi si sono impegnati nei decenni successivi in politiche più serie di "nuovo evoluzionismo" liberale, socialdemocratico o verde (per mutuare un’espressione del sessantottino polacco Adam Michnik), compreso il porre fine a una gran quantità di regimi autoritari in Europa, dal Portogallo alla Polonia e il promuovere i diritti umani e della democrazia in paesi lontani che hanno imparato a conoscere meglio.
È quindi troppo semplicistico nel bilancio del ’68 indicare solo l’aspetto frivolo, effimero e irrilevante, contrapponendolo ad un ’89 serio e significativo. A fare il punto è Daniel Cohn-Bendit, l’archetipo del sessantottino: «Abbiamo vinto in campo culturale e sociale, mentre, fortunatamente, abbiamo perso in politica». Il 1989 ha prodotto, sorprendentemente in mancanza di violenza, una trasformazione nelle strutture della politica interna ed estera e dell’economia che ha cambiato il mondo. Sotto il profilo culturale e sociale ha più il carattere di restaurazione, o quanto meno, di riproduzione o imitazione delle società consumistiche occidentali esistenti. Il 1968 non produsse trasformazioni paragonabili delle strutture politiche e sociali ma catalizzò un profondo cambiamento culturale e sociale, sia nell’est che nell’ovest d’Europa. (Il 1968 in realtà rappresenta un fenomeno più ampio, gli "anni Sessanta" nel complesso, in cui la diffusione della pillola ebbe più importanza di qualunque manifestazione o barricata).
Nessun mutamento di queste proporzioni ha solo effetti positivi e alcuni esiti negativi sono visibili nelle nostre società di oggi. Ma, nel complesso il ’68 ha segnato un passo avanti nell’emancipazione dell’umanità. In gran parte delle nostre società le donne, gli omosessuali e le lesbiche, gli appartenenti a molte minoranze e classi sociali in precedenza tenute a freno da rigide gerarchie hanno oggi maggiori opportunità rispetto a prima del 1968. Persino i critici del ’68 come Nicolas Sarkozy beneficiano di questo cambiamento. (Avrebbe mai potuto un figlio di immigrati, divorziato, diventare presidente nell’idillio conservatore pre-68 del suo immaginario?)
Per quanto i due movimenti siano fortemente contrastanti è stato l’effetto congiunto dell’utopico ’68 e dell’anti-utopico ’89 a produrre in gran parte d’Europa e del mondo una versione globalizzata socialmente e culturalmente liberale, politicamente socialdemocratica di capitalismo riformato. Ma in questo anniversario del ’68 vediamo problemi nella sala macchine del capitalismo riformato. E se i problemi si aggravassero il prossimo anno, proprio al momento dell’anniversario dell’89? Quella sì che potrebbe essere una rivoluzione...
www.timothygartonash.com
Traduzione di Emilia Benghi
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. --- Le "viscere" razziste, omofobe, misogine, su cui la destra antipolitica ha fatto breccia per raccogliere consensi, è il sedimento di barbarie, ignoranza e antichi pregiudizi, ma anche sogni e desideri mal riposti, che la sinistra, ancorata al primato del lavoro e della classe operaia, ha sempre trascurato, come se dopo il grande balzo della coscienza operato da Marx non ci fossero stati altri rivolgimenti altrettanto radicali, come la psicanalisi, il femminismo, la non violenza, la biopolitica, l’ambientalismo (Lea Melandri).1 maggio 2008, di Federico La Sala
 Sinistra, non di solo pane...
Sinistra, non di solo pane...
 Ecco cosa non hai visto
Ecco cosa non hai vistodi Lea Melandri (Liberazione, 29.04.08)
Se molti operai non avessero votato Lega, il 13-14 aprile 2008, forse non avremmo mai saputo cosa pensano dei gay, dei migranti, delle donne, dei dirigenti di sinistra, e del loro stesso lavoro. Da questo punto di vista, aver perso le elezioni è una fortuna e un’occasione da cogliere. Peccato che, dopo una rapida comparsa e altrettanto rapide interviste, siano spariti di nuovo dalla scena, per ridiventare l’oggetto delle verbose e perlopiù astratte dissertazioni di politici e intellettuali, che vorrebbero "rifondare" la sinistra, ripensare il "comunismo", ma partendo sempre dalle stesse domande: «che fare?», «con chi?». Con questa premessa, anche la risposta finisce per avere un sapore antico, che è nostalgia del già noto e, insieme, attesa di una miracolosa palingenesi. Sull’orizzonte famigliare e perduto tornano ad allinearsi ancora una volta il popolo, il territorio, la gente, i lavoratori e le lavoratrici - un femminile d’obbligo dal momento che la questione di genere, rimossa come problema politico, è diventata una vera ossessione di correttezza linguistica.
Di fronte alle parole ricorrenti -"radicarsi nel sociale", "ritorno nei quartieri", "apertura all’esterno" - viene spontaneo chiedersi: «ma dove sono stati finora?». Forse in riunione. Con tutti quegli organismi impalcati l’uno sull’altro, fino alla cima della piramide del partito, l’autoreferenzialità è inevitabile, la schiera dei dirigenti si infoltisce e quando si cerca la "base" ci si accorge che non c’è più. Nel documento della Conferenza nazionale di organizzazione, approvato il 16-17 dicembre 2006, si diceva che la crisi della politica e della forma partito riguardava anche Rifondazione: separatezza dei gruppi istituzionali, burocratismo, centralismo, personalismi, ingessamento del dibattito democratico. Nel Comitato politico nazionale di circa una settimana fa, convocato a ridosso del terremoto elettorale e dietro la pressione di quanti, dentro e fuori Rifondazione, vorrebbero avviarsi rapidamente verso una nuova sinistra "unita e plurale", l’idea di un possibile scioglimento, reale o immaginaria che sia, ha risvegliato spinte contrarie: la difesa di una "comunità di appartenenza", il rafforzamento di un "corpo collettivo", della sua storia, delle passioni che lo hanno alimentato. Un riflesso noto, prevedibile, che parla del difficile rapporto tra "gruppo chiuso" e "gruppo aperto", tra processi di "accomunamento" e settarizzazione, è venuto a coprire un lutto duplice: la sparizione di elettori fedeli e l’affacciarsi su un vuoto organizzativo, spinto quasi fatalmente verso la figura rassicurante di un leader carismatico. Colpisce il fatto che la minaccia alla propria sopravvivenza, il pericolo di disgregazione, dispersione di qualcosa che è stato conquistato con fatica, si sia così massicciamente spostata sul versante da cui sembrava venire, al contrario, la possibilità di un’apertura e di un potenziamento.
«Se nell’estraneo al gruppo non viene colta l’ostilità ma il suo contrario, vale a dire se nell’estraneo noi troviamo non il diverso ma l’uguale, il comune a noi, che pure esiste, allora tutto il movimento di elaborazione del gruppo si svolge con un senso diverso». La "comunanza stessa", in questo caso, diventa "un bene da estendere" (Elvio Fachinelli, Gruppo chiuso o gruppo aperto? , "Quaderni piacentini", n.36, nov. 1968). Perché i gruppi, le associazioni, l’assemblea che si è riunita a Firenze il 19 aprile per proporre "case comuni della sinistra", sperimentazione di "laboratori di analisi e di pensiero", spazi decisionali aperti a tutti, "fuori da leaderismi e da centralismi democratici", non ha convinto a procedere nel ripensamento della forma partito avviato a Carrara, il 29 marzo-1 aprile 2007 con la nascita della Sinistra europea? Perché si invocano territori, radicamenti, soggetti sociali perduti, e non si vede la terra su cui si mettono i piedi, luoghi e persone che già ci sono? Perché tanto insistenza sull’ "ascolto" di interlocutori lontani e distratti, e tanta sordità alla voce del vicino? Perché l’accelerazione verso la "costituente" di un nuovo soggetto della sinistra, capace di "impastare" idealmente lotte sociali e culture politiche diverse, non convince neppure chi, come me, non ha storia di partito né desidera averla, e pensa che questa forma organizzativa sia esaurita, e non da ora? Se a molti oggi appare inadeguata l’idea di partito come "organizzazione di combattimento", centralizzata e gerarchica - una specie di "stato dentro lo stato" - anche il dibattito che dovrebbe aprire la strada a nuove forme organizzative, così come è stato finora, appare molto meno "aperto, ampio, plurale" di quanto prometta.
Al di là delle affermazioni, traspare il rischio, sollevato al Cpn da Franco Russo, che a mettersi insieme siano solo "gruppi dirigenti", e, soprattutto, che si tratti ancora una volta di un ceto politico "neutro", cioè sostanzialmente maschile, tanto da far rimpiangere la consapevolezza nuova che era apparsa nella relazione di Franco Giordano a Carrara: «E per noi maschi c’è un problema che riguarda l’abbandono di ogni universalismo neutro e del riconoscimento della nostra parzialità, di dismettere il narcisismo che è sempre il segno più pubblico del cerimoniale del potere».
Ma non è solo la partecipazione democratica a far difetto in assemblee che dovrebbero far dialogare o confliggere culture diverse, e che si limitano a far sfilare sequenze di interventi "preiscritti", cioè pensati prima e al di fuori della relazione personale che si crea in un incontro, fuori quindi dagli imprevisti e dai cambiamenti che ne possono sortire. Insieme al femminismo, il pesante rimosso che si porta dietro la sinistra è tutto ciò che, connesso al destino femminile, è stato messo al bando dalla politica: il corpo, la persona, l’intelligenza e la sensibilità legati a esperienze fondamentali come la nutrizione, la riproduzione, l’amore, la cura. Di questa "mutilazione" e delle conseguenze che ne sono derivate alla vita politica, scrive con grande lucidità Marco Deriu, nel suo articolo Gli uomini il desiderio e la crisi della politica ("Pedagogika", n.6, dic. 2004):
«Quando si parla della crisi della politica e della partecipazione, si fa riferimento alla crisi dello Stato, delle istituzioni, dei partiti, dei sindacati. Si fa riferimento cioè alla crisi delle forme, delle strutture, delle organizzazioni. Di conseguenza si propongono riforme, interventi, operazioni di ingegneria politica, nuove aggregazioni politiche nella speranza di colmare il vuoto...La concezione strumentale dell’azione politica, tipica della cultura maschile, tende a deificare i valori e i desideri di cambiamento sociale, trasformandoli in qualcosa di esterno, di oggettivo, di quantificabile. Le persone, in questo tipico modo di agire finalistico, divengono mezzi, strumenti, materia da plasmare per realizzare i nostri progetti razionali. Invano si cercherebbe nei discorsi degli uomini politici uno sforzo di consapevolezza che riconosca il legame tra sé e il mondo, tra la propria esistenza e l’esistenza di altri esseri. In altre parole, quello che ci manca più di ogni altra cosa non è un nuovo progetto politico, un nuovo soggetto o una nuova formazione. Ci manca invece una politica che sia il riflesso di un desiderio autentico e radicale di vivere, di vivere insieme con gli altri».
Per un’azione politica che voglia tener dentro "unità e pluralità", differenza e condivisione, è necessario il rapporto diretto tra persona e persona, ma anche la disponibilità del singolo a lavorare su di sé, a mettersi in discussione. Quando si constata con sorpresa - come nel caso degli operai che hanno votato a destra - che "identità sociale" e "soggettività politica" sono scisse, si dice indirettamente che l’individuo, non solo non coincide col cittadino - anzi, diceva Tocqueville, è il suo "peggior nemico" - ma non si identifica neppure totalmente con la sua collocazione nei rapporti di lavoro, col suo essere in un territorio, né solo col suo ruolo sessuale nella coppia, nella famiglia.
L’essenza della politica, il motore primo della conflittualità sociale e della trasformazione, si sono venuti spostando, di volta in volta, su questo o quell’aspetto dell’esistenza, facendolo diventare unico e centrale. Dire che nel "sé", nel vissuto del singolo si danno concentrati e amalgamati bisogni, identità, luoghi, rapporti, passioni, fantasie, interessi e desideri diversi, è riconoscere che c’è un "territorio" che sfugge, o esorbita, dai confini storici e geografici, dai luoghi della vita pubblica - e quindi irriducibile al sociale - che è la vita psichica, una terra di confine tra inconscio e coscienza, tra corpo e pensiero, in cui affondano radici ancora in gran parte inesplorate.
Le "viscere" razziste, omofobe, misogine, su cui la destra antipolitica ha fatto breccia per raccogliere consensi, è il sedimento di barbarie, ignoranza e antichi pregiudizi, ma anche sogni e desideri mal riposti, che la sinistra, ancorata al primato del lavoro e della classe operaia, ha sempre trascurato, come se dopo il grande balzo della coscienza operato da Marx non ci fossero stati altri rivolgimenti altrettanto radicali, come la psicanalisi, il femminismo, la non violenza, la biopolitica, l’ambientalismo.
L’individuo, la persona, la soggettività intesa come esperienza del singolo e come corpo pensante, si sono fatti strada con fatica, fuori da vincoli famigliari e comunitari obbligati, e se sono andati assumendo sempre più le forme di un individualismo chiuso alla solidarietà, è anche perché su questo versante partiti e movimenti di sinistra hanno preceduto separati, guardandosi reciprocamente con sospetto. "Il personale è politico", per chi si preoccupava negli anni ’70 di salvaguardare la grande "unità di classe", suonava come uno slogan "borghese". Oggi, chi sottolinea la dimensione metropolitana del politico, chi si batte per i diritti civili di conviventi, di gay e lesbiche, per la libertà femminile, per la cittadinanza dei migranti, passa per "radical chic". Eppure è dalla testimonianza diretta dei singoli, voci che si raccolgono fuori dal dibattito pubblico, fuori, soprattutto, dalla cerchia del ceto politico, che il "sociale" tanto invocato prende forma, caricandosi di ragioni e di senso. Non necessariamente quelli che ci aspettiamo, ma che tuttavia non possiamo ignorare, se si vuole davvero costruire un’alternativa meno violenta e alienata di società.
Tatiana Gentilizi, giovane operaia della Zanussi di Forlì, nell’intervista pubblicata dalla rivista "Una città", così descrive il suo lavoro: «L’importante lì è non parlare del tuo lavoro, che è un po’ deprimente, ma di tutt’altro. Parli delle vacanze che hai fatto, di quello che ti sei comprata, del Grande fratello . Se non guardi il Grande fratello , là dentro sei un po’ tagliata fuori...I giovani che entrano in fabbrica lo fanno probabilmente per bisogno, ognuno ha la sua storia. Però tutti, o almeno la stragrande maggioranza, lo vedono come un momento di transizione, per cui non si interessano più di tanto del loro essere operai...Non c’è più una condivisione profonda del lavoro, l’importante è passare comunque le otto ore nella maniera più tranquilla possibile e poi del domani chissenefrega, si vedrà. Di positivo c’è che ti dà la possibilità di pensare ad altre cose, puoi anche ascoltare la musica: puoi portare il walkman e sentirlo in un solo orecchio..Oggi l’operaio si sente meno operaio e prevalgono le strategie individuali».
«Non si vive di solo pane», dice Bloch, «soprattutto quando non se ne ha». L’insegnante di una scuola per apprendisti commessi e impiegati spinge i suoi alunni a mobilitarsi il 1° maggio sul disagio della loro condizione. Lei porta in corteo il cartello "Viva l’unità delle masse popolari", loro, pochi numericamente, esclamano "basta con la politica". Alla richiesta di quali fossero i loro interessi, le ragazze rispondono: «Le nostre letture sono di tutti i generi, in particolare riviste come Grazia , Gioia , Grand Hotel ». «Il mondo cui tendevano e tendono - commenta l’insegnante sulla rivista "L’erba voglio" (n.1, luglio 1971) - e che vedono riflesso in tali letture, è un mondo fatto di vita non pressata dal bisogno di guadagno, una vita fatta di cose belle, di automobili sportive, di profondi affetti e storie amorose...vita che non vivono, e a cui pure tendono». In nota all’articolo, la redazione commenta: «Per poter veramente lavorare con la gente, per poterla concretamente toccare, bisogna passare, e non è ironia, proprio attraverso i suoi sogni». Non potevamo accorgercene prima?
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ... PRAGA. LA PRIMAVERA INSANGUINATA. L’invasione sovietica schiacciò il tentativo di rinnovare il sistema comunista dall’interno. Ma la fine di quel mondo cominciò proprio allora: vent’anni dopo le idee di Praga (di Bernardo Valli).27 aprile 2008, di Federico La Sala
 L’invasione sovietica schiacciò il tentativo di rinnovare il sistema comunista dall’interno
L’invasione sovietica schiacciò il tentativo di rinnovare il sistema comunista dall’interno La Primavera insanguinata
La Primavera insanguinata Ma la fine di quel mondo cominciò proprio allora: vent’anni dopo le idee di Praga
Ma la fine di quel mondo cominciò proprio allora: vent’anni dopo le idee di Praga
 riaffioreranno a Mosca
riaffioreranno a Mosca di Bernardo Valli (la Repubblica, 27.04.08)
di Bernardo Valli (la Repubblica, 27.04.08)Parigi. Erano circa le tre, nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto 1968, quando i praghesi furono svegliati da un rumore grave e forte, sempre più intenso. Un brontolio sordo. Sulle loro teste si muoveva il ponte aereo più importante organizzato nel cuore dell’Europa dalla Seconda guerra mondiale. Vibravano le vetrine di piazza San Venceslao, lunga come un ippodromo e dominata dall’imponente Museo nazionale che poche ore dopo sarebbe stato scalfito dai proiettili dell’Armata Rossa. Quello che sembrava un interminabile tuono echeggiava nei cortili dei solenni palazzi di Mala Strana, ai piedi del Castello di Hradcany. E investiva le facciate liberty allineate sulla Moldava e sulla stravagante via Parigi, tra il fiume e il ghetto defunto.
Forse faceva fremere anche i moschettieri di terracotta appollaiati su un tetto di via Parigi, come se dovessero proteggere dall’alto l’indimenticabile cimitero ebraico che è li a due passi. In quelle ore la preziosa città mitteleuropea, resa ancor più romantica, evanescente dalla ventennale trascuratezza del regime, era un antico, magico lampadario di cristallo, sbrecciato e polveroso, scrollato da una forza misteriosa, senz’altro infida.
Provati dalle emozioni delle ultime settimane, non pochi praghesi, i meno decisi, si rigirarono nel letto e cercarono di riaddormentarsi. Era evidente che la capitale era sorvolata da ondate di aerei a bassa quota, ma per loro doveva trattarsi di una manovra. Era comodo pensarlo. E non mancavano gli spunti che potevano rassicurare. La controversa, contrastata Primavera di Praga, il processo di rinnovamento comunista iniziato (o accelerato) il 5 gennaio con la nomina del riformatore Alexander Dubcek alla testa del partito, al posto dell’ortodosso Antonin Novotny, era arrivata al 204esimo giorno. E le minacce sembravano per il momento sospese se non proprio svanite del tutto. Il vertice di Bratislava del 3 agosto aveva fatto tirare un sospiro di sollievo. Riuniti a congresso, come un tribunale di ultima istanza, i capi di cinque Paesi comunisti (Urss, Bulgaria, Germania orientale, Ungheria e Polonia) avevano emesso una sentenza in apparenza assolutoria: avevano dato l’impressione di tollerare l’esperimento cecoslovacco e di non volerlo schiacciare come era accaduto dodici anni prima con lo scisma ungherese. A una sola condizione: che esso confermasse la sottomissione totale al Patto di Varsavia, ossia all’alleanza militare comunista, dominata dai sovietici.
Questa condizione annessa all’apparente assoluzione creava un’equazione irrisolvibile. Quindi esplosiva. Bratislava aveva acceso una breve illusione. Alla stessa ora, mentre i praghesi meno sensibili si agitavano nei loro letti infastiditi e impensieriti dal passaggio degli aerei, Dubcek e i suoi compagni venivano catturati dai paracadutisti sovietici nella sede del Comitato centrale. Dopo le cinque, quel mattino di mercoledì 21 agosto, al rumore del ponte aereo se ne aggiunsero altri più allarmanti. All’Hotel Esplanade, all’angolo di piazza San Venceslao, un giornalista straniero non ancora del tutto emerso dal sonno pensò a un martello pneumatico in funzione nei paraggi. Ma a quell’ora non potevano esserci lavori stradali in corso.
Quei tonfi ritmati, lenti erano quelli di una mitragliatrice pesante, attutiti dalla distanza. Quando il cronista assonnato si affacciò sulla piazza San Venceslao scoprì che era affollata come in un giorno di festa. La gente era tanta che traboccava nelle strade adiacenti. C’erano molte bandiere. Bandiere ceche di tutte le dimensioni, sventolate dalle automobili, appese alle finestre, in testa a cortei che si incrociavano, diretti verso il Museo, all’estremità alta della piazza, o nella direzione opposta, verso il fiume.
Si avvertiva una disperata esaltazione. I giovani, ragazzi e ragazze, ma anche gli anziani, uomini e donne, tutti a mani nude, avevano voglia di confrontarsi con gli invasori. La maggioranza dei praghesi non si era illusa. Era saltata giù dal letto. Non era stata tanto ottimista da pensare a una manovra militare. L’invasione era un incubo che accompagnava il Paese da mesi. Il tuono nella notte d’agosto già un po’ autunnale non aveva lasciato dubbi: l’invasione era cominciata. E subito masse di praghesi si erano rovesciate per le strade, prima ancora dell’alba, mentre si accendevano sparatorie sulle due sponde del fiume, e nella parte alta, verso Hradcany. Più che scontri armati erano spari sovietici di intimidazione. Non era la resistenza delle milizie del partito o dell’esercito nazionale che poteva fermare l’invasore.
La storia e la cultura hanno insegnato a un piccolo Paese ritagliato tra imperi prepotenti, dei quali non può contrastare la forza, quali sono le forme di resistenza consentitegli dalla ragione: l’ironia, il sarcasmo, il dialogo, la polemica. Armi spuntate quando prevale la violenza, ma che salvano la dignità e lasciano tracce ricche di sviluppi nell’attesa di tempi migliori.
Piazza San Venceslao era diventato il punto di raccolta dei manifestanti. Era in quelle ore il cuore di Praga. Clacson e voci esasperate rimbalzavano tra gli edifici dell’ampia spianata rettangolare, mentre le finestre via via si illuminavano, avvertendo che ormai tutti avevano abbandonato i loro letti, e con i letti l’illusione. Gli Ilyushin erano ormai ben visibili nel cielo, stanati dalle prime luci. E all’alba la gente scagliava le sue maledizioni alzando lo sguardo. Alcuni accompagnavano le imprecazioni con degli sputi.
L’Armata Rossa si era impossessata della città «con la rapidità di una piovra che stende i tentacoli» (si leggerà più tardi in uno dei tanti racconti anonimi di quelle ore). I russi erano sul Ponte Carlo, davanti a San Nicola, sulla piazza della Città Vecchia, davanti al monumento di Jan Hus, il teologo riformista bruciato vivo (nel Quattrocento), al quale un praghese avrebbe poi bendato gli occhi affinché non vedesse quello spettacolo vergognoso. I carri armati, i T55 e i più moderni T62, si aggiravano per la città con le torrette chiuse, senza che gli equipaggi mostrassero le facce, subendo gli insulti e gli sputi della folla. Non reagivano neppure quando alcuni giovani, rassicurati da quell’inerzia, si arrampicavano sui carri e sventolavano la bandiere cecoslovacche, come se esibissero un trofeo di guerra catturato a mani nude.
L’Armata Rossa aveva l’ordine di evitare il più possibile l’uso delle armi. Ma qualche comandante perse le staffe o ricevette l’ordine di reagire. Tre autoblindo aprirono il fuoco, prendendo di infilata piazza San Venceslao. Scaricarono le loro mitragliatrici, tenendo però alto il tiro, mirando al primo piano del Museo nazionale. Anche quello era un fuoco di intimidazione ma sul selciato, quando la piazza si vuotò, c’erano tracce di sangue. La folla si disperse nelle strade vicine inseguita dall’odore aspro di polvere e di grasso bruciato e dai frammenti di pietra strappati dalla facciata del Museo. Al panico, alle urla di paura, alle imprecazioni, segui un silenzio non tanto lungo. Poi la gente riempì di nuovo la piazza occupata dai carri armati. E lentamente si spalancò una scena destinata a durare alcuni giorni.
Giovani e anziani, uomini e donne, inermi, avevano accerchiato i carri armati, dai quali adesso spuntavano le facce stralunate di soldati per lo più imberbi. I cecoslovacchi parlavano il russo. L’avevano imparato a scuola. Era la lingua obbligatoria. La lingua dell’impero. La lingua dei liberatori del ‘45 diventati invasori nel ‘68. Più di vent’anni dopo la lingua imperiale serviva a polemizzare con i nuovi occupanti, a insultarli; a invitarli a tornare a casa, ad andarsene al più presto. C’era chi strappava la tessera del partito davanti ai cingoli e gettava i frammenti in faccia agli ufficiali che spuntavano a mezzo busto dalla torretta. Le ragazze boeme dicevano, senza sorridere: «Ritornate dalle vostre Natasha, con noi non combinerete mai niente. Neanche se ci minacciate con i vostri cannoni».
I sovietici erano esterrefatti. Non tutti sapevano in che Paese fossero capitati. I loro padri, nel ‘45, avevano avuto un’accoglienza diversa. Le donne di Praga li avevano presi sottobraccio, strappandoli dai ranghi, mentre sfilavano vincitori per le strade appena sgombrate dalle truppe naziste sconfitte.
Neppure un quarto di secolo dopo le ragazze cecoslovacche chiamavano i figli o i nipoti dei liberatori di un tempo con lo stesso nome. Per loro erano tutti «Ivan» senza distinzione. Affibbiavano a tutti lo stesso nome, come se fossero stati fabbricati in serie, uguali, ubbidienti. Non individui, ma elementi senza identità di un’unica massa umana. La Primavera di Praga era stata un tentativo di recuperare gli individui, schiacciati da un collettivismo inefficace e umiliante. Quegli «Ivan», spesso inconsapevoli, cancellavano con i loro carri armati quel tentativo, quella speranza, quell’illusione. Gli storici ci dicono che la fine del mondo comunista è cominciata nell’agosto 1968 a Praga. Altri risalgono alla Budapest del ‘56. È un fatto che per evitare il contagio politico, o la depressione, i soldati russi vennero spesso sostituiti, durante l’invasione della Cecoslovacchia. E le idee della Primavera di Praga sarebbero riaffiorate a Mosca, vent’anni dopo, e avrebbero contribuito all’autoaffondamento, al suicidio, dell’Unione Sovietica. Le armi spuntate dei giovani cechi sulla piazza San Venceslao, il sarcasmo, l’ironia, la polemica, servirono poco nell’agosto ‘68. Ma fa piacere pensare che abbiano poi dato dei frutti, proprio nel cuore dell’impero degli «Ivan», favorendone il crollo.
Stupito che l’avvenimento fosse ufficialmente ignorato, dieci anni fa, trovandomi a Praga per il trentesimo anniversario dell’invasione, scrissi che dopo essere stata condannata e sepolta nel 1968 dall’Unione Sovietica, la Primavera di Praga era stata condannata e sepolta nel 1993 dal Parlamento ceco liberamente eletto. L’Urss aveva usato i carri armati. La democrazia ceca usava una legge. In quest’ultima, nella legge ceca, si definiva senza distinzione il periodo dal 1948 al novembre 1989, vale a dire gli anni in cui il Paese fu governato dal partito comunista, una fase durante la quale la società fu violentata da un’organizzazione criminale. Nel presentare questa legge un esponente del governo aveva precisato che neppure i promotori dell’effimera Primavera, durata 204 giorni, potevano sfuggire a quel giudizio. Anche loro erano stati in definitiva guardiani del campo di concentramento: guardiani buoni rispetto ai loro predecessori e ai loro successori, ma pur sempre guardiani.
Ricavai questa scarna, un po’ brutale, interpretazione dell’atteggiamento cecoclovacco ufficiale nei confronti della Primavera dal discorso del filosofo Karel Kosic, un coraggioso intellettuale e protagonista della Primavera, che mi aveva aiutato a capire gli avvenimenti nella Praga del ‘68, prima e durante l’occupazione sovietica. E che per me era stato anche un amico. Un amico per il quale avevo una grande ammirazione. Adesso, nella Praga democratica, il giudizio sulla Primavera sta cambiando. È cambiato, poiché si valuta la Primavera con rispettosa attenzione. Era tempo. Karel Kosic e tanti suoi amici lo meritavano da un pezzo.
In quei mesi del ‘68 facevo la spola tra Parigi e Praga. Seguivo il Maggio francese e la Primavera cecoslovacca. Sulla diversità dei due avvenimenti simultanei vale la pena citare la laconica analisi di Milan Kundera (nella prefazione a Miracolo in Boemia di Josef Skvorecky). Tra l’altro Milan Kundera, non comunista, era un amico di Karel Kosic, filosofo critico marxista. Per Kundera, dunque, sulle rive della Senna ci fu un’esplosione di lirismo rivoluzionario, mentre sulle rive della Moldava ci fu l’esplosione di uno scetticismo postrivoluzionario.
-
> LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ... La lezione di Karel Kosìk contro la farsa del nostro tempo (di Pier Aldo Rovatti)29 giugno 2013
Torna il filosofo legato alla Primavera di Praga
La lezione di Kosìk contro la farsa del nostro tempo
di Pier Aldo Rovatti (la Repubblica, 29.06.2013)
- IL LIBRO Un filosofo in tempi di farsa e di tragedia di Karel Kosík (Mimesis pagg. 290 euro 24)
Di Karel Kosík, filosofo cecoslovacco, si parlò molto in Italia all’inizio degli anni Sessanta e fino alla Primavera di Praga, che certamente lui nutrì con il suo pensiero critico e dissidente, poi sempre meno fino a un completo silenzio. Quando morì nel 2003, a 77 anni, la rivistaaut aut - la stessa che nel 1961, grazie a Enzo Paci, lo aveva fatto conoscere - gli dedicò un dovuto omaggio.
Adesso esce una raccolta di suoi saggi e interventi intitolata Un filosofo in tempi di farsa e di tragedia (a cura di Gabriella Fusi e Francesco Tava, con una introduzione di Laura Boella, nella collana “Gli imperdonabili” delle edizioni Mimesis) e all’Università Statale di Milano se ne è parlato in un seminario di studi promosso dalla stessa Boella. Curioso: proprio lì dove, cinquant’anni fa, Kosík aveva tenuto la sua unica conferenza milanese dedicata a “La ragione e la storia”, invitato da Paci.
Ma chi è Kosík? È innanzi tutto colui che con La dialettica del concreto (pubblicata nel 1963 a Praga e tradotta nel ‘65 da Bompiani, oggi introvabile) lanciò al marxismo ufficiale di allora un messaggio critico di eccezionale portata, puntando sull’idea di filosofia come senso della pratica trasformatrice e invitando a una rilettura radicale del Capitale di Marx al di là di ogni naturalismo economicistico e di ogni schematismo politico. Un libro che innervò la giovane generazione intellettuale protagonista di quella “primavera”, facendo saltare molti interdetti che penalizzavano pensieri considerati “irrazionalistici” (Heidegger, Sartre, ecc.), compreso quello relativo all’importanza di Kafka, smascherando le “pseudoconcretezze” e aprendo tutte le dimensioni del campo del “concreto”, dall’arte alla vita quotidiana, alla politica ricondotta alla “prassi” vincente.
Un libro, infine, che ovviamente venne letto e usato dai critici del “socialismo reale”, e meno ovviamente incise a lungo nel dibattito a Occidente che cercava un marxismo più umano e spendibile. Troviamo, nelle pagine di Kosík, tante singolari anticipazioni: cito solo il suo interesse per i Grundrisse di Marx, che erano al tempo ignoti anche da noi (dopo, produssero dibattiti molto significativi soprattutto all’interno dell’“operaismo”) e in cui lui vedeva il necessario volano per non tagliare in due il pensiero di Marx, di là gli scritti giovanili e filosofici e di qua quelli maturi sotto il segno esclusivo dell’economia politica.
Questo libro, La dialettica del concreto, tra l’altro scritto con rara chiarezza, è stato completamente dimenticato, letteralmente “sepolto” nel tritacarne di quella cultura dell’amnesia che oggi è diventata dominante. Andrebbe ripubblicato, fatto circolare presso le nostre giovani generazioni, troppo digiune di storia e troppo analfabete di dialettica (parola, quest’ultima, che per Kosík andava rimessa al centro di ogni pensiero critico, mentre per noi si è ridotta a nulla più che un flatus vocis).
Sono stati in pochi, e perciò ancor più meritevoli, coloro che hanno cercato di salvare la preziosa memoria di Kosík, a partire naturalmente da Paci stesso (che lo conobbe in Francia a Royaumont e che di lì a poco si sarebbe recato proprio a Praga per lanciare il suo discorso su fenomenologia e marxismo, appoggiandosi anche alla filosofia di un altro grande “dimenticato”, Jan Patocka, amico di Kosík), poi Gianlorenzo Pacini, Guido Davide Neri, per arrivare a Gabriella Fusi e a Laura Boella.
Dopo il ‘68 a Praga arrivarono i carri armati sovietici e con loro la cosiddetta “normalizzazione”. Molti intellettuali dell’Est andarono in esilio (e qui le vicende di Praga e quelle di Budapest si intrecciano, penso agli allievi di Lukács e in primis ad Ágnes Heller). Kosík decise invece di rimanere, accettando che un pesante silenzio calasse su di lui: più volte nel catalogo Suhrkamp fu poi annunciata una sua opera sul “tecno-capitalismo” che però non vide mai la luce.
Il volume adesso uscito in Italia testimonia di alcuni scritti e conversazioni degli anni Novanta, una geniale conferenza sulla Metamorfosi di Kafka, un saggio su “globalizzazione e morale”, uno sulla “mafiosità” degli attuali poteri forti, interventi su altri temi vari (sull’architettura urbana, ecc.).
Ancora più coinvolgenti sono comunque un paio di recuperi di scritti del ‘69, allora bloccati dalla censura: Il ragazzo e la morte, in cui traluce il sacrificio del giovane Jan Palach (che si diede fuoco in piazza San Venceslao, lasciando attonita l’opinione mondiale), e dove viene posta a tema la filosofia come “offerta sacrificale”; e Il riso,dove questo tema assai caro a Kosík viene declinato come condizione spirituale del nostro tempo, un’epoca in cui saremmo ormai diventati del tutto incapaci di vivere la condizione della “tragedia”, sprofondati come siamo in quella della “farsa”. Ma, a guardar bene, resta un buco nero di più di vent’anni, tanti, in cui Kosík sembra essersi volontariamente sepolto vivo, condannato al silenzio, ben al di là - sembra proprio - della sua stessa idea di filosofia come una sorta di offerta sacrificale.
-
-
> LA LEZIONE DEL ’68. LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ..... Uno studio sociologico americano durato oltre trent’anni, dal 1972 al 2004.... "I giovani di oggi - continua Ampola - vivono invece il conflitto tra quantità e qualità. Hanno a disposizione tutto quello che vogliono, ma faticano a dare un valore qualitativo alle proprie risorse". Secondo il professore si tratta di una questione di qualità della vita: "E’ la società che non mette i giovani in condizione di apprezzare ciò che hanno: viviamo una fase di passaggio simile a quella che, a metà dell’800, sconvolse il mondo del lavoro con il passaggio all’industrializzazione. In momenti così delicati le nuove generazioni dovrebbero essere ascoltate".21 aprile 2008, di Maria Paola Falqui
Secondo uno studio Usa la generazione dei baby boomers è ancora ricca di entusiasmo Il sociologo Ampola: "Ai giovani manca una vita di qualità: dedicate più ore all’amore"
La felicità aumenta con gli anni "E’ il grido d’aiuto dei ragazzi"
di SARA FICOCELLI *
ROMA - La felicità è una questione di qualità e aumenta con l’avanzare degli anni. Questa frase non è solo la strofa di una canzone dei CSI ("Io sto bene") ma il risultato di uno studio sociologico americano durato oltre trent’anni, dal 1972 al 2004.
La ricerca è arrivata a questa conclusione a seguito di una serie di interviste condotte dal National Opinion Research Center dell’Università di Chicago, che ogni anno ha chiesto a 1500 - 3000 persone: "Diresti che sei molto felice, abbastanza felice o non troppo felice?".
A sorpresa, a rispondere in modo più ottimista sono state le persone più in là con l’età. Tra il 15 e il 33 per cento dei giovani americani si è detto contento, e tra questi le donne più degli uomini e i bianchi più dei neri. Ma oltre la metà degli intervistati intorno agli 80 anni si è dichiarato decisamente soddisfatto, in barba a rughe, responsabilità e acciacchi. "Con l’età arriva la felicità perché crescendo migliora la qualità della vita" spiega Yang Yang, sociologo dell’Università di Chicago, in un rapporto sul sondaggio pubblicato dall’American Sociological Review. Yang sostiene inoltre che il miglioramento nell’autostima e altri tratti che contribuiscono al benessere tendono a venire con l’età.
Secondo il professor Massimo Ampola, docente di Metodi e tecniche della ricerca sociale presso l’Università di Pisa, le ragioni sono invece da cercarsi altrove. "Gli adulti e gli anziani di oggi sono figli di generazioni che hanno lottato e creduto in ciò che facevano - spiega - Generazioni cresciute con una concezione costruttiva della vita: i baby boomers di ieri, grazie a quell’entusiasmo, riescono oggi a sentirsi ancora vivi". Nonostante le delusioni, i sogni irrealizzati e le aspettative mancate, gli adulti e gli anziani di oggi mantengono dunque un bagaglio di ottimismo ed entusiasmo che li aiuta a trovare sempre nuova energia.
"I giovani di oggi - continua Ampola - vivono invece il conflitto tra quantità e qualità. Hanno a disposizione tutto quello che vogliono, ma faticano a dare un valore qualitativo alle proprie risorse". Secondo il professore si tratta di una questione di qualità della vita: "E’ la società che non mette i giovani in condizione di apprezzare ciò che hanno: viviamo una fase di passaggio simile a quella che, a metà dell’800, sconvolse il mondo del lavoro con il passaggio all’industrializzazione. In momenti così delicati le nuove generazioni dovrebbero essere ascoltate".
Ecco perché il professore, ai suoi studenti, ricorda quanto sia importante dedicare più ore all’amore, alle amicizie e ai rapporti sociali in generale: questa, secondo lui, può essere l’unica strada verso il recupero della qualità di ogni giornata.
Con il termine baby boomer si intende una persona nata tra il 1945 ed il 1964 nel Regno unito, negli Stati Uniti, in Canada o Australia. Dopo la seconda Guerra Mondiale, questi Paesi presentarono un forte incremento nelle nascite, fenomeno comunemente conosciuto come "baby boom". I baby boomers hanno vissuto la guerra del Vietnam, le lotte per i diritti civili, il movimento hippie, la rivoluzione sessuale. E si ritrovano oggi, dopo aver attraversato l’ultimo secolo del millennio, mediamente più felici dei propri figli.
* la Repubblica, 21 aprile 2008.
-
> LA LEZIONE DEL ’68. LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ..... Lungo tutto l’anno, l’ANSA trasmetterà una serie di servizi sul 40/mo anniversario del ’68, tutti contraddistinti nel titolo dalla chiave ’68: una striscia di notizie per ricordare l’evolvere degli avvenimenti in Italia e all’estero, in tutti i campi, accompagnando le cronache allora trasmesse dall’Agenzia con servizi, interviste, approfondimenti stimolati dall’evento del giorno (Ansa)21 aprile 2008, di Maria Paola Falqui
SESSANTOTTO, CRONACHE ORIGINALI DI UN ANNO CHE HA FATTO STORIA *
Il ’68 non è solo l’anno delle rivolte studentesche, che, dagli Stati Uniti, dilagano in Europa, in Francia, in Germania, in Italia, altrove; ma è anche quello del terremoto del Belice; dell’offensiva del tet in Vietnam; degli assassini in America di Martin Luther King e di Bob Kennedy; della Primavera di Praga e dell’invasione della Cecoslovacchia condotta dal Patto di Varsavia; della vittoria dell’Italia di Riva e di Anastasi agli Europei di calcio; dell’enciclica Humanae Vitae di papa Paolo VI; della strage della Piazza delle tre culture e dei pugni chiusi guantati di nero dei velocisti di colore Usa alle Olimpiadi del Messico; dell’elezione di Richard Nixon alla presidenza degli Stati Uniti; dei braccianti uccisi ad Avola.
Il ’68 è questo e moltissimi altri eventi che hanno comunque segnato la vita di tutti noi, chi c’era già e chi sarebbe arrivato solo dopo, in un mondo profondamente cambiato. Non a caso, come il Quarantotto del XIX Secolo, il Sessantotto è l’unico anno del XX Secolo a essere divenuto un nome proprio.
Ansa» 2008-03-17 17:51
-
> LA LEZIONE DEL ’68. LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. ..... Il coltello nel ventre (di Maria G. Di Rienzo).22 aprile 2008, di Federico La Sala
Editoriale
Il coltello nel ventre
di Maria G. Di Rienzo
[Ringraziamo Maria G. Di Rienzo (per contatti: sheela59@libero.it) per questo intervento.] *
Gli stupratori non nascono tali. Vengono "costruiti", addestrati, come si addestrano i soldati ad uccidere. E la cultura che fa di un uomo uno stupratore e’ la stessa che "fa" noi tutti/e. Non e’ una questione femminile, e’ una questione condivisa, e come tale va affrontata. Molti uomini pensano, e sono sinceri, che la violenza sessuale, quella domestica ed il sessismo siano problemi altrui: segnatamente oggi, dopo gli ultimi fatti di cronaca, e’ problema/responsabilita’ dei barbari invasori stranieri. Sono dipinti un po’ come gli Orchi di Tolkien, forse non malvagi in origine ma ormai irrecuperabili, spaventapasseri mediatici, fasci di impulsi incontrollati, marionette guidate da fili di odio, massa di pupazzi insensibili, privi di autocontrollo, che seguono semplicemente la pulsione violenta ovunque essa li conduca, anche quando finira’ per schiantarli nel processo. Ma Tolkien ha molto chiaro che c’e’ un manovratore di questi burattini, un potere piu’ grande e piu’ distruttivo di loro stessi, che li istiga con la seduzione delle parole (gli imbattitibili Uruk-hai!) e la promessa di impunita’.
Il linguaggio sessista, i modelli sessisti, la gerarchia di valore per genere, ed il loro logico compimento, la violenza sessuale, promettono agli uomini potere e impunita’. Si’, ci sono le leggi, possiamo persino inasprirle, ma la condanna morale va ancora principalmente alla donna. Cosa ci faceva la’, perche’ era vestita in quel modo, ci ha ballato insieme, ci e’ andata a cena, avrebbe dovuto capire... Cosa dovremmo capire, spiegatemelo. Che dobbiamo smettere di provar gioia nella vita, di aver voglia di conoscere persone nuove, di lavorare, di studiare, di andare per strada, di vestirci come ci pare, di avere desideri, di innamorarci, di esistere?
Alla maggior parte degli uomini non salterebbe mai in testa di esaminare il proprio comportamento e di misurare il continuum tra il fare "apprezzamenti" pesanti ad una ragazzina ed il violentarla, o il rapporto fra il valutare, in una delle nostre ong "eque e solidali", i seni della volontaria (episodio realmente accaduto) quale requisito per l’assunzione ed il piantarle un coltello nel ventre prima di stuprarla. Eppure la connessione e’ diretta, e chiara come la luce del giorno.
Se la questione venisse almeno nominata (ma non si puo’, sono le femministe a farlo e le femministe sono molto noiose) ci sarebbe il permesso simbolico di affrontarla e di vedere la verita’. Quanto siano seccanti queste personagge lo aveva capito bene il giovane uomo che uccise quattordici studentesse e ne feri’ altre tredici all’Ecole Polytechnique, la facolta’ di ingegneria dell’Universita’ di Montreal in Canada. Stava ben attento a non colpire gli uomini. Aveva spesso ripetuto questo mantra, prima di tradurlo in azione: "Le femministe hanno rovinato la mia vita". Ha avuto la sua gloria, l’eroe, e’ passato alla storia come l’autore del "Massacro di Montreal", uno splendido riscatto per un’esistenza distrutta da qualche lurida cagna che gli aveva detto no, ripetuto no, e ribadito che no significa no. Ma questo dev’essere uno dei "mostri" colti da raptus sulla via di Damasco, non ha a che fare con noi, ci mancherebbe. E se ad essere aggressivo e volgare e’ il tuo compagno di vita, di scuola, o di lotta, be’, quello stava solo scherzando. Non si spingerebbe mai a violentarti. Sta semplicemente, con il suo comportamento, e con la tacita accettazione del mito di una mascolinita’ superiore perche’ violenta, continuando a nutrire chi lo fara’. Sta’ tranquilla, e passagli il fazzoletto quando si lamenta della propria sensibilita’ urtata da femmine moleste. Cosa credi, che non ci sia passata nessuna prima di te? A me il buon compagno comincio’ a parlare di quanto era infelice con sua moglie, e non fermo’ l’auto dove gli avevo chiesto di portarmi. Stavamo andando, invece, verso una comoda e solitaria boscaglia. E’ vero, gli ho tolto le chiavi dal cruscotto e le ho buttate dal finestrino, molto violento da parte mia, piu’ della sua mano untuosa sul mio ginocchio e dei probabili sviluppi di quel viaggio in auto. Ma visto che doveva correre in giro a recuperare le chiavi sono potuta scendere intatta, se si eccettuano la paura, la rabbia, e il gran cumulo di insulti vomitatimi dietro dal sensibile e sofferente individuo.
E’ possibile che a piu’ di vent’anni di distanza io debba ancora parlare di questo? E’ possibile che i metodi, le tecniche, le giustificazioni, e cioe’ il cumulo di spazzatura ideologica che copre la violenza sessuale sia sempre lo stesso? Fino a che l’equazione "mascolinita’ = violenza" resta la forma egemonica di socializzazione maschile proporre un modello alternativo, di partnership, e’ una delle azioni piu’ potenti che possiamo intraprendere a lungo termine.
Abbiamo bisogno di "mascolinita’ sostenibile" e di una "decrescita felice del machismo". Il femminismo ha parlato alle donne mostrando ed aprendo loro altre possibilita’; ha detto senza timori e con argomentazioni solide: questa cultura e’ nociva, ferisce donne ed uomini, uccide, rade al suolo, inquina, devasta. Deve cambiare. Tu puoi cambiarla. E’ ora che anche gli uomini si impegnino in questo processo, che elaborino modelli diversi, per un cumulo di buone ragioni oltre quella imprescindibile del fermare la violenza di genere. Una su tutte: il nesso tra il modello dominatore maschile e le tecnologie nucleari, biologiche, chimiche, la Terra non riesce piu’ a reggerlo; a livello simbolico (ed e’ un livello terribilmente potente) e’ il produttore principale del surriscaldamento globale, dei conflitti armati, dell’economia di rapina eccetera.
I violentatori sono uomini che si identificano in maniera sproporzionata con i valori "mascolini tradizionali" (quelli che passano con tranquillita’ nei media, nei programmi scolastici, negli sport soprattutto di contatto, e filtrano felici in tutte le sub-culture presenti in Italia) e sono particolarmente attenti a cio’ che gli altri uomini pensano di loro. In ragione di cio’, oscillano fra un’arroganza insopportabile ed un’autostima bassissima, e quando i dubbi e i sentimenti di esclusione arrivano al culmine hanno il nemico da punire a portata di mano. Forse non possono prendere a cazzotti quel tizio che li ha maltrattati all’ufficio di collocamento o li ha derisi in cantiere, ma possono "mettere sotto" una donna. La moglie o la prima che incontri per strada va bene lo stesso, tanto "sono tutte puttane".
Moltissimi altri uomini e ragazzi, invece, sono a disagio rispetto a quanto e’ stato insegnato loro sull’essere "maschi", con il suo corollario di omofobia, eterosessismo e stupri, vorrebbero uscirne, ma spesso il prezzo da pagare (scherno, umiliazione, solitudine) e’ troppo alto. E anche se si rivolgono a socialita’ "alternative" per appagare il bisogno di appartenenza, in esse ritrovano fin troppo spesso i medesimi schemi dell’interazione femmina/maschio. Johan Galtung non e’ una fastidiosa femminista, vero? Bene, assieme alle sue analisi di altro tipo, gli uomini potrebbero cominciare a valutare la sua affermazione che la misoginia (l’odio per le donne ed il "possesso" delle donne) e’ uno dei piu’ grandi problemi mondiali che abbiamo.
Abbiamo bisogno di quella campagna nazionale contro la violenza di genere che io chiedo da un bel pezzo. E abbiamo bisogno di coinvolgere in essa quanti piu’ soggetti e’ possibile. Possiamo cominciare da dove localmente abbiamo piu’ risorse. Qualche gruppo o rete potra’ portare avanti programmi educativi, per esempio. Se gli uomini e i ragazzi apprendono i meccanismi della socializzazione di genere possono muoversi oltre l’usuale modulo difensivo che adottano quando viene loro proposta la questione della violenza sessuale. Si tratta di offrirgli l’opportunita’ di liberarsi dai concetti strangolatori del paradigma patriarcale, e di abbracciare piu’ largamente la propria umanita’. Certo, comportera’ impegno e fatica. Come ha detto un mio amico: "Ognuno di noi deve faticare durante il viaggio che collega la sua testa al suo cuore. E’ il viaggio piu’ lungo e difficile di tutti, ma di certo e’ quello che ti offrira’ la ricompensa maggiore". Diversi tipi di associazioni possono intervenire con iniziative pubbliche di qualsiasi tipo per far conoscere la realta’ della violenza di genere nel nostro paese; possiamo costruire delle coalizioni di "pronto intervento" che facciano un gran rumore ogni volta in cui i media biasimano la vittima di stupro, denigrano donne e ragazze, sessualizzano pre-adolescenti, usano linguaggi sessisti, incoraggiano o celebrano la violenza, e cosi’ via.
Mi dispiace dirlo, ma credo che noi femministe dovremmo diventare ancor piu’ moleste, importune e seccanti di quanto siamo gia’, molto, molto di piu’. Per le ragazze e le donne che soffrono in questi giorni e di cui abbiamo saputo. Per quelle di cui non sapremo mai. Per gli uomini e i ragazzi che amiamo e per quelli di cui non vorremmo piu’ aver paura.
 Tratto da
Tratto da
 Notizie minime de
Notizie minime de
 La nonviolenza è in cammino
La nonviolenza è in camminoproposto dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
 Direttore responsabile: Peppe Sini.
Direttore responsabile: Peppe Sini.
 Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it
Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it Arretrati in:
Arretrati in:
 http://lists.peacelink.it/
http://lists.peacelink.it/Numero 433 del 22 aprile 2008
-
-
