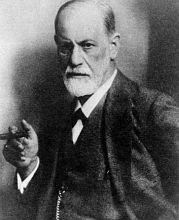
SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota di Federico La Sala
domenica 22 luglio 2007.
- [...] Per uscire dalla barbarie non ci sono altre strade: bisogna spezzare il cerchio vizioso della cecità e della follia e aprire gli occhi all’altro, all’altra, e a noi stessi e a noi stesse. E’ attraverso la mediazione delle cause interne che quelle esterne producono il loro effetto - questo ci hanno sempre detto i grandi saggi, e anche Freud. E, alla fine della sua vita (1938), lo dice in tutta chiarezza: Gesù è stato interpretato edipicamente - in modo tragico! Lo sapeva già anche Dante, che aveva ritrovato la strada alla, della, e nella Comoedìa! E, oggi, lo sappiamo - tutti e tutte: Gesù non è Edipo!!! E la gerarchia della chiesa cattolico-romana - dopo la morte dell’ultimo vecchio papa, Giovanni Paolo II - non ha più storia. Il Libro è stato chiuso: non è più né madre né maestra, sulla via della vita e della verità!!! [...]
- THE CLOISTERS (MANHATTAN): LA TEOLOGIA DELL’INCARNAZIONE NELLA ANNUNCIAZIONE DEL TRITTICO DI MERODE (ROBERT CAMPIN, 1425).
Cosa succede in casa - nella “camera nuziale”, e cosa succede in Parlamento - nella“camera reale”?! Per un nuovo "romanzo familiare", politico e teologico!!!
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I ’GENITORI’?!
Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud
di Federico La Sala *
Quali discorsi si fanno nella stanza dei bambini? Ma quali discorsi si fanno nella camera dei genitori e, ancor di più, in parlamento, nella “camera reale”? Se teniamo presente che ”[...] fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società pre-patriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano [...] che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme”(Françoise D’Eaubonne), e che questa lettera (nota con il titolo “Istruzione sessuale dei bambini”) di Freud al dott. M. Furst è del 1907, comprendiamo tutto il come e il perché, nella recente discussione sui quesiti referendari relativi alla Legge 40/2004, abbiamo perso tutti e tutte, ha ‘vinto’ una millenaria ignoranza, e soprattutto ha perso l’autonomia degli uomini e delle donne e dei cittadini e delle cittadini, e la stessa nostra concezione democratica della vita!!!
Una grande storica occasione per reimpostare ed equilibrare, coerentemente con la nostra stessa Costituzione repubblicana, il campo antropologico e politico tra uomini e donne, cittadini e cittadine, è stata sprecata. E la gerarchia della Chiesa cattolico-romana ha mostrato in tutta crudezza il suo vecchio volto di cecità, di ignoranza, e di tracotanza.
Per fare un esempio: nel 1993, in un articolo intitolato “Contro Wojtyla” (La Repubblica, 24.11.1993), Laura Lilli pose con grande limpidezza e determinazione la questione all’ordine del giorno del nostro presente: “È evidente che ormai alle soglie del Duemila, siamo alla vigilia di una svolta epocale: i soggetti sono due, e tutto è da ripensare”.
 Ma chi l’ha letta, sentita, o ascoltata? Non è un caso che la gerarchia cattolica ha dedicato e dedica più sforzi ancor oggi, al di là delle pur ovvie e salutari discussioni sull’argomento, a combattere le ‘fantasie’ dei grandi e dei piccoli - Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni ... e le avventure di Harry Potter, che affrontare il problema stesso per cui Essa esiste ... far conoscere la verità, rendere gli esseri umani liberi, e accogliere i bambini!!!
Ma chi l’ha letta, sentita, o ascoltata? Non è un caso che la gerarchia cattolica ha dedicato e dedica più sforzi ancor oggi, al di là delle pur ovvie e salutari discussioni sull’argomento, a combattere le ‘fantasie’ dei grandi e dei piccoli - Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni ... e le avventure di Harry Potter, che affrontare il problema stesso per cui Essa esiste ... far conoscere la verità, rendere gli esseri umani liberi, e accogliere i bambini!!!
Al di là del giudizio specifico sulle opere di Dan Brown, c’è da dire che i suoi due lavori hanno il grande merito di sollecitare a riflettere, a livello planetario (dato il successo), sul problema dei problemi, quello antropologico (il più importante, rispetto a quello etico, metafisico, e religioso!!!): l’equilibrazione del rapporto uomo-donna!!! I due romanzi thrillers non a caso hanno una sola parola in comune, ed è della lingua degli americani Hopi: “koyaanisqatsi - la vita priva di equilibrio” (Il codice da Vinci, p. 151; Angeli e demoni, p. 136). Una parola ‘magica’ come quella, passando dall’antropologia e dalla letteratura alla politica e a percorsi storici inediti “per la verità e la riconciliazione” (la Commissione istituita nel Sudafrica nel 1995, istituita da Nelson Mandela - con il motto “guariamo la nostra terra”), di “ubuntu”, una parola-concetto della antichissima lingua africana dal significato inequivocabile e di portata ‘biblica’: “le persone diventano persone attraverso altre persone”.
Per uscire dalla barbarie non ci sono altre strade: bisogna spezzare il cerchio vizioso della cecità e della follia e aprire gli occhi all’altro, all’altra, e a noi stessi e a noi stesse. E’ attraverso la mediazione delle cause interne che quelle esterne producono il loro effetto - questo ci hanno sempre detto i grandi saggi, e anche Freud. E, alla fine della sua vita (1938), lo dice in tutta chiarezza: Gesù è stato interpretato edipicamente - in modo tragico! Lo sapeva già anche Dante, che aveva ritrovato la strada alla, della, e nella Comoedìa! E, oggi, lo sappiamo - tutti e tutte: Gesù non è Edipo!!! E la gerarchia della chiesa cattolico-romana - dopo la morte dell’ultimo vecchio papa, Giovanni Paolo II - non ha più storia. Il Libro è stato chiuso: non è più né madre né maestra, sulla via della vita e della verità!!!
Dopo secoli di proposta di un modello di ‘sacra’ famiglia, con un semi-riconoscimento della paternità di Giuseppe, ora ha ‘sponsorizzato’ un modello di ‘sacra’ famiglia forte, biologicamente controllato dallo Stato. Non sapendo più nulla né della “camera nuziale” né della “camera reale”, si vorrebbero pure imitare i faraoni e ricostruire le piramidi, ma non sanno farlo ... e non sanno più risolvere nemmeno l’enigma della Sfinge di Tebe. I faraoni del vecchio Egitto, come del resto lo stesso Edipo, ne sapevano ben di più !!! (Federico La Sala).
ISTRUZIONE SESSUALE DEI BAMBINI. [Lettera al dottor M. Furst, 1907].
di Sigmund Freud *
Illustre collega
Suppongo che chiedendomi uno scritto sulla ‘istruzione sessuale dei bambini’, Lei non si attenda da me una trattazione sistematica, con riferimento alla intera letteratura sviluppatasi fuor di misura, ma che Lei desideri udire il giudizio indipendente di un singolo medico che dall’attività professionale è stato condotto a occuparsi intensamente dei problemi sessuali. So che Lei ha seguito con interesse le mie fatiche scientifiche e che non mi respinge a priori, come molti altri colleghi, solo perché vedo nella costituzione psico-sessuale e in pratiche nocive della vita sessuale le principali cause delle tanto frequenti malattie nervose; anche i miei Tre saggi sulla teoria sessuale (1905), in cui descrivo il processo dell’organizzazione sessuale e i disturbi che possono insorgere nel trasformarsi di tale istinto in funzione sessuale, hanno trovato recentemente nella sua rivista una cordiale menzione.
Debbo dunque rispondere circa questi quesiti: se in genere si debbano dare ai bambini spiegazioni sui fatti della vita del sesso, in quale età ciò debba essere fatto, e in quale forma. Voglio confessarle subitocce, mentre trovo del tutto comprensibile una discussione sul secondo e sul terzo punto, è secondo me assolutamente inconcepibile che il primo di questi quesiti possa dar luogo a una disparità di opinioni. Che cosa ci si può proporre di ottenere rifiutando ai bambini - o diciamo ai giovani - tali spiegazioni sulla vita sessuale dell’uomo? Si teme forse di risvegliare precocemente il loro interesse per queste cose, prima che si ecciti da solo? O si spera occultando le cose di poter trattenere l’istinto sessuale fino a che possa imboccare le sole strade che sono aperte all’ordinamento borghese della società? Si pensa che i bambini non manifesterebbero alcun interesse o alcuna comprensione dei fatti sessuali, se la loro attenzione non vi fosse richiamata da un intervento altrui? Si ritiene possibile che quelle cognizioni che si rifiutano loro, non vengano fornite per altre vie? O si ha davvero seriamente il proposito di ottenere che essi più tardi considerino basso ed esecrabile tutto ciò che ha a che fare con quella sessualità da cui genitori ed educatori li hanno voluti tener lontani il più a lungo possibile?
Veramente non so a quale di queste due intenzioni si debba attribuire il comportamento effettivamente seguito nell’occultare ai bambini la sessualità; so soltanto che esse sono tutte assurde, e che mi riesce difficile confutarle una ad una. Mi sovviene tuttavia di aver trovato nelle lettere familiari di un grande pensatore e filantropo, Multatuli, alcune righe le quali possono ben bastare come risposta:
“In genere, a mio modo di vedere, si circondano troppo le cose di mistero. È giusto mantenere pura la fantasia del bambino, ma questa purezza non si conserva con l’ignoranza. Credo piuttosto che nascondendo i fatti si fa maggiormente sospettare la verità al ragazzo e alla ragazza. La curiosità ci pone sulla traccia di cose che se ci fossero comunicate schiettamente susciterebbero poco o punto il nostro interesse. Capirei almeno questa ignoranza potesse essere garantita, ma ciò è impossibile: il bambino viene a contatto con altri bambini, e ha occasione di avere fra le mani libri che lo portano a meditare. Proprio il fare misterioso con cui i genitori trattano argomenti che ciò nonostante vengono in qualche misura compresi, acuisce il desiderio di sapere di più. Questo desiderio, appagato solo in parte e di nascosto, eccita i sentimenti e corrompe la fantasia; il bambino è già in peccato e i genitori credono ancora che egli non sappia che cosa sia peccato”.
Non so come si potrebbe dire meglio; ma qualche cosa si può forse aggiungere. Certo sono l’ormai abituale pruderie e la propria cattiva coscienza nelle cose della sessualità a determinare negli adulti il loro fare ‘misterioso’ di fronte ai bambini; ma agisce forse anche un po’ di ignoranza teorica e questa può essere ridotta con una istruzione degli adulti. Si pensa infatti che ai bambini manchi l’istinto sessuale, e che questo si instauri in essi soltanto durante la pubertà con lo sviluppo degli organi sessuali. Si tratta però di un grossolano errore, gravido di conseguenze sia teoriche sia pratiche; è tanto facile correggerlo mediante l’osservazione, che è veramente straordinario come possa persistere. In realtà il neonato reca la sessualità con sé venendo al mondo; determinate sensazioni sessuali lo accompagnano durante l’epoca dell’allattamento e le varie fasi dell’infanzia, e solo una piccolissima minoranza di bambini si sottrae prima della pubertà ad attività e a impressioni sessuali.
Chi vuole vedere un’esposizione completa di queste affermazioni può trovarla nei miei citati Tre saggi sulla teoria sessuale. Apprenderà là che gli organi veri e propri della riproduzione non sono le uniche parti del corpo che forniscono sensazioni di piacere sessuale, e che la natura ha organizzato le cose in modo che sono inevitabili durante l’infanzia anche stimolazioni dei genitali. Questo periodo della vita - in cui l’eccitamento di diverse parti della superficie corporea (zone erogene), per l’azione di certi istinti biologici e come eccitamento che accompagna molti stati affettivi si produce un certo importo di piacere sicuramente sessuale - viene indicato, con una espressione introdotta da Havelock Ellis, come periodo dell’autoerotismo. La pubertà non fa altro che conferire un primato, fra tutte le zone e fonti producenti piacere ai genitali, costringendo così l’erotismo a porsi al servizio della funzione riproduttiva: processo questo che può naturalmente soggiacere a determinate inibizioni e che in molti individui, i futuri perversi e nevrotici, si compie soltanto in forma incompleta. D’altra parte il bambino è in possesso, ben prima di raggiungere la pubertà, di molti atteggiamenti psichici che appartengono alla vita amorosa (tenerezza, dedizione, gelosia), e abbastanza spesso in lui questi stati emotivi si aprono il passaggio verso le sensazioni corporee dell’eccitamento sessuale, cosicché il bambino non può aver dubbi circa la connessione dei due ordini di fatti.
In breve il bambino è, ben prima della pubertà, un essere amoroso completo fatta eccezione per la capacità riproduttiva, e si deve ammettere che con quel ‘fare misterioso’ gli si impedisce soltanto di dominare intellettualmente attività per le quali è psichicamente preparato e nelle quali è somaticamente impegnato.
L’interesse intellettuale del bambino per gli enigmi della vita sessuale, la sua curiosità sessuale, si esprime del resto anche in un’età inopinatamente precoce. Dobbiamo dire che i genitori sono come colpiti da cecità per questo interesse del bimbo, o che essi, quando non possono fare a meno di constatarlo, si sforzano subito soltanto di soffocarlo: solamente così possiamo comprendere perché osservazioni come quelle che ora comunicheremo non vengano fatte più spesso. Conosco un simpatico bambinetto, che ora ha quattro anni, i cui intelligenti genitori hanno rinunciato a reprimere con la forza una parte dello sviluppo del bambino. Il piccolo Hans, che certamente non ha subito alcuna influenza corruttrice da parte delle persone che si occupano di lui, dimostra già da qualche tempo un vivissimo interesse per quella parte del suo corpo che è solito chiamare ‘fapipì’. Già a tre anni ha chiesto alla madre: ‘Mamma, hai anche tu un fapipì?’. A cui la madre ha risposto: ‘Certo, che cosa credevi?’. La stessa domanda egli l’ha rivolta ripetutamente anche al padre. Alla stessa età, condotto per la prima volta in una stalla, ha osservato una mucca durante la mungitura e ha esclamato con meraviglia: ‘Guarda, dal fapipì esce latte!’. A tre anni e tre quarti è in grado di scoprire da solo con le sue osservazioni categorie esatte. Vede che da una locomotiva viene fuori dell’acqua e dice: ‘Guarda, la locomotiva fa pipì; e allora dove ha il suo fapipì?’. Più tardi aggiunse pensieroso: ‘Un cane e un cavallo hanno il fapipì; un tavolo e una seggiola no’. Da poco ha osservato la sorellina, nata da una settimana, mentre le si fa il bagno, e commenta: ‘Ma il suo fapipì è ancora piccolo. Quando lei crescerà, esso diventerà più grande’. (La stessa posizione rispetto al problema della differenza dei sessi mi è stata riferita a proposito di altri ragazzi della stessa età). Posso escludere nel modo più assoluto che il piccolo Hans sia un bambino sessuale o che abbia addirittura una costituzione patologica; penso semplicemente che non sia stato intimidito, che non sia tormentato dal senso di colpa ed esprima perciò senza malizia quanto gli vien fatto di pensare.
Il secondo grande problema che impegna il pensiero infantile - anche se qualche anno più tardi - è quello della provenienza dei bambini: esso si collega per lo più alla indesiderata comparsa di un nuovo fratellino o sorellina. Si tratta del più antico e più scottante problema della giovane umanità. Chi sa interpretare i miti e le tradizioni può rintracciarlo anche nell’enigma proposto dalla sfinge tebana a Edipo. Le risposte che vengono date di solito nella stanza dei bambini feriscono l’onesto spirito di ricerca del bambino e scuotono in genere per la prima volta la fiducia da lui riposta nei suoi genitori: da questo momento in poi egli comincia per lo più a diffidare degli adulti e a mantener segreti di fronte a loro i suoi interessi più intimi. Il breve documento che segue mostra il carattere tormentoso che può spesso assumere proprio questa curiosità per bambini più grandicelli; si tratta della lettera di una ragazzina di undici anni e mezzo, orfana di madre, che ha riflettuto sul problema insieme con la sorellina minore:
Cara zia Mali,
ti prego, sii tanto buona e scrivimi come hai avuto Cristiano e Paolo. Tu lo devi sapere perché sei sposata. Noi abbiamo discusso proprio ieri sera di ciò e vorremmo sapere la verità. Quando venite a Salisburgo? Sai, cara zia Mali, noi non possiamo proprio capire come la cicogna porti i bambini. Gertrude credeva che la cicogna li portasse con la camicia. Vorremmo anche sapere se essa li prende nello stagno, e perché non si vedano bambini nello stagno. Ti prego, dimmi anche come si fa a sapere prima quando si ricevono. Rispondimi per esteso.
Con mille saluti e baci da noi tutti
la tua curiosa Lilli.
Non credo che questa lettera commovente abbia recato alle due sorelle la spiegazione richiesta. L’autrice di questa lettera si è più tardi ammalata di una nevrosi, e cioè di una mania ossessiva di rimuginare, alla cui base stanno domande inconsce rimaste senza risposta.
Io non credo che vi sia alcuna ragione per negare ai bambini quella spiegazione che la loro curiosità esige. Certo, se l’intenzione dell’educatore è quella di soffocare nel bambino, quanto più presto è possibile, la capacità di un pensiero autonomo (perché egli diventi quel ragazzo ‘per bene’ che tanto apprezziamo) non può esser meglio ottenuto che mediante l’inganno in campo sessuale e l’intimidazione in quello religioso. Le nature più forti tengono comunque testa a queste influenze, e diventano ribelli, prima contro l’autorità dei genitori e più tardi contro ogni altra autorità. Quando i bambini non ottengono quelle spiegazioni per le quali si sono rivolti ai più anziani, continuano a tormentarsi in segreto sul problema e pervengono a tentativi di soluzione, nei quali la verità sospettata si trova mescolata nelle forme più strane con errori grotteschi, oppure si comunicano fra di loro in segreto confidenze, nelle quali, a causa del senso di colpa del giovane ricercatore, viene impresso alla vita sessuale il marchio dell’orribile e del ripugnante. Queste teorie sessuali infantili meriterebbero di venire raccolte e pubblicate. Per lo più i bambini da questo momento in poi hanno perduto l’unica posizione esatta rispetto ai problemi del sesso, e molti di loro non la troveranno più.
La stragrande maggioranza degli autori, maschi e femmine, che hanno scritto intorno al problema della istruzione sessuale della gioventù, appare decisa in senso affermativo. Ma la goffaggine della maggior parte delle loro proposte, relativamente a quando e a come ciò si debba fare, induce a concludere che questi stessi interessati abbiano stentato ad ammetterlo. Fa eccezione, per quel che mi è noto della letteratura in proposito, la bella lettera di spiegazione di una donna, Emma Eckstein, immagina di scrivere al figlio decenne. Il modo che viene altrimenti seguito, per cui ci si rifiuta per la maggior parte del tempo di dare ogni cognizione sessuale ai bambini, per regalare poi loro un bel giorno, con parole pompose e solenni, una spiegazione che per di più è solo per metà sincera e che inoltre arriva in genere troppo tardi, non può essere evidentemente essere il modo giusto. La maggior parte delle risposte alla domanda ‘ma come faccio a dir questo al mio bambino?’ fanno, per lo meno a me, un’impressione così penosa che quasi preferirei che i genitori non si occupassero per nulla di questa spiegazione. Quello che piuttosto importa, è che i bambini non si formino mai un’idea che si vogliono mantener loro segrete le cose della vita sessuale, più che non altre cose che non sono ancora accessibili alla loro comprensione. E per ottenere ciò è necessario che fin da principio gli argomenti sessuali siano trattati allo stesso modo di ogni altra cosa che meriti di venir conosciuta.
È compito soprattutto della scuola di non eludere il riferimento alla sessualità, di inquadrare nel loro significato i fatti principali della generazione nelle lezioni dedicate al mondo animale, e di mettere contemporaneamente in rilievo che l’uomo ha in comune con gli animali superiori tutto ciò che è essenziale nella sua organizzazione.
Se quindi l’ambiente familiare non agisce in modo intimidatorio sull’attività di pensiero del bambino, si udranno più discorsi come quello che ho una volta sorpreso in una stanza di bambini, e in cui un ragazzetto obiettava alla sorellina minore: ‘Ma come puoi pensar che la cicogna porti i bambini piccoli. Sai bene che l’uomo è un mammifero; credi dunque che la cicogna porti i piccoli anche agli altri mammiferi?’. La curiosità del bambino non raggiungerà mai un alto livello, se in ogni fase dell’apprendere non troverà l’appagamento corrispondente. La spiegazione delle condizioni specificamente umane della vita sessuale e il riferimento al valore sociale di questa dovrebbero pertanto concludersi con la fine della scuola elementare (prima dunque della scuola media), non quindi dopo i dieci anni. E finalmente l’epoca della confermazione dovrebbe essere il momento più adatto per presentare al bambino, già illuminato su tutto ciò che riguarda l’aspetto fisico, i doveri morali che si collegano all’esercizio dell’istinto. Una tale istruzione sulla vita sessuale, graduale, progressiva, davvero mai interrotta, e di cui la scuola prenda l’iniziativa, mi sembra l’unica che tenga conto dello sviluppo del bambino e che possa quindi felicemente evitare ogni pericolo.
Considero come il più significativo progresso nell’educazione dell’infanzia il fatto che lo stato francese abbia adottato, in luogo del catechismo, un libro elementare che fornisce al bambino le prime cognizioni sulla sua condizione di cittadino e sui suoi futuri doveri morali. Ma tale istruzione elementare è incompleta se non comprende anche la sfera della vita sessuale. Questa è la lacuna che educatori e riformatori dovrebbero proporsi di colmare! Nei paesi che hanno lasciato l’educazione infantile tutta o in parte in mano al clero, ciò non può in alcun modo venir richiesto. L’uomo di chiesa non ammetterà mai l’eguaglianza di natura fra l’uomo e l’animale, perché non può rinunciare all’anima immortale, di cui ha bisogno per fondare il precetto morale. Così ancora una volta rimane comprovato quanto sia assurdo applicare su un abito logoro un’unica pezza di seta, come sia impossibile effettuare una singola riforma senza modificare le basi del sistema!
* S. Freud, Istruzione sessuale dei bambini, in Psicoanalisi infantile, Torino, Boringhieri, 1968, pp.17-25 (oppure, in - Opere, vol. 5, Bollati Boringhieri, Torino).
* www.ildialogo.org/filosofia, Lunedì, 18 luglio 2005
Freud (foto), da Wikipedia.
Sul lavoro di Freud, nel sito, si cfr. anche
 A FREUD, GLORIA ETERNA!!! Federico La Sala risponde a Dario Antiseri.
A FREUD, GLORIA ETERNA!!! Federico La Sala risponde a Dario Antiseri.
Sulla Costituzione della Repubblica italiana e il rapporto della Chiesa cattolica con l’Italia, si cfr. anche
Sulla "caritas", si cfr. anche
FINE DEL CATTOLICESIMO E DELLA CASTA ATEA E DEVOTA VATICANA.
FLS
Forum
-
> La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") --- Eros e agape declinati in ebraico. Catherine Chalier spiega l’amore secondo la tradizione rabbinica dialogando, sulle orme di Lévinas, con l’intera storia del pensiero cristiano (di M. Giuliani).28 maggio 2021, di Federico La Sala
Filosofia. Eros e agape declinati in ebraico
Catherine Chalier spiega l’amore secondo la tradizione rabbinica dialogando, sulle orme di Lévinas, con l’intera storia del pensiero cristiano. Scalzando non pochi stereotipi
di Massimo Giuliani (Avvenire, giovedì 27 maggio 2021)
- Foto] Marc Chagall, "Cantico dei Cantici I"
In principio era l’equivoco, forse generato dall’arcieretico Marcione già nel II secolo dell’era cristiana. L’equivoco cioè che il Dio della Bibbia ebraica fosse solo un demiurgo responsabile del male nel mondo, ossessionato dalla giustizia in forma di castigo, e che invece il Dio “più alto”, quello del Nuovo Testamento, fosse tutto amore e perdono, e che tra i due non potesse che esserci inimicizia e conflitto. Larga parte del difficile rapporto tra ebrei e cristiani dipenderebbe da questa supposta contrapposizione, tanto facile da formulare quanto falsa da dimostrare. Falsa, ovviamente, già a partire dai testi dell’Antico Testamento dove il Creatore ha, simultaneamente, i tratti più severi del padre (o del re) e i modi affettuosi e dolci della madre, e dove la metafora più usata per i rapporti tra Dio e il suo popolo resta quella degli sposi, addirittura degli amanti, come nel potente poema del Cantico dei cantici. Nondimeno lo stereotipo è persistito e sopravvissuto in non poca retorica religiosa, e di riflesso persino in molti intellettuali laici.
Con questa premessa a mente, la filosofa Catherine Chalier, la più nota tra gli interpreti ebrei di Emmanuel Lévinas, ha tenuto una serie di lezioni all’Institute Catholique di Parigi, per la cattedra dedicata a Étienne Gilson, nel tentativo di spiegare quanto l’amore, in tutte le sue dimensioni, sia presente come comandamento e come valore negli scritti sacri dell’ebraismo: dalla Torà ai profeti, dal Talmud ai filosofi ebrei medievali, fino ai grandi maestri del chassidismo, parola questa che viene appunto da chesed, che in ebraico significa amore e pietà. Queste lezioni sono ora raccolte in un volume dal titolo L’amore nell’ebraismo. Filosofia e spiritualità ebraiche (Giuntina, pagine 300, euro 18,00), un libro che evita i pericoli speculari dell’apologia e della supponenza, e riesce piuttosto a dialogare, da un punto di vista ebraico, con l’intera storia del pensiero cristiano.
 Ma come spiegare, in modo semplice e convinvente, che la controversia tra Legge e amore è falsa e tendenziosa? Che ogni precetto ebraico è sempre animato dall’amore per Dio e per ogni altra creatura vivente? Che non vi è dicotomia tra istanze di vera giustizia e disposizione al perdono autentico, ma solo un’esigente co-implicazione? E come narrare la bellezza dell’integrazione tra eros e agape, che nei testi biblici continuamente si intrecciano, si contemperano e si esaltano a vicenda, senza nessuna forma di sessuofobia o di dualismo manicheo?
Ma come spiegare, in modo semplice e convinvente, che la controversia tra Legge e amore è falsa e tendenziosa? Che ogni precetto ebraico è sempre animato dall’amore per Dio e per ogni altra creatura vivente? Che non vi è dicotomia tra istanze di vera giustizia e disposizione al perdono autentico, ma solo un’esigente co-implicazione? E come narrare la bellezza dell’integrazione tra eros e agape, che nei testi biblici continuamente si intrecciano, si contemperano e si esaltano a vicenda, senza nessuna forma di sessuofobia o di dualismo manicheo?Forte del linguaggio paradossale e a tratti iperbolico del suo mentore Lévinas, Catherine Chalier affronta uno stereotipo dopo l’altro e immerge il lettore e la lettrice di queste pagine nell’oceano della riflessione rabbinica sul tema dell’amore di Dio (dove il genitivo è sia soggettivo sia oggettivo) e del dovere di amare il prossimo e lo straniero come chiunque appaia vulnerabile nella scala sociale e persino nell’orizzonte dell’intera creazione.
 Chi si sobbarchi la fatica di questa lettura, o meglio di questo studio delle fonti, resterà sorpreso dal gran numero di domande con cui la studiosa procede, come se la grazia divina e l’amore umano restassero, sostanzialmente, non solo un dono che coglie che ne è oggetto sempre impreparato e persino inadeguato a rispondere, ma soprattutto un mistero, un enigma, da interrogare e su cui gli interrogativi sovrastano le possibili risposte.
Chi si sobbarchi la fatica di questa lettura, o meglio di questo studio delle fonti, resterà sorpreso dal gran numero di domande con cui la studiosa procede, come se la grazia divina e l’amore umano restassero, sostanzialmente, non solo un dono che coglie che ne è oggetto sempre impreparato e persino inadeguato a rispondere, ma soprattutto un mistero, un enigma, da interrogare e su cui gli interrogativi sovrastano le possibili risposte.
 Non mancano poi, qua e là, anche domande provocatorie, come quella circa la cecità cristiana che per secoli non è riuscita a percepire come «la perseveranza ebraica nella fede dei padri e nell’osservanza dei precetti» - chiamata con spregio ostinazione - altro non era che amore, un amore radicale per Dio e la sua Torà o, come scrisse audacemente proprio Lévinas, «un amare la Torà più di Dio stesso».
Non mancano poi, qua e là, anche domande provocatorie, come quella circa la cecità cristiana che per secoli non è riuscita a percepire come «la perseveranza ebraica nella fede dei padri e nell’osservanza dei precetti» - chiamata con spregio ostinazione - altro non era che amore, un amore radicale per Dio e la sua Torà o, come scrisse audacemente proprio Lévinas, «un amare la Torà più di Dio stesso».Quest’incomprensione «ha tragicamente reso fragile, agli occhi degli ebrei, l’amore cristiano» dice Chalier, che subito estende l’interrogativo anche al modo con cui accostiamo e giudichiamo le esperienze religiose di altri popoli, le culture e le religioni diverse dalla nostra. Il pensiero corre a William James e al suo pionieristico testo, qui non citato, sulla “varietà dell’esperienza religiosa”. Altro stereotipo frequente è quello che contrappone l’amore al timore di Dio, come se non si trattasse di due aspetti correlati e come se questo tratto tipico della spiritualità biblica andasse all’improvviso assorbito e dissolto nel comando evangelico del “non temere”. Con pazienza Chalier mostra che nella tradizione biblico-rabbinica aver timore non è sinonimo di aver paura o di provare terrore (tale aspetto della Bibbia sembra spesso taciuto dai teologi cristiani); piuttosto il timore è sempre associato alla coscienza della incommensurabilità del divino ed esprime la conseguente consapevolezza dei nostri limiti cognitivi e affettivi, dei nostri errori concettuali, della nostra fragilità morale. Buttar via il timore di Dio, in quest’accezione, preclude non tanto la comprensione della ricca antropologia dei testi sacri quanto i nostri tentativi di “conoscere Dio”. E chi più di Maimonide ha posto tale conoscenza al centro della propria spiritualità, oltre che della filosofia del mondo ebraico?
La teologia negativa del maggior pensatore ebreo del Medioevo era infatti tesa a purificare la nostra immaginazione da antropomorfismi fuorvianti, ricordandoci con rigore che persino l’espressione “Dio è buono” proietta su Dio la nostra esperienza di bontà. Ciò non impedisce di sapere che “Dio ama il mondo”, ma libera l’amore divino dalla nostra pretesa di fissarlo in categorie umane.
 Per Maimonide la Bibbia insegna che «la conoscenza e l’amore sono inscindibili, almeno la conoscenza vera, quella liberata dalle scorie dell’ignoranza e dai pregiudizi su Dio». Poco sapere equivale a poco amore, ecco il tratto comune a tutta la spiritualità ebraica, afferma Chalier a più riprese, perché non si può amare (non solo umanamente parlando) che quel che si conosce. Da qui l’imperativo ebraico di studiare. “Va e studia” è l’ammonimento con cui Hillel l’anziano, nel Talmud, accompagna la regola aurea, il precetto del non far male al prossimo. Infatti, come si può amare il Creatore, dice l’intera tradizione rabbinica successiva, se non si riconosce, per negligenza nello studio, il valore della sua straordinaria creazione?
Per Maimonide la Bibbia insegna che «la conoscenza e l’amore sono inscindibili, almeno la conoscenza vera, quella liberata dalle scorie dell’ignoranza e dai pregiudizi su Dio». Poco sapere equivale a poco amore, ecco il tratto comune a tutta la spiritualità ebraica, afferma Chalier a più riprese, perché non si può amare (non solo umanamente parlando) che quel che si conosce. Da qui l’imperativo ebraico di studiare. “Va e studia” è l’ammonimento con cui Hillel l’anziano, nel Talmud, accompagna la regola aurea, il precetto del non far male al prossimo. Infatti, come si può amare il Creatore, dice l’intera tradizione rabbinica successiva, se non si riconosce, per negligenza nello studio, il valore della sua straordinaria creazione?Ma le pagine più affascinanti sono quelle che illuminano il bisogno di temperare l’amore stesso con il senso della giustizia, senza il quale l’amore rischia di diventare “patetico” (nel senso levinasiano del termine), incentrato sul nostro pathos più che sul volto altrui, ruotando sulla nostra capacità di empatia che resta però circoscritta alla relazione immediata e perde di vista quel “terzo” che l’amore non vede, che resta fuori dalla prospettiva affettiva.
 La tzedaqà è la giustizia che estende l’amore anche fuori dall’orizzonte degli amanti, e stimola l’amore ad aprirsi, a non diventare patetico o addirittura patologico. Chesed e din ossia amore a giustizia - come eros e agape - sono ebraicamente inseparabili, anzi si esigono e si rafforzano a vicenda, impedendo che il particolare soffochi l’universale o il sentimento faccia torto alla ragione.
La tzedaqà è la giustizia che estende l’amore anche fuori dall’orizzonte degli amanti, e stimola l’amore ad aprirsi, a non diventare patetico o addirittura patologico. Chesed e din ossia amore a giustizia - come eros e agape - sono ebraicamente inseparabili, anzi si esigono e si rafforzano a vicenda, impedendo che il particolare soffochi l’universale o il sentimento faccia torto alla ragione.
 Ora, questo amore giusto e questa giustizia ricca di pietas possono spingersi fino al sacrificio di sé? Nell’ultimo capitolo la filosofa ebrea francese affronta anche questa domanda, mostrando come la tradizione rabbinica la conosca bene ma non abbia fretta a dare risposte. Del resto, il versetto del Cantico recita: «Forte come la morte è amore». Se sia più forte (o meno), non sempre dipende da scelta umana.
Ora, questo amore giusto e questa giustizia ricca di pietas possono spingersi fino al sacrificio di sé? Nell’ultimo capitolo la filosofa ebrea francese affronta anche questa domanda, mostrando come la tradizione rabbinica la conosca bene ma non abbia fretta a dare risposte. Del resto, il versetto del Cantico recita: «Forte come la morte è amore». Se sia più forte (o meno), non sempre dipende da scelta umana. -
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") ---- I giovani di oggi ritengono che sia normale adottare quella che possiamo chiamare “la legge del porno” (di Vanni Codeluppi).13 maggio 2021, di Federico La Sala
La legge del porno
di Vanni Codeluppi (Doppiozero, 11.05.2021).
Come mai Beppe Grillo ha realizzato un video con il quale intendeva scagionare dalle accuse di violenza sessuale suo figlio e invece probabilmente ha inguaiato ancora di più quest’ultimo? Non sappiamo come questa vicenda finirà sul piano giudiziario, ma è interessante chiedersi come mai un comunicatore dalla lunga esperienza come lui è incappato in questo errore. Le ragioni possono essere diverse, ma una è meritevole di riflessione: Grillo probabilmente si è fatto influenzare da quello che pensano i giovani e ha scambiato le idee di questi per qualcosa che viene condiviso dall’intera società. Perciò ha fatto suoi i pensieri dei giovani, ritenendo che giocassero a favore di suo figlio. Nella società invece continua a essere predominante una legge morale che è differente, ma che è quella che trova una traduzione nella legge giudiziaria.
I giovani di oggi ritengono che sia normale adottare quella che possiamo chiamare “la legge del porno”. La possiamo chiamare così perché è frutto di quella massiccia diffusione di contenuti pornografici che è avvenuta negli ultimi anni grazie al sempre maggiore utilizzo del Web ed è stata analizzata da Marco Menicocci in Pornografia di massa (Altravista 2014). I dati disponibili su questo fenomeno sono scarsi, ma si pensi che negli Stati Uniti a novembre 2020 la parola “pornhub” è stata più ricercata su Google di “coronavirus” e “Trump”.
Questo fenomeno è particolarmente grave in un Paese come l’Italia, nel quale da sempre l’educazione sessuale non esiste e il processo di acculturazione dei più giovani rispetto al sesso viene in gran parte svolto da parte dei media. È però ben differente l’acculturazione al sesso del passato, basata sulla lettura occasionale di un fumetto o di un giornaletto illustrato oppure sulla visione di un film in un cinema specializzato, da quella che è presente nell’attuale era digitale. Una volta la società in qualche misura censurava e limitava l’esposizione al materiale pornografico, mentre oggi rispetto a ciò non esiste praticamente nessun vincolo. Va considerato che oggi le persone si rapportano al Web per molte ore ogni giorno, la metà degli adolescenti per più di cinque ore al giorno (DAD esclusa), secondo una recente indagine della Fondazione PRO. Inoltre, la potenza comunicativa dei media digitali odierni è decisamente superiore rispetto a quella dei media del passato.
I nuovi media, infatti, sono estremamente ricchi sul piano linguistico e offrono a un giovane di oggi un gigantesco supermercato liberamente accessibile sui cui scaffali si possono trovare pratiche sessuali di ogni genere. È ovvio perciò che tali pratiche vengano scambiate da persone facilmente influenzabili come i più giovani per la norma condivisa nella società.
Il vero problema però è che da molto tempo i materiali di tipo pornografico contengono una ideologia fortemente maschilista che prevede che la donna rivesta un ruolo subordinato e passivo. Forse perché sono nati come materiali prodotti da uomini per essere consumati da altri uomini . Sta di fatto che, come scriveva qualche tempo fa Pietro Adamo nel volume Il porno di massa (Cortina, 2004), «Almeno da metà anni Novanta la messa in scena hard ha privilegiato una potente e prepotente iconografia della violenza, organizzata in massima parte su meccanismi di esplicita subordinazione della femmina da parte del maschio». Negli ultimi anni, come si è detto, il consumo di materiale pornografico si è ampliato e ciò ha comportato che al suo interno sia entrata anche una audience femminile. Il porno continua però a essere caratterizzato da un’ideologia maschilista e le donne che lo consumano l’accettano solitamente anch’esse come qualcosa di normale.
Con la diffusione del consumo di materiale porno attraverso i potenti strumenti digitali di oggi tale ideologia si è rafforzata. E a volte si traduce in concreti comportamenti violenti, come è dimostrato dai sempre più frequenti stupri di gruppo. La scena di una gang bang in cui una donna si accoppia con molti uomini, se vista tante volte, può diventare qualcosa da praticare in un normale sabato sera. Questo non vuol dire naturalmente che chi guarda del materiale pornografico sia destinato a diventare uno stupratore. Vuol dire però che l’attuale iperconsumo di pornografia via Web “normalizza” in misura crescente la violenza verso le donne.
Perché nella cultura sociale si creano degli standard di riferimento per i comportamenti e questi vengono progressivamente condivisi. Non stiamo parlando dell’esistenza di un rapporto causa-effetto tra un messaggio pornografico e dei comportamenti illeciti sul piano morale, ma del fatto che i messaggi si sommano e sommandosi potenziano i loro effetti nella società. L’influenza di un singolo messaggio è trascurabile, ma non lo è quella di migliaia di messaggi. I quali producono pertanto nuovi standard all’interno della cultura sociale.
 Non è un caso che dall’indagine Eurispes Sesso, erotismo e sentimenti, i giovani fuori dagli schemi di qualche tempo fa sia emerso come nelle coppie di giovani sposi intervistate più del 70% delle persone consuma abitualmente materiale pornografico, il 44% tradisce il proprio partner e quasi la metà vorrebbe ricorrere a pratiche sadomasochistiche.
Non è un caso che dall’indagine Eurispes Sesso, erotismo e sentimenti, i giovani fuori dagli schemi di qualche tempo fa sia emerso come nelle coppie di giovani sposi intervistate più del 70% delle persone consuma abitualmente materiale pornografico, il 44% tradisce il proprio partner e quasi la metà vorrebbe ricorrere a pratiche sadomasochistiche.Possiamo dire pertanto che da una decina d’anni, cioè da quando l’utilizzo di Pornhub, YouPorn e altri siti Web simili si è diffuso a livello di massa, nella società è nata anche una nuova morale sessuale. Una morale che abbiamo chiamato “la legge del porno” e che viene spesso condivisa da chi si è acculturato al suo interno al mondo del sesso. Generando così nella società una vera e propria frattura culturale, ma anche probabilmente dando vita a molti dei recenti fatti di cronaca nei quali le donne rivestono il ruolo di vittima.
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E --- "ULTIMA SOLITUDO"! LA NOZIONE DI "PERSONA" E DI "IO ROBOT". Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’.2 settembre 2019, di Federico La Sala
LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI... *
Dopo il discorso di Conte.
«Nuovo umanesimo» in politica: è tempo di dirlo e di farlo
di Giuseppe Lorizio (Avvenire, domenica 1 settembre 2019)
«Molto spesso, negli interventi pubblici sin qui pronunciati, ho evocato la formula di un nuovo umanesimo. Non ho mai pensato che fosse lo slogan di un governo. Ho sempre pensato che fosse l’orizzonte ideale per un intero Paese». Questa frase, pronunziata giovedì al Quirinale da Giuseppe Conte nel discorso con cui ha accettato di verificare la possibilità di formare un nuovo esecutivo, è stata ripresa dai media in modo spesso superficiale e talvolta in maniera irridente, in alcuni casi come esclusivo supporto alla cultura dell’accoglienza, soprattutto verso i migranti, e tuttavia, ha bisogno di essere ulteriormente pensata e approfondita.
Non bisogna dimenticare che la Chiesa italiana, nel suo V convegno nazionale, celebrato a Firenze nel 2015, è stata chiamata a riflettere sul tema del ’nuovo umanesimo’ nel suo radicamento cristologico. Il titolo di quell’evento recitava ’In Cristo il nuovo umanesimo’. E papa Francesco nella riflessione che ha proposto ai vescovi italiani nell’Assemblea generale del maggio scorso ha richiamato, in particolare con riferimento alla sinodalità, il discorso che aveva pronunziato in quell’occasione.
 Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
Nell’arduo tentativo di declinare teologicamente il sintagma ’nuovo umanesimo’, nella mia relazione a Firenze, io stesso avevo richiamato la categoria fondamentale, decisamente biblica, dell’alleanza come cifra di un autentico umanesimo radicato nella fede.
 Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).
Oggi mi sembra proprio questo il contributo decisivo che i cattolici italiani possono offrire al Paese in questo frangente, ma non solo. E si tratta di un orizzonte culturale, piuttosto che di un’indicazione programmatica per l’azione di un Governo (come giustamente ha rilevato Conte).Richiamando la Costituzione, si è fatto riferimento al ’primato della persona’, come radice antropologica di ogni azione sociale, politica, culturale. Come tutti sanno, o dovrebbero sapere - e qui il rammarico per averlo troppo spesso tralasciato e dimenticato -, la nozione di ’persona’, nella sua pregnanza ontologica, è stata consegnata (o, meglio, donata) all’Occidente dalle vicende delle dispute cristologiche e trinitarie dei primi secoli, messe in atto in ambito cristiano. Si è pensato l’umano a partire dall’identità di Cristo e dal mistero di Dio.
 Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
Per la cultura pagana la persona era semplicemente la ’maschera’ (prosopon), ovvero rappresentava il ruolo, che in ambito teatrale veniva assunto e interpretato dall’attore. Oltre la funzione pubblica, il cristianesimo, invita a considerare l’uomo nel suo rapporto con l’essere, piuttosto che col fare o col rappresentarsi. La trasposizione in ambito politico del concetto di persona passa attraverso la sua valenza giuridica.
 Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
Come Antonio Rosmini aveva efficacemente dichiarato della sua ’Filosofia del diritto’, «la persona ha nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l’essenza del diritto». Questa preziosa indicazione consente il superamento sia di un crudo giusnaturalismo, sia del contrattualismo, imperante soprattutto nella concezione hobbesiana e rousseauniana dello Stato.
 Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.
Ed è su tale base ’antropologica’ che si innesta la categoria dell’alleanza come modalità propria del rapporto fra persone e fra gruppi di persone.In questa prospettiva vanno letti gli autorevoli inviti - in particolare quello del presidente della Cei Gualtiero Bassetti - a fondare un’autentica prospettiva politica non su dei semplici contratti, spesso frutto di miopi compromessi, che prima o poi esplodono, determinando la catastrofe del rapporto, ma su una visione programmatica, basata appunto su vere e proprie alleanze.
Non possiamo non ricordare che la prospettiva rosminana si rifà alla definizione di Giovanni Duns Scoto, che a sua volta radicalizza la visione di Riccardo di San Vittore (per il quale la persona è intellectualis naturae incommunicabilis existentia) fino a definirla ultima solitudo. Il Roveretano infatti afferma che la persona è una sostanza spirituale dotata di un principio incomunicabile. Così possiamo cogliere la caratteristica fondamentale della persona, ossia la sua unicità.
Sonny, il protagonista artificiale del famoso film Io robot, allorché si scopre ’quasi umano’ e ne prende coscienza, afferma con stupore: «Io sono unico». La macchina si produce, la persona si genera. Questa unicità rende preziosa ogni persona e determina un’etica della sua salvaguardia a qualsiasi classe, cultura, religione, regione, cultura appartenga.
Ma, oltre che unicità, la persona dice anche ulteriorità. Un aforisma che ci giunge dall’antica sapienza (Seneca, Naturales quaestiones) recita: «Oh quam contempta res est homo, nisi supra humana surrexerit», che cosa misera è l’umanità se non si sa elevare oltre l’umano... In questa breve espressione si sintetizza in maniera mirabile l’ulteriorità della condizione umana, espressa peraltro col verbo (surrexerit) che fa riferimento alla risurrezione. Quell’«essere della lontananza » che è l’uomo, infatti, proprio a partire dalla sua distanza originaria e dal suo oltrepassamento realizza la più piena prossimità alle cose (Martin Heidegger). E da questo senso della ’trascendenza’ dell’umano il pensiero credente non è certo assente, anzi lo afferma, per esempio in un famoso frammento di Blaise Pascal, che viene a stemperare il facile ottimismo di un progresso ideologicamente mitizzato - allorché afferma che «La natura dell’uomo non è di avanzare sempre; ha i suoi alti e bassi» (fr. 318 ed. Brunschvicg) - e a mettere in guardia da una possibile deriva spiritualistica dell’antropologia: «L’uomo non è né angelo né bestia, e disgrazia vuole che chi vuol fare l’angelo fa la bestia» (fr. 325 ed. Brunschvicg).
Il nuovo umanesimo, che non intenda esprimersi nella forma di un acritico antropocentrismo, chiede così di declinarsi e di realizzarsi attraverso autentiche alleanze, spesso purtroppo infrante, fra uomo e natura, fra i generi, fra le generazioni, fra il cittadino e le istituzioni, fra emozione e ragione, fra popoli e religioni. Una saggia fatica che certo non può essere il risultato di un programma di Governo, ma quel quel programma può ben ispirare e illuminare. E che richiede una visione culturale e antropologica alla quale i cristiani possono efficacemente contribuire.
Teologo, Pontificia Università Lateranense
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO"
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico.
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud -- Aspettando l’educazione civica. Digisex. Tra umanoidi e sex doll sta nascendo un’ inaspettata identità sessuale. Che solleva profonde questioni etiche e filosofiche.8 maggio 2019, di Federico La Sala
Lettere
Aspettando l’educazione civica
risponde Stefania Rossini (L’Espresso, 05.05.2019)
- Cara Rossini, di educazione civica nelle scuole si parla da decenni senza fare nulla. Eppure è una materia importante. Certamente la più formativa. Purtroppo nella scuola italiana l’educazione civica è la cenerentola delle materie. Il perché è semplice: per insegnarla bene ci vorrebbero degli insegnanti specializzati che insegnino soltanto “educazione civica”. Inoltre ci dovrebbe essere un esame finale e il voto di rendimento, che avrà un peso sulla promozione. Si dirà subito che il costo, per lo Stato, sarebbe altissimo.
 Io credo, e sono certo che moltissimi italiani, anche cattolici, sarebbero d’accordo, di sostituire finalmente l’insegnamento dell’ora di religione (in contrasto con la Costituzione) con l’ora di educazione civica. Naturalmente gli attuali insegnanti di religione dovrebbero fare un corso e specializzarsi nella nuova materia.
Io credo, e sono certo che moltissimi italiani, anche cattolici, sarebbero d’accordo, di sostituire finalmente l’insegnamento dell’ora di religione (in contrasto con la Costituzione) con l’ora di educazione civica. Naturalmente gli attuali insegnanti di religione dovrebbero fare un corso e specializzarsi nella nuova materia.
 Ovviamente si dovrà rivedere il Concordato. Gli articoli 3 e 20 della nostra Costituzione daranno ai politici e ai legislatori l’appiglio legale per modificare il Concordato e sopprimere l’ora di religione cattolica. Non sarebbe la prima volta che si modifica il Concordato con la Santa Sede. Venne modificato nel 1984 durante il Governo di Bettino Craxi. Questa modifica, se realizzata, sarebbe un notevole successo storico del Parlamento e del nuovo Governo che usciranno dopo il voto sull’Europa.
Ovviamente si dovrà rivedere il Concordato. Gli articoli 3 e 20 della nostra Costituzione daranno ai politici e ai legislatori l’appiglio legale per modificare il Concordato e sopprimere l’ora di religione cattolica. Non sarebbe la prima volta che si modifica il Concordato con la Santa Sede. Venne modificato nel 1984 durante il Governo di Bettino Craxi. Questa modifica, se realizzata, sarebbe un notevole successo storico del Parlamento e del nuovo Governo che usciranno dopo il voto sull’Europa.
 Franco Vicentini, Treviso
Franco Vicentini, Treviso
Anche chi non è sostenitore dell’ora di religione cattolica (che sarebbe ormai saggio trasformare in un insegnamento di Storia della religioni), difficilmente sarà d’accordo con la sua proposta, tanto radicale da voler scardinare un patto quasi secolare tra Stato e Chiesa per fare spazio a un’educazione alla cittadinanza, come se le due cose non potessero convivere. Tanto più che un’ennesima legge per introdurre l’educazione civica nelle scuole va proprio in questi giorni in Parlamento, portandosi dietro la solita scia di polemiche.
C’è chi, come lei, vorrebbe una materia isolata con docenti specializzati e voti di profitto, chi ne introdurrebbe elementi in ogni materia di insegnamento, chi la ritiene pleonastica, chi addirittura dannosa perché toglierebbe tempo e impegno all’apprendimento.
Qualcuno si chiederà: ma come, la materia non c’è già, non la volle Aldo Moro come ministro dell’Istruzione nel lontano 1958? In effetti Moro l’aveva istituita, ma nei decenni è stata dimenticata, resa marginale, affidata alla sensibilità di qualche docente volenteroso, riproposta da ogni ministro che “riformava” la scuola a modo suo, magari solo cambiandole il nome, come per esempio in Cittadinanza e Costituzione.
Ma ora c’è fretta di tornare sull’argomento perché l’imbarbarimento delle giovani generazioni è sotto gli occhi di tutti e la violenza è arrivata anche nelle aule.
Così il governo muscolare ha fatto una sintesi di 15 proposte di legge parlamentari e di una di iniziativa popolare (che ha raccolto 100 mila firme) e farà presto, prestissimo, come è sua abitudine. Anche perché il progetto fa scena e non costa niente: 33 ore di civismo e legalità spalmate qua e là sulle altre materie, senza un’ora di più di scuola, senza un euro di più per gli insegnanti.
Digisex
I nuovi amanti
Sexbot, ovvero robot pensati per offrire piacere e, in futuro, addirittura amore. Tra umanoidi e sex doll sta nascendo un’ inaspettata identità sessuale. Che solleva profonde questioni etiche e filosofiche
di Emanuele Coen (L’Espresso, 05.05.2019)
Fate l’amore, non la guerra». In un futuro distopico non troppo lontano potrebbe essere lo slogan pubblicitario di una casa produttrice di sex robot. A differenza degli umanoidi killer, progettati per seminare morte tra i soldati nemici, i “sexbot” sono macchine pensate per sostituire gli esseri umani sotto le lenzuola, offrire piacere sessuale e addirittura amore. Già disponibili e configurabili in base ai propri gusti, basta fare un giro sul Web, pronti a soddisfare desideri sessuali e anche qualcosa di più. “Frigid Farrah” è programmata per dire “no”, resistere alle avance sessuali del partner o addirittura mettere in pratica violenze sessuali.
Il motto commerciale di un altro robot intelligente, Young Yoko, recita «così giovane, appena 18 anni, che aspetta solo te per imparare». Poi c’è “Samantha”, creata da Sergi Santos, ingegnere elettronico e responsabile della compagnia robotica Synthea Amatus, talmente verosimile che nel 2017 all’Ars Electronica Festival a Linz, in Austria, fu letteralmente presa d’assalto, “violentata” da un gruppo di uomini eccitati. Una scena raccapricciante. E così via, i robot del sesso hanno nomi ammiccanti: Roxxxy, Denyse, Solana, Isabel, ma anche Rbert o Stew. Dispositivi dotati di intelligenza artificiale, più evoluti delle sex dolls, le bambole in silicone per uso domestico o da bordello.
GALASSIA DIGISEXUAL
Se l’identità sessuale è un concetto sempre più variegato, anche l’offerta sintetica si fa più ricca e va incontro a esigenze in continua evoluzione. Persone demi-sessuali, in grado cioè di sviluppare attrazione fisica solo per persone con cui hanno una forte relazione emotiva; ases- suali, che non provano alcuna attrazione fisica, o ancora “skoliosexual”, individui attratti da persone che non si riconoscono nell’idea secondo cui esistono solo due generi, maschile e femminile. E così via. Per definire invece i pionieri dell’interazione sessuale uomo-macchina alcuni esperti hanno coniato il termine “digisexual”, che definisce una identità sessuale nuova da estendere anche a tutti coloro, ben più numerosi, che vivono immersi in un mondo dominato da pornografia digitale, “teledildonics”, vale a dire sex toy azionati a distanza con l’aiuto di computer, applicazioni per incontri sessuali. Nei prossimi anni i digisexual aumenteranno.
È suggestivo e inquietante lo scenario disegnato nel saggio “Benvenuti nel 2050. Cambiamenti, criticità e curiosità” (Egea) di Cristina Pozzi, bocconiana, imprenditrice sociale, esperta di tecnologie emergenti e visioni future. L’autrice, unica Young global leader 2019 per l’Italia di Forbes, prevede che fra trent’anni i robot umanoidi potranno assumere la personalità o l’aspetto estetico che preferiamo: una star del cinema, una ex fidanzata, un defunto, sempre che questo abbia lasciato il consenso, riportandolo in vita. Navigando on line potremmo ritrovarci a chiacchierare con robot in social network per persone scomparse, in un’epoca in cui sarà del tutto normale fare sesso con una macchina.
Già ora, del resto, la trasformazione digitale della specie è una delle grandi questioni del nostro tempo: non a caso si intitola “Society 5.0 - A human centric future” il TedX Roma che si è svolto il 4 maggio al convention center La Nuvola: 16 speaker provenienti da ogni parte del mondo tra cui Kate Devlin, per riportare l’uomo al centro di scelte e obiettivi.
«La società 5.0 non dovrà più basarsi sulla produzione fine a se stessa di beni, bensì sulla definizione delle soluzioni che realmente servano all’individuo», spiega Emilia Garito, curatrice di TedX Roma e fondatrice della società Quantum Leap Ip: «Vale per ogni settore, anche quello delle relazioni sessuali. In futuro l’offerta sarà sempre più estrema, tesa alla massimizzazione del profitto di chi mette i sexbot sul mercato. L’interazione uomo-macchina tuttavia non deve trasformarsi in compromesso, occorre mantenere spirito critico e libertà di giudizio di fronte al potere della tecnologia, che è in mano a pochi».
Al di là della curiosità, a volte morbosa, e dell’apparente frivolezza dell’argomento, l’idea che esistano robot per raggiungere l’orgasmo, o intessere una relazione più articolata, solleva una serie di questioni etiche e filosofiche: procurarsi il piacere da soli, a volte con l’aiuto di oggetti, è sesso? C’è qualcosa di immorale nel comprare e nell’avere rapporti con una macchina? Le persone che fanno sesso con un robot hanno un’inclinazione a praticare violenza sugli altri e sono incapaci di costruire relazioni affettive stabili con i propri simili?
 Temi di notevole portata, ai quali Maurizio Balistreri, esperto di bioetica e ricercatore di Filosofia morale dell’università di Torino, ha dedicato il libro “Sex Robot - L’amore al tempo delle macchine” (Fandango libri). «Dalla nostra analisi emerge che il sesso non è per sua natura relazionale e che, pertanto, così come possiamo avere rapporti sessuali a pagamento, con persone sconosciute, a distanza per telefono oppure facendo sesso in una realtà virtuale, allo stesso modo possiamo benissimo avere relazioni sessuali anche con i robot», dice Balistreri.
Temi di notevole portata, ai quali Maurizio Balistreri, esperto di bioetica e ricercatore di Filosofia morale dell’università di Torino, ha dedicato il libro “Sex Robot - L’amore al tempo delle macchine” (Fandango libri). «Dalla nostra analisi emerge che il sesso non è per sua natura relazionale e che, pertanto, così come possiamo avere rapporti sessuali a pagamento, con persone sconosciute, a distanza per telefono oppure facendo sesso in una realtà virtuale, allo stesso modo possiamo benissimo avere relazioni sessuali anche con i robot», dice Balistreri.E così, dopo aver sostituito i lavoratori, i robot si apprestano a mandare in pensione anche gli amanti. Ma cosa ne sarà dell’amore se le nostre relazioni sessuali si consumeranno con una macchina? «È vero che attraverso i robot del sesso non possiamo avere gli stessi rapporti che abbiamo con altri esseri viventi: è difficile riuscire ad amare un robot e anche se fossimo in grado di farlo il robot non potrebbe ricambiare i nostri sentimenti», aggiunge il ricercatore: «Ma se l’autoerotismo è sesso, allora possiamo fare sesso anche con i robot: possono aiutarci a raggiungere il piacere e soddisfare i nostri desideri sessuali. I sex robot esistono ve- ramente ed è arrivato il momento di prenderli sul serio».
MA SI PUÒ AMARE UN ROBOT?
Chi li ha presi sul serio, già da tempo, sono il cinema, la tv, la letteratura. Film come “Lei (Her)” di Spike Jonze, che descrive una relazione sentimentale tra il protagonista e un sistema operativo dotato di intelligenza artificiale. Oppure la serie tv “Westworld - Dove tutto è concesso” con le sue scene di sesso spinto, ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e basata sul film “Il mondo dei robot” (We- stworld, 1973) scritto e diretto da Michael Crichton. E più di recente la serie di animazione antologica di Netflix “Love, Death & Robots”, creata da David Fincher e Tim Miller, che mescola estetica da videogiochi, fantascienza, horror e fantasy. Tra gli episodi colpisce “La testimone”, in cui la protagonista, che lavora in un bordello in cui gli uomini si accoppiano con i robot, assiste a un omicidio e scappa dall’assassino per le strade di una città surreale. C’è poi il nuovo romanzo retrofuturista di Ian McEwan, Machines like me (J. Cape, pp. 320, £ 18,99) Sex robot, Maurizio Balistreri (Fandango, pp. 282, € 18) Il disagio del desiderio, Paola Marion (Donzelli, pp. 208, € 28) “Machines like me” (edito da Jonathan Cape), la storia del triangolo amoroso tra Charlie, la giovane Miranda e il robot quasi umano Adam, bello e forte, plasmato e programmato dalla coppia. Una storia ucronica ambientata a Londra nei primi anni Ottanta, in cui la Gran Bretagna ha perso la guerra delle Falkland e il matematico inglese Alan Turing invece di essere perseguitato in quanto omosessuale è uno scienziato di successo nel campo dell’intelligenza artificiale. Un romanzo in cui McEwan mette in guardia i lettori dal potere di creare robot fuori dal nostro controllo e pone questioni universali: cosa ci rende umani? Le nostre azioni o le nostre riflessioni interiori? Una macchina può comprendere il cuore di un uomo? Si può ipotizzare l’attrazione sessuale di un essere umano per un robot? Questioni che indagano i meccanismi della mente umana, e che si po- ne anche Paola Marion, psicoanalista, direttore della Rivista di psicoanalisi e autrice del saggio “Il disagio del desiderio” (Donzelli editore): «Non so se verso un robot si possa parlare di desiderio in senso vero e proprio. Il desiderio sessuale, per come noi ancora lo intendiamo, comprende un altro a cui rivolgersi e a cui tendere. Mette in gioco, cioè, la relazione con l’altro», afferma Marion: «Nel caso della sessualità mette in gioco il corpo e i corpi in relazione tra di loro. Il robot rappresenta un oggetto inanimato, anche se dotato di intelligenza artificiale, che può soddisfare senza coinvolgere relazione e corporeità. Mi pare questa la vera rottura».
Come è facile immaginare, le risposte non sono univoche. Un’altra esperta, Georgia Zara, psicologa e criminologa, docente nelle università di Torino e di Cambridge, alla domanda se si possa avere una relazione che implichi affetto, sessualità e investimento emozionale con un sexbot, risponde così: «La risposta più semplice è “sì”. Esistono relazioni sintetiche nelle quali si investe una forte carica affettiva. Gli studi scientifici evidenziano che quanto più un robot ha sembianze umane, tanto maggiore è il legame che si potrebbe venire a creare: una sorta di “illusione antropomorfica”. L’interazione fisica con i sexbot permetterebbe di avere un amante sempre diverso, senza controversie, con il quale tutto è possibile», dice Zara, che poi affronta altri aspetti, toccati anche nel saggio a sua firma pubblicato nel libro di Balistreri. La docente, infatti, è responsabile scientifica del primo progetto in Italia sull’uso dei robot per il trattamento degli autori di reati sessuali, intitolato S.o.r.a.t. (Sex offenders risk assessment and treatment), che vede coinvolti tra gli altri il Dipartimento di Psicologia dell’ateneo torinese e il Gruppo Abele, su un campione di 71 sex offender maschi, età media 47 anni, ai quali sono state mostrate quattro immagini raffiguranti due sexbot adulti, uomo e donna, e due bambini, maschio e femmina, allo scopo di studiare le loro reazioni. Argomento controverso e difficile: al momento non ci sono sufficienti evidenze scientifiche per dire che l’utilizzo dei sexbot possa inibire il passaggio all’abuso, ma lo studio non è ancora ultimato.
IL RISCHIO DELLA VIOLENZA
Una delle critiche che vengono rivolte agli androidi riguarda il rischio della normalizzazione della violenza sessuale. «Il rischio non è solo possibile, ma anche probabile. In uno studio sul diniego nei sex offender recentemente pubblicato, si evidenzia il ruolo delle fantasie sessuali nelle dinamiche sessualmente abusanti», aggiunge l’esperta. Secondo la ricerca, se la fantasia sessuale è quella del dominio e del controllo del partner, un sexbot può incoraggiarla. Se la fantasia è di tipo feticista, coinvolgendo solo alcune parti del corpo, un sexbot può alimentare il gioco erotico. «Sebbene i sexbot possano agevolare persone in difficoltà nella sfera intima o fungere semplicemente da sex toy tecnologicamente avanzati, dal punto di vista psicosociale e clinico non è da escludere che l’utilizzo di tali dispositivi possa diventare problematico, laddove il sexbot diventa il sostituto esclusivo dell’altro», conclude Zara, che porta l’esempio di Lilly, una donna francese che dice di essere attratta solo dai robot e di volerne sposare uno, dopo le esperienze deludenti con gli uomini. Del resto qualche tempo fa, in Giappone, un uomo di 35 anni, Akihiko Kondo, ha portato all’alta- re un ologramma, la versione peluche della popstar Hatsune Miku. Il matrimonio non ha alcun valore legale, naturalmente, ma è la spia di un fenomeno in evoluzione. Nascono alchimie misteriose, legami inediti, forti e inspiegabili.
Viene in mente la scena finale di “Io e Annie”, il celebre film di Woody Allen, con la voce fuori campo del protagonista Alvy: -«Quella vecchia barzelletta, sapete... Quella dove uno va dallo psichiatra e dice: “Dottore mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina”, e il dottore gli dice: “Perché non lo interna?”, e quello risponde: “E poi a me le uova chi me le fa?”. Beh, credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna. E cioè che sono assolutamente irrazionali, e... e pazzi. E assurdi... Ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova».
Il tempo scorre veloce, il mercato asseconda ogni richiesta con umanoidi sempre più sofisticati che rimpiazzano gli umani, si creano relazioni sempre più complesse, dai confini fluidi. E magari c’è chi, da qualche parte nel mondo, sta già costruendo il sexbot che depone le uova.
- Cara Rossini, di educazione civica nelle scuole si parla da decenni senza fare nulla. Eppure è una materia importante. Certamente la più formativa. Purtroppo nella scuola italiana l’educazione civica è la cenerentola delle materie. Il perché è semplice: per insegnarla bene ci vorrebbero degli insegnanti specializzati che insegnino soltanto “educazione civica”. Inoltre ci dovrebbe essere un esame finale e il voto di rendimento, che avrà un peso sulla promozione. Si dirà subito che il costo, per lo Stato, sarebbe altissimo.
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") - e la "raffineria" di papa Francesco (Catechesi sul “Padre nostro”)..22 febbraio 2019, di Federico La Sala
Catechesi sul “Padre nostro”: 7. Padre che sei nei cieli
di Papa Francesco *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’udienza di oggi si sviluppa in due posti. Prima ho fatto l’incontro con i fedeli di Benevento, che erano in San Pietro, e adesso con voi. E questo è dovuto alla delicatezza della Prefettura della Casa Pontificia che non voleva che voi prendeste freddo: ringraziamo loro, che hanno fatto questo. Grazie.
Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre incomincio il mistero.
 Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).
Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno; come noi, a nostra volta, non saremo mai genitori, o pastori, perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Per questo a volte le dichiarazioni di amore si tramutano in sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guarda, questi due si amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a morte: questo lo vediamo tutti i giorni! E’ per questo, perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e alle volte escono e fanno del male.
Ecco perché, quando parliamo di Dio come “padre”, mentre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, specialmente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad usare Gesù: è l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo mendicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti!
Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone. La mitologia dice che è figlio di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambivalente dell’amore umano: capace di fiorire e di vivere prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e morire; quello che afferra, gli sfugge sempre via (cfr Platone, Simposio, 203). C’è un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore: «Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce» (6,4). Ecco che cos’è spesso il nostro amore: una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al mattino esce il sole e si porta via la rugiada della notte.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’esperienza: abbiamo amato ma poi quell’amore è caduto o è diventato debole. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre forze: incapaci di mantenere una promessa che nei giorni di grazia ci sembrava facile da realizzare. In fondo anche l’apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire. L’apostolo Pietro non è stato fedele all’amore di Gesù. Sempre c’è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’amore.
Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato - un’ipotesi storica -, c’è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’amore di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16).
 Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.
Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito a conoscere Dio che è padre. La conversione di Sant’Agostino, ad esempio, è transitata per questo crinale: il giovane e brillante retore cercava semplicemente tra le creature qualcosa che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno ebbe il coraggio di alzare lo sguardo. E in quel giorno conobbe Dio. Dio che ama.
L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene.
Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo. Se anche per sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore con lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana: quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te.
*
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE -Aula Paolo VI
 Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
Federico La Sala
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA" --- ‘Militia amoris’. Ovidio: il lessico erotico e quello bellico nell’antica Roma (di Alba Subrizio).3 febbraio 2019, di Federico La Sala
L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA" .... *
‘Militia amoris’: la guerra meglio farla a letto!
Il lessico erotico e quello bellico nell’antica Roma
di Alba Subrizio (Il Mattino di Foggia, 03.02.2019)
“Non fate la guerra, fate l’amore” recita un famoso motto; eppure per i latini l’amore era anche ‘guerra’, al punto che i poeti romani coniarono il celebre sintagma “militia amoris” (milizia/servizio militare d’amore). Questo, in virtù del fatto che, come sosteneva il ‘maestro’ dell’arte d’amore per antonomasia, Publio Ovidio Nasone, sotto le coperte gli amanti combattono effettivamente una guerra (!) fatta di strategie di seduzione, ritrosie, “assalti”, etc, fino alla conquista dell’oggetto del desiderio, all’espugnazione della roccaforte. A ben guardare il lessico erotico ben si adattava a veicolare idee e concetti propri del linguaggio e del codice bellico.
Ecco allora che gladium (spada) e hasta (asta, giavellotto) potevano indicare un altro genere di ‘strumento’ che l’uomo portava in battaglia, così come pugna (il combattimento) indicava la ‘lotta’ tra amanti e, pertanto, il letto era un ‘accampamento’ (castra). Ma c’è di più.
In un carme della raccolta “Amori” (1, 9) Ovidio chiarisce che “Militat omnis amans”, ovvero “ogni amante deve militare”, nel senso di diventare vero e proprio ‘soldato’ al servizio dell’amata: «Ogni amante è un soldato, e Cupido ha i suoi accampamenti / [...] al soldato toccano i lunghi viaggi, ma se parte l’amata / l’amante la seguirà con coraggio e senza limiti; / [...] Chi, se non un soldato o un amante, / sopporterà il freddo della notte, e la neve mista alla fitta pioggia? / [...] Uno assedia le grandi città, l’altro la soglia / dell’amante inflessibile, l’uno spezza le torri, l’altro i battenti. / [...] Io stesso ero pigro, nato per gli ozi sciatti; / il letto e l’ombra avevano rammollito il mio animo; / ma l’amore di una bella donna mi ha spinto, ignavo com’ero, / a prestare servizio nel suo accampamento. / Per questo mi vedi svelto e capace di ingaggiare battaglie notturne. / Ami, chi non vuol essere pigro!».
Non solo: l’amante si dice spesso preda o ‘prigioniero di guerra’ (captus) della sua donna, nonché dell’Amore i cui ‘soldati’ (milites) sono Blandizie, Errore e Follia. Che dire di più? Nulla si ottiene senza combattere e, dunque, non c’è amore senza ‘guerra’... Non siate pigri, ma buoni soldati!
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Europa. Letteratura medioevale ...
 L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.),
L’AMORE E LA PAROLA. Che cos’è l’amore, chi può amare, chi è massimamente degno di amore, come amare? Del "Gualtieri" di Andrea Cappellano (XII sec.),SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini")
Federico La Sala
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud -- I successi delle biotecnologie interrogano su una questione: la fine del sesso (di Carlo Alberto Redi).5 agosto 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E SOCIETA’..... *
Confini. L’elmento maschile, in una panoramica generale, si presenta in modo sporadico e occasionale, e dunque accessorio
La fine del sesso
I successi delle biotecnologie interrogano su una questione: declino e limiti di «rapporti naturali» e riproduzione sessuata
di Carlo Alberto Redi (Corriere della Sera, La Lettura, 05.08.2018)
Una delle domande trabocchetto negli esami del corso di laurea in Scienze biologiche è quella relativa alla definizione di sesso. Lo studente impreparato cade nell’errata semplificazione antropocentrica di definire il sesso come potrebbe fare la mitica casalinga di Voghera (Arbasino docet): l’insieme delle contrastanti e complementari caratteristiche (anatomiche, fisiologiche, psicologiche) che mostrano gli individui delle specie a riproduzione sessuata, dissertando poi di sesso genetico, cromosomico, gonadico e precisando tutti i caratteri apprezzabili, primari (ovaio e testicolo), secondari (peli, barba e mestruazioni), terziari (aspetti psicologici e di genere). La corretta definizione fa riferimento al processo della ricombinazione genetica dei caratteri ereditari: nella produzione dei gameti, uova e spermatozoi, la molecola di Dna viene tagliata e ricucita, mescolando i caratteri genetici e creando variabilità nell’assortimento degli stessi. Il grande vantaggio evolutivo della riproduzione sessuata consiste così nel creare un’alta variabilità genetica, sulla quale si esercita la selezione darwiniana; gli individui che hanno ereditato le associazioni di caratteri più favorevoli per l’ambiente in cui vivono sono in grado di accedere con maggiore successo alle risorse ambientali e quindi di riprodursi (fitness).
Due le grandi ipotesi che tentano di spiegare l’origine della riproduzione sessuata, la tangled bank e la «Regina rossa». La prima fa riferimento a Charles Darwin, che nell’ultimo paragrafo della sesta e ultima edizione dell’Origine delle specie, usa l’espressione tangled bank per descrivere l’ambiente come una «banca ingarbugliata», ricco di un enorme assortimento di tante e diverse creature tutte in competizione tra loro; creando alta variabilità genetica tra gli individui, la riproduzione sessuata assicura loro un vantaggio nella competizione per le risorse. La critica più ovvia è legata al fatto che i batteri presentano una scarsissima variabilità, pur essendo sul pianeta Terra da miliardi di anni.
Anche l’ipotesi della «Regina rossa» incontra difficoltà teoriche. La formula è di Leigh van Valen, che nel 1973 la riprese dal romanzo di Lewis Carroll Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, quando la «Regina rossa» spiega che «se si vuole andare da qualche altra parte, si deve correre almeno due volte più veloce».
 Fu William Donald Hamilton a esplicitare la metafora in lavori scientifici che sono veri capisaldi concettuali della teoria genetica dell’evoluzione del sesso (e dell’altruismo, della sociobiologia, in particolare per le relazioni preda/predatore e parassitato/parassita): gli individui delle varie popolazioni che compongono una specie debbono sempre «correre», evolvere in continuazione, per sopravvivere; in altre parole, la ricombinazione genetica (il sesso) assicura al parassitato di evolvere rapidamente caratteristiche capaci di difenderlo dall’attacco del parassita, ma... anche il parassita, grazie al sesso, è in grado di evolvere nuove combinazioni di caratteri tali da permettergli di parassitare di nuovo, così perpetuando in continuazione l’infinita rincorsa.
Fu William Donald Hamilton a esplicitare la metafora in lavori scientifici che sono veri capisaldi concettuali della teoria genetica dell’evoluzione del sesso (e dell’altruismo, della sociobiologia, in particolare per le relazioni preda/predatore e parassitato/parassita): gli individui delle varie popolazioni che compongono una specie debbono sempre «correre», evolvere in continuazione, per sopravvivere; in altre parole, la ricombinazione genetica (il sesso) assicura al parassitato di evolvere rapidamente caratteristiche capaci di difenderlo dall’attacco del parassita, ma... anche il parassita, grazie al sesso, è in grado di evolvere nuove combinazioni di caratteri tali da permettergli di parassitare di nuovo, così perpetuando in continuazione l’infinita rincorsa.La riproduzione asessuata è molto diffusa sia tra gli animali sia tra i vegetali; associata a un’alta capacità di rigenerazione dell’individuo, assicura la procreazione di cloni genetici. Si realizza per scissione binaria o per frammentazione e rigenerazione del corpo: chi tra i lettori non ha mai compiuto un’operazione di riproduzione asessuata di un vegetale strappando un pezzo di foglia, ramo, radice per riprodurlo, tramite talea rigenerativa, a casa propria? Negli animali è presente in moltissimi gruppi, dai Protozoi unicellulari ai Metazoi pluricellulari come i Poriferi (le spugne).
È materia del contendere se la riproduzione sessuata si sia originata da quella asessuata o viceversa. Oggigiorno si tende a preferire l’ipotesi che sia la riproduzione asessuata a essersi originata dalla primigenia sessuata (in molti libri di testo è ancora favorito il caso inverso), considerando il fatto che tutta la macchina enzimatica che assicura il taglia-e-cuci del Dna nel corso della ricombinazione genetica è essenzialmente quella impiegata nei meccanismi molecolari del taglia-e-cuci utili alla riparazione della doppia elica del Dna; questi erano già attivi nel mantenere l’integrità della molecola di acido nucleico dell’ultimo antenato universale comune di tutti gli esseri viventi (in sigla Luca, Last Universal Common Ancestor).
Comunque originato, il sesso è determinato da specifici geni che nel corso dell’evoluzione si sono raccolti su singoli cromosomi, i cromosomi sessuali X e Y (Mammiferi) oppure Z e W (Uccelli). Anche l’ambiente (temperatura, durata del periodo d’illuminazione giornaliera, densità di popolazione, risorse trofiche...) influenza la determinazione del sesso, come nelle tartarughe ove una temperatura superiore ai 30°C determina la nascita di femmine. Il sesso primario nell’uomo si stabilisce intorno alla quinta settimana di sviluppo, quando l’embrione indifferenziato sviluppa i testicoli con l’accensione del gene Sry (sul cromosoma Y) o l’ovario grazie al gene Wnt4 (sul cromosoma 1). Si intuisce chiaramente che un processo così altamente complesso possa alterarsi e produrre uno spettro di caratteristiche sessuali (intersessualità) che trascende rigide categorizzazioni. L’intersessualità non va confusa con l’ermafroditismo, ove un solo tipo di individui è portatore delle gonadi dei due sessi e produce sia uova sia spermatozoi (sebbene a fasi alterne e quindi gli ermafroditi debbono comunque accoppiarsi).
Un aspetto assai curioso e paradossale della riproduzione sessuata è che il sesso maschile, in una panoramica biologica generale, si presenta qui e là in modo sporadico e occasionale. Pur tralasciando la visione sociobiologica che assegna un «costo» al mantenimento dei maschi (costituiscono la metà della popolazione, non partecipano in modo significativo all’allevamento dei piccoli, non li generano direttamente), il sesso maschile risulta dunque un sesso accessorio e non obbligatoriamente presente, non indispensabile nell’accadere della riproduzione sessuata, che può essere tranquillamente portata a termine dalle sole femmine grazie alla partenogenesi, una modalità di riproduzione sessuata uniparentale.
- Senza fecondazione.
- La partenogenesi è una forma di procreazione portata a termine dalle sile femmine: è possibile anche provocarla artificialmente, con stimolazioni chimiche dell’oocita così da indurlo a riassorbire un globulo polare (un falso spermatozoo) er ricostruire l’integrità del genoma
La partenogenesi può produrre solo femmine oppure solo maschi o entrambi i sessi e può essere un modo obbligatorio di riproduzione oppure può comparire accidentalmente ed essere del tutto facoltativa; le varie modalità sono in relazione ai contesti di variazione delle condizioni ambientali e negli insetti stecco (Fasmidi) e negli Imenotteri sociali (api, vespe...) viene studiata in dettaglio. È possibile anche indurre la partenogenesi, artificialmente, con stimolazioni chimiche dell’oocita così da indurlo a riassorbire un piccolo globulo polare (un falso spermatozoo!) e ricostituire l’integrità del genoma.
L’intervento delle biotecnologie in ambito riproduttivo risale all’abate Lazzaro Spallanzani e al 1786, con la prima fecondazione artificiale realizzata nel cane (il clamore fu mondiale) per giungere alla nascita del primo baby in provetta (Louise Brown, nel 1978 ad opera del Nobel sir Robert Edwards). Se la fecondazione artificiale è pratica accettata, con gli attuali circa 400 mila bimbi che ogni anno nascono in provetta, di fatto la sessualità umana si interroga dinanzi alle attuali possibilità e pratiche di selezione del sesso con risvolti drammatici in alcune società orientali (Cina, India) ove è abitudine diffusa l’aborto delle femmine, al punto di aver prodotto un eccesso di maschi nella società degli adulti.
Di grande interesse l’analisi di questi problemi a livello internazionale realizzata dalla banca mondiale in relazione alle cause che li influenzano (guerre, migrazioni, politiche riproduttive). In che termini le biotecnologie riproduttive possano ridisegnare l’umanità e rendere obsoleto il sesso, permettendo di eliminare patologie e scegliere caratteristiche fisiche e mentali del nuovo individuo (il «bambino disegnato») è un fatto ancora tutto da sviluppare, poiché, mentre avanzano le conoscenze scientifiche, resta da decidere quale possa essere il limite delle loro applicazioni. Oggi da una semplice biopsia di cellule della pelle si possono ottenere, in vitro, cellule staminali pluripotenti e differenziarle in spermatozoi e uova; la gran parte dei benestanti potrà avere figli geneticamente propri in un ampio spettro di possibilità, inclusa la uniparentalità, grazie alla produzione di gameti artificiali e alla produzione incrociata di gameti (uova da maschi e spermatozoi da femmine). Tralasciando ectogenesi, per lo sviluppo dell’individuo al di fuori dell’utero, e clonazione, ancora proibita in ambito umano in tutte le legislazioni, già oggi la multigenitorialità è assicurata dalle pratiche di gestazione surrogata (utero in affitto) e la omogenitorialità dagli scambi di gameti.
È tempo che su questo quasi inevitabile futuro i decisori politici (in fatto di eguaglianza), i giurisperiti (per gli aspetti di responsabilità) e i filosofi (in relazione al post-umanesimo) diano il via alla discussione per capire se abbiamo già imboccato l’autostrada che porta alla fine del sesso con un totale investimento sociale sulla cura corpo, sui problemi della senescenza e sul godimento ormonale grazie al sesso virtuale. Tanta parte della filosofia è ancora attardata a riflettere sulle conquiste della fisica e non a sviluppare nuove visioni e pensieri su chi è oggi un individuo, sul destino del singolo, sulla genitorialità come progetto affettivo di legame sociale consapevole ed elettivo, non sessual-riproduttivo (quindi ascrittivo, non voluto), sulla costituzione del nucleo familiare, sul significato delle storie, dei miti e della psicoanalisi circa i «legami di sangue».
- L’errore di Freud
- Si prova smarrimento dinnanzi alla meravigliosa capacità delle donne di trasmettere la vita. La teoria dell’invidia del pene non regge, semmai esiste un’invidia del parto
Tutte queste opportunità legate allo svolgersi della sessualità interrogano sulla obsolescenza del sesso «naturale» e sui limiti della riproduzione sessuata, sulle possibili pratiche odierne di sesso assicurate dalla realtà virtuale: la sezione della mostra Human+. Il futuro della nostra specie (chiusa a Roma il 1º luglio al Palazzo delle esposizioni) dedicata a questo tema impressionava coloro che (come lo scrivente) ancora sono amanti di inviti e corteggiamenti. La psicologia evolutiva potrebbe aiutare a dipanare lo smarrimento e lo stupore che i maschi provano dinnanzi alla meravigliosa capacità femminile di generare, a capire la genesi dei meccanismi di costrizione del fisico femminile messi in atto storicamente dai maschi per controllare quel corpo generante: e se Sigmund Freud avesse preso una cantonata con la storia dell’invidia del pene da parte femminile? E se fosse invidia del maschio della capacità riproduttiva delle femmine? Altri aspetti, forse meno impegnativi, attendono di essere chiariti: esiste una base chimica per l’attrazione sessuale? La bellezza è davvero negli occhi di chi guarda o nelle ghiandole sudoripare delle femmine? Sono soprattutto le femmine selettive nella scelta sessuale?
La risposta a quest’ultima domanda è la più facile: sì, in tutte le specie a fecondazione interna, dalle mosche all’uomo, la femmina è ben più discriminativa dei maschi nella scelta del partner sessuale. Ne conseguono alcuni avvertimenti, soprattutto per i maschi più giovani: i fiori non si mandano mai prima, ma solo dopo aver vinto la mitica «battaglia dei sessi». Con alcuni corollari: se la corteggiata è una biologa fate attenzione, i fiori sono organi genitali. State regalando ovari e testicoli... prudenza!
Il «testo sacro»
De Beauvoir spezzò le catene delle donne
di Cristina Taglietti (Corriere della Sera, La Lettura, 05.08.2018)
Nel 2019 saranno passati 70 anni dalla pubblicazione de Il secondo sesso di Simone De Beauvoir (in basso). Il testo della scrittrice di cui quest’anno ricorrono i 110 anni dalla nascita è una poderosa riflessione spesso ridotta allo slogan «Donna non si nasce, lo si diventa» perché - scrive Simone de Beauvoir - «nessun destino biologico, psichico, economico definisce l’aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell’uomo; è l’insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna».
 Testo sacro del femminismo che un editto Vaticano nel 1956 mise nell’indice dei libri proibiti (in Italia lo pubblicò il Saggiatore nel 1961), Il secondo sesso è una riflessione filosofica che, a partire dalla dialettica hegeliana, applica l’esistenzialismo di Sartre ai temi dell’emancipazione femminile, sottraendo la donna a un destino biologico che la esclude dalla storia, ma anche all’interpretazione fallocentrica di Freud e a quella del materialismo storico che pone la categoria economica al di sopra di tutte le altre.
Testo sacro del femminismo che un editto Vaticano nel 1956 mise nell’indice dei libri proibiti (in Italia lo pubblicò il Saggiatore nel 1961), Il secondo sesso è una riflessione filosofica che, a partire dalla dialettica hegeliana, applica l’esistenzialismo di Sartre ai temi dell’emancipazione femminile, sottraendo la donna a un destino biologico che la esclude dalla storia, ma anche all’interpretazione fallocentrica di Freud e a quella del materialismo storico che pone la categoria economica al di sopra di tutte le altre.Il secondo sesso, libro dal forte impianto filosofico, letto da migliaia di donne, passa in rassegna i ruoli attribuiti dal pensiero maschile alla donna mettendoli in relazione con i miti ancestrali, i costumi, i tabù, la sessualità studiata in ogni fase della vita femminile, dall’infanzia all’iniziazione sessuale, dalla maturità alla vecchiaia.
Il settantesimo anniversario sarà ancora un’occasione di dibattito tra chi vorrebbe rinchiudere quel testo, insieme alla sua autrice, nel recinto dell’inattualità e chi ritiene che sia stato ingiustamente messo da parte. Di certo Il secondo sesso fu un libro rivoluzionario: oggi si può metterlo in discussione, non ignorarlo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
>COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud -- Le sfide di oggi. La tecnologia ha sconnesso persino il triangolo di Edipo (di Silvia Vegetti Finzi)8 febbraio 2018, di Federico La Sala
Psicologia
Dalla tradizione freudiana alle sfide di oggi, il saggio di Paola Marion (Donzelli)
La tecnologia ha sconnesso persino il triangolo di Edipo
di Silvia Vegetti Finzi (Corriere della Sera, 08.02.2018)
Nel secolo scorso due avvenimenti epocali hanno infranto il paradigma della procreazione umana: la sessualità si è resa autonoma dalla generazione e, successivamente, la procreazione si e disgiunta dalla sessualità. Si tratta di profonde infrazioni nella concezione che abbiamo di noi stessi, dei rapporti con gli altri, con la natura, la società, l’etica e la storia. Ma, come accade per i traumi più gravi, abbiamo preferito rimuoverli o minimizzarli considerandole come forme di liberazione o interventi terapeutici. Solo in un secondo tempo, nell’ après coup che separa il trauma dalla sua elaborazione, è iniziato quel lento, doloroso processo di consapevolezza che porta a valutare le conseguenze reali e fantastiche, oggettive e soggettive di quanto è accaduto fuori e dentro di noi, come si ripromette il saggio della psicoanalista Paola Marion, Il disagio del desiderio, pubblicato da Donzelli.
Si tratta di un libro tanto opportuno quanto esauriente, rivolto non solo agli addetti ai lavori ma a tutti, perché nessuno può considerarsi indifferente rispetto ai quesiti che questa epoca ci pone.
Invitando il lettore ad affrontare un ambito così mobile e complesso, Paola Marion fornisce, nella prima parte del libro, le competenze storiche e teoriche necessarie per seguirla in un’esplorazione psicoanalitica appassionante e innovativa. Poiché le biotecnologie procedono espellendo il sesso dalla procreazione, la sua ricerca prende le mosse proprio dalla sessualità che la psicoanalisi aveva posto al centro della vita biologica e psichica.
Integrando la teoria freudiana, che privilegia la pulsione, con quella post-freudiana, che sottolinea gli aspetti relazionali della sessualità, l’autrice appronta un dispositivo teorico e clinico particolarmente idoneo a cogliere la complessità dei mutamenti in atto. Primo tra i quali la disintegrazione del triangolo edipico (formato da padre, madre, figlio), gravato, come effetto delle biotecnologie, da un eccesso di protagonisti. Nella gravidanza indotta con dono di gameti e condotta per conto terzi, ad esempio, le madri possono essere tre: genetica, portante, committente.
La «vertigine tecnologica» tende ad annullare i limiti e le differenze tra le generazioni, i sessi e le posizioni. È possibile generare da soli, con partner dello stesso sesso, dopo l’età feconda, post mortem e così via. Ma queste soluzioni impreviste pongono richieste psicologiche ed etiche sempre più impegnative. Il comprensibile desiderio di prolungare la propria vita si può trasformare in un bisogno necessario e insopprimibile che conduce a una pericolosa coazione a ripetere.
L’autrice conclude la sua discesa verso le profondità della psiche con un appello alla responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
Lo stesso che, in una magistrale introduzione, esprime Giuliano Amato, preoccupato che uno sviluppo illimitato delle nostre potenzialità trasformative possa «creare intorno a noi un contesto nel quale non siamo più in grado di riconoscerci». Dietro le neutrali finalità terapeutiche della fecondazione medicalmente indotta si cela un ventaglio di desideri e di possibilità che minacciano, tra l’altro, l’interesse prioritario del nascituro.
Ma, prima di affidare al legislatore il compito di dirimere una materia così intricata e sfuggente, Amato chiede a tutte le componenti della società di interrogarsi e di confrontarsi in una dimensione etica perché «è solo l’etica che può entrare nelle coscienze e qui dettare, quando serve, il comando giusto».
-
>L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". - Chiamatela pure “teologia del sesso”: Compendio della teologia del corpo di Giovanni Paolo II (Yves Semen).14 novembre 2017, di Federico La Sala
Il filosofo Semen.
Tutta la verità sull’amore secondo Wojtyla
Il filosofo francese Yves Semen spiega la teologia di Giovanni Paolo II su sessualità e matrimonio: «Le sue catechesi sono armi della luce per contrastare oggi l’ideologia del gender»
di Antonio Giuliano (Avvemire, martedì 7 novembre 2017)
Chiamatela pure “teologia del sesso”. Nessuna reticenza, nessun imbarazzo. L’ha definita proprio così il suo autore, un papa, un santo della Chiesa. La “scandalosa” Teologia del corpo di san Giovanni Paolo II è un tesoro prezioso che pur affermando verità scomode non ha alcuna soggezione nei confronti della cultura dominante. Sono ben 129 discorsi sull’amore umano che il pontefice polacco pronunciò nelle sue udienze del mercoledì dal 1979 al 1984. Una raccolta che spiazza ancora oggi come testimonia da anni un laico francese, il filosofo Yves Semen, presidente- fondatore dell’Istituto di Teologia del corpo a Lione e professore presso la Libera Facoltà di Filosofia a Parigi.
Appassionato e competente divulgatore delle lezioni di Karol Wojtyla, Semen ha curato ora un nuovo Compendio della teologia del corpo di Giovanni Paolo II (Ares, pagine 216, euro 15). Oltre a rivedere la traduzione dei testi, lo studioso ha tenuto conto del manoscritti originali di queste catechesi redatte in polacco ben prima dell’elezione al soglio pontificio. Non è dunque casuale che Wojtyla più che la sua firma personale abbia voluto mettere quella da pontefice: «Si tratta del più vasto insegnamento mai proposto da un Papa su uno stesso argomento ed è significativo che abbia voluto presentarlo all’inizio del suo pontificato come a farne il pilastro di tutto il suo magistero». A corredo del compendio, Semen inserisce anche un utile glossario che riprende parole e concetti dirompenti, come “godimento”: «Nella Teologia del corpo il piacere legato al godimento è talvolta considerato in senso positivo in quanto piacere erotico nobile conforme al disegno divino sulla sessualità umana, talvolta in senso negativo quando è ricercato per sé stesso e mediante l’uso e la strumentalizzazione dell’altra persona a servizio di un piacere egocentrico». Un manuale controcorrente che, smentendo i soliti pregiudizi, esalta il corpo e la sessualità umana, mettendo in luce un desiderio di infinito che nessun “consumo” o possesso può appagare.
George Weigel, biografo di Giovanni Paolo II, l’ha definita «una sorta di bomba ad orologeria teologica». Ma i cattolici hanno compreso la Teologia del corpo?
«Solo da qualche anno sono stati pubblicati libri di buona divulgazione e iniziative per farla conoscere. Adesso si stanno per diffondere anche all’estero i Forum Wahou (www.forumwahou. fr) che dal 2015 in Francia hanno già radunato migliaia di persone: nel corso di un week end la gente scopre la grandezza e la bellezza dell’amore nel piano divino. L’Istituto che presiedo dal 2014 ha già formato più di 120 persone in grado di insegnare questa teologia. Formiamo anche i genitori perché a loro spetta la responsabilità primaria dell’educazione sessuale dei ragazzi. Il successo che stiamo riscontrando, è il segno che qualcosa di nuovo sta nascendo nella Chiesa».
Difensore energico dell’Humanae vitae, Giovanni Paolo II ha detto che: «La prima, ed in certo senso la più grave difficoltà è che anche nella comunità cristiana si sono sentite e si sentono voci che mettono in dubbio la verità stessa dell’insegnamento della Chiesa». Crede che un giorno la Chiesa possa rivedere il magistero di Wojtyla?
«Non è la Chiesa che può cambiare la Teologia del Corpo ma è la Teologia del corpo che può cambiare la Chiesa! Bisogna lavorare alla sua larga e fedele diffusione perché la visione della persona e dell’amore che promuove è liberatrice e permette di comprendere la dimensione “profetica e sempre attuale” dell’ Humanae vitae, per usare le parole di Benedetto XVI».
La società oggi dà al “corpo” un significato diverso da quello di Giovanni Paolo II che risale al principio, all’uomo creato a immagine di Dio.
«La cultura contemporanea ha reso il corpo un materiale privo di senso che può essere manipolato in tanti modi. Fino alle affermazioni deliranti del transumanesimo. Per Wojtyla invece il corpo è stato fatto per realizzarsi nel dono di sé e per rivelare il divino: “Il corpo, e soltanto esso, è capace di rendere visibile ciò che è invisibile: lo spirituale e il divino. Esso è stato creato per trasferire nella realtà visibile del mondo il mistero nascosto dall’eternità in Dio, e così esserne segno”».
La Teologia del corpo insiste tanto sulla persona creata maschio e femmina. Un ammonimento profetico contro la diffusione del gender che oggi vuole annullare le differenze sessuali.
«Sì è una teologia della mascolinità e della femminilità che dimostra come il sesso non sia un semplice attributo, ma un dato fondamentale antropologico che qualifica la persona. È in questo senso che il cardinale Ouellet disse che la teologia di Giovanni Paolo II è l’unico vero “antidoto” all’ideologia del gender. Le catechesi di Wojtyla sono armi della luce per affrontare la corruzione antropologica del gender».
Niente contraccettivi, niente rapporti prematrimoniali... Spesso la Chiesa è stata accusata di dire sempre di “no”.
«Ma la Chiesa dice “sì”. Sì alla verità dell’amore come dono di sé. Sì alla verità del corpo fatto per essere donato. Sì alla nobiltà e alla dignità della sessualità. Sì alla grandezza del dono della vita. Sì al matrimonio come vocazione autentica alla santità. Sì al celibato offerto come annuncio profetico del Regno».
Perché i metodi naturali, che non sono contraccettivi, sono ancora poco conosciuti?
«Non se ne parla abbastanza, sebbene essi permettono di esercitare una maternità e una paternità realmente responsabili nel rispetto dell’integrità del corpo della donna. Molti però lo stanno comprendendo: in Francia, in dieci anni, la percentuale di donne che utilizzano la pillola è scesa dal 46% al 33%».
La teologia del corpo riprende un passo del Discorso della Montagna che Wojtyla stesso ammoniva dal considerarlo solo un divieto, ma come chiave per uno sguardo puro che ci permetterà un giorno di godere in anima e corpo il “sommo piacere” della visione di Dio.
«Quando Gesù dice: “Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” rivolge un appello al cuore dell’uomo, a non farsi dominare dalla concupiscenza che mira ad usare l’altro e a considerarlo oggetto di godimento e possesso. Ecco perché Giovanni Paolo II non ha esitato a affermare che uno può essere adultero anche con la propria moglie se la considera come oggetto per appagare il proprio istinto sessuale. Quando gli è stato obiettato che era “troppo esigente”, ha semplicemente risposto: “Non sono io che sono esigente, è Cristo”».
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla, Marietti 1968/1978).
UOMINI E DONNE. LA NUOVA ALLEANZA di "Maria" e di "Giuseppe"!!! AL DI LA’ DELL’ "EDIPO", L’ "AMORE CONOSCITIVO". SULL’USCITA DALLO STATO DI MINORITA’, OGGI.
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
Federico La Sala
-
>L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". - LINGUA, PAROLA, E SESSUALITA’: PENSARE BENE PRIMA DI APRIRE LA BOCCA.1 ottobre 2017, di Federico La Sala
PER NON DIVENTARE UN "BOCCALONE", UNA "BOCCALONE", PENSARE BENE PRIMA DI APRIRE LA BOCCA... *
- Nota a margine dell’art. di Armando Polito, "Fessa: il dialetto salentino e il sesso" (Fondazione terra d’Otranto, 20.09.17)
Dalle masse di gas sulfurei che dalla "fessa" della Madre Terra salivano in superficie nella zona di Delfi (o se si vuole, di Cuma), nell’antica Grecia (nell’antica Campania), la Sibilla sapeva saggiamente (e ambiguamente) portare alla luce una figura (e una risposta) piena di significato da interpretare, da decifrare.
Se è vero, come è vero, che "nessuno di noi avrebbe potuto aprir bocca a questo mondo" e (mangiare e) dire qualcosa, se non ci fosse stato (e non ci fosse) "L’origine du monde" ( si cfr. "DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?"), il problema è proprio quello di capire che cosa vogliamo significare con l’espressione "quiddhu è nnu FESSA" (quello è una "bocca aperta"), "queddha è nna FESSA" (quella è una "bocca aperta") - e saper distinguere tra (il cibo sano e) le notizie vere e (il cibo "adulterato" e ) le notizie false ("fake news"), tra ev-angelo ("buona-notizia") e vangelo (van-gelo, che "cattiva-notizia"!), tra "dio" (amore, "charitas") e "mammona" (caro-prezzo, "caritas"!).
- SUL TEMA, PER ULTERIORI RIFLESSIONI, UN INVITO:
ATTENZIONE A QUESTE TRE PAROLE: “FAQ”, “FAKE”, “FUCK”, ORMAI DI USO COMUNE.
Facendo interagire la loro scrittura, la loro pronuncia, e i loro significati, viene alla luce un prezioso invito ad “avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza” (Kant) e a porre “domande su tutto!” (Confucio).
Alle "domande poste frequentemente" (“Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ - pronuncia, in inglese: “F”, “A”, “Q”), CHI risponde (?!), se SA, dà le risposte che sa (fa il suo dovere, e si ferma!), ma, se NON sa e pretende di sapere (come spesso accade - in un abuso di autorità permanente e, ovviamente, di non rispetto di CHI pone le domande), dà solo risposte “false e bugiarde” (FAKE - parola inglese, pronuncia “feik”, che sta a significare "falso", "contraffatto", "alterato". Nel gergo di internet, un fake è un utente che falsifica in modo significativo la propria identità), che cercano solo di ingannare, fregare, fottere in tutti i sensi ( FUCK - parola inglese, pronuncia “fak” - "fach", " faq!": come interiezione equivale all’italiano - cazzo!, come sostantivo: scopata, come verbo: scopare, fottere!).
Non è meglio sapere CHI siamo e cercare di uscire dalla caverna - con Polifemo, Ulisse e compagni (come con il Minotauro, Teseo e Arianna) - senza "fottere" Nessuno e senza mandare Nessuno a farsi “fottere”! O no? La tragedia è finita da tempo! Dante l’ha detto da tempo. O no?!
- L’ANTRO DELLA SIBILLA E L’AVERNO, LA "BOCCA" DELL’INFERNO ...
Avendo letto l’intervento di Sergio Notario e molto apprezzato il suo riferimento all’eufemismo piemontese ("Bòja Fàuss"), colgo l’occasione per ricordare che anche in Piemonte c’è la presenza delle Sibille (di cui qui - e altrove si è parlato) e segnalo a Lui e alla redazione della Fondazione il lavoro di Marco Piccat, "La raffigurazione delle Sibille nel Saluzzese e nelle zone circostanti".
Federico La Sala
Sul tema, nel sito, si cfr.:
KANT E SAN PAOLO. -- "FAKE" E "WAKE": LA BACCHETTA DELLA VITA. UNA LEZIONE DI JAMES JOYCE.
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). - IL CERVELLO IN AMORE. la Francesca di Dante il simbolo tragico della forza sprigionata dalle nostre passioni (di M. Ammaniti).29 settembre 2017, di Federico La Sala
BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA E TEOLOGIA.... *
L’amore è davvero cieco così il cervello si spegne e la scienza non lo sa spiegare
È la Francesca di Dante il simbolo tragico della forza sprigionata dalle nostre passioni
di Massimo Ammaniti (la Repubblica, 29.09.2017)
Un saggio di Grazia Attili indaga le basi biologiche del sentimento più grande e misterioso. Studi ed esperimenti confermano le intuizioni dei poeti, ma non rispondono alla domanda cruciale: come accade? Consapevole di quanto l’amore plasmasse la vita quotidiana nel mondo occidentale, ma anche in altre culture, Sigmund Freud scrisse parole illuminanti in un suo saggio del 1915: «Indubbiamente l’amore fra i sessi è una delle cose più importanti della vita, e l’unione del soddisfacimento spirituale e fisico che si attinge nel godimento d’amore ne rappresenta precisamente uno dei vertici. Soltanto nella scienza si ha ritegno ad ammetterlo ».
È passato da allora più di un secolo ma la complessità dell’esperienza amorosa è ancora oggi difficile da decodificare in campo scientifico perché vi è un ritegno, più che comprensibile, ad entrare nell’intimità della vita individuale, ma anche a tradurre questo sentimento in un linguaggio troppo distante da quello che usano gli innamorati.
Ma l’amore non è solo quello del batticuore e del desiderio che si prova per la persona che si ama, anche il corpo e lo stesso cervello ne sono coinvolti, come viene raccontato nel libro Il cervello in amore (il Mulino, pag. 230) dalla psicologa e docente universitaria Grazia Attili.
Già in altri suoi libri Attili aveva esplorato l’esperienza amorosa in una chiave evoluzionistica mettendo in luce come l’amore dei genitori per i figli, ma anche fra partner sentimentali comporti l’attivazione di circuiti cerebrali che sostengono la relazione affettiva favorendo la propagazione delle specificità genetiche alle generazioni successive e la stessa sopravvivenza della specie umana. In questo nuovo libro esplora ulteriormente le basi biologiche dell’amore sentimentale con un’attenta revisione delle nuove scoperte nel campo dei neurormoni. Quando si pensa alla persona che si ama e ancora di più quando si è con lei si verifica nel cervello una tempesta ormonale, di cui la dopamina è la grande protagonista. Nel viso e negli occhi della persona innamorata si coglie il piacere che sta vivendo, ma che a volte suscita pensieri così insistenti da divenire travolgenti, quasi ossessivi.
Non può non ritornare in mente la tragica figura di Francesca da Rimini, che Dante incontra all’Inferno e che racconta il turbine da cui è stata travolta: «Amor che a’nullo amato amar perdona mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona». Ma il confine fra passione e innamoramento e delirio amoroso a volte può sfumare. Come per esempio nel film di François Truffaut Adele H., in cui la protagonista, la secondogenita di Victor Hugo, si innamora di un ufficiale inglese e lo insegue in Canada nonostante il divieto paterno, fino a perdere il senno.
Ma che cos’è che fa scivolare l’amore in un’ossessione che fa perdere il senso della realtà? A questo interrogativo cerca di rispondere il libro di Grazia Attili: nell’amore sentimentale, come hanno messo in luce le ricerche che hanno studiato il cervello delle persone innamorate utilizzando la risonanza magnetica, si verificano grandi cambiamenti. Le aree connesse alla sensazione di piacere e di euforia si attivano fortemente, ad esempio quando si guarda la foto della persona che si ama, mentre si disattivano le aree cerebrali connesse al riconoscimento delle emozioni negative e alla cognizione sociale. In altre parole gli studi confermano il detto “l’amore è cieco” proprio perché si verifica una specie di cecità mentale che compromette il riconoscimento delle qualità meno attraenti della persona che si ama.
È più che mai vero quello che scrisse Freud: artisti, poeti e scrittori hanno saputo raccontare le esperienze umane anticipando anche di molti secoli quello che la scienza ha cercato di scoprire molto dopo. Ma nel caso dell’amore la scienza sta compiendo i primi passi e ancora oggi non è in grado di spiegarne l’enigma: perché ci innamoriamo, perché succede proprio in un determinato momento della vita, perché siamo attratti da quella persona, ma anche perché può finire.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Antropologia e teologia....
 "EROS", "AGAPE", "CHARITAS". L’ALLEANZA DI FUOCO: L’ANTICO TESTAMENTO E IL SESSO.
"EROS", "AGAPE", "CHARITAS". L’ALLEANZA DI FUOCO: L’ANTICO TESTAMENTO E IL SESSO.SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA".
 La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini")
La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini")Federico La Sala
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). -- SANT’AGOSTINO, LE SIBILLE, MICHELANGELO, E PAPA FRANCESCO.6 settembre 2017, di Federico La Sala
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. AMORE, RESPONSABILITÀ, E SESSUALITÀ... *
IN MEMORIA DI SANT’AGOSTINO (E IN ONORE DEL LAVORO DELLA FONDAZIONE "TERRA D’OTRANTO").
- Considerazioni a margine dell’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò (elevata a Basilica minore nel 1980, da papa Giovanni Paolo II, durante l’episcopato di Antonio Rosario Mennonna)
- "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS"), DALLA GRAZIA ("gr.: "XAPIS", lat.: "CHARIS") DI DIO AMORE ("CHARITAS"), NON DI DIO MAMMONA ("CARITAS") ...
Lode a Marcello Gaballo per questa bellissima e preziosa nota su "L’affresco di sant’Agostino nella cattedrale di Nardò" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/08/28/laffresco-di-santagostino-nella-cattedrale-di-nardo/#_ftn1) - e il lavoro di De Giorgi: la sua trascrizione della scritta sul cartiglio (ormai scomparsa) "iuste/et cas/te viv/ere et/ xarita(te)" - contrariamente alla protervia che ha portato allo "sproposito maiuscolo" e alla brutta abitudine instauratasi almeno a partire da Ludovico A, Muratori di una "caritas" latina! - conserva ancora la memoria del legame della tradizione dell’evangelo (non: "vangelo"!) con la lingua greca ("charis", "charites"... "charitas").
FILOLOGIA E FILOSOFIA/TEOLOGIA. Giambattista Vico ("De constantia iurisprudentis", 1721) giustamente e correttamente e onestamente così pensava e scriveva: "Solo la carità cristiana insegna la prassi del Bene metafisico"("Boni metaphysici praxim una charitas christiana docet"). Sapeva che Gesù ("Christo") aveva cacciato i mercanti FUORI dal tempio, e non aveva autorizzato i sacerdoti a vendere a "caro-prezzo" (lat.: "caritas") la "grazia" (gr.: "Xapis", lat.: "Charis") di Dio (lat.: "Charitas")!!! Due padroni: Dio "Charitas" o dio "Caritas"?!, Dio Amore o dio Mammona?! In questo bivio ("X") ancora siamo, oggi - e ancora non sappiamo sciogliere l’incognita (""x")!
Sul tema, mi sia consentito, si cfr. la seguente nota:
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST").Una storia di lunga durata...
 MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori.
MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO. Un breve testo dalla "Prefazione ai lettori" del "Trattato sulla carità cristiana" di Ludovico A. Muratori.
 MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!
MURATORI E RATZINGER. "DEUS CARITAS EST": FINE DEL CRISTIANESIMO. TOLTA AL PESCE ("I.CH.TH.U.S.") L’ ACCA ("H"), IL COLPO ("ICTUS") E’ DEFINITIVO!!!- SANT’AGOSTINO E L’ECUMENISMO UMANISTICO-RINASCIMENTALE ...
ALLA LUCE DEL lavoro di ARMANDO POLITO e MARCELLO GABALLO SU "SANTA MARIA DI CASOLE E LE SUE SIBILLE" (cfr.: http://www.fondazioneterradotranto.it/2017/03/24/santa-maria-casole-copertino-le-sue-sibille/), all’affresco di Sant’Agostino (databile forse più precisamente nella seconda metà del sec. XV), mi augurerei una rinnovata e maggiore attenzione non solo a tutta la figura dell’affresco ma, in particolare, all’immagine del bastone-pastorale con i suoi DUE SERPENTI. Essa richiama, con chiarezza, non solo la figura di Mosè ma anche e soprattutto la figura di ERMETE TRISMEGISTO con il suo caducèo (e, con essa, della Sibilla Pizia, di Apollo, e di Delfi).
L’affresco di Sant’Agostino nella cattedrale di Nardò, a mio parere, è un luminosissimo segno "manifesto" della diffusione della concezione umanistico-rinascimentale nella Terra d’Otranto e, insieme, del grande lavoro che porterà infine la Chiesa e Michelangelo a celebrare le Sibille (5) insieme ai Profeti (7) nella Volta della Cappella Sistina: ovvero, dice chiaramente del ruolo "giocato" dalla figura di Agostino nella costruzione dell’ orizzonte ecumenico umanistico e rinascimentale.
Sul tema, si cfr., unitamente al già citato lavoro di A. Polito e M. Gaballo, la mia nota sul
 RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.
RINASCIMENTO ITALIANO, OGGI: LA SCOPERTA DI UNA CAPPELLA SISTINA CON 12 SIBILLE.- AGOSTINO, LE SIBILLE, LA LETTERA DELL’ALFABETO GRECO "X", E IL "PESCE"!
NEL LIBRO DI Marcello Gaballo e Armando Polito, "Santa Maria di Casole a Copertino (Lecce) ed altri repertori di Sibille" (Fondazione Terra d’Otranto 2017), è ripreso l’intero capitolo 23 del Libro XVIII del "De civitate Dei" (per eventuali approfondimenti, si cfr. sant’Agostino, "La città di Dio": http://www.augustinus.it/italiano/cdd/index2.htm)
- ... IL PASTORALE DI SANT’AGOSTINO CON *UN SOLO SERPENTE* E IL PASTORALE DI BARTOLOMEO I CON *DUE SERPENTI*
PER MEGLIO CAPIRE il filo che lega l’ecumenismo umanistico-rinascimentale (Niccolò Cusano, "La pace della fede", 1453) con l’ecumenismo del presente attuale (nuovo Concilio di Nicea, 2025) e, insieme, la portata simbolica del particolare PASTORALE di sant’Agostino nell’affresco della Cattedrale di Nardò, mi sia consentito rinviare all’immagine del pastorale del Patriarca di Costantinopoli e all’intervista relativa all’ INCONTRO DI PAPA FRANCESCO E BARTOLOMEO I A ISTANBUL (cfr.: http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=5791).
Federico La Sala
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger) !!! Fonti cattoliche a confronto...
MA NON E’ POSSIBILE FARE CHIAREZZA? SI TRATTA DELLA PAROLA FONDANTE E DISTINTIVA DELLA FEDE CRISTIANA!!! DIO E’ AMORE ("Charitas") O MAMMONA ("Caritas")?!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
GUARIRE LA NOSTRA TERRA. PER UNA NUOVA ERMENEUTICA E UN NUOVO PRINCIPIO DI CARITÀ ... *
Chi ha paura di Jorge Mario Bergoglio
di Riccardo Cristiano (Articolo 21, 1 settembre 2017)
Le anticipazioni di un libro intervista che contiene la trascrizione di dodici dialoghi con il sociologo Dominique Wolton (titolo: “Politique et sociétéˮ, edizioni L’Observatoire) riferiscono che Papa Francesco ha detto di essere andato per alcuni mesi da una psicanalista. In queste ore non sono pochi i giornali che riferiscono le condanne preconciliari della psicanalisi. Forse è il bisogno di trovare qualcosa di “inaudito” in quanto ha detto Bergoglio. Eppure a partire da Pio XII, passando attraverso gli apprezzamenti positivi del Vaticano II nei confronti della psicologia del profondo, si è giunti al riconoscimento di Paolo VI - nella Sacerdotalis coelibatus (1967) - della possibile necessità di un aiuto psicanalitico per i sacerdoti in difficoltà. Questa evoluzione è stata facilitata da una schiera di psicoanalisti dichiaratamente cattolici.
 C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”
C’è un saggio, ad esempio, del professor Bresciani sul debito della Chiesa verso la psicoanalisi e Sigmund Freud nel quale possiamo leggere: “Freud, nonostante proponesse una vera e propria antropologia, militava decisamente per l’alleanza terapeutica con il malato; mettendosi a livello del sofferente si prestava ad un ascolto profondo e ad una partecipazione alla sua vita emotiva. [Un studio del professor] Ancona vede qui un Freud vicino alla pedagogia cristiana più di quanto egli stesso pensasse. Il suo ideale di uomo come colui che è capace di «amare e lavorare», la sua posizione sulla possibilità di sublimazione della sessualità, la conclusione della sua opera di ricerca con l’affermazione che la coscienza «resta la sola luce che nelle tenebre della vita psichica ci illumina e ci guida», erano posizioni passibili di sviluppi meno conflittuali.”Passa in ombra così l’usuale coraggio di Jorge Mario Bergoglio, che anche in questa “confessione” di essere andato per sei mesi da una psicanalista ebrea, che lo ha molto aiutato, sembra stare in questo: anch’io sono un uomo, e tutti gli uomini hanno bisogno di aiuto. Lo dice lui, noi lo diciamo molto più difficilmente. -L’epoca buia dello scontro tra religione e psicanalisi è andata in soffitta da tempo. Ma siccome siamo in un’epoca che si fa nuovamente buia, intrisa di odio per l’altro, di pregiudizio, fondamentalmente di paura, sono moltissime le affermazioni fatte da Papa Francesco che colpiscono. E che per leggere bene dovremmo avere il suo stesso coraggio, cioè quello di toglierci il paraocchi e leggere per quel che sono. Un invito ad andare oltre gli steccati di oggi, oltre quei confini che ci chiudono in ghetti tanti asfittici quanto rassicuranti.
Leggiamo alcuni altri passaggi fondamentali delle sue riflessioni, partendo dall’ Africa e i migranti.
 “[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”
“[...]L’Europa ha sfruttato l’Africa ... non so se possiamo dirlo! Ma alcune colonizzazioni europee... sì, hanno sfruttato. Ho letto che un capo di stato africano appena eletto come primo atto di governo ha presentato al Parlamento una legge per il rimboschimento del suo paese - ed è stata promulgata. Le potenze economiche del mondo avevano tagliato tutti gli alberi. Rimboschire. La terra è secca per essere stata sfruttata e non c’è più lavoro. La prima cosa da fare, come ho detto alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa in tutto il mondo, è trovare qui fonti per creare di posti di lavoro, investire. È vero che l’Europa deve investire anche a casa propria. Anche qui esiste un problema di disoccupazione. L’altro motivo per la migrazione è la guerra. Possiamo investire, le persone avranno una fonte di lavoro e non dovranno partire, ma se c’è guerra, dovranno ancora fuggire. Ora chi fa la guerra? Chi dà le armi? Noi.”Per un uomo come Papa Francesco generalizzare è sempre difficile, ma se proprio deve farlo non generalizza sulle “razze”, ma sulle azioni degli Stati e le loro conseguenze. Per condannare? No, per esortare a invertire tendenza, a non cercare scorciatoie, a non vedere nelle vittime degli esseri inferiori, ma delle vittime.
Passiamo a Laicità e religioni. “Lo stato laico è una cosa sana. C’è una laicità sana. [...] Credo che la Francia - questo è il mio parere personale, non quello ufficiale della Chiesa - dovrebbe “elevareˮ un po’ il livello della laicità, nel senso che deve dire che anche le religioni sono parte della cultura. Come esprimerlo in modo laico? Attraverso l’apertura alla trascendenza. Ognuno può trovare la sua forma di apertura.” Come si vede, come si legge, qui non c’è una pretesa di superiorità del credente, ma la rivendicazione della spiritualità dell’uomo, del suo bisogno “naturale” di trascendenza.
Quarto punto, l’Europa. “Non vedo più Schumann, non vedo più Adenauer... L’Europa, in questo momento, ha paura. Chiude, chiude, chiude... L’Europa ha una storia di integrazione culturale, multiculturale come dice lei, molto forte. I Longobardi, i nostri Longobardi oggi, sono barbari che sono arrivati molto tempo fa... E poi tutto si fonde e abbiamo la nostra cultura. Ma qual è la cultura europea? Come definirei oggi la cultura europea? Sì, ha importanti radici cristiane, è vero. Ma non è sufficiente per definirla. Ci sono tutte le nostre capacità. Queste capacità per integrarsi, per ricevere gli altri. C’è anche la lingua nella cultura. Nella nostra lingua spagnola, il 40% delle parole è arabo. Perché? Perché erano lì per sette secoli. E hanno lasciato il segno... Credo che l’Europa abbia delle radici cristiane, ma non sono le uniche. Ci sono altre che non possono essere negati. Tuttavia, credo che sia stato un errore non citare le “radici cristianeˮ nel documento dell’Unione europea sulla prima Costituzione, e questo è stato anche commesso dai governi. Era un errore non vedere la realtà. Questo non significa che l’Europa debba essere interamente cristiana. Ma è un patrimonio, un patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto.”
C’è qualcosa di enorme in queste parole, in questa capacità di ricordarci che quel che è stato vero ieri è vero anche oggi. Non esiste purezza, esiste contaminazione. La purezza è delle pietre, la contaminazione è della vita. Anche se non vogliamo più capirlo qualcuno, per fortuna, ce lo ripete.
L’insistenza sulla morale «sotto la cintura». “Ma noi cattolici, come insegniamo la moralità? Non puoi insegnarla con precetti del tipo: “Non puoi farlo, devi farlo, devi, non devi, puoi, non puoiˮ. La morale è una conseguenza dell’incontro con Gesù Cristo. È una conseguenza della fede, per noi cattolici. E per altri, la moralità è una conseguenza dell’incontro con un ideale, o con Dio, o con se stessi, ma con la parte migliore di se stessi. La morale è sempre una conseguenza... C’è un grande pericolo per i predicatori, quello di cadere nella mediocrità. Condannare solo la morale - la prego di perdonare l’espressione - “sotto la cinturaˮ. Ma degli altri peccati, quali l’odio, l’invidia, l’orgoglio, la vanità, l’uccisione dell’altro, prendere la vita, non se ne parla. Entrare nella mafia, fare accordi clandestini...”
Il Vaticano, se posso dir così, è apparso a lungo strabico: l’etica vista dalla Città del Vaticano sembrava riguardare l’inizio e la fine della vita, la morale limitata alla sfera sessuale... Ora l’etica torna a riguardare tutta la vita, dal momento in cui si concepisce a quando si muore, passando però per tutti i momenti della nostra esistenza: da quando sfruttiamo a quando veniamo sfruttati, da quando siamo vittime a quando facciamo nostra vittima un altro. Poco?
Amoris laetitia e rigidità. “La tentazione è sempre quella dell’uniformità delle regole... Prenda ad esempio l’esortazione apostolica Amoris laetitia. Quando parlo di famiglie in difficoltà, dico: “Dobbiamo accogliere, accompagnare, discernere, integrare...ˮ e poi ciascuno vedrà le porte aperte. Quello che sta realmente accadendo è che le persone sentono dire la gente: “Non possono fare la comunione”, “Non possono farlo”: la tentazione della Chiesa è lì. Ma “noˮ, “noˮ e “noˮ!”
Papa Francesco parla di uniformità delle regole, si potrebbe dire che allora la sua Chiesa non si pensa un giudice eterno ed esterno alla storia. Poco?
«L’aborto rimane un peccato grave». “ L’estensione del potere di assolvere il peccato dell’aborto a tutti i sacerdoti, «attenzione, questo non significa banalizzare l’aborto. L’aborto è grave, è un peccato grave. È l’omicidio di un innocente. Ma se c’è peccato, è necessario facilitare il perdono.” Un papa non poteva fare un esempio più rilevante e drammatico per indicare la portata rivoluzionaria della misericordia. Che non è “cancellare il peccato”, ma rigenerare la vita del peccatore. La misericordia così appare la vera cultura alternativa all’odio e, quindi, al terrorismo.
Reciprocità con i musulmani. “Non accettano il principio della reciprocità. Alcuni paesi del Golfo sono aperti e ci aiutano a costruire chiese. Perché sono aperti? Perché hanno lavoratori filippini, cattolici, indiani... Il problema in Arabia Saudita è che è davvero una questione di mentalità. Con l’Islam, comunque, il dialogo sta andando bene, perché non so se lo sa, ma l’Imam di Al-Azhar è venuto a trovarmi. E ci sarà incontro: vado. Penso che farebbe bene a loro fare uno studio critico sul Corano, come abbiamo fatto con le nostre Scritture. Il metodo storico e critico di interpretazione li farà evolvere.”
E’ questo il punto per me più importante, più forte. Senza nessuna pretesa di superiorità, né religiosa né culturale, Bergoglio indica la strada della salvezza dell’islam, in una parola: ermeneutica. Non esita a far presente ai suoi interlocutori il punto decisivo, il punto “critico”, ma lo fa per il bene dell’islam, dei musulmani. E questo, francamente, è commovente.
*
SUL TEMA, BEL SITO, SI CFR.:
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
- OBBEDIENZA CIECA: TUTTI, PRETI, VESCOVI, E CARDINALI AGGIOGATI ALLA "PAROLA" DI PAPA RATZINGER ("DEUS CARITAS EST", 2006). Materiali per riflettere
EUROPA ED EVANGELO. LA ’CROCE’ DI CRISTO ("X" = lettera alfabeto greco) NON HA NIENTE A CHE FARE CON IL "CROCIFISSO" DELLA TRADIZIONE COSTANTINIANA E CATTOLICO-ROMANA.
Il cristianesimo non è un "cattolicismo": il ’cattolicesimo’ è morto.
 INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.
INDIETRO NON SI TORNA: GIOVANNI PAOLO II, L’ULTIMO PAPA. PER IL DIALOGO A TUTTI I LIVELLI: UT UNUM SINT.- Per una nuova antropologia e una nuova pedagogia - quella dell’Amore (Deus charitas est), non quella di "Mammasantissima" e di "Mammona" ("Deus caritas est") della Chiesa Cattolico-romana!!!
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). --- IL CANTICO DEI CANTICI. La verità sull’amore nascosta nel più erotico dei libri (di Silvia Ronchey)6 dicembre 2016, di Federico La Sala
- "Amore è più forte di Morte"(Ct., 8.6): Cantico dei cantici, traduzione e cura di Giovanni Garbini, Paideia, Brescia 1992
- SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota
- "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO -
Il Cantico dei cantici
La verità sull’amore nascosta nel più erotico dei libri
Il testo biblico che descrive il desiderio resta un codice segreto. Come dimostrano gli ultimi studi
- “È un enigma” scriveva già Sant’Agostino La sua sacralità andava di pari passo al suo mistero Nel III secolo perse l’originario connotato realistico e diventò allegoria dell’eros mistico
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 06.12.2016)
Di cosa parliamo quando parliamo del Cantico? Questa domanda non può avere risposta. «Il cantico è un enigma», scriveva Agostino (“Sermo” 46, 35). È un mistero nel senso tecnico della parola. L’iniziato non parlerà perché non potrà farlo (“mysterion” da “myein”, «tenere le labbra serrate»). Il profano parlerà, ma non saprà di che parla. «Perché chi sa non parla e chi parla non sa», secondo il detto di Lao Tse.
Ma alla fine del I secolo, quando si formò il canone della bibbia giudaica, il sapiente Rabbi Aqiba disse: «Il mondo intero non vale il giorno in cui il Cantico dei cantici è stato donato a Israele, perché tutte le Scritture sono sante, ma il Cantico dei cantici è il Santo dei santi». Già allora che cosa fosse il Cantico non lo si sapeva né voleva dire: la sua santità era direttamente proporzionale al suo mistero; anzi, era proprio la profondità abissale dei suoi enigmi a sprigionare quel vertice di santità.
«Petali di loto le labbra del mio amato /colano mirra. Il suo inguine è avorio / tempestato di zaffiri. / Favi colanti le tue labbra mia sposa / miele e latte sotto la tua lingua / come incenso del Libano / l’aroma del tuo grembo / giardino chiuso fonte sigillata. / Entri il mio amato nel suo giardino / succhi il suo frutto prodigioso. / Nel mio giardino entravo / mia sorella mia sposa / e la mirra e ogni essenza rapivo / e succhiavo il miele dal favo».
Poemetto di età post-esilica, forse patchwork di canti attinti al patrimonio della tradizione assiro-babilonese ed egizia oltre che ebraica, con echi greco- ellenistici nello stile di Teocrito, il Cantico è indubitabilmente un testo erotico, quasi pornografico.
Nella traduzione latina di Girolamo: Dilectus meus misit manum suam per foramen / et ventrem meus intremuit ad tactum eius. «Il mio amato infila la mano nel mio grembo/ le mie viscere fremono per lui. / Per aprirgli mi alzo /le mie mani colano mirra /dalle dita la mirra fluisce / sul chiavistello che impugno». Secondo la tradizione rabbinica, alcuni brani del Cantico venivano cantati nelle taverne. Si sdegnava Rabbi Aqiba: «Chi canta il Cantico nelle taverne o lo tratta come una canzone profana non avrà posto nel mondo futuro».
Levitò presto l’esegesi anagogica midrashica, gelosamente sacra, del Cantico come celebrazione dell’alleanza sponsale tra JH-WH e Israele, protratta poi nell’interpretazione cristiana che per secoli e secoli vi lesse la figura dell’amore di Cristo per la chiesa, non senza lasciare spazio a una congerie di altri sistemi allegorici minori, spesso iniziatici - astrologici, cabalistici, filosofico- sapienziali -, nella letteratura medievale, rinascimentale e moderna. Sulle ali della metafora della sposa-chiesa i versetti del Cantico si disseminarono nella fonosfera della liturgia, della musica, della letteratura, tramandole come mantra sempre meno dischiusi al senso. Più la torsione simbolica della teologia occidentale sottraeva loro il significato naturale - da Ambrogio a Gregorio Magno, da Guglielmo di Saint-Thierry a Bernardo di Clairvaux, da Francesco di Sales a Bossuet - più le sillabe e le immagini spandevano il loro mistero elementare.
Nigra sum sed formosa.
Da Monteverdi a Giovanni della Croce, da Maupassant a Moreau duemila anni di omissioni hanno addensato connessioni così colossali nel Cantico da renderlo simile all’Aleph di Borges: un punto dello spazio letterario che contiene una pluralità infinita di altri punti. Già il Talmud ammoniva, comunque, a non sottovalutare la letteralità che nessun testo biblico deve mai perdere. I letteralisti o naturalisti sono sempre, a ragione, esistiti: bizantini come Teodoro di Mopsuestia o giudaici come Ibn Ezra. Un grande saggio protestante del Cinquecento, Sébastien Castellion, propose di eliminare il Cantico dal canone dei testi ispirati, in polemica con Calvino; lo seguì Herder. Il Novecento ha visto anche esegeti ecclesiastici cattolici, da Dietrich Bonhoeffer a Luis Alonso Schökel, assaliti dal dubbio: se dietro i versetti del Cantico non ci fosse nulla?
Bisogna intendersi. Il Cantico è nulla. È un prisma trasparente nella cui luce si riflette, moltiplica e illumina qualunque esperienza reale o spirituale, intellettuale o dottrinale vi si accosti. Inoltre, dietro al Cantico c’è il nulla. «In verità, il vuoto del Cantico è lì per confermarne la sacralità. Il Cantico è un pezzo di vuoto sacrale. Dico che è vuoto per non negargli niente», ha scritto Guido Ceronetti.
Almeno quanto l’Ecclesiaste evoca il vuoto e almeno quanto Giobbe il dolore, il Cantico evoca la dolorosa inattingibilità dell’amore. «L’uomo non può capire il Cantico se non ha mai amato», ha scritto Bernardo. Anima mea liquefacta est. Quaesivi, et non inveni illum. Vocavi, et non respondit mihi. «La mia anima si disfa. / Lo cerco e non lo trovo / lo chiamo e non risponde».
Ha scritto Jung: «Mi sono ripetutamente trovato di fronte al mistero dell’amore, e non sono mai stato capace di spiegare cosa sia. Qui si trovano il massimo e il minimo, il più remoto e il più vicino, il più alto e il più basso, e non si può mai parlare dell’uno senza considerare l’altro. Non c’è linguaggio adatto a questo paradosso. Qualunque cosa si possa dire, nessuna parola potrà mai esprimere tutto».
Nessuna parola può esprimere tutto, ma il Cantico, illusionisticamente, lo fa. Se la natura del desiderio è indicibile, il Cantico la dispiega in enigmi. «Mettimi come un sigillo sul tuo cuore / come un tatuaggio sul tuo braccio / perché forte come la morte è l’amore / duro come l’Ade il desiderio ». L’amore è più forte della morte: cosa vuol dire? che l’amore può vincere la morte? che il piacere è una piccola morte? che l’eros è la morte dell’io e ci fa uscire dai suoi confini portando all’insania, come già segnalato da Lucrezio?
«L’eros lo conosciamo solo nella distanza del fallimento. Prima del fallimento non si dà conoscenza », ha scritto Christos Yannaras, massimo esperto contemporaneo del Cantico (alcune delle sue pagine in AA.VV., Il più bel canto d’amore. Letture e riscritture del Cantico dei cantici, Qiqajon, Comunità di Bose, pagg. 231, euro 20, che del Cantico contiene anche la migliore traduzione italiana, di Enzo Bianchi). «Dopo il fallimento sappiamo che l’eros è il modo della vita, ma un modo inaccessibile alla natura umana. Il modo della vita lo palpiamo nella privazione, nel calco dell’assenza ».
La riflessione sull’eros del teologo ortodosso Yannaras conclude oggi il discorso sul Cantico aperto da un altro filosofo greco-orientale, Origene: nel III secolo, quando da poco quell’erma testuale bifronte che esaltava un amore fisico e carnale fino all’oscenità era entrata nel libro sacro a tre religioni e in queste aveva cominciato a porre, o trasporre, il suo enigma. Enfant prodige del platonismo alessandrino, a poco più di vent’anni Origene si era evirato. Aveva, narra Eusebio, troppo da fare coi libri, giorno e notte, e questa era per lui già «una passione e una ginnastica ». Nulla doveva distoglierlo dal comparare e commentare i testi della bibbia. Il suo fu il più grande esperimento di applicazione dell’esegesi allegorica neoplatonica al cristianesimo.
Nel Commento al Cantico, opera della sua maturità, uscito ora in traduzione italiana insieme alle magnifiche Omelie sul Cantico di un altro grande padre greco, Gregorio di Nissa (Origene, Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei cantici, a c. di V. Limone e C. Moreschini, Bompiani, pagg. 1565, euro 50), raccolse l’eredità della ricerca platonica sull’essere e la sua contrapposizione fra anima e corpo, tra metafora e lettera, tra esoterismo e “annuncio”. Sottrasse al Cantico letteralità e fisicità per accenderne l’erotismo metaforico in un modo che nessuno aveva mai osato prima: utilizzandolo in senso psicologico. Col bisturi della filologia neutralizzò la carne degli sposi, per lasciare tutto lo spazio al loro puro spirito. Operò, in un certo senso, come aveva operato sul suo stesso corpo.
L’autoevirazione di Origene, che la tradizione antica riporta, fu reale o simbolica? Di fatto, in uno dei più fantasmagorici trompe l’oeil della letteratura universale, con Origene il Cantico perse per sempre il suo originario connotato realistico per diventare un’allegoria dell’eros mistico, di quell’amore sofferente che sta in ogni atto di ricerca o tentativo di creazione o impulso di unione.
La Sulamita che cerca lo sposo non è solo Israele, secondo l’interpretazione giudaica, e non è solo la chiesa, secondo la versione cristiana vulgata. È in primo luogo l’anima, che secondo la tradizione platonica cerca sempre, e non trova, la perfezione del Logos. Con il Commento al Cantico di Origene il cristianesimo orientale si è fin dall’inizio affiancato agli altri grandi saperi tradizionali nell’esprimere il quaesivi et non inveni, il “cerco e non trovo” che si applica a tutte le sfere dell’indagine, ma anzitutto a quella su noi stessi.
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud --- Maria Schneider e l’"Ultimo tango a Parigi". L’ira delle star Usa contro Bertolucci (di Stefano Landi).5 dicembre 2016, di Federico La Sala
L’ira delle star contro Bertolucci
Ultimo Tango a Parigi, Maria non consenziente
di Stefano Landi (Corriere della Sera, 05.12.2016
L’intervista a Bernardo Bertolucci su Ultimo Tango a Parigi è del 2013 («Nella scena dello stupro Maria Schneider non era consenziente»). Rilanciata sul web ha scatenato le attrici Usa contro il regista: «Vada in carcere».
È bastato che il sito americano della rivista Elle ripubblicasse (in inglese) quelle parole per scatenare un nuovo boato di polemiche in Rete su Ultimo tango a Parigi. Si tratta di un’intervista rilasciata nel 2013 dal regista del film Bernardo Bertolucci alla Cinémathèque Française, ora ripresa da tutti i siti americani: «L’allora 19enne Maria Schneider non era consenziente nella celebre scena dello stupro. Perché volevo vedere la sua reazione come ragazza, non come attrice. Volevo si sentisse realmente umiliata» ammette il regista.
E così ieri è (ri)esplosa la reazione sdegnata di attori e registi di Hollywood. «Per tutte le persone che amano questo film, state vedendo una ragazza di 19 anni violentata da un uomo di 48. E il regista aveva pianificato l’aggressione» ha twittato Jessica Chastain. Le repliche sono riassumibili in tre concetti: «Bertolucci dovrebbe finire in prigione». «Gli andrebbero tolti tutti i premi». «Il film non andrebbe più fatto vedere».
Alle parole di Chastain hanno fatto eco quelle di Evan Rachel Wood, che ha rivelato recentemente di essere stata vittima in passato di due stupri: «Una cosa straziante e oltraggiosa: quei due erano malati per pensare che la cosa potesse funzionare». Poi Chris Evans («non guarderò più questo film, va oltre il disgusto, provo rabbia»), Ava DuVernay («come regista posso a malapena immaginare, come donna sono disgustata»), Anna Kendrick («Miss Schneider aveva dichiarato tutto questo anni fa, io ricevevo occhiatacce quando ne parlavo con qualche uomo»).
Nella sequenza, il personaggio interpretato dall’allora 48enne Marlon Brando, costringe la giovane Schneider a un violento rapporto di sodomia. Lo stesso Bertolucci dice nell’intervista di «aver agito in un modo orribile con Maria, perché non le ho spiegato cosa sarebbe successo. Perché a volte nei film per ottenere una certa reazione bisogna essere completamente liberi».
Il film, uscito nel 1972 (premiato con un David di Donatello, un Nastro d’argento e nominato all’Oscar) ha una lunga storia legale, sfociata con la condanna alla distruzione della pellicola nel gennaio del ‘76, per poi essere riabilitata dalla censura nel 1987.
Schneider, che morì nel 2011 per un tumore, dopo una vita complicata anche da problemi di tossicodipendenza, portò i segni di quell’esperienza. Ne parlò direttamente nel 2007 in un’intervista al Daily Mail : «Mi sono sentita violentata, porto ancora le sofferenze di qualche scena. Bertolucci nei momenti di crisi non è mai corso in mio aiuto. E nemmeno Brando, dopo aver girato quella scena, mi consolò né chiese scusa» raccontò l’attrice. «La sua morte è arrivata prima che potessi riabbracciarla e chiederle scusa», disse Bertolucci il giorno della sua morte.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota
SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud --- "Ultimo tango a Parigi". Bertolucci: “Basta polemiche. Maria Schneider sapeva della scena”.6 dicembre 2016, di Federico La Sala
Bertolucci
“Basta polemiche. Maria Schneider sapeva della scena”
di S. N. (La Stampa, 06.12.2016)
«Qualcuno ha pensato, e pensa, che Maria Schneider non fosse stata informata della scena di violenza su di lei in Ultimo tango a Parigi. Falso! Maria sapeva tutto perché aveva letto la sceneggiatura, dove era tutto descritto. L’unica novità era l’idea del burro. È quello che, come ho saputo molti anni dopo, offese Maria, non la violenza che subisce nella scena e che, ripeto, era prevista nella sceneggiatura del film».
Lo ha chiarito il regista Bernardo Bertolucci all’indomani della polemica scoppiata sul web e che ha fatto schierare contro di lui molte attrici americane riguardo alla scena di sodomia nel famoso film scandalo. «Vorrei, per l’ultima volta, chiarire un ridicolo equivoco - sottolinea Bertolucci - che continua a riportare Ultimo Tango a Parigi sui giornali di tutto il mondo.
Qualche anno fa, alla Cinematèque Française, qualcuno mi ha chiesto dettagli sulla famosa “scena del burro”. Io ho precisato, ma forse non sono stato chiaro, di avere deciso insieme a Marlon Brando, di non informare Maria. Volevamo la sua reazione spontanea a quell’uso improprio. L’equivoco nasce qui».
«È consolante e desolante - prosegue il regista - che qualcuno sia ancora così naïf da credere che al cinema accada per davvero quello che si vede sullo schermo. Quelli che non sanno che al cinema il sesso viene (quasi) sempre simulato, probabilmente, ogni volta che John Wayne spara a un suo nemico, credono che quello muoia per davvero’». [S. N.]
-
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E --- KAMASUTRA. Ci sono gli dèi dietro i segreti dell’erotismo. Per alcuni versi è un trattato politico per altri un repertorio romanzesco2 dicembre 2016, di Federico La Sala
KamasutraCi sono gli dèi dietro i segreti dell’erotismo
 L’antico testo indiano non è solo una guida ai comportamenti sessuali
L’antico testo indiano non è solo una guida ai comportamenti sessuali
 Per alcuni versi è un trattato politico per altri un repertorio romanzesco
Per alcuni versi è un trattato politico per altri un repertorio romanzesco
 Ma il vero gusto dell’opera si coglie risalendo alla cornice divina di schermaglie amorose
Ma il vero gusto dell’opera si coglie risalendo alla cornice divina di schermaglie amorosedi Roberto Calasso (la Repubblica, 02.12.2016)
Universalmente noto come repertorio di posizioni erotiche, talvolta passabilmente acrobatiche e tali da mettere in soggezione un certo numero di amanti occidentali, timorosi di essere poco inventivi, il “Kamasutra” di Vatsyayana è anche, e forse soprattutto, un eccellente canovaccio romanzesco, sotto specie di trattato ossessivamente classificatorio. Ma per scoprirlo occorre una guida adatta - e nessuna potrebbe essere migliore di Wendy Doniger, unica - per quanto so - fra i grandi indologi viventi che sia anche un’autorità sui B-movies di Hollywood, nonché sui vertiginosi intrecci di storie che possono svolgersi intorno e dentro un letto, come ha dimostrato in un sostanzioso volume - “The Bedtrick” - di qualche anno fa. Così la sua edizione annotata del Kamasutra, pubblicata in collaborazione con Sudhir Kakar nel 2002, è diventata subito - e rimarrà - il testo di riferimento per questo classico che è stato a lungo troppo famigerato per essere letto con la dovuta attenzione.
Le reazioni sono state subito vivaci e, nel corso dei quattordici anni successivi, Wendy Doniger ha avuto più volte occasione di tornare sul tema, inserendo il Kamasutra nella trattatistica indiana, che costituisce un immane corpus di testi. E soprattutto su uno di questi trattati si è appuntata la sua indagine: l’Arthashastra, che è il supremo compendio politico dell’India, considerato da molti di gran lunga più spietato e spregiudicato del Principe di Machiavelli. E Doniger infierisce ancora, scrivendo che «Kautilya fa sembrare Machiavelli come Madre Teresa». Anche se un parallelo trattato cinese, il Libro del Signore di Shang, che conosciamo grazie alla sapiente edizione di J.J.L. Duyvendak, può far apparire in paragone miti - anche se non proprio da Kindergarten - sia Kautilya sia Machiavelli.
L’arte erotica esposta nel Kamasutra sarebbe dunque un ramo specifico di quell’arte degli stratagemmi e degli inganni che Kautilya tratta magistralmente. Dopotutto, spie, infiltrati e mezzani possono rivelarsi indispensabili per conquistare una città come per sedurre una donna. E il Kamasutra lo dimostra con dovizia di esempi. Il rapporto è indiscutibile e Doniger lo illumina puntualmente, anche se - come sempre in India - è disperante stabilire una sequenza temporale rigorosa in cui situare i testi.
Ma una volta accertata la matrice trattatistica entro cui il Kamasutra è nato e va considerato, per il lettore di oggi il fascino - e anche il sottile divertimento - dell’opera è tutto nella straripante materia romanzesca di cui è intriso. Il libro può essere letto, da cima a fondo, come un repertorio delle situazioni erotiche in cui può venirsi a trovare un certo personaggio - e delle reazioni che può provocare nelle sue controparti femminili.
Ma chi è questo personaggio? È il nagaraka, il man-about-town, come la lingua inglese concede di tradurre la parola, con perfetta corrispondenza idiomatica (nagara vuol dire “città” in sanscrito). Questo uomo di mondo innanzitutto è ricco e non ha obblighi di alcun genere. La sua unica mira è espandere e acutizzare i suoi piaceri, in numerose direzioni, anche se l’eros spicca fra tutte. È devoto soltanto al kama, al “desiderio”. Non intende accrescere il suo “potere” e i suoi “interessi” (sfera dell’artha).
Quanto al dharma, “ordine” o “legge”, lo rispetta e lo ignora. Come il giovane Ovidio a Roma due secoli prima, frequenta i riti e le feste religiose perché sono ottime occasioni per individuare donne belle, passibili di diventare un giorno oggetto di conquista. La sua vita è al tempo stesso variegata e altamente ripetitiva. Ma tale non è forse anche quella di un uomo d’affari, di un cortigiano o di un religioso? Se il culmine e coronamento di ogni sua attività è l’atto sessuale - così come lo era il concubitus per il giovane Ovidio dell’Ars amatoria -, l’uomo di mondo sarà tenuto ad addestrarsi anche nelle «sessantaquattro arti che deve imparare chiunque (maschio o femmina) tratti in modo veramente serio il piacere ». E qui è solo una delizia scorrerne l’elenco, che include la capacità di ritagliare sagome dalle foglie, fare musica sugli orli di bicchieri d’acqua (come il Mozart dei pezzi per Glasharmonika), preparare letti, mescolare profumi, insegnare a parlare a pappagalli e gracule, praticare la stregoneria, conoscere lessici e dizionari di sinonimi, essere esperti di presagi e delle scienze strategiche. Infine, al sessantaduesimo posto, appaiono “le buone maniere”.
Entrambi gli amanti devono gareggiare in tutte queste arti - e la loro pratica, secondo il “Kamasutra”, non fa che accrescere l’esaltazione erotica. Le stesse conoscenze appartengono all’educazione di una cortigiana di lusso. La quale, se ne è esperta, «ottiene un posto nel consesso pubblico». Nulla è arbitrario o accidentale: alle sessantaquattro arti corrispondono le sessantaquattro varianti dell’amplesso. Che non differiscono molto, per pure ragioni anatomiche, da quelle suggerite dalle massime autorità occidentali in materia, che rimangono l’Aretino e l’autore dei dialoghi di Aloisia Sigea.
E qui si impone una glossa: l’Occidente ha prevalentemente affidato la dottrina delle posizioni erotiche a voci femminili: i Ragionamenti dell’Aretino e i dialoghi di Aloisia Sigea sono conversazioni fra donne che sanno molto della vita sessuale o sono avide di saperne di più. Mentre l’unico trattato dell’antichità classica paragonabile al Kamasutra (e ahimè perduto) era attribuito a una certa Elephantis, il cui nome - secondo la Pauly-Wissowa - «può essere situato nel folto gruppo di nomi di etère che sono derivati da animali». Nulla rimane di tale testo, tuttavia sappiamo da Suetonio che le sue tabellae - ovvero illustrazioni - vennero fatte copiare dall’imperatore Tiberio sulle pareti della sua villa a Capri, come manuale di istruzioni per i suoi ospiti e per se stesso.
Ma, più che nell’elenco delle veneris figurae o modi coeundi - come si usava dire a Roma -, la peculiarità del Kamasutra sta nella sistematicità e nella implacabile precisione del dettaglio. Come anche nel fatto che questa puntigliosa cronaca fisiologica e psicologica include in sé sia una descrizione dell’orgasmo femminile quale nessun autore occidentale avrebbe azzardato sia un elenco degli accorgimenti con cui una cortigiana può liquidare un amante molesto. Lettura incantevolmente profana, che al tempo stesso non può comunque fare a meno di richiamarsi all’antichità vedica e, di là da essa, alla vita degli dèi. Perché di fatto già nel Rigveda si diceva che «il desiderio, kama, è il primo seme della mente».
Così veniamo a sapere che Vatsyayana è solo il tardo redattore di un trattato di materia erotica che nel corso del tempo si era sempre più ridotto e semplificato. Suo primo autore era stato il mite toro Nandin, che vegliava sulla porta della camera da letto dove Shiva e Uma erano congiunti in un interminabile coito, durato mille anni degli dèi. Insieme guardiano, voyeur e scriba, Nandin aveva annotato il sapere erotico che un giorno anche gli uomini avrebbero dovuto apprendere, sebbene parzialmente, essendo incapaci di applicarlo nella sua interezza. Procedimento usuale nell’India classica, presupponente all’inizio una conoscenza sterminata, che si contrae e inaridisce nel tempo, fino alle bassure del Kali Yuga, in cui viviamo. Concezione specularmente opposta a quella evoluzionistica occidentale, che presuppone all’inizio una successione di bruti inarticolati, che poi si innalzano fino alle sommità della Ragione.
Il vero gusto del Kamasutra non si coglie se dalle sue minuziose descrizioni di schermaglie e trappole erotiche, dove graffi e morsi ricordano sempre che l’eros è comunque un duello - e talvolta mortale -, non si risale a quella remota cornice divina. Perché in India, fin dall’origine e fin dai riti esposti nei Brahmana, l’eros è ubiquo e onnipresente. Non meno illuminante di Nandin è il secondo autore leggendario del Kamasutra: Shvetaketu, colui che ridusse i mille capitoli scritti da Nandin a quei cinquecento destinati a essere poi, nel corso del tempo, ulteriormente ridotti, fino a diventare i centocinquanta di Babhravya del Panchala e i trentasei di Vatsyayana.
Chi era Shvetaketu? Lo vediamo apparire, a ventiquattro anni, nella Chandogya Upanishad. Dopo dodici anni di studi, si presenta al padre come «contento di sé, fiero delle sue conoscenze, orgoglioso ». Il padre gli dice che ancora nulla sa, anche se aveva studiato tutti i Veda. Ora gli sarebbe toccato andare oltre. E a questo punto il padre di Shvetaketu avviava una sequenza rapinosa di pensieri, che culminava con l’atman, il Sé, e si condensava in tre parole: Tat tvam asi, “Ciò tu sei”. Quelle tre parole sono il grano di senape che schiude l’immensità vedica. E a noi sono giunte in quanto parole dette a questo giovane brahmano, il quale - in un momento successivo della sua vita - avrebbe redatto una versione abbreviata della dottrina erotica di Nandin. Così Shvetaketu era stato un anello fra gli anelli da cui è nato il Kamasutra. A dimostrazione del fatto che, se c’è stato un luogo dove tout se tient, tale era l’India vedica. In Occidente sarebbe difficile immaginare una leggenda che facesse risalire a Parmenide il trattato erotico dell’etèra Elephantis.
Wendy Doniger ha finalmente reso giustizia al Kamasutra, innanzitutto traducendolo in modo adeguato, senza i malintesi e le superfetazioni stilistiche di Burton, e ricollocandolo in una posizione eminente nella trattatistica indiana. Utile contravveleno a quelle «pratiche pervasive e spesso violente di polizia morale » che hanno attanagliato una parte dell’India e della diaspora indiana in questi ultimi anni, soprattutto dopo il ritorno al governo del Bharatiya Janata Party, con le sue squadre di fondamentalisti indù del Bajrang Dal, che intervengono brutalmente per impedire i festeggiamenti per San Valentino, considerati un esempio di “capitalismo pornografico”.
Giustamente, come considerazione finale, Doniger ha ricordato che il dio Kama, ovvero Desiderio, dopo esser stato incenerito da Shiva, venne a trovarsi infuso, con le sue particelle, «in un certo numero di altre sostanze, che facevano agire la magia di Kama in modo ancora più efficace - la luce lunare, le sopracciglia arcuate delle donne belle e così avanti». E Shiva stesso è contraddistinto dalla più vasta oscillazione fra estremi che conosciamo. Lo dice anche il titolo di un libro prezioso che Doniger pubblicò nel 1973: Shiva. L’asceta erotico. Ma quell’oscillazione vale anche per l’India in genere. Di Kama nessuno sarà in grado, per fortuna, di sbarazzarci.
From The New York Review of Books © 2016 by Roberto Calasso
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA" -- Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio! Il “biologo furioso” Carlo Alberto Redi torna in libreria, questa volta insieme a Manuela Monti, per raccontare la sorprendente storia di questo oggetto fondamentale della biologia!!!8 luglio 2016, di Federico La Sala
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!!
- Cogliere le cose alla radice non è facile. E la radice dell’uomo non è l’uomo stesso. Si ricordi quanto la completa conoscenza scientifica del fenomeno della procreazione sia recente nella scienza occidentale. E si ricordi che «dopo l’antica credenza nella sola responsabilità del maschio, la questione viene riveduta, diventa argomento di polemiche e resta a lungo incerta», e che, «fino al 1906, data in cui l’insegnamento adotta la tesi della fecondazione dell’ovulo con un solo spermatozoo e della collaborazione di entrambi i sessi alla riproduzione e la Facoltà di Parigi proclama questa verità ex cathedra, i medici si dividevano ancora in due partiti, quelli che credevano, come Claude Bernard, che solo la donna detenesse il principio della vita, proprio come i nostri avi delle società pre-patriarcali (teoria ovista), e quelli che ritenevano (...) che l’uomo emettesse con l’eiaculazione un minuscolo omuncolo perfettamente formato che il ventre della donna accoglieva, nutriva e sviluppava come l’humus fa crescere il seme»(Federico La Sala, Della Terra, il brillante colore, pref. di Fulvio Papi, pp. 140-141).
SIRONI EDITORE
- Storia di una cellula fantastica
 Scienza, cultura e natura dell’uovo
Scienza, cultura e natura dell’uovo
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio! Carlo Alberto Redi torna in libreria per raccontare la storia di questa cellula fantastica. Dalla conservazione degli oociti, alla produzione artificiale dei gameti, alla regolamentazione della ricerca pubblica e privata: dove vogliamo andare e con quali regole?
Tutti noi siamo stati un uovo, all’inizio!
Il “biologo furioso” Carlo Alberto Redi torna in libreria, questa volta insieme a Manuela Monti, per raccontare la sorprendente storia di questo oggetto fondamentale della biologia che da sempre esercita un fascino speciale sulle culture di ogni epoca.
A partire dalla loro esperienza di scienziati impegnati sul campo, gli Autori ci guidano in un viaggio meraviglioso alla scoperta di noi stessi che dalla biologia passa per l’arte, la letteratura, la sociologia e - poteva mancare? - la gastronomia.
Una lettura divertente e documentata, che non si sottrae a riflessioni sui temi caldi dell’attualità scientifica.
 Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
Codice ISBN: 978-88-518-0266-0
 Pagine: 224
Pagine: 224
 Prezzo di copertina: € 19,80
Prezzo di copertina: € 19,80
 Prezzo scontato 10%: € 17,82
Prezzo scontato 10%: € 17,82 Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).
Carlo Alberto Redi è professore di zoologia all’Università di Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo. È membro dell’Accademia dei Lincei. È autore per Sironi di Il biologo furioso. Provocazioni d’autore tra scienza e politica (2007).Manuela Monti è biologa. Lavora alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Collabora con iisitituti di ricerca negli USA e in Giappone. È coautrice con Redi di Staminali. Dai cloni alla medicina rigenerativa (Carocci).
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud --- Si fa presto a dire famiglia (di Massimo Recalcati)1 maggio 2016, di Federico La Sala
I tabù del mondoSi fa presto a dire famiglia
 La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
La vita umana non è la vita di una pianta o di un animale, ha bisogno di casa, radici, appartenenza non si accontenta della biologia, si nutre dell’amore dell’Altro, esige di essere riconosciuta
 Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con il sesso dei genitori o con la capacità di generare
 Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?
Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni contengono una profonda contraddizione in termini?di Massimo Recalcati (la Repubblica, 01.05.2016)
Famiglia è ancora una parola decente che può essere pronunciata senza provocare irritazione, fanatismi o allergie ideologiche? Famiglia è ancora una condizione fondamentale e irrinunciabile del processo di umanizzazione della vita oppure è un tabù da sfatare? Se c’è stato un tempo nel quale essa appariva circondata da un alone di sacralità inviolabile non rischia forse oggi di essere condannata come una sopravvivenza ottusa della civiltà patriarcale? Sono solo i cattolici più intransigenti a sostenere la sua esistenza come indispensabile alla vita umana?
Dal punto di vista laico della psicoanalisi la famiglia resta una condizione essenziale per lo sviluppo psichico ed esistenziale dell’essere umano. La vita umana ha bisogno di casa, radici, appartenenza. Essa non si accontenta di vivere biologicamente, ma esige di essere umanamente riconosciuta come vita dotata di senso e di valore. Lo mostrava “sperimentalmente” un vecchio studio di Renè Spitz sui bambini inglesi orfani di guerra che dovettero subire il trauma della ospedalizzazione ( Il primo anno di vita del bambino, Giunti 2009).
La solerzia impeccabile delle cure somministrate dalle infermiere del reparto nel soddisfare tutti i bisogni cosiddetti primari dei bambini non erano sufficienti a trasmettere loro il segno irrinunciabile dell’amore. Effetto: cadute depressive gravi, anoressia, abulia, marasma, stati di angoscia, decessi. Se la vita del figlio non è raccolta e riconosciuta dal desiderio dell’Altro, resta una vita mutilata, cade nell’insignificanza, si perde, non eredita il sentimento della vita. Non è forse questa la funzione primaria e insostituibile di una famiglia? Accogliere la vita che viene alla luce del mondo, offrirle una cura capace di riconoscere la particolarità del figlio, rispondere alla domanda angosciata del bambino donando la propria presenza.
La clinica psicoanalitica ha riconosciuto da sempre l’importanza delle prime risposte dei genitori al grido del figlio. Non si tratta solo di soddisfare i bisogni primari perché la vita umana non è la vita di una pianta, né quella dell’animale, non esige solo il soddisfacimento dei bisogni, ma domanda la presenza del desiderio dell’Altro; vive, si nutre del desiderio dell’Altro. La vita umana non vive di solo pane, ma dei segni che testimoniano l’amore.
L’attualità politica ci impone a questo punto una domanda inaggirabile: tutto questo concerne la natura del sesso dei genitori? Essere capaci di rispondere alla domanda d’amore del figlio dipende dalla esistenza di una coppia cosiddetta eterosessuale? La famiglia come luogo dove la vita del figlio viene accolta e riconosciuta come vita unica e insostituibile - ogni figlio è sempre “figlio unico”, afferma Levinas, - è un dato naturale, un evento della biologia? Siamo sicuri che l’amore di cui i figli si nutrono scaturisca, come l’ovulo o lo spermatozoo, dalla dimensione materialistica della biologia? Esiste davvero qualcosa come un istinto materno o un istinto paterno o forse queste formulazioni che riflettono una concezione naturale della famiglia contengono una profonda e insuperabile contraddizione in termini?
Se, infatti, quello che nutre la vita rendendola umana non è il “seno”, ma il “segno” dell’amore, possiamo davvero ridurre la famiglia all’evento biologico della generazione? Non saremmo invece obbligati a considerare, più coerentemente, che un padre non può essere mai ridotto allo spermatozoo così come una madre non può mai essere ridotta ad un ovulo?
La domanda si allarga inevitabilmente: cosa significa davvero diventare genitori? Lo si diventa biologicamente o quando si riconosce con un gesto simbolico il proprio figlio assumendosi nei suoi confronti una responsabilità illimitata? Le due cose non si escludono ovviamente, ma senza quel gesto la generazione biologica non è un evento sufficiente a fondare la genitorialità. In questo senso Françoise Dolto affermava che tutti i genitori sono genitori adottivi.
Generare un figlio non significa già essere madri o padri. Ci vuole sempre un supplemento ultra-biologico, estraneo alla natura, un atto simbolico, una decisione, un’assunzione etica di responsabilità. Un padre e una madre biologica possono generare figli disinteressandosi completamente del loro destino. Meritano davvero di essere definiti padri e madri? E quanti genitori adottivi hanno invece realizzato pienamente il senso dell’essere padre e dell’essere madre pur non avendo alcuna relazione biologico-naturale coi loro figli?
Questo ragionamento ci spinge a riconsiderare l’incidenza del sesso dei genitori. Ho già ricordato come l’amore sia a fondamento della vita del figlio. Ma l’amore ha un sesso?
Prendiamo come punto di partenza una formula di Lacan: “l’amore è sempre eterosessuale”. Come dobbiamo intendere seriamente l’eterosessualità? Questa nozione, per come Lacan la situa a fondamento dell’amore, non può essere appiattita sulla differenza anatomica dei sessi secondo una logica elementare che li differenzia a partire dalla presenza o meno dell’attributo fallico.
L’amore è eterosessuale nel senso che è sempre e solo amore per l’Altro, per l’eteros. E questo può accadere in una coppia gay, lesbica o eterosessuale in senso anatomico. Non è certo l’eterosessualità anatomica - come l’esperienza clinica ci insegna quotidianamente - ad assicurare la presenza dell’amore per l’eteros! È invece solo l’eterosessualità dell’amore a determinare le condizioni migliori affinchè la vita del figlio possa trovare il suo ossigeno irrinunciabile.
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". --- «S/Oggetti di desiderio: Sexistence»: «lectio» di Jean-Luc Nancy al Festival delle donne e dei saperi di genere.30 aprile 2016, di Federico La Sala
- SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
L’avventura del contatto
Tempi presenti. «S/Oggetti di desiderio: Sexistence»: un’anticipazione della «lectio» che il filosofo francese terrà a Bari il 5 e il 6 maggio, al Festival delle donne e dei saperi di genere
di Jean-Luc Nancy (il manifesto, Alias, 30.04.2016)
Esiste l’amore in tutta la sterminata estensione del termine, l’amore senza confini, l’amore per l’umanità, il mondo, la musica, il mare o la montagna, la poesia o la filosofia, che è essa stessa amore della sapienza. Non è così? Quest’ultima, a sua volta, consisterebbe soltanto nell’amare ciò che non si può giudicare, né conoscere o rifiutare: tutto l’altro in quanto altro, tutto l’esterno in quanto esterno, e la morte e l’amore stesso, impeto furibondo che ci fa morire nell’altro o fa morire l’altro in noi.
Esiste questo amore sconfinato, inesorabile, insopportabile, insensato, impossibile, ed esiste quello che si fa e per il quale non possediamo altro termine se non, appunto, «fare l’amore» (oppure «andare a letto», espressione che però non solo manca di eleganza, ma si trascina dietro una sfilza di parole volgari, triviali, oscene, sporche, disonorevoli, impronunciabili, oppure riservate per essere pronunciate, gridate o mormorate durante l’amore stesso, quando lo si fa). L’ultimo tipo di amore viene definito preferibilmente «eros», mentre per il primo il lessico oscilla tra «philia», «agapè» e «caritas».
In prossimità di soddisfazione
Questi due amori hanno in comune lo slancio, l’infervoramento, la precipitazione senza riserve e senza prospettive: non viene fissato lo scopo, l’esito non viene descritto, si tratta di arrivarci sapendo che l’importante non è giungere alla meta. Forse aspiriamo a tracciare i confini di una finalità possibile: se da un lato ciascun altro è il mio prossimo, la sua prossimità sembra giustificare e persino invocare la mia predilezione, la scelta che faccio di lui e il valore insigne che gli attribuisco; dall’altro, si suppone che il furore del desiderio raggiunga un grado di soddisfazione tale da potersi placare. Eppure sappiamo perfettamente che non ci è data alcuna prossimità senza che questa ci venga immediatamente sottratta più in là, in un’estraneità infinita. E sappiamo anche che non esiste «soddisfazione» - niente «satis», niente «abbastanza» per colui che desidera non tanto appagarsi quanto desiderare ancora e sempre, di nuovo.
All’orizzonte sia di un amore che dell’altro compare la riproduzione, sotto forma di conservazione del gruppo attraverso la pace comunitaria, oppure sotto forma di conservazione della specie (e/o del gruppo...) attraverso la generazione di nuovi individui. In entrambi i casi, tuttavia, ci si pone al di là dell’opera: tanto il gruppo quanto il nuovo individuo devono rinnovare il desiderio per conto proprio, invece di esserne il prodotto.
Forse il sesso propone una cifra - se non la cifra - di tale rinnovamento del desiderio, che in fondo non è altro che il desiderio stesso.
L’eccitazione sessuale, con tutta la sua forza animale e il suo singolare dominio sull’animale umano, rappresenta una turbolenza ontologica del rapporto: alla pari del linguaggio, lo porta molto lontano, cioè dove non si può parlare di satis-fazione, dove non se ne può mai fare abbastanza, ma dove c’è incessantemente qualcosa da fare, qualcosa che non avviene mai come tale, né come risultato, che perciò non è mai «fatta», ma che pure non smette mai di volersi fare.
Un atto performativo
Cosa facciamo quando facciamo l’amore? (domanda sussidiaria: in quante lingue si dice, più o meno letteralmente, fare l’amore?) Noi non facciamo niente nel senso di produrre qualcosa ; se si fa un figlio, che lo si consideri o meno una produzione (riporto l’espressione di Françoise Dolto: «I genitori credono di fare dei figli, ma si accorgono presto che i figli non lasciano fare!»), non si tratta dell’amore in quanto tale, che potrebbe benissimo essere del tutto assente. Noi facciamo nel senso che compiamo un atto, anche se quello designato non è un vero e proprio atto, è un sentimento, una disposizione, l’eccitazione del rapporto al di là di se stesso, verso ciò che sembra destinato a rinnovarlo all’infinito, oppure a oltrepassarlo in un amplesso con cui concluderlo, senza però sapere in che senso vada preso quest’ultimo verbo.
Se non altro l’espressione indica un’effettività dell’amore che nessuna dichiarazione, nessuna dimostrazione, nessuna testimonianza potrà mai pretendere di raggiungere. Ecco perché, in un certo senso, non è impossibile fare l’amore in maniera diversa dal rapporto sessuale in senso stretto: lo scambio di sguardi, di questo o quel contatto, persino delle parole può avventurarsi sul terreno di questo «fare». Almeno una cosa, infatti, è certa: l’amore non può essere soltanto detto, il suo dire stesso dev’essere un fare. «Ti amo» è un atto performativo: fa ciò che dice. L’amplesso si limiterà ad aggiungere un dire in eccesso, che «performa» il proprio limite.
Perché bisognerebbe parlarne? Semplicemente perché non c’è casualità nel gesto compiuto da Freud quando ha voluto fare piena luce teorica sul sesso, gesto cui tendevano già da qualche tempo alcuni approcci antropologici del XIX secolo. Non c’è casualità perché non sorprende che venga investito di nuovi significati ciò che era stato così accuratamente e costantemente sottoposto a un controllo morale e religioso, vale a dire ciò che poteva soltanto restare dissimulato per essere meglio sublimato nell’assunzione dell’amore divino.
La dissimulazione del sesso non faceva che portare avanti, con una modalità nuova proveniente dal contesto cristiano, la sua antichissima valenza sacra. Forse non esiste cultura in cui il sesso non sia, o non sia stato, oggetto di prescrizioni particolari, che si tratti dei culti rivolti agli organi genitali, dei sistemi di parentela e legittimità delle unioni, dei tabù o delle clausole d’impurità, delle condanne di alcune forme di sessualità, delle prostituzioni sacre oppure delle pratiche sessuali legate a certi esercizi spirituali - per limitarci ad alcune voci di un elenco che potrebbe essere molto più lungo e preciso.
Se è vero che il cristianesimo, tra tutte le culture, forse ha rappresentato la forma più propensa alla diffidenza e all’astinenza sessuali, evidentemente esiste un nesso con il motivo dell’amore così come è stato determinato dal cristianesimo. L’amore cristiano non si distingue soltanto, come si dice spesso e a ragione, dall’eros in quanto desiderio di possesso. Del resto, in buona parte della teologia e della spiritualità cattoliche, l’agapè - distinta in quanto affetto, diletto, cura (che diventa caritas) dell’altro - è stata spesso accostata per molti aspetti all’eros.
 Carità e concupiscenza si oppongono, ma l’una non può essere completamente estranea all’altra, perché in un certo senso si deve pure amare ciò che si desidera, oppure desiderare ciò che si ama. In realtà, carità e concupiscenza si attraggono a vicenda tanto quanto sembrano respingersi.
Carità e concupiscenza si oppongono, ma l’una non può essere completamente estranea all’altra, perché in un certo senso si deve pure amare ciò che si desidera, oppure desiderare ciò che si ama. In realtà, carità e concupiscenza si attraggono a vicenda tanto quanto sembrano respingersi.Il ritorno infinito
Se l’unico amore che vale (se non addirittura che esiste) è quello di Dio nel senso di un genitivo soggettivo, cioè l’amore che viene da Dio e anche l’amore che costituisce l’essere Dio, allora questo amore rivolto all’intero creato, amore egli stesso creatore, relega nell’insignificanza qualsiasi amore non divino e al contempo chiama qualsiasi creatura a entrare in quell’amore, a diventare amore. Così due tendenze profonde hanno governato e diviso il cristianesimo, riunendosi e dividendosi al suo interno: un’espansione infinita dell’eros e un’assunzione di qualsiasi desiderio e piacere sotto l’egida di una cura originaria.
Nell’ottica dell’infinito, l’esigenza eccede in maniera assoluta ogni possibilità di realizzazione, oppure non viene realizzata se non come l’atto divino da cui procede. Dio crea per amore e questo amore vuole tornare a sé all’infinito. L’amore diventa il nome di un ritorno infinito - all’origine, a sé, all’altro assoluto. Nell’ottica della totalità, il tutto va inteso non più come un ordine (un cosmos con il suo arché e il suo logos), bensì come una scelta gelosa che ordina (nuovo senso di èn archè hèn o logos). L’amore ordina che lo si preferisca, come esso stesso ci ha preferito (al nulla). Esiste un debito assoluto.
Esiste un debito, il dovere di restituire l’amore ricevuto e, al tempo stesso, questo amore ricevuto costituisce una specie di credito illimitato: l’amore rivendica se stesso ovunque, in tutti. Vi è dunque una specie di totalitarismo, un’economia totalitaria dell’amore, dietro la quale peraltro non è certo indifferente veder profilarsi un’economia del profitto. È a partire da questo che è possibile comprendere come il sesso si manifesti al mondo moderno con un vigore, una virulenza e persino una violenza mai conosciute altrove. Esso è carico di tutta l’energia che nessun impeto divino può più assumersi e che quindi non raccolgono nemmeno più le macchine adibite alla produzione.
La vita in più
Saremmo tentati di dire che il figlio è una produzione (poiesis), mentre l’amore è un comportamento (praxis). Tale distinzione, però, risulterebbe troppo semplicistica, perché un figlio è un’altra esistenza più che un prodotto e il comportamento sessuale è ben lungi dal limitarsi agli atti che portano questo nome. È molto difficile decidere dove cominci e dove finisca il sesso attraverso tutti i nostri rapporti, attività e atteggiamenti. Esso attraversa tutta la nostra vita. Ciò che ha portato alla luce Freud, con il nome di «pulsione (Trieb) erotica», non è l’imprevista importanza, più o meno meccanica, di un registro inferiore della nostra animalità umana: è piuttosto la figura al tempo stesso nuova e antichissima di ciò che ha aperto l’essere vivente a un sovrappiù di vita e l’essere vivente parlante a un’esclamazione ai confini del senso.
Per il momento accontentiamoci di dire che il sesso apre l’esistente a un abisso e a una violenza che se non esauriscono certo i tratti digressivi e scoperti dell’esistenza, quanto meno possiedono una caratteristica: ci conducono - in un groviglio di abisso e violenza - sul bordo di un «fare» che fondamentalmente si limita a sfiorare al tempo stesso il doppio al di là dell’animale e del divino, due nomi che non dicono altro se non che l’esistenza è la sua stessa «deiscenza», una sexistenza. (Traduzione italiana di Ida Porfido)
- SCHEDA
Si concluderà in grande la quinta edizione del Festival delle donne e dei saperi di genere, con le due lezioni di Jean-Luc Nancy del 5 e 6 maggio che andranno a coronare il percorso fitto di appuntamenti, tra filosofia, cinema, teatro e incontri, che ha preso avvio a Bari fin dalla metà di aprile.
 Dedicata interamente al segno delle transizioni, quindi partendo dalla riflessione intorno alla soggettività nomadica, la cifra complessa del presente riesce a dipanarsi. Ne è convinta Francesca Recchia Luciani, organizzatrice e direttrice del festival e docente di Storia delle filosofie contemporanee a Bari; appartiene infatti al presente l’interrogazione sul corpo «e l’identità sessuale, i corpi migranti nella loro relazione con i luoghi, riguarda tutti i cambiamenti innestati nell’esistenza individuale dall’appartenere a un mondo relazionale e sociale in perenne metamorfosi».
Dedicata interamente al segno delle transizioni, quindi partendo dalla riflessione intorno alla soggettività nomadica, la cifra complessa del presente riesce a dipanarsi. Ne è convinta Francesca Recchia Luciani, organizzatrice e direttrice del festival e docente di Storia delle filosofie contemporanee a Bari; appartiene infatti al presente l’interrogazione sul corpo «e l’identità sessuale, i corpi migranti nella loro relazione con i luoghi, riguarda tutti i cambiamenti innestati nell’esistenza individuale dall’appartenere a un mondo relazionale e sociale in perenne metamorfosi».
 Se nelle prime due edizioni il baricentro atteneva ai saperi e le pratiche delle donne, da tre anni a questa parte il festival ha cambiato non solo nome ma anche fisionomia. Una torsione che è apertura femminista al tema delle differenze.
Se nelle prime due edizioni il baricentro atteneva ai saperi e le pratiche delle donne, da tre anni a questa parte il festival ha cambiato non solo nome ma anche fisionomia. Una torsione che è apertura femminista al tema delle differenze.
 Il rilievo scientifico ma anche politico non può dunque sfuggire quando si nominano le protagoniste delle precedenti edizioni, da Ipazia a Carla Lonzi, passando per Audre Lorde. Centralità di vite e portati politico-filosofici che assumono quest’anno l’idea di un punto di partenza per raccontare cosa esprima la «transizione» quando a essere interpellati sono corpi sessuati e in relazione.
Il rilievo scientifico ma anche politico non può dunque sfuggire quando si nominano le protagoniste delle precedenti edizioni, da Ipazia a Carla Lonzi, passando per Audre Lorde. Centralità di vite e portati politico-filosofici che assumono quest’anno l’idea di un punto di partenza per raccontare cosa esprima la «transizione» quando a essere interpellati sono corpi sessuati e in relazione.
 Con una precisa intenzione di coinvolgimento del territorio, emerge allora una sinergia di forze e di pratiche capaci di attrarre non solo un pubblico di studenti ma più vasto che possa restituire narrazioni all’altezza di uno spaesamento che si fa sempre più pressante.
Con una precisa intenzione di coinvolgimento del territorio, emerge allora una sinergia di forze e di pratiche capaci di attrarre non solo un pubblico di studenti ma più vasto che possa restituire narrazioni all’altezza di uno spaesamento che si fa sempre più pressante.
 Il festival, promosso dal Centro interdipartimentale di studi sulla cultura di genere dell’università degli studi di Bari «Aldo Moro» e sostenuto dalla Regione Puglia, dall’università di Bari, da Apulia film commission e Teatro pubblico pugliese [mentre le lezioni di Nancy sono state sostenute da Fondazione Puglia e Alliance Française di Bari], viene largamente condiviso anche dal tessuto associazionistico e da molte e molti che con passione ci lavorano intorno, nonostante la variabilità dei fondi a disposizione ma con il saldo auspicio di un sempre maggiore impegno. Questo perché la formula adottata in direzione di una trasversalità dei linguaggi può rappresentare un antidoto alle chiusure disciplinari e al contempo un metodo efficace di ricognizione esperienziale.
Il festival, promosso dal Centro interdipartimentale di studi sulla cultura di genere dell’università degli studi di Bari «Aldo Moro» e sostenuto dalla Regione Puglia, dall’università di Bari, da Apulia film commission e Teatro pubblico pugliese [mentre le lezioni di Nancy sono state sostenute da Fondazione Puglia e Alliance Française di Bari], viene largamente condiviso anche dal tessuto associazionistico e da molte e molti che con passione ci lavorano intorno, nonostante la variabilità dei fondi a disposizione ma con il saldo auspicio di un sempre maggiore impegno. Questo perché la formula adottata in direzione di una trasversalità dei linguaggi può rappresentare un antidoto alle chiusure disciplinari e al contempo un metodo efficace di ricognizione esperienziale.
 Il sito che riguarda l’iniziativa è www.festivaldonnesaperidigenere.it. Mentre nel sito della rivista di pratiche filosofiche e scienze umane «Postfilosofie» (http://www.postfilosofie.it), si possono leggere gratuitamente i materiali dei festival precedenti, come quelli relativi agli Atti di questa edizione di prossima pubblicazione. (alessandra pigliaru)
Il sito che riguarda l’iniziativa è www.festivaldonnesaperidigenere.it. Mentre nel sito della rivista di pratiche filosofiche e scienze umane «Postfilosofie» (http://www.postfilosofie.it), si possono leggere gratuitamente i materiali dei festival precedenti, come quelli relativi agli Atti di questa edizione di prossima pubblicazione. (alessandra pigliaru) -
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud -- L’arte erotica (e inaspettata) della fedeltà (di M. Recalcati)3 aprile 2016, di Federico La Sala
- LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera
- PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA.
I tabù del mondoL’arte erotica (e inaspettata) della fedeltà
Il nostro tempo è cinico e pragmatico, crede alla libertà senza inibizioni, giudica l’aspirazione delle coppie al “per sempre” una farsa o una catena repressiva
Ma i legami non sempre sacrificano il desiderio: l’autentica forza dell’amore è trasformare la ripetizione in un’esperienza davvero unica e irripetibile
Quello che l’ideologia neo-libertina non vede è che ogni forma di disincanto tende, come spiegarono già Adorno e Horkheimer a ribaltarsi nel suo contrario
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 03.04.2016)
Il tempo ipermoderno sputa sulla fedeltà inneggiando una libertà fatta di vuoto. Tutto ciò che ostacola il dispiegarsi della volontà di godimento del soggetto appare come un residuo moralistico destinato ad essere spazzato via da un libertinismo vacuo sempre più incapace di attribuire senso alla rinuncia. Il principio si applica tanto ai legami con le cose quanto, soprattutto, a quelli con le persone.
Non è un caso che nel nostro paese la fedeltà sia stata recentemente considerata dai legislatori come una forma arcaica del legame amoroso al punto da volerla sopprimere negli articoli del Codice che normano le unioni civili e quelle matrimoniali. Perché evocare inutilmente un fantasma anacronistico reo di aver pesato come un macigno inutile sulla libertà affettiva e sessuale delle vite umane? Meglio liberarsene come di un tabù decrepito dalle armi desolatamente spuntate, come un ferro vecchio che non serve più a niente.
Oggi è il tempo del “poliamore”, della libertà senza inibizioni, della curiosità sperimentale, dell’esperienza senza vincoli, della morte dell’amore pateticamente romantico e dell’affermazione, al suo posto, dell’amore narcisistico che rende l’aspirazione degli amanti al “per sempre” una farsa o una ingenuità bigotta di qualche credulone, o, peggio ancora, una catena repressiva alla nostra libertà di amare che deve essere finalmente spezzata. Anche l’elevazione della fedeltà ad un rango superiore a quello della mera fedeltà (sessuale) dei corpi, teorizzata, non a caso, soprattutto dagli uomini, tradisce, in realtà, la stessa difficoltà a concepire un legame capace di durare nel tempo senza essere necessariamente mutilato nella spinta del desiderio.
Sembra un insegnamento fatale dell’esperienza: più una relazione dura nel tempo più il desiderio erotico si infiacchisce e necessita di nuovo carburante, o, meglio, di dopamina. Le neuroscienze lo confermano senza incertezza: il cervello per mantenere animato il desiderio deve essere dopato dall’eccitazione proveniente da un nuovo oggetto. L’anima, forse, si pensa, può restare fedele, ma non lo si può chiedere al corpo la cui spinta erotica non deve conoscere vincoli.
Il problema è che il nostro tempo non è più in grado di concepire la fedeltà come poesia ed ebbrezza, come forza che solleva, come incentivazione, potenziamento e non diminuzione del desiderio, come esperienza dell’eterno nel tempo, come ripetizione dello Stesso che rende tutto Nuovo. Il nostro tempo non sa né pensare, né vivere l’erotica del legame perché contrappone perversamente l’erotica al legame. È un assioma che deriva da una versione solo nichilistica della libertà: la libertà dell’amore - come la libertà in generale per l’uomo occidentale - deve escludere ogni forma di limite, deve porsi come assoluta. In questo senso la fedeltà diviene un tabù logoro che appartiene ad un’altra epoca e destinato ad essere sfatato.
Quello che l’ideologia neo-libertina del nostro tempo però non vede è che ogni forma di disincanto tende, come spiegarono già Adorno e Horkheimer in Dialettica dell’illuminismo, a ribaltarsi nel suo contrario. Il culto del poliamore, della libertà narcisistica, la polverizzazione dell’ideale romantico dell’amore porta davvero verso una vita più ricca, più soddisfatta, più generativa?
La clinica psicoanalitica ci consiglia di essere prudenti: la ricerca affannosa del Nuovo spesso non è altro che la ripetizione monotona della stessa insoddisfazione. Il punto è che il nostro tempo rischia di smarrire ogni possibile sguardo sulla trascendenza, sull’altrove, anche di quella che si dà nell’esperienza assolutamente immanente dei corpi. Perché non esiste amore se non del corpo, del volto, della particolarità insostituibile dell’Altro.
L’ideale della fedeltà può diventare - come lo è stato per diverse generazioni - una camicia di forza che sacrifica il desiderio sull’altare dell’Ideale divenendo dannosa per la vita. Quando questo accade è bene liberarsene al più presto.
Ma l’esperienza della fedeltà, vissuta non in opposizione alla libertà, ma come la sua massima realizzazione, offre alla vita una possibilità di gioia e di apertura rare. Quella che scaturisce dall’esperienza di rendere sempre Nuovo lo Stesso: la ripetizione della fedeltà rivela infatti che giorno dopo giorno il volto di chi amo può essere, insieme, sempre lo Stesso e sempre Nuovo.
Mentre il nostro tempo oppone lo Stesso al Nuovo, il miracolo dell’amore è, infatti, quando c’è, quello di rendere lo Stesso sempre Nuovo. Accade anche nella lettura dei cosiddetti classici. Lo diceva bene Italo Calvino: quando un libro diventa un classico se non quando risulta inesauribile di fronte ad ogni lettura? Quando la sua forza non si esaurisce mai, ma dura per sempre eccedendo ogni possibile interpretazione? E non è, forse, la fedeltà (ad un amore, ad un autore, ad un’idea) un nome di questa forza? Non è la fedeltà ciò che ci spinge a rileggere lo stesso libro - o un corpo che si trasforma in libro - scoprendo in esso sempre qualcosa di Nuovo? Non è il suo miracolo quello di fare Nuovo ogni cosa, soprattutto quella “cosa” che crediamo di conoscere di più? Non è questa la sua potenza: trasformare la ripetizione dello Stesso in un evento ogni volta unico e irripetibile?
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA" --- «Diritto d’amore» di Stefano Rodotà: il divenire universale dell’autonomia individuale (di Roberto Ciccarelli)7 gennaio 2016, di Federico La Sala
Rodotà, il divenire universale dell’autonomia individuale
Saggi. «Diritto d’amore» di Stefano Rodotà per Laterza. Dalle unioni civili alla laicità dell’istruzione. Un libro che segnala come la legge non può colonizzare la vita affettiva e la sessualità di uomini e donne. L’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica
di Roberto Ciccarelli (il manifesto, 07.01.2016)
È arduo per un giurista parlare del diritto di amare, dato che la disciplina che rappresenta ha usato l’amore come premessa di un progetto di controllo delle donne, ridotte a proprietà del coniuge, mentre la politica continua a decidere sulla vita di uomini e donne. E tuttavia, scrive Stefano Rodotà nel suo ultimo libro Diritto d’amore (Laterza, pp.151, euro 14), l’amore non rinuncia al diritto. Lo usa come un mezzo per realizzare una sua pienezza. Questo è possibile perché la sua storia è storia politica.
Proprietà, credito e obbedienza: questa è la triade usata dal «terribile diritto», il diritto privato, per assoggettare l’amore - e la vita delle persone - alla razionalità dello Stato e al dominio della legge. Rodotà conduce da sempre una critica instancabile a questo modello. Per lui il diritto d’amore, come tutti i diritti, non nasce dall’arbitrio soggettivo, né da un fondamento naturalistico, ma dal legame tra il diritto e la realizzazione di un progetto di vita. Il diritto è legittimato dalle persone che decidono di riconoscerlo e lo usano per affermare l’autonomia e la libertà di tutti, non solo la propria.
Ciò non toglie che il diritto e l’amore, il desiderio di unirsi a un’altra persona, indipendentemente dal suo sesso, mantengano una distanza irriducibile. Quasi mai, infatti, il diritto è un complice della vita. Anzi, esiste per disciplinare gli affetti e per creare il modello del cittadino laborioso, maschio, proprietario. L’amore, invece, non sopporta regole o norme. Preferisce crearle da sé, nell’esperienza delle relazioni, seguendo un divenire che difficilmente può essere contenuto in un’unica disciplina valida per tutti. Per questa ragione il diritto ha preferito confinare «l’amore senza legge in uno stato di eccezione», come ha scritto un grande giurista francese, Jean Carbonnier.
L’autonomia irrinunciabile
In questo stato di eccezione prevale l’originaria ispirazione del diritto privato - cioè la riduzione della passione a cosa e della persona a proprietà di qualcuno. Orientamenti presenti ancora oggi in alcune sentenza della Corte Costituzionali o in fatali decisioni come quella sulla legge 40 sulla fecondazione assistita approvata dal governo Berlusconi.
A tutela dell’autonomia e della libertà delle persone, Rodotà usa la Costituzione e dai suoi articoli fondamentali traccia un uso alternativo del diritto che distrugge i valori di cui la stessa carta fondamentale è espressione. A questo punto è quasi inevitabile per il giurista raccontare la storia dei movimenti che hanno fatto esplodere il perimetro formalizzato dei poteri e della legge nel secondo Dopoguerra. Prima il movimento femminista, oggi i movimenti Lgbtq a cui Rodotà dedica un intero capitolo. Il diritto di amare è diventato una questione politica di rilievo perché alimenta la ricerca dell’autonomia delle persone. Il conflitto è emerso, fortissimo, sulle unioni civili come, di recente, hanno dimostrato i movimenti Lgbtq che hanno organizzato una «marcia dei diritti» per criticare l’insufficienza, addirittura le potenziali discriminazioni presenti nel disegno di legge Cirinnà che il governo intende approvare.
Storia di un incontro
In questa partita rientra anche il conflitto sull’educazione alle differenze nelle scuole: da una parte, c’è un movimento vasto che sostiene la laicità dell’istruzione pubblica e la critica dei ruoli sessuali per tutelare la libertà dei bambini e degli insegnanti. Dall’altra parte, c’è una reazione furibonda che attraverso il meme dell’«ideologia del gender» - una narrazione tossica strumentale e infondata - ha saldato un ampio movimento conservatore con le istanze più reazionarie del cattolicesimo e mira a colpire la laicità dell’istruzione e la libertà nelle scelte d’amore.
Come accade nei suoi libri, Rodotà unisce la storia dei movimenti a quelle della Costituzione italiana e della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea alla quale ha contribuito. L’incontro con i movimenti serve al diritto per «conoscere se stesso, il proprio limite, l’illegittimità di ogni sua pretesa di impadronirsi della vita - scrive Rodotà -. Emerge così uno spazio di non diritto nel quale il diritto non può entrare e di cui deve farsi tutore, non con un ruolo paternalistico, ma con distanza e rispetto». Dal punto di vista dei movimenti, il diritto serve a riconoscere e a coltivare una tensione nel darsi regole che possono cambiare, seguendo una geometria delle passioni interna alle relazioni tra il soggetto e la sua vita.
In questo quadro è fondamentale il ruolo delle minoranze: il movimento omosessuale, insieme a quello femminista, quello Lgbtq, interpretano lo stesso modo di fare politica: per vincere i movimenti si coalizzano con altri soggetti attivi nella società al fine di ottenere un riconoscimento sociale e istituzionale. Le conquiste sulle libertà personali sono valide per tutti, come hanno dimostrato l’aborto e il divorzio. Il diritto d’amore si inserisce in questa nobile vicenda e risponde a un’esigenza che ha dato il titolo a un altro, notevole, libro di Rodotà: il diritto ad avere diritti.
Tensioni singolari
Auspicio, affermazione performativa, atto di cittadinanza: il diritto ad avere diritti è una formula che caratterizza l’azione coordinata delle minoranze e afferma i diritti universali di tutti: il welfare state, l’ambiente, i beni comuni, per esempio. L’universalismo singolare dei diritti si pratica sottraendosi dall’identità maggioritaria fissata per legge (Deleuze la definiva «divenire minoritario») e, allo stesso tempo, nella creazione di un diritto all’esistenza che sfugge ai principi della morale dominante e agli assetti del potere organizzato dal diritto. Questa duplice azione rivela l’esistenza di uno spazio rivoluzionario. Rodotà lavora alla sua riapertura, in un momento non certo felice di arretramento generale.
Diritto d’amore è infine un libro che va letto insieme a quello dedicato da Rodotà alla solidarietà. Da tempo il giurista è impegnato in una ricostruzione genealogica delle passioni e delle pratiche volte alla costituzione di una soggettività caratterizzata da un rapporto di reciprocità, irriducibile al narcisismo o alla naturalizzazione dei ruoli. Parla di uguaglianza e ne rintraccia la storia nelle pratiche della solidarietà e nella dignità della persona. In questa fittissima tessitura, l’amore è un «rapporto sociale», mentre la sua tensione singolare «a bassa istituzionalizzazione» spinge a creare mondi nuovi. Questa può essere considerata una risposta all’invocazione di Auden: «La verità, vi prego, sull’amore».
-
>L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". --- Spermatozoo incontra uovo. Scienziati Usa fotografano per la prima volta ciò che accade al momento della fecondazione.15 dicembre 2014
Spermatozoo incontra uovo: un esplosione di fuochi d’artificio
Scienziati Usa fotografano per la prima volta ciò che accade al momento della fecondazione. Lo scintillio dipende dagli atomi di zinco rilasciati dall’ovulo. Passo importante anche per procreazione assistita: si possono identificare le uova migliori *
Un «primo appuntamento» esplosivo. Quando lo spermatozoo incontra l’uovo volano letteralmente scintille. Di zinco. Un team di scienziati Usa è riuscito a fotografare per la prima volta i «fuochi d’artificio» che accompagnano il lieto evento e ha scoperto che le uova di mammiferi fecondate rilasciano dalla loro superficie miliardi di atomi di zinco in «scintille», un’ondata dopo l’altra.
Lo scatto che immortala il momento dell’incontro è stato rubato grazie a una tecnologia all’avanguardia sviluppata dal team multidisciplinare guidato dalla Northwestern University, che ha potuto così fermare le immagini del «colpo di fulmine» fra seme e uovo. Un’impresa da paparazzi con un risvolto scientifico che potrebbe rivelarsi prezioso per migliorare i risultati della fecondazione in vitro.
I ricercatori hanno catturato l’immagine di fuochi d’artificio molecolari e individuato l’origine delle scintille: piccoli pacchetti ricchi di zinco appena sotto la superficie dell’uovo. In uno studio pubblicato su «Nature Chemistry», gli esperti spiegano che le fluttuazioni di zinco giocano un ruolo centrale nella regolazione dei processi biochimici che assicurano la transizione da uovo sano a embrione. Queste nuove informazioni, assicurano, potrebbero aprire nuovi scenari: «La quantità di zinco rilasciato da un uovo potrebbe essere un marker ideale per identificare l’alta qualità di un uovo fecondato, cosa che adesso non siamo in grado di fare», spiega l’esperta di biologia ovarica Teresa K. Woodruff, direttore del Women’s Health Research Institute della Northwestern University Feinberg School of Medicine, e uno dei 2 autori corrispondenti dello studio. «Se riusciamo a identificare le uova migliori, un numero minore di embrioni potrebbe essere trasferito durante i trattamenti di fertilità. La nostra ricerca aiuterà a muoversi verso questo obiettivo».
Gli esperti dell’ateneo e dell’Us Department of Energy’s Advanced Photon Source (Aps), hanno sviluppato un pacchetto di 4 metodi fisici per determinare quanto zinco c’è in un uovo e dove si trova all’atto della fecondazione e nelle due ore successive. Dopo aver inventato un nuovo sensore fluorescente, gli scienziati hanno «mappato» quasi 8 mila compartimenti nell’uovo, ognuno contenente approssimativamente 1 milione di atomi di zinco. Tasche che, spiegano, rilasciano il loro carico simultaneamente in un processo ben orchestrato, simile al rilascio di un neurotrasmettitore nel cervello o al rilascio di insulina nel pancreas. I risultati sono stati ulteriormente confermati con metodi chimici.
«Al momento giusto vediamo l’uovo liberare migliaia di pacchetti, ciascuno con scariche milionarie di atomi di zinco. Poi la ”tempesta” si calma», spiega Thomas V. O’Halloran, l’altro autore corrispondente dello studio. «Successivamente c’è un altro scoppio con rilascio di zinco. Ogni uovo ha 4 o 5 di queste periodiche scintille. È bello da vedere, sembra quasi una sinfonia».
Lo zinco, spiegano i ricercatori, è parte di un interruttore principale che controlla la decisione di crescere e trasformarsi in un organismo genetico completamente nuovo. Un primo passo per comprendere più a fondo i meccanismi molecolari coinvolti nella nascita di una nuova vita. Le indagini degli scienziati proseguono.
* La Stampa, 15/12/2014 (ripresa parziale - senza immagini).
-
> "CHARITE DULCISSIMA": AMORE (EROS, CUPIDO) E PSICHE. IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!17 giugno 2012, di Federico La Sala
 UNA QUESTIONE MORALE EPOCALE. SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
UNA QUESTIONE MORALE EPOCALE. SE UN PAPA TEOLOGO SCRIVE LA SUA PRIMA ENCICLICA, TITOLANDOLA "DEUS CARITAS EST" ("CHARITAS", SENZA "H"), E’ ORA CHE TORNI A CASA, DA "MARIA E GIUSEPPE", PER IMPARARE UN PO’ DI CRISTIANESIMO.
 "CHARITE DULCISSIMA": IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!
"CHARITE DULCISSIMA": IL RACCONTO DI APULEIO, A DIFESA DI UNA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!
-
> "CHARITE DULCISSIMA": AMORE (EROS, CUPIDO) E PSICHE. ---- CANOVA E IL VATICANO.7 dicembre 2012, di Federico La Sala
-
-
> TUTTO QUEL SILENZIO CHE OSTACOLA LA CIVILTA’. Il sesso spiegato ai bambini L’eros rimane un tabù in casa. A fare l’amore si impara dalla rete Ma il 44% dei ragazzi vorrebbe parlarne con i genitori. Ecco le parole giuste3 dicembre 2011, di Federico La Sala
 Il sesso spiegato ai bambini
Il sesso spiegato ai bambini
 L’eros rimane un tabù in casa. A fare l’amore si impara dalla rete
L’eros rimane un tabù in casa. A fare l’amore si impara dalla rete
 Ma il 44% dei ragazzi vorrebbe parlarne con i genitori. Ecco le parole giuste
Ma il 44% dei ragazzi vorrebbe parlarne con i genitori. Ecco le parole giustedi Maria Novella De Luca (la Repubblica, 02.12.2011)
Il 44% degli adolescenti vorrebbe parlare di sesso con mamma e papà Ma si deve cominciare fin da piccoli Già a cinque anni si possono evitare nomignoli sulle parti intime, e a otto si deve puntare sui cambiamenti della pubertà. L’Accademia dei pediatri americani stila consigli per i genitori Per crescere ragazzi più felici che siano anche educati ai sentimenti Il punto di partenza è l’esempio in casa: dalla tenerezza alla naturalezza verso la nudità
Sembra sempre troppo presto. O troppo tardi. In realtà sono i genitori a pensare di non avere l’età. Di essere troppo giovani o troppo vecchi per affrontare "quelle questioni". Ancora tabù, nonostante tutto. E così accade che i ragazzi imparino da soli, oggi come ieri, soltanto che oggi c’è Internet, e questo cambia molto le cose se parliamo di sesso, di sessualità, e perché no, anche d’amore. Materia difficile nell’era dell’eros virtuale, dove dodicenni che forse non hanno mai dato né ricevuto un bacio fanno "sexting" in giro per la Rete "postando" immagini di sé in atteggiamenti sexy, con una grande confusione tra il vero e il falso... E allora, qual è l’età giusta? Quali i sono i termini, le parole, gli esempi per affrontare il discorso "sesso" con questa generazione di bambini e adolescenti che fin dall’infanzia rischia di imbattersi in ogni tipo di rappresentazione "hot", in ogni tipo di immaginario erotico? Il tema è talmente "urgente", nonostante le montagne di volumi scritti in ogni parte del mondo, che l’American Academy of Pediatrics ha messo insieme un breviario di pochi e sintetici consigli rivolti ai genitori.
Un gruppo di scienziati ed esperti dell’età evolutiva ha ripercorso le tappe di una educazione sessuale familiare tenendo però conto di quanto sono cambiati questi nuovi "bambini sapiens". E uno consigli più chiari è che di sesso con i bambini bisogna parlare, fin da quando sono piccolissimi, perché questo li aiuterà da grandi ad avere un rapporto sereno verso l’amore, e soprattutto, "a non anticipare l’età della prima volta". Così se a 4 anni la domanda sarà "mamma, come sono nato?", ad otto "sarà necessario avvertirli dei cambiamenti del loro corpo in vista della pubertà", inserendo però già dei filtri nei loro pc, mentre a 12 anni bisognerà "spingerli a fare domande, anche le più intime", e a partire dai 13 è "sull’amore e sul sesso sicuro" che è necessario insistere.
Del resto finché sono piccoli in fondo è tutto più semplice: ci sono i libri, le storie, titoli e titoli che spiegano l’avventura dell’uovo e del semino, c’è chi usa i disegni e chi i fumetti, chi punta al messaggio scientifico, chi si affida alla tenerezza degli animali antropizzati, "ecco tu sei arrivato così", e il gioco è fatto. Certo poi ci sono i bambini adottati, o magari quelli che hanno due madri o due papà: niente paura, anche per loro ci sono meravigliosi albi illustrati, che è indubbio, facilitano un bel po’ la comunicazione. Il grande silenzio nelle famiglie invece scatta subito dopo, quel "grande silenzio" che preoccupa e non poco pediatri e psicologi, quando gli ex bambini non ancora ragazzi sono alle soglie della pubertà, e di ciò che gli accade capiscono poco o nulla. Ma gli adulti che intercettano quel disagio sono davvero pochi, spiega Maria Rita Parsi, psicoterapeuta dell’infanzia «direi il 30% dei genitori contro il 70% di quelli che fingono di ignorare il problema, pensando che i figli se la caveranno da soli, magari come era avvenuto a loro quando erano ragazzi». Se infatti il 44% degli adolescenti afferma "mi piacerebbe poter parlare di questi temi con i miei genitori", e il 34% dei teenager ammette senza imbarazzo di aver scoperto il sesso su Internet, è evidente che un vuoto c’è...
«Resto sempre colpita da quanto la rivoluzione sessuale degli anni Settanta abbia cambiato la vita delle donne e della coppie - riflette Maria Rita Parsi - mentre tra i genitori e i figli continuino a prevalere gli imbarazzi e i silenzi di sempre. Invece questi ragazzi avrebbero bisogno più che mai di una educazione sentimentale, perché sono vittime di una informazione precoce, dove il sesso diventa soltanto quello dei video porno che trovano su Youtube. Mentre invece non sanno nulla dell’amore, e scindono il sentimento dal corpo. Nei questionari che facciamo con gli adolescenti nelle scuole, molti confessano che nei gruppi di coetanei esiste l’amico o l’amica con cui si sc..., cioè di fa sesso per fare esperienza, ma che queste esperienze non hanno nulla a che vedere con l’amore. E un film come i "Soliti idioti", campione di incassi, è proprio il paradigma di questo tipo di sessualità povera».
Se dunque l’informazione è così precoce (e fuorviante) come contrastarla con parole giuste? È ancora valido per i bambini sostituire i termini degli organi genitali con un lessico più "gentile", atteggiamento che ad esempio i pediatri americani sconsigliano? Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, al tema del della sessualità tra genitori e figli ha dedicato più di un libro, da "Mamma che cos’è l’amore" a "Col cavolo la cicogna". "Utilizzare i nomi esatti, quelli della fisiologia, non è mai sbagliato, purché si spieghi ai bambini che tutto questo ha a che fare con un cuore che batte o una mente che si innamora. Credo che l’educazione sessuale non sia una cosa che si insegni, ma piuttosto una disposizione che i genitori devono trovare dentro di sé per affrontare questi argomenti insieme ai figli. Una educazione che comunque parte sempre dall’esempio quotidiano, da come si parla dell’amore, dalla naturalezza verso la nudità, dal non vergognarsi della tenerezza. Per i bambini i libri sono un grande aiuto - suggerisce Pellai - non solo perché si leggono insieme, ma anche perché i più piccoli possono guardarli da soli, e trovare risposte alle loro domande".
È verso l’adolescenza invece che le cose cambiano, in quell’età ombrosa, vulnerabile e bellissima in cui però la vita è fatta di segreti, di mistero, e le porte, vere o simboliche delle camerette dei teenager, si chiudono. «Oggi per parlare di sesso ad un ragazzino dai 12 anni in poi - avverte ancora Alberto Pellai - bisogna conoscere la tecnologia. Non c’è scampo. Perché buona parte delle loro relazioni ha ormai un legame strettissimo con le loro capacità informatiche. E il fenomeno del sexting, neologismo formato dalle parole sex e texting, che consiste nell’inviare proprie foto sexy su Internet, e può aprire le porte a pericolosi incontri con sconosciuti, ci dà la misura di quanto gli adolescenti siano sospesi in un ambiente dissociato, da una parte ipersessualizzato, dall’altro del tutto ignaro dell’amore».
Ma c’è un altro aspetto importante e che infatti i pediatri americani sottolineano, quando insistono nel parlare di pubertà e che Alberto Pellai rilancia: «Oggi sono i maschi ad essere più in difficoltà nella relazione con il loro corpo. È raro che ci siano infatti ragazzine non avvisate dalle madri dell’arrivo del ciclo mestruale, mentre quasi nessuno informa i maschi di quanto i cambiamenti ormonali possano influire sul loro aspetto, sul loro umore, sulle loro relazioni».
Alessandra Graziottin, direttore del "Centro di ginecologia" San Raffaele Resnati di Milano, sposta il discorso, e dice che il miglior modo per parlare di sesso con i bambini e i ragazzi, è proprio quello di non "usare parole". «C’è una educazione sentimentale che nasce in famiglia e si sviluppa attraverso la relazione che i genitori hanno tra di loro e che i bambini osservano. La loro affettività, il rispetto reciproco, la loro sensualità, con delle aree riservate naturalmente, tutto questo è già una educazione. E poi il rapporto con il corpo dei figli, abbracciarli, accarezzarli, senza naturalmente che ci siano confusioni sessuali. Ecco - spiega Alessandra Graziottin - questo è già essere all’interno di un sano alfabeto di sentimenti. E questa scorta di affettività farà sì che i ragazzi, crescendo, non sentano di dover correre fuori dalla famiglia per trovare qualcuno che in modo o nell’altro li ami, ma aspetteranno il momento giusto per sperimentare il sesso. Proteggendosi così da delusioni che a volte segnano per tutta la vita».
"Più informazioni aiuterebbero i teenager nelle esperienze"
Tutto quel silenzio che ostacola la civiltà
di Chiara Saraceno (la Repubblica, 02.12.2011)
Stare al mondo con un corpo sessuato, quindi non solo diverso per maschi e femmine, ma attrezzato per l’attività sessuale, è una caratteristica così irrilevante dell’essere umano da essere oggetto esplicitamente o implicitamente di azioni educative. Il silenzio, come e più della semplice repressione, è un atto educativo potente, che consegna alla clandestinità emozioni, interrogativi, desideri, impedendo che vengano elaborati in modo riflessivo. Far diventare l’educazione sessuale una azione educativa esplicita da parte dei genitori e della scuola, e continuativa lungo tutto l’arco della crescita, aiuterebbe a maturare concezioni meno stereotipiche dell’appartenenza sessuale e dei rapporti tra i sessi. Aiuterebbe anche a integrare in modo armonico l’appartenenza sessuale e la sessualità nel proprio sviluppo complessivo. In questa prospettiva, l’educazione sessuale è molto più che le pur necessarie informazioni di tipo tecnico-andro-ginecologico cui è spesso ridotta. Nel rispetto del tipo di competenza e domande, insieme cognitive ed emotive, proprie di ogni età, è un’opera soprattutto di costruzione di senso, rispetto al proprio posto nel mondo e nelle relazioni, alla propria e altrui diversità, alle proprie emozioni.
Lasciare nel non detto e non dicibile queste domande e le emozioni in cui sono intricate, peggio ancora censurarle come inappropriate, non aiuta a crescere. Non aiuta neppure a sviluppare un atteggiamento insieme equilibrato e rispettoso nei rapporti - non solo sessuali - tra i sessi e nei confronti di chi ha un orientamento sessuale non standard rispetto alla propria appartenenza di sesso. Tantomeno aiuta a difendersi da rapporti incestuosi e da richieste pedofile. Perché se la sessualità non è detta e non viene riflessivamente integrata nella costruzione di sé, si è abbandonati solo alle pulsioni proprie ed altrui. E la distinzione tra offerta di amore e sfruttamento di una posizione di potere sparisce per mancanza di strumenti di elaborazione.
Chi teme, od ostacola, l’educazione sessuale, intesa come accompagnamento riflessivo alla comprensione del proprio essere al mondo come soggetti sessuati, ha lo stesso atteggiamento che i conservatori avevano un tempo nei confronti dell’istruzione delle classi subalterne, o delle donne: meglio non fornire mezzi di conoscenza, perché potrebbero indurre a cambiare il proprio stato, a criticare lo status quo. Si teme che l’educazione sessuale incentivi all’attività sessuale e, persino, suggerisca l’omosessualità a chi, nell’ignoranza, rimarrebbe tranquillamente eterosessuale. Il fatto è che i ragazzi hanno una attività sessuale a prescindere dalle informazioni che ricevono. Avere strumenti di informazione e di auto-riflessione li aiuterebbe a collocare meglio le esperienze che fanno nel loro percorso complessivo di costruzione dell’identità. Li aiuterebbe ad essere più liberi non solo o tanto da prescrizioni che comunque disobbediscono, ma dalle pressioni dei pari e dal giudizio altrui su ciò che è normale e ciò che è deviante.
Da questo punto di vista, appare comprensibile, ma anche molto preoccupante, la denuncia pronunciata dal papa il gennaio scorso in occasione del discorso di inizio anno al corpo diplomatico. Secondo Benedetto XVI, "l’educazione sessuale e civile impartita nelle scuole di alcuni paesi europei costituisce una minaccia alla libertà religiosa", perché "riflettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono una antropologia contraria alla fede e alla retta ragione." Se una visione dell’essere umano come intero, ove l’appartenenza di sesso e la sessualità non sono concepite come disgiunte dalla conoscenza e riflessività - e queste da quelle - è contraria alla fede cattolica, è un problema di quest’ultima. Per altro, si sono visti i guasti di questa separazione, dell’ignoranza e mancanza di rispetto che ha generato, dentro e fuori la Chiesa cattolica. Ma l’accostamento, per certi versi sorprendente, dell’educazione sessuale all’educazione civile, senza volerlo, segnala come la posta in gioco sia davvero la formazione di persone, cittadini, consapevoli e competenti, capaci di valutare e decidere autonomamente, sul piano privato della sessualità, come su quello pubblico della vita associata.
-
> L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". ---- L’HIT-PARADE DELL’AMORE (di Massimo Gramellini).24 giugno 2011, di Federico La SalaCHIEDO SCUSA A PLATONE SE NON ABBIAMO ANCORA CAPITO LA LEZIONE. L’hit-parade dell’amore - di Massimo Gramellini.
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". ---- "DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?" (P. Gauguin): "L’ORIGINE DEL MONDO" (Gustave Courbet, 1866).20 marzo 2011, di Federico La Sala
 "DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?": IMPRESSIONISMO, POST-IMPRESSIONISMO .... E "L’ORIGINE DEL MONDO" (Gustave Courbet, 1866).
"DA DOVE VENIAMO? CHI SIAMO? DOVE ANDIAMO?": IMPRESSIONISMO, POST-IMPRESSIONISMO .... E "L’ORIGINE DEL MONDO" (Gustave Courbet, 1866).
 ARTE E CONOSCENZA: LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO. Dal Musée d’Orsay di Parigi al Mart di Rovereto (Trento), opere di Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, Morisot, Vuillard, Bonnard, Denis, Courbet. Una breve presentazione, con una nota
ARTE E CONOSCENZA: LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO. Dal Musée d’Orsay di Parigi al Mart di Rovereto (Trento), opere di Monet, Cézanne, Pissarro, Sisley, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, Morisot, Vuillard, Bonnard, Denis, Courbet. Una breve presentazione, con una nota
 (...) lo scandaloso realismo di Gustave Courbet nella celeberrima tela "L’origine du monde" (1866), esposta per la prima volta nel nostro Paese (...)
(...) lo scandaloso realismo di Gustave Courbet nella celeberrima tela "L’origine du monde" (1866), esposta per la prima volta nel nostro Paese (...)
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE ---- Occorre portare l’educazione sessuale alla vera altezza dell’erotica (U. Galimberti risponde a Renato Pierri e a Francesca Ribeiro).30 aprile 2011, di Federico La Sala
L’educazione sessuale
Occorre portare l’educazione sessuale alla vera altezza dell’erotica
Risponde Umberto Galimberti *
Benedetto XVI ha affermato che l’educazione sessuale nelle scuole di alcuni paesi europei è una minaccia alla libertà religiosa. Le cose però non stanno così, giacché la morale, compresa quella sessuale, viene inevitabilmente trasmessa dall’intera società (costumi, mezzi di comunicazione di massa, ecc.) Gli insegnanti sono costretti ad affrontare temi che toccano la sfera della sessualità, perché è difficile restare neutrali davanti a problemi quali l’aborto, la contraccezione, l’omosessualità, le coppie di fatto, ecc. In realtà Benedetto XVI ha il timore, sacrosanto essendo il Papa, che nelle scuole venga trasmessa una morale sessuale diversa da quella cattolica. Ma siamo certi che questa sia rispettosa delle libertà individuali?
 Renato Pierri ex docente di religione cattolica
Renato Pierri ex docente di religione cattolica
 renatopierri@tiscali.it
renatopierri@tiscali.itBenedetto XVI forse ha ragione. Nelle scuole bisognerebbe insegnare la morale sessuale della Chiesa cattolica. Nessun rapporto con la persona amata, anche se si è in età matura, persino per tutta la vita, se non si è sposati (art. 2353 del Catechismo). E, in mancanza di rapporti, attenzione a non masturbarsi, perché "la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato" (art. 2352). Gli omosessuali, da accogliere con compassione, sono chiamati alla castità (art. 2358). Quindi nessun rapporto per tutta la vita con persone della stessa identità di genere. Atto "intrinsecamente cattivo", invece, anche per persone sposate in Chiesa, ricorrere al condom al fine di non procreare (art. 2370). Una donna che abortisce, anche nel caso in cui il feto sia affetto da malattia gravissima, oppure concepito a seguito di uno stupro, è un assassina come Caino (Giovanni Paolo II - Evangelium vitae). L’elenco sarebbe lungo, ma questo basta per rendersi conto che l’educazione sessuale cattolica è una minaccia alla libertà della persona.
 Francesca Ribeiro
Francesca Ribeiro
 ribesca@tiscali.it
ribesca@tiscali.itQuando la Chiesa si libererà dall’ossessione sessuale avrà più tempo per parlare di Dio e più capacità di persuadere che Dio è amore. Non nell’accezione protettiva e consolatoria secondo la quale Dio ama gli uomini che ha creato e redento, ma nel senso che senza un sprazzo di trascendenza, di cui Dio è la metafora, la sessualità perde la sua densità, la sua forza, il suo senso, la sua potenza. Questo bisogna insegnare ai giovani. E in questo deve consistere l’educazione sessuale affinché i ragazzi non si limitino alla pura meccanica dei corpi, ma sappiano, al di là del possesso e della loro appropriazione, leggere l’accadere di un mondo quale appare guardato con gli occhi dell’eros.
La negazione della sessualità, la sua proibizione, il silenzio sui temi sessuali, utile solo a custodirne l’ignoranza che non ha mai fatto fare un passo avanti a nessuno nella storia, non sono praticabili in quell’età in cui la natura sprigiona tutta la sua potenza sessuale in quei corpi giovani. E allora, se educazione ci deve essere, affinché la sessualità si esprima a livello umano e non solo animale, è necessario quel raggio di trascendenza, a cui ho accennato, che consente ai corpi di non chiudersi tristemente nel cerchio stretto della loro solitudine che si fa oppressiva, ma sappia articolare la passione in quella polifonia di linguaggi capace di trasfigurare la nudità nell’estasi della partecipazione, in modo da risvegliare la carne dalla sua opacità e, da puri funzionari della specie come natura ci prevede, ci faccia scoprire, proprio nell’atto sessuale, come individui, caratterizzati da un nome proprio che solo l’altro può chiamare.
E tutto ciò, vorrei dire a chi teme l’educazione sessuale intesa come qui ho cercato di illustrare, è profondamente religioso, se è vero quel che leggiamo nel Cantico dei Cantici (7, 12-13): "Vieni mio diletto, usciamo alla campagna, pernottiamo nei villaggi: di buon mattino andremo nei vigneti, vedremo se gemma la vite, se sbocciano i fiori, se fioriscono i melagrani, là ti darò i miei amori".
Educazione sessuale significa allora insegnare ai giovani come si passa dal corporeo all’incorporeo, per scoprire nel sorriso un offerta, nello sguardo una reciprocità di intenzioni, nel gesto quell’indistinta mescolanza di bellezza e tenerezza che consente di esprimere quella che poco prima era una timida gioia nascosta che la sessualità sprigiona. Non è una bella cosa insegnare tutto questo ai giovani, invece di proibire quello che la natura non consente a loro di ignorare?
* la Repubblica/D, 30.04.2011
-
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". --- "Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità. Secoli XVI-XVII" (di Adriano Prosperi - rec. del libro di Fernanda Alfieri).1 ottobre 2010, di Federico La Sala
L’altro kamasutra scritto da un gesuita
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 01.10.2010)
Anche la cultura cristiana ha avuto il suo Kamasutra. Per secoli la scienza del sesso è stata una scienza ecclesiastica. Confessori e direttori di coscienze, messi a guardia del peccato della lussuria e delle infrazioni capitali o veniali ai comandamenti sesto e nono, hanno dovuto illuminare, istruire, punire uomini e soprattutto donne nel segreto della confessione. Un sapere, il loro, tutto e solo libresco, fatto di nozioni mediche, psicologiche, filosofiche innestate sul tronco originario di una religione sessuofobica, guidata da un clero celibatario e da ideali di perfezione angelica. Ma si tratta pur sempre di una religione che ha conosciuto grandi mutamenti: fondamentale fra tutti quello che vide l’ingresso della Chiesa cattolica «nella camera degli sposi», come dice il titolo del libro di Fernanda Alfieri (Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità. Secoli XVI-XVII, il Mulino, pagg. 423, euro 29).
Un libro importante, centrato su di un’analisi per molti aspetti magistrale del monumento della casuistica morale cattolica della Controriforma applicata all’economia sessuale del rapporto coniugale: le Disputationes de sancto matrimonii sacramento (1602-1605), del gesuita spagnolo Tomás Sánchez.
L’opera segnò una svolta rivoluzionaria rispetto alla tradizione perché fece posto al piacere del sesso e alla esplorazione dei suoi veicoli e delle sue tecniche ben al di là dei limiti concessi a denti stretti dai predecessori, tanto da scatenare proteste e censure. Ma se la cultura cattolica con l’opera di Sánchez «libito fè licito in sua legge» lo si dovette alla decisione della Chiesa tridentina di reagire alla proposta della Riforma protestante portando la guerra fuori dai suoi confini, nel bel mezzo del campo occupato dalla famiglia e dalle dinamiche della riproduzione.
La Chiesa tridentina non solo aprì i recinti sacri al matrimonio e portò davanti all’altare gli sposi ma si impegnò a seguirne tutto il percorso di vita, quello diurno e soprattutto quello notturno, riconoscendo una funzione essenziale e moralmente positiva ai rapporti sessuali. Da allora dura la marcia ininterrotta di un’avanzata del magistero ecclesiastico nelle cose del sesso.
Ne registriamo quasi quotidianamente gli esiti nella vita della nostra società civile ogni volta che è questione di concepimento, aborto e giù fino alle polemiche sulle cellule staminali e gli embrioni.
Ed è a certi aspetti radicati nel profondo della vita sociale dei paesi cattolici - al di là di una superficie apparentemente disinibita e di una solo presunta liberazione o parità della donna - che il libro di Fernanda Alfieri fa riflettere.
Ci sono modelli culturali ancora latenti che vennero elaborati e argomentati in quel monumento eretto al sesso coniugale da un missionario spagnolo negli intervalli di un’opera di conquista religiosa e sotto un cielo andaluso dominato dall’azzurro mantello della Madonna vergine e madre dell’Immacolata Concezione.
È a quell’orizzonte che rinvia lo stereotipo femminile degli occhi bassi e della passività affettiva e sessuale di una donna considerata solo un recipiente silenzioso e sottomesso del seme maschile. E tuttavia la persistente autorità ecclesiastica su materie di questo tipo non si capirebbe senza l’opera di Tomás Sánchez: fu lui che rielaborando le fonti di una cultura cristiana più che millenaria, dette argomenti alla avanzata della Chiesa sul terreno della famiglia e del sesso: in primo luogo riportando la materia degli affetti, degli istinti e delle pulsioni sotto il dominio della ragione e facendone oggetto di conoscenza intellettuale.
Per il gesuita come per i suoi discepoli destinati al sacerdozio si trattava di conoscere per guidare e governare. Per questa via si giunse al riconoscimento della positività di sentimenti e istinti e si aprì alla donna la possibilità di vedersi riconosciuta una parte essenziale nel piano divino ricavandone intanto il diritto al possesso del suo uomo e alle prestazioni maritali.
Nel perdurante silenzio delle donne, era la voce del corpo che bisognava interpretare perché il progetto del concepimento andasse pienamente in porto: e quella voce trovò ascoltatori attenti. Occhi freddi ed esperti studiarono fisiologia e psicologia, intercettando tutti i segnali e spiando ogni sintomo per costruire una scienza della psicopatologia sessuale dell’animale femminile, il tutto subordinato alla finalità della riproduzione.
E tuttavia la scienza casuistica del sesso e la pratica delle possibilità infinite di tatti e di contatti illustrata agli ecclesiastici celibatari e per loro tramite ai, e soprattutto alle, penitenti, non poteva non produrre effetti imprevisti dilatando l’orizzonte delle fantasie e innescando reazioni a catena. Non per niente il mondo del libro, ignorando o trasgredendo limitazioni e proibizioni, ha trasformato la scienza teologica della morale in letteratura pornografica: dal Paradiso delle coppie sposate all’Inferno delle biblioteche
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud ---- E Karol Wojtyla, il primo nella Chiesa cattolica a utilizzare gli strumenti della psicoanalisi26 marzo 2010, di Federico La Sala
 IL VATICANO, LA PEDOFILIA, E IL PAPA "EDIPO RE". Il legame profondo di Giovanni Paolo II con i "fratelli maggiori" con Sigmund Freud non lo portò a "chiudere un occhio" o a "chiudere gli occhi" di fronte alla catastrofe ...
IL VATICANO, LA PEDOFILIA, E IL PAPA "EDIPO RE". Il legame profondo di Giovanni Paolo II con i "fratelli maggiori" con Sigmund Freud non lo portò a "chiudere un occhio" o a "chiudere gli occhi" di fronte alla catastrofe ...
 KAROL WOJTYLA E SIGMUND FREUD. Wojtyla è stato il primo nella Chiesa cattolica a utilizzare gli strumenti della psicoanalisi per vagliare i seminaristi e prevenire i casi di abusi sessuali del clero
KAROL WOJTYLA E SIGMUND FREUD. Wojtyla è stato il primo nella Chiesa cattolica a utilizzare gli strumenti della psicoanalisi per vagliare i seminaristi e prevenire i casi di abusi sessuali del clero
 (...) da arcivescovo di Cracovia, primo al mondo, aveva introdotto i test attitudinali per tracciare un profilo psicologico e sessuale dei candidati al sacerdozio. Wojtyla, infatti, è stato il primo nella Chiesa universale a utilizzare gli strumenti della psicoanalisi per vagliare i seminaristi e prevenire i casi di abusi sessuali del clero. A Cracovia affidò alla psichiatra amica Wanda Poltawska il delicato compito di individuare, con occhio clinico e mano ferma, chi meritasse un’osservazione supplementare. E il Papa polacco confidava talmente in questa strategia anti-abusi (...)
(...) da arcivescovo di Cracovia, primo al mondo, aveva introdotto i test attitudinali per tracciare un profilo psicologico e sessuale dei candidati al sacerdozio. Wojtyla, infatti, è stato il primo nella Chiesa universale a utilizzare gli strumenti della psicoanalisi per vagliare i seminaristi e prevenire i casi di abusi sessuali del clero. A Cracovia affidò alla psichiatra amica Wanda Poltawska il delicato compito di individuare, con occhio clinico e mano ferma, chi meritasse un’osservazione supplementare. E il Papa polacco confidava talmente in questa strategia anti-abusi (...)
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". --- LA SESSUALITA’ DEGLI ITALIANI. Una grande ricerca (di Michele Smargiassi). I dati rivelanouna società che perso molti suoi tabù rispetto al sesso (di U. Galimberti).24 febbraio 2010, di Federico La Sala
 Tanto sesso siamo italiani
Tanto sesso siamo italiani Si fa l’amore più per piacere (93,8%) che per avere figli (71%) e si continua a farlo da anziani
Si fa l’amore più per piacere (93,8%) che per avere figli (71%) e si continua a farlo da anziani
 L’80% condanna l’infedeltà. Per le donne la sessualità resta legata più al sentimento
L’80% condanna l’infedeltà. Per le donne la sessualità resta legata più al sentimentodi Michele Smargiassi (la Repubblica, 24.02.2010)
Ora lo facciamo con la luce accesa. Tre volte su quattro. La vergogna è finita. Lo facciamo più spesso, più volentieri, più a lungo nella vita. Ci diverte, ci soddisfa, non ci ossessiona ma ne sentiamo il bisogno. Lo facciamo una volta al mese in più di trent’anni fa, altro che stress e sonnolenza da tivù. Lo facciamo spensierati ma non incoscienti, senza tabù ma con rispetto, via via più audaci e sperimentatori. La sessualità degli italiani (Il Mulino editore, in libreria da domani) è sempre più sensuale, ma non insensata. Giunti all’ultima delle oltre trecento pagine di analisi, grafici e tabelle di quello che non è esagerato chiamare il "Rapporto Kinsey italiano", è palese che la pornomania, nel nostro paese, è essenzialmente una patologia del potere mediatico. Era legittimo temere che la volgarità televisiva interpretasse una dissolutezza pandemica, pescasse in un libertinismo di massa. Ma pagina dopo pagina ci si convince che nel nostro paese la "modernizzazione sessuale" (quanto alla rivoluzione, vedremo poi) non solo non ci sta trascinando verso un bordello di lolite e prosseneti, ma l’abbandono progressivo dei due paradigmi tradizionali, quello ascetico e quello procreativo, insomma del «non lo fo per piacer mio», solo in parte è sfociato in puro edonismo, più spesso in un legame più intenso tra affettività e sensualità, libero da sensi di colpa e di norme imposte, ma non privo di codici e di valori.
L’Italia del «si fa ma non si dice» è profondamente cambiata, rincorrendo un po’ a fatica i trend internazionali: questo l’équipe di sociologi coordinata da Marzio Barbagli, Giampiero Dalla Zuanna e Franco Garelli l’aveva previsto. Sul come, questa ricerca, basata sulle migliaia di interviste di tre successive indagini, riserva invece sorprese rispetto alle tendenze da rotocalco. Esempi. Una sessualità più spregiudicata non distrugge la famiglia, al contrario.
Il single, eroe dell’immaginario libertino degli ultimi vent’anni, ha una vita sessuale meno intensa del coniugato. L’età media della "prima volta" non è scesa tra i banchi della scuola media, e almeno per i maschi è stabile da ottant’anni.
Sì, la coppia trionfa ancora, e il matrimonio è tutt’altro che la tomba dell’amore. Nella classica partita fra scapoli e ammogliati, qui sono i secondi che vanno in gol più spesso: nella maturità sessuale, tra i 30 e i 50, chi vive in coppia si gode ogni mese due-tre rapporti in più di chi vive solo, anche se quest’ultimo cambia partner più spesso. E se i francesi fanno l’amore più di noi (8,8 volte al mese contro 7,6 per gli uomini, 8,7 contro 6,7 per le donne) è solo perché oltralpe si convive di più. La disponibilità di una stanza da letto è un afrodisiaco più efficiente del Viagra.
E già: i nostri bamboccioni scopano (scusate, sto esaurendo i sinonimi) meno dei coetanei europei non perché vittime di un crollo della libido nazionale, ma perché lungodegenti in casa dei genitori. Nel frattempo si arrangiano come possono, ma senza fretta. Certo, le ragazze oggi si lanciano prima: quelle nate un secolo fa aspettavano fino ai 22 anni, le ventenni di oggi l’hanno fatto poco dopo i diciotto, cioè appena un anno più tardi dei loro coetanei maschi. Che invece perdono la verginità più o meno alla stessa età dei bisnonni, ossia poco dopo i 17, ma in modo diverso: l’apprendistato con le professioniste è tramontato, oggi si debutta con la morosa, meglio se "fissa".
In compenso ci si sposa più tardi: quindi tra la "prima volta" e il primo figlio ora passano dodici anni di vita sessuale attiva, un’enormità rispetto ai tre dei nostri nonni. È per questa lunga parentesi di sesso spensierato e non procreativo che forse è passato il cambiamento epocale. Il ’68 se ne è attribuito il merito, ma per Barbagli «è solo il momento in cui la vita sessuale è diventata raccontabile e il privato è diventato pubblico», insomma il passaggio in cui si è cominciato a dire ciò che da tempo già si faceva.
Comunque, rivoluzione o modernizzazione lenta, l’approdo è un’inedita, travolgente voglia di sperimentare senza imbarazzi. Un’avventura libera che è più bella se vissuta in complicità con un partner affiatato: la vita sessuale degli italiani è fatta di poche relazioni importanti (l’80% non ne ha avute più di tre), con rari intervalli più disinvolti. Il sesso è molto più importante di un tempo, ma non lo si grida ai quattro venti: la rivendicazione "sindacale" è diventata diritto privato acquisito, i figli del ’68 danno per scontato ciò che per i padri era uno strappo scandaloso. Si fa l’amore per il piacere (93,8%) più che per avere figli (71%), e lo si fa a ogni età: per gli uomini forse era più normale, ma che le donne ultrasessantenni dichiarino di avere ancora tre rapporti al mese ha dell’incredibile. Ci si masturba senza complessi (un terzo degli italiani), anche da adulti (il boom del piacere solitario femminile in età matura è un’autentica rivoluzione) e anche da sposati, perché non è un surrogato ma un complemento, perfino "terapeutico"; e la verginità è un feticcio ormai vuoto. Il rapporto di coppia non è più il momento in cui si scopre il sesso, ma quello in cui lo si raffina, senza farsi dire da nessuno come-si-fa e soprattutto come-non-si-fa: per il 71% nel sesso «non c’è giusto o sbagliato». In camera da letto, né psicologo né confessore.
Lo dimostra il più sorprendente capitolo della ricerca, quello dedicato ai comportamenti privatissimi dei credenti "convinti e attivi". Tra i cattolici italiani il magistero della Chiesa in tema di etica sessuale sembra dissolto: 83 praticanti su cento ammettono i rapporti prematrimoniali, 81 la convivenza more uxorio, 67 la masturbazione, e non finisce qui: sei su dieci gradiscono il sesso orale, e quasi uno su quattro perfino il sesso anale. Non ci sono ormai più differenze con i laici nel ricorso agli anticoncezionali, i ragazzi di parrocchia usano il condom addirittura più dei loro coetanei miscredenti (più informati, più prudenti?). Se c’è ancora uno scarto fra chi va in chiesa e chi no, non è di qualità ma di grado: la coscienza cattolica morigera, attenua, orienta verso l’affettività e la stabilità di coppia, ma non vieta più tassativamente nulla.
Sembra proprio che, anche per i credenti, il discrimine non sia più "cosa è morale nel sesso" ma "cosa è naturale"; e la natura si mostra molto generosa. Zitti zitti, gli italiani da sessant’anni fanno tranquillamente sesso orale (oggi, 8 uomini e 7 donne su 10), quasi sempre col marito o la moglie (solo il 5% dei maschi lo "compra"); ma quel che sorprende davvero è che sia caduto anche l’estremo tabù: «E quando a letto lui / ti chiederà di più / glielo concederai / perché tu fai così»: spiacenti per Cocciante, se è questo che intendeva, ma oggi non è più necessario essere "bella senz’anima" per accettare ciò che un tempo era sinonimo di perversione e oggetto di derisione: la penetrazione anale, il più diseguale dei piaceri di coppia, è chiesta dagli uomini (41%) ma è sempre più accettata dalle donne (19%), e 42 italiani su cento l’hanno praticata solo con una compagna stabile. Di fatto, essendo gli etero più numerosi dei gay, da noi quel particolare capitolo del Kamasutra va in scena quattordici volte più spesso fra un uomo e una donna che fra due maschi. In questo siamo all’avanguardia mondiale: gli inglesi ad esempio bussano alla back door cinque volte meno di noi; curioso primato italico, forse un’eredità che risale all’antichità, azzardano i ricercatori.
Quanta disinvoltura: siamo diventati immoralisti? No. L’etica sessuale ha solo traslocato dal come al perché, dalle tecniche alle relazioni. In camera da letto tutto o quasi è lecito fra consenzienti, ma guai a chi tradisce: otto italiani su dieci condannano l’infedeltà, due su tre l’andare a puttane. Con qualche tolleranza: la "scappatella tecnica", senza legame affettivo, del marito frustrato, e lo "sfogo" di chi non ha altre opportunità. E qui s’affaccia una delle scoperte profonde della ricerca. Le differenze di genere si colmano, uomini e donne condividono sempre più alla pari la caduta dei tabù e la leggiadria sessuale, ma resta una frattura segreta, non quantificabile perché appartiene alla categoria delle credenze profonde: per le donne la sessualità è sorella del sentimento, per gli uomini del piacere. Antico pregiudizio, figlio della concezione "idraulica" della sessualità maschile («la natura vuole il suo sfogo...») che però continua ad essere condivisa anche da molte donne.
La maggioranza degli uomini (con sorprendente unanimità tra classi, età, istruzione) confessa di considerare sinonimi "piacere" e "orgasmo": le donne, no. Come può funzionare bene questo regime di aspettative discordanti? Eppur funziona, al prezzo di qualche tacito gioco delle parti. Le coperte nuziali sono il sipario di un teatrino in cui è ancora e sempre lui a chiedere, anche se lei sempre più spesso acconsente, anzi magari è lei che manda a lui un segnale di "chiedimelo", ma la formalità antica va rispettata, come se un eccesso di intraprendenza femminile fosse pericoloso per l’equilibrio della coppia.
Allo stesso modo funziona il copione del momento clou: nove maschi su dieci pensano che le compagne raggiungano sempre l’orgasmo, ma se lo chiedi a queste, è vero solo per sette su dieci. Se la matematica non è un’opinione, qualcosa non va; infatti, a domanda diretta, due donne su tre ammettono di aver simulato ogni tanto l’orgasmo. Maschi ingenui, donne da Harry ti presento Sally o tacito patto? Si "fa finta" nelle coppie in crisi, per non peggiorare la situazione, o in quelle appena nate, per non comprometterla subito, ma anche in quelle stabili, se lei non vuole deludere lui; in fondo, fare l’amore per il 91% è anche «un modo per mantenere stabile la coppia». È vero che sempre più maschi si preoccupano del piacere delle partner, ma più che una generosa ricerca dell’unisono sembra essere una prova di autostima virile. Immaginari diversi della sessualità convivono sotto l’apparente parità del nuovo "modello affettivo". Sempre più condiviso, egualitario, libertario e sperimentale, il talamo del terzo millennio sembra nascondere un mistero: con reciproco appagamento facciamo l’amore in due, sì, ma non è che poi ciascuno pensa il suo?
Se la trasgressione è un’idea superata
I dati rivelano una società che ha perso molti suoi tabù rispetto al sesso
di Umberto Galimberti (la Repubblica, 24.02.2010)
Quando in un sondaggio l’intervista riguarda il sesso, anche se anonima, è difficile che uno dica la verità. Perché nell’atto di rispondere entra in gioco, di fronte a se stessi, l’immagine di sé che ne esce. E siccome ognuno di noi cerca di nascondere a se stesso la propria ombra, le macchine psichiche della rimozione e della negazione, che Freud ha bene illustrato e che ogni psicoanalista verifica parlando a tu per tu con i pazienti in studi ben protetti, entrano in azione automaticamente, per dare a se stessi, prima che agli altri, un’immagine il più possibile apprezzabile di sé.
Detto questo, e accettando per vere tutte le risposte, quel che risulta è che nell’arco di cento anni le pratiche sessuali non sono variate di molto. La differenza è che un tempo erano segrete e oggi sono più verbalizzate, perché la sessualità non è più un tabù. A partire dal ’68, infatti, siamo passati dalla società della disciplina, dove il conflitto era tra la regola e la trasgressione, alla società dell’efficienza e della performance spinta, dove il conflitto è tra adeguatezza e inadeguatezza della prestazione. Non è un caso che i medici ci informano che i giovani, più degli anziani, sono i maggiori consumatori di Viagra e simil-farmaci, e questo ci dice due cose.
La prima è, che se è vero come scrive Freud: «Dove c’è tabù c’è desiderio» (la stessa cosa diceva San Paolo a proposito del divieto della Legge), la liberalizzazione della sessualità e la facile accessibilità alla pornografia hanno determinato una caduta del desiderio che, per essere all’altezza delle prestazioni, ha bisogno di supporti chimici. La seconda è che, se nella pratica sessuale entra in gioco il grado di prestazione o l’immagine di sé, allora si incarica la sessualità a tenere un discorso che non è propriamente il suo, perché non parla solo di piacere, ma di immagine di sé e quindi di identità che, nell’atto sessuale, viene rafforzata o diminuita.
Quando parliamo di identità oggi assistiamo (come mi pare di dedurre dalle risposte fornite) a un’identità sempre meno coincidente con il proprio genere femminile o maschile, come se nel sesso i maschi non rinunciassero a mettere in gioco la propria femminilità e le donne il tratto maschile dell’intraprendenza e dell’iniziativa. Tutto ciò è bene se non si arresta solo alle pratiche sessuali, ma diventa anche disposizione psichica, capacità dei maschi di esseri teneri e dolci senza vergognarsi, e capacità delle donne di saper guardare negli occhi i loro partner chiedendo loro di non essere trattate come «genere» (le donne), ma come «persone» (quella donna colta nella sua unicità).
Se la liberalizzazione del sesso portasse all’integrazione della nostra controparte sessuale e a un processo sempre più significativo di individuazione, non potremmo che approvarla e considerarla un’emancipazione delle relazioni personali in quel luogo, un tempo segreto e secretato, che è la sessualità.
-
> COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". ---- Al cittadino non far sapere (di Giancarlo De cataldo).10 novembre 2009, di Federico La Sala
Al cittadino non far sapere
di Giancarlo De Cataldo (l’Unità, 10.11.2009)
Condivido pienamente le preoccupazioni espresse dal Corriere della Sera: se davvero insegnassimo nelle scuole «Cittadinanza e Costituzione» trasformeremmo, sciaguratamente, «la democrazia in catechismo». Parole sante. I nostri ragazzi devono essere tenuti alla larga da discutibilissimi precetti quali l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3), il ripudio della guerra (art. 11), la libertà di culto (art. 8), di associazione (art. 18), di pensiero (art. 21), il diritto alla salute (art. 32) e all’istruzione (art. 34), il dovere di pagare le tasse (incredibile, vero? Beh, c’è anche quello, all’art. 53), la irrevocabilità della forma repubblicana (art. 139).
La maligna forza persuasiva di detti precetti è tale che i nostri figli potrebbero convincersi della validità della nostra Costituzione e mandare al diavolo quei politici, baroni e maestri del pensiero che da anni si battono per cambiarla (taluni sognando più mature e consapevoli forme di governo, ispirate a legislatori del calibro di Sardanapalo e del Leonida di Frank Miller). O, addirittura, potebbero prendere tanto sul serio questo confuso agglomerato di “buonismo democratico” da pretenderne l’applicazione.
Inoltre, i nostri ragazzi potrebbero persino coltivare la perniciosa illusione che la scuola non serva soltanto a ingozzarli di nozioni come oche da foie gras, ma possa e debba contribuire (orrore) a farne cittadini civili e consapevoli. Ciarpame culturale che abbiamo già sperimentato con l’esecrando Sessantotto, e che, fortunatamente, il vento impetuoso del progresso (e le norme della Finanziaria) spazzeranno presto via. Così i nostri ragazzi, finalmente istruiti da savi maestri senza grilli per la testa, saranno liberi di formarsi una coscienza critica attraverso strumenti più adeguati: Wikipedia, la Curva, Miss Italia e il Grande Fratello.
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". --- Polonia, un kamasutra cattolico con la "benedizione" della Chiesa (di Enrico Franceschini).15 maggio 2009, di Federico La Sala
 Grande successo per il libro di un frate francescano sulle gioie del sesso
Grande successo per il libro di un frate francescano sulle gioie del sesso
 "Mostratevi amore in ogni modo": ma è solo per coppie sposate e senza contraccezione
"Mostratevi amore in ogni modo": ma è solo per coppie sposate e senza contraccezione Polonia, un kamasutra cattolico
Polonia, un kamasutra cattolico
 con la "benedizione" della Chiesa
con la "benedizione" della Chiesa dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *LONDRA - Sesso, amore e fede. E’ una sorta di nuova santissima trinità, quella celebrata da un libro che è diventato rapidamente un best-seller in Polonia e sta per essere tradotto in mezza dozzina di lingue, compreso l’inglese e l’italiano: "Seks", ovvero sesso, sta scritto a caratteri cubitali in copertina, e nel sottotitolo, molto più in piccolo, "per le coppie sposate che amano Dio". Il Guardian di Londra ne parla oggi in prima pagina descrivendolo come un "kamasutra cattolico": già, perché l’autore è un frate francescano polacco, padre Ksawery Knotz, che prega e lavora in un monastero vicino a Cracovia.
Un manuale di sesso scritto da un sacerdote cattolico sarebbe già abbastanza sorprendente, ma ancora più sorprendenti sono le istruzioni che il frate dà alle coppie. Chi pensasse che il suo libro suggerisce di limitarsi alla posizione "del missionario" e a considerare il coito un esercizio unicamente diretto alla riproduzione della specie, resterebbe deluso, osserva il Guardian. Padre Knotz, al contrario, consiglia di prendere il sesso con allegria e di farlo, per così dire, in tutte le salse. "Ogni atto, un certo tipo di carezze, una certa posizione sessuale, fatto allo scopo di suscitare eccitazione, è permesso e fa piacere al Signore", scrive il frate. "Durante un rapporto sessuale, le coppie sposate possono mostrare il loro amore in qualsiasi modo, possono scambiarsi le carezze più ardite, possono fare ricorso a stimolazioni orali e manuali".
Il libro, che ha ricevuto la benedizione ossia l’approvazione della chiesa cattolica polacca, nota per il suo conservatorismo, segue l’ortodossia tradizionale in altro ambito: si rivolge esclusivamente alle coppie sposate, come se il sesso non potesse esistere fuori dal matrimonio, e scoraggia l’uso di qualunque genere di contraccettivi, "perché possono condurre una coppia fuori dalla cultura cattolica e verso uno stile di vita completamente differente". Ma a parte questo, una volta che l’unione è santificata dal sacramento del matrimonio, sotto le lenzuola tutto è permesso. "Alcune persone credono che il sesso nella vita matrimoniale debba essere privo di gioia, di frivola giocosità, di fantasia e di posizioni eccitanti. Pensano che debba essere triste come un tradizionale inno religioso", afferma padre Knotz nel suo libro. "Fanno fatica a capire che Dio è interessato anche alla felicità della loro vita sessuale, e che anche così ha dato loro un suo dono".
Sebbene il manuale del "kamasutra cattolico" abbia già avuto numerose ristampe in Polonia, e sia in procinto di essere tradotto in slovacco, italiano, inglese e altre lingue, qualcuno si domanda dove abbia messo insieme un’esperienza in fatto di sesso il suo autore, che come frate cattolico ha fatto voto di celibato.
Padre Knotz ammette che le sue informazioni in materia sono "di seconda mano", ma aggiunge che gli hanno dato lo stesso un’ampia conoscenza della materia. "Parlo con un sacco di coppie sposate, li ascolto, e cerco di aiutarli a essere più contenti della loro vita sessuale, a capire che il sesso nel matrimonio non deve avere sensi di colpa o provocare tensioni", spiega. Il successo è tale che, oltre al libro, ha aperto un sito internet dove dispensa i suoi insegnamenti in fatto di sesso ai devoti. A patto che siano sposati, naturalmente.
* la Repubblica, 15 maggio 2009
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". ---- Identita’ e destino... L’inizio e la fine: ipotesi sulla vita (di Emanuele Severino).22 marzo 2009, di Federico La Sala
Identità e destino.
Il dibattito su corpo e resurrezione, su esistenza e morte. Il «prossimo» del Vangelo e la legge morale di Kant
L’inizio e la fine: ipotesi sulla vita
Fede e ragione si interrogano (e si sfidano) su che cosa definisce un essere umano
di Emanuele Severino (Corriere della Sera, 20.03.2009)
Quando incomincia la vita umana? Quando finisce? Cosa significa «vita umana », «uomo»? Pressoché assente, invece, quest’altra domanda: «Esiste l’uomo? ». Certo, essa sembra paradossale, un perditempo fuori luogo. Sanno tutti che un uomo è un corpo che agisce e si esprime, guidato da sentimenti e pensieri. Di uomini ne vediamo tanti ogni giorno. Ma a rendere umano un corpo sono quei sentimenti e pensieri; che però non si lasciano vedere, toccare, sperimentare, nemmeno nell’amore più profondo. Se ne deve congetturare il contenuto, l’intensità, la provenienza, la direzione. A volte si coglie nel segno; a volte no. Nella vita quotidiana, comunque, non ci si rende conto che l’esistenza stessa dei sentimenti e pensieri altrui, dunque l’esistenza stessa dell’uomo, è una congettura. Dell’uomo, dico, ossia del «prossimo» e di me stesso in quanto mi credo radicalmente legato al mio prossimo. Tanto poco «evidente», l’esistenza dell’«uomo», quanto lo è l’esistenza di «Dio». La filosofia lo sa da tempo, anche se una delle questioni più complesse è appunto il significato dell’«evidenza».
Che l’uomo, il suo esser «prossimo» esista è qualcosa di voluto. Ossia di creduto. Qualcosa di discutibile, dunque. Si ha fede nell’esistenza dell’uomo; anche se nella vita quotidiana si crede (si ha fede) che certi esseri siano indiscutibilmente degli uomini. Esistono innumerevoli «conferme» di questa fede; ma che certi eventi siano «conferme » è daccapo una fede: come è soltanto una fede che i baci siano una conferma dell’amore, visto che si può esser baciati da chi ci tradisce.
Per Gesù il prossimo è chi viene amato («Ama il tuo prossimo»); e quindi è prossimo proprio perché viene amato. Dunque è prossimo anche l’amante (il buon Samaritano lo è rispetto all’uomo derubato), giacché se l’amore rende prossimo, cioè vicino, l’amato, anche l’amante si avvicina all’amato, gli si rende prossimo. Un essere è reso «prossimo» dall’amore, ma l’amare è il contenuto della «Legge», ossia di un «Comandamento »; e non si comanda quel che si ritiene «evidente». Al sole che splende nel cielo non si comanda di illuminare la Terra, né a un albero si comanda di non essere una pietra. Se per Gesù il prossimo è l’amato-amante, l’amore è un atto di volontà (persino quando non si può fare a meno di amare); dunque anche per Gesù che il prossimo esista è qualcosa di voluto, creduto, è una fede da cui ci si può quindi allontanare. (Si può dire che il vacillare di questa fede stia all’origine del massacro che incomincia con l’uomo, ma lo si può dire stando all’interno di questa fede). Anche per Kant che certi esseri debbano essere trattati come prossimo è il contenuto della «legge morale», di un «imperativo », di un comando. È un dovere morale credere che il prossimo esista, non è la constatazione di un fatto indubitabile. All’inizio della vicenda dei mortali sulla Terra tutto è per essi «prossimo » (e demonico): luce e suolo, acque, monti, cielo, stelle, animali e piante, vento, tuono, pioggia, lampo e, certo, anche questi esseri a cui oggi abbiamo ridotto l’ampio cerchio antico del «prossimo» e che chiamiamo «uomini». Ma questa riduzione non ha fatto ancora uscire dalla semplice fede, dalla semplice volontà che certi eventi siano il «prossimo».
L’esistenza stessa della vita altrui è un grande arcano e oggi, dimenticando tutto questo, si discute con convinzione per stabilire quando la vita altrui incominci e quando finisca! Di più: si ritiene che non ci sia niente, o più niente, da dire intorno al significato dell’«incominciare» e del «finire», e a questo punto l’inadeguatezza della riflessione tocca il fondo. Dalla quale non sanno liberarsi né scienza, o cristianesimo e altre forme religiose, né arte e filosofia. Si discute con convinzione per stabilire il momento dell’inizio e della fine di qualcosa - il «prossimo» e «io» stesso in quanto mi sento legato ad esso dalle radici - che potrebbe non esserci affatto. Si può replicare dicendo che la cosa non è poi così scandalosa, giacché è lecito e tutt’altro che insensato discutere sull’inizio e la fine di qualcosa la cui esistenza è probabile; e che anzi è insensato ritenere che alle nostre certezze possa competere qualcosa di più della probabilità più o meno elevata, cioè quel di più che sarebbe la loro «verità assoluta e definitiva». Un «sogno finito»; svegliamoci. Ma - rispondiamo - è davvero finito? Sì, dato il modo in cui ci si è addormentati. No, se si riesce a scorgere che c’è dell’altro, che da sempre circonda quel sogno e quel risveglio e che è libero da entrambi.
È stato comunque, quel sogno, grandioso: il sogno della «ragione». Se lo si dimentica, il risveglio è ben poca cosa, è un altro sogno. Il sogno della ragione evoca un sapere che stia al di sopra di ogni fede e di ogni volontà, un sapere che affermi che le cose stanno in un certo modo non perché si vuole e si ha fede che così stiano, ma perché esse stanno incontrovertibilmente così. «Il morire tra ragione e fede» è appunto il tema del Convegno che si terrà in questi giorni all’Università di Padova. Ma ci si vorrà accontentare del discorso (il discorso della scienza, di cui oggi la Chiesa si fida, ossia in cui oggi ha fede) per il quale è «probabile» che l’«uomo» esista, è «probabile» che la sua vita incominci in un certo momento e in un cert’altro finisca?
Si dice che «ognuno di noi» sperimenta la morte del prossimo, non la propria. Ma poiché l’esistenza stessa del prossimo non è sperimentata, del prossimo non si può sperimentare nemmeno la morte (o la nascita). Si sperimenta il sopraggiungere di configurazioni via via diverse di ciò che chiamiamo «il corpo altrui», sino a quella, angosciante, che chiamiamo «cadavere» (e poi altre ancora, come gli scheletri e le ossa, che le feste e i riti arcaici mostrano di considerare ancora come «prossimo»).
Configurazioni via via diverse e, certo, sempre più terribili. Che tuttavia non mostrano quanto è più terribile e angosciante: l’annientamento delle precedenti configurazioni del corpo altrui. Il cadavere mostra sì qualcosa di orrendamente diverso dalla vita da cui è preceduto, ma non mostra l’annientamento di questa vita. Gli uomini hanno imparato che, quando il cadavere compare sulla scena, la vita da cui è preceduto non ha più fatto ritorno, e hanno pensato che questo mancato ritorno sia l’«annientamento » della vita. Non appare, non si fa esperienza dell’annientamento della «beltà» di Silvia («Quel tempo della tua vita mortale, / quando beltà splendea / negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi »), ma appare, dopo le configurazioni del tempo dello splendore di Silvia, il suo «chiuso morbo» e il suo cadavere.
E l’annientamento non può apparire, perché quando si crede che le cose si annientino è necessario che si creda anche che non se ne possa più fare esperienza, ed è quindi impossibile che l’esperienza mostri a quale destino siano andate incontro le cose che da essa sono uscite. Appunto per questo ogni vita e ogni cosa che dopo il proprio calvario esce dall’esperienza «può» ritornare. Se qui si potesse spingere fino in fondo il discorso, si dovrebbe dire anzi che «è necessario » che ritorni.
Sia la ragione, sia la fede (e innanzitutto la fede cristiana e delle altre due religioni monoteistiche) credono che l’annientamento delle cose e dei viventi (e il loro uscire dal niente) costituisca quanto di più «evidente» vi sia, di più manifesto, di più esperibile. Ma alterano ciò che si manifesta, gettano sul suo volto la maschera della morte-che-annienta, l’autentico «pungiglione della morte». La resurrezione dei corpi e della carne, annunciata dal cristianesimo, è certo un tratto della maschera: per risorgere, la carne deve essere diventata niente. La resurrezione è figlia legittima del pungiglione mortale. Eppure, sebbene profondamente sviante, quell’annuncio è una metafora del destino di ciò che, uscendo dalla manifestazione delle cose del mondo, non è diventato niente, ma, eterno, attende di ritornare, nella sua gloria.
All’università di Padova
Confronto tra il filosofo e il patriarca di Venezia
Si apre oggi, alle 9.15, all’Università di Padova, nella sala dell’Archivio antico di Palazzo Bo, il convegno internazionale «Il morire tra ragione e fede: universi che orientano le pratiche di aiuto». I lavori iniziano con un dibattito, moderato da Armando Torno, tra il cardinale Angelo Scola (Patriarca di Venezia) e il filosofo Emanuele Severino (del quale pubblichiamo in anteprima alcune considerazioni sull’argomento). L’iniziativa è nata da un accordo tra il rettore dell’Università Vincenzo Milanesi, il sindaco Flavio Zanonato e il preside della Facoltà Teologica del Triveneto Andrea Toniolo. La direzione scientifica si deve a Ines Testoni, con il concorso delle Facoltà di Scienze della Formazione, di Medicina e Chirurgia, del Dipartimento di Psicologia Generale.
Tra i relatori: Enrico Berti, Dora Capozza, Antonio Da Re, David Spiegel, Michael Barilan. Tra i patrocinatori figura la «World Cultural Psychiatry Research Review».
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". ---- la violenza non conosce confini se non quelli dei nostri corpi, di maschi e di femmine, privi ormai di una qualunque minima grammatica affettiva comune. Incapaci di parlare d’amore e dunque di farlo (di Matteo Bartocci - Castrazione politica).17 febbraio 2009, di Federico La Sala
Castrazione politica
di Matteo Bartocci (il manifesto, 17 febbraio 2009)
Lo stupro non ha nazione né conosce limiti di censo. Stuprano i ricchi e stuprano i poveri di ogni etnia e latitudine. Nella proporzione che in ogni dove le condizioni materiali assegnano a ciascuno.
Sempre però stuprano gli uomini. In Italia, dicono le statistiche, ogni due ore una donna subisce violenza: tredici al giorno. Domandarsi perché accade è un compito della politica. Oltre al conflitto economico che divide le nostre società c’è quello, profondo e nascosto, che attraversa la nostra cultura e il nostro modo di essere maschi e femmine. Di incontrarci e amarci in famiglia e al di fuori di essa. Ogni violenza ha radici sociali e radici culturali. Uno stupro ogni due ore svela soprattutto le seconde.
Nasconderle dietro a un malinteso bisogno di «sicurezza» ha portato ieri all’esercito in piazza, oggi alle ronde e domani, chissà, a una qualche forma di castrazione. Al peggio non c’è fine. Gli stupri non sono più reati contro la morale e nemmeno contro la persona. Sono stupri «etnici». Non secondo chi li compie (italiani, rumeni...) ma secondo chi li subisce: noi, i «bianchi», gli «indigeni», contro i «forestieri» che violentano le «nostre» donne. Ma globale e locale, come sempre, si fondono. Perché se uomini rumeni stuprano ragazze italiane, giovani italiani a loro volta stuprano, non c’è altro modo di dirlo, bambine tailandesi o brasiliane che si prostituiscono ai quattro angoli del globo.
Dunque la violenza non conosce confini se non quelli dei nostri corpi, di maschi e di femmine, privi ormai di una qualunque minima grammatica affettiva comune. Incapaci di parlare d’amore e dunque di farlo.
Ne è un sintomo il fatto che questo paese è ormai capace di mostrare affetto solo a cose fatte. Quando l’oggetto del desiderio non c’è più, come nei tanti funerali pubblici che uniscono e commuovono a reti unificate. Da Alberto Sordi fino a Eluana. Che da viva non interessava nessuno e solo alla fine, prossima alla morte naturale, ha svelato gli istinti inconfessabili di un presidente del consiglio che confonde le mestruazioni con la capacità di avere figli. È o non è, questa, una fantasia di stupro, di appropriazione violenta di un corpo di donna?
Finché questo è il tono, la domanda di «sicurezza» che ossessiona la destra è destinata a cadere nel vuoto. Castrare tutti non si può. E se bastasse un «decreto contro la violenza» il problema passerebbe rapidamente a carceri e tribunali senza risolvere nulla. La destra perde sul suo stesso terreno, incapace di riconoscere un mostro che ne oltrepassa i confini ma che essa ha allevato in culla. Legittimando la cultura di massa più maschilista d’Europa dai tempi di «Colpo grosso», «Drive in» e «Non è la Rai» - fino all’attuale «mignottocrazia» - Berlusconi ha fatto della sessualità l’appeal principale della sua offerta politica.
Ma è sulle donne e le adolescenti, sulla loro sessualità, che si concentra una violenza sottile e diffusa. Il modo in cui vengono guardate per strada o in casa, approcciate sull’autobus, apostrofate a scuola, raccontate sui mass media, «messaggiate» da fidanzati e spasimanti: è un’invasione di corpi normale e quotidiana.
Contro questa spaventosa distruzione dell’alfabeto sentimentale la sinistra non ha da tempo nessuna risposta. E se si preoccupa della benzina nelle volanti vuol dire che non lo indica nemmeno più come un problema. Come il problema.
Non può essere un caso che la prima violenza sessuale di quest’anno terribile si sia consumata a Roma, tra due ragazzi che si incontrano a una festa in mezzo a trentamila persone. Una festa chiamata «Amore».
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota di Federico La Sala20 gennaio 2009, di Ivan
Riflessioni profonde e storicamente ricche e stratificate.
Qui si trova una vasta e sempre crescente raccolta di testi della letteratura amorosa, in varie lingue:
xoomer.alice.it/letteraturadamore
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". ---- Le ipocrisie sull’amore (di Luce Irigary).6 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
Le ipocrisie sull’amore
di LUCE IRIGARAY (la Repubblica, 16 settembre 2008)
Cercando nel dizionario Robert l’etimologia della parola "prostituire" o "prostituirsi", ho scoperto che il suo primo senso e’: esporre in pubblico cose che richiedono un po’ di riservatezza, un po’ di discrezione. Il significato della parola anzitutto conosciuto da noi oggi e’, infatti, piu’ tardo, cioe’ il suo riferimento alla prostituzione del corpo per rapporti sessuali con una, o generalmente parecchie persone, in cambio di denaro.
Stranamente, il primo senso della parola dovrebbe svanire quando si tratta di sessualita’. Anche se e’ per natura pubblica, la prostituzione dovrebbe allora rimanere invisibile. Ma come una cosa pubblica puo’ esercitarsi in modo nascosto? Questo e’ il paradosso legato alla prostituzione: esiste a condizione che non si sappia e che non si veda che esiste. Di conseguenza, e’ cacciata da tutti i luoghi pubblici in cui si potrebbe sapere o vedere che si esercita: le case di tolleranza, le strade, eccetera. Non c’e’ nulla di strano in tale contraddizione.
La prostituzione partecipa della sorte riservata alla sessualita’ nella nostra cultura: esiste a patto che non si sappia, che non si manifesti in quanto tale. Nulla nei programmi scolastici tiene conto della necessaria educazione sessuale dei bambini, dei ragazzi e adolescenti. I programmi scolastici si fermano a insegnamenti relativi agli organi di riproduzione senza abbordare la questione dell’attrazione sessuale e delle vie per condividere il desiderio a un livello corporeo.
L’istruzione si limita a descrizioni naturaliste degli organi sessuali da una parte, e dall’altra all’esposizione delle sventure amorose vissute dai personaggi della nostra letteratura. Si puo’ capire che i ragazzi cerchino presso le prostitute un’educazione un po’ piu’ adeguata a cio’ che provano. Sfortunatamente, visto il disprezzo della sessualita’ nella nostra tradizione, e pure l’etica della stessa prostituzione, questi maschi in cerca di educazione sessuale ricadono in rapporti sessuali piuttosto naturalisti, senza desiderio ne’ amore, che si svolgono in luoghi spesso sordidi e in cambio di denaro.
Una simile iniziazione alla sessualita’ non favorisce gli abbracci amorosi futuri fra amanti; e’ piuttosto incitamento a mostrare le proprie capacita’ in un rapporto venale fondato su una certa schiavitu’. Questo non contribuisce allo sviluppo della personalita’ del ragazzo, in particolare nella sua dimensione affettiva e relazionale, per la quale ha tanto bisogno di un’istruzione appropriata.
La ragazza, da parte sua, non ha quasi mai l’opportunita’ di un’iniziazione sessuale scelta da lei. Diviene il piu’ delle volte una sorta di prostituta involontaria, anche nello stesso matrimonio, e l’attrazione sessuale che prova si fa sogno sentimentale in attesa di qualche principe o signore, forse estraneo alla nostra vita terrena. Si possono immaginare i problemi e le delusioni dei primi abbracci amorosi.
Ora l’attrazione sessuale e’ cio’ che ci puo’ facilitare il passaggio dai bisogni individuali legati alla sopravvivenza a una condivisione con l’altro. E’ cio’ che ci puo’ aiutare a trascendere il nostro corpo come materia attraverso il desiderio, un desiderio che fa da ponte e mediazione tra corpo e anima, e anche fra l’altro e noi stessi. Questa spiritualizzazione del corpo e dell’amore carnale e’ resa impossibile per mancanza di una cultura della sessualita’, per la sua repressione e riduzione a un bisogno, sessuale e perfino procreativo, che non ha piu’ nulla di propriamente umano.
- Fonte: NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE.
 Supplemento settimanale del giovedi’ de "La nonviolenza e’ in cammino"
Supplemento settimanale del giovedi’ de "La nonviolenza e’ in cammino"
 Numero 218 del 6 novembre 2008
Numero 218 del 6 novembre 2008
- Fonte: NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE.
-
> SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". --- Apollo, il nuovo dio della democrazia ateniese, invece sancisce un principio che avra’ conseguenze disastrose per le donne dei millenni a venire: non e’ la madre che crea il figlio. Il suo ventre e’ da considerarsi solo un vaso che custodisce il seme paterno. Ecco come nasce una societa’ dei Padri. Persino la religione cristiana, che e’ stata rivoluzionaria nel riconoscere un’anima anche alle donne, si e’ tenuta, per quanto riguarda la gerarchia, ai principi (di Dacia Maraini).7 settembre 2008, di Maria Paola Falqui
E cosi’ Apollo rubo’ i figli alle madri
di DACIA MARAINI (Corriere della sera, 26 febbraio 2008)
"Non e’ la madre che crea / il figlio, come si pensa. / Ella e’ solo nutrice e niente altro, della creatura paterna / ...Soltanto chi getta il seme nella terra fertile e’ da considerarsi genitore. / La madre coltiva, ospite all’ospite, il germoglio, / quando non l’abbia disperso un demone". Questa frase messa in bocca ad Apollo da Eschilo, e pronunciata in un sacro spazio teatrale nel 458 a.C. segna un punto di svolta che ha marcato la storia della maternita’ in Occidente.
Presso i Pelasgi del II millennio, popolo antenato dei greci, chi creava il mondo era la dea Eurinome, nel cui uovo erano compresi tutti i mari, le montagne, i fiumi, le foreste del mondo. Solo lei poteva fare maturare quell’uovo, romperne il guscio e spargere i beni di cui avrebbero vissuto gli esseri umani.
Apollo, il nuovo dio della democrazia ateniese, invece sancisce un principio che avra’ conseguenze disastrose per le donne dei millenni a venire: non e’ la madre che crea il figlio. Il suo ventre e’ da considerarsi solo un vaso che custodisce il seme paterno. Ecco come nasce una societa’ dei Padri. Persino la religione cristiana, che e’ stata rivoluzionaria nel riconoscere un’anima anche alle donne, si e’ tenuta, per quanto riguarda la gerarchia, ai principi apollinei: nella Santa Trinita’ non appare la figura materna. E quando Dio decide di diventare padre, forma prima l’uomo a sua immagine e somiglianza, poi prende una costole di Adamo e da quella fa nascere la donna. Insomma capovolge la realta’ per sancire una gerarchia inamovibile.
Tutta la nostra cultura viene da questi grandi e originari avvenimenti simbolici. Poi, il laicismo, le rivoluzioni, l’illuminismo, i movimenti di emancipazione hanno cercato di rompere il dogma, riconoscendo alle donne la partecipazione al processo di riproduzione. Ma sempre sotto il controllo dei Padri e dentro le leggi stabilite da loro. Il diritto alla riproduzione non si e’ mai trasformato in liberta’ di riproduzione.
E la rete millenaria dei divieti e’ profonda e radicata anche quando non viene scritta. Da li’ derivano il culto della verginita’, la proibizione degli anticoncezionali, l’aborto clandestino, l’ignoranza indotta e tante altre disperanti piaghe della storia femminile. Se c’e’ una cosa su cui le donne hanno competenza e’ la maternita’: un processo che avviene nel loro corpo, di cui conoscono le pene e le gioie profonde, i tempi e le trasformazioni, il peso e le responsabilita’. Ma di questa competenza sono state espropriate e ogni movimento di riappropriazione viene visto come un attentato alla morale. Il processo procreativo si e’ complicato da ultimo per le scoperte della scienza: anticoncezionali meccanici e chimici, aborti chirurgici e chimici, possibilita’ di spiare e fotografare l’embrione nella sua formazione, mezzi per fare crescere un feto anche in assenza del corpo materno.
Ma tutto questo, anziche’ dare potere alle donne, le deruba ancora una volta dei loro saperi profondi, per stabilire sui loro corpi cosa fare e non fare, secondo principi assoluti stabiliti a tavolino da chi questi saperi non li conosce affatto e non vuole neanche fare lo sforzo di immaginarli.
-
> SESSO (EROS) E AMORE (CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") .... SOCIETA’, POLITICA E "GEN-ITALIA"-NITA’. Il paese degli impotenti di Ilvo Diamanti.25 settembre 2007, di Maria Paola Falqui
MAPPE
Il paese degli impotenti
di ILVO DIAMANTI *
Si dice che l’ondata di sfiducia popolare sia stata sollevata dall’indignazione contro i partiti, ridotti a oligarchie. E contro la classe politica. Una "casta", come recita il titolo del fortunatissimo libro-inchiesta di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. Che gode di benefici esorbitanti. Inaccettabili per la "gente comune".
Non ne siamo sicuri. Crediamo, invece, che la delegittimazione non origini dal distacco della classe politica dalla società, ma dall’esatto contrario. La perdita di ogni differenza rispetto alla "gente comune". Di cui i politici riflettono e riproducono, amplificati, i vizi più delle virtù. Come pretendere che i cittadini possano provare rispetto o timore nei loro confronti?
Per la stessa ragione, dubitiamo che sia giusto definire la classe politica una "casta". Termine usato per indicare un gruppo sociale distinto e diverso dagli altri, in base a motivi (religiosi, come in India) socialmente condivisi. I cui membri, se occupano posizioni più elevate, possono accedere a privilegi specifici. Se la classe politica fosse davvero una "casta", dunque, i riconoscimenti e i vantaggi di cui gode non provocherebbero scandalo. Sarebbero considerati "benefici di status" legittimi, legati al loro ruolo di rappresentanza e di governo. D’altronde, è quanto avviene altrove ed è avvenuto in passato anche in Italia, senza il "rigetto" popolare di questa fase. Gli innumerevoli scandali, denunciati da tutti i media, a nostro avviso, c’entrano solo in parte con questa ondata di sdegno. Conta di più, semmai, l’insoddisfazione per le "prestazioni" dei politici. La convinzione diffusa che siano poco competenti e poco efficaci. Che, per questo, i privilegi loro accordati siano un "costo" sociale improduttivo. Senza benefici per la società. D’altronde il Presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, oggi tanto ammirato, in Italia, da destra a sinistra, ha dichiarato esplicitamente: "se un uomo politico è capace ed efficiente, non vedo perché dovrebbe, in aggiunta, vivere modestamente". Appunto: se è "capace ed efficiente". Altrimenti, come in Italia, esplode il risentimento popolare.
Tuttavia, neppure questa spiegazione, da sola, ci pare sufficiente. Quando la sfiducia si trasforma in dileggio generalizzato e sfocia nello "sputo di massa", non si tratta solo di dissenso. E’ qualcosa di peggio: "banalizzazione". Perdita delle distinzioni fra i cittadini e chi li rappresenta e governa. La classe politica, in altri termini, è al centro delle polemiche non perché sia una "casta", lontana da noi. Ma, al contrario, perché ci somiglia troppo. Difetti, debolezze ed egoismi quotidiani compresi. Ma se i politici sono come noi, perché dovrebbero godere di tanti privilegi e favori?
Il problema è che, da molti anni, i politici fanno di tutto per mostrarsi e per apparire "persone come noi". Anzi: fanno di tutto per "mostrarsi" e "apparire". Hanno accettato la logica e le regole della "berlusconizzazione". Senza considerare che solo Berlusconi è "padrone delle televisioni".
Tutti gli altri, perlopiù copie modeste, si sono tuffati nei "media" senza mai un ripensamento. Hanno inflazionato le televisioni con la loro presenza. Convinti che fra "immagine" e "potere", fra "popolarità" e "autorità" vi sia un legame di reciprocità. Più immagine = più potere. Più popolarità = più autorità. E viceversa.
I politici. Hanno creduto che divenire personaggi televisivi familiari li avrebbe resi simpatici e, al tempo stesso, credibili. Ne avrebbe fatto crescere il consenso e la legittimità. Così, eccoli, all’assalto delle tivù, nazionali o locali non importa. A cucinare, cantare, danzare, giocare a biliardo, simulare orgasmi. Insieme a veline, cuochi, ballerini, tronisti, psicologi, sociologi, criminologi, criminali, enologi, attori, attrici, missitalia, calciatori, allenatori, motociclisti. Leader politici e di governo che nei cabaret televisivi duettano con i loro imitatori. Fino a rendere difficile individuare l’originale. Li abbiamo visti ricevere torte in faccia, lanciate da soubrettes dalle grandi forme, generosamente esibite. Hanno riempito le riviste di informazione gossip. Soprattutto quelle dove, scorrendo nomi e fotografie, non riconosci quasi nessuno. I soliti ignoti. La "Penisola dei famosi", descritta con quotidiana e chirurgica ferocia dai reportage di Dagospia. Un sito di riferimento per capire se uno esiste. Se "conta".
Gli uomini politici. Tutti impegnati a conquistare un posto al sole. Nei salotti tivù più esposti, più visibili. Porta a porta, ma anche Ballarò, Anno Zero, Matrix. Pronti alla mischia. Accettando (spesso cercando) la rissa, l’insulto, la frase a effetto. Pronti a darsi sulla voce, perché non è importante convincere e spiegare, ma gridare più degli altri. Avere l’ultima parola. Non importa quale.
Per cui ha fatto bene il Presidente Giorgio Napolitano, a diffidare gli uomini che hanno cariche pubbliche da questa bulimia televisiva. Il suo ammonimento, però, arriva tardi. Assai prima che Grillo invadesse la rete e - di recente - le piazze, la classe politica si era già squalificata da sola. Come ha commentato Altan, con disarmante ferocia, sulla prima pagina della Repubblica di qualche giorno fa. Quando fa dire alla caricatura del "politico" medio: "Basta con la demagogia. Siamo perfettamente in grado di mandarci a fanculo da soli". Il fatto è che il potere suscita prestigio e timore.
Quando è "legittimo", riconosciuto, evoca rispetto. "Deferenza". E i riti, gli stessi privilegi che lo accompagnano, contribuiscono ad alimentarlo e a riprodurlo. Per questo, gli uomini che dispongono davvero di "potere" non hanno bisogno di esibirlo. Non hanno bisogno di parole. Bastano il ruolo e i "segni" che lo distinguono. Il timore che possa esercitarlo. Basta la fama che lo circonda. Ciampi non ha mai messo piede in uno studio televisivo. E Cuccia: mai una parola, un’immagine. Lo ricordate? Staffelli, il mastino di "Striscia la notizia" che lo tallona, lo interroga, microfono e telecamera addosso. E lui: non una frase. Neppure una parola. Una piega del viso. E De Gaulle? Parlava il meno possibile.
Certo: altri tempi. L’era del marketing e dell’immagine ha cambiato tutto. E’ la democrazia del pubblico. La comunicazione diventa una risorsa. Perfino una necessità. Però, Blair (ieri) e Sarkozy (oggi) i media non solo li conoscono, ma li "usano". Nel senso che non si fanno "usare". Invece, in Italia, avviene il contrario. Ma ve lo immaginate Sarkozy interpellato dal Trio Medusa, delle Iene, sull’ultimo provvedimento in tema di immigrazione. E poi, immancabilmente, irriso a ogni risposta? Oppure incalzato dalla "Iena" Enrico Lucci, che, come normalmente fa con "grandi" politici e imprenditori italiani, scherza con lui come fosse un amicone. Un compagno di notti brave. Riuscite a immaginarlo?
Per questo è inutile prendersela con Grillo. Il quale ha guadagnato popolarità, in passato, andando in tivù. E si è conquistato credito e potere, in seguito, quando ha smesso di andarci. Sulle piazze egli si limita a replicare uno spettacolo che va in onda quotidianamente sugli schermi. Sui media. Stessi protagonisti, stesse comparse. Così le sue prediche corrosive, magari divertono, poi indignano. Ma alla fine lasciano un senso di vuoto. Perché evocano la storia di un Paese minore: il nostro. Dove privilegi grandi e piccoli vengono esibiti senza vergogna da tanti piccoli potenti. Pardon: tanti piccoli impotenti. Che non suscitano più né rispetto, né deferenza. E neppure paura. Perché li abbiamo sempre sotto gli occhi. Seguiti ovunque dalle telecamere. Più che una "casta", il "cast" di una politica ridotta ad avanspettacolo. A un reality show. Se la democrazia esige che le stanze del potere abbiano pareti di cristallo, per noi è come guardare la casa del "Grande Fratello".
* la Repubblica, 23 settembre 2007.
-
> SESSO (EROS) E AMORE (CHARITAS). COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota di Federico La Sala23 maggio 2007, di Federico La Sala
Una fabbrica di favole o disciplina necessaria? Due libri a confronto LETTINO E MISFATTI
Se lo psicoanalista fugge dalla Storia
di Umberto Galimberti *
Un giorno una donna si presenta nello studio che il dottor Freud aveva appena aperto a Vienna dopo le sue sfortune accademiche, per esporgli un quadro di sofferenze che lo stesso Freud faticava a trattare. Dopo diversi incontri Freud decise di inviare la paziente al dottor Fliess, famoso otorinolaringoiatra di Berlino che teorizzava una stretta relazione tra il naso e i mali dell’organismo. Questa relazione Freud l’aveva già sperimentata su di sé a proposito di certi suoi spasmi cardiaci superati dopo un trattamento nasale.
La poveretta, che si chiamava Emma Eckstein, fu sottoposta da Fliess a un’operazione al naso che la lasciò sfigurata, anche perché nella cavità nasale era stata dimenticata una benda. Ne seguì un’emorragia che portò la paziente vicino alla morte, ma Freud, amico di Fliess, difese a tal punto l’operato del collega da interpretare quell’emorragia come un sintomo isterico. La paziente, ripresasi, tornerà da Freud per curare la diagnosticata isteria e dopo alcuni anni diventerà essa stessa analista.
Di questi episodi la psicoanalisi alle sue origini, ma forse non solo alle sue origini, ne annovera molti, e probabilmente le cose non possono andare diversamente quando la volontà interpretante prevale sulle vicende della vita e sulla versione che ne dà il senso comune. Ma il sapere non è mai nato dal senso comune perché la pigrizia intellettuale, che è poi il terreno infecondo del senso comune, lascia le cose come sono, senza forzarle a cedere il segreto che custodiscono.
Approfittando di questo e di molti altri casi simili che la storia della psicoanalisi annovera, quaranta studiosi francesi dalle competenze più svariate sferrano un attacco senza precedenti alla psicoanalisi, accusandola di non essere una scienza, ma solo una fabbrica di favole, di non aver alcun effetto terapeutico se non quello generico di un placebo, di non condurre alla conoscenza di sé perché seleziona il materiale clinico all’unico scopo di trovare una conferma alle proprie teorie, di non promuovere alcuna ricerca, ma solo una difesa dei propri interessi economici e di potere.
Quando nel 2005 Il libro nero della psicoanalisi (oggi tradotto in italiano da Fazi Editore, pagg. 690, euro 29,50) uscì in Francia, Massimo Ammaniti intervenne opportunamente su Repubblica per denunciare che un simile attacco era rivolto a quel settanta per cento di psichiatri francesi che, nei loro trattamenti, utilizzavano la psicoanalisi o terapie di derivazione psicoanalitica. Quindi una guerra interna dove anche la cultura finisce stritolata e un po’ malmenata nei giochi di potere, per la gioia di chi diffida della psicoanalisi e, senza volerci entrare, plaude ad attacchi impropri come questo che accusa la psicoanalisi di non rispondere a criteri scientifici quando la psicoanalisi non ha mai preteso di essere una scienza.
La ragione è molto semplice. Il metodo scientifico prevede l’oggettivazione dell’uomo, la sua riduzione a cosa, e pertanto è incompatibile con la psicologia che non può annullare la soggettività e l’individualità dell’umano a cui essa è naturalmente ordinata. Queste cose le ha dette a chiare lettere Dilthey più di un secolo fa, le ha ribadite Jaspers, Husserl e Binswanger che hanno sottratto la psicologia all’ambito delle scienze della natura (Naturwissenschaften) per iscriverla tra le scienze dello spirito (Geisteswissenschaften) oggi denominate «scienze ermeneutiche». Stupisce che i francesi queste cose non le abbiano ancora imparate. Il loro atteggiamento assomiglia a quello di chi volesse affrontare lo studio della storia partendo dalle leggi della fisica o, per essere più comprensibili, di chi pretendesse di giocare a tennis tirando in porta.
Molto più interessante è leggere il libro di Eli Zaretsky, professore di storia presso la New York School University, autore de I misteri dell’anima. Una storia sociale e culturale della psicoanalisi (Feltrinelli pagg 520 euro 45) dove la psicanalisi esce dagli studi degli psicoanalisti per entrare in modo radicale nella società e nella storia della cultura, a cui fornisce gli strumenti teorici e pratici che rafforzano i nuovi valori che la modernità è andata proponendo.
In primo luogo il «principio dell’autonomia» che significa la libertà di decidere da soli cosa è giusto e cosa è sbagliato, anziché seguire un percorso stabilito dai propri natali, dalla consuetudine, dalla condizione economica. Nel tentativo di capire perché tale autonomia fosse così difficile da conseguire la psicoanalisi elaborò i concetti di ambivalenza, di resistenza, di meccanismi di difesa che aiutarono il processo di emancipazione.
Allo stesso modo la psicoanalisi contribuì all’emancipazione femminile e al riconoscimento dei diritti dell’omosessualità, sfatando l’idea ottocentesca di una totale alterità dei generi e ridefinendo il genere come scelta dell’oggetto sessuale, portando in primo piano l’individualità nella sfera dell’amore sessuale e l’aspirazione a una vita personale che non fosse in ogni suo aspetto subordinata ai codici sociali.
Dando espressione alla vita personale e sottolineando la distinzione tra pubblico e privato, la psicoanalisi ha emancipato dall’autorità paterna, centripeta, gerarchica e incatenata alla famiglia, e ha dato un significativo contributo all’interiorizzazione del concetto di "democrazia", lasciando intravedere la possibilità di nuove e più riflessive relazioni con l’autorità, nonché l’ingresso nella sfera pubblica di istanze considerate private come l’esercizio della sessualità, la libertà da vincoli irrevocabili, il diritto dell’individuo di operare scelte a partire dalla propria personale natura, considerata non per come appare, ma per come è vissuta.
Oggi, se un invito si può e forse si deve rivolgere alla psicoanalisi è quello di non abbandonare questo stretto contatto con la società e con la storia e andare ad esempio a indagare se accanto a un «inconscio pulsionale» non si sia formato negli uomini del nostro tempo anche un «inconscio tecnologico» che condiziona l’io risolvendo la sua identità in funzionalità, la sua libertà in competenza tecnica, la sua individuazione in atomizzazione, la sua specificità in omologazione.
E come nella vita impersonale della specie a cui appartiene, nelle vicissitudini del suo corpo che segue il proprio ritmo autonomo, l’io trova se stesso nell’inconscio pulsionale da cui cerca di emanciparsi, così nella vita sociale, in qualità di produttore e di consumatore, l’io incontra se stesso come funzionario dell’apparato tecnico, o addirittura come anello di quella catena che l’inconscio tecnologico sopraggiunto connette con il mondo delle macchine che, siano esse amministrative, burocratiche, industriali, commerciali, esigono l’omologazione dell’individuo.
Ciò significa che l’individuo realizza solo se stesso quanto più attivamente si adopera alla propria "passivazione", che consiste nella sua riduzione a semplice ingranaggio dell’apparato tecnico, a sua espressione, con progressivo decentramento da sé, e trasferimento del suo centro nel sistema tecnico che lo riconosce come sua componente e, riconoscendolo, gli conferisce un’identità appiattita sulla sua funzionalità.
Di questi problemi si sono accorti, prima degli psicoanalisti, i filosofi che proprio per questo hanno ideato la «consulenza filosofica» che gli psicoanalisti guardano con sospetto, invece di instaurare un proficuo dialogo, perché la psiche umana non è qualcosa di immutabile, di cui la psicoanalisi ne avrebbe scoperto una volta per tutte la struttura, ma è qualcosa che cammina con la storia e con la storia si modifica. Non seguire queste modificazioni potrebbe significare, per la psicoanalisi, chiudere definitivamente la sua storia.
Fonte: la Repubblica, 21.05.2007, p. 31
-
> SESSO (EROS) E AMORE (CHARITAS). COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota di Federico La Sala18 maggio 2007, di Federico La Sala
MONSIGNORE SI DIA UNA CALMATA
di Chiara Saraceno *
La gerarchia cattolica, come ogni autorità religiosa, ha sicuramente il diritto e persino il dovere di esprimersi sui temi che toccano la morale e il senso della vita. Ciò che dice va ascoltato con rispetto e con attenzione, anche quando non lo si condivide. Ma ci sono occasioni in cui è davvero difficile mantenere un atteggiamento di rispetto e ascolto. Le dichiarazioni di ieri di monsignor Betori, segretario della Conferenza episcopale italiana, a Gubbio sono una di queste - ormai sempre più frequenti - occasioni. Di fatto ha individuato come i peggiori nemici della umanità - «fomentatori di guerre e terrorismo», negatori «del riconoscimento dell’altro» a vantaggio del mantenimento di «situazioni e strutture di ingiustizia sociale» - le donne che abortiscono, le persone che riflettono sul testamento biologico e sul diritto a porre fine ad una vita che ha perso tutte le caratteristiche di vita umana, le coppie eterosessuali che convivono senza sposarsi e gli omosessuali in quanto attenterebbero alla dualità sessuale. Sono loro responsabili dei mali del mondo, non i dittatori politici ed economici, non coloro che fomentano guerre etniche e religiose, non gli sfruttatori di donne e bambini, non i mercanti di uomini e neppure coloro che in nome della morale sessuale si oppongono all’utilizzo di semplici precauzioni per evitare il diffondersi dell’Aids che da solo in alcune parti del mondo fa ancora più stragi delle guerre civili.
È difficile provare rispetto ed avere attenzione per chi confonde terroristi e violenti veri e persone che, assumendosene tutta la responsabilità e talvolta la sofferenza, compiono scelte eticamente motivate, ancorché in modo difforme dalla morale cattolica. Per chi, tra l’altro, non distingue neppure, dal punto di vista della gravità rispetto al suo stesso concetto di morale, tra aborto e convivenza senza matrimonio, tra eutanasia e approvazione dei Dico e ritiene (contro le stesse più recenti acquisizioni della Chiesa) che l’omosessualità sia uno stile di vita, e non una condizione umana in cui ci si trova a nascere e vivere. Perciò teme, un po’ grottescamente, che se si riconoscessero le coppie omosessuali nessuno più farebbe coppie (e matrimoni) eterosessuali. È una visione senza sfumature e senza distinzioni, oltre che senza rispetto. Per questo è intimamente violenta oltre che intellettualmente rozza.
Non credo che così si difenda veramente il cristianesimo. Certamente non è così che si può aspirare a ottenere rispetto e attenzione per le proprie posizioni. Si incoraggia soltanto l’escalation dell’insulto reciproco, dell’abuso del linguaggio, dell’incapacità a distinguere e ad ascoltare, della caccia al diverso. Non è né pedagogia civile né, tantomeno, pedagogia religiosa. È una chiamata alle armi. È questo che la gerarchia cattolica vuole per il suo popolo e per il nostro Paese? Chi sta davvero, per riprendere le parole di Betori, coltivando «sentimenti di arroganza e di violenza»? Un po’ di autocontrollo, per favore.
* La Stampa, 18/05/2007
-
> SESSO (EROS) E AMORE (CHARITAS). COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". --- L’amore addomesticato (di Adriano Prosperi).4 ottobre 2008, di Federico La Sala
L’amore addomesticato
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 04.10.2008)
"Crescete e moltiplicatevi": l’invito divino a Adamo ed Eva (Genesi 1,28) è forse il passo della Bibbia ebraica di più lungo corso nelle omelie ecclesiastiche, almeno a partire da quando l’ingresso del matrimonio nella sfera dei sacramenti ha segnalato la volontà del clero di addomesticare l’eros. Oggi l’invito di papa Benedetto XVI ne ripropone la versione antica, di richiamo al dovere di produrre figli senza ricorrere a metodi contraccettivi "innaturali". Ritorna il volto severo e obbligante in coscienza del matrimonio cristiano come rimedio alla lussuria, strumento per spegnere il fuoco dei sensi ("meglio sposarsi che bruciare", un avvertimento paolino che forse il clero dovrebbe meditare di più.
Volto antico: chi sfoglia i testi canonici in materia di matrimonio troverà testi di secoli e secoli fa dove la Chiesa si descrive nata dal costato di Cristo come Eva da quello di Adamo. Ma si dovrà arrivare al decreto approvato dal Concilio Vaticano II il 7 dicembre 1965 per trovare una definizione del matrimonio, dei legami tra marito e moglie e del rapporto coi figli incentrato su di una parola fino ad allora assente: l’amore, non quello spirituale, non quello divino - quello umano.Parole innovative: era l’uscita del linguaggio ufficiale cattolico dalla tradizione medievale dell’alleanza tra un clero celibatario e l’interesse maschile a disporre di una schiava a basso prezzo, per di più portatrice di dote.
Con quel matrimonio l’amore, quello profano, non aveva nessun rapporto. Le novelle del Rinascimento ne sono testimoni, come raccontò in un vecchio bel libro Lucien Febvre, un grande storico francese non sospetto di anticlericalismo. Del dovere imposto da quella cultura alla donna - dovere di essere sempre e comunque soggetta al marito e obbligata a concepire e partorire, naturalmente nel dolore - approfittarono poteri d’ogni genere pronti ad allearsi con l’egemonia culturale del clero.
Fare figli, possibilmente maschi, servì di volta in volta a tante cose. In primo luogo a far crescere la consistenza e la speranza di durata della famiglia e a trasmetterne il nome - quello maschile, cosa che oggi solo in Italia si ritiene ancora ovvia; ma poi anche a moltiplicare la popolazione come forza lavoro per i campi e le officine, come nerbo della potenza statale e carne da cannone. "La grande proletaria si è mossa", disse Giovanni Pascoli ai tempi di una guerra di Libia di cui paghiamo ancora i costi. La prole che si muoveva era nata da matrimoni obbligati a far molti figli. Ed è singolare che oggi si cerchi di pagare i costi di quella sciagurata avventura con un simbolo indiscutibile dell’amore umano, la Venere di Cirene graziosamente quanto arbitrariamente sottratta da Berlusconi al patrimonio artistico italiano per regalarla a Gheddafi (realizzando così una delle più cupe profezie di Federico Zeri).
Lungo i secoli, l’amore umano era rimasto assente dai documenti canonici e ancor più da quella scienza teologica chiamata a distinguere il lecito e l’illecito degli accoppiamenti umani una scienza che si insegnava ai preti nei seminari perché potessero poi interrogare con adeguata competenza in confessione mariti e soprattutto mogli sulle loro pratiche sessuali.
Ben diverso dal voyerismo mediato dallo schermo televisivo, la confessione ha consentito per secoli di vedere e ancor più di dirigere gli attori nei gesti e nelle tecniche del momento della riproduzione. Su questo sfondo l’apparizione della parola "amore" in un documento ufficiale cattolico sul matrimonio dette l’impressione di una svolta, di una volontà di riprendere contatto con la vita e coi sentimenti reali di donne e uomini, considerati non più solo come "fedeli", cioè passivamente obbedienti.
Oggi si riapre la questione della contraccezione. Il rapporto coniugale cessa di essere visto come il disegno complessivo di una storia di rapporti umani per tornare a frammentarsi nella meccanica della riproduzione, analizzata nelle sue sequenze da uno sguardo estraniato e sospettoso. Verrà ascoltato questo appello? Il Papa lo ha formulato cercando di conciliarlo col linguaggio del testo conciliare ma tornando sul terreno delle istruzioni tecniche. Lo ha fatto richiamando in vigore quel dispositivo della "Humanae vitae" con cui Paolo VI cercò di mettere il vino nuovo dell’amore umano negli otri antichi di una teologia morale impegnata a sorvegliare gli accoppiamenti, a insinuare tra moglie e marito la presenza del prete.
È un segno dei tempi che nello stesso momento giunga tra le mani dei lettori la riflessione del cardinal Martini su questo punto: nientedimeno che una domanda di perdono per la "Humanae vitae". Ripercorrendo il pontificato di Paolo VI il cardinale milanese ha scritto parole dense e pesanti sulla frattura che si è creata con quella enciclica oggi riattualizzata dal papa. La gioventù ha detto Martini ha cessato di chiedere alla Chiesa della "Humanae vitae" istruzioni per l’uso. È avvenuta una frattura di cui il Papa è stato invitato a tenere conto. Riconosciamo in queste parole l’esistenza di un mondo cattolico che non ha dimenticato quel documento conciliare e che non ha cessato di interrogarsi sulla realtà dei tempi e dei sentimenti.
Nella società descritta dal cardinale milanese il messaggio di Benedetto XVI rischia fortemente di cadere nel vuoto, come lui stesso ha mostrato di rendersi conto. Il documento papale è dunque con ogni evidenza una risposta all’appello del cardinal Martini.
Una risposta eloquente che documenta in quale direzione il pontificato attuale intende muoversi. Del resto, anche prescindendo dalla lettura di quella pagina del cardinal Martini, al pontefice romano non poteva essere sfuggito un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti: è proprio l’amore umano la molla che ha contribuito a rendere oceanici i raduni giovanili nei grandi eventi pubblici così amati in Vaticano. Un amore con largo uso di contraccettivi "non naturali": lo testimoniano le descrizioni di quel che si trova sui prati quando la festa finisce.
E allora, perché tornare su quell’antico deposito di istruzioni tecniche? La domanda si aggiunge alle tante a cui oggi cercano di rispondere i vaticanisti, una specializzazione del sapere giornalistico che si coltiva soprattutto in Italia.
Una cosa è certa: la questione della contraccezione sembra toccare ben poco l’opinione pubblica italiana. Il problema della contraccezione e più in generale dell’educazione sessuale è drammatico non da noi ma nei paesi di quegli altri mondi che compongono la geografia della fame e della sete. In Italia il passaggio dalla crescita demografia record del "crescete e moltiplicatevi" alla denatalità anch’essa da record è avvenuto con una rottura improvvisa e radicale, da parte di un popolo che si riteneva complessivamente cattolico ma non prestava molta attenzione agli avvertimenti ecclesiastici.
E tuttavia è facile prevedere che avremo altre occasioni di tornare sull’argomento. Questo appello fa parte di un’offensiva in atto sui diritti e le possibilità di scelta di tutti noi, credenti e non credenti. Diritti relativi ai momenti cruciali dell’esistenza: la nascita, la morte. Il matrimonio non poteva mancare: ma è come la tessera di un puzzle che viene collocata al suo posto. Senza particolare convinzione. Non è la più importante.
-
-
> SESSO (EROS) E AMORE (CHARITAS). COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota di Federico La Sala17 maggio 2007, di Federico La Sala
Intervista ad Alice Walker
di Lauren Wilcox (trad. M.G. Di Rienzo) *
Alice Walker è scrittrice, poeta e saggista. Le sue opere, tra cui la più famosa è sicuramente “Il colore viola”, sono state tradotte in più di venti lingue.
Lauren Wilcox: Nei tuoi lavori, romanzi o no, hai scritto moltissimo delle donne: le loro vite, i loro ruoli, le loro lotte. Sarei curiosa di conoscere la tua opinione rispetto al ruolo delle donne in comunità che funzionano, il ruolo di donne forti in relazione con gli uomini.
Alice Walker: E’ il punto cruciale dell’intera faccenda. Se le donne non hanno controllo sulle proprie scelte, sul proprio ambiente di vita, se sono continuamente espropriate da parte degli uomini nelle loro società, significa che non hanno l’autonomia necessaria a far sì che le loro esistenze e quelle delle loro figlie si realizzino pienamente. E’ così assolutamente essenziale che siamo in molti a studiare i modi per sostenere queste donne. Ed è una cosa non facile, se ci rifletti, perché persino nella nostra cultura ci sono troppe donne abbattute dal potere patriarcale che neppure pensano di doversi mettere insieme a organizzare dei cambiamenti. Naturalmente non possiamo farlo noi per loro. Ma possiamo dir loro di basarsi sulle proprie esperienze per pianificare le azioni che elevino il livello di salute e benessere per tutti, nelle loro comunità, ma in special modo per loro stesse e le loro figlie. Quando le donne ottengono dei miglioramenti, come sappiamo, le vite di tutti migliorano.
Lauren Wilcox: Hai scritto storie di donne ambientate in diversi periodi storici e nel presente. Credi che in generale la situazione delle donne sia cambiata in meglio, attraverso gli anni?
Alice Walker: Quello che mi viene in mente è l’ultima volta che sono stata in Africa, a Bolgatanga, nella parte nord del Ghana. La mia amica Pratibha Parmar, la regista cinematografica, ed io eravamo là come conseguenza del lavoro che avevamo fatto per eliminare le mutilazioni genitali. Era un’enorme assemblea, di uomini e donne, i più decisi “abolizionisti” della pratica che io avessi mai conosciuto. E’ stato commovente. Ciò che ho capito tramite l’incontro con queste persone è che nei posti più remoti che si possa immaginare vi sono connessioni con il resto del mondo, e vi è una buona comprensione del fatto che le cose stanno cambiando, e che devono cambiare per la salvezza del continente intero. Non si tratta del tuo villaggio, e neppure del tuo paese: la questione concerne la salute del continente e la salute del pianeta Terra.
Lauren Wilcox: Tutto il tuo scrivere ha elementi di attivismo, di consapevolezza delle durezze e delle lotte che le persone affrontano durante le loro vite. E’ uno scopo, nella tua scrittura, un attivismo intenzionale?
Alice Walker: La mia scrittura è olistica. Immaginami come un albero di pino. Da me non verrà nulla che non sia pino. Ho le mie pigne, i miei aghi di pino, il mio profumo specifico. Io vedo la scrittura come la mia ragione d’essere. Non è una parte preziosa della mia esistenza. Come per il pino è lasciar cadere e ricrescere... è un tutt’uno.
Lauren Wilcox: Perciò scrivere è il modo in cui realizzi pienamente ciò che sei?
Alice Walker: Sì. E’ il modo in cui dai acqua e fertilizzanti al pino. Continui a crescere, continui a condividere, continui a dare e ad avere e continui a lasciar andare. In questo circolo c’è il fattore di sostenibilità, che sostiene te stessa. Ma non ti sostieni trattenendo le cose. Ti sostieni lasciandole andare.
Lauren Wilcox: Dandole via, donandole?
Alice Walker: Sì. Nella nostra cultura, tutti sentono di dover conservare, tenere, trattenere, e non passare in giro nulla. Quando fai questo, che può accadere al resto del pianeta, se non morire di fame?
Lauren Wilcox: Qual è la cosa migliore che possiamo insegnare ai nostri figli, secondo te, per prepararli al futuro?
Alice Walker: Dobbiamo disabituarli alla nozione della scarsezza. Penso che si tratti del pensiero globale più pernicioso e definitivamente distruttivo, la nozione che viviamo in un mondo di scarsità. In effetti, viviamo invece in un mondo d’abbondanza. Ed è solo perché alcune persone si sono prese la maggior parte delle risorse per sé e sprecano le altre in guerra che altre persone non hanno nulla. Non c’è scusa possibile, per il fatto che le persone sulla Terra non hanno cibo sufficiente, abiti, istruzione e accesso all’assistenza sanitaria. Nessuna scusa, nessuna.
Lauren Wilcox: Come hai cominciato ad interessarti delle istanze relative alla fame ed alla povertà?
Alice Walker: Perché sono cresciuta nella povertà. Noi bambini non la percepivamo come tale solo perché i nostri genitori erano dei geni nel trarre molto dal poco. Ad un certo punto mio padre chiese alla proprietaria bianca della terra che lavoravamo un aumento di stipendio, chiese di avere dodici dollari al mese, perché aveva otto figli e tutti lavoravano nella piantagione. La donna divenne una furia e glielo negò. Non avevamo assistenza sanitaria, un dentista non l’abbiamo mai visto, dovevamo spostarci ogni anno su pezzi di terra diversi e lavoravamo duramente per tutto il giorno. E questa è la situazione per milioni e milioni di persone sulla Terra. Li capisco benissimo, e sono totalmente solidale con loro.
Lauren Wilcox: So che hai scritto un nuovo libro.
Alice Walker: Si chiama “Noi siamo coloro che stavamo aspettando”. E’ una raccolta di saggi, e di meditazioni, perché penso che questo sia un periodo in cui le cose sono davvero orribili per troppe persone. C’è così tanta paura, e così tanta tristezza, e rabbia... Non abbiamo bisogno solo di analisi politiche e di consapevolezza, ma abbiamo bisogno di meditazioni, di sederci assieme alle cose che ci stanno accadendo e di trovare modi per essere interi. Dobbiamo ricordare a noi stessi che abbiamo i nostri spiriti, e che possiamo usarli: usare la nostra luce interiore, per dissipare il buio che si addensa.
* IL DIALOGO, Giovedì, 17 maggio 2007
-
> SESSO (EROS) E AMORE (CHARITAS). COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota di Federico La Sala23 giugno 2007, di Federico La Sala
MEDIOEVO
Il binomio di mistica e carnalità nei trattati cristiani del XII secolo in un volume della Fondazione Valla curato da Zambon
Quell’amore senza misura
Guglielmo di Saint-Thierry: «Che rapporto c’è fra la conoscenza razionale di Dio e l’esperienza della caritas?»
di Gianfranco Ravasi (Avvenire, 23.06.2007)
È come un respiro d’amore che sembra alitare su tutto il XII secolo. Abelardo ed Eloisa intrecciano mistica e carnalità; fiorisce il grande mito di amore-passione che ha in Tristano e Isotta la sua rappresentazione simbolica; i trovatori intonano i loro canti amorosi nel nome di Lancillotto; la misteriosa Maria di Francia lancia al cielo i versi dei suoi Lais e Chrétien di Troyes intesse in un romanzo amore e sacramento, mentre per le strade gorgheggiano non solo i cantori della lirica cortese ma anche le voci ben più corpose e sensuali dei goliardi. Ma a risuonare con una solennità e una potenza espressiva e ideale particolare è la parola della teologia che s’intride d’amore avendo come ovvio codice capitale di riferimento il Cantico dei cantici biblico, naturalmente passato attraverso il filtro dell’allegoria che alla coppia originaria del poemetto sacro assegna le fisionomie di Cristo, il mistico amante, e della Chiesa o dell’anima innamorata.
Bene ha fatto, perciò, Francesco Zambon, uno dei maggiori esperti di storia e dottrina dei Catari medievali, a costruire un dittico testuale (per ora è apparso solo il primo tomo) - nell’importante collana degli «Scrittori greci e latini» della Fondazione Valla - raccogliendo proprio i più significativi trattati teologici dedicati a questo amore che si consuma nell’intimità delle anime ma non disprezza la simbolica dell’eros, sempre però alla luce dell’asserto giovanneo del Deus caritas est.
Nella prima tavola di questo dittico teologico, aperto da un esergo scandito da una folgorante citazione del grande mistico musulmano del IX-X sec. al-Hallaj, sono di scena due figure massime del Medioevo. Ecco campeggiare innanzitutto l’abate Guglielmo di Saint-Thierry, un monastero benedettino a una decina di chilometri da Reims: il suo nome sarà per sempre associato a quel monastero, anche se nell’ultima intensa parabola della sua vita egli si ritirerà come semplice monaco in un’abbazia cistercense sperduta tra le foreste delle Ardenne e frequenterà, nella stessa area, la prima fondazione certosina di Mont-Dieu. Di questo fremente teologo dall’intelligenza cristallina, morto nel 1148, vengono qui offerti due trattati, il De contemplando Deo, e il più ampio e articolato De natura et dignitate amoris. Solo per rendere la tonalità stilistica del nostro autore, basti leggere l’incipit del primo testo, segnato da un ammiccamento biblico a Genesi 22: «Venite, saliamo al monte del Signore... Attenzioni, intenti, volontà, pensieri, affezioni e tutto ciò che sta nel profondo di me: venite, saliamo sul monte, nel luogo in cui il Signore vede ed è veduto. Preoccupazioni, angosce, ansie, fatiche, pene della schiavitù, aspettatemi qui con l’asino, con questo corpo, finché io e il bambino, cioè la ragione e l’intelligenza, corriamo lassù e dopo aver adorato torniamo a voi...».
Passione e riflessione si mescolano anche nell’altro grande che qui è convocato, un personaggio così alto da aver conquistato Dante che lo vorrà come guida finale nell’empireo celeste (Paradiso XXXI), Bernardo di Clairvaux, morto nel 1153. Della sua vasta e straordinaria produzione letteraria viene offerto quel De diligendo Deo "L’amore di Dio") che nacque proprio dalle lunghe conversazioni del santo con Guglielmo di Thierry. E anche in questo caso basti solo evocare le righe d’avvio per coglierne la temperie, rigorosa e appassionata al tempo stesso: «La causa per cui si deve amare Dio è Dio stesso; la misura è amarlo senza misura».
Ma per procedere in questo itinerario, che è una festa dell’intelligenza e del cuore, è necessario ricorrere a un esercizio previo che aiuta a sciogliere il nodo teoretico centrale di queste e di altre riflessioni cristiane sull’amore. La domanda è formulata dal curatore Zambon nell’introduzione generale al dittico, un vero e proprio saggio di un centinaio di pagine: «Che rapporto c’è fra la conoscenza razionale di Dio e l’esperienza della caritas, dell’amore di Dio? La caritas comporta un qualche grado di conoscenza?». Sarà Guglielmo di Saint-Thierry ad appuntare la sua analisi teorica sistematica proprio su questo interrogativo, coniando una formula sintetica divenuta celebre e che non necessita di versione: Amor ipse intellectus est.
L’"intelletto d’amore" è, così, scavato in tutte le sue iridescenze e nei suoi percorsi che rivelano orizzonti inattesi, finemente illustrati da Zambon che conduce il lettore per mano attraverso sentieri d’altura. Così, si delinea quel "progresso dell’amore" che, per Guglielmo, parte dalla purificazione per approdare alla piena rinascita di quell’"immagine" divina impressa in noi nella creazione. Un itinerario di liberazione e di esaltazione che anche san Bernardo a suo modo illustra attraverso i famosi quattro gradi dell’amore: «l’uomo ama se stesso per se stesso»; «l’uomo ama Dio per se stesso», «l’uomo ama Dio per Dio stesso», in modo del tutto libero e gratuito; infine, «l’uomo non ama più se stesso se non per Dio», con uno svuotamento totale di se stesso per raggiungere l’unitas spiritus, l’estasi mistica con Dio. Un’occasione straordinaria, dunque, per ritrovare non solo l’atmosfera ideale di un secolo ma un’esperienza umana e spirituale che soprattutto oggi ci è necessaria. Tant’è vero che, proprio in contemporanea, è apparso in versione italiana presso l’editore senese Cantagalli il suggestivo saggio di Jean-Luc Marion, Il fenomeno erotico, che ci ripropone alcune questioni decisive: l’uomo è solo l’essere cartesiano che pensa o piuttosto è innanzitutto un essere che ama? L’uomo prima conosce e poi ama o è amando che conosce? L’amore fiorisce dalla conoscenza o è l’amore che la fa fiorire?
 TRATTATI D’AMORE CRISTIANI DEL XII SECOLO
TRATTATI D’AMORE CRISTIANI DEL XII SECOLO
 A cura di Francesco Zambon
A cura di Francesco Zambon
 Fondazione Valla - Mondadori
Fondazione Valla - Mondadori
 Pagine 317. Euro 27,00
Pagine 317. Euro 27,00-
> SESSO (EROS) E AMORE (CHARITAS). COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota di Federico La Sala17 giugno 2013, di John Mazzei
L’amore (“agàpe”): cosa non è e cosa è
Cosa non è Cosa è 1. Non è geloso 1. Longanime 2. Non si vanta 2. Benigno 3. Non si gonfia 3. Si rallegra della verità 4. Non si comporta 4. Copre ogni cosa indecentemente 5. Non cerca i propri 5. Crede ogni cosa interessi 6. Non si irrita 6. Spera ogni cosa 7. Non tiene conto del male 7. Sopporta ogni cosa 8. Non si rallegra dell’ingiustizia 9. Non viene mai meno
Geova umiliò Nabucodonosor perché si era vantato
Cord. Saluti a tutto lo staff Shalom
-
-