
LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera - di Federico La Sala
venerdì 31 agosto 2012.
- [...] Come Kafka - davanti alla legge, Freud ha "visto" la porta aperta e non ha capito [...] progressivamente, identificazione dopo identificazione, egli finisce per assumere la maschera del più terribile nemico della storia del suo popolo: non avendo vinto Roma (Annibale), non essendo giunto nella terra promessa (Mosè), si fa egiziano e diventa il Faraone con il cuore di pietra [49]. Chi osa pensare diversamente è subito espulso dal suo regno. Egli nega, rimuove, cancella le tracce ed ediphica. In un circolo vizioso si tengono insieme la Sfinge e la Piramide: l’una a salvaguardia dell’altra. Platone andò a scuola dai sacerdoti egiziani (Nietzsche), «Freud e Ferenczi si rifecero esplicitamente per fondare l’istituzione» alla Repubblica di Platone [50]. Il trionfo dell’ istinto di morte è garantito in "eterno" [...]
_________________________________
 IL PUNTO DI SVOLTA. L’INDICAZIONE DI FACHINELLI E LA SUA IMPORTANZA
IL PUNTO DI SVOLTA. L’INDICAZIONE DI FACHINELLI E LA SUA IMPORTANZA
 di Federico La Sala
di Federico La Sala
 da: La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-161.
da: La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica, Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-161.
«Ho cominciato a considerare con attenzione il concetto di bisessualità e considero la tua idea in proposito come la più significativa per il mio lavoro, dopo quella di "difesa"» (S. Freud a W. Fliess, 04.01.1898).
Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre»[1], Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto [2] de La mente estatica[3]. Dopo aver tentato, con coraggio e decisione, di passare di qua e di là, sembra che abbia trovato un passaggio decisivo, e riconquistato - al di là di una psicanalisi entrata concettualmente in irrimediabile crisi - la posizione originaria di Freud (come di ogni grande scienziato) di fronte all’inconscio e all’ignoto: «La rinuncia alla sopravvalutazione della qualità della coscienza diventa condizione prima indispensabile per qualsiasi visione esatta dello svolgimento dello psichico. Secondo l’espressione di Lipps, l’inconscio è il cerchio maggiore, che racchiude in sé quello minore del conscio [...] L’inconscio è lo psichico reale nel vero senso della parola, altrettanto sconosciuto - sottolinea Freud - nella sua natura più intima quanto lo è la realtà del mondo esterno, e a noi presentato dai dati della coscienza in modo altrettanto incompleto, quanto il mondo esterno dalle indicazioni dei nostri organi di senso»[4].
Con La freccia ferma [5], ma soprattutto con Claustrofilia[6], egli si era posto il problema di abbandonare la strada del "padre", ma molte erano ancora le resistenze e le paure. Lo sguardo era ancora quello di Freud: «Per indicare al lettore la via in cui mi muovo, vorrei citare - egli scrive - le parole di John Locke nell’Introduzione al Saggio sull’intelletto umano: «È di somma utilità al marinaio di conoscere la lunghezza della sua fune, anche se con essa egli non può scandagliare tutte le profondità dell’oceano. È bene che egli sappia che essa è abbastanza lunga per raggiungere il fondo in quei luoghi che sono necessari per dirigere il suo viaggio e per avvisarlo delle secche che potrebbero rovinarlo. Il nostro compito non è quello di conoscere tutte le cose, ma solo quelle che concernono la nostra condotta». Questo passo stupendo - egli prosegue - coglie il nucleo del sapere scientifico in generale. Se non presumo troppo, mi piacerebbe che esso fosse anche l’emblema di quel particolare sapere - sulla fune e sull’oceano, come si vedrà - che qui cerco di sviluppare»[7].
Tuttavia fatti nuovi accadevano e nuove idee prendevano corpo: nel corso del lavoro analitico, un paziente lo butta e lo trattiene. nella linea d’ombra - e la "nave" resta immobile [8] - ma, poi, ne viene fuori e giunge a definire un’area dello sviluppo precoce - una zona in cui Freud non s’era mai avventurato - che chiama, appunto, area claustrofilica[9]. Con questa nuova acquisizione, e con la decisione di affrontare i problemi connessi alla nascita, il suo instabile equilibrio con Freud, con la psicanalisi, e, non ultimo, con l’oceano, si modifica profondamente.
Nel 1985, sulla spiaggia di san Lorenzo a mare, in un pomeriggio ventoso di settembre, guardando affascinato il nastro del mare, «dal fondo del torpore, quasi dal sonno, un pensiero solitario» emerge e lo conquista: «Dopo lo squarcio iniziale, la psicanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, controllare, stare attenti, allontanare... Ma certo, questo è il suo limite: l’idea di un uomo che sempre deve difendersi, sin dalla nascita, e forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato [...] Ma se questo è vero bisogna rovesciare la prospettiva, mettersi dall’altro lato (della barricata, mi viene da scrivere: ma usando questa parola, resto nell’ambito dell’arte militare). Non inibizione, rimozione, negazione, eccetera: i diversi stratagemmi, le difese parziali di un’impostazione difensiva generale»[10].
La suggestione lockeana viene lasciata cadere. La fune-coscienza, «come misura di tutto lo psichico»[11], è riconosciuta per quello che è - uno strumento funzionale a vecchie strategie, una metafora inadeguata per le nuove prospettive che si intravedono.
La questione, infatti, ora è decisamente un’altra: non si tratta solo di cambiare strada, si tratta soprattutto di cambiare "casa". Si tratta di ristrutturare la coscienza: trasformare una coscienza chiusa in una coscienza aperta [12], o, detto altrimenti, "passare" da una monade con porte e finestre sbarrate (o, addirittura, inesistenti - come la concepiva Leibniz) a una monade con porte e finestre aperte, sul mare. E il fulcro di questo movimento è individuato in una disposizione della coscienza caratterizzata dall’accoglimento e non dalla vigilanza, dall’intrepidezza, «atteggiamento infinitamente più ricco e alla fine forse più efficace» della paurosa prudenza di chi edifica ed innalza barriere e muraglie: «Quest’idea dell’accettare e della sua importanza - scrive Fachinelli -mi è venuta in forma pura, astratta, nel momento in cui assonnato, ho accettato e direi quasi ascoltato ciò che mi veniva da non so dove»[13].
Sembra un’indicazione di Heidegger [14], o, più generalmente, di qualche mistico, ma non è così. La ricerca di Fachinelli, invece, ha una densità specifica e una tensione tutta propria: si colloca all’interno di un orizzonte critico-’dialettico’ (per capirsi) e apre la strada a percorsi nuovi, verso una soluzione inaudita e (per molti versi) impensabile dell’oltrepassamento della metafisica e, insieme, dell’uomo da esso "prodotto".
Sulla spiaggia, dinanzi al mare. Una situazione banalissima può metaforizzarci in tutte le direzioni e in tutti i sensi. Chi viene proiettato a due passi e chi addirittura nell’universo. Chi nel più alto dei cieli e chi all’inferno. A ciascuno secondo la sua sapienza e a ciascuno secondo la sua capienza. Infiniti livelli. E tutto dipende dalla propria disponibilità ad accogliere. La cosa è concessa, non voluta - egoistamente.
Non si tratta né di arroganza, né di aristocraticismo, come potrebbe apparire a chi guarda superficialmente o, peggio, dall’alto del suo turrito castello: «E che volete far, Signor Sarsi, se a me solo - scrive Galilei nel Saggiatore - è stato conceduto di scoprir tutte le novità celesti, ed a niun altro nissuna?».
Ai miei occhi - scriveva Newton (e la considerazione vale anche per Galilei) - «appaio essere stato null’altro che un ragazzo intento a giocare sulla riva del mare, distraendomi di tanto in tanto con la scoperta di un ciottolo più liscio o di una conchiglia più aggraziata delle altre, mentre il grande oceano della verità si estende, del tutto sconosciuto, dinanzi a me»[15].
È vero che «gli uomini furono condotti allo studio della filosofia, come in realtà lo sono ancora oggi, dalla meraviglia»[16], ma è anche vero che questo vale per chi ha occhi per vedere, orecchie per sentire. A parità di condizioni, ciò che decide è la disponibilità ad accogliere, ad accettare, ad ascoltare, a vedere, quanto ci viene incontro o quanto ci sorprende e stupisce.
Siamo immersi in un oceano di luce (E=mc2), ma chi mai (fisico o no) ha avuto il coraggio di accogliere e allevare pensieri simili: «Che aspetto avrebbe il mondo se io mi trovassi a cavallo di un raggio di luce?»[17]. Einstein aveva sedici anni ed era studente di ginnasio, quando aprì la "porta" della sua coscienza a tali idee; ne aveva 26, nel 1905, quando in poche settimane scrisse il suo primo saggio - non solo sulla luce o, come dice il titolo, Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento - sulla teoria della relatività speciale (o ristretta) e aprì la strada a «un intero continente di nuove idee» (J. Thomson). Ricordando con piacere questo periodo, molto tempo dopo, Einstein ebbe a dire a Leo Szilard: «Sono stati gli anni più felici della mia vita. Nessuno s’aspettava da me che fossi la gallina dalle uova d’oro»[18].
L’"avventura" di Fritjof Capra non è iniziata diversamente: «In un pomeriggio di fine estate, seduto in riva all’oceano, osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio respiro, quando all’improvviso ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. Essendo un fisico, sapevo che la sabbia, le rocce, l’acqua e l’aria che mi circondavano erano composte da molecole e da atomi in vibrazione, e che questi a loro volta erano costituiti da particelle che interagivano fra loro creando e distruggendo altre particelle. Sapevo anche che l’atmosfera della Terra era continuamente bombardata da una pioggia di raggi cosmici, particelle di alta energia sottoposte a urti molteplici quando penetrano nell’atmosfera. Tutto questo mi era noto dalle mie ricerche nella fisica delle alte energie, ma fino a quel momento ne avevo avuto esperienza attraverso grafici, diagrammi e teorie matematiche. Sedendo su quella spiaggia, le mie esperienze precedenti presero vita; vidi "scendere" dallo spazio esterno cascate di energia, nelle quali si creavano e si distruggevano particelle con ritmi pulsanti; "vidi" gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo partecipare a questa danza cosmica di energia; percepii il suo ritmo e ne "sentii" la musica; e in quel momento seppi che questa era la danza di Siva, il Dio dei Danzatori adorato dagli Indù»[19].
Sulla spiaggia. Tenere aperta la coscienza sull’orizzonte marino: una preziosa indicazione, da coniugare con quest’altra - «l’accoglimento non è simmetrico alla difesa». Qui non si parla di un banale capovolgimento (tipo, al posto dell’io l’es) o di azzeramento di uno dei due poli della relazione (riduzionismo e hybris-dismo, in un senso o nell’altro). Si indica e si parla di una metamorfosi connessa alla scoperta e all’utilizzo di un altro piano (sempre negato e rimosso) della "casa", che da sempre abitiamo: «c’è un funzionamento diverso, un’altra logica»[20]. Non si tratta più né di barricarsi, vigilare, difendersi, né di armarsi e andare all’attacco; si tratta di accogliere. Accogliere: femminile ... un altro "raggio di luce". Si tratta di capire, di rendersi conto che il femminile è «nel cuore, il cuore di molte esperienze», «anche di questa - precisa Fachinelli - mia esperienza»[21].
Senza equivoci e senza serrate. Il messaggio non è per soli uomini o per sole donne (per uomini soli o per donne sole). Né è ai soli travestiti che egli pensa [22]. Si parla e si tratta del venir fuori dalla trappola (o dalla gabbia) in cui tutti siamo. È a W. Reich che occorre pensare: «Fondamentalmente la vita è semplice. La complica solo la struttura umana, quando è caratterizzata dalla paura di vivere».
Fachinelli ha ripreso le indicazioni di Reich [23] e le "stravolge": l’attenzione deve essere spostata, non si tratta né di demolire né di saltare oltre le barriere, ma «piuttosto di lasciar affluire, lasciar defluire», e, così, «i paletti della difesa finiranno, forse, per scendere alla deriva»[24]. Non servono né i carri armati né gli astuti r-aggiramenti: quando si lasciano affluire e si lasciano defluire le cose, le cortine di ferro cadono da sole. Accogliere, si tratta di ripartire da questo punto di vista nuovo: «Le cose che vengono da un’altra parte: come un accento imprevisto che muta, che sposta l’intera figura. Da questo punto di vista, limiti ben evidenti della psicanalisi. E limiti ben evidenti dell’antropologia fondata su di essa»[25].
Né demonizzare, né omologare [26]. Accogliere: femminile... qui la questione non è solo e più psicanalitica. L’indicazione è più profonda di quanto non sembri. Non solo mette in discussione la psicanalisi e l’antropologia fondata su di essa (nel senso attivo e passivo), ma offre elementi preziosi per focalizzare meglio il vortice che muove il più generale processo di riorientamento gestaltico che è attualmente in corso in molti e diversi campi del sapere contemporaneo [27].
È, per dirla in breve, una "chiave" decisiva per aprire finalmente le porte e le finestre della coscienza dell’intera storia occidentale: svegliarsi dal sonno della ragione narcisista e imperialista, che sogna il «Dov’era l’Es, deve divenire l’Ego» (Freud), e di riconoscere i molteplici, infiniti, altri modi di essere e di creare; e liberarsi sia di quelle concezioni astoriche e asociali, pessimistiche e catastrofiche, che ci vogliono porcospini o lupi («Homo homini lupus: chi ha il coraggio - scrive Freud ne Il disagio della civiltà - di contestare quest’affermazione dopo tutte le esperienze della vita e della storia?»), sia della malattia delle catene (Nietzsche) che esse comportano. Per uscire dalla preistoria (Marx), molte sono le chiavi di cui abbiamo bisogno. Ma questa fornita da Fachinelli, sembra essere tra le più importanti - riguarda noi, il soggetto.
È in questa direzione che Fachinelli sollecita a pensare: «Al momento di diventare sciamani, si dice, gli uomini cambiano sesso. È così posta in rilievo la profondità del mutamento necessario. Il femminile come atteggiamento recettivo non abolisce però il maschile, gli propone un mutamento parallelo»[28]. A tal punto, però, inoltrandosi e inoltrandoci nel «mare aperto» (l’espressione è nietzscheana), si aprono prospettive vertiginose e problemi a non finire: venir fuori «da interi millenni di labirinto» (Nietzsche) è impresa non disperata, ma delicata - è un sogno d’amore, ad occhi aperti [29].
Arianna offre a Teseo il filo, ma non lo fa per dar vita a un’altra thalassocrazia. Fachinelli guarda a Creta -«Cnosso, Pesto, le potenze aperte sull’orizzonte marino»[30] - ma non è lì il luogo per nascere o, se si vuole, per passare. Né «Nausicaa, Ulisse», né «le regge di Creta aperte verso il mare, senza difese»[31]. Qui siamo nel regno di Edipo, entro cui è rimasto prigioniero lo stesso Freud [32]. A Creta c’è Minosse, Pasifae, il Mino-tauro e il labirinto. Arianna abbandonata da Teseo salirà sul carro di Dioniso-Ade, Teseo uccide (fa morire) il padre e andrà (con Giasone, il monosandalos) alla conquista del vello d’oro (la madre): c’è il vicolo cieco, per entrambi. E’ la tragedia dell’eterno ritorno della volontà di potenza - un gioco sisifoideo [33].
Idea dell’accettare e sua importanza: questa è la "piccola porta" [34] attraverso cui Fachinelli esce dall’orizzonte freudiano. E grazie all’aiuto dello stesso Freud: "Il sogno osa generalmente di più di quanto si permetta il sognatore da sveglio. Di qui, l’idea di Freud di trasferire questo oltrepassamento alla coscienza vigile, nella cura dei nevrotici. Il sogno testimonia ciò che vuoi essere - ciò che puoi essere, allora" [35]. Il pensiero, invero, è alquanto oscuro e criptico, ma cerchiamo di capire e chiarire.
La cosa è importante. Da essa dipende - se è bene impostata la "reazione" - la "fusione nucleare" della coscienza, "a freddo".
"Traduciamo" e generalizziamo. Chi entra nello stato di sonno e sogna, nel sogno si comporta diversamente da come si comporta nello stato di veglia. Freud, avendo capito che "lo stato di sonno rende possibile la formazione del sogno, in quanto riduce la censura endopsichica»[36], ha cercato di trasferire e ottenere - nello stato di veglia - il tipo di coscienza propria del sogno. Egli non vi è riuscito: le ragioni sono proprio nelle modalità ("a caldo") che egli sceglie, soluzioni prevalentemente figlie di una intelligenza armata e astuta - quella di Ulisse e della sua dea protettrice, Atena.
Fachinelli si rende ben conto di tutto questo ma, sopravvivendo in lui ancora toni venatorii e thalassocratici (Creta, Ulisse, cacciatori, tagliole e «altre immagini di taglio»), non riesce a comprendere a pieno tutta la portata dell’idea dell’accettare. Ad ogni modo la "fusione" è avvenuta ed egli ha fatto passi da gigante in questa direzione.
Raccogliendo ed esplicitando, possiamo dire che la coscienza - facendosi accogliente - "fonde" e libera energie come prospettive in tutte le direzioni, sia nello stato di veglia sia nello stato di sonno, e sia in direzione dell’inconscio sia in direzione dell’ignoto.
Contemporaneamente, scompare l’assolutezza e l’onnipotenza di quella modalità della coscienza che «conferisce un privilegio generalmente sovrano alla difesa»[37] e si autopone come coscienza tout court, ed emergono dal buio (anche del tempo) altri modi di "abitare" (non esistono solo le casematte o i castelli), che soltanto superficialmente possono essere accostati a quelli concepiti secondo la logica della difesa: «Diminuzione della vigilanza, allentamento della difesa. Allentamento nel sogno, nel fantasticare, nell’inventare, nell’usare droghe - insomma in quella phantastica umana dove, a tratti, passa un messaggio inatteso»[38].
Sulla spiaggia, dinanzi al mare... riaffiora la domanda di Galilei: «Chi vorrà asserire, già essersi saputo tutto quello che è al mondo di scibile?».
L’orizzonte si ristruttura, si arricchisce, si allarga e si illumina - vertiginosamente. Oltre Aristotele. Oltre Freud: «II concetto di difesa definiva all’inizio le difficoltà e le impasses di un comportamento alterato; rapidamente è diventato normativo, capace di stabilire leggi e criteri, anche per il comportamento non alterato. E questo perché si è presupposta implicitamente una continuità tra l’uno e l’altro. L’anormale è diventato, con qualche differenza quantitativa, il normale»[39].
Oltre la psicanalisi - lettino di Procuste: «Miseria incurabile della teoria della sublimazione, che tenta di spiegare ciò che, se è sublime, è sublime sin dal principio. La psicanalisi dischiara: ecco un letterato chiaramente nevrotico; un filosofo ossessivo; un matematico quasi psicotico, un musicista autistico... Ma la legna da ardere non spiega di per sé il divampare del fuoco»[40].
Oltre Freud... riappare Nietzsche. Non c’è più un sopra e un sotto, un alto e un basso: «Chi può stabilire che cos’è essenziale e non essenziale, importante e non importante? Chi può giurare: questo è il centro e quella la periferia?»[41]. Ritroviamo questioni vitali di politica dell’esperienza [42]: «E oltre, il territorio della mistica. Non la religione istituita. Ma la mistica come zona irriducibile, inassimilabile, refrattaria alla religione stessa. Apex mentis. Mistica che è nello stesso tempo rapporto percettivo, percezione possibile ad alcuni, se non comune a tutti. Molte mistiche? evitare i codici che, invariabilmente, da sempre rifiutano o sequestrano questi tipi di esperienze»[43].
La ridefinizione del rapporto tra veglia e sonno è nel programma di Freud: «[...] lo stato di sonno rende possibile la formazione del sogno, in quanto riduce la censura endopsichica. Certo, siamo tentati di considerare questa conclusione come l’unica possibile in base ai dati di fatto dell’oblio dei sogni, e di sviluppare partendo da essa altri corollari sui rapporti energetici tra sonno e veglia. Ma per ora intendiamo fermarci qui [...] Qui interrompiamo per riprendere più oltre»[44].
Ma oltre, egli non è mai andato. Resterà per lo più confinato entro le coordinate cartesiane, a riguardo. La sua attenzione rimarrà fissamente legata alla censura e non verrà mai più fuori dalla logica oppositiva di una intelligenza armata ed astuta. Cercherà di vincere le resistenze, di sorprendere il "nemico", di abbattere le difese, ma l’impresa si fa interminabile e ... fallimentare [45]. Anzi, l’effetto sarà solo quello di caricare la coscienza sempre più di armi e di chiuderla entro un grande sistema di fortificazioni: «Dentro il suo castello dalle sette mura, la principessa non riesce più a muoversi»[46].
Come Kafka - davanti alla legge, Freud ha "visto" la porta aperta e non ha capito, non è entrato: «La resistenza al fatto che i pensieri del sogno divengono coscienti può forse essere aggirata anche senza dover subire in sé una riduzione»[47]. La paura del guardiano della soglia (il padre) lo ha bloccato e, passato l’attimo, la porta si è richiusa. Per tutta la vita, poi, tenterà ancora e insistentemente di entrare, cercherà di abbattere o di aggirare la porta, ma non ci riuscirà. Edipo abbatte il primo ostacolo (uccide il padre), abbatte il secondo ostacolo (la sfinge - madre cattiva), ma finisce sempre per sposare la madre e prendere il posto del padre. Un tentativo impossibile. Dal cerchio non si esce, il complesso edipico non è risolvibile [48]; e la sconfitta personale viene teorizzata ed elevata a legge - per tutti, dappertutto e per sempre. Girando, girando, alla fine, il Conquistador (così Freud si definiva: «niente altro che un conquistador per temperamento - un avventuriero, se volete tradurre il termine») - realizzata la sua «accumulazione originaria» (Il Capitale) - si da ad innalzare la sua Piramide (Teoria) e la sua Sfinge (Istituzione) intorno alla "sua" proprietà: «La psicanalisi - scrive nel 1914 - è una mia creazione».
Su questa strada, progressivamente, identificazione dopo identificazione, egli finisce per assumere la maschera del più terribile nemico della storia del suo popolo: non avendo vinto Roma (Annibale), non essendo giunto nella terra promessa (Mosè), si fa egiziano e diventa il Faraone con il cuore di pietra [49]. Chi osa pensare diversamente è subito espulso dal suo regno. Egli nega, rimuove, cancella le tracce ed ediphica. In un circolo vizioso si tengono insieme la Sfinge e la Piramide: l’una a salvaguardia dell’altra. Platone andò a scuola dai sacerdoti egiziani (Nietzsche), «Freud e Ferenczi si rifecero esplicitamente per fondare l’istituzione» alla Repubblica di Platone [50]. Il trionfo dell’ istinto di morte è garantito in "eterno"...
Ma con la morte non si scherza - «il deserto cresce: guai a colui che nasconde in sé dei deserti»[51]. Nella notte più buia, nessuna maschera può aiutare a nascondersi e nessun lampo di genio può aiutare a vedere - come Dante sapeva (Inf., III, v. 9), ogni egoica speranza e ogni motto di spirito (WITZ) debbono essere lasciati fuori (AUS-CH). Forse, dinanzi alla prova più tragica che il suo popolo (nonostante tutto) ed egli stesso stava per affrontare, Freud, infine, avrà capito e deposto le armi della sua intelligenza, e si sarà piegato («la più scottante mortificazione») a quella verità da lui stesso acquisita nel corso dell’indagine, «che non solo egli [l’Io] non è padrone in casa propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a quello che avviene»[52].
«Segnale dell’avvenire»[53]. Nella comunicazione presentata al Convegno Internazionale su «Psicanalisi Psichiatria Antipsichiatria», tenutosi a Milano nel 1969, e intitolata significativamente e provocatoriamente «Che cosa chiede Edipo alla sfinge?», l’analista «dissidente» interroga la psicanalisi e gli stessi psicanalisti. E contro quella che è divenuta ormai solo una «psicanalisi della risposta»[54], Fachinelli riafferma tutto il valore - e tutta la centralità - dell’«ascolto analitico», e sollecita i suoi colleghi a «un lavoro senza fissa dimora, per così dire», a costituire anche «in altri luoghi condizioni, possibilità, linguaggio dell’interrogazione analitica»[55]. Sicuro di sé, egli annuncia sviluppi futuri. Tra le righe, qui, già si legge una tensione profonda a ripensare il discorso epistemologìco dalle radici, al di là della tradizione baconiana e kantiana [56]: alla base e all’inizio del lavoro scientifico, c’è l’ascolto - o, per dirlo con la consapevolezza sopraggiunta, l’accoglimento - non l’interrogazione; l’interrogazione viene dopo.
Fiducioso, egli così conclude il suo intervento: «Mi sembra chiaro che in queste direzioni ci incontreremo con altri ricercatori - sociologi, psichiatri, psicologi, antropologi - non certo in vista di una eclettica collaborazione interdisciplinare, come si usa dire e fare, ma perché avremo scoperto un luogo di base da cui partire per ricerche differenziate e molto spesso divergenti, se non in aperta polemica fra loro. Soprattutto però mi sembra chiaro che reincontreremo, sulla strada di Tebe, una sfinge senza più maschera, e un soggetto, di cui non conosciamo ancora il nome col quale potremo forse scambiare giuste domande e giuste risposte»[57].
Andando avanti e riemerso dal gorgo claustrofilico si ritrova davanti questioni decisive, fondamentali, non più annullabili, né rinviabili: Istinto di morte e conoscenza; Psicoanalisi della nascita e castrazione umana; La marionetta e il burattino [58]... È in gioco la vita, la vita o la morte «dell’Io in un senso non psicologico» [59], soltanto.
Giunto «sulla spiaggia», Fachinelli ritrova se stesso, e, al contempo, non trova più il Conquistador, ma lo scienziato, l’uomo accogliente e creativo - il Freud che sapeva del mare [60]. E, così, il dialogo come la discussione si riapre e si reimposta, correttamente.
Con Freud, oltre - in una nuova direzione e in modo nuovo: contro le sfingi e contro l’imbalsamazione degli uomini come delle teorie. Di fronte a Freud Fachinelli, finalmente, si pone come Galilei dinanzi ad Aristotele, come un ricercatore dinanzi a un altro ricercatore: «Aristotele fu un uomo, vedde con gli occhi, ascoltò con gli orecchi, discorse col cervello. Io sono un uomo veggo con gli occhi, e assai più che non vedde lui: quanto al discorrere, credo che discorresse intorno a più cose di me; ma se più o meglio di me, intorno a quelle che abbiamo discorso ambedue, lo mostreranno le nostre ragioni, e non le nostre autorità»[61].
Sulla spiaggia, davanti al mare, tutto acquista un’altra dimensione e appare nella sua luce più propria: «Progetto infantile: svuotare il mare con un secchiello! O setacciarne la sabbia. Anche il progetto di Freud - prosciugare l’inconscio, come la civiltà ha prosciugato lo Zuiderzee - è infantile»[62]. I libri di Aristotele stanno al gran libro dell’universo, come i libri di Freud stanno al mare: una proporzione preziosa e tuttavia incolmabile.
Di fronte all’inconscio come di fronte all’ignoto, non c’è hybris che duri. Accogliere: femminile... non è cosa di poco conto. Comporta un radicale rivolgimento del nostro atteggiamento di pensiero. Ed è, forse, una delle condizioni essenziali per concepire diversamente la storia...
Già solo quella della psicoanalisi è tutta da riscrivere. Da questo nuovo punto di vista, accolto,il contributo e il ruolo sponsale di Breuer e di Fliess prima, e di tanti altri "eretici" dopo, rispetto alla «straordinaria fecondità»[63] di Freud, è tutto da riconsiderare. Il non accettare la propria femminilità - fino a scambiarla e a ridurla a omosessualità - ha portato direttamente Freud e la psicanalisi nel buio più nero.
Aprendo la Piramide e accogliendo la luce, si potrebbe riprendere il cammino dall’inizio - con Breuer, con Fliess e con Freud, insieme. È l’unico filo che ci è rimasto, per uscire dal labirinto - non quello di Arianna, ma quello di Bloch: la Speranza [64]. Ricominciare proprio dall’idea abbandonata, dalla "figlia" di Fliess e Freud: «E ora la cosa più importante! Il mio prossimo libro, per quanto posso vedere, si intitolerà La bisessualità nell’uomo; investigherà la radice del problema e dirà l’ultima parola, che mi sarà permesso di dire, sull’argomento; l’ultima e la più profonda... L’idea stessa è tua. Ricorderai che ti dicevo anni fa, quando tu eri ancora specialista del naso e chirurgo, che la soluzione risiedeva nella sessualità. Anni dopo tu mi correggesti e dicesti bi-sessualità, e vedo che hai ragione. Probabilmente dovrò prendere a prestito ancora di più da te e forse sarò spinto dall’onestà a chiederti di apporre la tua firma al mio libro; ciò significherebbe un’estensione della parte anatomico-biologica, che a me riuscirebbe assai scarsa. Per parte mia dovrei occuparmi dell’aspetto mentale della bi-sessualità e della spiegazione del lato nevrotico. Questo dunque è il mio prossimo progetto che spero ci unirà ancora nella ricerca scientifica»[65].
Su questa strada, poi, non potremmo non riaprire la questione della fecondità, e ripensarla in tutta la sua portata e in tutta la sua importanza - come una decisiva categoria ontologica, secondo l’indicazione di Lévinas.
In tale direzione - tenendo presente che «l’origine biologica di questo concetto non neutralizza in alcun modo il paradosso del suo significato e delinea una struttura che va al di là dell’empiria biologica»[66] - forse, potremo comprendere (finalmente e meglio) che «la fecondità fa parte del dramma stesso dell’io», che «la fecondità attesta un’unità che non si oppone alla molteplicità, ma, nel senso preciso del termine, la genera»[67], e così aprirci a nuove possibilità e nascere a un avvenire che non sia - ancora una volta e sempre - «un avvenire del Medesimo»[68].
L’accogliere: femminile... mina alla radice il «narcisistico godimento» di quel soggetto che «vuole signoreggiare in sé e intorno a sé e sentirsi padrone», che «possiede la volontà di ridurre il molteplice all’unità» e, «subordinato un impulso apparentemente antitetico», una «erompente risoluzione all’ignoranza, al volontario isolamento, un serrar le proprie finestre, un intimo dir di no a questa o quella cosa, un non lasciarsi avvicinare, una sorta di condizione difensiva contro quel molto che può essere conosciuto, un contentarsi dell’oscuro, dell’orizzonte che rinchiude, un dir di sì e un consentire all’ignoranza»[69]; e pone all’ordine del giorno - in modo inedito - la realizzazione del sogno illuministico: l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità il quale è da imputare a lui stesso[70].
NOTE
 1 E. Fachinelli, Il bambino dalle uovo d’oro. Brevi scritti con testi di Freud, Reich, Benjamin e Rose Thè, Milano, Feltrinelli, 1974, p. 9.
1 E. Fachinelli, Il bambino dalle uovo d’oro. Brevi scritti con testi di Freud, Reich, Benjamin e Rose Thè, Milano, Feltrinelli, 1974, p. 9.
 2 Questo scritto era già apparso in «Lettera Internazionale», 6, 1985.
2 Questo scritto era già apparso in «Lettera Internazionale», 6, 1985.
 3 E. Fachinelli, La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989.
3 E. Fachinelli, La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989.
 4 S. Freud, L’interpretazione dei sogni, Torino, Boringhieri, 1973, p. 553.
4 S. Freud, L’interpretazione dei sogni, Torino, Boringhieri, 1973, p. 553.
 5 E. Fachinelli, La freccia ferma. Tre tentativi di annullare il tempo, Milano, edizioni L’Erba Voglio, 1979.
5 E. Fachinelli, La freccia ferma. Tre tentativi di annullare il tempo, Milano, edizioni L’Erba Voglio, 1979.
 6 E. Fachinelli, Claustrofilia. Saggio sull’orologio telepatico in psicanalisi, Milano, Adelphi, 1983.
6 E. Fachinelli, Claustrofilia. Saggio sull’orologio telepatico in psicanalisi, Milano, Adelphi, 1983.
 7 E. Fachinelli, Claustrofilia, cit., p. 12.
7 E. Fachinelli, Claustrofilia, cit., p. 12.
 8 J. Conrad, La linea d’ombra, Torino, Einaudi, 1989. A riguardo, cfr. la bella recensione di A. Asor Rosa, La nave è immobile, «La Repubblica», 22.3.1989.
8 J. Conrad, La linea d’ombra, Torino, Einaudi, 1989. A riguardo, cfr. la bella recensione di A. Asor Rosa, La nave è immobile, «La Repubblica», 22.3.1989.
 9 E. Fachinelli, Claustrofilia, cit., p. 11.
9 E. Fachinelli, Claustrofilia, cit., p. 11.
 10 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 15-6. "
10 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 15-6. "
 11 Ibid., p. 18.
11 Ibid., p. 18.
 12 In analogia, cfr., già, le riflessioni su «Gruppo aperto o gruppo chiuso?», in E. Fachinelli, Il bambino..., cit., pp: 114-141.
12 In analogia, cfr., già, le riflessioni su «Gruppo aperto o gruppo chiuso?», in E. Fachinelli, Il bambino..., cit., pp: 114-141.
 13 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
13 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
 14 M. Heidegger, L’abbandono, Genova, II melangolo, 1983.
14 M. Heidegger, L’abbandono, Genova, II melangolo, 1983.
 15 La citazione, notissima, è ripresa da: J. Bronowski, L’ascesa dell’uomo. Storia dell’evoluzione culturale, Milano, Fabbri Editori, 1976, p. 234.
15 La citazione, notissima, è ripresa da: J. Bronowski, L’ascesa dell’uomo. Storia dell’evoluzione culturale, Milano, Fabbri Editori, 1976, p. 234.
 16 Aristotele, Metafisica, Libro I, 982 b, 10.
16 Aristotele, Metafisica, Libro I, 982 b, 10.
 17 J. Bronowski, op. cit., pp. 245-7. A riguardo, cfr. anche E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 69.
17 J. Bronowski, op. cit., pp. 245-7. A riguardo, cfr. anche E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 69.
 18 J. Bronowski, op. cit., pp. 252-254.
18 J. Bronowski, op. cit., pp. 252-254.
 19 F. Capra, Il Tao della fisica, Milano, Adelphi, 1982, pp. 11-12. «La scoperta del parallelo fra i koan zen e i paradossi della fisica quan¬tlstica [...] stimolò grandemente il mio interesse per il misticismo orientale e acuì la mia attenzione [...] La scoperta di queste somiglianze non fu dapprima nulla più di un esercizio intellettuale, anche se molto stimolante, ma poi, in "un tardo pomeriggio dell’estate del 1969, ebbi un’esperienza molto intensa che mi fece considerare con molta maggiore
serietà i paralleli tra fisica e misticismo» (cfr. F. Capra, Verso una nuova saggezza. Conversazioni con Gregory Bateson, Indira Gandhi, Werner Heisenberg, Krishnamurti, Ronald David Laìng, Ernest F. Schumacher, Alan Watts e altri personaggi straordinari, Milano, Feltrinelli, 1988, pp. 26-27). Altri noti lavori sono: F. Capra, Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente, Milano, Feltrinelli, 1984, e, F. Capra - C. Spretnak, La politica dei verdi, Milano, Feltrinelli, 1986.
19 F. Capra, Il Tao della fisica, Milano, Adelphi, 1982, pp. 11-12. «La scoperta del parallelo fra i koan zen e i paradossi della fisica quan¬tlstica [...] stimolò grandemente il mio interesse per il misticismo orientale e acuì la mia attenzione [...] La scoperta di queste somiglianze non fu dapprima nulla più di un esercizio intellettuale, anche se molto stimolante, ma poi, in "un tardo pomeriggio dell’estate del 1969, ebbi un’esperienza molto intensa che mi fece considerare con molta maggiore
serietà i paralleli tra fisica e misticismo» (cfr. F. Capra, Verso una nuova saggezza. Conversazioni con Gregory Bateson, Indira Gandhi, Werner Heisenberg, Krishnamurti, Ronald David Laìng, Ernest F. Schumacher, Alan Watts e altri personaggi straordinari, Milano, Feltrinelli, 1988, pp. 26-27). Altri noti lavori sono: F. Capra, Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente, Milano, Feltrinelli, 1984, e, F. Capra - C. Spretnak, La politica dei verdi, Milano, Feltrinelli, 1986.
 20 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
20 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
 21 Ibid., p. 21.
21 Ibid., p. 21.
 22 Su questo, cfr. la coraggiosa e importante prefazione al libro di fotografìe di Lisetta Carmi, I travestiti, Roma, Essedì Editrice; e l’articolo Travestiti, «L’erba voglio», 11, 1973, ripreso poi in: E. Fachinelli, Il bambino..., cit., pp. 202-211. Qui, anche, già si "covano uova" che saranno deposte poi «Sulla spiaggia».
22 Su questo, cfr. la coraggiosa e importante prefazione al libro di fotografìe di Lisetta Carmi, I travestiti, Roma, Essedì Editrice; e l’articolo Travestiti, «L’erba voglio», 11, 1973, ripreso poi in: E. Fachinelli, Il bambino..., cit., pp. 202-211. Qui, anche, già si "covano uova" che saranno deposte poi «Sulla spiaggia».
 23 Su W. Reich, cfr. E. Fachinelli, Il bambino..., cit., pp. 52-70.
23 Su W. Reich, cfr. E. Fachinelli, Il bambino..., cit., pp. 52-70.
 24 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 21.
24 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 21.
 25 Ibid., p. 24.
25 Ibid., p. 24.
 26 L’espressione è ripresa da quell’interessante e coraggioso libro che «cerca di muoversi nello spazio etico che si trova tra demonizzazione e omologazione sulla base dell’idea che entrambi gli atteggiamenti vivano male la trascendenza dell’altro» di F. Cassano (Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro, Bologna, II Mulino, 1989, p. 8). Il tema centrale della sua riflessione è molto prossimo al tema dell’accogliere: si tratta di «deporre l’elmo» (p. 9) dell’intelligenza astuta e armata, quello di Atena-Metis. L’invito a non demonizzare e a non omologare è rivolto, per quanto riguarda la ricerca di Fachinelli (ma la cosa vale anche per quella di Cassano, come qualcuno ha già fatto), a S. Vegetti Pinzi, che chiude una sua recensione de La mente estatica (cfr. Dalla psicoanalisi all’estasi un viaggio della conoscenza, «Corriere della sera», 30.4.1989) con la seguente considerazione: «Si tratta, come è evidente, di una indagine ad alto rischio dove la psicoanalisi, sganciata dalla pratica clinica e dalla referenza teorica, esplora i territori dell’immaginario e le potenzialità della suggestione».
26 L’espressione è ripresa da quell’interessante e coraggioso libro che «cerca di muoversi nello spazio etico che si trova tra demonizzazione e omologazione sulla base dell’idea che entrambi gli atteggiamenti vivano male la trascendenza dell’altro» di F. Cassano (Approssimazione. Esercizi di esperienza dell’altro, Bologna, II Mulino, 1989, p. 8). Il tema centrale della sua riflessione è molto prossimo al tema dell’accogliere: si tratta di «deporre l’elmo» (p. 9) dell’intelligenza astuta e armata, quello di Atena-Metis. L’invito a non demonizzare e a non omologare è rivolto, per quanto riguarda la ricerca di Fachinelli (ma la cosa vale anche per quella di Cassano, come qualcuno ha già fatto), a S. Vegetti Pinzi, che chiude una sua recensione de La mente estatica (cfr. Dalla psicoanalisi all’estasi un viaggio della conoscenza, «Corriere della sera», 30.4.1989) con la seguente considerazione: «Si tratta, come è evidente, di una indagine ad alto rischio dove la psicoanalisi, sganciata dalla pratica clinica e dalla referenza teorica, esplora i territori dell’immaginario e le potenzialità della suggestione».
 27 Uno per tutti, cfr. il testo di F. Capra, Verso una nuova saggezza..., cit., nota 19.
27 Uno per tutti, cfr. il testo di F. Capra, Verso una nuova saggezza..., cit., nota 19.
 28 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 21-22.
28 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 21-22.
 29 II primo riferimento è a M. [Lea] Melandri, Come nasce il sogno d’amore, Milano, Bompiani, 1988; il secondo è a uno dei temi centrali dei lavori di M. Fagioli, Istinto di morte e conoscenza; La marionetta e il burattino; Psicoanalisi della nascita e castrazione umana, Roma, Armando Editore, rispettivamente del 1972, 1974, e 1975. I due richiami, ovviamente, non sono affatto casuali, rispetto alla ricerca portata avanti in questi anni da Fachinelli. Di M. Melandri ricordo ancora l’altro suo importante lavoro, L’infamia originaria, Milano, edizioni L’Erba Voglio, 1977.
29 II primo riferimento è a M. [Lea] Melandri, Come nasce il sogno d’amore, Milano, Bompiani, 1988; il secondo è a uno dei temi centrali dei lavori di M. Fagioli, Istinto di morte e conoscenza; La marionetta e il burattino; Psicoanalisi della nascita e castrazione umana, Roma, Armando Editore, rispettivamente del 1972, 1974, e 1975. I due richiami, ovviamente, non sono affatto casuali, rispetto alla ricerca portata avanti in questi anni da Fachinelli. Di M. Melandri ricordo ancora l’altro suo importante lavoro, L’infamia originaria, Milano, edizioni L’Erba Voglio, 1977.
 30 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
30 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
 31 Ibid., p. 16.
31 Ibid., p. 16.
 32 «Freud è interamente compreso nella rete del complesso di Edipo» (cfr. E. Fachinelli, II bambino..., cit., p. 154).
32 «Freud è interamente compreso nella rete del complesso di Edipo» (cfr. E. Fachinelli, II bambino..., cit., p. 154).
 33 Su questi problemi, cfr. F. La Sala, Le "regole del gioco" dell’Occidente e il divenire accogliente della mente [di seguito, in La mente accogliente...cit., pp.162-189].
33 Su questi problemi, cfr. F. La Sala, Le "regole del gioco" dell’Occidente e il divenire accogliente della mente [di seguito, in La mente accogliente...cit., pp.162-189].
 34 Ogni secondo, nel tempo, "era la piccola porta da cui poteva entrare il Messia" sono le ultime parole delle Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin (cfr. W. Benjamin, Angelus Novus, Torino, Einaudi, 1962, p. 63). Il richiamo è voluto. Fachinelli, infatti, ha sempre posto e dedicato molta attenzione all’opera di Benjamin, cfr. Il bambino... cit., pp. 158-168, e La mente estatica, cit., p. 42 e nota. e pp. 90-92.
34 Ogni secondo, nel tempo, "era la piccola porta da cui poteva entrare il Messia" sono le ultime parole delle Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin (cfr. W. Benjamin, Angelus Novus, Torino, Einaudi, 1962, p. 63). Il richiamo è voluto. Fachinelli, infatti, ha sempre posto e dedicato molta attenzione all’opera di Benjamin, cfr. Il bambino... cit., pp. 158-168, e La mente estatica, cit., p. 42 e nota. e pp. 90-92.
 35 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 20.
35 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 20.
 36 S. Freud, L’interpretazione..., cit., p. 477.
36 S. Freud, L’interpretazione..., cit., p. 477.
 37 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 19-20.
37 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 19-20.
 38 Ibid., p. 20.
38 Ibid., p. 20.
 39 lbid., pp. 23-24
39 lbid., pp. 23-24
 40 Ibid., p. 24.
40 Ibid., p. 24.
 41 Ibid., p. 23.
41 Ibid., p. 23.
 42 R.D. Laing, La politica dell’esperienza, Milano, Feltrinelli, 1968;e, ancora, R.D. Laing, Nascita dell’esperienza, Milano, Mondadori, 1982.
42 R.D. Laing, La politica dell’esperienza, Milano, Feltrinelli, 1968;e, ancora, R.D. Laing, Nascita dell’esperienza, Milano, Mondadori, 1982.
 43 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 24.
43 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 24.
 44 S. Freud, L’interpretazione..., cit., p. 477.
44 S. Freud, L’interpretazione..., cit., p. 477.
 45 «Un’analisi basata sistematicamente sullo smantellamento delle difese incontra ad ogni passo quel pericolo che le ha fatte erigere. [...] L’analisi assume allora il senso di un decondizionamento ad infinitum. Interminabilità, eccetera» (cfr. E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 20-21).
45 «Un’analisi basata sistematicamente sullo smantellamento delle difese incontra ad ogni passo quel pericolo che le ha fatte erigere. [...] L’analisi assume allora il senso di un decondizionamento ad infinitum. Interminabilità, eccetera» (cfr. E. Fachinelli, La mente estatica, cit., pp. 20-21).
 46 Ibìd., p. 22.
46 Ibìd., p. 22.
 47 S. Freud, L’interpretazione..., cit., p. 477.
47 S. Freud, L’interpretazione..., cit., p. 477.
 48 S. Freud, Il tramonto del complesso edipico, in: S. Freud, La vita sessuale, Torino, Boringhieri, 1970, pp. 209-217.
48 S. Freud, Il tramonto del complesso edipico, in: S. Freud, La vita sessuale, Torino, Boringhieri, 1970, pp. 209-217.
 49 Nota è la costante attenzione e ambivalenza di Freud nei confronti di Mosè. Dal 1934 al 1938, Freud lavora a L’uomo Mosè e la religione monoteistica (Torino, Boringhieri, 1977), e in quest’opera egli avanza e fa sua l’ipotesi che «Mosè è un egiziano probabilmente di origine nobile che il mito ha fatto ebreo».
49 Nota è la costante attenzione e ambivalenza di Freud nei confronti di Mosè. Dal 1934 al 1938, Freud lavora a L’uomo Mosè e la religione monoteistica (Torino, Boringhieri, 1977), e in quest’opera egli avanza e fa sua l’ipotesi che «Mosè è un egiziano probabilmente di origine nobile che il mito ha fatto ebreo».
 50 E. Fachinelli, Il bambino..., cit., p. 243.
50 E. Fachinelli, Il bambino..., cit., p. 243.
 51 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, parte IV, «Tra le figlie del deserto».
51 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, parte IV, «Tra le figlie del deserto».
 52: S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Torino, Boringhieri, 1969, p. 258.
52: S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Torino, Boringhieri, 1969, p. 258.
 53 Questo è il titolo della sezione che comprende «Che cosa chiede Edipo alla sfinge?» e il «Programma per un teatro proletario di bambini» di Walter Benjamin, cfr. E. Fachinelli, Il bambino..., cit., p. 143.
53 Questo è il titolo della sezione che comprende «Che cosa chiede Edipo alla sfinge?» e il «Programma per un teatro proletario di bambini» di Walter Benjamin, cfr. E. Fachinelli, Il bambino..., cit., p. 143.
 54 Op. cit., p. 152.
54 Op. cit., p. 152.
 55 Ibid.,p. 155.
55 Ibid.,p. 155.
 56 Essa è condensata e condensabile nella considerazione kantiana, secondo cui «la ragione deve accostarsi alla natura, certo per venire ammaestrata da questa, non però nella qualità di uno scolaro, che si fa suggerire tutto ciò che vuole il maestro, bensì nella qualità di un giudice
investito della sua carica, il quale costringe i testimoni a rispondere alle domande che egli propone loro» (cfr. I. Kant, Critica della ragione pura, Prefazione alla seconda edizione, trad. it. di G. Colli, Milano, Adelphi, 1976, p. 21).
56 Essa è condensata e condensabile nella considerazione kantiana, secondo cui «la ragione deve accostarsi alla natura, certo per venire ammaestrata da questa, non però nella qualità di uno scolaro, che si fa suggerire tutto ciò che vuole il maestro, bensì nella qualità di un giudice
investito della sua carica, il quale costringe i testimoni a rispondere alle domande che egli propone loro» (cfr. I. Kant, Critica della ragione pura, Prefazione alla seconda edizione, trad. it. di G. Colli, Milano, Adelphi, 1976, p. 21).
 57 E. Fachinelli, Il bambino..., cit., p. 157.
57 E. Fachinelli, Il bambino..., cit., p. 157.
 58 Sono richiamati, ancora una volta, contro il generale e diffuso stile ediphicatorio, i lavori di M. Fagioli (espulso dalla Società Psicoanalitica Italiana, insieme ad A. Armando, agli inizi del 1976).
58 Sono richiamati, ancora una volta, contro il generale e diffuso stile ediphicatorio, i lavori di M. Fagioli (espulso dalla Società Psicoanalitica Italiana, insieme ad A. Armando, agli inizi del 1976).
 59 La citazione è ripresa da: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Torino, Einaudi, 1968, p. 181. La questione a cui si allude non è affatto da sottovalutare, è cruciale per Freud, per lo stesso Wittgenstein, come per noi: «L’Io, l’Io è il mistero
profondo!» (op. cit.). Questo è il nodo da sciogliere per uscire dallo «stato di minorità» edipico.
59 La citazione è ripresa da: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Torino, Einaudi, 1968, p. 181. La questione a cui si allude non è affatto da sottovalutare, è cruciale per Freud, per lo stesso Wittgenstein, come per noi: «L’Io, l’Io è il mistero
profondo!» (op. cit.). Questo è il nodo da sciogliere per uscire dallo «stato di minorità» edipico.
 60 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
60 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 23.
 61 G. Galilei, Il Saggiatore, in Opere, Edizione Nazionale, a cura di A. Favaro, 20 voll., Firenze 1929, voi. VI, p. 538. Sulla centralità di questo "atteggiamento" nel lavoro e nella ricerca di Galilei, cfr. U. Curi, Schemi logici e forme reali del sapere in Galilei, in: U. Curi, La linea divisa. Modelli di razionalità e pratiche scientifiche nel pensiero occidentale, Bari, De Donato, 1983, pp. 135-156.
61 G. Galilei, Il Saggiatore, in Opere, Edizione Nazionale, a cura di A. Favaro, 20 voll., Firenze 1929, voi. VI, p. 538. Sulla centralità di questo "atteggiamento" nel lavoro e nella ricerca di Galilei, cfr. U. Curi, Schemi logici e forme reali del sapere in Galilei, in: U. Curi, La linea divisa. Modelli di razionalità e pratiche scientifiche nel pensiero occidentale, Bari, De Donato, 1983, pp. 135-156.
 62 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 21.
62 E. Fachinelli, La mente estatica, cit., p. 21.
 63 Ibid., p. 180.
63 Ibid., p. 180.
 64 E. Bloch, Il princìpio Speranza (1954-1959). A riguardo, si tengano anche presenti le considerazioni di E. Paci sul tema «Modalità e novità in Bloch», in: E. Paci, Idee per una enciclopedia fenomenologica, Milano, Bompiani, 1973, pp. 576-586. In tale dirczione, forse, si potrà elaborare un nuovo percorso che non porti né tra le braccia del Freud conquistador, né tra le braccia dello Jung «mago-pastore, Seel-sorger» (cfr. E. Fachinelli, «A proposito di Jung», in Il bambino..., cit., p. 74), e né tra le braccia dello Hillman discepolo di Dioniso (cfr.
J. Hillman, Il mito dell’analisi, Milano, Adelphi, 1979, tutta la terza parte «Sulla femminilità psicologica», e, particolarmente, le pp. 279-307).
64 E. Bloch, Il princìpio Speranza (1954-1959). A riguardo, si tengano anche presenti le considerazioni di E. Paci sul tema «Modalità e novità in Bloch», in: E. Paci, Idee per una enciclopedia fenomenologica, Milano, Bompiani, 1973, pp. 576-586. In tale dirczione, forse, si potrà elaborare un nuovo percorso che non porti né tra le braccia del Freud conquistador, né tra le braccia dello Jung «mago-pastore, Seel-sorger» (cfr. E. Fachinelli, «A proposito di Jung», in Il bambino..., cit., p. 74), e né tra le braccia dello Hillman discepolo di Dioniso (cfr.
J. Hillman, Il mito dell’analisi, Milano, Adelphi, 1979, tutta la terza parte «Sulla femminilità psicologica», e, particolarmente, le pp. 279-307).
 65 S. Freud, Le origini della psicoanalisi: lettere a Wilhelm Fliess 1887-1902, Torino, Boringhieri, 1968, pp. 254-256 (lettera del 7 agosto 1901). - Per problemi e suggestioni connessi a tale linea di ricerca, cfr. F. La Sala, Le due metà del cervello, «Alfabeta», 17, 1980, p. 11, recensione del lavoro di P. Watzlawick, Il linguaggio del cambiamento, Milano, Feltrinelli, 1980. [Si cfr., inoltre AA.VV., I gemelli. Il vissuto del doppio, a cura di Liana Valente Torre, Firenze, La Nuova Italia, 1989].
65 S. Freud, Le origini della psicoanalisi: lettere a Wilhelm Fliess 1887-1902, Torino, Boringhieri, 1968, pp. 254-256 (lettera del 7 agosto 1901). - Per problemi e suggestioni connessi a tale linea di ricerca, cfr. F. La Sala, Le due metà del cervello, «Alfabeta», 17, 1980, p. 11, recensione del lavoro di P. Watzlawick, Il linguaggio del cambiamento, Milano, Feltrinelli, 1980. [Si cfr., inoltre AA.VV., I gemelli. Il vissuto del doppio, a cura di Liana Valente Torre, Firenze, La Nuova Italia, 1989].
 66 E. Lévinas, Totalità e Infinito, Milano, Jaca Book, 1980, p. 286. Polemizzando sia con l’empirismo sia con l’idealismo, Feuerbach già ne aveva intuito le ricche potenzialità: «Le idee scaturiscono soltanto dalla comunicazione, solo dalla conversazione dell’uomo con l’uomo. L’uomo si eleva al concetto, alla ragione in generale, non da solo, ma insieme con l’altro. Due uomini [esseri umani, fls] occorrono per creare l’uomo, sia l’uomo spirituale, sia quello fisico [...]» (cfr. L. Feuerbach, Prìncipi della filosofia dell’avvenire, Torino, Einaudi, 1971, 126).
66 E. Lévinas, Totalità e Infinito, Milano, Jaca Book, 1980, p. 286. Polemizzando sia con l’empirismo sia con l’idealismo, Feuerbach già ne aveva intuito le ricche potenzialità: «Le idee scaturiscono soltanto dalla comunicazione, solo dalla conversazione dell’uomo con l’uomo. L’uomo si eleva al concetto, alla ragione in generale, non da solo, ma insieme con l’altro. Due uomini [esseri umani, fls] occorrono per creare l’uomo, sia l’uomo spirituale, sia quello fisico [...]» (cfr. L. Feuerbach, Prìncipi della filosofia dell’avvenire, Torino, Einaudi, 1971, 126).
 67 E. Lévinas, op. cit., p. 282.
67 E. Lévinas, op. cit., p. 282.
 68 Ibid., p. 276.
68 Ibid., p. 276.
 69 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, af. 230, Milano, Adelphi, 1976, vol. VI, t. II, pp. 139-140.
69 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, af. 230, Milano, Adelphi, 1976, vol. VI, t. II, pp. 139-140.
 70 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?
70 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
 UNA QUESTIONE DI ECO. L’orecchio disturbato degli intellettuali italiani->undefined
UNA QUESTIONE DI ECO. L’orecchio disturbato degli intellettuali italiani->undefined
 DAL DISAGIO ALLA CRISI DI CIVILTA’: FINE DEL "ROMANZO" EDIPICO DELLA CULTURA CATTOLICO-ROMANA.
DAL DISAGIO ALLA CRISI DI CIVILTA’: FINE DEL "ROMANZO" EDIPICO DELLA CULTURA CATTOLICO-ROMANA.
 IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO di Sigmund Freud (1931).
IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO di Sigmund Freud (1931).
 EQUIVOCATO O EQUIVOCO? BENEDETTO XVI O BERLUSCONI, NESSUNO COMPRERA’ LE NOSTRE PAROLE
EQUIVOCATO O EQUIVOCO? BENEDETTO XVI O BERLUSCONI, NESSUNO COMPRERA’ LE NOSTRE PAROLE
 "GIUDITTA E OLOFERNE":DON PAOLO FARINELLA HA "SPOSATO" BERLUSCONI. E "HA TRADITO" (DA CITTADINO) LO SPIRITO DELLA COSTITUZIONE E (DA PRETE) LO SPIRITO DI DIO (AMORE - CHARITAS).
"GIUDITTA E OLOFERNE":DON PAOLO FARINELLA HA "SPOSATO" BERLUSCONI. E "HA TRADITO" (DA CITTADINO) LO SPIRITO DELLA COSTITUZIONE E (DA PRETE) LO SPIRITO DI DIO (AMORE - CHARITAS).
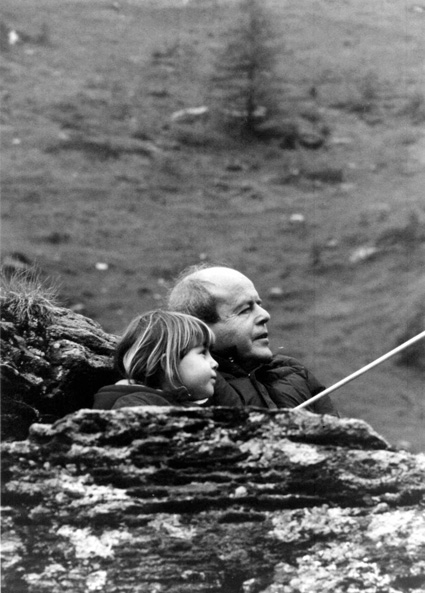

Forum
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- L’«URLO» DI «JUDITH SHAKESPEARE». UNA NOTA A MEMORIA DI VIRGINIA WOOLF.9 aprile 2025, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, “AGRICOLTURA”, E “DISAGIO DELLA CIVILTÀ” (S. FREUD, 1929):
L’«URLO» DI «JUDITH SHAKESPEARE».
- Un omaggio a “Phrasikleia” (Jesper Svenbro, 2024). *
A MEMORIA DI VIRGINIA WOOLF, a suo onore e gloria, forse, è bene rimeditare le sue stesse parole, “pronunciate” nella “conferenza” dedicata al tema di “Una stanza tutta per sé” (1929):
- “[...] sarebbe stato impossibile, completamente e interamente impossibile che una donna scrivesse nell’epoca di Shakespeare le opere di Shakespeare. Immaginiamo, giacché ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, diciamo.” (Virginia Woolf, “Romanzi e Altro”, Mondadori, Milano).
“TO BE, OR NOT TO BE - THAT IS THE QUESTION” (“HAMLET, III.1). Se si considera il luogo e la modalità della morte di Virginia Stephen Woolf, con i suoi particolari riferimenti (“appoggia il suo bastone da passeggio sull’argine dell’Ouse e poi si getta nelle acque del fiume”: https://www.lindau.it/Libri/La-morte-di-Virginia ), data la dichiarata “sorellanza” di “Judith” con “William Shakespeare” e la sua “urlata” domanda amletica sul «Chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna?», come non “registrare” (chissà se mai è stato fatto) la forte “consonanza” con il “racconto” della regina Gertrude sulla morte di Ofelia: “C’è un salice che cresce di traverso /a un ruscello e specchia le sue foglie /nella vitrea corrente; qui ella venne [...]” (“Amleto”, IV. 7)?!
 E, ancora, come non sollecitar-si a una rilettura delle opere degli “Shakespeare” e a una più ampia e profonda riflessione sulla “tragedia” della “zoppicante" e “cieca” questione antropologica, a partire dal “due”, dai “due soli” della "Monarchia” di Dante Alighieri e delle “tre corone” dello “Spaccio della bestia tropnfante” di Giordano Buno?!
E, ancora, come non sollecitar-si a una rilettura delle opere degli “Shakespeare” e a una più ampia e profonda riflessione sulla “tragedia” della “zoppicante" e “cieca” questione antropologica, a partire dal “due”, dai “due soli” della "Monarchia” di Dante Alighieri e delle “tre corone” dello “Spaccio della bestia tropnfante” di Giordano Buno?!*
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- ANTROPOLOGIA ANATOMIA E FILOSOFIA. UNA NOTA A MARGINE DEL TEMA "IL VASO DI LACAN" ("IL SEMINARIO", LIBRO X).21 marzo 2025, di Federico La Sala
PSICOANALISI ANTROPOLOGIA ANATOMIA E FILOSOFIA: "CLAUSTROFILIA" (ELVIO FACHINELLI, 1983) E "MENTE ACCOGLIENTE. Tracce per una svolta_antropologica" (Federico La Sala, 1991).
- In memoria di Enzo #Paci, di Elvio #Fachinelli e di Fulvio #Papi...
Una nota a margine dell’articolo di Gianfranco Ricci - Psicologo sul tema antropologico-psicoanalitico "Il vaso di Lacan" (v. allegato *):
Il "vas [o]" di "Lacan", a ben riflettere sulla "#concezione" lacaniana della donna e della #femminilità, è ancora pieno di memoria tragico-mammonico, di "spirito" #giocastolaio dello storico "compromesso olimpico" (apollineo-platonico-hegeliano e, "cum grano salis", nietzscheano).
PIANETA TERRA. Antropologicamente, e "terronicamente", invece, "uomo" e "donna" ("maschio" e "femmina"), sono, a "#coniugare" bene il discorso di #DanteAlighieri (come #RealdoColombo e #MichelangeloBuonarroti e #GiovanniValverde, e, ancora, di #GiordanoBruno, #GalileoG alilei e Immanuel #Kant), "#dueSoli" in Terra (illuminati) dal terzo "Sole" che è in Cielo. Questo attuale "presente storico", ormai, è, contro ogni evidenza, il tempo della Commedia, della #DivinaCommedia!
Il prossimo #25marzo 2025 è il giorno del #Dantedì, forse, è bene tenerne conto e uscire dal "#letargo" infernale.
- NOTA: COSMOTEANDRIA PLANETARIA. UN ANDROCENTRISMO TEOLOGICO-POLITICO DI LUNGA DURATA: TUTTI A CENA, AL "SIMPOSIO" DI PLATONE , IN UNA "CAVERNA A LUCI-FERINE ROSSE". TUTTI ACCALCATI NELLA "STANZA DELLA SEGNATURA" A "COPIARE" LA "SCUOLA DI ATENE" (RAFFAELLO, 1509-1511) E, OGNUNO PER SE’, CERCARE DI DIVENTARE "SAPIENTE" (1509-1510) COME BOVILLUS, UN SAGGISSIMO (ATEO E DEVOTO) DELL’ACCADEMIE DEL PIANETA TERRA. Nella «notte in cui tutte le vacche sono nere» o nel «dì in cui tutte le pecore sono bianche», si continua a in-segnare e in-sognare platonicamente, che, «rompendo l’uovo si fa sì l’Homo ma anche l’Hommelette» (Lacan).
*
IL VASO DI LACAN
di Gianfranco Ricci (20 mar 2024)
Jacques Lacan ha dedicato oltre trent’anni della sua vita all’insegnamento pubblico della psicoanalisi: le sue lezioni, raccolte nei celebri “Seminari”, erano un vero e proprio evento nella Parigi degli anni Sessanta e Settanta.
Nella sua ricerca, Lacan faceva riferimento ad altri grandi studiosi, come Jacobson, Sartre, Claude Levi - Strauss, Godel e molti altri.
In particolare, Lacan farà riferimento agli studi antropologici e culturali di Levi - Strauss per introdurre in psicoanalisi i tre registri che, per lo strutturalismo, organizzano la realtà: il simbolico, l’immaginario e il reale.
La prima fase dell’insegnamento di Lacan, gli anni della sua giovinezza, vedono al centro il registro dell’immaginario: sono gli anni della ricerca sulla psicosi e dello stadio dello specchio.
Il “Lacan classico” degli anni Cinquanta e Sessanta invece mette al centro della propria ricerca il primato del Simbolico sugli altri due registri: è il Lacan del “Ritorno a Freud” e dell’“inconscio strutturato come un linguaggio”.
Negli anni Settanta invece l’insegnamento di Lacan mette al centro il registro, criptico ed enigmatico, del Reale. Lacan cercherà in ogni modo di trattare il Reale: come definire il Reale? Lacan cerca di “bordarlo” da diversi versanti: il Reale sarebbe l’impossibile a dirsi, la dimensione del godimento, ciò che sfugge al simbolico, la pulsione, il registro della pulsione di morte.
Per affrontare il Reale, Lacan introdurrà la clinica dei nodi, detta anche “clinica Borromea”, in onore del nodo Borromeo. La clinica dei nodi cerca di superare la concezione classica della clinica psicoanalitica, mettendo al centro il modo unico e singolare in cui i tre registri si “annodano” tra loro nell’esperienza di ciascun paziente.
Abbiamo parlato della passione di Lacan per i nodi in questo articolo.
 Nel corso del Seminario X, dedicato all’angoscia, Lacan introduce una metafora affascinante per descrivere il Reale; lo fa tramite la figura del vaso.
Nel corso del Seminario X, dedicato all’angoscia, Lacan introduce una metafora affascinante per descrivere il Reale; lo fa tramite la figura del vaso.Come è fatto un vaso? Un vaso è un oggetto che “borda”, che circoscrive uno spazio, con vari scopi: metterci dei fiori e del terriccio, oppure dell’acqua o magari nulla!
L’uso che facciamo del vaso lo rende pieno o vuoto. Ma di per sé, al vaso manca qualcosa?
- Dice Lacan:
“Così si dice, per esempio, che il reale è sempre pieno. Fa un certo effetto, ha una certa qual aria che conferisce credito alla cosa, un’arietta come quella che tira dalle nostre parti, quella di un lacanismo di buona lega.
Chi può parlare del reale, se non io? Il guaio è che io non l’ho mai detto.
Il reale formicola di cavità, ci si può persino fare il vuoto.
Io dico una cosa completamente diversa, cioè che al reale non manca nulla.
Ho aggiunto, che se si fanno dei vasetti. anche quando li si fa tutti uguali, è sicuro che siano differenti...
La mia storia dei vasetti continua. Il momento successivo è che la loro identità - ossia ciò che è scambiabile fra i vasetti - è il vuoto attorno al quale un vasetto è fatto.
E il terzo tempo è che l’azione umana ha inizio quando questo vuoto viene barrato per essere riempito con quello che farà il vuoto del vasetto accanto, in altri termini quando per un vasetto essere mezzo-pieno è la stessa cosa che essere mezzo-vuoto.
Sempre che, evidentemente, il vasetto non perde da tutte le parti.
In tutte le culture possiamo essere certi che una civiltà è ormai completa e insediata quando si trovano le prime ceramiche. Talvolta contempo una bellissima collezione di vasi che ho nella mia casa di campagna. Manifestamente per quelle genti, alla loro epoca, come testimoniano molte altre culture, era quello il bene principale.
Anche se non siamo in grado di leggere quanto è magnificamente, lussuosamente dipinto sulla loro superfici, anche se non riusciamo a tradurlo in un linguaggio articolato di riti e miti, c’è una cosa che sappiamo, e cioè che in quel vaso c’è tutto.
Il vaso basta.
Il rapporto dell’uomo con l’oggetto e con il desiderio sta interamente lì, vi è percepibile e lì sopravvive.
È proprio questo a legittimare quel famoso vasetto di senape che ha fatto digrignare i denti ai miei colleghi per più di un anno, a tal punto che io, gentile come sempre, ho finito per riporlo sul ripiano dei vasetti della colla. E dire che mi serviva! Lo portavo come esempio del fatto che a tavola il vasetto di senape è sempre vuoto, come sapete per esperienza.” (Sem X, pag. 201)
 Con il suo stile ironico e canzonatorio, Lacan parla del “vasetto in quanto tale”, al di là della sua funzione e del suo uso: in questo senso, fuori dal simbolico della funzione, il vasetto non manca di nulla.
Con il suo stile ironico e canzonatorio, Lacan parla del “vasetto in quanto tale”, al di là della sua funzione e del suo uso: in questo senso, fuori dal simbolico della funzione, il vasetto non manca di nulla.Il vaso è per Lacan metafora della femminilità: i critici della psicoanalisi accusavano Freud di avere declassato la femminilità, riducendola ad una posizione di inferiorità rispetto al maschile, come se le mancasse qualcosa. Lacan farà ordine, ribadendo la natura simbolica e non reale della castrazione.
- Risponde quindi Lacan:
“Il vaso femminile è vuoto, è pieno? Che importanza ha dato che basta a se stesso, quandanche fosse per consumarsi stupidamente, come si esprime la mia paziente.
Non vi manca niente.
La presenza dell’oggetto è qui, se così possiamo dire, in sovrappiù. Perché? Perché è una presenza che non è legata alla mancanza dell’oggetto causa del desiderio al (-φ), al quale è collegata invece nell’uomo .
L’angoscia dell’uomo è legata alla possibilità di non potere.
Da qui, il mito, tutto maschile, che fa della donna l’equivalente di una delle sue costole. Gli è stata tolta una costola, non sappiamo quale, e del resto non gliene manca nessuna. Ma è chiaro che nel mito della costola si tratta proprio di quell’oggetto perduto.
La donna, per l’uomo, è un oggetto fatto di questo.” (Sem. X, pag. 205)
 Per approfondire:
Per approfondire:
 Jacques Lacan, Il Seminario, Libro X, L’angoscia.
Jacques Lacan, Il Seminario, Libro X, L’angoscia.Anche in Freud troviamo il vaso come oggetto metaforico per descrivere un aspetto della psiche. Ecco qui l’articolo in cui viene approfondito questo aspetto.
Il reale quindi, per Lacan, "non manca di nulla". Questo è un dettaglio decisivo: se l’immaginario si manifesta per la sua inconsistenza e il simbolico per la presenza stessa della mancanza e dell’incompletezza, il reale invece "non mancherebbe di nulla".
Pertanto, il reale segue una logica propria, quella del godimento e della soddisfazione, facendosi beffe dei limiti imposti dal simbolico.
[Gianfranco Ricci, 20 mar 2024.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- 25 NOVEMBRE 2024: DALLA "INFAMIA ORIGINARIA" (1977) ALLA "MENTE ESTATICA" (1989). In ricordo di Elvio Fachinelli, un omaggio a Lea Melandri.25 novembre 2024, di Federico La Sala
25 NOVEMBRE 2024: #DONNE, #UOMINI, #FILOLOGIA E #ANTROPOLOGIA #STORIA, #LETTERATURA, E #STORIOGRAFIA.
- In ricordo di #Elvio #Fachinelli, un omaggio a #Lea #Melandri
Nella "ricorrenza" della #giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne, una #domanda, una #questione #hamletica: #achegiocogiochiamo?, a che #giogo si continua ad #aggiogare?!
La "memoria" di una denuncia della "infamia #originaria, di un #tradimento strutturale della #fiducia di #lungadurata, "biblico".
- Nota:
- STORIA #LETTERATURA #ARCHEOLOGIA #PSICOANALISI E #ANTROPOLOGIA (#NEXOLOGIA #CHIASMATICA): L’#INDICAZIONE DI #ELVIOFACHINELLI.
 Pensare antropologica-mente permette di essere lungimiranti, in anticipo sui tempi (brevi e lunghi). Credo che, a questo punto (oggi, #24novembre), sia da segnalare anche (e ancora) l’opera di Elvio Fachinelli, "La mente #estatica" (Adelphi, 1989), e, ricordare, in occasione del prossimo #8dicembre, che Victor Hugo, nel 1831, fa "un gesto" nei confronti dei parigini e pubblica un libro, intitolato "Notre-Dame de Paris 1482"; questo stesso "gesto", una "subliminale" sollecitazione a ripensare a quel "libro di pietra", lo fa Sigmund Freud, il 14 giugno 1912, che manda in regalo una copia del "Notre-Dame de Paris" di #Hugo a Ludwig #Binswanger! Forse è è proprio il caso di svegliarsi dal #sonnodogmatico (#Kant), liberarsi dalla "claustrofilia" (#Fachinelli, 1983) e nascere, rinascere!
Pensare antropologica-mente permette di essere lungimiranti, in anticipo sui tempi (brevi e lunghi). Credo che, a questo punto (oggi, #24novembre), sia da segnalare anche (e ancora) l’opera di Elvio Fachinelli, "La mente #estatica" (Adelphi, 1989), e, ricordare, in occasione del prossimo #8dicembre, che Victor Hugo, nel 1831, fa "un gesto" nei confronti dei parigini e pubblica un libro, intitolato "Notre-Dame de Paris 1482"; questo stesso "gesto", una "subliminale" sollecitazione a ripensare a quel "libro di pietra", lo fa Sigmund Freud, il 14 giugno 1912, che manda in regalo una copia del "Notre-Dame de Paris" di #Hugo a Ludwig #Binswanger! Forse è è proprio il caso di svegliarsi dal #sonnodogmatico (#Kant), liberarsi dalla "claustrofilia" (#Fachinelli, 1983) e nascere, rinascere!
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA --- LA PSICOANALISI E I QUATTRO "MOSCHETTIERI": FREUD, ABRAHAMS, MUSATTI, E FACHINELLI.7 giugno 2024, di Federico La Sala
LA PSICOANALISI E I QUATTRO "MOSCHETTIERI": FREUD ("L’UOMO DEI TOPI"), ABRAHAMS" (L’UOMO COL MAGNETOFONO"), MUSATTI ("CONDIZIONI DELL’ESPERIENZA E FONDAZIONE DELLA PSICOLOGIA") E FACHINELLI ("IL BAMBINO DALLE UOVA D’ORO". Appunti sul tema...
- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "#CRITICA DELLA RAGION PURA": VIVERE A #MILANO E NON CAPIRE UN #BISCIONE. CON #KANT, #FREUD, #MUSATTI, E #FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’#UOMO COL #MAGNETOFONO (J.-J. #ABRAHAMS) E UN PASSO OLTRE IL GEOCENTRISMO E L’#ANDROCENTRISMO EDIPICO ...
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA: "PSICHE E POLIS" (26 MAGGIO 2024). Alcuni "vecchi" appunti a margine del Congresso Nazionale della #Spi (Società Psicoanalitica Italiana).
- ANTROPOLOGIA E NEXOLOGIA CHIASMATICA: "IL BAMBINO DALLE UOVA D’ORO" (ELVIO FACHINELLI). "Con #Freud invece si apre il campo di una #ricerca sui rapporti interindividuali: comincia una sorta di #nexologia umana (dal latino: #nexus: legame, intreccio), che include il corpo come parte in causa e interlocutore. Di essa, la #psicanalisi comunemente intesa è solo un momento parziale, limitato, anche se di grande fecondità" (E. Fachinelli).
- A sua memoria, "vent’anni dopo" (1989-2009).
FACHINELLI intuì CHE J.-J.ABRAHAMS, L’UOMO COL MAGNETOFONO, ERA UN SINGOLARE (KIERKEGAARD) GATTO, MA GLI SFUGGì il legame CON I TOPI, CON LA "MOUSETRAP" DI "AMLETO" E L’OPERA DI ALEXANDRE DUMAS.
- PSICOANALISI E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD, 1937): "L’UOMO DEI TOPI" (1909).
"L’uomo dei topi fu un caso clinico affrontato da hashtag#SigmundFreud e pubblicato come Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose ("Note su un caso di nevrosi ossessiva") (1909).
 Il soprannome deriva dal fatto che il paziente aveva sviluppato una serie di fantasie ossessive in cui, nelle parole di Freud, i "topi avevano acquisito una serie di significati simbolici ai quali... continuamente venivano aggiunti di nuovi". "Uomo dei topi" è uno dei tanti pseudonimi che utilizzava Freud per proteggere l’anonimato dei propri pazienti (come quelli di "Anna O.", "Hans", "Dora", "Uomo dei lupi", ecc.). [...]".
Il soprannome deriva dal fatto che il paziente aveva sviluppato una serie di fantasie ossessive in cui, nelle parole di Freud, i "topi avevano acquisito una serie di significati simbolici ai quali... continuamente venivano aggiunti di nuovi". "Uomo dei topi" è uno dei tanti pseudonimi che utilizzava Freud per proteggere l’anonimato dei propri pazienti (come quelli di "Anna O.", "Hans", "Dora", "Uomo dei lupi", ecc.). [...]".
ANTROPOLOGIA PSICOLOGIA E NEXOLOGIA CHIASMATICA: "ACHERONTA MOVEBO". Aprire gli occhi (Freud), tutti e due, è difficile, ma solo sciogliendo il nesso ("nexus") tragico, il nodo edipico, è possibile uscire dall’orizzonte della tragedia e della claustrofilia (Elvio Fachinelli, 1983) e andare oltre le colonne d’#Ercole e, con Virgilio e Dante, oltre... "Sàpere aude! (Orazio-Kant).
- "Il selvaggio Abrahams: tra Bolaño e Basaglia". Una recensione del libro (ristampato nel 2017) di Piero Cipriano: "Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina (Introduzione e cura di),
- Un singolare gatto selvatico. Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono, Ombre Corte, Verona, 2017, pp. 152, € 14,00
- Un singolare gatto selvatico, sottotitolo Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono, libro a cura di Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina, edito da Ombre Corte, è un libro che mi ha incuriosito molto, ma non certo perché ho a cuore le sorti della psicanalisi, di cui non mi importa granché, ma perché sapevo che entrambi i miei demoni, il demone della letteratura [...]".
PSICOANALISI (NEXOLOGIA) E ANTROPOLOGIA CHIASMATICA: CON KIERKEGAARD ("AUT - AUT"), OLTRE. Mi auguro che le poche indicazioni date siano buone sollecitazioni a riprendere il filo: "L’uomo dei topi" è "radioattivamente" carico di teoria. Freud s’è l’è portato dietro tutta la vita, fino alle "costruzioni nell’analisi" (1937) e oltre.
DA FREUD A FACHINELLI: CON KIERKEGAARD, OLTRE. "L’uomo col magnetofono", fondamentalmente, è lo stesso Fachinelli (v. "La parola contaminata", nel testo), andato a "scuola" di Cesare Musatti, e, al contempo, critico nel rapporto con la Società Psicoanalitica Italiana (che ancora oggi si attarda a parlare alla Platone, "Psiche e Polis").
Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- PSICOANALISI E PSICHIATRIA: UNA CITAZIONE IN MEMORIA DI FRANCO BASAGLIA E DI FRANCA ONGARO BASAGLIA.11 marzo 2024, di Federico La Sala
CREATIVITÀ E SOCIETÀ: ARITMETICA, PSICHIATRIA, PSICOANALISI, E COSTITUZIONE (#Europa2024: #Francia)
- "L’ISTITUZIONE NEGATA" (FRANCO BASAGLIA,1968) E UNA QUESTIONE DI FILOLOGIA E DI ANTROPOLOGIA (DA PORRE ALL’ORDINE DEL GIORNO, PER EVITARE... UN ARROSSIMENTO GENERALE).
Una "citazione" in memoria di FRANCO BASAGLIA E DI FRANCA ONGARO:
"un’operazione matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (Franca Ongaro Basaglia, "Donna", Enciclopedia, V, Einaudi, Torino 1978).
NOTE:
- "La #clinica dopo #Basaglia: [...] L’#istituzione #negata è una singolare linea di derivazione. Come in #matematica la #singolarità è un punto dove una curva cambia radicalmente e fa nascere l’imprevedibile; oppure in musica, quando si tratta di una variazione repentina - come in alcune composizioni di Schoenberg, o nell’improvvisazione jazz. Se la matematica e la #musica sono all’altezza di gestire la #complessità dei propri contenuti, trasformando i propri limiti in nuove frontiere della #conoscenza - nel primo caso - e in nuove esperienze della sensibilità uditiva e ritmica - nel secondo caso -, perché la società non dovrebbe favorire variazioni esistenziali dello stesso tipo? Se un nuovo teorema e un nuovo brano musicale sono forme della #creazione umana, perché la follia non può esserlo? [...]" (cfr. Pietro Barbetta, "#Doppiozero", 11 Marzo 2024).
- ANTROPOLOGIA #PSICOANALISI E #8MARZO2024: RICORDANDO #DANTEALIGHIERI E I #DUESOLI DELLA SUA #MONARCHIA, RIPENSARE L’#UNO, ri-#pensare l’#ONU - a partire da #Due, "almeno due" (Gregory Bateson).
- CON #BATESON, OLTRE #VERSAILLES: LA FRANCIA, CON UN PASSO DECISIVO, SI E’ PORTATA (E IN-#VITA A PORTARSI) COSTITUZIONAL-MENTE OLTRE L’ORIZZONTE DEMIURGICO DELL’#ANDROCENTRISMO DELLA #TRAGEDIA E HA RESTITUITO ALLA #DONNA LA SUA "KANTIANA" FACOLTA’ DI #GIUDIZIO.
- RAPPORTO SOCIALE DI #PRODUZIONE E #RIPRODUZIONE: GENITORI E FIGLI. "ALBERTA BASAGLIA: “Non è tardi per parlare di mia #madre #FrancaOngaro e del suo ruolo nella rivoluzione che portò alla chiusura dei manicomi”
 La #psicologa, #figlia dello psichiatra #FrancoBasaglia, racconta nel libro "Contro tutti i muri" (Donzelli editore) il ruolo avuto dalla madre nel processo che portò alla #Legge180: "Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico. Ho il ricordo della presenza contemporanea di entrambi i miei #genitori inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di #cambiare il #mondo" (cfr. EmanueleSalvato, "Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2022).
La #psicologa, #figlia dello psichiatra #FrancoBasaglia, racconta nel libro "Contro tutti i muri" (Donzelli editore) il ruolo avuto dalla madre nel processo che portò alla #Legge180: "Sono convinta che mia madre abbia dato un apporto importante soprattutto in termini di concretezza del discorso teorico. Ho il ricordo della presenza contemporanea di entrambi i miei #genitori inseriti e attivi in questo gruppo di lavoro nel quale era evidente la volontà di #cambiare il #mondo" (cfr. EmanueleSalvato, "Il Fatto Quotidiano, 25 giugno 2022).
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- JUDITH (E LA "INVINCIBILE ARMATA"): VIRGINIA WOOLF, LA "SORELLA" DI WILLIAM SHAKESPEARE.26 luglio 2023, di Federico La Sala
ELEUSIS 2023
ANTROPOLOGIA STORIA FILOSOFIA FILOLOGIA E LETTERATURA:
VIRGINIA WOOLF E LA "PUPILLA" ("KORE", "FANCIULLA", "BAMBOLETTA") NELL’OCCHIO E NELLO SGUARDO DI SOCRATE E DI PLATONE. Alcuni appunti...
A) VIRGINIA WOOLF: "The eyes of others our prisons; their thoughts our cages" ("Short Stories").
B) PLATONE: "SOCRATE: Rifletti anche tu: se [l’iscrizione delfica] avesse rivolto un consiglio al nostro occhio, come se fosse un uomo, e gli avesse detto: «Guarda te stesso», che supposizione avremmo fatto su ciò a cui ci esortava? Non forse a guardare a quella cosa guardando alla quale l’occhio avrebbe visto se stesso?
 ALCIBIADE: è chiaro.
ALCIBIADE: è chiaro.
 SOCRATE: Riflettiamo: guardando a quale degli oggetti esistenti vediamo quello e contemporaneamente anche noi stessi?
SOCRATE: Riflettiamo: guardando a quale degli oggetti esistenti vediamo quello e contemporaneamente anche noi stessi?
 ALCIBIADE: è chiaro, Socrate, che dovremmo guardare a uno specchio o a qualcosa del genere.
ALCIBIADE: è chiaro, Socrate, che dovremmo guardare a uno specchio o a qualcosa del genere.
 SOCRATE: Quel che dici è giusto. Ma nell’occhio col quale guardiamo non c’è qualcosa di questo genere?
SOCRATE: Quel che dici è giusto. Ma nell’occhio col quale guardiamo non c’è qualcosa di questo genere?
 ALCIBIADE: Certamente.
ALCIBIADE: Certamente.
 SOCRATE: Hai notato dunque che quando guarda nell’occhio il volto si riflette nello sguardo di chi si trova di fronte come in uno specchio, cosa che chiamiamo anche pupilla (72 -> "kore", "còre"), dato che è come un immagine di chi guarda?
SOCRATE: Hai notato dunque che quando guarda nell’occhio il volto si riflette nello sguardo di chi si trova di fronte come in uno specchio, cosa che chiamiamo anche pupilla (72 -> "kore", "còre"), dato che è come un immagine di chi guarda?
 ALCIBIADE: Quel che dici è vero.
ALCIBIADE: Quel che dici è vero.
 SOCRATE: Dunque quando un occhio osserva un occhio e guarda in esso ciò che appunto esso ha di più bello, e con cui vede, in tal caso potrebbe vedere se stesso [...]"("Alcibiade primo", 133 e ss.).
SOCRATE: Dunque quando un occhio osserva un occhio e guarda in esso ciò che appunto esso ha di più bello, e con cui vede, in tal caso potrebbe vedere se stesso [...]"("Alcibiade primo", 133 e ss.).C) LA "SORELLA" DI WILLIAM SHAKESPEARE: JUDITH (E LA "INVINCIBILE ARMATA"). Con straordinaria e fulminea eleganza e grande coraggio ("Sàpere aude"), Virginia Woolf prende il nome di Judith ("Una stanza tutta per sé") e taglia definitivamente la testa all’ "Oloferne" della tradizione "mammonica" occidentale e si porta fuori dal tragico e infantile ("stadio dello specchio") dello sguardo socratico-platonico e lacaniano (narcisitico, edipico, golem-antico).
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA --- Note a margine del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West e tra Sigmund Freud e Wilhelm Fliess.18 novembre 2022, di Federico La Sala
ALLA RICERCA DELLA LINGUA D’AMORE: LETTERATURA, PSICOANALISI, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA.
Note a margine del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West e tra Sigmund Freud e Wilhelm Fliess...
PREMESSO CHE "Una stanza tutta per sé" è un saggio pubblicato nell’ottobre del 1929, e il romanzo Orlando ("Orlando: A Biography") era stato pubblicato l’anno prima, nel 1928, forse, può essere una buona traccia per ulteriori approfondimenti porre accanto e "coniugare" il carteggio tra "Judith, la sorella di Shakespeare", Virginia Woolf e Vita Sackville-West (“Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio”, Donzelli, 2019) e il carteggio tra "Guglielmo il Conquistatore", Sigmund Freud e Wilhelm Fliess ("Lettere a Wilhelm Fliess, 1887-1904", Boringhieri, 1986): nel fuoco della relazione e della ricerca delle due coppie sono proprio i temi dell’antropologia e del "disagio della civiltà" (S. Freud, 1929), con le loro profonde tragiche radici nel "Simposio" di Platone e nella tradizione del "platonismo per il popolo" (Nietzsche):
A) ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI: «Ho cominciato a considerare con attenzione il concetto di bisessualità e considero la tua idea in proposito come la più significativa per il mio lavoro, dopo quella di "difesa"» (S. Freud a W. Fliess, 04.01.1898).
B) "DE AMORE": L’AMORE E LA PAROLA. "[...] cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: Orlando, il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile [...] La stesura di Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno." (Caterina Venturini, "Ti nomino meglio che posso: la lingua d’amore di due donne libere. Sul carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West", Femministerie 26 settembre 2019).
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA --- PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E TEOLOGIA DELLA STORIA. A Roma, una mostra. C’è Giuditta fra Caravaggio, Artemisia e gli altri (di Maurizio Cecchetti).31 dicembre 2021, di Federico La Sala
Roma. C’è Giuditta fra Caravaggio, Artemisia e gli altri
Una mostra affianca al capolavoro di Palazzo Barberini circa trenta opere sul tema dell’eroina biblica. Il confronto, come al solito, è con la figlia di Orazio Gentileschi
di Maurizio Cecchetti (Avvenire, giovedì 30 dicembre 2021)
- [Foto] Caravaggio, "Giuditta decapita Oloferne" (Roma, Palazzo Barberini)
Quando c’è di mezzo Caravaggio, è bene cercare sempre nel quadro un riflesso della sua vita interiore, della sua psicologia. Per un artista dal carattere rissoso e mosso da un forte sentimento competitivo, che a quanto riporta Gaspare Celio - pittore e trattatista seicentesco di cui qualche anno fa venne scoperta una copia del suo compendio alle Vite del Vasari - forse era fuggito da Milano ancora giovane per evitare processi per un omicidio non ben precisato, e che altri ne commetterà a Roma e altrove, si può pensare che mentre dipingeva il quadro Giuditta decapita Oloferne si ricordasse di ciò che aveva provato assistendo ad alcune esecuzioni capitali, riflettendo su se stesso («e se prima o poi dovesse capitare anche a me?). Nelle azioni drammatiche che dipingeva, spesso lui è dentro il quadro: nel Davide con la testa di Golia, è suo il volto del gigante. Nel Martirio di san Matteo, lui è ai margini della scena e si gira a guardare l’assassinio dell’evangelista; nella Cattura di Cristo è sulla destra che alza la testa per vedere sopra la fila dei soldati venuti per arrestare Gesù... Che cosa vede? Se l’immagine ha un senso, vede Giuda che sta per baciare il suo profeta disarmato mentre lo consegna alla giustizia romana: il quadro è un saggio di antropologia sul tradimento degli “amici”...
A voler stare ai fatti, non ci fu nessuna sfida fra Artemisia e Caravaggio. Tanto più che quando lui morì, nel 1610, ormai lontano da Roma da qualche anno, Artemisia aveva circa diciassette anni e aveva appreso gli strumenti della pittura attraverso il padre, nella cui bottega transitavano artisti di valore e notabili della Roma reduce, dopo il 1600, da uno dei giubilei più fastosi e più orientati al trionfalismo della Chiesa che stava da decenni contrastando l’avanzata protestante.
 Se di sfida si può parlare riguardo ad Artemisia, l’unica degna di approfondimenti è quella con la pittura del padre Orazio. Ma di questo parlerò fra poco, perché è un altro il tema della mostra romana ordinata a Palazzo Barberini fino al 27 marzo da Maria Cristina Terzaghi, storica dell’arte con un nutrito carnet di saggi sul Caravaggio (anche lei fu tra i primi a rinvenire la mano del pittore nell’Ecce homo spuntato come un fungo dalla sera alla mattina a Madrid in un’asta, poi ritirato e finito nel caveau del Prado che lo sta facendo pulire per capire se è veramente di Caravaggio).
Se di sfida si può parlare riguardo ad Artemisia, l’unica degna di approfondimenti è quella con la pittura del padre Orazio. Ma di questo parlerò fra poco, perché è un altro il tema della mostra romana ordinata a Palazzo Barberini fino al 27 marzo da Maria Cristina Terzaghi, storica dell’arte con un nutrito carnet di saggi sul Caravaggio (anche lei fu tra i primi a rinvenire la mano del pittore nell’Ecce homo spuntato come un fungo dalla sera alla mattina a Madrid in un’asta, poi ritirato e finito nel caveau del Prado che lo sta facendo pulire per capire se è veramente di Caravaggio).
 Il tema della mostra infatti è quello dell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, la cui interpretazione prima di Caravaggio non ebbe mai la stessa capacità di raffigurare un evento efferato e sacro come se stesse accadendo sotto i nostri occhi.
Il tema della mostra infatti è quello dell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, la cui interpretazione prima di Caravaggio non ebbe mai la stessa capacità di raffigurare un evento efferato e sacro come se stesse accadendo sotto i nostri occhi.La mostra è accompagnata da un catalogo (Officina libraria) con le opere esposte e le schede per ogni dipinto, precedute da alcuni saggi storici che seguono percorsi iconografici, letterari, sociali, fino agli sviluppi psicoanalitici su “Donne e violenza nell’arte occidentale”. Ovviamente, la curatrice ha redatto un saggio ampio e ponderoso sulla storia del dipinto caravaggesco, a partire dal primo proprietario, il banchiere Ottavio Costa, che possedeva altre due opere del pittore, ma della Giuditta fu particolarmente “geloso” (forse, come pensa la Terzaghi, non voleva che qualcuno convincesse Caravaggio a farne un’altra versione, in realtà io credo che le ragioni fossero legate alla natura e qualità stessa del quadro: inaudita potenza visiva e conturbante bellezza sacra). Quando la tela venne scoperta dal restauratore romano Pico Cellini nel 1951, la retrospettiva del Caravaggio a Milano era stata già inaugurata. Longhi, strabiliato dalla bellezza dell’opera, fece prorogare la mostra di due mesi perché il quadro potesse venire esposto. Ci fu anche il tentativo di venderlo all’estero, ma la pronta notifica vincolò il quadro, che venne acquistato dallo Stato vent’anni dopo, nel 1971, per 250 milioni di lire. Non mi dilungo sugli accostamenti, già fatti nei decenni scorsi, con un fatto di cronaca che fece scalpore, la decapitazione di Beatrice Cenci nel 1599 per aver ucciso il padre che la maltrattava e la segregava. Secondo Gianni Papi, in realtà, l’opera sarebbe successiva, anche a quelle della Cappella Contarelli (ciclo di san Matteo). Un documento che attesta un pagamento del banchiere Costa datato 1602 per un quadro imprecisato, rafforzerebbe il dubbio sulla cronologia. -Segnalo i riferimenti che Terzaghi fa con alcune opere che potrebbero aver ispirato Caravaggio nel momento in cui escogitava l’opera (in particolare una incisione del 1540 di Giovan Battista Scultori derivata da una Giuditta decapita Oloferne di Giulio Romano, che potrebbe far pensare alle peregrinazioni del Merisi in quegli anni “vacanti” tra Milano e Roma, che lo portarono quasi certamente fino a Venezia); e tralascio gli spunti per l’identificazione della modella che prestò la sua bellezza a Giuditta (Longhi l’aveva definita una «Fornarina del naturalismo»), con ogni probabilità Fillide Melandroni, cortigiana senese a Roma fin da adolescente.
Con Artemisia si entra, invece, in un campo minato, perché la “premiata ditta Gentileschi”, «padre e figlia», in realtà è ancora coperta da ombre e da dissidi familiari da chiarire. Da tempo è in atto una ricerca che aspira a distinguere con chiarezza le opere che sono di Orazio e quelle di Artemisia. Non è facile, almeno tra quelle che precedono l’esodo della pittrice da Roma. Resta però, a mio parere, un elemento dirimente che possono negare soltanto quelli che si richiamano ancora al mito femminista di Artemisia - il libro di Anna Banti diede la stura a questa interpretazione da superare -: Orazio è un pittore più bravo di sua figlia. Ed è sulle qualità pittoriche che bisogna trovare un maggior accordo fra gli studiosi.
Il caso da manuale riguarda le due versioni della Giuditta decapita Oloferne attribuite ad Artemisia: quella di Capodimonte, esposta ora a Roma, e quella degli Uffizi: quasi identica l’impostazione, ma in realtà diversa nello spazio, perché quella di Firenze è più ampia e mostra le gambe di Oloferne, ma soprattutto il sangue che sprizza ovunque con una violenza che nel quadro di Capodimonte, seppur più ravvicinato, è attenuata. Quel sangue che imbratta, come uno stigma psicologico, fa pensare a una mano femminile. Nel quadro di Napoli l’eroina indossa un abito azzurro-blu, mentre a Firenze è del tipico giallo che ricorre spesso nella pittura di Artemisia. Orazio dipinge con maggior eleganza e raffinatezza, con una luce che esalta la bellezza “sartoriale” dei tessuti e congela i toni in una visione quasi metafisica (per esempio il bianco dei lenzuoli), come si vede anche nella tela Giuditta e la fantesca con la testa di Oloferne di Hartford.
Vi fu sempre un certo traffico di opere dallo studio di Orazio, dove anche la giovane Artemisia lavorava, e i documenti, che anche la Terzaghi ricorda, oggi insinuano il dubbio che il quadro di Capodimonte possa essere, come sostenevo fin dalla mostra del 1991 che rilanciò il mito di Artemisia, non suo ma di Orazio. Questo, francamente, rende un po’ superficiale il giudizio di Keith Christiansen secondo cui Orazio non badava troppo alla paternità dei suoi dipinti. Se fosse per amore verso la figlia non so, può anche darsi, ma il problema potrebbe invece essere che Artemisia aveva il “complesso di Elettra”, come direbbero gli psicoanalisti, cioè invidiava l’intesa fra Orazio e la sua pittura, vedendola come sostituta della madre. Ci sarebbe ben altro da aggiungere riguardo ai quadri esposti, fra cui figurano, tra i più straordinari, quelli del Valentin, di Cristofano Allori, di Cagnacci, di Manfredi, di Lavinia Fontana, di Pierfrancesco Foschi e del Tintoretto.
Mi limito a due appunti finali sull’impostazione della mostra: aver poco approfondito la diversa interpretazione del tema da parte di mani femminili, rispetto alla predominanza di quelle maschili. Questo è il classico tema su cui si possono indagare due psicologie, se non opposte, complementari.
 La seconda riguarda il fatto biblico, rispetto al quale si offre una lettura poco puntuale per lo più vedendo la fortuna del tema in funzione antiprotestante. In sostanza, mi chiedo perché fra saggi storici molto curati, compreso quello del Giano bifronte Filippo Maria Ferro, grande studioso d’arte e psicoanalista, non abbia trovato posto il contributo di un teologo-biblista.
La seconda riguarda il fatto biblico, rispetto al quale si offre una lettura poco puntuale per lo più vedendo la fortuna del tema in funzione antiprotestante. In sostanza, mi chiedo perché fra saggi storici molto curati, compreso quello del Giano bifronte Filippo Maria Ferro, grande studioso d’arte e psicoanalista, non abbia trovato posto il contributo di un teologo-biblista.
 Chi vuole può compensare la carenza appoggiandosi all’ultimo numero di “La Civiltà Cattolica” (4114) dove i gesuiti Saverio Corradino e Giancarlo Pani offrono una propedeutica al tema, ovvero La teologia della storia nel Libro di Giuditta, che il testamento ebraico non ha accolto fra i canonici, ma che i due autori definiscono «a suo modo un midrash sull’intera storia della salvezza».
Chi vuole può compensare la carenza appoggiandosi all’ultimo numero di “La Civiltà Cattolica” (4114) dove i gesuiti Saverio Corradino e Giancarlo Pani offrono una propedeutica al tema, ovvero La teologia della storia nel Libro di Giuditta, che il testamento ebraico non ha accolto fra i canonici, ma che i due autori definiscono «a suo modo un midrash sull’intera storia della salvezza». -
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA --- TRACCE PER UNA SVOLTA ANTROPOLOGICA: LA LEZIONE DI GIOVANNI VALVERDE (1560).31 marzo 2021, di Federico La Sala
#ACHEGIOCOGIOCHIAMO?! #TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA.
#EUROPA #SPAGNA #DUE ANNI DOPO LA MORTE DI #CARLOV nel 1560, in #Italia, a #Roma si pubblica il testo di #Anatomia di #GiovanniValverde: si riconosce il ruolo attivo della donna nella #concezione del problema #comenasconoibambini
La sollecitazione di #Michelangelo (1512), #GiovanniValverde (1560), #LuigiCancrini (2005) e #MarioDraghi (2021) a finirla con "il farisaico rispetto della #legge"
#VITAEFILOSOFIA. #COMENASCONOIBAMBINI (#ENZOPACI). Fermare il #giogo, #uscire dall’orizzonte della #tragedia e imparare a #contare
FLS
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- "Critica della ragione dialettica" (J. P.Sartre)/"Critica della ragione psicoanalitica": Recalcati lettore di Fachinelli (di Rocco Ronchi).18 novembre 2020, di Federico La Sala
Gioie eccessive /
Recalcati lettore di Fachinelli. L’oceano al di là dell’Edipo
di Rocco Ronchi (Doppiozero, 18 novembre 2020)
Elvio Fachinelli ha avuto il grande merito di portare la psicoanalisi dentro il dibattito politico e culturale dell’Italia degli anni ’60 - ‘80, quando il vento del rinnovamento soffiava forte sulla società italiana. Psicoanalista eterodosso, ma non dissidente, sospettoso delle dinamiche autoritarie dei gruppi, anche quando questi erano fondati su buone cause, si era sottratto all’invito formulatogli da Jacques Lacan di rappresentarlo in Italia, preferendo mantenere una posizione da libero battitore. A trent’anni dalla prematura scomparsa, uno dei maggiori “eredi” italiani di Jacques Lacan, Massimo Recalcati, gli ha dedicato un piccolo densissimo volume, articolato in tre saggi e in una Appendice, dal titolo significativo e assai impegnativo: Critica della ragione psicoanalitica.
Di Fachinelli, il suo esegeta condivide non solo una matrice intellettuale lacaniana, che è certamente più sfumata nel caso di Fachinelli, ma anche quella che si potrebbe definire una comune vocazione all’“impegno”. Per entrambi, infatti, la psicoanalisi è una prassi interamente calata nell’attualità, che non teme di sporcarsi le mani con il conflitto. Certamente diversissimi sono gli sfondi nei quali prende rilievo la loro riflessione. La temperie sociale, politica e culturale che caratterizzava gli anni di Fachinelli non ha quasi più rapporto con quella attuale. Le urgenze sono altre, anche se non meno drammatiche. Comune a entrambi è tuttavia la persuasione che la psicoanalisi, che nella sua pratica resta sostanzialmente una faccenda privata, sia, quanto al suo senso, parte integrante del discorso pubblico. Essa deve fungere da criterio di orientamento nel reale e da principio della sua trasformazione.
Ecco allora che la deriva ossessiva che Fachinelli denunciava nella logica gruppale dell’estrema sinistra degli anni ‘70 diventa, nella rilettura che ne offre Recalcati una diagnosi della pulsione securitaria che attraversa la contemporaneità, a riprova del fatto che il fascismo, per la psicoanalisi, non è qualcosa di contingente, ma si inscrive nella logica dell’inconscio. È un fatto degno di nota che quando la psicoanalisi si fa “ontologia del presente”, come avviene in modi diversi in Fachinelli e in Recalcati, il fascismo bussi sempre alle sue porte, presentandosi come il fantasma che assilla la compagine sociale. Lo si può verificare scorrendo a volo d’angelo la storia di questa disciplina: con sistematica puntualità - dal Freud della Psicologia delle masse al Reich della Psicologia di massa del fascismo fino alla schizoanalisi di Deleuze-Guattari - ogni incursione nel sociale della psicoanalisi fa emergere una “ricerca del chiuso” che, come scrive Recalcati, sembra appartenere “alla forma umana della vita” (il corsivo è mio). La “necessità” di questo libro di Recalcati è, dunque, immediatamente politica.
Senza lo spettro del fascismo, che si ritrova nelle nuove forme del populismo sovranista, non si spiegherebbe il ritornare dello psicoanalista di oggi alle pagine del suo collega di ieri. Il primo capitolo ha infatti un titolo “programmatico”, Uscire dal chiuso, ed è tutto costruito sulla fenomenologia schizzata da Fachinelli (in La Freccia ferma del 1979) di quella ossessione che porta il soggetto a trovare riparo presso “un padrone assoluto”, “una istanza superiore esterna (Dio, una Causa, o altro) che possa ribadire il suo affidamento regressivo all’Altro”.
Uscire dal chiuso è allora qualcosa di più di un titolo descrittivo: è la parola d’ordine di una psicoanalisi che accetta la sfida del tempo storico, pagando il prezzo del proprio impegno con i sarcasmi di chi la vorrebbe invece confinata nella penombra di un comodo appartamento borghese, appannaggio di una ristretta cerchia di privilegiati, e ne irride il tentativo di rendersi comunicabile e condivisa.
Accanto all’urgenza politica, ma connessa ad essa, vi è poi un’urgenza schiettamente teorica. Bisogna andare all’Appendice del libro (Il mare della formazione) per trovarla enunciata. La questione che viene sollevata in quelle pagine concerne la formazione dello psicoanalista in un contesto, quello lacaniano, dove l’osservanza della “lettera” del Maestro sembra costituire il solo valore al quale attenersi: formazione come conformazione, dunque. Nel caso poi l’esperienza non si lasciasse ricondurre al Libro, tanto peggio per l’esperienza.
Ciò che conta, infatti, è impratichirsi in una neolingua inaccessibile ai più che funziona come setaccio al cui vaglio passare il reale, trattenendo solo ciò che conferma la premessa del sillogismo lasciando perdere tutto il resto. “Viene alla mente - scrive sconsolato Recalcati - una tesi di Fachinelli: la psicoanalisi si è progressivamente costituita come una difesa fobico-ossessiva nei confronti dell’aperto”. Si ripete, anche nel caso di Lacan, quello che era già avvenuto con l’insegnamento freudiano, non solo presso i post-freudiani, sempre preoccupati di ricucire gli strappi procurati da Freud al dominio dell’Io, ma già in Freud stesso, che Fachinelli amava presentare come spaventato rispetto agli effetti prodotti dalla sua stessa veggenza: la scoperta dell’inconscio come causa.
- “Dopo lo squarcio iniziale, la psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, controllare, stare attenti, allontanare... Ma certo questo è il suo limite, l’idea di un uomo che deve sempre difendersi, sin dalla nascita e forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato” (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989).
Vi è, insomma, una naturale tendenza della psicoanalisi a (ri)costituirsi terapeuticamente come un discorso della padronanza, replicando un antico modello, quello del soggetto che è padrone del possibile, che ne dispone sovranamente come di una capacità, e che perciò argina (“ottura”, diceva Fachinelli) tutti quei “buchi” dai quali può passare un reale che si sottrae alla sua misura, un reale che è in eccesso sulla possibilità di accoglierlo, di farlo proprio, di digerirlo, un reale che non si lascia metabolizzare e trasformare in alimento utile alla autoconservazione del soggetto. Vi sono, scriveva Fachinelli, “gioie eccessive”, dalle quali la psicoanalisi, in quanto discorso della padronanza, si guarda come se fossero minacce. Queste gioie, che rinviano al grande tema lacaniano di una jouissance “al di là” del principio di piacere, “aprono”, strappandoci all’“umidiccia intimità gastrica” del nostro Io (l’espressione, potentissima, la mutuo dal giovane Sartre polemico con l’“idealismo” del suo maestro Husserl; ricordo che senza passare da Sartre poco si comprenderebbe del lacanismo di Recalcati).
Esse ci mettono in comunicazione con un Altro che non è l’Altro del Simbolico, della Legge, dell’Edipo. Per Fachinelli è un Altro molto più antico, ben poco “umano”, dal momento che ciò che c’è di “umano, troppo umano” è proprio l’ossessione per la chiusura, vale a dire quella sordida inclinazione al fascismo che accompagna, come uno spettro, ogni processo di soggettivazione.
 Per questo Altro deve essere convocato un “sentimento oceanico”, come aveva fatto, in una celebre lettera a Freud, il suo amico Romain Rolland. La sua figura - che, come vedremo, non è affatto una metafora - è il “mare”. L’Altro assume qui il volto della natura, colta però non nel suo aspetto pietrificato di mosaico di fatti retto da leggi meccaniche, bensì in quello che aveva di mira Spinoza quando coniava per l’attività generativa della natura il neologismo latino naturans e che Henri Bergson, un altro spinoziano, aveva chiamato “durata creatrice di imprevedibili novità”.
Per questo Altro deve essere convocato un “sentimento oceanico”, come aveva fatto, in una celebre lettera a Freud, il suo amico Romain Rolland. La sua figura - che, come vedremo, non è affatto una metafora - è il “mare”. L’Altro assume qui il volto della natura, colta però non nel suo aspetto pietrificato di mosaico di fatti retto da leggi meccaniche, bensì in quello che aveva di mira Spinoza quando coniava per l’attività generativa della natura il neologismo latino naturans e che Henri Bergson, un altro spinoziano, aveva chiamato “durata creatrice di imprevedibili novità”.È impressionante, anzi, la concordanza tematica e, addirittura, lessicale che c’è tra le tesi esposte da Fachinelli in saggi come La mente estatica e La Freccia ferma e la metafisica bergsoniana, soprattutto se si tiene presente l’ultima grande opera del filosofo francese: Le due fonti della morale e della religione. La grammatica concettuale di Fachinelli, fondata sulle coppie antinomiche aperto/chiuso, statico/dinamico, durata /spazio, concetto/ estasi, è infatti la stessa di Bergson. Ne è quasi un calco fatto con il linguaggio psicoanalitico.
 Si pensi solo alla critica bergsoniana delle religioni statiche, territoriali, identitarie, al suo rifiuto delle morali chiuse, basate sul dualismo amico-nemico, al suo invito incessante ad aprire ciò che tende naturalmente a cristallizzarsi, a rendere dinamica l’esperienza che l’intelletto astratto invece reifica in una molteplicità disgiunta di stati immobili.
Si pensi solo alla critica bergsoniana delle religioni statiche, territoriali, identitarie, al suo rifiuto delle morali chiuse, basate sul dualismo amico-nemico, al suo invito incessante ad aprire ciò che tende naturalmente a cristallizzarsi, a rendere dinamica l’esperienza che l’intelletto astratto invece reifica in una molteplicità disgiunta di stati immobili.
 Si consideri, poi, il suo appello alla mistica, differente per natura da ogni religione tramandata anche se è costretta ad esprimersi nella retorica di una religione determinata. La mistica, afferma Bergson, non è contemplazione, ma azione trasformatrice, praxis generatrice di comunità libere. Solo come “grande politica” l’estasi era per il filosofo francese qualcosa di efficace. Altrimenti è solo un nuovo capitolo della storia della ideologia. Difficile trovare una tesi più “fachinelliana” (e sessantottina) di questa...
Si consideri, poi, il suo appello alla mistica, differente per natura da ogni religione tramandata anche se è costretta ad esprimersi nella retorica di una religione determinata. La mistica, afferma Bergson, non è contemplazione, ma azione trasformatrice, praxis generatrice di comunità libere. Solo come “grande politica” l’estasi era per il filosofo francese qualcosa di efficace. Altrimenti è solo un nuovo capitolo della storia della ideologia. Difficile trovare una tesi più “fachinelliana” (e sessantottina) di questa...Ma Bergson, ai tempi in cui Fachinelli scriveva, era da tempo un corpo estraneo nel dibattitto intellettuale italiano e non solo. Ad occupare la scena era piuttosto l’hegelo-marxismo, vale a dire una visione del reale tutta storica, impregnata di un irriducibile umanismo, incrollabilmente fondata sulla tesi dell’eccezione umana rispetto al piano della natura. Lo stesso vale evidentemente per l’insegnamento lacaniano, anch’esso vittima della stessa congiuntura intellettuale, sebbene Lacan fosse filosoficamente assai più attrezzato del suo allievo italiano.
 Degno di nota è allora il fatto che proprio oggi, nel tempo in cui la crisi prodotta dall’antropocene è sotto gli occhi di tutti (ne è segno tangibile la mascherina indossata ad ogni latitudine), il maggiore tra gli psicoanalisti italiani senta la necessità di riaprire la pratica Fachinelli. Non solo per areare la casa della psicoanalisi, nella quale da troppo tempo ormai si soffoca per i miasmi prodotti da settarismi, piccole invidie e da una scolastica autoritaria, ma perché forse si fa incalzante la questione della crisi del paradigma antropologico che sottende la psicoanalisi mainstream.
Degno di nota è allora il fatto che proprio oggi, nel tempo in cui la crisi prodotta dall’antropocene è sotto gli occhi di tutti (ne è segno tangibile la mascherina indossata ad ogni latitudine), il maggiore tra gli psicoanalisti italiani senta la necessità di riaprire la pratica Fachinelli. Non solo per areare la casa della psicoanalisi, nella quale da troppo tempo ormai si soffoca per i miasmi prodotti da settarismi, piccole invidie e da una scolastica autoritaria, ma perché forse si fa incalzante la questione della crisi del paradigma antropologico che sottende la psicoanalisi mainstream.
 Già un altro psicoanalista, Sergio Benvenuto, ha sottolineato in un recente articolo l’aspetto “dionisiaco” latente nell’esperienza del suo antico amico Fachinelli evidenziando la distanza che lo separava dall’umanismo storicistico della sinistra italiana del tempo. Recalcati procede cautamente perché vuole evitare di gettare il bambino con l’acqua sporca. Diffida della retorica dell’impersonale, delle facili fascinazioni per il neutro.
Già un altro psicoanalista, Sergio Benvenuto, ha sottolineato in un recente articolo l’aspetto “dionisiaco” latente nell’esperienza del suo antico amico Fachinelli evidenziando la distanza che lo separava dall’umanismo storicistico della sinistra italiana del tempo. Recalcati procede cautamente perché vuole evitare di gettare il bambino con l’acqua sporca. Diffida della retorica dell’impersonale, delle facili fascinazioni per il neutro.Chi, come Recalcati, fa della clinica la cartina di tornasole per giudicare la bontà di una ipotesi teorica, non può agire diversamente. Se è vero che l’aspetto restaurativo della psicoanalisi è storicamente rappresentato dal suo essere un esorcismo nei confronti dell’aperto, è altrettanto vero che senza una difesa dal reale non c’è soggettivazione e che la psicoanalisi è una teoria e una prassi del soggetto ed è rivolta al soggetto. Non al suo “bene” - che, ricorda Recalcati, è la pretesa foriera di ogni possibile male - ma sicuramente al suo “essere”. Le vie della desoggettivazione e della desublimazione secca, le vie dionisiache, possono semmai essere percorse dagli artisti, perché a difenderli dal reale è il velo “apollineo” dell’immaginario; sono invece non solo impraticabili, ma, direi, eticamente irresponsabili per lo psicoanalista.
Tuttavia chi abbia seguito lo svolgersi nel tempo del pensiero di Recalcati non può non notare come in alcune sue recenti dichiarazioni teoriche, e in queste pagine in particolare, l’aperto promesso al soggetto da una psicoanalisi non reazionaria prenda sempre di più un aspetto “oceanico” e sempre meno “umano, troppo umano”, fino al punto da riabilitare - in modo apparentemente distratto, ma proprio per questo ancora più significativo - la grande tesi di Ferenczi, secondo la quale non è l’oceano il simbolo della madre, ma la madre uno dei simboli di quell’al di là dell’Edipo che è l’oceano.
 In psicoanalisi l’oceano, il mare, l’onda, sono metafore che, come ha scritto una volta Bergson, parlano al senso proprio. Se il rumore delle onde funziona per il soggetto come il canto delle Sirene per Ulisse è, insomma, perché rammenta una provenienza e una destinazione. Siamo fatti di quella stessa stoffa. Certo, per Recalcati è sempre “sulla scala del desiderio” che va ricalcolato questo al di là dell’Edipo. Recalcati non viene mai meno a questo assioma sul quale ha articolato tutta la sua impresa teorica, ma questo non significa che il desiderio ricucia lo strappo del godimento sul modello del discorso della padronanza.
In psicoanalisi l’oceano, il mare, l’onda, sono metafore che, come ha scritto una volta Bergson, parlano al senso proprio. Se il rumore delle onde funziona per il soggetto come il canto delle Sirene per Ulisse è, insomma, perché rammenta una provenienza e una destinazione. Siamo fatti di quella stessa stoffa. Certo, per Recalcati è sempre “sulla scala del desiderio” che va ricalcolato questo al di là dell’Edipo. Recalcati non viene mai meno a questo assioma sul quale ha articolato tutta la sua impresa teorica, ma questo non significa che il desiderio ricucia lo strappo del godimento sul modello del discorso della padronanza.In passato Recalcati è stato spesso vittima di questa interpretazione riduttiva, non senza una qualche sua responsabilità, ma il passaggio attraverso le “gioie eccessive” di Fachinelli serve proprio a dissipare l’equivoco. La psicanalisi, scrive Recalcati esegeta di Fachinelli, è un’avventura e non un programma. Il suo metodo è la navigazione a vista: mappe e cartografia (il Libro) sono funzionali al processo, lo accompagnano ma non lo dirigono. L’essere dell’uomo è certamente la preoccupazione della psicoanalisi, ma Fachinelli ci ha insegnato che preservarlo vuol dire esporlo, cioè riconsegnarlo, “per quanto è possibile”, al suo elemento estraneo: alla potenza non umana del mare.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. --- "FEMMINISMO", "ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE", E "SCONFITTA DELLA PSICOANALISI".3 dicembre 2019, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA": L’ ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO...
Psicoanalisi e femminismodi Luisa Muraro e Lucetta Scaraffia *
Su Sette Corriere della sera del 22 novembre 2019 è apparso un articolo di Lucetta Scaraffia, Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi, chiarissimo in quello che dice. Potete leggerlo qui di seguito. È un testo di notevole interesse perché attira l’attenzione e fa luce sulla parte avuta dalla psicoanalisi nella rivoluzione femminista del ventesimo secolo. L’autrice finisce con un punto di domanda, giustamente, e invita così ad approfondire l’argomento.
Per parte mia ci tengo a dire che la “sconfitta” della psicoanalisi avviene su un antico campo di battaglia, quello dell’autorità della parola, autorità negata alle donne dal regime patriarcale, e campo di battaglia dalle donne tenacemente tenuto aperto attraverso i secoli. Parlo dell’isteria. Dedicandosi alla cura dell’isteria, Freud ha avuto il merito innegabile di essere entrato nel campo di battaglia e di sbagliare, sì, ma in un modo significativo: è il suo inconscio che lo fa sbagliare e lui finisce che se ne accorge. Se possiamo fare festa per la fine del discredito patriarcale e l’affermarsi di autorità femminile nella vita pubblica, qualcosa dobbiamo anche a lui. A sua volta, lui deve qualcosa, o molto, all’umanità femminile. (Luisa Muraro)
Corriere della sera - Sette, 22 novembre 2019
Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi
di Lucetta Scaraffia *
Quando Ida ha acconsentito alla richiesta del padre, che voleva far curare da Freud i suoi strani disturbi (afonia, svenimenti, tosse continua), la ragazza sperava che il dottore avrebbe creduto alle sue parole, convincendo così anche suo padre che l’amico di famiglia Hanss Zellenka l’aveva molestata con insistenza e pesantemente, per mesi, suscitandole profondo turbamento e paura. Le molestie erano cominciate quando aveva solo tredici anni, e lei si era trovata invischiata in una situazione angosciosa: le vacanze con la famiglia Zellenka sul lago di Garda - dove la madre Pepina l’aveva accolta con un affetto e una simpatia che le mancavano in casa - nascondevano un segreto imbarazzante.
Pepina era in realtà l’amante del padre di Ida, un ricco industriale, che si era portato in vacanza la figlia per mascherare la relazione. E proprio mentre la ragazza cominciava ad accorgersene, diveniva oggetto di corteggiamenti e molestie da parte di Hanss, il marito di Pepina. È questa situazione difficile all’origine dei suoi disturbi di salute ma, come quasi tutte le giovani donne in casi analoghi, Ida ha paura di parlarne e si sente confusamente colpevole, finché un episodio più grave non la induce a raccontare tutto alla madre. Il padre, prontamente informato, convoca Hanss, il quale non solo nega indignato ma ritorce su Ida le accuse, consigliando di mandarla in cura da Freud.
Ferita dall’incomprensione paterna, Ida lo sarà ancor più dolorosamente da Freud che, dopo averla spinta a parlare, comprensivo - finalmente qualcuno la prendeva sul serio! - le aveva spiegato la sua complicata interpretazione dell’episodio. Secondo Freud le parole della ragazza rivelavano un suo amore edipico verso il padre, spostato poi su Hanss, e di conseguenza «lei non aveva affatto paura del signor Zellenka ma piuttosto di se stessa, e più precisamente della tentazione di cedere al signor Zellenka».
Ida reagisce a questa nuova cocente delusione interrompendo la cura con Freud, e proseguendo, sia pure con fatica, nella sua vita di donna che si sarebbe sposata, avrebbe avuto un figlio, avrebbe lavoratoe sarebbe scampata alla persecuzione nazista fuggendo prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, dal figlio. Una vita dura e drammatica, che racconta alla nipote, autrice della bella biografia a lei dedicata. La vita di una donna che dal rifiuto dell’interpretazione di Freud ha tratto forza e coraggio. Una posizione totalmente diversa da quella che lo stesso Freud rivela concludendo la narrazione dell’analisi: «Promisi comunque di perdonarla per avermi privato della soddisfazione di guarirla radicalmente». E se invece Ida si fosse guarita da sola rifiutando l’interpretazione di chi non considerava vere le sue parole?
Ida è Dora, la protagonista del primo caso clinico di Freud, che su questo ha costruito la sua ipotesi sulle cause dell’isteria, considerando il caso come prova chiara e convincente della sua teoria del complesso di Edipo.
Agli occhi di una donna di oggi, invece, la vicenda di Ida appare solo come la drammatica storia di una ragazza molestata che non viene creduta dagli uomini ai quali si rivolge per avere aiuto. Il padre, probabilmente anche perché segnato da sensi di colpa nei confronti di Hanss, crede a questi piuttosto che alla figlia, mentre Freud dà credito al padre, e si lascia influenzare dal desiderio di trovare nei desideri edipici rimossi la causa dell’isteria. Le malattie di Ida, invece, rivelano piuttosto la sofferenza di una donna le cui parole non vengono ascoltate né rispettate. Una donna che non viene presa sul serio, proprio come tante altre sue contemporanee - ma anche molte più vicine a noi - che non hanno visto riconosciuto il valore delle loro parole.
La biografia di Ida (scritta dalla pronipote Katharina Adler, Ida, Sellerio 2019) rovescia la storia raccontata da Freud: non si tratta della prima paziente alla quale è stata diagnosticata e curata l’isteria, ma una delle tante - troppe - donne che hanno subito due forme di violenza, quella sessuale e quella contro la loro identità perché le loro parole non vengono credute. È la storia narrata dal punto di vista delle donne, che vedono le cose molto diversamente dagli uomini, ma non sono ascoltate.
C’è voluta una lunga battaglia, combattuta dalle donne, perché le parole delle vittime venissero ascoltate e prese seriamente in considerazione, perché le vittime stesse non fossero sempre considerate possibili complici della violenza - Ida aveva forse provocato, magari anche inconsapevolmente, come insinua Freud, il violento? - e venissero invece aiutate a superare il trauma, e risarcite.
Nell’ordinamento giuridico italiano gli articoli del codice Rocco, vigenti fino al 1996, punivano ogni tipo di violenza o molestia sessuale - sia sulle donne che sui minori - come «delitto contro la morale pubblica e il buoncostume». Tutelavano cioè quello che veniva considerato un bene collettivo e non la vittima. È stato solo nel 1996, grazie alle pressioni del movimento femminista, che viene promulgata la nuova legge per cui lo stupro diventa reato contro la persona, e di conseguenza l’attività sessuale riconosciuta come frutto di una libera scelta perché rientra nel diritto proprio dell’individuo.
Mentre nella fase precedente si collocava al primo posto la condizione di vita della comunità, che per il legislatore costituiva il massimo valore, oggi a essere valorizzata è invece la dimensione individuale di chi subisce il reato, divenuta il bene giuridico protetto dalla legge. Rivendicando la loro posizione di vittime della violenza, le donne capovolgono la situazione di debolezza in cui si trovavano, s’impadroniscono del potere di accusa, le loro parole si caricano di valore, e hanno finalmente diritto di essere ascoltate.
Oggi Ida troverebbe ascolto, Hanss verrebbe punito per molestie su una minore, e Freud non avrebbe più la possibilità di elaborare la sua teoria sull’isteria. Un caso in cui la psicanalisi, elemento fondamentale della nostra modernità, viene forse sconfitta dalla realtà che sta nelle parole delle donne?
(www.libreriadelledonne.it, 29 novembre 2019)
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". La crisi epocale dell’ordine simbolico di "mammasantissima" ("patriarcato": alleanza Madre-Figlio).
DONNE, UOMINI, E DISORDINE SIMBOLICO
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- IL MITO DELLE DANAIDI, LA METAFORA DI KANT, E L’ALZHEIMER.23 settembre 2019, di Federico La Sala
Fili di pensiero e buchi di memoria. Immanuel Kant e l’Alzheimer
Nell’ultimo decennio della sua vita il filosofo fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria: l’intervento di Francesca Rigotti per l’Alzheimer Fest
di FRANCESCA RIGOTTI *
- A Treviso dal 13 al 15 settembre si svolge la terza edizione dell’Alzheimer Fest. Dal dolore nasce una festa, che coinvolge persone affette da demenza, famigliari, medici, operatori, artisti, liberi cittadini. Gli eventi previsti sono circa 150, tutti gratuiti (info su alzheimerfest.it). Qui pubblichiamo un estratto dell’intervento che la filosofa Francesca Rigotti terrà domenica 15 alle 11.30. Sul numero 405 del 1° settembre, «la Lettura» ha anticipato l’originale componimento in versi a staffetta realizzato per l’occasione da Vivian Lamarque, Roberta Dapunt, Flavio Pagano, Stefano Scateni, Giovanna Baglione e altri poeti (con un articolo di Michele Farina). Nel supplemento #406 in edicola fino a sabato 14 settembre, è disponibile l’intervento Donatella Puglia, docente di Lingua e letteratura latina all’università di Siena (anche lei ospite dell’evento).
Parleremo di Alzheimer e di filosofia concentrandoci sulla figura di un filosofo che fu presumibilmente colpito da questa sindrome. Un filosofo che alcuni hanno studiato a scuola, altri solo orecchiato: Immanuel Kant, che nell’ultimo decennio della sua vita fu affetto da confusione mentale e perdita di memoria.
Kant visse tra il 1724 e il 1804, ottant’anni giusti tutti trascorsi a Königsberg, allora nella Prussia orientale, ora Kalinigrad, enclave russa. Alla locale università seguì le lezioni di filosofia, matematica, fisica e dogmatica. È l’autore delle tre critiche (della Ragion Pratica, della Ragion Pura, del Giudizio). Nel campo della morale ha elaborato una dottrina deontologica molto rigorosa basata sul dovere di comportarsi in modo tale che il proprio agire possa diventare massima dell’agire universale (in contrasto con l’utilitarismo e con la dottrina del male minore, capolavoro etico di Tommaso d’Aquino, quella che consiglia di ingoiare tu il rospo piccolo prima che il rospo grande ingoi te). Nel campo teorico-conoscitivo, la dottrina di Kant ha messo al centro della conoscenza il soggetto e le peculiarità del suo apparato conoscitivo categoriale attraverso il quale viene letto e interpretato il mondo.
Un grandissimo filosofo insomma, che proprio perché tale non sfugge allo sport preferito dai piccoli filosofi, che è quello di sparare al grande filosofo. È uno sport di tutti i tempi e di tutte le età, che ai nostri tempi è stato praticato contro Platone (trasformato in fautore dello stato autoritario); Marx (unisono o quasi: «in soffitta, in soffitta!»); Hegel e l’idealismo tedesco (che alcuni professori tedeschi vorrebbero cancellare dal programma di filosofia); Heidegger (ancora quasi un unisono: il bersaglio è facile data l’indulgenza di Martin verso il nazionalsocialismo). Ultimamente ci si è accaniti contro Kant, dapprima attaccando i suoi scritti gnoseologici cui si è voluto dare un bel «good bye», ora rivolgendosi anche alla roccaforte dei suoi scritti etici, troppo rigorosi per la nostra edonista società. Io però sono convinta che lassù, nel cielo dei filosofi, a Platone, Hegel, Marx, Kant, Heidegger e compagni quelle cannonate facciano il solletico.
Anche Kant, dicevo, è oggetto proprio in questi giorni di pesanti bordate che mirano a demolire nientemeno che il suo apparato etico, rigoroso e cogente, non adatto a un’epoca di grandi opportunisti e edonisti di bassa lega pronti a chinarsi a soluzioni di comodo. Ma che cosa c’entra tutto questo con l’Alzheimer? C’entra, c’entra, o almeno vorrei farcelo entrare io mostrando come, se un vero nemico di Kant ci fu, esso fu proprio questa malattia subdola e strisciante che venne a guastare gli ultimi anni di vita del grande pensatore di Königsberg.
Conosciamo bene la biografia di Kant e in particolare gli anni della vecchiaia grazie a ben tre biografie scritte da suoi conoscenti e amici, Borowski, Jachmann e Wasianski, e a un testo letterario del 1827 di Thomas de Quincey, Last days of Immanuel Kant, da cui è stata tratta la suggestiva versione cinematografica, del 1993, del regista francese Philipp Collin, Les derniers jours d’Emmanuel Kant, che purtroppo non posso mostrarvi, neanche un pezzettino. Se siete interessati potete guardarla integralmente su YouTube. Vedrete un anziano signore con parrucca, redingote e scarpini con la fibbia, dagli occhi azzurrissimi (che si possono soltanto immaginare perché il film è in bianco e nero), a volte ancora splendenti di intelligenza, più spesso offuscati dalla malattia che quell’intelligenza si stava portando via. Vedrete un uomo minuto e segaligno, anche se meno magro di come viene descritto nel libro (non portava mai calze nere per non far apparire i polpacci ancora più secchi), vittima del proprio rigore di abitudini di vita, che si autocostringeva a seguire rituali rigidissimi quanto ridicoli per quanto riguarda il dormire (impacchettato strettissimamente tra lenzuola e coperte), il vestirsi, il mangiare, lo scrivere, il fare le passeggiate...
Ma torniamo al Kant filosofo. Oltre che del pensiero critico Kant si interessò, tra l’altro, di estetica, di cosmologia, di antropologia. In relazione a quest’ultimo ambito scrisse nel 1798 una Antropologia dal punto di vista pragmatico, l’ultima opera pubblicata in vita anche se redatta nel corso di anni precedenti . Un’opera senile nella quale Kant tratta, forse non a caso, di memoria e oblio (e qui apro una parentesi per mandare un saluto ossequioso al grande Harald Weinrich, lo studioso autore del più bel libro sull’oblio che sia mai stato scritto e che qui mi ha molto aiutato: Lete. Arte e critica dell’oblio, chiusa parentesi).
Ebbene Kant, che aveva sempre goduto di ottima memoria, trattandone egli stesso teoricamente scriveva che la memoria è importante per prendere parte alle vicende della cultura e della scienza, e per questo la si deve esercitare fin dalla più tenera età. La collega poi ai principi della ragione, soprattutto quella che definisce la terza forma della memoria. La prima infatti, (memoria meccanica), è una specie di facoltà minore, quasi animalesca, con la quale si immagazzina materiale e basta; la seconda (memoria ingegnosa), è un metodo per ricordare attraverso associazioni che non hanno nulla a che fare con il concetto da memorizzare; al gradino più alto sta la memoria giudiziosa, che permette di esercitare scelte opportune e ragionate sui contenuti di memoria, tramite sistemi di classificazione, per es. dei libri delle biblioteche come delle specie naturali; scelte giudiziose perché basate su principi di ragione.
Eppure al teorico della memoria verranno a mancare, paradossalmente, tutte le forme di memoria, condizione che il suo maggior biografo, Wasianski, diacono della chiesa di Tragheim a Königsberg e amico personale e devoto di Kant, tentò di minimizzare e giustificare: «a poco a poco lo colsero le debolezze della vecchiaia, tra cui la mancanza di memoria...». E così continua la descrizione che l’amico diacono effettua delle trasformazioni del filosofo: cominciò a ripetere i suoi racconti più volte nello stesso giorno; vedeva le cose più lontane del suo passato vive e precise davanti a sé, ma il presente, come avviene nei vecchi, gli restava meno impresso; sapeva recitare lunghe poesie tedesche e latine, brani dell’Eneide, senza intoppo, mentre gli sfuggivano le cose apprese un momento prima. Si era accorto anche lui che la memoria gli si affievoliva, sicché annotava le cose su foglietti, buste usate, informi pezzetti di carta. Oltre alla perdita di memoria incominciò a elaborare teorie strampalate, per esempio attribuendo la morìa di gatti a Basilea, Vienna e Copenhagen, a una particolare elettricità dell’aria. Si sentiva debole, astenico. Si addormentava per fiacchezza sulle seggiole, fuori orario; non era in grado di badare al suo denaro, perse la nozione del tempo, talché un minuto gli sembrava esageratamente lungo; l’appetito era sregolato e degenerato (ingollava avidamente bocconi di pane spalmati di burro e premuti su formaggio inglese grattugiato). Si esprimeva in modo sempre meno adeguato e divenne incapace di scrivere il suo nome né riusciva più a figurarsi la forma delle lettere. Il suo linguaggio diventò improprio anche se cercava di spiegarsi con affinità e analogie (parlava di mare e scogli per intendere minestra e bocconi di pane); non riusciva a farsi capire su cose comunissime, poi cominciò a non riconoscere chi gli stava intorno. Non si raccapezzava e allora gridava con voce stridula. Si consumò, e morì il 12 febbraio 1804. La diagnosi di Alzheimer per la «debolezza senile» di Kant venne proposta da Alexander Kurz nel 1992, e poi ripresa e descritta da altri, in particolare Fellin, nel 1997.
Nella sua Antropologia, a proposito della smemoratezza, che Kant chiama obliviositas, il filosofo usa una immagine, per descriverla, con la quale sembra parlare di sè: la smemoratezza è lo stato in cui la testa è come «una botte piena di buchi» (ein durchlöchertes Fass). Per quanto la riempi, rimane sempre vuota, e questo è un grandissimo male (ein größeres Übel). I contenuti versati nella testa scorrono fuori dai buchi come fili d’acqua da un setaccio, e questa perdita rende la mente vuota, sterile.
 Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.
Come il vaso che nel mito greco delle Danaidi le spose assassine erano condannate a riempire nell’al di là. E ora racconterò un meraviglioso mito che spiega molte cose di ora e di allora perché il mito tratta di ciò che non è mai e fu sempre.Le Danaidi erano le cinquanta figlie di Danaos, re dell’Argolide, regione a nord del Peloponneso, che il padre aveva destinato spose, contro la loro volontà, ai cinquanta figli di Aigyptos, Egitto. Ma durante la prima notte di nozze le ragazze, tranne una, uccisero i loro sposi prima che il matrimonio venisse consumato. Nell’al di là le Danaidi dovevano riempire continuamente d’acqua un recipiente dal fondo bucherellato.
 Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.
Io vi leggo un mito di infertilità, desiderata dalle fanciulle ma punita dalla società. Vedo fili d’acqua che escono dai buchi del corpo come vedo, nella metafora kantiana, fili di pensiero che escono dai buchi della mente rendendola sterile e improduttiva come non riproduttivo fu il ventre delle Danaidi.Nel caso del filosofo sono fili di ragionamento che il vecchio professore (Kant aveva insegnato Logica e metafisica nell’Università di Königsberg), non riesce più a annodare, a intrecciare, nemmeno a districare, come si si esprime Kant in un’altra metafora per parlare dello stesso problema. Scrivendo nel 1794 all’allievo Sigismund Beck, Kant così scriveva: «Neppure io riesco a capire...me stesso, e le farò le mie congratulazioni se sarà in grado di mettere in chiara luce uno a uno questi esili fili della nostra facoltà conoscitiva...Districare fili così sottili non fa più per me».
 Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).
Con queste parole Kant fornisce almeno due indicazioni; che la sua facoltà di ragionare è carente già nel 1794, e che i pensieri sono fili, nel suo e nel nostro immaginario, che pensa alla mente come a una matassa ingarbugliata (lo «gnommero» del commissario Ingravallo nel Pasticciaccio brutto de via Merulana di Gadda), come a un ciuffo di lana di pecora infilato sulla rocca che attende di essere dipanato e filato dalla mano del pensiero in forma di fili continui, filati, lineari, pronti per essere intrecciati in un tessuto-testo (teXtus).Che cosa succedeva nella mente bucherellata di Kant, da cui uscivano fili che non potevano più essere razionalmente intrecciati? Che essa continuava a lavorare e a pensare, ma in maniera bizzarra. Lo mostra l’episodio del licenziamento del domestico Lampe, Martin Lampe (Lampe è la lampada in tedesco), che aveva seguito e servito il filosofo per quarant’anni, assistendolo in tutte le occasioni, dalla sveglia al mattino alle 5 con il lume a candela, al servizio del pranzo (preparato da una cuoca), all’accompagnamento nelle sue passeggiate ossessive sulle quali la gente di Königsberg regolava le sue attività. Non che Kant fosse molto interessato alla vita privata di Lampe, tant’è che ignorava che fosse stato sposato per diversi anni, e il giorno che il domestico indossò la marsina gialla invece della livrea bianca (e Kant si arrabbiò moltissimo) era perchè andava a risposarsi.
 Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
Ebbene nel 1802 Kant decise di separarsi da questo servo a causa del suo cattivo contegno insorto negli ultimi anni: esigeva supplementi di salario, litigava con la cameriera, e poi commise qualcosa di grave che non ci è dato sapere e su cui Kant così sentenzia: «Lampe ha commesso una tale mancanza che mi vergogno di nominarla». Lampe fu dunque dimesso e al suo posto venne assunto un tale Johann Kaufmann, con il quale il filosofo entrò in
sintonia - dopo un po’ di attrito perché le cose dovevano essere disposte e porte dal domestico sempre nello stesso modo, la teiera/caffettiera, la tazza di caffé/tè, la pipa. A questo punto, decide Kant, «il nome di Lampe va assolutamente dimenticato». E per dimenticarlo meglio che cosa fa? Lo annota su un foglietto di appunti: «dimenticare Lampe». Ma a differenza di quei pensieri che scappavano dai buchi della mente, il nome Lampe non riusciva a uscirgli dalla testa. Weinrich prova a interpretare questo imperativo categorico come un esercizio dell’arte dell’oblio, non dell’arte della memoria, dal momento che proprio le cose che si scrivono (si registrano, si mettono nella memoria, nostra o del computer) possono essere dimenticate. In qualche modo lo scrivere le cose, l’immagazzinarle nella memoria, le consegna all’oblio. Una volta scritte, possiamo anche dimenticarle e di fatto le dimentichiamo. Lo pensava del resto anche Platone, che definisce la vecchiaia l’età della smemoratezza (τό ληθης γηρας, to létes ghêras).
 Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».
Nel dialogo Fedro infatti, a proposito dell’invenzione della scrittura da parte del dio egiziano Theuth, che presenta la sua invenzione come medicina per la memoria e per la sapienza, così commenta il saggio re Thamus, le cui opinioni riflettono quelle di Platone: «Ingegnosissimo Theuth, c’è chi è capace di dar vita alle arti e chi invece di giudicare quale danno o quale vantaggio comportano per chi se ne servirà. E ora tu, che sei il padre della scrittura, per benevolenza hai detto il contrario di quello che essa vale. Questa infatti, (la scoperta della scrittura) produrrà dimenticanza nelle anime di coloro che l’avranno imparata, perché fidandosi della scrittura non fanno esercitare la memoria. Infatti, facendo affidamento sulla scrittura, essi trarranno i ricordi dall’esterno, da segni estranei, e non dall’interno, da se stessi».Se consegno la nozione allo scritto, insomma, la tolgo dalla memoria, la dimentico, e in più indebolisco la memoria stessa. Dimentico, faccio cadere fuori dai buchi della testa, dalla mente, de-mente, demente.
Cent’anni dopo la morte di Kant il medico dei pazzi Alois Alzheimer diagnosticò il morbo che da lui prese il nome: un morbo preciso dunque, una malattia da curare. Non di generica debolezza senile soffriva Kant, quanto di una malattia specifica. Probabilmente qualcuno lo sospettò già prima, ma soltanto nel 1992 il sospetto venne scritto e assunse la forma di certezza. Cosa che apre un altro quesito filosofico riguardante l’attacco innescato pochi anni fa dai filosofi newrealisti contro i pensatori postmodernisti. Alcuni di questi (v. Bruno Latour) hanno sostenuto che il faraone Ramsete non potè morire di tubercolosi (come avrebbero provato alcune moderne autopsie) perchè il bacillo di Koch non era ancora stato isolato. Il che filosoficamente corrisponde a sostenere che «sapere che x» equivale a «essere costitutivo dell’essere x», ovvero afferma che Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora individuata e battezzata. Argomento che secondo alcuni discenderebbe direttamente dalla «rivoluzione copernicana» introdotta da Kant, il quale pose il soggetto/sole al centro della conoscenza/sistema solare, affermando che il soggetto comprende la realtà attraverso le proprie categorie e assegnando dunque al nostro intelletto un ruolo fortemente attivo nel metodo conoscitivo; sono i nostri schemi mentali che determinano il modo in cui un oggetto viene percepito. Ma mentre la prima conclusione (Kant non potè soffrire di Alzheimer perché la malattia non era stata ancora inventata/scoperta), è assurda, non lo è per nulla la seconda conclusione (la centralità del soggetto nella comprensione dei fatti e l’idea che le proposizioni scientifiche in grado di ampliare il nostro sapere sul mondo non si limitano a recepire passivamente dei dati, ma sono di natura critica e deduttiva). Non possiamo però occuparci a fondo della diatriba perchè il discorso ci porterebbe troppo lontano. La lasciamo lì, insieme al marasma senile del povero Kant, e alle sue occupazioni delle ultime settimane di vita, quali togliere e riannodare continuamente la cravatta, abbottonare e sbottonare la veste, in uno stato di continua agitazione, finché, come scrive un altro biografo, Jachmann, «svanì a mano a mano il vigore del più grande filosofo fino alla sua completa impotenza intellettuale».
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli.18 aprile 2018, di Federico La SalaFILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- Artemisia Gentileschi, il destino di una donna "ante litteram" (di Antonella Orefici).19 maggio 2017, di Federico La Sala
Artemisia Gentileschi, il destino di una donna "ante litteram"
di Antonella Orefice (Nuovo Monitore Napoletano, 19 Maggio 2017)
Sicuramente lo stile di Caravaggio influenzò tantissimo quello di Artemisia Gentileschi, donna talentuosa, dalla personalità decisa ed intollerabile in un’epoca in cui le donne vivevano emarginate dalla vita pubblica riservata ai soli uomini.
Ma la passione di Artemisia ruppe ogni regola, la sofferenza fortificò la sua arte tanto quanto l’incrollabile personalità.
Figlia del pittore Orazio Gentileschi, Artemisia nacque a Roma nel 1593 e sin da bambina mostrò un vivo interesse ed una naturale inclinazione verso la pittura.
Avendone percepito le grandi capacità, il padre le fece da maestro alimentandone l’innato talento.
Rimasta presto orfana di madre, giovane, bella e promettente, aveva poco più di diciotto anni Artemisia quando a seguito di una violenza, divenne oggetto di scandalo.
Il talento della giovane era stato da sempre motivo di orgoglio e di vanto per il padre Orazio che nel 1611 aveva deciso di affidarla alla guida del pittore Agostino Tassi.
Soprannominato «lo smargiasso» il Tassi, vantava però trascorsi poco edificanti, dalle disavventure giudiziarie alla nota fama di scialacquatore e mandante di diversi omicidi. Ciononostante, Orazio Gentileschi lo teneva in grande stima tanto da fargli frequentare assiduamente la sua casa.
L’attrazione verso la giovane pittrice divenne presto palese, seppur non corrisposta. All’ennesimo rifiuto di lei, il Tassi tirò fuori la sua deplorevole indole e la stuprò.
La violenza, minuziosamente ricostruita nella testimonianza che la giovane rilasciò durante il processo, si consumò una sera in casa di lei.
Il Tassi diceva di amarla e di voler riparare all’insano gesto sposandola, omettendo però di dire che era già sposato e che per giunta intratteneva anche una relazione con la cognata.
Ignara dell’ingannevole retroscena, Artemisia dovette credere a quella promessa d’amore perché da quella sera trascorsero ben nove mesi durante i quali il Tassi continuò a frequentare i Gentileschi e ad avere rapporti con la giovane artista, fino a quando non venne fuori lo squallido raggiro.
Indignato per il disonore arrecato alla figlia, Orazio decise allora di denunciare il Tassi.
La vicenda processuale fu lunga ed umiliate per Artemisia costretta non solo a raccontare in tribunale e sotto tortura quanto accaduto, ma a sottoporsi a visite ginecologiche pubbliche, durante le quali il suo corpo fu esposto alla morbosa curiosità della gente.
Fu forte Artemisia, coraggiosa e pronta a sopportare qualsiasi dolore pur di far valere i proprie diritti.
Ciononostante le conseguenze psicologiche della violenza furono sublimate nelle sue raffigurazioni di eroine bibliche, quali Giuditta, Giaele, Betsabea o Ester, che animate da un desiderio vendicativo, sfidano il pericolo e trionfano sul crudele nemico, affermando il proprio diritto all’interno della società.
Per anni le opere della Gentileschi sono state interpretate solo in relazione al suo vissuto, offuscando pertanto gli indubbi meriti artistici e ponendo limiti ad un’interpretazione più esaustiva delle sue creazioni.
Il Tassi fu riconosciuto colpevole di stupro e condannato a cinque anni di reclusione, o all’esilio da Roma. Ma fu questa una pena che non scontò mai perché, pur avendo scelto di allontanarsi dalla capitale, il realtà non lo fece mai.
Chi pagò per tutti fu Artemisia la cui reputazione andò del tutto distrutta, tanto da diventate oggetto di pubblico ludibrio. E’ il caso di dire “dopo il danno, anche la beffa”.
Pur di farle gettare alle spalle quella lunga e purtroppo incancellabile parentesi di sofferenza, già all’indomani del processo, il padre organizzò un matrimonio riparatore. E fu così che il 29 novembre 1612 Artemisia convolò a nozze con Pierantonio Stiattesi, un modesto pittore con il quale si trasferì a vivere a Firenze.
- A. Gentileschi "Giuditta che decapita Oloferne"
Tutta la tragicità di quell’esperienza finì in qualche modo condensata nella tela Giuditta che decapita Oloferne, realizzata tra il 1612 ed il 1613, oggi custodita a Napoli nel museo di Capodimonte.
L’incontro con una realtà diversa, lontana dal clima ostile romano, favorì l’inizio di un periodo fecondo. La diretta conoscenza di persone illustri del tempo, da Galileo Galilei al nipote di Michelangelo Buonarroti, aiutò la giovane pittrice non solo ad allontanarsi da quel suo passato, ma ad introdursi in un mondo nuovo. Purtroppo fu un momento che durò solo qualche anno.
Dal matrimonio con lo Stiattesi regolato da rapporti di convenienza e certo non da sentimenti d’amore, nacquero quattro figli. Incapace di gestire la vita economica della famiglia, il pittore si coprì presto di debiti, tanto da costringere Artemisia a ricorrere alla benevolenza di Cosimo de’Medici per ripianare le sanzioni di mancati pagamenti.
Oltre ai debiti, la scoperta di una relazione con il rampollo Francesco Maria Maringhi, costrinse Artemisia ancora una volta a scappare pur di chiudere un’altra parentesi scandalosa della sua esistenza.
Fece ritorno a Roma dove riuscì a recuperare rapporti di amicizia, crearne nuovi ed a cancellare quel penoso ricordo che di lei giovanissima aveva lasciato.
Ebbe modo di entrare in contatto con eminenti personalità dell’arte e i fecondi esiti di questo soggiorno romano furono impressi in Giuditta con la sua ancella, un’opera famosa oggi custodita a Detroit.
La ricerca di nuove commesse la portò a spostarsi da Roma a Venezia, poi a Londra e più volte a Napoli, che in quel tempo, oltre ad essere capitale del viceregno spagnolo era costituita da un eminente ambiente culturale ed un grandissimo fervore artistico da cui spiccavano nomi del calibro di Caravaggio, José de Ribera, Massimo Stanzione e il Domenichino.
E a Napoli Artemisia finì i suoi giorni nel 1653 quando ancora era nel pieno della sua attività. Sessantenne lasciava una vita costellata da periodi tristi, dure battaglie e splendide opere d’arte sparse tra chiese e collezioni private.
Fu seppellita nella Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini di Napoli, sotto una lapide oggi perduta che recitava due semplici parole: «Heic Artemisia».
Per secoli, come spesso succede alle donne ante litteram, anche Artemisia è stata quasi condannata all’oblio, tanto da non essere menzionata neppure nei libri di storia dell’arte.
Solo nel 1916 fu riscoperta e rivalutata grazie al critico d’arte Roberto Longhi che in un articolo cercò di liberarla dai pregiudizi che la opprimevano e di riportare all’attenzione della critica la sua statura artistica nell’ambito dei caravaggeschi della prima metà del XVII secolo.
Artemisia, in sintesi, fu un’artista che lottò con determinazione, utilizzando le armi della propria personalità e delle proprie qualità artistiche contro i secolari ed opprimenti pregiudizi sessisti.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- Da Giuditta a Chiara da Siena, al papato di Bergoglio. «Il potere delle donne nella Chiesa» di Adriana Valerio (di A. Santagata)14 gennaio 2017, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO":
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO":- CIVILTA’ DELL’AMORE E VOLONTA’ DI GUERRA. DOPO GIOVANNI PAOLO II, IL VATICANO SOPRA TUTTO E CONTRO TUTTI. Il "peccato originale" e la "mala fede" antropo-teo-logica di Papa Ratzinger
L’accesso alle Scritture per l’altra metà del Settimo cielo
Saggi. Da Giuditta a Chiara da Siena, al papato di Bergoglio. «Il potere delle donne nella Chiesa» di Adriana Valerio per Carocci
- «Giuditta e Oloferne» di Caravaggio, 1598-99 (Galleria nazionale d’arte antica, Roma)
di Alessandro Santagata (il manifesto, 14.1.2017)
La questione del ruolo delle donne nella Chiesa cattolica tocca direttamente il nodo del potere pastorale e delle strutture del cattolicesimo. Lo conferma in maniera convincente Il potere delle donne nella Chiesa. Giuditta, Chiara e le altre (Carocci editore, pp. 248, euro 18), l’ultima pubblicazione di Adriana Valerio, storica del cristianesimo e autrice di importanti contributi sul conflitto di genere nella storia della Chiesa.
La riflessione prende le mosse dal recente intervento di papa Francesco volto a istituire una commissione di studio sul diaconato femminile. Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi che «hanno riaperto questioni antiche, suscitando speranze e opposizioni che, ancora una volta, indicano come la posta in gioco sia il potere nella Chiesa». «Se infatti - prosegue Valerio - il ministero fosse realmente inteso e vissuto come servizio non ci sarebbe alcun ostacolo per consentirlo anche alle donne. Ma evidentemente non è così. Le donne rimangono «a servizio», ma non hanno alcun ruolo decisionale».
IL TEMA DEL «SERVIZIO» nei suoi molteplici significati rappresenta il filo rosso con il quale si può leggere la vasta, per quanto sintetica, analisi proposta dall’autrice. Nelle Scritture, per esempio, da un lato si rimanda a contesti culturali nei quali la donna è sottomessa alle istituzioni di una società patriarcale e gerarchica, dall’altro non mancano episodi che rimandano alla condizione reale della donna dell’Oriente antico e aprono orizzonti di possibile emancipazione. È da leggere in quest’ottica l’ambivalente figura di Ester che attraverso la seduzione piega il dominio maschile ai propri fini. Lo stesso strumento usato da Giuditta che diventa emblema della fragilità del potere.
Si tratta dunque di un potere ambivalente che può risultare decisivo per le sorti di Israele, ma nello stesso tempo che spaventa e necessita di norme di controllo. In questo contesto - spiega Valerio - Gesù e la sua comunità sovvertono le regole di purità e impurità e integrano a pieno titolo le donne nel loro progetto di rifondazione religiosa. Per Paolo di Tarso «non c’è maschio e femmina, perché tutti siete uno in Cristo». Eppure, il cristianesimo presenta tra le sue aporie l’aver messo in discussione i rapporti di potere tra le persone riproponendoli però in maniera palese già a partire dal primo processo di clericalizzazione tra il II e III secolo.
PRENDE COSÌ FORMA una «teologia del peccato» che si nutre di un’interpretazione forzata delle lettere paoline e «vedrà la donna responsabile in prima persona di un debito infinito davanti a un Dio offeso e punitivo». Arriviamo così al cuore dello studio: l’esclusione dal sacerdozio, motivata da Tommaso sulla base della soggezione naturale del genere femminile, lo stratificarsi di un’antropologia negativa volta stigmatizzare la sessualità della donna («debole nel corpo e imperfetta nella ragione»), e contemporaneamente la presenza di donne in diverse posizione di potere.
L’autrice ci restituisce un panorama popolato da diaconesse e badesse, talvolta dignitarie di poteri feudali e semi-episcopali, e di protagoniste di esperimenti nuovi, come nel caso di Chiara d’Assisi che si presenta come «madre che non domina ma governa». Chiudono la rassegna alcune grandi figure del Novecento come Dorothy Day, fondatrice nel 1933 del movimento Catholic Worker, Eileen Egan, dirigente della sezione americana di Pax Christi, e Barbara Ward, economista di chiara fama e «uditrice» al Concilio Vaticano II.
Parlando dell’attualità della Chiesa di Bergoglio, Valerio auspica un cambiamento profondo che possa conciliare la religione con l’avvenuta trasformazione del paradigma antropologico.
IL CATTOLICESIMO è chiamato a «sperimentare modalità nuove di autorità feconda, creativa e condivisa» rifuggendo l’assimilazione alle categorie politico-androcentrice del passato, riscoprendo il sacerdozio come reale «servizio» e il messaggio originario del Cristo liberatore e sovversivo. Il nodo politico da sciogliere riguarda quindi principalmente la Chiesa, ma le implicazioni tra religioso e secolare analizzate in questo libro lasciano intuire le potenzialità civili di una riforma di questo tipo in una società ancora fortemente androcentrica.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE -- AL DI LA’ DEL NARCISISMO DI GENERE. LA "GIUDITTA SHAKESPEARE" DI VIRGINIA WOOLF, I MAESTRI "CONTRO LE DONNE", E LE "PROSPETTIVE FEMMINISTE".8 giugno 2016, di Federico La Sala
I maestri del disprezzo per le donne
di Daniela Monti (Corriere della Sera, 08.06.2016)
Nel 1929 Virginia Woolf, nel saggio Una stanza tutta per sé, inventa una storia: quella di Judith, ipotetica sorella di William Shakespeare, stessa genialità, stessa irrequietezza, stessa voglia di fare del fratello. Per seguire il proprio talento, Judith si istruisce come può, leggendo il poco che trova per casa (ma appena i genitori se ne accorgono, le tolgono i libri e le mettono in mano delle calze da rammendare), rifiuta il matrimonio spezzando il cuore al padre, scappa per inseguire il sogno di fare teatro e viene accolta da un impresario che la schernisce e da un agente teatrale che, impietosito, la mette incinta. Alla fine, non trova altra via di uscita che uccidersi.
Mentre il talento del fratello è celebrato, il suo non vale niente: ha sfidato l’ordine naturale delle cose che la vuole debole, inferiore, indegna di ricevere un’istruzione e, insieme, selvaggia e ingestibile, una a cui mettere fin da subito il guinzaglio; si è illusa di potersi esprimere da donna e artista, senza neppure ricorrere all’espediente di camuffarsi da uomo, che pure è una strada battuta; ha sbagliato tutto, è andata fuori ruolo e infatti non c’è nessuno disposto ad ascoltarla. Così Judith «giace sepolta a un certo incrocio, lì dove ora gli autobus si fermano nei pressi di Elephant and Castle». Potessimo posare una lapide mortuaria, sopra ci sarebbe scritto: coraggiosa e ingenua Judith Shakespeare, vittima di due millenni di pregiudizi contro le donne.
Perché quello contro il genere femminile, «a conti fatti, appare come il più antico, radicato, diffuso pregiudizio che la vicenda umana è stata in grado di produrre», scrive Paolo Ercolani nel suo Contro le donne (Marsilio, pp. 318, e 17,50), resoconto dettagliato di come, dalle origini della società occidentale, scrittori, filosofi, intellettuali abbiano alimentato un dibattito «tutto fra uomini» - le donne sembrano assenti dalla filosofia, se non come oggetto del discorso dei filosofi maschi - «per arrivare a stabilire l’inferiorità inemendabile e irrecuperabile dell’essere femminile». I grandi filosofi greci, i padri della Chiesa, gli illuministi, i rivoluzionari, i filosofi idealisti, persino quel campione della causa femminile che fu John Stuart Mill: un’operazione culturale a senso unico che affonda le radici nella presunta «deficienza fisica» delle donne per poi esportare tale mancanza in altri campi, quelli dell’etica, della morale, dell’organizzazione politica della società.
Fu nell’Atene democratica, «tanto esaltata dalla tradizione occidentale, che si diffuse il costume di imporre alle donne il velo di fronte a situazioni pubbliche e a uomini scapoli, al contrario di quello che accadeva a quel tempo in Persia o in Siria», scrive Ercolani, aprendo il fronte della globalizzazione del pregiudizio, il quale, come le malattie contagiose, è riuscito a infettare culture lontane e all’apparenza inconciliabili, stringendole in un unico blocco misogino.
E loro, le donne? «Molto spesso sono le donne stesse a sminuirsi rispetto al maschio, in una sorta di autofobia indotta da secoli di indottrinamento», scrive Ercolani. Il femminismo, che pure è una delle grandi narrazioni della modernità, resta ai margini del lungo excursus, diventando esso stesso un bersaglio quando «negando l’esistenza di una specificità femminile (differente dal maschio) e prefigurando irrealistici scenari di individui a-sessuati ha finito con il fare da sponda al pensiero misogino».
La via d’uscita proposta sta nel ridefinire i canoni dell’identità e soggettività umana, al di là del «narcisismo di genere». Come scriveva Caterina Botti nel suo Prospettive femministe (Mimesis), «fino a relativamente poco tempo fa l’assenza delle donne dalla filosofia non era considerata una questione degna di nota. Oggi invece lo è».
SUL TEMA, IN RETE, SI CFR.:
- DAL "CHE COSA" AL "CHI" ... DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant
- IL "SOGNO" DI MICHELANGELO: "DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE". Sibille e profeti: sulle tracce di Benjamin
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI -- Il Congresso della SPI. Antiche certezze (di Silvia Vegetti Finzi)23 maggio 2016, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA.
Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana
FACHINELLI, "SU FREUD".
Dal 26 al 29 maggio il congresso della Società Psicoanalitica Italiana
Antiche certezze: la Terra è Madre
Freud torna a Goethe per aiutarci
di Silvia Vegetti Finzi (Corriere della Sera, 23.05.2016)
Viviamo in un’epoca di crisi in cui l’orizzonte del futuro si è fatto opaco. Difficile per i giovani elaborare un progetto di vita in una società statica, dove il ricambio generazionale sembra essersi inceppato. La stagnazione, indebolendo la speranza, favorisce comportamenti ripetitivi, monotoni e coatti, come quelli indotti dalle dipendenze. Questo è uno dei problemi che saranno discussi nel prossimo Congresso nazionale della Società Psicoanalitica Italiana (Spi), che si terrà a Roma da giovedì 26 a domenica 29 maggio intitolato Le logiche del piacere, l’ambiguità del dolore.
Sotto il segno dell’ambivalenza tra piacere e dolore saranno affrontati molti temi, quali la malattia, l’anoressia, l’autismo, la seduzione della violenza, la corruzione, il terrorismo suicida, le mutilazioni genitali.
Ma quello delle dipendenze appare, per gravità e diffusione, uno dei più urgenti. Il loro ambito, un tempo riservato alle sostanze tossiche, come l’alcol e gli oppiacei, si sottrae ormai a qualsiasi catalogazione perché tutto può divenire droga: Internet, il sesso, il cibo, il gioco d’azzardo, persino il lavoro. Ciò che contraddistingue i comportamenti coatti è l’eccesso, la mancanza del limite, la dismisura. Come tali si rivelano effetti dell’inconscio, di un’economia onnipotente che ricerca il piacere sino a prevaricarlo per inseguire un «aldilà» che, come aveva svelato Freud, finisce per convergere con la pulsione di morte. La morte ci attrae perché offre un «rifugio» per la mente che, evitando la conflittualità che ogni relazione comporta, s’illude di bastare a se stessa.
La psicoanalisi più attuale e radicale, posta di fronte a queste contraddizioni, sta elaborando un nuovo modello che, articolando le dicotomie freudiane, come quelle tra pulsioni di vita e di morte, piacere e dolore, esterno e interno, individua scambi, commistioni e fusioni che rendono più complessa la teoria e più raffinata la clinica. La terapia non si limita ad abolire il sintomo ma si propone di trasformare l’assetto della mente per renderla capace di accettare l’ambivalenza e aprirsi alla percezione della bellezza creata dal lavoro analitico stesso.
La parte più innovativa del programma consiste tuttavia nel confronto con la neurobiologia delle emozioni, in particolare con le proposte di Jaak Panksepp che, riprendendo la convergenza auspicata da Freud nel Progetto (1895), propone di fondare una «neuropsicanalisi». Una prospettiva che coinvolge la ricerca, la formazione, la terapia, il modo di pensare noi stessi.
Non dimentichiamo però che, nel saggio Il problema dell’analisi condotta da non medici (1926), Freud indica, per la formazione degli psicoanalisti, un programma prevalentemente storico-letterario in cui lo psicoanalista ideale risulta un intellettuale complessivo. Una figura che sarà ribadita dal progetto Geografie della psicoanalisi che, affrontando il rischio dell’incomprensione, apre il sapere dell’inconscio a culture diverse e lontane.
L’ultima giornata infine, che fa da contrappunto alla discussione scientifica, sarà dedicata alla dimensione estetica nella natura, nell’arte e nella vita psichica stessa. Mentre la psicoanalisi classica sonda soprattutto il tempo, quella contemporanea valorizza lo spazio nella convinzione che il paesaggio esterno e interno interagiscano tramite una segreta, speculare sintonia. La contemplazione del mondo, non solo umano ma globale, naturale e culturale, ricongiunge etica ed estetica, riprendendo la coincidenza tra bello e buono degli antichi Greci.
Ogni nuovo nato incontra una primordiale esperienza della bellezza nella contemplazione della madre, che rappresenta per lui tutto l’ambiente. Riconoscere questa priorità significa recuperare una visione premoderna della Madre-Terra: valorizzare il nostro essere parte del cosmo, non per dominarlo e sfruttarlo ma per comprenderlo e tutelarlo.
Questa prospettiva ci riporta al dialogo che Freud intrattiene con Goethe quando, nel Faust , scorge nella bellezza la forza creativa che salverà il mondo.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
 Psicoanalisi, Storia e Politica....
Psicoanalisi, Storia e Politica....
 "LA FRECCIA FERMA". La lezione sorprendente e preveggente di Elvio Fachinelli
"LA FRECCIA FERMA". La lezione sorprendente e preveggente di Elvio Fachinelli PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET.
PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET. Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 PERVERSIONI di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
PERVERSIONI di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO- PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
- PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- IL PROGRAMMA DI KANT E LA MENTE ACCOGLIENTE. La mente più creativa? È quella androgina, parola di Virginia Woolf (di E. Brenna)4 aprile 2016, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E CONOSCENZA: IL PROGRAMMA DI KANT, FREUD, FACHINELLI. LA MENTE ACCOGLIENTE:
- Questione antropologica
 IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
IL PROGRAMMA DI KANT. DIFFERENZA SESSUALE E BISESSUALITA’ PSICHICA: UN NUOVO SOGGETTO, E LA NECESSITA’ DI "UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA".
- «Al momento di diventare sciamani, si dice, gli uomini cambiano sesso. È così posta in rilievo la profondità del mutamento necessario. Il femminile come atteggiamento recettivo non abolisce però il maschile, gli propone un mutamento parallelo» (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989). (federico la sala)
La mente più creativa? È quella androgina, parola di Virginia Woolf (e degli psicologi)
di Elena Brenna ("spunti di mezzanotte", 12 maggio, 2015)
- «Una mente che è puramente maschile non può creare, tanto quanto non può farlo una mente che sia puramente femminile»
Androgino è un termine che trova la propria origine nel greco. E non è poi così difficile intuirne le parole che gli danno vita e il loro significato. Basti pensare alla medicina che si occupa del corpo maschile e a quella che si occupa del corpo femminile: andrologia e ginecologia. Andròs e gyné, uomo e donna. Ma che cos’è l’androginia? Personalmente, mi piace pensarla come quell’insieme di caratteristiche di un essere umano che trascende la rigida definizione dei generi.
I Sonic Youth cantavano “Androgynous mind, androgynous mind. Hey hey are you gay? Are you God? God is gay, and you were right”. Era il 1994, probabilmente il decennio meno androgino della storia del Novecento. Ma qui non si parlerà di stile, anche se oggi l’androginia sembra essere diventata una moda. Forse, ma poco importa. Quel che conta, in fondo, è il risultato. E il risultato è abituare certe mentalità ad accettare la natura umana, quella natura umana che sono convinte di conoscere ed identificare in due distinte sessualità, ma che in verità è assai più complessa. Complessa, varia, multipla e bella in modo assurdo.
E non sarà certo un caso se è proprio la mente androgina ad essere la più creativa. Un concetto che Virginia Woolf espresse già nel 1929 nel saggio Una stanza tutta per sé, una lucida riflessione sulla condizione femminile. Che l’androginia psicologica sia essenziale alla creatività non è però solo un’idea nata dalla mente della scrittrice inglese: anche gli studi psicologici, come quelli condotti da Mihaly Csikszentmihalyi, lo dimostrano.
Ma facciamo un passo per volta e torniamo a Virginia Woolf, che nel suo saggio scriveva:
- Quando vidi la coppia entrare nel taxi, la mente sentì come se, dopo essere stata divisa, fosse tornata di nuovo insieme in una fusione naturale. La ragione ovvia sarebbe che è naturale per i sessi co-operare. Si ha un istinto profondo, se irrazionale, in favore della teoria secondo cui l’unione di uomo e donna porta alla massima soddisfazione, la felicità più completa. Ma la vista delle due persone che salivano sul taxi e la soddisfazione che mi diede, mi fece anche domandare se ci sono due sessi nella mente che corrispondono ai due sessi nel corpo e se questi richiedono anche di essere uniti perché si ottenga la completa soddisfazione e felicità. E sono andata avanti, in modo dilettantesco, a fare uno schizzo della mappa dell’anima, in modo che in ognuno di noi presiedano due poteri, uno maschile, uno femminile; e nel cervello maschile, l’uomo predomina sulla donna e nel cervello femminile, la donna predomina sull’uomo. Il normale e confortevole stato dell’essere si ha quando entrambi vivono insieme armoniosamente, quando co-operano spiritualmente. Se uno è uomo, la parte femminile del suo cervello deve ancora avere effetto; e anche una donna deve avere un rapporto con l’uomo che c’è in lei.
- Forse Coleridge voleva dire questo quando disse che una grande mente è androgina. È quando questa fusione prende luogo che la mente è pienamente fertilizzata e usa tutte le sue facoltà. Forse una mente che è puramente maschile non può creare, tanto quanto non può farlo una mente che sia puramente femminile, penso. [...] Coleridge voleva dire, forse, che la mente androgina è risonante e permeabile; che trasmette emozione senza impedimenti; che è naturalmente creativa, incandescente e assoluta. In effetti, si torna indietro alla mente di Shakespeare come esempio di androgino, della mente uomo-femminile... E se fosse vero che non pensare specialmente o separatamente del sesso è uno dei gettoni della mente pienamente sviluppata, quanto più difficile è conquistare quella condizione ora più che mai... Nessuna età può essere stata acutamente cosciente del sesso come la nostra...
Quasi 70 anni dopo il saggio di Virginia Woolf, anche lo psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, autore di studi sulla felicità e sulla creatività e celebre per aver ideato il concetto di flusso, ha espresso la stessa opinione nel libro Creativity: The Psychology of Discovery and Invention:
L’androginia mentale, è chiaro, non va confusa con l’omosessualità:
- L’androginia psicologica è un concetto molto più ampio che si riferisce all’abilità di una persona di essere allo stesso tempo aggressiva e protettiva, sensibile e rigida, dominante e remissiva, a prescindere dal genere. Una persona psicologicamente androgina a tutti gli effetti duplica il proprio repertorio di risposte e può interagire con il mondo in termini di un più ricco e vario spettro di opportunità. Non è una sorpresa che gli individui creativi sono più propensi a non avere solo le forze del loro genere ma anche quelle dell’altro.
- Questione antropologica
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- SU "JUDITH", LA LEZIONE DI VIRGINIA WOOLF.29 marzo 2016, di Federico La Sala
"UN UOMO PIU’ UNA DONNA HA PRODOTTO, PER SECOLI, UN UOMO" (Franca Ongaro Basaglia).
- JUDITH, LA "SORELLA MERAVIGLIOSAMENTE DOTATA" DI SHAKESPEARE. LA LEZIONE DI VIRGINIA WOOLF: *
- [...] Ad ogni modo non potevo non pensare, mentre guardavo le opere di Shakespeare nello scaffale, che almeno in questo il vescovo aveva avuto ragione; sarebbe stato impossibile, completamente e interamente impossibile che una donna scrivesse nell’epoca di Shakespeare le opere di Shakespeare. Immaginiamo, giacché ci riesce così difficile conoscere la realtà, che cosa sarebbe successo se Shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata, chiamata Judith, diciamo. -Molto probabilmente Shakespeare studiò - poiché sua madre era ricca - alla grammar school; gli avranno insegnato il latino - Ovidio, Virgilio e Orazio - e qualche elemento di grammatica e di logica. Era, come si sa un ragazzo irrequieto, il quale cacciava di frodo i conigli, e forse anche i daini; e dovette anche, prima di quanto avrebbe voluto, sposare una donna dei dintorni, che gli diede un figlio un po’ più presto del solito. Questa avventura lo spinse a cercare fortuna a Londra. Si interessava, a quanto pare, di teatro; dicono che abbia cominciato facendo la guardia ai cavalli presso l’ingresso degli attori. Presto imparò a recitare, divenne un attore di successo, e si trovò al centro della società contemporanea; vedeva tutti, conosceva tutti, sfoggiava al sua arte sulla scena, il suo spirito per strada, e riuscì perfino ad essere ricevuto nel palazzo della regina.
 Intanto sua sorella,così dotata, supponiamo, rimaneva in casa. Ella non era meno avventurosa, immaginativa e desiderosa di conoscere il mondo di quanto non lo fosse suo fratello. Ma non aveva studiato. Non aveva potuto imparare la grammatica e la logica, e non diciamo leggere Orazio e Virgilio. A volte prendeva un libro, magari un libro di suo fratello, e leggeva qualche pagina. Ma poi arrivavano i suoi genitori e le dicevano di rammendare le calze o di fare attenzione all’umido in cucina e di non perdere tempo tra libri e carte. Questi ammonimenti saranno stati netti, benché affettuosi, poiché si trattava di persone agiate, che sapevano come debbono vivere le donne, e amavano la loro figlia; anzi, è molto probabile che ella fosse la figlia diletta di suo padre. Forse riusciva a riempire di nascosto qualche pagina, su nell’attico; ma poi aveva cura di nasconderle o di bruciarle.
Intanto sua sorella,così dotata, supponiamo, rimaneva in casa. Ella non era meno avventurosa, immaginativa e desiderosa di conoscere il mondo di quanto non lo fosse suo fratello. Ma non aveva studiato. Non aveva potuto imparare la grammatica e la logica, e non diciamo leggere Orazio e Virgilio. A volte prendeva un libro, magari un libro di suo fratello, e leggeva qualche pagina. Ma poi arrivavano i suoi genitori e le dicevano di rammendare le calze o di fare attenzione all’umido in cucina e di non perdere tempo tra libri e carte. Questi ammonimenti saranno stati netti, benché affettuosi, poiché si trattava di persone agiate, che sapevano come debbono vivere le donne, e amavano la loro figlia; anzi, è molto probabile che ella fosse la figlia diletta di suo padre. Forse riusciva a riempire di nascosto qualche pagina, su nell’attico; ma poi aveva cura di nasconderle o di bruciarle.
 A ogni modo, non appena arrivata alla pubertà, ella era stata promessa al figlio di un vicino mercante di lane. La ragazza protestò che il matrimonio era per lei una cosa abominevole; sicché suo padre la picchiò con violenza. Poi, cambiando tono, la pregò di non fargli questo danno, questa vergogna di rifiutare il matrimonio. Le avrebbe regalato una bella collana, oppure una bella gonna, diceva, con le lacrime agli occhi. Poteva forse disubbidirgli? Poteva forse spezzargli il cuore? Eppure la forza del suo talento la spinse al gesto inconsueto.
A ogni modo, non appena arrivata alla pubertà, ella era stata promessa al figlio di un vicino mercante di lane. La ragazza protestò che il matrimonio era per lei una cosa abominevole; sicché suo padre la picchiò con violenza. Poi, cambiando tono, la pregò di non fargli questo danno, questa vergogna di rifiutare il matrimonio. Le avrebbe regalato una bella collana, oppure una bella gonna, diceva, con le lacrime agli occhi. Poteva forse disubbidirgli? Poteva forse spezzargli il cuore? Eppure la forza del suo talento la spinse al gesto inconsueto.
 Una sera d’estate Judith fece fagotto con le sue cose, scese dalla finestra e prese la strada di Londra. Non aveva ancora diciassette anni. Gli uccelli che cantavano sulle siepi non erano più musicali di lei. Ella possedeva, come suo fratello, la più viva fantasia, il più vivo senso della musica delle parole. Come lui, si sentiva attratta dal teatro. Bussò alla porta degli attori;voleva recitare, disse. Gli uomini le risero in faccia. L’amministratore, - un uomo grasso, dalle labbra spesse - proruppe in una gran risata. Disse qualcosa sui cani ballerini e sulle donne che volevano recitare; nessuna donna, disse, poteva essere attrice. Egli accennò invece ... ve lo potete immaginare. Nessuno le avrebbe insegnato a recitare. D’altronde non poteva mangiare nelle taverne, né girare per le strade a mezzanotte.
Una sera d’estate Judith fece fagotto con le sue cose, scese dalla finestra e prese la strada di Londra. Non aveva ancora diciassette anni. Gli uccelli che cantavano sulle siepi non erano più musicali di lei. Ella possedeva, come suo fratello, la più viva fantasia, il più vivo senso della musica delle parole. Come lui, si sentiva attratta dal teatro. Bussò alla porta degli attori;voleva recitare, disse. Gli uomini le risero in faccia. L’amministratore, - un uomo grasso, dalle labbra spesse - proruppe in una gran risata. Disse qualcosa sui cani ballerini e sulle donne che volevano recitare; nessuna donna, disse, poteva essere attrice. Egli accennò invece ... ve lo potete immaginare. Nessuno le avrebbe insegnato a recitare. D’altronde non poteva mangiare nelle taverne, né girare per le strade a mezzanotte.
 Eppure il genio di Judith la spingeva verso la letteratura; ella desiderava cibarsi abbondantemente della vita degli uomini e delle donne studiare i loro costumi. Infine (poiché era molto giovane, e di viso assomigliava molto a Shakespeare, con gli stessi occhi grigi e la fronte curva) Nick Greene, l’attore-regista, ebbe pietà di lei; Judith si trovò incinta di questo signore, e pertanto - chi può misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando questo si trova prigioniero e intrappolato nel corpo di una donna? - si uccise, una notte d’inverno, e venne sepolta a un incrocio, là dove ora si fermano gli autobus, presso Elephant and Castle.
Eppure il genio di Judith la spingeva verso la letteratura; ella desiderava cibarsi abbondantemente della vita degli uomini e delle donne studiare i loro costumi. Infine (poiché era molto giovane, e di viso assomigliava molto a Shakespeare, con gli stessi occhi grigi e la fronte curva) Nick Greene, l’attore-regista, ebbe pietà di lei; Judith si trovò incinta di questo signore, e pertanto - chi può misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando questo si trova prigioniero e intrappolato nel corpo di una donna? - si uccise, una notte d’inverno, e venne sepolta a un incrocio, là dove ora si fermano gli autobus, presso Elephant and Castle.
 Così più o meno, sarebbe andata la storia, immagino, se ai tempi di Shakespeare una donna avesse avuto il genio di Shakespeare [...].
Così più o meno, sarebbe andata la storia, immagino, se ai tempi di Shakespeare una donna avesse avuto il genio di Shakespeare [...].
- Cos’altro posso fare per incoraggiarvi a far fronte alla vita? Ragazze, dovrei dirvi - e per favore ascoltatemi, perché comincia la perorazione - che a mio parere siete vergognosamente ignoranti. Non avete mai fatto scoperte di alcuna importanza. Non avete mai fatto tremare un impero, né condotto in battaglia un esercito. Non avete scritto i drammi di Shakespeare, e non avete mai impartito i benefici della civiltà ad una razza barbara.
 Come vi giustificate? È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo gremite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell’industria, nel commercio, nell’amore: abbiamo avuto altro da fare. Senza la nostra attività nessuno avrebbe solcato questi mari, e queste terre fertili sarebbero state deserto.
Come vi giustificate? È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo gremite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell’industria, nel commercio, nell’amore: abbiamo avuto altro da fare. Senza la nostra attività nessuno avrebbe solcato questi mari, e queste terre fertili sarebbero state deserto.
 Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all’età di sei o sette anni, i milleseicentoventitré milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo; e questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.
Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all’età di sei o sette anni, i milleseicentoventitré milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo; e questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.
 C’è del vero in quel che dite - non lo nego. Ma nello stesso tempo devo ricordarvi che fin dal 1866 esistevano in Inghilterra almeno due colleges femminili; che, a partire dal 1880, una donna sposata poteva, per legge, possedere i propri beni; e nel 1919 - cioè più di nove anni fa - le è stato concesso il voto? Devo anche ricordarvi che da ben dieci anni vi è stato aperto l’accesso a quasi tutte le professioni?
C’è del vero in quel che dite - non lo nego. Ma nello stesso tempo devo ricordarvi che fin dal 1866 esistevano in Inghilterra almeno due colleges femminili; che, a partire dal 1880, una donna sposata poteva, per legge, possedere i propri beni; e nel 1919 - cioè più di nove anni fa - le è stato concesso il voto? Devo anche ricordarvi che da ben dieci anni vi è stato aperto l’accesso a quasi tutte le professioni?
 Se riflettete su questi immensi privilegi e sul lungo tempo in cui sono stati goduti, e sul fatto che in questo momento devono esserci quasi duemila donne in grado di guadagnare più di cinquecento sterline l’anno, in un modo o nell’altro, ammetterete che la scusa di mancanza di opportunità, di preparazione, di incoraggiamento, di agio e di denaro non regge più. Inoltre gli economisti ci dicono che la signora Seton ha avuto troppi figli. Naturalmente dovete continuare a far figli, ma, così dicono, solo due o tre a testa, non dieci o dodici come prima [...].
Se riflettete su questi immensi privilegi e sul lungo tempo in cui sono stati goduti, e sul fatto che in questo momento devono esserci quasi duemila donne in grado di guadagnare più di cinquecento sterline l’anno, in un modo o nell’altro, ammetterete che la scusa di mancanza di opportunità, di preparazione, di incoraggiamento, di agio e di denaro non regge più. Inoltre gli economisti ci dicono che la signora Seton ha avuto troppi figli. Naturalmente dovete continuare a far figli, ma, così dicono, solo due o tre a testa, non dieci o dodici come prima [...].
- Vi ho già detto, nel corso della mia conferenza, che Shakespeare aveva una sorella; ma voi non cercatela nella
biografia del poeta scritta da Sir Sidney Lee. Lei morì giovane, e ahimé non scrisse neanche una parola. È sepolta
là dove si fermano gli autobus, di fronte alla stazione di Elephant and Castle.
 Ora, è mia ferma convinzione che
questa poetessa che non scrisse mai una parola e fu seppellita nei pressi di un incrocio, è ancora viva. Vive in voi,
e in me, e in molte altre donne che non sono qui stasera perché stanno lavando i piatti e mettendo a letto i
bambini. Eppure lei è viva.
Ora, è mia ferma convinzione che
questa poetessa che non scrisse mai una parola e fu seppellita nei pressi di un incrocio, è ancora viva. Vive in voi,
e in me, e in molte altre donne che non sono qui stasera perché stanno lavando i piatti e mettendo a letto i
bambini. Eppure lei è viva.
 Perché i grandi poeti non muoiono; essi sono presenze che rimangono; hanno bisogno
di un’opportunità per tornare in mezzo a noi in carne ed ossa. E offrirle questa opportunità, a me sembra, comincia
a dipendere da voi.
Perché i grandi poeti non muoiono; essi sono presenze che rimangono; hanno bisogno
di un’opportunità per tornare in mezzo a noi in carne ed ossa. E offrirle questa opportunità, a me sembra, comincia
a dipendere da voi.
 Poiché io credo che se vivremo ancora un altro secolo - e mi riferisco qui alla vita comune,
che è poi la vita vera e no alle piccole vite isolate che viviamo come individui - e se riusciremo, ciascuna di noi,
ad avere cinquecento sterline l’anno e una stanza tutta per sé; se prenderemo l’abitudine alla libertà e il coraggio di
scrivere esattamente quello che pensiamo; se ci allontaneremo un poco dalla stanza di soggiorno comune e
guarderemo gli esseri umani non sempre in rapporto l’uno all’altro ma in rapporto alla realtà; e così pure il cielo, e
gli alberi, o qualunque altra cosa, allo stesso modo; se guarderemo oltre lo spauracchio di Milton, perché nessun
essere umano deve precluderci la visuale; se guarderemo in faccia il fatto - perché è un fatto - che non c’è
neanche un braccio al quale dobbiamo appoggiarci ma che dobbiamo camminare da sole e dobbiamo entrare in
rapporto con il mondo della realtà e non soltanto con il mondo degli uomini e delle donne, allora si presenterà
l’opportunità, e quella poetessa morta, che era sorella di Shakespeare, riprenderà quel corpo che tante volte ha
dovuto abbandonare. Prendendo vita dalla vita di tutte quelle sconosciute che l’avevano preceduta, come suo
fratello aveva fatto prima di lei, lei nascerà.
Poiché io credo che se vivremo ancora un altro secolo - e mi riferisco qui alla vita comune,
che è poi la vita vera e no alle piccole vite isolate che viviamo come individui - e se riusciremo, ciascuna di noi,
ad avere cinquecento sterline l’anno e una stanza tutta per sé; se prenderemo l’abitudine alla libertà e il coraggio di
scrivere esattamente quello che pensiamo; se ci allontaneremo un poco dalla stanza di soggiorno comune e
guarderemo gli esseri umani non sempre in rapporto l’uno all’altro ma in rapporto alla realtà; e così pure il cielo, e
gli alberi, o qualunque altra cosa, allo stesso modo; se guarderemo oltre lo spauracchio di Milton, perché nessun
essere umano deve precluderci la visuale; se guarderemo in faccia il fatto - perché è un fatto - che non c’è
neanche un braccio al quale dobbiamo appoggiarci ma che dobbiamo camminare da sole e dobbiamo entrare in
rapporto con il mondo della realtà e non soltanto con il mondo degli uomini e delle donne, allora si presenterà
l’opportunità, e quella poetessa morta, che era sorella di Shakespeare, riprenderà quel corpo che tante volte ha
dovuto abbandonare. Prendendo vita dalla vita di tutte quelle sconosciute che l’avevano preceduta, come suo
fratello aveva fatto prima di lei, lei nascerà.
 Ma che lei possa nascere senza quella preparazione, senza quello
sforzo da parte nostra, senza la precisa convinzione che una volta rinata le sarà possibile vivere e scrivere la sua
poesia, è una cosa che davvero non possiamo aspettarci perché sarebbe impossibile. Ma io sono convinta che lei
verrà, se lavoreremo per lei, e che lavorare così, anche se in povertà e nell’oscurità, vale certamente la pena.
Ma che lei possa nascere senza quella preparazione, senza quello
sforzo da parte nostra, senza la precisa convinzione che una volta rinata le sarà possibile vivere e scrivere la sua
poesia, è una cosa che davvero non possiamo aspettarci perché sarebbe impossibile. Ma io sono convinta che lei
verrà, se lavoreremo per lei, e che lavorare così, anche se in povertà e nell’oscurità, vale certamente la pena.
- Virginia Woolf, "Una stanza tutta per sé", in: Romanzi e Altro, "I Meridiani" - Mondadori, pp. 761-763, e, pp. 831-833.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
FILOSOFIA E PSICOANALISI. E. Fachinelli, Sulla spiaggia (1985): La mente estatica (1989). Il libro, nella dedica, è "per Giuditta"....
 LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera
LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali)
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE. Una nota di Eleonora Cirant (e altri materiali) CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA.
CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA. CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.
CREATIVITA’: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE.-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- SU "JUDITH", LA LEZIONE DI VIRGINIA WOOLF.30 marzo 2016, di Federico La Sala
DOPO "Una stanza tutta per sé" (1929), DOPO I "Pensieri di pace durante un’incursione aerea" (1940), DOPO LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA, CHI HA (ANCORA!) PAURA DI "GIUDITTA", di "JUDITH" (VIRGINIA WOOLF)?!:
- Cerchiamo di fare conscio l’inconscio hitlerismo che ci opprime. E’ il desiderio di aggressione; il desiderio di rendere schiavi. Perfino nel buio possiamo vederlo chiaramente. Vediamo le vetrine dei negozi illuminati a giorno, e le donne che guardano; donne incipriate; donne travestite; donne dalle labbra rosse e dalle unghie rosse. Sono schiave che cercano di rendere schiavi gli altri. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, avremo liberato gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi.
- COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! Una nota introduttiva alla “Istruzione sessuale dei bambini” (1907) di Sigmund Freud (federico la sala)
PENSIERI DI PACE DURANTE UN’INCURSIONE AEREA [1940]
di Virginia Woolf *
I tedeschi sono passati sopra questa casa ieri sera e la sera prima. Eccoli un’altra volta. E’ una strana esperienza, questa di stare sdraiata nel buio e ascoltare il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerci mortalmente. E’ un rumore che non permette di pensare freddamente e coerentemente alla pace. Eppure è un rumore che dovrebbe costringerci - assai più che non gli inni e le preghiere - a pensare alla pace. Poiché se non riusciamo, a forza di pensare, a infondere esistenza a questa pace, continueremo per sempre a giacere - non questo corpo in questo letto bensì milioni di corpi non ancora nati - nello stesso buio, ascoltando lo stesso rumore di morte sulla testa. Facciamo tutto il possibile per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre là sul colle sparano i cannoni e i riflettori tastano le nuvole; e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba.
Lassù in cielo combattono giovani inglesi contro giovani tedeschi. I difensori sono uomini, gli attaccanti sono uomini. Alla donna inglese non vengono consegnate armi, né per combattere il nemico né per difendersi. Ella deve giacere disarmata, questa sera. Eppure se ella crede che quel combattimento lassù in cielo è una lotta da parte degli inglesi per proteggere la libertà, da parte dei tedeschi per distruggere la libertà, ella deve lottare, con tutte le sue forze, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi? Fabbricandole, oppure fabbricando vestiti e alimenti. Ma c’è un altro modo di lottare senza armi per la libertà. Possiamo lottare con la mente; fabbricare delle idee, le quali possano aiutare quel giovane inglese che combatte lassù in cielo a vincere il nemico.
Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di accendere la loro miccia. Dobbiamo metterle in azione. E quel calabrone in cielo mi sveglia un altro calabrone nella mente. Ce n’era uno questa mattina, che ronzava nel "Times"; era la voce di una donna che protestava: "Le donne non possono dire una parola sulle questioni politiche." Non c’è nessuna donna nel Gabinetto; né in nessun posto di responsabilità. Tutti i fabbricanti di idee, in grado di attuare queste loro idee, sono uomini. Ecco un pensiero che soffoca il pensiero, e incoraggia invece l’irresponsabilità. Perché non sprofondare allora la testa nel cuscino, otturarsi le orecchie e abbandonare questa futile attività di fabbricare idee? Poiché ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari, e i tavoli delle conferenze. Potrebbe darsi che se noi rinunciamo al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché esso ci sembra inutile, stiamo privando quel giovane inglese di un’arma che potrebbe essergli utile. Non stiamo esagerando la nostra incapacità, solo perché la nostra capacità ci espone forse all’insulto, al disprezzo? "Non cesserò di lottare mentalmente", scrisse Blake. Lottare mentalmente significa pensare contro la corrente, e non a favore di essa.
E quella corrente scorre veloce e violenta. Straripa in parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero il quale combatte per difendere la libertà. Quella è la corrente che ha trascinato nei suoi turbini quel giovane aviatore fino al cielo, e che lo fa girare incessantemente tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas sotto le mani, è nostro dovere sgonfiare questi palloni d’aria e scoprire qualche germe di verità. Non è vero che siamo liberi. Questa sera siamo tutti e due prigionieri: lui nella sua macchina con un’arma accanto, noi sdraiati nel buio con una maschera antigas accanto. Se fossimo liberi saremmo all’aperto, a ballare, o in un teatro, o seduti davanti alla finestra, conversando. Che cosa ce lo impedisce? "Hitler!" esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cosa è Hitler? L’aggressività, la tirannia, l’amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo, e sarete liberi.
Ora sulla mia testa gli aerei rombano come se segassero il ramo di un albero. Gira e gira, segando e segando quel ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro suono comincia a aprirsi, anch’esso segando, una galleria. "Le donne capaci" - così diceva Lady Astor nel "Times" di questa mattina - "vengono ostacolate in tutte le carriere a causa dell’inconscio hitlerismo nel cuore dell’uomo." E’ vero, siamo ostacolate. E questa sera siamo tutti prigionieri: gli inglesi nei loro aerei, le inglesi nei loro letti. Ma se lui smette un attimo di pensare, possono ucciderlo; e anche noi. Pertanto, pensiamo per lui. Cerchiamo di fare conscio l’inconscio hitlerismo che ci opprime. E’ il desiderio di aggressione; il desiderio di rendere schiavi. Perfino nel buio possiamo vederlo chiaramente. Vediamo le vetrine dei negozi illuminati a giorno, e le donne che guardano; donne incipriate; donne travestite; donne dalle labbra rosse e dalle unghie rosse. Sono schiave che cercano di rendere schiavi gli altri. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, avremo liberato gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi.
Cade una bomba. Tutte le finestre tremano. I cannoni antiaerei entrano in azione. Là, sull’alto del colle, sotto una rete con pezzi appiccicati di stoffa verde e bruna, imitando i colori delle foglie d’autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle nove ci dirà: "Questa sera sono stati abbattuti quarantaquattro aerei nemici, dieci dei quali dal fuoco antiaereo." E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, sarà il disarmo. Non ci saranno più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell’avvenire. I giovani non saranno più addestrati a combattere con le armi. Quello sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello, un’altra citazione: "Combattere contro un nemico reale, meritare eterno onore e gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti, e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni, quello era il colmo delle mie speranze... A questo era stata dedicata, finora, tutta la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto..."
Queste sono le parole di un giovane inglese combattente nell’ultima guerra. Davanti a queste parole, possono credere onestamente i pensatori dell’accennata corrente che scrivendo "disarmo" su un pezzo di carta in una conferenza di ministri, avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Otello non avrà più occupazione, ma egli sarà sempre Otello. Quel giovane aviatore in cielo non è spinto soltanto dalle voci degli altoparlanti; è spinto anche dalle voci che ascolta in sé, antichi istinti, istinti incoraggiati e nutriti dall’educazione e dalla tradizione. Glieli dobbiamo forse rimproverare? Si potrebbe forse sopprimere l’istinto materno, perché così ha voluto un gruppo di politici? Supponiamo che fra le condizioni di pace ci fosse questa, imperativa: "L’esercizio della maternità sarà ristretto a una classe ridotta di donne accuratamente selezionate", forse sarebbe accettata? Piuttosto diremmo: "L’istinto materno è la gloria della donna. A questo è stata dedicata finora la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto..." Ma se fosse necessario, per il benessere dell’umanità, per la pace del mondo, che l’esercizio della maternità venisse ristretto, e l’istinto materno messo a tacere, forse le donne non si rifiuterebbero. Gli uomini le aiuterebbero. Onorerebbero queste donne per il loro rifiuto di generare. Aprirebbero altre possibilità al loro potere creativo. E anche questo deve essere parte della nostra lotta per la libertà. Dobbiamo aiutare i giovani inglesi a togliere dai loro cuori l’amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per coloro i quali cercano di dominare in se stessi l’istinto combattivo, l’inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l’uomo per la perdita delle sue armi.
Il rumore di sega sulle nostre teste aumenta. Tutti i riflettori puntano in alto, verso un punto sito esattamente sopra questo tetto. In qualunque momento può cadere una bomba in questa stanza. Uno due tre quattro cinque sei... passano i secondi. La bomba non è caduta. Ma durante quei secondi di attesa, l’attività del pensiero è cessata. E anche è cessato ogni sentimento, tranne un opaco timore. Un chiodo fissava tutto l’essere a un’asse di legno duro. L’emozione della paura e dell’odio è pertanto sterile, non fertile. Non appena la paura scompare, la mente affiora di nuovo e istintivamente cerca di rivivere creando. Siccome la stanza è al buio, può creare soltanto con la memoria. Si protende verso il ricordo di altri agosti, a Bayreuth, ascoltando Wagner; a Roma, passeggiando per la campagna romana; a Londra. Ritornano le voci degli amici; frammenti di poesia. Ognuno di questi pensieri, anche nella memoria, era assai più positivo, rinfrescante, consolatore e creativo di quanto non lo fosse quell’opaco spavento, fatto di paura e di odio. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane della perdita della sua gloria e della sua arma, gli dobbiamo aprire l’accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fabbricare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all’aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese, se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi?
I riflettori, ondeggiando sulla pianura hanno trovato finalmente l’aereo. Da questa finestra si può vedere un piccolo insetto argentato che gira e si contorce nella luce. I cannoni sparano e sparano. Poi smettono. Probabilmente l’attaccante è stato colpito, dietro il colle. L’altro giorno, uno dei piloti riuscì ad atterrare in un campo qui vicino. In un inglese abbastanza tollerabile, disse ai suoi catturatori: "Come sono contento che la lotta sia finita!" Poi un inglese gli diede una sigaretta, e una inglese gli offri una tazza di tè. Questo starebbe a dimostrare che se si riesce a liberare l’uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile.
Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. Tutti i riflettori si sono spenti. Il buio naturale della notte d’estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo grida, spostandosi da un albero all’altro. E qualche parola quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese mi viene in mente: "I cacciatori si sono alzati in America... " Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono alzati in America, agli uomini e alle donne il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, con la speranza che vengano ripensate, generosamente e caritatevolmente, e forse rimaneggiate fino a diventare qualcosa di utile. E adesso, in questa metà buia del mondo, a dormire.
1940, da The Death of the Moth
* Virginia Woolf, Romanzi e Altro, "I Meridiani" - Mondadori, pp. 871-876.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. -- SPINOZA NON FA SPETTACOLO: GLI OFFENDICULA DI PIPPO BAUDO (E. Fachinelli - a c. di Dario Borso).20 marzo 2016, di Federico La Sala
GLI OFFENDICULA DI PIPPO BAUDO
di Elvio Fachinelli *
- Dopo un lustro di Domenica In e svariati Festival di Sanremo, Baudo nel 1984 era all’apice del successo televisivo. Logico quindi che Ermanno Rea lo intervistasse il 17 novembre sul “Giorno” - meno logico, apparentemente, che all’intervista dedicasse un commento a latere lo psicanalista Elvio Fachinelli.
 A leggerlo però, si capisce tutto: in una società che stava passando rapida da Edipo a Narciso, la saga parentale del Pippo nazionale confermava in pieno senza volerlo (né saperlo) la duplicità kleiniana del seno (buono/cattivo), quadruplicando addirittura. Leggere per credere.
A leggerlo però, si capisce tutto: in una società che stava passando rapida da Edipo a Narciso, la saga parentale del Pippo nazionale confermava in pieno senza volerlo (né saperlo) la duplicità kleiniana del seno (buono/cattivo), quadruplicando addirittura. Leggere per credere.
 Avverto solo che nel ’68 Baudo aveva scalato l’hit parade dei 45 giri con Donna Rosa; che una buona definizione di offendicula si trova su Wikipedia; che il commento non l’ho inserito in E. Fachinelli, Al cuore delle cose. Scritti politici, DeriveApprodi 2016, per il suo carattere solo indirettamente politico (e forse ho fatto male); che ne riparliamo qui con Muraro, Recalcati ecc.
Avverto solo che nel ’68 Baudo aveva scalato l’hit parade dei 45 giri con Donna Rosa; che una buona definizione di offendicula si trova su Wikipedia; che il commento non l’ho inserito in E. Fachinelli, Al cuore delle cose. Scritti politici, DeriveApprodi 2016, per il suo carattere solo indirettamente politico (e forse ho fatto male); che ne riparliamo qui con Muraro, Recalcati ecc.
 Dario Borso
Dario Borso
#
L’analista cammina sulla superficie liscia e lucente dell’intervista all’uomo-spettacolo e non incontra ostacoli. Finché, a un certo punto, urta contro un sassolino roseo, anzi Rosa... È un nome, il nome della zia Rosa alla quale è stata dedicata persino una canzone e che ci viene presentata dall’attore-giornalista come una figura di «ballerina», di «complice» nell’ambito familiare. Possiamo da ciò arguire che si tratta di una persona accettante, consenziente, entusiasta delle imprese «esibitive» del bambino Pippo Baudo? Se così è stato, e non sembra eccessivo affermarlo, allora abbiamo davanti una figura di madre chiamata a compensare le difficoltà suscitate dalla madre vera, matriarca ostinata e severa, capo della casa, che non ha mai visto di buon occhio - perlomeno fino a un certo punto! - l’attività di entertainer e si è augurata per il figlio qualcosa di più «serio», quanto meno la presentazione del telegiornale...
Di fianco alla madre «complice», avremmo perciò per il giovane Baudo un’altra madre - non approvante, forse vietante, forse giudicante - che provoca un rancore non sopito («Lo dico a costo di offendere mia madre, ma lo debbo dire»).
È un sassolino, si è detto, e si potrebbe ritenere senza alcuna importanza rispetto alla riuscita trionfale di Baudo, nata dall’esercizio e dallo sviluppo di un talento, di un gusto per lo spettacolo, di un piacere di stare in scena che risalgono alla primissima infanzia.
Ma qui l’analista incontra sulla sua strada un altro sassolino da nulla in apparenza, che questa volta è segnato da un grazioso nome latino: gli offendicula («bisogna mettere gli offendicula»). Termine non dei più noti e frequenti, che ha in sé qualcosa di elegante e impertinente insieme, degno di un umanista ironico. E che non ci aspetteremmo di trovare sulla bocca del popolarissimo presentatore di Domenica In.
Ermanno Rea, l’intervistatore, ha guardato nella sua libreria e vi ha trovato libri in serie, casuali, acquistati per fare arredamento. Sarà. Ma gli offendicula testimoniano che la mente dell’intervistato non è così uniforme come le copertine dei suoi volumi d’enciclopedia. Non è così liscia e piatta come l’immagine sul teleschermo dei suoi spettacoli. Vi si svolge in sordina quasi un dibattito tra aspirazione alla serietà, alla severità, al rigore, termini che ricorrono continuamente nell’intervista, e il principio dominante, assoluto, dello spettacolo a ogni costo. «Se la cosa fa spettacolo, m’interessa; se non fa spettacolo, non m’interessa». Se la cultura fa spettacolo, allora via libera a scrittori e intellettuali; sono richiesti e benvenuti; se non fa spettacolo, bocca chiusa. E Spinoza non fa spettacolo, ci vien detto in un punto dell’intervista; di conseguenza, lo si cancelli.
Ma Spinoza, cancellato, si vendica e mette gli offendicula; la sua severità si sposta sullo spettacolo: ed ecco allora che, quando Giorgio Bocca tuona contro la melassa delle domeniche televisive, il cuore di Baudo sanguina e si ode un grido: il mio spettacolo è serio, serissimo; è una sfida, una battaglia, un fronte di lotta. Il rigore della madre innominata si è insinuato nella madre ballerina e l’ha fatta incespicare.
- Dopo un lustro di Domenica In e svariati Festival di Sanremo, Baudo nel 1984 era all’apice del successo televisivo. Logico quindi che Ermanno Rea lo intervistasse il 17 novembre sul “Giorno” - meno logico, apparentemente, che all’intervista dedicasse un commento a latere lo psicanalista Elvio Fachinelli.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA --- Elvio Fachinelli: il clinico che ridefinì l’osceno (di Pietro Barbetta)5 marzo 2016, di Federico La Sala
Elvio Fachinelli: il clinico che ridefinì l’osceno
di Pietro Barbetta ("doppiozero", 2 settembre 2015)
Tempo fa William Buckley rimproverava Allen Ginsberg di comporre opere oscene per via del suo linguaggio; invitato a una trasmissione televisiva gestita dallo stesso Buckley, Ginsberg rispose che oscene non sono le parole, ma le morti durante l’allora guerra del Viet-Nam.
La biografia culturale di Elvio Fachinelli (1928-1989) sembra una genealogia Biblica. Il suo analista fu Cesare Musatti (1897-1989), il quale - considerato uno dei Padri della psicoanalisi italiana - si formò con Edoardo Weiss (1889-1970), il primo psicoanalista italiano. Weiss era, a sua volta, in supervisione dallo stesso Sigmund Freud. Nonostante le sue origini nobili e ortodosse, Fachinelli fu tra gli psicoanalisti che più cambiarono la psicoterapia in Italia.
In primo luogo rifiutò l’idea di “resistenza del paziente” a favore dell’accoglienza della “persona che frequenta l’analisi”, spostando la responsabilità della terapia sull’"esperto”. Negli anni Settanta nacque e si diffuse la strana idea che se c’è fallimento nella relazione tra il professionista e il suo utente, la responsabilità è del professionista, non dell’utente. Per esempio, se un tempo una persona moriva legata a un letto, si attribuiva la morte alla furia della persona. Basaglia per primo ebbe l’idea di invertire l’ordine delle responsabilità nei manicomi. Don Milani invertì l’ordine delle responsabilità nelle scuole. Lo stesso Fachinelli contribuì, con altri autori, a fondare una scuola libera, nell’epoca in cui veniva messo in discussione il ruolo dell’insegnamento. C’erano assonanze tra queste imprese. Quel che si ricorda meno di Fachinelli è il suo modo di ripensare il settting clinico, i limiti discorsivi e le pratiche inscritte in quel setting, la sua parte oscena.
Lo fece prima di quando Foucault pubblicò La volontà di sapere, nel novembre 1976. Foucault aveva indicato la psicoanalisi come luogo dove il desiderio incestuoso si trasforma in discorso, trattamento riservato alle élite borghesi, costantemente occupate a gestire perversioni e sentimenti di colpevolezza. Fachinelli aveva posto la medesima questione in modo ancor più radicale. A una conferenza nel 1975, parlando del Denaro dello psicoanalista, aveva contrapposto il contratto terapeutico classico - che vede il paziente nevrotico parlare di avversioni sessuali, ossessioni, manie e fissazioni - a un contesto sociale ampio, dove i soggetti possono raccontare storie di vita, di salari, politica, religione, lavoro, famiglia.
- “Nell’analisi - scriveva Fachinelli - qualcuno, l’analista, offre a pagamento una prestazione, un servizio, un’assistenza, chiamatelo come volete, qualcosa che nella sostanza è dell’ordine del lavoro, mentre qualcun altro, l’analizzando, chiede contro denaro qualcosa che è sempre nell’ordine di eros e della sua storia”.
Più tardi, in Claustrofilia, Fachinelli tornò su questi argomenti sviluppando nuove critiche al setting clinico. Una ricerca intorno ai termini “onorario” e “salario” gli aveva fatto scrivere che il termine “onorario” è, nell’uso tradizionale, somma una tantum, pagata dal soggetto che riceve il servizio, al professionista che onora l’impegno. “Salario” - che deriva dalla rata di sale ricevuta dal soldato durante l’Impero Romano - è una quota fissa di denaro pagata ai lavoratori nella moderna civiltà delle macchine. Con l’introduzione su larga scala delle prime generazioni di macchine, le “mansioni” dell’operaio addetto si modificarono rispetto all’attuazione di un compito preciso e ben definito. Si spostarono verso la sorveglianza del lavoro fatto dalle macchine, che a sua volta era ripetitivo, sempre uguale, con pochi “tempi morti” e così via. Ora, è del tutto notevole che Freud, passando al tipo definitivo di psicoterapia, sia andato incontro, senza esserne consapevole, a modificazioni analoghe della sua attività [...] In questo senso l’attività psicoterapeutica [...] diventa per la prima volta nella storia un lavoro proto-industriale, dove il “lavoro” è formalmente separato dalla “vita”, ma dove la “vita” è inglobata dal “lavoro” [...] la costanza del tempo macchinico si riflette in una durata programmaticamente indefinita del “trattamento”. Eliminando i “tempi morti” viene eliminata tendenzialmente anche la morte (cfr. pp. 24-25).
Gravi colpi, questi, inferti al setting clinico, di cui nessuno sembra ricordare: 1. critica radicale al concetto di “resistenza” e conseguente uso dell’accoglienza come responsabilità del terapeuta; 2. critica a un setting che paragona a quello della prostituta: scambio di denaro, nell’ordine del lavoro, in cambio di discorsività relegata all’ordine dell’eros; 3. critica alla posizione dell’analista che inverte, nel contratto, l’onorario con il salario: il salario si presenta nella forma di onorario ripetuto.
In un saggio che oggi appartiene alla raccolta Su Freud (Adelphi), Fachinelli ricorda che già il fondatore della psicoanalisi aveva affrontato la questione dell’assistenza psicologica gratuita agli indigenti, cambiando parere - da negativo a positivo - a proposito dell’impegno dell’Imperatore d’Austria a fornire consulenza psicologica gratuita ai poveri. Insomma, critica radicale all’invenzione americana di fare degli psicoanalisti dei signorotti con lo studio al ventesimo piano di un grattacielo di New York e delle assistenti sociali delle antipatiche signore che rubano i bambini ai poveri, insegnano loro come tenere un’agenda e a smettere di bere, i cosiddetti social skills.
Nel 1977 l’Erba voglio pubblicò L’uomo col magnetofono di Jean-Jacques Abrahams. Di questo Abrahams poco si conosce, un po’ come di Louis Wolfson, caso analogo e compresente sulla scena intellettuale francese di quegli anni. Abrahams accese l’attenzione degli intellettuali parigini, in particolare di Jean-Paul Sartre, inviandogli un nastro registrato, che il filosofo pubblicò nel 1969 su Les Temps Modernes, contro il parere di Pontalis e Pingaud. L’homme au magnetophone, questo il titolo della registrazione, si trasformò in una pièce teatrale e poi in un libro. Audace trascrizione di una conversazione tra Abraham e il suo psicoanalista che, dopo anni di terapia, lo fece internare. Secondo alcune leggende, non si sa quanto attendibili, Abraham evase dal manicomio di Brugman e fuggì negli Stati Uniti, ove pubblicò un testo dallo stesso titolo, L’homme au magnetophone, per le Sagittaire, un anno prima della pubblicazione italiana dell’Erba voglio. Alcune voci sostengono addirittura che lo psichiatra in questione fosse Jaques Lacan, altre smentiscono.
Di fronte allo scandalo Abraham, molti intellettuali e psicoanalisti reagirono con sdegno, primi fra tutti Pontalis e Pingaud, condannando l’invasione dello studio clinico come oscenità e molestia. Fachinelli, in modo altrettanto osceno, individuò invece nel magnetofono di Abraham un nuovo strumento democratico e l’opera di Abraham come ribellione contro l’asimmetria del potere psicoanalitico e il tradimento di un clinico che, durante la psicoterapia, ti fa internare in manicomio. Non molti anni dopo a Milano, altri psicoanalisti - Selvini, Boscolo, Cecchin - useranno la videoregistrazione come strumento costitutivo del setting terapeutico familiare. Fachinelli si era preoccupato di trasformare l’alienazione, nascosta dietro l’asimmetrica relazione tra terapeuta e paziente, in reciprocità e accoglienza. Ripartì dalle critiche di Ferenczi, insabbiate per anni dalle associazioni psicoanalitiche.
Il suo punto di vista si mostra oggi come decostruzione sociale del setting, come se la psicoanalisi avesse bisogno di essere liberata da un rigore che rasenta l’ossessione e il paziente diventasse un libero “soggetto che frequenta la terapia”. Il ruolo delle due parti va trasformato, per Fachinelli, da asimmetrico in reciproco. Il giovane paziente anancastico, proveniente dalla famiglia della classe dominante milanese, che obbliga la sorella a coprirsi le orecchie coi capelli, affinché non gli provochi crisi di angoscia, viene sostituito dal giovane povero, che vive nelle case popolari di Quarto Cagnino. Quest’ultimo semplicemente molesta la sorella perché costretto a dormire nella stessa camera con lei in uno spazio di 4 metri quadri. Che il primo continui a frequentare il suo analista imperialregio, a Fachinelli interessava poco. Assai di più il secondo. Forse è arrivato il momento di smettere di trattare Elvio Fachinelli “come un cane morto” e riscoprire davvero le sue posizioni radicali.
*
Leggi anche su doppiozero:
Mario Porro, Elvio Fachinelli. Su Freud
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- "LA MENTE ESTATICA" E LA LEZIONE DEGLI SCIAMANI. Un libro di matteo Guarnaccia (di Niccolò de Mojana)10 luglio 2014, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA E CONOSCENZA: FREUD, FACHINELLI, E LA MENTE ACCOGLIENTE.
 «Al momento di diventare sciamani, si dice, gli uomini cambiano sesso. È così posta in rilievo la profondità del mutamento necessario. Il femminile come atteggiamento recettivo non abolisce però il maschile, gli propone un mutamento parallelo» (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989). *
«Al momento di diventare sciamani, si dice, gli uomini cambiano sesso. È così posta in rilievo la profondità del mutamento necessario. Il femminile come atteggiamento recettivo non abolisce però il maschile, gli propone un mutamento parallelo» (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989). *
“Sciamani: istruzioni per l’uso culturale”. Il libro
Abbiamo letto il nuovo saggio dell’artista e scrittore “psichedelico” Matteo Guarnaccia, in uscita per la Shake Edizioni. La recensione e le immagini
di Niccolò de Mojana *
Il nuovo saggio curato dal papà dell’arte lisergica italiana è un excursus storico e antropologico sulla storia dello sciamanesimo, una raccolta di ritratti sulle diverse tipologie di tradizioni sciamaniche, un racconto fumettistico sul “volo magico”, una collezione di canti sacri tradotti. La sintesi di un percorso che ha origine da un assunto: lo sciamano è un artista, la cui psiche “eccentrica” viene accolta dalla società in cui vive. Egli viene così lasciato libero di utilizzare poesia, musica e arti figurative per esprimere le proprie visioni e le proprie pulsioni.
Guarnaccia chiarisce subito che il suo approccio all’argomento non ha nulla a che spartire con quello new age, pacchiano e misticheggiante. Al contrario, il suo è il tentativo di comprendere che cosa si nasconde dietro il mistero che circonda la cultura sapienziale delle popolazioni tribali. “Lo sciamano”, scrive Guarnaccia, “è qualcuno che, con disciplina, coraggio, perseveranza, esercizio mentale, riesce a mantenere e controllare questo stato ‘infantile’, mettendolo al servizio della sua evoluzione mentale/spirituale e del benessere della sua comunità”.
“In ogni tradizione”, spiega, “lo sciamano compie un ‘volo magico’ attraverso i vari livelli del cosmo, superando ostacoli e difficoltà sempre crescenti, fino a raggiungere un certo grado di conoscenza. Dopodiché ritorna indietro, portando ciò che ha ottenuto a beneficio di tutti. Mantiene così un equilibrio sociale. Vuole compiere il viaggio non per sé, ma per gli altri”.
Ecco allora che il disegno tratteggiato da Guarnaccia comincia a intravedersi: l’archetipo della fiaba descritto da Campbell ci parla esattamente dell’eroe che in tutte le storie abbandona il suo mondo per avventurarsi in un regno soprannaturale, nel quale è costretto a fronteggiare forze favolose, vincere (uccidere il drago, salvare la principessa) e infine tornare indietro, dotato del potere di diffondere la felicità tra gli uomini.
Si tratta di un modello che può essere ritrovato oggi in un certo tipo di arte contemporanea. Marcel Duchamp che assemblava oggetti trovati per la strada, Joseph Beuys che dorme accanto a un coyote, vogliono entrambi dimostrare che è possibile viaggiare - più o meno coscientemente - al di fuori del proprio microcosmo per abitare una dimensione altra. Ecco perché lo sciamano è sempre un artista, e viceversa.
C’è poi anche un altro discorso da esplorare, parimenti importante, necessarip per parlare di sciamanesimo. “L’abito dello sciamano”, spiega Guarnaccia, “racconta sempre un’esperienza. Ha un utilizzo sistemico. Serve come protezione per il ‘volo magico’. Il guardaroba dello sciamano comprende un solo costume sgargiante, in cui forma e struttura sono direttamente dettate dalla sua esperienza visionaria. Ogni esemplare è, di conseguenza, un’opera d’arte unica e irripetibile che deve accompagnare, sottolineare, la postura agitata/scossa/elettrica del veggente, dell’essere estatico. Convoglia assimilazioni animistiche, sollecita e solletica panico, esultanza, turbolenza, traumi e perturbazioni psichiche e anatomiche”. L’abito fa il monaco, verrebbe da dire. E lo aiuta ad accedere a un’altra dimensione.
Si tratta, in ogni caso, di tentare di raggiungere i propri limiti. In questo, gioca un ruolo fondamentale la musica. Il tamburo è il mezzo di locomozione privilegiato, “da utilizzare come un cavallo, una renna, un cammello, una barca, una nuvola, una stella, un’oca, una slitta, un lago (dove immergersi). Nel caso lo sciamano fosse impossibilitato a spostarsi, il tamburo può servire come una pista di atterraggio, un salottino temporaneo, un altare tremolante e sobbalzante per intrattenere gli spiriti in visita”.
Oggi, potremmo pensare ai rave (dove non a caso si parla di musica “trance”) come a momenti nei quali si compie il tentativo di far viaggiare le proprie percezioni al di fuori di confini puramente fisici. Il battito del tamburo come della cassa - sebbene estremamente accelerato - come portali da attraversare per espandere le proprie percezioni.
Ma non bisogna per questo pensare che l’esperienza metafisica sia riservata a pochi. “Tutti noi - scrive Guarnaccia - abbiamo sperimentato nella nostra infanzia l’esperienza sciamanica, anche se tendiamo a dimenticarcene. Uno stato naturale che scaturisce dalla possibilità di muoversi su diversi piani di coscienza e di attingere a piacere - e, aggiungiamo, con piacere - a una molteplicità di sensazioni e stimoli (...) I bambini vedono passare gli angeli, parlano con cose (apparentemente) inanimate, hanno amici invisibili, si sdoppiano, si servono di oggetti magici. Amano le vertigini e sanno come procurasele: ruotano come folli, fanno capriole, urlano, trattengono il respiro, ripetono frasi senza senso, inanellano parole in loop, si fanno lanciare in aria da mamma e papà. E che dire di quanto apprezzano il suono dei sonagli e delle percussioni? Ognuno di noi, da bambino, è abilitato ad un uso emancipato dell’immaginazione, in fase non ancora formattata dal controllo e dalla riprovazione sociale”.
Non esiste, insomma, una sola forma di realtà. Questo sembra voler ricordare, una volta ancora, il libro-prisma di Matteo Guarnaccia. E lo sciamano è esattamente colui che è in grado di mostrarci diversi piani del reale. Ciò che bisogna imparare a fare è saper conoscerli entrambi, senza limitarsi a credere solo in quello metafisico o in quello materiale. Perché nel primo caso saremmo degli squilibrati e, nel secondo, persone dalla mentalità estremamente limitata.
In conclusione, come diceva Elèmire Zolla, l’ultimo vero sapiente occidentale: “Grazie all’allenamento sciamanico, la fantasia può diventare duttile e forte come il polso di uno spadaccino”. Sta solo a noi (re)imparare a utilizzarla. Anche a questo possono servire le “istruzioni per l’uso” di Matteo Guarnaccia.
* (XL Repubblica - 03 marzo 2014 - ripresa parziale, senza immagini)
SUL TEMA, NEL SITO E IN RETE, SI CFR.:
 LA PSICOANALISI, IL LETTINO DI MISS FREUD, E LA LEZIONE DI FACHINELLI NEGATA E IGNORATA.
LA PSICOANALISI, IL LETTINO DI MISS FREUD, E LA LEZIONE DI FACHINELLI NEGATA E IGNORATA. Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento di Nicola Fanizza ("L’Acropoli, 3/2014)
Sibille e profeti oggi. L’onda lunga del Rinascimento di Nicola Fanizza ("L’Acropoli, 3/2014)-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- "Il tarantismo oggi": la riscossa delle donne ragno (di Marino Niola).21 marzo 2015, di Federico La Sala
Tarantismo la riscossa delle donne ragno
A 50 anni dalla morte di Ernesto de Martino l’antica cultura salentina protagonista delle sue ricerche è più viva che mai
di Marino Niola (la Repubblica, 21.03.2015)
- IL SAGGIO Il tarantismo oggi, di Giovanni Pizza (Carocci pagg. 176 euro 26) In libreria dal 26 marzo
IL tarantismo è finito. Anzi no. Le tarantole pizzicano ancora alla grande. Ma questa volta non mordono più le raccoglitrici di tabacco salentine, stremate dalla fatica, cresciute a fave e cicoria e rimaste impigliate negli ingranaggi di una storia inceppata, di una mobilità sociale negata. Quelle che danzavano la loro ribellione sul ritmo sfrenato della pizzica, cercando di schiacciare con il piede quel ragno immaginario che era il simbolo del loro mal di vivere. Oggi ad essere morse dall’aracne mediterranea sono le nuove generazioni che hanno fatto della taranta un emblema identitario trasversale.
Una nuova patria culturale, come avrebbe detto Ernesto de Martino, fondatore dell’antropologia italiana, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa. Ed è proprio de Martino, all’origine di questo revival. Perché con il suo capolavoro La terra del rimorso (1961) fece del tarantismo l’emblema di un Meridione dell’anima, di un Sud stretto fra emigrazione e possessione, religione e superstizione.
Il reperto di una perturbante archeologia sociale impressa nei gesti e nei corpi, nelle ossessioni e nelle devozioni di un mondo solo apparentemente arcaico e lontano dalle grandi direttrici dello sviluppo che, in quegli anni, rivoltava il paese come un guanto. Mentre in realtà quella scheggia dionisiaca era l’altra faccia del miracolo economico. Perché Rocco e i suoi fratelli, che erano andati ad avvitare bulloni nelle fabbriche del Nord, avevano lasciato al paese le sorelle. Che continuavano a ballare in trance, come menadi disoccupate.
Come accade ai grandi classici, il libro di de Martino da allora ha continuato a scriversi, dando origine a una nuova stagione culturale e politica che dalla metà degli anni Novanta ha rovesciato in positivo l’ombra nera del ragno. Da zavorra del passato a risorsa per il futuro, da relitto folklorico a prodotto tipico, bene culturale.
Lo racconta Giovanni Pizza, antropologo dell’università di Perugia, in un bel libro in uscita da Carocci. Titolo, Il tarantismo oggi. Una sorta di making of di quella fabbrica collettiva che in questi anni ha rispolverato la tradizione della taranta ballerina facendone un’icona glocal, un brand ad alta definizione da vendere sul mercato globale delle differenze culturali. E perfino un mito politico. Non a caso il ragno è diventato il leitmotif di una produzione artistica, letteraria, cinematografica, musicale, teatrale. Nel 1994 un regista come Edoardo Winspeare gira Pizzicata, un film liberamente ispirato a La terra del rimorso. Che proprio allora viene ristampata, dopo diciotto anni di assenza in libreria, e sull’onda travolgente del neo-tarantismo diventa, per la prima volta, un bestseller. La Bibbia del tarantismo. L’editoria locale comincia a sfornare a ripetizione libri con storie di tarantolati, veri o presunti, che si vendono perfino nelle tabaccherie di paese.
Ovviamente in questo revival la musica fa la parte del leone, con gruppi come Il Canzoniere Grecanico-Salentino e i Sud Sound System, che traducono il mood della pizzica in world music. Anche perché sin dai tempi antichi la cura del morso, l’antidotum tarantulae, è fatta di ritmo e di danza. Sono secoli che il frenetico ballo delle donne possedute dal ragno - quello che Paracelso, il grande medico e filosofo rinascimentale, chiamava Lasciva Chorea, cioè ballo licenzioso - è un topos dell’immaginario colto di tutta Europa. Tanto che un personaggio come Giovanbattista Marino, simbolo della letteratura barocca, dedica sonetti da antropologo ante litteram alle crisi frenetiche dei tarantolati. E un altro grande secentista, il funambolico Giacomo Lubrano, nel poemetto Stravaganza velenosa della tarantola descrive con precisione da etnografo il doppio pizzico del ragno, che è il vero algoritmo del tarantismo. Il primo morso, che provoca la crisi iniziatica e poi il rimorso, che arriva puntuale ogni anno il 29 giugno, giorno di san Paolo, che delle tarantole è considerato il signore e padrone, il mandante e il guaritore.
Ma il primo in assoluto a fare dell’aracnide il logo della Puglia è il grande Cesare Ripa, a fine Cinquecento, quando nella sua Iconologia - uno dei libri più venduti e influenti del tempo - raffigura il tacco d’Italia come una bella donna che danza, vestita di «un sottil velo» costellato di tarantole e ha ai suoi piedi un tamburello, insieme ad altri strumenti che oggi chiameremmo musicoterapici.
In fondo questo grande costruttore di immagini e di immaginari inaugura quella “tarantolizzazione” dell’identità pugliese che oggi i politici e gli amministratori locali trasformano in uno strumento di marketing territoriale. Simbolo del riscatto di un Sud che non vuole diventare la brutta copia del Nord e che sceglie di guardare dentro di sé per cercare nuovi cammini. E la Notte della taranta, il festival musicale che ogni anno richiama centinaia di migliaia di appassionati a Melpignano e in altri paesi salentini, è la sintesi esemplare di questa fitta rete di strategie economiche, di narrazioni identitarie, di processi di patrimonializzazione che nascono ancora una volta da quel morso.
Un’inversione della tradizione, che sta facendo del Salento una delle aree più interessanti e innovative d’Italia. A riprova del fatto che il cantiere d’idee aperto da de Martino, ed esplorato ora da Giovanni Pizza, continua a essere un laboratorio culturale anche visto da fuori. Come dire che siamo tutti tarantolati.
-
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- "L’Erba voglio", in rete (Archivio Primo Moroni)9 aprile 2014, di Federico La Sala
- Grazie all’ Archivio Primo Moroni, "L’Erba voglio", la rivista diretta da Elvio Fachinelli, è disponibile in rete:
http://www.inventati.org/apm/archivio/320/ERB/lerbavoglio.php
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- IL PROBLEMA DELLA "MENTE ESTATICA" (di James H. Leuba)7 gennaio 2014, di Federico La Sala
IL PROBLEMA DELLA ILLUMINAZIONE, AL DI LA’ DELLA DUPLICE ORIGINE E DELLA DUPLICE NATURA *:
"Il problema dell’ispirazione o illuminazione o rivelazione - o in qualsiasi modo si voglia chiamarlo - non interessa soltanto qualche caso particolarmente notevole e raro. Le caratteristiche che comunemente sono considerate atte a stabilire la differenza tra rivelazione e prodotti ordinari e naturtali dell’attività mentale dell’uomo, appartengono in verità a ogni pensiero e a ogni azione.
Imprevedibilità, assenza di sforzo, passività (ed anche come vedremo più tardi, chiarezza e certezza) sono caratteri che possono essere applicati ugualmente a ciò che è grande e a ciò che è piccolo, a ciò che è vero e a ciò che è falso, a ciò che è religioso e a ciò che è laico.
Non è più il tempo in cui se ne faceva il criterio di una duplice origine e di una duplice natura dei pensieri e delle azioni umane, e se ne traeva argomento per imprimere agli uni il timbro di una provenienza umana, e agli altri quello di un dono disceso dall’alto.
Gli esempi straordinari e sorprendenti nei quali, dopo uno sforzo mentale e infruttuoso, appare bruscamente e all’improvviso la soluzione di un problema, non sono che i casi estremi del processo normale del pensiero cosciente e razionale. Solo che, in questi casi più impressionanti, i problemi sono tanto considerevoli e la fase di passività tanto lunga da colpire l’attenzione e provocare la sorpresa".
* James H. Leuba, La psicologia del misticismo religioso, Feltrinelli, Milano 1960, p. 265 (l’edizione originale, inglese, è del 1925).
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- LA BIBBIA EBRAICA NON E’ OMOFOBA (di Pierre-Israël Trigano)25 giugno 2013, di Federico La Sala
La Bibbia ebraica non è omofoba
di Pierre-Israël Trigano *
in “www.temoignagechretien.fr” del 20 giugno 2013 (traduzione: www.finesettimana.org)
Lungi dal condannare l’omosessualità, il Levitico invita ad umanizzare la relazione del maschile al femminile nella coppia.
La multisecolare persecuzione degli omosessuali in nome della Bibbia, fino al rifiuto violento della legge che oggi li autorizza al matrimonio, si è essenzialmente costruita attorno alla lettura di un comandamento del Levitico (Lv 18,22): “Non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna: è cosa abominevole”.
Letta così, la proibizione è senza appello. Ed è in questo senso che l’ebraismo e il cristianesimo scomunicano gli omosessuali, in tutta coscienza. Ma il testo ebraico di questo versetto è, così come è costituito, uno dei più oscuri della Bibbia. È il segno indubitabile che è carico di un inconscio portatore di un senso inedito.
Considerato nella sua letteralità, possiamo infatti tradurlo così: “Con un maschio [ zékher o zakàr], tu non coabiterai [verbo al maschile] gli stati di essere coricato [le “coabitazioni”, i “letti”] di donna [isshah].” Tanto vale dire che questo versetto è in gran parte incomprensibile, e che il modo in cui le Chiese lo traducono è un’estrapolazione della versione greca dei Settanta, non tradotta dall’originale ebraico.
Se la Torah avesse voluto avere come bersaglio direttamente l’omosessualità, lo avrebbe fatto in maniera più chiara, in termini più diretti. Del resto non si vede perché essa avrebbe ignorato l’omosessualità femminile.
Constatiamo in primo luogo che da nessuna parte nel testo si trova la parola “come” che stabilirebbe un paragone tra un rapporto con un uomo e uno con una donna.
tornare alla letteralità del testo
Letteralmente, in questo versetto si tratta per l’uomo di “coabitare” i “letti” di donna. Come vedervi un qualsiasi riferimento all’omosessualità? Al contrario, questa strana formula potrebbe evocare delle relazioni sessuali dell’uomo con le donne.
In secondo luogo, la parola tradotta con “donna”, isshah, appare per la prima volta nella Bibbia in Genesi 2, nel racconto della Creazione della donna. Il suo contrario, designante “l’uomo”, è ish. Ci si aspetterebbe di trovare questa parola nel versetto per designare l’opposto della donna. Invece, è la parola zékher (o zakàr), il “maschio” che troviamo nel testo, che ha per polo opposto la parola neqebàh, la “femmina”.
Queste due parole fanno la loro apparizione in Genesi 1, nel racconto della Creazione dell’essere umano. Poiché il Levitico si riferisce a zékher (o zakàr), il “maschio”, avremmo dovuto logicamente trovare nel versetto neqebàh, “la femmina”, piuttosto che isshah, “la donna”. Come comprendere questa differenza?
“Maschio” e “femmina” sono delle categorie per le quali la Bibbia (Gn 1,27) definisce l’essere umano che è appena stato creato da Dio: “Maschio e femmina li creò”. La Chiesa si serve del resto anche di questo versetto per affermare senza appello che solo il matrimonio “di un papà e di una mamma” è la norma divina per fondare la famiglia umana.
Ora, bisogna rendersi conto che “maschio” e “femmina” sono delle categorie animali, e non umane. Esse caratterizzano una umanità primitiva che esce ancora con difficoltà dall’animalità. È precisamente l’emergere di tale umanità, arcaica, originale, non ancora totalmente realizzata, che Genesi 1 descrive. Certamente vi è scritto che è creata “ad immagine e somiglianza di Dio”, ma si tratta di un potenziale divino di umanizzazione che non è ancora attivato all’origine e che è in gioco in tutta l’evoluzione umana.
maschile e femminile arcaici
Le categorie animali zékher e neqebàh esprimono lo stato di violenza che caratterizza l’umanità arcaica da cui sarà difficile per gli esseri umani, uomini e donne, uscire.
La sorprendente potenza significante dell’ebraico biblico ci aiuta a comprenderlo, in particolare per le possibilità di rilettura che offre. Infatti, questa lingua è puramente consonantica e le vocali non sono fissate nei manoscritti originali. La stessa parola, associata a vocali diverse, assume significati insospettati ad una prima lettura, e manifesta così sottilmente un “inconscio” dell’esperienza umana che simbolizza.
È, ad esempio, il caso, molto sorprendente, per la parola neqebàh, “femmina”, che noi possiamo rileggere néqoubah, che ha in sé un significato terribile per la condizione femminile, la “forata”, la “maledetta”! Questa parola ci rivela così senza alcun dubbio che, nell’umanità più arcaica, ancora animale e “primate”, la donna è ridotta alla condizione di “femmina”, dominata, schiacciata dai “maschi”, come oggi ancora nei clan degli scimpanzé, i nostri cugini animali più prossimi. Anche se nelle tribù primitive dette “matriarcali”, le madri hanno avuto un certo potere, non era certamente così per le figlie, ridotte ad essere oggetti di scambio tra clan, a beneficio dei “maschi”.
la psicologia dello zékher
Ed ecco precisamente ciò che ci suggerisce la parola zékher, che designa questi ultimi: pronunciato zakhor, esprime l’azione di ricordare. Così facendo, lo spirito della lingua ebraica sembra insegnarci che è la potenza dei “maschi” che organizza il “ricordo” dell’origine, la fedeltà alle stirpi arcaiche dell’umanità, e quindi la ripetizione del maltrattamento fatto alle donne di generazione in generazione.
È la psicologia dello zékher, il maschile arcaico e violento, che desidera mantenere e perpetuare nella cultura umana le donne e la femminilità nella condizione maledetta di “femmina” inferiorizzata, violentata e umiliata.
Un’altra caratterizzazione dei generi emerge in Genesi 2 con le parole ish e isshah, “uomo” e “donna”. Sarebbe necessario dissipare molti controsensi che la tradizione (investita, occupata dallo zékher) ha accumulato riguardo a queste parole. Cosa impossibile da studiare nei limiti di questo articolo.
Constatiamo semplicemente che significano “sposo” e “sposa”, e sono quindi delle categorie eminentemente relazionali. Esse designano una umanità finalmente umanizzata, uscita dal suo arcaismo “animale”, nella quale, quindi, può sbocciare la relazione d’amore. Rivelatore è il fatto che la parola isshah, “donna”, pronunciato éshéh, significa: “Dimenticherò...”.
maltrattamento fatto alle donne
Il “maschio” nell’essere umano vuole organizzare il ricordo dell’arcaismo violento e inumano dell’origine animale, mentre la “donna” nell’essere umano “dimenticherà”! È una promessa profetica portata da isshah. Verrà un tempo di compimento in cui il maltrattamento fatto alle donne e alla femminilità sarà dimenticato.
A questo punto, il senso del versetto si chiarisce. Ingiunge all’uomo soprattutto di non entrare nella coabitazione (sessuale, ma anche in tutti gli ambii della vita di coppia) con isshah, la donna, con (sulla base di) lo spirito dello zékher, il maschio arcaico senza amore e violento. Isshah è la donna, ma è anche, sul piano archetipico, la femminilità, la capacità di apertura all’altro e di amore, presente nell’uomo quanto nella donna.
Così, questo versetto, lungi dal proibire formalmente l’omosessualità, è piuttosto un’ingiunzione divina a prendersi cura di ogni relazione di coabitazione e di coppia, qualunque sia il (o la) partner che si ha, di fondarla sull’amore, sulla tenerezza, e quindi di coltivare lo sbocciare della femminilità in sé e nell’altro, invece di ferirla sotto i colpi dell’egocentrismo maschile arcaico di onnipotenza. Come si vede, questa ingiunzione può interpellare sia le coppie omosessuali che eterosessuali, senza gettare l’anatema su una qualsiasi categoria di esseri umani.
interrogativo etico
Il suo interrogativo non è legalistico, ma etico. Non si accontenta di una applicazione “tecnica” che sarebbe qui il rifiuto o la repressione dell’omosessualità, come lascerebbe pensare la traduzione abituale. Ma apre una ricerca etica sulla fondatezza della relazione che ciascuno, chiunque sia, allaccia con un altro, chiunque sia, in quanto essere umano.
E questa ricerca è, in se stessa, un cammino di vita che mira a favorire sempre più l’amore, a dare risalto alla femminilità (sia degli uomini che delle donne) ferita dallo zékher. Sicuramente non si può quindi utilizzare la Bibbia ebraica per condannare l’omosessualità.
Tutta la mia ricerca dimostra che essa veicola nel suo testo ebraico un “inconscio” che aspetta di essere riscoperto, portatore di un senso che rivoluziona le interpretazioni della tradizione ebraico- cristiana e sovverte la riduzione dispotica e moralistica della religione. Questo versetto ne è una testimonianza caratteristica.
* Pierre-Israël Trigano è filosofo e psicanalista. È l’autore di L’inconscient de la Bible (Edizioni Réel, 7 tomi).
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE --- E LA DECAPITZIONE DI PLATONE E CARTESIO DA PARTE DELLA "METAFISICA" DI GIAMBATTISTA VICO.22 maggio 2013, di Federico La Sala
 VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
VICO CON NEWTON: "NON INVENTO IPOTESI"!
 RILEGGERE VICO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
RILEGGERE VICO. Teoria e pratica della "Scienza Nuova".
 Un breve lavoro (pdf, scaricabile)
Un breve lavoro (pdf, scaricabile)
 Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” (“Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che (...)
Se pochi filosofi e letterati sanno dell’omaggio di Ugo Foscolo al filosofo delle “nozze e tribunali ed are” (“Dei sepolcri”, v. 91), moltissimi “addottrinati” ignorano ancora e del tutto che (...)
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- IL FASCISMO, GENTILE, E LA COSTITUZIONE: IN ONORE DI TERESA MATTEI, L’ULTIMA DONNA DELLA COSTITUENTE15 marzo 2013, di Federico La Sala
- Aveva 92 anni
 È scomparsa Maria Mattei l’ultima donna costituente
È scomparsa Maria Mattei l’ultima donna costituentedi Maria Corbi (La Stampa, 13.03.2013)
Se ne va un altro pezzo di memoria del Paese, una donna, Maria Teresa Mattei, che è stata la più giovane eletta all’Assemblea Costituente e che ha contribuito a porre le basi di un Paese libero e democratico. Classe 1921, partigiana, combattente nella formazione garibaldina Fronte della Gioventù, si è sempre dedicata alla lotta per i diritti delle donne e dei bambini. È lei la madre della mimosa, il simbolo dell’8 marzo, della battaglia per la parità. Un fiore povero e diffuso che vinse sulla violetta proposta dalla Luigi Longo che voleva regalarle quel giorno.
Teresa era genovese di nascita, si iscrisse nel 1942 al Partito Comunista che lascerà nel 1955 quando rifiuterà la candidatura alle elezioni per la Camera a causa del dissenso nei confronti di Togliatti. Il nome di battaglia della Mattei era «Chicchi» e operava nella città di Firenze (a lei ed al suo gruppo si ispirò Roberto Rossellini per l’episodio di Firenze di Paisà).
Il fratello Gianfranco Mattei è un martire della resistenza. Docente e ricercatore di chimica al Politecnico di Milano, assistente prediletto del futuro premio Nobel Giulio Natta, fabbricava esplosivi per i Gap della capitale. Nel 1944 si tolse la vita nella cella di via Tasso, a Roma, per non cedere alle torture e non rischiare di rivelare il nome dei compagni.
Anni più tardi la Mattei raccontò che da quel lutto nacque in lei e in Bruno Sanguinetti (che dopo la guerra sposerà) l’idea di uccidere il filosofo Giovanni Gentile. Per fare in modo che i gappisti incaricati dell’agguato potessero riconoscerlo, alcuni giorni prima li accompagnò lei stessa (che conosceva personalmente il filosofo) presso l’Accademia d’Italia della Rsi, che lui dirigeva. «Mentre usciva lo indicai ai partigiani, poi lui mi scorse e mi salutò».
Sessant’anni dopo rivendicò quella scelta: «Se un grande pensatore si schiera con un regime orribile come la Repubblica di Salò, si assume una responsabilità enorme. È un tradimento che non si può perdonare». Nel 1946 si presentò alle elezioni per l’Assemblea Costituente, candidata nel Pci. Venne eletta e fu la più giovane deputata al Parlamento. Nel 1947 fondò, insieme alla democristiana Maria Federici, l’Ente per la Tutela morale del Fanciullo. Con la morte di Maria Teresa Mattei i componenti dell’assemblea costituente ancora in vita sono solo due: Giulio Andreotti e Emilio Colombo.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- EMERGENZA ANTROPOLOGICA E TEOLOGICO-POLITICA. Uno spettro si aggira nella storia della Chiesa cattolica moderna: il Concilio.14 febbraio 2013, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE --- RIPENSARE IL MASCHILE. "Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità" (di Delia Vaccarello -L’omofobia serve agli adolescenti per sentirsi veri uomini)9 gennaio 2013, di Federico La Sala
L’omofobia serve agli adolescenti per sentirsi veri uomini
di Delia Vaccarello (l’Unità, 9 gennaio 2013)
A cosa serve il bullismo omofobico? la violenza a scuola è un fulmine nel cielo sereno della convivenza scolastica o invece ha radici fortissime? Dinanzi alle differenze a chi giova rispondere con la violenza? A questi e ad altri interrogativi, Giuseppe Burgio, ricercatore in campo pedagogico da anni impegnato sulle questioni legate all’orientamento sessuale, risponde in maniera netta: l’omofobia serve agli adolescenti per sentirsi veri uomini.
Nel saggio Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità (ed. mimesis), Burgio dimostra che il bullismo omofobico è una tappa nel processo di costruzione della virilità: chi lo esercita ricava il vantaggio di aderire allo stereotipo del maschio come si deve. Disprezzare ciò che è «passivo» e «femminile» (caratteristiche associate all’omosessualità) diventa un elemento cruciale, così in adolescenza l’odio per i gay si rivela un modo di esorcizzare la tentazione di essere «dipendenti» quindi «femminucce» attraverso l’identificazione della virilità con l’aggressività.
un fenomeno non isolato
L’omofobia non sarebbe un fenomeno isolato, messo in atto a scuola dai ragazzi che «scherzano pesante» ma diventa necessario ai ragazzi eterosessuali per definirsi all’altezza di quella virilità simbolica che la società e la cultura impongono di interpretare. Prendendo in esame testimonianze dirette Burgio si concentra sugli attori della relazione - vittime, aggressori, contesto scolastico - e analizza alcuni aspetti importanti tra cui spicca «il disgusto maschile»: nei racconti si parla di sputi e di altre violenze che avvengono nei gabinetti (dove ci sono sporcizia e cattivi odori), una collocazione che dimostra il bisogno di marcare un confine nei riguardi dei gay, considerati persone che provocano ribrezzo contro le quali schierarsi. Poiché a livello «fantastico» il contatto con l’omosessuale «sporca» la virilità, il ragazzo gay viene degradato, associato allo squallore, per sottolineare ancora di più la differenza rispetto al coetaneo etero con il vantaggio di proclamarsi «veri maschi».
Ancora, un elemento costante nelle testimonianze è «il pettegolezzo derogatorio»: oltre all’insulto, infatti, assume un ruolo predominante «il dirlo in giro». L’omosessualità di un compagno va resa nota attraverso un turbinio di voci e, peggio, va provata attraverso invasioni della privacy, come il furto di telefonini e diari, nonché vere e proprie trappole. Un compagno etero, ad esempio, provoca l’amico che sente invaghito di lui fino ad illuderlo di dargli un bacio: «il mio ex compagno di banco, ex amico, ex persona di cui ero innamorato, ci ha provato con me in maniera molto esplicita e spudorata per vedere se io ero gay, io ho ceduto e appena sono andato per baciarlo si è scostato, mi ha allontanato, si è alzato e se ne è andato e poi mi ha sputtanato con tutti quanti...».
atteggiamento inquisitorio
L’atteggiamento inquisitorio nei riguardi di chi è sospettato di omosessualità risulta necessario perché avere accanto un ragazzo gay diventa per molti etero un’esperienza minacciosa. Inutile sottolineare la tortura cui l’adolescente omosessuale viene esposto.
A cambiare la situazione - oltre che una scuola del futuro dove programmi, docenti e personale ausiliario, non colludano con gli stereotipi della «virilità autentica» -, ci stanno pensando anche i ragazzi. L’omosessuale che dichiara se stesso e il proprio desiderio non si pone più come vittima e non fornisce più al ragazzo etero uno specchio rovesciato utile a definirsi. Il ragazzo gay che si sfila dal gioco «vittima aggressore», spinge gli etero a non considerare il proprio percorso così scontato, con l’esito auspicato di incrinare la corazza degli stereotipi.
È possibile - conclude Burgio - che la rottura del legame tra violenza e maschilità possa ricodificare la virilità a livello simbolico, e far sorgere «una maschilità che non si vergogni di riconoscere come proprie anche la cura, la relazionalità, la mitezza». Per far questo occorre ripensare il maschile, fornire ai ragazzi modelli diversi e articolati, far comprendere che per diventare adulti bisogna necessariamente «attraversare» la condizione di sentirsi «confusi e smarriti», che è ben più fertile del mascherarsi dietro corazze, violenze, stereotipi. Occorre una nuova educazione alla maschilità, i cui primi «discepoli» saranno i maschi già adulti.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- IL LABORATORIO DI FREUD E LA LEZIONE DI FACHINELLI.4 ottobre 2012, di Federico La Sala
 AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
AL DI LA’ DELLE "ROBINSONATE" (MARX) E AL DI LA’ DELL’EDIPO (FREUD). INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. I soggetti sono due, e tutto è da ripensare...
 FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica”
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI. “Su Freud”, un’ottima introduzione a “La mente estatica”
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA. Una nota (di Federico La Sala)22 settembre 2012, di Federico La Sala
 DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
DIO E’ AMORE ("CHARITAS"), MA NON PER IL CATTOLICESIMO-ROMANO! Una gerarchia senza Grazie ( greco: Χάριτες - Charites) e un papa che scambia la Grazia ("Charis") di Dio ("Charitas") con il "caro-prezzo" del Dio Mammona ("Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006).
 GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA. Una nota di Federico La Sala
GESU’ SPOSATO E LA CHIESA NUDA. Una nota di Federico La Sala
 Riconoscere fondamentalmente che senza il libero e decisivo sì della donna (Maria) non sarebbe nato non solo Cristo ma nemmeno la Chiesa, per l’ uomo della stessa Chiesa è paradossalmente “scandalo e follia”
Riconoscere fondamentalmente che senza il libero e decisivo sì della donna (Maria) non sarebbe nato non solo Cristo ma nemmeno la Chiesa, per l’ uomo della stessa Chiesa è paradossalmente “scandalo e follia”
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- L’inquisizione di oggi e le religiose nordamericane (di Ivone Gebara - suora, filosofa e teologa)31 agosto 2012, di Federico La Sala
L’inquisizione di oggi e le religiose nordamericane
di Ivone Gebara, suora, scrittrice, filosofa e teologa brasiliana
in “www.paves-reseau.be” del 25 aprile 2012 (traduzione dal francese: www.finesettimana.org)
Una volta ancora assistiamo stupite alla “valutazione dottrinale” o piuttosto al sedicente appello alla sorveglianza o alla punizione condotta dalla Congregazione della Dottrina della fede nei confronti di chi, a suo avviso, si discosta dall’osservanza della dottrina cattolica corretta. Unica differenza: oggi, non è su una persona che puntano il dito accusatore, ma su un’istituzione che riunisce e rappresenta più di 55000 religiose nordamericane. Si tratta della Conferenza nazionale delle Religiose, conosciuta sotto la sigla LRWC - Conferenza della Direzione religiosa femminile. In tutta la loro storia, queste religiose hanno sviluppato - e sviluppano ancora - una vasta missione educativa a favore della dignità di molte persone e di molti gruppi negli Stati Uniti e oltre.
La maggioranza di queste donne appartiene a diverse congregazioni nazionali e internazionali; oltre alla loro formazione umanista cristiana, sono delle intellettuali e delle professioniste impegnate negli ambiti più diversi della conoscenza. Sono scrittrici, filosofe, biologhe, sociologhe, avvocate, teologhe e possiedono un vasto curriculum e una competenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sono anche educatrici, catechiste e militanti per i diritti umani. In molteplici circostanze sono state capaci di mettere a rischio la propria vita a favore delle vittime dell’ingiustizia o di opporsi a comportamenti gravi assunti dal governo nordamericano.
Ho l’onore di conoscerne alcune che sono state imprigionate perché si erano messe in prima fila in una manifestazione per la chiusura della Ecole des Amériques, istituzione del governo nordamericano che prepara i militari in vista di interventi repressivi e crudeli nei nostri paesi. Queste religiose sono donne di pensiero e d’azione, hanno una lunga storia di servizio non solo nei loro paesi ma anche in altri. Oggi sono sotto il sospetto e la sorveglianza del Vaticano. Sono criticate per le loro divergenze con i vescovi considerati come “gli autentici maestri della fede e della morale”.
Inoltre sono accusate di essere sostenitrici di un femminismo radicale, di deviazioni rispetto alla dottrina cattolica romana, di complicità con l’approvazione delle unioni omosessuali e di altre accuse che ci stupiscono per il loro anacronismo. Che cosa sarebbe un femminismo radicale? Quali sarebbero le sue manifestazioni reali nella vita delle congregazioni religiose femminili? Quali devianze teologiche vivrebbero queste religiose? Noi donne saremmo spiate e punite per la nostra incapacità ad essere fedeli a noi stesse e alla tradizione del vangelo attraverso la sottomissione cieca ad un ordine gerarchico maschile? I responsabili delle Congregazioni vaticane sarebbero estranei alla grande rivoluzione mondiale femminista che raggiunge tutti i continenti, comprese le congregazioni religiose?
Molte religiose negli Stati Uniti e in altri paesi sono, di fatto, eredi, maestre e discepole di una delle più interessanti espressioni del femminismo mondiale, soprattutto del femminismo teologico che si è sviluppato negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni ’60. Le loro idee originali, le loro critiche, le loro posizioni libertarie permetteranno una nuova lettura teologica che, a sua volta, può accompagnare i movimenti di emancipazione delle donne. Di modo che esse potranno contribuire a ripensare la nostra tradizione religiosa cristiana al di là della “invisibilizzazione” e dell’oppressione delle donne. Creeranno anche spazi alternativi di formazione, testi teologici, testi di celebrazione affinché la tradizione del Movimento di Gesù continui a nutrire il nostro presente e non sia abbandonata da migliaia di persone affaticate dal peso delle norme e delle strutture religiose patriarcali.
Quale atteggiamento adottare davanti alla violenza simbolica degli organismi di governo e di amministrazione della Chiesa cattolica romana? Che cosa pensare del riferimento filosofico rigido che assimila il meglio dell’essere umano alla sua parte maschile? Che dire della visione antropologica filosofica unilaterale e misogina a partire dalla quale interpretano la tradizione di Gesù?
Che cosa pensare di questo trattamento amministrativo-punitivo a partire dal quale si nomina un arcivescovo per rivedere, orientare e approvare le decisioni prese dalla Conferenza delle Religiose, come se noi fossimo incapaci di discernimento e di lucidità. Saremmo per caso una multinazionale capitalistica nella quale i nostri “prodotti” dovrebbero obbedire ai diktat di una linea di produzione unica? E per mantenerla, dovremmo essere controllate come degli automi da coloro che si considerano i proprietari e i guardiani dell’istituzione? Dove vanno a finire la libertà, la carità, la creatività storica, l’amore ’sororale’ e fraterno?
Nel momento in cui l’indignazione si fa strada in noi, un sentimento di fedeltà alla nostra dignità di donne e al Vangelo annunciato ai poveri e agli emarginati ci invita a reagire a questo ulteriore atto di ripugnante ingiustizia.
Non è da oggi che i prelati e i funzionari della Chiesa agiscono con due pesi e due misure. Da un lato, gli organismi superiori della Chiesa cattolica romana sono stati capaci di accogliere di nuovo al loro interno i gruppi di estrema destra, la cui storia negativa soprattutto nei confronti dei giovani e dei bambini è ampiamente conosciuta.
Penso in modo particolare ai Legionari di Cristo di Marcial Maciel (Messico) o ai religiosi di Mons. Lefebvre (Svizzera), la cui disobbedienza al papa e i metodi coercitivi per creare dei discepoli sono attestati da molti. La stessa Chiesa istituzionale accoglie gli uomini che le interessano in vista del proprio potere e respinge le donne che desidera mantenere sottomesse. Questo atteggiamento le espone alle critiche ridicole veicolate anche nei media religiosi cattolici in mala fede. I prelati fingono di riconoscere in maniera formale qualche merito a queste donne quando le loro azioni si riferiscono a quelle esercitate tradizionalmente dalle religiose nelle scuole e negli ospedali. Ma noi siamo forse solo quello?
Sappiamo che mai, negli Stati Uniti, c’è stato il minimo sospetto che quelle religiose possano aver violentato dei giovani, dei bambini e dei vecchi. Nessuna denuncia pubblica ha offuscato la loro immagine. Non si è mai sentito dire che si siano alleate per i propri interessi alle grandi banche internazionali. Nessuna denuncia per traffico di influenze, scambio di favori per preservare il silenzio dell’impunità. Ma anche così, nessuna di loro è stata canonizzata e neanche beatificata dalle autorità ecclesiastiche come invece è stato fatto per degli uomini di potere. Il riconoscimento di queste donne viene da molte comunità e gruppi cristiani o non cristiani che hanno condiviso la vita e il lavoro con molte di loro. E certamente quei gruppi non resteranno in silenzio davanti a questa “valutazione dottrinale” ingiusta che colpisce anche loro in maniera ingiusta.
Plagiando Gesù nel suo vangelo, lo sento dire: “Ho pietà di quegli uomini” che non conoscono le contraddizioni e le bellezze della vita nella prossimità, che non lasciare vibrare il loro cuore in tutta chiarezza con le gioie e le sofferenze delle persone, che non amano in tempo presente, che preferiscono la legge severa alla festa della vita. Hanno soltanto imparato le regole chiuse di una dottrina chiusa in una razionalità superata ed è a partire da lì che giudicano una fede diversa , specialmente quella delle donne. Forse pensano che Dio li approvi e si sottometta a loro e alle loro elucubrazioni talmente lontane da quelle di coloro che hanno fame di pane e di giustizia, dagli affamati, dagli abbandonati, dalle prostitute, dalle donne violentate o dimenticate. Fino a quando dovremo soffrire sotto il loro giogo? Quali atteggiamenti ci ispirerà “lo Spirito che soffia dove vuole” perché possiamo continuare ad essere fedeli alla VITA che è in noi?
Alle care suore nordamericane della LWRC, la mia riconoscenza, la mia tenerezza e la mia solidarietà. Se siete perseguitate per il bene che fate, probabilmente il vostro lavoro produrrà frutti buoni e abbondanti. Sappiate che noi, donne di altri continenti, con voi, non permetteremo che facciano tacere la nostra voce. Ancor di più, se le facessero tacere con un decreto di carta, ce ne faremmo una ragione ulteriore per continuare a lottare per la dignità umana e per la libertà che ci costituisce.
Continueremo con tutti i mezzi ad annunciare l’amore del prossimo come la chiave della comunione umana e cosmica presente nella tradizione di Gesù di Nazareth ed in molti altri, sotto forme diverse. Continueremo insieme a tessere per il nostro momento storico un tratto supplementare della vasta storia dell’affermazione della libertà, del diritto di essere diversi e di pensare in modo diverso, e, cercando di fare questo, di non aver paura di essere felici.
Testo originale al sito:
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&langref=PT&cod=66441
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- APULEIO E "CHARITAS", LA FANCIULLA RAPITA DA UNA CRICCA DI BRIGANTI PER OTTENERE UN BUON RISCATTO!15 giugno 2012, di Federico La Sala
LA FAVOLA DI AMORE E PSCICHE. "Il mito, che unisce l’amore e l’anima, viene ascoltato dall’uomo-asino in una caverna di banditi. Qui è trattenuta una fanciulla di nome Càrite, rapita per ottenere un buon riscatto. Per consolarla, la vecchia che la custodisce narra una storia a lieto fine. Figlia di re, Psiche è così bella da suscitare la reazione di Venere, che chiede al dio Amore di ispirare alla fanciulla una passione per l’uomo più brutto della terra".
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ----DIO E’ IL NOME DEL BENE NON DEL POTERE. Spezzare la subordinazione alla Chiesa della teologia. Non è teologia se non ci libera (di Roberta De Monticelli).23 aprile 2012, di Federico La Sala
Non è teologia se non ci libera
di Roberta De Monticelli (Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2012)
Tanti sono i sapienti che hanno commentato la pagina forse più famosa di Dostoevskij, La leggenda del Grande Inquisitore. Eppure poche sono le spiegazioni convincenti del bacio con il quale il Cristo della Leggenda - tornato in terra al tempo dell’Inquisizione, e subito gettato in carcere - risponde al lungo monologo del vecchio Inquisitore: che pure rivendica per la sua Chiesa il pietoso nichilismo con cui questa ha spento la «libera decisione del cuore», alla quale il Cristo affidava il Regno di Dio. E l’ha sostituita con l’obbedienza degli uomini-bambini al potere spirituale-temporale dell’istituzione.
L’Inquisitore ha raccontato in ogni dettaglio il baratto ispirato dal demonio: libertà contro "felicità", obbedienza (e licenza di peccato, e perdono) in cambio del sollievo di non dover dubitare, e cercare, e scegliere, e portare responsabilità delle proprie scelte. Ha ricordato "il segreto del mondo", la sapienza del tentatore, che è sapienza politica e riguarda il meccanismo dell’obbedienza, nutrita dal bisogno che gli uomini hanno di inchinarsi "tutti insieme" a qualcuno, cioè dalla dimensione sociale della religione. Ha evocato la contraffazione del divino mediante le forze che da sempre corteggiano l’"umiltà del male" (come direbbe Franco Cassano): «miracolo, mistero, autorità». E per tutta risposta il Nazareno bacia le sue labbra esangui, di un bacio che brucia l’anima del vecchio e lo induce ad aprirgli la porta della libertà. Perché?
Aprendo l’ultimo libro di Vito Mancuso - Obbedienza e libertà - troviamo una risposta nuova. «Gesù vede che il vero prigioniero è proprio il suo carceriere, racchiuso in una prigione non fisica ma mentale, da cui è molto più difficile uscire». Quel bacio è un varco offerto alla mente prigioniera dell’Inquisitore. Aljoscia Karamazov, il monaco novizio - che più tardi sceglierà di vivere nel mondo - ripete questo gesto, e bacia il fratello Ivan, il filosofo, il cui pensiero racchiude entrambe le possibilità: l’Istituzione che imprigiona la mente e il nazareno che la libera. Ecco: Mancuso è Aljoscia. Proseguite nella lettura e ve ne convincerete.
Tutti i suoi libri infine sono questo: un bacio che brucia di un fuoco soave, "purificatore", in cui possa incenerirsi l"’autorità" di una Chiesa costruita nei millenni sopra il "miracolo" e il "mistero", per lasciar spazio all’autenticità" cui Gesù richiamava l’anima («svegliati, ragazza»). In cui l’obbedienza si depuri del suo diabolico fondamento - il potere
 e si inchini soltanto alla "legge della libertà", all’autonomia della coscienza. Il bacio offre a quella
Chiesa da cui Mancuso proviene il varco di una libertà che è a lei ben nota, nutrita com’è, fin nei
suoi ultimi papi, del pensiero europeo moderno e contemporaneo, dal quale sorgono (come dal
pensiero di Ivan Karamazov) entrambi gli interlocutori: l’obbedienza asservita e la libertà autentica,
il nichilismo morale e il primato della coscienza, la "fede" come devozione atea e la fede come
«esperienza che l’intelligenza è illuminata dall’amore» (S.Weil).
e si inchini soltanto alla "legge della libertà", all’autonomia della coscienza. Il bacio offre a quella
Chiesa da cui Mancuso proviene il varco di una libertà che è a lei ben nota, nutrita com’è, fin nei
suoi ultimi papi, del pensiero europeo moderno e contemporaneo, dal quale sorgono (come dal
pensiero di Ivan Karamazov) entrambi gli interlocutori: l’obbedienza asservita e la libertà autentica,
il nichilismo morale e il primato della coscienza, la "fede" come devozione atea e la fede come
«esperienza che l’intelligenza è illuminata dall’amore» (S.Weil).Questa chiave di lettura illumina tutta la complessa dialettica di questo libro, giustamente presentato come "sintesi matura" del pensiero del suo autore. Un libro pubblicato nella collana "Campo dei fiori" - la piazza romana in cui arse il rogo di Giordano Bruno - e dedicato «alla memoria degli italiani uccisi in quanto "eretici", martiri della libertà religiosa, testimoni obbedienti del primato della coscienza». E i cui nomi sono riportati nell’Appendice.
Eppure è a questa stessa Chiesa che li ha bruciati che Mancuso si rivolge con il sottotitolo del suo libro: Critica e rinnovamento della coscienza cristiana. Lo afferma chiaramente: un cristianesimo non può esistere senza chiesa, senza magistero, senza tradizione, senza liturgia, senza comunità/comunione. Non si tratta quindi di eliminare la "sua" Chiesa, si tratta di spezzare la subordinazione alla Chiesa della teologia. In una "teologia laica" si dispiega il bacio liberatorio. E la liberazione, si badi, è rigorosamente teologica. Biblica anzitutto: Dio non ha bisogno del sangue per salvare gli uomini, non è dunque Paolo il vero fondatore della Chiesa di Cristo.
La salvezza non va pensata come redenzione, ma secondo l’annuncio di Gesù: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia». Di teologia fondamentale, in secondo luogo. All’inizio dell’avventura umana non c’è il peccate originale, ma «l’energia caotica... che ha bisogno di essere ordinata e disciplinata per diventare volontà di bene e di giustizia»: cioè la libertà.
Dio è il nome del bene, e non il nome del potere.
Ed ecco le due radici di quella logica dell’obbedienza e del potere che attanaglia la mente del moderno Inquisitore: il pessimismo relativo all’uomo, con la dottrina del peccato originale che avvinghia l’esercizio del potere all’umiltà del male; e il fatto che il cattolicesimo «non ha più una visione del mondo dai tempi di Dante», perché ha tradito, da Galileo in poi, la ricerca del vero. Il bacio, dunque, fiorisce proprio dai due temi principali dell’innovazione teologica di Mancuso. E offre scampo al duplice disagio, della coscienza e dell’intelligenza, e al tragico paradosso della Chiesa: «L’istituzione per merito della quale ancora oggi nel mondo continua a risuonare il messaggio di liberazione di Gesù è governata nel suo vertice da una logica che rispecchia proprio quel potere contro cui Gesù lottò fino a essere ucciso». Sarà finalmente aperta, quella porta?
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- INDETERMINAZIONE. Le aprole della scienza (di Carlo Rovelli)15 aprile 2012, di Federico La Sala
Le parole della scienza
Indeterminazione
di Carlo Rovelli (la Repubblica, 15.04.2012)
Werner Karl Heisenberg è uno dei personaggi più interessanti e inquietanti della fisica del Novecento. A ventiquattro anni, poco più che studente, Werner Karl risolve il problema che angustiava i grandi fisici del tempo e scrive le equazioni che descrivono il moto degli atomi e dei quanti di luce: le equazioni della "meccanica quantistica". Queste equazioni rimpiazzano la meccanica di Newton (quella che studiamo a scuola) e cambiano completamente l’idea Newtoniana che la materia sia fatta di piccole palline.
Qualche anno prima, Einstein, venticinquenne, aveva cambiato l’immagine dello spazio e del tempo. In pochi anni, due ragazzi hanno sconvolto a fondo la nostra immagine del mondo. Che cos’è allora la materia descritta dalla meccanica di Heisenberg, se non è un insieme di palline? Due anni dopo, nel 1927, Heisenberg scrive un secondo lavoro in cui mostra che le sue equazioni implicano che la materia è fatta da "palline imprecise", o "palline nuvolette": palline tali che se le vedo in un punto non posso sapere a che velocità si muovono e quindi dove ricompariranno quando le vedo di nuovo. Questa impossibilità di determinare contemporaneamente con precisione la posizione e la velocità delle particelle che formano la materia reale non è un accidente tecnico: è il cuore della differenza fra il mondo reale, e la nostra immagine (sbagliata) che la materia sia fatta di palline come quelle della nostra esperienza quotidiana.
Questa impossibilità è considerata oggi un pilastro centrale della fisica moderna, edè chiamata il "Principio di indeterminazione di Heisenberg". A dire il vero si chiama così solo in italiano. Nelle altre lingue del mondo si chiama "principio di incertezza", perché esprime il fatto che se conosciamo con certezza la posizione di una particella non ne conosciamo la velocità, e viceversa.
Ma forse la denominazione italiana, "indeterminazione", è la migliore, perché cattura l’idea che il problema non è quello che sappiamo noi: il problema è la natura stessa delle particelle elementari, che sono oggetti più sottili ed eleganti che i sassolini della nostra esperienza. Ma possiamo davvero concepire lo strano mondo atomico intuito da Heisenberg? Davvero la realtà è così strana? L’efficacia della meccanica quantistica di Heisenberg si è rivelata strabiliante. Le sue semplici equazioni spiegano perché la tavola periodica degli elementi ha proprio quella struttura, fondano tutta la chimica, la fisica atomica, la fisica nucleare, la fisica delle particelle, la fisica della materia, l’astrofisica, e quant’altro.
Hanno dato origine ad applicazioni innumerevoli, che comprendono i semiconduttori e quindi tutti i computer di oggi. Eppure anche oggi, anche a molti fisici, il mondo "indeterminato" del principio di Heisenberg sembra troppo strano per essere vero. Ancora oggi, filosofi, fisici teorici e fisici sperimentali, si arrabattano per cercare di capire meglio. Forse trovare un’alternativa più ragionevole. O forse convincersi che davvero la materia è così strana. Staremo a vedere.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. - IL PEGGIO FEMMININO. Un discorsetto (di Lameduck)28 settembre 2011, di Federico La Sala
Il peggio femminino
di Lameduck [la’me duc] *
"Questo patto [dichiarazione di voto, n.d.a.] vogliamo stipularlo con Lei e non col prof. Prodi: la sua campagna fatta di ’serietà’ e ’sacrifici’ non ci piace, ci intristisce e ci fa un po’ spavento. E noi signore lo lasciamo volentieri perdere. ’La bellezza salverà il mondo’." (Dalla Lettera aperta delle donne a Silvio Berlusconi, marzo 2006)
Quando tutto sarà finito e ci aggireremo tra le macerie fumanti di questo disgraziato paese, bisognerà fare un discorsetto come si deve alle donne che hanno popolato, appoggiato, sfruttato ed acclamato il maledetto regime del Drago Flaccido per tutto questo tempo. Qualche testolina da rapare metaforicamente a zero per intelligenza - anzi incoscienza - con il nemico, insomma, non guasterebbe [...]....
* CLICCARE SU QUI , PER PROSEGUIRE LA LETTURA
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- IL MOVIMENTO DELLE DONNE CI RIPROVA. Una "ripresa" nel senso che Elvio Fachinelli dava a questo termine (di Lea Melandri).11 luglio 2011, di Federico La Sala
IL MOVIMENTO DELLE DONNE CI RIPROVA
di LEA MELANDRI (Gli altri, 08.07.2011)*
Sembra un destino dei movimenti rendersi "visibili" solo quando scuotono la compagine istituzionale, le sue chiusure, i suoi modelli, la sua cecita’ rispetto a tutto cio’ che si muove intorno e al suo interno. La divisione tradizionale tra politica e societa’ e’ ancora cosi’ salda che e’ bastata l’imprevista partecipazione alle elezioni amministrative e al referendum per qualificare come "nuovi" protagonisti che sono da decenni tutt’altro che assenti dalla scena pubblica e dai suoi conflitti. I cortei degli studenti e dei precari, le occupazioni delle universita’, le singolari forme di lotta adottate negli ultimi tempi dagli operai, le grandi manifestazioni delle donne, dal 2006 al 13 febbraio, appaiono nonostante tutto "carsici" finche’ non producono cambiamenti riconoscibili nei luoghi deputati della politica.
"Il clima d’opinione, scrive Ilvo Diamanti ("La Repubblica", 27 giugno 2011), non cambia da solo. Ci vogliono nuovi ’attori’ in grado di riscrivere l’agenda pubblica imponendo all’attenzione dei cittadini nuovi temi (...) Si tratta di una partecipazione nuova, caratterizzata da componenti sociali tradizionalmente periferiche, rispetto all’impegno politico. In primo luogo le donne e i giovani".
Ma come e’ possibile che i "soggetti imprevisti" del ’68, a distanza di quarant’anni, siano ancora tali? Anche ammettendo che non si tratti di un disperante ritorno dell’uguale ma di una "ripresa" nel senso che Elvio Fachinelli dava a questo termine - il gia’ noto che cerca nuove vie di uscita -, non possiamo non chiederci se il primo nemico del cambiamento non sia la politica stessa, la strenua difesa dei confini astratti che si e’ data storicamente, fatti di esclusioni ingiustificate, di strappi violenti, privilegi, poteri e linguaggi sempre piu’ vacillanti. La radicalita’ della dissidenza giovanile e del femminismo degli anni ’70 e’ stata, principalmente, la ridefinizione dell’agire politico: il lavoro, ma anche la quotidianita’, la persona, i corpi, i ruoli sessuali, la formazione dell’individuo, le professioni, il rapporto con la natura, con l’ambiente, con la diversita’ sotto qualsiasi forma si presenti. Sul tracciato che si e’ aperto allora, si puo’ dire che l’onda lunga di alcuni movimenti non ha mai smesso di scavare solchi profondi e sempre piu’ estesi, fino a far balenare l’idea che "un altro mondo e’ possibile".
Eppure, la loro presenza e i cambiamenti di cui sono gli anonimi protagonisti, vengono registrati solo quando i "nuovi barbari" riescono ad abbattere qualche paletto della fatiscente impalcatura istituzionale: la cancellazione o la conquista di una legge, un risultato favorevole alle elezioni, l’accostamento alle regole di una politica ancora sostanzialmente separata dalla vita. A questa visione dicotomica non sfugge neppure l’analisi di un osservatore acuto come Ilvo Diamanti che, pur rilevando la "moltitudine di esperienze diverse, diffuse, articolate" del popolo che oggi esprime il suo desiderio di partecipazione, accosta ancora una volta le donne ai giovani, agli studenti e agli operai. Mi chiedo se il femminismo stesso, la’ dove ha rinunciato a interrogarsi sul rapporto tra il corpo e la polis, la sessualita’ e la politica, non abbia avallato involontariamente una classificazione che vede le donne come un gruppo sociale tra altri, sia che le si consideri alla stregua di una minoranza svantaggiata o, al contrario, una "risorsa viva" da reintegrare, a sostengo di un sistema in declino.
"Il risultato vero che la manifestazione del 13 febbraio ha dato con successo - scrive Franca Chiaromonte (www.donnealtri.it, 17 giugno 2011) - e’ stato quello di mettere in scena una mobilitazione di popolo a egemonia femminile (...) quello che voglio dire e’: cosi’ come innumerevoli manifestazioni - che di solito chiamiamo di carattere generale, per es. quelle dei sindacati o dei partiti -, sono piene anche di donne (...) altrettanto ora si renderanno possibili e ugualmente potenti, se non di piu’, manifestazioni all’inverso, dove cioe’ saranno le donne a segnare i passi decisivi".
Le oltre duecento piazze che hanno accolto l’appello del comitato romano "Se non ora quando" possono far pensare a una forza unitaria delle donne, capace di imporre i suoi temi all’agenda politica, cosi’ come suggerire l’idea che uno spazio pubblico segnato per secoli dall’autorita’ maschile cambi finalmente volto. Ma se si vuole dare una risposta alla domanda di continuita’ che viene oggi dai comitati diffusi su tutto il territorio nazionale, e’ importante - come ha scritto Serena Sapegno ("Gli Altri", primo luglio 2011) tener conto che, se il 13 febbraio ha fato cadere "vecchi steccati e pregiudizi aprendosi a donne molto diverse per eta’ e ceto sociale, cultura e esperienza di vita, posizioni politiche, opzioni religiose, scelte sessuali", non per questo viene meno il carattere problematico, contraddittorio, della "frammentazione" che caratterizza da sempre il movimento delle donne. Connaturata a una pratica che parte da "se’", dall’esperienza particolare di singole, gruppi, associazioni, per estendersi a un orizzonte piu’ generale, la pluralita’ dei soggetti, delle situazioni locali, dei percorsi storici, mal sopportano strette organizzative omologanti, cosi’ come la rassegnazione a vedere trasformarsi l’autonomia in isolamento.
L’assemblea di Snoq che si terra’ a Siena il 9-10 luglio non puo’ non richiamare alla memoria tentativi analoghi che quasi sempre hanno fatto seguito a mobilitazioni riuscite, ma la ripresa, oltre che essere in questo momento nelle aspettative di molte, prende una valenza nuova e la speranza di riuscita dal contesto in cui avviene. La concomitanza tra le piazze segnate dall’autonomia del movimento delle donne con quelle occupate per giorni dai comitati elettorali e referendari, ha creato occasioni di incontro, scambio, condivisioni inaspettate tra donne di formazione culturale e politica diversa, tra associazioni del femminismo e donne provenienti da ambiti sindacali e partitici. Per alcune citta’, come Milano, si tratta di una situazione nuova, che richiede come tale attenzione, impegno, disponibilita’ a interpretare le ragioni che ci hanno tenuto a lungo separate, estranee e diffidenti le une verso le altre. A un livello ancora piu’ esteso, quale e’ un’assemblea nazionale, sara’ possibile fare interagire realta’ cosi’ diverse, darsi una forma minima di organizzazione che non ricalchi modelli noti - lobby o partiti -, trovare "un sentire comune, terreni condivisi, azioni concertate"?
Sara’ questa la sfida maggiore: non scambiare la forza collettiva con l’obbedienza al pensiero unico, la valorizzazione delle differenze con l’assenza di conflitto, la solidarieta’ con l’adeguamento. Molto dipendera’ dall’ascolto reciproco e dall’apertura ai temi molteplici che via via sono venuti allo scoperto nei percorsi della coscienza femminile, oltre che dall’attenzione ai nessi non sempre evidenti che li attraversano. Non solo percio’ la rappresentazione della donna nei media, l’ideologia assorbita oggi dalle leggi del mercato e della pubblicita’ che da sempre l’ha identificata col corpo - erotico e materno -, ma anche la violenza domestica, la subalternita’ inconsapevole alla cultura maschile dominante, la divisione sessuale del lavoro, che ancora vede le donne - direttamente o attraverso la messa al lavoro di donne, per lo più straniere - responsabili "naturali" della conservazione della vita, l’estensione indebita del concetto di maternita’ a tutte le funzioni di cura indifferentemente prodigate a persone non autosufficienti e perfettamente autonome, la tentazione di assolutizzare, assumendole come proprie, le attrattive femminili che l’uomo ha asservito ai propri bisogni e desideri.
Dietro i corpi artificiali e mercificati, "offerti ossessivamente al consumo", come scrive Sapegno, ci sono donne non meno reali di quelle che giustamente criticano l’imposizione di modelli. Si possono trovare di volta in volta "obiettivi strategici" all’azione comune, se si ha, al medesimo tempo, la voglia di costruire una visione di insieme che si avvalga della ricchezza di saperi prodotta, paradossalmente, proprio dalla frammentazione conosciuta finora.
* Fonte: http://www.universitadelledonne.it/
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- FREUD, FACHINELLI, E LA MENTE ACCOGLIENTE.1 giugno 2011, di Federico La SalaFREUD, FACHINELLI, E LA MENTE ACCOGLIENTE. «Al momento di diventare sciamani, si dice, gli uomini cambiano sesso. È così posta in rilievo la profondità del mutamento necessario. Il femminile come atteggiamento recettivo non abolisce però il maschile, gli propone un mutamento parallelo» (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989).
 LA PSICOANALISI, IL LETTINO DI MISS FREUD, E LA LEZIONE DI FACHINELLI NEGATA E IGNORATA. Un’inchiesta di Vera Schiavazzi, una riflessione di Michela Marzano, e un nota in premessa
LA PSICOANALISI, IL LETTINO DI MISS FREUD, E LA LEZIONE DI FACHINELLI NEGATA E IGNORATA. Un’inchiesta di Vera Schiavazzi, una riflessione di Michela Marzano, e un nota in premessa
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- "AVE MARY" E LA TEOLOGIA DI DIO COME "UOMO SUPREMO". Un saggio di Michela Murgia, recensito da Natalia Aspesi.12 maggio 2011, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- Che fine ha fatto il futuro? Come rinchiusi dentro una specie di presente “artificiale”, eterno (di Flore Murard-Yovanovitch - interv. a MarcAugé)..7 ottobre 2010, di Federico La Sala
Marc Augé: «Rendiamo eterno il presente per paura del futuro»
L’antropologo francese parla del «nontempo» che caratterizza la nostra epoca e dei rischi di una società globale divisa in classi che ci porterà verso una pericolosa «oligarchia planetaria» piena di disuguaglianze
di Flore Murard-Yovanovitch (l’Unità, 07.10.2010)
Immigrazione e Rom. «Non esiste una “questione Rom”, ma una cattiva accoglienza dei Rom. Quanto alla multietnicità è un fenomeno naturale» L’ultimo suo appuntamento italiano è stato il Festival della Filosofia svoltosi il mese scorso a Modena Carpi e Sassuolo. Ma non sono i «luoghi» a interessare Marc Augé, e neanche il tempo... Al «nonluogo», il neologismo da lui coniato nel ’92, ha ora aggiunto il «nontempo», ovverosia il presente eterno che caratterizza questa nostra epoca recente.
Abbiamo incontrato il celebre antropologo francese in un nonluogo e nel nontempo per chiedergli uno sguardo sulla costruzione di un’Europa multietnica, sulle attuali reazioni di xenofobia che Francia e Italia hanno in comune e sul tema della diversità.
Professor Augé, cominciando dal presente, che fine ha fatto l’idea di uguaglianza nella società contemporanea?
«A livello globale c’è più ricchezza, ma non funziona il meccanismo di redistribuzione e il divario tra ricchi e poveri sta aumentando in modo vertiginoso. La società globale verso cui andiamo è irriducibilmente divisa in classi. Non puntiamo, perciò, verso una “democrazia planetaria”, come pensa Fukuyama, bensì verso una “oligarchia” planetaria... Con il rischio di una disuguaglianza inimmaginabile oggi, perché riguarda soprattutto la conoscenza, tra quelli che saranno alla punta del sapere e quelli chiusi in una permanenza del non sapere».
Ma c’è ancora un futuro, visto che nel suo recente libro «Che fine ha fatto il futuro?» parla del «nontempo» che sarebbe davanti a noi?
«Oggi c’è una sorta di ideologia del presente, si parla molto meno del “tempo”. Siamo accerchiati da strumenti di comunicazione che ci bombardano di messaggi e di immagini. C’è una istantaneità che, combinata alla sovrabbondanza visiva, dà l’impressione di essere rinchiusi dentro una specie di presente “artificiale”, eterno».
Dalle sue parole sembra che siamo condannati all’«eterno ritorno dell’uguale» di nietzschiana memoria...
«È solo una impressione, che corrisponde alla nostra paura del futuro. Anche se la storia e la scienza vanno avanti velocemente, c’è come una sorta di rifiuto del presente. Abbiamo la coscienza che il pianeta è fragile, i nostri sogni di benessere non si realizzano, non c’è uguaglianza sociale e la storia è violenta. Ne sembriamo sorpresi, allorché la storia è sempre stata violenta».
Come spiega che, nonostante il suo tragico passato di nazismo e fascismo, in Europa stiano riapparendo discorsi e atti xenofobi?
«C’è una crescita dei movimenti di estrema destra in Europa occidentale e nei paesi ex comunisti, come avevo già segnalato anni fa. L’Occidente ha una sua reazione di paura, ma non è l’unica, anche altri sono violenti. Ci sono ideologie mortifere nell’ombra, situazioni di tensione che purtroppo possono essere facilmente strumentalizzate».
A questo proposito, esiste una reale «questione Rom» o è una costruzione mediatica e politica?
«Non c’è un “problema Rom”, ma una questione di cattiva accoglienza dei Rom. Le strutture abitative non sono all’altezza, non hanno nemmeno decenti connessioni energetiche di base. Invece ci sarebbero cospicui finanziamenti europei per creare una degna politica di integrazione, ma essi sono sottoutilizzati e persino non utilizzati dai governi. D’altro canto, è una questione fittizia, dal momento che i rumeni sono comunitari, liberi di tornare quando lo desiderano, e che in Francia, i due terzi della cosiddetta “gente del viaggio” sono cittadini francesi. L’argomento, almeno nel mio Paese, è bassamente elettorale, in vista delle prossime elezioni».
Ma in Europa c’è, in generale, un attacco all’essere umano diverso, all’immigrato...
«L’Europa è cambiata molto con l’immigrazione, è in corso un inedito rinnovamento della popolazione. Basta scendere nella metro parigina e la multietnicità salta agli occhi. Ma solo quando ci sono crisi o incidenti, si parla, e in termini negativi, della diversità... Quando invece si potrebbe riconoscere come essa sia “accaduta” in modo del tutto naturale e con una positività dei nuovi rapporti interculturali. Non sono convinto, d’altronde, che il fenomeno di rifiuto del diverso sia maggioritario.
Con questi presupposti, quale rivoluzione culturale e politica è auspicabile?
«L’espressione “rivoluzione culturale” è troppo connotata storicamente. Fermo restando che la nozione di cultura e quella di rivoluzione dovrebbero essere sinonimi. La cultura dovrebbe essere sempre critica se non rivoluzionaria. La cultura non è lo specchio dell’esistente ma la sua disamina, la sua messa in causa; dovrebbe essere attenta, vigile. La cultura non è apolitica. E la politica, come la morale, dovrebbe ispirarsi alla scienza, che è il contrario della ideologia: fondarsi sullo stesso spirito della ricerca, prospettare ipotesi, cercare soluzioni anche provvisorie, formulare idee nuove, senza basarsi sui modelli del passato. Per questo faccio anzi l’elogio del futuro».
*
Chi è. Lo studioso che ha «inventato» il nonluogo
MARC AUGÉ Già Directeur d’études presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, dopo aver contribuito allo sviluppo delle discipline africanistiche ha elaborato un’antropologia della pluralità dei mondi contemporanei attenta alla dimensione rituale del quotidiano e della modernità. Ha inoltre focalizzato la sua attenzione su una serie di esperienze contemporanee che attraversano la progettazione urbanistica, le forme dell’arte contemporanea e l’espressione letteraria.
Tra le sue opere tradotte di recente: «Rovine e macerie» (Torino 2004); «Perché viviamo» (Roma 2004); «Tra i confini. Città, luoghi, interazioni» (Milano 2007); «Il mestiere dell’antropologo» (Torino 2007); «Il bello della bicicletta» (Torino 2009); «Il metrò rivisitato» (Milano 2009); «Che fine ha fatto il futuro? Dai non luoghi al nontempo» (Milano 2009). È componente del Comitato Scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- L’ALTALENA E LA CRISI: UN RIMEDIO PER ATENE DALL’ORACOLO DI APOLLO.30 agosto 2010, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- FREUD,PIRANDELLO, E LA "SACRA FAMIGLIA" CATTOLICO-ROMANA, ZOPPA E CIECA!!!8 maggio 2010, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- NEGARE AL FARAONE LA VITTORIA POSTUMA. LA CRISI EPOCALE DELLA CHIESA ’CATTOLICA’ E LA LEZIONE DI SIGMUND FREUD LONDRA.21 aprile 2010, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- {{["IL TEMPO CHE RESTA": UNA DOMANDA DI GIORGIO AGAMBEN A UNA CHIESA PERSA NEL TEMPO.29 dicembre 2009, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- IL RITORNO DI LILITH. Joumana Haddad, con Lilith un successo gigantesco3 novembre 2009, di Federico La Sala
Agi 2.11.09
Poesia: Joumana Haddad, con Lilith un successo gigantesco
(AGI) - Roma, 2 nov. - Quasi 2 mila copie vendute in poco piu’ di una settimana, un gran pubblico entusiasta accorso alle sue presentazioni, numerose interviste radiotelevisive e della carta stampata. Questi i dati del gran successo avuto da Joumana Haddad con ’Il ritorno di Lilith’, la prima opera integrale in italiano edita da ’L’Asino d’oro, nella sua tournee italiana appena conclusasi.
"Non e’ stato un gran successo ma un successo gigantesco!", chiosa la scrittrice libanese, che annuncia una nuova avventura letteraria sempre con l’Asino d’oro per il 2010. E, assicura, nel suo stile: scrivere con le unghie perche’ le piace scavare, andare in profondita’.
Come ha fatto con ’Il ritorno di Lilith’ per sferzare le donne: perche’ non fate sentire le vostre voci? Non mostrate le vostre unghie? Quali i motivi di questo ’successo gigantesco’ che tra l’altro smentisce il luogo comune che la poesia non la legge nessuno?
"Innanzitutto il valore letterario dell’opera. Poi il lavoro, la riflessione del poeta che deve sostenere, accompagnare il testo non smentirlo ma rendendolo piu’ solido e forte", risponde certa e soddisfatta la Haddad. "Quindi l’ottimo lavoro della casa editrice - aggiunge - ed infine la qualita’ della traduzione: sono questi i quattro elementi del successo gigantesco. E direi non solo del libro in se’. Ma del dialogo culturale che ha piu’ valore del dialogo politico".
’Il ritorno di Lilith’, e’ un libro di poesia ed affronta un tema attualissimo ma al tempo stesso controverso: la donna ed il suo essere, e poi il suo ruolo nella societa’. "Verissimo - precisa la Haddad - Il libro ruota tutto attorno alla donna, alla sua identita’, al suo essere: e in questo sta il suo valore letterario".
E si puo’ dire che in questo sta il suo valore culturale che si integra con il dialogo culturale di cui ha parlato? "Si’ sono d’accordo, noi tutti abbiamo bisogno - spiega la Haddad - del dialogo a livello culturale, che ha piu’ valore del dialogo politico, perche’ si riscontrano i segni piu’ solidi di sensibilita’ e comunicazione da parte della gente".
Che per la politica ha ben poca fiducia. "Sono convinta che e’ dal dialogo culturale che ci si conosce meglio, di piu’ e - precisa la Haddad - e piu’ profondamente".
Contaminarsi dunque come cultura, tradizione, modo e stile di vita, insomma. "Si’ e’ a questo che penso", evidenzia la Haddad anche sulla base del gran successo anzi del successo gigantesco, riscontrato come presenza di pubblico. Joumana Haddad, e lo ha spiegato bene, vuole, con ’Il ritorno di Lilith’, sprigionare e poi alimentare una ’speranza’ per le donne arabe oppresse ma anche di altri paesi, Italia compresa: del resto l’oppressione della donna, pur se registra diverse modalita’ sul piano fisico, e’ identica come intenzionalita’.
E Lilith la prima donna creata che non si sottomise e non si ridusse in schiavitu’ ad Adamo e’ la speranza per le donne. Dunque, "donne ribellatevi - e’ il messaggio della Haddad - fate sentire la vostra voce, mostrate le unghie". (AGI)
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- DON PAOLO FARINELLA, PRETE E CITTADINO "SPOSATOSI" CON BERLUSCONI, GLI HA SCRITTO UNA "LETTERA DI RIPUDIO", FINALMENTE!!! (di Federico La Sala - Una nota).11 settembre 2009, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- TEOLOGIA POLITICA LUCIFERINA ... A SILVIO BERLUSCONI ... PER AVER MOSTRATO ALL’ITALIA INTERA L’ENORME POTERE DISTRUTTIVO DEL GIOCO ("IO MENTO") DEL MENTITORE: "FORZA ITALIA" (1994-2009)!!!29 settembre 2009, di Federico La Sala
-
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. --- Concita De Gregorio, Natalia Lombardo, Federica Fantozzi, Maria Novella Oppo, Silvia Ballestra. Sono tutte donne le colleghe e amiche dell’Unità citate per danni dal presidente del consiglio per "lesa dignità" ... (di Ida Dominjanni): Nessuno comprerà le nostre parole (di Maria Novella Oppo).5 settembre 2009, di Federico La Sala
L’Onore ferito
di Ida Dominijanni (il manifesto, 03.09.2009) *
Concita De Gregorio, Natalia Lombardo, Federica Fantozzi, Maria Novella Oppo, Silvia Ballestra. Sono tutte donne le colleghe e amiche dell’Unità citate per danni dal presidente del consiglio per "lesa dignità". E’ un caso e non lo è. Perché fin dall’inizio dell’affaire che lo sta coprendo di ridicolo, in Italia e nel mondo, sono soprattutto donne, a partire da Veronica Lario, quelle che si sono prese la libertà di dire "vedo" di fronte al poker delle sue performance da "vero uomo". Vedo e non credo.
Basta questo per mandare in briciole il mito del grande seduttore a cui nessuna resiste. Vediamo, non crediamo, resistiamo. La libertà di stampa brucia. Se è libertà femminile brucia il doppio, perché per un vero uomo è doppiamente insopportabile. Lesiva non della sua dignità ma del suo narcisismo. E va doppiamente punita.
Come è stato per Veronica, data per "nervosa" («capita talvolta alle donne di essere un po’ nervose», commentò suo marito: questione ormonale), inaffidabile e manipolabile, e triturata dalla stampa del principe come "velina ingrata" (quel gentiluomo di Feltri) nonché moglie infedele. Com’è stato per Patrizia D’Addario, manovrata e pagata da chissà chi. Com’è stato per altre che si sono impicciate di altri affari del premier, a cominciare da Nicoletta Gandus, giudice sul caso Mills (qualcuno ricorda la faccia di Ghedini in tv mentre commentava la sua sentenza?).
Il premier e la sua corte hanno un’idea precisa di dove deve stare una donna e di come la si possa "utilizzare". Se una, due, cinque, cinquanta, cinquantamila in quel posto non ci stanno sono guai. Per lui, perché questo è l’ennesimo segnale di dove sia finito il mitico fiuto di Silvio Berlusconi che pareva metterlo sempre dalla parte del senso comune. In quel posto non ci stiamo, il senso comune stavolta dice questo. Il fiuto del grande comunicatore è svaporato.
Fa davvero piacere vedere il premier riconciliato con le virtù di quella giustizia che per anni ha denigrato, appellarsi pieno di fiducia a quegli stessi magistrati per i quali un tempo invocava test attitudinali e prove di stabilità psicologica. Aveva ragione. Ci vuole effettivamente molto equilibrio per decidere di questioni tipo questa: Luciana Littizzetto avrà leso o no l’onore del premier con le sue battute "sull’utilizzo di speciali accorgimenti contro l’impotenza sessuale"? Avrà leso o no «la sua identità personale presentando l’onorevole Berlusconi come soggetto che di certo non è, ossia come una persona con problemi di erezione»? Non invidiamo i magistrati, e nemmeno i periti di parte. Neanche per sorridere indagheremmo mai su quel "di certo": non ci serve. Di certo, quando un "vero uomo" mette sul tavolo l’evidenza letterale della sua potenza, è perché traballa quella simbolica.
Silvio Berlusconi è di certo un "vero uomo", di quelli che affidano alla mascherata sessuale la certificazione della loro misura. Altrettanto di certo è un uomo politico finito: nella miseria, nella rabbia, nella dismisura.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- ITALIA. LE ELEZIONI COSTITUENTI E LE DONNE (DELL’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE E DEGLI "UOMINI VIRTUOSI" - "ANDRAGATHIA"). Una riflessione di Rossana Rossanda4 settembre 2009, di Federico La Sala
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. .... E le ’difficoltà’ di Lea Melandri a capire perché "i dogmi delle gerarchie vaticane somigliano stranamente ai codici tradizionali della Sharia" e a vedere cosa nasconde la "maschera di neutralità" del "patriarcato".16 aprile 2009, di Federico La Sala
LEA MELANDRI: SE IL PATRIARCATO NON DEPONE LA MASCHERA DELLA NEUTRALITA’
[Dal sito della Libera universita’ delle donne di Milano (www.universitadelledonne.it)] *
Accanto all’allarme per la crisi economica, la disoccupazione crescente, le manovre dei potenti della Terra per porre un argine alla rabbia dei ceti piu’ colpiti, nelle ultime settimane sono tornate ad occupare un posto non trascurabile questioni che vengono ancora genericamente riferite alla vita personale, alla sfera intima, alla coscienza del singolo, benche’ sempre piu’ intersecate con le istituzioni della "cosa pubblica".
Da un lato, e’ passata, come sempre, la cronaca pressoche’ quotidiana degli stupri e degli omicidi in famiglia, con l’unica variante del tipo di parentela che ogni volta lega la vittima all’aggressore. Dall’altro, si e’ venuto imponendo, per circostanze tra loro apparentemente lontane, un dibattito acceso su leggi e principi costituzionali, parlamenti e consulte, diritti, liberta’ delle persone e poteri dello Stato, laicita’ e imposizioni religiose, garanzie democratiche e consuetudini tribali.
La norma votata dal parlamento afgano, che legalizza, per la minoranza sciita, lo stupro in famiglia e la totale dipendenza della donna dall’uomo, la revisione, in Italia, da parte della Consulta, della legge 40 sulla fecondazione assistita, per quanto riguarda "l’impianto unico e contemporaneo" di "non piu’ di tre embrioni", il caso di Kante Katadiatou, la donna ivoriana ricoverata per parto all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli e inquisita per "identificazione urgente", in nome di una clausola del decreto sicurezza non ancora approvato - ma si potrebbe aggiungere anche la vicenda parlamentare del testamento biologico -, parlano sostanzialmente della violazione di alcuni diritti e liberta’ essenziali della persona, garantiti, nei Paesi che si considerano "civili" e "democratici", dalle rispettive Costituzioni, e negli altri casi da organismi e convenzioni internazionali.
Le reazioni che hanno provocato, i cambiamenti di rotta, le spaccature all’interno di gruppi politici che si pensavano ideologicamente compatti - i cento deputati del Pdl che si sono espressi contro l’emendamento della Lega, inteso ad abolire il divieto di segnalazione, da parte dei medici, degli immigrati senza permesso di soggiorno -, gli interventi di Fini contro lo "Stato etico", in difesa della laicita’, la decisione del presidente Karzai di congelare una legge fatta per negoziare il consenso della minoranza religiosa piu’ oltranzista, dicono che le vicende essenziali riguardanti la vita nella sua interezza - il rapporto tra i sessi, la nascita, la morte, la salute, ecc. -, tenute a lungo fuori dalla storia, dai linguaggi e dai poteri pubblici, hanno la forza "perturbante" di una "stirpe oppressa" dalla civilta’, che oggi chiede il conto.
Ma come definire il contesto economico, culturale e politico, nelle sue incomparabili differenze, che oggi, di fronte all’imprevisto, balbetta, si contraddice, attacca e si difende? Se Pierluigi Battista, sul "Corriere della sera" (2 aprile 2009), ha provato a riproporre con poco successo quello che e’ stato il cavallo di battaglia della destra piu’ vicina al Vaticano - lo "scontro tra Islam e Occidente" -, questo non vuol dire che le democrazie occidentali e le loro affiliazioni in terre lontane e inospitali non siano tutt’oggi convinte della loro superiorita’ e unicita’, incapaci di interrogarsi su quei residui arcaici, che le rendono cosi’ simili alla culture "tribali", su quelle inclinazioni fondamentaliste che ancora confondono religione e politica, legge divina e liberta’ della persona.
Se la contrapposizione tra mondo civile e barbarie appare cosi’ netta, se qualcuno, nonostante i casi di violenza quotidiana che lo smentiscono, puo’ ancora parlare di "donne liberate" dell’Occidente, se ci si puo’ illudere che basti schierarsi "in difesa delle donne", rendere giustizia alle "vittime" identificando di volta in volta l’oppressore con qualcuno che e’ "altro da se’" - lo straniero, lo psicopatico, il politico in cerca di consenso facile, ecc. -, e’ perche’ una barriera, forte del senso comune e di un pregiudizio millenario, ancora avvolge le molteplici, multiformi "culture" create dal dominio maschile, in una maschera impenetrabile di neutralita’.
Ma se proviamo a scostare il velo, il paesaggio cambia, il confine tra le citta’ dell’Occidente e i villaggi afgani si fa mobile e impercettibile, i dogmi delle gerarchie vaticane somigliano stranamente ai codici tradizionali della Sharia, la deriva verso lo "Stato etico", il fondamentalismo religioso, criticato e combattuto dall’Occidente in altri Paesi, appare per quello che e’, la prima e l’ultima sponda del patriarcato, il tentativo, di fronte all’irruzione di una "preistoria" - il corpo, la vita personale, il rapporto tra i sessi - mai del tutto addomesticata, di riprendersi un potere antico: il sequestro dei corpi, l’appropriazione della vita dei singoli, la cancellazione di quella conquista inalienabile dell’incivilimento che e’ l’autodeterminazione, il diritto di ogni persona "a prendere in liberta’ le decisioni piu’ intime" (Stefano Rodota’).
Non e’ un caso che, nel dibattito che si e’ acceso intorno a questi temi, si parli ancora esclusivamente di "bioetica", come se la vita che e’ stata ridotta a corpo biologico, la persona, a cui si vorrebbero togliere liberta’ e diritti, non fosse stata, prioritariamente, quella della donna; non e’ un caso che tutte le vicende di cui si e’ parlato sopra abbiano come protagonista il sesso femminile - sia come "oggetto" di violenza che di tutela -, e mai, come ci si dovrebbe aspettare, la consapevolezza e la cultura femminista che, da oltre un secolo, ha cominciato a scuotere i privilegi e le certezze della comunita’ storica degli uomini.
La legge afgana, che sulla sponda "civile" del mondo ha suscitato tanto sdegno, se si riuscisse a guardarla per la verita’ "domestica", violenta, quotidiana, e pressoche’ senza tempo e patria, che porta allo scoperto - la cancellazione della sessualita’ femminile, la donna espropriata di volonta’ ed esistenza propria, sottoposta a un potere di vita e di morte, esclusa dallo studio e da responsabilita’ pubbliche -, potrebbe finalmente far riflettere sull’unico dominio, quello di un sesso sull’altro, che sfugge alle analisi, e quindi ai cambiamenti, che qualcuno ipocritamente vorrebbe circoscrivere a intoccabili "differenze culturali", altri al terreno non meno rispettabile e riservato della sfera intima.
Al sessismo esplicito, impugnato dai mullah come legge naturale, fa riscontro, per la parentela evidente, l’insignificanza - intellettuale, politica, professionale - in cui sono tenute le donne "emancipate" dell’Occidente, casalinghe, madri, mogli sempre e comunque, o, nel migliore dei casi, "conduttrici" di un discorso unico e privilegiato tra uomini, che occupa ininterrotto da secoli la scena pubblica.
*
 Fonte: NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE
Fonte: NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE Supplemento settimanale del giovedi’ de "La nonviolenza e’ in cammino"
Supplemento settimanale del giovedi’ de "La nonviolenza e’ in cammino"
 Numero 245 del 16 aprile 2009
Numero 245 del 16 aprile 2009
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- Il libro "Scomparso" di Fachinelli. Guerra tra Editori ... Un pasticcio. Fachinelli l’antiautoritario non lo meritava (di Simonetta Fiori).3 aprile 2009, di Federico La Sala
-Guerra tra editori.
 Nel ventennale della morte, doveva uscire in libreria l’opera omnia dello psicoanalista
Nel ventennale della morte, doveva uscire in libreria l’opera omnia dello psicoanalista
 Calasso fa bloccare un volume della Bollati: il curatore sono io
Calasso fa bloccare un volume della Bollati: il curatore sono io
 Ma la figlia ci ripensa. Così resta congelata anche "un’inedita autobiografia"
Ma la figlia ci ripensa. Così resta congelata anche "un’inedita autobiografia" Il libro "Scomparso" di Fachinelli
Il libro "Scomparso" di Fachinelli Cataluccio: "Adelphi s’è ricordata dello studioso quando ha saputo di noi"
Cataluccio: "Adelphi s’è ricordata dello studioso quando ha saputo di noi" Calasso: "Teniamo molto alle sue opere, anche agli scritti sparsi"
Calasso: "Teniamo molto alle sue opere, anche agli scritti sparsi" di Simonetta Fiori (la Repubblica, 03.04.2009)
di Simonetta Fiori (la Repubblica, 03.04.2009)Era stato presentato come un avvenimento culturale, la raccolta completa delle opere di Elvio Fachinelli in due volumi. Non solo i suoi libri conosciuti, ma anche un volume di settecento pagine radicalmente nuovo, con scritti sparsi dello psicoanalista, comparsi su giornali e riviste nell’arco di un trentennio. Era pronta la copertina, già decisa la collana "Nuova Cultura". Un titolo secco, Opere, la cura affidata a Lea Melandri, compagna di militanza ai tempi della rivista L’erba voglio. Pronto anche "lo strillo" per i librai, ben calibrato il risvolto, che ripercorre l’inquieta biografia del "rinnovatore libertario" scomparso vent’anni fa. La redazione di Bollati Boringhieri era attrezzata per l’uscita, ma il lavoro annunciato per lo scorso autunno non è mai arrivato in libreria.
Poco prima di andare in stampa, l’opera è stata bloccata da una lettera. Scritta dal "curatore" scelto da Fachinelli nel suo testamento. Un amico carissimo, un editore importante, l’editore di tre dei suoi libri più significativi. La missiva è indirizzata a Giuditta, figlia ventiseienne dello psicoanalista.
L’intonazione usata da Roberto Calasso appare poco conciliante. Fachinelli racchiuso in un’opera omnia? Inconcepibile. Un tradimento, in sostanza, questo progetto editoriale. Una pietra tombale. Un torto all’originalità di un pensatore curioso e disorganico. Giuditta si lascia convincere e rinuncia alla pubblicazione, a cui pure aveva partecipato.
L’opera di Bollati Boringhieri viene fermata. Con essa la preziosa raccolta di pagine poco conosciute, "un’inedita autobiografia".
L’idea di mettere insieme libri e scritti sparsi di Fachinelli risale al decennale della morte. «Allora», racconta Melandri, «ebbi modo di constatare che, dei suoi cinque libri, alcuni erano di difficile reperibilità, altri decisamente esauriti. Con insistenza riuscii a far ristampare dall’editore Feltrinelli Il bambino dalle uova d’oro e dall’Adelphi La freccia ferma. Però continuava a mancare un’opera completa che restituisse la complessità di un pensatore originale, oggi totalmente dimenticato».
Nessun problema di copyright con l’Adelphi, già editrice di La freccia ferma, Craustrofilia e La mente estatica? «No, sul piano dei diritti non c’era incompatibilità», spiega Cataluccio. «Noi ci siamo valsi del diritto di "opera in raccolta". Le obiezioni mosse da Calasso infatti non riguardano il copyright, ma l’opportunità di stampare l’opera omnia. Mi chiedo però come mai l’editore-curatore-erede intellettuale di Fachinelli si sia ricordato del grande psicoanalista solo quando ha saputo del nostro progetto editoriale. Non a caso la figlia Giuditta si è rivolta a me, non a Calasso, lamentando il disinteresse di Adelphi per i titoli di suo padre. Libri che circolavano poco, uno addirittura esaurito».
La Bollati Boringhieri che "sveglia" l’Adelphi? Calasso sbuffa: «Ovviamente teniamo molto alle opere di Fachinelli e non abbiamo bisogno che alcuno ce le ricordi. Nel gennaio di quest’anno abbiamo acquistato i diritti del Bambino dalle uova d’oro, appena abbiamo saputo che il titolo era tornato libero, e a settembre sarà in libreria la nuova edizione, in veste diversa dalla prima, della Mente estatica». Ma fu proprio Giuditta a lamentare con Cataluccio la scarsa visibilità dei libri paterni. «La freccia ferma e Claustrofilia sono disponibili nella Piccola Biblioteca, collana che si trova ovunque. Sarebbe stato tutto più semplice, in ogni modo, se la figlia di Fachinelli si fosse rivolta subito a me, a cui suo padre ha affidato la "cura editoriale" della sua opera».
Perché non coinvolgere fin dal principio Adelphi? Lo chiediamo a Lea Melandri, artefice del nuovo progetto su Fachinelli. «Ma non mi sembrava che ci fosse per Elvio tutta questa attenzione. È anche per spirito polemico nei confronti di Calasso che mi sono rivolta altrove. Le date mi sembrano significative: noi ci siamo mossi in anticipo sul ventennale, Calasso ha cominciato a darsi da fare solo dopo aver saputo del nostro lavoro. Attualmente La mente estatica appare ancora esaurito. Come "curatore" designato, non mi sembra granché».
Giuditta è una ventenne, quando è morto il padre aveva solo sei anni. Al telefono appare spaventata, anche inesperta. «Pensavo che sui diritti si accordassero le due case editrici», si difende. «Ora Adelphi s’è impegnata a ristampare in una nuova collana tutti i libri di mio padre». E il volume delle sue pagine sparse: non c’è il rischio di perderlo?
Calasso dà per sottinteso l’interesse dell’Adelphi. «Aspetto molto questi scritti, che solo in parte conosco. Giuditta dovrebbe consegnarceli al più presto». Già, i materiali: ma in che forma? «Non intendo certo dare a Calasso le bozze del volume di Bollati Boringhieri», precisa Giuditta. «Sarebbe inopportuno». Forse anche un torto per chi vi ha lavorato per oltre un anno. Un pasticcio. Fachinelli l’antiautoritario non lo meritava.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera - di Federico La Sala4 dicembre 2008, di Federico La Sala
IL TEMA affrontato da Simone Weil, richiama LE DISCUSSIONI E L’IMPORTANTE RIFLESSIONE DI FACHINELLI SU "GRUPPO CHIUSO O GRUPPO APERTO? ("Quaderni Piacentini", n. 36, 1968 - poi in IL BAMBINO dalle uova d’oro, Feltrinelli)
 E se provassimo a fare a meno dei partiti politici?
E se provassimo a fare a meno dei partiti politici?
 L’eretica, la mistica, la rivoluzionaria Simone ce lo suggerisce.
L’eretica, la mistica, la rivoluzionaria Simone ce lo suggerisce.
di Ritanna Armeni (il Riformista 2.12.2008)
Sono organizzazioni totalitarie in sé come dice Simone Weil? O forse hanno esaurito il loro compito storico e la democrazia oggi ha bisogno di nuovi pilastri
Mi è capitato di leggere in questi giorni un piccolo volume di Simone Weil titolato "Manifesto per la soppressione dei partiti politici". Una «modesta proposta» rimasta inedita e pubblicata dopo la sua morte che colpisce per la sua radicalità e la sua potenza. «I partiti - scrive senza mezzi termini l’eretica Simone - sono organismi costituiti in maniera tale da uccidere nelle anime il senso di verità e di giustizia», perché sono costruiti proprio per «esercitare una pressione collettiva sul pensiero di ognuno degli esseri umani che ne fanno parte». «L’unico fine di qualunque partito politico - prosegue la Weil - è la sua propria crescita, e questo senza alcun limite», di conseguenza «è totalitario in nuce e nelle aspirazioni. Se non lo è nei fatti, questo accade solo perché quelli che lo circondano non lo sono da meno». La conclusione non ammette compromessi: «Se si affidasse al diavolo l’organizzazione della vita pubblica, non saprebbe immaginare nulla di più ingegnoso» e quindi «la soppressione dei partiti costituirebbe un bene quasi allo stato puro».
Il piccolo volume mi ha colpito molto. Per due motivi probabilmente molto personali e apparentemente contradditori. Quelle definizioni non contenevano quasi nulla di ciò che io avevo fino a quel momento pensato e detto dei partiti e che, con me, avevano pensato e detto molti altri. Ma nello stesso tempo quelle parole così drastiche, appassionate e definitorie mi convincevano, squarciavano un velo, portavano alla luce qualcosa che sapevo e che - paradossalmente - non avevo avuto il coraggio di pensare fino in fondo.
Lo so bene, oggi i partiti non godono di buona fama. Anche l’uomo della strada pensa che il loro fine è il potere. La scarsità di adesioni e di militanza indica che la sfiducia è profonda. La supremazia che i governi hanno ormai acquistato rispetto ai parlamenti e quindi ai partiti che qui sono rappresentati è un segnale inequivocabile della loro crisi.
Ma quelle parole vanno ancora più nel profondo e aprono nuove domande. Dicono che i partiti, non in conseguenza di condizioni date (Simone Weil scrive in pieno stalinismo e nazismo), ma in sé e per sé, in quanto organizzazioni del pensiero e dell’azione, ne contengono la soppressione, producono l’abolizione della libertà di espressione e delle idee di cambiamento.
Naturalmente so bene che, guardando alla storia, mi si potrebbe dimostrare il contrario. Ma il punto interessante non riguarda il passato bensì il presente. L’eretica Simone non stimola sull’analisi di quanto è avvenuto ieri ma sull’oggi e sul domani. La domanda che ci fa o alla quale ci induce è la seguente: la società moderna ha ancora bisogno dei partiti per produrre idee di cambiamento e per organizzarlo? Non stiamo assistendo oggi nel concreto della loro azione al fatto che non sono capaci né dell’uno né dell’altro? Chi dovrebbe sostituirli? E, ancora, se il loro fine, e quindi il fine della politica è il potere, è possibile separare l’una dall’altro? E - soprattutto - è giusto e utile? Confesso che non so rispondere a queste domande. E a molte altre che Simone Weil con i suoi drastici assunti suggerisce. Ho, invece, alcune piccole certezze.
Negli ultimi anni non ho visto nascere nessuna idea, nessuna analisi convincente della realtà da un partito. È più facile, molto più facile, che essa nasca da un giornale, da un singolo intellettuale e persino da una discussione in un salotto. Nei partiti di destra e di sinistra il conformismo è la regola. Ed è il conformismo la forma moderna del totalitarismo. La liberazione da esso, che pure alcuni attuano, è quasi obbligatoriamente simultanea all’abbandono del partito che, nel migliore dei casi, rimane uno stanco riferimento elettorale.
Separare il potere dalla politica non è una idea tanto astratta e velleitaria se è vero che milioni di persone si dedicano al volontariato, si organizzano autonomamente, cercano di portare avanti nuove idee di cambiamento. Il senso di verità e di giustizia di cui parlava Simone Weil sta cercando nuovi modi di esprimersi.
Il pessimismo quindi non è d’obbligo. Ma lo è il ripensamento di tutti gli schemi che ci hanno guidato finora compreso quello secondo cui «i partiti sono i pilastri della democrazia».
E se non fosse più così? Se per la democrazia dovessimo trovare altri pilastri, altre parole? Se non potesse essere ridotta a prendere posizione dall’una e dall’altra parte? Se fosse sbagliare liquidare come «qualunquistica» la diffidenza e l’abbandono dei partiti? Se pensassimo a nuovi strumenti per «perseguire il bene pubblico»"?.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. ---- Se sull’amore parla Lacan.... c’è un epilogo, è dell’ordine del suicidio. Da parte dell’analista (di Nadia Fusini)5 dicembre 2008, di Federico La Sala
SE SULL’AMORE PARLA LACAN ...... NON VA SI VA OLTRE PLATONE, SOCRATE... E FREUD. IL LAVORO E LA NOVITA’ RADICALE DELL’INDICAZIONE DI FACHINELLI E’ ANCORA IGNORATA DALLA PUR BRILLANTE NADIA FUSINI E LA SUA ENTUSIASTICA LETTURA DELLE LEZIONI SUL "TRANSFERT" DI LACAN APPARTIENE AL "VECCHIO" MONDO, OLOFERNICO E CLAUSTROFILICO.
Se sull’amore parla Lacan
Escono ora le sue lezioni sul "transfert"
 Sono pagine accessibili e interesseranno anche i classicisti, gli studiosi del mondo antico e della letteratura
Sono pagine accessibili e interesseranno anche i classicisti, gli studiosi del mondo antico e della letteratura
 "Il seminario. Libro VIII" parla dell’eros tra l’analista e il paziente indispensabile alla cura
"Il seminario. Libro VIII" parla dell’eros tra l’analista e il paziente indispensabile alla cura
 Si tratta del corso tenuto dal maestro francese tra il 1960 e l’anno successivo al Sainte-Anne
Si tratta del corso tenuto dal maestro francese tra il 1960 e l’anno successivo al Sainte-Anne
 Grande competenze nella lettura del "Simposio" di Platone, come su Arcimboldo o Swift
Grande competenze nella lettura del "Simposio" di Platone, come su Arcimboldo o Swiftdi Nadia Fusini (la Repubblica, 5.12.2008)
Nell’inverno 1960 Jacques Lacan riprende le sue lezioni all’ospedale di Sainte-Anne, secondo una cadenza settimanale, e cioè ogni mercoledì, fino al giugno 1961: un anno accademico, come ai vecchi tempi. Quest’anno a tema sarà il transfert, termine chiave per la comunità di attenti allievi cui il maestro si rivolge, essendo l’amore del paziente e per contro quello dell’analista il carburante necessario al viaggio in psicoanalisi. La coppia analista-analizzando come potrà stare insieme sulla stessa carrozza, se non amandosi e odiandosi, come ogni coppia?
Il testo di quelle lezioni stabilito da Jacques-Alain Miller e tradotto da Antonio Di Ciaccia, che cura l’edizione italiana, è raccolto ne Il Seminario, Libro VIII, uscito da Einaudi (pagg. 436, euro 34,00). Il libro è immensamente interessante: non esagero. Interesserà non solo i ricercatori della psiche, gli adepti del mestiere. Ma coinvolgerà gli studiosi del mondo antico, i classicisti, che vi troveranno un’analisi approfondita di indubbia intelligenza e competenza del Simposio di Platone; e gli studiosi in genere della letteratura, che vi troveranno una lettura del mito di Edipo oggi, così come risorge nella trilogia dei Coufontaine di Paul Claudel. E infinite altre acute, stranianti osservazioni su artisti e scrittori, da Arcimboldo a Swift: tutte pertinenti e insieme impertinenti, eccitanti come punture di uno spillo.
Per mesi Lacan guida i suoi uditori. E a noi leggendo pare di stare lì, di partecipare all’evento. Merito, questo, di una perfetta alleanza tra chi ha curato il passaggio dall’oralità alla scrittura, e ciò che era phoné ha trasformato in gramma, stabilizzando così un testo instabile. E chi nel tradurre ha saputo mantenere quel brusio ininterrotto, quell’infinito intrattenimento di una parola che, nello sforzo di acchiapparsi in quel che prova a dire, discorre secondo un moto ondoso. Non si era mai letto così bene Lacan. In un italiano altrettanto chiaro, limpido, mosso, secondo un movimento allegro andante con misura che allena la mente di chi legge all’esercizio del pensiero. Il che dovrebbe, chissà!, demolire le false resistenze di chi si protegge dall’incontro con Lacan invocando a pretesto difficoltà astruse, impervi concettismi.
Non c’è niente di astruso qui, provare per credere. C’è invece la straordinaria impresa di qualcuno che legge il mistero della nostra esistenza di uomini e donne ora e sempre nel mistero della lingua, nella dimensione creativa della parola umana. Per questo Lacan riconosce che la cultura classica gli è essenziale. Se legge il Simposio, se di questo testo filosofico fa la materia del suo insegnamento, invece che, non so, di un trattato sul funzionamento delle cellule del cervello, è perché gli è chiaro che chi voglia anche un poco sbrogliare la complessità della mente umana dovrà ricorrere al pensiero. Nel riconoscimento del fondo emotivo in cui si innesta. Ci vuole Platone, per pensare il desiderio. Come ci vuole Apuleio per cogliere «il punto di nascita dell’anima».
E se rilegge Claudel è perché crede che nella lingua della letteratura può "cadere" qualcosa che altrove non si lascia afferrare. La lingua poetica è un rete che tira su molti pesci, per chi la sappia ascoltare. Se non altro per la sua specialissima dote di misurarsi con l’indicibile, l’inesplicabile - che non sono affatto paroloni, ma esperienze assai comuni della nostra esistenza - mantenendone il carattere di enigma. Dimostrando così, con semplicità, la profonda verità dei limiti del linguaggio, e con coraggio assumendosi, sempre la letteratura, la passione della "capacità negativa" di sopportare l’incondizionato, come avrebbe detto Heidegger. La lingua poetica attrae Lacan per lo stesso motivo.
Non a caso, qualche anno prima di queste lezioni, e precisamente nel 1955, tramite l’amico e paziente Beaufret, Lacan ha incontrato Heidegger. A quanto pare, e la cosa non stupisce, visti i complessi legami di cui Beaufret si fece perno, parlarono di transfert, come quella condizione a priori dell’esperienza analitica, a cui in queste lezioni Lacan torna. E sempre in quell’incontro si decise che Lacan avrebbe tradotto Logos, il commento di Heidegger a un frammento di Eraclito, dove a tema è la ricerca da parte del filosofo tedesco di un modo prefilosofico del pensiero. Il testo di Lacan apparirà nel primo numero de La Psychanalyse, da lui diretto, dedicato per l’appunto alla parola, così come opera nel campo della psicoanalisi.
Il linguaggio - è qui che cerca Lacan l’inizio di ogni cosa. In principio era il verbo, ripete al suo uditorio più volte durante queste lezioni. E’ il linguaggio che lega, ci lega: la creatura umana vi sta immersa come nel liquido amniotico. Un segno noi siamo, scriveva Hölderlin, che nulla indica; e Heidegger commentava: un segno senza interpretazione, nell’ambigua posizione di chi nel proprio cammino è attratto da quel che gli sfugge, gli si sottrae.
E’ questo l’enigma della nostra condizione, riconosce Lacan. C’è chi la sostiene, c’è chi ne patisce più di altri. Ogni patologia umana nasce di lì, più o meno. E se è vero che la psicoanalisi ruota intorno agli affetti rimossi, è anche vero che quegli affetti li coglierà come effetti del significante. Nel linguaggio.
Però, attenzione: per lo più l’affetto si slega dal suo proprio significante, perché è proprio dell’espressione umana l’equivoco carattere di mostrare e insieme di nascondere. Sì che l’intrinseca teatralità della parola andrà di volta in volta velata e rivelata. Interpretata, dunque. Non è lì per questo l’analista?
Ma perché l’interpretazione acchiappi qualcosa, chi ascolta dovrà essere istruito a farsi apparecchio uditivo che non registra quel che ode come fosse nel posto della legge. Per regolarne cioè l’iscrizione entro una classificazione di malattie, in cui risolve la sua maestria come fosse padronanza.
L’analista non è questo, per Lacan. Né uno psicoterapeuta, né un medico. Semmai, un chirurgo. O ancora meglio, in questo seminario si chiarisce che se v’è una figura a cui Lacan si ispira, un’immagine in cui si specchia, è quella di Socrate. Socrate - il sileno ricco di tesori - è la sua controfigura: il maestro senza maestro è lui. E come tutti sappiamo il vanto di Socrate è di non insegnare niente. Lui non ha altro desiderio che la domanda dell’altro.
Lacan parla. A chi? Perché? E’ lì per insegnare come si conduce un’analisi? O c’è dell’altro? Mai come in questo seminario, centrato sul transfert, la domanda sul desiderio campeggia, prendendo la forma di atti e movimenti quali ascoltare, lasciarsi trasformare; lasciare aperta in sé, dentro di sé, la disponibilità perché un altro essere entri, questa la scommessa e il rischio dell’analisi. Una situazione erotica, senz’altro. Che andrà a buon fine se l’analista e il paziente sapranno scambiarsi le posizioni di amante e amato, se il paziente saprà farsi amante, e lo psicoanalista saprà decadere dalla posizione di amato; e soprattutto se accoglierà in sé «una mutazione nell’economia del suo desiderio». Mutation - proprio questa parola usa Lacan. E fedelmente Di Ciaccia traduce "mutazione", trattenendo il senso biologico che Lacan intende. Se di una mutazione biologica si tratta, di essa è soggetto lo psicoanalista: un nuovo tipo d’uomo, capace di un «desiderio più forte». Più forte, viene da chiedere, di quello sessuale?
Ma se esiste un desiderio più forte, essendo Lacan freudiano, non potrà che essere quello di morte; ovvero, un desiderio che abolisce l’analista in quanto desiderante, e lo fa sparire come soggetto. E’ di questa morte - la morte dell’analista - che alla fine Lacan celebra il lutto in pagine meste, e coraggiose. La posizione dell’analista, rivela nell’ultima seduta del 28 giugno 1961, è al cuore della questione del transfert: e se prima l’ha descritta dal punto di vista del desiderio, perché di amore si tratta, ora la guarda da un altro verso e denuncia la «perfetta distruttività» del desiderio più forte, di cui ha dotato lo psicoanalista. Chi si avvinghia al transfert come fosse un potere, chi si arrocca nella posizione di colui che sa come si fa a mettere a posto l’altro, a dargli il suo bene, non ha compiuto il giusto percorso. Se c’è un epilogo, è dell’ordine del suicidio. Da parte dell’analista.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. ---- Lea Melandri, riprende il filo della rivista "L’erba voglio" e del femminismo ... e "riprende" a reinterrogarsi, ma sempre lasciando fuori dalla porta l’indicazione del-"la mente estatica".10 dicembre 2008, di Federico La Sala
 1968 - 2008
1968 - 2008
 il paradosso dei movimenti
il paradosso dei movimenti
 Relazione di Lea Melandri
Relazione di Lea MelandriIo vorrei portare l’attenzione su due movimenti -il movimento non autoritario nella scuola, la rivista "L’erba voglio", e il femminismo - a cui devo la nascita del mio impegno sociale e politico, un impegno che è rimasto inalterato nel tempo, nonostante siano passati quarant’anni, e che non avrebbe potuto avvenire altrimenti, data la mia estraneità alle forme organizzate della politica
di Lea Melandri *
Io vorrei portare l’attenzione su due movimenti -il movimento non autoritario nella scuola, la rivista "L’erba voglio", e il femminismo - a cui devo la nascita del mio impegno sociale e politico, un impegno che è rimasto inalterato nel tempo, nonostante siano passati quarant’anni, e che non avrebbe potuto avvenire altrimenti, data la mia estraneità alle forme organizzate della politica.
L’uscita da una dimensione solo privata della vita, che è avvenuta allora per me come per moltissimi altri, non posso che riferirla a un mutamento della politica stessa, che per la prima volta si avvicinava alla "quotidiana comune esperienza", interrogava l’origine sociale, ma anche il diverso destino toccato a un sesso e all’altro, apriva, come nel mio caso, figlia di contadini che aveva avuto il privilegio di poter studiare, la possibilità di rivedere con sguardo critico un percorso scolastico che aveva lasciato "fuori tema" una larga parte di vita, la più dolorosa, di mettere in discussione il ruolo di insegnante nel momento stesso in cui stavo per assumerlo.
Sono stati due movimenti che hanno prolungato la "lezione del ‘68" per quasi tutto il decennio anni ’70, quando già la "rivolta degli studenti" ripiegava verso forme più tradizionali della politica: i gruppi extraparlamentari, in tutto simili ai partiti, e la lotta armata. Forse è stata proprio questa durata, i conflitti che ha aperto in un fronte "rivoluzionario" che si voleva il più unitario possibile, sotto la bandiera delle lotte operaie, a far sì che vi cadesse sopra una dimenticanza sospetta, quella operata dalle ricostruzioni storiografiche, dalle ricorrenze e dalle mostre celebrative. Chi non ha dimenticato è la destra oggi al governo, che si accanisce a demolire alcune delle conquiste più significative di quella stagione "breve e intensa".
Non penso che la destra si stia accanendo contro un fantasma, ma neppure, al contrario che ci si trovi oggi di fronte a un "nuovo ‘68", evocato dal movimento in atto nella scuola e dalla comparsa sulle piazze di una generazione di femministe e lesbiche, decise a riportare l’attenzione sulla famiglia, come luogo in cui si consuma il potere più violento degli uomini sulle donne. Nella storia degli individui e delle società non esistono solo "repliche" cieche o cancellazioni definitive di ciò che si è già vissuto, ma anche "riprese" -quello che Elvio Fachinelli, uno dei più originali interpreti del ’68, ha chiamato «il paradosso della ripetizione»-, è cioè qualcosa che emerge dal passato e che, riproponendosi in un contesto diverso, si espone perciò stesso al cambiamento, a nuove vie d’uscita.
Dov’è dunque che vedo "riprese"? Innanzi tutto, ci sono analisi, intuizioni, da cui quei movimenti hanno preso avvio, e su cui hanno fondato le loro pratiche anomale, che appaiono oggi più attuali di allora. Nell’articolo Il desiderio dissidente , pubblicato sui "Quaderni piacentini" nel febbraio 1968, Fachinelli, distanziandosi sia dalla psicanalisi che dal marxismo, che avevano irrigidito la contrapposizione tra individuo e società, leggeva, nella società di massa, nel trionfo del consumismo, il declino dell’autorità paterna e l’emergere di figure più astratte e indeterminate del potere, ma soprattutto un fantasma più arcaico di «madre saziante e divorante», una società che prometteva liberazione dai bisogni, sicurezza, in cambio di dipendenza, servitù, rinuncia a sé come «progetto e desiderio».
Non è difficile constatare quanto questa tendenza alla passivizzazione, al consenso, all’integrazione in un sistema «il cui funzionamento è già previsto in anticipo», sia diventata il tratto dominante della nostra epoca, la "mucillaggine" in cui siamo immersi. La grande mutazione che si è profilata allora era lo spostamento dei confini tra privato e pubblico, rapporti e contaminazioni sempre più intensi tra poli tradizionalmente separati. L’uscita da ogni dualismo, a partire da quello tra maschile e femminile, corpo e linguaggio, biologia e storia, è stato, al medesimo tempo, l’esito di una società di massa, di mercato, di spettacolo, è l’acquisizione più importante dei movimenti che hanno tentato di controllarne lo sviluppo, volgerlo ad altri fini.
Dall’esperienza degli asili autogestiti venne allora l’idea che, per sradicare modelli precocemente incorporati, fosse necessaria una «politica radicale», capace di «andare alla radici dell’umano», dal femminismo la scoperta della politicità della sfera personale, e di tutte quelle esperienze che la storia, la politica, la cultura tradizionalmente intese hanno confinato nell’immobilità di un ordine naturale. Con una «scandalosa inversione», il racconto dell’esperienza, del vissuto del singolo, diventava più importante del linguaggio codificato della politica.
Non è un caso che, proprio in concomitanza con quello spostamento di confini, siano comparsi sulla scena pubblica soggetti "imprevisti", i giovani e le donne, e insieme a loro problematiche legate al corpo, alla sessualità, all’inconscio, esperienze essenziali dell’umano tenute in un lungo esilio. Al centro della politica si sono venuti a porre soggetti visti nella loro interezza -corpi pensanti, sessuati-, nella loro irriducibile singolarità e in ciò che li accomuna agli altri esseri umani. Nel momento in cui veniva recuperata alla politica la dimensione biologica, la memoria del corpo, cambiava anche l’idea di potere, di cui si cominciava a vedere l’aspetto più subdolo, più devastante: l’interiorizzazione precoce delle logiche di dominio e coercizione, l’inclinazione alla passività, alla delega, all’affidamento.
Combattere l’autoritarismo, dalla famiglia, alla scuola, alla società, ha significato allora mettere in discussione tutti i sistemi che creavano esclusione, competizione, disuguaglianza, a partire dalla divisone tra chi decide e chi esegue,e, per un altro verso, incentivare la presa di parola, l’esercizio collettivo del potere, pratiche liberanti, capaci di favorire in ognuno quella che Marx chiama la «passione dell’uomo», una «totalità di manifestazioni di vita umana».
Guardando la fiumana di bambini, maestre, madri, padri, insegnanti, studenti di ogni ordine di scuola, che si è rovesciata in questi ultimi tempi per le strade delle città, le assemblee, le lezioni all’aperto, l’intercambiabilità delle voci, la creatività delle forme di contestazione, viene da pensare che, sotterraneamente, sia passata un’acquisizione essenziale di quei movimenti: il far politica in prima persona, il rifiuto della delega, la ricerca di nuove forme di rappresentanza, un agire rispettoso dell’individuo e della collettività.
Ma c’è una contraddizione evidente. Oggi, saltati i confini tra sfera personale e sfera pubblica, le problematiche del corpo, della persona, del rapporto tra i sessi, hanno assunto un protagonismo e una centralità mai conosciuta prima, ma non nella direzione che avremmo voluto. Non sono venuti allo scoperto i "nessi", che ci sono sempre stati tra un polo e l’altro, e che volevamo fare oggetto della nostra ricerca, ma un "amalgama", un accorpamento preoccupante, indistinto tra sfera domestica e istituzioni pubbliche, casa e polis, azienda e Stato.
Le «acque insondate della persona», da cui era partito il femminismo, per costruire una cultura "altra", antagonista, capace si mettere in causa istituzioni «funzionalizzate a un sesso solo», sono diventate il terreno più fertile su cui crescono l’antipolitica, il populismo, la personalizzazione del potere. Il corpo, la sessualità, la donna, si sono emancipati ma "in quanto tali", cioè conservando i segni che vi ha impresso il lungo esilio dalla vita pubblica e la secolare "naturalizzazione": corpo-oggetto dei massimi poteri, corpo biologico e corpo rappresentato, esaltato immaginativamente dai media; donne presenti nella vita pubblica ma in gran parte ancora subalterne, impigliate negli stereotipi e negli habitus del maschile e del femminile.
La domanda che viene da porsi è: come mai un processo di cambiamento, che era stato portato allo scoperto con tanta lucidità, ha potuto sfuggire così vistosamente di mano, prendere strade indesiderate, giocare oggi a favore delle forze più insidiosamente autoritarie e conservatrici del paese? Perché le culture prodotte dal movimento libertario e dal femminismo, pur avendo molto da dire riguardo agli interrogativi del presente, sono così silenziose, così poco incisive?
Gli ostacoli, le difficoltà vanno cercate innanzitutto all’interno del proprio sviluppo, ma è innegabile che non poco ha contato l’arroganza distruttiva di una cultura di sinistra, fondata su una decisionalità quasi esclusivamente maschile, che ancora non riesce a mettere al centro la "vita intera", a prendere atto che, come già si leggeva sull’ "Erba voglio" molti anni fa, «la vita di un essere umano è più che il suo posto nella produzione; lo sappiamo per l’esperienza concreta iscritta in noi dalle ore passate a giocare, a fare l’amore, a ricordare, a dimenticare».
* Liberazione, 10/12/2008
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. ---- Freud, come Marx, le due grandi utopie del 900 (di Lea Melandri)11 gennaio 2009, di Federico La Sala
7 maggio 2006. L’intellettuale femminista rilegge il padre della psicoanalisi.
Subito dopo l’uscita del numero interamente dedicato ai 150 anni dalla nascita, Luca Bonaccorsi - attuale acquirente di "Liberazione" - chiese di destituire la curatrice dell’inserto angela azzaro
 Freud, come Marx, le due grandi utopie del 900
Freud, come Marx, le due grandi utopie del 900
 Davvero, Rifondazione, lo vuoi scaricare?
Davvero, Rifondazione, lo vuoi scaricare?di Lea Melandri (Liberazione Queer, 11.1.2009, p 3)
«Dal fondo del torpore, quasi dal sonno, un pensiero solitario. Dopo lo squarcio iniziale, la psicanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità...l’idea di un uomo che sempre deve difendersi, sin dalla nascita, da un pericolo interno.
Bardato. Corazzato. Dalla foresta appuntita delle difese non si esce. Ma invece accoglimento, accettazione, fiducia intrepida verso ciò che si profila all’orizzonte. Nausicaa, Ulisse. Le regge di Creta aperte verso il mare, senza difese...
Anche per la scoperta freudiana fu così? Un’accettazione di qualcosa che veniva, in certo senso, dall’esterno, dopo un estenuante brancolare? Bisognerebbe rileggere le origini della psicanalisi da questo punto...Il sogno osa generalmente di più di quanto si permetta il sognatore da sveglio. Di qui l’idea di Freud di trasferire questo oltrepassamento alla coscienza vigile nella cura dei nevrotici. Il sogno testimonia di ciò che vuoi essere - ciò che puoi essere, allora» (Elvio Fachinelli, La mente estatica , Adelphi 1989).
Forse l’invenzione, scientifica o non scientifica, procede sempre con un movimento analogo, che è allentamento di difese, abbandono al fantasticare, defluire di frammenti, sprazzi di idee, da cui emerge un messaggio inatteso, un pensiero più organizzato e coerente. Ma non possono non colpire le risonanze profonde tra un geniale interprete di Freud, quale è stato Elvio Fachinelli nel momento in cui si accingeva, avendo se stesso "come unica bussola", a esplorare quell’ "area di frontiera" che è per ogni essere umano l’originaria indistinzione con la madre, e il singolare "conquistador" che nell’ultimo decennio dell’800 cominciava a inoltrarsi, "primo tra i mortali", in regioni inesplorate della vita psichica.
A Wilhelm Fliess, l’"amico segreto" con cui intrattiene uno scambio intenso, intellettuale e, pur nella castità, dichiaratamente amoroso, nel periodo più originale della sua scoperta - gli studi sull’isteria, l’autoanalisi, l’interpretazione dei sogni - Freud scrive: «Posso guarire solo lavorando con l’inconscio: con sforzi esclusivamente coscienti non posso farcela... uno strano stato mentale che la coscienza non riesce ad afferrare; pensieri crepuscolari, la mente offuscata, appena un raggio di luce qua e là».
«In una giornata come e come oggi tutto tace dentro di me e io mi sento terribilmente solo...bello attendere che qualcosa cominci a muoversi dentro di me e che io riesca ad accorgermene. Perciò spesso sogno per giorni interi».
«Mi sono aiutato col rinunciare a qualsiasi sforzo mentale cosciente, in modo da affrontare i problemi a tentoni. Da allora ho lavorato forse meglio di prima, ma quasi non so quel che sto effettivamente facendo».
«Io non sono né uno scienziato né un osservatore né uno sperimentatore né un pensatore. Non sono altro che un conquistador per temperamento - un avventuriero, se volete tradurre il termine - con la curiosità, la baldanza e la tenacia propria di quel genere di individui».
Nel momento in cui rinunciano a tradurre "in modo razionale e scientifico" il misterioso mondo della psiche, per cimentarsi nell’"eroica impresa" di esplorare il proprio inconscio, fin nelle regioni estreme verso cui li spinge "la passione per il preistorico", sia Freud che Fachinelli operano, sia pure in contesti storici diversi, un rovesciamento di prospettiva. Ne sono investiti e trasformati in eguale misura: l’io onnipotente della ragione tecnica e burocratica, la coscienza certa di non avere alle spalle che il deserto del senso, la cultura occidentale avviata al dominio del mondo, e la figura di una maschilità distorta dall’abitudine millenaria all’offesa e alla difesa. Indagatori entrambi della felicità, a partire dalle sue misteriose radici nell’infanzia, curiosi dell’origine e della natura degli umani, disposti a imbarcare la ragione "nel mare procelloso del mondo emotivo", non potevano non approdare a verità ambigue, contraddittorie, sfuggenti a interpretazioni lineari e sistematiche, reperti di un passato mai del tutto estinto e, nel medesimo tempo, segnali di insospettate potenzialità antropologiche.
La scoperta dell’inconscio, e dei modi per aprirgli uno spiraglio dentro i territori della coscienza, era destinata a produrre un radicale ripensamento di quell’"enigma del dualismo" che, quasi negli stessi anni, Otto Weininger si affrettava a riportare sulle solide fondamenta della cultura occidentale, greca e cristiana. Freud si muove ancora dentro la cornice di opposizioni complementari - biologia e psicologia, vita e anima, corpo e mente, realtà e sogno - e cerca per tutti gli anni del suo maggiore sforzo esplorativo della vita psichica l’armonioso completamento di parti maschili e femminili di sé - e quindi della "fecondità" creativa - nella "gioia smisurata" che gli danno gli incontri con Fliess.
«Mi era necessario amarti per poter arricchire la mia vita. Nessuno può sostituire i rapporti con un amico che un lato particolare di me stesso - forse femminile - richiede». Fliess è, rispetto a Freud, colui che sa, che dà, che può appagare la fame e la sete di chi vive nell’attesa di riempire un vuoto, di ricevere incoraggiamento, consolazione, consigli.
Ma, al di là dell’aspetto più evidente del loro rapporto - in cui si mescolano le figure complementari di una sedotta e di femminili e maschili scambievoli - si profila oscuramente una situazione più complessa, destinata a gettare una luce nuova sul rapporto tra i sessi e sul legame profondo che ha tenuto insieme per millenni una comunità storica di soli uomini.
Lo svelamento non poteva che avvenire attraverso lo sguardo dell’esploratore che, con uguale ardimento, a distanza di un secolo, si addentra nello stesso paesaggio e mostra quello che l’altro non poteva ancora vedere. Nella rilettura del rapporto tra Freud e Fliess, Fachinelli scrive: «L’attesa sembra rivolta a una figura resuscitata: quella della prima madre, el sesso (il riferimento è alla vecchia bambinaia che, scoperta a rubare, sarà cacciata dal fratellastro Phillip). L’incontro con Fliess l’ha fatta tornare e Fliess dovrebbe saziare una fame non saziata, colmare un vuoto che si creò allora bruscamente... Siamo qui nell’ambito di un rapporto di compenetrazione con una particolare figura materna... Vi è un sovrappiù, un acme di godimento, qualcosa che si collega a un "desiderio preistorico", l’unico che generi felicità secondo Freud».
Ma è proprio questa "gioia smisurata" a far sorgere l’immagine dell’assorbimento nell’oceano materno, a costituirsi come minaccia per la propria identità. Dietro il sogno realizzato della fusione col primo oggetto d’amore, si profila l’ombra della pulsione di morte, cessazione di ogni tensione, cioè della vita stessa. «Come segno di compromesso -scrive sempre Fachinelli - tra tendenze all’unità e tendenze all’individuazione, affiora la figura del doppio, del gemello, dell’alter. Basta qui una sola citazione: "Non posso fare a meno di un altro, l’unico altro, l’alter, sei tu"».
Il femminile conosciuto dall’uomo nella "beatitudine", sia pure solo sognata, di un’originaria indistinzione, è ciò da cui si fugge ma è anche nel cuore dell’amore e odio per la persona dello stesso sesso. A distanza di un secolo, nel punto più alto dello sviluppo tecnologico e industriale, la preistoria parla con la stessa lingua, ma il paesaggio e i suoi protagonisti appaiono dislocati, i contorni meno nitidi, i fantasmi più vicini alla coscienza che li ha prodotti. Il mutamento più significativo riguarda la figura del padre, che già nell’autoanalisi Freud era venuto decantando.
Dopo aver ipotizzato una seduzione da parte dell’adulto di sesso maschile nella genesi delle nevrosi, Freud si accorge di aver piegato la teoria alle sue fantasie, e da quel momento affiorano altri rapporti con fratelli, nipoti, soprattutto con due figure materne, la madre reale e la vecchia bambinaia, e il fratellastro Phillip, collocato nei sogni al posto del padre. A muoversi dentro un’imbrogliata vicenda famigliare è il Freud-figlio, prossimo a quella che considera l’unica felicità possibile e, nel medesimo tempo, la "terra promessa" in cui non potrà entrare. Il "complesso di Edipo" si può pensare allora che intervenga, come osserva Fachinelli, come "ideale regolatore", destinato a fare un po’ d’ordine nella grande confusione, a ridare una certa importanza e centralità alla figura di Jacob, il padre di Freud morto nel 1896, poco prima che Freud cominciasse la sua autoanalisi.
Nella zona più remota e inesplorata della preistoria degli umani non poteva che esserci il corpo femminile da cui si nasce, la memoria di un’appartenenza intima che entrambi i sessi hanno conosciuto, i segni di un desiderio sessuale che li accomuna, indipendentemente dal diverso destino che la storia ha loro assegnato. Se prima dell’autoanalisi, negli Studi sull’isteria, Freud aveva creduto di trovare l’origine della malattia nell’incompatibilità tra pulsioni sessuali e "purezza morale" delle donne prese in cura, nel Caso Dora riconosce, sia pure alcuni anni dopo che la giovane paziente aveva interrotto l’analisi, il suo "errore tecnico": non aver detto in tempo alla malata «che il suo impulso erotico omosessuale con la signora K. era la più forte delle sue correnti psichiche inconsce». Se la madre è per entrambi il primo oggetto d’amore, come giunge la bambina a rinunziarvi e ad assumere invece il padre come oggetto? Questa "svolta" verso l’uomo, «necessaria al mantenimento del matrimonio in una società civile », concludeva Freud, potrebbe per molte donne non avvenire mai.
L’affermazione "l’anatomia è il destino", con cui sembra voler dare un fondamento biologico alla differenza tra i sessi, può essere letta allora, non diversamente dal "complesso edipico", come l’extrema ratio di un osservatore che ha visto cadere ad una ad una ragioni preconcette, l’ultimo appiglio a quella visione del mondo che il suo nuovo sapere stava mettendo alle corde.
Negli anni ’70, sia il movimento antiautoritario, che scopriva la necessità della politica di "andare alle radici dell’umano", l’influenza decisiva delle esperienze infantili sui sistemi sociali, sia il femminismo che riportava l’attenzione sul corpo e sulla sessualità cancellata delle donne, hanno riservato a Freud la stessa critica repressiva, patriarcale e autoritaria, proprio nel momento in cui appariva chiaro il declino della figura paterna, l’emergere, dietro al consumismo di massa, di un fantasma materno saziante e divorante. Strano, ingiustificato destino per l’intrepido "avventuriero" che, con angoscia, vergogna, tentennamenti, aveva osato penetrare il "rimosso" innominabile della storia dei padri, sfidare i rigidi codici del rigore scientifico, affinché la sua grande scoperta, la "cura delle parole", lasciasse parlare l’umano in tutta la sua complessità.
«Le storie cliniche che scrivo si l’impronta rigorosa della scientificità... una rappresentazione particolareggiata dei processi psichici, quale in genere ci è data dagli scrittori...Mi servo di una serie di similitudini, mi prendo la libertà di fare uso di paragoni... mi guida l’intenzione di rendere intuibile una situazione mentale estremamente complessa e mai sinora descritta» (Breuer, Freud, Studi sull’isteria ).
Mai il pensiero e la vita, la parola e il corpo sono parsi vicini e indisgiungibili come nella lettura che Freud fa dei sintomi isterici: un archivio di simboli, idee, esperienze allontanate dalla coscienza, perché troppo dolorose, torna a partecipare al discorso, a raccontare attraverso segnali corporei le storie di sofferenze sepolte, mai registrate. Il "demone" che ora irrigidisce ora agita oltre misura i corpi delle isteriche, se va talvolta a collocarsi sotto il segno di un male da estirpare - "cavità purulenta", "camino da spazzare" - nella maggior parte dei casi viene accolto, attraverso le fessure che gli apre la coscienza, come irruzione di energie intellettuali e psichiche sorprendenti, messaggere di individualità femminili a venire, di cui Freud sembra avere un’oscura ma inequivocabile percezione.
La scoperta della sessualità infantile e dell’influenza che ha la preistoria degli umani sulle sedimentazioni inconsce della vita psichica, non poteva che affiorare all’animo inquieto di un uomo- figlio; l’analisi in chiave psicologica dell’isteria, l’attenzione straordinaria, partecipe e lungimirante con cui Freud si addentra nelle inedite storie delle sue pazienti, sarebbe inspiegabile senza quel movimento parallelo che piega lo sguardo su di sé, su quella "parte femminile" che l’uomo tiene celata dentro la corazza della virilità, e su cui ha continuato a costruire fisionomie immaginarie dell’altro sesso. Se è l’uomo di scienza, il medico, l’appassionato esploratore della mente umana, che vede nella sessualità - identificata con la donna, la famiglia - una "stirpe" che la civiltà ha asservito alle sue "sublimazioni", non c’è dubbio che è la tenerezza filiale a voler vedere come "esente da ambivalenze" il rapporto madre-figlio, a fare dell’unità a due dell’origine il modello di ogni felicità, a leggere nelle carezze di una madre "antiche aspirazioni sessuali" inibite o scoraggiate dalla violenza maschile.
L’idealizzazione dell’Eros nella sua forma primordiale, dove ancora si confondono l’Io e il suo oggetto d’amore, impedisce a Freud di accorgersi quanto abbia a che vedere con il "rifiuto della femminilità" la pulsione di morte che si accompagna all’abbraccio-inglobamento materno; è quella che lo induce a ritenere "naturale" il riserbo, la purezza morale, la dedizione della donna a padri, mariti, figli, la cura dei malati, a scapito della propria persona.
Ma è per la stessa ragione che, paradossalmente, Freud arriva a intuire che non è genericamente la sessualità repressa, tenuta a bada dalle convinzioni morali, a provocare la malattia, bensì la sessualità violenta, che decide deldel destino della donna. La "non comune intelligenza", l’"acuto spirito critico", il talento, l’ambizione, lo spirito di indipendenza, la combattività, che nota nelle sue pazienti, non incontrano solo l’ostacolo di pulsioni sessuali incanalate in disturbi corporei, ma urtano in modo più diretto e consapevole con una sorte decisa da altri, che toglie loro i piaceri più elementari, che fa del dovere, della moralità, del sacrificio, l’unica via praticabile per avere riconoscimento e autostima. Contrastano, soprattutto, con la solitudine e il bisogno d’amore a cui sembra condannata la donna che non si piega alla sottomissione, alla violenza sessuale e psicologica a cui la costringe quasi sempre il matrimonio: «Effettivamente essa era molto scontenta del suo stato di ragazza, era piena di progetti ambiziosi, voleva studiare o perfezionarsi nella musica, si ribellava al pensiero di dover sacrificare in un matrimonio le sue inclinazioni e la sua libertà di giudizio».
«...il senso di non poter mai, come ragazza sola, godere qualcosa della vita o fare qualcosa nella vita. Fino ad allora essa si era creduta forte abbastanza per poter fare a meno dell’aiuto di un uomo, adesso si impossessava di lei il sentimento della sua debolezza femminile, una nostalgia di amore sulla quale la rigidezza del suo carattere cominciava a sciogliersi».
«La tendenza a respingere ciò che è sessuale viene ulteriormente rafforzata dal fatto che l’eccitamento sessuale nella vergine ha una componente di angoscia, il timore dell’ignoto, del presagito, di quel che verrà, mentre nel giovane maschio sano e naturale è una pulsione nettamente aggressiva. La fanciulla presagisce nell’Eros la terribile potenza che ne domina e decide il destino ed è angosciata da essa... Il matrimonio porta traumi sessuali...la prima notte... tanto spesso non è una seduzione erotica, bensì uno stupro... non credo di esagerare affermando che la grande maggioranza delle nevrosi gravi nelle donne proviene dal letto matrimoniale».
Sulla strada del suo avventuroso viaggio nel mondo ignoto della vita psichica, Freud non poteva non incontrare prima di tutto il sesso che la storia ha identificato con le sue origini - corpo, animalità, sessualità, infanzia - e cioè la donna, ma non avrebbe potuto leggere così a fondo nelle vicende e passioni contraddittorie dell’esistenza femminile se non avesse scoperto quasi contemporaneamente in se stesso il protagonismo del corpo, dell’infanzia, dell’immaginario sessuale, di un "preistorico", esclusivo, e perciò tirannico, modello di felicità.
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ---- La caverna di Blumenberg (di Bruno Accarino).5 luglio 2009, di Federico La Sala
IL LUNGO APPRENDISTATO ALLA MODERNITA’
La caverna di Blumenberg
Uscito per Medusa il saggio di Hans Blumenberg su Platone. Un’opera dove il filosofo tedesco muove dall’elaborazione antropologica sulla natura umana per giungere alla conclusione che la ricerca della verità sia un viaggio senza meta finale e con molte soste dovute alla contingenza della vita sociale
di Bruno Accarino (il manifesto, 4 luglio 2009)
Paghiamo subito un debito di gratitudine: alla casa editrice Medusa, al traduttore Martino Doni e al curatore Giovanni Leghissa, che ci offrono in edizione italiana Uscite dalla caverna di Hans Blumenberg (Medusa edizioni, pp. 648, euro 65). Siamo in debito per l’accuratezza, mista a un pizzico di follia, con cui è stata realizzata un’impresa che avrebbe fatto tremare i polsi a chiunque. Quando il nostro paese, da sempre esterofilo e perfino un po’ nevrotico nel tradurre tutto e tutti, sarà stato definitivamente travolto dal ciarpame mercatistico che classifica come orripilanti diseconomie le scienze dello spirito, guarderemo con nostalgia a quegli ultimi bagliori di lungimiranza che hanno reso disponibili nella nostra lingua una serie impressionante di testi classici e meno classici. Pagato il debito, cerchiamo il bandolo della matassa nelle ultime pagine: quelle in cui Blumenberg intensifica gli interessi antropologici a stento repressi nel corso della sua vita, lasciando intendere che d’ora in poi, cioè dal 1989, avranno un ruolo assolutamente prioritario. Il che è stato puntualmente confermato dalle opere postume finora apparse.
Il mito platonico della caverna, attorno al quale ruota l’avvincente catena di digressioni e di diramazioni che compone il libro, ha poco a che fare con i cavernicoli. I cacciatori e i raccoglitori potevano sfruttare le caverne solo di passaggio, in condizioni nelle quali la transizione dal nomadismo alla sedentarietà richiedeva un cumulo di circostanze insolitamente favorevoli. Le caverne erano abitate, in epoche a cui noi siamo soliti associare la figura del cavernicolo, in modo sporadico e fugace, al punto che il mito di Platone non ha alcun titolo per disegnare l’immagine generale del progresso: il superamento delle ombre e l’uscita alla luce. Ma perché si pensa sempre alla fuga dalla caverna e non anche alla fuga nella caverna?
Se l’imperativo dell’esistenza umana è lo stare alla larga dalla realtà, o il difendersi, come suona la formula famosa del Blumenberg studioso del mito, dal suo assolutismo, la caverna è uno stratagemma non accidentale, qualcosa di più di un riparo fortuito. Blumenberg parla di uno spostamento del baricentro dalla metafisica o dall’ontologia verso l’antropologia. Solo questo spostamento consente di mettere a fuoco la profonda razionalità di chi si rifiuta di abbandonare la caverna e si oppone all’attrattiva esterna di verità superiori. Perché, in altri termini, colui che riesce a uscire e torna nella caverna per «liberare» i suoi compagni trova solo diffidenza ed è perfino vittima di un’aggressione? Perché fallisce la strategia della paideia e che cosa c’è dietro alla riluttanza all’insegnamento? L’avversione a una conoscenza superiore e definitiva tradisce la percezione di un rischio. Chi esce abbandona una forma di esistenza divenuta familiare e perciò scevra di pericoli: ci si lascia alle spalle - si può chiamarlo solo così - un mondo della vita.
Ammaestrati alla conoscenza
Ammaestrati - è il caso di dire - dai benefici presunti della paideia, sappiamo facilmente enumerare i vantaggi acquisibili da chi fugge dalla caverna. Ma siamo in grado anche di fare il censimento delle fregature a cui va incontro? Sulle orme di Arnold Gehlen e per altri versi di André Leroi-Gourhan, l’abbacinamento dello sguardo che colpisce l’abitante della caverna classica viene interpretato come il corrispettivo di un profluvio di stimoli che non può essere padroneggiato: finché il subominide può contare su segnali che sono in sintonia con il suo corredo organico, non conosce il disorientamento che colpisce chi capita in un mondo privo di segnaletica perché infinito. Gli involucri e le gabbie non solo non ostacolano, ma assecondano il programma biologico degli umani.
Il capolavoro della caverna fu l’invenzione della fantasia, e qui essa trovò anche le energie per spingersi ben oltre la mera soglia dell’autoconservazione. Se l’abitante della caverna non si fosse opposto all’aperto, alla smisuratezza dell’esterno, al territorio del cacciatore e del raccoglitore, del coltivatore e del nomade, essa sarebbe stata solo una dimora. Ma la sua tensione a de-naturalizzarsi, a installarsi nel mondo dell’artificialità, promuove una candidatura di livello superiore: quella tesa a favorire la «cultura della cura». Fu così che, passando per la caverna, «l’uomo divenne l’animale sognante»: e più propriamente fantasticante. Nella caverna ci si immagina ciò che non è dato e, invece di dar vita ad una impari colluttazione con la realtà, si opta per ciò che è assente: se ci si ritira dalla realtà, si può però sempre disporre dell’immagine, del simbolo, del nome e infine del concetto.
Gli antieroi del superfluo
Certo, bisogna pensare a strumenti inizialmente magici e non razionali, ma qualcosa di straordinario succede: i deboli, inetti alla caccia e alla predazione, rimangono dentro sperimentando il meccanismo della compensazione. Con la fantasia rappresentano qualcosa di non visto, raccontano qualcosa di non vissuto, costruiscono trame narrative da antieroi del superfluo. I cacciatori pensano alla sopravvivenza, quelli che non vanno fuori mettono a punto le strategie di un superfluo che ben presto sa farsi necessità. Come tutti gli esponenti - a cominciare da Peter Sloterdijk - della più recente e smaliziata antropologia filosofica, Blumenberg non ha dubbi sul fatto che il segno fondamentale dell’antropogenesi sia il lusso, non l’indigenza. E il primo tratto del lusso è la distanza: i deboli si appropriano di un’operatività in absentia et per distans, magari progettando trappole che facciano il loro mestiere senza essere presidiate e senza il loro intervento. Fu su questa base che si fecero largo la parola e l’immagine, le due diavolerie deputate a scansare i contatti diretti e gli scontri frontali con la realtà. Quanto a quelli che escono, e che non possono schivare né gli né gli altri, è per loro importante trovare sempre aperta la via del ritorno a «casa»: al clima confortevole che la domesticazione della caverna ha saputo determinare.
Mai più la fantasia avrebbe trovato una tale, intatta pienezza di possibilità, un momento così irripetibile di grazia e di felicità: al punto che tutti i nostri ritorni nella caverna, immaginari o fisicamente e architettonicamente reali che siano, sono un tentativo di riguadagnare una ricchezza che viene percepita come ormai sminuzzata e mortificata. Gli intellettuali, ereditando il ruolo di chi ha saputo così brillantemente gestire il rapporto tra il reale e il possibile all’interno della caverna, devono produrre una narratività che ha comunque smarrito l’opulenza della fantasia cavernicola. Il fascino immortale del mito di Platone non dipende dalla sua collocazione nella gerarchia dei suoi miti, né dal messaggio didattico-illustrativo, ma dalla sua capacità di poter riproporre nei luoghi più impensati una domanda radicale sulll’origine e sul destino degli uomini.
Il dominio del presente
Troppo raffinato per lasciarsi andare, con un corto circuito improvviso e improvvisato, a qualche proclama da sociologia dell’attualità, Blumenberg non è però reticente nel far intendere che gli universi mediatici nei quali siamo immersi, annaspando, rimasticano spesso le problematiche cavernicole dell’autogestione dell’esistenza. Nelle pagine su Jean-Paul Sartre come «fenomenologo della contingenza» si incontra il cinema: i giochi d’ombre dei moderni propongo il dominio delle arti proiettive, a cui il filosofo sfugge, come racconta in uno dei suoi interventi autobiografici, uscendo in strada. Dove però trova la contingenza e non, platonicamente, la verità: nel cinema la contingenza è assente - così Sartre -, lì tutto è necessario perché il cinema è una caverna che ha nella città il suo mondo esterno.
Il trauma originario non è per Blumenberg quello individuale della nascita, ma quello evolutivo della postura eretta. È all’altezza di quello stadio dell’evoluzione che un essere vivente scopre possibilità inedite di vedere, ma impatta con l’angoscia che si accumula in chi è visibile. Lo sguardo altrui: non poteva capitare niente di peggio, e non solo perché si moltiplicano le possibilità di essere aggrediti da quando si è molto più esposti dei quadrupedi. È allora che la parola-chiave Geborgenheit, che ha il dono di miscelare ascosità e sicurezza, nascondimento e protettività, comincia a mulinare soluzioni disparate: quelle escogitate dalla razionalità illuministica, con il suo appello a far sempre più luce, sono tutto sommato minoritarie e non durature.
La via che porta fuori dalla caverna non era stata sponsorizzata a scatola chiusa nemmeno dai greci, che non ignoravano la potenza dei misteri, dei riti di iniziazione, dei culti orfici, e potevano così apprezzare il senso della svolta all’indietro, sulla via del ritorno alla caverna. Le caverne sono accreditate di custodire l’antica sapienza e fungono da rifugio per i vinti, pronte ad ospitare la densità dei misteri più che la chiarezza deludente della conoscenza. Platone avrebbe potuto anche fare a meno di immaginare che i prigionieri della caverna fossero incatenati, stante il fatto che i veri ceppi della caverna sono le sue pareti, che non solo lasciano un’unica uscita, ma ostruiscono, respingono e rinviano ciò che preme contro di esse per sfondarle.
Turista e disincantato
Anche la brama esplorativa, allora, può conoscere battute a vuoto. La curiositas, una delle figure trainanti de La legittimità dell’età moderna, il libro a cui è legata la fama mondiale di Blumenberg, è sottoposta qui ad una declinazione diversa. Come non può fare a meno di osservare il gesuita spagnolo Baltasar Gracián (1601-1658), chi esce dalla caverna entra in un processo realistico e va incontro alla delusione di un mondo che non soddisfa le aspettative di chi nella caverna si è cimentato con una sorta di apprendistato.
Lo stupore e la meraviglia non mancano, ma per quelli che hanno deciso di uscire hanno un che di irreale, perché continuano ad operare gli effetti protettivi della caverna, che sono comparativamente gli unici ad essere reali. Dopo qualche giorno, lo stupore e la meraviglia sono condannati a scemare, sopraffatti dall’abitudine, e anzi lo stupore fa posto al terrore che sorprende il turista della mondanità: se entrare nel mondo, commenta Blumenberg, vuol dire imparare l’arte di vedere, guadagnare la distanza da esso è l’arte del tornare a non vedere, di ridurre l’attenzione.
In termini biologici, alla riduzione dell’attenzione corrisponde la riduzione dell’attività cerebrale resa possibile dal sonno profondo e non molestato che è tipico delle caverne primitive, in quella che può essere pensata come l’origine più libera da perturbazioni di tutta la storia umana. Non occorre neanche pensare alle complicazioni psicoanalitiche del sonno come succedaneo della prenatalità, basta fare l’esperimento mentale di questo unicum immunitario per capire che è irrinunciabile. Fuggire dalla caverna e soddisfare la curiosità? E chi ce lo fa fare?
-
> LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. ----Claustrofobia è un concetto che si usa poco in politica, eppure è proprio questo che provocano i regimi chiusi e totalitari, a diversi gradi del loro insediamento (di Beppe Sebaste - I carcerieridi Durrenmatt).1 dicembre 2009, di Federico La Sala
I carcerieri di Dürrenmatt
di Beppe Sebaste (l’Unità, 01.12.2009)
Claustrofobia è un concetto che si usa poco in politica, eppure è proprio questo che provocano i regimi chiusi e totalitari, a diversi gradi del loro insediamento. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: chiusura, appunto, omogeneizzazione, ripiegamento sulla propria identità; identità che, a diversi livelli di fascistizzazione, si basa sulla comunanza del suolo oppure del sangue. L’appartenenza religiosa ha pure un ruolo importante in questa marca di identità.
In Svizzera, storicamente terra d’asilo e di rifugiati politici e religiosi, dove un referendum populista ha proibito l’edificazione di minareti, nel 1990 il grande Friedrich Dürrenmatt pronunciò un discorso d’indimenticabile e feroce ironia contro la politica claustrofobizzante del suo Paese. Descrisse la Svizzera come una paradossale prigione nella quale gli svizzeri sono carcerati e al tempo stesso carcerieri di se stessi, «per dimostrare la propria libertà». In tale prigione, disse, «gli Svizzeri si sono rifugiati (...) perché soltanto lì essi sono sicuri di non essere aggrediti».
Vale la pena di ricordare alla lettera un passo del discorso di Dürrenmatt: «C’è un solo problema in questa prigione, quello di provare che non è una prigione ma il rifugio della libertà, poiché, dall’esterno, una prigione è una prigione e quelli che sono dentro sono carcerati, e chi è carcerato non è libero: agli occhi del mondo esterno, solo i carcerieri sono liberi, poiché se non fossero liberi sarebbero carcerati. Per risolvere questa contraddizione i carcerati hanno introdotto l’obbligo generale di essere guardiani: ogni carcerato dimostra di essere libero facendo lui stesso il proprio carceriere. Ciò che dà agli svizzeri il vantaggio dialettico di essere al tempo stesso liberi, carcerati e carcerieri».
Le sue parole valgono oggi più che mai per l’Italia, da quando a fare le leggi c’è un paradossale «Popolo delle libertà», guidato dai carcerati-carcerieri della Lega. Non so voi, ma la ma claustrofobia sta superando il livello di guardia.❖
-
-
-
-
-