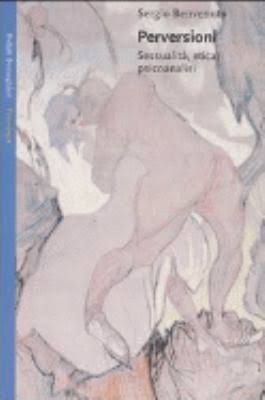
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. Un omaggio a Elvio Fachinelli - di Federico La Sala
PERVERSIONI: Sessualità, etica, psicoanalisi*.
- Sergio Benvenuto, Perversioni. Sessualità, etica, psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 2005, pp. 189.
Che l’Essere sia o non sia, non è un problema ontologico - come sempre si è creduto, ma un problema morale ed etico! La Verità esiste, e infinite sono le sue versioni. Ma come si chiamano quelle che negano (in senso freudiano) la realtà e pretendono di dire tutta la verità nient’altro che la verità?! Che cosa sono, se non altro che per-versioni!? Questa la radice del problema.
Benvenuto lo sa e cerca di mettere a soqquadro tutto, per uscire dal labirinto e dal regime della ‘Normalità’, della Per-versione ‘Vera’! La questione è antropologica, edipica ... e riguarda tutta la Città (Tebe, come Tokyo, Roma come New York, Madrid com Pechino, ecc.) e tutto il nostro sapere. Edipo ha saputo sciogliere l’enigma della Sfinge... ma la peste continua a mietere vittime! La questione non è risolta... e se è un problema di “gelosia” (come già Freud, e come ripete ancora lo stesso Benvenuto: “che è il cuore dell’Edipo”, pp. 41-42), bisogna capire che la gelosia di Edipo non è originaria né originale, è una ‘risposta’ alla gelosia già presente nella camera del re e della regina, del padre e della madre - di quell’uomo e di quella donna che sono i suoi genitori!
Se per il passato la relazione Madre-Figlio diede luogo alla tragedia, non possiamo dire che la relazione Padre-Figlia (il cattolicesimo-romano) ci abbia portato alla “commedia” - come voleva Dante! Il Figlio - l’uomo e la Figlia - la donna devono riprendere il cammino e cercare ancora.... il loro ‘Padre’!
Tre metri sopra il cielo - Benvenuto rompe gli indugi e sollecita a ‘saltare’: omnia munda mundis o meglio, nell’ottica della pratica zen, prima dell’illuminazione le perversioni sono perversioni, dopo l’illuminazione le perversioni sono perversioni. Cosa si vuol dire? Semplicemente, che Benvenuto, sia pure con ambiguità ed esitazioni, si getta al di là di là del narcisismo (il personale è politico, e viceversa!) e ci presenta il risultato di un lavoro (nonostante tutto) eccellente, segnato proprio dall’illuminazione, vale a dire, da una (auto)coscienza ‘adulta’ (in senso forte), aperta all’altro e alla luce del Sole.
Per chiarire e far capire meglio, citiamo:
- “Non è l’oggetto anatomico desiderato a fare la perversione, ma direi, la presenza o meno della cura dell’altro come soggetto di desiderio.
 Insomma, l’atto sessuale - sottolinea l’autore - non perverso è quello in cui si mostra carità per l’altro. Caritas nel Medioevo non significava fare opere di beneficenza, bensì ‘amore’ in quanto distinto da amor, il trasporto sessuale. [...] Per avere un coito decente ci vogliono sia amor che caritas. E questa carità è provare com-passione per il desiderio dell’altro, è sentirsi chiamati a rispondere all’attrazione e al bisogno che l’altro ha di noi, e quindi andargli in soccorso. Il coito, come carità compassionevole, è atto etico per eccellenza (non a caso la Chiesa cattolica ha elevato il coito a sacramento: se fatto nelle dovute forme è il matrimonio).
Insomma, l’atto sessuale - sottolinea l’autore - non perverso è quello in cui si mostra carità per l’altro. Caritas nel Medioevo non significava fare opere di beneficenza, bensì ‘amore’ in quanto distinto da amor, il trasporto sessuale. [...] Per avere un coito decente ci vogliono sia amor che caritas. E questa carità è provare com-passione per il desiderio dell’altro, è sentirsi chiamati a rispondere all’attrazione e al bisogno che l’altro ha di noi, e quindi andargli in soccorso. Il coito, come carità compassionevole, è atto etico per eccellenza (non a caso la Chiesa cattolica ha elevato il coito a sacramento: se fatto nelle dovute forme è il matrimonio).
 Dire che il coito è un atto di carità compassionevole rischia di muovere al riso [...] Ma ci rendiamo presto conto che senza carità compassionevole - anche il più ligio alla norma eterosessuale - prende una coloritura perversa, cioè appare come uso dell’altro in quanto soggetto che non è fine ma mezzo di piacere.
Dire che il coito è un atto di carità compassionevole rischia di muovere al riso [...] Ma ci rendiamo presto conto che senza carità compassionevole - anche il più ligio alla norma eterosessuale - prende una coloritura perversa, cioè appare come uso dell’altro in quanto soggetto che non è fine ma mezzo di piacere.
 La premessa eminentemente intersoggettiva del rapporto sessuale è del resto evidente: è nella misura in cui l’altro (uomo o donna) mi desidera o trae piacere da me che io sono disposto/a a desiderarlo/a e a trarne piacere. Ciò che eccita eroticamente è il riflesso del proprio desiderio nell’altro; ma questo riflesso implica il riconoscimento ipso facto della soggettività dell’altro”(p.36).
La premessa eminentemente intersoggettiva del rapporto sessuale è del resto evidente: è nella misura in cui l’altro (uomo o donna) mi desidera o trae piacere da me che io sono disposto/a a desiderarlo/a e a trarne piacere. Ciò che eccita eroticamente è il riflesso del proprio desiderio nell’altro; ma questo riflesso implica il riconoscimento ipso facto della soggettività dell’altro”(p.36).
Al di là della logica dello specchio e dell’opposizione (con o senza dialettica), il lavoro mette in evidenza l’esercizio di una ragione aperta (ma non popperiana) e critica, potremmo dire - chiasmatica, che riprende e porta avanti alla grande la lezione avviata da Freud (e ripresa anche da Elvio Fachinelli - mi riferisco in particolare e soprattutto al suo ultimo lavoro, La mente estatica del 1989). L’intera psicoanalisi ne esce semplicemente ‘terremotata’, e l’antropologia e l’etica anche. Aria pura in ‘Danimarca’, e non solo!
Benvenuto, in cammino e in dialogo con Freud e soprattutto con “Masud Khan, Jacques Lacan e Robert Stoller”, ma (se vogliamo, pur non essendo espressamente ricordato, e ripeto) anche con Fachinelli (si cfr., a riguardo, la sua importantissima indicazione - un vero e proprio punto di svolta antropologico e non solo psicoanalitico - ‘segnata’ Sulla spiaggia, in La mente estatica), con il coraggio delle origini (di Freud, come degli altri), “non chiudendosi nel narcisismo della prassi e della teoria” proprio della psicoanalisi ‘normalizzata’, “ma investendo direttamente forme di sapere e di discorso limitrofe”, supera fossati e barriere, mette in connessione “accordi slegati”, trova “il filo rosso tra i suoi vicoli di Napoli e la Berggasse viennese” di Freud, riesce a comporre il tutto in “una sinfonia”, e giunge (finalmente) a dirci e “a dire ancora qualcosa di fresco e convincente” - dentro e al di là del paludoso e mefitico orizzonte del nostro presente storico... e a fare un coraggioso passo al di là dell’edipo, al di là della tradizione cartesiana ed hegeliana e marxista, e al di là della tradizione ‘cattolico’- romana!!!
Federico La Sala
* Sergio Benvenuto, Perversioni. Sessualità, etica, psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 2005, pp. 189.
- Sergio Benvenuto, Hestia-Hermes. La Filosofia tra focolare ed angelo, "Dialegesthai", 2001.
- La «franchezza sorridente» di Elvio Fachinelli. Conversazione con Sergio Benvenuto, di Gioele P. Cima (psychiatry on line - Italia, 18 ottobre, 2018).
Sul tema, nel sito e in rete, cfr.:
- BAMBINE E COMPLESSO DI EDIPO "(...)Come si compie lo sviluppo corrispondente nella bambina? Il nostro materiale diventa qui - incomprensibilmente - molto più oscuro e lacunoso. Anche il sesso femminile sviluppa un complesso edipico, un Super-Io e un’epoca di latenza. Gli si può attribuire anche un’organizzazione fallica e un complesso di evirazione? La risposta è affermativa, ma la situazione non può essere identica a quella del maschio.
 La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
 Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
- AL DI LA’ DELLA LEZIONE DI PAOLO DI TARSO: "Diventate miei imitatori [gr.: mimetaí mou gínesthe], come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l’uomo [gr. ἀνήρ ἀνδρός «uomo»], e capo di Cristo è Dio" (1 Cor. 11, 1-3).
- MENTE ESTATICA E "CARITÀ CARNALE": GIULIA DI MARCO (Jean-Michel Sallmann)
 IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO di Sigmund Freud (1931).
IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO di Sigmund Freud (1931).
 UNA QUESTIONE DI ECO. L’orecchio disturbato degli intellettuali italiani
UNA QUESTIONE DI ECO. L’orecchio disturbato degli intellettuali italiani
 AI CERCATORI DEL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla "lettera" perduta.
AI CERCATORI DEL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla "lettera" perduta.
- THE CLOISTERS (MANHATTAN): LA TEOLOGIA DELL’INCARNAZIONE NELLA ANNUNCIAZIONE DEL TRITTICO DI MERODE (ROBERT CAMPIN, 1425).
- LACAN CON FREUD E "KANT CON SADE": "Che l’opera di Sade anticipi Freud, foss’anche solo riguardo al catalogo delle perversioni, è una sciocchezza detta e ridetta nelle lettere, la cui colpa, come sempre, va agli specialisti". Così inizia il testo di J. Lacan, Kant con Sade, (Scritti, Einaudi, Torino 1974, p. 762).
 Sulla "kantizzazione" di Sade e sulla "sadizzazione" di Kant da parte di Lacan, cfr.: E, Fachinelli, "Lacan e la Cosa", La Mente estatica, Adelphi, Milano 1989, pp. 181-195; e, sulla più generale "hitlerizzazione" di Kant, si cfr.: F. La Sala, Sigmund Freud, i diritti umani, e il problema dell’"Uno")
Sulla "kantizzazione" di Sade e sulla "sadizzazione" di Kant da parte di Lacan, cfr.: E, Fachinelli, "Lacan e la Cosa", La Mente estatica, Adelphi, Milano 1989, pp. 181-195; e, sulla più generale "hitlerizzazione" di Kant, si cfr.: F. La Sala, Sigmund Freud, i diritti umani, e il problema dell’"Uno")
- LACAN E "L’ORIGINE DEL MONDO" (G. Courbet, 1866): "(...) Jacques Lacan conservava L’ origine del mondo nascosta dietro un pannello, nello studio della sua casa di campagna, non rivelandone il segreto che agli ospiti d’ élite: Dora Maar, Marguerite Duras, Claude Lévi-Strauss... E quando finalmente svelava il dipinto, Lacan concentrava il proprio sguardo non sul monte di Venere, ma sullo sguardo dello spettatore. Si divertiva a farsi voyeur del voyeur" (Sergio Luzzatto).
"CHE IMPOSTOR QUEL LACAN". La "tapeuse de Lacan": recensione di FABIO GAMBARO del libro di Maria Pierrakos,la stenotipista che dal 1967 al 1979 ha seguito Lacan nei suoi seminari per trascriverne fedelmente le parole ("la Repubblica", 20 aprile 2004).
- "Se il sapere umano è attraversato da una faglia, non è perché è impossibile acquisire tutto il sapere, ma perché il sapere è solcato da un limite: il sapere non può venire a capo del senso della vita, non può sapere tutto" (Massimo Recalcati. L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento)
- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).
La mente estatica e l’accoglienza astuta degli apprendisti stregoni. Il caso "Perniola".
di Federico La Sala (04.12.1994)
Del sentire (Torino Einaudi, 1991) era il tema del precedente lavoro. Con determinazione e coraggio, ora, Mario Perniola rompe gli indugi e decide di farsi sentire. Il sex appeal dell’inorganico (Torino, Einaudi, 1994, pp.185, L. 20.000) è un’opera al vetriolo, per argomento e scrittura.
Chiariamo. Farsi sentire, non è niente di arbitrario, né di meramente soggettivo: significa, innanzitutto, un “operare su se stessi in modo da uscire dall’impassibilità metafisica e dal dualismo tra attività e passività”, “non subire in silenzio le stucchevoli esibizioni del già sentito, né le pretese totalitarie delle sensologie, ma dare voce, corpo, manifestazione alla nascita sempre ripetentesi che esse non riescono a bloccare”.
Ciò a cui egli mira è l’oltrepassamento della “concezione metafisica del sentire come un patire, come uno stato passivo inferiore e subordinato all’attività intellettuale”: la sua convinzione è che, “se da un lato la dimensione affettiva è già un’operazione intellettuale, dall’altro lato la dimensione intellettuale è già una ricezione affettiva”, “pensare è ricevere ciò che viene da fuori, accogliere, ospitare quanto si presenta come estraneo ed enigmatico” (Del sentire, cit. , pp. 93-95). E il vetriolo non è tanto e solo l’acido gettato addosso ai suoi colleghi filosofi (“Trovo più affinità col rock - ha dichiarato in una recente intervista sugli argomenti del libro - che con il pensiero debole”) per sfregiarne il volto accademico, quanto e soprattutto il “viaggio iniziatico” (Visita Interiora Terrae [Terra = corpo] Rectificando Invenies Occultum Lapidem) di chi ha trovato la pietra dei filosofi, si è trasformato in una cosa che sente e ha scoperto “la chiave per intendere tante e disparate manifestazioni della cultura e dell’arte attuali” (p. 3): “non l’arte, ma solo la sessualità può farci vedere e sentire la cosa come cosa” (p. 167) - la sessualità neutra (“Essa emancipa la sessualità della natura e l’affida all’artificio, il quale ci apre un mondo in cui non hanno più importanza la differenza tra i sessi, la forma, l’apparenza sensibile, la bellezza, l’età, la razza” p.5).
Ciò di cui egli scrive, infatti, non è più il frutto di una riflessione sulle riflessioni di esperienze altrui (cfr. i suoi lavori su Bataille, i Situazionisti, Blanchot, Nietzsche, Baudrillard, ecc.), ma il frutto di una riflessione su un’esperienza estatica (benché mimetizzata tra le righe e collocata in un orizzonte teorico carico di equivoci), di cui è stato protagonista, segnata da una sospensione dell’ordine della rappresentazione, dal “sentirsi non più Dio, né animale, ma una cosa senziente” (p. 8), e ... dalla volontà di proporsi come il filosofo fortissimo della sessualità neutra (“il punto di arrivo di un cammino che è sempre appartenuto” alla filosofia) e dello scenario contemporaneo (“il cui protagonista non è Dio, né l’animale, e tantomeno l’uomo, ma la cosa”, p. 21).
Fachinelli scrive, a riguardo: "Ciò che si genera nel vuoto, nell’esterna rarefazione [delle situazioni estatiche], è ciò che si è cercato. Si trova ciò che in noi qualcuno, al di là dell’io, cercava: Dio, l’arte, la scienza: o anche, immediatamente, semplicemente, la sospensione del tempo della caducità. In generale: una nuova figura del mondo. Il rinvenimento è sempre singolare, e rimanda alla singolarità del cercatore. Ma questa sorge dal fondo comune del corpo, se è vero che il passaggio dal vuoto al pieno presuppone il corpo come mediatore indispensabile”; “Norma di se stessa, questa esperienza non tollera alcuna apologetica e rifiuta qualsiasi subordinazione (alla teologia, all’estetica, alla scienza). La si conosce solo attraversandola. Hodie Legimus in libro experientiae” (E. Fachinelli, La mente estatica, Milano, Adelphi, 1989, pp. 30-31 e 34).
Come interprete della propria esperienza di vita, a dir poco, Perniola si mostra molto ingenuo. Una minore superficialità autoanalitica e una maggiore attenzione alla decisiva ricerca di Elvio Fachinelli, così come meno risentimento nei confronti dei teorici del pensiero debole, forse, gli avrebbero evitato passi falsi e alti livelli di inflazione ego-logica.
Procediamo con calma, e chiariamo. Al sex appeal dell’inorganico si accede solo “quando il mio corpo e quello del mio partner perdono la loro ovvietà di corpi animati e funzionanti, di forme espressive e rappresentative, di mezzi individuati al raggiungimento di scopi precisi...(p. 166): esso abolisce ogni opposizione e “immerge il sentire in un interminabile sbigottimento, e - perché non dirlo - ci dona l’esperienza della realtà” (pp. 166-167). Egli si rende conto che, “per entrare nell’anonimo e impersonale territorio delle cose che sentono bisogna saper dire [reciprocamente da parte di entrambi i partners] «fai di me ciò che vuoi» ” (p. 27), e saper “sospendere le quattro passioni fondamentali, il piacere, il dolore, il desiderio e la paura” (p. 166), ma poi capovolge tutto e, come sempre è avvenuto in filosofia (il novello Teseo abbandona sempre la novella Arianna), hegelianamente, fa del risultato il cominciamento: “il maestro dell’eccitarsi e dell’accendersi della sensazione è il sex appeal dell’inorganico” (p. 167).
Vere duo in carne una: egli giunge a riconoscere che “ il mutuo e vicendevole darsi e prendere come cose non [è] affatto un vizio, ma una virtù, anzi la sola condizione dell’esercizio della sessualità” e che “vedono più a fondo nell’essenza della sessualità coloro che considerano il matrimonio come un sacramento [...] come attinente al fas, al diritto divino, e non allo ius, al diritto umano” (p. 26), ma poi si vieta - come aveva già fatto Hegel ai suoi tempi - di ammettere che solo l’amore è il vero maestro dell’iniziazione ai “misteri nuziali” (ama l’Amore e fai di me ciò che vuoi), che accende la sensibilità e introduce alla sensualità neutra né dello sposo né della sposa, ma di entrambi: “nel sex appeal dell’inorganico non c’è strazio, né soggetto, né rispecchiamento, né interiorità, né esteriorità”, (p. 120); “un impersonale «si sente» prende il posto delle forme soggettive del sentire [...] si sente insieme con estrema evidenza e con sospensione, come in una specie di epoche colorata e intensa”, (p. 167).
Questo mancato riconoscimento lo porta fuori strada e non gli permette di capire che il problema fondamentale della filosofia non è tanto e solo farsi sentire (e sentirsi Dio, animale e cosa) quanto e soprattutto se e come dare ascolto e risposta a chi e a ciò che bussa alla porta della sensibilità (io intuisco, mi faccio sentire), si fa sentire e chiede di essere riconosciuto dall’intelletto e accolto dalla coscienza (Io penso e Io voglio).
E così, dopo Kant (e senza nemmeno un’analoga confutazione dell’idealismo), ripete lo stesso errore: il filosofo, nell’andata (nell’esperienza), si toglie i panni accademici e osa riconoscere la piena autonomia della sensibilità, nel ritorno (nella riflessione), rientrato in Accademia e rimessi i vestiti del vecchio intelletto e del vecchio io, la nega e comincia ad affermarsi: “spetta oggi proprio al filosofo proclamare la grandezza e la dignità di una sessualità senza vita e senza anima; è il suo impegno e la sua responsabilità dire che il regno delle cose non è tanto il trionfo della tecnica e del capitalismo, quanto l’impero di una sessualità senza orgasmo; così finalmente proprio nell’attimo che sembra più irrazionale, casuale e fragile, quello dell’eccitazione sessuale, viene mostrata la potenza della filosofia, al cui appello non riesco a sottrarmi, anche volendolo” (pp. 14-15).
Non ridere, né piangere. Oggi abbiamo gli strumenti per comprendere il vecchio gioco di Edipo. Ogni figlio uccide il padre-re, uccide la donna sfinge, sposa la madre-regina e proclama urbe et orbi: Io sono lo sposo e il re, io sono l’autorità e la legge!
La ripetizione della tragica dichiarazione, oggi, suona così in filosofia: "Il filosofo che si sente cosa ha l’impressione di trasgredire la tradizione che lo ha rappresentato come soggetto, persona,spettatore,attore; ma nello stesso tempo questa trasgressione è fedeltà nel proseguire quel movimento di innovazione paradossale, di superamento e di oltrepassamento imposto da Hegel e da Nietzsche” (p. 17). E sollecita ogni filosofo-custode a riconoscere la sua autorità: “nei secoli fedele”, a chiunque prende il posto del padre-re accanto alla madre-regina (sapienza nell’accademia).
Questa trasgressione è fedeltà: non ci sono inganni, dice Perniola ai suoi colleghi dell’accademia. L’estremismo speculativo della filosofia del sex appeal dell’inorganico non è altro che interpretazione e apologia della “suprema volontà di potenza” platonico- nietzscheana - “imprimere al divenire il carattere dell’essere” (F. Nietzsche, Opere, VIII, 1, p. 297, Milano, Adelphi, 1975): si tratta di imprimere al sentire il carattere dell’intelligenza attuale, quella artistica, “Insomma la cosalità [di cui parlo] - precisa Perniola - non ha niente a che fare con un realismo conoscitivo che afferma la realtà del mondo esterno e la sua trascendenza rispetto al pensiero. Il tipo di conoscenza cui il sex appeal dell’inorganico ci inizia è più prossimo all’immaginazione tecnica che all’epistemologia, nel senso che non si preoccupa tanto delle condizioni dell’oggettività delle proprie esperienze quanto della ricerca di esperienze-limite che allargano insieme gli orizzonti del sentire e del sapere” (pp. 139) della nostra tradizione tecno-logica e capitalistica.
Di destra o di sinistra, dopo Lenin, l’estremismo è una malattia infantile ... Dissociazione, rimozione e volontà di potenza costringono il nostro filosofo nelle maglie edipiche, lo confondono e, alla fine, lo riducono alla Ragione. Dura Lex sed Lex: si entra “in due nel territorio del sesso neutro” (p. 164), ma solo uno può accedere nel territorio della filosofia.
Perniola, come Garibaldi e meglio di Cartesio, afferra il concetto, impone con le buone maniere (“ci vuole molta purezza, onestà e perfino candore”, p. 16) alla sessualità “la sospensione speculativa della libido” (p. 17) e, padrone del proprio e altrui sentire, esibendosi in una girandola di negazioni del diniego (“Questo processo è reso possibile da una scissione dell’io [...] che ci consente di negare la differenza sessuale pur riconoscendola parzialmente: esso implica un rapporto di sostanziale estraneità nei confronti del vero sesso femminile”, pp. 76-77), obbedisce: Io penso “l’idea stessa della cosa senziente” (p.11), Io sono il filosofo del sex appeal dell’inorganico.
E come all’Università, così a casa, “contro le anime belle della liberazione sessuale e della contestazione universitaria”, l’opposizione eccessiva (si allea con l’integralismo cattolico-musulmano) e riafferma il valore della Legge: “E’ ora di vedere il matrimonio e l’università dalla parte del male, come spacciatori di eccessi sessuali e filosofici cui non si può rinunciare, anziché dalla parte del bene come rimedi alla libidine sessuale e a quella conoscitiva” (p. 25).
L’inquietudine è svanita e l’enigma è stato risolto: “il confluire in un unico fenomeno di due dimensioni opposte, quali il modo di essere della cosa e la sensibilità umana” (p. 5) - “l’evento paradigmatico chiave intorno a cui ruota la società e la cultura contemporanea” (p. 145), è stato ben rimosso e posto nel rinnovato Ordine Mondiale.
Ciò che è inorganico è razionale e ciò che è razionale è inorganico! La filosofia, portata la sessualità (“triviale e snervata”, p. 16) fuori "dal vicolo cieco in cui il sadismo la conduce” (p. 35), e ospitatala nella sua casa ("connubio", p. 3), finalmente, realizza il suo antico sogno “di transitare in dimensioni reali” (p. 16): “la sessualità inorganica è simile ad una eccitazione appagata e implica una reciprocità, una comunanza di sentire tra i partner impegnati in essa, e addirittura una specie di entusiasmo intellettuale, di eretismo cerebrale, di estremismo concettuale che derivano dalla filosofia [...] il sex appeal dell’inorganico è piuttosto un farsi mondo, un abolire la distanza che separa l’uomo dalla cosa” (p. 123). Il filosofo del dissolvimento della soggettività ha vinto i filosofi del pensiero debole, ma chi più chi meno si è consegnato mani e piedi alla propria Signora - la Tecnica.
Come avevano capito Horkheimer e Adorno (Dialettica dell’Illuminismo, Torino, 1980), chi per salvare o per salvarsi, si chiama Nessuno e adopera l’assimilazione allo stato di natura (naturale o artificiale) cade in preda alla hybris. Come a casa così all’Accademia, la logica del sado-masochismo imperversa e devasta le menti e i corpi degli uomini e delle donne, e la comune Terra. E la filosofia ricade nel pantano della totale apologia del vecchio passato, ancora presente, contrabbandato come futuro.
Oggi però, non c’è solo e ancora la servetta tracia a ridere (in strada e a piangere a casa): ci sono donne e uomini con i piedi per terra e lo sguardo sereno, pieno di vita e di amore (vita tua, vita mea) - coraggiose e coraggiosi, entrambi accoglienti, anche nei confronti di chi si attarda in brutti e vecchi sogni.
Al di là di ogni naturalismo e al di là di ogni idealismo, essi ed esse hanno trovato l’accesso a un nuovo rapporto sociale di produzione e a una nuova forza produttiva. Con Marx, con Freud, con W. Reich, con E. Paci, con Fachinelli e tantissimi altri e tantissime altre, hanno capiti che “l’amore, il lavoro e la conoscenza sono le fonti della nostra vita” e possono “anche governarla” (W. Reich) - come all’interno, così all’esterno; come a casa, così all’Università; come in famiglia, così nello Stato. La favola delle api (Bernard de Mandeville, 1705) è finita: gli uomini e le donne della terra hanno già dato inizio a un’altra storia. Al di là di ogni integralismo Tecnologico, Teologico e Politico, si amano e fanno ciò che vogliono - con sensibilità, intelligenza e coscienza, amorevolmente unite.
 Milano, 04.12.1994
Milano, 04.12.1994
Federico La Sala
- Franco Berardi Bifo, Un falso Perniola, [rec. di Berlusconi o il ’68 realizzato], "Alfabeta-2, 09 febbraio 2012.
- MENTE ESTATICA E "CARITÀ CARNALE": GIULIA DI MARCO (Jean-Michel Sallmann)
- "Se il sapere umano è attraversato da una faglia, non è perché è impossibile acquisire tutto il sapere, ma perché il sapere è solcato da un limite: il sapere non può venire a capo del senso della vita, non può sapere tutto" (Massimo Recalcati. L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento)
 IL RISPETTO DELLE DONNE E LE 21 "MADRI DELLA REPUBBLICA": LA VIA MAESTRA PER UN’ALTRA POLITICA.
IL RISPETTO DELLE DONNE E LE 21 "MADRI DELLA REPUBBLICA": LA VIA MAESTRA PER UN’ALTRA POLITICA.
Federico La Sala
Forum
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. Un omaggio a Elvio Fachinelli --- Una questione di differenza logica e ontologica: c’è "Madre" e Madre, "Padre" e Padre, e "Dio" e Dio.20 luglio 2024, di Federico La Sala
COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (FREUD), "DIVINA COMMEDIA" (DANTE ALIGHIERI), E "VIOLENZA" DELLA "INTERPRETAZIONE".
SULLA "LA FINZIONE DELLA MADRE". Una #questione di #differenza logica e ontologica: c’è "Madre" e #Madre, "Padre" e #Padre, e "Dio" e #Dio.
- Una nota di commento in omaggio alla sollecitazione di Psicoanalisi e Psicoterapia Salerno - Dott. Egidio T. Errico, a riflettere e a discutere sul tema della #comunicazione psicoanalitica (e non):
"LA FINZIONE DELLA MADRE. [...] se la madre, ad esempio, come è giusto che faccia, non coglie più il carattere comunicativo di segno del pianto del suo bambino, ma lo interpreta in qualche modo ("piange perché gli fa male il pancino"), ne snatura il carattere di segno per farne un significante, ritrovandosi di conseguenza a costruire, in tal modo, una #verità con la struttura della #finzione, vale a dire una verità stabilita solo dalla sua parola. [...] Una verità che conserva tuttavia una struttura logica di credibilità, in effetti un #sofisma. [...]"." (cit.).
CRITICA DELLA METAFISICA DELLA TRAGEDIA: "IN #PRINCIPIO ERA IL #LOGOS" (NON UN #LOGO). Forse, per capirsi, su un tema tanto importante, e non restare impigliati in ciò che appare "in effetti un sofisma" del sofisma di #Edipo, vale a dire del figlio della "giocastolaia (la madre del "giocastolaio"), è opportuno rimeditare la lezione antropologica e teologica di #Dante (nient’affatto platonica, paolina, costantiniana, e lacaniana):
- «Regnum coelorum violenza pate
 da caldo amore e da viva speranza,
da caldo amore e da viva speranza,
 che vince la divina volontade;
che vince la divina volontade;
 non a guisa che l’uomo a l’uom sobranza;
non a guisa che l’uomo a l’uom sobranza;
 ma vince lei perché vuol esser vinta,
ma vince lei perché vuol esser vinta,
 e, vinta, vince con sua beninanza.»
e, vinta, vince con sua beninanza.»
 (Par. XX, 94-99).
(Par. XX, 94-99).
NOTA:
- PSICOANALISI, LINGUISTICA E #FILOLOGIA: #SAUSSURE. PER JACQUES #LACAN, «IL NOME "FREUD" SIGNIFICA "#GIOIA"», cfr. "Conferenza: Freud nel suo secolo", 1956)!
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. --- "IL DIALOGO PSICOANALITICO" SUL "DIVANO". CON KANT, FREUD, E FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’ UOMO COL MAGNETOFONO (J.-J. ABRAHAMS),28 giugno 2024, di Federico La Sala
A CHE #GIOCO GIOCHIAMO, IN #REALTÀ?! LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA DEL DIVANO DI #FREUD E IL PERMANERE DEL COMPROMESSO "OLIMPICO" (PLATONICO E ARISTOTELICO) SUL PROBLEMA DEL "COME NASCONO I BAMBINI".
ANTROPOLOGIA E STORIA: #UNO (#ONU). Alla luce dell’eredità tragica di #Edipo (#Sofocle) e #Amleto (#Shakespeare), sulla questione antropologica (e cristologica) la cultura europea (e planetaria) ancora non è riuscita a fare chiarezza sulla dimensione "nexologica" (da "#nexus") e confonde ancora "nexuno", con "#nessuno", e non comprende nemmeno un semplice "nesso"!
PSICOANALISI ("L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI", 1899): "IL DIALOGO PSICOANALITICO" (Jean-Jacques #Abrahams, "Les Temps Modernes", 1969). A partire dal caso dell’«uomo dei topi» (Freud, 1909) e dell’«uomo con il magnetofono, dramma in un atto con grida d’aiuto di uno psicoanalista» (Jean-Jacques Abrahams, 1977), il problema è ancora sul divano di #SigmundFreud (non di #Lacan), e l’#enigma del "come nascono i bambini" non è stato ancora risolto... A gloria eterna della sollecitazione di "Sigismondo di Vindobona" e di Franca Ongaro Basaglia (cfr. "Così parlò Edipo a #Cuernavaca", "pM - Panorama mese", novembre 1982), che fare? Continuare i giochi "olimpici" di enigmistica nello spirito di Edipo e di cruciverba nello spirito di Amleto?
STORIA, STORIOGRAFIA E "DIVINA COMMEDIA" (#DANTE2021): L’IMMAGINARIO APOLLINEO E LA SOPRAVVIVENZA DELL’ #ALGORITMO DELLA TRAGEDIA. Se è vero, come è vero, che per la religione greca «non è la madre la generatrice di quello che è chiamato suo figlio; ella è la nutrice del germe in lei inseminato. Il generatore è colui che la feconda» (#Eschilo, "Eumenidi"), è anche vero che dopo la nascita di Cristo e dopo la diffusione del Cristianesimo, come ha scritto Franca Ongaro Basaglia (1978), continua ad essere "possibile un’operazione #matematica ritenuta abitualmente sbagliata: un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo".
NOTE:
- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "CRITICA DELLA RAGION PURA": CON KANT, FREUD, E FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’ UOMO COL MAGNETOFONO (J.-J. ABRAHAMS), UNA GENIALE E HAMLETICA "TRAPPOLA PER TOPI".
- MEMORIA, STORIA, E FILOLOGIA: DIVANO.
- "DIVANO DI LACAN ALL’ ASTA A PARIGI" ("La Repubblica", 06 Ottobre 1991):
- "[...] Clou della vendita il divano per analisi più illustre di Parigi: un semplice lettino, stile salotto borghese anni cinquanta. Partita dal prezzo base di poco più di 4 mila lire, l’ asta è salita subito vertiginosamente, fino a raggiungere i 20 milioni di lire. E’ a questo prezzo che un anziano signore, subito eclissatosi discretamente, senza farsi riconoscere, si è portato a casa quella specie di feticcio [...]"(cit.).
- IL CADUCEO* DI ERMES (MERCURIO) E LE "COSTRUZIONI NELL’ANALISI": COME FREUD, CHE VOLEVA SAPERE DELLE ANGUILLE, DIVENNE TIRESIA. "Si racconta che il pastore Tiresia, figlio di Evere, sul monte Cilene percosse col bastone oppure calpestò due serpenti che si congiungevano e per questo fu trasformato in donna. Poi, consigliato da un oracolo, calpestò altri due serpenti nello stesso luogo e riprese l’aspetto antico. In quel tempo, Giove e Giunone stavano discutendo scherzosamente se durante l’amplesso il piacere più grande toccasse all’uomo o alla donna. Essi presero Tiresia come arbitro della disputa, dato che conosceva entrambe le situazioni; poiché egli aveva dato ragione a Giove, Giunone, adirata, lo toccò col dorso della mano e lo rese cieco. Ma Giove in cambio lo fece vivere per sette generazioni e ne fece l’indovino migliore fra tutti gli uomini." (Cfr. Igino, "Miti", a c. di G. Guidorizzi, Adelphi, 2022, p. 57).
- * CADUCEO.
-
> "PERVERSIONI" --- PSICOANALISI e "MOSCHETTIERI": "L’UOMO DEI TOPI" (FREUD), "L’UOMO COL MAGNETOFONO" (ABRAHAMS), E "IL BAMBINO DALLE UOVA D’ORO" (FACHINELLI).7 giugno 2024, di Federico La Sala
LA PSICOANALISI E I QUATTRO "MOSCHETTIERI": FREUD ("L’UOMO DEI TOPI"), ABRAHAMS" (L’UOMO COL MAGNETOFONO"), MUSATTI ("CONDIZIONI DELL’ESPERIENZA E FONDAZIONE DELLA PSICOLOGIA") E FACHINELLI ("IL BAMBINO DALLE UOVA D’ORO". Appunti sul tema...
- "LA PAROLA CONTAMINATA" E LA "#CRITICA DELLA RAGION PURA": VIVERE A #MILANO E NON CAPIRE UN #BISCIONE. CON #KANT, #FREUD, #MUSATTI, E #FACHINELLI, UN OMAGGIO ALL’#UOMO COL #MAGNETOFONO (J.-J. #ABRAHAMS) E UN PASSO OLTRE IL GEOCENTRISMO E L’#ANDROCENTRISMO EDIPICO ...
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA: "PSICHE E POLIS" (26 MAGGIO 2024). Alcuni "vecchi" appunti a margine del Congresso Nazionale della #Spi (Società Psicoanalitica Italiana).
- ANTROPOLOGIA E NEXOLOGIA CHIASMATICA: "IL BAMBINO DALLE UOVA D’ORO" (ELVIO FACHINELLI). "Con #Freud invece si apre il campo di una #ricerca sui rapporti interindividuali: comincia una sorta di #nexologia umana (dal latino: #nexus: legame, intreccio), che include il corpo come parte in causa e interlocutore. Di essa, la #psicanalisi comunemente intesa è solo un momento parziale, limitato, anche se di grande fecondità" (E. Fachinelli).
A sua memoria, "vent’anni dopo" (1989-2009).
FACHINELLI intuì CHE J.-J.ABRAHAMS, L’UOMO COL MAGNETOFONO, ERA UN SINGOLARE (KIERKEGAARD) GATTO, MA GLI SFUGGì il legame CON I TOPI, CON LA "MOUSETRAP" DI "AMLETO" E L’OPERA DI ALEXANDRE DUMAS.
- PSICOANALISI E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (S. FREUD, 1937): "L’UOMO DEI TOPI" (1909).
"L’uomo dei topi fu un caso clinico affrontato da hashtag#SigmundFreud e pubblicato come Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose ("Note su un caso di nevrosi ossessiva") (1909).
 Il soprannome deriva dal fatto che il paziente aveva sviluppato una serie di fantasie ossessive in cui, nelle parole di Freud, i "topi avevano acquisito una serie di significati simbolici ai quali... continuamente venivano aggiunti di nuovi". "Uomo dei topi" è uno dei tanti pseudonimi che utilizzava Freud per proteggere l’anonimato dei propri pazienti (come quelli di "Anna O.", "Hans", "Dora", "Uomo dei lupi", ecc.). [...]".
Il soprannome deriva dal fatto che il paziente aveva sviluppato una serie di fantasie ossessive in cui, nelle parole di Freud, i "topi avevano acquisito una serie di significati simbolici ai quali... continuamente venivano aggiunti di nuovi". "Uomo dei topi" è uno dei tanti pseudonimi che utilizzava Freud per proteggere l’anonimato dei propri pazienti (come quelli di "Anna O.", "Hans", "Dora", "Uomo dei lupi", ecc.). [...]".
ANTROPOLOGIA PSICOLOGIA E NEXOLOGIA CHIASMATICA: "ACHERONTA MOVEBO". Aprire gli occhi (Freud), tutti e due, è difficile, ma solo sciogliendo il nesso ("nexus") tragico, il nodo edipico, è possibile uscire dall’orizzonte della tragedia e della claustrofilia (Elvio Fachinelli, 1983) e andare oltre le colonne d’#Ercole e, con Virgilio e Dante, oltre... "Sàpere aude! (Orazio-Kant).
- "Il selvaggio Abrahams: tra Bolaño e Basaglia". Una recensione del libro (ristampato nel 2017) di Piero Cipriano: "Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina (Introduzione e cura di),
- Un singolare gatto selvatico. Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono, Ombre Corte, Verona, 2017, pp. 152, € 14,00
- Un singolare gatto selvatico, sottotitolo Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono, libro a cura di Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina, edito da Ombre Corte, è un libro che mi ha incuriosito molto, ma non certo perché ho a cuore le sorti della psicanalisi, di cui non mi importa granché, ma perché sapevo che entrambi i miei demoni, il demone della letteratura [...]".
PSICOANALISI (NEXOLOGIA) E ANTROPOLOGIA CHIASMATICA: CON KIERKEGAARD ("AUT - AUT"), OLTRE. Mi auguro che le poche indicazioni date siano buone sollecitazioni a riprendere il filo: "L’uomo dei topi" è "radioattivamente" carico di teoria. Freud s’è l’è portato dietro tutta la vita, fino alle "costruzioni nell’analisi" (1937) e oltre.
DA FREUD A FACHINELLI: CON KIERKEGAARD, OLTRE. "L’uomo col magnetofono", fondamentalmente, è lo stesso Fachinelli (v. "La parola contaminata", nel testo), andato a "scuola" di Cesare Musatti, e, al contempo, critico nel rapporto con la Società Psicoanalitica Italiana (che ancora oggi si attarda a parlare alla Platone, "Psiche e Polis").
Federico La Sala
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. Un omaggio a Elvio Fachinelli --- Al di là del #paolinismo (dell’hegelismo e del lacanismo): "Psiche e Polis". Note sul "XXI Congresso Società Psicoanalitica Italiana" (maggio 2024).1 maggio 2024, di Federico La Sala
Al di là del #paolinismo (dell’#hegelismo e del #lacanismo): "Psiche e Polis" (#Platonismo) e "#Costruzioni nell’#analisi" (S. Freud, 1937).
- Una nota a margine del "XXI Congresso Società Psicoanalitica Italiana" ) *
ANTROPOLOGIA E #PSICOANALISI: "LA FERMA FERMA" (E. Fachinelli, 1979). Purtroppo, bisogna dirlo la Società Psicoanalitica Italiana, all’altezza del XXI Congresso (in coincidenza con l’anniversario della #nascita di #Kant, trecento anni fa, 1724) ha perso tutto il coraggio degli inizi (del "#sàpereaude!" oraziano come dell’#illuminismo kantiano) del suo "fondatore" (#COPERNICO, #DARWIN, e #FREUD): non riesce ad "#apriregliocchi" su una vera e propria "seconda" #rivoluzionecopernicana in progress e continua ad agitare "la_can_na" per l’aria - almeno dal 1989, dalla morte contemporanea di #CesareMusatti e di #ElvioFachinelli.
MEMORIA E STORIA: L’ITALIA, IL VECCHIO E NUOVO #FASCISMO, E "LA FRECCIA FERMA". La lezione sorprendente e preveggente di Elvio Fachinelli.
ARCHEOLOGIA, #STORIAELETTERATURA, E "DISAGIO DELLA CIVILTÀ" (1929): "RIVEDERE IL SOLE E LE ALTRE STELLE" E’ POSSIBILE. "L’#Interpretazione dei #Sogni" (1899) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della "Divina Commedia" (Pg. II, 46-48) di #DanteAlighieri.
NOTA:
- CON #KANT E #FREUD, #OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO #FACHINELLI.
- Antropologia, #psicoanalisi, e #critica della #ragione hegeliana (e lacaniana).
- Una nota a margine del lavoro di Pietro Barbetta, "Elvio Fachinelli - Psychoanalysis of Dissension in Italy.
PSICOANALISI E #SOCIETA’: "TENTATIVI DI ANNULLARE IL #TEMPO" E "#COSTRUZIONI NELL’ #ANALISI" ...
- In #memoria di #SigmundFreud (1939), #CesareMusatti (1989) e di #ElvioFachinelli (1989)
Una breve nota a margine di un intervento di Sergio Benvenuto ("Anti-Deleuze", "Le parole e le cose", 29 aprile 2024).
IL TITOLO DEL XXI CONGRESSO NAZIONALE DELLA Società Psicoanalitica Italiana (Roma, 24-25-26 MAGGIO 2024) E’ “PSICHE E POLIS”. Incapaci di riuscire ad “aprire gli occhi” fuori dalla famosa “caverna” e guardare il “mondo” al di là della luce “del sapere del “Maestro di color che sanno”, del sole e delle altre stelle del cielo aristotelico, è più che “verosimile la tesi promossa da George #Lakoff (in #Moral #Politics): che i grandi conflitti politici, quelli che portano anche a distruzioni e miserie immani, sono una proiezione espansiva, cosmica, delle nostre primitive relazioni con mamma, papà, la balia, la zia... In analisi, emerge la straordinaria pregnanza del Piccolo Mondo Antico”. (cfr. S. Benvenuto, "Anti-Deleuze", cit.).
"ANTI-EDIPO": "[...] Il primato dei crucci privati mi ha certamente colpito ma non sorpreso. Perché non ho mai creduto alla predicazione di #Deleuze e #Guattari. Come è noto, costoro rimproveravano alla psicoanalisi soprattutto freudiana di voler “familiizzare” tutto, di ridurre tutti i conflitti detti psichici a storie di mamma, papà, inauspicato fratellino, toccamenti di pisellino o patatina tra bambini... Mentre, altroché, i veri problemi inconsci sono cose serie, politiche, lotta di classe, rivoluzione degli oppressi, ecc. Gli schizofrenici, in particolare, vibrano per le sorti drammatiche del mondo. [...]" (Benvenuto, cit.).
"LA #FRECCIA #FERMA". A quanto pare, l’evidenza appare al massimo del suo livello: il tempo si è fermato! A questo punto, a che vale chiedersi ”se certi colleghi possano portarmi esperienze ben diverse”, quando “La freccia [è] ferma” (E. Fachinelli, 1979), per quanto qualche “vecchia #talpa” possa essere ancora benvenuta nella sua volontà di scavare, può mai contribuire a trovare la via d’uscita? Così non si butta la "Psiche" del #Bambino ("Edipo") e l’acqua sporca della Città di #Tebe?, della "Polis" t(al)ebana?! Boh e bah?!
PIANETA TERRA (#EARTHRISE). Individuo ("Psiche") e Società ("Polis"): una relazione chiasmatica aperta alla luce del Sole copernicano (e galileiano e kantiano)! Nel 1989, il tema del 36º congresso internazionale dell’ International Psychoanalytical Association (IPA), tenutosi a Roma (con #Musatti, morto il #21marzo 1989, e #Fachinelli, morto il 21 dicembre 1989) era quello dell’#oikos, del "terreno comune" in psicoanalisi - e non solo!
Nota:
- STORIA #FILOSOFIA E #PSICOANALISI. Gilles #Deleuze, Félix #Guattari, "L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia".
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. --- "UNA SCELTA DECISIVA PER L’INDIVIDUO E PER LA SPECIE". "Elvio Fachinelli - Psychoanalysis of Dissension in Italy": una nota a margine del lavoro di Pietro Barbetta (di Federico La Sala)26 aprile 2024, di Federico La Sala
CON #KANT E #FREUD, #OLTRE. "UNA SCELTA DECISIVA PER L’INDIVIDUO E PER LA SPECIE". Un nuovo #paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO #FACHINELLI. Antropologia, psicoanalisi, e #critica della #ragione hegeliana (e lacaniana).
Una nota a margine del lavoro di Pietro Barbetta: *
- "[...] I recently wrote a chapter on the book The Years of Alienation in Italy (Barbetta, 2019) focusing on the persona of Elvio Fachinelli (1928-1989). In this essay, I will outline Fachinelli’s thought and clinical practice from the 1960s to the 1980s, up until his premature death at 61, in 1989. Fachinelli was a prominent exponent of the critical psychoanalysis in Milan; he was a peculiar type of psychoanalyst, not the kind of person easily to be enrolled or framed into a mainstream - whether it be Freudian or Lacanian. But this is not Fachinelli’s main highlight; during the years following 1968 in Europe, there have been many left-wing dissidents, or libertarians, psychiatrists, psychologists and psychoanalysts: Ronald #Laing, Franco #Basaglia and #FrancaOngaro, Franz #Fanon, Felix #Guattari, just to mention few [...]".
Brillante breve saggio sulla storica figura della cultura psicoanalitica e filosofica italiana, "Elvio Fachinelli - Psychoanalysis of Dissension in Italy" ("Qeios", 24 aprile 2024): pur partendo dall’importante #caso dell’#uomo con il #magnetofono (cfr. J.-J. #Abrahams, "L’uomo col magnetofono: dramma in un atto con grida d’aiuto di uno psicoanalista", con note di J.-P. #Sartre, J.-B #Pontalis, B. #Pingaud e E. #Fachinelli, edizioni L’erba voglio, Milano 1977), seguendo il filo di una obsoleta #storiografia freudiana (e fachinelliana), a mio parere, si perde l’equilibrio e ne esce una #visione della ricerca fachinelliana del tutto riduttiva, schiacciata nella valorizzazione pure importante dell’indicazioni di Sándor #Ferenczi.
Sul tema, mi sia lecito, si cfr. il capitolo intitolato "Il punto di svolta. L’indicazione di Fachinelli" all’interno di un mio "vecchio" lavoro, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica" (Antonio Pellicani editore, Roma 1991, pp. 138-161): "Con #Freud, #oltre - in una nuova direzione e in modo nuovo: contro le sfingi e contro l’imbalsamazione degli uomini come delle teorie".
DA RICORDARE: "L’#Interpretazione dei #Sogni" (1899) ha il suo legame con l’#Eneide (VII, 312: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo") di #Virgilio e "L’uomo Mosè e la religione monoteistica"(1938) con il tema dell’«In exitu Isräel de Aegypto» della #DivinaCommedia (Pg. II, 46-48) di #DanteAlighieri.
Note:
- A) PSICOANALISI E FILOSOFIA. Federico La Sala, "La mente accogliente. Tracce per una svolta antropologica", Antonio Pellicani editore, Roma 1991.
- B) PSICOANALISI E #ANTROPOLOGIA CULTURALE: "COSTRUZIONI NELL’ANALISI (S. FREUD, 1937). J.-J. Abrahams, "L’uomo col magnetofono: dramma in un atto con grida d’aiuto di uno psicoanalista", con note di J.-P. Sartre, J.-B. Pontalis, B. Pingaud e E. Fachinelli, edizioni L’erba voglio, Milano 1977.
L’ipotesi della distruzione in Sigmund Freud
di Elvio Fachinelli ("Il Corpo", 1, marzo 1965).*
"[...] Si pensi al programma ambizioso iscritto sul frontespizio della Interpretazione dei sogni: Acheronta movebo; trent’anni dopo, nelle ultime pagine de Il disagio nella civiltà, la mantenuta coerenza del proposito appare velata d’amarezza: "M’inchino al rimprovero... di non saper recare alcuna consolazione."Né disperazione, è chiaro; ma piuttosto la consapevolezza del profilarsi - al limite di separazione fra ciò che siamo e il futuro visibile dell’utopia - di una scelta decisiva per l’individuo e per la specie" (* ).
- [NOTA AGGIUNTA - 1974]: "[...] In questa lotta di esito incerto, e forse, alla fine, negativo, tra Eros e Tanatos, sembra apparire, come una visione fra il sonno e l’insonnia, la finitezza e l’incompiutezza delle alternative concesse alla specie umana. Alla specie intera, e non a singole culture storiche. E come se ciò che sembrava lontano e perduto nel tempo diventasse improvvisamente ipotesi quotidiana, persino banale; come se d’improvviso l’occhio visionario vedesse da vicino e chiara la possibile conclusione di una lunga vicenda. A questo punto, è persino ovvio rilevare che ciò significa, per Freud, porre il problema del senso e della continuità della cultura cui apparteneva, la cultura occidentale egemone nel mondo; e rompere definitivamente il rapporto ottimistico che essa aveva intrattenuto con se stessa e le proprie mete tecnico-scientifiche, ultime eredi del rapporto con Dio. Si vedano queste sobrie osservazioni:
- "Non paiono soltanto una fiaba, sono l’appagamento di tutti (o quasi) i desideri favolosi, queste cose che l’uomo, mediante la scienza e la tecnica, ha prodotto sulla terra. [...] Oggi... è diventato lui stesso quasi un dio... una specie di dio-protesi, veramente magnifico quando è equipaggiato di tutti i suoi organi accessori; ma essi non formano un tutt’uno con lui e ogni tanto gli danno ancora del filo da torcere" (Il disagio della civiltà, Boringhieri 1971, pp. 227-8).
- Il dio-protesi si è da allora incredibilmente complicato, e il decorso del mondo si è incaricato di attorcigliargli ben bene il filo che lo lega ai suoi organi accessori. Visti oggi, i modesti avvertimenti di Freud sembrano imporci di imparare dall’esperienza, di cambiare strada. Ma è altrettanto tipico di Freud il non concedere illusioni: i suoi avvertimenti sono disarmati e non serviranno quindi a evitare quel che si sta preparando. Il vecchio indagatore della felicità dell’uomo - perché questo, esplicitamente, è il tema del Disagio - finisce dunque per urtarsi a una debolezza della verità. che si somma a quella di Eros nella sua lotta con Tanatos, e contribuisce a renderla ancora più incerta e difficile." (*).
* Cfr. AA, VV., "La negazione freudiana", "Nuova Corrente", 61/62, 1973, 159-171; poi, in E. Fachinelli, "Il bambino dalle uova d’oro", Milano, Feltrinelli 1974, pp. 13-29).
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. --- MEMORIA E STORIA. IL "SOGNO IN W. R. BION": UN’APERTURA SUL TEMA DELLA "MENTE_ESTATICA" (E. FACHINELLI, 1989).9 settembre 2023, di Federico La Sala
CON FREUD, OLTRE: MEMORIA DI W.R. BION.
- "COSTRUZIONI NELL’ ANALISI" (SIGMUND FREUD, 1937) E LETARGO (Par. XXXIII, 94) "PSICOANALITICO":
- LA CRITICA DEI SOGNI DELLA RAGIONE "OLIMPICA" (PLATONICO-HEGELIANA) E UN’APERTURA SUL TEMA DELLA "MENTE_ESTATICA" (E. FACHINELLI, 1989).
- COMPLIMENTI alla Società Psicoanalitica Italiana: "Nel giorno dell’anniversario della nascita di W. R. Bion (Mathura, 8 settembre 1897 - Oxford, 8 novembre 1979) proponiamo la voce "sogno in Bion" a cura di Michele Bezoari (15/12/2021):
Sogno in W.R. BION
Per evidenziare il contributo innovativo di Bion alla teoria psicoanalitica del sogno è utile partire dal concetto di lavoro onirico, introdotto da Freud nel sesto capitolo della Interpretazione dei sogni (1899).
A cura di Michele Bezoari *
- [Foto] Rene Magritte, 1966
Il lavoro psichico da cui scaturisce il sogno consiste, per Freud, di due fasi successive: la produzione dei pensieri inconsci e la loro trasformazione nel contenuto manifesto del sogno. Solo questa seconda operazione, in quanto specifica dei sogni, è stata da lui considerata come il vero e proprio lavoro onirico e descritta mettendone in luce le modalità impiegate per eludere la censura (condensazione, spostamento, raffigurazione simbolica, elaborazione secondaria).
La ricerca di Bion si è, invece, focalizzata sulla prima fase, cioè sulla formazione dei pensieri inconsci mediante un processo dal quale derivano, come lo stesso Freud aveva ipotizzato, anche i pensieri coscienti. Per indicare la novità del suo apporto Bion ha usato inizialmente il termine lavoro-del-sogno-alfa, ridefinito in seguito funzione alfa (1962, 1992).
Questa funzione opera trasformando le impressioni emotivo-sensoriali (elementi beta) in immagini (gli elementi alfa) idonee alla costruzione dei pensieri sia consci che inconsci. Si tratta di un lavoro onirico basilare e necessario per la vita psichica: lavoro che, a differenza di quello che porta alla formazione del sogno, si svolge di continuo, non solo quando dormiamo ma anche quando siamo svegli. È un processo paragonabile, secondo Bion, alla digestione.
Nell’ottica bioniana il contenuto manifesto del sogno è un’aggregazione di elementi alfa articolati in forma narrativa durante il sonno e successivamente rielaborati durante la veglia. Il nucleo del sogno come evento vissuto dal soggetto dormiente è un’esperienza emotiva, che la funzione alfa elabora nel tentativo di renderla pensabile, analogamente a quanto accade per le esperienze emotive vissute nello stato di veglia.
Parlando di “sogno necessario” e affermando che ogni uomo deve poter “sognare” un’esperienza emotiva mentre gli capita, sia che gli capiti nel sonno sia che gli capiti da sveglio, Bion (1962) si riferisce dunque al primo livello di pensiero onirico. Per evitare di essere frainteso dal lettore, egli usa - almeno inizialmente - le virgolette quando con i termini “sogno” e “sognare” intende il prodotto e l’attività della funzione alfa, non il sogno e il sognare propriamente detti (che devono la loro specificità allo stato di coscienza peculiare del sonno), né le fantasticherie della veglia talvolta chiamate, nel linguaggio comune e anche da Freud, “sogni a occhi aperti”.
La nuova teoria è compatibile, come dichiara lo stesso Bion, con i concetti classici di rimozione, censura e resistenza impiegati da Freud a proposito del sogno. Ma questi meccanismi vengono ora considerati al servizio della funzione alfa, che crea e differenzia i pensieri inconsci e quelli consci per mezzo di una membrana virtuale in continuo sviluppo denominata barriera di contatto. Più che prodotti dall’inconscio, essi sarebbero dunque meccanismi produttori dell’inconscio.
Con Bion viene pienamente riconosciuta al sogno quella capacità di generare nuovi significati della vita emotiva che Freud aveva solo in parte e tardivamente ammesso, legato com’era al suo assunto teorico di considerare il sogno come una deformazione di significati già presenti nell’inconscio (Riolo 1983).
Ma non tutti i sogni sognati, ricordati ed eventualmente raccontati hanno lo stesso valore per la pensabilità dell’esperienza emotiva. Adottare la prospettiva bioniana non significa considerare il contenuto manifesto del sogno come se raccontasse “la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità” (Meltzer 1984).
Per Bion il lavoro simbolopoietico della funzione alfa, nelle sue varie fasi, è soggetto a influenze contrastanti che tendono ad evitare invece che a favorire la consapevolezza di emozioni troppo dolorose. Il materiale onirico può essere inconsciamente usato come bugia - invece che per accostarsi alla verità - e la stessa funzione alfa può invertire il suo corso, come accade nei disturbi psicotici, trasformando anche i simboli già prodotti in elementi quasi concreti (simili agli elementi beta originari), non più utilizzabili per il pensiero ma destinati all’evacuazione nel corpo, nel comportamento o nel mondo esterno con modalità allucinatorie.
Alla luce degli sviluppi bioniani anche il posto del sogno in analisi viene in parte riconfigurato.
Mentre il sogno della notte è un tentativo di rendere pensabile l’esperienza emotiva del sognatore addormentato, nella seduta analitica il sogno raccontato dal paziente si inserisce nel contesto di un dialogo che ha come nucleo emotivo ciò che egli sta vivendo nella relazione con l’analista. È compito dell’analista cercare di sintonizzarsi con questa esperienza emotiva in atto per favorirne la simbolizzazione condivisa, mettendo la propria funzione alfa al servizio di quella del paziente grazie a una disposizione mentale definita da Bion reverie [], che integra il concetto freudiano di attenzione fluttuante.
L’analista, afferma Bion (1992), deve poter “sognare” l’analisi mentre questa avviene, ma naturalmente - precisa con un pizzico di umorismo - non deve addormentarsi. Obiettivo dell’analista è realizzare insieme al paziente una “trasformazione in sogno” (Ferro 2009) dei fatti della seduta. Tra questi fatti il racconto di un sogno ha un carattere speciale in quanto è espressione (più o meno riuscita) del lavoro onirico notturno del paziente e, soprattutto, in quanto può offrire al pensiero associativo della coppia analitica spunti inediti per esplorare nuove prospettive di senso (Bezoari e Ferro 1994).
Interpretare il sogno equivale per Freud a disfare i travisamenti del lavoro onirico notturno per risalire ai pensieri già presenti nell’inconscio del sognatore. Per Bion si tratta piuttosto di portare avanti il lavoro del sogno nella veglia, mettendo a frutto anche le potenzialità creative delle trasformazioni oniriche descritte da Freud (condensazione, spostamento, raffigurazione) per produrre nuovi pensieri, idonei a rappresentare l’esperienza emotiva in divenire. Come dice Ogden (2005) ispirandosi a Bion, scopo dell’analisi è migliorare nell’analizzando la capacità di “sognare i suoi sogni non sognati o interrotti”.
Bibliografia
Bezoari M., Ferro A. (1994). Il posto del sogno all’interno di una teoria del campo analitico. Riv.Psicoanal., 40, 251-272.
Bion W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza. Roma, Armando, 1972.
Bion W.R. (1992). Cogitations. Pensieri. Roma, Armando, 1996.
Ferro A. (2009). Trasformazioni in sogno e personaggi del campo psicoanalitico. Riv.Psicoanal., 55, 395-420.
Freud S. (1899). L’interpretazione dei sogni. O.S.F., 3.
Meltzer D. (1984). La vita onirica. Roma, Borla, 1989.
Ogden T. (2005). L’arte della psicoanalisi. Milano, Cortina, 2008.
Reverie, Spipedia enciclopedia SPIWEB https://www.spiweb.it/la-ricerca/ricerca/spipedia/
Riolo F. (1983). Sogno e teoria della conoscenza in psicoanalisi. Riv.Psicoanal., 29, 279-295.
NOTA.
A) FILOSOFIA E "SAPERE AUDE!" (1784). Ricordando W. R. Bion, non è male ricordare anche la lezione (di Kant e) del suo amico e filosofo H. J. Paton ("Kant’s metaphysic of experience", 1938). A scuola da Kant (https://www.academia.edu/12356078/KANT_FREUD_E_LA_BANALITA_DEL_MAL ): Wilfred Bion "rammentò sempre con gratitudine le conversazioni da lui avute col filosofo H. J. Paton" (Francesca Bion, 1982).
B) PSICOANALISI E RICERCA SCIENTIFICA. Ricordando il "contributo innovativo" di W. R. Bion (1897 - 1979) alle indicazioni di Freud, non è male ricordare anche il lavoro "consonante" di ricerca psicoanalitica e antropologica portato avanti da Elvio Fachinelli (1928-1989), sul tema della "mente estatica".
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. --- "IL MOVIMENTO DI UN’ANALISI" (NELLA "STANZA" DI FREUD) E IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (NELLA "NAVE" DI GALILEO GALILEI).5 settembre 2023, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E COSMOLOGIA:
"IL MOVIMENTO DI UN’ANALISI" (NELLA "STANZA" DI FREUD) E IL "DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI DEL MONDO" (NELLA "NAVE" DI GALILEO GALILEI).
Una nota sul tema, in memoria di Sigmund Freud (1939), Elvio Fachinelli (1989) e di Jean-Bertrand Pontalis (2013).
- PIANETATERRA: NAVIGAZIONE E "COSTRUZIONI NELL’ANALISI" (SIGMUND FREUD, 1937).
- "Finestre" (J.-B. Pontalis): "Spesso, quando ricevo un eventuale futuro paziente, vedo tessersi il canovaccio di un romanzo. Una storia di vita si delinea, con un’infanzia, con drammi, lutti, momenti di svolta, avvenimenti salienti e un ambiente sociale. Sono così convinto di capire, di afferrare i fili di un destino, che mi succede persino di anticipare quanto seguirà, come nella lettura di un romanzo.
 E poi bastano poche sedute e la storia si confonde, l’intelligibile cede il posto all’enigma, e io non sono più capace di raccontare niente.
E poi bastano poche sedute e la storia si confonde, l’intelligibile cede il posto all’enigma, e io non sono più capace di raccontare niente.
 Non so più con che cosa né con chi ho a che fare.
Non so più con che cosa né con chi ho a che fare.
 Avanziamo, l’uno e l’altro, nel buio.[...]
Avanziamo, l’uno e l’altro, nel buio.[...]
 Questo movimento che ci anima - il movimento del pensiero, della lingua, del sogno, della memoria, della parola, del desiderio - non potrà raccontare sé stesso. Tutt’al più potrà essere evocato. È possibile trasmettere il movimento di un’analisi? A questa condizione: che attraverso la mia voce si senta quella dell’altro."(J.-B. Pontalis, "Finestre", e/o 2001).
Questo movimento che ci anima - il movimento del pensiero, della lingua, del sogno, della memoria, della parola, del desiderio - non potrà raccontare sé stesso. Tutt’al più potrà essere evocato. È possibile trasmettere il movimento di un’analisi? A questa condizione: che attraverso la mia voce si senta quella dell’altro."(J.-B. Pontalis, "Finestre", e/o 2001).
FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI (*). Nella "#culla" di Freud, a ben considerare, c’è la #memoria della #rivoluzionescientifica, e, al contempo, ci sono le #tracce per una ripresa della #rivoluzionecopernicana kantiana e una #svolta_antropologica epocale: la sollecitazione pontalisiana a "trasmettere il movimento di un’analisi" è un grande invito a rileggere il "#Dialogo sopra i #due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano" (#GalileoGalilei, 1632) e riprendere il lavoro nella "stanza" della "grande nave":
- "[...] Con Freud, probabilmente, nessuno (né del ‘mondo’ psicoanalitico, né tantomeno del ‘mondo’ filosofico) ha ‘dialogato’ con più libertà di giudizio e onestà intellettuale di #ElvioFachinelli (1928-1989). E, come si sa, “essere giusti con Freud” non è affatto facile! [...] Grandezza e limiti di Freud: “Su Freud” (a c. di #LambertoBoni, Adelphi Edizioni, Milano 2012, e. 12, pp. 115) è un’ottima occasione per riconsiderare il percorso di Elvio Fachinelli e rendersi conto del suo lavoro (dal 1966 al 1989) per portare la psicoanalisi fuori dalla claudicanza e dalla cecità dell’orizzonte edipico.[...]" (cfr. FACHINELLI E FREUD NELLA “NAVE” DI GALILEI).
PSICOLOGIA, FILOSOFIA, E CRITICA DELLA RAGIONE "PURA":
USCIRE DALLO "STATO DI MINORITÀ"(I. KANT, 1784 - M. FOUCAULT, 1984).
- Una lettera di SigmundFreud a Siegmund Heinrich Foulkes, "padre della psicoanalisi dei gruppi"
SUL "MOVIMENTO DELL’ANALISI" (J.-B. PONTALIS) E SULLA "MATURITÀ" DELL’ ANALISTA,
QUESTA LA RISPOSTA DI FREUD (1° maggio 1932) A S. H. FOULKES:
- "[...] Ho l’impressione che voi prendiate un po’ troppo sul personale le precauzioni che la Società tedesca osserva riguardo ai nuovi membri. [...]
- Molto di ciò che voi indicate criticamente nella vostra lettera è purtroppo ben fondato. A me sembra che la più grande delusione dell’analisi sia il fatto che essa non produca un maggiore cambiamento negli analisti stessi. Nessuno ha ancora fatto oggetto di studio con quali mezzi gli analisti riescano ad eludere l’influenza dell’analisi sulla propria persona. Speriamo che ci siano altri e più forti motivi per tenere insieme i membri, oltre al comune rapporto con me, che naturalmente non potrebbe durare a lungo nella mia esistenza.[...]" (cfr. Centro Veneto di Psicoanalisi).
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO --- DIVINA COMMEDIA E MENTE ESTATICA! Ripensare "la figura di Gesù non tanto come una figura storica o come un personaggio letterario, ma come evento". La metamorfosi sulla via di Damasco (di Massimo Recalcati)10 agosto 2023, di Federico La Sala
La metamorfosi sulla via di Damasco
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 3 agosto 2023
Due studi recentissimi prolungano la fortuna contemporanea di Paolo di Tarso e della sua opera. Si tratta di Vincenzo Vitiello, Nel silenzio del padre (Salerno Editrice) e Metamorfosi necessaria di JoséTolentino de Mendoça (Vita e pensiero). Essi si aggiungono a una già ricca serie di lavori apparsi all’inizio del nuovo secolo che hanno visto impegnati autori del calibro di Badiou, Agamben e Zizek, per citare solo i più noti.
Ma cosa significa rileggere oggi San Paolo? Innanzitutto ripensare la figura di Gesù non tanto come una figura storica o come un personaggio letterario, ma come evento. Se c’è, infatti, un tema cruciale che viene ripreso da questi due testi è il seguente: non si può comprendere la parola di Gesù se non a partire dalla sua incidenza su chi la ascolta. Per questo Paolo assimila Gesù a un evento. Ma cos’è un evento? È qualcosa che scompagina le leggi consuete del mondo, è un taglio nel loro ordine, una frattura, un trauma. Più di preciso, per Paolo l’“evento Gesù” è stato innanzitutto un incontro.
Questo incontro precede il pensiero, precede la traduzione militante del messaggio cristiano, precede la vita stessa di Paolo perché la istituisce come nuova. Il libro di Tolentino dedica pagine toccanti a questo evento che la leggenda racconta come una caduta di cavallo di Saul, persecutore accanito dei cristiani, e della perdita della sua vista. Accecamento dell’Ego, destituzione del suo prestigio, caduta con la faccia a terra. Passaggio brusco da Saul - che nel suo etimo significa “il più grande” - a Paolo - che nel suo etimo significa “il più piccolo”. Tolentino lo descrive come un “drammatico contromano”.
Ma è solo dall’incontro con l’evento-Cristo che Paolo diventa Paolo. È, più in generale, solo da questo incontro che il cristiano diventa cristiano. Il credere sorge, dunque, da una esperienza di metamorfosi. Prima è l’incontro e poi la fede, non il contrario. È quello che scrive Vitiello quando parla della sovversione cristiana del rapporto tra uomo e Dio: non dall’uomo a Dio, ma da Dio all’uomo. Paolo lo afferma nella Lettera ai Filippesi evocando la kenosis di Dio: Gesù è l’esito dello svuotamento (abbassamento, indebolimento) di Dio, del suo farsi uomo. Il Verbo, come recita il prologo del Vangelo di Giovanni, si è fatto carne. Nondimeno, compito dell’uomo, per Paolo, resta quello di vivere nel nome della Legge perché il suo rispetto per la Torah non viene mai meno.
Il suo martirio, come ricorda Vitiello, rovescia quello di Antigone. Se l’eroina sofoclea, col suo gesto di rivolta nei confronti della Legge, intende denunciarne il carattere disumano, Paolo assume la propria morte non per negare ma per istituire la Legge. Prima dell’incontro con Cristo - prima del tempo della sua conversione - egli era un esecutore irreprensibile della Legge. Ebreo, figlio di ebrei, il suo Dio è il Dio dell’Antica alleanza che ha parlato per via dei profeti, dunque, come si descrive nella prima Lettera ai Galati, «ero molto più zelante delle mie stesse tradizioni patrie». Poi accade l’evento dell’incontro che sposta irreversibilmente la direzione della propria vita e con essa il senso stesso della Legge. In gioco è una esperienza mistica che ruota attorno a una chiamata.
La conversione provocata dalla chiamata, come ricorda Tolentino, attraverso le parole di Paolo stesso, si differenzia sia dalla domanda greca di sapere, sia da quella giudea dei “segni”. L’universo simbolico del sapere e quello immaginario dei segni vengono disarticolati dalla centralità che Paolo attribuisce alla dimensione reale dell’incontro, dell’evento-Cristo. Si tratta di una metamorfosi, dell’acquisizione di una nuova forma di vita. Per Tolentino la parola chiave alla quale apre la conversione è speranza: la speranza che la morte non sia l’ultima parola sulla vita, la speranza che s’incarna nella resurrezione di Cristo, nel dare morte alla morte. Ma questa speranza non assume mai le forme della rassicurazione o del rifugio. Sarà questa invece la lettura freudiana della religione come fuga dalla realtà, regressione infantile della vita, rifiuto della sua asprezza. Nella speranza, come viene sostenuta da Paolo, è tutto il contrario.
La fede non è affatto rifugio, ma tribolazione, non è rassicurazione ma angoscia, non è accasamento ma esodo. È quello che ha sottolineato anche Heidegger nella sua lettura di Paolo: «per la vita cristiana - scrive - non c’è alcuna sicurezza».
È il valore che Paolo nella Lettera ai romani riconosce alla testimonianza di Abramo. La speranza che egli incarna è “la speranza contro ogni speranza”, la “speranza che non vede” poiché se vedesse quello che spera, scrive Paolo, come potrebbe sperarlo?
Più di preciso, la lettura di Vitiello fa emergere come l’esperienza paolina della conversione implichi non solo una trasformazione del soggetto, ma anche del senso del tempo. L’evento del Messia modifica il suo ordine: il passato è morto, l’età del peccato e della morte è scaduta per sempre; l’avvenire si apre come giorno della resurrezione e della vita eterna.
È la differenza profonda tra la concezione ebraica del tempo e quella cristiana: nella cristologia paolina l’adesso - il “grande Oggi” di Rosenzweig -, è il Kairos rivelato dall’evento-Cristo. «L’ora viene, ed è adesso», recita il Vangelo di Giovanni: la salvezza del Regno non è domani, ma adesso, accade oggi e non in un futuro sempre a venire. Nessuno più di Paolo ha avuto l’idea del Messia come evento, incontro, contingenza che si rivela “adesso”, nella vita individuale come in quella collettiva.
È quello che Kierkegaard indicava come compito di ogni cristiano: essere contemporaneo a Cristo. Per questo cristianesimo e gnosticismo risultano, come fa notare Vitiello, radicalmente eterogeni. Se il figlio di Dio si è fatto carne è perché la carne di cui si è fatto onora il mondo, è “carne sacra”, ricorda ancora giustamente Vitiello, come sacro è il mondo.
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO. --- IL PUNTO DEL CAPITONE (LACAN), L’ESCA DI "POLONIO" LE ANGUILLE DI "AMLETO" (FREUD).1 febbraio 2023, di Federico La Sala
L’ESCA AL "POLONIO" E LA "CARPA DELLA VERITÀ": IL PUNTO DEL CAPITONE (LACAN) E LE ANGUILLE DI "AMLETO" (FREUD).
- PSICOANALISI COME SCIENZA (POSITIVISMO) "Sembra che tu abbia familiarità con il mio atteggiamento verso la filosofia (metafisica)... Non solo non ho talento per questo, ma anche rispetto. Segretamente - uno. Non si può dire molto ad alta voce - penso che la metafisica un giorno sarà condannata come fastidio, come abuso di pensiero" Freud, lettera allo psicologo Werner Achelis Oggi, 30 gennaio 1927 ("It seems that you are familiar with my attitude towards philosophy (metaphysics)...I not only have no talent for it but also no respect. Secretly - one You can’t say much out loud - I think metaphysics will one day be condemned as a nuisance, as an abuse of thought" Freud, letter to psychologist Werner Achelis This day, January 30, 1927).
- PSICOANALISI COME PSICANALISI LACANIANA (PLATONISMO): ’Psychoanalysis After Freud: Lacan’. Explore Lacan’s linguistic re-interpretation of Freud, & his understanding of neurosis, psychosis, human sexuality & the process of psychoanalytic therapy. Online course (FREUD MUSEUM LONDON)
- "Psychoanalysis After Freud: Lacan"?! Dove l’#etica? Cosa è possibile pensare dopo l’interpretazione di Lacan di "L’uomo Mosè e la religione monoteistica" di Freud? Non è meglio rimeditare il lavoro di Elvio Fachinelli ("La mente estatica", 1989)?
- LA SCOPERTA DELLA TOMBA DI TUTANKHAMON (1922), LA PSICOANALISI E L’ ARCHEOLOGIA. In memoria di Sigmund Freud (Freiberg, 6 maggio 1856 - Hampstead, 23 settembre 1939) e di Howard Carter (Londra, 9 maggio 1874 - Londra, 2 marzo 1939).
UN PUNTO DA APPROFONDIRE.Una citazione da le "Costruzioni in analisi" (S. #Freud, 1937):
- "[...] Diverso è il caso con gli oggetti psichici di cui l’analista vuole scoprire: la #preistoria. Qui si verifica regolarmente ciò che con gli oggetti archeologia avviene solo in pochissimi casi fortunati, come #Pompei o come la #tomba di #Tutankhamen. Tutto l’essenziale è conservato; anche ciò che appare assolutamente dimenticato è ancora presente in qualche modo e in qualche luogo, solo che è sepolto e reso inaccessibile all’individuo. In effetti, com’è noto, si può dubitare che una formazione psichica possa cadere realmente nella distruzione totale. È solo un problema di tecnica analitica riuscire a portare compiutamente alla luce ciò che è nascosto. [...]
 Ogni analista sa che nel corso del trattamento analitico le cose vanno ben diversamente e che entrambi i modi di lavorare procedono appaiati, uno sempre avanti, l’altro a ruota. L’analista termina un pezzo di costruzione, lo comunica all’analizzante in modo che agisca su di lui. Poi, a partire dal materiale nuovamente affluito, ne costruisce un altro, quindi procede allo
stesso modo nello scambio [Abwechslung] sino alla fine [...]
Ogni analista sa che nel corso del trattamento analitico le cose vanno ben diversamente e che entrambi i modi di lavorare procedono appaiati, uno sempre avanti, l’altro a ruota. L’analista termina un pezzo di costruzione, lo comunica all’analizzante in modo che agisca su di lui. Poi, a partire dal materiale nuovamente affluito, ne costruisce un altro, quindi procede allo
stesso modo nello scambio [Abwechslung] sino alla fine [...]
 In questo modo la costruzione falsa è messa fuori campo, come se non fosse nemmeno stata fatta; ma in alcuni casi abbiamo l’impressione, per usare le parole di Polonio, come di avere preso con l’esca della falsità una carpa di verità. Il pericolo di sviare il paziente suggestionandolo in modo da instillargli ciò cui noi crediamo, ma che egli non dovrebbe accettare, è stato certamente esagerato. [...]
In questo modo la costruzione falsa è messa fuori campo, come se non fosse nemmeno stata fatta; ma in alcuni casi abbiamo l’impressione, per usare le parole di Polonio, come di avere preso con l’esca della falsità una carpa di verità. Il pericolo di sviare il paziente suggestionandolo in modo da instillargli ciò cui noi crediamo, ma che egli non dovrebbe accettare, è stato certamente esagerato. [...]
 Senza vantarmi posso affermare che nella mia pratica non si è mai verificato simile abuso di “suggestione”. Da quanto detto sopra risulta, quindi, che non siamo in alcun modo inclini a trascurare gli indizi derivanti dalle reazioni del paziente, quando gli comunichiamo una nostra costruzione. Il punto va approfondito [...]" (S. Freud, "Costruzioni in analisi", trad. di Antonello Sciacchitano).
Senza vantarmi posso affermare che nella mia pratica non si è mai verificato simile abuso di “suggestione”. Da quanto detto sopra risulta, quindi, che non siamo in alcun modo inclini a trascurare gli indizi derivanti dalle reazioni del paziente, quando gli comunichiamo una nostra costruzione. Il punto va approfondito [...]" (S. Freud, "Costruzioni in analisi", trad. di Antonello Sciacchitano).
JACQUES LACAN E IL GIOCO DEL DEMIURGO PLATONICO. "IL PUNTO DI CAPITONE": "Al tempo di Lacan, i materassi erano fatti di lana e i materassai li facevano cucendo la fodera con dei punti tramite un ago ritorto. I punti che tengono insieme le due fodere e la lana si chiamano “punti di capitone”.
 Il punto di capitone è il nodo dell’imbottitura e Lacan ne fa la metafora del nodo che lega il piano dei significanti con il piano dei significati, altrimenti separati, come accade nella psicosi. [...] Lacan dice che il rapporto del significante e il significato è mobile, tende a disfarsi, invece nei punti in cui il significante si incrocia con il significato si producono effetti di senso. Il punto di capitone è la nozione necessaria per situare l’intenzione di significazione, cioè l’intenzione che mobiliterebbe il significante. Per colui che ascolta, ma anche per chi parla, quando si ascolta qualcosa che è stato detto è sempre nel momento successivo, in après coup, che si può accedere a quest’intenzione di capire qualcosa." (Cinzia Crosali, 2014).
Il punto di capitone è il nodo dell’imbottitura e Lacan ne fa la metafora del nodo che lega il piano dei significanti con il piano dei significati, altrimenti separati, come accade nella psicosi. [...] Lacan dice che il rapporto del significante e il significato è mobile, tende a disfarsi, invece nei punti in cui il significante si incrocia con il significato si producono effetti di senso. Il punto di capitone è la nozione necessaria per situare l’intenzione di significazione, cioè l’intenzione che mobiliterebbe il significante. Per colui che ascolta, ma anche per chi parla, quando si ascolta qualcosa che è stato detto è sempre nel momento successivo, in après coup, che si può accedere a quest’intenzione di capire qualcosa." (Cinzia Crosali, 2014).FREUD E LE ANGUILLE (BURATELLI maschi E CAPITONI femmine), E L’ANATOMIA DEGLI ORGANI RIPRODUTTIVI. TRIESTE 1876: "il giovane Sigmund Freud, grazie ad una borsa di studio ministeriale, svolge presso la Stazione Zoologica di S.Andrea una ricerca sul sistema riproduttivo dell’anguilla. Freud esamina circa 400 anguille e scrive la sua prima pubblicazione: Beobachtungen über Gestaltung und feineren Bau der als Hoden beschriebenen Lappenorgane des Aals (osservazioni sulla conformazione e intima costituzione dell’organo globoso dell’anguilla, descritto come testicolo)." (OGS-ISTITUTO DI OCEANOGRAFIA).
PSICOANALISI, "NEXOLOGIA", E DISAGIO DELLA CIVILTÀ: "[...] Il paradosso di Freud è stato quello di tentare una scienza dell’individuo [...]. E se il suo tentativo può dirsi, in parte, riuscito, ciò si deve al fatto che la sua non è stata una ricerca individualizzante; non è stata una ricerca di psicologia, nel senso stretto, nel senso classico della psicologia individuale. E’ stata sin dal principio una rilevazione dei nessi, dei rapporti peculiari attraverso i quali passa l’individuo singolo dalla sua nascita, e attraverso i quali egli si forma come individuo. In questo senso il termine psicoanalisi, da lui dato al campo di ricerca da lui dato al campo di ricerca messo in luce, è fuorviante, significa un aggancio e un compromesso con la disciplina accademica chiamata psicologia [...] Con Freud, invece si apre il campo di una ricerca sui rapporti interindividuali; comincia una sorta di nexologia umana (dal latino nexus: legame, intreccio), che include il corpo come parte in causa e interlocutore. Di essa, la psicoanalisi comunemente intesa è solo un momento parziale, limitato, anche se di grande fecondità. La sua prima linea di sviluppo, non l’unica, è in direzione dell’analisi della struttura familiare" (cfr. E. Fachinelli, "Il paradosso della ripetizione","L’erba voglio" - Rivista, n. 5, 1972; poi, in E. F., "Il bambino dalle uova d’oro", Feltrinelli, Milano, 1974).
Federico La Sala
-
>MEMORIA E STORIA: A 700 ANNI DALLA MORTE DI D. GONZALO RUIZ DI TOLEDO, "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023)", UNA BUONA OCCASIONE PER RI-ANALIZZARE L’OPERA DI "EL GRECO".25 gennaio 2023, di Federico La Sala
MEMORIA E STORIA DI LUNGA DURATA. APPUNTI SU PROBLEMI DI PATRIMONIO CULTURALE, ARTE, E ANTROPOLOGIA
- NELL’EUROPA DI IERI (XVI SECOLO) E DI OGGI (XXI SECOLO):
A) SPAGNA: A 700 ANNI DALLA MORTE DI D. GONZALO RUIZ DI TOLEDO, "SEÑOR DE ORGAZ (1323-2023)", UNA BUONA OCCASIONE PER RI-ANALIZZARE L’OPERA DI "EL GRECO" ("LA SEPOLTURA DEL CONTE DI ORGAZ", TOLEDO 1586 -1588) ... E PER RIMEDITARE LO STRAORDINARIO IMPEGNO RIFORMATORE (CARICO DI TEORIA E DI FUTURO) DI TERESA D’AVILA (1515-1582).
B) TERESA D’AVILA (Avila 1515 - Alba de Tormes 1582): "[...] Teresa (Teresa Sánchez de Cepeda Ávila y Ahumada) nasce in una famiglia ricca; il padre era figlio di un ebreo convertito - dunque tTeresa fu di origini ebree. La madre trasmette alla figlia l’amore per i romanzi cavallereschi, ma muore quando Teresa ha solo 13 anni.
Diventa una donna determinata, affascinante e trascinatrice, estrema nelle sue scelte e insieme capace di amministrare i monasteri e di trattare con diplomazia coi grandi dell’epoca. Da ragazza convince il fratello a fuggire per andare a combattere contro gli infedeli. Sempre col fratello scrive un romanzo cavalleresco; manifesta, insomma, subito due grandi amori della sua vita: la fede e la scrittura.
È l’epoca della grande crisi della Chiesa, che all’apice della propria magnificenza è percorsa da profonde inquietudini, divisa dalla predicazione di #Lutero e Juan de Valdés, una ferita profonda e interna. Teresa ha trent’anni all’epoca del Concilio di Trento (1545-1563), tappa di quella “rifondazione” della chiesa cattolica, che si impegna tanto nella guida delle anime, con la fondazione di nuovi ordini religiosi e la promozione di una rinnovata austerità e spiritualità, quanto nel controllo delle stesse, imponendo nuove e più severe regole monastiche e potenziando i tribunali dell’#Inquisizione. In in Spagna in particolare, dopo il culmine della potenza raggiunto sotto il regno di Carlo V (1500-1558), suo figlio Filippo II (1527-1598) si fa paladino della ortodossia cattolica. [...]" (Cfr. Maria Rosa Panté, "Teresa d’Avila", Enciclopedia delle donne)
C) CARMELITANI SCALZI: L’ULTIMA LEZIONE DI TERESA D’AVILA. A CONTURSI TERME, IN PROVINCIA DI SALERNO, NELLA TERRA DEL "PRINCIPE DI EBOLI" (Rui Gomes da Silva), L’ULTIMO MESSAGGIO DELL’ECUMENISMO RINASCIMENTALE (IN STATO DI PROGRESSIVO DEGRADO).
D) QUESTIONE ANTROPOLOGICA E PSICOANALISI: LA STORIA NON LA FANNO SOLO I PROFETI, MA ANCHE LE SIBILLE. Ricordando che l’interpretazione del messaggio evangelico di Teresa d’Avila è connessa alle "Meditazioni sul Cantico dei cantici" (e non all’androcentrismo della lettura paolina), ed è molto prossima a quella di Michelangelo Buonarroti e al suo "Tondo Doni" (e al suo Mosè), sollecita anche a riproblematizzare (Julia Kristeva, "Teresa, mon amour", 2009) il rapporto tra Freud e Lacan ("Encore", 1972-1973) ) e, infine, a portarsi oltre la logica del "superuomo" del cattolicesimo costantiniano!
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO - ALLA RICERCA DELLA LINGUA D’AMORE. Note a margine del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West e tra Sigmund Freud e Wilhelm Fliess.18 novembre 2022, di Federico La Sala
ALLA RICERCA DELLA LINGUA D’AMORE: LETTERATURA, PSICOANALISI, E QUESTIONE ANTROPOLOGICA.
Note a margine del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West e tra Sigmund Freud e Wilhelm Fliess...
PREMESSO CHE "Una stanza tutta per sé" è un saggio pubblicato nell’ottobre del 1929, e il romanzo Orlando ("Orlando: A Biography") era stato pubblicato l’anno prima, nel 1928, forse, può essere una buona traccia per ulteriori approfondimenti porre accanto e "coniugare" il carteggio tra "Judith, la sorella di Shakespeare", Virginia Woolf e Vita Sackville-West (“Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio”, Donzelli, 2019) e il carteggio tra "Guglielmo il Conquistatore", Sigmund Freud e Wilhelm Fliess ("Lettere a Wilhelm Fliess, 1887-1904", Boringhieri, 1986): nel fuoco della relazione e della ricerca delle due coppie sono proprio i temi dell’antropologia e del "disagio della civiltà" (S. Freud, 1929), con le loro profonde tragiche radici nel "Simposio" di Platone e nella tradizione del "platonismo per il popolo" (Nietzsche):
A) ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI: «Ho cominciato a considerare con attenzione il concetto di bisessualità e considero la tua idea in proposito come la più significativa per il mio lavoro, dopo quella di "difesa"» (S. Freud a W. Fliess, 04.01.1898).
B) "DE AMORE": L’AMORE E LA PAROLA. "[...] cosa succede e dove si può arrivare considerando il tradimento della tradizione amorosa/letteraria soltanto un punto di partenza? Il risultato naturale di questo anticonformismo - che non si interroga più sul conforme, quanto sull’autenticità di quel che resta, quando il conforme viene spazzato via - ha nell’immediato un nome: Orlando, il romanzo che Virginia scrive proprio in quegli anni (la cui musa è proprio Vita), che trasforma il celebre eroe in un essere che sperimenta il maschile e il femminile [...] La stesura di Orlando è un modo per Virginia di superare una crisi non solo letteraria appunto (in quel momento sta completando a fatica la stesura di alcuni saggi), ma anche il tentativo di sublimare la sua gelosia per Vita, di cui ormai ha imparato a riconoscere/misurare le distanze mutevoli, trasformandola in un personaggio, e dunque in qualcosa di eterno." (Caterina Venturini, "Ti nomino meglio che posso: la lingua d’amore di due donne libere. Sul carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West", Femministerie 26 settembre 2019).
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO --- FREUD E LACAN: RIPARTENDO DA LONDRA, con W. R. BION, RIPRENDERE LA VIA DELLA "METAFISICA DELL’ESPERIENZA DI KANT" ( H. J. PATON).20 ottobre 2022, di Federico La Sala
FREUD E LACAN: ATTO PSICOANALITICO, METAFISICA DELL’ESPERIENZA ED ETICA DELLA PSICOANALISI. Un omaggio al prof. di Filosofia, H. J. PATON, amico di Wilfred Bion ...
RIPARTENDO DA LONDRA, (J. Lacan, "LA PSICHIATRIA INGLESE E LA GUERRA", 1947) E RITENENDO IMPORTANTE OGGI PIù DI IERI, QUANTO SCRITTO nell’editoriale degli "Appunti" della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano (Giugno 2016), che l’atto_analitico è "un concetto nuovo" che si deve a Lacan: “L’atto psicoanalitico, mai visto né sentito se non da noi, vale a dire mai notato, e ancor meno messo in discussione, ecco che invece noi lo poniamo come il momento elettivo del passaggio dello psicoanalizzante a psicoanalista”; “Ciò che chiamiamo la seduta è un lasso di tempo in cui si tratta dello stabilirsi di un rapporto con la dimensione fuori tempo dell’inconscio [...]” (cfr. SLPcf), FORSE, POTREBBE essere una buona idea, per riflettere di nuovo sul "tempo e l’atto nella pratica della psicoanalisi", mettere a disposizione in lingua italiana le opere di H.J. PATON: 1). "Kant’s Metaphysics of Experience (1936); 2) "The Categorical Imperative" (1947).
STORIA E STORIOGRAFIA: "APPRENDERE DALL’ESPERIENZA". A ben vedere, il titolo dell’opera di W. R. BION offre una indicazione-chiave, carica di teoria: richiama "ovviamente" l’amicizia di Wilfred R. Bion con Herbert James Paton e le sue indicazioni sulla via critica dell’imperativo categorico e della metafisica dell’ esperienza di Kant" (e, freudianamente e assolutamente, non la via paolina del "Kant con Sade" di Lacan).
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- CON LACAN (ANCORA SOTTO LA LEGGE DI EDIPO): "LA LEGGE DELLA PAROLA". Dalla Bibbia alla psicoanalisi: il nuovo saggio di Massimo Recalcati (di Roberto Esposito).20 giugno 2022, di Federico La Sala
Dalla Bibbia alla psicoanalisi: il nuovo saggio di Massimo Recalcati
In "La legge della parola", lo psicoanalista rilegge alcuni episodi del Vecchio Testamento con gli strumenti di Freud e Lacan, facendo incontrare due linguaggi
di Roberto Esposito (la Repubblica, 15 giugno 2022).
- [Foto] Eugène Delacroix: La lotta di Giacobbe con l’angelo (1853-1861)
- Il libro. "La legge della parola" di Massimo Recalcati è edito da Einaudi (pagg. XIV - 386, euro 21)
Nella prima cappella a destra della Chiesa di Saint-Sulpice, a Parigi, vi è una pittura murale di Eugène Delacroix che ritrae la figura biblica della lotta di Giacobbe. L’identità del personaggio con cui si batte è misteriosa. Chi è l’essere che affronta in un corpo a corpo mortale? Un uomo, un angelo, un dio? Chiunque sia, in termini simbolici Giacobbe lotta contro se stesso, con la propria immagine speculare, col fantasma del proprio narcisismo. Secondo il racconto biblico, quando il combattimento finalmente termina, Giacobbe resta ferito all’anca. Quella ferita alla propria identità lo muta profondamente, dandogli un nuovo nome. Reciso un legame troppo vincolante con se stesso, egli adesso è pronto a incontrare l’Altro, ad aprirsi alla relazione.
È la lettura, profonda e suggestiva, che nel suo nuovo libro, La Legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi, edito da Einaudi, Massimo Recalcati fornisce di quell’episodio e, più in generale, del Libro. Come egli stesso spiega, non si tratta di un’interpretazione psicoanalitica della Bibbia e neanche di una declinazione religiosa della psicoanalisi. Ma di un incontro tra linguaggi diversi, che tali restano, reso possibile da un presupposto comune: esiste una legge non al servizio della morte - della colpa e del castigo -, ma destinata a generare nuova vita.
Si tratta della legge della parola. Essa chiede all’uomo di non volersi fare Dio, di ammettere la propria finitezza, di riconoscere la tensione che attraversa la sua esperienza, umanizzandola. La stessa che per Freud articola pulsione di vita e pulsione di morte e per Lacan distingue desiderio e godimento. Solo superando l’identificazione narcisistica con la propria immagine, come fa Giacobbe, l’uomo può riconoscere il ritmo dell’esistenza nell’alternanza tra pienezza e mancanza, gioia e dolore, vittoria e sconfitta. La rinuncia al godimento assoluto - comunque non alla nostra portata - apre la porta al desiderio. Soltanto l’esperienza di una lesione profonda - abbandono, perdita, lutto - può rendere di nuovo generativa la vita umana.
Da questa prospettiva - maturata in una rivisitazione particolarmente creativa della psicoanalisi lacaniana - Recalcati rilegge gli episodi più intensi della Bibbia. Al centro di tutti torna, declinato in modi diversi, il rapporto costitutivo tra desiderio e divisione. Il rifiuto della fusione con se stessi a favore dell’alterità. Da parte dell’uomo, ma anche di Dio. Che, nella genesi, crea il mondo separandolo da sé. La luce di cui lo inonda coincide con la forza simbolica di una parola che rompe la notte dell’indifferenziato, generando l’infinita molteplicità della vita. Come anche nella psicoanalisi freudiana e lacaniana, la parola che Dio rivolge all’uomo non è solo comunicazione, ma rivelazione. Luce e taglio. Creando il mondo Dio si ritira, rinuncia all’onnipotenza, come hanno diversamente sostenuto Lévinas, Bonhoeffer, Simone Weil. Con un secondo taglio immette la differenza, anche sessuale, nelle forme viventi. Separa la vita umana dalla nuda vita biologica.
Ma, contro ogni retorica umanistica, la vita umana non nasce integra. Sperimenta l’odio prima dell’amore, la vendetta prima del perdono. Il fratricidio di Caino apre la storia dell’uomo nel segno della violenza assoluta. Egli uccide il fratello per essere solo, per essere tutto.
Come sostiene Lacan, Caino è l’altro nome di Narciso. Riconosce in Abele la propria immagine irraggiungibile e la distrugge. Dio lo condanna, per poi salvarlo, spezzando la catena della violenza reciproca. La violenza divina non è mai cieca. Il diluvio che scatena sul mondo corrotto consente a Noè di rigenerarlo. Così come il crollo della torre di Babele e del suo sogno di monolinguismo ripristina la molteplicità delle lingue. Perfino nell’episodio, in prima istanza incomprensibile, del sacrificio di Isacco, la mano di Dio si arresta, si ritira, sostituendo un montone al figlio prediletto di Abramo. Dio rinuncia al dominio, interrompendo la spirale del sacrificio.
Il rapporto dell’uomo con Dio resta problematico. Il racconto biblico non nasconde la tensione. Al contrario, come farà la psicoanalisi, la rivela. Il grido di Giobbe, a metà tra blasfemia e preghiera, reclama una spiegazione da Dio per la sofferenza ingiusta. Anch’egli non è una figura della rassegnazione, della pazienza, ma della lotta. In termini psicoanalitici, la sua vicenda attesta che, se la sofferenza umana è ineliminabile, attraverso il sintomo la si può interpretare, tradurre, decifrare. Il libro sapienziale di Qohelet spinge al culmine la consapevolezza dell’inaggirabilità della morte e dunque della vanità della vita. Il suo eterno oscillare tra splendore e polvere. Ma invita, proprio perciò, a godere di quanto si ha. Non nell’attesa, ma ora, adesso.
Per questo Recalcati collega Qohelet al Cantico dei cantici. In questo esplode la gioia dell’amore, la festa degli amanti. Che, però, non infrange la legge del desiderio, non s’inscrive nella logica del godimento assoluto. Anzi lo dichiara impossibile. Impossibile è la fusione in Uno di coloro che restano Due, differenziando la disponibilità femminile dal sogno di possesso maschile. La Bibbia rivela la problematicità, ma anche la necessità, del rapporto. Come insegna il racconto paradossale di Giona, il più umano dei profeti, è difficile rispondere alla chiamata di Dio, ma tale difficoltà custodisce il mistero dell’esistenza.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA NASCITA DELL’ESSERE UMANO E IL GIOCO DEL ROCCHETTO. Al di là del giogo di Edipo e Giocasta.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - L’ETICA DELLA PSICOANALISI. A proposito di Freud, Jung, Lacan, e Fachinelli.5 giugno 2022, di Federico La Sala
ARCHEOLOGIA FILOSOFICA E RELIGIONE. Appunti intorno a "L’uomo Mosè" (Freud) e "l’etica della psicoanalisi" (J. Lacan):
"A PROPOSITO DI JUNG" (Elvio Fachinelli, 1967) E A PROPOSITO DI LACAN (E. Fachinelli, 1989). *
COSMOLOGIA E COSMOTEANDRIA. Forse è giunto, finalmente, il tempo della svolta antropologica e del sorgere della Terra: deporre l’elmo di Costantino e parlare nella luce del logos (eu-angelo) e non nel buio del logo (van-gelo)!
FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO DELLA MITOLOGIA. Oggi, forse, è tempo di riprendere il cammino e, come indicato da Michael Maier, portarsi oltre Tebe d’Egitto e di Grecia, oltre l’orizzonte tragico di Edipo, l’eroe dai piedi gonfi , oltre la stazione dell’ Emblema XXXIX ("Atalanta Fugiens", 1618), nella direzione di Nietzsche: "Ecce Homo. Come si diviene ciò che si è" (1888) e, finalmente, rileggere le note del 1982 su "Così parlò Edipo a Cuernevaca" e riflettere su quanto proviene dalla "voce" (1982) di Franca Ongaro Basaglia: "un uomo più una donna ha prodotto, per secoli, un uomo" (1978). **
"FREUD O JUNG?" (E. GLOVER, 1950). La lingua batte dove il dente duole: è "un’impostazione vicina a quella esigenza antropologica dell’estatico" su cui Elvio Fachinelli richiamava l’attenzione (già dal 1975, con le note critiche sul "quinto privilegio dell’inconscio" e nel 1989, con il suo ultimo lavoro, dedicato a "La mente estatica" - alla mente accogliente).
* Per Jung, si cfr. E. Fachinelli, "Il bambino dalle uova d’oro. Brevi scritti con testi di Freud, Reich, Benjamin e Rose Thè", Feltrinelli, Milano, 1974, pp. 71-75; per Lacan, si cfr. E. Fachinelli, "Lacan e la Cosa", in "La mente estatica", Adelphi, Milano 1989, pp. 181-195.
** Franca Ongaro Basaglia, "Una voce Riflessioni sulla donna", Il Saggiatore, Milano 1982.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- CINEMA, PLATONISMO, E COSTITUZIONE. Lacan e l’atto di vedere: l’occhio di Wenders (di Felice Cimatti).2 maggio 2022, di Federico La Sala
CINEMA, PLATONISMO, E COSTITUZIONE.
- WITTGENSTEIN (“l’occhio in realtà non lo vedi. E nulla nel campo visivo fa concludere che esso sia visto da un occhio” 5.633) E IL “MISTERO PROFONDO” DELLO SGUARDO SOVRANO. “L’Io è il mistero profondo”, “e non dell’io in senso psicologico”(L. W., Quaderni 1914-1916)
L’occhio di Wenders
di Felice Cimatti (Fata Morgana web, 25 Aprile 2022)
- [Foto] L’atto di vedere di Wim Wenders.
- Riferimenti bibliografici: J. Lacan, Altri scritti, a cura di A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2013; Wim Wenders, L’atto di vedere, Meltemi Editore, Milano 2022.
«L’occhio» scriveva Jacques Lacan in un breve testo del 1961 dedicato a Maurice Merleau-Ponty, «è fatto proprio per non vedere» (Lacan 2013, p. 183). L’occhio, ovviamente, vede, tuttavia questo non vuol dire che sia fatto per vedere, nel senso usuale del verbo “vedere”. Il vedere, nella nostra tradizione, è il gesto sovrano attraverso cui il corpo del soggetto percettivo prende possesso del mondo; infatti, nella vista l’umano “abbraccia” con lo sguardo il campo del visibile che si offre a lui in tutta la sua estensione. Così lo spettacolo del mondo è l’oggetto che corrisponde al soggetto che lo contempla. Da notare che la posizione del soggetto dello sguardo è esterna rispetto a ciò che sta osservando, come se occupasse da una posizione privilegiata (secondo il Dizionario online Treccani vedere significa appunto “percepire stimoli esterni per mezzo della funzione visiva”). Chi vede è nel mondo, ma come se, in fondo, non ne facesse parte in senso proprio. C’è il mondo, e c’è chi lo vede, il soggetto.
Questo radicale dualismo produce, tuttavia, un effetto inaspettato, e forse è proprio riferendosi a questo effetto che Lacan può sostenere che l’occhio non è fatto per vedere: siccome l’occhio che guarda non ritiene di fare parte del mondo che sta osservando, ne segue che quello stesso occhio, alla fine, non riesce a partecipare veramente a ciò che vede: quest’occhio sovrano finisce per essere un occhio disattento perché troppo lontano da ciò che sta vedendo. Come dice in un’intervista Wim Wenders: «Senza dubbio l’intorpidimento del pubblico si sta estendendo; e i film diventano sempre meno “visibili”, per così dire. Non è un caso che l’ironia o le sottigliezze siano merce sempre più rara. E questo deriva dalla sazietà, dalla mole delle immagini riversate sul pubblico, dal fatto che ascoltando e guardando troppo, tutte le nostre impressioni vengono eccitate al massimo. Ogni genere di complessità, di diversità viene spazzato via» (Wenders 2022, p. 30).
Per vedere la complessità serve tempo, attenzione, pazienza, soprattutto vicinanza. Qualità che l’occhio sovrano non si può permettere, ché anzi può dirsi sovrano solo se rifiuta ogni vicinanza con ciò che sta vedendo. In questo senso il vedere in senso proprio, il vedere tattile, ravvicinato, che si “sporca” con il visibile, è al contrario un vedere che si lascia trasformare da ciò che vede. Si tratta di un vedere che non sa già in anticipo che cosa è che si sta vedendo, un vedere, cioè, che è tanto più libero quanto più è disposto a rinunciare alla posizione esterna e sovrana che, invece, qualifica il vedere che si colloca fuori del visibile. Il cinema, per Wenders, è appunto questo esperimento in cui qualcosa si offre alla vita, ma senza predeterminare che cos’è che si sta offrendo alla vista:
- Il film ovviamente è un atto di violenza, o rischia di diventarlo in ogni tappa del suo processo. Partiamo dalla fine: a film terminato, nel momento in cui lo si proietta, è un atto di violenza se, anziché offrire allo spettatore immagini da vedere liberamente, prescrive loro ciò che devono vedere. E questo è senza dubbio un rischio latente nel cinema. Il caso estremo è la pubblicità o il film di propaganda [...]. Esistono ovviamente anche film che lasciano molta libertà allo spettatore, la libertà di ricostruire da sé il proprio film, o di vedere un certo film. Non si presentano come una entità chiusa che passa sullo schermo, non esercitano alcuna costrizione sullo spettatore, gli offrono libertà. Questi film esistono, e io faccio ogni sforzo perché anche i miei siano così, voglio che si formino anzitutto nella mente degli spettatori, che non prescrivano: “Adesso guarda questo e nient’altro!” Oppure: “Questo deve essere interpretato così”. Non devono prescrivere niente, bensì stimolare la sensibilità visiva dello spettatore, allargare la visuale, come nella vita. Riuscire in questo non è facile, perché nel momento in cui si racconta una storia si seleziona una porzione di visualità. E raccontare storie anche per me è un problema, perché significa correre il rischio della limitazione, la tendenza alla semplificazione (ivi, pp. 53-54).
Si tratta di offrire qualcosa alla vista dello spettatore, evitando però che quanto si offre sia così saturo di “visibile” - così pieno di immagini, di sequenze visive, di potenza immaginaria - da impedire, paradossalmente, di vederlo. Il cineasta, per Wenders, lavora con il visibile, ma non per guidare lo sguardo dello spettatore, al contrario, per liberarlo dall’illusione della visione sovrana, piena di sé, lontana e supponente. La posta in gioco è liberare lo sguardo. O, per usare ancora la curiosa formula lacaniana, per liberarlo dalla credenza che l’occhio sia fatto per vedere. È per questa ragione che per Wenders il cinema è così legato alla contingenza, perché il bisogno di evitare la «manipolazione» non vale solo nei confronti dello spettatore, ma anche del regista rispetto al “proprio” stesso film: «Ogni giorno, mi trovo con la macchina da presa in un luogo determinato che mi dà qualcosa, sono profondamente legato, anche esposto, a una realtà che mi nutre. C’è sempre un paesaggio, oggetti, uccelli che volano attraversando il campo di ripresa, c’è qualcuno dietro la macchina da presa, ci sono colori e forme, c’è sempre una realtà presente» (ivi, pp. 57-58). In questo senso il vedere non sovrano, distaccato e dualistico, è un vedere tattile, sempre esposto all’urto imprevedibile con un evento fortuito: «Un paesaggio, oggetti, uccelli che volano attraversando il campo di ripresa».
- [Foto] Paris, Texas (Wenders, 1984).
L’occhio, per Wenders, vede solo se tocca ed è toccato. Solo se, per così dire, si lascia sporcare dal visibile. Allo stesso tempo questo vedere tattile, da scultore più che da pittore, richiede un continuo esercizio di allontanamento dal rischio di assumere una posizione definitiva sul mondo: se il soggetto sovrano è fuori dal mondo, il vedere alla Wenders è un vedere mobile, vagabondo, irrequieto, perché il visibile è sempre più ricco del nostro bisogno di fissarlo in un’immagine, per quanto splendida e definitiva:
- Mi sembra [...] che il bisogno di muoversi nasca come da una forza centrifuga interiore che ti espelle all’esterno, allontanandoti da un centro che qualcuno potrebbe definire una patria; l’allontanarsi dal centro dà soddisfazione, ma pone al contempo, per lo meno, il problema del ritorno. Viaggiare è per definizione sia un avvicinamento che un allontanamento. Nel mio primo film non c’era una riflessione matura su questa polarità. Ma il senso del viaggio, di partire e andare, diventa sempre più esplicito; e con ciò anche la possibilità del ritorno: mi chiedo se il senso del viaggio non sia in fondo più nel tornare, dopo aver preso le distanze per vedere meglio, o semplicemente per potere vedere (ivi, p. 59).
Per «poter vedere» occorre allontanarsi dal visibile, ma anche ritornarci. Si tratta di un vedere che riesce propriamente a vedere solo nel movimento fra queste due posizioni, solo oscillando fra partire e tornare, così come una mano, per esplorare un oggetto, lo deve percorrere in tutte le dimensioni. Wenders, così, può rimanere fedele all’esigenza fondamentale di non manipolare lo sguardo dello spettatore solo “costringendolo” (ed è curioso, perché anche questa è una forma di manipolazione) a non fermarsi su un’immagine, solo facendolo “viaggiare” fra le immagini. Si tratta sempre della stessa operazione, rinunciare alla posizione sovrana dello sguardo, rinunciare al proprio potere di tirarsi fuori dal mondo. Si tratta di stare nel mondo, raccontandolo attraverso le immagini. Si tratta, in sostanza, di mettere in movimento le cose, cioè, appunto, liberarle dalla fissità a cui lo sguardo sovrano le costringe:
- E con quali strumenti si può raccontare oggi se non con le immagini? Ovvero, come fare per mettere in movimento le cose? Io non ragiono affatto in termini deduttivi, non posso porre un postulato e derivare da quello una serie di deduzioni. Posso solo pensare al movimento mentre lo realizzo, e verificare così anche la direzione del movimento. E solo nel cinema, nella realizzazione di un film, con le immagini, si assume come metodo quello di mettere le cose in movimento, da un punto all’altro (ivi, p. 61).
«Come fare per mettere in movimento le cose?», è questa la domanda fondamentale, e non solo per il cinema di Wenders. Una domanda del tutto analoga a quest’altra: come fare per tornare a vedere il mondo? E quindi, rovesciandola? Che posizione deve assumere il soggetto dello sguardo sovrano perché il mondo possa farsi vedere? In effetti, come dice Wenders, «le città hanno reso invisibile la terra» (ivi, p. 136), ossia, il nostro modo di vedere il mondo come se fosse il nostro mondo, cioè come nient’altro che l’oggetto della nostra sovrana potenza visiva, ha finito per rendere invisibile la terra. Si tratta di invertire questo movimento, restituire la visibilità al mondo, e quindi destituire la posizione privilegiata dello sguardo umano sul mondo:
- Una volta, nel deserto del Mojave in California, vidi un cartello arrugginito, una sorta di spot pubblicitario, molto lontano dalla strada. Era piantato nel nulla, e le sue grandi lettere sbiadite annunciavano: Western World Development: slots 410-460. Qualcuno doveva aver progettato proprio in quel lembo di deserto una città. Il paesaggio circostante era completamente arido, si vedeva solo qualche sparuto cactus. Provai a immaginare lì una città: osservando quella distesa avevo quasi l’impressione che fosse effettivamente esistita, e soltanto scomparsa. Una cosa però non potevo ignorare: la regione era molto più antica di qualsiasi insediamento, quindi era anche inessenziale sapere se fosse o meno esistito un agglomerato urbano (ibidem).
Torniamo, allora, alla paradossale affermazione di Lacan, di un occhio che non è fatto per vedere, al contrario, di un occhio che deve lasciare al mondo la possibilità di farsi vedere e, soprattutto, di un occhio che si destituisce affinché sia il mondo stesso a vedere. Lo sguardo sovrano vede cose, vede e costruisce oggetti: l’occhio di Wenders, invece, cerca - facendo muovere le cose - di immaginare il movimento contrario; così, parlando ad un congresso di architetti, li esorta a «creare spazi liberi per conservare il vuoto, affinché la sovrabbondanza non ci accechi, e il vuoto giovi al nostro ristoro» (ivi, p. 137). Vedere il vuoto, cioè vedere il vuoto non come assenza di qualcosa, bensì vedere il vuoto come presenza, come pienezza di mondo e di vita: «Per me, vedere significa sempre immergersi nel mondo; pensare, invece, prenderne le distanze» (ivi, p. 72). A che il mondo sia, a questo serve l’occhio. "L’atto di vedere" di Wim Wenders
- [Foto] Fino alla fine del mondo (Wenders, 1991).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET. Due note
"PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO.
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
Federico La Sala
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- PSICOANALISI E ANTROPOLOGIA: L’UOMO VITRUVIANO, LA DIGNITA’ DELL’UOMO, E LA DIGNITA’ DELLA DONNA.4 gennaio 2022, di Federico La Sala
QUESTIONE ANTROPOLOGICA, ANTROPOLOGIA CULTURALE, ARTE E PSICOANALISI...
L’UOMO VITRUVIANO, LA DIGNITA’ DELL’UOMO, E LA DIGNITA’ DELLA DONNA.
In memoria di Franca Ongaro Basaglia e Ida Magli....
Con l’anno nuovo e l’arrivo dei Magi presso la #sacrafamiglia, è proprio bene richiamare l’attenzione sulle parole del Salmo (8: 4-8): “Che cos’è l’uomo che tu n’abbia memoria? e il figliuol dell’uomo che tu ne prenda cura! Eppure tu l’hai fatto poco minor di Dio..”; e, lodevolissimamente, sollecitare a riflettere sul tema e sul significato di "uomo" e di "figliuol dell’uomo".
Ma di quale uomo si parla? Si parla solo di andrologia?
Riprendendo "l’uomo vitruviano", Leonardo ha fatto un disegno, ma l’industria "culturale" di ieri e di oggi ne ha fatto un mito, che associato alla generica e generale parola di "uomo" e "figlio dell’uomo" ha guidato e guida ancora l’immaginazione filosofica, teologica, artistica dei "diritti dell’uomo"!
Ma cosa "nasconde" questa mitizzazione e idolatrizzazione dell’ Uomo Vitruviano (dello stesso tempo di Leonardo e Raffaello, vedere l’altra faccia del quadro (1510), quello del Sapiente di Charles de Bouelles.? Semplimente "l’altra metà del cielo" è confinata nello stadio dello specchio, nello stato di minorità.
Luce Irigaray, in occasione dell’ 8 marzo del 2004, sul "Perché il pianeta donna non è stato ancora esplorato a fondo", ricordava: “[...] Mafalda a suo padre che sostiene che “l’occhio di Dio ci vede tutti uguali”: “Ma chi è il suo oculista?” lei gli chiede“.
IL MONDO E’ UNO. Non è più tempo né di conquistatori (il ’vecchio’ gioco di "Freud o Jung?", alla Eduard Glover) né di colonizzati (Cuernavaca). Una antropologia (e una cristologia) al di là dell’orizzonte edipico e della cosmoteandria andrologica (Dante 2021 insegna) è già nata: Giuditta ha tagliato la testa ad Oloferne e la critica della demitizzazione non solo della "nascita dell’eroe" (Otto Rank) ma anche della stessa figura di Freud e delle strutture chiesastiche della psicoanalisi (si vedano le preziose ricerche e il lavoro investigativo di Michele Lualdi) ha aperto porte e finestre sugli infiniti universi...
Dall’alto della mia ignoranza, non è più il tempo di esportazione né di peste né di democrazia! Sigmund Freud da Londra se ne sta "sulla spiaggia" di Maresfield e guarda compiaciuto il cielo stellato (Kant) e sorride: la claustrofilia è finita e ha capito che "la mente estatica" (Elvio Fachinelli) è la via di una formazione cosmica e di un’amicizia stellare...
-
> "PERVERSIONI" --- Sesso, erotismo e sentimenti. La legge del porno (di Vanni Codeluppi).).13 maggio 2021, di Federico La Sala
La legge del porno
di Vanni Codeluppi (Doppiozero, 11.05.2021).
Come mai Beppe Grillo ha realizzato un video con il quale intendeva scagionare dalle accuse di violenza sessuale suo figlio e invece probabilmente ha inguaiato ancora di più quest’ultimo? Non sappiamo come questa vicenda finirà sul piano giudiziario, ma è interessante chiedersi come mai un comunicatore dalla lunga esperienza come lui è incappato in questo errore. Le ragioni possono essere diverse, ma una è meritevole di riflessione: Grillo probabilmente si è fatto influenzare da quello che pensano i giovani e ha scambiato le idee di questi per qualcosa che viene condiviso dall’intera società. Perciò ha fatto suoi i pensieri dei giovani, ritenendo che giocassero a favore di suo figlio. Nella società invece continua a essere predominante una legge morale che è differente, ma che è quella che trova una traduzione nella legge giudiziaria.
I giovani di oggi ritengono che sia normale adottare quella che possiamo chiamare “la legge del porno”. La possiamo chiamare così perché è frutto di quella massiccia diffusione di contenuti pornografici che è avvenuta negli ultimi anni grazie al sempre maggiore utilizzo del Web ed è stata analizzata da Marco Menicocci in Pornografia di massa (Altravista 2014). I dati disponibili su questo fenomeno sono scarsi, ma si pensi che negli Stati Uniti a novembre 2020 la parola “pornhub” è stata più ricercata su Google di “coronavirus” e “Trump”.
Questo fenomeno è particolarmente grave in un Paese come l’Italia, nel quale da sempre l’educazione sessuale non esiste e il processo di acculturazione dei più giovani rispetto al sesso viene in gran parte svolto da parte dei media. È però ben differente l’acculturazione al sesso del passato, basata sulla lettura occasionale di un fumetto o di un giornaletto illustrato oppure sulla visione di un film in un cinema specializzato, da quella che è presente nell’attuale era digitale. Una volta la società in qualche misura censurava e limitava l’esposizione al materiale pornografico, mentre oggi rispetto a ciò non esiste praticamente nessun vincolo. Va considerato che oggi le persone si rapportano al Web per molte ore ogni giorno, la metà degli adolescenti per più di cinque ore al giorno (DAD esclusa), secondo una recente indagine della Fondazione PRO. Inoltre, la potenza comunicativa dei media digitali odierni è decisamente superiore rispetto a quella dei media del passato.
I nuovi media, infatti, sono estremamente ricchi sul piano linguistico e offrono a un giovane di oggi un gigantesco supermercato liberamente accessibile sui cui scaffali si possono trovare pratiche sessuali di ogni genere. È ovvio perciò che tali pratiche vengano scambiate da persone facilmente influenzabili come i più giovani per la norma condivisa nella società.
Il vero problema però è che da molto tempo i materiali di tipo pornografico contengono una ideologia fortemente maschilista che prevede che la donna rivesta un ruolo subordinato e passivo. Forse perché sono nati come materiali prodotti da uomini per essere consumati da altri uomini . Sta di fatto che, come scriveva qualche tempo fa Pietro Adamo nel volume Il porno di massa (Cortina, 2004), «Almeno da metà anni Novanta la messa in scena hard ha privilegiato una potente e prepotente iconografia della violenza, organizzata in massima parte su meccanismi di esplicita subordinazione della femmina da parte del maschio». Negli ultimi anni, come si è detto, il consumo di materiale pornografico si è ampliato e ciò ha comportato che al suo interno sia entrata anche una audience femminile. Il porno continua però a essere caratterizzato da un’ideologia maschilista e le donne che lo consumano l’accettano solitamente anch’esse come qualcosa di normale.
Con la diffusione del consumo di materiale porno attraverso i potenti strumenti digitali di oggi tale ideologia si è rafforzata. E a volte si traduce in concreti comportamenti violenti, come è dimostrato dai sempre più frequenti stupri di gruppo. La scena di una gang bang in cui una donna si accoppia con molti uomini, se vista tante volte, può diventare qualcosa da praticare in un normale sabato sera. Questo non vuol dire naturalmente che chi guarda del materiale pornografico sia destinato a diventare uno stupratore. Vuol dire però che l’attuale iperconsumo di pornografia via Web “normalizza” in misura crescente la violenza verso le donne.
Perché nella cultura sociale si creano degli standard di riferimento per i comportamenti e questi vengono progressivamente condivisi. Non stiamo parlando dell’esistenza di un rapporto causa-effetto tra un messaggio pornografico e dei comportamenti illeciti sul piano morale, ma del fatto che i messaggi si sommano e sommandosi potenziano i loro effetti nella società. L’influenza di un singolo messaggio è trascurabile, ma non lo è quella di migliaia di messaggi. I quali producono pertanto nuovi standard all’interno della cultura sociale.
 Non è un caso che dall’indagine Eurispes Sesso, erotismo e sentimenti, i giovani fuori dagli schemi di qualche tempo fa sia emerso come nelle coppie di giovani sposi intervistate più del 70% delle persone consuma abitualmente materiale pornografico, il 44% tradisce il proprio partner e quasi la metà vorrebbe ricorrere a pratiche sadomasochistiche.
Non è un caso che dall’indagine Eurispes Sesso, erotismo e sentimenti, i giovani fuori dagli schemi di qualche tempo fa sia emerso come nelle coppie di giovani sposi intervistate più del 70% delle persone consuma abitualmente materiale pornografico, il 44% tradisce il proprio partner e quasi la metà vorrebbe ricorrere a pratiche sadomasochistiche.Possiamo dire pertanto che da una decina d’anni, cioè da quando l’utilizzo di Pornhub, YouPorn e altri siti Web simili si è diffuso a livello di massa, nella società è nata anche una nuova morale sessuale. Una morale che abbiamo chiamato “la legge del porno” e che viene spesso condivisa da chi si è acculturato al suo interno al mondo del sesso. Generando così nella società una vera e propria frattura culturale, ma anche probabilmente dando vita a molti dei recenti fatti di cronaca nei quali le donne rivestono il ruolo di vittima.
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LÀ DELL’EDIPO --- IL LAVORO DI FACHINELLI E "UNA CURIOSA IMMOBILITÀ". Sergio Benvenuto "gioca" a mettersi "alla pari con Lacan!".1 maggio 2021, di Federico La Sala
UN SASSO NELLO STOMACO DELLA PSICANALISI: IL “CASO” DELLO “PSICANALISTA «COL MAGNETOFONO»”!
- Una nota a margine dell’art. di Sergio Benvenuto (“Ti metti alla pari con Lacan! Patafisica psicoanalitica”, Le parole e le cose, 26 aprile 2021)
«Disse Freud: “Tre sono i mestieri impossibili: governare, educare, psicoanalizzare”. Tutte e tre sono attività che hanno a che fare con l’inconscio. E proprio per questo non possono essere attività scientifiche. Ciò non toglie che il politico, l’educatore e lo psicoanalista debbano conoscere le scienze che li riguardano, debbano ispirarsi a esse, ma non sono essi stessi scienziati. Queste pratiche di cura sono aperte a tutte le alee della contingenza: ogni società e ogni epoca è diversa dall’altra, ogni educando è diverso dall’altro, ogni analizzante è diverso dall’altro. Guai generalizzare! La scienza generalizza, le pratiche di cura particolarizzano.» (Sergio Benvenuto, “Ti metti alla pari con Lacan! Patafisica psicoanalitica”, Le parole e le cose, 26 aprile 2021).
ACCOLTA QUESTA PREMESSA che ci colloca in un orizzonte-paradigma che presuppone e accetta la distinzione tra “le scienze” e “le pratiche”, per uscire da “un certo dogmatismo in psicoanalisi” (come dal “dogmatismo settario marxista”), forse, è proprio opportuno, per cercare di portarci “sulla spiaggia” e ristabilire il contatto con il mare aperto, ricordare il “caso” dello “psicoanalista «col magnetofono»”, Elvio Fachinelli!
UNA CURIOSA IMMOBILITA’. Nel 1977, Fachinelli pubblica il testo di uno straodinario caso, quello di “J.-J. Abrahams. L’UOMO COL MAGNETOFONO dramma in un atto con grida d’aiuto di uno psicoanalista, con note di J.-P. Sartre, J.-B. Pontalis, B. Pingaud e E. Fachinelli” (edizioni L’ERBA VOGLIO). Nel suo intervento, dal titolo “La parola contaminata”, egli scrive: “Leggendo i commenti preposti (nell’edizione originale di «Les Temps Modernes», 1969), al testo di Abrahams, si ha ora il seno di una curiosa immobilità. Sartre pone una domanda, parziale se si vuole, ma pungente: quella della violenza (o del potere) che sta dentro la relazione psicanalitica; Pontalis e Pingaud rispondono in modo generale e come di lato: scacco della reciprocità, testimoniato nell’opera stessa di Sartre (Pontalis); reciprocità come esito finale, come conquista (Pingaud). Le spade si sono incrociate, senza dubbio, ma i duellanti non sono andati oltre la prima mossa. E il testo di Abrahams risulterebbe così un exploit solitario, fermo come un sasso nello stomaco della psicanalisi - che ne ha digeriti ben altri. Senonché alcuni mesi fa è uscita una raccolta di vari scritti di Abrahams (L’homme au magnétophone, Le Sagittaire, Paris, 1976) che a mio parere riapre il problema e permette, forse, di far muovere quel sasso [...]”.
FAR MUOVERE QUEL SASSO! Nel 1979, Fachinelli pubblica “La Freccia Ferma. Tre tentativi di annullare il tempo” (edizioni L’ERBA VOGLIO), nel 1983 “CLAUSTROFILIA. Saggio sull’orologio telepatico in psicanalisi” (Adelphi), e, nel 1985, un breve testo “Sulla spiaggia” ( “Lettera Internazionale”, 2, n. 6, autunno 1985).
Con evidenti “segnali” di grande audacia teorica., Fachinelli si mette in gioco, coraggiosamente, e si porta “al di là del bene e del male” - al di là del femminile e del maschile e al di là della debolezza e della forza: depone le armi dialettiche della “intelligenza astuta” hegelo-lacaniane e osa aprire la porta a un nuovo orizzonte-paradigma, a una nuova antropologia e a una nuova psicoanalisi.
Nel febbraio del 1989, stampa “La mente estatica”: “La metamorfosi dei sensi, non un loro oltrepassamento, è anche - scrive Fachinelli - al centro del trasumanar dantesco”. Che dire? Non è ora di uscire dall’inferno, e dal presente lockdown?!
-
>IL LAVORO DI FACHINELLI E "UNA CURIOSA IMMOBILITÀ" [1977]. --- PRIMO MAGGIO, 2021: L’ARTISTA «COL VIDEO-REGISTRATORE». Fedez e il video della telefonata con la Rai: «Sul palco devo essere libero di dire quello che voglio, non lo stabilite voi» (di G. Sclaunich).2 maggio 2021, di Federico La Sala
DOC.: L’ARTISTA «COL VIDEO-REGISTRATORE» (2021) !
Primo Maggio
Fedez e il video della telefonata con la Rai: «Sul palco devo essere libero di dire quello che voglio, non lo stabilite voi»
Fedez dopo il discorso del Primo maggio pubblica il video della telefonata con la Rai: «La vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani mi esorta ad “adeguarmi a un sistema”»
di Greta Sclaunich *
Fedez accusa i vertici di Rai3 di avergli chiesto di omettere nomi e partiti dal suo intervento sul palco del Concertone, la Rai controbatte smentendo pressioni e censure preventive. Ma il cantante non ci sta e, subito il suo discorso sul palco del concerto del Primo Maggio, ribatte su Twitter: «La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi».
 Pubblicando il video della telefonata, nel quale si sente la discussione molto accesa con i dirigenti di Rai3 [...] *
Pubblicando il video della telefonata, nel quale si sente la discussione molto accesa con i dirigenti di Rai3 [...] **Corriere della Sera (ripresa parziale).
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA: ELVIO FACHINELLI, UNO PSICOANALISTA COL MAGNETOFONO.30 aprile 2021, di Federico La Sala
VITA, FILOSOFIA, E PSICOANALISI. ELVIO FACHINELLI (1928-1989):
LA FRECCIA FERMA [1979], CLAUSTROFILIA [1979] ... E LOCKDOWN, OGGI [2021]
- Una nota a margine di Psicoanalisi contaminata. Recensione di "Un singolare gatto selvatico" Il caso di Jean-Jacques Abrahams (Alessandro Siciliano, 2017) e di "Un singolare gatto selvatico. Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono" (Gianluca d’Amico, 2021).
PREMESSO E CONSIDERATO CHE "In Italia la vicenda di Abrahams e il suo gesto di rottura arrivano nel 1977 grazie alla casa editrice di Elvio Fachinelli, L’erba voglio. La vicenda riverbera fino ai nostri giorni e il dialogo psicoanalitico viene ripubblicato, a cura di Giacomo Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina, per Ombre corte. 1967-1977-2017: l’uomo col magnetofono non c’è più, ma la sua registrazione testimonia ancora di qualcosa che, nell’era della tecnica, forse non ha più così risonanza: i rapporti di potere all’interno dei setting di psicoterapia" (Gianluca D’Amico, "Un singolare gatto selvatico. Jean-Jacques Abrahams, l’uomo col magnetofono", Psicologia Fenomenologica, 21.04.2021), è da DIRE (a mio parere, ovviamente) che la situazione del "lavoro psicoanalitico" OGGI è ancora (purtroppo) come (e peggio di) IERI: "Leggendo i commenti [...]" al testo di Abrhamms, scrive Fachinelli (nel 1977) - "si ha ora il senso di una curiosa immobilità". Niente è cambiato! E tutto è fermo: una questione al di là del bene e del male, al di là della debolezza e della forza e al di là del femminile e del maschile (sul tema, cfr. La lezione di Dante - e Nietzsche, oggi)!
Giusto: "Che la vicenda di Abrahams instilli in noi tecnici della salute mentale il dubbio. Il dubbio sul nostro sapere; il dubbio sull’uso che ne facciamo di questo sapere di fronte alla persona che incontriamo e che ci chiede aiuto. Il delicato e strano equilibrio di cui parlavamo prima è un equilibrio che dovrebbe farci oscillare e renderci consapevoli di questo esercizio di oscillazione: a tratti posso pendere dalla parte della tecnica, del come si fa; a tratti mi sarà necessario pendere dalla parte della soggettività che eccede la tecnica e, quindi, chiedermi non tanto come si fa a guarire questo disturbo ma chi è questo persona che ho di fronte e chi sono io per lei: appunto, l’enigma dell’intersoggettività.
 Niente di magico e spirituale, anzi. Si tratta, per l’appunto, di un esercizio: fare pratica di pensiero debole direbbe il filosofo Pier Aldo Rovatti. Prendere distanza dalla tecnica, immergersi nella dimensione profondamente interpersonale dell’esperienza per costruire e ricostruire costantemente questa fragile sensazione di reciprocità con l’Altro" (G. D’Amico, cit.)!
Niente di magico e spirituale, anzi. Si tratta, per l’appunto, di un esercizio: fare pratica di pensiero debole direbbe il filosofo Pier Aldo Rovatti. Prendere distanza dalla tecnica, immergersi nella dimensione profondamente interpersonale dell’esperienza per costruire e ricostruire costantemente questa fragile sensazione di reciprocità con l’Altro" (G. D’Amico, cit.)!Ma per fare questo passo, al di là della vecchia antropologia, occorre portarsi "Sulla spiaggia" (1985), deporre le armi dialettiche della "intelligenza astuta" hegelo-lacaniana, e "mettersi in gioco, coraggiosamente", come ha sollecitato a fare e ha fatto Fachinelli ("La Mente estatica", 1989).
Federico La Sala
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO DI ELVIO FACHINELLI ---- E "LA SVOLTA ANTROPOLOGICA" DI GIOVANNI VALVERDE ("ANATOMIA", 1560).31 marzo 2021, di Federico La Sala
#ACHEGIOCOGIOCHIAMO?! #TRACCE PER UNA #SVOLTA_ANTROPOLOGICA.
#EUROPA #SPAGNA #DUE ANNI DOPO LA MORTE DI #CARLOV nel 1560, in #Italia, a #Roma si pubblica il testo di #Anatomia di #GiovanniValverde: si riconosce il ruolo attivo della donna nella #concezione del problema #comenasconoibambini
La sollecitazione di #Michelangelo (1512), #GiovanniValverde (1560), #LuigiCancrini (2005) e #MarioDraghi (2021) a finirla con "il farisaico rispetto della #legge"
#VITAEFILOSOFIA. #COMENASCONOIBAMBINI (#ENZOPACI). Fermare il #giogo, #uscire dall’orizzonte della #tragedia e imparare a #contare
FLS
-
> "PERVERSIONI" UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- FREUD, FACHINELLI, E "LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA".16 marzo 2021, di Federico La Sala
LA POCA SAGGEZZA DELLA FILOSOFIA, I “VENTICINQUE SECOLI” DI LETARGO DI DANTE E LA PRESENTE STORICA CRISI DELLA CULTURA EUROPEA...
- Una nota a margine dell’art. di Sergio Benvenuto, "La poca saggezza della filosofia", "Le parole e le cose" (15 marzo 2021).
CONSIDERATO CHE UN FILOSOFO, "Anche quando sbaglia di grosso, se è un vero filosofo sbaglia con argomenti non banali, fino al punto che, grazie a lui, l’errore brilla della luce convincente della verità" (cf. S. Benvenuto, op. cit.), E VISTO CHE EGLI HA MESSO IL DITO NELLA PIEGA (e nella piaga) della storia della filosofia, nel gioco sofistico di Socrate: «Malgrado lo slogan “so di non sapere”, tutti ci rendiamo conto che Socrate in realtà sapeva tante cose. Ma il suo sapere squisitamente filosofico era proprio quello di non sapere, ovvero, il suo appello all’epistheme come “ricominciare tutto daccapo”» (op.cit. ), VISTO IL PERSISTERE E , AL CONTEMPO, L’ESAURIRSI DELLA "GRANDE INSTAURAZIONE" ANTROPOLOGICA ED EPISTEMOLOGICA apollinea-socratica (su questo, si cfr. la grande analisi di Nietzsche!), forse, è bene e salutare riprendere alla radice (Marx!) la questione e, riaccogliendo l’indicazione di Sofocle, ripensare le «perversioni» di tremila e più anni (come sapeva Dante, meglio di Goethe), rileggere il cap. 15 del manuale di "Anatomia" (Roma, 1560) di Giovani Valverde, e ripensare l’«edipo completo», come voleva Freud e Fachinelli. Altro che continuare a menare la canna per l’aria. O no?!
-
> "PERVERSIONI" --- Sfuggire al "doppio polo" e "costruire, anche attraverso Freud, una pratica della soggettività giusta per il XXI secolo" (di Sergio Benvenuto).19 febbraio 2021, di Federico La Sala
OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE, CON ULISSE-DANTE. Essere giusti con (Kant e) Freud....
PACCOTTIGLIA FREUDIANA
di Sergio Benvenuto *
Molti, e non solo psicoanalisti, votano a Sigmund Freud un vero culto. Per loro Freud non è solo l’inventore di una teoria e di una pratica che hanno marcato la nostra epoca, ma è un genio che raramente si è sbagliato. Il rovescio di questo culto della personalità sono i Freud bashers, quegli autori che non solo attaccano radicalmente Freud e la psicoanalisi, ma dedicano spesso gran parte della loro vita a distruggere il mito di Freud. Ho sempre cercato di sfuggire a questo doppio polo, per confrontarmi con un’immagine del tutto laica - né agiografica né spregiativa - di Freud.
- [...]
In conclusione. Ho segnalato questi cedimenti intellettuali di Freud per liberarci di una persistente egemonia del pensiero freudiano? Ricordare le concessioni di Freud alla paccottiglia storiografica è parte della campagna per screditare Freud e la psicoanalisi?
No, perché sono convinto che Freud abbia detto alcune cose fondamentali, e che la pratica analitica non è riducibile a una pratica magica o suggestiva. Ma questo a condizione di non prendere Freud alla lettera, di non far parte di una sacrestia psicoanalitica del culto freudiano. Freud era un uomo della propria epoca, con pregiudizi e limiti di certi intellettuali razionalisti della propria epoca, aveva i suoi punti ciechi. Insomma, non si può comprare Freud in toto.
Ma proprio questo dovrebbe permetterci di mettere in luce ciò che in Freud non è effimero, fossero anche solo due o tre cose... Come facciamo del resto con quasi tutti i grandi autori del passato: distinguiamo ciò che resta di un autore, da aspetti transeunti legati alle mode e alle fisime del pubblico dell’epoca, a idiosincrasie personali che oggi non ci dicono più nulla.... Questo è vero per Platone, per Dante, per Molière, per Kant... per tutti. Occorre voltare pagina nella storiografia psicoanalitica: uscire dall’alternativa “ricostruzione pia e pietosa” versus “demistificazione demolitiva”, prendere la giusta distanza da Freud e dalla psicoanalisi. E costruire, anche attraverso Freud, una pratica della soggettività giusta per il XXI° secolo.
* Fonte: Le parole e le cose, 15 febbraio 2021 (ripresa parziale - senza note).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
PER LA CRITICA DELLA RAGIONE ATEA E DEVOTA: FREUD CON KANT.
FLS
-
> "PERVERSIONI". --- “...o peggio”. L’Uno in psicoanalisi. Un fondamento fonduto. Il Seminario XIX di Jacques Lacan (di A. Siciliano).2 dicembre 2020, di Federico La Sala
L’Uno in psicoanalisi. Un fondamento fonduto. Il Seminario XIX “...o peggio” di Jacques Lacan
Da poco pubblicato nella sua edizione italiana da Einaudi, il Seminario XIX di Jacques Lacan dall’enigmatico titolo “...o peggio”, pronunciato durante l’anno accademico 1971-1972 torna su alcuni dei temi più importanti che hanno caratterizzato l’insegnamento dello psicoanalista francese. Come quello del concetto di Uno: che non è quello che la filosofia vorrebbe mettere a fondamento del pensiero, ma è quello equivoco, paradossale, ambiguo con cui ha a che fare l’inconscio
di Alessandro Siciliano (DinamoPress, 29 novembre 2020)
“Fondamento” è un termine che ricorre spesso nelle pagine di questo seminario (Jacques Lacan, Il seminario. Libro XIX. ... o peggio. 1971-1972, testo stabilito da Jacques-Alain Miller, edizione italiana a cura di Antonio Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2020). La questione che maggiormente interroga qui Lacan è quella dell’origine di ogni fondamento: l’Uno. Come si origina l’Uno? Com’è possibile che, dal nulla, si manifesti qualcosa come Uno? Come si passa dallo Zero all’Uno? Che dall’indifferenziato si stacchi ed emerga qualcosa come Uno, come principio, come inizio di una serie, di una struttura, è ciò che classicamente nel discorso della filosofia desta meraviglia. Perché c’è qualcosa, anziché il nulla? Con tale questione, dentro e fuori la filosofia, Lacan qui si confronta, a partire da quel dialogo platonico in cui a parlare, a dirsi, è proprio l’Uno stesso, il Parmenide.
C’è un’altra cosa che ricorre spesso, quando Lacan parla di fondamento in queste pagine, ed è una cautela, un’attenzione a «non considerare questo fondato come troppo fondamentale» (p. 209), vale a dire a non fare del fondamento qualcosa di immaginario, di consistente, di non rappresentarselo cioè come un mito.
- Perché Lacan ci avverte che «non c’è nulla di più pericoloso delle confusioni a proposito di quello che è l’Uno»? Perché scambiare l’Uno per un ente porta dritti dritti verso ... il peggio (p. 102). Si potrebbe, ad esempio, interpretare così quello che Umberto Eco chiamava l’Urfascismo, il fascismo “eterno” o fondamentale: un grande abbaglio su quello che è l’Uno.
Anziché dunque indagare il fondamento in quanto essere, Lacan si mette qui sulle tracce della sua esistenza al di qua di ogni essere, al di qua di ogni rappresentazione. In più momenti, gioca con i termini fonder e fondre, fondare e fondere. E ci dice: «per fondare, bisogna fondere». E poco dopo: «[...] Solo gli equivoci fondano e fondono. [...] Quello che mi interessa è il significante come Uno, e l’unico interesse del significante sono gli equivoci che possono scaturirne» (p. 205).
Abbiamo dunque qui una linea di ricerca piuttosto chiara - chiara nella sua paradossalità. Ciò che interessa lo psicoanalista in questo seminario è il significante come Uno, il primo significante, il punto di origine della batteria dei significanti che costituiscono un essere parlante. Saremmo portati a pensare che il significante come Uno abbia, tra le sue caratteristiche, innanzitutto quella di essere univoco, a senso unico, identico a sé. E invece Lacan ci dice che la psicoanalisi ha messo in luce che dal significante come Uno scaturiscono equivoci, e che tali equivoci sono il luogo privilegiato del lavoro di analisi.
Ma se l’Uno è uno, se esso non è due o molti, come può essere equivoco?
* I significanti come Uno - nell’algebra lacaniana S1 - sono i significanti padroni che determinano la vita di un soggetto, i punti in cui si fissano nell’inconscio i rapporti tra soggetto e discorso dell’Altro. Obiettivo di un’analisi è mettere al lavoro il soggetto al fine di reperirli, costruirli, fare in modo che possano produrre tutta la propria significazione attraverso quello che Jacques-Alain Miller ha delineato come un lavoro di amplificazione, prima, e riduzione, poi. Tramite il lavoro dell’analisi, il soggetto entra in contatto con il sapere che tali S1 organizzano inconsciamente.
«Nell’analisi, dice Lacan, prevale una cosa, e cioè che c’è un sapere che si trae dal soggetto. Al posto del polo del godimento» - nel posto in alto a destra nello schema dei quattro discorsi, posto detto del godimento o anche del lavoro - «il discorso analitico mette la S barrata. Questo sapere risulta dal vacillamento, dall’atto mancato, dal sogno, dal lavoro dell’analizzante». E qui ciò su cui vorrei portare maggiormente l’attenzione: «è un sapere che non è supposto, è sapere caduco, rimasuglio di sapere, surrogato di sapere. È questo l’inconscio» (p. 73).
Rimasuglio, surrogato, caduco. Perché Lacan non dice semplicemente che l’inconscio è un sapere propriamente detto, di cui il soggetto, tramite l’analisi, può venire a conoscenza? Perché invece ne sottolinea questo carattere parziale, surrogato, spezzettato, come qualcosa che si ottiene come resto e come scarto? Perché altrimenti non sarebbe l’inconscio freudiano, sarebbe invece un sapere che, inconsapevole, passa alla consapevolezza, in una sorta di insight integrale; sarebbe cioè possibile una piena traduzione dell’inconscio nella sfera della coscienza. Il sapere organizzato da questi S1 arriverebbe a essere un sapere articolato tutto nella dimensione della coscienza. Avremmo, cioè, una esautorazione dell’inconscio.
- La psicoanalisi prende invece le mosse dalla constatazione che l’inconscio è tale in quanto claudicanza della conoscenza, che non c’è padronanza dell’inconscio, possedimento dell’inconscio, e che l’inconscio lavora e produce i suoi giochi manifestandosi sempre come fallimento, come pietra d’inciampo di ogni padroneggiamento.
Ça rêve, ça rate, ça rit; sogna, fallisce e ride, l’inconscio (Jacques Lacan, Il mio insegnamento, la sua natura e i suoi fini, pp. 67-68). È per questo che la tesi che Lacan segue in questo seminario non è quella di certa filosofia, che lavora per la conoscenza dell’Uno, per cui “l’Uno è”, ma una tesi certamente inedita, quella per cui “c’è dell’Uno”, al partitivo. Non lo dice nemmeno correttamente, non dice “il y a de l’un”, ma pronuncia “yadl’un”, c’èdl’uno. Dunque ne indica il carattere di sincope, di surrogato, di pezzo (c’è dell’Uno), e lo fonde, con l’intenzione di studiarne il fondamento al di qua dell’essere. Si mette sulle tracce del fonduto del fondato, potremmo dire.
Come le fondamenta rispetto ai muri di un edificio, i significanti Uno fissano e stabilizzano una struttura di discorso. Una volta fissate le fondamenta, la struttura è fondata. Ma, lo abbiamo detto, ciò che ci interessa in psicoanalisi è, sì, il fondamento, da prendersi però nella sua natura di equivoco linguistico, o potremmo dire linguisterico con un termine che troviamo nel seminario dell’anno successivo a questo. Non dobbiamo, dice Lacan, considerare il fondamento come troppo fondamentale, giacché è grazie all’equivoco e non al significato o al senso, che può risuonare al meglio il significante radicato nell’inconscio, nella carne del soggetto. È col lavoro dell’interpretazione analitica, che mira a «produrre delle onde» semantiche al fine di far vacillare il senso stabilito e stabile, che meglio può evidenziarsi, può dimostrarsi il punto di scaturigine della significazione, il significante come Uno.
*
A proposito di muri e fondamenta, nel capitolo che Jacques-Alain Miller titola Topologia della parola troviamo una metafora che parla proprio del muro. Qui Lacan si interroga sul senso, sulla necessità di un suo sgonfiamento in psicoanalisi. Il riferimento è ad alcuni manoscritti di Leonardo Da Vinci riguardanti la figurazione. «Guardate il muro», dice Leonardo. Sul muro si possono scorgere delle macchie, piccole increspature, talvolta delle muffe. «Una macchia di muffa è un’ottima occasione per trasformarla in una madonna», ci dice Lacan con Leonardo, «oppure in un atleta muscoloso. La muffa si presta particolarmente bene perché presenta sempre delle ombre, dei buchi. È molto importante accorgersi che sui muri c’è un genere di cose che si prestano alla figurazione, alla creazione artistica, come si dice. La macchia stessa è il figurativo in quanto tale» (p. 68).
Qui Lacan ci invita a considerare il muro nel suo al di qua e nel suo al di là. Al di qua del muro, abbiamo l’osservatore, che guarda le immagini che si formano a partire da macchie, buchi e ombre, e attraverso cui costruisce le figure in cui il desiderio si articola e si capta. Sono queste figure, dice Lacan, che si prestano a far «risonare la lira del desiderio», l’erotismo. È questo il territorio privilegiato del senso, del compiacimento e dell’alimentazione del desiderio nel suo versante immaginario. Una figura, potremmo dire così, è una organizzazione di senso a opera del desiderio inconscio, a partire da macchie e ombre. «C’è un senso, dice Lacan, per coloro che, davanti al muro, si compiacciono delle macchie di muffa che si rivelano tanto adatte a essere trasformate in una madonna o in un dorso di atleta. Ma noi non possiamo accontentarci di questi sensi confusionali [sens-confusions]. In fin dei conti non servono ad altro che a far risonare la lira del desiderio, l’erotismo, per chiamare le cose con il loro nome» (p. 70).
- Perché una tale controtendenza (che non significa abolizione o rigetto) rispetto al senso? Perché la psicoanalisi lacaniana si fonda sulla divaricazione saussuriana tra significante e significato. Se il significato è dell’ordine del consensuale, del culturale, del discorso stabilito, dell’evidenza, il significante è ciò che interrompe la comprensione e obbliga il soggetto a domandarsi “Cosa significa?”. Il significato è il luogo in cui il senso sembra riposare, depositarsi, filare liscio, mentre il significante porta con sé un’interrogazione.
«Voi comprendete fintantoché il significante non vi ferma. Ora, comprendere è sempre essere a propria volta compresi negli effetti del discorso» (p.147). E così Lacan ci invita a portare l’attenzione a ciò che c’è al di là del muro. Incontriamo subito l’impasse: «Al di là del muro, tanto per dirvelo subito, non c’è altro, per quel che ne sappiamo, se non quel reale che si segnala precisamente come impossibile, per l’impossibilità di raggiungerlo al di là del muro» (p. 69). Nessuna illusione, dunque, di accedere a un al di là del muro, alla manifestazione del fondamento reale. Ciò con cui siamo confrontati in quanto esseri parlanti è il muro del linguaggio. Volerne cogliere l’al di là reale richiede un certo lavoro, che è quello della scienza e, in particolare delle matematiche. La scienza moderna ha trovato il modo, con i numeri e le formule, di avere a che fare con ciò che c’è dietro il muro. Ma per il soggetto che frequenta l’esperienza analitica, che è “affetto” dal significante nei suoi equivoci, non si dà un discorso di ciò che “lavora” dietro il muro.
Che non si dia discorso, però, non significa che non si dia una certa forma di “contatto”, cosa a cui una psicoanalisi punta. Sul muro dell’essere parlante c’è infatti un “clivaggio”, «c’è qualcosa che è installato davanti, e che ho chiamato parola e linguaggio, mentre dietro qualcosa lavora, forse matematicamente» (p. 70). Un clivaggio, una sfaldatura sul muro, una fessura. Di ciò che dietro al muro lavora, qualcosa passa da questa fessura; e forse questo qualcosa ha a che fare con la formazione di certe macchie, certe increspature, certe muffe.
- Lo sappiamo: clivaggio, faglia, beanza, divisione, ferita, sono tutti termini per dire ciò che viene messo al lavoro in psicoanalisi. Il discorso analitico interroga proprio quella faglia, quella divisione del soggetto che non si riconosce, non si realizza completamente nelle immagini che si figurano sul muro. Qualcosa lo disturba, qualcosa lo morde, qualcosa al di qua del figurato, al di qua del mostrabile, lo guasta.
È per tale motivo che in psicoanalisi «l’unico interesse del significante sono gli equivoci che possono scaturirne». Dall’ordine della figura, nella sua forma stabilita, attraverso la presa in carico degli equivoci di quella stessa figura, di ciò che nella figura non quadra, una psicoanalisi lavora in negativo; dalla figura alla macchia, dalla macchia alla muffa, dalla muffa alla fessura. Ci si indirizza cioè verso i punti di insorgenza della fenditura sul muro, anziché soffermarsi sulla contemplazione, o sulla riconfigurazione delle figure sul muro, e questo significa orientare un’analisi verso il reale, verso la causa materiale del proprio dire.
Quando l’equivoco significante viene messo al lavoro dall’interpretazione analitica, sua omologa, si tocca indirettamente il punto di scaturigine dell’equivoco stesso, il c’è dell’Uno del significante nella sua “natura” di surrogato, di rimasuglio parziale e informe. È per questo che in Ancora, seminario dell’anno successivo, Lacan dirà che, più che il linguaggio, il campo di lavoro di una psicoanalisi è lalangue, lalingua. Anche qui, un fonduto! Che cos’è lalingua? La fusione equivoca e crea un litorale tra la lallazione e il linguaggio articolato, oltre che richiamare il pezzo di corpo. Lacan ne dà una definizione: «Una lingua fra tante altre non è niente di più che l’integrale degli equivoci che la sua storia vi ha lasciato persistere» (Jacques Lacan, Altri scritti, p. 488).
Lalingua per Lacan è un luogo di impasti e disimpasti tra simbolico e reale, luogo in cui il significante affetta il corpo, in cui carne e parola si mescolano e si fondono, in cui l’una fonda l’altra fondendovisi. «Siamo affetti da lalingua innanzitutto in quanto essa comporta degli effetti che sono affetti. Se si può dire che l’inconscio è strutturato come un linguaggio, è nella misura in cui gli effetti di lalingua, già lì come sapere, vanno ben oltre tutto ciò che l’essere parlante ha la possibilità di enunciare» (Jacques Lacan, Il seminario. Libro XX, pp. 132-133).
* L’Uno della psicoanalisi non è l’Uno dell’essere, della forma, della rappresentazione, ma bensì il cèd’luno, informe, in tutta la sua equivocità, qualcosa che esiste al di qua o al di là di ogni essere, punto di insorgenza di ciò che sarà figurato. Obiettivo di un’analisi è seguire le tracce del significante come Uno per metterlo «spalle al muro» (p. 148). Operazione da cui il senso stesso risulta rinnovato.
- Il sapere che si ottiene da un’esperienza analitica non sarà dunque un sapere pieno, unitario, articolato, interamente trasmissibile, ma un sapere a pezzi, o meglio, dei pezzi staccati.
Questa «etica del ben dire», del ben dire quello che del significante come Uno c’è, è ciò che una psicoanalisi può «permettere di sperare»: sperare cioè di «mettere in chiaro l’inconscio di cui siete soggetti» e di «ritrovarcisi» (Jacques Lacan, Altri scritti, p. 530 e p. 526). Ritrovarcisi in ciò che, di questo Uno-tutto-solo, c’è.
-
> "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- Gioie eccessive/Recalcati lettore di Fachinelli (di Rocco Ronchi).18 novembre 2020, di Federico La Sala
Gioie eccessive /
Recalcati lettore di Fachinelli. L’oceano al di là dell’Edipo
di Rocco Ronchi (Doppiozero, 18 novembre 2020)
Elvio Fachinelli ha avuto il grande merito di portare la psicoanalisi dentro il dibattito politico e culturale dell’Italia degli anni ’60 - ‘80, quando il vento del rinnovamento soffiava forte sulla società italiana. Psicoanalista eterodosso, ma non dissidente, sospettoso delle dinamiche autoritarie dei gruppi, anche quando questi erano fondati su buone cause, si era sottratto all’invito formulatogli da Jacques Lacan di rappresentarlo in Italia, preferendo mantenere una posizione da libero battitore. A trent’anni dalla prematura scomparsa, uno dei maggiori “eredi” italiani di Jacques Lacan, Massimo Recalcati, gli ha dedicato un piccolo densissimo volume, articolato in tre saggi e in una Appendice, dal titolo significativo e assai impegnativo: Critica della ragione psicoanalitica.
Di Fachinelli, il suo esegeta condivide non solo una matrice intellettuale lacaniana, che è certamente più sfumata nel caso di Fachinelli, ma anche quella che si potrebbe definire una comune vocazione all’“impegno”. Per entrambi, infatti, la psicoanalisi è una prassi interamente calata nell’attualità, che non teme di sporcarsi le mani con il conflitto. Certamente diversissimi sono gli sfondi nei quali prende rilievo la loro riflessione. La temperie sociale, politica e culturale che caratterizzava gli anni di Fachinelli non ha quasi più rapporto con quella attuale. Le urgenze sono altre, anche se non meno drammatiche. Comune a entrambi è tuttavia la persuasione che la psicoanalisi, che nella sua pratica resta sostanzialmente una faccenda privata, sia, quanto al suo senso, parte integrante del discorso pubblico. Essa deve fungere da criterio di orientamento nel reale e da principio della sua trasformazione.
Ecco allora che la deriva ossessiva che Fachinelli denunciava nella logica gruppale dell’estrema sinistra degli anni ‘70 diventa, nella rilettura che ne offre Recalcati una diagnosi della pulsione securitaria che attraversa la contemporaneità, a riprova del fatto che il fascismo, per la psicoanalisi, non è qualcosa di contingente, ma si inscrive nella logica dell’inconscio. È un fatto degno di nota che quando la psicoanalisi si fa “ontologia del presente”, come avviene in modi diversi in Fachinelli e in Recalcati, il fascismo bussi sempre alle sue porte, presentandosi come il fantasma che assilla la compagine sociale. Lo si può verificare scorrendo a volo d’angelo la storia di questa disciplina: con sistematica puntualità - dal Freud della Psicologia delle masse al Reich della Psicologia di massa del fascismo fino alla schizoanalisi di Deleuze-Guattari - ogni incursione nel sociale della psicoanalisi fa emergere una “ricerca del chiuso” che, come scrive Recalcati, sembra appartenere “alla forma umana della vita” (il corsivo è mio). La “necessità” di questo libro di Recalcati è, dunque, immediatamente politica.
Senza lo spettro del fascismo, che si ritrova nelle nuove forme del populismo sovranista, non si spiegherebbe il ritornare dello psicoanalista di oggi alle pagine del suo collega di ieri. Il primo capitolo ha infatti un titolo “programmatico”, Uscire dal chiuso, ed è tutto costruito sulla fenomenologia schizzata da Fachinelli (in La Freccia ferma del 1979) di quella ossessione che porta il soggetto a trovare riparo presso “un padrone assoluto”, “una istanza superiore esterna (Dio, una Causa, o altro) che possa ribadire il suo affidamento regressivo all’Altro”.
Uscire dal chiuso è allora qualcosa di più di un titolo descrittivo: è la parola d’ordine di una psicoanalisi che accetta la sfida del tempo storico, pagando il prezzo del proprio impegno con i sarcasmi di chi la vorrebbe invece confinata nella penombra di un comodo appartamento borghese, appannaggio di una ristretta cerchia di privilegiati, e ne irride il tentativo di rendersi comunicabile e condivisa.
Accanto all’urgenza politica, ma connessa ad essa, vi è poi un’urgenza schiettamente teorica. Bisogna andare all’Appendice del libro (Il mare della formazione) per trovarla enunciata. La questione che viene sollevata in quelle pagine concerne la formazione dello psicoanalista in un contesto, quello lacaniano, dove l’osservanza della “lettera” del Maestro sembra costituire il solo valore al quale attenersi: formazione come conformazione, dunque. Nel caso poi l’esperienza non si lasciasse ricondurre al Libro, tanto peggio per l’esperienza.
Ciò che conta, infatti, è impratichirsi in una neolingua inaccessibile ai più che funziona come setaccio al cui vaglio passare il reale, trattenendo solo ciò che conferma la premessa del sillogismo lasciando perdere tutto il resto. “Viene alla mente - scrive sconsolato Recalcati - una tesi di Fachinelli: la psicoanalisi si è progressivamente costituita come una difesa fobico-ossessiva nei confronti dell’aperto”. Si ripete, anche nel caso di Lacan, quello che era già avvenuto con l’insegnamento freudiano, non solo presso i post-freudiani, sempre preoccupati di ricucire gli strappi procurati da Freud al dominio dell’Io, ma già in Freud stesso, che Fachinelli amava presentare come spaventato rispetto agli effetti prodotti dalla sua stessa veggenza: la scoperta dell’inconscio come causa.
- “Dopo lo squarcio iniziale, la psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, controllare, stare attenti, allontanare... Ma certo questo è il suo limite, l’idea di un uomo che deve sempre difendersi, sin dalla nascita e forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato” (E. Fachinelli, La mente estatica, 1989).
Vi è, insomma, una naturale tendenza della psicoanalisi a (ri)costituirsi terapeuticamente come un discorso della padronanza, replicando un antico modello, quello del soggetto che è padrone del possibile, che ne dispone sovranamente come di una capacità, e che perciò argina (“ottura”, diceva Fachinelli) tutti quei “buchi” dai quali può passare un reale che si sottrae alla sua misura, un reale che è in eccesso sulla possibilità di accoglierlo, di farlo proprio, di digerirlo, un reale che non si lascia metabolizzare e trasformare in alimento utile alla autoconservazione del soggetto. Vi sono, scriveva Fachinelli, “gioie eccessive”, dalle quali la psicoanalisi, in quanto discorso della padronanza, si guarda come se fossero minacce. Queste gioie, che rinviano al grande tema lacaniano di una jouissance “al di là” del principio di piacere, “aprono”, strappandoci all’“umidiccia intimità gastrica” del nostro Io (l’espressione, potentissima, la mutuo dal giovane Sartre polemico con l’“idealismo” del suo maestro Husserl; ricordo che senza passare da Sartre poco si comprenderebbe del lacanismo di Recalcati).
Esse ci mettono in comunicazione con un Altro che non è l’Altro del Simbolico, della Legge, dell’Edipo. Per Fachinelli è un Altro molto più antico, ben poco “umano”, dal momento che ciò che c’è di “umano, troppo umano” è proprio l’ossessione per la chiusura, vale a dire quella sordida inclinazione al fascismo che accompagna, come uno spettro, ogni processo di soggettivazione.
 Per questo Altro deve essere convocato un “sentimento oceanico”, come aveva fatto, in una celebre lettera a Freud, il suo amico Romain Rolland. La sua figura - che, come vedremo, non è affatto una metafora - è il “mare”. L’Altro assume qui il volto della natura, colta però non nel suo aspetto pietrificato di mosaico di fatti retto da leggi meccaniche, bensì in quello che aveva di mira Spinoza quando coniava per l’attività generativa della natura il neologismo latino naturans e che Henri Bergson, un altro spinoziano, aveva chiamato “durata creatrice di imprevedibili novità”.
Per questo Altro deve essere convocato un “sentimento oceanico”, come aveva fatto, in una celebre lettera a Freud, il suo amico Romain Rolland. La sua figura - che, come vedremo, non è affatto una metafora - è il “mare”. L’Altro assume qui il volto della natura, colta però non nel suo aspetto pietrificato di mosaico di fatti retto da leggi meccaniche, bensì in quello che aveva di mira Spinoza quando coniava per l’attività generativa della natura il neologismo latino naturans e che Henri Bergson, un altro spinoziano, aveva chiamato “durata creatrice di imprevedibili novità”.È impressionante, anzi, la concordanza tematica e, addirittura, lessicale che c’è tra le tesi esposte da Fachinelli in saggi come La mente estatica e La Freccia ferma e la metafisica bergsoniana, soprattutto se si tiene presente l’ultima grande opera del filosofo francese: Le due fonti della morale e della religione. La grammatica concettuale di Fachinelli, fondata sulle coppie antinomiche aperto/chiuso, statico/dinamico, durata /spazio, concetto/ estasi, è infatti la stessa di Bergson. Ne è quasi un calco fatto con il linguaggio psicoanalitico.
 Si pensi solo alla critica bergsoniana delle religioni statiche, territoriali, identitarie, al suo rifiuto delle morali chiuse, basate sul dualismo amico-nemico, al suo invito incessante ad aprire ciò che tende naturalmente a cristallizzarsi, a rendere dinamica l’esperienza che l’intelletto astratto invece reifica in una molteplicità disgiunta di stati immobili.
Si pensi solo alla critica bergsoniana delle religioni statiche, territoriali, identitarie, al suo rifiuto delle morali chiuse, basate sul dualismo amico-nemico, al suo invito incessante ad aprire ciò che tende naturalmente a cristallizzarsi, a rendere dinamica l’esperienza che l’intelletto astratto invece reifica in una molteplicità disgiunta di stati immobili.
 Si consideri, poi, il suo appello alla mistica, differente per natura da ogni religione tramandata anche se è costretta ad esprimersi nella retorica di una religione determinata. La mistica, afferma Bergson, non è contemplazione, ma azione trasformatrice, praxis generatrice di comunità libere. Solo come “grande politica” l’estasi era per il filosofo francese qualcosa di efficace. Altrimenti è solo un nuovo capitolo della storia della ideologia. Difficile trovare una tesi più “fachinelliana” (e sessantottina) di questa...
Si consideri, poi, il suo appello alla mistica, differente per natura da ogni religione tramandata anche se è costretta ad esprimersi nella retorica di una religione determinata. La mistica, afferma Bergson, non è contemplazione, ma azione trasformatrice, praxis generatrice di comunità libere. Solo come “grande politica” l’estasi era per il filosofo francese qualcosa di efficace. Altrimenti è solo un nuovo capitolo della storia della ideologia. Difficile trovare una tesi più “fachinelliana” (e sessantottina) di questa...Ma Bergson, ai tempi in cui Fachinelli scriveva, era da tempo un corpo estraneo nel dibattitto intellettuale italiano e non solo. Ad occupare la scena era piuttosto l’hegelo-marxismo, vale a dire una visione del reale tutta storica, impregnata di un irriducibile umanismo, incrollabilmente fondata sulla tesi dell’eccezione umana rispetto al piano della natura. Lo stesso vale evidentemente per l’insegnamento lacaniano, anch’esso vittima della stessa congiuntura intellettuale, sebbene Lacan fosse filosoficamente assai più attrezzato del suo allievo italiano.
 Degno di nota è allora il fatto che proprio oggi, nel tempo in cui la crisi prodotta dall’antropocene è sotto gli occhi di tutti (ne è segno tangibile la mascherina indossata ad ogni latitudine), il maggiore tra gli psicoanalisti italiani senta la necessità di riaprire la pratica Fachinelli. Non solo per areare la casa della psicoanalisi, nella quale da troppo tempo ormai si soffoca per i miasmi prodotti da settarismi, piccole invidie e da una scolastica autoritaria, ma perché forse si fa incalzante la questione della crisi del paradigma antropologico che sottende la psicoanalisi mainstream.
Degno di nota è allora il fatto che proprio oggi, nel tempo in cui la crisi prodotta dall’antropocene è sotto gli occhi di tutti (ne è segno tangibile la mascherina indossata ad ogni latitudine), il maggiore tra gli psicoanalisti italiani senta la necessità di riaprire la pratica Fachinelli. Non solo per areare la casa della psicoanalisi, nella quale da troppo tempo ormai si soffoca per i miasmi prodotti da settarismi, piccole invidie e da una scolastica autoritaria, ma perché forse si fa incalzante la questione della crisi del paradigma antropologico che sottende la psicoanalisi mainstream.
 Già un altro psicoanalista, Sergio Benvenuto, ha sottolineato in un recente articolo l’aspetto “dionisiaco” latente nell’esperienza del suo antico amico Fachinelli evidenziando la distanza che lo separava dall’umanismo storicistico della sinistra italiana del tempo. Recalcati procede cautamente perché vuole evitare di gettare il bambino con l’acqua sporca. Diffida della retorica dell’impersonale, delle facili fascinazioni per il neutro.
Già un altro psicoanalista, Sergio Benvenuto, ha sottolineato in un recente articolo l’aspetto “dionisiaco” latente nell’esperienza del suo antico amico Fachinelli evidenziando la distanza che lo separava dall’umanismo storicistico della sinistra italiana del tempo. Recalcati procede cautamente perché vuole evitare di gettare il bambino con l’acqua sporca. Diffida della retorica dell’impersonale, delle facili fascinazioni per il neutro.Chi, come Recalcati, fa della clinica la cartina di tornasole per giudicare la bontà di una ipotesi teorica, non può agire diversamente. Se è vero che l’aspetto restaurativo della psicoanalisi è storicamente rappresentato dal suo essere un esorcismo nei confronti dell’aperto, è altrettanto vero che senza una difesa dal reale non c’è soggettivazione e che la psicoanalisi è una teoria e una prassi del soggetto ed è rivolta al soggetto. Non al suo “bene” - che, ricorda Recalcati, è la pretesa foriera di ogni possibile male - ma sicuramente al suo “essere”. Le vie della desoggettivazione e della desublimazione secca, le vie dionisiache, possono semmai essere percorse dagli artisti, perché a difenderli dal reale è il velo “apollineo” dell’immaginario; sono invece non solo impraticabili, ma, direi, eticamente irresponsabili per lo psicoanalista.
Tuttavia chi abbia seguito lo svolgersi nel tempo del pensiero di Recalcati non può non notare come in alcune sue recenti dichiarazioni teoriche, e in queste pagine in particolare, l’aperto promesso al soggetto da una psicoanalisi non reazionaria prenda sempre di più un aspetto “oceanico” e sempre meno “umano, troppo umano”, fino al punto da riabilitare - in modo apparentemente distratto, ma proprio per questo ancora più significativo - la grande tesi di Ferenczi, secondo la quale non è l’oceano il simbolo della madre, ma la madre uno dei simboli di quell’al di là dell’Edipo che è l’oceano.
 In psicoanalisi l’oceano, il mare, l’onda, sono metafore che, come ha scritto una volta Bergson, parlano al senso proprio. Se il rumore delle onde funziona per il soggetto come il canto delle Sirene per Ulisse è, insomma, perché rammenta una provenienza e una destinazione. Siamo fatti di quella stessa stoffa. Certo, per Recalcati è sempre “sulla scala del desiderio” che va ricalcolato questo al di là dell’Edipo. Recalcati non viene mai meno a questo assioma sul quale ha articolato tutta la sua impresa teorica, ma questo non significa che il desiderio ricucia lo strappo del godimento sul modello del discorso della padronanza.
In psicoanalisi l’oceano, il mare, l’onda, sono metafore che, come ha scritto una volta Bergson, parlano al senso proprio. Se il rumore delle onde funziona per il soggetto come il canto delle Sirene per Ulisse è, insomma, perché rammenta una provenienza e una destinazione. Siamo fatti di quella stessa stoffa. Certo, per Recalcati è sempre “sulla scala del desiderio” che va ricalcolato questo al di là dell’Edipo. Recalcati non viene mai meno a questo assioma sul quale ha articolato tutta la sua impresa teorica, ma questo non significa che il desiderio ricucia lo strappo del godimento sul modello del discorso della padronanza.In passato Recalcati è stato spesso vittima di questa interpretazione riduttiva, non senza una qualche sua responsabilità, ma il passaggio attraverso le “gioie eccessive” di Fachinelli serve proprio a dissipare l’equivoco. La psicanalisi, scrive Recalcati esegeta di Fachinelli, è un’avventura e non un programma. Il suo metodo è la navigazione a vista: mappe e cartografia (il Libro) sono funzionali al processo, lo accompagnano ma non lo dirigono. L’essere dell’uomo è certamente la preoccupazione della psicoanalisi, ma Fachinelli ci ha insegnato che preservarlo vuol dire esporlo, cioè riconsegnarlo, “per quanto è possibile”, al suo elemento estraneo: alla potenza non umana del mare.
-
> "PERVERSIONI" --- "Il seminario perpetuo: il tardo e l’ultimo Lacan". Che dire del reale?! Ritornare a Freud e ad Alessandro Manzoni.4 settembre 2020, di Federico La Sala
CHE DIRE DEL REALE? E CHE DIRE DEL "SEMINARIO PERPETUO"?! RITORNARE A FREUD E AD ALESSANDRO MANZONI... *
FORSE è meglio riprendere il filo del discorso dalle riflessioni "fallimentari" di Freud sul "caso clinico di Dora" o, se si vuole e meglio, della "Madonna Sistina"(cfr. S. Freud, "Frammento di un’analisi d’isteria", 1901) e, rianalizzando la ’possessione’ di Lacan per "L’origine del mondo" di Courbet, ripartire dalle indicazioni critiche di Alessandro Manzoni sul caso della monaca di Monza e di un’antropologia zoppa e cieca - edipica, appunto - fondata sull’ordine simbolico della madre. Vogliamo o non vogliamo uscire dalla caverna?! Boh e bah?!
Che dire del reale?
Il seminario perpetuo: il tardo e l’ultimo Lacan di Gioele P. Cima.
di FELICE CIMATTI (Fata Morgana Web, 30 Agosto 2020) *
- Voilà. Je vous quitte
- (Jacques Lacan, 11 marzo 1980).
Se c’è qualcosa che l’interminabile vicenda del virus Sars-Cov-2 ci sta, a suo modo, “dicendo”, è proprio quanto sia indicibile il reale. Un reale che è tanto più indicibile quanto più, ovviamente, ne diciamo. Più i discorsi e le parole aumentano meno riescono anche solo a graffiare il reale del virus. In effetti ogni giorno ci viene detto che ne sappiamo di più, sulla sua origine, sulla sua struttura molecolare, sugli effetti che causa, sulle sue mutazioni, e così via. Tuttavia rimane l’insoddisfazione per questo sapere, che ci dà sempre più notizie su come è fatto il virus, ma non aggiunge nulla sul fatto indicibile che c’è il virus. Secondo lo psicoanalista Jacques Lacan nell’irriducibile scarto fra come e che - scarto che è al centro delle ultime vertiginose pagine del Tractatus logico-philosophicus - precipita il disagio umano che la psicoanalisi ha la pretesa non certo di “curare” ma almeno di mostrare.
Ma in che consiste, propriamente, questo scarto? Torniamo al virus, l’oggetto assoluto del nostro tempo. Anche se sapessimo tutto del virus, ma proprio tutto, rimarrebbe senza risposta la domanda su quello che rappresenta il virus nelle nostre vite. Rimarrebbe cioè senza risposta il senso del virus. Ora, è evidente che quel senso non esiste, dal momento che non esiste qualcuno o qualcosa che stabilisce il senso di un evento, tantomeno di un virus: tuttavia l’animale umano è l’animale che, parlando e parlandosi, non fa che interrogarsi sul senso. Per questa ragione per Lacan la struttura mentale umana è tendenzialmente paranoide, perché cerca e vede dovunque un senso possibile. Ma siccome il senso di un virus non esiste nello stesso modo in cui esiste il suo genoma, ecco allora che si apre un intervallo sconfinato - lo scarto fra “come” e “che” - dove si colloca un domandare senza risposta. Ma si può dire che esista il senso di qualcosa? In realtà “esiste” solo nei discorsi che intrecciamo intorno ad esso. Ma questo vuol dire che, propriamente, il senso non è reale. Siamo arrivati al punto, gli umani sono malati di senso, ossia sono malati di irrealtà.
In questa diagnosi lacaniana è implicito un immediato paradosso, dal momento che la psicoanalisi è, secondo la celebre definizione data da una delle prime persone ad essere trattate secondo questo metodo, Bertha Pappenheim (Anna O.), una “talking cure”, cioè una cura parlata, fatta esclusivamente di parole e discorsi. Come può allora il senso curare l’inesausto bisogno di senso? Evidentemente non può. Lacan si scontrò sempre con questa evidenza, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, in cui cercò in molti modi diversi di fare a meno del senso. La storia dettagliata di questi anni decisivi è ora raccontata in modo analitico e perspicuo nel libro di Gioele Cima, Il Seminario Perpetuo. Il tardo e l’ultimo Lacan, Orthotes 2020. Si tratta di un libro davvero importante, sia per il tema che affronta, sia per l’accuratezza della ricostruzione storico-teorica con cui questa vicenda viene ricostruita.
Se ora torniamo al tema del “reale” (come quello del suolo di Marte ripreso da una sonda automatica: forse solo una macchina può sopportare la vista del reale del mondo) e alla sua elusività, già il titolo ci mette sulla giusta strada: il Seminario perpetuo è un seminario che non finisce, che non può finire, perché non c’è modo di fermare la deriva del senso. Tuttavia Lacan non ha cercato altro che un modo per farla finita con il senso. Si coglie così la rilevanza filosofica del lavoro teorico di Lacan, che si estende oltre l’ambito della psicoanalisi, che poi è il motivo per cui la filosofia, in particolare in Italia, è così interessata a Lacan. Nell’ultimo e ultimissimo Lacan, per usare l’espressione di Cima, in questione non è altro che il tema dell’intrinseca elusività del senso. E quindi, rovesciando la prospettiva, il tema non è altro che l’intrinseca inafferrabilità del reale.
Ma in che senso (non si scappa mai dal senso, appunto), infine, quello del senso costituirebbe un problema? Se ci si preoccupa del senso si sta trascurando il reale, cioè la vita effettiva che si sta effettivamente vivendo. La vita qui, ora, la vita che si sta vivendo non quella del come la si sta vivendo (un “come” che non sarà mai davvero come avremmo voluto viverla). Si pensi al tipo di esistenza che il reale del virus ha, almeno momentaneamente, interrotto, la vita al tempo del capitalismo planetario: quella del desiderio, dell’investimento su di sé, del viaggio perpetuo; una vita, appunto, sempre spostata oltre l’istante presente. Vivere nel senso significa non vivere nel reale. Significa vivere nella mente e non nel corpo, nell’aspettativa e non nel momento. Vivere nello scarto.
Scartare lo scarto, si potrebbe dire con un facile gioco di parole. La psicoanalisi non consiste in altro: non provare ad attribuire un senso allo scarto fra “come” e “che”, bensì proprio e soltanto nel provare a uscire da quel buco e cercare di godersi la vita che c’è, non quella che potrebbe esserci. Per questa ragione, come osserva Cima, «la psicoanalisi dunque, pur essendole tanto prossima da “tender[vi] irresistibilmente”, è l’ultimo baluardo contro il trionfo della religione» (ivi, p. 449), cioè contro il trionfo del senso. Può non essere inutile precisare che quando Lacan parla di “religione” non parla tanto di Dio e dell’Inferno, quanto di tutte le manifestazioni del senso ultimo, come il Mercato per un economista, la Scienza per un medico o l’Ambiente per un ecologista. La psicoanalisi, in quanto pratica del reale, non sa che farsene del senso.
Per questo la psicoanalisi è intrinsecamente realista, perché non crede al senso, qualunque esso sia, soprattutto non crede ovviamente che esista un senso psicoanalitico: «Il senso è una componente irriducibile ed essenziale della vita di ogni soggetto: il fatto stesso che si parli, inevitabilmente, presuppone l’ipotesi Dio, e la religione lavorerebbe proprio da industria del senso, una macchina inarrestabile che mette il soggetto al riparo dalla desolante indifferenza del reale» (ivi, pp. 449-450).
Questa ammissione di brutale realismo - e quindi di ateismo - pone l’analista in una posizione molto scomoda, dal momento che tipicamente le persone vanno in analisi proprio per trovare un senso alla propria esistenza. Ma un analista che sia colluso con questo desiderio passa dalla parte della religione in quanto discorso del senso, cioè passa dalla parte della malattia e non della “cura”: mentre invece «Il discorso dell’analista è il rovescio di quello del padrone in virtù del suo costitutivo decentramento dalla posizione dominante: esso è uno scarto senza padronanza che l’analista “deve sostenere da solo sino al momento in cui finalmente l’altro ne riconosca la funzione”» (ivi, p. 78). Si va in analisi per fare esperienza del non avere bisogno di un senso. Si va in analisi per diventare realisti, quindi per non credere né in Dio né nel Mercato: infatti «La psicoanalisi [...] [funziona] proprio come operatore di non-senso, perpetuando la demistificazione radicale delle elucubrazioni ideologiche» (ivi, p. 448).
Ma che significa, in definitiva, diventare realisti, o atei che in fondo è la stessa cosa? Alla conclusione della sua accuratissima ricostruzione storica del pensiero dell’ultimissimo pensiero lacaniano, cioè di quel pensiero che si può osare solo da vecchi, quando ci si è liberati di ogni estrinseca sovrastruttura teorica, Cima mostra un Lacan che si sbarazza anche dell’ultimo feticcio della psicoanalisi; di quello stesso “inconscio” che in fondo, come sostiene nel suo ultimo Seminario, il xxvii, Dissolution del 1980, non è altro che un «malinteso». Ma se l’inconscio è un malinteso, che ne è, infine, della psicoanalisi? Se prendiamo sul serio la proposta di Cima, cioè la psicoanalisi come un ateo e materialistico «operatore del non-senso», allora la psicoanalisi non solo non sta né può stare dalla parte della religione (neanche quella mite del dialogo e della misericordia) e dell’etica (qualunque essa sia, da quella fenomenologica dell’empatia a quella dell’intersoggettività ermeneutica); la psicoanalisi diventa una prassi che smonta ogni malinteso ideologico del senso, una prassi che non sembra avere altro scopo che collocare ogni “parlessere” nella sua irriducibile singolarità corporea, quello che Lacan chiama «sinthomo» (cioè «il modo singolare in cui ciascun soggetto “gode” del proprio inconscio»; p. 388). Liberarsi dell’inconscio, vuol dire, allora, liberarsi della stessa psicoanalisi, cioè del bisogno di un sapere che guidi alla ricerca del senso:
- L’errore dell’animale parlante allora, la sua debilità mentale, sta nel credere che il linguaggio possa schiudergli un sapere assoluto, ovvero condurlo, come nel Faust, ad uno svelamento totale del sapere. Tutt’al contrario, egli è nel pieno del “malinteso [malentendu]”, perché il linguaggio è, per usare [...] un termine del Seminario XXI, un puro troumatisme (gioco di parole tra trou (buco) e traumatisme (trauma)), un’invenzione che subentra proprio per supplire all’incompletezza del reale. Il fatto che si parli è la prova lampante che siamo inchiodati al non-tutto, a “pezzi” di reale. La psicoanalisi ribadisce questa verità d’incompletezza ogni giorno (ivi, p. 450).
Gioele P. Cima, Il seminario perpetuo: il tardo e l’ultimo Lacan, Orthotes, Nocera Inferiore (Sa) 2020.
-
> "PERVERSIONI"...UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- USCIRE DAL LETARGO TEOLOGICO E FILOLOGICO, AL DI LA’ DELLE "NOZZE DI EROS E CARITAS".6 luglio 2020, di Federico La Sala
Uscire dal letargo "teologico" e "filologico" e dalla notte «in cui tutte le vacche sono nere»! La mistica dell’Amore (Deus charitas est), o quella di "Mammasantissima" e di "Mammona" ("Deus caritas est")?! *
- CHARIDAD. s. f. Virtud Theologál, y la tercera en el orden. Hábito infuso, qualidad inherente en el alma, que constituye al hombre justo, le hace hijo de Dios, y heredero de su Gloria. Viene del Griego Charitas. Pronúnciase la ch como K: y aunque se halla freqüentemente escrito sin h, diciendo Caridád, debe escribirse con ella. Lat. Charitas. PARTID. 1. tit. 5. l. 42. La primera Charidád, que quiere tanto decir como amor de Dios mäs que de otra cosa, è de sí, è de su Christiano. NIEREMB. Aprec. lib. 1. cap. 1. El Angélico Doctor con mäs acierto dice, que aunque no es el mismo Dios, ni es infinita la Charidád, hace efecto infinito, juntando al alma con Dios. CORNEJ. Chron. lib. 1. cap. 38. Uno de los principales exercicios era por este tiempo la assisténcia à los Hospitáles, donde desahogassen los fervores de su inflamada Charidád.
- Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729)
Spiritualità.
Mistica cristiana: le nozze di eros e caritas
I Meridiani pubblicano il primo di tre volumi dedicati alla mistica cristiana. L’incontro con Dio supera ogni limite, fisico e linguistico, e si configura come esperienza sensibile di un amore totale
di Rosita Copioli (Avvenire, mercoledì 1 luglio 2020)
La Mistica Cristiana (Mondadori, I Meridiani, pagine. LXXXVIII+1624, euro 70,00), è il primo dei tre volumi di una vastissima opera - estesa dalle origini ai nostri giorni - ideata dieci anni fa e curata da Francesco Zambon, su ’impulso’ di Pietro Citati. Questo libro, curato da Zambon con Marco Rizzi, Sabino Chialà, Boghos Levon Zekiyan, comprende la mistica tardogreca e bizantina, siriaca, armena, latina e italiana medievale; il secondo volume presenterà la mistica tedesca e fiamminga, francese, italiana moderna; il terzo la mistica iberica (spagnola, portoghese e catalana), inglese e americana, russa, svedese. Nessun progetto ha avuto la medesima ampiezza, né pari cura filologica e critica: nemmeno i Mistici occidentali curati da Elémire Zolla; e altre pregevoli sillogi sono parziali.
Le radici sono ebraiche - nel Cantico dei Cantici, il testo più ardente e complesso dell’amore umano e divino - e greche: nel Fedro e nel Simposio di Platone, dove la ricerca della conoscenza diviene quella del bene e del bello, l’intelletto sale verso il divino: la mente si unisce allo slancio erotico, la mania che porta all’estasi: invasa da una luce alla quale tenderà tutta la tradizione occidentale fino al Rinascimento, e oltre: da Plotino, per il quale la contemplazione è superiore all’azione poiché permette la visione del vero, a Proclo; da Apuleio a Tasso, i poeti barocchi, i romantici, Yeats, Ungaretti, Luzi, Milosz.
La potenza della vista interiore è previsione e profezia. Lo afferma già Esiodo, e poi Saffo e Platone, seguiti da sant’Agostino e Dante: il poeta sprofonda nella memoria bevendo l’acqua di vita di Oceano, e lascia che il soffio del dio spiri dentro di lui, investendolo del suo nume sconvolgente. «Entra nel petto mio, e spira tue / sì come quando Marsia traesti / de la vagina de le membra sue». È il solo modo per riceverne il barlume, per glorificarlo: «O divina virtù, se mi ti presti / tanto che l’ombra del beato regno / segnata nel mio capo io manifesti».
 Il mistico ricapitola ogni passaggio del Verbo incarnato e dello Spirito Santo che permette - osano i più temerari - di diventare Dio, trascinando con sé l’intera creazione. La trasfigurazione, la passione, la morte sulla croce di Gesù, il suo corpo martoriato sono lo strumento-specchio per rivivere Gesù in anima-spirito-corpo, oltrepassando i ’sensi spirituali’. Francesco nutre nelle viscere il sole - Cristo. Dalle mani e dai piedi spuntano chiodi di carne, sul costato si apre la ferita di Cristo.
Il mistico ricapitola ogni passaggio del Verbo incarnato e dello Spirito Santo che permette - osano i più temerari - di diventare Dio, trascinando con sé l’intera creazione. La trasfigurazione, la passione, la morte sulla croce di Gesù, il suo corpo martoriato sono lo strumento-specchio per rivivere Gesù in anima-spirito-corpo, oltrepassando i ’sensi spirituali’. Francesco nutre nelle viscere il sole - Cristo. Dalle mani e dai piedi spuntano chiodi di carne, sul costato si apre la ferita di Cristo.
 Angela da Foligno aderisce al Crocifisso con i sensi dell’eros totale: «Tu sei me e io sono te». La mente di Iacopone da Todi, «En Cristo trasformata, è quasi Cristo, /cun Deo conionta tutta sta devina». Chi osa tanto, non teme la sintassi, scardina ogni figura e senso. Se fa miracoli, sfida la gravità e si innalza dal suolo, come Doucelina di Digne, altri aboliscono gli intermediari con Dio nel linguaggio, come Caterina Fieschi: «Il mio Mi è Dio, io non conosco altro Mi che esso Dio mio».
Angela da Foligno aderisce al Crocifisso con i sensi dell’eros totale: «Tu sei me e io sono te». La mente di Iacopone da Todi, «En Cristo trasformata, è quasi Cristo, /cun Deo conionta tutta sta devina». Chi osa tanto, non teme la sintassi, scardina ogni figura e senso. Se fa miracoli, sfida la gravità e si innalza dal suolo, come Doucelina di Digne, altri aboliscono gli intermediari con Dio nel linguaggio, come Caterina Fieschi: «Il mio Mi è Dio, io non conosco altro Mi che esso Dio mio».I mistici non hanno paura di niente, né del pudore, né di “ardiri” che il volgo deride: come i patriarchi della Bibbia, variano la metafora del latte della sapienza, con una passione tenerissima. Nel II secolo in Siria, un’Ode di Salomone, e Clemente Alessandrino suggono i seni del Padre e le dolci mammelle di sposa di Gesù; nel X secolo Gregorio di Narek, autore di inni inarrivabili al Cristo glorioso, invoca «comunione che distilla latte»: siamo in Armenia, dove la teologia del sacerdozio di tutti i fedeli - i corpi sono templi e altari - renderà possibile il sacrificio dell’intero popolo: il “Martirio armeno”. Misakh Metzarents (1886-1908) ne è l’ultimo fiore: «Nella notte discende ancora il ruscello di luce, / una goccia di latte della tua santità divenuta un mare; / e vedi, o Madre di Dio, ecco sto diventando bambino».
Come diceva san Tommaso d’Aquino, la mistica è la Cognitio Dei experimentalis, che Jean Gerson esplica: «Theologia mistica est cognitio experimentalis habita de Deo per amoris unitivi complexum». Ma è la più abissale delle imprese gnoseologiche e amorose. Per la “teognosia” dell’ombra, che deriva da Plotino e si distanzia da seguaci di Gesù come Giovanni e Paolo, e Agostino, mai giungeremo a conoscere Dio. La sua trascendenza rispetto a ciò che è, e all’essere stesso, è superessentialis: Dio non può essere conosciuto, descritto, visto, nemmeno dagli angeli e dai santi. Di Dio non si può parlare né in forma positiva, né in forma negativa. Ma la forma negativa si avvicina di più al suo mistero. Lo si contempla tra luce e tenebra.
Scrive Zambon: «Anche nella vita beata, al termine del reditus di tutta la creazione nel seno del Verbo, Dio sarà conoscibile solo attraverso delle mediazioni, delle teofanie (in greco, “manifestazioni, immagini di Dio”)». La teofania segue i gradi della contemplazione, della deificazione (theosis), e coincide con l’unione mistica. Ricorre alle immagini, al loro fantasma, alla fantasia: l’“alta fantasia” di Dante. La docta ignorantia fa apparire Chi è superiore alla Luce come tenebra, caligine, nube: nella “notte oscura” di Giovanni della Croce.
Una rivoluzione accade in pieno XII secolo: Guglielmo di Saint-Thierry, Bernardo di Clairvaux, Aelredo di Rievaulx, Ivo, e Riccardo di San Vittore (di cui Zambon ha curato sapientemente i Trattati d’amore cristiani del XII secolo per Valla Mondadori) mostrano a quale fuoco di trasformazione può accendersi l’intelletto d’amore che guida fino a Dio, intrecciando eros platonico e caritas paolina. Come in Ildegarda di Bingen, il grande impeto d’amore dà le ali. Culminano la poesia della fin’amor dei trovatori, le storie di Tristano e Isotta, il romanzo cortese.
 Con Beatrice davanti alla candida rosa dei beati, Bernardo invita Dante a fissare Dio, nel movimento rapidissimo che imprime al creato e a noi: la metamorfosi dell’anima in Dio, l’excessus mentis, avviene per opera divina in un solo istante: «ma già volgeva il mio disio e ’l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle». Riccardo di San Vittore è il più ardito. Amore terreno e carità hanno la stessa fonte, ma la carità non è mite. Ha la stessa struttura, manifestazioni e gradi della passione violenta. I Quattro gradi della violenta carità gridano in Iacopone da Todi: «Amor de caritate, perché m’ài ssì feruto? / Lo cor tutt’ho partuto, et arde per amore».
Con Beatrice davanti alla candida rosa dei beati, Bernardo invita Dante a fissare Dio, nel movimento rapidissimo che imprime al creato e a noi: la metamorfosi dell’anima in Dio, l’excessus mentis, avviene per opera divina in un solo istante: «ma già volgeva il mio disio e ’l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa, / l’amor che move il sole e l’altre stelle». Riccardo di San Vittore è il più ardito. Amore terreno e carità hanno la stessa fonte, ma la carità non è mite. Ha la stessa struttura, manifestazioni e gradi della passione violenta. I Quattro gradi della violenta carità gridano in Iacopone da Todi: «Amor de caritate, perché m’ài ssì feruto? / Lo cor tutt’ho partuto, et arde per amore».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM". Il teologo Ratzinger scrive da papa l’enciclica "Deus caritas est" (2006) e, ancora oggi, nessuno - nemmeno papa Francesco - ne sollecita la correzione del titolo. Che lapsus !!! O, meglio, che progetto!!!
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" --- IL MALE, L’AVVENIRE DI UN’ILLUSIONE. RIPRENDERE IL LAVORO DI FREUD: L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI D’AMORE DELLA RAGION PURA.16 giugno 2020, di Federico La Sala
RIPRENDERE IL LAVORO DI FREUD. IL MALE, L’AVVENIRE DI UN’ILLUSIONE ....
Nota a margine di "Il male, un’illusione? Intervento al Convegno Internazionale UNESCO” *
PRIMA DI FARE DICHIARAZIONI STORIOGRAFICHE DI GRANDE IMPEGNO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ARGOMENTAZIONI:
- “[...] Non a caso la letteratura, il teatro e il cinema moderni si sono riempiti di figure di mostri umani, a cominciare dalla divinizzazione retroattiva del marchese de Sade. E così il Moosbrugger dell’Uomo senza qualità di Musil, il tema del Male in Blanchot, il Pierre Rivière di Foucault, fino al serial killer del film di Lars von Trier The House That Jack Built.... Il fascino che l’uomo “al di là del Bene e del Male” esercita oggi su molti di noi deriva dal fatto che quello che era nostro orrore per l’uomo diventa una sorta di ammirazione per il carattere orrendo dell’uomo. (Horrendus in latino significa orrendo, ma anche bellissimo. Horrenda virgo in Virgilio significa “ragazza terribilmente bella”[Aeneid., 11.507]. Era la qualificazione di una dismisura) [...]” (Sergio Benvenuto, "Il male, un’illusione? Intervento al Convegno Internazionale UNESCO”, "Le parole e le cose", 15 giugno 2020);
E PARLARE DI “divinizzazione retroattiva del marchese de Sade” è bene ricordare che l’associazione indebita di “Kant e Sade”, fatta da Lacan, nasce sulla base di una interpretazione edipico-hegeliana e di un vera e propria distruzione della kantiana “critica dell’idealismo”.
E, ancora, quando Freud richiama all’inizio del suo lavoro sulla “Interpretazione dei sogni” le parole di Giunone “flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo” (Eneide, VII, 312), sa già (“sibillina-mente”) di che cosa sta parlando e di cosa c’è in gioco e, come Giunone (“Non mi sarà dato, ahimé, di impedirgli di regnare sui Latini e Lavinia, immutabile, resta sua sposa in forza del destino, ma ho il potere di tirare per il lungo, di imporre dei ritardi a eventi così grandi ...”: Eneide, VII, 312- 315 ), va avanti e ricordando-si di Napoli comincia capire cosa c’è dietro la questione “Didone” (Eneide, IV, 625 ) e la sua infatuazione per Annibale, per il vendicatore: la vittoria di Roma, dell’Amore sulla Morte. Fiducioso, continua il suo lavoro!
La “Horrenda Virgo” (Eneide XI, v. 507) , la “ragazza terribilmente bella”, come Giunone (e Freud), lo sa: deve cedere il passo ad un’altra “Virgo”, ad Astrea, alla Giustizia: «Già viene l’ultima era dell’oracolo di Cuma, / nasce di nuovo il grande ordine dei secoli. / Già ritorna la Vergine, ritornano i regni di Saturno, /già una nuova stirpe scende dall’alto del cielo.» (Ecloga IV, 4-7). La “Horrenda SYbilla” (Eneide VI, 11), ispirata da Apollo, il profeta di Delo, ha rivelato ad Enea tutto il futuro (Eneide VI, 11-12).
PERCHE’ HANNAH ARENDT, nella sua “Vita della mente” (alla luce di un inedito dialogo con Kant) richiama ancora e di nuovo Virgilio e Dante, e dal “Libro del malumore” di Goethe cita: “Chi di tremila anni / Non sa darsi conto, / Rimane all’oscuro inesperto, /Vuol vivere così di giorno in giorno”? Boh e bah?!
*
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- IL “SOGNO D’AMORE” E LA TRAPPOLA DELLA “TRUFFA ROMANTICA” (di Laura Vasselli).10 giugno 2020, di Federico La Sala
La truffa esiste anche in danno alla vita sentimentale
di Laura Vasselli (InLibertà, 10 Giugno 2020)
Chi non ha avuto modo di venire a conoscenza, se pur in modo fugace e non dettagliato, della vicenda del fantomatico Mark Caltagirone, promesso sposo virtuale della nota showgirl Pamela Prati?
Il gossip che si scatenato su di lei per questo autentico guazzabuglio di notizie, sulla cui veridicità si sono scatenati dibattiti televisivi di ogni livello, ha lasciato spazio ad una specie di “giallo informativo”, nel quale si sono aggrovigliati elementi di falso recitativo misti ad esternazioni di reale innamoramento con scenari rosei di vita futura con esclamazioni pubbliche di gioia del tipo “...sarò moglie e mamma!...e altre simili esternazioni.
Ma è meglio procedere con ordine.
Nei fatti reali, diversi mesi fa, Pamela Prati annunciò il suo matrimonio con questo tale Mark Caltagirone che, dal racconto della “promessa sposa”, era un imprenditore italiano che l’aveva portata con sé in molti viaggi di lavoro in giro per il mondo; la showgirl parlava di lui offrendo dati concreti e dichiarando che si trattasse di un personaggio noto nel suo ambiente ed apprezzato come professionista.
Tuttavia, nessun rilievo venne attribuito all’indizio della totale assenza di fotografie di lui, che giustificava con esigenze di riserbo sulla propria vita privata, anche in ragione della presenza dei suoi due bambini che sarebbero stati adottati dalla fidanzata, una volta che sarebbe diventata sua moglie.
Ma la data dell’8 maggio 2019 che era stata annunciata per le nozze, venne rinviata e - a seguito di verifiche, riscontri incrociati e indagini di vario tipo - si accertò che Mark Caltagirone non è mai esistito e che è stato un personaggio completamente inventato.
Dal racconto felice al disagio totale, Pamela Prati - che come ospite aveva raccontato in varie trasmissioni televisive la sua storia d’amore miseramente fallita - è stata costretta suo malgrado ad ammettere di essere stata plagiata, con tanto di conseguenze sul piano giudiziario in danno a chi l’aveva tratta in inganno, salvi poi ulteriori retroscena che non riguardano questo argomento.
Insomma, questo episodio di cronaca rosa ha reso conoscibile l’esistenza di preoccupante fenomeno in diffusione che è proprio quello definito “truffa amorosa” realizzata attraverso un sistema di manipolazione mentale costruita attraverso raffinate tattiche persuasive, elogi esagerati, false prospettive di “vita insieme per sempre” per far seguito a vissuti problematici più o meno verosimili per tutti i truffatori sentimentali in danno a persone desiderose di poter finalmente realizzare qualcosa che - a quanto pare - non passerà mai di moda: il “sogno d’amore”.
Queste vere e proprie condotte criminali penalmente perseguibili, attuate con gli inganni, gli artifizi e i raggiri che connotano il reato di truffa come disciplinata dall’art. 640 del codice penale, risultano essere incrementate nell’ultimo periodo perché favorite dall’isolamento imposto dalla protezione pandemica che ha reso più fragili le persone che vivono in solitudine, così esponendole in maniera così subdola al rischio di essere vittime di questo terribile reato, lesivo della buona fede e della dignità di chi auspica un’esistenza migliore attraverso la ricerca della felicità in coppia.
Attraverso l’uso della rete e dei social networks, i malcapitati destinatari di questo reato vengono portati a legarsi sentimentalmente con il truffatore che agisce fino ad ottenere vantaggi economici e di altra natura con trappole particolarmente sofisticate
Col sistema tipico della tela del ragno, l’autore della truffa comincia col reperire lentamente ogni utile informazione sulla vita privata della sua futura vittima, magari studiando i suoi interessi e le sue abitudini fino all’approccio diretto azionato con la creazione di un falso profilo dotato di apposito nickname.
Spesso la vittima resta malamente intrappolata nella rete perché viene prima sedotta e poi illusa attraverso sapienti approcci con forte carica psicologica persuasiva; questi autentici delinquenti sono infatti sempre pronti a intervenire sulle fragilità e sui i punti deboli della vittima che sono riusciti a scovare mediante questa tattica di attento e incalzante corteggiamento.
Scattano quindi i meccanismi di intimità, fiducia e comprensione tipici dell’innamoramento virtuale con questo partner apparentemente ideale che portano a credere in uno scambio sentimentale vero e proprio e che si realizza mediante attenzioni e pensieri quotidiani a sostegno dell’interesse dell’uno verso la vita dell’altro (compresi i diffusissimi messaggini del buongiorno e della buonanotte a cui viene ancora attribuita una valenza affettiva esageratamente elevata).
Una volta catturata la vittima, colui o colei che pone in essere la truffa, parte con l’azione vera e propria: inizia la filza delle lamentele su problematiche debitorie (tipo: devo restituire denaro a un caro amico che mi ha aiutato nel momento del bisogno!), su danni alla salute (tipo: devo subire un urgente intervento chirurgico!), su emergenze economiche (tipo: ho perso il bancomat!), su progetti in comune (tipo: dobbiamo arredare la nostra futura casa!), ma anche su depressioni causative di disagio che richiedono fondi a vario titolo economico e simili, fino alla diretta richiesta di danaro, di utilità e vantaggi di qualsiasi natura che induce all’offerta di aiuto economico spontaneo vero e proprio da parte della vittima che non riesce a vincere il senso di colpa in caso di diniego a pagare.
Nei casi più gravi, la vittima arriva anche ad indebitarsi e addirittura ad esaurire i risparmi per non deludere la falsa persona amata; non di rado si trova anche isolata per aver il truffatore escogitato anche il piano di allontanamento dagli affetti per rafforzare il suo potere facendogli perdere la lucidità e il senso di realtà.
Ma quel che stupisce maggiormente è che per la “coppia” non c’è, non ci sarà mai neanche alcun incontro personale; normalmente lontani per ragioni lavorative, truffatore e vittima fissano appuntamenti che vengono puntualmente disdettati con scuse o contrattempi di vario genere.
Raramente, infatti, si registrano casi di incontri a scopo sessuale perché il truffatore dovrebbe utilizzare all’esterno la sua falsa identità che costituisce un ulteriore tipo di reato a sé stante.
La suggestione della vittima è quindi talmente forzata da far credere che la finzione si confonda con la realtà; ecco perché occorre sempre - in ogni caso - verificare l’identità degli interlocutori virtuali e segnalare le anomalìe per la tutela di tutti.
Fingere dunque di provare sentimenti verso una persona al solo fine di trarre un ingiusto profitto è reato pieno; chi avesse voglia di approfondire il tema, può leggere la motivazione della Suprema Corte di Cassazione Penale che, con la sentenza n. 25165/2019 in materia di “truffa romantica” ha stabilito che essa
“non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo“
Nota:
IL DESIDERIO, IL “SOGNO D’AMORE”, E LA TRAPPOLA DELLA “TRUFFA ROMANTICA”. *
PER CHI HA AVUTO L’OPPORTUNITA’ O IL MODO “di venire a conoscenza, se pur in modo fugace e non dettagliato, della vicenda del fantomatico Mark Caltagirone, promesso sposo virtuale della nota showgirl Pamela Prati”, CONSIGLIO UNA LETTURA ATTENTA DELL’ARTICOLO “La truffa esiste anche in danno alla vita sentimentale” (Laura Vasselli, "InLibertà", 10.06.2020), TOCCA UNA QUESTIONE FONDAMENTALE DELLA STESSA VITA DI OGNI PERSONA, NON SOLO SUL PIANO DEI RAPPORTI PRIVATI MA ANCHE DEI RAPPORTI PUBBLICI: “[...] credere che la finzione si confonda con la realtà , [...] perdere la lucidità e il senso di realtà”!
QUANTO TALE “PROBLEMA” SIA DEGNO DI ESSERE PENSATO A FONDO (E A TUTTI I LIVELLI) è chiaramente detto - come scrive l’autrice - nella motivazione della Suprema Corte di Cassazione Penale che, con la sentenza n. 25165/2019 in materia di “truffa romantica” ha stabilito che essa “non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo“ (cit.).
CHE DIRE?! E’ UNA SOLLECITAZIONE A SAPERSI CONDURRE CON SENNO SIA NELLE QUESTIONI PRIVATE SIA NELLE QUESTIONI PUBBLICHE E UN INVITO A NON PERDERE IL SENSO DELLA REALTA’ (sul tema, non sembri strano né casuale, si cfr. l’articolo di Italo Mastrolia, su “#iorestoacasa, Forza Italia”). NE VA DELLA NOSTRA STESSA VITA : E’ UN PROBLEMA DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE, A TUTTI I LIVELLI.
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- «Tiresia», il primo e ultimo romanzo di Mario Perniola. L’indovino lacrimante alla ricerca di sé (di Fabrizio Scrivano).9 maggio 2020, di Federico La Sala
IL "METAROMANZO" DI MARIO PERNIOLA. Un tentativo di uscire dalla caverna, e dalle trame millenarie del "romanzo familiare" di Giocasta ed Edipo... *
- "Quando nel 1992 pubblicai il libro Del sentire, il mio amico Giorgio Tagini, con cui discorro di cattolicesimo fin dall’infanzia, mi fece osservare che di tutte le forme del sentire dell’Occidente antico e moderno trattavo, tranne che di quella cristiana. Colmo ora parzialmente questa lacuna e a lui dedico il presente lavoro, senza tuttavia voler minimamente coinvolgerlo in questa impresa che forse giudicherà temeraria.
- Coraggiosa ho invece sempre considerato la sua opinione secondo la quale solo l’eredità dell’antichità classica ci mette in condizione di superare il fanatismo, nonché lo spirito di fazione e di setta, che sembrano oggi estendersi a tutta la società e coinvolgere anche i rapporti più personali e intimi; del resto cercare di capire chi sente e pensa diversamente è una non trascurabile conseguenza del profondo legame che unisce la filosofia all’amicizia. M. P., 25 dicembre 2000" (Mario Perniola, "Del sentire cattolico", Premessa, Il Mulino, Bologna, 2001).
- "Il sentire rituale implica l’abbandono di ogni prospettiva grettamente ideologica [...] Viene così colta con grande acume l’irriducibilità del rituale ad alcunché di cognitivo che può essere descritto in termini di vero o falso o ad alcunché di morale che può essere descritto in termini di bene o male.
- «Manca solo il colpo di grazia - che si chiama passione». Essa implica una perfetta aderenza al «questo» del vivere, il cui esempio è rappresentato dalla passione di Cristo; essa perciò è la chiave della condizione umana, del G. H., del genere umano. «Quando si realizza il vivere, ci si domanda: era dunque solo questo? E la risposta è: non è solo questo, è esattamente questo». Ci si sente così «battezzati dal mondo» e più forte della speranza, più forte dell’amore, è la fiducia" (Mario Perniola, Del sentire casttolico, cit., pp. 156-157, senza le note).
L’indovino lacrimante alla ricerca di sé
«Tiresia», il primo e ultimo romanzo di Mario Perniola. Narrazione filosofica sull’identità, uscì nel 1968. Ora riedito da Mimesis
di Fabrizio Scrivano (il manifesto, 27.03.2020)
- [Foto] L’anima di Tiresia appare a Odisseo, un dettaglio dall’opera di Johann Heinrich Füssli
In una breve divagazione risalente ai primissimi anni Quaranta del Novecento, Emil Cioran scrisse a proposito degli esseri umani che «niente li addolorerebbe peggio che ritrovarsi,sopra il mucchio dei loro piacevoli inganni, di fronte alla pura esistenza». Questa frase, che è insieme un giudizio, una sfida e una prospettiva di studio, non starebbe malissimo, se non in epigrafe, almeno a lato del primo e ultimo romanzo di Mario Perniola, Tiresia (Mimesis, pp.110, euro 12), che il filosofo e teorico dell’arte contemporanea già rinnegava pubblicandolo nel 1968, in quanto «effettivo superamento della mia precedente attività di critico letterario, concentratasi nel libro Il Metaromanzo (edito nel 1966)».
IN EFFETTI, narrazione filosofica sull’identità, sull’essere e sul divenire, Tiresia era pensato escritto come la messa in pratica di una teoria del racconto, e come tale metaromanzo, ma anche voluto da Perniola, in quel tratto di vita, come ultimo gesto prima di divenire altro.
Qualche anno prima di morire,cinquant’anni dopo averlo scritto, Perniola aveva pensato di ripubblicarlo, scrivendo, quale nuova premessa, una severa recensione di sé e dell’opera, che tuttavia riabilitava come strumento di una ricognizione autobiografica.
Il primo degli indovini lacrimanti che Dante nel XX Canto dell’Inferno vide camminare in processione con il volto ritorto rispetto al busto, tanto da far scorrere le lacrime nel solco intergluteo, fu proprio Tiresia, colui «che mutò sembiante / quando di maschio femmina divenne / cangiandosi le membra tutte quante».
NELLA NARRAZIONE mitologica,quello di Tiresia è un tipico caso non risolto cui è comunque assegnata una pena senza fine. Diventato donna per aver toccato col bastone una serpentessa nel momento dell’accoppiamento, dopo sette anni di sessualità femminea decide di reinvertire la sua identità. Non ermafrodita né transessuale né omosessuale ma pienamente l’uno e l’altro sesso in tempi diversi. Per aver incautamente svelato(ma, in altre narrazioni, anche solo per aver conosciuto) i segreti dell’essere donna, viene punito da Era con la cecità e poi ricompensato da Zeus con la chiaroveggenza. Ed è per questo ultimo premio che si trova all’inferno. Diciamo che è un’identità che non sa mai cosa possa condannarlo o premiarlo, e che per questo è costretto ad affidarsi a una trasformazione continua.
PERNIOLA fu molto visionario nell’intercettare questo soggetto, che poteva rappresentare un certo modo di essere senza essere. In particolare qui prende il nome e l’immagine del borghese, inteso come colui che non milita, che non combatte (né può farlo essendo per definizione senza essere alcuno ed essendo anche inconsapevole di questa sua inesistenza) per affermare contemporaneamente sé e la negazione di sé.
 Ma per procedere a questa acquisizione dell’essere e della coscienza di essere, è necessario mutare completamente il corpo, negare la propria identità per poterla riaffermare in quanto
negazione della trasformazione. Così Tiresia, che non ha nulla da rappresentare ma ha il solo obbligo di essere qualcosa, sí manifesta a sé e all’altro da sé con una sola frase tanto rassicurante quanto paradossale: di aver fatto quelle cose solo con te, e per la prima volta. Poteva forse esserci memoria di un dramma teatrale di Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Tirésìas (1916), che recla-mava il piacere del cambiamento consapevole, ma rimane poco e niente di surrealista nel racconto che le diverse identità di Tiresia mettono in fila, che ora parla con lei o di lei, come estranea a sé, ora parla di sé come la lei che non è più o non è ancora.
Ma per procedere a questa acquisizione dell’essere e della coscienza di essere, è necessario mutare completamente il corpo, negare la propria identità per poterla riaffermare in quanto
negazione della trasformazione. Così Tiresia, che non ha nulla da rappresentare ma ha il solo obbligo di essere qualcosa, sí manifesta a sé e all’altro da sé con una sola frase tanto rassicurante quanto paradossale: di aver fatto quelle cose solo con te, e per la prima volta. Poteva forse esserci memoria di un dramma teatrale di Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Tirésìas (1916), che recla-mava il piacere del cambiamento consapevole, ma rimane poco e niente di surrealista nel racconto che le diverse identità di Tiresia mettono in fila, che ora parla con lei o di lei, come estranea a sé, ora parla di sé come la lei che non è più o non è ancora.Uno sdoppiamento sessuale che ricorda assai di più Carlo, il protagonista dell’incompiuto romanzo di Pier Paolo Pasolini, noto a noi tutti con il titolo di Petrolio (scritto dal 1972 e pubblicato postumo nel 1992), che prima si sdoppia tra un modello urbano, Carlo di Polis, e un modello silvestre, Carlo di Tetis, interpretando cioè i due poli dell’accomodamento e della metamorfosi, dell’ubbidienza e del rifiuto, ma che poi si accorge di essere diventato donna, cioè qualcuno di completamente diverso da sé (cangiate tutte quante le membra) e capace perciò di esperienze tutte diverse. «E un romanzo, ma non è scritto come sono scritti i romanzi veri», scriveva Pasolini ad Alberto Moravia: «Ho reso il romanzo oggetto non solo per il lettore ma anche per me: ho messo tale oggetto tra il lettore e me, e ne ho discusso insieme (come si può fare da soli, scrivendo)». Un proposito che sa di metaromanzo anch’esso.
PERNIOLA VOLLE allontanarsi subito da quel modo di dire e ragionare, che percepiva egli stesso come troppo violento (però in realtà umoristico e qualche volta comico). Ma non dal problema che Tiresia poneva: «La femmina è tanto diversa dall’eroe che quando dice una cosa intende esattamente il contrario di ciò che dice; perciò non è vero che menta, lei in realtà non mi mente mai, parla soltanto una lingua che non conoscevo». Che, tentando di non leggere al rovescio questa frase, più o meno significa che conoscere è sorpassare l’inibizione di non riconoscere.
* SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:- PERVERSIONI (...) La mente estatica e l’accoglienza astuta degli apprendisti stregoni. Una nota sul sex-appeal dell’inorganico di Mario Perniola.
IDENTIFICARSI CON CRISTO PER SUPERARE EDIPO. "Frammento inedito" (1931) di Sigmund Freud
DAL DISAGIO ALLA CRISI DELLA CIVILTA’: FINE DEL "ROMANZO FAMILIARE" EDIPICO DELLA CULTURA CATTOLICO-ROMANA.
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica -
 L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944) ?!
L’EUROPA IN CAMMINO - SULLA STRADA DI GOETHE O DI ENZO PACI (“NICODEMO O DELLA NASCITA”, 1944) ?!Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- IL CANTICO DEI CANTICI, L’ANTROPOLOGIA, E LA FILOLOGIA: COME NASCONO I BAMBINI, COME NASCONO LE PAROLE.11 febbraio 2020, di Federico La Sala
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! ... *
Cantico dei Cantici.
Il corpo delle donne (intimità della Bibbia)
di Luigino Bruni (Avvenire, martedì 11 febbraio 2020)
Sono tra coloro che sono rimasti delusi dalla performance di Roberto Benigni al Festival di Sanremo dedicata al biblico Cantico dei Cantici. Forse perché avevo aspettative alte, grazie al ricordo, vivissimo, delle sue meravigliose letture di Dante, della Costituzione italiana, dei Dieci comandamenti; forse perché Benigni ci ha donato film molto amati per la loro poesia e forza etica.
Ma, forse, in questa delusione c’è anche qualcosa di più. Il corpo delle donne, insieme a quello dei bambini, è il primo bene che una civiltà deve tutelare e proteggere con tutte le sue forze. Quando un uomo, un maschio, parla del corpo della donna, prima deve togliersi i calzari dai piedi perché sta entrando in un territorio sacro, una terra fatta sacra da molto amore e da moltissimo dolore. Da sempre il corpo della donna, prima di essere icona dell’amore, è stato immagine di potere, di violenza, di abusi e di soprusi, di corpo ferito e di eros comprato dai maschi.
 Non si può parlare del corpo delle donne senza avere ben in mente i molti millenni di storia umana in cui le donne hanno vissuto il proprio corpo come luogo da custodire e da preservare dall’uso cattivo dei maschi, un uso sbagliato che ancora troppo spesso è presente e non solo storia.
Non si può parlare del corpo delle donne senza avere ben in mente i molti millenni di storia umana in cui le donne hanno vissuto il proprio corpo come luogo da custodire e da preservare dall’uso cattivo dei maschi, un uso sbagliato che ancora troppo spesso è presente e non solo storia.Ho guardato Benigni insieme a mia mamma e mia sorella. Due donne moderne, laiche, riconciliate con la vita e con i corpi loro, dei figli e dei mariti. Non hanno detto una parola durante lo spettacolo, ma l’aria di casa si è riempita di un pudore mescolato con l’imbarazzo e il disagio.
 Accanto a loro, io ho avuto forte l’impressione di vedere sullo schermo una donna denudata in pubblico da Benigni, senza che lei avesse dato il suo consenso, denudata ai soli fini dello show. Ho visto quella giovane donna medio-orientale, vissuta due millenni e mezzo fa, e in lei ho rivisto le bellissime ragazze delle Mezzaluna fertile (il Cantico mette insieme antichi poemi nuziali babilonesi e cananei).
Accanto a loro, io ho avuto forte l’impressione di vedere sullo schermo una donna denudata in pubblico da Benigni, senza che lei avesse dato il suo consenso, denudata ai soli fini dello show. Ho visto quella giovane donna medio-orientale, vissuta due millenni e mezzo fa, e in lei ho rivisto le bellissime ragazze delle Mezzaluna fertile (il Cantico mette insieme antichi poemi nuziali babilonesi e cananei).Una ragazza ’bruna’ in un mondo di maschi, in una cultura patriarcale che vedeva poco e male le donne, nascoste sotto la tenda, a occuparsi per tutta la vita di bambini e anziani. Quando nella Bibbia si incrocia una donna non è mai un incontro banale. Quelle donne hanno in genere lottato e sofferto molto per entrare in quel racconto, hanno dovuto farsi spazio in una cultura che non glielo dava spontaneamente.
Donne che vivevano poco e male, quasi tutte analfabete, e non di rado morivano per gravidanze non sempre volute e desiderate. Quale eros conosceva quella ragazza del Cantico? Non certamente quello delle fantasie di noi maschi del XXI secolo, né quello che ci ha raccontato Benigni.
 Il Cantico è testo profetico, perché dice ai maschi e alle donne del suo tempo quale fosse il disegno di Dio sulla donna e sull’amore. Non era la descrizione dell’eros che quegli antichi scrittori vedevano attorno a loro, ma l’eros di un mondo futuro sempre desiderato e mai raggiunto.
Il Cantico è testo profetico, perché dice ai maschi e alle donne del suo tempo quale fosse il disegno di Dio sulla donna e sull’amore. Non era la descrizione dell’eros che quegli antichi scrittori vedevano attorno a loro, ma l’eros di un mondo futuro sempre desiderato e mai raggiunto.
 Non dobbiamo infatti dimenticare che il Cantico è un intreccio di presenza e di assenza dell’amato. È anche un canto all’amore non trovato, che fugge, che non si trova:
Non dobbiamo infatti dimenticare che il Cantico è un intreccio di presenza e di assenza dell’amato. È anche un canto all’amore non trovato, che fugge, che non si trova:«Lungo la notte, ho cercato l’amore dell’anima mia; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze; voglio cercare l’amore dell’anima mia. L’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: ’Avete visto l’amore dell’anima mia?’» (Cantico 3,1-3).
Senza questa dimensione di mancanza, di assenza, di limite, non si comprende l’eros che diventa solo gioco o sterile ricerca di piacere. L’eros è insieme pienezza e indigenza, ferita e benedizione. Ferita per tutti, uomini e donne, ma diversamente e di più per le donne (ferita, cioè vulnus).
Non credo che il Cantico sia stato scritto da una donna, e non lo credo per molte ragioni. Ma soprattutto non lo credo perché una donna non avrebbe parlato del proprio corpo e di quello del suo uomo con quelle parole. Le donne hanno altre parole per parlare dell’amore, dell’eros, della philia e dell’agape. Perché dell’eros le donne amano parlare solo due alla volta, nell’intimità di un rapporto d’amore, dove le parole non dette e quelle sussurrate sono importanti almeno quanto il corpo donato, e quando mancano queste poche parole diverse il corpo parla poco e male.
L’unico numero buono dell’eros è il due. E quando dell’eros si parla troppo e si parla in pubblico l’eros diventa altro, ed è bene usare altre parole molto meno nobili. La Bibbia ha da sempre letto quell’antico canto nuziale in modo sapienziale, allegorico e profetico, non per negare l’eros ma per salvarlo, perché l’unico modo per salvare l’eros è custodirlo nella sua intimità e nel suo nascondimento. E quando il Cantico viene letto senza ideologie e manipolazioni, non si fa una esperienza erotica, ma si fa una esperienza spirituale, mistica e soprattutto poetica:
«Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! Perché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!» (2,10-13).
La poesia è stata infatti la grande assente dalla lettura di Benigni, una poesia mangiata dalla bramosia, molto infantile, di stupire gli spettatori con quell’eros ’nascosto’ dai preti e rabbini finalmente scoperto e liberato. Tutti i giorni i media usano i corpi delle donne per fare spettacolo, per vendere, per fare audience. E ogni giorno di più. La Bibbia non lo ha mai fatto. Parla poco di eros e di sesso, perché ne rispetta il mistero e l’intimità. La Bibbia va portata in tv, va portata ovunque, perché parla solo e sempre di vita. Ma se proviamo a manipolarla si chiude e non ci fa accedere al suo mistero e alla sua bellezza. Come, nonostante le probabili buone intenzioni, è accaduto l’altra sera sul palco di Sanremo.
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
L’AMORE NON E’ LO ZIMBELLO DEL TEMPO: "AMORE E’ PIU’ FORTE DI MORTE" (Cantico dei cantici: 8.6). Un omaggio a William Shakespeare e a Giovanni Garbini.
COME NASCONO I BAMBINI? E COME ‘NASCONO’ I GENITORI?! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
- ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA. IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS - NON IL "LOGO"! La questione della "Parola" e della "Lingua" ...
- RILEGGERE SAUSSURE. UN "TRATTATO TEOLOGICO-POLITICO" RIDOTTO A UN BANALE "CORSO DI LINGUISTICA GENERALE"!!!
DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- Il sorprendente dono del Cantico dei Cantici a Sanremo (di Rosanna Virgili).8 febbraio 2020, di Federico La Sala
«Canzonissima della Bibbia».
Il sorprendente dono del Cantico dei Cantici a Sanremo
di Rosanna Virgili (Avvenire, sabato 8 febbraio 2020)
Che gioia il Cantico dei Cantici a Sanremo! Grazie a Roberto Benigni che ha sorpreso e stupito il Festival con quel libretto della Bibbia che la tradizione ebraica e cristiana ha conservato come la canzone più bella, la ’canzonissima’ secondo una suggestione di Gianluigi Prato. Tre sono i trascendentali: verum, bonum e pulchrum. Importante è il bello. L’arte, nelle sue forme più nobili - quali la musica, la pittura, la poesia - è capace di far emergere il divino che si annida nella Parola, più di ogni altro linguaggio.
E allora l’idea di far conoscere e gustare il Cantico è stata davvero stupenda, appropriata, preziosa per un pubblico tanto vasto e popolare come quello del Sanremo in mondovisione (e non può inficiarla neppure la forzata ’licenza interpretativa’ che ha tradotto, tradendolo, l’amore tra amato e amata in altri amori che sono lontani e fuori dal limpido orizzonte biblico).
Del resto i duetti del Cantico, intervallati dalle voci del coro, assomigliano ai testi delle canzoni in gara e anch’essi nascono in un ambiente popolare; quadretti di vita rurale che hanno il sapore delle sere d’estate o del primo autunno quando, dopo la mietitura o la vendemmia, a notte, si faceva festa e gli occhi e le braccia dei ragazzi e delle ragazze si incrociavano, si intrecciavano, si inebriavano al sogno dei baci. Nel Cantico - scrive Guido Ceronetti - non c’è il nome di Dio, perché tutto è puro, quindi tutto è sacro! La forza dell’amore sveglia la primavera sui passi dell’amante che - inverosimilmente - è una donna. È lei a uscire per prima verso chi ancora non ha mai visto, ma è solcato nel suo desiderio profondo, nelle sue cavità vitali. Trasgressiva, testarda è la ’sorella’ del Cantico, si sottrae all’autorità dei fratelli, non cura la sua vigna ma corre verso le ’tende dei pastori’, esce nei deserti, batte la campagna, sfida le guardie alle mura della città, ’malata d’amore’! Una vera anomalia per un mondo in cui le donne non potevano scegliere i loro uomini ma venivano date in spose a scopo di procurare ai mariti una discendenza. Non avevano diritto sul proprio corpo, ma la donna del Cantico lo rapisce e ne fa guida e grammatica del viaggio dell’Amore. C’è un esodo dal sé, un’effrazione del self, per osare gli ignoti sentieri, le rischiose curve, gli anfratti del volto dell’Altro.
L’Amore è un’avventura senza garanzie, una strada senza ritorno, ’forte più della morte’. Irreversibile, fonte di creature nuove, diverse, bagnate di futuro. Amore che azzera i possessivi: ’io sono sua, mentre lui è mio’: l’estasi di un’unione che non risponde alla tentazione di divorare l’altro, rendendolo un cadavere.
Ma è pienezza di ’te’: del consegnarmi a te. Bocca d’infinito, sorso d’eternità, graffio di Vita! Nel testo originario le sue consonanti asciutte, nette, impossibili a essere fraintese. I sensi sono sentinelle e finestre del corpo, teso fuori di sé. ’Una voce, il mio amato’: il primo senso è casto come l’udito. ’Come sei bella, amica mia, come sei bella, le tue labbra una striscia di porpora’. Gli occhi di lui scoprono l’incanto della pelle di lei ’color del miele’, traduce magnificamente Luca Mazzinghi. Il tuo profumo è la quintessenzadi ogni aroma delle piante più squisite d’Oriente; ’c’è latte e miele sotto la tua lingua’; l’olfatto e il gusto si alleano nell’estasi d’Amore dove il tuo nardo è ben più forte di ogni vino drogato. Restituiscono al corpo la sua anima. Un minuto solo dura il tatto ma procura un vero svenimento; com’era per i Greci così nel Cantico, l’Amore è lelymmenos ’scioglitore di membra’. Per fare ’dei due un corpo solo’ direbbe l’Apostolo Paolo.
L’Amore è attesa, fatica, sudore di brama e di timore; esso regala attimi di estasi e anni di deserto, però quegli attimi valgono bene gli anni! L’Amore è corpo nudo, vuoto, puro, come il Santo dei Santi. Per questo il Cantico è il libro dei mistici, Paese sospeso. Dio come in un passaggio, la meghillà di Pasqua. Nel corpo che si perde è il profumo di Dio. Per questo è un gran peccato che la Chiesa abbia impedito per secoli l’accesso a questo piccolo libro, grandissimo tesoro, fonte di salute e salvezza per il corpo e per l’anima. Teniamo sveglio il cuore ora che ’il tempo del canto è tornato’.
-
> "PERVERSIONI" - «Il "Moro" ci dice che il capitalismo gronda sangue, ma porta nel mondo una più alta razionalità. Perciò non pensa la riproduzione, un’attività irriducibile alle macchine». Interv. a silvia Federici (di Paola Rudan).1 febbraio 2020, di Federico La Sala
Silvia Federici, quello che Marx non ha visto
L’intervista . Parla l’accademica e femminista italiana che vive negli Stati Uniti. Autrice del fortunato «Calibano e la strega», il suo «Genere e Capitale» è di imminente pubblicazione per DeriveApprodi. «Il "Moro" ci dice che il capitalismo gronda sangue, ma porta nel mondo una più alta razionalità. Perciò non pensa la riproduzione, un’attività irriducibile alle macchine»
di Paola Rudan (il manifesto, 30.01.2020)
In occasione dell’imminente uscita di Genere e Capitale. Per una rilettura femminista di Marx (con la casa editrice DeriveApprodi), abbiamo raggiunto l’autrice Silvia Federici per un’intervista. A risaltare è il rapporto conflittuale dell’autrice con il pensiero di Marx, considerato tanto fondamentale per la critica del capitalismo quanto insufficiente a coglierne il carattere distruttivo. Centrale è per Federici la necessità di fare i conti con la complessità delle lotte che contestano il dominio del capitale e di cui le donne - indigene, migranti, proletarie - sono oggi protagoniste in ogni parte del mondo.
Che cosa motiva questo ripensamento di Marx, che oggi sembra più aspro e polemico che in passato?
Una motivazione più immediata è relativa alla necessità di rispondere all’ondata di celebrazioni che si sono fatte in occasione dell’anniversario della pubblicazione del Capitale e poi della nascita di Marx. Bisogna celebrare, ma anche domandarsi dove è necessario andare oltre.
 La seconda motivazione è più profonda: mentre negli anni Settanta la critica a Marx si concentrava sul fatto che non ha visto tutta l’area della riproduzione, quindi il lavoro delle donne, con il passare del tempo ho compreso che questa sottovalutazione è collegata anche a un limite più profondo del suo pensiero, la sopravvalutazione del capitalismo in una visione storica progressista. Marx ci dice che il capitalismo gronda sangue sporco, ma porta nel mondo una razionalità più alta.
La seconda motivazione è più profonda: mentre negli anni Settanta la critica a Marx si concentrava sul fatto che non ha visto tutta l’area della riproduzione, quindi il lavoro delle donne, con il passare del tempo ho compreso che questa sottovalutazione è collegata anche a un limite più profondo del suo pensiero, la sopravvalutazione del capitalismo in una visione storica progressista. Marx ci dice che il capitalismo gronda sangue sporco, ma porta nel mondo una razionalità più alta.
 Questo è forse il peccato originale a causa del quale Marx non pensa la riproduzione, perché è un’attività irriducibile alla meccanizzazione, all’industrializzazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro domestico, l’allevamento dei bambini, la sessualità, l’aspetto emotivo. Il confronto allora non è più aspro, ma più profondo. A motivare questo tipo di critica, infine, è la distruzione ambientale causata dalla tecnologia e specialmente dal digitale. Se guardo a quello che succede in Congo, o in Niger, vedo la distruzione e i massacri che si stanno verificando in gran parte dell’Africa e sono dovuti a espropriazioni massicce e brutali funzionali alle compagnie minerarie e petrolifere.
Questo è forse il peccato originale a causa del quale Marx non pensa la riproduzione, perché è un’attività irriducibile alla meccanizzazione, all’industrializzazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro domestico, l’allevamento dei bambini, la sessualità, l’aspetto emotivo. Il confronto allora non è più aspro, ma più profondo. A motivare questo tipo di critica, infine, è la distruzione ambientale causata dalla tecnologia e specialmente dal digitale. Se guardo a quello che succede in Congo, o in Niger, vedo la distruzione e i massacri che si stanno verificando in gran parte dell’Africa e sono dovuti a espropriazioni massicce e brutali funzionali alle compagnie minerarie e petrolifere.
 Sono stata sempre polemica con l’idea che la lotta più efficace contro il capitalismo si dà ai livelli più alti dello sviluppo tecnologico, e anche con gli accelerazionisti. Che cosa acceleriamo? I massacri, lo spossessamento delle terre? Sviluppo oggi vuol dire violenza, ma in mille luoghi si sta combattendo contro lo sviluppo capitalistico. Se oggi Marx guardasse queste lotte le considererebbe arretrate?
Sono stata sempre polemica con l’idea che la lotta più efficace contro il capitalismo si dà ai livelli più alti dello sviluppo tecnologico, e anche con gli accelerazionisti. Che cosa acceleriamo? I massacri, lo spossessamento delle terre? Sviluppo oggi vuol dire violenza, ma in mille luoghi si sta combattendo contro lo sviluppo capitalistico. Se oggi Marx guardasse queste lotte le considererebbe arretrate?Lei non pensa al salario solo come retribuzione del lavoro, ma come rapporto sociale di dominio, che coinvolge anche chi non svolge un lavoro salariato, come le casalinghe. Parlando delle esperienze contemporanee di organizzazione autonoma comunitaria sembra però che valorizzi politicamente proprio il carattere non retribuito del lavoro che si svolge al loro interno, come una sorta di esteriorità al capitale.
Costruisco i miei discorsi a partire dalle esperienze di lotta. Il discorso sul salario per il lavoro domestico nasceva in un contesto nel quale esistevano grandi movimenti di donne, soprattutto nere, che già parlavano di lavoro domestico in altri termini. Adesso, guardando a queste esperienze della post-globalizzazione, di milioni di persone che sono state dislocate dalle loro terre, che non sono state integrate nel lavoro salariato ma stanno costruendo qualcosa, allora il discorso si è articolato di più. I due obiettivi fondamentali rimangono il rifiuto del lavoro non pagato e il recupero della ricchezza sociale, che comunque vedo anche in esperimenti comunitari come le villas miserias argentine. C’è un momento di riappropriazione della ricchezza non solo per i terreni occupati, ma anche perché si crea un tessuto sociale più solidale che ti permette di affrontare lo Stato in modo da ottenere dei beni materiali. Questa non è un’alternativa al discorso del salario, ma è una maggiore articolazione.
In quest’enfasi sulle esperienze comunitarie non c’è il rischio di un’identificazione delle donne con il lavoro riproduttivo?
È un discorso complicato. Noi femministe degli anni Settanta siamo state le prime a contestare il discorso identitario, abbiamo detto che la femminilità è una cosa costruita e da sempre la mia posizione fondamentale è che non c’è un significato universale dell’essere donne. Che cosa vuol dire essere donne è sempre diverso ed è una lotta continua per stabilire chi sei, chi non sei, che cosa vogliamo essere. Detto questo, rimane anche vero - ed è qui che si possono generare degli equivoci - che guardando all’esperienza che moltissime donne hanno vissuto in America Latina, per esempio, risulta che siccome sono loro che per prime hanno a che fare con i bambini, con le malattie, con il fare da mangiare, sono anche quelle in prima linea contro i progetti estrattivi.
 Le loro però sono esperienze storiche che si collegano all’appropriazione, all’agricoltura, alle sementi, che non riguardano la natura ma la conoscenza. Ci sono conoscenze profonde di che cosa c’è nell’acqua, nella terra, nelle piante, del rapporto con gli animali. Ascoltare queste storie, vedere queste esperienze è quello che alla mia età, dopo aver visto tanto, mi dà coraggio, mi dà forza.
Le loro però sono esperienze storiche che si collegano all’appropriazione, all’agricoltura, alle sementi, che non riguardano la natura ma la conoscenza. Ci sono conoscenze profonde di che cosa c’è nell’acqua, nella terra, nelle piante, del rapporto con gli animali. Ascoltare queste storie, vedere queste esperienze è quello che alla mia età, dopo aver visto tanto, mi dà coraggio, mi dà forza.L’altro problema sul quale insiste è quello del razzismo. Fenomeno che si riconfigura in un contesto globale segnato da movimenti di donne e uomini senza precedenti, e contemporaneamente ridefinisce il lavoro domestico e riproduttivo rispetto al passato.
Per me la lotta delle lavoratrici domestiche migranti è uno dei movimenti di donne più importante di questi anni. Porta in sé tutte le rivendicazioni che riguardano sia il discorso sulla riproduzione e la valorizzazione - loro dicono «senza di noi niente si muove» - sia quello della colonialità e del razzismo. Con questo il movimento femminista non si è ancora rapportato in modo reale e decisivo. Per migrare devi sfondare mille porte, devi avere una comprensione dei rapporti internazionali, delle polizie, delle leggi, delle norme sul lavoro, è quindi un movimento molto ricco di conoscenze e di capacità di rottura.
Nel suo lavoro ha sottolineato come oppressione sessuale e razzismo non siano fattori solo culturali. Perciò si concentra sul lavoro delle donne. Oggi i movimenti delle donne stanno contestando in altro modo la distinzione tra il «culturale» e il «materiale», perché considerano la violenza maschile costitutiva dei rapporti sociali.
È vero anche il fatto che le condizioni materiali generano la violenza. L’indebitamento nella famiglia accresce l’intensità della violenza. L’organizzazione del lavoro negli Stati Uniti genera violenza. È difficilissimo sfuggire alle molestie di chi controlla il posto di lavoro. Le cameriere nei ristoranti devono «vendere il corpo» per ottenere mance perché nella maggior parte dei posti di lavoro non ti danno un salario ma vivi di mance. La mancia ti obbliga a mostrare il décolleté, a sporgere i seni, soprattutto alla fine del mese. Cameriere e proletarie dicono che le attrici che hanno animato il movimento #metoo sono privilegiate. Devono combattere con quelli che le toccano, ma da loro dipende la mancia.
Qual è la sua riflessione sul movimento femminista globale che è cresciuto e si è consolidato negli ultimi anni?
Il tema della violenza ha subito una grande trasformazione, agli inizi si è concentrato sulla violenza domestica, ma ora è messa al centro anche la sua dimensione pubblica. L’iniziativa delle donne di Las Tesis in Cile, che dicono allo Stato «lo stupratore sei tu» è il simbolo di questo cambiamento che riconosce la violenza non solo nelle case ma anche quella istituzionale ed economica. Quando si svalorizza una moneta e da un giorno all’altro migliaia di persone non hanno più niente, o si chiude un’azienda e la gente è sul lastrico, o aumentano gli affitti e la gente dorme in strada, questa è violenza. Oggi il movimento vede come violenza lo stupro, il femminicidio, ma anche l’esproprio dalle terre, l’imposizione della miniera, la gentrificazione che ti costringe a vivere per strada, e ormai capisce che è un rapporto che si dà in forme diverse ma a livello globale. È un momento molto importante, per cui se abbiamo i Bolsonaro e i Trump, abbiamo anche una risposta. Anzi, forse i Trump e i Bolsonaro sono loro la risposta: vedo anche la fascistizzazione come una risposta a un forte movimento dal basso. Si rendono conto che il movimento delle donne sta trainando le lotte. Questo è un momento terribile ma c’è anche una grossa agitazione dal basso. Credo che oggi la gran parte del mondo sappia che il capitalismo è un sistema distruttivo, orrendo. Il problema è come organizzarsi.
-
> "PERVERSIONI" --- CARITÀ O EMPATIA?: CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO, A PARTIRE DALLA "FILOLOGIA"!1 febbraio 2020, di Federico La Sala
CAPIRE IL COMPORTAMENTO UMANO.
Linguaggio ed empatia in W. V. Quine
Carità o empatia?
di Antonio Rainone *
Esiste una tematica nella filosofia del linguaggio e nell’epistemologia di W. V. Quine che può apparire per molti versi atipica o sorprendente a chi abbia del celebre filosofo statunitense un’immagine limitata alle sue concezioni fisicalistiche e comportamentistiche, per non dire “scientistiche”, non di rado considerate le più caratteristiche della sua produzione filosofica. Si tratta della tematica dell’empatia, cioè della capacità di avanzare spiegazioni o interpretazioni del comportamento (linguistico e non) di altri soggetti “mettendosi nei loro panni” o “simulandone” la situazione cognitiva o, ancora, assumendone immaginativamente il ruolo.
 L’empatia - anche indipendentemente da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object (1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione più tarda.
L’empatia - anche indipendentemente da Quine - ha peraltro suscitato una particolare attenzione nella filosofia della mente degli ultimi trent’anni, dove ha dato vita a un ampio dibattito sul cosiddetto mindreading, incontrandosi inoltre con la teoria neuroscientifica dei cosiddetti neuroni specchio 1. I più recenti lavori sulla filosofia del linguaggio di Quine dedicano una particolare attenzione a tale tematica 2, anche perché Quine, pur accennandovi in Word and Object (1960), ne ha proposto una esplicita teorizzazione solo nella sua produzione più tarda.A partire dagli anni Settanta, ma più esplicitamente negli anni Novanta, Quine ha considerato il metodo dell’empatia come il metodo fondamentale di traduzione nel celebre Gedankenexperiment della traduzione radicale (ovvero la traduzione di una lingua completamente sconosciuta), ma anche come una capacità naturale ai fini dell’acquisizione del linguaggio e dell’attribuzione di stati mentali intenzionali (ossia percezioni, credenze, desideri ecc.) ad altri. In effetti, l’empatia ha acquisito un rilievo così crescente in Quine che nei suoi due ultimi lavori sistematici, Pursuit of Truth (1992) e From Stimulus to Science (1995), essa appare come un nucleo centrale della sua filosofia del linguaggio e della mente.
È stato del resto lo stesso Quine a sottolineare la rilevanza dell’empatia nella sua filosofia del linguaggio, “retrodatandone”, per così dire, la teorizzazione agli anni Cinquanta. Così Quine si esprime in uno dei suoi ultimi interventi sulla questione:
- Il mio uso della parola “empatia” è piuttosto recente ed è stato notato, ma io avevo già riconosciuto che l’approccio del traduttore radicale è di tipo empatico in Word and Object e, in realtà, già nove anni prima. «Il lessicografo - avevo scritto - dipende [...] da una proiezione di sé stesso, con la sua Weltanschauung indo-europea, nei sandali del suo informatore Kalaba» (Quine, 2000, p. 410).
Il brano qui citato da Quine, ripreso dall’importante The Problem of Meaning in Linguistics (1951b, p. 63) - una notevole anticipazione della problematica della traduzione radicale - non è privo di una certa ambiguità, prestandosi a una duplice lettura. È forse vero che in Word and Object alcune affermazioni di Quine potrebbero essere interpretate come la proposta di un metodo empatico, sostenuto comunque in modo non del tutto esplicito (cfr. Rainone, 1995), ma possono essere avanzati dei dubbi circa la difesa di tale metodo nel saggio del 1951. Se da un lato il concetto di proiezione sembra proporre il metodo dell’empatia nell’attività di traduzione di una lingua completamente sconosciuta da parte di un etnolinguista, dall’altro sembra in effetti riferirsi non tanto al metodo empatico, quanto, piuttosto, a quello che, grazie allo stesso Quine, e in seguito a Donald Davidson (cfr. Davidson, 1984), sarebbe diventato noto come «principio di carità» (principle of charity). Il linguista - asseriva infatti Quine - proietta sé stesso con la sua Weltanschauung nei panni del nativo che usa una lingua sconosciuta, presupponendo (o ipotizzando) così che il suo informatore si conformi ai suoi principi logici e abbia le sue stesse credenze (ritenute vere) riguardo alla realtà (sono questi, grosso modo, i principali tenet del principio di carità, che presuppone una comune natura razionale tra interprete/ traduttore e interpretato/parlante).
In Word and Object Quine avrebbe esplicitamente utilizzato - e teorizzato - il principio di carità riguardo alla traduzione dei connettivi logici e degli enunciati “ovvi”. L’esempio più pertinente, in merito, è rappresentato dal «caso estremo» di qualche nativo che accetti come veri enunciati traducibili nella forma “p e non-p” (per esempio, “piove e non piove”), una forma enunciativa che, violando il principio di non contraddizione, deporrebbe per Quine non a favore dell’irrazionalità dei parlanti - come riteneva Lévy-Bruhl con la sua teoria della «mentalità prelogica» - ma contro la correttezza della traduzione (Quine, 1960, p. 58).
Il medesimo argomento varrebbe inoltre per la traduzione di enunciati ovvi: una risposta negativa da parte del nativo alla domanda (nella lingua nativa) “sta piovendo?” fatta sotto la pioggia costituirebbe una prova di cattiva traduzione nella lingua nativa, non del fatto che il nativo non condivida con il traduttore la credenza in qualcosa di così evidente. In generale, nota Quine in un famoso passo di Word and Object, «quanto più assurde o esotiche sono le credenze attribuite a una persona tanto più sospetti abbiamo il diritto di essere nei confronti delle traduzioni; il mito dei popoli prelogici segna solo il caso estremo» (ivi, p. 68).
Difficilmente, pertanto, la «proiezione» del linguista nei «sandali» del nativo di cui Quine parlava nel saggio del 1951 potrebbe apparire come una forma di metodo empatico, dal momento che essa “imporrebbe” al nativo uno «schema concettuale» (quello del linguista) che, per quanto il linguista può saperne, potrebbe essergli del tutto estraneo. Questo è, in fondo, il problema sottostante a tutto il celebre secondo capitolo di Word and Object 3. Non vi sarebbe alcuna garanzia, infatti, secondo Quine, che i nativi condividano lo stesso schema concettuale (la stessa Weltanschauung) del linguista. Ma il linguista non può, d’altro canto, che fare affidamento sul proprio linguaggio (o schema concettuale), data la scarsa evidenza empirica di cui dispone nel tradurre la lingua sconosciuta. Basarsi sul proprio schema concettuale, proiettandolo sul «linguaggio della giungla», è una necessità pratica, che - asseriva Quine in Word and Object - investirebbe soprattutto l’elaborazione delle «ipotesi analitiche», ovvero le ipotetiche correlazioni tra le emissioni verbali olofrastiche dei nativi e le loro possibili traduzioni mediante cui il linguista deve stabilire quali frammenti di enunciati andranno considerati termini (singolari e generali), quali congiunzioni, quali articoli, quali desinenze per il plurale e quali pronomi, sulla cui base individuare un insieme plausibile di credenze ontologiche ed epistemiche. La scelta delle ipotesi analitiche, infatti, non è altro che un modo di «catapultarsi nel linguaggio della giungla utilizzando i propri modelli linguistici » (ivi, p. 70).
 Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.
Per ricordare il celebre esempio di Quine, la traduzione del proferimento di “gavagai” con “coniglio” (invece che con alternative bizzarre quali “stadi di coniglio” o “sta conigliando”, per quanto ammissibili sulla base dell’evidenza osservativa) equipara l’emissione verbale nativa a un termine generale del linguaggio del linguista, ma nulla esclude che i nativi possano essere privi di un termine referenziale generale per designare i conigli, anche se il linguista ritiene ciò “caritatevolmente” improbabile.Utilizzare i modelli del proprio linguaggio per tradurre un linguaggio alieno non equivale quindi ad applicare un metodo empatico di comprensione, trattandosi al massimo di un’ulteriore e più ampia applicazione del principio di carità. L’empatia sembra in realtà qualcosa di diverso dalla carità: a differenza di quest’ultima, l’empatia non presuppone necessariamente una condivisione di significati e stati cognitivi (credenze). Forse l’assunzione di un’analogia di stati cognitivi tra interprete e interpretato - il «ritrovamento dell’io nel tu», secondo la celebre formula di Wilhelm Dilthey (1927, trad. it. p. 293) - può apparire inevitabile ed efficace riguardo alle risposte verbali fenomenologiche direttamente connesse a stimolazioni elementari provenienti da eventi osservativi intersoggettivi del mondo esterno (la pioggia, il colore rosso, il caldo e il freddo ecc.): ci si aspetta infatti che i nativi, che presentano una conformazione neurofisiologica e neuropsicologica analoga alla nostra, non abbiano percezioni di tipo diverso dalle nostre, rispondendo linguisticamente a tali percezioni in modo analogo a come risponderemmo noi; in tal caso l’empatia sembrerebbe indistinguibile dalla carità interpretativa, in quanto fondata sull’assunzione dell’esistenza di meccanismi percettivi comuni ai soggetti coinvolti. Ma difficilmente tale analogia potrebbe essere presupposta allorché si tratti di tradurre il linguaggio o spiegare il comportamento di soggetti appartenenti a una cultura del tutto estranea a quella dell’interprete. In questo caso l’interprete dovrà in qualche modo “entrare”, per così dire, nella “mente” dei soggetti da interpretare per comprendere il loro peculiare punto di vista, le loro credenze sulla realtà e i significati delle loro parole.
In definitiva, la differenza tra carità ed empatia può essere intesa come la differenza tra imporre il proprio punto di vista all’altro e assumere il punto di vista dell’altro. La differenza è particolarmente rilevante nei casi di interpretazione di soggetti appartenenti a “mondi” radicalmente diversi da quello dell’interprete. Se così non fosse, difficilmente gli etnoantropologi avrebbero potuto attribuire credenze animistiche o culti religiosi atipici (come i celebri cargo cults) alle popolazioni studiate (in entrambi i casi si dovrebbe trattare, secondo un’interpretazione caritatevole, di errori di traduzione o interpretazione).
Non dovrebbe costituire motivo di sorpresa, allora, che David K. Lewis, in un saggio dedicato alla problematica davidsoniana dell’«interpretazione radicale», avesse dato una definizione del principio di carità che ingloba, per così dire, anche il procedimento empatico: un soggetto di interpretazione, asseriva Lewis, «dovrebbe credere ciò che crediamo noi, o forse ciò che avremmo creduto noi al suo posto; e dovrebbe desiderare ciò che desideriamo noi, o forse ciò che avremmo desiderato noi al suo posto» (Lewis, 1974, p. 336; corsivi aggiunti).
 In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.
In pratica, secondo questa definizione del principio di carità, si tratterebbe di assumere empaticamente il punto di vista dei soggetti interpretati, tenendo conto delle loro credenze (eventualmente false o strane) e della loro cultura di appartenenza, attribuendo a essi non le credenze e i desideri dell’interprete, ma le credenze e i desideri che l’interprete avrebbe se fosse “nei loro panni”. Si può aggiungere, a tale proposito, che l’empatia rappresenta una sorta di “correttivo” del principio di carità, tenendo conto del punto di vista dell’altro.Ma forse c’è ancora qualcosa da dire: mentre la carità impone dei vincoli normativi sulla razionalità dei soggetti da interpretare - vincoli a priori basati sui principi logici e sulle norme di razionalità epistemica e pratica dell’interprete, ritenuti universali 4 -, l’empatia sembrerebbe invece un metodo descrittivo ed empirico, essendo subordinata all’acquisizione di un’ampia gamma di informazioni relative alle credenze, alla cultura e alle esperienze passate dei soggetti da interpretare (inutile aggiungere che non c’è accordo su quest’ultimo punto).
4. Si può ricordare, riguardo a questa presunta universalità, che Robert Nozick ha contestato il principio di carità in quanto assunzione di tipo «imperialistico», conferendo tale principio «un peso indebito alla posizione che accade di occupare a noi, alle nostre credenze e alle nostre preferenze» (Nozick, 1993, p. 153). Giustamente, Nozick fa notare che difficilmente questa sarebbe l’assunzione di un antropologo relativamente alle cosiddette società “primitive” (ivi, p. 154).
* Cfr. Antonio Rainone, "Capire il comportamento umano. Azione, razionalità, empatia", Carocci editore, Roma, 2019, pp. 55-59, ripresa parziale.
- UNA STORIA DI LUNGA DURATA: IL CERVELLO IN UNA VASCA. Amore (Charitas) o Mammona (Caritas)?! Il «principio di carità» ("caritas"!), un assunzione di tipo «imperialistico» (Robert Nozick, "La natura della razionalità", Milano 1995):
- "[..] Il carattere della presente ricerca non permette l’interpretazione dettagliata delle varie forme di situazione emotiva e della connessione dei loro fondamenti. questi fenomeni sono noti onticamente da lungo tempo e furono studiati dalla filosofia sotto il nome di emozioni e di sentimenti [...] E’ merito dell’indagine fenomenologica aver posto su nuove basi l’esame di questi fenomeni. Non solo; Scheler, sotto l’influenza di Agostino e di Pascal°, ha orientato la problematica nel senso della determinazione del fondamento delle connessioni fra atti «rappresentativi» e atti «di interesse». anche qui, però restano sempre oscuri i fondamenti ontologico-esistenziali del fenomeno dell’atto in generale [...] °a. Cfr. Pensées [...] n’entre dans la vérité que par la charité [...]"; per questo cfr. Agostino, Opera (Migne, P. L., tomo VIII), Contra Faustum, lib. 32, cap. 18: "Non intratur in veritatem nisi per charitatem" (M. Heidegger, "Essere e tempo", 1927, pf. 29, Torino 1969, p. 231-232).
- "Amor qua appetitus", "Caritas e cupitas" (Cfr. H. Arendt, "il concetto di amore in Agostino" (1929 - "Le citazioni ... seguono l’edizione maurina").
- ROBERT NOZICK: LA MACCHINA DELL’ESPERIENZA(di Roberto Casati e Achille Varzi).
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. Dipartimento Lettere e Filosofia. Corso di Laurea in FILOSOFIA.
- Supervisore: Prof. Varzi Achille Carlo, Co-Supervisore: Prof. Ghia Francesco
- Tesi di Laurea
IL PRINCIPIO DI CARITÀ [2016]
Definizione e analisi critica tra ermeneutica e logica
a cura di Francesco Gandellini *
- La tesi si preoccupa di analizzare l’origine e il decorso storico del principio di carità o benevolenza, con particolare riferimento alla linea etico-ermeneutica e alla linea logico-ontologica, al fine di metterne in luce gli aspetti significativi che lo identificano e ne caratterizzano l’uso nella storia della filosofia. [...]
INTRODUZIONE
Il termine “carità” deriva etimologicamente dal latino caritas (acc. caritatem, «benevolenza», «amore», questo da carus, «caro», «costoso», «diletto», «amato»), e a sua volta dal greco χάρις, «grazia». Dal punto di vista dell’etimo, la parola cattura l’idea dell’amore disinteressato ma prezioso verso qualcuno, della benevolenza gratuitamente concessa al destinatario, senza riserve rispetto alla sua condizione.
 Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovvero careo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
Gli etimologisti latini derivavano il lemma carus dalla prima persona singolare del presente del verbo carēre, ovvero careo, «manco», «sono privo di», e ritenevano di giustificare il valore di una cosa sul metro della mancanza della cosa stessa, in modo tale che tanto più se ne avverte l’assenza, tanto più essa acquista valore e pregio.
 Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello», kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
Passando per il greco χάρις e dal verbo χαίρω, «rallegrarsi», «provare piacere», si arriva alla radice sanscrita ka = ca (sscr. ka, kan, kam), presente in parole quali kâma, «amore», kamana, «desiderabile», «bello», kamara, «amoroso», kam-e, «desiderò», «amò». Si possono, inoltre, trovare affinità nel lettone kahrs, «cupido», nel gotico hors, da cui il tedesco Hure, «meretrice», ma che si riallaccia al latino quaero, «cercare», «ricercare», «bramare» ciò che è desiderato. Il termine “carità” afferisce, dunque, anche alla sfera dell’amore desiderato, del richiesto perché bramosamente bello e capace di dare piacere e rallegrare.
 Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
Il principio di carità rappresenta un criterio prezioso, disinteressato ma richiesto nella logica del dialogo. Esso fornisce una norma fondante, sebbene implicita, per la costruzione di un confronto fecondo e esente da appropriazioni o strumentalizzazioni di qualunque sorta. Il valore apportato dal principio di carità consiste, forse banalmente, nel rendersi disponibile all’ascolto dell’altro e nell’attribuire pregnanza di senso alle sue parole, almeno fino a un evidente punto di non ritorno.
 La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano[...].
La scelta di trattare il principio di carità come argomento di tesi va incontro alla necessità di indagare l’implicito, il sottinteso, il banale che sovente viene trascurato e passato sotto silenzio, col rischio di dimenticarne la validità e l’utilità concreta e portante nell’ambito dell’umano[...].
 Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
Il principio di carità è una guida rimasta finora col capo coperto. Esso ha condotto e conduce gli uomini nei meandri tortuosi della comunicazione, del rapporto dialogante e dell’interpretazione reciproca. Può pregiudicare il buon andamento di una discussione, rimanendo nell’anonimato e nell’ombra. Determina e garantisce lo spazio minimo per l’intesa e l’accordo, ma può anche sancirne il definitivo naufragio.
 [...] La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
[...] La filosofia, nel suo decorso storico, si è raramente rivolta in modo esplicito al principio di carità. Fatta eccezione per Agostino, per il caso isolato dell’illuminista tedesco Georg Meier (che lo chiama principio di equità ermeneutica) e per la riflessione dei logici contemporanei (Wilson, Quine, Davidson), esso non viene pressoché mai menzionato o, almeno, non con questo appellativo con cui, soprattutto recentemente, è tornato alla ribalta.
 Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.
Si tratta, quindi, e questo è l’intento del lavoro, di rimarcarne gli aspetti costituivi, laddove il criterio sia stato suggerito dagli autori, oppure di ricercare ed enucleare possibili edizioni, implicitamente consegnate dai filosofi alla riflessione sul principio in questione. Per questo la tesi potrebbe soffrire di discontinuità più o meno consistenti, dettate appunto dall’esigenza di scandagliare le profondità del pensiero filosofico, anche mediante salti temporali e concettuali rilevanti, in quei punti ritenuti significativi per una trattazione ampia e pregnante, ma filtrata sempre nel setaccio della carità ermeneutica e logica.* Tesi di Laurea a cura di GANDELLINI Francesco
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
"PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". --- UN SONNAMBULISMO DI LUNGA DURATA. Note su "Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore".1 febbraio 2020, di Federico La Sala
L’AMORE ("CHARITAS") NON E’ LO ZIMBELLO NE’ DEL TEMPO NE’ DELLA FILOLOGIA. IL SONNAMBULISMO DI HANNAH ARENDT E MARTIN HEIDEGGER (e dell’intera storiografia filosofica, teologica, e filologica):
- "Amor qua appetitus", "Caritas e cupitas" (Cfr. H. Arendt, "il concetto di amore in Agostino" (1929 - "Le citazioni ... seguono l’edizione maurina");
- "[..] Scheler, sotto l’influenza di Agostino e di Pascal [...] a. Cfr. Pensées [...] n’entre dans la vérité que par la charité [...]"; per questo cfr. Agostino, Opera (Migne, P. L., tomo VIII), Contra Faustum, lib. 32, cap. 18: "Non intratur in veritatem nisi per charitatem" (M. Heidegger, "Essere e tempo", 1927, pf. 29, Torino 1969, p. 231-232).
Martin Heidegger e Hannah Arendt: la storia della fedeltà all’amore
A cura di bea *
Negli anni in cui Martin Heidegger andava elaborando "Essere e tempo" (1927) ebbe un’intensa avventura amorosa con una sua studentessa: Hannah Arendt aveva solo diciotto anni, ed era una giovane donna di un’ intelligenza vivace e profonda. Diventò a poco a poco una vera musa ispiratrice per il pensatore tedesco: tra i due, già dal 1925, ci furono intensi scambi epistolari, grazie ai quali è possibile non solo ricostruire il loro silenzioso amore, ma anche riflessioni più intime su temi profondi, quali il rapporto “verità-amore” e “fedeltà”.
Nel paragrafo 29 di “Essere e tempo”, l’opera più famosa di Martin Heidegger, troviamo due citazioni: la prima è di Pascal
- Donde viene che mentre parlando delle cose umane si dice che occorre conoscerle prima di amarle, ciò che è diventato proverbiale, i santi invece dicono, parlando delle cose divine, che occorre amarle per conoscerle, e che nella verità si penetra soltanto per mezzo della carità, del che hanno fatto una delle loro più utili sentenze...
La seconda, più incisiva, è di Agostino di Ippona
- Nella verità si penetra soltanto attraverso l’amore.
Anche se non sono citazioni dell’autore, queste prove bastano ad annullare quanto sostenne K. Jaspers, ovvero che la filosofia di Heidegger fosse “senza amore”.
Se da un lato possiamo capire la sua posizione, in quanto nell’opera i temi principali ruotano attorno all’essere, il Dasein, il tempo e la morte, dall’altra è fondamentale chiedersi il perchè di quelle due citazioni.
La spiegazione la troviamo nella vita reale del filosofo. Negli anni in cui andava elaborando Essere e tempo (1927) ebbe un’intensa avventura amorosa con una sua studentessa: Hannah Arendt aveva solo diciotto anni ed era una giovane donna di un’ intelligenza vivace e profonda.
Diventò a poco a poco una vera musa ispiratrice per il pensatore tedesco: tra i due, già dal 1925, ci furono intensi scambi epistolari, grazie ai quali è possibile non solo ricostruire il loro silenzioso amore, ma anche riflessioni più intime su temi profondi, quali il rapporto “verità-amore” e “fedeltà”.
Nelle ultime lezioni che Heidegger tenne a Marburgo nel semestre estivo del 1928 si fa riferimento alle due citazioni: egli riprende delle riflessioni che aveva scambiato con Max Scheler, per il quale amore e odio fondano la conoscenza, e sulla scia di una frase dell’Ordo Amoris “L’uomo, prima di essere un ente pensante o volente è un ente amante”, costruisce il motore immobile e invisibile che dà vita al suo Dasein, l’essere-nel-mondo.
Se Heidegger si appella ad Agostino e a Scheler, significa che l’amore è per lui un modo di apertura più originario di ogni conoscenza.
In riposta alla teoria delle passioni, la Arendt scrive nel 1953
- Niente più dell’amore ci introduce più inevitabilmente all’interno dell’universo vivente.
Essere-nell’amore significa fare in primis esperienza dell’esistenza più “propria” e poi scoprire, in due, che l’essere nell’esistenza significa anche volere l’esistenza dell’altro. Amo, come dice Agostino, significa volo ut sis, ti amo, voglio che tu sia ciò che sei.
- ...Come sei tutt’intera, e come rimarrai, così io ti amo
scriveva Heidegger alla sua studentessa.
Amare è anche lasciare libero l’altro, amare è cogliere il “tu” pur lasciandolo essere, senza cercare di possederlo: “... lasciar essere l’essere”
scrive il filosofo circa il concetto di libertà ne Lettere sull’umanismo.
Secondo la Arendt l’amore non consiste propriamente solo nei sentimenti verso l’ altro, ma prende una forma propria, che chiede qualcosa a entrambi gli amanti.
Se è fuori da ogni dubbio che Heidegger la amò, spingendola ad essere libera, resta tuttavia il fatto che rifiutò ostinatamente di cambiare per lei il corso della propria vita: non avrebbe mai lasciato il suo “punto fisso”, Elfride.
La concretizzazione del loro amore non avvenne mai. Avevano sì un mondo loro, ma era pur sempre circoscritto a qualche momento fuggitivo.
Hannah decise di chiudere la clandestina relazione, e lui, nonostante l’avesse ritenuta da sempre “molto più di una stella cadente”, non la trattenne, conservando però la speranza di riconquistarla.
In realtà tra i due ci fu sempre un collegamento, una sintonia che si riflette nelle numerose lettere che i due si spedirono anche dopo il primo matrimonio -poi fallito- della Arendt con G.Stern. Qualcosa cambiò nel 1933, quando Heidegger aderì al partito nazionalsocialista.
Nel frattempo la giovane Hannah si era trasferita a Parigi, dove sposò “il suo grande amore”, il filosofo tedesco H.Blucher, con il quale si imbarcò per gli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle i ricordi del tormentato amore con quella “volpe” di Heidegger. Come un vero Don Giovanni, egli passa di donna in donna alla ricerca della Donna, vale a dire una “verità della Donna”, rifacendosi alle teorie filosofiche di Proust e Sartre:
- L’amore non può ridursi al solo desiderio di possedere Una donna, ma anche esso tende, attraverso la donna, a impadronirsi del mondo intero.
Alla ricerca di questa verità, passa da graziose dottorande a giovani signore eleganti. Inoltre, si può notare che il suo Amore non si mostra affatto platonico, anzi l’amore si manifesta principalmente nell’effervescenza sessuale.
Non è dunque un caso che dedichi un libro su Platone alla sua “moglie-rifugio” Elfride, né che mandi alla Arendt alcuni versi dell’Antigone di Sofocle in cui il coro evoca il dio Eros.
Il 1950 è un anno di crisi per Hannah: se da una parte il secondo matrimonio sembra crollare a causa di un tradimento da parte del marito, dall’altra è un momento di riflessione feconda su un tema molto delicato, la fedeltà. Tra i due non c’erano più segreti, Blucher era al corrente delle lettere che mandava ancora al suo professore-amante, e addirittura la incoraggiava a riallacciare i rapporti.
- “Lascia che siano tutti gelosi di te, qui a casa ti aspetta il tuo nient’affatto geloso bombolo, che in compenso ti ama davvero a suo modo”
- “Sì amor mio, i nostri cuori hanno messo radici l’uno nell’altro ed i nostri passi vanno in armonia. E quest’armonia niente può turbarla, anche se la vita va avanti. Questi sciocchi credono che fedeltà ci sia quando la vita attiva cessa e s’inchioda a Una persona. Costoro si privano non solo della vita comune, ma della vita come tale...”
Ma è nel suo Diario intellettuale che la filosofa trae le conclusioni dei vari episodi della sua vita.
Rispondere all’infedeltà - come è abitualmente intesa - con la gelosia equivale quindi a una perversione della fedeltà. L’infedeltà più grave e terribile che possa esistere, il peccato più grande è per la Arendt l’oblio, poiché spegne la Verità, la verità che è stata.
È per questo motivo che, pur con tutto l’orrore provato per l’adesione di Heidegger al partito nazista, decise di restare sempre in contatto, mentale e non, con lui. Un’affinità elettiva non priva di tormenti e sofferenze, incomprensioni e oscurità.
Più che di perdono, bisognerebbe parlare di una volontà di non rinnegare ciò che era stato “l’evento dell’amore”.
* A cura di bea - 30 Luglio 2014
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- SANT’AGOSTINO, DOTTORE DELLA GRAZIA ("CHARIS"): "ECCO DA DOVE COMINCIA L’AMORE" ("ECCE UNDE INCIPIT CHARITAS").
- PER CARITÀ!!! Prof. Giovanni Reale, si svegli dal sonno dogmatico!!! L’amore evangelico è "charitas", non "caritas"!!!
- IL MONITO DI PASCAL A SERGIO GIVONE: NON CONFONDERE IL NOME DEL MIO DIO ("charité") CON IL NOME DEL DIO ("caritas") DEI VESCOVI E DI PAPA RATZINGER.
HEIDEGGER, KANT, E LA MISERIA DELLA FILOSOFIA - OGGI.
"LEZIONE SU KANT" A GERUSALEMME: PARLA EICHMANN "PILATO", IL SUDDITO DELL’"IMPERATORE-DIO". Il ’sonnambulismo’ di Hannah Arendt prima e di Emil Fackenheim dopo.
DANTE 2021: DANTE, ERNST R. CURTIUS E LA CRISI DELL’EUROPA. Note per una riflessione storiografica.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- Concepire un mondo nuovo: "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano" (di Luce Irigaray).29 gennaio 2020, di Federico La Sala
NASCERE. Costruire una cultura adatta alla nostra incarnazione...
- Concepire un mondo nuovo (di Luce Irigaray)*
Non vi è alcun dubbio che una certa epoca della nostra cultura sia al termine: quella della metafisica, che alla fine si è incarnata in un’era tecnica e scientifica che da allora in poi è la nostra. In effetti, o l’umanità e il mondo in cui dimora sono destinati a scomparire, o noi troviamo il modo di tornare o ritornare a ciò che significa essere umano per riflettere a fondo su di esso, in quanto primo agente del nostro destino, e sulla possibilità di giungere a una parola di cui la tecnica e le tecnologie non possono privarci, riducendoci a una sorta di meccanismo meno performante di quelli che siamo in grado di fabbricare.
È in noi stessi, in quanto esseri umani incarnati, che possiamo trovare un modo di pensare come sfuggire al dominio della tecnica e delle tecnologie senza sottovalutarne i vantaggi. Invitandoci a liberarci dalla soggezione a ideali sovrasensibili, Nietzsche ci indica, almeno in parte, verso quale direzione volgerci. Ma il suo insegnamento è innanzitutto critico, ed è quello che ha ispirato la decostruzione della metafisica occidentale portata avanti, dopo di lui, da Heidegger e dai suoi seguaci. Se Nietzsche ha intuito giustamente che dobbiamo ricominciare da zero, iniziando in particolare dalla nostra appartenenza fisica per passare dal vecchio uomo occidentale a una nuova umanità, egli non ha avuto il tempo di aprire il cammino o di costruire il ponte per raggiungere questo obiettivo. Temo che anche la «volontà di potenza» e l’«eterno ritorno», in un modo o nell’altro, rimangano nell’orizzonte della nostra logica passata. Agiscono come strumenti della sua interpretazione, ma forniscono una prospettiva che ci consente di liberarci da essa. Tuttavia, le «intuizioni ispirate» di Nietzsche, come le chiama Heidegger, non ci forniscono la struttura di cui abbiamo bisogno per costruire una cultura adatta alla nostra incarnazione.
Questa struttura - Heidegger talvolta la chiama «ispezione» -, che rende possibile l’avvento di una nuova epoca della verità e della cultura, d’ora in poi deve risiedere nel nostro corpo, dal momento che è una struttura adatta a esso, tramite la quale può dirsi di nuovo fin quando il mondo e tutti gli elementi che vi prendono parte sono coinvolti. Questo tipo di struttura esiste e si esprime già, anche in modo inconscio, nella nostra concezione passata del reale e del linguaggio che ne parla - corrisponde alla sessuazione della nostra identità. In quello che è stato chiamato «essere umano» è rimasto ignorato un aspetto che ne determina la natura e che contribuisce a sottrarlo a una neutralità disincarnata che non gli permette di manifestarsi così com’è, e che riemerge, sebbene la presunta verità del mondo e delle cose non gli corrisponda.
Il rischio rappresentato dalla neutralizzazione degli umani in quanto esseri viventi adesso sta diventando evidente a causa della trasformazione in robot di diversi elementi del mondo, tramite l’organizzazione prodotta dalla mente umana a partire dal potenziale di meccanismi, di cui, però, è diventata schiava, esiliata dalla sua appartenenza vivente. Qualunque sia il loro potenziale performativo, gli esseri umani eccedono già quello della macchina a diversi livelli. La loro salvezza può venire soltanto dalla percezione del rischio e dalla maniera di superarlo, attribuendogli significato, e tramite un ritorno al proprio essere come specifici esseri viventi. Per superare una concezione del mondo dominata da un modo di pensare e di agire tecnico, dobbiamo trovare un’altra configurazione o struttura grazie alla quale gli esseri umani possano sfuggire a tale dominio riconoscendo e interpretando la natura del suo potere. Dobbiamo liberarci dal predominio tecnico e scientifico sulla nostra epoca e garantire la salvaguardia del significato tramite una nuova incarnazione dell’essere.
*Luce Irigaray, "Nascere. Genesi di un nuovo essere umano", TecaLibri.
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- IL LATO GROTTESCO DELLA PSICOANALISI (di Massimo Recalcati)10 gennaio 2020, di Federico La Sala
IL LATO GROTTESCO DELLA PSICOANALISI
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 08/01/2020)
Nei giorni scorsi ricorreva il trentennale della morte di Elvio Fachinelli, psicoanalista e intellettuale tra i più significativi in Italia negli anni Settanta-Ottanta, avvenuta a Milano il 21 dicembre del 1989. A commemorarne la scomparsa è appena stata pubblicata per i tipi di ITALO SVEVO e alla cura dedita e filologicamente attenta di Dario Borso, rigoroso studioso di Hegel e Kierkegaard, parte dei diari che Fachinelli ha tenuto con regolarità dai primi anni Sessanta sino ai suoi ultimi giorni con il titolo: Grottesche. Notizie, racconti, apparizioni. Si tratta di una serie di aforismi di natura psicosociale che scandagliano un tema centrale di tutta la sua ricerca: la difficoltà dell’essere umano di abitare generativamente la contingenza illimitata dell’esistenza, di stare nell’aperto della vita, di affidarsi alla pulsazione estatica dell’inconscio.
Erede della lezione freudiana, per Fachinelli la psicologia individuale è già da sempre psicologia sociale; lo sguardo dell’analista attraversa obliquamente - secondo un movimento più topologico che topico - le vicissitudini della vita individuale e della vita collettiva. Il suo metodo è laico nel senso anch’esso freudiano del termine: ignora le verità assolute, incontrovertibili; sottopone al vaglio ininterrotto del pensiero critico i suoi oggetti.
Ma cosa indica la categoria del grottesco? Grottesca appare innanzitutto la vita che rinuncia alla sua fondamentale apertura, che si separa dalla trascendenza interna dell’inconscio per chiudersi nell’adattamento conformistico al principio di realtà. Questa vita si difende grottescamente dalla vita stessa. Essa preferisce il chiuso all’aperto, l’adattamento alla creazione, l’irrigidimento del confine alla "brezza marina". È la tendenza della psicoanalisi ortodossa che nella sua istituzionalizzazione ha finito per tradire la sua stessa invenzione, quella dell’inconscio come apertura illimitata, luogo "femminile" di una "gioia eccessiva".
La prima faccia del grottesco risulta dal rigetto fobico di questa apertura e dallo schiacciamento - "iperrealistico" lo definisce Borso nella sua introduzione della vita che si riduce a quella di un automa senza desideri preda di una ripetizione sterile. È la vita del paziente nevrotico ossessivo protagonista della parte iniziale de La freccia ferma per il quale «il tempo è segmentato in una serie di tempuscoli, ognuno dei quali è chiuso e delimitato in sé». Ne abbiamo una descrizione efficace: «solo e sicuro nella sua auto come un mollusco nella sua valva. Si mette le dita nel naso, scorreggia, prega, eccetera». È questo il primo volto del grottesco; la vita che smarrisce la sua trascendenza per compattarsi con l’esistente. Declinazione quotidiana della pulsione securitaria: meglio il chiuso, l’ottundimento identitario, dell’estasi che spalanca pericolosamente la vita verso l’infinito come piega interna e ingovernabile del finito.
Esiste però un secondo volto del grottesco; esso si palesa quando l’Ideale vorrebbe esercitare un dominio assoluto sull’esistenza singolare. Grottesca appare allora la rimozione della vita individuale nel nome del carattere universale dell’Idea. È un punto di chiave di tutto il pensiero di Fachinelli. La psicoanalisi ha elevato l’infimo, il dettaglio, il particolare ad una dignità sconfessata dalla ragione filosofica e politica classica. Viceversa il dominio dell’Idea è una malattia endemica del fanatismo rivoluzionario e del tono fondamentalistico e settaristico della sua predicazione. Fachinelli, intellettuale di sinistra, la squaderna con ironia amara davanti ai nostri occhi: «è paradossale - scrive - il destino di molti rivoluzionari. Lavorano sul serio a una cosa che, per essere fatta, per diventare realmente popolare, implica l’entusiasmo, il senso di avventura, la novità - e sono spietati nell’ucciderla».
Si tratta di un fantasma rigoristico, sacrificale ed eroico insieme: «attesa della palingenesi, mito della purezza e della violenza». La distinzione è severa e rigida; da una parte il bene dall’altra il male, da una parte i puri dall’altra gli impuri. È l’”ossatura paranoica" di ogni ideologia che esclude la laicità del pensiero. È la tentazione di tutti coloro che, identificandosi ad una Causa che annichilisce il particolare, vorrebbero farsi maestri e padroni della Causa stessa. Ma questo inno esaltato dell’Ideale non può evitare il continuo inciampo nel particolare che crede di rimuovere. L’oratore di estrema sinistra che arringa il suo popolo ad agire nel nome dell’Ideale di purezza, osserva Fachinelli, «cade in continui lapsus di date e di nomi»; un noto scrittore di estrema sinistra non riesce a dormire perché pensa continuamente ai soldi; «la sinistra ha sostituito il sorriso con il ghigno».
Il grottesco sarebbe suscitato dal ritorno del rimosso del particolare nelle maglie anonime della predicazione purista dell’universale. Ma tutte le critiche che lo spirito laico di Fachinelli muove al settarismo della sinistra sono le stesse che rivolge alla psicoanalisi ortodossa. La malattia è comune; il senso del grottesco anche. Fantasma di purezza, attitudine paranoica a concepire la differenza come deformità minacciosa, sclerotizzazione del linguaggio in codici morti, lontananza siderale dall’esperienza dell’apertura illimitata della vita: «trionfo dell’esegesi psicoanalitica; malore della psicoanalisi».
-
> "PERVERSIONI" ---L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE (DI EDIPO) REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO: "PSICOANALISI E FEMMINISMO" (di Luisa Muraro e Lucetta Scaraffia).3 dicembre 2019, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA": L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO...
Psicoanalisi e femminismodi Luisa Muraro e Lucetta Scaraffia *
Su Sette Corriere della sera del 22 novembre 2019 è apparso un articolo di Lucetta Scaraffia, Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi, chiarissimo in quello che dice. Potete leggerlo qui di seguito. È un testo di notevole interesse perché attira l’attenzione e fa luce sulla parte avuta dalla psicoanalisi nella rivoluzione femminista del ventesimo secolo. L’autrice finisce con un punto di domanda, giustamente, e invita così ad approfondire l’argomento.
Per parte mia ci tengo a dire che la “sconfitta” della psicoanalisi avviene su un antico campo di battaglia, quello dell’autorità della parola, autorità negata alle donne dal regime patriarcale, e campo di battaglia dalle donne tenacemente tenuto aperto attraverso i secoli. Parlo dell’isteria. Dedicandosi alla cura dell’isteria, Freud ha avuto il merito innegabile di essere entrato nel campo di battaglia e di sbagliare, sì, ma in un modo significativo: è il suo inconscio che lo fa sbagliare e lui finisce che se ne accorge. Se possiamo fare festa per la fine del discredito patriarcale e l’affermarsi di autorità femminile nella vita pubblica, qualcosa dobbiamo anche a lui. A sua volta, lui deve qualcosa, o molto, all’umanità femminile. (Luisa Muraro)
Corriere della sera - Sette, 22 novembre 2019
Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi
di Lucetta Scaraffia *
Quando Ida ha acconsentito alla richiesta del padre, che voleva far curare da Freud i suoi strani disturbi (afonia, svenimenti, tosse continua), la ragazza sperava che il dottore avrebbe creduto alle sue parole, convincendo così anche suo padre che l’amico di famiglia Hanss Zellenka l’aveva molestata con insistenza e pesantemente, per mesi, suscitandole profondo turbamento e paura. Le molestie erano cominciate quando aveva solo tredici anni, e lei si era trovata invischiata in una situazione angosciosa: le vacanze con la famiglia Zellenka sul lago di Garda - dove la madre Pepina l’aveva accolta con un affetto e una simpatia che le mancavano in casa - nascondevano un segreto imbarazzante.
Pepina era in realtà l’amante del padre di Ida, un ricco industriale, che si era portato in vacanza la figlia per mascherare la relazione. E proprio mentre la ragazza cominciava ad accorgersene, diveniva oggetto di corteggiamenti e molestie da parte di Hanss, il marito di Pepina. È questa situazione difficile all’origine dei suoi disturbi di salute ma, come quasi tutte le giovani donne in casi analoghi, Ida ha paura di parlarne e si sente confusamente colpevole, finché un episodio più grave non la induce a raccontare tutto alla madre. Il padre, prontamente informato, convoca Hanss, il quale non solo nega indignato ma ritorce su Ida le accuse, consigliando di mandarla in cura da Freud.
Ferita dall’incomprensione paterna, Ida lo sarà ancor più dolorosamente da Freud che, dopo averla spinta a parlare, comprensivo - finalmente qualcuno la prendeva sul serio! - le aveva spiegato la sua complicata interpretazione dell’episodio. Secondo Freud le parole della ragazza rivelavano un suo amore edipico verso il padre, spostato poi su Hanss, e di conseguenza «lei non aveva affatto paura del signor Zellenka ma piuttosto di se stessa, e più precisamente della tentazione di cedere al signor Zellenka».
Ida reagisce a questa nuova cocente delusione interrompendo la cura con Freud, e proseguendo, sia pure con fatica, nella sua vita di donna che si sarebbe sposata, avrebbe avuto un figlio, avrebbe lavoratoe sarebbe scampata alla persecuzione nazista fuggendo prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, dal figlio. Una vita dura e drammatica, che racconta alla nipote, autrice della bella biografia a lei dedicata. La vita di una donna che dal rifiuto dell’interpretazione di Freud ha tratto forza e coraggio. Una posizione totalmente diversa da quella che lo stesso Freud rivela concludendo la narrazione dell’analisi: «Promisi comunque di perdonarla per avermi privato della soddisfazione di guarirla radicalmente». E se invece Ida si fosse guarita da sola rifiutando l’interpretazione di chi non considerava vere le sue parole?
Ida è Dora, la protagonista del primo caso clinico di Freud, che su questo ha costruito la sua ipotesi sulle cause dell’isteria, considerando il caso come prova chiara e convincente della sua teoria del complesso di Edipo.
Agli occhi di una donna di oggi, invece, la vicenda di Ida appare solo come la drammatica storia di una ragazza molestata che non viene creduta dagli uomini ai quali si rivolge per avere aiuto. Il padre, probabilmente anche perché segnato da sensi di colpa nei confronti di Hanss, crede a questi piuttosto che alla figlia, mentre Freud dà credito al padre, e si lascia influenzare dal desiderio di trovare nei desideri edipici rimossi la causa dell’isteria. Le malattie di Ida, invece, rivelano piuttosto la sofferenza di una donna le cui parole non vengono ascoltate né rispettate. Una donna che non viene presa sul serio, proprio come tante altre sue contemporanee - ma anche molte più vicine a noi - che non hanno visto riconosciuto il valore delle loro parole.
La biografia di Ida (scritta dalla pronipote Katharina Adler, Ida, Sellerio 2019) rovescia la storia raccontata da Freud: non si tratta della prima paziente alla quale è stata diagnosticata e curata l’isteria, ma una delle tante - troppe - donne che hanno subito due forme di violenza, quella sessuale e quella contro la loro identità perché le loro parole non vengono credute. È la storia narrata dal punto di vista delle donne, che vedono le cose molto diversamente dagli uomini, ma non sono ascoltate.
C’è voluta una lunga battaglia, combattuta dalle donne, perché le parole delle vittime venissero ascoltate e prese seriamente in considerazione, perché le vittime stesse non fossero sempre considerate possibili complici della violenza - Ida aveva forse provocato, magari anche inconsapevolmente, come insinua Freud, il violento? - e venissero invece aiutate a superare il trauma, e risarcite.
Nell’ordinamento giuridico italiano gli articoli del codice Rocco, vigenti fino al 1996, punivano ogni tipo di violenza o molestia sessuale - sia sulle donne che sui minori - come «delitto contro la morale pubblica e il buoncostume». Tutelavano cioè quello che veniva considerato un bene collettivo e non la vittima. È stato solo nel 1996, grazie alle pressioni del movimento femminista, che viene promulgata la nuova legge per cui lo stupro diventa reato contro la persona, e di conseguenza l’attività sessuale riconosciuta come frutto di una libera scelta perché rientra nel diritto proprio dell’individuo.
Mentre nella fase precedente si collocava al primo posto la condizione di vita della comunità, che per il legislatore costituiva il massimo valore, oggi a essere valorizzata è invece la dimensione individuale di chi subisce il reato, divenuta il bene giuridico protetto dalla legge. Rivendicando la loro posizione di vittime della violenza, le donne capovolgono la situazione di debolezza in cui si trovavano, s’impadroniscono del potere di accusa, le loro parole si caricano di valore, e hanno finalmente diritto di essere ascoltate.
Oggi Ida troverebbe ascolto, Hanss verrebbe punito per molestie su una minore, e Freud non avrebbe più la possibilità di elaborare la sua teoria sull’isteria. Un caso in cui la psicanalisi, elemento fondamentale della nostra modernità, viene forse sconfitta dalla realtà che sta nelle parole delle donne?
(www.libreriadelledonne.it, 29 novembre 2019)
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". La crisi epocale dell’ordine simbolico di "mammasantissima" ("patriarcato": alleanza Madre-Figlio).
DONNE, UOMINI, E DISORDINE SIMBOLICO
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Federico La Sala
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- "IL CLOWN SENZA PADRE", L’ESISTENZA DEL COMPLESSO EDIPICO COMPLETO, E L’INDICAZIONE DI ELVIO FACHINELLI21 novembre 2019, di Federico La Sala
IL CLOWN SENZA PADRE
di Sergio Benvenuto (Le parole e le cose, 19 Novembre 2019)
- [Intervento tenuto al convegno Il padre oggi, 26-27 ottobre 2019, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma. Il convegno è stato organizzato dall’IPRS (Istituto Psicoanalitico per la Ricerca Sociale) e dall’IREP].
1.
Il film Joker di Todd Phillips, che circola attualmente in Italia, è tratto dai fumetti di Batman, ma in realtà è ispirato sia al romanzo di Victor Hugo L’uomo che ride, sia al film V for Vendetta di James McTeigue.
Il protagonista di Joker, Arthur, è un giovane comico fallito, con ricoveri psichiatrici nel suo pedigree, che si adatta a fare il clown di strada. Questo quasi-psicotico vive da sempre con la madre stramba, non ha mai conosciuto suo padre. A un certo punto Arthur si convince, credendo a rivelazioni della madre, di essere il figlio di un grande magnate, Thomas Wayne (questo è il nome del padre di Bruce Wayne, alias Batman, nei famosi fumetti; un padre assassinato). Wayne si candida a sindaco di Gotham, alias fumettistica di New York. La madre sostiene di essere stata l’amante di Wayne da giovane e di aver avuto da lui Arthur, figlio che il padre non ha riconosciuto. Ma secondo un’altra versione, Arthur sarebbe stato adottato dalla madre, che da piccolo avrebbe abusato di lui, fino a finire lei in manicomio. Non sapremo mai, fino alla fine del film, se Wayne è davvero il padre di Arthur o no. Arthur è marcato come figlio di NN.
Arthur, una sera, spara a tre yuppies che lo aggrediscono in metropolitana e li uccide. Si diffonde la voce in tutta l’America che uno mascherato da clown è l’assassino dei tre brokers. Ben presto questo clown giustiziere diventa un eroe per la massa dei diseredati di Gotham, che protestano contro il potere indossando tutti una maschera da clown che ride. È interessante che tutti i mascherati da clowns siano uomini. L’intera città è messa a ferro e fuoco da migliaia di clowns. Arthur, che nel frattempo ha ucciso la madre e varie altre persone, viene riconosciuto come l’assassino dei tre yuppies e glorificato dai clown ribelli. Nel frattempo un uomo, anch’egli mascherato da clown, uccide Wayne. Non dico il finale.
- [Foto] Arthur the Joker
Mi sono soffermato su questo film perché mi pare che esso esprima a suo modo il passaggio dal padre edipico freudiano a quello che chiamerei il nuovo Edipo, dove alla figura del padre si sostituisce una nuova figura pervasiva: quella del “potere”. O, come si dice in America, “the system”. Paolo Sorrentino, in un film recente, lo ha chiamato Loro. Chi sono Loro? Loro sono tutti coloro che hanno potere: i politici soprattutto, i ricchi, i grandi imprenditori, le star... Forse, col tempo, anche noi psicoanalisti... Tutti coloro che ormai vengono chiamati winners, di fronte ai quali soffre e si rode la massa dei losers.
2.
La figura del clown malinconico ha una storia secolare. I fools di Shakespeare hanno il compito di far ridere il re, ma di fatto seguono il re nella sua rovina. Dicono al re delle verità inascoltate perché amare. Il fool denuncia la follia dei re.
Gwynplaine è il protagonista di L’uomo che ride di Hugo, pubblicato nel 1869. Gwynplaine è stato rapito da piccolo in Inghilterra da furfanti i quali gli hanno fatto subire un’operazione al volto grazie a cui egli ha l’aria di ridere sempre. Viene adottato da un vagabondo che mette in scena poi uno spettacolo comico ambulante centrato sul ruolo ridanciano di Gwynplaine. Quindi l’agnizione: si scopre a un certo punto che il saltimbanco è in realtà il figlio di un lord d’Inghilterra. Il lord di Hugo corrisponde al magnate Wayne di Joker. Gwynplaine, riconosciuto nobile, farà un discorso alla Camera dei Lord in cui attaccherà i loro privilegi, ma farà solo ridere....
La differenza importante tra il romanzo di Hugo e il film del 2019 è che in Hugo si scopre che Gwynplaine è veramente figlio di un lord, mentre in Joker si ha l’impressione che il padre tycoon sia un delirio della madre. Inoltre, in Joker si compie un parricidio che non accade nel romanzo di Hugo, anche se esso viene compiuto da un misterioso killer mascherato da clown. La rivolta dei diseredati con le maschere da pagliacci in Joker ricorda molto la rivolta cieca, senza fine e senza fini, dei gilets gialli francesi.
Una variante su questo tema è il film V for Vendetta del 2006. In un futuro distopico, un misterioso radicale anarchico, abbigliato come Guy Fawkes e con una maschera fissa in un riso costante, solleva i britannici contro un regime fascista oppressivo. Guy Fawkes fu l’artefice della fallita Congiura delle polveri del 1606, un evento rimasto memorabile nella tradizione popolare inglese: il complotto mirava a far esplodere il re James 1° d’Inghilterra e i membri del Parlamento, insomma tutto il sistema politico inglese. Tuttora il 5 novembre in Inghilterra si brucia l’effigie di Guy Fawkes. Evidentemente negli ultimi anni questa figura di iperbolico regicida si è ribaltata in un personaggio positivo - insomma, oggi si è dalla parte del “figlio parricida”. La maschera e il logo ‘V per Vendetta’ sono stati adottati da vari movimenti populisti, anche dal nostro Movimento 5 Stelle, guidato da un joker appunto, Beppe Grillo.
- [Foto] Maschera di Guy Fawkes
3.
In vario modo, tutte queste opere girano attorno al tema del parricidio, o all’uccisione di una figura potente. Il parricidio, la grande ossessione di Freud. Quasi ognuno di noi ha un’ossessione spirituale; quella di Freud era il parricidio. Esso è il senso ultimo dell’Edipo.
Freud stimava come massimi capolavori della letteratura occidentale tre opere: l’Edipo re di Sofocle, l’Amleto, e I Fratelli Karamazov di Dostojevskij. Li preferiva perché tutti e tre hanno a che fare con l’omicidio del padre, e inoltre il parricidio, diretto o indiretto, è legato alla rivalità tra padre e figlio per il possesso di una donna. Parricida è sempre il figlio maschio, perciò Freud ha parlato di Edipo e non di Edipo-Elettra, per esempio, come qualcuno ha proposto. Ovvero, anche la donna è “edipica”. Cosa che non è piaciuta a tante femministe. Ora, Freud fa del parricidio non solo la fantasia fondamentale di ogni soggetto, ma anche l’atto inaugurale della Kultur, della civiltà, ovvero della vita sociale, che per lui segna l’inizio anche della psiche individuale. La psiche, l’inconscio, per Freud è frutto di un evento storico, e questo evento è il parricidio. Non potendolo dimostrare, Freud ha fatto ricorso a ricostruzioni apertamente mitiche, che oggi non possono mancare di farci sorridere - molta acqua è passata sotto i ponti dei nostri metodi storiografici.
In Totem e tabù ha immaginato l’assassinio del padre dell’orda primordiale da parte dei suoi figli maschi coalizzati, allo scopo di dividersi equamente tra loro le donne dell’orda, che prima il padre-padrone accaparrava tutte per sé. In Mosè e il monoteismo, il testamento visionario di Freud, vuole persuaderci che Mosè, il quale non sarebbe stato ebreo ma egiziano, è stato ucciso dagli ebrei stessi, che non volevano sottomettersi alle regole severe del monoteismo imposto da Mosè. In questo caso il parricidio, o regicidio potremmo dire, non è motivato da una rivalità per la conquista delle donne, ma da un rifiuto che oggi chiamiamo “populista” del potere monoteistico. Dietro la religione ebraica, Freud vede una sorta di Guy Fawkes giudeo che ride alle spalle di Mosè.
Si è detto tante volte che questa centralità del padre, e quindi del parricidio, nella visione di Freud non è oggi più attuale, perché rifletteva una società ancora patriarcale, la quale in questo ultimo secolo si è in gran parte dissolta. In realtà, come abbiamo detto, per Freud il padre è figura centrale dell’inconscio per un vero e proprio peccato originale, un crimine inaugurale a cui è legata tutta la nostra storia, e che è appunto il parricidio. Ovvero, lungi dal prendere sul serio il primato della società patriarcale, Freud ne drammatizza il declino e la scomparsa. La sua ossessione teorica del parricidio fa eco al tema di Nietzsche della morte di Dio. Nietzsche pensava che Dio, ucciso dagli umani, sia un evento storico, come per Freud è un evento storico la messa a morte del padre. La differenza è che mentre l’uccisione di Dio per Nietzsche è un evento moderno che apre la modernità, l’uccisione del padre per Freud è un evento arcaico, è l’atto primordiale che apre a un tempo la vita sociale e l’inconscio individuale. Prima di questo evento per Freud non c’è psiche individuale, ma solo collettiva.
Come ha poi detto esplicitamente Lacan, il padre di cui si occupa la psicoanalisi è sempre il padre morto - anche se il padre reale è vivo e vegeto. Non è la morte di nostro padre ma la morte del Padre, ovvero della funzione strutturante simbolica della paternità. In altri termini, il nostro avversario non ha più una qualifica fallica, non è più il nostro generatore, ma è un altro collettivo, chiamato, come in Sorrentino, Loro - il Sistema, “i poteri forti” come si dice oggi. È come se la psiche umana si fosse ri-collettivizzata: morto il padre individuale, ci schiaccia il Padre simbolico, che in qualche modo ci castra tutti come popolo impotente. Insomma, non è più il padre di famiglia a spiegare un certo odio per il potere politico, è l’odio per il potere politico a riflettersi, talvolta, nell’odio per il padre familiare.
4.
Perché, da Shakespeare fino a Joker, il poveraccio, il subalterno, il perdente, assume spesso le forme comiche del saltimbanco, del buffone, come Rigoletto o come il Canio pagliaccio di Leoncavallo? Da dove deriva questa antinomica sovrapposizione tra il buffo e il tragico? Ricordiamo che nelle tragedie antiche i personaggi umili, la gente del popolo, erano per lo più figure comiche, ridicole, mentre figure tragiche erano re e regine. Il clown, il pagliaccio, è la figura stessa del figlio - non della figlia. Credo che le clown donne siano rare. I clown sono i figli maschi castrati, direbbe Freud, come allegoricamente è castrato il Gwynplaine di Hugo. Il subalterno ride, ma la sua risata è congelata, assume la fissità di un ghigno perturbante. Le masse, si sa, vogliono ridere, ridere sempre, e per questo non fanno affatto ridere, e sono spregiate. Ma il clown è il figlio matto, fool appunto, matto perché senza padre. Se mi si concede un’intemperanza allegorica, possiamo vedere la fiumana irosa dei clown in Joker come una massa senza padre. La strana teoria lacaniana della psicosi come forclusion, pignoramento, del Nome-del-Padre, mi sembra derivare proprio da questa figura secolare e metafisica del giullare senza padre e senza patria, quindi pazzo, che ride del potere proprio perché ne è dominato. L’eterna pasquinata dei deboli.
Oggi si parla sempre di populismo. In particolare di populismo di destra, che esalta contro la globalizzazione, contro il cosmopolitismo, il narcisismo patriottico e vernacolare della propria Heimat. Il populismo, si dice, è ringhioso, è la rabbia dei marginali contro le élites prestigiose, politici e scienziati, finanzieri sinistre e intellettuali. La funzione paterna è oggi socializzata, dicevamo, e assume le forme persecutorie di un potere che pare manipolarci. Tramontato l’Edipo familiare, imperversa un Edipo politico.
La figura del padre e della sua morte in Freud è certamente una costruzione mitica. Ma i miti sono sintomi, sono un modo di mi-dire, mezzo-dire, la verità. La verità è che, col declino della cultura patriarcale, il padre tiranno oggi non è più tanto incontrato in casa, ma nella proiezione iperbolica di un assetto sociale. Il padre edipico si è disimpastato da quel poveraccio che, di fatto, è ogni padre - i miei pazienti oggi considerano istanze super-egoiche più le madri che i padri. Il padre da uccidere è l’Altro imperscrutabile del potere, il caleidoscopio diffratto delle innumerevoli figure del dominio.
Quest’anno gli ucraini hanno eletto presidente del loro paese, con una valanga di voti, Volodymyr Zelenskij, un attore comico, di fatto un clown, senza alcuna esperienza politica. Era chiamato nel suo paese joker. Il film Joker, girato prima di questa elezione, mostra che, come diceva Wilde, la vita imita l’arte. Del resto, attualmente anche noi in Italia siamo governati da una forza ideata da un attore comico. E dopo tutto, non sembra imitazione di un clown lo stesso Boris Johnson, premier britannico? In Ucraina, in Gran Bretagna e in Italia vengono innalzati dai figli perdenti, irrilevanti, castrati, dei clown, contro la serietà accigliata di Loro. È giunta l’ora del rovesciamento, quella del potere dei buffoni. Ma il figlio-che-ride rischia di diventare, a sua volta, il nuovo despota, un despota che gli stessi figli hanno eletto.
Nota:
L’ESISTENZA DEL COMPLESSO EDIPICO COMPLETO (S. FREUD, "L’IO E L’ES "), L’INDICAZIONE DI ELVIO FACHINELLI *, E "IL CLOWN SENZA PADRE" ....
"TODO MODO": A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!! "La princeps einaudiana è del 1974 e, per comprendere a pieno l’ironica e durissima denuncia civile di questo breve romanzo di Sciascia, bisognerebbe intavolare una seduta spiritica ed evocare la mai defunta processione politico-economica dei primi anni Settanta in Italia. Razza padrona di Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani esce lo stesso anno per Feltrinelli ... Il romanzo giunge così al delitto-contrappasso, al quale ne seguono altri, ma il dispositivo spaziale, o il quadrilatero semiotico, è già dato: la Chiesa (don Gaetano), lo Stato (il procuratore Scalambri), la Corruzione (l’onorevole Michelozzi), la Pena (l’assassino). [...] Il "todo modo" del titolo dice appunto questo, un “con ogni mezzo” che getta un ponte aberrante e tuttavia reale tra gli Esercizi spirituali di Loyola e il Principe di Machiavelli (Matteo Meschiari, "Todo modo", Doppiozero, 21 ttobre 2019).
* Si cfr.: "CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI"; e, ancora, "GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- AMORE E RESPONSABILITA’. Percorso formativo dell’Azione cattolica. La sessualità spiegata ai ragazzi (di Luciano Moia).15 novembre 2019, di Federico La Sala
AMORE E RESPONSABILITA’. UN CORAGGIOSO PASSO ..... *
Il percorso.
«Perché o casti o superficiali?». La sessualità spiegata ai ragazzi
Da oggi a domenica percorso formativo dell’Azione Cattolica. Teologi, biblisti, psicologi, sessuologi e formatori a confronto su affettività e dintorni con duecento giovani
di Luciano Moia (Avvenire, venerdì 15 novembre 2019)
- L’Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa per numero di matrimoni (3,2 ogni mille abitanti). In testa (dati Eurostat) Lituania (7,5) e Romania (7,3)
Educare all’affettività e alla sessualità al tempo del web. Compito tanto difficoltoso quanto inutile, sostiene chi pensa che tanto, in rete, i ragazzi dispongano di ogni tipo di informazione possibile. No, replica chi invece è convinto che senza lo sforzo di trovare un senso profondo a quegli "oggetti" meravigliosi ma non sempre facili da maneggiare che sono cuore e corpo, sia impossibile arrivare a un rapporto sereno con sé stessi e con gli altri. E che, dalla qualità delle relazioni affettive, discenda anche uno sguardo più maturo sulla fede, se è vero che il trascendente non è mai disincarnato ma sempre strettamente connesso alle nostre esperienze, soprattutto quelle più coinvolgenti e più intime. Ecco perché, quando si parla di educazione all’affettività e alla sessualità la Chiesa non può dire "non mi riguarda".
 Del resto lo spiegano in modo esplicito sia il Documento finale del Sinodo sui giovani, sia la Christus vivit che sottolinea l’importanza di «educare la propria sessualità, in modo che sia sempre meno uno strumento per usare gli altri e sempre più una capacità di donarsi pienamente a una persona in modo esclusivo e generoso» (Ch.v265).
Del resto lo spiegano in modo esplicito sia il Documento finale del Sinodo sui giovani, sia la Christus vivit che sottolinea l’importanza di «educare la propria sessualità, in modo che sia sempre meno uno strumento per usare gli altri e sempre più una capacità di donarsi pienamente a una persona in modo esclusivo e generoso» (Ch.v265).Per dare seguito a queste sollecitazioni, circa 200 giovani formatori di Azione Cattolica si ritrovano da oggi a domenica a Morlupo, alle porte di Roma, nella Casa dei padri rogazionisti, per un confronto con un gruppo di esperti. "A cuore scalzo" non è un convegno formale, ma un dialogo diretto. A ciascuno degli specialisti sono state inviate alcune domande. E avranno un solo un quarto d’ora ciascuno per rispondere. «Anche per noi è stata una sfida e l’occasione di un ripasso tutt’altro che semplice», scherzano ma non troppo la psicologa Roberta Carta e il marito Diego Buratta, responsabile della cooperativa "Pepita" che si occupa di servizi educativi.
Perché, quando tra le domande dei giovani ci sono temi come la difficoltà di trasmettere la visione cristiana della sessualità oppure le ragioni che devono motivare la necessità di non "bruciare i tempi" per avere il primo rapporto, anche i terapeuti più navigati sono chiamati a misurare le parole con attenzione. «Dobbiamo accompagnarli a vivere una sessualità che non sia solo il richiamo a una regola astratta. Conoscere sé stessi, dare senso alle proprie decisioni, aprirsi a relazioni serene ed equilibrate è più importante di un generico richiamo alla morale, anche perché rischiamo di rifugiarci in un linguaggio normativo che i giovani non comprendono più», osserva Roberta Carta.
LE DOMANDE
 1 Castità e poi?
1 Castità e poi?
 Perché noi giovani credenti siamo costretti a scegliere tra l’essere casti o l’essere superficiali?
Perché noi giovani credenti siamo costretti a scegliere tra l’essere casti o l’essere superficiali?
 2 Perché aspettare?
2 Perché aspettare?
 Per avere un rapporto matrimoniale è necessario dover aspettare e perché?
Per avere un rapporto matrimoniale è necessario dover aspettare e perché?
 3 Cybersex
3 Cybersex
 Come i media influenzano la sessualità? In che modo vivo il rapporto con il mio corpo sui social? Qual è l’influenza dei media sulla mia dimensione affettiva, inclusa l’identità di genere?
Come i media influenzano la sessualità? In che modo vivo il rapporto con il mio corpo sui social? Qual è l’influenza dei media sulla mia dimensione affettiva, inclusa l’identità di genere?
 4 Sensi di colpa
4 Sensi di colpa
 Come gestire gli eventuali sensi di colpa legati alle nostre pulsioni? E se il mio partner è di un’altra religione?
Come gestire gli eventuali sensi di colpa legati alle nostre pulsioni? E se il mio partner è di un’altra religione?E, quindi, come si risponde a chi chiede qual è l’età giusta per il primo rapporto? Considerando anche che i giovani formatori di Ac dovranno maturare dentro sé stessi un approccio equilibrato e sereno per trasmettere a loro volta queste indicazioni agli adolescenti loro affidati. C’è una via adeguata e comprensibile tra l’elenco dei divieti, ormai improponibile, e il laissez faire della rinuncia educativa? «La formula - riprende l’esperta - potrebbe essere di rivolgere loro una domanda del genere: "Quando pensi si essere abbastanza maturo per mettere la tua vita nelle mani di un altro/a dal punto di vista mentale e fisico? Pensi di avere la responsabilità sufficiente per farti carico della vita di un’altra persona?"». Perché la sfida è tutta qui, spiegare che cuore e corpo devono viaggiare sempre connessi. E proprio per questo occorre sottolineare l’importanza di curare le relazioni, cioè il rispetto reciproco, le attenzioni, le parole giuste.
Quelle che cercheranno di trovare anche Marinella Perroni, biblista, e don Aristide Fumagalli, teologo morale, chiamati a ricordare ciò che Scrittura e magistero indicano sul tema. A Nicoletta Musso, mediatrice familiare, e Piera Di Maria sessuologa Piera Di Maria, è stato chiesto di avventurarsi nelle emozioni filtrate, o distorte dal web. «Intanto diciamo loro che la sessualità è una cosa meravigliosa, un dono da custodire e da comprendere. Ai ragazzi vogliamo mandare messaggi semplici, senza parole troppo complesse, del tipo "fai pace con il tuo corpo, accettalo e rispettarlo e ringrazia Dio per quello che hai, fai pace con la tua storia e con quella della tua famiglia accogliendone luci e ombre, pensa che le relazioni vanno curate e costano fatica, ma questo è il senso della vita e da qui nasce l’amore"».
E Caterina Donato, giovane psicologa della diocesi di Messina, spiegherà ai ragazzi che pulsioni adolescenziali e vita di fede non sono in contrasto: «Le esperienze della corporeità non confliggono con l’amore di Dio perché il corpo è dono del Padre. Per accettare la relazione, occorre imparare ad accettarsi. Questione complessa, soprattutto oggi con la grande confusione sull’identità di genere».
Ne è consapevole padre Pino Piva, gesuita, educatore proprio sulla pastorale di frontiera, in particolare con i giovani omosessuali che «come tutti gli altri, hanno bisogno d’essere accompagnati nella loro crescita umana e spirituale, ed ecclesiale; come gli altri. E per questo riprenderò una parte del n. 150 del Documento finale del Sinodo dei giovani. In particolare dove i vescovi sollecitano ad aiutare i giovani "a leggere la propria storia; ad aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata battesimale; a riconoscere il desiderio di appartenere e contribuire alla vita della comunità; a discernere le migliori forme per realizzarlo. In questo modo si aiuta ogni giovane, nessuno escluso, a integrare sempre più la dimensione sessuale nella propria personalità, crescendo nella qualità delle relazioni e camminando verso il dono di sé"».
Un invito che Michele Tridente e Luisa Alfarano, vicepresidenti nazionali dell’Azione cattolica per il Settore giovani, non intendono lasciare cadere: «Il rischio in cui è facile cadere è quello di trattare questi temi come un tabù, preferendo il silenzio e rischiando di cedere alla tentazione del giudizio verso i comportamenti degli altri. Questo genera spesso incomprensioni e allontanamento dalla Chiesa. La strada invece - concludono - è quella del dialogo e del confronto soprattutto con chi la pensa diversamente e con chi vive in modo poco sereno il rapporto con il proprio corpo e le relazioni affettive».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- Amore e responsabilità (Karol J. Wojtyla) - e "caritas" (J. Ratzinger)!!!
"PERVERSIONI. Sessualità, etica, psicoanalisi". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" --- Un sintomo che non guarisce. Perché Freud è ancora necessario (di Sergio Benvenuto).14 novembre 2019, di Federico La Sala
Perché Freud è ancora necessario
Un sintomo che non guarisce
di Sergio Benvenuto (Doppiozero, 13 Novembre 2019) *
Foucault scrisse: "il marxismo sta nel pensiero del XIX secolo come un pesce sta nell’acqua; e cessa di respirare in qualsiasi altro luogo”. Anche Freud stava come un pesce nell’acqua del XX secolo, e non respira più nel XXI?
Freud e psicoanalisi restano temi più che mai controversi nella nostra epoca: chi considera Freud un ciarlatano - “la psicoanalisi è spalmarsi miti greci sui genitali” (Nabokov) - e chi gli dedica un culto acritico di massimo genio della modernità. Credo che l’importante di Freud non siano le teorie “freudiane” - l’Edipo, l’eziologia sessuale, la scena primaria, ecc. - ma il setting analitico, una certa relazione tra due persone, uno speciale “gioco linguistico” che la nostra epoca ha inventato e di cui le è molto difficile disfarsi.
Dopo Freud abbiamo avuto tante altre ‘chiavi’ psicoanalitiche, e non-psicoanalitiche, ma lui ha fatto il colpo gobbo: il “terzo orecchio” con cui si ascoltano le persone. Non importa che cosa si ascolti con il terzo orecchio - ogni scuola sente cose diverse - l’importante è che faccia capolino l’orecchio in più. Che ci sia un ascolto speciale. Fin quando esisterà il bisogno di questo ascolto (quel che chiamiamo inconscio) ci saranno sempre degli psicoanalisti. Spesso squilla l’annuncio della morte della psicoanalisi, che in realtà è un augurio: si ripete che la psicoanalisi è inefficace, mentre le terapie cognitive, invece, farebbero faville... Ma non è vero. Si attacca la psicoanalisi perché invece è molto efficace. La psicoanalisi - disse Lacan - è il sintomo della nostra epoca, e i sintomi, come è noto, sono sempre molto efficaci.
*
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- IL "PADRE NOSTRO" E LA "RAFFINERIA" DI PAPA FRANCESCO22 febbraio 2019, di Federico La Sala
Catechesi sul “Padre nostro”: 7. Padre che sei nei cieli
di Papa Francesco *
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’udienza di oggi si sviluppa in due posti. Prima ho fatto l’incontro con i fedeli di Benevento, che erano in San Pietro, e adesso con voi. E questo è dovuto alla delicatezza della Prefettura della Casa Pontificia che non voleva che voi prendeste freddo: ringraziamo loro, che hanno fatto questo. Grazie.
Proseguiamo le catechesi sul “Padre nostro”. Il primo passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre incomincio il mistero.
 Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).
Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, purificarle. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: «La purificazione del cuore concerne le immagini paterne e materne, quali si sono configurate nella nostra storia personale e culturale, e che influiscono sulla nostra relazione con Dio» (n. 2779).Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno; come noi, a nostra volta, non saremo mai genitori, o pastori, perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso o di manipolazione dell’altro. Per questo a volte le dichiarazioni di amore si tramutano in sentimenti di rabbia e di ostilità. Ma guarda, questi due si amavano tanto la settimana scorsa, oggi si odiano a morte: questo lo vediamo tutti i giorni! E’ per questo, perché tutti abbiamo radici amare dentro, che non sono buone e alle volte escono e fanno del male.
Ecco perché, quando parliamo di Dio come “padre”, mentre pensiamo all’immagine dei nostri genitori, specialmente se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbiamo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del Padre “che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad usare Gesù: è l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono eternamente mendicanti di amore, - noi siamo mendicanti di amore, abbiamo bisogno di amore - cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti!
Il dio greco dell’amore, nella mitologia, è quello più tragico in assoluto: non si capisce se sia un essere angelico oppure un demone. La mitologia dice che è figlio di Poros e di Penía, cioè della scaltrezza e della povertà, destinato a portare in sé stesso un po’ della fisionomia di questi genitori. Di qui possiamo pensare alla natura ambivalente dell’amore umano: capace di fiorire e di vivere prepotente in un’ora del giorno, e subito dopo appassire e morire; quello che afferra, gli sfugge sempre via (cfr Platone, Simposio, 203). C’è un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la congenita debolezza del nostro amore: «Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce» (6,4). Ecco che cos’è spesso il nostro amore: una promessa che si fatica a mantenere, un tentativo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al mattino esce il sole e si porta via la rugiada della notte.
Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’esperienza: abbiamo amato ma poi quell’amore è caduto o è diventato debole. Desiderosi di voler bene, ci siamo poi scontrati con i nostri limiti, con la povertà delle nostre forze: incapaci di mantenere una promessa che nei giorni di grazia ci sembrava facile da realizzare. In fondo anche l’apostolo Pietro ha avuto paura e ha dovuto fuggire. L’apostolo Pietro non è stato fedele all’amore di Gesù. Sempre c’è questa debolezza che ci fa cadere. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non trovare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’amore.
Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”. Nessuno deve dubitare di essere destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro padre e nostra madre non ci avessero amato - un’ipotesi storica -, c’è un Dio nei cieli che ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’amore di Dio è costante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16).
 Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.
Oggi è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così siamo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polvere, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fedele di Dio.Nella fame d’amore che tutti sentiamo, non cerchiamo qualcosa che non esiste: essa è invece l’invito a conoscere Dio che è padre. La conversione di Sant’Agostino, ad esempio, è transitata per questo crinale: il giovane e brillante retore cercava semplicemente tra le creature qualcosa che nessuna creatura gli poteva dare, finché un giorno ebbe il coraggio di alzare lo sguardo. E in quel giorno conobbe Dio. Dio che ama.
L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lontananza, ma una diversità radicale di amore, un’altra dimensione di amore, un amore instancabile, un amore che sempre rimarrà, anzi, che sempre è alla portata di mano. Basta dire “Padre nostro che sei nei Cieli”, e quell’amore viene.
Pertanto, non temere! Nessuno di noi è solo. Se anche per sventura il tuo padre terreno si fosse dimenticato di te e tu fossi in rancore con lui, non ti è negata l’esperienza fondamentale della fede cristiana: quella di sapere che sei figlio amatissimo di Dio, e che non c’è niente nella vita che possa spegnere il suo amore appassionato per te.
*
PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE -Aula Paolo VI
 Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
Mercoledì, 20 febbraio 2019 (ripresa parziale).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA "NON CLASSIFICATA"!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907
VIVA L’ITALIA!!! LA QUESTIONE "CATTOLICA" E LO SPIRITO DEI NOSTRI PADRI E E DELLE NOSTRE MADRI COSTITUENTI. Per un ri-orientamento antropologico e teologico-politico. Una nota (del 2006)
UN NUOVO CONCILIO, SUBITO. 95 TESI? NE BASTA UNA SOLA! Cattolicesimo, fascismo, nazismo, stalinismo: il sogno del "regno di ‘dio’" in un solo ‘paese’ è finito.
Federico La Sala
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- E DI NARCISO. Il mito di Filemone e Bauci, Etty Hillesum, e la gratitudine (di Anna Stefi)15 gennaio 2019, di Federico La Sala
Etty Hillesum e la gratitudine
di Anna Stefi (Doppiozero, 15 gennaio 2019)
“Non sopravvalutare le tue forze interiori”, scrive Etty Hillesum in un passo del suo Diario (Adelphi, 2012). È la mattina del 10 marzo 1941. Il groviglio della sua anima, che non smette di interrogare, è groviglio che, al cuore, ha questo “sentirsi prescelta”, questo “dover diventare ‘qualcuno’” cui fa spesso ritorno. L’educazione spirituale passa, per la giovane ebrea che morirà ad Auschwitz, attraverso una profonda accettazione della propria “nullità”: io stessa, scrive, devo scomparire interamente, devo abbandonare il mio piccolo ego. La propria vita emotiva e intellettuale è messa in relazione con quella delle persone che, ai suoi occhi, appaiono “normali”; sa bene, tuttavia, che non le è dato comprendere nulla del mondo interiore di chi ha davanti. Del proprio, invece, conosce la bizzarra irrequietezza. “Perché devi saper fare qualcosa?” L’ambizione trattiene il suo dire, la vanità lo attorciglia.
Etty Hillesum non porta soluzioni, le pagine del diario mostrano invece il continuo guardare alla propria posizione: dove sono?, sembra chiedersi in ogni parola che scrive. C’è un passo, in Vite che non sono la mia, in cui Carrère scrive: “la malattia, il terrificante approssimarsi della morte, gli hanno insegnato chi era. Sapere chi siamo - Étienne più che altro direbbe: dove siamo - significa essere guariti dalla nevrosi”.
Un groviglio occupa, in apparenza, poco spazio; dipanare la matassa significa cogliere l’immensa stratificazione che lo costituisce.
L’attenzione per la realtà pura, libera da pregiudizi e aspettative, e dunque il tempo della vita come tempo presente, appartengono a questa stessa necessità di fare a meno di pensieri che affaticano e confondono. Etty comprende che il continuo rimandare a domani risponde ad una logica che muove verso un ideale: iniziare “adesso” il proprio compito, muoversi “oggi”, non è dunque semplicemente un invito a godere l’attimo che fugge, ma, più precisamente, un invito a liberarsi da una prospettiva che ci voglia sempre in attesa dell’istante che ci troverà, finalmente, degni.
Ecco perché “una vera maturazione non può tenere conto del tempo”; quel tempo che vogliamo disponibile, sembrano suggerire le pagine del Diario, quel tempo che è necessario impiegare, far fruttare, investire, mostra - nel momento stesso in cui ci troviamo a pensarlo in questo modo, transito per qualcosa di ulteriore - la trappola che non smette di farci prigionieri. Concedersi al fluire del mondo è stare nel suo ritmo come appartenenza al vivente, porsi in ascolto del suo accadere. Legge Rilke, Etty, e chissà se aveva nella mente l’animale dell’ottava elegia “puro come il suo sguardo sull’Aperto./ E dove noi vediam futuro lui vede invece il tutto,/ e in quel tutto se stesso e salvo sempre”.
Le giornate devono iniziare rammendando calze, e sarà necessario, quando i buchi saranno finiti, crearne di nuovi.
Le parole di Etty mettono in luce quanto il senso di inadeguatezza e la presunzione, imponenti blocchi di granito che la schiacciano, siano l’uno il rovescio e il complementare dell’altra. Autocommiserazione e compiacimento. C’è la sua grazia, il suo dono - la scrittura -, ma vi è pure quel non esserne sicura. Il processo che pagina dopo pagina la Hillesum compie sotto ai nostri occhi, e che dimostra che all’essere umano è dato di cambiare, non è, come inizialmente scrive e crede, dal lato dell’ordine e della disciplina. Credere che sia la tecnica a mancarle, ipotizzare che il talento di cui scrive non sia supportato da una disponibilità al sacrificio, e che questo sia il limite da combattere, significa restare dal lato di un più, di un ulteriore, di un aggiungere. Ostinazione e avidità.
È necessario togliere, invece. Eliminare il ciarpame sempre presente.
Il dono deve accadere e la dolcezza appartiene a una logica del meno, di un vivere in perdita: nessuna risposta, nessun controbattere, nessuna battaglia, nessun nemico e nessun aggrapparsi. La forza deve farsi umile. Non si tratta di porgere l’altra guancia, si tratta, più radicalmente, di quel “disorientamento doloroso e al contempo interrogativo”, solo modo di porsi davanti all’odio così come davanti all’ambizione e alla spinta al possesso. Crollare violentemente sulle ginocchia, scrive Etty. E poi avere pace. “Sempre c’è mondo/ e mai quel nessundove senza negazioni/ puro, non sorvegliato, che si respira/ si sa infinito e non si brama”.
- [Foto] Vista del fiume Soła. Oświęcim, Polonia 2017 - da ’Where water comes together with other water’ (2015-18) © gianfranco gallucci.
Vi è in questo, io credo, un invito importante da accogliere, un invito che richiede quel lungo lavoro spirituale che Etty compie nelle pagine del proprio diario: si tratta di abbandonare l’ideale, in ogni sua forma. Una tra le due metà in lotta del proprio volto.
L’abbandono dell’ideale porta a conseguenze che mettono in qualche modo di fronte a un radicale vuoto di senso, ma è solo grazie a questa tabula rasa, questa epoché, che diventa possibile accogliere qualcosa di più grande che poco tiene in conto la vita del singolo individuo se non per raccoglierlo in una logica del tutto; tutto che, nello stesso tempo, lo comprende e lo pervade: “volevo assoggettare la natura, vale a dire il tutto; volevo contenerlo. E il bello invece è - ed è davvero semplice - che adesso sono io a sentirmi assoggettata al tutto. Mi aggiro di qua e di là, invasa da questa profonda sensazione, ma essa non mi prosciuga più l’anima: al contrario: mi dà forza”.
Il vuoto di senso è quello dell’intercambiabilità, della non onnipotenza: non più la strada orientata e la guerra da combattere, non più il “cuore nervoso”, ma una radicale accettazione dell’accadere. Abbandonare l’io significa prima di tutto abbandonarne la presunzione. Il paesaggio interiore potrà allora consistere di grandi, vaste pianure, quasi prive di orizzonte.
Cambiare la propria posizione, guardare la parte che si ha nel disordine che si lamenta, è abitare una prospettiva che metta al centro l’insufficienza: non desiderare tutto, nemmeno se fosse possibile averlo. “’Che significa tutto questo, e la vita vale davvero la pena di essere vissuta? Sarebbe invece necessario vivere con pienezza, in modo che una simile domanda non abbia la benché minima possibilità di sorgere nel proprio io, e si dovrebbe traboccare di vita e di pace al tempo stesso”. “O tutto è casuale, o niente lo è. Se io credessi nella prima affermazione non potrei vivere, ma non sono ancora convinta della seconda”. Sente la sua mente offuscata, e tuttavia confrontarsi con il dolore dell’umanità - di nuovo arresti, terrore, campi di concentramento, sequestri di padri e sorelle - significa ospitarne ogni frammento.
Si tratta di una resa? No.
Scrive Freud che profondamente religioso non è l’uomo che ceda al sentimento della piccolezza e dell’impotenza umana di fronte all’universo, ma l’uomo che sappia attraversarlo per procedere oltre, per cercare aiuto contro tale sentimento. Chi si rassegna alla parte insignificante è irreligioso nel più vero significato della parola. Ma non è questo l’invito di Etty. L’inermità radicale non è che punto di partenza, possibilità di appello all’Altro.
Chi abita la propria insufficienza è chi può, come scrive Lou Andreas Salomé, specchiarsi nelle acque del fiume non già per rimanere prigioniero della propria immagine, ma per guardarsi riflesso al di sotto del pezzetto di cielo. Racconta Lou che la perdita del proprio sentimento religioso aveva coinciso, in lei bambina, in un’impressione, avvertita davanti alla propria immagine allo specchio, di estrema espropriazione: improvvisamente si era ritrovata esclusa da quel cosmo - Dio al suo centro - che fino a quel momento l’aveva accolta e contenuta. Un adulto, continua, avrebbe piuttosto sentito disagio nel contrario, nella perdita di delimitazione del proprio io. Questo ci insegna il narcisismo teorizzato da Freud, suo maestro. E tuttavia vi è una possibilità ulteriore, una possibilità di ripensare Narciso, di mostrare che vi è qualcosa di più in quel mito, qualcosa che Freud non ha saputo vedere. Nella lettura della donna, infatti, non è possibile guardare Narciso senza tenere a mente lo stato di pienezza originario, l’esperienza fusionale con il materno. Lungi dall’essere qualcosa che condanna a una nostalgia irreparabile, questa esperienza di unità permette al soggetto - la donna soprattutto, attraversata da questa comunione originaria in maniera più radicale - di provare uno stato di armonia con il cosmo che resta come memoria di una meta da ritrovare attraverso l’espressione artistica, l’estasi. Andreas-Salomé parla di un Tutto, di una completezza che definisce narcisistica, ma tale narcisismo è precisamente una tensione che non inchioda il soggetto a sé, ma lo rende per sempre appartenente a una realtà vitale che lo supera e anticipa. Il giovane uomo non guarda la propria immagine in uno specchio artificiale ma nelle acque della natura, e dunque non è solo sé stesso quello che vede, ma sé stesso in quanto creato. Narciso è l’uomo che ha fatto esperienza di una totalità. Stasi, malinconia e, soprattutto, abbandono di padronanza. È una nuova possibilità, un narciso femminile, scrive Lou.
“Che cosa hai tu, che tu non l’abbia ricevuto?”: sembra essere questo l’insegnamento di Etty in cui riecheggiano le riflessioni della psicoanalista. Non c’è logica di scambio. L’insufficienza, l’esistere come parte della Natura, si fa gratitudine e dunque motore. Rendere grazie non è movimento di chiusura che ha, come esito, la stasi, non è annullamento di un debito quanto piuttosto riconoscimento radicale della grazia dell’Altro, della sua differenza, della nostra stessa differenza in quanto sempre altro da noi. Gratitudine è rilancio, scommessa verso il futuro. Si tratta di raccogliere un’eredità d’amore, conoscere la provvisorietà della tenda e darsi all’esistenza come qualcosa che ci supera: è la comune appartenenza a renderci fratelli. L’esistenza universale, esistenza ferita, è occasione di legame. Non si dà posizione - dove sono? - se non in relazione all’altro. Soltanto in questa prospettiva diventa possibile quel dare non perché tu mi restituisca, ma perché tu dia ad altri.
È questo che ci insegna il mito di Filemone e Bauci, raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi. I due vecchietti, insieme sin dalla giovinezza, accolgono Giove e Mercurio nella loro povera casa, li accolgono nelle loro sembianze umane, di sperduti viandanti. La povertà in cui i due hanno vissuto rende loro possibile mettere in rapporto la propria condizione alla condizione dello straniero. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno. Ed è l’ospitalità agli dei sotto mentite spoglie che permette il compiersi del prodigio: la casa si fa tempio e loro ne diventano i custodi. Zeus rivela così la sua identità. Un solo desiderio esprimono al potente dio: non sopravvivere l’uno alla morte dell’altro. Così, la metamorfosi: Filemone e Bauci diventano albero, pianta, mondo; fanno ritorno a quel Tutto che li ricomprende.
-
> "PERVERSIONI" -- La pastorale, antica e moderna. Riflessioni a partire da: Michel Foucault, Les aveux de la chair. 2018 (di Sergio Benvenuto).13 gennaio 2019, di Federico La Sala
La pastorale, antica e moderna Riflessioni a partire da: Michel Foucault, Les aveux de la chair 2018.
di Sergio Benvenuto (Psychiatry on line, 18 settembre, 2018)
Ci sono voluti 34 anni, dalla morte di Foucault, perché si ricostruisse definitivamente quello che avrebbe dovuto essere l’ultimo volume della sua Storia della Sessualità, il quarto. Lavoro portato a termine da Frédéric Gros, che ha ricostruito il libro - o quel che Foucault ne aveva scritto - a partire da manoscritti e da parti già edite. E’ il volume - Le confessioni della carne - in cui Foucault si confronta con le concezioni cristiane, pre-medievali, della sessualità.
Va ricordato che, a differenza di tanti altri storici di oggi, Foucault in questa Storia non si occupa dei costumi sessuali nel mondo occidentale se non marginalmente. Non cerca di ricostruire come la gente comune si comportasse a letto, chi sposasse, ecc.; si occupa dell’elaborazione teorica - da parte di filosofi, moralisti, teologi - a proposito della sessualità. Più che Storia della sessualità, dovrebbe essere chiamata Storia dei discorsi sulla sessualità. In fondo, l’approccio di Foucault è aristocratico: quel che conta è quel che i “filosofi” in senso lato hanno elaborato sul rapporto tra soggetto e impulsi sessuali. La decisione di Foucault sembra l’equivalente storiografico della strategia missionaria dei gesuiti: questi non perdevano tempo a convertire la gente comune, ma il loro principe. Foucault dà per scontato che, poi, anche le pratiche sessuali nelle varie epoche si adeguassero prima o poi allo stato dell’arte riflessiva sull’argomento.
Foucault mette in chiaro che l’austerità della “pastorale cristiana della vita quotidiana” non è un’invenzione cristiana, ma continua essenzialmente la morale filosofica di autori pagani, in particolare stoici, come Plutarco, Musonio, Seneca o Epitteto. (La differenza però, aggiungerei, è che mentre la morale ascetica pagana era riservata appunto alle persone molto colte, a esseri in qualche modo superiori, quella cristiana intende essere una direttiva per tutti i cristiani e quindi, in prospettiva, per tutti gli esseri umani. La morale cristiana antica popolarizzava, direi persino democratizzava, un’ascesi che nel paganesimo non intendeva educare le masse.)
La tesi di Foucault è che la differenza del cristianesimo rispetto ad altre morali di controllo della sensualità propria e degli altri è che questo controllo si fa attraverso una confessione (e questo ancora prima che la pratica della confessione venisse istituzionalizzata come sacramento). Confessando, una verità individuale si manifesta. “Enuncia la tua colpa al fine di distruggere la colpa” diceva S. Giovanni Crisostomo. L’enunciazione esplicita all’altro del proprio peccato, quindi del proprio desiderio colpevole, è nel cristianesimo un operatore fondamentale.
 Per esempio, secondo S. Ambrogio Dio punisce Caino non tanto per il fratricidio da lui commesso, quanto per l’impudenza di aver mentito a Dio, di non aver ammesso il proprio delitto davanti a Lui. E la confessione (aveu) non è tanto semplice comunicazione all’altro di qualcosa che già il soggetto sa di sé, ma è prima di tutto scoperta interiore della propria colpa. Si scopre di essere peccatori, e lo si deve riconoscere di fronte a un altro o all’Altro (Dio). “Il peccato quindi, nel momento stesso in cui infrange la verità di Dio o la sua legge - scrive Foucault - fa contrarre un obbligo di verità [...] Nel cuore dell’economia della colpa, il cristianesimo ha posto il dovere di dir-vero”. “Il ‘dir-vero’ della colpa occupa nel cristianesimo un posto indubbiamente ben più importante e vi gioca comunque un ruolo ben più complesso che nella maggior parte delle altre religioni [...] che richiedono la confessione dei peccati”. Ciò che perde il peccatore non è il peccato in sé, ma il non confessarlo e ammetterlo. “Il dovere di verità, come credenza e come confessione, è al centro del cristianesimo”. Foucault non lo dice esplicitamente in questo testo, ma è evidente quel che pensa: che l’etica della psicoanalisi oggi - riuscire a dire il proprio inconscio, ammettere i propri inammissibili fantasmi (quel che Lacan chiamerà “parola piena”) - deriva in qualche modo proprio dalla specificità cristiana, che lega la fede a una pratica del dir-vero. Anche se inventata da un ebreo, la psicoanalisi prosegue, in chiave laica, una strategia cristiana.
Per esempio, secondo S. Ambrogio Dio punisce Caino non tanto per il fratricidio da lui commesso, quanto per l’impudenza di aver mentito a Dio, di non aver ammesso il proprio delitto davanti a Lui. E la confessione (aveu) non è tanto semplice comunicazione all’altro di qualcosa che già il soggetto sa di sé, ma è prima di tutto scoperta interiore della propria colpa. Si scopre di essere peccatori, e lo si deve riconoscere di fronte a un altro o all’Altro (Dio). “Il peccato quindi, nel momento stesso in cui infrange la verità di Dio o la sua legge - scrive Foucault - fa contrarre un obbligo di verità [...] Nel cuore dell’economia della colpa, il cristianesimo ha posto il dovere di dir-vero”. “Il ‘dir-vero’ della colpa occupa nel cristianesimo un posto indubbiamente ben più importante e vi gioca comunque un ruolo ben più complesso che nella maggior parte delle altre religioni [...] che richiedono la confessione dei peccati”. Ciò che perde il peccatore non è il peccato in sé, ma il non confessarlo e ammetterlo. “Il dovere di verità, come credenza e come confessione, è al centro del cristianesimo”. Foucault non lo dice esplicitamente in questo testo, ma è evidente quel che pensa: che l’etica della psicoanalisi oggi - riuscire a dire il proprio inconscio, ammettere i propri inammissibili fantasmi (quel che Lacan chiamerà “parola piena”) - deriva in qualche modo proprio dalla specificità cristiana, che lega la fede a una pratica del dir-vero. Anche se inventata da un ebreo, la psicoanalisi prosegue, in chiave laica, una strategia cristiana.Descrivere il pensiero cristiano attorno alla sessualità significa ricostruire il modo in cui, per secoli, i teologi hanno dovuto affrontare vari puzzle; in particolare, il modo in cui cercano di rendere coerente la morale della Chiesa che si andava precisando con la lettera delle Sacre Scritture e con l’argomentazione razionale. Un puzzle era come mettere assieme l’esaltazione della verginità con una certa santificazione, più tardiva, del matrimonio.
 Già con S. Paolo, la verginità e la castità erano messe su un livello superiore rispetto al matrimonio (che all’epoca non era ancora un sacramento). Ma allora: perché Dio ha dato questa istituzione agli uomini? Ora, contrariamente alla Chiesa di oggi, nei primi secoli la morale cristiana non valorizza il matrimonio come strumento di procreazione. In un’epoca in cui la fine dei tempi appariva prossima, la necessità di riprodursi non era affatto in cima alle preoccupazioni teologiche. Il matrimonio era considerato soprattutto, paradossalmente, un modo di reprimere la concupiscenza ed esaltare la castità, dato che il cristiano sposato si accontenta della propria donna ed evita la fornicazione (ovvero, rapporti sessuali con persone diverse dal marito e dalla moglie).
Già con S. Paolo, la verginità e la castità erano messe su un livello superiore rispetto al matrimonio (che all’epoca non era ancora un sacramento). Ma allora: perché Dio ha dato questa istituzione agli uomini? Ora, contrariamente alla Chiesa di oggi, nei primi secoli la morale cristiana non valorizza il matrimonio come strumento di procreazione. In un’epoca in cui la fine dei tempi appariva prossima, la necessità di riprodursi non era affatto in cima alle preoccupazioni teologiche. Il matrimonio era considerato soprattutto, paradossalmente, un modo di reprimere la concupiscenza ed esaltare la castità, dato che il cristiano sposato si accontenta della propria donna ed evita la fornicazione (ovvero, rapporti sessuali con persone diverse dal marito e dalla moglie).Nei primi secoli, il matrimonio è un legame indissolubile grazie a cui il corpo di ciascun coniuge non appartiene più a sé stesso, ma all’altro. In una cultura in cui la donna era considerata inferiore all’uomo, il matrimonio cristiano introduce invece - straordinaria discrasia - una perfetta parità sessuale tra uomo e donna. Se uno dei due coniugi richiede l’atto sessuale, l’altro (fosse anche l’uomo!) non può sottrarvisi. Il matrimonio, insomma, è una forma di schiavitù sessuale in cui ciascuno è allo stesso tempo schiavo e padrone dell’altro. Ciascun coniuge è in debito di rapporti sessuali con l’altro, e ciascuno ha diritto di usare sessualmente il corpo dell’altro. Dato che ci si sposa per porre un limite agli eccessi della concupiscenza, si chiede all’altro di assicurare questa limitazione. “Se vuoi astenerti [dal sesso] in accordo con il tuo coniuge - prescrive san Giovanni Crisostomo - che la cosa non duri molto”. Chi ha deciso di sposarsi piuttosto che votarsi alla castità è obbligato al sesso, perché questo è il modo di evitare la tentazione della fornicazione a sé e all’altro.
Ora, per il pensiero cristiano dell’epoca il matrimonio è effetto della caduta dopo il peccato originale: nel paradiso terrestre non c’era matrimonio, ovvero - questa è la prima tesi che si fa strada - non c’erano rapporti sessuali. Il coito implica concupiscenza, che è effetto della caduta. Questa ha condannato gli umani al commercio sessuale e alla morte individuale (il rapporto sessuale era visto come una forma di corruzione del tutto simile alla morte; l’orgasmo era visto come un andare verso il limite della morte). Ma allora, che intendeva Dio quando ha detto ai due primi umani “crescete e moltiplicatevi”? E soprattutto, perché ha creato la donna, come se non bastasse Adamo? Il genesi dice “perché la donna aiuti l’uomo”, ma non nel senso di fare sesso assieme, perché allora non sarebbe stato paradiso. E allora, come si sarebbe procreato nel paradiso? Senza rapporto sessuale? Ma se non c’era bisogno del rapporto sessuale per riprodursi, perché allora la differenza sessuale?
Foucault mostra l’evoluzione di questa problematica, da Giovanni Crisostomo in poi, fino a quella che gli appare la sistemazione finale più sofisticata, quella di Agostino di Ippona. S. Agostino ipotizza che nel paradiso Adamo ed Eva avessero sì rapporti sessuali, ma senza concupiscenza: essi dovevano “fare sesso” così come con le mani si avvita la ruota di un carro o con i piedi si cammina, attività puramente volontarie che non implicano un desiderio sensuale alla fonte. All’epoca il proprio sesso era un organo controllato dagli umani con la pura volontà, come braccia e gambe. Perché è questo il discrimine essenziale per S. Agostino (e lo sarà poi per gran parte della Chiesa successiva): l’anima è soprattutto libera volontà, mentre la sensualità, e quella erotica in particolare, è costrizione, ha la forma del bisogno fisico. Dopo la caduta, gli umani - il maschio in particolare - hanno perso il libero uso dei genitali, che funzionano solo se stimolati da libido.
La Storia della sessualità nel suo insieme va letta su uno sfondo che l’autore ha esplicitato solo parzialmente nel primo volume, La volontà di sapere, e che chiamerei una presa di distanza dalla cultura di denuncia liberal-libertina dell’ascetismo. Una cultura da cui Foucault stesso proveniva. Questa cultura, oggi molto diffusa negli ambienti intellettuali, trova i suoi mentori essenziali in Nietzsche, Mill e Freud: tende a vedere la vocazione ascetica, prima pagana e poi cristiana, che si prolunga fino a fine Ottocento, come un “falso pregiudizio”, per usare un termine abusato. Essa prosegue la critica illuminista dei pregiudizi: come le fedi religiose sono superstizioni che devono lasciar posto alla razionalità scientifica, analogamente la repressione - sia laica che religiosa - della concupiscenza è effetto o di un errore cognitivo (l’idea che la sensualità sia dannosa alla salute) o di una lesione psichica, ovvero effetto di una morbosa rimozione delle pulsioni. Il controllo della libido è morbigeno. L’ascetismo è errore o patologia, o entrambe le cose assieme.
 Questa rivalutazione della sensualità e dei piaceri corporei (non si usa più il termine carne) da un secolo e poco più a questa parte ha finito con il contagiare la stessa teologia e moralità cristiane, che oggi appaiono molto meglio disposte nei confronti della vita pulsionale (purché non si commetta adulterio, la sessualità tende a essere oggi sacralizzata).
Questa rivalutazione della sensualità e dei piaceri corporei (non si usa più il termine carne) da un secolo e poco più a questa parte ha finito con il contagiare la stessa teologia e moralità cristiane, che oggi appaiono molto meglio disposte nei confronti della vita pulsionale (purché non si commetta adulterio, la sessualità tende a essere oggi sacralizzata).
 In questa prospettiva laica, che ho chiamato liberal-libertina, dei sette peccati capitali andrebbero defalcati almeno lussuria e gola, i due più intimamente connessi alla vita pulsionale. Se si pensa che a fine Ottocento i medici positivisti (non religiosi quindi) erano ossessionati dalla masturbazione infantile come causa di vari disastri psico-fisici, e che quindi occorreva usare ogni mezzo per impedirla, si misurerà la distanza della nostra mentalità attuale, improntata in gran parte alla libertà sessuale.
In questa prospettiva laica, che ho chiamato liberal-libertina, dei sette peccati capitali andrebbero defalcati almeno lussuria e gola, i due più intimamente connessi alla vita pulsionale. Se si pensa che a fine Ottocento i medici positivisti (non religiosi quindi) erano ossessionati dalla masturbazione infantile come causa di vari disastri psico-fisici, e che quindi occorreva usare ogni mezzo per impedirla, si misurerà la distanza della nostra mentalità attuale, improntata in gran parte alla libertà sessuale.
 In effetti, nell’ultimo secolo nell’Occidente cristiano prevale la filosofia utilitarista (di Bentham, Mill...), secondo la quale l’essere umano è essenzialmente tendenza ad avere piacere e a evitare dispiacere. Tendere al piacere e fuggire il dispiacere è ciò che l’essere umano in ultima istanza è, ma anche ciò che l’essere umano dovrebbe in qualche modo cercare di essere. Secondo l’etica (anche sessuale) utilitarista la contrapposizione tra anima e corpo, o tra volontà e carne, è annullata, perché piacere e dispiacere sono allo stesso tempo cosa del corpo e cosa della mente.
In effetti, nell’ultimo secolo nell’Occidente cristiano prevale la filosofia utilitarista (di Bentham, Mill...), secondo la quale l’essere umano è essenzialmente tendenza ad avere piacere e a evitare dispiacere. Tendere al piacere e fuggire il dispiacere è ciò che l’essere umano in ultima istanza è, ma anche ciò che l’essere umano dovrebbe in qualche modo cercare di essere. Secondo l’etica (anche sessuale) utilitarista la contrapposizione tra anima e corpo, o tra volontà e carne, è annullata, perché piacere e dispiacere sono allo stesso tempo cosa del corpo e cosa della mente.Così, alla nostra cultura la paura della concupiscenza appare per certi versi un enigma. In effetti, condannare la paura della concupiscenza non è ancora spiegarla. Perché, da Platone ai moralisti vittoriani, in Occidente è fiorita - senza prevalere sempre, è vero - questa cultura di condanna morale o medica della sensualità? Foucault, da storico, non avanza ipotesi esplicative. Ma la sua storiografia ci mette sulla strada se non di una risposta, almeno di una ricostruzione più perspicua dei perché delle varie “culture” sessuali.
Quel che diceva S. Agostino, che l’atto sessuale nel paradiso terrestre era compiuto senza concupiscenza, mi pare cruciale. Perché rivela come al centro della riflessione cristiana ci sia proprio quella che, a seguito di Nietzsche, chiamiamo la volontà di potenza. (Del resto, tutta l’opera di Foucault è, in sostanza, un’applicazione al campo storiografico della dottrina nietzscheana della Wille zur Macht.) Quel che sia i filosofi pagani che i teologi cristiani temono della sensualità è il suo essere pathos, passione, sottomissione passiva al desiderio. L’anima con le sue qualità viene identificata alla volontà consapevole dell’uomo: l’intelligibile si oppone al sensibile così come la libertà della volontà umana si oppone alla servitù della sensualità. -La libido è considerata una forza esterna alla volontà, che la condiziona e la annulla. L’anima come libertà della volontà è costantemente minacciata dalla “carne” che rischia di sommergerla. Dall’ascetismo stoico fino a quello cristiano si profila quindi la continuità di una concezione che identifica i desideri sensuali alla servitù, e la coscienza volontaria alla padronanza. Gran parte del pensiero antico, che si è prolungato in Occidente fino a non molto tempo fa, era una teoria-pratica che doveva assicurare il dominio del soggetto su sé stesso. Esso vedeva quindi i desideri sessuali (ma anche quelli puramente sensuali) un po’ come noi oggi consideriamo le dipendenze da sostanze, dall’alcool alla cocaina: coartazioni della libertà che provengono dal corpo stesso. In questa prospettiva, l’ascetismo di parte della cultura occidentale diventa una strategia comprensibile anche per noi moderni: declina un certo progetto che mette al centro la libertà della coscienza umana. E’ un progetto di separazione dalla propria carne in quanto bisognosa.
Significa questo che allora la cultura contemporanea ha rinunciato alla volontà di potenza? Sarebbe assurdo affermarlo. Oggi più che mai la nostra cultura è assillata dal controllo del proprio corpo e della propria mente, anche se attraverso le tecnologie, vale a dire attraverso un trattamento che si vuole sempre più scientifico del corpo e della mente. Da qui la passione per le diete, per le palestre, per la cosmetica, per i test mentali, insomma, per la fitness. La massimizzazione dell’efficienza del corpo e della mente sono oggi parte anche della cultura popolare. Ma la differenza rispetto al passato è che questa fitness, sulla falsariga della filosofia utilitarista, si applica sia alla vita sensuale che a quella intellettuale, senza alcuna barriera etico-ontologica tra le due: bisogna massimizzare gli orgasmi così come bisogna massimizzare le proprie capacità logico-matematiche o il proprio patrimonio. Sesso, danaro, potere, sapere: tutto va massimizzato. Si deve essere ottimi amanti così come ottimi imprenditori od ottimi buongustai, od ottimi filosofi se si fa una carriera accademica. La moderna volontà di potenza non distingue più l’anima e la carne. I desideri sensuali vanno soddisfatti il più possibile, purché non danneggino la fitness generale dell’individuo.
CONTINUAZIONE POST-SUCCESSIVO.
-
> "PERVERSIONI" -- La pastorale, antica e moderna. Riflessioni a partire da: Michel Foucault, Les aveux de la chair. 2018 (di Sergio Benvenuto).13 gennaio 2019, di Federico La Sala
CONTINUAZIONE - PARTE FINALE
- La pastorale, antica e moderna Riflessioni a partire da: Michel Foucault, Les aveux de la chair 2018.
Significa questo che nella nostra cultura non c’è più alcuna pastorale? Foucault dedica molta attenzione al tema tradizionale, nelle culture antiche, del potere politico figurato come relazione tra il pastore e il suo gregge di pecore. Il buon re, e nel mondo cristiano il vescovo o il papa, è un buon pastore del suo gregge umano. Come nota Foucault, questo non implica affatto un’indistinzione degli individui nel gregge: il buon pastore sa che le proprie pecore non sono tutte eguali, che ciascuna ha bisogno di un trattamento specifico.
 Omnes et singulatim, scrive Foucault: il gregge è considerato nella sua totalità ma ogni singolo è preso in carico. E il buon pastore, come nella parabola evangelica (Luca 15, 3-7; Matteo 18, 12-14), deve saper abbandonare il gregge per recuperare la singola pecora smarrita. L’immagine del re-pastore o del prete-pastore va trasposta anche all’interno del soggetto stesso: bisogna essere anche pastori di sé stessi, se consideriamo i nostri desideri un gregge di sensualità. Allora, nelle nostre società capitaliste e liberali, non c’è più alcuna pastorale?
Omnes et singulatim, scrive Foucault: il gregge è considerato nella sua totalità ma ogni singolo è preso in carico. E il buon pastore, come nella parabola evangelica (Luca 15, 3-7; Matteo 18, 12-14), deve saper abbandonare il gregge per recuperare la singola pecora smarrita. L’immagine del re-pastore o del prete-pastore va trasposta anche all’interno del soggetto stesso: bisogna essere anche pastori di sé stessi, se consideriamo i nostri desideri un gregge di sensualità. Allora, nelle nostre società capitaliste e liberali, non c’è più alcuna pastorale?Anche nella nostra cultura esiste una élite, intellettuale e scientifica. Come erano élites i filosofi antichi o teologi quali S. Crisostomo o S. Agostino - possiamo pensare che le larghe masse all’epoca, soprattutto contadine, non fossero granché ascetiche, che insomma la gente comune continuasse a comportarsi come nel passato. Foucault, abbiamo detto, analizza solo le opere delle élites. E allora, che cosa pensa l’élite liberal-libertina di oggi, incluso magari Foucault (e chi scrive)?
Credo che l’ideale moderno sia quello della creatività. Che si stia a letto con il proprio partner, che si lavori come manager in un ente, o che si faccia lavoro scientifico o informatico, l’importante è essere creativi. Non basta insomma massimizzare orgasmi, danaro, titoli: l’importante è avere una vita intellettuale, lavorativa, sessuale, familiare creativa. In questo senso l’accento posto dallo psicoanalista D.W. Winnicott sulla creatività, o la concezione surrealista di una creatività artistica di cui ciascuno sarebbe capace se solo desse libero corso al proprio inconscio, sono espressioni eloquenti delle idealità moderne. Ci si può quindi lasciar tranquillamente andare ai desideri dei sensi, purché la loro gestione sia creativa, non piatta e ripetitiva. La libido, le pulsioni (l’inconscio) non vanno rimossi ma assorbiti e integrati come occasioni e fonte di energia creativa.
 Nel passato, fino a Ottocento inoltrato, il primato era dato alla forza della volontà. Oggi però il motto non può essere più quello di Alfieri, “volli, sempre volli, fortissimamente volli” ma piuttosto “creai, sempre creai, ampiamente creai”. Il creatore di opere estetiche o tecniche, il pensatore originale, lo scopritore scientifico sono tutte figure idealizzate oggi, anche se hanno condotto una vita sessuale alquanto sregolata. L’importante oggi, insomma, è essere originali, che è una ricaduta della creatività. La dicotomia non è più quindi tra sensibile e intelligibile, tra sensualità e volontà forte, ma tra creatività e ripetitività, tra originalità e conformismo.
Nel passato, fino a Ottocento inoltrato, il primato era dato alla forza della volontà. Oggi però il motto non può essere più quello di Alfieri, “volli, sempre volli, fortissimamente volli” ma piuttosto “creai, sempre creai, ampiamente creai”. Il creatore di opere estetiche o tecniche, il pensatore originale, lo scopritore scientifico sono tutte figure idealizzate oggi, anche se hanno condotto una vita sessuale alquanto sregolata. L’importante oggi, insomma, è essere originali, che è una ricaduta della creatività. La dicotomia non è più quindi tra sensibile e intelligibile, tra sensualità e volontà forte, ma tra creatività e ripetitività, tra originalità e conformismo.L’ascetismo antico era, come ogni altra cultura sessuale, un tentativo di controllare il potenziale devastatore della sessualità. Siccome la sessualità umana ha un lato costruttivo (non foss’altro che come strumento di riproduzione) e un lato distruttivo, ogni cultura, ciascuna a proprio modo, cerca di ridurre al minimo questo secondo lato. Ricordiamo che anche Freud, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, descrive la coppia innamorata come qualcosa di anti-sociale capace di sfaldare il legame sociale. Ogni cultura, dalla più primitiva alla più moderna, deve confrontarsi con un Unbehagen in der Sexualität, inscindibile dall’Unbehagen in der Kultur. La sessualità è fonte di grandi piaceri, ma anche di grandi dolori.
La morale cristiana, fondata sul matrimonio indissolubile e sulla monogamia, parte dal fatto biologico che c’è un numero quasi pari di donne e uomini: se ciascuno si contentasse di avere un partner dell’altro sesso, la vita sociale sarebbe del tutto tranquilla. Naturalmente questo è vero sulla carta, di fatto, lo sappiamo, ci sono uomini che hanno tante donne e uomini che non ne hanno nessuna, e per le donne può esser detta la stessa cosa. Di fatto, la sessualità è una mina vagante nelle società che distrugge famiglie, genera delitti passionali, fa sprecare a uomini e donne molto tempo nel corteggiamento, nei flirt, nei litigi, in penosi divorzi, ecc. Ma la morale cristiana tende all’optimum di una società sessualmente pacificata.
Comunque, anche la morale laica moderna tende a un optimum: è disposta a pagare il prezzo di una certa anarchia sessuale, purché la sessualità venga incanalata, per dir così, verso mete creative. In ogni caso, sia nell’ascetismo che nel permissivismo, ogni cultura sessuale tende a ottimizzare il commercio sessuale. Diciamo che la volontà di potenza liberal-libertina è più sofisticata dell’ascetismo, nel senso che è ancora più ambiziosa: bisogna lasciarsi andare ai sensi, abbandonarsi a essi, perché così il soggetto accede a una potenza superiore, quella creativa.
Ma la creatività è un ideale per tanti, forse per i più, non meno duro da soddisfare dell’ascesi penitenziale cristiana. Tanti, forse i più, non vogliono essere creativi, a loro basta una vita tranquilla, ordinarie soddisfazioni, imboscarsi in una sorta di benessere di massa. Le élite appaiono, agli occhi dei più, portavoce di una pastorale troppo esigente. Cosa che, forse, potrebbe spiegare le svolte politiche in Occidente degli ultimi anni.
-
-
> "PERVERSIONI" --- "Les aveux de la chair" (Michel Foucault). Il sesso è ribelle all’uomo come l’uomo a Dio (di Andrea Calzolari).13 gennaio 2019, di Federico La Sala
Alias Domenica
Il sesso è ribelle all’uomo come l’uomo a Dio
Saggi. Esce da Gallimard, "Les aveux de la chair", dove Michel Foucault ripercorre la genesi della confessione nella prospettiva del tema che lo assilla nei primi anni ’80: il rapporto del soggetto con la verità
di Andrea Calzolari (il manifesto, Alias Domenica, 13.01.2019)
Da quando Pierre Janet, nel 1903, scrisse che la confessione sembrava inventata da un alienista geniale che intendeva studiare gli ossessi, l’analogia tra il confessore e lo psicoanalista è stata ripetutamente riproposta, diventando un luogo comune. Ma, un secolo prima di Janet, le Liaisons dangereuses avevano mostrato un altro aspetto della confessione nella pagina in cui la Merteuil, protagonista «cattiva» del romanzo, racconta di quando, adolescente, per informarsi sui piaceri proibiti del sesso, aveva dichiarato falsamente al confessore di aver fatto «quel che fanno tutte le donne»; le indagini e le domande del sacerdote, ansioso di salvare l’anima della giovanissima penitente, l’avevano così resa edotta proprio sui seducenti vizi da cui il prete avrebbe voluto distoglierla.
n quell’episodio Laclos inscena la spirale di sapere, potere e godere che Foucault ha messo al centro de La volontà di sapere: «Piacere di esercitare un potere che interroga, sorveglia, indaga, spia, fruga, palpa, porta alla luce; e dall’altra parte, piacere che arde di doversi sottrarre a quel potere, di fuggirlo, ingannarlo o travestirlo. Potere che si lascia invadere dal piacere che perseguita; e di fronte a lui, potere che si afferma nel piacere di mostrarsi, di scandalizzare o di resistere». Chi non ricorda questa pagina superba? Se non si conosce quel libro, si ignora uno dei vertici della coscienza contemporanea, e si resta sordi a domande che non smettono, e a lungo non smetteranno, di farci pensare.
Ma dopo La volontà di sapere (datata 1976), primo volume della Storia della sessualità, il progetto sembrò arenarsi: negli anni seguenti Foucault non pubblicò niente, mentre i corsi al Collège de France e l’intensa attività di conferenziere testimoniano sia lo spostamento dei suoi interessi dall’età moderna all’antichità, sia una rimodulazione dei vettori d’indagine.
 Nel 1984, lo stesso anno della morte dell’autore, uscirono L’uso dei piaceri e La cura di sé, i due volumi sull’«esperienza greco-latina degli aphrodisia»; da qualche mese, in Francia, è uscito finalmente anche il quarto volume, Les aveux de la chair (Le confessioni della carne, sul cristianesimo delle origini, a cura di Frédéric Gros, Gallimard, pp. 427, € 24,00) nella stesura, che Foucault non considerava definitiva, consegnata a Gallimard nel 1982, e quindi prima dei due precedenti lavori. Se restano tracce della mancata elaborazione finale (quattro frammenti che non si sa dove collocare sono annessi in appendice), il libro è già compiutamente organizzato, splendidamente scritto e talmente concentrato che è persino difficile estrapolarne qualche esemplificazione.
Nel 1984, lo stesso anno della morte dell’autore, uscirono L’uso dei piaceri e La cura di sé, i due volumi sull’«esperienza greco-latina degli aphrodisia»; da qualche mese, in Francia, è uscito finalmente anche il quarto volume, Les aveux de la chair (Le confessioni della carne, sul cristianesimo delle origini, a cura di Frédéric Gros, Gallimard, pp. 427, € 24,00) nella stesura, che Foucault non considerava definitiva, consegnata a Gallimard nel 1982, e quindi prima dei due precedenti lavori. Se restano tracce della mancata elaborazione finale (quattro frammenti che non si sa dove collocare sono annessi in appendice), il libro è già compiutamente organizzato, splendidamente scritto e talmente concentrato che è persino difficile estrapolarne qualche esemplificazione.Basti un accenno a due temi cruciali, con cui Foucault sembra rispondere in anticipo alle obiezioni del filosofo medievista Alain de Libera, che nella ponderosa «archeologia del soggetto» a cui stava lavorando da una decina d’anni, criticava sia Foucault sia Heidegger, ai quali peraltro dichiaratamente si ispirava, per aver sostenuto che il soggetto è un’invenzione moderna. In realtà, nel pensiero medievale, secoli prima del cogito cartesiano, la questione del nesso tra la soggettità (il soggetto-sostanza, supporto di attributi: il sostantivo grammaticale) e la soggettività (il soggetto come io pensante e/o agente) fu posta e discussa, anche se per lo più sotto forma di dibattiti teologici o addirittura cristologici (del resto niente affatto alieni da raffinate analisi logiche).
Ora, Les aveux de la chair riconosce il ruolo cruciale del pensiero cristiano delle origini nella costituzione del soggetto cosiddetto moderno, a partire appunto dalla istituzione della confessione: la genesi del sacramento nei primi secoli della chiesa, già a lungo studiata dagli specialisti, è ripercorsa da Foucault nella prospettiva dei temi che lo assillano negli anni in cui scrive il libro, quelli in cui studia il rapporto del soggetto con la verità.
La novità del Cristianesimo
Non a caso il libro insiste nel distinguere concettualmente due modi della confessione, l’exomològesis e l’exagòreusis, che nella pratica si sovrappongono. L’exomològesis è propriamente un «far-vero» (una «veri-ficazione»), in quanto implica non solo ammettere le proprie colpe, ma dimostrare praticamente, ovvero performare il proprio pentimento al cospetto della comunità con digiuni e mortificazioni di ogni genere. Questa penitenza, che finirà per dare il nome al sacramento, ne costituisce però solo un aspetto, complementare all’exagòreusis, il «dire-vero» (o «veri-dizione»), cioè l’impegno a dichiarare i propri peccati nella maniera più esaustiva: ciò che presuppone un «esame ininterrotto di sé», connesso «alla confessione incessante all’altro» in modo tale, nota Foucault, che si può considerare quest’ultima come il «versante esteriore dell’esame, la sua faccia verbale volta verso l’altro».
L’exomològesis, l’exagòreusis e l’esame, veri-ficazione e veri-dizione, sfociano nell’obbedienza assoluta al direttore spirituale: rifacendosi a Cassiano e agli altri teorici del monachesimo, Foucault ricorda che l’ideale monastico comportava persino l’abdicazione a una volontà propria. Nello stesso ambiente monastico viene del resto elaborata la dottrina relativa alla direzione spirituale, descritta da Gregorio Nazianzeno come «l’arte delle arti, la scienza delle scienze», dove si stabilisce che può dirigere solo chi sa a sua volta obbedire.
Si viene così definendo la struttura del complesso apparato istituzionale, consolidatosi nei secoli, in cui il soggetto cristiano plasma se stesso e su cui si è fondato il potere della chiesa. Sta in questo quadro il tema della sessualità, la cui trattazione (focalizzata sull’amore coniugale e sulla verginità) culmina nell’ultimo capitolo di Les aveux de la chair, dedicato alla concezione agostiniana della libido che, sostiene Foucault, segna un passaggio fondamentale nella storia, non solo teologica, del concetto.
Nel fuoco delle polemiche contro manichei e pelagiani, Agostino aveva delineato un quadro destinato, pur con successivi sviluppi, a durare secoli, muovendo da una questione allora assai discussa: esisteva una sessualità nel paradiso terrestre? Per i manichei la sessualità, prodotta dal demiurgo malvagio, era irredimibile; per i pelagiani, essendo stata creata da Dio, non poteva essere in sé peccaminosa (condannabili erano solo gli eccessi, come per i moralisti classici).
Per Agostino nel paradiso terrestre il sesso era docile come qualunque altro organo, svolgeva cioè la sua funzione, come la mano, per esempio, senza alcuna oscenità e immune dalla attuale parossistica violenza. Perversioni, queste, che secondo Agostino, sono l’effetto della caduta: con una sorta di contrappasso, come Adamo si è ribellato a Dio, così il sesso si ribella alla volontà umana, una ribellione che si attesta appunto nella motilità autonoma, positiva o negativa (erezione o impotenza) del sesso maschile. In questa prospettiva, primariamente fallica, il sesso - scrive Foucault in una formula folgorante, «è per l’uomo ciò che l’uomo è per Dio: un ribelle. Uomo dell’uomo, eretto davanti a lui e contro di lui».
Sapere, potere, godere
Che la libido sia ereditata da tutti gli uomini venuti al mondo (tant’è vero che essa caratterizza necessariamente anche la sessualità lecita del matrimonio), non significa tuttavia che il peccato sia dovuto all’azione di una forza esterna all’anima (la carne che sovverte lo spirito) o a un conflitto tra la ragione e la volontà («et veggio ‘l meglio, et al peggior m’appiglio»). La libido, infatti, non è qualcosa di diverso dalla volontà stessa, in quanto non è che la sua forma decaduta. Per quanto forte sia la pulsione della libido, essa non potrebbe mai tradursi in atto, senza il consenso - concetto fondamentale in Agostino - della volontà, che nel peccato «vuole ciò che vuole la concupiscenza»; ed è tale consenso che rende il soggetto di concupiscenza soggetto di diritto, responsabile delle proprie azioni.
Questa la novità del Cristianesimo secondo Foucault: mentre per il pensiero antico non si trattava di analizzare la sessualità, ma «piuttosto di collocarla in un’economia generale dei piaceri e delle forze», il cristianesimo, con Agostino, fonda «l’analitica del soggetto della concupiscenza, dove sono legati, con nodi che la nostra cultura ha piuttosto rafforzato che allentato, il sesso, la verità e il diritto». È in queste parole, le ultime del libro, che andrebbe probabilmente letta la trasformazione, ma anche la continuità, di quel circuito di sapere, potere e godere di cui parlava la Volontà di sapere.
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - "DEL SENTIRE CATTOLICO": "LA STORIA VERA". Benedetto Croce, Mario Perniola, e Luciano di Samosata e Alberto Savinio. Note..9 dicembre 2018, di Federico La Sala
Gli storici, questi mentitori. Torna il Luciano di Savinio
di Andrea Santurbano (Alfabeta-2, 02.12.2018)
- Luciano di SamosataUna storia vera e altre storie scelte da Alberto Savinio
- traduzione di Luigi Settembrini, introduzione, note e illustrazioni di Alberto Savinio, Adelphi, 2018, 386 pp. Con 50 illustrazioni b/n, € 14
La verità greca ha tremato un tempo con l’affermazione «io mento», ricorda Michel Foucault nel Pensiero del fuori, riferendosi al noto paradosso del mentitore di Epimenide, secondo cui tutti i cretesi sarebbero bugiardi, compreso il cretese che, nel dir questo, pretende di affermare il vero. Luciano di Samosata, che della civiltà greca ed ellenistica poteva ormai osservare l’epilogo dall’alto del II sec. d. C., può aggiustare il tiro: «giacché non ho a contar niente di vero [...], mi sono rivolto a una bugia, che è molto più ragionevole delle altre, ché almeno dirò questa sola verità, che io dirò la bugia». Quanto mai opportuno, dunque, appare oggi, in epoca di fake news, recuperare un classico impolverato dal tempo, di Luciano appunto, Una storia vera e altre storie scelte da Alberto Savinio, libro apparso per la prima volta nel 1944, da Bompiani, e ora riproposto da Adelphi. E già, non poteva essere che Savinio l’artefice di tale riscoperta, in anni, tra l’altro, che lo vedevano impegnato nella stesura di articoli, poi riuniti in Nuova enciclopedia (opera anch’essa riproposta da Adelphi, lo scorso anno), in cui non manca di esprimersi al riguardo con la sua consueta, funambolica arguzia: «Il difetto maggiore e la profonda immoralità dei regimi assolutistici come di ogni condizione assolutistica, è il principio della ‘verità unica’. Mentre si sa che la verità umana, la verità nostra, la verità ‘vera’ è fatta di vero e di falso: più di falso che di vero».
In realtà, è difficile distinguere a chi appartenga la paternità del volume: se Kafka, come vuole Borges, altro maestro di paradossi, avrebbe prodotto retroattivamente lo scrivano Bartleby, non è fuori luogo affermare che Savinio abbia prodotto retroattivamente questi scritti di Luciano. Ci si trova di fronte, infatti, a una lettura nella lettura: si legge Luciano ma si legge Savinio, che nell’introduzione lascia che sia lo stesso Luciano a raccontare la sua storia - questa sì, presumibilmente vera - alla maniera di un’«intervista impossibile». E non bisogna dimenticare la modernissima traduzione di Luigi Settembrini, realizzata durante la prigionia sull’isola di Santo Stefano (1851-59) per cospirazione contro il regime borbonico (anni in cui - o forse più tardi, ma il discorso non cambia molto - il serio letterato scrisse, probabilmente suggestionato da questa stessa traduzione, la breve favola omoerotica dei Neoplatonici, rinvenuta solo nel 1937, che Croce avrebbe considerato una «caduta» del maestro e di cui invece Giorgio Manganelli accompagnerà con un memorabile scritto la prima edizione nel 1977). Savinio, nella nuova edizione, si premura appena di «rinettare» questa versione di pochissimi arcaismi, considerandola bella, fedele e minuziosa.
Ma si diceva, insomma, di una polifonia di fondo; di un dialogo a tre, neanche troppo tenero, spesso spassoso, in cui Settembrini fa più compuntamente da esegeta al testo, mentre Savinio, teppisticamente, usa le note da contrappunto, per vivaci commenti o per libere divagazioni. Ne è esempio il dialogo Il Menippo o la negromanzia, in cui Savinio apre le danze chiamando in causa Settembrini: «Nota, o lettore, il modo “filologico” col quale è usato qui l’aggettivo indifferente: è a simili finezze che si riconosce l’eccellenza di questa versione dal greco»; Luciano, da parte sua, si lancia in uno dei suoi contundenti attacchi: «manda alla malora i filosofi e i loro sillogismi, ché son tutte sciocchezze; e attendi solo a questo, usare bene del presente, passare ridendo sopra molte cose, non dare importanza a nulla»; al che segue la pungente reazione di Savinio: «Peccato che questo dialogo così spiritoso finisca in una così povera morale. Questo purtroppo è il lato debole degli spiriti liberi: Luciano, Voltaire... Tra libertà di spirito e sciocchezza il passo è breve: troppo spesso gli spiriti liberi fanno il passo oltre il limite»; ma subito dopo Settembrini riporta la calma con una precisazione da par suo: «Livadia, città di Beozia, dov’era il tempio, anzi l’antro di Trofonio».
Proviamo per un attimo anche noi, allora, a riportare tutto sotto controllo. Una storia vera e altre storie si divide in due sezioni: «Dialoghi e saggi» e «Una storia vera e altre opere». Dei dialoghi soprattutto si sa quanto abbiano, e dichiaratamente, influenzato le Operette morali di Leopardi. Ma è tutta la silloge a rappresentare uno scrigno prezioso, a partire dal meraviglioso «trattatello storico-didascalico» Della dea Siria e dalla stessa Una storia vera, viaggio fintamente autobiografico che rivisita tradizione mitologica, storica e odeporica, tra battaglie interplanetarie fra Lunari e Solari (una sorta di Guerre Stellari ante litteram) e mesi vissuti nella pancia di una balena (Collodi, come Savinio suggerisce, doveva aver letto questa storia!). E poi l’incontro vis-à-vis, durante le peripezie marittime, con filosofi e personaggi di quel grande universo della cultura greca, fatta oggetto di ironia, ancorché venata di affetto, perché l’ironia, come puntualizza Savinio nell’introduzione, «- e qui io parlo anche per me e lo dico alle orecchie fini - [...] è una forma di amore indiretto: è l’amore più pudico, l’amore più geloso».
Quel che non smette di sorprendere in un autore come Luciano di Samosata, ancora oggi, sono tuttavia i tanti spunti, quella sorte di immagini dialettiche che continueranno a brillare nei secoli a venire in materia di critica letteraria o di rapporti tra storia e letteratura. Per esempio, in una Storia vera è già chiamata in causa l’«intenzionalità» dell’autore. A domanda specifica, «E perché cominciasti da quel Cantami l’ira?», Omero, fattosi personaggio e già satireggiato in altro passo, risponde: «Perché così mi venne in capo: credi tu che ci pensavo?». Verrebbe addirittura da chiedersi: ma chi scrive, Luciano o Savinio? O ancora, sul finale, giunge la stoccata agli storici, relegati in una specie di girone infernale: «le pene più gravi sono date ai bugiardi e specialmente agli storici che non scrivono la verità, come Ctesia di Cnido, Erodoto, e altri molti».
Ancorché in forma di satira, dunque, è già messo sotto accusa lo statuto di verità della storia, prima di Marc Bloch, e prima dei vari Michel de Certeau, Roger Chartier e Carlo Ginzburg che finiscono col fare i conti con un dilemma evidente: l’esigenza di organizzarsi secondo un ordine diegetico, che muove evidentemente da categorie retoriche e narrative proprie della letteratura, la quale però non è obbligata a stringere compromessi con un’esigenza di veridicità, non farebbe anche della storia un «racconto»? Jacques Rancière non esita addirittura a reclamare un’esigenza opposta, quando afferma che «il reale deve essere reso finzione per poter essere pensato».
Anche in questo caso risulta complice, dunque, il dialogo Luciano-Savinio: provvedendo alla demolizione di rigide frontiere narrative, compreso quell’autobiografismo impastato anch’esso dall’ibridismo dei generi scritturali, che nel secondo (sarà bene ricordare, nato e cresciuto in Grecia) sfocerà in un continuo gioco di rimandi e dissimulazioni, di ricordi e libere associazioni (ri)creative: da Tragedia dell’infanzia a Dico a te, Clio, da Narrate, uomini, la vostra storia a Infanzia di Nivasio Dolcemare.
Discorso a parte meritano infine le illustrazioni di Savinio che impreziosiscono il volume. Quell’animismo metamorfico, suo marchio di fabbrica, che insuffla vita agli oggetti e rapprende gli esseri umani in forme materiche, animali o vegetali, trova nelle mirabolanti narrazioni di Luciano un terreno fertilissimo d’ispirazione. Insomma, nel rileggere questo libro si entra nel vivo di quell’idea di anacronismo suggerita da Georges Didi-Huberman: un palpitare, un metodo, un montaggio vivo e fecondo di tempi diversi, e non quel tremendo peccato inviso agli storici. Gli storici, già, ancora loro.
_
3 risposte a “Gli storici, questi mentitori. Torna il Luciano di Savinio”:
- 1)
CHE BELLA STORIA, QUELLA DEL PAESE DELLA GENTE DALLA DOPPIA TESTA E DALLA LINGUA BIFORCUTA.... *
SE “La verità greca ha tremato un tempo con l’affermazione «io mento»”, COME “ricorda Michel Foucault nel *Pensiero del fuori*, riferendosi al noto paradosso del mentitore di Epimenide, secondo cui tutti i cretesi sarebbero bugiardi, compreso il cretese che, nel dir questo, pretende di affermare il vero”, OGGI NON SOLO “la verità greca”, MA la stessa verità planetaria trema e sollecita a NARRARE ancora e sempre UNA STORIA VERA ....
EPIMENIDE (con questo nome è rimasto nella storia, come persona degna di essere ricordata per la sopravvivenza della stessa isola), indignato contro i suoi stessi concittadini (che evidentemente lo accusavano di chissà quali malefatte), fece il primo passo nella terra della post-verità, e gridò infuriato: “Tutti i cretesi mentono”! Se molti risero, altrettanto molti lo applaudirono.
Qualche anno dopo, sempre in quell’isola, ci furono le elezioni: tra i partiti (quello che la storia non ci ha tramandato) comparve uno strano partito, con il nome “Forza Creta”, e il leader era proprio il vecchio EPIMENIDE!
CONQUISTATO IL POTERE legalmente, IL SUO GRIDO AI pochi CRETESI CHE AVEVANO RISO DELLA SUA “BATTUTA” FU QUASI SIMILE A QUELLO DI BRENNO CONTRO I ROMANI SORPRESI NEL SONNO, ANZI, NEL SONNAMBULISMO: “GUAI AI VINTI”!
SOLO CHE A ROMA CI FURONO LE OCHE CHE SVEGLIARONO UN POCO tutti e tutte E I GALLI FURONO CACCIATI, MA A CRETA ALLA FINE NESSUNO PIU’ OSO’ RIDERE E ... “TUTTI I CRETESI MENTONO” ANCORA!!! A MEMORIA (E A VERGOGNA) ETERNA.
*
Sul tema, mi sia consentito, si cfr.:
L’APOLOGIA DEL MENTITORE ISTITUZIONALIZZATO E LA FILOSOFIA ITALIANA
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE..
- 2)
P.S. - COME LA FANNO “TRAGICA”, questi STORICI. Ecco “come si deve scrivere la storia...” *
“Così dunque deve essere per me lo storico: impavido, incorruttibile, libero, amante della franchezza e della verità, e come dice IL COMICO, capace di chiamare i fichi, fichi, e la barca, barca, di non risparmiare o concedere nulla per odio o per amicizia; non deve avere riguardo, pietà, vergogna, o paura; sia un giudice imparziale, benevolo verso tutti ma non al punto di concedere a nessuno più di quel che gli è dovuto; nelle proprie opere deve essere straniero, senza patria, indipendente da ogni potere, uno che non calcola che cosa ne penserà l’uno o l’altro ma che racconta i fatti così come sono accaduti. [...]”
* Luciano di Samosata, “Come si deve scrivere la storia”.
- 3)
N.B.! - STORIA, STORIOGRAFIA, E “COMICITÀ”....
Per non sottovalutare l’importanza della indicazione di Luciano sul “come si deve scrivere la storia”, e non pensare che Benedetto Croce (“Perché non possiamo non dirci «cristiani»”, 20 nov. 1942), come Mario Perniola (“Perché non posso non dirmi «cattolico»”: “Del sentire cattolico. la forma culturale di una religione universale”, 2001), si sia “rincristianito per dispetto” ( don Giuseppe De Luca al Ministro dell’Educazione Nazionale Bottai, per un commento su “Critica Fascista” del 1° genn. 1943, al testo di Croce), è bene “guardare la luna” e non “il dito”, e ricordare che
- “Prima dell’illuminazione, una montagna è una montagna. Durante l’illuminazione, una montagna non è una montagna; dopo l’illuminazione, una montagna è di nuovo una montagna!”.
Pur se sia Croce sia Perniola, in cammino sulla strada di Luciano (non di Heidegger), siano rimasti intrappolati nell’orizzonte degli storici “mentitori”, a loro del lavoro di Dante come di Kant e Nietzsche e Freud molto è sfuggito, non per questo bisogna arrendersi alla “tragedia” e a vivere prima della “commedia” - in una “storia” senza “comicità”, nella “preistoria”!
“Dico a Te, Clio”. Narrate, uomini e donne, la vostra storia - comicamente...
SUL TEMA, mi sia lecito, cfr. CROCE “CRISTIANO” , VICO “ATEO”, E L’UOMO DELLA PROVVIDENZA;
“PERVERSIONI” di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto --- Lacan, Kristeva, e "Teresa, Mon Amour" - "Santa Teresa d’Avila in alta definizione". Note30 novembre 2018, di Federico La Sala
In principio era l’amore (charitas - non caritas!!!): pensare l’ "edipo completo"(Freud) *
Un libro su Santa Teresa d’Avila, una serenata in forma di fiction
Lacan e Kristeva come godono i santi
Un’analisi dedicata alla beata spagnola e alla sua estasi. Come interpretare questa forma sublime di rapimento? Perché il sesso non spiega tutto
di NADIA FUSINI (la Repubblica, 27.01.2009) *
Teresa, mon amour è non solo il titolo dell’ultimo libro di Julia Kristeva (tradotto da Alessia Piovanello per Donzelli Editore, pagg.628, euro 35,00); è il ritornello che l’attraversa, quasi il libro tutto fosse una canzone, una lunghissima serenata che l’autrice dedica alla santa spagnola, alla sua estasi. In copertina, of course, la Transverberazione di Santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini. Subito comprendiamo che lacaniano sarà il corteggiamento, debitore al medesimo fremito barocco che scioglie perfino il marmo della famosa scultura.
 E non a caso Jacques Lacan sceglieva lo stesso gruppo marmoreo a copertina del suo seminario Encore dell’anno accademico 1972-73. Dove nel capitolo sesto a chi volesse intendere l’amore divino e il godimento mistico si raccomandava di andare a Roma a contemplare la statua del Bernini. Guardatela e vedrete, affermava Lacan, vedrete che lei gode! Non c’è dubbio. E di che cosa gode? Di che cosa godono i mistici, le mistiche? Fino al secolo scorso, fino a Charcot, fino a Freud si sarebbe detto che era una faccenda puramente sessuale, energia libidica repressa, e così via.
E non a caso Jacques Lacan sceglieva lo stesso gruppo marmoreo a copertina del suo seminario Encore dell’anno accademico 1972-73. Dove nel capitolo sesto a chi volesse intendere l’amore divino e il godimento mistico si raccomandava di andare a Roma a contemplare la statua del Bernini. Guardatela e vedrete, affermava Lacan, vedrete che lei gode! Non c’è dubbio. E di che cosa gode? Di che cosa godono i mistici, le mistiche? Fino al secolo scorso, fino a Charcot, fino a Freud si sarebbe detto che era una faccenda puramente sessuale, energia libidica repressa, e così via.No, dice Lacan, non è una questione di fottere, o meno. C’è di più. In quell’attacco c’è un vero e proprio passaggio all’ ex-sistenza, un passaggio in quell’"ex", in quel "fuori" che fa da prefisso alla parola ex-stasi.
In mille variazioni Julia Kristeva riprende il motivo lacaniano, intrecciando il delirio mistico alla dimensione immaginativa e alla scrittura, e in quest’ultima versione, in quanto scrittrice, fa "sua" la santa. Letteralmente se ne appropria. Si identifica. Una volta adottata questa chiave - la vera estasi è la scrittura - non ci vuole molto a stabilire una stretta affinità tra la santa e la scrittrice. Tanto più che Teresa, oltre che santa e scrittrice e fondatrice, fu interprete e analista dell’anima.
A dare più brio alla serenata, l’inno a Teresa viene affidato a un alter ego, tale Sylvia Leclercq, psicoterapeuta, ossessionata, invasata dalla santa, intorno alla quale monta la sua fiction; fiction postmoderna, più che letteratura vera e propria, perché solo nel registro di una bulimica assimilazione, che procede per scorci temporali e incroci spaziali, pare a Sylvia di riuscire ad afferrare la vita della santa. Se Sylvia legge con passione le opere di Teresa, è per comprendere se stessa, le donne di oggi che incontra in terapia. E si esalta a certe affinità che intravvede. E’ meno sensibile alle differenze.
Il termine fiction piace alla dotta dottoressa di Linguistica e Semiotica Julia Kristeva, che in questa sua opera si sforza al massimo di rendere contemporaneo il suo soggetto anche grazie a una scrittura che si vuole veloce, gergale. E si concede vezzi modaioli che per via di slang ci presentano Teresa come "un big-bang fatto donna" (p.588); mentre per descrivere la sua religiosa confidenza con Dio si ricorre all’ espressione: "fare una Tac al mistero del Signore (p.274). Abbondano allusioni all’idea della rete. Internet, default sono termini che tornano. E i corsi di Derrida e di Kristeva alla Columbia University vengono citati come occasioni uniche per i pochi privilegiati che li frequentarono per penetrare, o meglio decostruire i misteri della rete che per l’appunto connetterebbe i mistici e i kamikaze.
 La nebulosa mistica si espande così in nebbia religiosa, e si aprono a ventaglio nel libro scottanti temi di attualità, tra cui sovrani i problemi del fanatismo e della fede: con Teresa sempre al centro, al crocevia di pensieri e concezioni di sé e del mondo che cambiano, che la vedono accanto a Montaigne, a Spinoza, a Cervantes. Teresa esponente sublime del Siglo de Oro. E ragazza d’oggi, runaway girl. Come Louise Bourgeois. Come Julia Kristeva. Tutte donne capaci di darsi un altro padre, un’altra patria. E di farsi un nome!
La nebulosa mistica si espande così in nebbia religiosa, e si aprono a ventaglio nel libro scottanti temi di attualità, tra cui sovrani i problemi del fanatismo e della fede: con Teresa sempre al centro, al crocevia di pensieri e concezioni di sé e del mondo che cambiano, che la vedono accanto a Montaigne, a Spinoza, a Cervantes. Teresa esponente sublime del Siglo de Oro. E ragazza d’oggi, runaway girl. Come Louise Bourgeois. Come Julia Kristeva. Tutte donne capaci di darsi un altro padre, un’altra patria. E di farsi un nome!In questo senso, Teresa mon amour è una "installazione" (p.577). E forse proprio tale termine meglio descrive questo strano libro troppo lungo, interessante quando si presenta come "una avventura nel cuore del credere" (p.565). Meno, quando riduce quell’avventura a una spiegazione della vita umana tutta - sia barocca sia contemporanea sia mistica sia mondana - in chiave di parafrasi attualizzante tradotta in termini psicoanalitici della vita medesima. A proposito della scrittura teresiana Kristeva parla di "una scrittura fuori genere, perché li mescola tutti" (p.311). Così fa lei qui; trasportata non dall’estasi, ma da una specie di hybris intellettuale che di certo non le manca, si fa una e trina: autrice, narratrice, protagonista del racconto, che è insieme una biografia, una autobiografia, un saggio, una fiction; alla fine, un monumento alla diva Julia.
Sul tema, in rete e nel sito, si cfr.:
- Ana De Mendoza, Principessa di Eboli: Santa Teresa in alta definizione
In principio era l’amore (charitas - non caritas!!!): pensare l’ "edipo completo"(Freud)
 INTERVISTA A JULIA KRISTEVA. Anche chi non crede in Dio, crede nell’amore e ciò mi pare oggi il più grande elemento di persistenza della nostra civiltà cristiana. Ma, detto questo, la studiosa ri-cade nelle braccia dell’autorità paterna (della versione cattolico-romana del cristianesimo ... ancora edipica)
INTERVISTA A JULIA KRISTEVA. Anche chi non crede in Dio, crede nell’amore e ciò mi pare oggi il più grande elemento di persistenza della nostra civiltà cristiana. Ma, detto questo, la studiosa ri-cade nelle braccia dell’autorità paterna (della versione cattolico-romana del cristianesimo ... ancora edipica)Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". - FILOSOFIA E BIOLOGIA: LA FINE DEL SESSO. I successi delle biotecnologie interrogano su una questione: declino e limiti di «rapporti naturali» e riproduzione sessuata (di Carlo Alberto Redi).5 agosto 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, E SOCIETA’..... *
Confini. L’elmento maschile, in una panoramica generale, si presenta in modo sporadico e occasionale, e dunque accessorio
La fine del sesso
I successi delle biotecnologie interrogano su una questione: declino e limiti di «rapporti naturali» e riproduzione sessuata
di Carlo Alberto Redi (Corriere della Sera, La Lettura, 05.08.2018)
Una delle domande trabocchetto negli esami del corso di laurea in Scienze biologiche è quella relativa alla definizione di sesso. Lo studente impreparato cade nell’errata semplificazione antropocentrica di definire il sesso come potrebbe fare la mitica casalinga di Voghera (Arbasino docet): l’insieme delle contrastanti e complementari caratteristiche (anatomiche, fisiologiche, psicologiche) che mostrano gli individui delle specie a riproduzione sessuata, dissertando poi di sesso genetico, cromosomico, gonadico e precisando tutti i caratteri apprezzabili, primari (ovaio e testicolo), secondari (peli, barba e mestruazioni), terziari (aspetti psicologici e di genere). La corretta definizione fa riferimento al processo della ricombinazione genetica dei caratteri ereditari: nella produzione dei gameti, uova e spermatozoi, la molecola di Dna viene tagliata e ricucita, mescolando i caratteri genetici e creando variabilità nell’assortimento degli stessi. Il grande vantaggio evolutivo della riproduzione sessuata consiste così nel creare un’alta variabilità genetica, sulla quale si esercita la selezione darwiniana; gli individui che hanno ereditato le associazioni di caratteri più favorevoli per l’ambiente in cui vivono sono in grado di accedere con maggiore successo alle risorse ambientali e quindi di riprodursi (fitness).
Due le grandi ipotesi che tentano di spiegare l’origine della riproduzione sessuata, la tangled bank e la «Regina rossa». La prima fa riferimento a Charles Darwin, che nell’ultimo paragrafo della sesta e ultima edizione dell’Origine delle specie, usa l’espressione tangled bank per descrivere l’ambiente come una «banca ingarbugliata», ricco di un enorme assortimento di tante e diverse creature tutte in competizione tra loro; creando alta variabilità genetica tra gli individui, la riproduzione sessuata assicura loro un vantaggio nella competizione per le risorse. La critica più ovvia è legata al fatto che i batteri presentano una scarsissima variabilità, pur essendo sul pianeta Terra da miliardi di anni.
Anche l’ipotesi della «Regina rossa» incontra difficoltà teoriche. La formula è di Leigh van Valen, che nel 1973 la riprese dal romanzo di Lewis Carroll Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, quando la «Regina rossa» spiega che «se si vuole andare da qualche altra parte, si deve correre almeno due volte più veloce».
 Fu William Donald Hamilton a esplicitare la metafora in lavori scientifici che sono veri capisaldi concettuali della teoria genetica dell’evoluzione del sesso (e dell’altruismo, della sociobiologia, in particolare per le relazioni preda/predatore e parassitato/parassita): gli individui delle varie popolazioni che compongono una specie debbono sempre «correre», evolvere in continuazione, per sopravvivere; in altre parole, la ricombinazione genetica (il sesso) assicura al parassitato di evolvere rapidamente caratteristiche capaci di difenderlo dall’attacco del parassita, ma... anche il parassita, grazie al sesso, è in grado di evolvere nuove combinazioni di caratteri tali da permettergli di parassitare di nuovo, così perpetuando in continuazione l’infinita rincorsa.
Fu William Donald Hamilton a esplicitare la metafora in lavori scientifici che sono veri capisaldi concettuali della teoria genetica dell’evoluzione del sesso (e dell’altruismo, della sociobiologia, in particolare per le relazioni preda/predatore e parassitato/parassita): gli individui delle varie popolazioni che compongono una specie debbono sempre «correre», evolvere in continuazione, per sopravvivere; in altre parole, la ricombinazione genetica (il sesso) assicura al parassitato di evolvere rapidamente caratteristiche capaci di difenderlo dall’attacco del parassita, ma... anche il parassita, grazie al sesso, è in grado di evolvere nuove combinazioni di caratteri tali da permettergli di parassitare di nuovo, così perpetuando in continuazione l’infinita rincorsa.La riproduzione asessuata è molto diffusa sia tra gli animali sia tra i vegetali; associata a un’alta capacità di rigenerazione dell’individuo, assicura la procreazione di cloni genetici. Si realizza per scissione binaria o per frammentazione e rigenerazione del corpo: chi tra i lettori non ha mai compiuto un’operazione di riproduzione asessuata di un vegetale strappando un pezzo di foglia, ramo, radice per riprodurlo, tramite talea rigenerativa, a casa propria? Negli animali è presente in moltissimi gruppi, dai Protozoi unicellulari ai Metazoi pluricellulari come i Poriferi (le spugne).
È materia del contendere se la riproduzione sessuata si sia originata da quella asessuata o viceversa. Oggigiorno si tende a preferire l’ipotesi che sia la riproduzione asessuata a essersi originata dalla primigenia sessuata (in molti libri di testo è ancora favorito il caso inverso), considerando il fatto che tutta la macchina enzimatica che assicura il taglia-e-cuci del Dna nel corso della ricombinazione genetica è essenzialmente quella impiegata nei meccanismi molecolari del taglia-e-cuci utili alla riparazione della doppia elica del Dna; questi erano già attivi nel mantenere l’integrità della molecola di acido nucleico dell’ultimo antenato universale comune di tutti gli esseri viventi (in sigla Luca, Last Universal Common Ancestor).
Comunque originato, il sesso è determinato da specifici geni che nel corso dell’evoluzione si sono raccolti su singoli cromosomi, i cromosomi sessuali X e Y (Mammiferi) oppure Z e W (Uccelli). Anche l’ambiente (temperatura, durata del periodo d’illuminazione giornaliera, densità di popolazione, risorse trofiche...) influenza la determinazione del sesso, come nelle tartarughe ove una temperatura superiore ai 30°C determina la nascita di femmine. Il sesso primario nell’uomo si stabilisce intorno alla quinta settimana di sviluppo, quando l’embrione indifferenziato sviluppa i testicoli con l’accensione del gene Sry (sul cromosoma Y) o l’ovario grazie al gene Wnt4 (sul cromosoma 1). Si intuisce chiaramente che un processo così altamente complesso possa alterarsi e produrre uno spettro di caratteristiche sessuali (intersessualità) che trascende rigide categorizzazioni. L’intersessualità non va confusa con l’ermafroditismo, ove un solo tipo di individui è portatore delle gonadi dei due sessi e produce sia uova sia spermatozoi (sebbene a fasi alterne e quindi gli ermafroditi debbono comunque accoppiarsi).
Un aspetto assai curioso e paradossale della riproduzione sessuata è che il sesso maschile, in una panoramica biologica generale, si presenta qui e là in modo sporadico e occasionale. Pur tralasciando la visione sociobiologica che assegna un «costo» al mantenimento dei maschi (costituiscono la metà della popolazione, non partecipano in modo significativo all’allevamento dei piccoli, non li generano direttamente), il sesso maschile risulta dunque un sesso accessorio e non obbligatoriamente presente, non indispensabile nell’accadere della riproduzione sessuata, che può essere tranquillamente portata a termine dalle sole femmine grazie alla partenogenesi, una modalità di riproduzione sessuata uniparentale.
- Senza fecondazione.
- La partenogenesi è una forma di procreazione portata a termine dalle sile femmine: è possibile anche provocarla artificialmente, con stimolazioni chimiche dell’oocita così da indurlo a riassorbire un globulo polare (un falso spermatozoo) er ricostruire l’integrità del genoma
La partenogenesi può produrre solo femmine oppure solo maschi o entrambi i sessi e può essere un modo obbligatorio di riproduzione oppure può comparire accidentalmente ed essere del tutto facoltativa; le varie modalità sono in relazione ai contesti di variazione delle condizioni ambientali e negli insetti stecco (Fasmidi) e negli Imenotteri sociali (api, vespe...) viene studiata in dettaglio. È possibile anche indurre la partenogenesi, artificialmente, con stimolazioni chimiche dell’oocita così da indurlo a riassorbire un piccolo globulo polare (un falso spermatozoo!) e ricostituire l’integrità del genoma.
L’intervento delle biotecnologie in ambito riproduttivo risale all’abate Lazzaro Spallanzani e al 1786, con la prima fecondazione artificiale realizzata nel cane (il clamore fu mondiale) per giungere alla nascita del primo baby in provetta (Louise Brown, nel 1978 ad opera del Nobel sir Robert Edwards). Se la fecondazione artificiale è pratica accettata, con gli attuali circa 400 mila bimbi che ogni anno nascono in provetta, di fatto la sessualità umana si interroga dinanzi alle attuali possibilità e pratiche di selezione del sesso con risvolti drammatici in alcune società orientali (Cina, India) ove è abitudine diffusa l’aborto delle femmine, al punto di aver prodotto un eccesso di maschi nella società degli adulti.
Di grande interesse l’analisi di questi problemi a livello internazionale realizzata dalla banca mondiale in relazione alle cause che li influenzano (guerre, migrazioni, politiche riproduttive). In che termini le biotecnologie riproduttive possano ridisegnare l’umanità e rendere obsoleto il sesso, permettendo di eliminare patologie e scegliere caratteristiche fisiche e mentali del nuovo individuo (il «bambino disegnato») è un fatto ancora tutto da sviluppare, poiché, mentre avanzano le conoscenze scientifiche, resta da decidere quale possa essere il limite delle loro applicazioni. Oggi da una semplice biopsia di cellule della pelle si possono ottenere, in vitro, cellule staminali pluripotenti e differenziarle in spermatozoi e uova; la gran parte dei benestanti potrà avere figli geneticamente propri in un ampio spettro di possibilità, inclusa la uniparentalità, grazie alla produzione di gameti artificiali e alla produzione incrociata di gameti (uova da maschi e spermatozoi da femmine). Tralasciando ectogenesi, per lo sviluppo dell’individuo al di fuori dell’utero, e clonazione, ancora proibita in ambito umano in tutte le legislazioni, già oggi la multigenitorialità è assicurata dalle pratiche di gestazione surrogata (utero in affitto) e la omogenitorialità dagli scambi di gameti.
È tempo che su questo quasi inevitabile futuro i decisori politici (in fatto di eguaglianza), i giurisperiti (per gli aspetti di responsabilità) e i filosofi (in relazione al post-umanesimo) diano il via alla discussione per capire se abbiamo già imboccato l’autostrada che porta alla fine del sesso con un totale investimento sociale sulla cura corpo, sui problemi della senescenza e sul godimento ormonale grazie al sesso virtuale. Tanta parte della filosofia è ancora attardata a riflettere sulle conquiste della fisica e non a sviluppare nuove visioni e pensieri su chi è oggi un individuo, sul destino del singolo, sulla genitorialità come progetto affettivo di legame sociale consapevole ed elettivo, non sessual-riproduttivo (quindi ascrittivo, non voluto), sulla costituzione del nucleo familiare, sul significato delle storie, dei miti e della psicoanalisi circa i «legami di sangue».
- L’errore di Freud
- Si prova smarrimento dinnanzi alla meravigliosa capacità delle donne di trasmettere la vita. La teoria dell’invidia del pene non regge, semmai esiste un’invidia del parto
Tutte queste opportunità legate allo svolgersi della sessualità interrogano sulla obsolescenza del sesso «naturale» e sui limiti della riproduzione sessuata, sulle possibili pratiche odierne di sesso assicurate dalla realtà virtuale: la sezione della mostra Human+. Il futuro della nostra specie (chiusa a Roma il 1º luglio al Palazzo delle esposizioni) dedicata a questo tema impressionava coloro che (come lo scrivente) ancora sono amanti di inviti e corteggiamenti. La psicologia evolutiva potrebbe aiutare a dipanare lo smarrimento e lo stupore che i maschi provano dinnanzi alla meravigliosa capacità femminile di generare, a capire la genesi dei meccanismi di costrizione del fisico femminile messi in atto storicamente dai maschi per controllare quel corpo generante: e se Sigmund Freud avesse preso una cantonata con la storia dell’invidia del pene da parte femminile? E se fosse invidia del maschio della capacità riproduttiva delle femmine? Altri aspetti, forse meno impegnativi, attendono di essere chiariti: esiste una base chimica per l’attrazione sessuale? La bellezza è davvero negli occhi di chi guarda o nelle ghiandole sudoripare delle femmine? Sono soprattutto le femmine selettive nella scelta sessuale?
La risposta a quest’ultima domanda è la più facile: sì, in tutte le specie a fecondazione interna, dalle mosche all’uomo, la femmina è ben più discriminativa dei maschi nella scelta del partner sessuale. Ne conseguono alcuni avvertimenti, soprattutto per i maschi più giovani: i fiori non si mandano mai prima, ma solo dopo aver vinto la mitica «battaglia dei sessi». Con alcuni corollari: se la corteggiata è una biologa fate attenzione, i fiori sono organi genitali. State regalando ovari e testicoli... prudenza!
Il «testo sacro»
De Beauvoir spezzò le catene delle donne
di Cristina Taglietti (Corriere della Sera, La Lettura, 05.08.2018)
Nel 2019 saranno passati 70 anni dalla pubblicazione de Il secondo sesso di Simone De Beauvoir (in basso). Il testo della scrittrice di cui quest’anno ricorrono i 110 anni dalla nascita è una poderosa riflessione spesso ridotta allo slogan «Donna non si nasce, lo si diventa» perché - scrive Simone de Beauvoir - «nessun destino biologico, psichico, economico definisce l’aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell’uomo; è l’insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna».
 Testo sacro del femminismo che un editto Vaticano nel 1956 mise nell’indice dei libri proibiti (in Italia lo pubblicò il Saggiatore nel 1961), Il secondo sesso è una riflessione filosofica che, a partire dalla dialettica hegeliana, applica l’esistenzialismo di Sartre ai temi dell’emancipazione femminile, sottraendo la donna a un destino biologico che la esclude dalla storia, ma anche all’interpretazione fallocentrica di Freud e a quella del materialismo storico che pone la categoria economica al di sopra di tutte le altre.
Testo sacro del femminismo che un editto Vaticano nel 1956 mise nell’indice dei libri proibiti (in Italia lo pubblicò il Saggiatore nel 1961), Il secondo sesso è una riflessione filosofica che, a partire dalla dialettica hegeliana, applica l’esistenzialismo di Sartre ai temi dell’emancipazione femminile, sottraendo la donna a un destino biologico che la esclude dalla storia, ma anche all’interpretazione fallocentrica di Freud e a quella del materialismo storico che pone la categoria economica al di sopra di tutte le altre.Il secondo sesso, libro dal forte impianto filosofico, letto da migliaia di donne, passa in rassegna i ruoli attribuiti dal pensiero maschile alla donna mettendoli in relazione con i miti ancestrali, i costumi, i tabù, la sessualità studiata in ogni fase della vita femminile, dall’infanzia all’iniziazione sessuale, dalla maturità alla vecchiaia.
Il settantesimo anniversario sarà ancora un’occasione di dibattito tra chi vorrebbe rinchiudere quel testo, insieme alla sua autrice, nel recinto dell’inattualità e chi ritiene che sia stato ingiustamente messo da parte. Di certo Il secondo sesso fu un libro rivoluzionario: oggi si può metterlo in discussione, non ignorarlo.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- VITRIOL. Walter Benjamin e le pietre dell’apocatastasi (di Raffaele K. Salinari).21 luglio 2018, di Federico La Sala
ALIAS
Walter Benjamin e le pietre dell’apocatastasi
Ultraoltre. La salvezza di tutti gli esseri attraverso il ritorno allo stato originario
- [Foto] Schema alchemico del V.I.T.R.I.O.L.
di Raffaele K. Salinari (il manifesto, 21.07.2018)
Ad un certo punto del folgorante saggio sull’opera di Nikolaj Leskov, Walter Benjamin ci introduce alla sua originalissima idea di apocatastasi: la salvezza universale attraverso il ritorno di tutti gli esseri alla pienezza originaria. Il sentiero che invita a percorrere da quel momento è, come spesso nel suo stile, notturno e sotterraneo: pieno di oscure analogie minerali e necriche metafore che però, alla fine, seguendo la mappa tracciata dal suo immaginario messianico, ci porteranno alla luce di una splendente verità.
Come guida naturale del tortuoso cammino, Benjamin staglia dai racconti di Leskov quella particolarissima figura che egli chiama «il giusto». Incarnazione complessa perché estremamente sfaccettata, maschera di volta in volta diversa - il buffone, lo scemo del villaggio, il viaggiatore, l’artigiano, il briccone - il giusto ha, però, un’essenza costante che si trasmette di personaggio in personaggio come in quelle Pathosformel che Warburg cercò di incasellare nel suo favoloso atlante Mnemosyne.
Per distillare questa essenza Benjamin parte da Bloch - che come lui aveva difficili rapporti con i francofortesi - citandone l’interpretazione del mito di Filemone e Bauci, nel quale si descrive la figura del giusto come colui, o colei, che portando con sé un tocco gentile, lo fa amico di tutte le cose. La madre di Leskov stesso ad esempio «che non poteva infliggere una sofferenza a nessuno, neppure agli animali. Non mangiava carne né pesce, tanta era la sua compassione per le creature viventi». Il giusto, conclude Benjamin, è allora il portavoce delle creature ed insieme la sua più alta incarnazione. E così vediamo che la sua essenza immutabile è quella di un essere «favolosamente scampato alla follia del mondo» e che, proprio mercé questa sua caratteristica, è in grado, attraverso i suoi racconti, di portare un annuncio di salvezza, di apocatastasi.
«Apocatastasi» è un termine dalle molteplici accezioni a seconda degli ambiti in cui viene usato. Letteralmente significa «ritorno allo stato originario», oppure «reintegrazione». Nella filosofia stoica, ad esempio, si collega alla «dottrina dell’eterno ritorno»: quando gli astri assumeranno la stessa posizione che avevano all’inizio dell’universo. Per il neoplatonismo, invece, l’apocatastasi è qualcosa di più spirituale, cioè il ritorno dei singoli enti all’unità originaria, all’Uno indifferenziato da cui l’intero insieme delle cose manifestate proviene; è ciò che gli gnostici chiamerebbero il Pleroma. Questa idea si inserisce appieno all’interno del tema, prettamente religioso, della Caduta: l’allontanamento dell’uomo dalla sua originaria comunione con l’Assoluto, col Divino, ma anche di un suo possibile ritorno alla pienezza edenica originaria. Nella teologia dei primi Padri della Chiesa il suo teorico è Origene.
Dice allora Benjamin: «Una parte importante, in questa dogmatica [della chiesa greco-ortodossa], è svolta, com’è noto, dalle teorie di Origene, respinte dalla chiesa romana, sull’apocatastasi: l’ingresso di tutte le anime in paradiso. Leskov era molto influenzato da Origene. Egli si proponeva di tradurre la sua opera Sulle cause prime. In armonia con la fede popolare russa, egli interpretava la resurrezione più che come una trasfigurazione, come la liberazione da un incantesimo, in senso affine a quello della favola». Benjamin, dunque, è qui teso a mettere in rilievo, anzi diremmo a dispiegare pienamente, non tanto il senso teologico, escatologico, del termine, quanto il suo potenziale immaginale, evocativo, metaforico, grazie al quale egli può farci vedere, nei personaggi della narrativa leskoviana, «l’apogeo della creatura» ed allo stesso tempo «un ponte fra il mondo terreno e ultraterreno», costruito attraverso l’atto creativo, poietico, del racconto.
Ma, per la nota verità metafisica secondo cui «ciò che è in alto è come ciò che è in basso», «il giusto» collega sia le vette, gettando un ponte tra il modo terreno e quello ultraterreno, sia le voragini nascoste nelle viscere della terra con ciò che avviene in superficie. «La gerarchia creaturale, che ha nel giusto la sua cima più alta, sprofonda in gradini successivi nell’abisso dell’inanimato. Dove bisogna tener presente un fatto particolare. Tutto questo mondo creaturale non si esprime tanto, per Leskov, nella voce umana, ma in quella che si potrebbe chiamare, col titolo di uno dei suoi racconti, la voce della natura». E dunque eccolo presentarci una di quelle intuizioni che collegheranno la figura del giusto, inteso come interprete della «voce della natura» e della salvezza, alle sue rappresentanze più elementari e sotterranee. «Quanto più Leskov discende lungo la scala della creature, tanto più chiaramente la sua concezione si avvicina a quella dei mistici». Ed a questo punto, con uno dei suoi scarti spettacolari, Benjamin passa a parlare del racconto di una pietra che racchiuderebbe una profezia: l’Alessandrite.
L’Alessandrite e la pulce di acciaio
Il racconto di Leskov citato da Benjamin, si intitola come la pietra che ne è protagonista. Narra di un tagliatore di pietre di nome Wenzel che ha raggiunto nel suo lavoro vette eccelse, paragonabili a quelle degli argentieri di Tule che ferrarono la famosa «pulce di acciaio» capitata nelle mani dello zar Nicola I. Qui una breve digressione è d’obbligo poiché questa pulce, questa «ninfosoria» come viene definita nel racconto, caricabile a molla e di grandezza naturale, pare esista davvero e sarebbe ammirabile nel Museo delle armi in città. Uno scrittore italiano contemporaneo dice di averla vista.
 Chi ama Tolstoj conosce Tule, dato che la sua famosa residenza, Jasnaja Poljana e la sua tomba, si trovano da quelle parti. La storia è semplice ma suggestiva: il fratello della zar Nicola I, Aleksàndr Pàvlovic, riceve in dono dagli «inghilesi» questo manufatto, una «ninfosoria» appunto, fatta di acciaio brunito che, mercé una piccola chiavetta inserita nella pancia, può essere caricata e dunque muoversi come una vera. Alla morte del fratello la pulce meccanica passa all’Imperatrice vedova Elisavéta Alekséevna che però, stretta nel suo lutto inconsolabile, decide di inoltrarla al nuovo sovrano. Il novello zar Nicolàj Pàvlovic in un primo tempo la trascura, per impellenti questioni di stato, poi si impunta e cerca di trovare il modo di eguagliare, o meglio, superare la bravura degli odiati «inghilesi». E dunque ordina ad un suo uomo di fiducia di raggiungere i famosi argentieri di Tule, rinomati per la loro maestria, e vedere cosa potessero fare per surclassare l’arte britannica. Dopo qualche tempo la ninfosoria di acciaio brunito torna a palazzo. In apparenza è immutata e lo zar si adira ma, ad una più attenta osservazione microscopica, ecco apparire il prodigio tecnologico: su ogni zampetta della pulce di acciaio è stato addirittura apposto come un ferro di cavallo e, su ognuno, è inciso il nome del mastro argentiere che l’ha forgiato!. L’orgoglio russo è salvo.
Chi ama Tolstoj conosce Tule, dato che la sua famosa residenza, Jasnaja Poljana e la sua tomba, si trovano da quelle parti. La storia è semplice ma suggestiva: il fratello della zar Nicola I, Aleksàndr Pàvlovic, riceve in dono dagli «inghilesi» questo manufatto, una «ninfosoria» appunto, fatta di acciaio brunito che, mercé una piccola chiavetta inserita nella pancia, può essere caricata e dunque muoversi come una vera. Alla morte del fratello la pulce meccanica passa all’Imperatrice vedova Elisavéta Alekséevna che però, stretta nel suo lutto inconsolabile, decide di inoltrarla al nuovo sovrano. Il novello zar Nicolàj Pàvlovic in un primo tempo la trascura, per impellenti questioni di stato, poi si impunta e cerca di trovare il modo di eguagliare, o meglio, superare la bravura degli odiati «inghilesi». E dunque ordina ad un suo uomo di fiducia di raggiungere i famosi argentieri di Tule, rinomati per la loro maestria, e vedere cosa potessero fare per surclassare l’arte britannica. Dopo qualche tempo la ninfosoria di acciaio brunito torna a palazzo. In apparenza è immutata e lo zar si adira ma, ad una più attenta osservazione microscopica, ecco apparire il prodigio tecnologico: su ogni zampetta della pulce di acciaio è stato addirittura apposto come un ferro di cavallo e, su ognuno, è inciso il nome del mastro argentiere che l’ha forgiato!. L’orgoglio russo è salvo.Alla stessa dinastia zarista è invece legata la vicenda, anche questa in bilico tra storia e leggenda, dell’Alessandrite. Qui si tratta della scoperta di una pietra singolare che prende il nome dal futuro zar Alessandro II, figlio di Nicola I. La pietra venne, infatti, cavata per la prima volta il giorno della sua nascita, nel 1818. Questo è lo zar dell’epoca in cui si svolge il romanzo Anna Karenina di Tolstoj, un periodo burrascoso e denso di avvenimenti storici rilevanti. Ecco che allora la caratteristica peculiare di questa pietra diviene una sorta di profezia sulla vita e la morte dell’omonimo sovrano. Essa, infatti, è verde alla luce del sole e rossa a quella artificiale. Il fenomeno è dovuto alle inclusioni di cromo, presenti anche nel corindone e nello smeraldo. Ora, nel racconto di Leskov, la casuale scoperta della pietra nel giorno natale del futuro zar, e le sue caratteristiche cromatiche, fanno intessere al narratore la profezia che la vuole metafora della vita di Alessandro II. Verde alla luce del mattino, dunque nella giovinezza e nella maturità dell’imperatore di tutte le Russie, essa diviene color sangue al calar delle tenebre, simboleggiando così la tragica fine che, effettivamente, subì il sovrano.
Il 13 marzo del 1881, infatti, lo Zar si disse disposto a prendere in considerazione le modalità dell’abolizione della servitù della gleba. Ma era già troppo tardi. Lo stesso giorno alcuni cospiratori guidati da Sofja Perovskaja misero in atto un astuto piano per eliminarlo. Alessandro II era già sfuggito più volte alla morte per attentato, ma quella volta il disegno riuscì. Mentre faceva ritorno al Palazzo d’Inverno, la sua carrozza fu colpita da una bomba lanciata da Nikolaj Rysakov, ma egli rimase illeso. Sceso per accertarsi dei danni fu investito dall’esplosione di una seconda bomba. Lo scoppio lo colpì ferendolo mortalmente. La profezia dell’Alessandrite si era avverata.
V.I.T.R.I.O.L.
Ma la poetica di questi elementi naturali, secondo la visione di Benjamin, emana ancor più potentemente da ciò che rimane nella profondità della terra, dando loro addirittura il potere di ricombinare il destino dei vivi con quello dei morti, di salvare eternamente e al tempo stesso gli uni e gli altri. E d’altronde il pensiero dell’eternità non ha sempre avuto la sua fonte principale nella morte? Per attivare questa operazione favolosa egli utilizza allora come Prima Materia del suo athanor immaginale uno degli autori preferiti l’«indimenticabile Johann Peter Hebel». «La morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare» afferma icasticamente e aggiunge, «dalla morte egli attinge la sua autorità. O, in altre parole, è la storia naturale in cui si situano le sue storie». La morte dunque è l’origine del racconto, la matrice della sua eternità. Come non vedere in questa affermazione la sanzione dell’opera al nero, primo gradino del processo alchemico?
Per Benjamin allora la pietra filosofale, cioè l’incanto salvifico della narrazione, la sua funzione come strumento di una vera e propria apocatastasi, nasce nel crogiolo della storia naturale formandosi da un compost affatto speciale. Ecco l’atmosfera nella quale ci vengono presentati i due grandi protagonisti del racconto di Hebel Insperato incontro: il tempo che dissolve i corpi, ed il suo comprimario che qui, paradossalmente, li coagula, il vetriolo.
La parola vetriolo, dal latino vetriolum, compare per la prima volta intorno al VII-VIII secolo d.C., e deriva dal classico vitreolus. Con questa radice etimologica possiamo pensare che il nome trovi origine dall’aspetto vetroso assunto dai solfati di rame e di ferro cristallizzati. Per quelli di rame è di colore azzurro intenso (per questo detto anche vetriolo azzurro o di Cipro o di Venere, la dea portata verso l’isola dalle azzurre onde del mare, ma anche il pianeta di riferimento del rame) mentre nel solfato di ferro è di colore verde azzurro (vetriolo verde o marziale, perché Marte è il pianeta di riferimento del ferro). Sarà quest’ultimo, lo vedremo tra poco, il vetriolo protagonista del racconto.
Sia il vetriolo di rame che il vetriolo di ferro erano conosciuti ed utilizzati dagli Egizi e dai Greci, anche se non sotto questo nome. Forse il famoso natron, che serviva ad imbalsamare i corpi, ne conteneva una certa quantità. L’immancabile Plinio il Vecchio, nella sua Historia Naturalis, menziona una sostanza che chiama «vetriolo« e ne descrive l’estrazione «dalle acque ramifere». Questo nome comprende, e confonde, in realtà, una vera e propria famiglia di composti. Ecco allora che bisogna chiamare in causa anche l’alchimia poiché esso, chiamato vetriolo filosofico, indica nulla di meno che il Solvente Universale, e cioè tutti quei composti chimici che consentono di avviare la procedura condensata nella nota formula «solve et coagula». Per questo le sue origini si perdono nella notte dei tempi, essendo indicato come tale, ma anche con tantissimi altri nomi, in tutti i trattati di Arte Regia. La prima sintesi del vetriolo come Solvente Universale, cioè come acido solforico, la si deve all’alchimista islamico Ibn Zakariya al-Razi che lo ottenne per distillazione a secco di minerali contenenti ferro e rame.
Per completezza simbolica bisogna citare anche l’acronimo, V.I.T.R.I.O.L., che compare nell’opera Azoth del 1613 dell’alchimista Basilio Valentino. Il suo svolgimento è: «Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem», cioè «Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta». La frase simboleggia la discesa all’interno dell’essere per operare con rettitudine alla ricerca del proprio gioiello interiore.
E allora concludiamo la parabola dell’apocatastasi benjaminiana, con il bel racconto di Hebel di cui il vetriolo marziale è protagonista. Siamo a Falun, in Svezia, presso le miniere di ferro. Due giovani sono innamorati e presto si sposeranno. Lui però è un minatore ed un giorno non torna più: la miniera è crollata. Passano gli anni e la fidanzata gli rimane fedele. Dopo decenni, in cui il tempo lavora sulla materia vivente, ecco che dalla vecchia miniera riemerge il corpo del minatore: è intatto poiché il vetriolo lo ha imbalsamato nel momento della giovinezza. Mentre lo seppellisce esclama: «Dormi in pace adesso, un giorno ancora o forse dieci, in questo fresco letto nuziale, e non ti sembri lungo il tempo. Mi restano soltanto poche cose da fare, e presto verrò, presto sarà di nuovo giorno. Ciò che la terra ha già una volta reso, una seconda non lo tratterrà». Tutto è giusto e perfetto.
-
> "PERVERSIONI" -- La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica (Giovanni Orsina). Rec. di Sergio Benvenuto.6 giugno 2018, di Federico La Sala
Narcisismo e democrazia
di Sergio Benvenuto (Doppiozero, 06 giugno 2018)
Il libro di Giovanni Orsina, La democrazia del narcisismo. Breve storia dell’antipolitica (Marsilio) si inserisce in un filone di studi che chiamerei, parafrasando Gibbon: Declino e (possibile) Caduta della Democrazia. Insomma, Orsina tematizza uno dei maggiori problemi della nostra epoca: la crisi della democrazia pluralista e liberale.
Una crisi che non a tutti appare evidente. Perché è vero che 25 paesi negli ultimi 18 anni sono retrocessi, per dir così, dalla democrazia al dispotismo - compresi Russia, Turchia e Venezuela - ma in Occidente la democrazia può sembrare ben salda. In effetti, le tre grandi catastrofi degli ultimi due anni - Brexit, elezione di Trump, vincita dei partiti anti-politica in Italia - si sono prodotte rispettando in tutto i meccanismi democratici. Non è un caso, però, che molti commentatori, anche in Italia, abbiano deprecato la decisione di Cameron di indire un referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Europa: “non è materia su cui ha da decidere il popolo”, hanno detto. -Insomma, molti democratici cominciano ad aver seriamente paura della democrazia. E ne hanno le ragioni, perché sappiamo che talvolta le democrazie uccidono democraticamente se stesse: fu questo il caso del fascismo italiano nel 1923, del nazismo in Germania nel 1933, delle elezioni algerine del 1991, e più di recente delle elezioni russe (Putin), turche (Erdogan) e venezuelane (Maduro). Il presupposto di onniscienza politica della democrazia è smentito storicamente. Un popolo può liberamente decidere di rovinarsi, come accade a certi individui, che decidono liberamente di rovinarsi; ne conosciamo tanti.
Ma per Orsina come per altri (incluso il sottoscritto) il sintomo della crisi della democrazia in Occidente è l’avanzare dei cosiddetti partiti populisti, ovvero “anti-politici”. Partiti o movimenti ossimorici, perché attaccano il potere politico proponendo se stessi come potere politico. Ma il merito di Orsina è di situare questo retreat della liberal-democrazia non come evento nuovo, congiunturale, ma come il manifestarsi di una contraddizione fondamentale nel genoma stesso della democrazia. Così, Orsina si appella all’analisi, così ambivalente, di Tocqueville della democrazia americana nell’800.
 Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.
Potremmo dire che questo filone di studi cerca di fare nei confronti della democrazia quel che Karl Marx fece nei confronti del capitalismo. Per Marx il capitalismo non sarebbe caduto per la rivolta indignata delle classi oppresse, ma per un’implosione interna, per il venire al pettine dei nodi di una contraddizione fondamentale del capitalismo stesso. Analogamente, la democrazia comporta una contraddizione fondamentale che sta per venire al pettine. Siccome la profezia marxiana del crollo del capitalismo non si è (finora) verificata, c’è solo da augurarsi che, analogamente, il crollo della democrazia non si verifichi. Ce lo auguriamo perché dopo tutto pensiamo come Churchill, che la democrazia è il peggiore dei sistemi politici, a esclusione di tutti gli altri.Va detto che Orsina, professore di Storia contemporanea alla LUISS, non si rifà tanto a sociologi e politologi accademici, quanto piuttosto a testi e ad autori del mondo filosofico e poetico: a La rivolta delle masse di José Ortega y Gasset, a Nelle ombre del domani di Johan Huizinga, a Massa e potere di Elias Canetti, a Montale, a Marcel Gauchet. È tra quelli che pensano che non bastino fatti e statistiche per capire il mondo in cui viviamo: occorrono anche le intuizioni, le folgorazioni intellettuali, di scrittori e filosofi.
Del resto, sin dal titolo - che riecheggia il bestseller anni 70 La cultura del narcisismo di Christopher Lasch - Orsina usa un concetto non ‘sociologico’, quello di narcisismo. Concetto freudiano più che mai, anche se l’autore non cita Freud ma i sociologi e i pensatori che, oltre Lasch, hanno sdoganato il concetto di narcisismo nella cittadella sociologica (Tom Wolfe, Richard Sennett, Gilles Lipovetski).
 Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.
Ora, per narcisismo Orsina non intende egoismo e nemmeno individualismo. Quest’ultimo, diceva Tocqueville, “è un sentimento ponderato e tranquillo”, è il valutare oculatamente i costi e benefici, e difatti tutte le teorie liberali si basano sull’individuo come homo rationalis, come buon calcolatore dei propri personali vantaggi. Il narcisista invece è una personalità fondamentalmente irrazionale (ho cercato di descrivere il narcisismo secondo Freud qui). Non è tranquillo, anzi, tende all’ira e alla protesta perenne, divorato da una frustrazione che lo assilla. In modo stringato, possiamo dire che il narcisista è chi si crede. Chi crede solo nella propria opinione, e che crede soprattutto nei propri desideri. Ma siccome nella vita sociale ci sarà sempre qualcuno al di sopra di lui, sentirà conficcate nella sua pelle “le spine del comando” (dice Orsina citando Canetti) ogni volta che ubbidirà a qualche ordine, e tutte queste spine costituiranno “un duro cristallo di rancore”. Perciò le democrazie sono caratterizzate da un cumulo di rabbia contro chi “comanda”, come ha visto il filosofo Peter Sloterdijk in Ira e tempo, dove parla di partiti e movimenti politici come “banche dell’ira”.In effetti la democrazia non è solo un sistema per scegliere chi deve governare, essa si basa su una Promessa fondamentale, implicita o esplicita che sia: l’auto-determinazione di ciascun uomo e di ciascuna donna. Ovvero, non c’è alcun criterio che trascenda la volontà di ciascuno, sia esso la religione, la patria, il re, la classe sociale... “Il popolo è sovrano”, quindi ciascuno si sente sovrano nel pensare e nell’odiare. Ormai contano le opinioni dei singoli, ovvero la loro somma, non l’autorevolezza delle opinioni: se un’opinione è diffusa, diventa ipso facto autorevole. Se un libro si vende bene, allora è un capolavoro. Se un leader cialtrone prende una barca di voti, diventa ipso facto un grande uomo politico. Da qui l’esplosione dei sondaggi d’opinione: essi servono non solo a sapere quel che la gente pensa, ma a stabilire, appunto, che cosa vale e che cosa no. Ora, ciascuno è convinto che la propria opinione sia quella giusta, anche se in realtà non sa nulla di ciò di cui ha un’opinione. In democrazia, dicevano gli antichi greci, prevale la doxa, l’opinione, non l’epistheme (il sapere). Dico qui a parole mie quel che mi sembra il succo del libro di Orsina.
Decenni fa le persone semplici, non colte, mi chiedevano spesso “Professore, ma per chi devo votare?” Non rispondevo, ligio all’ideale democratico per cui il “professore” non deve esercitare un’autorità intimidente sull’elettore. Oggi invece le persone senza cultura non sanno che farsene non solo delle mie idee politiche, ma di quelle di tutti i professori. Del resto, per ogni opinione, per quanto becera, si riesce a trovare sempre qualche “esperto” che la puntelli o la legittimi. Si scoprono “specialisti” i quali dicono che vaccinare i bambini fa male, per esempio, quando si spande il rumor secondo cui vaccinare fa male. Il narcisismo è insomma l’arroganza dei propri desideri e delle proprie opinioni; non conta più il percorso - di studio, riflessione, informazione, confronto con esperti - che porta ad avere un’opinione che pesi.
Così, scrive Michel Crozier (citato da Orsina):
- I cittadini avanzano richieste incompatibili fra di loro. Insistono perché i loro problemi siano affrontati in maniera più efficace, e perciò chiedono più controllo sociale. Allo stesso tempo, si oppongono a qualsiasi forma di controllo sociale si associ ai valori gerarchici che hanno imparato a scartare e rigettare.
- Emerge qui la contraddizione fondamentale della democrazia, grazie al narcisismo che essa genera: ci si aspetta che loro (i politici) risolvano i problemi, ma per risolverli costoro devono esercitare un’autorità, devono infliggere “le spine del comando” e limitare l’autodeterminazione su cui la democrazia si fonda, eppure questa limitazione è costantemente rigettata. Scrive Orsina:
- Cacciati dalla porta, i vincoli della piena autodeterminazione soggettiva rientrano dalla finestra. È vero che il narcisista non è più tenuto a osservare alcun codice etico, ma deve comunque sottostare alle regole che disciplinano la convivenza civile. È vero che nessuno può più imporgli dall’esterno alcun obiettivo esistenziale, ma è soltanto dall’esterno che possono venire la stima altrui e il successo sociale dei quali ha disperato bisogno - anche perché osserva con invidia i molti che, attorno a lui, riescono a raccoglierli (p. 60).
Insomma, il principio di autodeterminazione di ciascuno porta a un indebolimento progressivo della politica. Da qui il crescente discredito dei politici: essi fanno da capro espiatorio di questa contraddizione fondamentale. Vengono applauditi solo i politici che si dichiarano anti-politici... Il narcisista moderno esige dalla politica che risolva i propri problemi, ma siccome la politica deve cercare di risolvere anche i problemi degli altri, qualunque cosa un politico farà sarà sempre insoddisfacente. Ogni misura politica pesta sempre i piedi a qualcuno. Ogniqualvolta un politico agirà politicamente, tenendo conto quindi dei vari interessi tra loro spesso contrapposti, sarà sempre considerato fallimentare, anzi un corrotto.
Si prenda il caso esemplare della lotta all’evasione fiscale: questa dovrebbe essere popolare perché permette allo stato di avere più fondi per i servizi pubblici, per il sistema sanitario..., ma essa comporta una decurtazione del reddito di chi prima evadeva. Solo questa decurtazione viene vista, e biasimata.
Il paradosso è che la credibilità dei politici si abbassa sempre più man mano che essi si convertono alla demagogia, diventando “cantastorie” come dice Orsina, ovvero aizzano richieste specifiche anche se irrealistiche al fine di guadagnare voti e potere. Sempre più abdicano a una funzione che i politici di vecchio stampo esercitavano: quella di presentare agli elettori anche gli oneri che un sistema politico-economico esige, i vincoli che vengono dall’economia, dal sistema internazionale delle alleanze. Oggi i politici promettono sempre di più a tutti, non mettono mai gli elettori di fronte alla complessità e alla durezza dei problemi sociali. Ma la demagogia dà un vantaggio effimero: prima o poi, l’elettore capisce che le promesse non vengono mantenute. E si volgerà a un altro demagogo...
Si è denunciato il fatto che il nuovo governo della Lega e del M5S in Italia si basi su due progetti praticamente contraddittori: da una parte la flat tax, che di fatto regala soldi ai più ricchi; dall’altra il reddito di cittadinanza, che dovrebbe andare ai più poveri. Ma se lo stato rinuncia a una parte cospicua delle tasse, gli sarà impossibile dare un reddito a chi non lavora.
 Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).
Il fatto che questi due progetti abbiano trovato una sorta di affinità elettiva è un’allegoria della contraddizione della democrazia narcisista: dallo stato, ovvero dalla politica, si chiede che da una parte esso dia sempre più, ma dall’altra gli si vuole dare sempre meno. Esigo che lo stato spenda sempre più per me, ma mi rifiuto sempre più di dargli questi soldi da spendere. Il segreto dell’esplosione del debito pubblico in Italia, che ha raggiunto il 130% del PIL nazionale, è tutto qui (esso è il frutto di decenni di politiche che hanno comprato consenso di massa indebitando però i nostri figli fino al collo).Da qui il paradosso: lo stato italiano è fortemente indebitato, mentre i patrimoni e i risparmi personali sono altissimi. In Italia abbiamo uno stato quasi alla bancarotta, e una ricchezza privata cospicua.
Come nota Orsina, i pericoli della democrazia del narcisismo hanno portato gli stati, nel corso degli ultimi decenni, a sottrarre spazi al controllo democratico (cosa che viene denunciata dai populisti). Le banche centrali si sono autonomizzate sempre più dal potere politico, difendono la moneta del paese senza subire le pressioni dei governi, i quali esprimono le esigenze confuse di chi li ha eletti. Orsina legge il distacco crescente della magistratura dal potere politico come un altro segno di questa secessione di parti dello stato dal controllo democratico (sempre più, in quasi tutti i paesi, i magistrati fanno la loro politica; come abbiamo visto in Brasile oggi con Lula, la magistratura può opporsi fermamente alla volontà popolare). Egli nota, ad esempio, che tra il 1969 e il 1976 la quota di budget federale americano sul quale la politica conservava un controllo discrezionale si è dimezzato, scendendo dal 50 al 24%. Le istituzioni europee, di fatto, tolgono spazi all’autodeterminazione dei singoli paesi, imponendo a ciascuno parametri entro cui operare. Va detto che questo controllo della tecnocrazia europea sui destini nazionali non ha funzionato sempre. Non ha impedito il crack della Grecia nel 2016 né l’esplosione del debito pubblico italiano e portoghese fino a oggi.
Molti denunciano questo crescente potere tecnocratico e rivendicano più democrazia, ma non si rendono conto del fatto che la secessione di molte funzioni dalla “politica” - banche centrali, magistratura, FMI, WTO, ecc. - è proprio un ammortizzatore della democrazia frutto della democrazia stessa: rispetto all’autodeterminazione di tutti contro tutti, le istituzioni non elette, “tecniche”, pongono dei paletti fondamentali che impediscano le derive. Così, le costrizioni esterne imposte dai trattati internazionali, che il narcisista delle democrazie rigetta rivendicando la propria autodeterminazione nazionale (o regionale), rientrano.
“Il basso continuo” (è l’espressione di Orsina) dei populismi, rivendicando la propria sovranità nazionale di contro ai vincoli che pone a una nazione il tessuto europeo (o, per gli Stati Uniti, il NAFTA e altri trattati internazionali), titilla il desiderio di autodeterminazione di ciascuno. Si dice “Se noi italiani potessimo decidere tutto quello che vogliamo, senza tener conto dell’Europa, saremmo più liberi...” Si tratta ovviamente di un’illusione, perché rinunciare ai vincoli volontari non evita affatto i vincoli involontari, quelli imposti dai mercati internazionali, ad esempio. Rinunciare ai vincoli con altri stati ci mette in balia di forze economiche e politiche internazionali per noi ancor più incontrollabili.
Vent’anni fa ci fu una forte reazione alla globalizzazione “da sinistra”. Ma la sinistra, soprattutto marxista, è globalista per vocazione. Il vero grande attacco alla globalizzazione - di cui Trump e la Brexit sono gli episodi più salienti - viene però oggi da destra, o dai “populismi”. Dilaga la tendenza a negare l’evidenza di un mondo globalmente interconnesso, tornando alle vecchie identità, nazionali o regionali.
Ora, questa esigenza di autodeterminazione va sempre più spezzettandosi: ogni regione potrà pensare che sia meglio decidere da sola, senza avere i lacci nazionali che la legano ad altre regioni, magari più povere, ecc.
Lo abbiamo visto con la Lega Nord, prima che svoltasse verso un nazionalismo neo-fascista. Accade così che da una parte la Gran Bretagna decide di separarsi dall’Europa, ma dall’altra questo spingerà scozzesi e nord-irlandesi a volersi separare a loro volta dalla Gran Bretagna, ecc. ecc. Alla fine di questo processo ricorsivo di separazioni, nel quale ci si illuderà di diventare sempre più liberi... c’è solo l’individuo solo, narcisista. Che non vuole legami né costrizioni. Ma non si può vivere da soli. A meno di non fare come il protagonista del film Into the Wild di Sean Penn: se ne va a vivere completamente isolato, autarchico, sovrano, in Alaska, per morirvi. Anche la prospettiva delle nostre società potrebbe essere la morte, quella della democrazia.
Questo di Orsina è un libro che evade dal recinto di molto dibattito politico di oggi, diviso tra neo-marxisti, neo-liberisti e neo-populisti. Un dibattito ormai stereotipato, dove già si sa prima che cosa ciascuno dirà.
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO -- Le cinque passioni del ’68: liberalismo libertario, dionisismo, spettacolarismo, fraternismo, dadaismo (di Sergio Benvenuto).31 maggio 2018, di Federico La Sala
Le cinque passioni del ’68
di Sergio Benvenuto *
Nel 1968 compii vent’anni. Ero da un anno studente alla Sorbona di Parigi, e quindi potetti partecipare al maggio 68 - da ossimorico militante individualista, non ero organico ad alcuna organizzazione politica. Ho ripercorso la mia esperienza all’epoca in un libro appena uscito, Godere senza limiti (Mimesis). Allora mi consideravo un comunista trotzkista, quindi in opposizione ai partiti comunisti pro-Unione Sovietica, il partito comunista italiano di Berlinguer e il partito comunista francese di Marchais. In quegli anni ho viaggiato molto tra Italia, Francia e Inghilterra, per cui ho potuto confrontare de visu i diversi “68”.
Che cosa è stato allora, il 68 francese? Lo chiamo francese, ma è evidente che quello italiano aveva molte affinità con esso. Rispondo che esso può essere capito in riferimento a cinque passioni: liberalismo libertario, dionisismo, spettacolarismo, fraternismo, dadaismo.
Le illustrerò brevemente.
Liberalismo libertario
All’epoca la cultura dominante tra gli intellettuali sia in Italia che in Francia era comunista marxista. Era la cultura che avevamo ereditato dai nostri nonni, padri o amati professori. Eppure proprio nel maggio 68 ricomparve alla grande il movimento libertario, di cui prima nessuno sentiva quasi più parlare. I boulevard parigini si riempirono di foreste di bandiere rosse-e-nere, ovvero mezzo comuniste mezzo anarchiche. Daniel Cohn-Bendit, il simbolo del 68 francese, era anarchico confesso, quindi detestato dai “bolscevichi”. Ora, per l’anarchismo il nemico principale non è il capitalismo ma lo Stato, e ogni forma di gerarchia. Decisamente, lo stato francese, forte e centralizzatore, era allora più antipatico del capitalismo (che peraltro, all’epoca, era spesso capitalismo di stato). Il vero nemico appariva lo stato forte, poliziesco, gaullista o giacobino, CIA o regime sovietico.
Ma la ripulsa dello stato non è solo fisiognomico dell’anarchismo: anche del liberalismo. Il libertarismo è una forma radicale di liberalismo. Non a caso, l’anarchismo negli Stati Uniti viene percepito come un estremismo di destra, e non di sinistra come in Europa. La hybris del 68 - rispetto alla tradizione socialista e comunista, o cattolica, dei nostri seniors - fu l’irrompere di questa voglia di libertà. Insomma, fu un nostro modo obliquo di convertirci al liberalismo, senza darlo a vedere a noi stessi. Da qui il successo dello slogan “è vietato vietare”.
Anna Maria Ortese disse, in Il mare non bagna Napoli, che il marxismo degli intellettuali napoletani nel primo Dopoguerra era un liberalismo di emergenza. Il marxismo degli anni attorno al 68 fu un liberalismo d’impazienza. Spazientiti dalla lentezza di quella modernizzazione che pur stavamo vivendo.
Il 68 - che di fatto è proseguito in tante società occidentali e in Giappone fino alla fine degli anni 70 - ricorda le notti bianche nelle estati dei paesi nordici. E’ difficile dire, a un certo punto, se le luci lattiginose che vediamo sono quelle del tramonto o quelle dell’alba. Nel 68 lungo si è sovrapposta una cultura che stava tramontando a una cultura che invece andava verso il mezzogiorno. La cultura al tramonto erano i paradigmi marxisti, e non ci rendevamo conto del fatto che era il liberalismo libertario (quello incarnato da Pannella e Bonino da noi) quello che stava prendendo luce. Eravamo molto più liberals di quanto non volessimo ammettere. Io non ho mai avuto cotte maoiste, ma persino i compagni “cinesi” all’epoca leggevano la Rivoluzione culturale allora in pieno corso in Cina in un’ottica infondo liberale: appariva loro la rivolta dei giovani cinesi contro un apparato comunista dispotico, anchilosato e burocratizzato. La Rivoluzione culturale ovviamente è stata cosa molto più complessa, intrisa com’era di aspetti che oggi chiameremmo populisti. Ma era attraverso una lente anarchica che molti - non io - la ammiravano.
E poi all’epoca fiorirono i movimenti anti-autoritari, che hanno generato il movimento femminista e quello degli omosessuali, rampolli del 68. Noi “extra-parlamentari” - in Francia ci chiamavano gauchistes - odiavamo come simmetrici il capitalismo occidentale e i “socialismi reali”. Con gli anni, a molti di noi i socialismi reali apparvero più odiosi del capitalismo occidentale, e così, verso la fine degli anni 70, molti di noi si convertirono al liberalismo. I nouveaux philosophes. Diventarono ciò che in fondo erano sempre stati.
Dionisismo
Il vero patron spirituale del 68 non è stato Marcuse né Che Guevara né Mao, ma Friedrich Nietzsche, anche se pochi tra noi lo avevano letto. Dal pensatore tedesco veniva un’idea fondamentale, forte soprattutto in Francia: che alle forme apollinee della vita che chiamavamo allora “borghese” dovevamo contrapporre una spensierata vitalità dionisiaca. Avevamo voglia di pura dépense, di spreco (Georges Bataille). E non a caso gran parte delle filosofie che chiamerei sessantottesche - di Deleuze, Guattari, Foucault, Baudrillard, Lyotard, Vattimo, Badiou, ecc. - trovarono il loro riferimento fondamentale in Nietzsche.
Le avanguardie artistiche che allora sembravano divenute popolari erano illuminate dalla figura eccessiva, tragica, debordante di Antonin Artaud, poeta psicotico. I nostri idoli estetici all’epoca erano due autori in fondo opposti: Artaud e Brecht. Da una parte l’irrazionalissimo teatro della crudeltà artaudiano, dall’altra il razionale teatro epico brechtiano. Come combinare l’inumano dionisismo di Artaud e l’umana compassione riflessiva di Brecht? Non solo il teatro, ma anche il cinema, la letteratura, l’arte, all’epoca cercarono di amalgamare due poli che allo stesso tempo ci definivano e ci dilaniavano (ma infondo ogni epoca, ogni cultura, non è veramente, intimamente definita da ciò che la dilania?).
Da dionisiaci artaudiani, non potevamo avere limiti morali. All’epoca, già gli intellettuali approfittavano della differenza tra latino e greco per opporre morale a etica. I due termini vengono da due parole che significano costume, modo di vivere; ma mentre il termine di origine latina, morale, era la cosa spregevole da denunciare, quello di origine greca, etica, era la cosa da esaltare. “La morale” era l’etica che si rigettava, ovvero quella degli altri - “il moralismo”, in particolare la morale sessuale repressiva e le ipocrisie sociali. Ci pensavamo amoralmente etici.
Il dionisismo è l’esito sacrale di un’estrema secolarizzazione: l’ateismo, portato fino in fondo, ritrova la divinità di Dioniso. La differenza, allora, tra la secolarizzazione liberal-capitalista e la nostra era tutta qui: è che la prima non dava alcuno spazio al sacro, solo interesse privato e danaro; mentre noi pensavamo alla vita in termini sacrali. Anche se il sacro a cui guardavamo era quello dei Tarahumara del Messico o del buddismo zen, non quello del papa o dei pastori protestanti. Il nostro rigetto di ogni religione istituzionale, “occidentale maschile bianca”, esponeva una dimensione mistica di cui sentivamo il morso pur senza vederne la forma. La Rivoluzione era la nostra divinità apocalittica, il nostro mantra.
Spettacolarismo
L’emulazione fu un fattore fondamentale del 68. Prima del maggio 68, seguivo con invidia le gesta degli studenti tedeschi, italiani, americani che, già nell’inverno 68, avevano attratto l’attenzione dei media per le loro vistose agitazioni. Parigi si mosse in ritardo - si disse: per scimmiottare gli studenti italiani e tedeschi.
Le prime due settimane il maggio fu solo studentesco. Venne in delegazione alla Sorbona occupata un gruppo di operai. Nell’aula magna, uno di loro disse: “Prima d’ora, gli operai pensavano che gli studenti fossero ragazzi viziati che passavano il tempo a ballare e a bere whisky. Ora hanno capito che anche voi sapete battervi.” E aggiunse: “Oggi tutti i giornali, le televisioni, parlano di voi. Ma ricordatevi che la spina dorsale del sistema siamo noi, operai. E quando ci muoveremo noi...” Difatti si mossero, e la rivolta studentesca passò in secondo piano. Ma quel che fece muovere gli operai di alcune grandi industrie - come poi, in Italia, nell’”autunno caldo” del 1969 - fu una sorta di emulazione fraterna degli studenti che già all’epoca stava assumendo le forme dell’esposizione mediatica: “le prime pagine dei giornali saranno occupate dalle nostre manifestazioni?”
In Italia avevo esperienza di volantinaggio sotto alle fabbriche, nella città dove abitavo, Napoli. Nel Dopoguerra si decise di trasformare l’indolente regione napoletana in un polo industriale, così il golfo di Pozzuoli fu deturpato da una lunga serie di officine una più puzzolente dell’altra. Con i miei compagni trotzkisti andavo sotto l’acciaieria Italsider a vendere il nostro giornaletto, all’ora dell’uscita del turno. In quei grigi pomeriggi, i lavoratori avevano un’aria poco rivoluzionaria: stanchi, lenti, sembravano non pensare ad altro che a tornarsene a casa a guardare la televisione aspettando la cena. Un mio compagno, un intellettuale come noi che cercava di vendere la Rivoluzione alla classe rivoluzionaria, mi disse: “Mi sembra che gli operai ne abbiano le palle piene di essere così al centro della Storia!” Col 68 invece sembrò che gli operai si decidessero a giocare il gioco che ci si aspettava da loro: non solo essere (intrinsecamente) proletariato rivoluzionario, ma sembrarlo (estrinsecamente) anche. Comunque, la vivacità operaia, in Italia e in altri paesi, non è spiegabile senza l’emulazione dell’agitazione giovanile e studentesca dell’epoca.
Sul piano politico ed economico il 68 francese ha prodotto effetti irrilevanti o nulli. I gaullisti uscirono rafforzati dal 68 - bisogna aspettare ben altri tredici anni perché la sinistra con Mitterrand vada al potere. I vistosi aumenti salariali strappati con i grandi scioperi del maggio dopo un anno erano già del tutto annullati dall’inflazione. In Italia, il predominio della Democrazia Cristiana - e dell’alleanza di centro-sinistra di cui essa era il perno - è durato fino al 1992. Gran Bretagna e Germania ebbero governi di sinistra negli anni 70, ma sfociarono nel trionfo di Thatcher e di Kohl. In fondo, il solo 68 politicamente riuscito fu quello americano: l’opposizione alla guerra del Vietnam contribuì molto alla resa americana in quell’area. A partire dagli anni 80 il mondo occidentale sembra aver voltato le spalle alle proposte marxiste e anarchiche. Eppure...
Questo mondo globalizzato che alcuni detestano non è anche figlio di quel movimento di questi “alcuni”? In effetti, dal 68 in poi si è affermata in modo spettacolare quel che il situazionista Guy Debord chiamò la società dello spettacolo. Certo quel marxista ne parlava per stigmatizzarla, ma proprio mettendo l’accento sulla spettacolarità Debord è, in qualche modo, la figura teorica più rappresentativa di quell’epoca. Il maggio 68, malgrado tutto, segnò l’affermazione nuova, inedita, vincente, della società dello spettacolo. Il 68 è importante soprattutto per i suoi effetti “culturali”, ovvero per la formazione del nostro attuale sentirci-al-mondo. Non a caso molti degli autori che si affermarono in quell’epoca si occupavano di media e di cultura popolare: McLuhan, Barthes, Eco...
La svolta fu questa: “quel che conta è che si parli di noi”.
La Storia ha una faccia nascosta (processi economici, intrighi diplomatici, ecc., su cui poco o nulla si può) e una faccia invece spettacolare, mediatica, alla quale possiamo credere di poter partecipare. Alcuni dicono che l’evento più importante del nuovo secolo sia stato l’11 settembre 2001. In realtà quell’attentato non ha cambiato per nulla l’assetto economico, politico e militare del mondo. Lo consideriamo storico solo perché è stato massimamente spettacolare. L’importante è che si tratti di eventi fotografati.
Fraternismo
Oggi chiunque si dica di sinistra è convinto che un impulso lo caratterizzi essenzialmente: più eguaglianza. Della terna rivoluzionaria - liberté, égalité, fraternité - pensa che la seconda sia quella marcante. Credo invece che, anche se un po’ rimossa, la passione della sinistra di allora (e forse di oggi, anche se mitigata) era un profondo desiderio di fraternità.
Il fraternismo non è il collettivismo. Il fraternismo socializzava il nostro impetus dionisiaco: era la faccia collettiva di un’urgenza innanzi tutto soggettiva di rompere tutti i limiti di quella che chiamerei l’economia domestica della società. Per molti, in effetti, il 68 ha significato soprattutto l’esplosione di una hybris individualista, malgrado il sound and fury degli slogan socialisti.
Non a caso uno dei film più rappresentativi di quell’epoca appare Easy Rider di Dennis Hopper. Questo film non ha nulla di socialista: si tratta di due corrieri della droga che traversano in motocicletta parte degli States. Oltre-uomini al di là del Bene e del Male, si lanciano in viaggi con LSD con delle puttane, si fanno canne, ecc. Epopea on the road sulla scia di Kerouac, cantava la nostra passione squisitamente nomadica: mutazione permanente, mai riposare nella certezza delle norme morali o delle istituzioni consolidate. Non è casuale che trip divenisse termine comune per indicare l’esperienza con un allucinogeno. Ma non si trattava della forma poetica, quindi radicale, di una Stimmung che poi è diventata l’essenza stessa della modernità liberale? Flessibilità, deregulation, velocità, mutamento, innovazione: tutte parole che esaltano la passione eraclitea della modernità, la sua intolleranza per ogni adagiarsi duraturo e senile nel già-fatto. Comunque, in Easy Rider quel che conta è, tra i due protagonisti, la loro fraternità.
Una sera, incalzati dalle cariche della polizia nelle stradine del Quartier, riparammo nella Sorbona occupata. Là alcuni medici e studenti di medicina ci presero in carico: temevano che i nostri vestiti fossero intrisi dei candelotti tossici che allora usava la polizia, e ci fecero spogliare in gran parte. Quei medici erano deliziosi, ogni tanto venivano a chiederci come stessimo.
Dall’alto dei tetti potevamo seguire le scene di guerriglia urbana che si dipanavano nel quartiere. Vivevamo l’azione pur potendoci concedere i piaceri passivi della contemplazione. E ci sentivamo tutti fratelli, coccolati da quei deliziosi medici-compagni. Credo che tutti noi, in quella fresca serata di maggio, sentimmo l’ebbrezza di un mondo nettamente diviso in due: da una parte il male che invano si accaniva contro angeli guerriglieri, dall’altra una fraternità finalmente praticata.
Credo che nella sinistra il progetto di eguaglianza sia una facciata (Marx era contrario al progetto di eguaglianza), quel che veramente spinge verso la sinistra radicale è un sogno delizioso di fraternità illimitata che sdrammatizzi l’emancipazione individualista. Si vuole che nel mondo nessuno ci sia estraneo, che tutti ci siano amici; soprattutto, si sogna un universo di persone gentili. Chi odia il liberalismo, lo identifica a un mondo di egoisti che sbraitano in autobus affollati e puzzolenti di sudore dove ci si pestano i piedi, alla furbizia di negozianti marpioni che ti sorridono solo per carpirti qualche soldo in più. Se si pensa alle scabrosità del 68, non lo si direbbe: ma infondo, volevamo un mondo che finalmente credesse, e non ipocritamente, nella buona educazione. Dall’alto della Sorbona, quello star-tutti-assieme ci faceva sentire giganti che dominavano il futuro e sconfiggevano il male.
Dadaismo
Il 68 è stato anche l’epoca di massimo rigoglio delle avanguardie artistiche, che riprendevano - in Francia, ma non solo - temi ed entusiasmi delle cosiddette avanguardie storiche, specialmente del dadaismo e del surrealismo. In America dilagava la pop art, in Italia l’arte povera... Anche in questo, quindi, il 68 ha una continuità col passato: è stata l’epoca in cui si è cercato di popolarizzare quella che era stata sempre fatto d’élite, l’arte d’avanguardia. Non a casa allora divennero star creatori “difficili”, anti-popolari: Ingmar Bergman, Godard, Ronconi, Pasolini, Peter Brook, il Living Theatre...
Mi resi conto, già nel 1966 - quando cominciarono in Italia manifestazioni di sinistra che facevano a meno, per la prima volta, del patronato del partito comunista - che l’estetica della protesta contro l’America stava decisamente cambiando, che insomma si americanizzava. Si trattava di una nuova ondata di dadaismo. A un’iconografia naturalista alla “Quarto stato” di Pellizza da Volpedo si stavano sostituendo segni e stili della pop art: le forme della nostra generazione erano ormai quelle di Allen Ginsberg, Andy Wahrol, Roy Lichtenstein, Bob Dylan, del Bread and Puppet Theatre di New York, oltre che dei Beatles, Doors, Rolling Stones, ecc. Il 68 ha segnato la svolta verso l’anglo-americanizzazione culturale della gioventù, che è proseguita trionfalmente nei decenni successivi. Anche se per noi si trattava ancora di costituire l’Internazionale Rivoluzionaria, mentre oggi i giovani appartengono all’internazionale giovanile, ligi all’American Way: tutti ascoltano musica americana, tutti in jeans, tutti usano computer americani, tutti adorano gli stessi film ovviamente americani, ecc.
Per far capire lo spirito dionisiaco e dadaista del 68 e post ricorderò un aneddoto personale, da cui ne esco alquanto malconcio. Nell’inverno del 1970, intrapresi un viaggio in auto da Parigi alla Lorena, con due amici filosofi e la mia esplosiva ragazza francese dell’epoca, Dominique, che si proclamava surrealista. Ci fermammo a Reims, e infreddoliti andammo a pranzare di fronte alla magnifica cattedrale. Dopo un caldo pasto innaffiato di buon vino renano, entrammo nella Notre-Dame. Quel pomeriggio la chiesa era completamente vuota. Né preti, né fedeli. Solo noi quattro, avvinazzati e dadaisti. I miei due giovani amici marxisti ne approfittarono per rubare un paio di sedie e qualche lungo cero, mentre Dominique, ricordandosi che proprio colà per secoli venivano incoronati i re di Francia, si inginocchiò davanti a me e si impegnò in una assorta fellatio. Il crepuscolo stava virando verso la sera, gli ultimi raggi del giorno invernale penetravano attraverso le splendide vetrate.
Allora noi tre maschi scegliemmo un bassorilievo sulla parete e orinammo tutti e tre, in simultanea, incrociando i nostri getti sulle pietre gotiche. Ricordo i rivoli dei liquidi giallastri che sgocciolavano sul marmo grigio del pavimento.
Perché lo facemmo? Proprio in quei mesi avevo letto tutto d’un fiato il saggio di Erwin Panofsky Architettura gotica e filosofia scolastica - adoravo il gotico. Non volevo, come Marinetti, distruggere Venezia e ricostruirla con macchine d’acciaio, trovavo il passato più bello e commovente del presente. Una schizi dello spirito ci portava quindi da una parte a venerare le opere d’arte, e dall’altra ad atti vandalici contro i monumenti del potere monarchico e religioso. Era un modo per mostrare a noi stessi, e per estensione al mondo intero, che non potevamo avere limiti. Che osavamo imbrattare anche dei capolavori che ammiravamo. Praticavamo la figura iperbolica di un’apertura smisurata verso il possibile, che non si cura di ciò che distrattamente calpesta. Oggi vorrei tornare con Dominique nella cattedrale di Reims, e fare qualcosa per riparare.
Ho rinnegato molte delle idee che nutrivano le mie esperienze all’epoca, non rinnego affatto la mia esperienza di quell’epoca.
È uscito da pochi giorni il libro di Sergio Benvenuto, Godere senza limiti. Un italiano nel maggio ’68 a Parigi, Mimesis 2018.
* Doppiozero, 16 marzo 2018 (ripresa parziale, senza immagini).
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - "Leggere Freud. Dall’isteria alla fine dell’analisi". Il corpo che gode (di Felice Cimatti).30 aprile 2018
"PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ....
Il corpo che gode
di FELICE CIMATTI *
- Leggere Freud. Dall’isteria alla fine dell’analisi di Sergio Benvenuto.
La psicoanalisi è morta, o comunque moribonda. È morta perché, nonostante il suo “successo”, ormai è stato largamente rimosso il suo nucleo bollente, che è fatto di godimento autistico e di sessualità. Gli psicoanalisti, oggigiorno, scrivono di “amore”, “legge”, “desiderio”, “relazione”, “oggetto”, “maternità”, “intersoggettività”, “empatia” (elenco che potrebbe essere allungato ancora molto): parlano di tutto, ma proprio di tutto (talvolta anche di come votare), ma non parlano più di sesso e di inconscio. Ma una psicoanalisi che non parla di questo, di che cosa può propriamente parlare? Da questo punto di vista il prezzo che la psicoanalisi ha dovuto pagare per il suo “successo” sembra essere stato di rimuovere la propria stessa ragion d’essere. Per non parlare della sempre più forte tentazione moralistica.
Facciamo un solo esempio, ma illuminante: la questione della gestazione per altri (GPA), al centro di accese discussioni nella società contemporanea, perché rimette in questione assetti ritenuti eterni della famiglia borghese eterosessuale e mononucleare (sulle tante varianti storiche di quell’entità che noi chiamiamo “famiglia” ha scritto un libro esemplare Francesco Remotti, Contro natura. Una lettera al Papa). Si prenda il caso dell’articolo apparso sul quotidiano di sinistra “Liberation” nell’estate del 2015, scritto da una figura significativa della psicoanalisi francese, Marilia Aisenstein; un intervento che già dal titolo ci fa capire quanto tempo sia passato da Freud: “Un enfant à quel prix?”. Aisenstein scrive, sul quotidiano fondato fra gli altri da Jean-Paul Sartre, che «trop souvent, le désir d’un enfant “à tout prix” me paraît, lui, marqué par la collusion entre une forte pression sociale et un désir personnel anachronique de la petite fille qui veut un bébé pour elle, doublée d’un déni du temps qui passe».
 Non si rendono conto, queste quarantenni che si ostinano a volere un figlio, che sono vecchie e che il loro desiderio “collude” con la pressione sociale? E che cos’è questa negazione «du temps qui passe»? Memento mori, si sente sullo sfondo. Dopodiché la psicoanalista francese ci spiega anche che cos’è «un véritable désir d’enfant»: ovviamente «le résultat de l’amour qui unit deux êtres». E se si vuole un figlio da sola/o? Aisenstein non soltanto ci ricorda compiaciuta che il tempo passa, ma anche come dovremmo passarlo, quel tempo, se volessimo un figlio. Ma in nome di chi parla, Marilia Aisenstein? Nell’articolo, subito sotto il titolo e accanto al nome dell’autrice, è ben evidenziato «membre de la Société psychanalytique de Paris». È la voce della psicoanalisi. Ma sembra quella di un prete. Tanti cari saluti all’ateo Freud.
Non si rendono conto, queste quarantenni che si ostinano a volere un figlio, che sono vecchie e che il loro desiderio “collude” con la pressione sociale? E che cos’è questa negazione «du temps qui passe»? Memento mori, si sente sullo sfondo. Dopodiché la psicoanalista francese ci spiega anche che cos’è «un véritable désir d’enfant»: ovviamente «le résultat de l’amour qui unit deux êtres». E se si vuole un figlio da sola/o? Aisenstein non soltanto ci ricorda compiaciuta che il tempo passa, ma anche come dovremmo passarlo, quel tempo, se volessimo un figlio. Ma in nome di chi parla, Marilia Aisenstein? Nell’articolo, subito sotto il titolo e accanto al nome dell’autrice, è ben evidenziato «membre de la Société psychanalytique de Paris». È la voce della psicoanalisi. Ma sembra quella di un prete. Tanti cari saluti all’ateo Freud.In un articolo che compare sul sito ufficiale della Società Psicoanalitica Italiana, lo psicoanalista Pietro Rizzi, commentando e riprendendo l’articolo di Aisenstein, scrive: «Se il desiderio di un figlio, e la sua nascita, può legittimamente far sentire alla neo-madre di aver realizzato il compito immemoriale di proseguire la specie, esso può anche produrre, nella odierna temperie di negazione/oblio della storia, un’esperienza di auto-creazione narcisistica, a metà tra la fantascienza e la magia».
 L’articolo di Rizzi è pieno di interessanti osservazioni, tuttavia si pone per lui lo stesso problema che si pone per Aisenstein: qual è il titolo “scientifico” - per non parlare di titolo “morale” - della psicoanalisi per giudicare se un desiderio è “legittimo” oppure no, se è “narcisistico” oppure no? E chi stabilisce che alla donna spetta il «compito immemoriale di proseguire la specie»? Se un giorno alla riproduzione pensassero delle macchine (uno scenario neanche troppo futuribile, esplorato nell’interessantissimo La fine del sesso e il futuro della riproduzione umana, scritto dal giurista e genetista Henry Greely)? E non poteva mancare, infine, un classico del discorso psicoanalitico contemporaneo, il mortifero riferimento al lutto; infatti è «il lutto, [la] necessaria premessa di una maternità consapevolmente scelta, creata dall’amore tra due esseri umani, dove un figlio è desiderio di un “altro” da sé e non appendice del proprio sé».
L’articolo di Rizzi è pieno di interessanti osservazioni, tuttavia si pone per lui lo stesso problema che si pone per Aisenstein: qual è il titolo “scientifico” - per non parlare di titolo “morale” - della psicoanalisi per giudicare se un desiderio è “legittimo” oppure no, se è “narcisistico” oppure no? E chi stabilisce che alla donna spetta il «compito immemoriale di proseguire la specie»? Se un giorno alla riproduzione pensassero delle macchine (uno scenario neanche troppo futuribile, esplorato nell’interessantissimo La fine del sesso e il futuro della riproduzione umana, scritto dal giurista e genetista Henry Greely)? E non poteva mancare, infine, un classico del discorso psicoanalitico contemporaneo, il mortifero riferimento al lutto; infatti è «il lutto, [la] necessaria premessa di una maternità consapevolmente scelta, creata dall’amore tra due esseri umani, dove un figlio è desiderio di un “altro” da sé e non appendice del proprio sé».
 E il divertimento, il sesso, e il godimento “narcisistico”, e soprattutto, l’inconscio? Si parla di tutto, anche del lutto («un lutto, non necessariamente così doloroso»), pur di non parlare del godimento. Vengono in mente le parole di Gilles Deleuze: «il fatto è che la psicoanalisi ci parla in continuazione dell’inconscio, ma in un certo modo lo fa sempre per ridurlo, distruggerlo, scongiurarlo» (Deleuze 2000, p. 59).
E il divertimento, il sesso, e il godimento “narcisistico”, e soprattutto, l’inconscio? Si parla di tutto, anche del lutto («un lutto, non necessariamente così doloroso»), pur di non parlare del godimento. Vengono in mente le parole di Gilles Deleuze: «il fatto è che la psicoanalisi ci parla in continuazione dell’inconscio, ma in un certo modo lo fa sempre per ridurlo, distruggerlo, scongiurarlo» (Deleuze 2000, p. 59).In questo desolante panorama spicca al contrario la figura di Sergio Benvenuto, psicoanalista e filosofo che negli anni ha costruito un proprio autonomo e originale profilo teorico. Una originalità che Benvenuto collega proprio al dimenticato e rimosso Freud. Quel Freud, e così torniamo al nucleo originario della psicoanalisi, che nella Vienna fin de siècle mette sotto gli occhi di tutti quel che è sempre stato evidente e proprio per questo si è sempre voluto nascondere: «la sessualità» - scrive in Leggere Freud. Dall’isteria alla fine dell’analisi (2017) - «per Freud, è questo bordo tra il linguaggio e il puro grido; un bordo di per sé impresentabile, di cui non possiamo vantarci, a meno che non siamo in una posizione critica proprio nei confronti del mondo della decenza e della rispettabilità» (p. 13).
 La psicoanalisi non si occupa del godimento sessuale per dargli una forma, fosse anche la forma della meta-psicologia freudiana; se ne occupa perché la psicoanalisi freudiana nasce dalla scoperta di questo oggetto, tutto il resto già si sapeva: «se, come accade spesso, l’analisi viene vista come una relazione tra due soggetti, un modo di definirsi di un essere-con, allora l’inconscio svapora, e con esso anche la sessualità come esperienza che eccede la parola, che ne esula e la rende insufficiente» (p. 15). Si tratta di una precisazione rilevante, perché smonta la tentazione, a cui troppi psicoanalisti non riescono a resistere, di credere che l’analisi serva a dare parole all’inconscio. L’onnipresente tentazione di pensare la psicoanalisi come esperienza di comprensione e interpretazione, come dialogo e scambio intersoggettivo.
La psicoanalisi non si occupa del godimento sessuale per dargli una forma, fosse anche la forma della meta-psicologia freudiana; se ne occupa perché la psicoanalisi freudiana nasce dalla scoperta di questo oggetto, tutto il resto già si sapeva: «se, come accade spesso, l’analisi viene vista come una relazione tra due soggetti, un modo di definirsi di un essere-con, allora l’inconscio svapora, e con esso anche la sessualità come esperienza che eccede la parola, che ne esula e la rende insufficiente» (p. 15). Si tratta di una precisazione rilevante, perché smonta la tentazione, a cui troppi psicoanalisti non riescono a resistere, di credere che l’analisi serva a dare parole all’inconscio. L’onnipresente tentazione di pensare la psicoanalisi come esperienza di comprensione e interpretazione, come dialogo e scambio intersoggettivo.
 Al contrario, per Benvenuto «l’inconscio è sacrilego» (p. 14). Non rispetta nulla, e non vuole nessuna comprensione.
Al contrario, per Benvenuto «l’inconscio è sacrilego» (p. 14). Non rispetta nulla, e non vuole nessuna comprensione.La psicoanalisi si occupa piuttosto di quel lato dell’umano che sfugge al calcolo e alla ragione, alla mente ma anche al corpo. L’inconscio, infatti, non è al servizio né della mente, ma nemmeno del corpo animale, quello che condividiamo con tutti gli altri mammiferi: «insomma, la psicoanalisi si orienta a occuparsi della parte non adattativa dell’essere umano» (p. 193). Nonostante Darwin, la natura specie-specifica dell’umano è profondamente disadattativa, se non direttamente anti-biologica.
 La psicoanalisi di cui ci parla Benvenuto ci offre una immagine dell’umano agli antipodi con quella corrente, sia quella offerta dalle scienze cognitive (il mainstream ideologico della contemporaneità) che quella offerta dall’economia (che ha preso il posto un tempo occupato dal Catechismo): un essere umano abitato e attraversato da forze che non controlla, da desideri che non hanno alcuna funzione biologica (la sessualità umana è normalmente perversa, come scopre Freud nel suo capolavoro, i Tre saggi sulla teoria sessuale), naturalmente scisso al suo interno: «quella di Freud non è una teoria dell’individuo, ma del “dividuo”. Non dell’Io come indivisibile, ma del soggetto come diviso. E rispetto a questa visione dell’essere umano in quanto dividuo che possiamo misurare la portata della restaurazione cognitivista, che consiste nel ristabilire l’unità dell’individuo in quanto essere sostanzialmente razionale e calcolatore» (p. 141).
La psicoanalisi di cui ci parla Benvenuto ci offre una immagine dell’umano agli antipodi con quella corrente, sia quella offerta dalle scienze cognitive (il mainstream ideologico della contemporaneità) che quella offerta dall’economia (che ha preso il posto un tempo occupato dal Catechismo): un essere umano abitato e attraversato da forze che non controlla, da desideri che non hanno alcuna funzione biologica (la sessualità umana è normalmente perversa, come scopre Freud nel suo capolavoro, i Tre saggi sulla teoria sessuale), naturalmente scisso al suo interno: «quella di Freud non è una teoria dell’individuo, ma del “dividuo”. Non dell’Io come indivisibile, ma del soggetto come diviso. E rispetto a questa visione dell’essere umano in quanto dividuo che possiamo misurare la portata della restaurazione cognitivista, che consiste nel ristabilire l’unità dell’individuo in quanto essere sostanzialmente razionale e calcolatore» (p. 141).Una psicoanalisi che proprio per questo non pretende di essere una scienza, come invece prova a fare affannosamente e vanamente la psicoanalisi del nostro tempo “cognitivo”, del tutto subalterna all’ideologia scientista contemporanea, che ammette come unico criterio di validità quello scientifico (o presunto tale). Si tratta di un punto rilevante dell’analisi di Benvenuto, perché rivendica l’autonomia della psicoanalisi, che ha valore non perché sia una (pseudo) scienza, bensì perché dà spazio alla natura intrinsecamente e radicalmente irrazionale dell’animale umano, non perché sia appunto una scienza, al contrario, perché è materialista e quindi volgare: «molti parlano di “rivoluzione psicoanalitica” - io invece direi che la psicoanalisi è stata un Ritorno riabilitativo al popolare» (p. 22). Nei sogni si parla di escrementi, di buchi, di carne e passione. Di questo è fatto l’inconscio. Questa è la psicoanalisi:
- Molti analisti si vergognano di questa natura “popolare” del loro sapere, ragion per cui, da decenni, scimmiottano il più possibile stili, norme e protocolli delle “scienze serie”. Cercano di scrivere, ovviamente in inglese, in uno stile più arido e obiettivo possibile, con la gelida neutralità del ricercatore scientifico, in modo da meritarsi una rispettabilità scientifica che - ahimè - oggi viene loro, malgrado i loro sforzi, negata. Non basta imitare lo stile delle riviste scientifiche per essere accettati nel club esclusivo e schizzinoso delle Scienze (p. 22).
La psicoanalisi di Benvenuto è così radicalmente scomoda, perché parla non tanto di quello che non ci piace di noi, piuttosto dice la nostra radicale subordinazione a pulsioni che ci attraversano, e parlano per noi, al nostro posto. Freud, l’intransigente materialista Freud, ci ricolloca al nostro posto, quello di primati parlanti, che però credono a quello che si dicono (Homo sapiens è l’unico animale che pensa di sé di non esserlo). È troppo cruda, e sconsolante, questa immagine, per questo la rimozione della psicoanalisi è cominciata nello stesso momento della sua comparsa. Ma questo, ancora una volta, significa che l’animale umano, per Freud, non smette di essere un primate, una scimmia, anche se si tratta di una scimmia con la testa piena di parole e pensieri che pensano per lei, che ha bisogno di sentirsi amata, e di credere che un senso, da qualche parte, c’è.
 La psicoanalisi non crede al senso, neanche a quello biologico (che, ammesso che sia un senso, è del tutto privo di senso, è cieco e autistico, come mostrò in modo esemplare, sebbene sgradevole, il biologo Richard Dawkins ne Il gene egoista). La psicoanalisi non è ottimista, non propone una soluzione, soprattutto non ci e si racconta storie: «si ha voglia di rigirare la frittata, ma se si è freudiani si crede nella pulsione di morte, e quindi nell’impossibilità costitutiva di una società Buona e Felice» (p. 129).
La psicoanalisi non crede al senso, neanche a quello biologico (che, ammesso che sia un senso, è del tutto privo di senso, è cieco e autistico, come mostrò in modo esemplare, sebbene sgradevole, il biologo Richard Dawkins ne Il gene egoista). La psicoanalisi non è ottimista, non propone una soluzione, soprattutto non ci e si racconta storie: «si ha voglia di rigirare la frittata, ma se si è freudiani si crede nella pulsione di morte, e quindi nell’impossibilità costitutiva di una società Buona e Felice» (p. 129).
 Ma attenzione, Benvenuto non è dalla parte del “lutto”, tutto al contrario, la psicoanalisi è dalla parte del godimento e della liberazione del corpo dall’Io, che infatti - qui Benvenuto è affatto lacaniano - «è a un tempo solo sé stesso, ma anche l’Altro che l’io stesso ha assunto come il proprio» (p. 140). La psicoanalisi non rafforza l’Io, che non esiste, o meglio esiste solo come introiezione dello sguardo dell’Altro.
Ma attenzione, Benvenuto non è dalla parte del “lutto”, tutto al contrario, la psicoanalisi è dalla parte del godimento e della liberazione del corpo dall’Io, che infatti - qui Benvenuto è affatto lacaniano - «è a un tempo solo sé stesso, ma anche l’Altro che l’io stesso ha assunto come il proprio» (p. 140). La psicoanalisi non rafforza l’Io, che non esiste, o meglio esiste solo come introiezione dello sguardo dell’Altro.Da questo punto di vista la grande e rimossa figura della psicoanalisi è, insieme allo stesso Freud, è quella del suo allievo rinnegato, eretico ed eccessivo, Wilhelm Reich, che cercò in modo pazzo e fallimentare di coniugare comunismo e psicoanalisi, sessualità e rivoluzione, libertà e godimento. Non è un caso che il suo nome non compaia più fra quelli citati dalla psicoanalisi “scientifica” (nemmeno nel libro di Benvenuto, per la verità; la sua storia dimenticata si può leggere in un libro di qualche anno fa di Paul Robinson, La sinistra Freudiana - Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse), e che sia morto nel 1957 in un penitenziario negli Stati Uniti. La psicoanalisi è eccessiva, anche se le piace presentarsi sotto le luci soffuse di un accogliente ed elegante studio borghese, è esagerata, è intrattabile. Insistiamo su questo punto, la libertà della psicoanalisi. Una libertà che per essere “libera” deve liberarsi, per prima cosa, da quello stesso soggetto, l’Io, che per Freud è il riflesso interno delle forze sociali esterne.
Benvenuto è esplicito su questo punto, in cui cade buona parte della psicoanalisi contemporanea: «l’analista teorizza come se in realtà egli stesse dicendo al suo analizzante: “Io so scientificamente, medicalmente, il tuo questo, quel self che tu sei”. [...] Questo analista, nell’istante in cui teorizza, crede che il soggetto sia qualcosa. Per l’analista praticante invece ogni essere “qualcosa” è un’alienazione» (p. 89).
 Per questa ragione, per Benvenuto, «l’abilità dell’arte psicoanalitica consiste nel mostrare a un soggetto l’altro sogno, quello dentro al quale egli non suppone di vivere» (p. 100). Il problema del sogno, in fondo, è che appunto è soltanto un sogno, un sogno che qualcun altro sogna per noi. La psicoanalisi, per Benvenuto, è invece una pratica di radicale individuazione: «di fatto, è il lavoro di ogni psicoanalisi riuscita: aiutare ciascuno di noi a individuarsi, a soggettivarsi, ovvero a raccontarsi la storia giusta delle proprie origini in modo di “svincolarsi dal gruppo”» (p. 151). Si va in analisi non per stare meglio con gli altri, tantomeno per adattarsi ad un mondo che non si sopporta, ma per fare a meno del bisogno di essere guardati, dagli altri e da sé stessi. E questo non è narcisismo, questa si chiama libertà.
Per questa ragione, per Benvenuto, «l’abilità dell’arte psicoanalitica consiste nel mostrare a un soggetto l’altro sogno, quello dentro al quale egli non suppone di vivere» (p. 100). Il problema del sogno, in fondo, è che appunto è soltanto un sogno, un sogno che qualcun altro sogna per noi. La psicoanalisi, per Benvenuto, è invece una pratica di radicale individuazione: «di fatto, è il lavoro di ogni psicoanalisi riuscita: aiutare ciascuno di noi a individuarsi, a soggettivarsi, ovvero a raccontarsi la storia giusta delle proprie origini in modo di “svincolarsi dal gruppo”» (p. 151). Si va in analisi non per stare meglio con gli altri, tantomeno per adattarsi ad un mondo che non si sopporta, ma per fare a meno del bisogno di essere guardati, dagli altri e da sé stessi. E questo non è narcisismo, questa si chiama libertà.Riferimenti bibliografici
 S. Benvenuto, Leggere Freud. Dall’isteria alla fine dell’analisi, Orthotes, Nocera Inferiore (SA) 2017.
S. Benvenuto, Leggere Freud. Dall’isteria alla fine dell’analisi, Orthotes, Nocera Inferiore (SA) 2017.
 G. Deleuze, Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste. 1975-1995, Einaudi, Torino 2000.
G. Deleuze, Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste. 1975-1995, Einaudi, Torino 2000.
 H. Greely, La fine del sesso e il futuro della riproduzione umana, Codice, Torino 2017.
H. Greely, La fine del sesso e il futuro della riproduzione umana, Codice, Torino 2017.
 F. Remotti, Contro natura. Una lettera al Papa, Laterza, Roma-Bari 2008.
F. Remotti, Contro natura. Una lettera al Papa, Laterza, Roma-Bari 2008.* Fata Morgana, 12 febbraio 2018 (ripresa parziale, senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
A FREUD (Freiberg, 6 maggio 1856 - Londra, 23 settembre 1939), GLORIA ETERNA!!! IN DIFESA DELLA PSICOANALISI.
- NATURA, CULTURA E FAMIGLIA. FRANCESCO REMOTTI SCRIVE "UNA LETTERA AL PAPA" E RILANCIA UN DIBATTITO TRA "CIECHI".
FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
 IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".
IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".- LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND. Una nota
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana.30 aprile 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI, ANTROPOLOGIA, E MISTICISMO. Uscire dallo Stato di minorità (superiorità) ...
 LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.
LA BALLATA DI COLAPESCE ("DER TAUCHER") DI SCHILLER E LA "LEZIONE" DI FREUD A BRUNO GOETZ E A ROMAIN ROLLAND.FILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
 IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".
IL PUNTO DI SVOLTA. Proseguendo nel suo «viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre», Fachinelli è giunto finalmente dinanzi al mare. «Sulla spiaggia», questo è il titolo del primo e più originale scritto de "La mente estatica".FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - Invidia. Il metro di Caino (di Umberto Fiori)21 aprile 2018, di Federico La Sala
Invidia. Il metro di Caino
di Umberto Fiori *
- E come alli orbi non approda il sole, / così all’ombre quivi, ond’io parlo ora, / luce del ciel di sé largir non vole; / ch’a tutti un fil di ferro i cigli fora / e cuce sì, come a sparvier selvaggio / si fa però che queto non dimora. (Dante, Purg. XIII, 67-72)
Quando ero bambino, a catechismo, un prete mi ha raccontato la storia di Caino e Abele. Di quel racconto - e della sua autorevole interpretazione - mi sono a lungo accontentato. Per me, come per tanti cattolici, la Bibbia era affare della Chiesa.
Solo molti anni dopo ho avvertito la necessità di un “libero esame” del passo della Genesi. Ho scoperto così che, per rendere più comprensibile a noi piccini la morale della foschissima favola, il buon parroco aveva prudentemente “rivisto” il racconto. Nella sua rassicurante versione, Abele sacrificava a Dio gli agnelli più belli e grassi del suo gregge, mentre Caino gli offriva solo gli scarti del proprio raccolto: di qui la ragionevole benevolenza del Signore per il pio pastore, la sua giusta collera contro il fratello infido e sacrilego.
Il fatto è che, nella Genesi, della disparità tra i due sacrifici non si fa menzione. Niente fa pensare che un sacrificio fosse più “giusto” dell’altro: le due offerte risultano equivalenti.
Questa equivalenza - ci si può chiedere - vuole presentarsi come un dato “oggettivo”, o invece intende sottilmente alludere al punto di vista di Caino, soggettivo e distorto? Non fa differenza. Ciò che conta non è tanto la disparità o l’equivalenza “effettiva” delle due offerte, quanto piuttosto il metro che Caino adotta per valutarle.
 Il fatto stesso che applichi un metro, che le confronti, contestando le “misure” di Dio, è l’errore che lo acceca e lo perde. Se accettassimo la versione “moraleggiante” (presente anche nella tradizione ebraica) secondo la quale il sacrificio di Caino era inadeguato, dovremmo aspettarci che il rimprovero che il Signore gli rivolge riguardi proprio questo. Invece, Dio non ne parla affatto, e Caino, da parte sua, non dà a vedere di sentirsi in colpa per avere offerto un olocausto indegno. È dall’equivalenza delle due offerte che occorre partire; è questa misteriosa, misconosciuta “uguaglianza” a conferire al racconto il senso tragico che avvertiamo.
Il fatto stesso che applichi un metro, che le confronti, contestando le “misure” di Dio, è l’errore che lo acceca e lo perde. Se accettassimo la versione “moraleggiante” (presente anche nella tradizione ebraica) secondo la quale il sacrificio di Caino era inadeguato, dovremmo aspettarci che il rimprovero che il Signore gli rivolge riguardi proprio questo. Invece, Dio non ne parla affatto, e Caino, da parte sua, non dà a vedere di sentirsi in colpa per avere offerto un olocausto indegno. È dall’equivalenza delle due offerte che occorre partire; è questa misteriosa, misconosciuta “uguaglianza” a conferire al racconto il senso tragico che avvertiamo.Tanto Abele quanto Caino - così sta scritto - offrivano a Dio i frutti del proprio lavoro: “Caino fece un’offerta al Signore dei prodotti del suolo. E Abele, anche lui, offrì dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso”. E tuttavia - leggiamo, con un brivido di sgomento - “Il Signore riguardò [guardò con favore, gradì, premiò] Abele e la sua offerta, mentre non riguardò [non guardò con favore, non gradì, non premiò] Caino e la sua offerta; Caino perciò ne fu grandemente adirato e il suo volto fu abbattuto”.
Caino non riesce ad accettare la preferenza che Dio accorda al fratello. Se si sta al testo biblico (non alla sua vulgata “moraleggiante”), è terribilmente facile comprenderlo: visto che i sacrifici si equivalgono, non dovrebbero equivalersi anche i favori di Dio?
Questa è la sfida che si presenta al primogenito di Adamo e a noi, suoi figli. Questa, la prova a cui siamo messi.
Invece di esporre paternamente a Caino le sovrumane ragioni della propria “ingiustizia”, il Signore lo provoca crudelmente, con parole che stringono il cuore e spaventano: “Perché sei così adirato e il tuo volto è abbattuto? Forse che, se agisci bene, non potrai tenere alto il tuo volto? Ma, se non fai bene, il peccato giacerà alla porta e contro di te si volgono le sue brame; però tu devi dominarlo”.
Caino non riesce a tenere alto il volto, a sollevare il viso (il visus: lo sguardo) da terra. L’esistenza del fratello, illuminata dal favore di Dio, gli è invisa: non la può proprio guardare, non può vederla. È invidus, invidioso.
Invidioso: cosa significa? Noi lo sappiamo: fin troppo bene, lo sappiamo; ma per il nostro disgraziato progenitore, l’esperienza è del tutto nuova e incomprensibile.
Che cosa gli accade? Cos’è, questa angoscia che lo sconvolge nel profondo?
È Dio, dall’alto dei cieli, a dare un nome al suo tormento. Ciò che prova - lo ammonisce - non è il legittimo sdegno per un torto subito: è una colpa, un peccato.
Caino - osserviamolo - nulla obietta. Non protesta contro l’Altissimo, non gli rinfaccia apertamente la sua iniquità, non gli chiede conto del torto fattogli. È lui il primo ad avvertire oscuramente che la sua sorda ribellione non ha i caratteri di un sentimento nobile, giusto. Il suo sdegno non gli colma l’animo del sacrosanto entusiasmo di chi ha ragione; al contrario: lo abbatte, lo deprime. La sua rivolta non ha il coraggio di manifestarsi: resta nel petto, celata come una vergogna. Ma sul volto, nei gesti, nella postura, i segni dell’amarezza affiorano irresistibilmente. Il figlio di Eva è livido, non ha gioia.
I sintomi - non c’è dubbio - sono funesti. Di per sé, tuttavia, non provano ancora che ciò che Caino sente sia un peccato. È una colpa, la tristezza? Ed essere felici, è un merito?
Abele è felice. Ma qual è il suo merito? I suoi sacrifici erano forse più puri, più santi, più devoti di quelli del fratello? No. È l’arbitraria benevolenza del Signore, non una speciale devozione, ad avergli procurato la felicità di cui gode. E Caino? Non aveva meriti?
Dio non li nega, quei meriti, ma nemmeno li riconosce. Non è di questo che intende parlare.
Il peccato di Caino, quello che lui si ostina a non vedere, non consiste nella inadeguatezza delle sue offerte. Il suo vero peccato (Dio non lo dichiara: si limita a suggerirlo) è comparare ciò che è incomparabile: la propria fortuna e quella di un altro, la vita di un uomo e quella di un altro uomo. Peccato è il confronto; di lì nasce l’angoscia che lo spingerà a uccidere Abele. Mentre Caino commisura i meriti, mentre scruta e raffronta i premi ricevuti, mentre aguzza gli occhi sul meglio e sul peggio, perde di vista il bene. Chi fa il bene - lo ammonisce il Signore - tiene alto il volto.
 Il primogenito di Adamo, invece, guarda rabbiosamente a terra. Calcola, valuta, soppesa (nella tradizione ebraica, Caino è anche l’inventore di pesi e misure). Vorrebbe che fosse finalmente fatta giustizia. È questo ad accecarlo, a esporlo ai morsi del peccato, che sta “accovacciato come una belva sulla soglia di casa”. La sua giustizia - la giustizia umanamente intesa - pretende di giudicare quella divina, vuole imporle il proprio metro, le proprie scadenze; si spinge fino a vedere in essa una iniquità intollerabile. Questo è, l’invidia: la disperata incapacità di comprendere l’operare di Dio, di accettare senza condizioni la Sua santa volontà.
Il primogenito di Adamo, invece, guarda rabbiosamente a terra. Calcola, valuta, soppesa (nella tradizione ebraica, Caino è anche l’inventore di pesi e misure). Vorrebbe che fosse finalmente fatta giustizia. È questo ad accecarlo, a esporlo ai morsi del peccato, che sta “accovacciato come una belva sulla soglia di casa”. La sua giustizia - la giustizia umanamente intesa - pretende di giudicare quella divina, vuole imporle il proprio metro, le proprie scadenze; si spinge fino a vedere in essa una iniquità intollerabile. Questo è, l’invidia: la disperata incapacità di comprendere l’operare di Dio, di accettare senza condizioni la Sua santa volontà.Nella vicenda di Abele e Caino, l’aspetto religioso è predominante: si parla di uomini che offrono sacrifici, di una divinità che li gradisce o li disdegna, si parla di peccato, di castigo divino. Questo potrebbe indurci a ridurre questa grandiosa rappresentazione dell’invidia a un racconto moraleggiante, il cui senso sarebbe condizionato dai valori propri di una determinata fede. Proviamo a spogliare l’antichissima favola della sua veste biblica, proviamo a tradurla in termini laici. Al posto di Dio mettiamo la fortuna, il caso, l’opinione corrente; al posto dell’olocausto di agnelli e di mèssi mettiamo la fatica, il lavoro, gli sforzi quotidiani di ogni uomo e di ogni donna; al posto della benevolenza del Signore, mettiamo il benessere, la felicità, il pubblico riconoscimento. Così impostata, la favola appare ancora più cupa, davvero tragica.
È vero, l’invidia del nostro Caino “laico”, che non tollera i propri fallimenti e i successi del suo vicino, non è più un peccato, è solo un sentimento tra gli altri: non c’è un Dio che gli possa rimproverare ciò che sente. Ma anziché liberarlo, questo lo sprofonda ancora più in basso nell’angoscia e nel risentimento, gli fa sentire ancora più grave il peso della sua impotenza. Che se la prenda con il destino avverso, o invece con la malevolenza degli uomini, con la stoltezza della pubblica opinione, è sempre una superiore Ingiustizia a sfidarlo.
Il suo sguardo storto e risentito sulla fortuna del vicino rimane celato nel suo intimo, nessuno lo bolla come una colpa; ma Caino non riesce comunque a “tenere alto il volto”: anche senza un Dio che la condanni, la sua tristezza resta un tormento; il suo abbattimento, anzi, è ancora più disperato.
Come può guarire da questo male? Dove sono le radici della sua rabbia, della sua disperazione? Perché soffre, l’invidioso?
Soffre perché il bene che ha fatto (che presume di aver fatto) non gli ha procurato ciò che si aspettava: un bene ulteriore, corrispondente al valore del suo fare, anzi maggiore. L’invidioso concepisce il bene come adeguata ricompensa di uno sforzo, come risultato finale di un lavoro che buono è solo in subordine, in quanto mezzo per ottenere l’oggetto a cui aspira. Caino è un lavoratore. La sua non è una preghiera, non è un’offerta: è un’opera realizzata in vista di un vantaggio, di un adeguato tornaconto (sia pure immateriale, morale). La fatica che quest’opera gli è costata gli sembra enorme, mentre in quella dell’altro non avverte traccia di sforzo. Se ripensa al proprio sacrificio e lo paragona a quello del suo rivale, il premio che questi riceve, ai suoi occhi, è vergognosamente immeritato.
L’invidia svanirebbe, se l’invidioso si accontentasse del proprio giudizio, della bruciante certezza dalla quale si è originato il suo sdegno: la fatica e l’opera sua valgono quanto quelle del vicino, se non di più. Il fatto che non vengano premiate non dovrebbe diminuirne, ai suoi occhi, la dignità e il valore. Ma l’invidioso è incapace di prestar fede al proprio giudizio; questa è la sua sventura: il giudizio del mondo è per lui talmente autorevole, talmente divino, che egli non può fare a meno di dubitare della qualità della propria opera spregiata, e anzi di spregiarla a sua volta rabbiosamente, in segreto, mentre quella altrui - per quanti sforzi egli faccia al fine di sminuirla - comincia a sembrargli terribilmente buona, illuminata com’è dalla grazia del pubblico favore.
Se l’invidia fosse un peccato, se ci fosse un Dio a condannarla, l’invidioso potrebbe liberarsene confessandola, ammettendo la propria colpa, purificandosi. Ma qui - lo abbiamo detto - stiamo parlando di un invidioso senza Dio, senza colpa, senza perdono. La sua sofferenza non ha vie d’uscita. L’invidia si rivela come il sentimento più doloroso, più inconfessabile.
 Analizzando e confrontando la natura dell’odio e quella dell’invidia, Plutarco osserva che “alcuni ammettono di odiare molte persone, ma sostengono di non invidiare nessuno” (L’invidia e l’odio, D’Auria, Napoli, 2004, p.85). Eppure, l’invidia è uno dei sentimenti più propri dell’uomo: Plutarco fa notare che mentre il nostro odio può investire anche gli animali, l’invidia è pensabile solo tra un uomo e un altro uomo. E aggiunge: “Tra gli animali selvatici invece non è probabile che sorga invidia reciproca (dato che non hanno idea della buona o cattiva fortuna dell’altro, né li tocca la presenza o l’assenza della gloria, motivi dai quali l’invidia è inasprita al massimo grado)” (p.83).
Analizzando e confrontando la natura dell’odio e quella dell’invidia, Plutarco osserva che “alcuni ammettono di odiare molte persone, ma sostengono di non invidiare nessuno” (L’invidia e l’odio, D’Auria, Napoli, 2004, p.85). Eppure, l’invidia è uno dei sentimenti più propri dell’uomo: Plutarco fa notare che mentre il nostro odio può investire anche gli animali, l’invidia è pensabile solo tra un uomo e un altro uomo. E aggiunge: “Tra gli animali selvatici invece non è probabile che sorga invidia reciproca (dato che non hanno idea della buona o cattiva fortuna dell’altro, né li tocca la presenza o l’assenza della gloria, motivi dai quali l’invidia è inasprita al massimo grado)” (p.83).
 Un cervo e un altro cervo potranno competere, affrontarsi, conquistare o perdere femmine e territorio, ma non potranno invidiarsi. L’invidia sorge nell’uomo grazie alla sua essenziale capacità di andare oltre la mera fattualità, e di riconoscere il simbolico (la gloria, l’ammirazione, la pubblica approvazione). Che un uomo sia invidioso, dunque, è la prova più certa della sua umanità. E tuttavia, “Gli uomini (...) negano di provare invidia, e qualora si provi loro il contrario, adducono innumerevoli giustificazioni, dicendo di provare ira o paura o odio per l’uomo in questione, ricoprendo e nascondendo il nome della passione con qualsiasi altro capiti loro in mente diverso dall’invidia, come se tra le malattie dell’anima questa fosse la sola a non poter essere nominata”.
Un cervo e un altro cervo potranno competere, affrontarsi, conquistare o perdere femmine e territorio, ma non potranno invidiarsi. L’invidia sorge nell’uomo grazie alla sua essenziale capacità di andare oltre la mera fattualità, e di riconoscere il simbolico (la gloria, l’ammirazione, la pubblica approvazione). Che un uomo sia invidioso, dunque, è la prova più certa della sua umanità. E tuttavia, “Gli uomini (...) negano di provare invidia, e qualora si provi loro il contrario, adducono innumerevoli giustificazioni, dicendo di provare ira o paura o odio per l’uomo in questione, ricoprendo e nascondendo il nome della passione con qualsiasi altro capiti loro in mente diverso dall’invidia, come se tra le malattie dell’anima questa fosse la sola a non poter essere nominata”.Superbia, ira, lussuria, gola, avarizia, accidia, sono altrettanto riprovevoli, ma nessun affetto umano è amaro quanto l’invidia. Amaro, e funesto, e contagioso.
In una lettera a Dario, re di Persia, che lo aveva invitato alla sua corte offrendogli onori e ricchezze, Eraclito motiva il proprio rifiuto dichiarando tra l’altro di astenersi, per principio, dalla brama e dall’ambizione che accecano gli altri uomini, e di fuggire “la sazietà [la soddisfazione, la gloria] che è legata all’invidia” (kai koron feugon panti oikeioumenon phthonoi).
La sua spiegazione può sorprendere. Perché mai ci si dovrebbe guardare dal suscitare l’invidia altrui? Non è forse, la gelosia degli uomini, il segno più certo del nostro valore, la naturale conseguenza del suo riconoscimento? Non è anche per il sottile piacere di essere invidiati che ci battiamo per ottenere il successo? Eraclito la pensa diversamente. Essere invidiati - ci insegna - è doloroso quanto lo è invidiare. Se non è accecato dalla propria vanità, chi avverte su di sé l’occhio storto dell’invidioso fatica a goderne. L’effetto di quello sguardo maligno non è soltanto di generare allarme e inquietudine. Il malocchio è un fluido venefico che contamina il bene, lo deforma, lo riduce a cosa, a un oggetto che si possiede strappandolo ad altri. Nelle mani dell’invidiato, la contentezza che il bene genera si sporca, si adombra di alterigia, di superbia; il valore e il suo riconoscimento appaiono come l’odioso privilegio di un singolo.
Nello Zibaldone [3778], Leopardi osserva che l’invidia, passione antisociale per eccellenza, nasce non nella “società scarsa e larga destinataci dalla natura” - dove tende piuttosto a prevalere la solidarietà - ma in quella che egli chiama “società stretta”, insomma nell’ambito della convivenza civile caratteristica dell’età moderna. Nella “società stretta” gli uomini vivono uno di fronte all’altro, le loro esistenze si espongono ogni giorno allo sguardo altrui. La loro sorte - buona, grama, mediocre - è in pubblico. Il Pubblico è il dio di questi uomini serrati uno contro l’altro, il giudice sommo del loro bene, del loro male. L’invidia serpeggia da una finestra a un mercato, da un teatro a una bottega, fino alla piazza principale. La Città è il terreno ideale dell’invidia.
Oltre che primo assassino, Caino è il primo fondatore di città. L’invidia - ci suggeriscono le Scritture - non è solo un sentimento individuale, il peccato di un singolo: è l’oscuro fondamento di ogni socialità, di ogni società. La civiltà stessa, così com’è, è fondata sull’invidia, cioè sul perpetuo confronto tra gli uomini, sul sentimento di un’uguaglianza comparativa, sul bene inteso come felicità individuale, benessere da soppesare e misurare, tesoro di cui impossessarsi.
Alla radice della polis greca, il giovane Nietzsche vede proprio l’invidia, la “seconda” Eris (Discordia), la Eris “buona” che Esiodo nomina ne Le opere e i giorni:
- Il Greco è invidioso, e non sente questa proprietà come un difetto, bensì come azione di una divinità benefica: quale abisso fra il nostro giudizio etico e il suo! Poiché è invidioso, egli sente anche - ogni volta in cui gode di un eccesso di onore, di ricchezza, di lusso, di felicità - che su di lui si posa l’occhio invidioso di un dio, e teme questa invidia; in questo caso egli si sente richiamato all’instabilità di ogni sorte umana, inorridisce di fronte alla propria felicità e, sacrificandone la parte migliore, si piega di fronte all’invidia divina” (La filosofia nell’epoca tragica dei Greci, p.121)
Ma l’invidia non è solo “buona” discordia, positivo spirito di emulazione, argine ad ogni umana hybris: è anche la fonte del risentimento dei diseredati nei confronti dei privilegiati (germe di quella che Nietzsche chiama “morale da schiavi”), dei contrasti tra popoli, tra classi.
 Un’intepretazione “sociale” della favola di Caino e Abele si ritrova persino in Baudelaire con toni insoliti, da barricata: “Race d’Abel, dors, bois et mange;/ Dieu te sourit complaisemment. // Race de Caïn, dans la fange/ rampe et meurs misérablement”.
Un’intepretazione “sociale” della favola di Caino e Abele si ritrova persino in Baudelaire con toni insoliti, da barricata: “Race d’Abel, dors, bois et mange;/ Dieu te sourit complaisemment. // Race de Caïn, dans la fange/ rampe et meurs misérablement”.
 La fiera requisitoria contro Abele e i suoi immeritati privilegi si conclude con un incitamento alla rivolta: “Race de Caïn, au ciel monte/ et sur la terre jette Dieu!”. Sulla scia della tradizione romantica, il Caino di Baudelaire è un Titano umiliato, un Prometeo che per liberare l’umanità deve dare l’assalto al cielo, sopprimere quel Dio che ha provocato l’uomo con il suo arbitrio.
La fiera requisitoria contro Abele e i suoi immeritati privilegi si conclude con un incitamento alla rivolta: “Race de Caïn, au ciel monte/ et sur la terre jette Dieu!”. Sulla scia della tradizione romantica, il Caino di Baudelaire è un Titano umiliato, un Prometeo che per liberare l’umanità deve dare l’assalto al cielo, sopprimere quel Dio che ha provocato l’uomo con il suo arbitrio.Anche senza Dio però - ne abbiamo ragionato - l’invidioso non è comunque libero dall’amarezza che lo tormenta. Il peso dell’invidia non deriva dal fatto che qualcuno la condanni come un peccato. L’invidioso soffre, perché è incapace di concepire il bene se non come premio, come risultato. Nella sua misera prospettiva, l’opera buona può portare al successo, ma è anche esposta al fallimento. Il suo sguardo ansioso è tutto teso a calcolare quanta felicità sia toccata a lui e quanta al suo simile. Questo sguardo guidato da un disperato senso di giustizia, questo sguardo che insegue il miraggio della felicità, è senza gioia, è sempre più lontano dalla gioia.
Gioia, felicità. I due termini sembrano sinonimi, ma forse le nostre riflessioni sull’invidia hanno già messo in luce alcune differenze significative. Cerchiamo di approfondirle.
La felicità è strettamente legata alla volontà: è l’oggetto di un desiderio, il risultato sperato di uno sforzo cosciente dell’individuo; la gioia è una sensazione - involontaria, quasi impersonale - di pienezza, di forza, di entusiasmo. Entrambe - felicità e gioia - sono moventi del nostro operare umano; ma chi opera in vista della felicità è inquieto, insoddisfatto: si muove nell’ansia, nell’incertezza del suo premio; quando anche ottenga un risultato, sarà sempre spinto a valutarne la consistenza, l’adeguatezza agli sforzi fatti, a confrontarlo con le proprie aspettative, con i risultati altrui. L’operare mosso dalla gioia, invece, non insegue un obiettivo: parte da una certezza. La gioia è la sua origine, non il suo fine. La gioia è un’esperienza che ci accade, non l’oggetto della nostra volontà, della nostra brama. Chi opera per gioia, potremmo dire, ha già ricevuto il premio: è il premio a muoverlo.
Parlare di premio, tuttavia, è ancora inappropriato: un premio è sempre commisurato allo sforzo di cui è ricompensa. La gioia, invece, è smisurata, incommensurabile. È un dono immotivato, senza rapporto alcuno col nostro merito. Un dono sovrabbondante, traboccante, che ci spinge a condividerlo, a donare.
Chi opera in vista della felicità, parte dall’idea di una uguaglianza di principio fra gli uomini. Proprio questa idea, che a noi moderni appare sacrosanta, è ciò che induce al confronto, e infine all’invidia. Se gli uomini sono uguali, anche le loro quote di felicità dovranno esserlo. Quando non lo sono, ci si trova di fronte a un’ingiustizia: la felicità è un bene limitato, quella di uno è tolta all’altro. Che sia Dio a commettere questa ingiustizia, che siano le circostanze storiche, economiche, sociali, che sia lo Stato, il caso, la fortuna, Caino vorrà sempre opporle il suo metro, la sua giustizia. Ma - lo abbiamo visto - questa giustizia è impotente a fare ciò che pretenderebbe.
Scrutando il meglio e il peggio, ha perso di vista il bene. Più acutamente spia il proprio simile, per smascherarlo, meno lo vede. Lo sguardo che calcola e misura non è capace di guardare davvero Abele; è uno sguardo abbattuto, cieco, disperato. Solo la gioia permette, a chi se ne lascia invadere, di vedere il bene, proprio e altrui, di guardare al proprio simile non come a un uguale da guatare con sospetto, ma come a un altro da contemplare e custodire. Solo la gioia - gratuita, incomparabile, inesauribile - se sappiamo attenderla, ascoltarla, ci permette di oltrepassare l’invidia, di uscire dalla penosa meschinità del metro, del confronto e del calcolo, ci permette di donare ciò che ci è stato donato, ciò che siamo, senza altro premio se non la forza che ci muove.
-
> "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - Invidia. Il metro di Caino (di Umberto Fiori)21 aprile 2018, di Federico La Sala
- Invidia. Il metro di Caino - di Umberto Fiori
* DoppioZero, 21 aprile 2018 (ripresa parziale, senza immagini).
Sul tema, nel sito, si cfr.:
NATURA E INTELLIGENZA ASTUTA: UN’UMANITA’ SENZA GRAZIA. Una sollecitazione a pensare (non dal Festival di Filosofia ma) dal mondo di Esopo e di Fedro
Al di là dei "corsi e ricorsi", il filo della tradizione critica. Contro la cecità e la boria dei dotti e delle nazioni ...
 ELVIO FACHINELLI E GIAMBATTISTA VICO: INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. Un segnavia -
PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA. Le "regole del gioco" dell’Occidente e il divenire accogliente della mente.
ELVIO FACHINELLI E GIAMBATTISTA VICO: INDICAZIONI PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA. Un segnavia -
PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA. Le "regole del gioco" dell’Occidente e il divenire accogliente della mente.Federico La Sala
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli (di Federico La Sala).18 aprile 2018, di Federico La SalaFILOSOFIA, PSICOANALISI E MISTICA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..
 FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
FREUD, IL MARE, E "LA MENTE ESTATICA". Un invito a ripensare il lavoro di Elvio Fachinelli
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - AL DI LA’ DI LACAN. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana27 marzo 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana ..... *
Inconscio ergo sumChi dice che è morta? Prima che terapeutica l’invenzione freudiana è una rivoluzione etica. E la scommessa più ardita si chiama “desiderio”. Da assecondare così
di Massimo Recalcati (la Repubblica, Robinson, 25.03.2018)
- Il libro. Ritratti del desiderio di Massimo Recalcati (172 pagine, 14 euro, con le fotografie di Giancarlo Fabbri) è pubblicato da Raffaello Cortina Editore. E’ uscita da pochi giorni una ristampa con una nuova prefazione dell’autore
Che cosa resta della grande lezione di Freud? Cosa resiste della esperienza sovversiva dell’inconscio? Cosa della grande rivoluzione culturale rappresentata dalla psicoanalisi è destinato a non essere cancellato? Il progresso delle neuroscienze, l’affermazione delle psicoterapie cognitivo-comportamentali, la potenza chimica dello psicofarmaco, la promessa di terapie brevi ed efficaci centrate sul cosiddetto “ sintomo bersaglio”, sembra abbiamo messo definitivamente all’angolo la psicoanalisi riducendola a uno spettro condannato a circolare solo nel museo delle cere del Novecento. Lo si grida da più parti e ormai da molto tempo: la psicoanalisi è morta, le sue categorie teoriche irrimediabilmente compromesse da un irrazionalismo di fondo che rifiuta di confrontarsi con la valutazione scientifica, la sua efficacia terapeutica dubbia, la proverbiale lunghezza delle sue cure assolutamente sfasata rispetto al ritmo performativo richiesto dallo spirito del nostro tempo e indice di una fumisteria epistemologica e clinica priva di fondamenti.
Perché allora dovremmo insistere nel difendere tenacemente l’invenzione di Freud? Il nucleo di questa invenzione è etico prima che terapeutico. Se il Novecento è stato il secolo del sacrificio della singolarità schiacciata sotto il peso inumano dell’universale ideologico della Causa, la teoria e la pratica della psicoanalisi, sin dalla sua origine, si è posta al servizio del carattere insacrificabile della singolarità. Non certamente della natura borghese dell’Io o dell’individualismo liberista, ma di quella singolarità assai più ampia che sconfina in zone dell’essere che eccedono la coscienza e la sua illusione (cartesiana) di padronanza. La singolarità irregolare e anarchica dell’inconscio impone infatti di ripensare innanzitutto il concetto stesso di identità. Certamente questo riguarda la sessualità umana che Freud rivela essere sempre parzialmente contaminata da quella infantile e pregenitale come se non esistesse una sessualità cosiddetta “matura”, “genitale”, perché essa vive e si nutre di fantasmi che provengono dalle esperienze infantili del corpo pulsionale.
 Ma la prima vera e grande sovversione etica imposta da Freud è quella che ci costringe a modificare la nostra ordinaria concezione della malattia e della sofferenza psichica. Questo è un contributo ancora attualissimo e nevralgico della psicoanalisi: l’eccessivo compattamento identitario del soggetto non è una virtù da salvaguardare, ma è la vera malattia da curare. La divisione multipla interna al soggetto - tra coscienza, preconscio e inconscio, tra Es, Io e Super- io - ci costringe infatti a ridisegnare la nostra idea della vita umana. L’Io non è mai padrone in casa propria: l’alterità non è innanzitutto esperienza dello straniero che viene dal di fuori, ma del nostro stesso essere, della nostra più propria intimità.
Ma la prima vera e grande sovversione etica imposta da Freud è quella che ci costringe a modificare la nostra ordinaria concezione della malattia e della sofferenza psichica. Questo è un contributo ancora attualissimo e nevralgico della psicoanalisi: l’eccessivo compattamento identitario del soggetto non è una virtù da salvaguardare, ma è la vera malattia da curare. La divisione multipla interna al soggetto - tra coscienza, preconscio e inconscio, tra Es, Io e Super- io - ci costringe infatti a ridisegnare la nostra idea della vita umana. L’Io non è mai padrone in casa propria: l’alterità non è innanzitutto esperienza dello straniero che viene dal di fuori, ma del nostro stesso essere, della nostra più propria intimità.
 L’inconscio freudiano è infatti “uno stato nello stato” - un “territorio straniero interno” - che obbedisce a una legislazione che eccede radicalmente quella che governa il funzionamento normativo dell’Io. Nei sogni, nelle nostre più quotidiane sbadataggini, nei lapsus, nei sintomi di una singolarità eccedente l’Io parla, manifesta la propria voce dissonante disturbando il funzionamento diurno della coscienza e del pensiero. Ne deriva, appunto, un’inedita concezione della malattia e della sofferenza psichica che scaturirebbe non tanto da una assenza o da una debolezza dell’Io, ma da una sua postura troppo rigida, da una mancanza di democrazia interna che vorrebbe escludere la voce dell’inconscio dal parlamento interno del soggetto. Se queste procedure egoico-narcisistiche di esclusione si rafforzano, se il soggetto persegue una rappresentazione solo ideale di sé stesso finalizzata a scongiurare l’esistenza di quelle parti di sé giudicate “incompatibili” con questo stesso Ideale, la vita si atrofizza e si ammala. È un principio clinico che riguarda tanto la vita individuale quanto quella collettiva: i confini che disegnano la nostra identità devono essere plastici, capaci più di integrare lo straniero interno che di scindere e segregare. La psicoanalisi incoraggia una politica anti-segregativa.
L’inconscio freudiano è infatti “uno stato nello stato” - un “territorio straniero interno” - che obbedisce a una legislazione che eccede radicalmente quella che governa il funzionamento normativo dell’Io. Nei sogni, nelle nostre più quotidiane sbadataggini, nei lapsus, nei sintomi di una singolarità eccedente l’Io parla, manifesta la propria voce dissonante disturbando il funzionamento diurno della coscienza e del pensiero. Ne deriva, appunto, un’inedita concezione della malattia e della sofferenza psichica che scaturirebbe non tanto da una assenza o da una debolezza dell’Io, ma da una sua postura troppo rigida, da una mancanza di democrazia interna che vorrebbe escludere la voce dell’inconscio dal parlamento interno del soggetto. Se queste procedure egoico-narcisistiche di esclusione si rafforzano, se il soggetto persegue una rappresentazione solo ideale di sé stesso finalizzata a scongiurare l’esistenza di quelle parti di sé giudicate “incompatibili” con questo stesso Ideale, la vita si atrofizza e si ammala. È un principio clinico che riguarda tanto la vita individuale quanto quella collettiva: i confini che disegnano la nostra identità devono essere plastici, capaci più di integrare lo straniero interno che di scindere e segregare. La psicoanalisi incoraggia una politica anti-segregativa.
 La prima grande lezione etica della psicoanalisi consiste nel favorire una concezione indebolita della soggettività che consenta il transito e l’apertura in alternativa a ogni sua illusione identitaria di padronanza che finisce per irrigidire i propri confini contribuendo alla loro chiusura.
La prima grande lezione etica della psicoanalisi consiste nel favorire una concezione indebolita della soggettività che consenta il transito e l’apertura in alternativa a ogni sua illusione identitaria di padronanza che finisce per irrigidire i propri confini contribuendo alla loro chiusura.Quale è il volto dello straniero che si tratta di accogliere? Innanzitutto quello del desiderio che esprime la dimensione radicalmente insacrificabile della singolarità. Si tratta di un’altra grande e ardita scommessa della psicoanalisi: non contrapporre la ragione al desiderio - come la luce all’ombra - ma fare della “ voce del desiderio” la voce stessa della ragione. È questo un punto nevralgico presente nel pensiero di Freud, ripreso con forza da Lacan: non solo la vita si ammala per un eccesso di solidificazione dell’identità, ma anche quando essa volta le spalle alla chiamata del desiderio, quando tradisce la sua attitudine, la sua vocazione, il suo talento fondamentale. Questo desiderio - assimilato kantianamente da Freud alla “voce della ragione” - non può essere normalizzato, irreggimentato, assoggettato da nessun principio, compreso quello di realtà. La difesa della singolarità comporta l’opzione per un pensiero laico, anti-dogmatico, anti-fondamentalista, critico nei confronti di ogni tentativo di assimilazione del singolare nelle procedure anonime dell’universale.
 È il tratto, se si vuole, irriducibilmente “ femminista” della psicoanalisi: la cura è cura per il particolare, per la sua differenza assoluta, per l’incomparabile, per la vita non nel suo statuto generico e biologico ma nel suo nome proprio, nel suo volto unico e irriproducibile. Questo comporta un attrito fatale nei confronti di tutte le pratiche di normalizzazione autoritaria e di medicalizzazione disciplinare della vita. La vita del desiderio - la vita della singolarità - è sempre vita storta, difforme, deviante, bizzarra, anomala.
La psicoanalisi opta per l’accoglienza di questo “straniero interno” come condizione di possibilità per l’accoglienza della vita in tutte le sue forme più divergenti. Essa contrasta politicamente ogni conformismo del pensiero, ogni attitudine all’adattamento passivo, ogni ideale moralistico di normalità. Non esiste infatti mai un “rapporto giusto col reale”, affermava Lacan. Ciascuno ha il compito di trovare la propria misura della felicità.
È il tratto, se si vuole, irriducibilmente “ femminista” della psicoanalisi: la cura è cura per il particolare, per la sua differenza assoluta, per l’incomparabile, per la vita non nel suo statuto generico e biologico ma nel suo nome proprio, nel suo volto unico e irriproducibile. Questo comporta un attrito fatale nei confronti di tutte le pratiche di normalizzazione autoritaria e di medicalizzazione disciplinare della vita. La vita del desiderio - la vita della singolarità - è sempre vita storta, difforme, deviante, bizzarra, anomala.
La psicoanalisi opta per l’accoglienza di questo “straniero interno” come condizione di possibilità per l’accoglienza della vita in tutte le sue forme più divergenti. Essa contrasta politicamente ogni conformismo del pensiero, ogni attitudine all’adattamento passivo, ogni ideale moralistico di normalità. Non esiste infatti mai un “rapporto giusto col reale”, affermava Lacan. Ciascuno ha il compito di trovare la propria misura della felicità.
 La psicoanalisi è una teoria critica della società: il potere che impone una misura unica della felicità diviene necessariamente totalitario. La sua vocazione è antifascista nel senso più radicale e militante del termine: veglia affinché la tentazione autoritaria che spinge l’uomo verso il padrone o verso il suo carnefice che promette la tutela autoritaria da ogni rischio che la libertà della vita fatalmente impone, sia avvistata per tempo.
La psicoanalisi è una teoria critica della società: il potere che impone una misura unica della felicità diviene necessariamente totalitario. La sua vocazione è antifascista nel senso più radicale e militante del termine: veglia affinché la tentazione autoritaria che spinge l’uomo verso il padrone o verso il suo carnefice che promette la tutela autoritaria da ogni rischio che la libertà della vita fatalmente impone, sia avvistata per tempo.
 La psicoanalisi svela che esiste nell’uomo una tendenza pulsionale ad amare più le catene della propria libertà, a disfarsi del proprio desiderio, a consegnarsi nelle mani di una autorità che, in cambio della cessione della propria libertà, assicurerebbe la protezione della vita. È la dimensione “fascista” della psicologia delle masse che costituisce un grande capitolo della ricerca sociale e politica della psicoanalisi oggi più che mai attuale.
La psicoanalisi svela che esiste nell’uomo una tendenza pulsionale ad amare più le catene della propria libertà, a disfarsi del proprio desiderio, a consegnarsi nelle mani di una autorità che, in cambio della cessione della propria libertà, assicurerebbe la protezione della vita. È la dimensione “fascista” della psicologia delle masse che costituisce un grande capitolo della ricerca sociale e politica della psicoanalisi oggi più che mai attuale.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
 CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLIPSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" -- Il tizio che mi guarda dallo specchio: "Lo spettacolo di sé. Filosofia della doppia personalità" (di Paolo Godani).16 febbraio 2018, di Federico La Sala
UN PASSO AL DI LÀ DEL NARCISISMO E DELL’EDIPO: "SE’ COME UN ALTRO". OSSERVARE SE STESSI, SE STESSE ... CON "SIMPATIA"! *
- PER "un’etica della non-coincidenza con sé quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”». nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”» (Paolo Godani).
Il tizio che mi guarda dallo specchio
di Paolo Godani (Alfabeta-2, 11.02.2018)
- Barbara Chitussi, Lo spettacolo di sé. Filosofia della doppia personalità, Meltemi, 2018, 298 pp., € 16
L’attuale eclissi della psicanalisi, cioè la marginalizzazione della sua posizione epistemologica e della sua funzione sociale in favore delle scienze cognitive, è un’ottima notizia per almeno due ragioni. Innanzitutto perché, come alcuni segni già invitano a immaginare, c’è la possibilità che la psicanalisi stessa, da una posizione di minorità, torni a produrre qualcosa di interessante. Ma anche perché può ora riapparire, in tutto lo splendore che la bolla psicanalitica aveva lungamente offuscato, l’immenso patrimonio della ricerca psichiatrica, soprattutto francese, cresciuta nella seconda metà del XIX secolo.
Jean-Martin Charcot, Théodule Ribot, Alfred Binet, Pierre Janet, solo per nominare gli autori un tempo più celebri di questa età dell’oro della psicologia francese, non sono stati soltanto curiosissimi ricercatori sperimentali, ma anche e soprattutto inventori di ipotesi, spiegazioni, concetti che ancora sfidano l’asfissia della cultura contemporanea.
 Lo dimostra brillantemente Barbara Chitussi che in un saggio appena uscito da Meltemi non solo, quasi come in un romanzo, mette in scena i casi clinici, le storie fantastiche di personalità multiple di cui si sono occupati gli psichiatri francesi, ma ne trae il materiale teorico per costruire una vera e propria filosofia della personalità. «Se mi sono occupata dell’analisi di questi casi - spiega l’autrice fin dall’introduzione - è stato per studiare in una prospettiva filosofica le strategie con le quali il soggetto si è pensato e costruito nella forma di un rapporto con sé, accettando di essere un personaggio, assumendo l’inautenticità della propria immagine, aprendosi al dominio della finzione attraverso l’imitazione dell’altro, o meglio osservandosi come uno spettatore osserva uno spettacolo».
Lo dimostra brillantemente Barbara Chitussi che in un saggio appena uscito da Meltemi non solo, quasi come in un romanzo, mette in scena i casi clinici, le storie fantastiche di personalità multiple di cui si sono occupati gli psichiatri francesi, ma ne trae il materiale teorico per costruire una vera e propria filosofia della personalità. «Se mi sono occupata dell’analisi di questi casi - spiega l’autrice fin dall’introduzione - è stato per studiare in una prospettiva filosofica le strategie con le quali il soggetto si è pensato e costruito nella forma di un rapporto con sé, accettando di essere un personaggio, assumendo l’inautenticità della propria immagine, aprendosi al dominio della finzione attraverso l’imitazione dell’altro, o meglio osservandosi come uno spettatore osserva uno spettacolo».Tutto è iniziato, si potrebbe dire, negli anni che seguono il 1875, quando la Francia sembrava attraversata da un’epidemia di personalità multipla. Tra i casi anonimi, raccolti dal dottor Krishaber e analizzati da Émile Littré, c’è chi «voleva parlare, ma fu costretto a interrompersi, tanto il suono della sua voce lo stordiva», chi credeva di «non essere di questo mondo», chi sentiva in sé stesso «un io che pensa e un io che esegue». Ma, come accade spesso, il brusio delle voci senza volto finisce per raccogliersi nel fulgore di un nome che quelle voci, tutte, le fa risuonare assieme. «Racconterò - spiega in un articolo del 1876 il chirurgo-psicologo Eugène Azam - la storia di una giovane donna la cui esistenza è tormentata da un’alterazione della memoria che non ha precedenti nella scienza; l’alterazione è tale che è lecito chiedersi se questa giovane donna non abbia due vite». La ragazza di cui parla Azam si chiama Félida, è «bruna, di statura media», molto intelligente e piuttosto istruita, seria, taciturna, grande lavoratrice, «di carattere triste e persino cupo». O meglio, triste e cupa Félida appare di solito sino al momento della sua crisi. Le accade infatti, talvolta, di cadere improvvisamente nel sonno e di risvegliarsi in uno stato che non è più quello nel quale si era addormentata: «solleva la testa e aprendo gli occhi saluta sorridendo i nuovi arrivati, la sua fisionomia si illumina emanando allegria». Dopo il sonnellino o la catalessi, insomma, «il suo carattere è completamente cambiato; da triste è diventata allegra e la sua vivacità raggiunge l’impetuosità, la sua immaginazione è più esaltata». Per spiegare che cosa significhi e come possa accadere che la malinconica Félida-1 lasci il posto all’estroversa Félida-2, gli psicologi si lanciano nell’invenzione di nomi e concetti: amnesia periodica, raddoppiamento o sdoppiamento della vita, doppia coscienza o doppia esistenza, per arrivare alla nozione più carica di conseguenze: sdoppiamento della personalità.
Come nota con finezza Barbara Chitussi, gli psicologi che a proposito del caso di Félida iniziano a parlare di doppia personalità, operano a loro volta uno sdoppiamento dello stesso termine di personalità. Non più sinonimo di coscienza o di vita, la personalità torna ora a riavvicinarsi al significato originario del latino persona: avere una personalità significa ormai «indossare una maschera, avere un particolare modo di essere». Passaggio decisivo, con ogni evidenza, che consentirà a Pierre Janet di verificare la distinzione tra un moi interiore e un moi esteriore, tra un sentimento della pura esistenza di sé, cioè di un’esistenza indipendente da qualsivoglia attributo, qualità o maschera, e un sentimento della propria personalità, che come tale è complessa e variabile, nonché esteriore rispetto al mero sentimento dell’esistenza. Ma passaggio decisivo, questo, lo è soprattutto perché stabilisce che la personalità di ognuno non è un che di sostanziale, ma semmai un modo, una maniera di essere, una postura, un’immagine che può essere assunta o rigettata, un abito che si può indossare, ma anche cambiare e sostituire.
Da qui in avanti, il percorso dell’autrice attraversa una molteplicità di campi all’interno dei quali la questione della personalità, confrontata con problematiche diverse come lo sdoppiamento nel sogno, la costruzione immaginaria di un sé ideale in quello che si chiamerà «bovarismo», le questioni della co-coscienza e della doppia moralità, assume nuove connotazioni. Ma questa varietà di campi problematici - ognuno con i suoi casi singolari che rendono Lo spettacolo di sé così avvincente (fra cui non si può passare sotto silenzio l’affascinante e riottosa Sally, una delle personalità della «famiglia Beauchamp», analizzata da Morton Prince) - non toglie nulla alla compiutezza filosofica del testo.
La sua tesi fondamentale è che il soggetto è un rapporto, cioè che la formazione soggettiva di ognuno avviene sempre e soltanto attraverso lo sdoppiamento di sé, prendendo distanza da ciò che si è o si crede di essere, trattando se stessi come altri. In questo senso, il sé figura come una contrattazione continua, come un campo sul quale si alternano una pluralità di caratteri o personaggi, nessuno dei quali può affermare di essere l’autentico rappresentante del soggetto.
 «Ripensare il paradigma della personalità-maschera - spiega di conseguenza
l’autrice - significa [anche] disancorare nuovamente la vita personale [...] dall’ottusa identità della vita biologica». Infine, è ancora un’etica della non-coincidenza con sé, quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”».
«Ripensare il paradigma della personalità-maschera - spiega di conseguenza
l’autrice - significa [anche] disancorare nuovamente la vita personale [...] dall’ottusa identità della vita biologica». Infine, è ancora un’etica della non-coincidenza con sé, quella che Barbara Chitussi definisce, quando spiega che «l’identificazione con la maschera [...] non dà mai la felicità, mentre nello spazio che abbiamo imparato a chiamare rapporto conoscere se stessi significherà osservarsi e godere di sé come l’attore che prova per il proprio ruolo un sentimento di “simpatia”».
*
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DAL "CHE COSA" AL "CHI": NUOVA ERMENEUTICA E NUOVO PRINCIPIO DI "CARITÀ"! DELLA TERRA, IL BRILLANTE COLORE.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" - "Il disago del desiderio" (Paola Marion). Dalla tradizione freudiana alle sfide di oggi (di Silvia Vegetti Finzi).8 febbraio 2018, di Federico La Sala
Psicologia
Dalla tradizione freudiana alle sfide di oggi, il saggio di Paola Marion (Donzelli)
La tecnologia ha sconnesso persino il triangolo di Edipo
di Silvia Vegetti Finzi (Corriere della Sera, 08.02.2018)
Nel secolo scorso due avvenimenti epocali hanno infranto il paradigma della procreazione umana: la sessualità si è resa autonoma dalla generazione e, successivamente, la procreazione si e disgiunta dalla sessualità. Si tratta di profonde infrazioni nella concezione che abbiamo di noi stessi, dei rapporti con gli altri, con la natura, la società, l’etica e la storia. Ma, come accade per i traumi più gravi, abbiamo preferito rimuoverli o minimizzarli considerandole come forme di liberazione o interventi terapeutici. Solo in un secondo tempo, nell’ après coup che separa il trauma dalla sua elaborazione, è iniziato quel lento, doloroso processo di consapevolezza che porta a valutare le conseguenze reali e fantastiche, oggettive e soggettive di quanto è accaduto fuori e dentro di noi, come si ripromette il saggio della psicoanalista Paola Marion, Il disagio del desiderio, pubblicato da Donzelli.
Si tratta di un libro tanto opportuno quanto esauriente, rivolto non solo agli addetti ai lavori ma a tutti, perché nessuno può considerarsi indifferente rispetto ai quesiti che questa epoca ci pone.
Invitando il lettore ad affrontare un ambito così mobile e complesso, Paola Marion fornisce, nella prima parte del libro, le competenze storiche e teoriche necessarie per seguirla in un’esplorazione psicoanalitica appassionante e innovativa. Poiché le biotecnologie procedono espellendo il sesso dalla procreazione, la sua ricerca prende le mosse proprio dalla sessualità che la psicoanalisi aveva posto al centro della vita biologica e psichica.
Integrando la teoria freudiana, che privilegia la pulsione, con quella post-freudiana, che sottolinea gli aspetti relazionali della sessualità, l’autrice appronta un dispositivo teorico e clinico particolarmente idoneo a cogliere la complessità dei mutamenti in atto. Primo tra i quali la disintegrazione del triangolo edipico (formato da padre, madre, figlio), gravato, come effetto delle biotecnologie, da un eccesso di protagonisti. Nella gravidanza indotta con dono di gameti e condotta per conto terzi, ad esempio, le madri possono essere tre: genetica, portante, committente.
La «vertigine tecnologica» tende ad annullare i limiti e le differenze tra le generazioni, i sessi e le posizioni. È possibile generare da soli, con partner dello stesso sesso, dopo l’età feconda, post mortem e così via. Ma queste soluzioni impreviste pongono richieste psicologiche ed etiche sempre più impegnative. Il comprensibile desiderio di prolungare la propria vita si può trasformare in un bisogno necessario e insopprimibile che conduce a una pericolosa coazione a ripetere.
L’autrice conclude la sua discesa verso le profondità della psiche con un appello alla responsabilità verso se stessi e verso gli altri.
Lo stesso che, in una magistrale introduzione, esprime Giuliano Amato, preoccupato che uno sviluppo illimitato delle nostre potenzialità trasformative possa «creare intorno a noi un contesto nel quale non siamo più in grado di riconoscerci». Dietro le neutrali finalità terapeutiche della fecondazione medicalmente indotta si cela un ventaglio di desideri e di possibilità che minacciano, tra l’altro, l’interesse prioritario del nascituro.
Ma, prima di affidare al legislatore il compito di dirimere una materia così intricata e sfuggente, Amato chiede a tutte le componenti della società di interrogarsi e di confrontarsi in una dimensione etica perché «è solo l’etica che può entrare nelle coscienze e qui dettare, quando serve, il comando giusto».
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - AL DI LA’ DI "PIGMALIONE". Diffido dell’istruzione (di Alessandro D’Avenia).6 febbraio 2018, di Federico La Sala
"PIGMALIONE", UNA "FIGURA" NARCISISTICA ED EDIPICA, ANCORA MODELLO DI ESSERE UMANO E DI MAESTRO?!
- L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore. Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale (...) Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi (Alessandro D’Avenia)
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
Diffido dell’istruzione
di Alessandro D’Avenia (Corriere della Sera, 05.02.2018)
«Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. Ho visto ciò che nessuno dovrebbe vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti, bambini avvelenati da medici ben formati, lattanti uccisi da infermiere provette, donne e bambini uccisi e bruciati da diplomati e laureati. Diffido - quindi - dell’istruzione. Aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri formati, degli psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti. La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non servono a rendere i nostri figli più umani».
 Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.
Fu il compianto dirigente della mia scuola, qualche anno fa, a condividere questa lettera apparsa su Le Monde in un pezzo della scrittrice Annick Cojean. L’occasione era il Giorno della Memoria, ricorrenza sterile se non ricorda un fatto che il XX secolo ha inciso nella storia a caratteri di sangue: non basta essere istruiti per essere umani.Il divorzio tra istruzione ed educazione è uno dei mali peggiori della scuola, frutto del luogo comune secondo cui esisterebbe un’istruzione neutra. Invece sempre si educa mentre si istruisce, perché la prima comunicazione è quella dell’essere, e solo dopo arrivano le parole, altrimenti non sarebbe necessaria la relazione viva con i ragazzi, ma basterebbe caricare le lezioni sulla rete. In senso stretto non esiste insegnamento in differita , ma solo in diretta.
Insegnare è una branca della drammaturgia. È l’essere dell’insegnante che genera la conoscenza, perché apre la via al desiderio dello studente, che scorge nel docente una vita più viva e libera grazie alla cultura e al lavoro ben fatto, e la vuole anche per sé. Lo ricordava con precisione il Nobel Canetti nella sua autobiografia: «Ogni cosa che ho imparato dalla viva voce dei miei insegnanti ha conservato la fisionomia di colui che me l’ha spiegata e nel ricordo è rimasta legata alla sua immagine. È questa la prima vera scuola di conoscenza dell’uomo».
Le nozioni più raffinate da sole non rendono umani, tutto dipende da come gli insegnanti si relazionano tra loro e con i ragazzi, perché, prima delle nozioni, sono le relazioni a essere generative dell’io e del sapere. È nella relazione che si impara a sentire il valore del sé come destinatario del dono del sapere. Quali insegnanti siete tornati a ringraziare e per cosa? Per la lezione sulle leggi della termodinamica e su Leopardi, o per come vivevano e offrivano la termodinamica e Leopardi proprio a voi?
Qualche tempo fa mi scriveva uno studente: «Le racconto due esperienze. La prima: la faccia polverosa della scuola. Un professore, che aveva esordito in prima liceo con “siete troppi: vi ridurremo”, pochi giorni fa ha condensato l’amore per il suo lavoro in questa frase: “Un insegnante non deve avere cuore, deve avere un cuore di pietra... altrimenti farà preferenze”. Uno scherzo, pensavamo. Un mio compagno ribatte: “Ma no, prof! Un insegnante deve avere un cuore talmente grande da non fare nessuna preferenza!”. “No, no: un cuore di pietra”. Parlava seriamente. La seconda: la faccia luminosa della scuola. Quest’anno ho scoperto la poesia grazie al gesto straordinario di un ordinario professore di filosofia, che un giorno ci ha parlato della sua giovinezza e di come la poesia ai tempi occupasse la sua vita e impegnasse la sua fantasia. Interessato anche io dal momento che non avevo letto nessun grande poeta ho chiesto un consiglio. Il giorno seguente lo vedo estrarre dalla sua ventiquattrore un libricino invecchiato. Viene verso di me. “Questo è per te”. Mi ha regalato una delle sue copie di Elegie duinesi, di R.M. Rilke, il suo libro di poesia preferito. Il libro della sua giovinezza!».
La differenza tra le due impostazioni è proprio quella che corre tra chi si illude si possano separare istruzione ed educazione e chi invece le tiene naturalmente unite. Nel primo caso si pensa che il docente sia un distributore di nozioni, nel secondo la didattica è conseguenza della relazione. Il primo professore educa all’insensibilità di cuore, a non sentire l’unicità del tu, il secondo rende Rilke interessante prima di averne letta una riga. Il nesso che tiene unite istruzione ed educazione è nella realtà, e nessuna presa di posizione teorica le può nei fatti separare. L’elemento che fa sì che educazione e istruzione siano in efficace armonia è l’amore.
Niente di sentimentale: l’amore è una presa di posizione nei confronti della realtà e ne permette la conoscenza, perché ne coglie il valore ancora potenziale da portare a compimento con l’impegno personale. Non si può aumentare la conoscenza di qualcosa senza che prima aumenti l’interesse nei confronti del soggetto in questione (vale per l’amicizia come per la chimica). L’amore genera conoscenza e la conoscenza ampliata rinnova l’amore: se il docente non «erotizza» la materia, la materia per quanto ben conosciuta resta inerte, come spiega Massimo Recalcati.
Non esistono cose poco «interessanti», ma uomini e donne poco «interessati», perché le emozioni (la neurobiologia qui ci conforta) sono le guide che aprono la strada allo sviluppo cognitivo. Solo così gli studenti diventano soggetti di possibilità e non oggetti al peggio da ridurre o al meglio da riempire. È questa la rivoluzione copernicana chiesta a ogni docente: non sono gli alunni a ruotare attorno a lui ma il contrario. Un professore - il letto da rifare oggi lo suggerisce lo studente della lettera - è chiamato ad avere un cuore tale da non far preferenze perché preferisce tutti e ciascuno diversamente: sfida difficilissima (quanti errori, quante gioie...) ma decisiva.
È la stessa sfida narrata da Ovidio, nelle sue Metamorfosi, a proposito del mito di Pigmalione. Uno scultore che, deluso da tutte le donne, si innamora della donna ideale che ha scolpito nel marmo. Il suo trasporto è tale che gli dei trasformano la statua in una donna in carne e ossa. Il mito viene usato per descrivere lo sguardo educativo, il cosiddetto effetto-Pigmalione, per il quale se un docente (ma vale per ogni educatore) guarda un alunno convinto che farà bene, genererà in lui una fiducia in sé tale che, nella quasi totalità dei casi, anche a fronte di un’inadeguata disposizione iniziale, otterrà risultati positivi.
L’effetto vale anche in negativo: se sono convinto che non vali, l’effetto sui risultati sarà coerente, anche a fronte di buone capacità. Lo sguardo educante non è mai neutro ma sempre profetico, nel bene e nel male. Ne abbiamo conferma quotidiana nel bambino che, appena caduto, si volge verso i genitori: se si mostrano allarmati ne provocano il pianto, se sorridenti il sorriso, quasi che il dolore, pur oggettivo, venga trasformato nello e dallo sguardo.
I ragazzi non hanno bisogno di insegnanti amiconi né aguzzini, ma di uomini e donne capaci di guardarli come amabili soggetti di inedite possibilità a cui non fare sconti. E non è questione di missione o di poteri magici, ma di professionalità. Per questo l’appello è il momento chiave della giornata scolastica: segna il tono della relazione e fa sì che ognuno senta su di sé lo sguardo profetico che spinge a far bene come conseguenza dell’ esser bene. Il contrario del «siete troppi, vi ridurremo», sterile autoritarismo, è il fecondo «sei unico, ti aumenterò».
La parola autorità viene da augeo (aumentare): la esercita non chi ha il cuore molle o sprezzante, ma chi si impegna ad aumentare la vita che ha di fronte, per quanto fragile, difficile, resistente possa sembrare. Questa è l’istruzione di cui non diffido, perché ispirata da un umanesimo maturo, l’umanesimo dell’altro uomo, come lo chiama il filosofo Lévinas, che fa del tu il cuore dell’etica e smaschera il falso umanesimo dell’istruito incapace di sentire il tu, tanto da distruggerlo proprio attraverso l’istruzione.
Non è facile però essere educatore in un sistema scolastico che asfissia di burocrazia e svilisce la dignità sociale ed economica, e in un contesto culturale che spesso attacca dall’alto (genitori) e dal basso (studenti). Ma questi elementi possono anche diventare scuse per non fare ciò che è alla portata di un uomo libero: prendersi cura di chi gli viene affidato.
Soltanto così diventiamo pigmalioni di ragazzi dal cuore caldo e la testa fredda, a fronte del dilagare, tra gli adulti prima che tra i giovani, di teste calde e cuori freddi.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
-
CHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- L’ Amore (Charitas) non è lo zimbello del tempo e di Mammona (Caritas)!!!
 OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
OBIEZIONE DI COSCIENZA!!! L’OBBEDIENZA NON E’ PIU’ UNA VIRTU’. LETTERA AI CAPPELLANI MILITARI. LA LEZIONE DI DON LORENZO MILANI
- "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - UN "DISPOSITIVO DI SESSUALITÀ" E LA LIBERTÀ DI IMPORTUNARE . Je ne suis pas Catherine Deneuve Je ne suis pas Catherine Deneuve (di Ida Dominijanni).11 gennaio 2018, di Federico La Sala
FEMMINISMO
Je ne suis pas Catherine Deneuve
di Ida Dominijanni, giornalista *
La scoperta delle molestie e dei ricatti sessuali in uso a Hollywood e in tutto il mondo del lavoro americano dimostra che questi non sono tempi buoni né per il desiderio né per l’esercizio della sessualità fra donne e uomini. Com’era già accaduto in Italia con gli scandali sessuali d’epoca berlusconiana, quello che viene alla luce non è solo la tentazione maschile perenne all’abuso di potere, che riduce le donne a oggetto da possedere e la libertà femminile a disponibilità di concedersi. È anche, forse soprattutto, una diffusa miseria della sessualità maschile, che scambia potere, favori, assunzioni in cambio di briciole come un massaggio sotto un accappatoio, una masturbazione a cielo aperto, un assoggettamento a una virilità incerta. Una miseria sessuale che è parente stretta di una miseria relazionale, ovvero di una altrettanto diffusa incapacità maschile di relazionarsi all’altra, al suo desiderio e ai suoi dinieghi, alla sua forza e alla sua vulnerabilità, alla sua libertà e alle sue necessità.
Precisamente il cinema hollywoodiano, a ben guardare, ci aveva lentamente abituato, nell’ultimo decennio, a questo progressivo immiserimento, per non dire scomparsa, della sessualità nelle relazioni fra uomini e donne, con un sottile ma percettibile scivolamento dalle scene di sesso passionale degli anni novanta a quelle quasi sempre giocate successivamente su un ambiguo confine fra sesso e violenza, sesso e possesso, sesso e performance. E del resto basterebbe il successo sorprendente, e non a caso contemporaneo al #metoo, di un racconto come Cat person per farsi un’idea dello stato delle cose: in questo caso non c’è ombra di violenza né di molestie, ma la miseria sentimentale è la stessa, l’alfabeto della seduzione è precipitato nel dimenticatoio e ogni passione è spenta.
Quello che sta saltando con il #metoo e il Time’s up è il tappo di silenzio-assenso femminile che copriva questa situazione. A un primo sguardo, certo, si tratta di movimenti contro le molestie e i ricatti sessuali, e contro l’abuso di potere maschile che c’è dietro. Ma com’era già avvenuto in Italia pochi anni fa, la presa di parola femminile ha l’effetto di svelare qualcosa di più profondo, un “dispositivo di sessualità”, per dirlo con l’espressione di Foucault, in cui il desiderio non ha più posto e il sesso è ridotto a contrattazione, ricatto, performance. E da cui è urgente uscire, se i destini della sessualità come espressione libera e creativa della specie umana ci stanno a cuore.
- La Francia è la Francia, e pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”
Perciò è del tutto fuori campo e fuori fuoco la reazione, finora prevalentemente maschile nonché prevalentemente italiana, di chi ulula che all’esito del #metoo ci sarebbe l’oscurantismo politically correct di un totalitarismo (sic!) proibizionista e sessuofobico.
 È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
È vero l’esatto contrario: il #metoo, e in generale la presa di parola femminile contro l’andazzo corrente della miseria del maschile, nasce in una situazione che ha già mandato a morte la sessualità, e forse più farla risorgere, una volta liberata dal dispositivo di cui sopra.
 Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.
Non stupisce che a non capirlo sia, in Italia, lo stesso fronte mediatico, il Foglio in testa, che agitò gli stessi fantasmi liberticidi, sessuofobici e proibizionisti a tutela della “libertà” e della “seduzione” che circolava nelle “cene eleganti” di Berlusconi, già allora paventando e minacciando la fine dell’ars amatoria, la censura della passione, l’inibizione del corteggiamento, e impugnando l’inscindibilità del sesso da una certa dose (quale, esattamente?) di prevaricazione, o l’indecidibilità fra molestia e avance.Stupisce di più - ma in fondo neanche tanto - che a usare gli stessi argomenti sia adesso un gruppo di donne francesi - intellettuali, artiste, attrici, psicoanaliste, giornaliste, fra le altre una campionessa riconosciuta della seduzione doc come Catherine Deneuve - le quali si lanciano nella difesa della “libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale”, come se il #metoo avesse già instaurato un regime del divieto dove nessuno può sporgersi sull’altra e nessuna sull’altro, il nemico delle donne sono gli uomini nella loro totalità, la parola femminile, altro che liberarsi, si autoimprigiona in un codice politically correct autoinibitorio, e le donne, altro che guadagnarci qualcosa, si auto-segregano nel ruolo di “eterne vittime dominate da demoni fallocrati”. Potenza dei fantasmi maschili interiorizzati anche dalla mente femminile, o “differenza culturale” francese vs egemonia “puritana” americana? L’una e l’altra cosa, probabilmente, e la seconda non meno influente della prima.
Non c’è donna al mondo che non sappia distinguere un “corteggiamento insistente e maldestro” da uno stupro, come le firmatarie dell’appello francese temono: esse stesse non possono non saperlo. Non c’è persona sana di mente che non possa aver registrato, seguendo le vicende del #metoo o più semplicemente la recente cerimonia dei Golden Globe sotto il segno del Time’s up, che tutto circola fra le silence breakers americane tranne un’autovittimizzazione inerziale e passiva: tutta la faccenda sembra al contrario parecchio empowering, e parecchio liberatoria anche per quegli uomini che la guardano con curiosità e fiducia invece che attaccarsi come Francesca Bertini alle tende di una virilità decadente. E anche questo le consorelle francesi non possono non averlo notato.
 Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
Ma si sa che la Francia è la Francia, e quand’è in gioco la sacra triade della modernità pretende sempre di avere l’ultima parola, a costo di far diventare la libertà “libertà di importunare”, o, come ai tempi di Charlie Hebdo, liberté d’impertinence, sottospecie opinabile della libertà d’espressione.
 Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.
Ma il politically correct gioca brutti scherzi . Allora fu molto politically correct, e conformista, lo slogan “Je suis Charlie Hebdo”, e molto politically uncorrect, e anticonformista, arrogarsi il diritto di dire “Je ne suis pas Charlie Hebdo”: negli Stati Uniti lo rivendicarono in molti, anche nella stampa mainstream, in nome di una libertà di religione che non poteva essere conculcata dalla libertà di satira. Questione di punti di vista. Del resto, anche i simboli della seduzione non sono eterni e risentono dell’usura del tempo. A dispetto di uno slogan che ha fatto scuola per generazioni di donne, oggi la palma della seduttività passa a chi può permettersi allegramente di dire “Je ne suis pas Catherine Deneuve”.- L’attrice Catherine Deneuve a Berlino, il 14 febbraio 2017. (John Macdougall, Afp)
* Internazionale, 10 gennaio 2018 (ripresa parziale - senza immagini).
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA"!!! IL MAGGIORASCATO: L’ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE, L’ALLEANZA DELLA MADRE CON IL FIGLIO, REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO
 DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
Ragione ("Logos") e Amore ("Charitas"). Per la critica dell’economia politica ..... e della teologia "mammonica" ( "Deus caritas est": Benedetto XVI, 2006)
 L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana"
L’ILLUMINISMO, OGGI. LIBERARE IL CIELO. Cristianesimo, democrazia e necessità di "una seconda rivoluzione copernicana" -
> "PERVERSIONI" - COME SI VA DALLO STESSO ALLO STESSO. Mario Perniola o del transito (di Sergio Benvenuto).10 gennaio 2018, di Federico La Sala
Mario Perniola o del transito
di Sergio Benvenuto (Doppiozero, 10.01.2018)
Quando già Mario Perniola era molto malato, a casa sua, assieme ad altri amici, qualcuno lanciò una domanda-esca: “se tu fossi completamente libero di scegliere la città o il paese dove vivere, cosa sceglieresti?” Ognuno di noi rispose, e quando venne la volta di Mario, lui disse: “Vorrei essere come quel personaggio che viveva nell’aeroporto di Roissy, perché non gli permettevano di entrare in Francia e nemmeno di ripartire”. Si ricorderà il film di Spielberg The Terminal, dove Tom Hanks incarnava la versione americana di un disgraziato vero, che a Parigi divenne vittima della protervia di un burocrate francese che non gli permise di uscire dalla parte internazionale dell’aeroporto.
Credo che allora, sapendo di morire, Mario abbia detto qualcosa di essenziale di sé: la sua impossibilità di avere una patria elettiva, una radice a cui tornare. Il suo sentirsi sempre su una sorta di borderline, di no man’s land, di luogo interstiziale. Il che pare contraddire la sua biografia, di un professore di estetica ben radicato nel mondo accademico. Credo che abbia espresso bene quel suo “sentire” un libro del 1985, Transiti. Come si va dallo stesso allo stesso. Mario si è sentito sempre in transito, in un Transfer come si dice negli aeroporti. Ma un transito che, circolarmente, riporta a dove si era partiti. Un fascino per il “trans” che produsse il suo unico romanzo, Tiresia del 1968: la storia di un transito da uomo a donna, e viceversa.
Tempo fa, mi confidò che in un certo senso si è sempre sentito un “senza famiglia”: i suoi genitori sin da piccolo lo affidarono ai nonni. Costoro avevano bisogno di un bambino, e lui fu ceduto a loro. Un senza-genitori vezzeggiato, forse viziato, ma pur sempre senza genitori. Che proprio per questo aveva un bisogno molto forte di identificazione, di “appartenere”, pur capendo l’impossibilità di soddisfarlo. Da qui quell’oscillazione che dà una deliziosa vertigine a leggere i suoi libri: quel suo andare da un opposto all’altro, quel che Sartre chiamava “il pensare contro se stessi”. Fino al punto, in Il sentire cattolico, di riconoscersi come cattolico: non credeva affatto in Dio, ma voleva sentirsi italiano, voleva sentirsi qualcosa, voleva sentire di essere qualcuno al di fuori dell’aeroporto. Perciò coniò il termine sensologia in opposizione a ideologia: come a voler cancellare una sorta di obbligata anestesia. Attutire una sua pendenza ai disgusti, titolo di un altro suo libro.
Conobbi Mario nel 1980 grazie al terremoto che colpì l’Irpinia, e anche Napoli, nel novembre 1980. Allora Napoli sembrava una città morta che si leccava le sue numerose ferite, solo depressione e rabbia. Assieme ad alcuni amici pensammo di organizzare un evento culturale che non facesse il minimo riferimento al terremoto. Nel marzo del 1980 invitammo a Napoli Mario Mieli, Mario Perniola e Aldo Carotenuto a tenere un convegno su “Sessualità e diversità”, con proiezioni di film di Genet e Beckett. Vennero migliaia di persone. Fu un happening unico. Mario Mieli, il portavoce del movimento omosessuale in Italia allora più famoso, provocò il pubblico tessendo l’elogio della necrofilia. Intervenne Lucio Amelio, famoso gallerista amico di Andy Warhol, promuovendo i locali di omosessualità sado-maso americani... In quell’occasione direi dionisiaca si strinse quindi un’amicizia tra Perniola e me che non è mai venuta meno nel corso del tempo.
Perniola allora appariva il portavoce di una visione estremista della vita e della filosofia: fautore delle avanguardie più rischiose, di un gauchisme allora però già declinante, fautore del sex appeal dell’inorganico. Io lo vedevo come rappresentante illustre di quello che chiamavo Pensiero 68. Ma mi sbagliavo. Mario non ha mai smesso di transitare. Una fabbrica di idee e di significanti nuovi.
Mario mi ha detto che due uomini - oltre alle donne - avevano marcato la sua esistenza: Luigi Pareyson e Guy Debord. I suoi due padri adottivi, direi.
Pareyson, oltre che essere lui stesso un filosofo di grandissima sensibilità, è stato uno dei padri - è il caso di dirlo - di parte della cultura italiana degli ultimi decenni. Dalla sua scuola torinese sono venuti fuori, oltre Perniola, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Sergio Givone e altri ancora. Pareyson era un accademico cattolico, uno dei massimi interpreti italiani dell’esistenzialismo tedesco, ed era una personalità completamente diversa rispetto ai suoi rampolli, i quali hanno tutti avuto un tratto comune: il cosmopolitismo, una visione essenzialmente libertina e libertaria della vita e della società, l’anti-conformismo, l’apertura alle avanguardie anche più scapigliate. Il fatto che i suoi allievi abbiano preso una strada filosoficamente autonoma non ha fatto mai mancar loro il suo affetto e il suo aiuto. Mario sembrava commosso quando parlava di Pareyson.
Mario mi ha sempre parlato con una punta di amara nostalgia di Guy Debord, conosciuto a Parigi alla fine degli anni 60; fece parte dell’ Internazionale Situazionista, di cui Debord era il leader. Questa era formata da poche persone, eppure oggi essa è ricordata come l’espressione più eloquente del 68. Perniola scrisse che il situazionismo fu l’ultima grande avanguardia del Novecento, come a voler prendere congedo da se stesso. Debord ha rappresentato il lato scontroso, aspro, e in fin dei conti tragico, del 68. Malgrado il nome roboante, l’Internazionale Situazionista era un gruppo di poche decine di persone costituitosi nel 1957 e scioltosi nel 1972. Proponeva una società costituita da Consigli, non solo operai, dove in una sorta di assemblea permanente si sarebbero prese tutte le decisioni. Il situazionismo si vantava di essere un marxismo puro, ed è stato divorato dalla propria smania di purezza.
Negli anni 50 Debord scrisse su un muro di Parigi “Non lavorate mai”, e in effetti lui stesso non ha mai lavorato. Lavorava invece la sua compagna cinese, Alice, proprietaria di un ristorante asiatico. Debord, uomo di cultura raffinata e intriso di letture classiche, era un uomo duro, refrattario, alcolista. Fu a causa dell’alcolismo che si ammalò di polinevrite, per cui nel 1994, a 63 anni, si suicidò sparandosi un colpo di pistola al cuore. Debord è oggi celebre soprattutto per il suo libro La società dello spettacolo, che alcuni considerano il versante di sinistra di una riflessione di cui Marshall McLuhan sarebbe, per così dire, “la destra”. Come gli altri situazionisti, rigettava completamente il mondo dell’università, dell’editoria, del giornalismo, dei media e della politica spicciola. Quando si usciva dall’Internazionale, questo significava anche una rottura personale: Mario ne uscì, e Debord non volle più vederlo. Credo che abbia sempre molto sofferto di questo.
Mario è stato sempre affascinato dalle tecnologie della comunicazione. Sulla linea di Walter Benjamin, ha sempre pensato che il senso di un’opera è inscindibile dalla tecnologia che la produce. Negli ultimi anni era particolarmente affascinato da Wikipedia, forse uno dei pochi esempi riusciti di democrazia conoscitiva: un’Enciclopedia sterminata scritta non da Diderot e d’Alembert, ma dalle masse. Agli esami universitari a Roma 2, i suoi studenti per essere ammessi dovevano mostrare di saper operare con disinvoltura su Wikipedia. Può allora apparire strano che uno dei suoi libri più noti sia Contro la comunicazione, del 2004, titolo su cui si è ironizzato. Come un libro, che è atto di comunicazione per eccellenza, può essere scritto contro la comunicazione? Ma credo che questa sia stata, sempre, la sfida di Mario: in un certo senso, essere sempre contro quello che lui era. Proprio perché capiva che siamo nell’epoca del trionfo della comunicazione, scrivere contro di essa. Anche le sue preferenze per i paesi avevano qualcosa di contraddittorio. Amava molto il Brasile - dove comprò una casa - e il Giappone, paesi che più diversi non si possono concepire.
Togliersi la terra sotto i piedi, che poi, in un certo senso, è stata sempre la viziosa delizia della filosofia.
-
> "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - Morto Mario Perniola. "Poco tenero con la tematica del post-modernismo, vi ha tuttavia recato contribuiti originali" (di G. Vattimo)9 gennaio 2018, di Federico La Sala
Vattimo, 9 gennaio 2018, parla della morte di Mario Perniola *
Mario Perniola, scomparso prematuramente il 9 gennaio (era nato ad Asti nel 1941).
 Ho letto recentemente che il nostro pensiero era in contrapposizione, ma non è così.
Ho letto recentemente che il nostro pensiero era in contrapposizione, ma non è così.Ha costituito una voce estremamente significativa e suggestiva della filosofia italiana degli ultimi decenni. Forse il solo intellettuale italiano capace di misurarsi con le tematiche filosofiche e socio culturali sviluppate negli stessi anni nella cultura francese, a cui Perniola è stato sempre prevalentemente legato.
Cultore dell’eredità di Bataille, del situazionismo, e specialmente vicino agli studi di Jean Baudrillard, ha portato nella sua considerazione della cultura e della società attuale gli elementi più vivi di queste varie eredità.
Fondatore e direttore di numerose riviste, tra cui l’ultima è stata Agalma, ha sempre rifiutato una pratica filosofica troppo attenta all’attualità; e tuttavia la sua passione teorica lo ha condotto a cercare di comprendere e analizzare aspetti anche estremi della condizione umana presente.
Poco tenero con la tematica del post-modernismo, vi ha tuttavia recato contribuiti originali, come per esempio con il libro “Il sex appeal dell’inorganico”.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - di Federico La Sala
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - di Federico La Sala
 La mente estatica e l’accoglienza astuta degli apprendisti stregoni. Una nota sul sex-appeal dell’inorganico di Mario Perniola.
La mente estatica e l’accoglienza astuta degli apprendisti stregoni. Una nota sul sex-appeal dell’inorganico di Mario Perniola.
OCCIDENTE E ORIENTE. Filosofia del "Sol calante" e filosofia del "Sol levante". Profonda frattura o connessione "nascosta"? -- Morto Mario Perniola, il filosofo del super-estetico (di Francesco Gallo)
- Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
-
> "PERVERSIONI" - FILOSOFIA, PSICOANALISI, E INSEGNAMENT0. Dove e come si perde il ruolo del professore. Chat con studentesse (di Ferdinado Camon).5 gennaio 2018, di Federico La Sala
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
Al liceo.
Chat con studentesse
Dove e come si perde il ruolo del professore
di Ferdinando Camon (Avvenire, venerdì 5 gennaio 2018)
Non illudiamoci: noi parliamo raramente, con reticenza e malvolentieri delle simpatie (per usare un termine neutro) che nascono nelle classi tra professori e studentesse, ovviamente delle superiori, tendiamo a minimizzare, ma loro, le studentesse, ne parlano sempre, e le commentano, con tendenza ad esagerare. La conseguenza è che per loro la loro versione è quella vera, e resterà nel loro cervello per tutta la vita. E se c’è una relazione immaginaria tra un prof e una studentessa, che per loro diventa una relazione vera, corredata di chissà quali e quanti incontri di cui nessuno sa niente, quella storia sarà per loro il marchio che contrassegnerà per sempre quella scuola e quegli anni, e per tutta la vita, a ogni rimpatriata, ne riparleranno. Quella storia, quelle storie, saranno più importanti di Hegel e Kant, che pure le hanno tanto impressionate.
Più importanti di Nietzsche, che oggi va per la maggiore. Quando qualcuna di queste storie trapela sui giornali, diventa subito la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia. In questo momento la notizia più letta dalle ragazze in tutta Italia è certamente l’accusa di rapporti inopportuni del prof di filosofia di un liceo romano con alcune studentesse, quattro delle quali hanno presentato denuncia. Due sono minorenni. Ci sarà una causa. Il prof sarà interrogato e sapremo le sue risposte. Finora non c’è una sentenza, e quindi non parliamo di un reato e di una condanna. Parliamo del fenomeno carsico, sempre negato e tuttavia presente in tutte le scuole, dei legami sentimentali che nascono tra insegnanti e allievi.
Anticipo subito, qui ad apertura, una mia vecchia tesi, ma non obbligo nessuno ad accettarla: il professore, di cui le studentesse non s’innamorano, è un cattivo professore; il professore, che s’innamora delle studentesse, è un cattivo professore. Perciò qui, nel caso del liceo romano, per quel che ne sappiamo finora, il problema non è che le studentesse si scambiavano tra loro email sospirose (o anche esplicite) sul professore, il problema è che email sospirose, anzi esplicite e audaci (parole degli studenti) le scambiava il prof con loro.
La difesa del prof sostiene che i messaggi del prof non sono molestie o violenze, perché hanno sempre ottenuto risposta. Da parte delle ragazze (nel caso delle minorenni, potremmo parlare di bambine) c’è insomma il consenso. Ma, a parte il fatto che il consenso delle minorenni non è valido (per questo son dichiarate minorenni), se la relazione vien corrisposta, vuol dire che è andata molto avanti e che è diventata stabile. Per la ragazza, e per la bambina, innamorarsi del prof è un fenomeno di crescita: si sente più grande, diventa più grande.
Per il prof, innamorarsi di una ragazza o una bambina è un fenomeno di de-crescita, e nel caso della bambina di rimbambimento. Il rapporto del prof con i suoi studenti e studentesse non è diverso dal rapporto dell’analista con i suoi e le sue pazienti. In questo caso, come insegna Freud, è inevitabile, utile, necessario che nasca un trasporto affettivo, che Freud chiama transfert. Il transfert è un grosso problema analitico. Per anni Freud lo intese come un ostacolo all’analisi, il paziente s’innamora del suo analista e va in transfert perché vuole uscire dall’analisi, il transfert va dunque combattuto e ignorato, affinché l’analisi prosegua.
Ma alla fine Freud si convinse che il transfert è un nuovo terreno sul quale il paziente replica i suoi problemi e i suoi bisogni, e che dando importanza al transfert e analizzandolo si favorisce l’analisi, e la si porta a compimento. Posso sbagliare (sono uno scrittore, non uno psicanalista), ma ho sempre guardato con sospetto lo psicanalista che si mette con una sua paziente, e la sposa. Mi sembra un rapporto analitico interrotto e deviato. Per la stessa ragione guardo con sospetto il prof che scambia email erotiche con le sue alunne, ancora minorenni o appena maggiorenni: mi sembra un rapporto didattico perduto e non più recuperabile.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
PSICOANALISI E FILOSOFIA. Indicazioni per una seconda rivoluzione copernicana .....
 DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".
DAL LABIRINTO SI PUO’ USCIRE. FACHINELLI, "SU FREUD".Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPOCHI INSEGNA A CHI CHE COSA COME?! QUESTIONE PEDAGOGICA E FILOSOFICA, TEOLOGICA E POLITICA
 INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!
INSEGNAMENTO E COSTITUZIONE: "CHI INSEGNA AI MAESTRI E ALLE MAESTRE A INSEGNARE?"!PER IL "RISCHIARAMENTO" ("AUFKLARUNG") NECESSARIO. ANCORA NON SAPPIAMO DISTINGUERE L’UNO DI PLATONE DALL’UNO DI KANT, E L’IMPERATIVO CATEGORICO DI KANT DALL’IMPERATIVO DI HEIDEGGER E DI EICHMANN !!!
 FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. -
> "PERVERSIONI" -- MASSIMO RECALCATI, IL RITORNO A LACAN, E IL RITORNO A FREUD.30 luglio 2017, di Federico La Sala
LACAN PROPOSE UN “RITORNO A FREUD”, MA A LONDRA, A “20 MARESFIELD GARDENS”, NON ARRIVÒ MAI ... *
- ”(...)” l’importante e imponente ricostruzione del pensiero del grande analista francese portata avanti in questi ultimi anni da Recalcati si configur[a] come un vero e proprio «ritorno a Lacan» (nel senso in cui lo stesso Lacan propose un «ritorno a Freud»), cioè a colui che ha saputo individuare tempestivamente la trasformazione del nostro mondo di relazioni economiche e psicologiche, riconoscendo la declinazione contemporanea delle forme dell’alienazione e proponendo, nel contempo, un armamentario teorico e operativo che fosse all’altezza dei tempi (...) (Giancarlo Alfano, “Massimo Recalcati, ritorno a Lacan”, Alfabeta2, 8 aprile 2016).
LACAN INTERPRETA “KANT CON SADE” E SI AUTO-INTERPRETA CON “L’ORIGINE DEL MONDO” DI COURBET.... **
KANT CON SADE: “Che l’opera di Sade anticipi Freud, foss’anche solo riguardo al catalogo delle perversioni, è una sciocchezza detta e ridetta nelle lettere, la cui colpa, come sempre, va agli specialisti”. Così inizia il testo di J. Lacan, "Kant con Sade", (Scritti, Einaudi, Torino 1974, p. 762).
Sulla “kantizzazione” di Sade e sulla “sadizzazione” di Kant da parte di Lacan, cfr.: E. Fachinelli, “Lacan e la Cosa”, "La Mente estatica", Adelphi, Milano 1989, pp. 181-195; e, sulla più generale “hitlerizzazione” di Kant, si cfr., mi sia consentito, Federico La Sala, FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO. ALLA RADICE DEI SOGNI DELLA TEOLOGIA POLITICA EUROPEA ATEA E DEVOTA).
LACAN E “L’ORIGINE DEL MONDO” (G. Courbet, 1866): “(...) Jacques Lacan conservava L’origine del mondo nascosta dietro un pannello, nello studio della sua casa di campagna, non rivelandone il segreto che agli ospiti d’élite: Dora Maar, Marguerite Duras, Claude Lévi-Strauss... E quando finalmente svelava il dipinto, Lacan concentrava il proprio sguardo non sul monte di Venere, ma sullo sguardo dello spettatore. Si divertiva a farsi voyeur del voyeur” (Sergio Luzzatto, “L’origine del mondo, storia di un tabù”, Corriere della Sera, 24 maggio 2008).
** PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA “KANT CON SADE” E SI AUTO-INTERPRETA CON “L’ORIGINE DEL MONDO” DI COURBET.
Federico La Sala
-
> "PERVERSIONI" -- CARISMA E NARCISISMO. Lo strano paradosso del potere (di Annamaria Testa)25 luglio 2017, di Federico La Sala
CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LÀ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione .... *
- Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo esistono. In oltre quarant’anni, mi è perfino capitato di incontrarne alcune, tra politica e impresa, ma posso contarle sulle dita di una mano. Ce ne vorrebbero molte di più (Annamaria Testa).
- Why We Select Toxic Leaders (David Rock, "Psychology Today", 2016)
PSICOLOGIA
Lo strano paradosso del potere
di Annamaria Testa, esperta di comunicazione *
Che cosa frulla nella mente delle persone di potere? Ce lo domandiamo - e capita non di rado - quando i loro comportamenti ci appaiono contraddittori, o poco comprensibili, o così arroganti da essere difficili da sopportare. Un recentissimo articolo uscito sull’Atlantic ci invita a porci la domanda in termini più radicali: che cosa succede al cervello delle persone di potere?
L’Atlantic cita un paio di pareri autorevoli. Secondo Dacher Keltner, docente di psicologia all’università di Berkeley, due decenni di ricerca e di esperimenti sul campo convergono su un’evidenza: i soggetti in posizione di potere agiscono come se avessero subìto un trauma cerebrale. Diventano più impulsivi, meno consapevoli dei rischi e, soprattutto, meno capaci di considerare i fatti assumendo il punto di vista delle altre persone.
Sukhvinder Obhi è un neuroscienziato dell’università dell’Ontario. Non studia i comportamenti, ma il cervello. Quando mette alcuni studenti in una condizione di potere, scopre che questa influisce su uno specifico processo neurale: il rispecchiamento, una delle componenti fondamentali della capacità di provare empatia.
Ed eccoci alla possibile causa di quello che Keltner definisce paradosso del potere. Quando le persone acquisiscono potere, perdono (o meglio: il loro cervello perde) alcune capacità fondamentali. Diventano meno empatiche, cioè meno percettive. Meno pronte a capire gli altri. E, probabilmente, meno interessate o disposte a riuscirci.
Come polli senza testa
Inoltre. Spesso le persone di potere sono circondate da una corte di subordinati che tendono a rispecchiare il loro capo per ingraziarselo, cosa che non aiuta certo a mantenere un sano rapporto con la realtà.
E ancora: è il ruolo stesso a chiedere che le persone di potere siano veloci a decidere (anche se non hanno elementi sufficienti per farlo, né tempo per pensarci), assertive (anche quando non sanno bene che cosa asserire. O quando sarebbe meglio prestare attenzione alle sfumature) e sicure di sé al limite dell’insolenza.
I top manager delle multinazionali girano freneticamente per il mondo come polli decapitati: decidono guidati dall’ansia, senza pensare, senza capire, senza vedere e senza confrontarsi. L’ho sentito dire nel corso di una riunione riservata ai partner di un’assai nota società internazionale di consulenza, dal relatore più anziano e autorevole. Mi sarei aspettata qualche brusio di sconcerto tra gli astanti, e invece: ampi segni di assenso.
Ho il sospetto che la sindrome del pollo possa appartenere non solo a chi guida le imprese, ma anche a chi governale istituzioni e le nazioni.
Il fatto è che le persone di potere “devono” andare dritte per la loro strada, infischiandosene di tutto quanto sta attorno. Questo può aiutarle a raggiungere i loro obiettivi (il che è molto vantaggioso a breve termine) ma ne danneggia le capacità di decisione, di interazione e di comunicazione, che nel lungo termine sono strategiche.
- È facile ammirare e rispettare le persone carismatiche. Ma non è così semplice distinguere il carisma dal narcisismo
Il potere logora chi non ce l’ha, diceva Andreotti, che di potere sapeva abbastanza, citando Maurice de Talleyrand. Ma la citazione medesima contiene una dose consistente di protervia.
C’è una parola molto antica che descrive bene tutto ciò: hỳbris. Indica la tracotanza presuntuosa di chi ha raggiunto una posizione eminente e si sopravvaluta. È notevole il fatto che nel termine greco sia implicita anche la fatalità di una successiva punizione, divina o terrena: il fallimento, la caduta.
Si stima che il 47 per cento dei manager falliscano, scrive Adrian Furnham, docente di psicologia all’University College di Londra. È una percentuale molto alta. Uno dei principali motivi di fallimento è il narcisismo: un cocktail deteriore di arroganza, freddezza emozionale e ipocrisia.
C’è un paradosso: è facile ammirare e rispettare le persone carismatiche e fiduciose in se stesse. Ma non è così semplice distinguere il carisma dal narcisismo, che per molti versi ne è il lato oscuro. Sappiamo davvero individuare il confine che c’è tra assertività e prepotenza? Tra sicurezza e ostinazione? Tra fascino e manipolazione?Tra pragmatismo e cinismo?
C’è un ulteriore paradosso: prepotenza, ostinazione, manipolazione e cinismo possono perfino rivelarsi utili nelle battaglie per la conquista del potere, che sono spesso logoranti, sleali e feroci. Ma, una volta ottenuto il potere, per mantenerlo servirebbe proprio quella visione più aperta ed equilibrata che - l’abbiamo visto prima - il ruolo stesso sembra rendere difficilissima da procurarsi e mantenere. Il potere è l’afrodisiaco supremo, diceva Henry Kissinger.
Ma “difficilissimo” non vuol dire “impossibile”. D’altra parte, almeno nelle democrazie occidentali e nelle imprese moderne, il potere si conserva nel lungo termine solo attraverso il consenso. E la capacità di mantenere il consenso è direttamente proporzionale alla capacità di comunicare, di ascoltare e di interagire mettendosi a confronto.
Ehi, si può fare! Persone di potere dotate di un carisma privo di narcisismo esistono. In oltre quarant’anni, mi è perfino capitato di incontrarne alcune, tra politica e impresa, ma posso contarle sulle dita di una mano. Ce ne vorrebbero molte di più.
* Internazionale, 25 luglio 2017
Sul tema, nel sito, si cfr.:
DIO, NATURA, TECNICA COMUNICATIVA, E DEMOCRAZIA. IL "CHARISMA" DELL’ITALIA E IL "CHARISMA" DEGLI ITALIANI E DELLE ITALIANE. CARISMA, COSTITUZIONE, E POLITICA: AL DI LÀ DELLA TRAPPOLA ATEA E DEVOTA. Una importante provocatoria riflessione di Lidia Ravera
Il Narcisismo e l’uso lucidissimo come arma politica dell’"antinomia del mentitore"
UBUNTU: "Le persone diventano persone grazie ad altre persone".
 "CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994).
"CHI" SIAMO: LA LEZIONE DEL PRESIDENTE MANDELA, AL SUDAFRICA E AL MONDO. "La meditazione" di Marianne Williamson, nel discorso di insediamento (1994).FILOSOFIA, E TEOLOGIA POLITICA DELLA’ "ANDRO-POLOGIA" ATEA E DEVOTA....
 LA RISATA DI KANT
LA RISATA DI KANTFederico La Sala
-
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- Sartre, il tema cristiano della carne, e la carne del desiderio (di Paolo Godani).22 giugno 2017, di Federico La Sala
"GRATIA PLENA": LA CARNE DEL DESIDERIO - SARTRE, E IL TEMA CRISTIANO (NON CATTOLICO-ROMANO) DELLA CARNE. Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
- LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89). Un omaggio a Kurt H. Wolff e a Barrington Moore Jr.
La carne del desiderio
di Paolo Godani (Le parole e le cose, 22 giugno 2017)
La filosofia francese del Novecento ha ripreso in vario modo il tema cristiano della carne. Talvolta, come in Michel Henry, ci si è limitati a rivendicare la carnalità come arma da opporre ad una presunta smaterializzazione del corpo avvenuta in età moderna e post-moderna. In altri casi, per esempio quando Merleau-Ponty, nel Visibile e l’invisibile, fa della nozione di chair un concetto fondamentale della sua ultima fenomenologia, della carne è rimasta poco più che la metafora: la “carne delle cose” è solo un sinonimo di “essere grezzo”, di un essere che si dà solo in una pienezza opaca, prima della separazione di un soggetto che percepisce e di un oggetto percepito, in un’esperienza al contempo originaria e impura. Oppure, ancora, si denuncia, come accade a Deleuze, il “carnismo” cristiano a cui sembra approdata certa estetica fenomenologica francese, opponendo provocatoriamente, a una chair pia e devota, l’immagine pietosa della carne macellata (viande, meat) che popola le opere di Francis Bacon.
 In mancanza delle Confessioni della carne, ultimo volume programmato della Storia della sessualità che Foucault non è riuscito a portare a compimento, si può dire che l’unico autore del XX secolo capace di fare un utilizzo al contempo letterale e nuovo della nozione di carne sia stato probabilmente Jean-Paul Sartre, quando nell’Essere e il nulla descrive l’incarnazione di sé e dell’altro che si realizza grazie al desiderio sessuale.
In mancanza delle Confessioni della carne, ultimo volume programmato della Storia della sessualità che Foucault non è riuscito a portare a compimento, si può dire che l’unico autore del XX secolo capace di fare un utilizzo al contempo letterale e nuovo della nozione di carne sia stato probabilmente Jean-Paul Sartre, quando nell’Essere e il nulla descrive l’incarnazione di sé e dell’altro che si realizza grazie al desiderio sessuale.
 In pagine profondamente ispirate, Sartre spiega che nel momento in cui desideriamo un corpo si produce una trasformazione radicale nei modi in cui normalmente ci rapportiamo all’altro: non vogliamo fare uso del corpo altrui per giungere al nostro godimento, né limitarci a possederlo, riducendolo semplicemente a un oggetto in sé, ma entriamo nel campo di una relazione assoluta, nella quale il nostro corpo e il corpo dell’altro si mutano simultaneamente in corpi di carne.
In pagine profondamente ispirate, Sartre spiega che nel momento in cui desideriamo un corpo si produce una trasformazione radicale nei modi in cui normalmente ci rapportiamo all’altro: non vogliamo fare uso del corpo altrui per giungere al nostro godimento, né limitarci a possederlo, riducendolo semplicemente a un oggetto in sé, ma entriamo nel campo di una relazione assoluta, nella quale il nostro corpo e il corpo dell’altro si mutano simultaneamente in corpi di carne.L’estasi del puro desiderio sessuale, che sarà presto sopraffatta dal bisogno di entrare nel corpo altrui facendo uso di forze e movimenti che riportano inesorabilmente la relazione nel contesto di un rapporto tra mezzi e fini, sospende per un tempo indeterminato l’esercizio volontario delle facoltà e consente così l’accesso a una sorta di sentire puro. Le nostre capacità senso-motorie naturalmente restano intatte, ma la loro funzionalità è ridotta all’unico fine del sentire. Perché ciò accada è però necessario che il corpo dell’altro si sia a sua volta immerso in quello stato nascente, simile al sonno, nel quale tutto viene sentito, mentre nulla sta accadendo. Perché io riduca il mio corpo al suo sentire, è necessario che la relazione assoluta abbia portato anche l’altro a uscire da sé, per fare del suo stesso corpo un essere meramente senziente. È questa estasi relazionale che Sartre chiama incarnazione.
Posso guardare, conoscere e amare una donna in molti modi; posso osservarla per qualche sua stranezza più o meno attraente o perché è una vera bellezza, posso ammirarla per il modo di vestire o per un certo modo trattenuto di parlare, per un gesticolare nervoso o per l’intelligenza delle sue considerazioni, posso amare la sua tenerezza o la sua indecisione, i tratti del suo volto o le situazioni nelle quali perde la testa, ma nel momento in cui la sto desiderando la desidero in quanto corpo di carne.
- Il desiderio - scrive Sartre - è un tentativo di svestire il corpo dei suoi movimenti come di vestiti, e di farlo esistere come pura carne; è un tentativo di incarnazione del corpo dell’altro (EN, p. 451).
Una carezza (termine che non deriva da caro, carne, ma da carus, che a sua volta si riferisce alla radice sanscrita ka, da cui kama, amore, e kamana, desiderabile) o uno sguardo che siano già situati in questo campo del desiderio sono uno sguardo o una carezza che si rivolgono alla carne dell’altro, e lo sono in quanto effetti del mio stesso corpo carnale.
Non si tratta solo del corpo nudo, della sua epidermide o della morbida consistenza della pelle: la carne non è un dato, non è già là, sotto i vestiti che sarebbe sufficiente sfilare.
- Carezzando l’altro, io faccio nascere la sua carne con la mia carezza, sotto le mie dita. La carezza fa parte dell’insieme di cerimonie che incarnano l’altro. Ma, si può obiettare, non era forse già incarnato? No. La carne dell’altro non esisteva esplicitamente per me, perché percepivo il corpo dell’altro in situazione; non esisteva per lui perché la trascendeva verso le sue possibilità e verso l’oggetto. La carezza fa nascere l’altro come carne per me e per lui (EN, p. 452).
È possibile non solo guardare o accarezzare, ma anche denudare l’altro e denudarsi, senza che questo abbia nulla a che vedere con il desiderio e senza che dunque produca in alcun modo un essere di carne. Ma quando una carezza inaugura l’accesso al mondo parallelo del desiderio, quando si sfiora con uno lo sguardo il volto o con una mano il fianco della donna desiderata o si lascia che le labbra facciano sentire la propria fantasmatica presenza prima di scivolare per un momento, quasi impercettibili, sulla superficie del collo, allora l’atmosfera che circonda i corpi muta improvvisamente, rendendo perfettamente irreali tutti i movimenti di cui pure ancora siamo gli attori.
Ogni gesto è come circonfuso del suo stato potenziale, sta avvenendo come pura possibilità; ogni mio atto, pur essendo io a compierlo, è come se si svolgesse fuori dal mio dominio, in quella zona senza giurisdizione che è costituita solo in virtù della vicinanza e dell’attrazione di due corpi. Fuori da quell’attrazione, i gesti riprendono il loro senso ordinario e tornano a essere segni, i movimenti rientrano nel campo d’azione del mio corpo, l’altro torna a essere l’in sé che è sempre stato, un po’ familiare un po’ estraneo, ma comunque ormai privo dell’atmosfera a cui soltanto la relazione di desiderio può dar luogo.
È per questo che i gesti del desiderio sessuale non possono essere volontari, perché non sono i miei gesti o quelli dell’altro a poter far nascere la relazione, ma questa si istituisce precisamente quando sono proprio e solo i gesti stessi ad appropriarsi di me e dell’altro. L’incontro di un desiderare e di un essere desiderati è il modo in cui si analizza, a posteriori, una relazione nella quale non ci sono propriamente né io né l’altro. Non sono io che desidero, né è l’altro a desiderarmi. Siamo su un terreno nel quale la correlazione neutralizza l’intenzionalità. Il carattere involontario dell’erezione e delle secrezioni non sono che le modalità fisiologiche nelle quali si traduce questo esser parte di una situazione che ci reclama e a cui per un lungo momento veniamo interamente affidati.
Il luogo che viene a costituirsi tra i corpi desideranti, un luogo che in realtà appare come un “frammezzo” solo a una osservazione esteriore, non è che il divenire carne di quei corpi. Solo nei momenti in cui si desidera si è effettivamente corpi di carne, perché la carne è l’unica sostanza attraverso cui due corpi istituiscono una relazione che non sia di mera esteriorità. Al limite, si dirà che la carne che nasce nella relazione di desiderio non è mai semplicemente la carne di questo mio corpo in contatto con la carne dell’altro, ma che il contatto desiderante dei corpi produce una zona di indeterminazione, alla quale soltanto possiamo dare il nome di “carne”.
In verità, Sartre resta ancora per molti versi impigliato in una concezione tradizionale, specialmente quando fa della carne la “contingenza pura della presenza” (EN, p. 403) dell’altro, e quando sembra voler opporre alla fatticità del corpo di carne la grazia per la quale il corpo appare come “uno psichico in situazione” (EN, p. 462). Quando Sartre dice che normalmente la fatticità è rivestita e nascosta dalla grazia, e dunque la nudità della carne, per quanto sia sempre presente, è tuttavia costantemente invisibile (cfr. EN, p. 463), sembra tornare a fare della carne una sostanza naturale e pre-esistente, anziché un prodotto effettivo del desiderio; e sembra concepire la carne come il puro esserci di un corpo privato della grazia, anziché come uno stato alterato del corpo stesso, dovuto al suo essere in relazione. La carne non è là per nulla, ma c’è solo in quanto effetto di desiderio. Qui, non si può dire che la carne dell’altro ci sia, nella mera contingenza della sua presenza, come se l’incarnazione dell’altro non implicasse la mia stessa incarnazione; la mia carne e la sua esistono solo nel mezzo dei nostri corpi, anzi quella carne che propriamente non appartiene a nessuno è la sostanza stessa di quell’essere tra i corpi. Lo stesso Sartre, del resto, riconosce che
- non si può percepire il corpo d’altri come carne a titolo di oggetto isolato che ha con gli altri questi dei puri rapporti di esteriorità. Questo sarebbe vero solo per il cadavere. Il corpo d’altri, in quanto carne, mi è immediatamente dato come centro di riferimento di una situazione che si organizza sinteticamente attorno a esso e che è inseparabile da questa situazione” (EN, p. 404).
Questo significa che anche il corpo di carne non è mai semplicemente un corpo ridotto alla pura apparenza naturale o alla sussistenza fisiologica. Essere sempre in situazione significa, per il corpo carnale, essere già sempre quella certa maniera d’essere che in esso si incarna.
Così, da una parte, la stessa carne del desiderio, per quanto possa essere priva degli abiti, dei movimenti e delle espressioni che governano per lo più il corpo funzionale, resta nondimeno vestita, abitata e percorsa da cima a fondo da una potenza espressiva. I tremiti interiori, la lentezza dei gesti, gli spasmi improvvisi che definiscono il campo del desiderio sono le forme proprie della vita della carne, sono le espressioni di una carnalità, non semplicemente “naturale”, che ha luogo solo in quella sospensione dell’ordinario istituita dalla relazione sessuale.
E, d’altra parte, un corpo può farsi corpo di carne pur in un contesto del tutto ordinario o addirittura formale, nel quale il vestiario, le pose, gli atti e le parole continuino a figurare come meri segni sociali. Un modo di guardarsi, di salutarsi o sorridersi mentre, legati nell’eleganza dell’abito, ci si scambiano parole di circostanza può già istituire la tensione di un campo carnale - la cui eterogeneità rispetto al territorio dell’agire intenzionale è testimoniata dalla nostra incapacità di sapere se quelle forze di attrazione che all’occasione di un’espressione stranamente magnetica ci hanno trasportato nelle estreme vicinanze dell’altro sussistano realmente o se non siano solo l’effetto della nostra immaginazione.
In entrambi i casi, la carne del desiderio è sempre gratia plena. La cosmesi o la cosmicità della grazia non le sopravviene, ma costituisce il suo unico modo di apparizione.
È il sadico, invece, che immaginando la grazia come un abito, come un segno estrinseco e supplementare, pretenderebbe di sfilarlo via per fare apparire la carne dell’altro in quanto tale, per ridurre l’altro al suo essere nient’altro che carne.
- L’ideale del sadico sarà di cogliere il momento in cui l’altro sarà già carne senza cessare di essere uno strumento, carne da far carne; quando, per esempio, le cosce si offrono già in una passività oscena e sfiorita e sono ancora degli strumenti che si maneggiano, si aprono, e si curvano, per far risaltare di più le natiche e per incarnarle a loro volta (EN, p. 465).
Così facendo, il sadico in realtà non ottiene nulla dall’altro, e tantomeno accede al suo proprio divenire carne. Trattando “l’altro come uno strumento” (EN, p. 465), sottoponendo il proprio corpo e l’altrui al prelievo forzoso di quella grazia immanente che li fa essere carnali, non entrerà mai nel campo d’apparizione del desiderio. La sua ricerca di una carne senza trucco si rivela impossibile, in fondo, anche solo per il fatto stesso di essere una ricerca volontaria. Volere la carne dell’altro è il modo più sicuro di mancarla.
Il fatto è che la passività oscena e sfiorita con cui le cosce possono offrirsi alla visione sadica non può che restare ai margini dell’esperienza propriamente carnale. Non certo perché questa esperienza abbia qualcosa a che vedere con qualche amenità del corpo, ma solo per il fatto che essa, trovando il suo unico compimento nel sentire la comunanza della “propria” attrazione con l’attrazione dell’altro, non ammette la distanza che è invece necessaria a ogni osservazione come a ogni volontà cosciente. La passività oscena e sfiorita è il modo in cui la carne si presenta allo sguardo sadico, dal momento in cui quest’ultimo, nel suo pathos per la distanza, implica una sorta di giudizio estetico capovolto. Quello del sadico, però, resta appunto un giudizio, che come tale impedisce proprio quell’affondare della coscienza del corpo (cfr. EN, p. 459), necessario a ogni esperienza carnale.
In fondo, ciò che il sadico vorrebbe vedere incarnato non è che la malignità del corpo, l’essere ripugnante che, ai suoi occhi, si nasconde dietro le ingannevoli apparenze della grazia. In questo senso, lo sguardo sadico non è che il rovescio di quello cristiano: mentre quest’ultimo intende liberare il corpo di carne da quelli che riconosce come istinti peccaminosi, il primo vuole spogliare il corpo dei suoi belletti, per “dimostrare” la carne stessa in tutta la sua malvagia oscenità.
Non che la vista sia esclusa dal sentire propriamente carnale. Solo che il vedere in stato di desiderio è un vedere esclusivamente aptico. Non diversamente dalla mano, che non è mobilizzata per afferrare, anche l’occhio, divenuto carne, non fa che sorvolare a una distanza infinitesima il corpo dell’altro. Solo questo sguardo di carne, che scivola sul corpo come una carezza, è in grado di mantenersi nel campo del desiderio. La carnalità del piacere prende la sua consistenza propria solo dal momento in cui la tensione di uno sguardo aptico vibra del tremore della carne dell’altro. A distanza di giudizio, invece, la carne dell’altro non può essere sentita. Lo sguardo panoramico del voyerista e quello altrettanto globale anche se ravvicinato del sadico posso certo produrre eccitazione e godimento, ma nessun essere di carne.
Il mero godimento, così come si presenta in maniera esemplare nell’esperienza sadica, si distingue dal piacere carnale non per il suo essere immediatamente pulsionale, bensì, proprio al contrario, per la distanza strumentale che in esso si conserva. Un godimento che non è dell’ordine della pulsione acefala, ma è semmai il correlato di un comando volontario. Mentre il piacere che si accompagna al desiderio implica l’accesso a una relazione capace di sospendere l’intenzionalità personale, e solo in questo senso è propriamente carnale, il godimento è sempre e solo il godimento di un Io. Non solo di un Io che tiene a distanza l’altro, riducendolo a un fantasma di cui potersi cibare, ma di un Io che pretende di governare il proprio stesso modo di rapportarsi all’altro.
Anche lo sguardo fisso e ossessivo che gli amanti si rivolgono talvolta nei momenti che precedono il piacere è uno sguardo di carne, benché in un senso peculiare. Con gli occhi negli occhi, cercano di trattenersi entro il campo del desiderio, mettendo tra parentesi il senso meccanico dei movimenti con i quali sono tornati a utilizzare il corpo come uno strumento; cercano di portare dentro il campo d’attrazione della carne anche ciò che, per sua stessa natura, sembra sfuggirgli.
-
>«Un Dio a parte». Che altro? Jacques Lacan e la teologia. Un saggio di Rossano Gaboardi, presentato da Pierangelo Sequeri.7 giugno 2017, di Federico La Sala
COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE. L’immaginario del cattolicesimo romano.
Teologia e psicoanalisi (lacaniana)
Alleanza nel segno dell’umanesimo
- Il volume di Rossano Gaboardi, «Un Dio a parte». Che altro? edito da Glossa
di Marco Garzonio (Corriere della Sera, 07.06.2017)
Sono lontani i tempi di anatemi e diffidenze tra Chiesa e psicoanalisi. Oggi l’inconscio può essere ponte, non luogo di scontri. Scrive Pierangelo Sequeri: «Tra istituzione religiosa e istituzione psicoanalitica si è consolidato un assetto di reciproca convivenza, che fa largo spazio ad un atteggiamento di rispettosa distinzione degli ambiti e - persino - di virtuale ammissione di margini di cooperazione, nell’interesse di soggetti con speciali difficoltà proprio nell’articolazione psichica dell’esperienza religiosa». Da agosto Sequeri è preside del Pontificio Istituto «Giovanni Paolo II» per gli studi su matrimonio e famiglia. Ce lo ha voluto papa Francesco.
Al culmine d’un percorso quasi ventennale «teoria psicoanalitica» e «ragione teologica» sono spinte «dalla stessa parte», dice ancora Sequeri. All’inizio hanno giocato sensibilità e interessi di docenti della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. A Milano si sono svolti corsi e ricerche sui rapporti tra esperienza religiosa e psicologia del profondo, con predilezione per Jacques Lacan perché meglio corrisponderebbe alle esigenze della fede, visti i riferimenti lacaniani al «nome del Padre». Un dialogo nei propositi non ristretto alla ricerca scientifica. Dai chiostri della Facoltà s’è prospettato un percorso di cultura e responsabilità civili da assumersi, cattolici e laici, nei confronti di un diffuso disorientamento in fatto di valori alti a livello individuale e sociale. Tanto che si parla oggi di una sorta di alleanza «nella difesa dello spessore ontologico dell’essere simbolico e dell’essere pratico», nel pronunciarsi «sul senso etico della psiche», scrive (ma lo sostiene da anni) Sequeri.
Quando Bergoglio lo chiamò a Roma, Sequeri era preside della Facoltà Teologica che Paolo VI volle a Milano fuori però dalle mura della Cattolica. Una sofferenza per Giuseppe Lazzati, allora rettore, che puntava a rilanciare l’ateneo dopo il Sessantotto attraverso un dialogo tra scienze umane e teologia. Corsi e ricorsi di storia e di fede!
Prodotto recente della scuola teologica milanese è il libro di Rossano Gaboardi «Un Dio a parte». Che altro? Jacques Lacan e la teologia, pubblicato dalle Edizioni Glossa, l’editrice della Facoltà. È l’esito di una tesi di dottorato: oltre seicento pagine, rassegna densa di autori, testi, riferimenti a Lacan e seguaci e al teologo Hans Urs von Balthasar. Dalla presentazione al volume abbiamo tratto le citazioni di Sequeri intorno alla nuova «frontiera dell’umanesimo», sulla quale sembrano dunque attestate oggi Chiesa e psicoanalisi.
Poste le basi dalla teologia fondamentale, adesso la sfida potrebbe allargarsi e coinvolgere altre branche del sapere teologico, quali ad esempio la teologia pastorale e quella biblica. Si pone per primo infatti un problema di linguaggio, trasmissione, coinvolgimento sulle questioni che una corretta relazione tra fede e psicologia del profondo può generare. Se non diventano parola parlata, spezzata come pane della conoscenza, vissuta, condivisa, le parole dei teologi che studiano la psicoanalisi rimangono per pochi addetti ai lavori, autoreferenziali, lessico per iniziati.
La teologia biblica poi è l’esempio della fecondità di approcci molteplici. Numerosi specialisti già si servono di vari strumenti psicoanalitici per comprendere le Scritture, le componenti umane e storiche dei testi sacri, i pionieri della psicologia del profondo. Questi ultimi sarebbero fuori luogo in soffitta, anche se Lacan li ha criticati con un linguaggio al cui fascino la teologia fondamentale non sembra indifferente.
La rivoluzione di Sigmund Freud, ad esempio, si coglie se si ha il coraggio di affrontare con spirito libero e senza pregiudizi l’essere ebreo del fondatore della psicoanalisi. Un lettore della Bibbia può verificare come Talmud e modi di lettura del testo siano importanti per comprendere L’interpretazione dei sogni. L’ebraicità di Freud è un valore che avvicina in modo significativo il cultore della psiche, che cerca di decifrare i contenuti inconsci attraverso il mondo onirico, e il docente di critica testuale che fa parlare la Parola tramite simboli e immagini.
Discorso simile può essere fatto a proposito di Carl Gustav Jung. Dopo la pubblicazione del Libro Rosso , nel 2010, Jung va riconsiderato, in specie dai teologi: dall’apporto di questi potrebbe venire molto. Un esempio: il «processo di individuazione», cioè la conoscenza e la realizzazione di sé poggiata su riferimenti a Isaia e a Giovanni nel Libro Rosso, è versione moderna e attuale dell’Imitatio Christi, in termini psicologici. Non dimentichiamo che Jung fu psichiatra e in quanto tale ha vissuto in prima persona le sofferenze estreme della psiche che disputa con Dio, come Giobbe, o che del Creato coglie il vuoto, come Qoelet, e rischia di sprofondarci. Sul dolore del singolo e del collettivo fede e psicoanalisi insieme possono chinarsi e farsi prossimo all’uomo.
Il saggio
«Un Dio a parte». Che altro? Jacques Lacan e la teologia di Rossano Gaboardi è pubblicato da Glossa (pp. XXIV-620, e 50), la casa editrice della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale che ha sede a Milano. -La presentazione al volume - l’esito della tesi di dottorato di Gaboardi - è di Pierangelo Sequeri, dallo scorso agosto preside del Pontificio istituto «Giovanni Paolo II». Il francese Jacques Lacan (1901-1981) era psichiatra e filosofo. È stato uno dei maggiori psicoanalisti del Novecento. La sua psicoanalisi si basa sulla tesi secondo cui l’inconscio «è strutturato come un linguaggio»
-
> "PERVERSIONI". UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- Dalla "scoperta dell’infanzia" all’infanzia oggi/Pedofilia. L’eterno ritorno della "lettera scarlatta" (di Sergio Benvenuto)11 maggio 2017, di Federico La Sala
Dalla "scoperta dell’infanzia" all’infanzia oggi /
Pedofilia
di Sergio Benvenuto (doppiozero, 11.05.2017)
Confesso di aver paura di scrivere o parlare di pedofilia - oggi, è come attraversare un campo minato. Il vespaio provocato dal romanzo di Walter Siti, Bruciare tutto, il cui protagonista è un prete che desidera i bambini ma casto, mostra bene che la pedofilia tocca certi nostri nervi scoperti.
Siti in un’intervista (“Il caso Siti”, La Repubblica, 20 aprile 2017) si è sbagliato quando ha detto che desiderare i bambini senza farci nulla non è reato. Invece, si incrimina qualcuno anche solamente per aver visitato siti pedopornografici. Non solo gli atti pedofili, ma il desiderio pedofilo in sé oggi è criminalizzato. Come il decimo comandamento, il solo che proibisca un desiderio - dei beni altrui, compresa la donna altrui.
Anni fa una rivista di psicoanalisi mi chiese un intervento sulla pedofilia, e io scrissi un saggio in cui esaminavo alcuni casi di pedofilia presi dalla letteratura clinica. Con mia sorpresa il saggio fu rifiutato; il compianto amico Pietro Barcellona, membro della redazione, mi disse che quel mio scritto era apparso una lancia spezzata a favore dei pedofili. Caddi dalle nuvole. Il mio pezzo, almeno così credevo, era un’analisi scientifica, cioè distaccata, del mondo mentale pedofilico, senza una minima intenzione di apologia. Eppure, quel mio articolo è uno dei pochissimi, tra i tanti da me scritti, che nessuno abbia voluto pubblicare. In effetti, articoli anche di genere scientifico iniziavano con un anatema contro il flagello della pedofilia, con una denuncia di una quasi-cospirazione mondiale dei pedofili, ecc. Il mio saggio mancava di questo preambolo, forse perciò era apparso compiacente nei confronti della pedofilia.
Perciò tengo a informare prima di tutto il lettore di due cose: 1) non sono pedofilo; 2) ritengo giusto che la legge punisca l’adulto che indulga ad atti sessuali con bambini. Spero che, detto questo, io possa esprimere impunemente la mia idea.
Appunto, quel che mi sembra importante analizzare è proprio questa nostra esacerbata reattività quando si parla di pedofilia. Perché non è stato sempre così. Quando alla fine del XIX° secolo nacque la sessuologia medica, e Krafft-Ebing, Havelock Ellis e altri descrissero le perversioni - oggi chiamate parafilie - la pedofilia vi svolgeva un ruolo alquanto marginale. I medici europei di allora erano ossessionati piuttosto dall’omosessualità e dalla masturbazione. L’omosessualità era descritta come la peggiore perversione, del resto era perseguita penalmente in molti paesi (ma - questo lo si ignora - non in Italia, paese sempre permissivo nei confronti degli omosessuali). Gli omosessuali erano perseguitati in modo triplice: come peccatori dalle chiese, come malati mentali dagli psichiatri, e come delinquenti dallo stato. Quanto alla masturbazione, specialmente quella infantile, veniva denunciata come causa di terribili disturbi mentali e sessuali. I medici di allora ricorrevano a strumenti inquietanti per combattere “la peste onanista”, come corsetti antimasturbatori, astucci da erezioni, macchinari per allargare le gambe delle bambine, manette per le mani, addirittura cauterizzazione della clitoride, e altri sistemi sado-medici. All’inverso, si parlava e si scriveva ben poco di pedofilia. In sintonia con una certa omertà della popolazione nei confronti dei pedofili, soprattutto di quelli ecclesiastici, fino a pochi decenni fa.
Mio padre, professore di filosofia nato nel 1916, aveva studiato a Napoli in scuole di barnabiti e gesuiti, cosa che aveva prodotto in lui un desiderio di sacerdozio. Eppure ogni tanto alludeva a preti chiaramente pedofili; mi disse che un nostro caro amico di famiglia, una persona molto fragile, da ragazzo aveva accettato una relazione con un prete pedofilo. Mi disse che anche lui era stato oggetto di attenzioni, che aveva respinto. Apparirà oggi stupefacente che poi lui stesso mi mandasse a 15 anni a studiare dai barnabiti, a Napoli, istituto Bianchi, per due anni. E là alcuni compagni mi indicarono a dito i due o tre monaci “pericolosi”, dai quali stare alla larga.
Una volta un barnabita che non avevo mai visto, un uomo magro sulla trentina, mi dette appuntamento per parlarmi; evidentemente era il sacerdote incaricato della consulenza spirituale dei giovani allievi, tutti maschi. La sera mi recai al Bianchi. Attraversai lunghi corridoi bui con grandi finestroni, senza incontrare anima viva; quindi giunsi nella camera di questo sacerdote, anch’essa alquanto spettrale. Mi fece sedere di fronte a sé, molto vicino, la sua bocca quasi mi alitava in faccia, e mi prese una mano. Ricordo le sue mani fredde, i suoi grandi occhiali, il volto ossuto, la voce felpata e vischiosa. Senza andare troppo per le lunghe, mi chiese se avevo avuto polluzioni, se mi toccavo... mentre mi guardava fisso negli occhi come a volermi trivellare l’anima. Capii che dovevo tagliare la corda, difatti, senza rispondere alle sue domande, trovai una scusa e me ne andai.
Non so se quel tutore spirituale volesse sedurmi sessualmente, ma considero la sua lubrica curiosità sulla mia aurorale vita sessuale come già di per sé un attentato pedofilo. Era evidente che godeva nello strappare il velo di pudore degli adolescenti, nel penetrare anche solo verbalmente la loro intimità. Fu così che trovai del tutto pertinente la tesi che, molti anni dopo, Michel Foucault espresse in La volontà di sapere: che il nostro moderno interesse per il sesso, lungi dall’essere una novità rivoluzionaria, eredita una lunga tradizione, non solo cattolica, di investigazione della libido, di confessioni balbettanti, di puntiglioso smascheramento delle nostre fragilità sessuali.
Come mostra il film Spotlight di Tom McCarthy, quando il giornale The Boston Globe lanciò un’inchiesta sui preti pedofili ruppe un muro del silenzio. Ma questo muro non era stato alzato solo dalle alte gerarchie cattoliche, era mantenuto e rafforzato dalle stesse famiglie, non diversamente da quel che accadeva nella Napoli degli anni ’50 e ’60. D’un tratto, qualcosa che tutti sapevano ma di cui non si poteva parlare in pubblico, e che andava accettato come fosse un dato di natura, come i freddi invernali e la canicola estiva, veniva immesso nel discorso pubblico come oggetto di denuncia. Un cambio di discorso. O, come si dice in filosofia della scienza, un cambio di paradigma.
Sin dalla seconda metà degli anni ‘80 il mondo anglo-americano, pur dominato dall’apologia reaganiano-thatcheriana dei valori familiari, fu scosso dalla campagna contro il child abuse. D’un tratto un’intera società alzò un velo sulla privacy propria e altrui, e si convinse che una quota ingente di famiglie - anche insospettabili - praticava correntemente l’incesto e la violenza sui figli piccoli. Questo ciclone ha fatto breccia nella pedagogia, nella critica letteraria, nella psichiatria, nel cinema, ecc. Vi ricordate che per molti anni in tanti film americani i protagonisti prima o poi evocavano violenze o molestie subìte nell’infanzia, a opera di parenti o vicini? Se qualche personaggio rivelava turbe psichiche, potevate essere certi che prima o poi spuntava qualche abuso sessuale patito nell’infanzia. La psichiatria si convinse del valore patogeno del trauma, e il trauma per lo più erano abusi sessuali. Non si contavano i biografi di scrittori, artisti, politici, musicisti, ecc., che ricostruivano qualche violenza, o gioco erotico, di cui le suddette celebrità sarebbero state oggetto da bambini, come esperienze cruciali della loro vita. In Italia si dice "i panni sporchi si lavano in famiglia", invece nel mondo anglo-americano si andavano e si vanno a cercare prima di tutto i panni sporchi delle famiglie per esibirli in pubblico. La denuncia della pedofilia fu all’inizio una denuncia degli scheletri negli armadi delle rispettabili famiglie middle class. Poi il faro dell’attenzione si è spostato sui preti e sul “potere pedofilo”.
Eppure questa ricerca del parente pedofilo aveva orli paranoidi. Ho vissuto spesso negli Stati Uniti negli anni ‘90, e mi resi conto che in tante famiglie dei miei amici erano state sporte denunce per pedofilia da parte di figli o nipoti nei confronti di genitori, zii o nonni. Una febbre querelante, dove era difficile separare il delirio dalla rimemorazione di eventi reali, sconvolse le famiglie statunitensi. Se un americano soffriva di qualche malessere spirituale, si lambiccava il cervello per ritrovare nella propria lontana memoria situazioni e atti incestuosi, e di solito li trovava, perché spesso è difficile stabilire una linea di demarcazione netta tra l’abbraccio affettuoso e quello eroticamente stimolante.
Ha colto qualcosa di questo il regista danese Thomas Vinterberg. Nel 1998 Vinterberg diresse un film, Festen, in cui a una festa di famiglia ricca uno dei figli denuncia drammaticamente il padre-padrone per aver abusato sessualmente di lui e della sorella, morta suicida, quando erano piccoli. Era chiaramente una critica in chiave “di sinistra” della pedofilia familista, dove il pedofilo coincideva non solo col padre, ma anche con “il capitalista”.
Poi nel 2012 Vinterberg produce Jagten, “Caccia”, distribuito in Italia col titolo fuorviante Il sospetto; mentre si tratta propriamente di caccia, di caccia al pedofilo. Un giovane maestro di asilo in un villaggio danese viene accusato (noi spettatori sappiamo ingiustamente) di aver sedotto sessualmente una bambina sua allieva. Il villaggio non è garantista, per cui tutti sono convinti che il maestro sia un pedofilo e perseguitano lui e il figlio adolescente. Poi il maestro viene scagionato dal giudice, ma questo non basta: egli continua a essere oggetto di violenze e ostracismi. Col tempo, tutto sembra calmarsi, il risentimento pare archiviato. Ma un giorno, durante una partita di caccia con amici, qualcuno che non vediamo spara addosso al maestro, mancandolo.
 Insomma, “il villaggio” continua a vederlo come un pedofilo, anche se è stato prosciolto da ogni accusa. Quel che Vinterberg coglie è insomma un bisogno collettivo di avere un pedofilo da perseguitare. Un paradossale desiderio di pedofili. Siamo nella logica del capro espiatorio, su cui tanto si è scritto. Così, la psicosi della pedofilia si è diffusa anche nel mondo carcerario e tra la criminalità. I condannati per pedofilia non possono essere messi in cella con i detenuti “normali”, altrimenti verrebbero sicuramente uccisi. Mentre un compagno di cella che ha ucciso più persone viene accettato.
Insomma, “il villaggio” continua a vederlo come un pedofilo, anche se è stato prosciolto da ogni accusa. Quel che Vinterberg coglie è insomma un bisogno collettivo di avere un pedofilo da perseguitare. Un paradossale desiderio di pedofili. Siamo nella logica del capro espiatorio, su cui tanto si è scritto. Così, la psicosi della pedofilia si è diffusa anche nel mondo carcerario e tra la criminalità. I condannati per pedofilia non possono essere messi in cella con i detenuti “normali”, altrimenti verrebbero sicuramente uccisi. Mentre un compagno di cella che ha ucciso più persone viene accettato.Nel film di Vinterberg si tratta di fiction, ma storie analoghe sono accadute realmente in molti paesi. In Italia avemmo il caso inquietante di Rignano Flaminio: in questa tranquilla cittadina a nord di Roma, nel 2007, quattro insegnanti, tutte donne, della scuola materna locale e un autore televisivo furono accusati di praticare orge sessuali con alcuni piccoli allievi. Molti media parlarono di loro come di “orchi”, anche se sin dal primo giorno non ho mai creduto in una storia così assurda: possibile che quattro maestre tutte pedofile si ritrovassero guarda caso nella stessa scuola e portassero fuori dell’edificio scolastico dei bambini senza che nessuno se ne accorgesse? Sembrava una storia di caccia alle streghe del Rinascimento (anche allora, contrariamente a quel che si pensa, l’Inquisizione perseguiva donne che venivano denunciate “dal basso”, attraverso la vox populi, come streghe). In seguito tutti gli accusati sono stati assolti e le accuse archiviate, ma non c’era bisogno di aspettare quelle sentenze per rendersi conto che si trattava di un delirio collettivo. Una persecuzione come quella delle streghe di Salem nel Massachusetts, nel 1692, potrebbe ripetersi anche domani, qui in Italia; e le “streghe” sarebbero ovviamente delle pedofile.
Come spiegare questo orrore per il pedofilo, ambiguo perché esprime il desiderio di averne uno da perseguitare? Alcuni sostengono che esso è il segno di una nostra maggiore sensibilità al mondo infantile, che insomma oggi i genitori sono molto più attenti nei confronti dei figli. Dovremmo rallegrarci del fatto che finalmente la nostra società si sia accorta di qualcosa che pur esiste da che mondo è mondo, e cioè che i bambini vengono picchiati, i padri vanno a letto con le figlie e i fratelli con le sorelline, e alcuni preti seducono ragazzi e ragazze.
Non a caso, si dice, nelle società industriali avanzate facciamo sempre meno figli: anziché disperdere le cure e l’eventuale patrimonio tra tanti figli, preferiamo concentrare cure ed eredità su uno o due figli. Viviamo in una società dove il bambino è sempre più importante, da qui la tendenza - soprattutto italiana - a permettergli tutto. La psicosi del pedofilo sarebbe solo un corollario della venerazione per quello che Freud chiamava “Sua Maestà il bambino”.
Ma qualcun altro non la pensa così.
Mi colpì un episodio, letto sui giornali qualche anno fa. In una cittadina inglese si diffuse l’idea che ci fosse in giro un pedofilo. Una banda di uomini alticci andò in giro per la città, di notte, con una maledetta voglia di picchiarne uno. Videro una porta con su scritto “Paediatrician” e presero la scritta per “Pedophile” - devastarono lo studio della pediatra. Ora, quel che mi colpisce non è solo l’idea assurda che un pedofilo possa mettere una targhetta qualificandosi come tale, ma anche che, in vino veritas, si sia punita una persona che cura i bambini, non che li violenta. È una specie di lapsus freudiano, che andrebbe interpretato.
Emerge insomma un’ambivalenza nei confronti del bambino che andrebbe esaminata con attenzione. Come ha mostrato bene lo storico Philippe Ariès nel libro Padri e figli nell’Europa medievale e moderna (Laterza, 1981), l’infanzia non è sempre esistita; la “scoperta” dell’infanzia è un evento relativamente recente, che risale al XVI° secolo; prima i piccoli d’uomo erano visti altrimenti. Insomma, ogni epoca ha un diverso sentimento dell’infanzia, ogni società la tratta, la veste, la educa, la ama, la detesta in modi diversi. Dovremmo chiederci quale sia il nostro modo attuale.
Mi pare che oggi trattiamo l’infanzia in una maniera che parrebbe del tutto opposta a quella che l’angoscia del pedofilo farebbe supporre. Ovvero, aboliamo sempre più la differenza tra i bambini e noi, soprattutto per quel che riguarda la sessualità. Innanzitutto vestiamo i bambini sempre più come noi adulti. Il successo della Barbie - attraverso i giocattoli gli adulti plasmano la mente dei loro bambini - la dice lunga: si propone alle bambine come ideale non una bambola-bambina, ma una ragazza alta e magra, quasi anoressica, bionda, modello scandinavo, vestita sportivamente... La Barbie ha imposto alle bambine il paradigma della donna moderna. Quanto poi alle altre bambole alternative alla Barbie, come Bratz, mi sembra che esaltino la figura della adolescente sexy e alla moda che va in discoteca. E non dobbiamo più dare scappellotti ai nostri bambini, proprio perché non li diamo agli adulti.
Il sesso viene insegnato nelle scuole, ovvero vogliamo che i nostri bambini sappiano sulla sessualità e sulla nascita più o meno le stesse cose che sappiamo noi. Favole come la cicogna o i bambini sotto i cavoli sono derise e vituperate. Inoltre esponiamo sempre più i bambini a immagini sessuali, attraverso la televisione, i rotocalchi, i film; questo spiegherebbe tra l’altro la tendenza delle bambine occidentali ad anticipare sempre più la loro pubertà. L’esposizione a scene erotiche ha l’effetto, pare, di affrettare il primo ciclo estrale. Aggiungiamo che la verginità non è più considerata un valore, così che se una ragazza perde la verginità a tredici anni, i genitori ormai non se ne preoccupano più di tanto.
 Evidentemente la teoria di Freud - che ha svelato un segreto di Pulcinella, il fatto che i bambini abbiano impulsi sessuali, cosa che ogni madre e padre e baby sitter sa - è stata assorbita dalla nostra cultura, per cui non reprimiamo più atti sessuali tra bambini. Certo non proibiamo più la masturbazione. Insomma, la barriera tra il mondo infantile e quello adulto - che era enorme ancora nella mia infanzia, anni ’50 - è caduta. Assieme al femminismo, che ha realizzato un’ampia omologia tra uomini e donne, un tacito bambinismo ha omologato sempre più bambini e adulti. Come si spiega allora questo accanimento anti-pedofili? Non contraddice la nostra tendenza a secolarizzare l’infanzia, ovvero a de-sacralizzarla?
Evidentemente la teoria di Freud - che ha svelato un segreto di Pulcinella, il fatto che i bambini abbiano impulsi sessuali, cosa che ogni madre e padre e baby sitter sa - è stata assorbita dalla nostra cultura, per cui non reprimiamo più atti sessuali tra bambini. Certo non proibiamo più la masturbazione. Insomma, la barriera tra il mondo infantile e quello adulto - che era enorme ancora nella mia infanzia, anni ’50 - è caduta. Assieme al femminismo, che ha realizzato un’ampia omologia tra uomini e donne, un tacito bambinismo ha omologato sempre più bambini e adulti. Come si spiega allora questo accanimento anti-pedofili? Non contraddice la nostra tendenza a secolarizzare l’infanzia, ovvero a de-sacralizzarla?Probabilmente proprio questa caduta della barriera bambini/adulti ha riaperto un vasto campo di tentazioni in molti: siccome i bambini sono “come noi”, perché non avere giochi sessuali con loro? Ci sono impulsi pedofili in moltissime persone, anche se sono repressi dalla nostra etica sessuale. La secolarizzazione dell’infanzia fa affiorare questi impulsi, da qui il terrore di esternarli. L’orrore per i pedofili - per coloro che non resistono a questi impulsi - va allora letto come un orrore per la propria stessa pedofilia. Il pedofilo funziona allora come capro espiatorio su cui delegare il proprio interesse morboso per i bambini. Come nel film di Vinterberg o a Rignano Flaminio, si ha bisogno di un pedofilo, anche se inventato, per incarnare in un altro le proprie tentazioni.
 È l’eterno ritorno della lettera scarlatta di Hawthorne: il pastore che perseguita la donna peccatrice è proprio colui che l’ha resa peccatrice.
È l’eterno ritorno della lettera scarlatta di Hawthorne: il pastore che perseguita la donna peccatrice è proprio colui che l’ha resa peccatrice. -
> "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO - di Federico La Sala3 maggio 2017, di Federico La Sala
Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
- "Dobbiamo mettere queste testimonianze una accanto all’altra, un po’ come fece il giornalista di Citizen Kane, se vogliamo costruire il puzzle Lacan. Ma ci resta un rosebud a cui dare risposta? Penso di sì. Insomma, per me c’è un enigma Lacan (Sergio Benvenuto, L’enigma Lacan (guidatore spericolato), "DoppioZero", 03.05.2017)
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
L’enigma Lacan (guidatore spericolato)
di Sergio Benvenuto (DoppioZero, 03.05.2017)
Il film celeberrimo di Orson Welles Citizen Kane (Quarto potere) si snocciola come una ricostruzione biografica. Un giornalista deve ricostruire la vita del magnate della stampa e tycoon Charles Foster Kane, giusto dopo la sua morte. Il giornalista compone una sorta di puzzle intervistando varie persone che hanno condiviso parte della vita di Kane. Le molteplici testimonianze vengono a comporre un’immagine sfaccettata del personaggio, ma il giornalista vuole capire soprattutto perché prima di morire Kane abbia pronunciato la parola rosebud. Chi o che cosa era questo Rosebud? Questo significante sembra indicare un pezzo mancante nel puzzle.
Rosebud letteralmente significa bocciolo di rosa, ma viene usato anche come bocca di rosa, una bocca con labbra delicate e rosee. Come orifizio con mucosa, il termine evoca anche le piccole e grandi labbra della vagina. Rosebud sembra insomma riferirsi a una donna, ma è anche significante di qualcosa che in francese si chiama béance, ciò che resta aperto come una vena tagliata o una bocca socchiusa. Il giornalista non scoprirà nulla, la rivelazione finale - un MacGuffin come si dice nel cinema - è riservata allo spettatore, una rivelazione che però lascia aperta la domanda sul significato ultimo di quel significante pronunciato sull’orlo della morte.
Mi sono ricordato del film di Welles dopo aver letto Vita con Lacan (La vie avec Lacan) di Catherine Millot (Raffaello Cortina editore). Costei, psicoanalista e scrittrice, negli anni ‘70 fu amante, allieva e compagna di Lacan. Tra loro c’erano 43 anni di differenza, e l’autrice nota che oggi scrive questo libro avendo l’età che aveva Lacan quando lei l’aveva conosciuto, attorno ai 72 anni. Questa di Millot è una testimonianza sulla sua esperienza personale con Lacan. Che si aggiunge a varie altre testimonianze, pubblicate nel corso degli anni da parenti amici allievi o analizzanti di Lacan, da prospettive tra loro diverse, a cui bisogna aggiungere la lunga biografia di Lacan scritta da Elisabeth Roudinesco. Abbondano aneddoti anche gustosi, altri più o meno immaginari, sul personaggio Lacan. Dobbiamo mettere queste testimonianze una accanto all’altra, un po’ come fece il giornalista di Citizen Kane, se vogliamo costruire il puzzle Lacan. Ma ci resta un rosebud a cui dare risposta? Penso di sì. Insomma, per me c’è un enigma Lacan.
Vari amici, che stimo, mi hanno detto che questo libretto secondo loro non vale granché. Mi chiedo che cosa abbia potuto motivare questo giudizio severo. Un libro-testimonianza deve il suo interesse non al fatto che sia scritto più o meno bene, che sia più o meno profondo, ma al fatto che testimoni appunto, che ci informi su aspetti a noi ignoti di una vita. Certi lacaniani aborriscono gli scritti biografici su Lacan in genere, “sono solo pettegolezzi” dicono, ma in fondo ogni storiografia è una forma di pettegolezzo. E la stessa analisi appare in qualche modo un pettegolezzo su se stessi, un tradurre in parola qualcosa di intimo e inconfessabile. Forse alcuni vorrebbero che di Lacan si scrivessero non biografie ma agiografie. Le biografie serie comportano sempre un alone di demistificazione, e posso capire che chi vota a Lacan una forma di culto della personalità non possa accettarle.
A me interessano invece anche i “pettegolezzi” su Lacan perché, come la psicoanalisi insegna, le teorie psicoanalitiche non sono il prodotto di menti disincarnate, ma di soggetti particolari con la loro storia, il loro inconscio, le loro ferite. D’altro canto è vero che ogni biografia fa appello al nostro voyeurismo. Al limite, ci saremmo aspettati che Millot ci parlasse anche dei suoi rapporti sessuali con Lacan, o dei suoi rapporti con la moglie di Lacan Sylvia, perché no? Ma più ne sappiamo di uomini e donne eminenti, più un tarlo, simile a Rosebud, ci assilla: resta sempre qualcosa che ci sfugge, una sorta di buco. Insomma, chi era veramente Lacan?
Di Lacan colpisce un comportamento che i suoi più intimi mettono in evidenza: il suo modo di guidare l’auto. Correva oltre i limiti di velocità, non dava la precedenza, passava col rosso, prendeva anche la corsia d’emergenza pur di superare un ingorgo, insomma metteva a repentaglio la vita propria e di chi gli stava accanto. Anche se un altro guidava, di fronte a semafori rossi si spazientiva subito e talvolta usciva dall’auto. Questo anarchismo automobilistico sorprende perché Lacan è stato, tra tutti gli psicoanalisti, quello che ha dato più peso al ruolo della legge nell’inconscio e nel destino individuale. Per Lacan, come per S. Paolo, la legge non è un ostacolo posto al nostro desiderio, è anzi la condizione del desiderio stesso, ciò che lo costituisce e lo sferra. Ora, come vedere il fatto che il teorico della legge non tenesse in alcun conto la legge più banale, il codice stradale? Cogliamo qui una discrasia tra la teoria e la vita?
La trasgressione, appunto. Non credo sia un caso che Lacan sia venuto in rotta di collisione con l’International Psychoanalytic Association - l’organizzazione ufficiale e più antica degli psicoanalisti - non per il contenuto del suo insegnamento, ma per ragioni direi fiscali: il fatto che facesse sedute a tempo variabile (e non a tempo fisso, di solito 45 minuti, come fanno gli analisti ortodossi) e che queste sedute fossero di solito troppo corte. Non c’è nulla di male in sé nell’ideare una nuova tecnica analitica, nel fare sedute corte, ma trovo significativo che la rottura sia avvenuta perché Lacan non rispettava il codice del setting analitico. Ritroviamo questo suo rapporto problematico con “le regole” in molti altri comportamenti, in particolare nel fatto che abbia preso Catherine Millot come sua amante quando era ancora sua analizzante e allieva.
Lo stesso Lacan racconta quando incontrò il famoso psicoanalista austriaco Ernst Kris al congresso psicoanalitico di Marienbad nel 1936 (“La direzione della cura”, Scritti). Il giovane Lacan gli disse di voler andare poi alle Olimpiadi di Berlino, che si tenevano allora. Il punto è che queste dovevano essere le Olimpiadi di Hitler... E Kris, ebreo, gli disse in francese “Cela ne se fait pas!”, “Questo non si fa!” Lacan ci andò lo stesso.
Appunto, cela ne se fait pas. Non si passa col rosso, non si va a letto con le pazienti, non si fanno sedute eccessivamente corte, si deve dare la precedenza in strada... E dico questo non per gettare l’anatema su Lacan, tutt’altro. Piuttosto per dire che Lacan era un dandy.
Nessun biografo o testimone di Lacan, a quanto io ne sappia, ha presentato Lacan come un dandy. Forse perché i grandi dandies - Baudelaire, Oscar Wilde, Raymond Roussel, ecc. - non ci appaiono eticamente corretti. Essi si escludevano dai valori e dai gusti della massa, vantando la loro libertà rispetto alle regole che valgono per la gente comune, ovvero per i mediocri. Ora, sembra che la fascinosa arroganza del dandy non possa conciliarsi con la psicoanalisi, che è pur sempre, lo si riconosca o meno, un’attività di cura, di aiuto, un servizio alla persona. Può essere il dandy un filantropo, o semplicemente un medico? Millot sottolinea come Lacan facesse sentire la gente comune a proprio agio, come sapesse interloquire bene con gli psicotici; insomma, sapeva aiutare. E poi, quando si ha quel fascino misterioso che oggi chiamiamo carisma, si riesce ad aiutare meglio il prossimo che quando non lo si ha.
Il dandy, dunque, si sente libero. Ora, si dà il caso che Lacan abbia sempre disdegnato di predicare la libertà, cosa che lo separa nettamente da Sartre, il filosofo della sconfinata libertà dell’essere umano.
Quando una giornalista televisiva gli chiese qualcosa sulla libertà, Lacan si mise a ridere e alla fine disse “Io non parlo mai di libertà”. Non ne parlava, ma la praticava, anche a costo di rompersi l’osso del collo.
Millot accenna all’allievo di Lacan Giacomo Contri, traduttore degli Ecrits, e qui lei commette un errore. Dice che Lacan era esasperato dal fatto che Contri avesse chiamato Comunione e Liberazione la sua scuola di Milano. In realtà Contri aveva chiamato il suo gruppo Scuola freudiana (di cui io stesso feci parte per qualche anno), ma era anche membro del movimento Comunione e Liberazione che noi italiani conosciamo bene.
 Di fatto Lacan rimproverava a Contri la sua adesione all’integralismo cattolico. In un incontro a Milano con gli allievi di Contri, disse che i due significanti “comunione” e “liberazione” erano profondamente estranei al suo insegnamento, che certamente non era catto-comunista. In particolare, l’analista non è mai libero: “Non si può dire che il mio discorso vi prometta una liberazione da alcunché, perché si tratta, al contrario, di incollarsi alla sofferenza delle persone...” (Lacan in Italia/En Italie Lacan, La Salamandra, 1978, p. 122).
Di fatto Lacan rimproverava a Contri la sua adesione all’integralismo cattolico. In un incontro a Milano con gli allievi di Contri, disse che i due significanti “comunione” e “liberazione” erano profondamente estranei al suo insegnamento, che certamente non era catto-comunista. In particolare, l’analista non è mai libero: “Non si può dire che il mio discorso vi prometta una liberazione da alcunché, perché si tratta, al contrario, di incollarsi alla sofferenza delle persone...” (Lacan in Italia/En Italie Lacan, La Salamandra, 1978, p. 122).Scrive Millot: “A un transessuale che rivendicava la sua qualità di donna, non smise di ricordare durante il colloquio il fatto che era un uomo, che lo volesse o no, e che nessuna operazione ne avrebbe fatto una donna” (p. 42). Ecco una posizione che oggi apparirebbe retrograda, che il movimento LGBT contesterebbe. Oggi prevale la concezione per cui il proprio gender è qualcosa che ci si assegna, non qualcosa che si è oggettivamente. Ma appunto, egli non compiaceva l’ideologia liberal secondo cui si deve essere liberi di essere quello che si vuole, con l’aiuto anche della chirurgia e della tecnologia. La retorica della liberazione, che all’epoca andava per la maggiore sia a sinistra che a destra - “è proibito proibire”, la teologia della Liberazione, ecc. - gli era del tutto estranea.
In effetti, all’epoca altre teorie si contrapposero a Lacan rivendicando, sulla scia del ’68, una liberazione incondizionata: era il caso dell’apoteosi orgasmica di Wilhelm Reich, o delle macchine desideranti di Deleuze e Guattari, o della critica liberatoria da parte di Jean Baudrillard... Rispetto a queste filosofie di esaltazione della libertà del desiderio, il pensiero di Lacan appare un dolente richiamo al determinismo in cui l’essere umano è preso.
Eppure Lacan si sentiva libero da ogni regola. Quindi, il suo pessimismo sulla libertà era solo una faccia della medaglia, l’altra era quella di una liberazione direi in extremis che nasce proprio da una sorta di sottomissione inaugurale. Lo si può così accostare ad Antigone - su cui tenne bellissimi seminari - l’eroina che si ribella alla legge della città per seguire la propria legge, la legge del proprio desiderio.
Perché le trasgressioni di Lacan erano contro le leggi di Creonte - dalle sedute standard dell’IPA fino ai semafori rossi - per affermare un’altra legge, quella del desiderio. “Ci si sente colpevoli - diceva - quando si cede sul proprio desiderio”. Egli non voleva cedere sul proprio desiderio. “Per lui, non c’erano piccoli desideri, la minima voglia era già sufficiente” dice Millot (p. 69), comprese le voglie delle persone che amava, voglie che doveva soddisfare subito, senza mai rimandare all’indomani ciò che poteva essere fatto immediatamente.
Non a caso in gioventù fu amico di surrealisti, tra i quali Dalì, anche se Millot preferisce definirlo “dadaista”. E forse non a caso sposò la ex moglie di Georges Bataille, che possiamo considerare il massimo filosofo libertario. È proprio negando teoricamente la libertà umana, come fece Lutero (De servo arbitrio), che la si deve praticare, in modo ingenuamente disperato.
Lacan voleva sempre godere di tutto: delle donne, del danaro, del sapere, del pensare. Insomma, di Lacan non si può dire affatto che fosse saggio - in barba al pregiudizio secondo lui l’analista deve essere un campione di saggezza. Lacan esprimeva piuttosto una straordinaria vitalità, una passione quasi futurista per il movimento, gli sport, la velocità, i viaggi. Una vitalità quasi infantile, che Lacan stesso riconosceva quando diceva che aveva l’età mentale di un bambino di cinque anni. In fondo, quel che alla fine decide tra chi è semplicemente intelligente, anche molto intelligente, e il genio è proprio la vitalità, l’energia. Lacan non aveva bisogno di amfetamine, come Sartre che ne prese a bizzeffe, per essere sempre un po’ su di giri. E in effetti, come Erik Porge, potremmo interpretare il titolo del libretto di Millot come “Con Lacan, la vita”.
Questa vitalità si esprimeva anche nell’opposto del movimento: Lacan passava lunghe ore assorto, silenzioso, immobile. Questo vuoto immoto che faceva attorno a sé, in casa, assorbito dalle sue riflessioni, esprime in realtà la vitalità del suo pensare, che, frustato dall’urgenza di una soluzione forse impossibile, lo inchiodava. Un correre veloce per la vita che però si dirigeva dritto verso la morte, e non nel senso che ciascuno di noi deve morire. Dopo aver avuto la diagnosi di cancro all’intestino, Lacan rifiutò di curarsi. E alla figlia che gli chiedeva perché, rispose “Così, per capriccio”. Un’ombra di quasi-suicidio plana così su di lui; e gli stoici dicevano che il suicidio è uno dei pochi atti veramente liberi che l’essere umano possa permettersi.
Chi è molto vitale, non teme la morte. E Millot insiste sulla impavidità di Lacan. Una volta, mentre faceva una supervisione, dei ladri entrarono con le pistole puntate chiedendogli soldi; ma lui si rifiutò assolutamente di darglieli. Quando la morte gli si presentava davanti, non la fuggiva.
Come il dandy, pagava il prezzo di una solitudine di fondo. “Non c’era mai un ‘noi’, c’era lui, Lacan, e c’ero io che lo seguivo... D’altronde se a me il ‘noi’ non è mai stato congeniale, a Lacan era del tutto estraneo... La sua profonda solitudine, il suo apartismo [sentirsi “a parte” rispetto agli altri] rendevano il ‘noi’ qualcosa di fuori luogo” (p. 19). Il ‘noi’ è quella dimensione di comunione che, come abbiamo visto, rimproverava agli emuli di don Giussani. Perciò non credeva nel comunismo, e sono allergici a Lacan quelli che praticano l’analisi di gruppo. Freud si era occupato della dimensione del ‘noi’ in Psicologia delle folle e analisi dell’Io, in cui descrive ogni Mass, ogni collettivo, ogni ‘noi’, come qualcosa di essenzialmente fascista. Perché l’unità nel ‘noi’ presume sempre un Führer, un leader, una sorta di alienazione del desiderio in lui. Come ha potuto Lacan fondare allora una scuola quasi di massa di cui lui era il capo indiscusso? Il fatto che poco prima della sua morte l’abbia sciolta ci dice però che non era fatto per il potere sulle folle. “Aveva con l’esercizio del potere un rapporto che definirei minimalista” (p. 52).
Qual era allora il rosebud di Lacan? Direi proprio averci detto che ogni esistenza singolare - anche la propria - gira attorno al mistero di una bocca socchiusa che si presenta come dolcissima. Egli era a un tempo Kane con il suo buco e il giornalista che lo cerca. Quell’enigma che Lacan è per noi, è il suo modo di girare attorno a quell’enigma che ogni essere umano, anche per se stesso, è. In fondo, ha indicato sempre un buco fondamentale che rompe la coerenza del soggetto-organismo. Una beanza - se mi si permette questo neologismo - nella teoria psicoanalitica, certo, anche nella propria teoria, che però a sua volta esprime una beanza fondamentale dell’essere umano. Come ci ricorda Millot, chiamò l’essere umano “il singolare”, separandolo dal particolare. Egli cercava una singolarità senza senso con cui ciascuno di noi deve confrontarsi.
In fisica si chiama singolarità ogni fenomeno per cui le leggi della fisica normale cessano di valere, come nei buchi neri. Lacan pensava che il fondo di ciascuno è qualcosa di “impossibile” per il quale non valgono le nostre leggi e che lui chiamava il Reale, un buco nero che lo ha polarizzato negli ultimi anni.
Allora Lacan fu completamente assorbito, direi assillato, dai nodi borromei. Si tratta di un numero indefinito di anelli - minimo tre - allacciati in un certo modo che, se se ne taglia uno, tutti gli altri risultano liberi.
Millot ci ricorda che gli spaghi per fare catene borromee avevano ormai invaso le due case di Lacan. Negli ultimi tempi, nei suoi seminari si limitava a disegnare sulla lavagna anelli e nodi sempre più complessi, in silenzio; quasi non parlava più.
Non discuto qui l’eventuale utilità dei nodi borromei nella pratica e nella teoria analitiche; ma certamente la passione di Lacan per essi erano il suo godimento e il suo sintomo. Bisogna psicoanalizzare anche la teoria psicoanalitica, e lo psicoanalista che la elabora. Evidentemente Lacan si interrogava: come mettere assieme il fatto che riusciamo a legare aspetti della nostra soggettività in modo da “chiuderci” felicemente, con il taglio, lo spezzarsi del nodo, che getta tutto nella baraonda della libertà? In quei nodi vedo il tentativo di una risposta a un paradosso fondamentale, quello dell’esistenza umana che la psicoanalisi non fa altro che ricalcare.
Attorno a questo paradosso, il vortice del modo di vivere e di pensare di Lacan. Questo vortice lo rende indigesto a molti, proprio perché non ci si può mai riposare in una definitiva consistenza della teoria. In questo vortice faceva girare insieme gran parte dello scibile, in una bulimia simile a quella speculativa di Hegel: psicoanalisi e opere letterarie, matematica e filosofia, logica arte e linguistica. Questo ciclone girava attorno a un occhio che egli chiamò Reale. Con questo qualcosa che manca al puzzle - e che in qualche modo ci libera pericolosamente da ogni legge - si è confrontato tutta la vita.
-
> "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. --- I tre passi fondamentali della perversione (di Massimo Recalcati)13 marzo 2017, di Federico La Sala
- "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
I tre passi fondamentali della perversione
di Massimo Recalcati (DoppioZero, 13.03.2017)
Possiamo riassumere l’illusione perversa in tre passi distinti. Il primo passo è quello critico. Il perverso ambisce a denunciare la Legge degli uomini come un’impostura, a smascherarne la falsità e l’ipocrisia, a sviluppare una serrata critica alla dimensione disciplinare, repressiva, assoggettante della Legge. Per Sade la Legge assomiglia ad un “serpente velenoso”. La Legge degli uomini è un veleno perché trasforma la vera virtù - la spinta acefala della pulsione - in vizio, perché associa la virtù al giudizio morale imboccando la strada superegoica dell’esaltazione idealizzante del sacrificio e della colpa.
La critica della Legge è un punto fondamentale del pensiero perverso. Non a caso Sade assume l’atto perverso come una sorta di “negazione della negazione”: negazione di quella negazione morale che la Virtù eserciterebbe sul Vizio. Nega la negazione della vita promossa dalla Legge; solo il Vizio, non la Virtù, sarebbe, infatti, l’espressione naturale - “senza Legge” - della vita. Il carattere di impostura e di artificio simbolico della Legge consiste invece nel fatto che essa allontana l’uomo dalla Natura rendendolo schiavo, prigioniero della Legge stessa, la quale non sarebbe altro che una manifestazione della difesa impaurita del soggetto nei confronti dell’eccesso indomabile del godimento. È la prossimità paradossale che Lacan sottolinea tra Kant e Sade: eleggere il godimento - la “volontà di godimento” sadiana - come nuovo imperativo universale della Legge al quale vengono subordinate le vite individuali e i loro interessi più empirici.
La colpa e la maledizione della Legge degli uomini è negare la realtà della Legge del godimento. La Legge degli uomini aliena la vita dalla sua Origine, da quel godimento compatibile col corpo che Sade vede incarnarsi nella vita della Natura. Non è quindi un caso che il progetto sadiano consista nel tentativo di rinaturalizzare l’uomo, di ricuperarne l’Origine, l’innocenza della vita al di qua dell’esistenza della Legge.
Il secondo passo è quello fondazionista. Il progetto perverso non può essere contenuto nella sola critica alla Legge. La sua esigenza è assai più radicale. Esso non si accontenta della versione paolina della Legge nella sua dialettica col desiderio (interdizione-trasgressione), ma pretende di riscrivere ex-novo la Legge, di rifondare la Legge, di dare alla Legge un nuovo fondamento. Il “senza Legge” del godimento perverso non è quindi un vero “senza Legge” perché il godimento diviene la nuova e unica forma possibile della Legge una volta abbandonata l’impostura della Legge degli uomini. Il vero perverso non gode, infatti, nella trasgressione della Legge - è questo è semmai il tratto perverso che può accompagnare il desiderio nevrotico -, ma aspira alla sua rifondazione radicale.
Quale? Qual è la Legge delle Leggi alla quale il perverso si vota come un “crociato”, come un “cavaliere della fede”, per usare le espressioni che Lacan propone nel Seminario XVI? Qual è la Legge delle Leggi che dovrebbe oltrepassare la maledizione colpevolizzante della Legge degli uomini? Questa Legge - nella lettura perversa della vita - è la Legge della Natura che, non a caso, Sade concepisce come una sorta di “armonia invertita” e che Pasolini sintetizza nella prima battuta di uno dei membri del diabolico quartetto del suo Salò : “l’eccesso è Bene”. Battuta che eleva l’eccesso alla sola forma possibile della Legge, alla sua forma compiuta, ovvero inumana.
Il terzo e più fondamentale passo è però quello metamorfico. Il passo più essenziale della perversione non è infatti né quello della critica alla Legge, né quello della spinta alla sua rifondazione. Il passo più essenziale - il più decisivo passo - è quello della metamorfosi dell’umano. Quale metamorfosi? Quella che Lacan nel Seminario X descrive come trasformazione del Soggetto sbarrato nell’oggetto piccolo (a). Si tratta di una metamorfosi masochista.
Il perverso non si limita a realizzare il godimento di fronte alla negatività infelice del desiderio, ma punta a trasformare il soggetto stesso del desiderio, il soggetto diviso, sbarrato, mancante, il soggetto che non può mai coincidere con se stesso - il soggetto dell’inconscio - in un oggetto inerte che non conosce mancanza, non conosce divisione, non conosce desiderio, non conosce negatività. In Sade questa metamorfosi rinvia alle figure di Dio e dell’animale come due forme di vita che escludono la distanza che separa il corpo dal godimento. L’esito ultimo della metamorfosi perversa è quello di assimilarsi a Dio (“Dio è presente ovunque in Sade”, ha scritto Lacan ) o, ma è, paradossalmente, la stessa cosa nella logica perversa, all’animale. Dio e l’animale sono, infatti, due forme di vita nelle quali la disgiunzione che distanzia e che separa il godimento dal corpo viene annullata.
La metamorfosi perversa eleva il masochismo a forma compiuta della perversione. Solo nel masochismo può realizzarsi pienamente la soppressione del soggetto diviso come indice della forma umana della vita perché nel sadismo sopravvive ancora una quota di soggettività, una quota di volontà, di intenzionalità. Il sadico vuole godere, agisce per sottomettere l’Altro al suo regime volontaristico gettandolo nell’angoscia, ma non può mai coincidere con l’oggetto del suo godimento. La sua resta ancora una spinta a godere che denuncia paradossalmente lo scarto che continua a sussistere tra corpo e godimento. Nel sadismo - come mostrano le pagine sartriane de L’essere e il nulla dedicate al desiderio sadico - sussiste una spinta a godere che mentre vorrebbe annullare la distanza insopprimibile tra il godimento e il corpo è costretto a rivelarla eternamente. Questa distanza può essere soppressa (illusoriamente) solo nell’inerzia della posizione masochista. Per questo secondo Lacan, diversamente da Freud, non esiste alcuna simmetria tra sadismo e masochismo; l’uno non è il polo attivo (sadismo), né l’altro quello passivo (masochismo) di una identica economia pulsionale. Piuttosto secondo Lacan è il masochismo a realizzare la metamorfosi compiuta del soggetto alla quale punta il disegno perverso.
Nel masochista più che nel sadico ci troviamo di fronte a una totale abolizione del soggetto diviso del desiderio. Il masochista si gode, infatti, solo in quanto oggetto; si rende oggetto compatto come un minerale, una pietra, un “cane”, un “detrito”, uno “scarto”, come afferma Lacan. Puro oggetto, impersonalità pura dell’oggetto e del godimento Uno.
L’aspirazione più estrema della perversione è quella di realizzarsi - come scrive puntualmente Lacan in Kant con Sade - in una “vicinanza” assoluta con la Cosa. Il masochista è un Dio che non conosce la morte: essere un cane, uno scarto, un detrito significa realizzare una forma di vita (inumana) in cui la mancanza e il desiderio siano finalmente aboliti. La sua impersonalità spurga la vita dall’angoscia per la morte e per l’eccesso anarchico della vita. Essa vuole restituire al corpo - sottratto alla Legge del linguaggio - la sua integrità assoluta di corpo di godimento, compatto come il cemento, libero da ogni forma di mancanza.
 In questo senso il masochismo è il tentativo più radicale di raggiungere, in vita, una forma di vita (impersonale) che non conosce più l’assillo della mancanza. Una vita che è già non-vita; quella di un Dio o di un animale. Operazione di messa a morte della forma umana della vita. Per il masochista il desiderio è morto e, di conseguenza, il godimento può finalmente darsi, nel corpo, come assoluto. Essere cane, scarto o detrito realizza una forma di vita dove la mancanza è dichiarata illusoriamente estinta. Il desiderio morto e il godimento reso assoluto; la vita finalmente libera dall’angoscia della morte.
In questo senso il masochismo è il tentativo più radicale di raggiungere, in vita, una forma di vita (impersonale) che non conosce più l’assillo della mancanza. Una vita che è già non-vita; quella di un Dio o di un animale. Operazione di messa a morte della forma umana della vita. Per il masochista il desiderio è morto e, di conseguenza, il godimento può finalmente darsi, nel corpo, come assoluto. Essere cane, scarto o detrito realizza una forma di vita dove la mancanza è dichiarata illusoriamente estinta. Il desiderio morto e il godimento reso assoluto; la vita finalmente libera dall’angoscia della morte. -
> "PERVERSIONI". --- "THE PRODIGY". Gaffe della Casa Bianca su Theresa May, diventa pornostar.28 gennaio 2017, di Federico La Sala
L’EUROPA, IL CRISTIANESIMO ("DEUS CHARITAS EST"), E IL CATTOLICESIMO COSTANTINIANO ("DEUS CARITAS EST"). Una storia di lunga durata...
- MURATORI, BENEDETTO XVI, E "UNO SPROPOSITO MAIUSCOLO": LA LEZIONE DI VICO.
- LA CHIESA DEL SILENZIO E DEL "LATINORUM".
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
- SULL’INCONTRO DI RATZINGER - BENEDETTO XVI E BUSH. LA CRISI DEL CATTOLICESIMO ROMANO E DELLA DEMOCRAZIA AMERICANA NON SI RISOLVE... RILANCIANDO UNA POLITICA OCCIDENTALE DA SACRO ROMANO IMPERO
Gaffe della Casa Bianca su Theresa May, diventa pornostar
Nei suoi comunicati, l’ufficio stampa ha dimenticato di mettere la ’h’
di Redazione ANSA *
Nuova gaffe dell’amministrazione Trump in politica estera. Dopo aver confuso il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop per il premier Malcolm Turnbull, l’ufficio stampa della Casa Bianca ha ’dimenticato’ la ’h’ nel nome della premier britannica Theresa May. Risultato: in due documenti l’inquilina di Downing Street è diventata la nota star del soft-porn Teresa May.
L’errore, poi corretto, è stato ripetuto due volte nel comunicato di ieri con il quale la Casa Bianca annunciava l’agenda odierna degli incontri Trump-May e una volta in un comunicato dell’ufficio del vice presidente. "Nel pomeriggio il presidente parteciperà ad un incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Teresa May", recitava la nota dell’ufficio stampa della Casa Bianca.
E qualche riga dopo la ’h’ era di nuovo sparita nel previsto "pranzo di lavoro con Teresa May...". Ancora una volta, nella nota dell’ufficio di Mike Pence il nome di battesimo di May è diventato quello della star di un video per la canzone ’Smack My Bitch Up’ del gruppo The Prodigy. "E’ per questo che Donald Trump era eccitato di incontrarla?", commenta ironico il tabloid britannico Mail online riferendosi al previsto colloquio di oggi tra il neo presidente e la premier britannica a Washington. Sempre ieri, ricorda il Mail online, in un altro comunicato la Casa Bianca ha definito il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop il ’primo ministro degli Esteri’ del Paese.
-
>"PERVERSIONI" --- L’empatia virtuale di Ed Atkins e il sex appeal dei corpi digitali (di Simona Brunetti).4 gennaio 2017, di Federico La Sala
- "PERVERSIONI" (...) La mente estatica e l’accoglienza astuta degli apprendisti stregoni. Una nota sul sex-appeal dell’inorganico di Mario Perniola.
- "OMBRE ET PHOTO": IN ITALIA, NELLA PRIMA REPUBBLICA "PLATONICA" A LUCI ROSSE E A CIELO APERTO. UNA GRANDE LEZIONE (E GLI SCATTI) DI BAUDRILLARD.
L’empatia virtuale di Ed Atkins
di Simona Brunetti *
L’esperienza della contemporaneità è segnata da una progressiva perdita di importanza del corpo quale luogo primario ed esclusivo di qualsiasi rapporto tangibile col mondo e con gli altri. Il nostro “abitare” un corpo materiale non ci preclude la possibilità di switchare con disinvoltura su un corpo digitale che a sua volta abita un mondo parallelo, alternativo a quello reale, e di interagire con esso sulla scia dell’idea illusoria di un trascendimento emozionale pressoché totale.
Eppure succede davvero, che “virtualmente” siamo liberi di cambiare faccia, nome e identità, accettare l’amicizia di qualcuno o cancellarlo dalla nostra vita. Virtualmente possiamo finanche morire o rimanere vivi, pur essendo morti nella vita reale. È un corpo, questo virtuale, che si configura sempre meno come surrogato e sempre più come prolungamento del corpo fisico ed emozionale, alimentando un fenomeno che è assai più evidente nelle ultime generazioni dei cosiddetti “nativi digitali”, nati cioè all’interno di una società multi-schermo e abituati ad interagire con una realtà mediata da schermi e dispositivi tecnologici di varia natura.
A tale generazione appartiene Ed Atkins, inglese, classe 1982, a cui Torino dedica due grandi mostre personali, una al Castello di Rivoli (a cura di Marianna Vecellio e Carolyn Christov-Bakargiev) e l’altra alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (a cura di Irene Calderoni e della stessa Bakargiev). Di questa generazione Atkins mantiene un punto di vista “interno” al medium pur avendo, da artista, una visione accorta dei molteplici processi di riversamento della realtà nel suo epigono digitale. Egli in pratica è sia dentro che fuori quel vissuto ibrido generazionale in cui il corpo fisico individuale si espande in un corpo virtuale (dal latino virtualis che viene da virtus = forza, potenza) che racchiude in sé, appunto, tutte le potenzialità dell’essere. Un corpo “desiderante” ma anche desiderato poiché, bisogna ammetterlo, «esso ha un suo sex appeal ed è spesso molto più interessante da invitare a cena di quello reale perché la rappresentazione che costruiamo di noi è molte volte assai più sexy della banale realtà» (Luca Poma, Il sex appeal dei corpi digitali. Seduzione, amori, tradimenti, malattie e immortalità dei nostri digital body, Franco Angeli 2016).
La rappresentazione simbolica di questi corpi desideranti/desiderati si concretizza, nel lavoro di Atkins, in una serie di personaggi animati digitalmente che riaffiorano dal buio delle stanze del Castello di Rivoli su superfici-schermo sulle quali talvolta il video è sincronicamente ripetuto, seguendo una logica di compresenza che è paradigmatica dell’universo virtuale. Lo spazio espositivo diviene dunque una proiezione della scatola nera dell’inconscio: luogo da dove emergono creature digitali modellate sulle sembianze del volto dell’artista, descritte con un’attenzione iperrealistica che indulge su dettagli anatomici come capelli, salive, denti, pelli, lividi, tatuaggi, cicatrici, e che le riqualifica, illusoriamente, come corpi “di carne e sangue”. Sono uomini dalla bellezza stereotipata, persi nei meandri dell’esistenza tra abusi, noia e malattia; che ci parlano di malinconia, di morte, dello scorrere del tempo, di ricordi e che, da un primo sguardo, appaiono ben più che semplici avatar.
Atkins non si limita infatti a ricreare delle rappresentazioni virtuali del sé che vivono e agiscono in un ambiente tecnologico disgiunto da quello reale. Il suo intento è di dar vita a personaggi che ammaliano il pubblico, perché creano empatia. E lo fanno attraverso gli strumenti usuali dell’arte del sedurre. Ovvero attraverso la parola, e dunque coi soliloqui poetici imploranti e carichi di autocommiserazione con i quali ciascuno di essi getta un ponte emotivo tra sé e l’interlocutore; attraverso lo sguardo, nella loro continua ricerca di un contatto visivo con lo spettatore; e ancora attraverso la musica, nei loro canti di autocommiserazione che, nati come altrettante elaborazioni digitali della voce dell’artista, rappresentano la voce inquieta di un inconscio che anela e al tempo stesso patisce la propria mutazione nella direzione dell’umano sentire.
Quella mutazione che i personaggi di Atkins subiscono “da dentro”, in uno scenario hypersensual in cui la sensazione non è indotta e dunque esterna all’opera ma è rappresentata o, per meglio dire, personificata, a mezzo di una strategia che potremmo definire “batetica” (da bathos, parola di origine greca utilizzata dal poeta del XVIII secolo Alexander Pope per descrivere una situazione letteraria in cui l’estrinsecazione eccessiva di un’intensa emozione sfocia nel ridicolo o, addirittura, nell’osceno). Proprio per questo la potenza emotiva che gli alter-ego digitali di Atkins tentano di restituire non convince fino in fondo ed è ragione, piuttosto, di uno scetticismo diffuso nei confronti di questi surrogati emozionale di cui l’artista è consapevole artefice.
Il protagonista di uno dei video esposti a Rivoli, Ribbons (2014), un bifolco di nome Dave, sputa poesie su un amore perduto mentre fuma sigarette fino al filtro e orina dentro al suo stesso bicchiere. Egli è antipatico e al tempo stesso accattivante, proprio per quel carattere di vibrante e accorata umanità che lo contraddistingue. Ma facciamo appena in tempo ad affezionarci a lui che la sua testa si accartoccia come un pallone sgonfio, disvelando la beffa di un’esistenza vissuta solo in qualità di oggetto creato e controllato da altri.
È esattamente quel che accade al protagonista di Safe Conduct (2016), la grande installazione video a tre canali che, negli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, è allestita in modo da ricordare i tabelloni di arrivi e partenze degli aeroporti: soggetto ai normali controlli aereoportuali di sicurezza, egli vede passare nei contenitori porta-oggetti, che scorrono sul tapis roulant verso lo scanner a raggi x, i pezzi del suo corpo smembrato da una tecnologia che teoricamente avrebbe dovuto proteggerlo. Chi è dunque il personaggio che continua con enfasi a renderci partecipi dell’ansia provocata da tale macabra esperienza? È possibile assimilarlo ancora a un’idea di umano pur essendo egli mancante di testa, braccia, gambe, mani, piedi?
Con questo ulteriore espediente narrativo Atkins spezza il cerchio magico dell’empatia tra schermo e fruitore e al tempo stesso opera una critica nei confronti di quella necessità dell’“essere visti” per “vedere” cui faceva riferimento Baudrillard con la metafora dello “specchio senza amalgama”: uno specchio dietro il quale «vediamo il mondo ma lui non ci vede, non ci guarda; ora, le cose si vedono solo se ci guardano. Lo schermo fa schermo a qualsiasi rapporto duale» (Jean Baudrillard, Il patto di lucidità o l’intelligenza del male, Cortina 2006). E così sottende l’ennesimo invito a riconoscere il limite, che va sempre più perdendosi nell’era digitale, oltre il quale le nostre vite smettono di essere il risultato di una reale interazione tra noi e il mondo; quel limite oltre il quale si esaurisce la nostra capacità di rimanere radicati nella storia in quanto soggetti immuni a qualsiasi strategia di controllo esercitata dai media.
Ed Atkins
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna Vecellio
Torino, Castello di Rivoli, 27 settembre 2016-29 gennaio 2017
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Irene Calderoni
Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 27 settembre 2016-29 gennaio 2017
-
> "PERVERSIONI" -- IL CANTICO DEI CANTICI. La verità sull’amore nascosta nel più erotico dei libri.6 dicembre 2016, di Federico La Sala
- "Amore è più forte di Morte"(Ct., 8.6): Cantico dei cantici, traduzione e cura di Giovanni Garbini, Paideia, Brescia 1992
- SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota
- "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO -
- SESSO, POLITICA, E RELIGIONE - OGGI. IL "CATTOLICESIMO" PLATONICO E LA PLANETARIA "CAVERNA A LUCI ROSSE". QUALE POSSIBILE NUOVO RAPPORTO TRA "EROS"(il "dio" di Platone) E "AGAPE"(il "dio" di Giovanni)? Un’intervista al teologo Giuseppe Angelini
Il Cantico dei cantici
La verità sull’amore nascosta nel più erotico dei libri
Il testo biblico che descrive il desiderio resta un codice segreto. Come dimostrano gli ultimi studi
- “È un enigma” scriveva già Sant’Agostino La sua sacralità andava di pari passo al suo mistero. Nel III secolo perse l’originario connotato realistico e diventò allegoria dell’eros mistico
di Silvia Ronchey (la Repubblica, 06.12.2016)
Di cosa parliamo quando parliamo del Cantico? Questa domanda non può avere risposta. «Il cantico è un enigma», scriveva Agostino (“Sermo” 46, 35). È un mistero nel senso tecnico della parola. L’iniziato non parlerà perché non potrà farlo (“mysterion” da “myein”, «tenere le labbra serrate»). Il profano parlerà, ma non saprà di che parla. «Perché chi sa non parla e chi parla non sa», secondo il detto di Lao Tse.
Ma alla fine del I secolo, quando si formò il canone della bibbia giudaica, il sapiente Rabbi Aqiba disse: «Il mondo intero non vale il giorno in cui il Cantico dei cantici è stato donato a Israele, perché tutte le Scritture sono sante, ma il Cantico dei cantici è il Santo dei santi». Già allora che cosa fosse il Cantico non lo si sapeva né voleva dire: la sua santità era direttamente proporzionale al suo mistero; anzi, era proprio la profondità abissale dei suoi enigmi a sprigionare quel vertice di santità.
«Petali di loto le labbra del mio amato /colano mirra. Il suo inguine è avorio / tempestato di zaffiri. / Favi colanti le tue labbra mia sposa / miele e latte sotto la tua lingua / come incenso del Libano / l’aroma del tuo grembo / giardino chiuso fonte sigillata. / Entri il mio amato nel suo giardino / succhi il suo frutto prodigioso. / Nel mio giardino entravo / mia sorella mia sposa / e la mirra e ogni essenza rapivo / e succhiavo il miele dal favo».
Poemetto di età post-esilica, forse patchwork di canti attinti al patrimonio della tradizione assiro-babilonese ed egizia oltre che ebraica, con echi greco- ellenistici nello stile di Teocrito, il Cantico è indubitabilmente un testo erotico, quasi pornografico.
Nella traduzione latina di Girolamo: Dilectus meus misit manum suam per foramen / et ventrem meus intremuit ad tactum eius. «Il mio amato infila la mano nel mio grembo/ le mie viscere fremono per lui. / Per aprirgli mi alzo /le mie mani colano mirra /dalle dita la mirra fluisce / sul chiavistello che impugno». Secondo la tradizione rabbinica, alcuni brani del Cantico venivano cantati nelle taverne. Si sdegnava Rabbi Aqiba: «Chi canta il Cantico nelle taverne o lo tratta come una canzone profana non avrà posto nel mondo futuro».
Levitò presto l’esegesi anagogica midrashica, gelosamente sacra, del Cantico come celebrazione dell’alleanza sponsale tra JH-WH e Israele, protratta poi nell’interpretazione cristiana che per secoli e secoli vi lesse la figura dell’amore di Cristo per la chiesa, non senza lasciare spazio a una congerie di altri sistemi allegorici minori, spesso iniziatici - astrologici, cabalistici, filosofico- sapienziali -, nella letteratura medievale, rinascimentale e moderna. Sulle ali della metafora della sposa-chiesa i versetti del Cantico si disseminarono nella fonosfera della liturgia, della musica, della letteratura, tramandole come mantra sempre meno dischiusi al senso. Più la torsione simbolica della teologia occidentale sottraeva loro il significato naturale - da Ambrogio a Gregorio Magno, da Guglielmo di Saint-Thierry a Bernardo di Clairvaux, da Francesco di Sales a Bossuet - più le sillabe e le immagini spandevano il loro mistero elementare.
Nigra sum sed formosa.
Da Monteverdi a Giovanni della Croce, da Maupassant a Moreau duemila anni di omissioni hanno addensato connessioni così colossali nel Cantico da renderlo simile all’Aleph di Borges: un punto dello spazio letterario che contiene una pluralità infinita di altri punti. Già il Talmud ammoniva, comunque, a non sottovalutare la letteralità che nessun testo biblico deve mai perdere. I letteralisti o naturalisti sono sempre, a ragione, esistiti: bizantini come Teodoro di Mopsuestia o giudaici come Ibn Ezra. Un grande saggio protestante del Cinquecento, Sébastien Castellion, propose di eliminare il Cantico dal canone dei testi ispirati, in polemica con Calvino; lo seguì Herder. Il Novecento ha visto anche esegeti ecclesiastici cattolici, da Dietrich Bonhoeffer a Luis Alonso Schökel, assaliti dal dubbio: se dietro i versetti del Cantico non ci fosse nulla?
Bisogna intendersi. Il Cantico è nulla. È un prisma trasparente nella cui luce si riflette, moltiplica e illumina qualunque esperienza reale o spirituale, intellettuale o dottrinale vi si accosti. Inoltre, dietro al Cantico c’è il nulla. «In verità, il vuoto del Cantico è lì per confermarne la sacralità. Il Cantico è un pezzo di vuoto sacrale. Dico che è vuoto per non negargli niente», ha scritto Guido Ceronetti.
Almeno quanto l’Ecclesiaste evoca il vuoto e almeno quanto Giobbe il dolore, il Cantico evoca la dolorosa inattingibilità dell’amore. «L’uomo non può capire il Cantico se non ha mai amato», ha scritto Bernardo. Anima mea liquefacta est. Quaesivi, et non inveni illum. Vocavi, et non respondit mihi. «La mia anima si disfa. / Lo cerco e non lo trovo / lo chiamo e non risponde».
Ha scritto Jung: «Mi sono ripetutamente trovato di fronte al mistero dell’amore, e non sono mai stato capace di spiegare cosa sia. Qui si trovano il massimo e il minimo, il più remoto e il più vicino, il più alto e il più basso, e non si può mai parlare dell’uno senza considerare l’altro. Non c’è linguaggio adatto a questo paradosso. Qualunque cosa si possa dire, nessuna parola potrà mai esprimere tutto».
Nessuna parola può esprimere tutto, ma il Cantico, illusionisticamente, lo fa. Se la natura del desiderio è indicibile, il Cantico la dispiega in enigmi. «Mettimi come un sigillo sul tuo cuore / come un tatuaggio sul tuo braccio / perché forte come la morte è l’amore / duro come l’Ade il desiderio ». L’amore è più forte della morte: cosa vuol dire? che l’amore può vincere la morte? che il piacere è una piccola morte? che l’eros è la morte dell’io e ci fa uscire dai suoi confini portando all’insania, come già segnalato da Lucrezio?
«L’eros lo conosciamo solo nella distanza del fallimento. Prima del fallimento non si dà conoscenza », ha scritto Christos Yannaras, massimo esperto contemporaneo del Cantico (alcune delle sue pagine in AA.VV., Il più bel canto d’amore. Letture e riscritture del Cantico dei cantici, Qiqajon, Comunità di Bose, pagg. 231, euro 20, che del Cantico contiene anche la migliore traduzione italiana, di Enzo Bianchi). «Dopo il fallimento sappiamo che l’eros è il modo della vita, ma un modo inaccessibile alla natura umana. Il modo della vita lo palpiamo nella privazione, nel calco dell’assenza ».
La riflessione sull’eros del teologo ortodosso Yannaras conclude oggi il discorso sul Cantico aperto da un altro filosofo greco-orientale, Origene: nel III secolo, quando da poco quell’erma testuale bifronte che esaltava un amore fisico e carnale fino all’oscenità era entrata nel libro sacro a tre religioni e in queste aveva cominciato a porre, o trasporre, il suo enigma. Enfant prodige del platonismo alessandrino, a poco più di vent’anni Origene si era evirato. Aveva, narra Eusebio, troppo da fare coi libri, giorno e notte, e questa era per lui già «una passione e una ginnastica ». Nulla doveva distoglierlo dal comparare e commentare i testi della bibbia. Il suo fu il più grande esperimento di applicazione dell’esegesi allegorica neoplatonica al cristianesimo.
Nel Commento al Cantico, opera della sua maturità, uscito ora in traduzione italiana insieme alle magnifiche Omelie sul Cantico di un altro grande padre greco, Gregorio di Nissa (Origene, Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei cantici, a c. di V. Limone e C. Moreschini, Bompiani, pagg. 1565, euro 50), raccolse l’eredità della ricerca platonica sull’essere e la sua contrapposizione fra anima e corpo, tra metafora e lettera, tra esoterismo e “annuncio”. Sottrasse al Cantico letteralità e fisicità per accenderne l’erotismo metaforico in un modo che nessuno aveva mai osato prima: utilizzandolo in senso psicologico. Col bisturi della filologia neutralizzò la carne degli sposi, per lasciare tutto lo spazio al loro puro spirito. Operò, in un certo senso, come aveva operato sul suo stesso corpo.
L’autoevirazione di Origene, che la tradizione antica riporta, fu reale o simbolica? Di fatto, in uno dei più fantasmagorici trompe l’oeil della letteratura universale, con Origene il Cantico perse per sempre il suo originario connotato realistico per diventare un’allegoria dell’eros mistico, di quell’amore sofferente che sta in ogni atto di ricerca o tentativo di creazione o impulso di unione.
La Sulamita che cerca lo sposo non è solo Israele, secondo l’interpretazione giudaica, e non è solo la chiesa, secondo la versione cristiana vulgata. È in primo luogo l’anima, che secondo la tradizione platonica cerca sempre, e non trova, la perfezione del Logos. Con il Commento al Cantico di Origene il cristianesimo orientale si è fin dall’inizio affiancato agli altri grandi saperi tradizionali nell’esprimere il quaesivi et non inveni, il “cerco e non trovo” che si applica a tutte le sfere dell’indagine, ma anzitutto a quella su noi stessi.
-
> "PERVERSIONI" --- L’ira delle star contro Bertolucci ("Ultimo Tango a Parigi").5 dicembre 2016, di Federico La Sala
L’ira delle star contro Bertolucci
Ultimo Tango a Parigi, Maria non consenziente
di Stefano Landi (Corriere della Sera, 05.12.2016
L’intervista a Bernardo Bertolucci su Ultimo Tango a Parigi è del 2013 («Nella scena dello stupro Maria Schneider non era consenziente»). Rilanciata sul web ha scatenato le attrici Usa contro il regista: «Vada in carcere».
È bastato che il sito americano della rivista Elle ripubblicasse (in inglese) quelle parole per scatenare un nuovo boato di polemiche in Rete su Ultimo tango a Parigi. Si tratta di un’intervista rilasciata nel 2013 dal regista del film Bernardo Bertolucci alla Cinémathèque Française, ora ripresa da tutti i siti americani: «L’allora 19enne Maria Schneider non era consenziente nella celebre scena dello stupro. Perché volevo vedere la sua reazione come ragazza, non come attrice. Volevo si sentisse realmente umiliata» ammette il regista.
E così ieri è (ri)esplosa la reazione sdegnata di attori e registi di Hollywood. «Per tutte le persone che amano questo film, state vedendo una ragazza di 19 anni violentata da un uomo di 48. E il regista aveva pianificato l’aggressione» ha twittato Jessica Chastain. Le repliche sono riassumibili in tre concetti: «Bertolucci dovrebbe finire in prigione». «Gli andrebbero tolti tutti i premi». «Il film non andrebbe più fatto vedere».
Alle parole di Chastain hanno fatto eco quelle di Evan Rachel Wood, che ha rivelato recentemente di essere stata vittima in passato di due stupri: «Una cosa straziante e oltraggiosa: quei due erano malati per pensare che la cosa potesse funzionare». Poi Chris Evans («non guarderò più questo film, va oltre il disgusto, provo rabbia»), Ava DuVernay («come regista posso a malapena immaginare, come donna sono disgustata»), Anna Kendrick («Miss Schneider aveva dichiarato tutto questo anni fa, io ricevevo occhiatacce quando ne parlavo con qualche uomo»).
Nella sequenza, il personaggio interpretato dall’allora 48enne Marlon Brando, costringe la giovane Schneider a un violento rapporto di sodomia. Lo stesso Bertolucci dice nell’intervista di «aver agito in un modo orribile con Maria, perché non le ho spiegato cosa sarebbe successo. Perché a volte nei film per ottenere una certa reazione bisogna essere completamente liberi».
Il film, uscito nel 1972 (premiato con un David di Donatello, un Nastro d’argento e nominato all’Oscar) ha una lunga storia legale, sfociata con la condanna alla distruzione della pellicola nel gennaio del ‘76, per poi essere riabilitata dalla censura nel 1987.
Schneider, che morì nel 2011 per un tumore, dopo una vita complicata anche da problemi di tossicodipendenza, portò i segni di quell’esperienza. Ne parlò direttamente nel 2007 in un’intervista al Daily Mail : «Mi sono sentita violentata, porto ancora le sofferenze di qualche scena. Bertolucci nei momenti di crisi non è mai corso in mio aiuto. E nemmeno Brando, dopo aver girato quella scena, mi consolò né chiese scusa» raccontò l’attrice. «La sua morte è arrivata prima che potessi riabbracciarla e chiederle scusa», disse Bertolucci il giorno della sua morte.
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
Cultura. Sessualità, etica, psicoanalisi ...
 "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
"PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO".
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota
SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota-
> "PERVERSIONI" --- Bertolucci ("Ultimo Tango a Parigi"): “Basta polemiche. Maria Schneider sapeva della scena”.6 dicembre 2016, di Federico La Sala
Bertolucci
“Basta polemiche. Maria Schneider sapeva della scena”
di S. N. (La Stampa, 06.12.2016)
«Qualcuno ha pensato, e pensa, che Maria Schneider non fosse stata informata della scena di violenza su di lei in Ultimo tango a Parigi. Falso! Maria sapeva tutto perché aveva letto la sceneggiatura, dove era tutto descritto. L’unica novità era l’idea del burro. È quello che, come ho saputo molti anni dopo, offese Maria, non la violenza che subisce nella scena e che, ripeto, era prevista nella sceneggiatura del film».
Lo ha chiarito il regista Bernardo Bertolucci all’indomani della polemica scoppiata sul web e che ha fatto schierare contro di lui molte attrici americane riguardo alla scena di sodomia nel famoso film scandalo. «Vorrei, per l’ultima volta, chiarire un ridicolo equivoco - sottolinea Bertolucci - che continua a riportare Ultimo Tango a Parigi sui giornali di tutto il mondo.
Qualche anno fa, alla Cinematèque Française, qualcuno mi ha chiesto dettagli sulla famosa “scena del burro”. Io ho precisato, ma forse non sono stato chiaro, di avere deciso insieme a Marlon Brando, di non informare Maria. Volevamo la sua reazione spontanea a quell’uso improprio. L’equivoco nasce qui».
«È consolante e desolante - prosegue il regista - che qualcuno sia ancora così naïf da credere che al cinema accada per davvero quello che si vede sullo schermo. Quelli che non sanno che al cinema il sesso viene (quasi) sempre simulato, probabilmente, ogni volta che John Wayne spara a un suo nemico, credono che quello muoia per davvero’». [S. N.]
-
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- Kamasutra. Ci sono gli dèi dietro i segreti dell’erotismo. L’antico testo indiano non è solo una guida ai comportamenti sessuali.2 dicembre 2016, di Federico La Sala
KamasutraCi sono gli dèi dietro i segreti dell’erotismo
 L’antico testo indiano non è solo una guida ai comportamenti sessuali
L’antico testo indiano non è solo una guida ai comportamenti sessuali
 Per alcuni versi è un trattato politico per altri un repertorio romanzesco
Per alcuni versi è un trattato politico per altri un repertorio romanzesco
 Ma il vero gusto dell’opera si coglie risalendo alla cornice divina di schermaglie amorose
Ma il vero gusto dell’opera si coglie risalendo alla cornice divina di schermaglie amorosedi Roberto Calasso (la Repubblica, 02.12.2016)
Universalmente noto come repertorio di posizioni erotiche, talvolta passabilmente acrobatiche e tali da mettere in soggezione un certo numero di amanti occidentali, timorosi di essere poco inventivi, il “Kamasutra” di Vatsyayana è anche, e forse soprattutto, un eccellente canovaccio romanzesco, sotto specie di trattato ossessivamente classificatorio. Ma per scoprirlo occorre una guida adatta - e nessuna potrebbe essere migliore di Wendy Doniger, unica - per quanto so - fra i grandi indologi viventi che sia anche un’autorità sui B-movies di Hollywood, nonché sui vertiginosi intrecci di storie che possono svolgersi intorno e dentro un letto, come ha dimostrato in un sostanzioso volume - “The Bedtrick” - di qualche anno fa. Così la sua edizione annotata del Kamasutra, pubblicata in collaborazione con Sudhir Kakar nel 2002, è diventata subito - e rimarrà - il testo di riferimento per questo classico che è stato a lungo troppo famigerato per essere letto con la dovuta attenzione.
Le reazioni sono state subito vivaci e, nel corso dei quattordici anni successivi, Wendy Doniger ha avuto più volte occasione di tornare sul tema, inserendo il Kamasutra nella trattatistica indiana, che costituisce un immane corpus di testi. E soprattutto su uno di questi trattati si è appuntata la sua indagine: l’Arthashastra, che è il supremo compendio politico dell’India, considerato da molti di gran lunga più spietato e spregiudicato del Principe di Machiavelli. E Doniger infierisce ancora, scrivendo che «Kautilya fa sembrare Machiavelli come Madre Teresa». Anche se un parallelo trattato cinese, il Libro del Signore di Shang, che conosciamo grazie alla sapiente edizione di J.J.L. Duyvendak, può far apparire in paragone miti - anche se non proprio da Kindergarten - sia Kautilya sia Machiavelli.
L’arte erotica esposta nel Kamasutra sarebbe dunque un ramo specifico di quell’arte degli stratagemmi e degli inganni che Kautilya tratta magistralmente. Dopotutto, spie, infiltrati e mezzani possono rivelarsi indispensabili per conquistare una città come per sedurre una donna. E il Kamasutra lo dimostra con dovizia di esempi. Il rapporto è indiscutibile e Doniger lo illumina puntualmente, anche se - come sempre in India - è disperante stabilire una sequenza temporale rigorosa in cui situare i testi.
Ma una volta accertata la matrice trattatistica entro cui il Kamasutra è nato e va considerato, per il lettore di oggi il fascino - e anche il sottile divertimento - dell’opera è tutto nella straripante materia romanzesca di cui è intriso. Il libro può essere letto, da cima a fondo, come un repertorio delle situazioni erotiche in cui può venirsi a trovare un certo personaggio - e delle reazioni che può provocare nelle sue controparti femminili.
Ma chi è questo personaggio? È il nagaraka, il man-about-town, come la lingua inglese concede di tradurre la parola, con perfetta corrispondenza idiomatica (nagara vuol dire “città” in sanscrito). Questo uomo di mondo innanzitutto è ricco e non ha obblighi di alcun genere. La sua unica mira è espandere e acutizzare i suoi piaceri, in numerose direzioni, anche se l’eros spicca fra tutte. È devoto soltanto al kama, al “desiderio”. Non intende accrescere il suo “potere” e i suoi “interessi” (sfera dell’artha).
Quanto al dharma, “ordine” o “legge”, lo rispetta e lo ignora. Come il giovane Ovidio a Roma due secoli prima, frequenta i riti e le feste religiose perché sono ottime occasioni per individuare donne belle, passibili di diventare un giorno oggetto di conquista. La sua vita è al tempo stesso variegata e altamente ripetitiva. Ma tale non è forse anche quella di un uomo d’affari, di un cortigiano o di un religioso? Se il culmine e coronamento di ogni sua attività è l’atto sessuale - così come lo era il concubitus per il giovane Ovidio dell’Ars amatoria -, l’uomo di mondo sarà tenuto ad addestrarsi anche nelle «sessantaquattro arti che deve imparare chiunque (maschio o femmina) tratti in modo veramente serio il piacere ». E qui è solo una delizia scorrerne l’elenco, che include la capacità di ritagliare sagome dalle foglie, fare musica sugli orli di bicchieri d’acqua (come il Mozart dei pezzi per Glasharmonika), preparare letti, mescolare profumi, insegnare a parlare a pappagalli e gracule, praticare la stregoneria, conoscere lessici e dizionari di sinonimi, essere esperti di presagi e delle scienze strategiche. Infine, al sessantaduesimo posto, appaiono “le buone maniere”.
Entrambi gli amanti devono gareggiare in tutte queste arti - e la loro pratica, secondo il “Kamasutra”, non fa che accrescere l’esaltazione erotica. Le stesse conoscenze appartengono all’educazione di una cortigiana di lusso. La quale, se ne è esperta, «ottiene un posto nel consesso pubblico». Nulla è arbitrario o accidentale: alle sessantaquattro arti corrispondono le sessantaquattro varianti dell’amplesso. Che non differiscono molto, per pure ragioni anatomiche, da quelle suggerite dalle massime autorità occidentali in materia, che rimangono l’Aretino e l’autore dei dialoghi di Aloisia Sigea.
E qui si impone una glossa: l’Occidente ha prevalentemente affidato la dottrina delle posizioni erotiche a voci femminili: i Ragionamenti dell’Aretino e i dialoghi di Aloisia Sigea sono conversazioni fra donne che sanno molto della vita sessuale o sono avide di saperne di più. Mentre l’unico trattato dell’antichità classica paragonabile al Kamasutra (e ahimè perduto) era attribuito a una certa Elephantis, il cui nome - secondo la Pauly-Wissowa - «può essere situato nel folto gruppo di nomi di etère che sono derivati da animali». Nulla rimane di tale testo, tuttavia sappiamo da Suetonio che le sue tabellae - ovvero illustrazioni - vennero fatte copiare dall’imperatore Tiberio sulle pareti della sua villa a Capri, come manuale di istruzioni per i suoi ospiti e per se stesso.
Ma, più che nell’elenco delle veneris figurae o modi coeundi - come si usava dire a Roma -, la peculiarità del Kamasutra sta nella sistematicità e nella implacabile precisione del dettaglio. Come anche nel fatto che questa puntigliosa cronaca fisiologica e psicologica include in sé sia una descrizione dell’orgasmo femminile quale nessun autore occidentale avrebbe azzardato sia un elenco degli accorgimenti con cui una cortigiana può liquidare un amante molesto. Lettura incantevolmente profana, che al tempo stesso non può comunque fare a meno di richiamarsi all’antichità vedica e, di là da essa, alla vita degli dèi. Perché di fatto già nel Rigveda si diceva che «il desiderio, kama, è il primo seme della mente».
Così veniamo a sapere che Vatsyayana è solo il tardo redattore di un trattato di materia erotica che nel corso del tempo si era sempre più ridotto e semplificato. Suo primo autore era stato il mite toro Nandin, che vegliava sulla porta della camera da letto dove Shiva e Uma erano congiunti in un interminabile coito, durato mille anni degli dèi. Insieme guardiano, voyeur e scriba, Nandin aveva annotato il sapere erotico che un giorno anche gli uomini avrebbero dovuto apprendere, sebbene parzialmente, essendo incapaci di applicarlo nella sua interezza. Procedimento usuale nell’India classica, presupponente all’inizio una conoscenza sterminata, che si contrae e inaridisce nel tempo, fino alle bassure del Kali Yuga, in cui viviamo. Concezione specularmente opposta a quella evoluzionistica occidentale, che presuppone all’inizio una successione di bruti inarticolati, che poi si innalzano fino alle sommità della Ragione.
Il vero gusto del Kamasutra non si coglie se dalle sue minuziose descrizioni di schermaglie e trappole erotiche, dove graffi e morsi ricordano sempre che l’eros è comunque un duello - e talvolta mortale -, non si risale a quella remota cornice divina. Perché in India, fin dall’origine e fin dai riti esposti nei Brahmana, l’eros è ubiquo e onnipresente. Non meno illuminante di Nandin è il secondo autore leggendario del Kamasutra: Shvetaketu, colui che ridusse i mille capitoli scritti da Nandin a quei cinquecento destinati a essere poi, nel corso del tempo, ulteriormente ridotti, fino a diventare i centocinquanta di Babhravya del Panchala e i trentasei di Vatsyayana.
Chi era Shvetaketu? Lo vediamo apparire, a ventiquattro anni, nella Chandogya Upanishad. Dopo dodici anni di studi, si presenta al padre come «contento di sé, fiero delle sue conoscenze, orgoglioso ». Il padre gli dice che ancora nulla sa, anche se aveva studiato tutti i Veda. Ora gli sarebbe toccato andare oltre. E a questo punto il padre di Shvetaketu avviava una sequenza rapinosa di pensieri, che culminava con l’atman, il Sé, e si condensava in tre parole: Tat tvam asi, “Ciò tu sei”. Quelle tre parole sono il grano di senape che schiude l’immensità vedica. E a noi sono giunte in quanto parole dette a questo giovane brahmano, il quale - in un momento successivo della sua vita - avrebbe redatto una versione abbreviata della dottrina erotica di Nandin. Così Shvetaketu era stato un anello fra gli anelli da cui è nato il Kamasutra. A dimostrazione del fatto che, se c’è stato un luogo dove tout se tient, tale era l’India vedica. In Occidente sarebbe difficile immaginare una leggenda che facesse risalire a Parmenide il trattato erotico dell’etèra Elephantis.
Wendy Doniger ha finalmente reso giustizia al Kamasutra, innanzitutto traducendolo in modo adeguato, senza i malintesi e le superfetazioni stilistiche di Burton, e ricollocandolo in una posizione eminente nella trattatistica indiana. Utile contravveleno a quelle «pratiche pervasive e spesso violente di polizia morale » che hanno attanagliato una parte dell’India e della diaspora indiana in questi ultimi anni, soprattutto dopo il ritorno al governo del Bharatiya Janata Party, con le sue squadre di fondamentalisti indù del Bajrang Dal, che intervengono brutalmente per impedire i festeggiamenti per San Valentino, considerati un esempio di “capitalismo pornografico”.
Giustamente, come considerazione finale, Doniger ha ricordato che il dio Kama, ovvero Desiderio, dopo esser stato incenerito da Shiva, venne a trovarsi infuso, con le sue particelle, «in un certo numero di altre sostanze, che facevano agire la magia di Kama in modo ancora più efficace - la luce lunare, le sopracciglia arcuate delle donne belle e così avanti». E Shiva stesso è contraddistinto dalla più vasta oscillazione fra estremi che conosciamo. Lo dice anche il titolo di un libro prezioso che Doniger pubblicò nel 1973: Shiva. L’asceta erotico. Ma quell’oscillazione vale anche per l’India in genere. Di Kama nessuno sarà in grado, per fortuna, di sbarazzarci.
From The New York Review of Books © 2016 by Roberto Calasso
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- RECALCATI ALLA LEOPOLDA. Il Telemaco, il messia e la Costituzione (di S. Thanopulos)19 novembre 2016, di Federico La Sala
Psicoanalisi, Storia e Politica....
- GENITORI, FIGLI, E FORMAZIONE: AL DI LA’ DEL FALLIMENTO, COSA RESTA DEL PADRE? PER MASSIMO RECALCATI, OBBEDIENTE A LACAN, RESTA ANCORA (E SEMPRE) LA LUNGA MANO DELLA MADRE.
- "PERVERSIONI" di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO
Verità nascoste.
Il Telemaco, il messia e la Costituzione
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 19.11.2016)
Massimo Recalcati nell’elogiare, alla Leopolda, Matteo Renzi, ha accusato la sinistra del No di essere masochista, paternalista e di odiare la giovinezza. Accuse fondate su luoghi comuni.
Un discorso aforistico, privo di argomenti, teso a screditare l’avversario piuttosto che ad esprimere una propria opinione sui quesiti referendari.
L’andazzo è proprio questo: la grande maggioranza degli italiani nel referendum prossimo voterà pro o contro Renzi, a prescindere dalla valutazione di una riforma che modificherà in modo sostanziale la costituzione italiana.
La personalizzazione del conflitto politico ha finito per espropriarci della cura nei confronti delle regole fondamentali della nostra convivenza democratica. Si è fatta strada una corrente di «eccezione dalla costituzione», che mentre aspira formalmente a riformarla, di fatto crea il clima di una sua sospensione sul piano emotivo.
Questo tipo di sospensione dell’ordinamento costituzionale è il più pericoloso. La restrizione diretta e apertamente autoritaria delle garanzie costitutive dei nostri diritti, crea opposizione e ribellione.
La loro sostituzione con l’affidamento regressivo all’«uomo della provvidenza», da una parte sposta l’attenzione su un quesito fuorviante - se costui è quello «vero» o quello «falso» - e dall’altra favorisce la deresponsabilizzazione.
La nota identificazione del premier con Telemaco, nella versione ideata da Recalcati come riparazione (impropria) dell’assenza del padre, è espressione di un vissuto di delegittimazione collettiva. Di questa delegittimazione, della cui origine non è responsabile, Renzi si è costituito come l’interprete più importante.
L’ha fatto per negazione, cioè oscurandola: più incerta sente la propria legittimità, più insiste sulla delegittimazione degli altri.
La rottamazione pura e semplice di una classe politica inadeguata non produce di per sé legittimazione. Se resta come unica opzione perpetua il senso di delegittimazione. Infatti, Renzi, il rottamatore, si identifica con Telemaco: un figlio reso illegittimo dall’assenza del padre e dalla solitudine, vedovanza «bianca», della madre (le due condizioni sono inscindibili).
Dimentica che il ritorno della legge nel regno di Itaca, non è opera di Telemaco. Deriva dal ritorno di Ulisse nel letto coniugale, dal suo riconoscimento e legittimazione come uomo e come padre dall’amore di Penelope.
Le regole «costituzionali» che garantiscono la buona gestione delle relazioni familiari, sono fondate sulla capacità dei genitori di essere soggetti paritari nel loro legame di desiderio. I figli che rottamano il padre, cercando di sostituirlo nell’amore della madre, finiscono per assumere un ruolo messianico.
In modo analogo al governo familiare, il governo della Polis non può essere affidato a un Telemaco capovolto nel suo significato, che non sa attendere il suo tempo. Aspettare il momento giusto per sentirsi adulti - l’accesso alla piena comprensione della congiunzione erotica dei genitori e della sua problematicità - è il senso vero dell’attesa del padre in Odissea.
Un leader capace di identificarsi con Penelope e Ulisse, cioè con il senso di corresponsabilità che costituisce le relazioni cittadine in termini di condivisione e di scambio, è molto più affidabile di un figlio che si sostituisce ai genitori. Costui si imprigiona nel destino del redentore e, diversamente da Telemaco di Omero, si considera il frutto di una unione spirituale tra un padre ideale e una madre/figlia vergine. Promuove la deresponsabilizzazione che gli ha assegnato la sua funzione immaginaria e si/ci illude di poter farcela.
-
> PERVERSIONI. ---- Se Madame Bovary avesse letto "Madame Bovary", ha scritto Flaiano, avrebbe probabilmente frenato le sue fantasticherie di «pornografia sentimentale» (di Ilaria Gaspari).11 luglio 2016, di Federico La Sala
CONOSCI TE STESSO!!! Dopo millenni di riflessione, la nostra identità ("tautòtes" - greco) ancora nella culla o, meglio, nella bara ("taùto" - napoletano)
- LA FILOSOFIA E IL NARCISISMO "DIALOGICO". AMORE DELL’ALTRO O AMORE DI SE’? E’ LO STESSO. Una "risposta" di Umberto Galimberti.
- IMMAGINARIO E POLITICA. ALLE ORIGINI DEL SUPERUOMO DI MASSA E DELL’ITALIA COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE DI UN UOMO SUPREMO
 KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
KANT E GRAMSCI. PER LA CRITICA DELL’IDEOLOGIA DELL’UOMO SUPREMO E DEL SUPERUOMO D’APPENDICE.
SENTIMENTI. Un legame gioioso e maturo non è una passione esclusiva: esige una presa di distanza per comprendere e accettare l’inaccessibilità dell’altro
In amore ascoltate Spinoza per evitare il rischio Bovary
di Ilaria Gaspari (Corriere della Sera, La Lettura, 10.07.2016)
Se Madame Bovary avesse letto Madame Bovary, ha scritto Flaiano, avrebbe probabilmente frenato le sue fantasticherie di «pornografia sentimentale». Un effetto dissuasivo ancora più forte l’avrebbe ottenuto, credo, con un paio di proposizioni dell’ Etica di Spinoza.
La povera Emma modellò la sua infelicità sulle molte possibilità narrative degli amori tormentati. Sognando di balli, duelli, eroine esangui nel gorgo della passione, imbrigliò l’amore nella fantasticheria di una forza che trascina alla rovina.
L’amore fa soffrire, doveva sospirare fra sé l’infelice signora Bovary, boccheggiante di noia, con la testa piena di romanzi d’appendice e un marito prosaico che nel frattempo sorbiva rumorosamente la soupe à l’oignon. A furia di sospirarlo, ci credette; pur di vivere quell’avventura romantica che si era imbastita non fece caso allo squallore della scappatella con Rodolphe. E finì avvelenata.
E pensare che l’antidoto a questo veleno si poteva trovare facilmente, distillando un po’ dell’ Etica di Spinoza; non un romanzo (qualcuno ha detto che non esistono romanzi sugli amori felici), e nemmeno un libretto di istruzioni o un decalogo che insegni a sfuggire alle relazioni fallimentari. Ma un libro per lettori coraggiosi; un libro petroso che, se lo si ascolta bene, può curare molti dei mali che nascono quando si vive prigionieri del luogo comune secondo il quale l’amore deve far soffrire.
Di Spinoza non si ricordano grandi amori. Le lettere raccolte dagli amici con cui coltivò una lunga corrispondenza dal suo esilio di reietto dopo lo herem, il decreto che lo «scomunicò», sono scritti dottrinali, con qualche fortuito scorcio sulla sua vita nascosta - troppo poco, però, per poterne ricostruire le vicende. Tutte le biografie ce lo consegnano come una sorta di santo eretico, un saggio stoico capace di condurre una vita esemplare, sobria e morigerata. Strana figura, quella di Spinoza, l’ateo virtuoso che sarà riesumato, ancora avvolto nel suo odore di santità, da un gruppo di giovanotti inquieti nella Germania di fine Settecento. Ma Spinoza dell’amore ha detto una cosa fondamentale: che amare non significa possedere l’altro, ma vederlo così com’è, comprendere che esiste al di fuori di noi; e quindi che l’amore vero non fa soffrire, ma anzi, è pura gioia.
L’ Etica parla molto di amore, ne costruisce una vera fenomenologia. L’amore è per Spinoza il motore di quella comprensione del mondo che, sola, permette all’uomo di rendersi veramente libero. L’amore gioioso di cui parla Spinoza è tutto il contrario di una passione esclusiva che procede per slanci di insicurezza e narcisismo, che segrega e fa soffrire; l’amore di cui parla Spinoza è la strada per uscire da se stessi e addentrarsi nel mondo.
Spinoza è stato forse il primo filosofo a costruire un’etica che sapesse farsi beffe della morale come scienza che addomestica il corpo a una teoria di valori astratti; ha sovvertito i termini dell’antica opposizione monolitica fra passione e ragione.
L’amore non è necessariamente una passione, nel senso di qualcosa che si subisce, dice Spinoza, che inventa il concetto nuovo di affetto, e trasfigura così la nozione classica di passione aprendole la possibilità di trasformarsi in un atto di conoscenza. Se la passione ci getta in balia di quello che proviamo, l’affetto è un mezzo per capire e conoscere il mondo anche attraverso le emozioni che suscita in noi. Come i colori nascono da combinazioni di giallo, rosso e blu, anche la tavolozza degli affetti è fatta di tre affetti primari: il desiderio - una sorta di primordiale istinto di sopravvivenza -, la gioia e la tristezza. Se la tristezza è un negarsi al mondo, la gioia è uno slancio verso un legame più intenso con la realtà - per Spinoza, che usa una parola della Scolastica, perfezione.
Spinoza racconta un amore che è una pura espressione della gioia: una gioia particolare però, innescata dalla presenza di una causa esterna - l’oggetto dell’amore. L’amore, essendo gioia, ci rende più attivi, più «perfetti», più immersi nella realtà; ma non è possibile se non alla presenza di un altro, che coincide con lo scatenarsi di questa gioia. Simone Weil è stata perfettamente spinoziana quando ha scritto che l’amore ha bisogno di realtà; e che amare è riconoscere l’esistenza di altri esseri umani.
Qui inciampò la povera Madame Bovary: trincerandosi in un amore asfittico, non fece troppo caso alla causa esterna se non come a una proiezione delle sue fantasticherie scopiazzate dai romanzi, e non seppe allarmarsi quando quella gran passione, invece di renderla più attiva e più viva, la paralizzò, impedendole anche di indovinare quello che poteva passare per la testa di Rodolphe. Chi non riconosce l’esistenza dell’altro, infatti, è incapace anche di quell’esercizio di empatia che rende l’amore uno strumento di conoscenza dell’altro, ma anche di sé.
«Chi immagina che ciò che ama sia affetto da Gioia o Tristezza, sarà anch’egli affetto da Gioia o Tristezza», dice la proposizione 21 della terza parte dell’ Etica : l’amore induce un mimetismo che ci porta a provare, per empatia, quello che immaginiamo provi la persona che amiamo; a condividerne le paure, gli odi e gli amori. Ma questo slancio empatico sarebbe solo una prova di narcisismo - o di bovarismo - se non tenessimo ben fermo l’aspetto fondamentale della teoria spinoziana dell’amore: cioè il fatto che si può parlare di amore solo in presenza di una causa esterna, di un altro che sta fuori di noi.
Per amare davvero, bisogna accettare la distanza, il segno che l’oggetto del nostro amore è reale. Robert Musil, in una sua pagina quasi di diario, Percezioni finissime, racconta la scoperta vertiginosa di questa distanza che ci separa dall’altro. Lo scrittore è a letto, con la febbre, in una camera d’albergo; ascolta nel dormiveglia, senza vederla, la toilette della moglie che si prepara per andare a dormire; e sente per la prima volta, nel frusciare della camicia da notte, nelle forcine che cadono sotto la spazzola, la vita segreta di lei: «Con piccoli gesti incoscienti e innumerevoli, di cui non sai renderti conto, tu t’immergi in un vasto spazio dove nemmeno un soffio di me stesso t’ha mai raggiunta. Lo sento per caso, perché ho la febbre e ti aspetto».
La povera Emma Bovary non dovette mai guardare Rodolphe con questi occhi, né ascoltarlo così, nel buio; eppure, se l’avesse fatto, le sarebbe stata risparmiata la vita. La vita, magari; non quel pungolo di dolore che si cerca di anestetizzare, nel nostro tempo che demonizza la sofferenza, con terapie di coppia e poste del cuore e manuali di self-help, e che però fa parte anche dell’amore più gioioso. Nell’atto di comprendere e accettare l’inaccessibilità dell’altro, nel vedere il segreto di un’intimità senza desiderare di violarla o di annientarla, un dolore c’è. Un dolore sottile che - direbbe Spinoza - non si può domare a furia di ragionamenti, né cancellare con i sillogismi; ma viene abbracciato dall’amore vero, un affetto più forte della gelosia e della smania di possesso.
Solo se abbracciamo quel dolore, e troviamo il coraggio di guardare chi amiamo sapendo che non lo possederemo mai, possiamo provare a sfuggire all’epigrafe su cui Leo Longanesi ha fissato lo sberleffo di chi rifiuta per accidia la fatica della libertà: «Visse infelice, perché costava meno».
-
> PERVERSIONI. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- L’avventura del contatto. «Lectio» di Jean-Luc Nancy al Festival delle donne e dei saperi di genere (Bari)30 aprile 2016, di Federico La Sala
- SESSO (EROS) E AMORE (AGAPE, CHARITAS). L’ARTE DI AMARE: COSTITUZIONE E "KAMASUTRA". La lezione di Sigmund Freud (l’"Istruzione sessuale dei bambini") e una nota
- KANT E SAN PAOLO. COME IL BUON GIUDIZIO ("SECUNDA PETRI") VIENE (E VENNE) RIDOTTO IN STATO DI MINORITA’ DAL GIUDIZIO FALSO E BUGIARDO ("SECUNDA PAULI").
L’avventura del contatto
Tempi presenti. «S/Oggetti di desiderio: Sexistence»: un’anticipazione della «lectio» che il filosofo francese terrà a Bari il 5 e il 6 maggio, al Festival delle donne e dei saperi di genere
di Jean-Luc Nancy (il manifesto, Alias, 30.04.2016)
Esiste l’amore in tutta la sterminata estensione del termine, l’amore senza confini, l’amore per l’umanità, il mondo, la musica, il mare o la montagna, la poesia o la filosofia, che è essa stessa amore della sapienza. Non è così? Quest’ultima, a sua volta, consisterebbe soltanto nell’amare ciò che non si può giudicare, né conoscere o rifiutare: tutto l’altro in quanto altro, tutto l’esterno in quanto esterno, e la morte e l’amore stesso, impeto furibondo che ci fa morire nell’altro o fa morire l’altro in noi.
Esiste questo amore sconfinato, inesorabile, insopportabile, insensato, impossibile, ed esiste quello che si fa e per il quale non possediamo altro termine se non, appunto, «fare l’amore» (oppure «andare a letto», espressione che però non solo manca di eleganza, ma si trascina dietro una sfilza di parole volgari, triviali, oscene, sporche, disonorevoli, impronunciabili, oppure riservate per essere pronunciate, gridate o mormorate durante l’amore stesso, quando lo si fa). L’ultimo tipo di amore viene definito preferibilmente «eros», mentre per il primo il lessico oscilla tra «philia», «agapè» e «caritas».
In prossimità di soddisfazione
Questi due amori hanno in comune lo slancio, l’infervoramento, la precipitazione senza riserve e senza prospettive: non viene fissato lo scopo, l’esito non viene descritto, si tratta di arrivarci sapendo che l’importante non è giungere alla meta. Forse aspiriamo a tracciare i confini di una finalità possibile: se da un lato ciascun altro è il mio prossimo, la sua prossimità sembra giustificare e persino invocare la mia predilezione, la scelta che faccio di lui e il valore insigne che gli attribuisco; dall’altro, si suppone che il furore del desiderio raggiunga un grado di soddisfazione tale da potersi placare. Eppure sappiamo perfettamente che non ci è data alcuna prossimità senza che questa ci venga immediatamente sottratta più in là, in un’estraneità infinita. E sappiamo anche che non esiste «soddisfazione» - niente «satis», niente «abbastanza» per colui che desidera non tanto appagarsi quanto desiderare ancora e sempre, di nuovo.
All’orizzonte sia di un amore che dell’altro compare la riproduzione, sotto forma di conservazione del gruppo attraverso la pace comunitaria, oppure sotto forma di conservazione della specie (e/o del gruppo...) attraverso la generazione di nuovi individui. In entrambi i casi, tuttavia, ci si pone al di là dell’opera: tanto il gruppo quanto il nuovo individuo devono rinnovare il desiderio per conto proprio, invece di esserne il prodotto.
Forse il sesso propone una cifra - se non la cifra - di tale rinnovamento del desiderio, che in fondo non è altro che il desiderio stesso.
L’eccitazione sessuale, con tutta la sua forza animale e il suo singolare dominio sull’animale umano, rappresenta una turbolenza ontologica del rapporto: alla pari del linguaggio, lo porta molto lontano, cioè dove non si può parlare di satis-fazione, dove non se ne può mai fare abbastanza, ma dove c’è incessantemente qualcosa da fare, qualcosa che non avviene mai come tale, né come risultato, che perciò non è mai «fatta», ma che pure non smette mai di volersi fare.
Un atto performativo
Cosa facciamo quando facciamo l’amore? (domanda sussidiaria: in quante lingue si dice, più o meno letteralmente, fare l’amore?) Noi non facciamo niente nel senso di produrre qualcosa ; se si fa un figlio, che lo si consideri o meno una produzione (riporto l’espressione di Françoise Dolto: «I genitori credono di fare dei figli, ma si accorgono presto che i figli non lasciano fare!»), non si tratta dell’amore in quanto tale, che potrebbe benissimo essere del tutto assente. Noi facciamo nel senso che compiamo un atto, anche se quello designato non è un vero e proprio atto, è un sentimento, una disposizione, l’eccitazione del rapporto al di là di se stesso, verso ciò che sembra destinato a rinnovarlo all’infinito, oppure a oltrepassarlo in un amplesso con cui concluderlo, senza però sapere in che senso vada preso quest’ultimo verbo.
Se non altro l’espressione indica un’effettività dell’amore che nessuna dichiarazione, nessuna dimostrazione, nessuna testimonianza potrà mai pretendere di raggiungere. Ecco perché, in un certo senso, non è impossibile fare l’amore in maniera diversa dal rapporto sessuale in senso stretto: lo scambio di sguardi, di questo o quel contatto, persino delle parole può avventurarsi sul terreno di questo «fare». Almeno una cosa, infatti, è certa: l’amore non può essere soltanto detto, il suo dire stesso dev’essere un fare. «Ti amo» è un atto performativo: fa ciò che dice. L’amplesso si limiterà ad aggiungere un dire in eccesso, che «performa» il proprio limite.
Perché bisognerebbe parlarne? Semplicemente perché non c’è casualità nel gesto compiuto da Freud quando ha voluto fare piena luce teorica sul sesso, gesto cui tendevano già da qualche tempo alcuni approcci antropologici del XIX secolo. Non c’è casualità perché non sorprende che venga investito di nuovi significati ciò che era stato così accuratamente e costantemente sottoposto a un controllo morale e religioso, vale a dire ciò che poteva soltanto restare dissimulato per essere meglio sublimato nell’assunzione dell’amore divino.
La dissimulazione del sesso non faceva che portare avanti, con una modalità nuova proveniente dal contesto cristiano, la sua antichissima valenza sacra. Forse non esiste cultura in cui il sesso non sia, o non sia stato, oggetto di prescrizioni particolari, che si tratti dei culti rivolti agli organi genitali, dei sistemi di parentela e legittimità delle unioni, dei tabù o delle clausole d’impurità, delle condanne di alcune forme di sessualità, delle prostituzioni sacre oppure delle pratiche sessuali legate a certi esercizi spirituali - per limitarci ad alcune voci di un elenco che potrebbe essere molto più lungo e preciso.
Se è vero che il cristianesimo, tra tutte le culture, forse ha rappresentato la forma più propensa alla diffidenza e all’astinenza sessuali, evidentemente esiste un nesso con il motivo dell’amore così come è stato determinato dal cristianesimo. L’amore cristiano non si distingue soltanto, come si dice spesso e a ragione, dall’eros in quanto desiderio di possesso. Del resto, in buona parte della teologia e della spiritualità cattoliche, l’agapè - distinta in quanto affetto, diletto, cura (che diventa caritas) dell’altro - è stata spesso accostata per molti aspetti all’eros.
 Carità e concupiscenza si oppongono, ma l’una non può essere completamente estranea all’altra, perché in un certo senso si deve pure amare ciò che si desidera, oppure desiderare ciò che si ama. In realtà, carità e concupiscenza si attraggono a vicenda tanto quanto sembrano respingersi.
Carità e concupiscenza si oppongono, ma l’una non può essere completamente estranea all’altra, perché in un certo senso si deve pure amare ciò che si desidera, oppure desiderare ciò che si ama. In realtà, carità e concupiscenza si attraggono a vicenda tanto quanto sembrano respingersi.Il ritorno infinito
Se l’unico amore che vale (se non addirittura che esiste) è quello di Dio nel senso di un genitivo soggettivo, cioè l’amore che viene da Dio e anche l’amore che costituisce l’essere Dio, allora questo amore rivolto all’intero creato, amore egli stesso creatore, relega nell’insignificanza qualsiasi amore non divino e al contempo chiama qualsiasi creatura a entrare in quell’amore, a diventare amore. Così due tendenze profonde hanno governato e diviso il cristianesimo, riunendosi e dividendosi al suo interno: un’espansione infinita dell’eros e un’assunzione di qualsiasi desiderio e piacere sotto l’egida di una cura originaria.
Nell’ottica dell’infinito, l’esigenza eccede in maniera assoluta ogni possibilità di realizzazione, oppure non viene realizzata se non come l’atto divino da cui procede. Dio crea per amore e questo amore vuole tornare a sé all’infinito. L’amore diventa il nome di un ritorno infinito - all’origine, a sé, all’altro assoluto. Nell’ottica della totalità, il tutto va inteso non più come un ordine (un cosmos con il suo arché e il suo logos), bensì come una scelta gelosa che ordina (nuovo senso di èn archè hèn o logos). L’amore ordina che lo si preferisca, come esso stesso ci ha preferito (al nulla). Esiste un debito assoluto.
Esiste un debito, il dovere di restituire l’amore ricevuto e, al tempo stesso, questo amore ricevuto costituisce una specie di credito illimitato: l’amore rivendica se stesso ovunque, in tutti. Vi è dunque una specie di totalitarismo, un’economia totalitaria dell’amore, dietro la quale peraltro non è certo indifferente veder profilarsi un’economia del profitto. È a partire da questo che è possibile comprendere come il sesso si manifesti al mondo moderno con un vigore, una virulenza e persino una violenza mai conosciute altrove. Esso è carico di tutta l’energia che nessun impeto divino può più assumersi e che quindi non raccolgono nemmeno più le macchine adibite alla produzione.
La vita in più
Saremmo tentati di dire che il figlio è una produzione (poiesis), mentre l’amore è un comportamento (praxis). Tale distinzione, però, risulterebbe troppo semplicistica, perché un figlio è un’altra esistenza più che un prodotto e il comportamento sessuale è ben lungi dal limitarsi agli atti che portano questo nome. È molto difficile decidere dove cominci e dove finisca il sesso attraverso tutti i nostri rapporti, attività e atteggiamenti. Esso attraversa tutta la nostra vita. Ciò che ha portato alla luce Freud, con il nome di «pulsione (Trieb) erotica», non è l’imprevista importanza, più o meno meccanica, di un registro inferiore della nostra animalità umana: è piuttosto la figura al tempo stesso nuova e antichissima di ciò che ha aperto l’essere vivente a un sovrappiù di vita e l’essere vivente parlante a un’esclamazione ai confini del senso.
Per il momento accontentiamoci di dire che il sesso apre l’esistente a un abisso e a una violenza che se non esauriscono certo i tratti digressivi e scoperti dell’esistenza, quanto meno possiedono una caratteristica: ci conducono - in un groviglio di abisso e violenza - sul bordo di un «fare» che fondamentalmente si limita a sfiorare al tempo stesso il doppio al di là dell’animale e del divino, due nomi che non dicono altro se non che l’esistenza è la sua stessa «deiscenza», una sexistenza. (Traduzione italiana di Ida Porfido)
- SCHEDA
Si concluderà in grande la quinta edizione del Festival delle donne e dei saperi di genere, con le due lezioni di Jean-Luc Nancy del 5 e 6 maggio che andranno a coronare il percorso fitto di appuntamenti, tra filosofia, cinema, teatro e incontri, che ha preso avvio a Bari fin dalla metà di aprile.
 Dedicata interamente al segno delle transizioni, quindi partendo dalla riflessione intorno alla soggettività nomadica, la cifra complessa del presente riesce a dipanarsi. Ne è convinta Francesca Recchia Luciani, organizzatrice e direttrice del festival e docente di Storia delle filosofie contemporanee a Bari; appartiene infatti al presente l’interrogazione sul corpo «e l’identità sessuale, i corpi migranti nella loro relazione con i luoghi, riguarda tutti i cambiamenti innestati nell’esistenza individuale dall’appartenere a un mondo relazionale e sociale in perenne metamorfosi».
Dedicata interamente al segno delle transizioni, quindi partendo dalla riflessione intorno alla soggettività nomadica, la cifra complessa del presente riesce a dipanarsi. Ne è convinta Francesca Recchia Luciani, organizzatrice e direttrice del festival e docente di Storia delle filosofie contemporanee a Bari; appartiene infatti al presente l’interrogazione sul corpo «e l’identità sessuale, i corpi migranti nella loro relazione con i luoghi, riguarda tutti i cambiamenti innestati nell’esistenza individuale dall’appartenere a un mondo relazionale e sociale in perenne metamorfosi».
 Se nelle prime due edizioni il baricentro atteneva ai saperi e le pratiche delle donne, da tre anni a questa parte il festival ha cambiato non solo nome ma anche fisionomia. Una torsione che è apertura femminista al tema delle differenze.
Se nelle prime due edizioni il baricentro atteneva ai saperi e le pratiche delle donne, da tre anni a questa parte il festival ha cambiato non solo nome ma anche fisionomia. Una torsione che è apertura femminista al tema delle differenze.
 Il rilievo scientifico ma anche politico non può dunque sfuggire quando si nominano le protagoniste delle precedenti edizioni, da Ipazia a Carla Lonzi, passando per Audre Lorde. Centralità di vite e portati politico-filosofici che assumono quest’anno l’idea di un punto di partenza per raccontare cosa esprima la «transizione» quando a essere interpellati sono corpi sessuati e in relazione.
Il rilievo scientifico ma anche politico non può dunque sfuggire quando si nominano le protagoniste delle precedenti edizioni, da Ipazia a Carla Lonzi, passando per Audre Lorde. Centralità di vite e portati politico-filosofici che assumono quest’anno l’idea di un punto di partenza per raccontare cosa esprima la «transizione» quando a essere interpellati sono corpi sessuati e in relazione.
 Con una precisa intenzione di coinvolgimento del territorio, emerge allora una sinergia di forze e di pratiche capaci di attrarre non solo un pubblico di studenti ma più vasto che possa restituire narrazioni all’altezza di uno spaesamento che si fa sempre più pressante.
Con una precisa intenzione di coinvolgimento del territorio, emerge allora una sinergia di forze e di pratiche capaci di attrarre non solo un pubblico di studenti ma più vasto che possa restituire narrazioni all’altezza di uno spaesamento che si fa sempre più pressante.
 Il festival, promosso dal Centro interdipartimentale di studi sulla cultura di genere dell’università degli studi di Bari «Aldo Moro» e sostenuto dalla Regione Puglia, dall’università di Bari, da Apulia film commission e Teatro pubblico pugliese [mentre le lezioni di Nancy sono state sostenute da Fondazione Puglia e Alliance Française di Bari], viene largamente condiviso anche dal tessuto associazionistico e da molte e molti che con passione ci lavorano intorno, nonostante la variabilità dei fondi a disposizione ma con il saldo auspicio di un sempre maggiore impegno. Questo perché la formula adottata in direzione di una trasversalità dei linguaggi può rappresentare un antidoto alle chiusure disciplinari e al contempo un metodo efficace di ricognizione esperienziale.
Il festival, promosso dal Centro interdipartimentale di studi sulla cultura di genere dell’università degli studi di Bari «Aldo Moro» e sostenuto dalla Regione Puglia, dall’università di Bari, da Apulia film commission e Teatro pubblico pugliese [mentre le lezioni di Nancy sono state sostenute da Fondazione Puglia e Alliance Française di Bari], viene largamente condiviso anche dal tessuto associazionistico e da molte e molti che con passione ci lavorano intorno, nonostante la variabilità dei fondi a disposizione ma con il saldo auspicio di un sempre maggiore impegno. Questo perché la formula adottata in direzione di una trasversalità dei linguaggi può rappresentare un antidoto alle chiusure disciplinari e al contempo un metodo efficace di ricognizione esperienziale.
 Il sito che riguarda l’iniziativa è www.festivaldonnesaperidigenere.it. Mentre nel sito della rivista di pratiche filosofiche e scienze umane «Postfilosofie» (http://www.postfilosofie.it), si possono leggere gratuitamente i materiali dei festival precedenti, come quelli relativi agli Atti di questa edizione di prossima pubblicazione. (alessandra pigliaru)
Il sito che riguarda l’iniziativa è www.festivaldonnesaperidigenere.it. Mentre nel sito della rivista di pratiche filosofiche e scienze umane «Postfilosofie» (http://www.postfilosofie.it), si possono leggere gratuitamente i materiali dei festival precedenti, come quelli relativi agli Atti di questa edizione di prossima pubblicazione. (alessandra pigliaru) -
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- Elvio Fachinelli: una nuova lingua per la psicoanalisi (di Massimo Recalcati)11 aprile 2016, di Federico La Sala
- Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
 CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI
- PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET.
- METTERSI IN GIOCO, CORAGGIOSAMENTE. PIER ALDO ROVATTI INCONTRA ELVIO FACHINELLI.
Elvio Fachinelli: una nuova lingua per la psicoanalisi
di Massimo Recalcati (Doppiozero, 01.04.2016)
La recente pubblicazione di alcuni scritti politici di Elvio Fachinelli, curati con attenzione dal filosofo Dario Borso, col titolo semplice ma suggestivo Al cuore delle cose (DeriveApprodi, Roma), suggerisce un bilancio dell’opera di una tra le figure più notevoli e originali della psicoanalisi italiana.
Non a caso Jacques Lacan aveva sempre considerato, sin dalla fine degli anni sessanta, il giovane Elvio Fachinelli come il suo erede più promettente in Italia, il quale però, non a caso, come tutti i suoi migliori allievi, aveva fatta propria l’indicazione di Lacan: “fate come me, non imitatemi!”. In Fachinelli, nella persona e nell’opera, non ritroviamo, infatti, nessuna di quelle farsesche riproduzioni dello stile di Lacan - alla Verdiglione per intenderci - che hanno contrassegnato e penalizzato gravemente la diffusione del lacanismo in Italia negli anni Settanta.
Fachinelli, pur conservando una posizione critica nei confronti del suo establishment, resta membro della Società psicoanalitica italiana rifiutandosi di finire fagocitato nel culto della personalità del grande psicoanalista francese - destino fatale per quasi tutti i suoi allievi, francesi e non.
 E tuttavia, considerando l’itinerario del suo lavoro teorico, risulta evidente come egli si sia ricollegato, sebbene in modo mai scolastico, ad alcune profonde intuizioni di Lacan conferendo loro uno sviluppo singolare. Prima fra tutte lo sforzo, avvertito da entrambi come necessario, di costruire una nuova lingua della psicoanalisi. Il codice della psicoanalisi si è logorato, cristallizzato, è divenuto un tecnicismo senza vita nel quale il discorso universitario (per Lacan “l’ignoranza consolidata”) ha preso il sopravvento reificando in categorie morte la vitalità che permeava il discorso originario di Freud.
E tuttavia, considerando l’itinerario del suo lavoro teorico, risulta evidente come egli si sia ricollegato, sebbene in modo mai scolastico, ad alcune profonde intuizioni di Lacan conferendo loro uno sviluppo singolare. Prima fra tutte lo sforzo, avvertito da entrambi come necessario, di costruire una nuova lingua della psicoanalisi. Il codice della psicoanalisi si è logorato, cristallizzato, è divenuto un tecnicismo senza vita nel quale il discorso universitario (per Lacan “l’ignoranza consolidata”) ha preso il sopravvento reificando in categorie morte la vitalità che permeava il discorso originario di Freud.
 Si rilegga in questa luce la breve introduzione a La freccia ferma (1979) dove Fachinelli dichiara esplicitamente di voler mettere tra parentesi la terminologia psicoanalitica “classica - “irrigidita in un formulario ipostatizzato che spesso impedisce, anziché facilitare, la comprensione delle situazioni concrete" - al fine di poter seguire con maggiore coerenza il filo della sua interrogazione originale sul senso del tempo.
Si rilegga in questa luce la breve introduzione a La freccia ferma (1979) dove Fachinelli dichiara esplicitamente di voler mettere tra parentesi la terminologia psicoanalitica “classica - “irrigidita in un formulario ipostatizzato che spesso impedisce, anziché facilitare, la comprensione delle situazioni concrete" - al fine di poter seguire con maggiore coerenza il filo della sua interrogazione originale sul senso del tempo.Il punto ancora più rilevante è che la grande e raffinata descrizione della nevrosi ossessiva che egli sviluppa in questo primo lavoro finisce per coincidere con l’involuzione della dottrina psicoanalitica stessa che, alla stregua del suo paziente gravemente ossessivo, dall’essere stata una impresa originariamente sovversiva si è trasfigurata “nel battito impersonale di una macchina morale”. La pietrificazione mortificante del soggetto ossessivo coincide dunque con quella che ha investito la dottrina psicoanalitica. Fu lo stesso problema che attraversò il pensiero di Lacan, il quale si sforzò, nel suo stesso stile di insegnamento, di trovare una lingua in grado di riflettere, se non addirittura di imitare, le infinite tortuosità dell’oggetto di cui la psicoanalisi si occupa (l’inconscio).
 Solo che mentre Lacan prende risolutamente la via di una lingua formalmente barocca ma capace di generare una batteria impressionante di concetti inediti, Fachinelli, meno magistralmente, adotta piuttosto quella di un ricorso sempre più frequente all’esperienza fenomenologica capace di raggiungere il cuore delle “cose stesse” sospendendo, con una epochè di fatto, i codici ormai logori e rituali della dottrina psicoanalitica classica.
Solo che mentre Lacan prende risolutamente la via di una lingua formalmente barocca ma capace di generare una batteria impressionante di concetti inediti, Fachinelli, meno magistralmente, adotta piuttosto quella di un ricorso sempre più frequente all’esperienza fenomenologica capace di raggiungere il cuore delle “cose stesse” sospendendo, con una epochè di fatto, i codici ormai logori e rituali della dottrina psicoanalitica classica.Ma il punto dove più sensibilmente si manifesta il lacanismo originale di Fachinelli concerne proprio lo statuto epistemico dell’inconscio. Come per Lacan, anche per lui l’inconscio non è l’istintuale, l’irrazionale, l’animale che un rafforzamento pianificato dell’Io - posto come obbiettivo principale della terapia analitica - dovrebbe governare sino a sedare. Fachinelli si mantiene sulla via aperta da Lacan nel ritenere che l’inconscio non sia il luogo di una minaccia che deve essere scongiurata ma di una apertura che diventa una occasione di trasformazione del soggetto.
 Più radicalmente, per Fachinelli la dottrina psicoanalitica è stata colpevole di essersi eretta come una vera e propria “difesa” nei confronti dell’inconscio finendo per perdere il contenuto più specifico della propria invenzione. È lo stesso giudizio che Jacques Derrida dava di Freud: se per un lato questi aveva con un primo passo sovversivo aperto la ragione all’incontro con l’alterità radicale della follia, con un secondo passo aveva invece provato a colonizzare quella alterità attraverso la concettualizzazione razionale della propria dottrina.
Più radicalmente, per Fachinelli la dottrina psicoanalitica è stata colpevole di essersi eretta come una vera e propria “difesa” nei confronti dell’inconscio finendo per perdere il contenuto più specifico della propria invenzione. È lo stesso giudizio che Jacques Derrida dava di Freud: se per un lato questi aveva con un primo passo sovversivo aperto la ragione all’incontro con l’alterità radicale della follia, con un secondo passo aveva invece provato a colonizzare quella alterità attraverso la concettualizzazione razionale della propria dottrina.La tesi di Fachinelli diventa sempre più chiara e audace col passare degli anni. Quello che ne La freccia ferma attribuiva a una certa degenerazione scolastica della psicoanalisi, ne La mente estatica (1989) viene descritto come un problema già presente nell’originaria posizione di Freud. Per Fachinelli la psicoanalisi stessa, già con Freud, tende a difendersi dall’inconscio, non essendo altro che un tentativo (“infantile”) di arginare la sua potenza e la sua forza eccedente.
 L’apertura de La mente estatica, nell’intensissimo racconto fenomenologico delle proprie percezioni sulla spiaggia di San Lorenzo, pone al centro l’interpretazione di Freud e della psicoanalisi come barriere, argini, barricate nei confronti dell’eccedenza dell’inconscio.
L’apertura de La mente estatica, nell’intensissimo racconto fenomenologico delle proprie percezioni sulla spiaggia di San Lorenzo, pone al centro l’interpretazione di Freud e della psicoanalisi come barriere, argini, barricate nei confronti dell’eccedenza dell’inconscio.
 La sua tesi è chiara: “la psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, controllare, stare, attenti, allontanare... Ma certo questo è il suo limite: l’idea di un uomo che sempre deve difendersi, sin dalla nascita, e forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato”
La sua tesi è chiara: “la psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, controllare, stare, attenti, allontanare... Ma certo questo è il suo limite: l’idea di un uomo che sempre deve difendersi, sin dalla nascita, e forse anche prima, da un pericolo interno. Bardato, corazzato”Questa “apologia della difesa” dall’inconscio anziché rendere possibile l’incontro con l’inconscio come occasione, apertura, evento stesso dell’apertura, finisce per sbarrarne l’accesso, per richiudere anziché aprire l’inconscio. Vigilanza ossessiva, senso perenne del pericolo, rafforzamento delle barriere difensive. È la metafora, giudicata da Fachinelli “soffocante”, che Freud in Introduzione alla psicoanalisi offre dell’inconscio come “salotto” borghese separato dall’“anticamera”. Metafora “triste come la sua casa in Bergasse, con la finestra dello studio rivolta ad un muro di cemento”[1].
 La stessa tristezza che orienta il simbolismo psicoanalitico che finisce per ridurre in modo angusto la potenza e la bellezza del mare a simbolo della madre senza cogliere che, caso mai, come fa notare Ferenczi, opportunamente citato da Fachinelli, si dovrebbe dire il contrario, ovvero che è la madre a simboleggiare il mare. È la “miseria” che ispira la cosiddetta psicoanalisi applicata all’esperienza estetica che finisce per trasformare l’artista in un paziente e la sua opera nel suo sintomo, quando, invece, come giustamente ricorda Fachinelli, “la legna da ardere non spiega il perché del divampare del fuoco”.
La stessa tristezza che orienta il simbolismo psicoanalitico che finisce per ridurre in modo angusto la potenza e la bellezza del mare a simbolo della madre senza cogliere che, caso mai, come fa notare Ferenczi, opportunamente citato da Fachinelli, si dovrebbe dire il contrario, ovvero che è la madre a simboleggiare il mare. È la “miseria” che ispira la cosiddetta psicoanalisi applicata all’esperienza estetica che finisce per trasformare l’artista in un paziente e la sua opera nel suo sintomo, quando, invece, come giustamente ricorda Fachinelli, “la legna da ardere non spiega il perché del divampare del fuoco”.In gioco come si vede è per Fachinelli, come del resto per Lacan, lo statuto stesso del soggetto dell’inconscio. Come intendere l’inconscio senza ricondurlo paranoicamente a una minaccia? Come pensare l’eccedenza che ci abita? Come interpretare quella trascendenza che pur essendo interna al soggetto lo trascende? In diverse occasioni Fachinelli ha ricordato, a questo proposito, l’importanza della rilettura lacaniana del famoso detto di Freud Wo es war soll Ich werden (tradotto da Cesare Musatti in italiano: “Dove era l’Es deve subentrare l’Io”) che conclude la celebre lezione 31 della nuova serie di lezioni di Introduzione alla psicoanalisi.
 Quello che Fachinelli trova decisivo di questa lettura è l’accento nuovo che Lacan pone non tanto sull’Io come istanza deputata a bonificare l’Es, ma sull’Es come luogo di una apertura inedita, di una possibilità nuova e, al tempo stesso, antica, scritta da sempre, che chiama il soggetto alla sua ripresa, alla sua soggettivazione in avanti. In questo senso Fachinelli si spinge a pensare, con Lacan, l’inconscio al futuro, all’avvenire; non come mera ripetizione del già stato, ma come non ancora realizzato.
Quello che Fachinelli trova decisivo di questa lettura è l’accento nuovo che Lacan pone non tanto sull’Io come istanza deputata a bonificare l’Es, ma sull’Es come luogo di una apertura inedita, di una possibilità nuova e, al tempo stesso, antica, scritta da sempre, che chiama il soggetto alla sua ripresa, alla sua soggettivazione in avanti. In questo senso Fachinelli si spinge a pensare, con Lacan, l’inconscio al futuro, all’avvenire; non come mera ripetizione del già stato, ma come non ancora realizzato.
 Per questa ragione in La mente estatica può scrivere che il sogno non è solo la ripetizione di tracce mnestiche già scritte, ma il testimone di “ciò che vuoi essere” e di “ciò che puoi essere". Si tratta di cogliere “l’inaudita penetranza dell’inconscio”, la sua capacità di “creare il futuro”. In altri termini il sogno non è più il prodotto di una difesa dall’inconscio - di una attività di censura - ma una chiamata dove qualcosa - una trascendenza interna al soggetto, direbbe Lacan - si manifesta, “osa”.
Per questa ragione in La mente estatica può scrivere che il sogno non è solo la ripetizione di tracce mnestiche già scritte, ma il testimone di “ciò che vuoi essere” e di “ciò che puoi essere". Si tratta di cogliere “l’inaudita penetranza dell’inconscio”, la sua capacità di “creare il futuro”. In altri termini il sogno non è più il prodotto di una difesa dall’inconscio - di una attività di censura - ma una chiamata dove qualcosa - una trascendenza interna al soggetto, direbbe Lacan - si manifesta, “osa”.Un secondo grande tema della riflessione di Fachinelli, presentissimo anche in questa ultima raccolta di scritti politici, è quello del legame sociale, o, più precisamente, della possibilità di realizzare una comunità umana non alienata: è possibile emancipare le relazioni tra chi gestisce il potere e chi lo subisce essendone escluso? “È utopico pensare di costituire delle relazioni di eguaglianza tra non uguali?”, si chiede Fachinelli. La relazione di uguaglianza non può essere una relazione che appiattisce le differenze ma che le emancipa dall’incubo della “dipendenza". La relazione di uguaglianza non può mai essere tra uguali. Per questo Fachinelli ribadisce che essa può accadere solo se implica l’esistenza di non eguali. Non si dà, infatti, Comunità possibile se non sullo sfondo di una impossibilità condivisa: l’impossibilità della Comunione, di fare e di essere Uno con l’Altro, di scrivere il rapporto sessuale, direbbe Lacan.
È questo un tema decisivo in Fachinelli (la sola condizione in comune è l’impossibilità del comune), che troverà, in anni più recenti, in Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben e Roberto Esposito sviluppi considerevoli. Ma la particolarità psicoanalitica e non filosofica della riflessione di Fachinelli consiste nel mettere in connessione la problematica della Comunità con quella della femminilità.
 Anche con questa mossa egli mostra di conoscere bene la lezione che Lacan sviluppa a ridosso del 1968, in particolare nel Seminario XX (1972-73), sul rapporto tra sessuazione maschile e sessuazione femminile considerate come possibilità di declinare, in modi diversi, il legame sociale.
Anche con questa mossa egli mostra di conoscere bene la lezione che Lacan sviluppa a ridosso del 1968, in particolare nel Seminario XX (1972-73), sul rapporto tra sessuazione maschile e sessuazione femminile considerate come possibilità di declinare, in modi diversi, il legame sociale.
 Nel caso della sessuazione maschile o fallica il fondamento del legame è concepito a partire dall’eccezione che si sottrae alla regola e che garantisce attraverso la sua sovranità l’immedesimazione e l’eguaglianza dei suoi membri. Si tratta di un modello che trova il suo fondamento nel mito freudiano dell’orda come Freud afferma in Totem e tabù: è il padre totemico, quello che gode di tutte le donne, a garantire l’esistenza dell’eccezione sulla quale si fonda il patto tra i fratelli.
Nel caso della sessuazione maschile o fallica il fondamento del legame è concepito a partire dall’eccezione che si sottrae alla regola e che garantisce attraverso la sua sovranità l’immedesimazione e l’eguaglianza dei suoi membri. Si tratta di un modello che trova il suo fondamento nel mito freudiano dell’orda come Freud afferma in Totem e tabù: è il padre totemico, quello che gode di tutte le donne, a garantire l’esistenza dell’eccezione sulla quale si fonda il patto tra i fratelli.
 Diversamente, la sessuazione femminile non è garantita dall’esistenza di una eccezione esterna a fondamento dell’insieme, dell’eccezione che sfugge, come il padre dell’orda, alla Legge della castrazione. In questo caso non è più l’eccezione che fonda la regola ma è l’eccezione stessa che diventa la regola. L’insieme femminile non è fondato sull’identificazione verticale all’eccezione ma sulla sua distribuzione orizzontale. Se, come ripete Lacan, La donna all’universale non esiste è perché esistono le donne al singolare, una per una, come incarnazioni singolari e non seriali dell’eccezione: è perché l’eccezione non fonda la regola ma è la regola.
Diversamente, la sessuazione femminile non è garantita dall’esistenza di una eccezione esterna a fondamento dell’insieme, dell’eccezione che sfugge, come il padre dell’orda, alla Legge della castrazione. In questo caso non è più l’eccezione che fonda la regola ma è l’eccezione stessa che diventa la regola. L’insieme femminile non è fondato sull’identificazione verticale all’eccezione ma sulla sua distribuzione orizzontale. Se, come ripete Lacan, La donna all’universale non esiste è perché esistono le donne al singolare, una per una, come incarnazioni singolari e non seriali dell’eccezione: è perché l’eccezione non fonda la regola ma è la regola.
 In questo senso Fachinelli concepisce in una pagina fondamentale dell’articolo titolato Desiderio dissidente, apparso originariamente in Il bambino dalle uova d’oro e poi in Al cuore delle cose, riprendendo la classica distinzione lacaniana tra bisogno e desiderio ne propone una applicazione originale alla clinica dei gruppi umani.
In questo senso Fachinelli concepisce in una pagina fondamentale dell’articolo titolato Desiderio dissidente, apparso originariamente in Il bambino dalle uova d’oro e poi in Al cuore delle cose, riprendendo la classica distinzione lacaniana tra bisogno e desiderio ne propone una applicazione originale alla clinica dei gruppi umani.
 Il gruppo che preserva la sua generatività è quello che è capace di interpretare il desiderio non a partire dal suo Oggetto ma come una condizione, come uno “stato” che abbandona l’illusione che possa esistere un Oggetto del desiderio. Solo se il gruppo si sottrare a questa illusione riesce a non scadere in un “gruppo di bisogno” che intrattiene fatalmente rapporti di dipendenza con l’Oggetto che viene incarnato fatalmente dal leader. In questo modo il desiderio da impresa collettiva viene sequestrato in una cristallizzazione transferale all’Uno solo che priva i membri del gruppo di ogni facoltà critica rendendoli degli adepti[2].
Il gruppo che preserva la sua generatività è quello che è capace di interpretare il desiderio non a partire dal suo Oggetto ma come una condizione, come uno “stato” che abbandona l’illusione che possa esistere un Oggetto del desiderio. Solo se il gruppo si sottrare a questa illusione riesce a non scadere in un “gruppo di bisogno” che intrattiene fatalmente rapporti di dipendenza con l’Oggetto che viene incarnato fatalmente dal leader. In questo modo il desiderio da impresa collettiva viene sequestrato in una cristallizzazione transferale all’Uno solo che priva i membri del gruppo di ogni facoltà critica rendendoli degli adepti[2].
 Allora, conclude il suo ragionamento Fachinelli, “il gruppo di desiderio diviene un gruppo di bisogno”. Ma anche in questo caso, come si vede, il punto prospettico resta quello di una valorizzazione del femminile come antidoto alle tendenze settarie e totalitarie, dipendenti, del gruppo.
Allora, conclude il suo ragionamento Fachinelli, “il gruppo di desiderio diviene un gruppo di bisogno”. Ma anche in questo caso, come si vede, il punto prospettico resta quello di una valorizzazione del femminile come antidoto alle tendenze settarie e totalitarie, dipendenti, del gruppo.
 È questo il punto dove la sua concezione dell’inconscio, che ho inizialmente riassunto, si incrocia risolutamente con la problematica della sessuazione femminile. Fachinelli è davvero esplicito su questo punto. Da una parte riconduce il gruppo di bisogno, il gruppo morto a livello del desiderio, a una declinazione solo fallica della Comunità, ovvero a una concezione dell’inconscio come minaccia che dà luogo, come abbiamo visto, a una concezione paranoica della terapia come difesa, arginamento, antagonismo verso l’inconscio stesso.
È questo il punto dove la sua concezione dell’inconscio, che ho inizialmente riassunto, si incrocia risolutamente con la problematica della sessuazione femminile. Fachinelli è davvero esplicito su questo punto. Da una parte riconduce il gruppo di bisogno, il gruppo morto a livello del desiderio, a una declinazione solo fallica della Comunità, ovvero a una concezione dell’inconscio come minaccia che dà luogo, come abbiamo visto, a una concezione paranoica della terapia come difesa, arginamento, antagonismo verso l’inconscio stesso.Questa versione dell’inconscio risente di una priorità del “sistema vigilanza-difesa” ed ha, precisa Fachinelli, una chiara “impostazione virile" L’alternativa all’esclusione dell’inconscio sarà allora quella della sua ospitalità, della sua accoglienza. Si tratta di un movimento di apertura che riguarda innanzitutto gli psicoanalisti e la psicoanalisi: “Accogliere chi? Un ospite interno. Accoglierlo prima di esaminarlo ed eventualmente respingerlo. Intrepidezza, atteggiamento infinitamente più ricco e alla fine forse più efficace della prudenza di chi edifica muraglie". In sintesi estrema si tratta di accogliere l’inconscio come eccedenza, di dare “accoglienza del femminile”. Ci si deve incamminare, come suggeriva anche Lacan, in una direzione opposta a quella della compattezza identitaria che caratterizza la sessuazione maschile: “diminuzione della vigilanza, allentamento della difesa”. Sebbene, come precisa giustamente Fachinelli, questa nuova via non si configuri affatto come il rovesciamento simmetrico della prima. Piuttosto si tratta, ancora una volta, di mettere in movimento “un’altra logica”. Di nuovo risorge il problema della lingua, di un’altra lingua per la psicoanalisi. “Come scrivere tutto questo?”, si chiede Fachinelli. Come, dunque? Come dare figura all’eccedenza irraffigurabile del femminile? All’ospite che ci attraversa? “Vento sulla fronte, rombo del mare, luce, torpore, pensiero dell’accettazione, gioia con senso di gratitudine, verso chi?”.
***
[1] Anche la lettura che Fachinelli propone del noto episodio autobiografico raccontato da Freud relativamente a un disturbo della memoria accadutogli sull’Acropoli è assai significativa. La sua tesi è che questo disturbo denuncia l’avvertimento di una “gioia eccessiva eppure reale, che minaccia di sconvolgere un equilibrio, un’intera economia psichica - di qui un dubbio radicale di realtà, di tale violenza da funzionare come barriera”.
[2] L’opposizione che viene sviluppata ne La mente estatica tra religione e misticismo riflette l’opposizione tra gruppo del bisogno e gruppo del desiderio. Mentre il mistico non teme il rapporto con la “gioia eccessiva”, con l’assoluto tutto o l’assoluto nulla, il religioso si costituisce come argine nei confronti dell’Altro godimento aperto dal mistico: “il mistico eccede ogni religione - e perciò il religioso, nel suo fondo, rifiuta il mistico”.
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- FREUD, FACHINELLI, E RECALCATI. Una nota di Sarantis Thanopulos.23 aprile 2016, di Federico La Sala
- PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET. Due note
Verità nascoste.Essere giusti con Freud
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 23.04.2016)
Fabio [Elvio, fls] Fachinelli è stato una figura significativa della Società Psicoanalitica Italiana tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso. Pensatore elegante e originale, era poco incline all’ortodossia. La sua morte prematura privò la psicoanalisi del nostro paese di una voce «fuori dal coro». Massimo Recalcati, analista lacaniano, gli ha tributato recentemente un giusto riconoscimento. Nel farlo, ha sottolineato la sua presa di distanza dalla concezione freudiana dell’inconscio. La critica di Fachinelli a Freud, che Recalcati condivide e rilancia, seppure colga una prospettiva importante, lo fa a spese di una valutazione giusta del criticato. Questo non è privo di conseguenze: la critica che non coglie bene il suo bersaglio, non coglie bene neppure la propria prospettiva.
Dire che l’inconscio non è una minaccia, ma il luogo di un’apertura dell’essere che può trasformare il soggetto, è giusto. L’affermazione che secondo Freud l’uomo deve difendersi dal suo inconscio, arginarlo come pericolo interno, è infondata. Freud aveva una concezione omeostatica dell’apparato psichico: privilegiava la capacità della psiche di mantenere l’equilibrio del suo lavoro (la rappresentazione della realtà sul piano affettivo e ideativo) al variare delle condizioni esterne. Delle spinte pulsionali, alloggiate nell’inconscio, non aveva una percezione paranoica, considerava insidioso il loro conflitto con la realtà esterna. Nel suo modo di pensare l’essere umano è sano quando riesce a tener conto della realtà senza reprimere troppo le spinte vitali che vengono dal suo corpo.
Nella prospettiva freudiana l’Io, l’istanza dell’apparato psichico preposta all’autoconservazione, deve prevenire «un soddisfacimento pulsionale immediato e senza riguardi per nulla e nessuno» che rovinerebbe il rapporto con il mondo esterno, mettendo in discussione sia l’appagamento del desiderio sia quello del bisogno e quindi anche la sopravvivenza fisica del soggetto. Nello svolgere questa funzione l’Io non si comporta nei confronti delle pulsioni come se dovesse sbarrare l’accesso a un invasore. Nella metafora che Freud ha usato per rendere chiara la sua asserzione che “L’Io non è padrone in casa propria”, l’Io è il Re, la coscienza è il primo ministro e le forze pulsionali e i processi inconsci ad esse associate sono il popolo. L’Io è un monarca costituzionale che governa in nome e per il bene del suo popolo. Non ascolta solo il primo ministro.
Con la sua celebre asserzione «Dove era l’Es, l’Io deve avvenire», Freud non intendeva affatto dire che l’Io dovesse «bonificare» l’Es (l’inconscio pulsionale) come sostiene Recalcati, sulla scia di un accostamento tra Fachinelli e Lacan. L’Io era visto da Freud come prodotto di una differenziazione dell’Es che tiene conto delle condizioni oggettive dell’esistenza umana: deve crescere nel luogo dell’Es, come la casa si innalza sulle sue fondamenta. Tra l’Io e le forze pulsionali Freud non ha immaginato una divisione insormontabile, una barriera di difesa contro un nemico. Ha visto il loro rapporto in termini di continuità nella discontinuità, come processo di trasformazione perenne della materia umana. Questo processo è la matrice della nostra reale apertura al mondo, che alle sue radici è inconscia.
Il limite vero nel discorso di Freud deriva dal suo percepire l’apertura prevalentemente come rischio e dall’inclinazione conseguente a interpretare il piacere come ritorno dell’organismo a uno stato di equilibrio precedente. Ancorando, tuttavia, i processi trasformativi nel rapporto con la realtà, egli si allontanò da una concezione metafisica dell’inconscio.
- Sulla spiaggia. Di fronte al mare...
-
> "PERVERSIONI": UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO -- L’arte erotica (e inaspettata) della fedeltà. I legami non sempre sacrificano il desiderio (di M. Recalcati)3 aprile 2016, di Federico La Sala
- LA DECAPITAZIONE DI OLOFERNE E LA FINE DELLA CLAUSTROFILIA. UN OMAGGIO A ELVIO FACHINELLI. Una nota sull’importanza della sua ultima coraggiosa opera
- PSICOANALISI: LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET.
- CHI SIAMO NOI, IN REALTA’?! RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTA’: UN NUOVO PARADIGMA.
I tabù del mondoL’arte erotica (e inaspettata) della fedeltà
Il nostro tempo è cinico e pragmatico, crede alla libertà senza inibizioni, giudica l’aspirazione delle coppie al “per sempre” una farsa o una catena repressiva
Ma i legami non sempre sacrificano il desiderio: l’autentica forza dell’amore è trasformare la ripetizione in un’esperienza davvero unica e irripetibile
Quello che l’ideologia neo-libertina non vede è che ogni forma di disincanto tende, come spiegarono già Adorno e Horkheimer a ribaltarsi nel suo contrario
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 03.04.2016)
Il tempo ipermoderno sputa sulla fedeltà inneggiando una libertà fatta di vuoto. Tutto ciò che ostacola il dispiegarsi della volontà di godimento del soggetto appare come un residuo moralistico destinato ad essere spazzato via da un libertinismo vacuo sempre più incapace di attribuire senso alla rinuncia. Il principio si applica tanto ai legami con le cose quanto, soprattutto, a quelli con le persone.
Non è un caso che nel nostro paese la fedeltà sia stata recentemente considerata dai legislatori come una forma arcaica del legame amoroso al punto da volerla sopprimere negli articoli del Codice che normano le unioni civili e quelle matrimoniali. Perché evocare inutilmente un fantasma anacronistico reo di aver pesato come un macigno inutile sulla libertà affettiva e sessuale delle vite umane? Meglio liberarsene come di un tabù decrepito dalle armi desolatamente spuntate, come un ferro vecchio che non serve più a niente.
Oggi è il tempo del “poliamore”, della libertà senza inibizioni, della curiosità sperimentale, dell’esperienza senza vincoli, della morte dell’amore pateticamente romantico e dell’affermazione, al suo posto, dell’amore narcisistico che rende l’aspirazione degli amanti al “per sempre” una farsa o una ingenuità bigotta di qualche credulone, o, peggio ancora, una catena repressiva alla nostra libertà di amare che deve essere finalmente spezzata. Anche l’elevazione della fedeltà ad un rango superiore a quello della mera fedeltà (sessuale) dei corpi, teorizzata, non a caso, soprattutto dagli uomini, tradisce, in realtà, la stessa difficoltà a concepire un legame capace di durare nel tempo senza essere necessariamente mutilato nella spinta del desiderio.
Sembra un insegnamento fatale dell’esperienza: più una relazione dura nel tempo più il desiderio erotico si infiacchisce e necessita di nuovo carburante, o, meglio, di dopamina. Le neuroscienze lo confermano senza incertezza: il cervello per mantenere animato il desiderio deve essere dopato dall’eccitazione proveniente da un nuovo oggetto. L’anima, forse, si pensa, può restare fedele, ma non lo si può chiedere al corpo la cui spinta erotica non deve conoscere vincoli.
Il problema è che il nostro tempo non è più in grado di concepire la fedeltà come poesia ed ebbrezza, come forza che solleva, come incentivazione, potenziamento e non diminuzione del desiderio, come esperienza dell’eterno nel tempo, come ripetizione dello Stesso che rende tutto Nuovo. Il nostro tempo non sa né pensare, né vivere l’erotica del legame perché contrappone perversamente l’erotica al legame. È un assioma che deriva da una versione solo nichilistica della libertà: la libertà dell’amore - come la libertà in generale per l’uomo occidentale - deve escludere ogni forma di limite, deve porsi come assoluta. In questo senso la fedeltà diviene un tabù logoro che appartiene ad un’altra epoca e destinato ad essere sfatato.
Quello che l’ideologia neo-libertina del nostro tempo però non vede è che ogni forma di disincanto tende, come spiegarono già Adorno e Horkheimer in Dialettica dell’illuminismo, a ribaltarsi nel suo contrario. Il culto del poliamore, della libertà narcisistica, la polverizzazione dell’ideale romantico dell’amore porta davvero verso una vita più ricca, più soddisfatta, più generativa?
La clinica psicoanalitica ci consiglia di essere prudenti: la ricerca affannosa del Nuovo spesso non è altro che la ripetizione monotona della stessa insoddisfazione. Il punto è che il nostro tempo rischia di smarrire ogni possibile sguardo sulla trascendenza, sull’altrove, anche di quella che si dà nell’esperienza assolutamente immanente dei corpi. Perché non esiste amore se non del corpo, del volto, della particolarità insostituibile dell’Altro.
L’ideale della fedeltà può diventare - come lo è stato per diverse generazioni - una camicia di forza che sacrifica il desiderio sull’altare dell’Ideale divenendo dannosa per la vita. Quando questo accade è bene liberarsene al più presto.
Ma l’esperienza della fedeltà, vissuta non in opposizione alla libertà, ma come la sua massima realizzazione, offre alla vita una possibilità di gioia e di apertura rare. Quella che scaturisce dall’esperienza di rendere sempre Nuovo lo Stesso: la ripetizione della fedeltà rivela infatti che giorno dopo giorno il volto di chi amo può essere, insieme, sempre lo Stesso e sempre Nuovo.
Mentre il nostro tempo oppone lo Stesso al Nuovo, il miracolo dell’amore è, infatti, quando c’è, quello di rendere lo Stesso sempre Nuovo. Accade anche nella lettura dei cosiddetti classici. Lo diceva bene Italo Calvino: quando un libro diventa un classico se non quando risulta inesauribile di fronte ad ogni lettura? Quando la sua forza non si esaurisce mai, ma dura per sempre eccedendo ogni possibile interpretazione? E non è, forse, la fedeltà (ad un amore, ad un autore, ad un’idea) un nome di questa forza? Non è la fedeltà ciò che ci spinge a rileggere lo stesso libro - o un corpo che si trasforma in libro - scoprendo in esso sempre qualcosa di Nuovo? Non è il suo miracolo quello di fare Nuovo ogni cosa, soprattutto quella “cosa” che crediamo di conoscere di più? Non è questa la sua potenza: trasformare la ripetizione dello Stesso in un evento ogni volta unico e irripetibile?
-
> PERVERSIONI. --- Uccidere in nome della Legge di Dio. Impugnando insieme il mitra e il Corano... (di Massimo Recalcati).24 novembre 2015, di Federico La Sala
Uccidere in nome della Legge di Dio
di Massimo Recalcati (Psychiatry-on-line, 24 novembre, 2015)
Impugnando insieme il mitra e il Corano, i terroristi dell’Isis uccidono vite innocenti in nome della Legge di Dio: possono sparare freddamente, a bruciapelo, contro giovani sconosciuti senza provare la minima emozione, senza avere alcun dubbio sulla necessità della loro crudeltà.
Se il loro braccio è armato direttamente da Dio, la loro forza scaturisce dal sentirsi espressioni della volontà di un Essere supremo che li libera da ogni senso di colpa e dalla paura umana della morte.
Il loro Dio, infatti, li ricompenserà con una vita ultraterrena fatta di godimenti senza limiti: abbeverarsi di sostanze estasianti, possedere innumerevoli vergini, bearsi in un mondo dove tutto è permesso li solleverà da una vita terrena fatta di stenti e disperazione. Il loro martirio è richiesto da una Legge che non è quella degli uomini, ma quella di un Essere supremo che saprà riconoscere e premiare giustamente la loro fedeltà assoluta. La loro vera vita non è questa, ma è in un altro mondo.
L’esistenza dell’Occidente impuro gli consente di identificarsi al giustiziere senza macchia che serve la Legge di un Dio folle. Tuttavia, il paradiso a cui anelano coincide paradossalmente con quella rappresentazione della vita dei giovani occidentali che odiano ma dalla quale, in realtà, si sentono esclusi. Il meccanismo che presiede la loro volontà omicida è drammaticamente elementare. Si chiama “proiezione”: essendosi identificati coi rendentori dell’umanità, con gli unici e autentici cavalieri della fede, con la purezza intransigente del martire, proiettano i loro desideri più impuri nell’Occidente corrotto che s’incaricano di distruggere per emendare quella parte scabrosa di se stessi che non riescono a riconoscere come tale. In questo senso sono davvero anime morte che uccidono le esistenze di cui invidiano la vita e la libertà.
Jacques Lacan ha fatto notare che quando l’uomo calpesta la Legge della parola per rispondere ad una Legge che è totalmente al di là degli uomini, che trascende ogni limite che questa Legge impone, esso si incammina lungo il sentiero tetro della perversione. Ogni volta che qualcuno diviene giustiziere, ogni volta che uccide in nome di una Causa che trascende la vita particolare dell’uomo, egli diventa un “crociato”, un militante della Fede che disprezzando la Legge (imperfetta) degli uomini vuole affermare quella (perfetta) del suo Idolo. In questo senso profondo la psicologia del terrorista dell’Isis è perversa. Essa agisce in nome di una Causa, di un Essere supremo che odia gli infedeli ordinando la loro epurazione fisica.
La depravazione dell’Occidente li rinsalda nei loro ideali ascetici che non sono solo uno stile di vita tra gli altri, ma che vorrebbe essere imposto come il solo stile di vita possibile. I loro cuori bruciano di spirito di vendetta: farsi esplodere o uccidere è un modo per avvicinarsi a Dio, per accedere ad un paradiso di carne che li beatificherà eternamente. L’ingenuità di questa costruzione può rapire la vita dei più giovani che, come ricorda Gesù nella parabola della donna adultera, sono gli ultimi a lasciare la piazza, a lasciare cadere dalla loro mani le pietre del giudizio...
I terroristi coltivano perversamente l’orrore per suscitare l’angoscia nel loro nemico. Nessuna forma di terrorismo sino ad oggi è stata così meticolosa nel coltivare mediaticamente questa strategia.
Mostrare in diretta lo sgozzamento dei prigionieri, trascinare nella polvere i loro cadaveri sghignazzando, ammonire severamente l’Occidente che la sua libertà pacifica, conquistata nei secoli, ha i giorni contati, mostrare, insomma, l’orrore senza veli serve a provocare l’angoscia nell’Altro.
E’ il loro ricatto perverso: non si tratta di semplicemente di impaurire l’Occidente, né di colpire bersagli determinati come accadeva per il terrorismo che abbiamo già conosciuto (l’ebreo, il capitalista, il comunista, ecc), ma di corrodere dall’interno la sua stessa vita, di rendere la nostra vita in generale meno sicura, meno certa, esposta al rischio della morte casuale dell’atto terrorista che, come sappiamo, non potrà mai in nessun modo essere totalmente prevenuto.
Essendo dappertutto, non-circoscritto, il pericolo non genera più una paura localizzata all’oggetto considerato minaccioso (l’obbiettivo cosiddetto sensibile), ma si diffonde ovunque, attraversa le nostre vite diventando puro panico collettivo. Inoculare l’angoscia trasformandola in panico è, dunque, l’obbiettivo massimo della strategia terrorista.
Essi vogliono vedere negli occhi dell’Occidente lo smarrimento e il terrore rendendo la nostra vita prigioniera. Per questa ragione la prima risposta che, come insegna la psicoanalisi, è sempre necessario dare alla perversione è quella di respingere l’angoscia, di sottrarsi alla sua ipnosi maligna, di rifiutarsi di cedere sulla nostra libertà.
-
> PERVERSIONI. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- JASPERS. Sulla zattera della gelosia inevitabile è il naufragio (di Diego Fusaro)21 novembre 2015, di Federico La Sala
KARL JASPERS
Sulla zattera della gelosia inevitabile è il naufragio
Uno studio finora inedito in Italia del filosofo e psichiatra: la sindrome di Otello tra indagine culturale ed esame clinico
di Diego Fusaro (La Stampa - TuttoLibri 21.11.015)
- [Delirio di gelosia di Karl Jaspers Raffaello Cortina, a cura di S. Achella, pagg. 154, euro 12]
Si è soliti pensare che la gelosia rimandi naturalmente all’amore, di cui sarebbe, per così dire, un eccesso che si traduce in patologia del possesso. Forse, però, a ben vedere, il delirio della gelosia andrebbe posto in relazione con l’egoismo più che con l’autentica passione amorosa. È quanto, nelle sue massime, ci suggerisce La Rochefoucauld: «nella gelosia c’è più egoismo che amore». Si pensi anche solo alle memorabili pagine della Recherche di Proust dedicate ad Albertine, che altro non sono se non una variazione sul tema del solipsismo amoroso, accompagnata da considerazioni sul tema della gelosia.
A suffragare questo aspetto, in fondo, è il fatto stesso che il lemma «gelosia» (zhlos) rinvii al desiderio bramoso di preservare e custodire ciò che appartiene al singolo io, per ciò stesso sorgendo da un istinto tutt’altro che legato all’altruismo amoroso del donarsi all’amata. Sarà, forse, per questa ragione che nel nostro tempo dell’«amore liquido» e della precarietà affettiva, in cui la stabilità della passione amorosa è sostituita dalla fugacità del godimento autistico dell’io isolato, la gelosia si conserva, coerente con la cifra dell’epoca dell’egoismo rapace e dell’individualismo possessivo. Si rivela prossima al narcisismo più che al sentimento, all’egoismo calcolatorio che all’altruismo donativo.
Non che nel mondo premoderno la gelosia fosse sconosciuta. Tutt’altro. Le tragedie greche ce ne restituiscono un affresco grandioso. È, tuttavia, con il teatro della modernità che essa diventa passione dominante, a partire da quello che resta, in fondo, il più noto volto di questa patologia nell’evo moderno: l’Otello di Shakespeare, tragicamente in preda a quel «mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre».
L’individualismo radicale e lo spazio dell’interiorità disegnano tanto l’orizzonte di senso del moderno, quanto, a maggior ragione, della gelosia: la quale induce il soggetto ad agire non sulla base di elementi concreti e di effettivi tradimenti, bensì a causa di paure e di fantasmi che si agitano negli antri della sua interiorità, facendolo da ultimo prigioniero di se stesso.
Già l’Etica di Spinoza distingue tra effetti passivi, nei quali l’uomo è in balia degli eventi, ed effetti attivi, dei quali invece è artefice. La gelosia, proprio come l’ambizione, è una passione triste, che espropria l’uomo della facoltà del controllo di sé e lo rende vittima dei propri fantasmi. E ne dirotta l’intelligenza verso obiettivi di per sé inconsistenti, facendo della gelosia - come notava Nietzsche - la passione più intelligente e, insieme, la massima sciocchezza.
Intrecciando virtuosamente le proprie competenze culturali e filosofiche con quelle mediche, nel Novecento anche Karl Jaspers si soffermò su questa passione triste: e lo fece dedicandovi, nel 1910, uno studio che ora viene per la prima volta tradotto e pubblicato in lingua italiana, Delirio di gelosia. Un contributo alla questione: «sviluppo di una personalità» o «processo»?
L’opera di Jaspers è dedicata a un’esplorazione del «delirio di gelosia», studiato tramite l’esame - frutto di lunghe e minuziose analisi - dei vissuti di alcuni pazienti da esso affetti.
A cavaliere tra indagine culturale ed esame clinico, il lavoro di Jaspers si addentra nella vita dei pazienti, uomini e donne deliranti, in balia della passione triste della gelosia, nel tentativo di comprenderne le radici e le conseguenze.
La domanda che guida e orienta l’analisi di Jaspers potrebbe così essere formulata: fino a che punto il soggetto in preda al delirio di gelosia è ancora in grado di agire come soggetto libero e responsabile e quando, invece, diventa mera espressione di un corpo malato, vittima degli spettri che ne ottundono la mente e ne offuscano la ragione? La sindrome di Otello, come anche potremmo qualificarla, comporta il precipitare del paziente in uno stato di totale passività o resta, nel suo agire, un barlume di libertà?
Che cosa accomuna il caso dell’orologiaio Julius Klug all’insegnante Max Mohr e agli altri casi esplorati nel testo di Jaspers, tutti vittime del delirio di gelosia? Paure di avvelenamenti, soggettività eccentriche e personalità ipomaniacali, rapidità del costituirsi del «sistema delirante», molteplicità dei sintomi e delle cause: sono questi i principali elementi in comune rinvenuti da Jaspers nel suo studio; dal quale traspare nitidamente un’attenzione focalizzata soprattutto sul prodursi della rottura e della discontinuità nell’esperienza esistenziale dei soggetti che, in una sorta di analogon psicopatologico della «situazione limite», improvvisamente precipitano nel delirio di gelosia. Che è, poi, la prova, dal punto di vista clinico, che la gelosia nasce da un amore esasperato del proprio io che porta alla perdita dell’altro e, alla fine, anche di se stessi.
-
> PERVERSIONI. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- Delirio di gelosia. Un testo di Karl Jaspers (di Francesca Bolino).15 novembre 2015, di Federico La Sala
Karl Jaspers
Quando la gelosia diventa delirio
di Francesca Bolino (la Repubblica, 15.11.2015)
- Delirio di gelosia di Karl Jaspers Raffaello Cortina, a cura di S. Achella, pagg. 154, euro 12
Se nell’antichità la gelosia era uno slancio appassionato verso qualcosa o qualcuno che si teme di perdere, con l’avvento della modernità qualcosa peggiora. Si trasforma in male di vivere, in impossibilità di dominare se stessi e gli altri. In breve: in delirio. Con il Novecento, il delirio diventa annichilimento di ogni dialettica possibile tra pensiero ed essere. Proprio in questo quadro si inserisce il lavoro di Karl Jaspers.
In questo prezioso testo per la prima volta tradotto in italiano, attraverso la descrizione della vita di pazienti, il filosofo tedesco mette in luce come il delirio diventi metafora delle contraddizioni inscritte nell’uomo. L’essere geloso mette in gioco l’integrità della soggettività.
L’esperienza delirante distorce il giudizio di realtà e la capacità di agire e reagire. E dunque viene meno la possibilità di condividere il mondo con gli altri. Così il mondo diventa abnorme. Nel delirio, afferma Jasper «urtiamo contro ciò che è irrimediabilmente perduto nella non verità».
-
>Sessualità, etica, psicoanalisi --- Del matrimonio considerato come un’arte. L’elogio del matrimonio di Julia Kristeva e Philippe Sollers.5 ottobre 2015, di Federico La Sala
Kristeva-Sollers, elogio del matrimoniodi Daniele Zappalà (Avvenire, 4 ottobre 2015)
Parigi. Quando discettano assieme in un’aula universitaria, si può pensare che allettare questi due con le gioie semplici della vita sarebbe impresa vana anche per i più geniali oratori. Perché i coniugi Joyaux, che nel 1966 si conobbero e amarono subito sulle sponde della Senna, avvolgono da allora il focolare in reti chilometriche di conversazioni zeppe di coltissime citazioni e frasi ben annodate, comprese quelle di ogni nuovo libro in uscita dell’una o dell’altro, trattandosi di una linguista-semiologa-psicanalista scrittrice e di un romanziere sperimentale famosi in Francia e non solo.
Ma qual è il segreto degli smaglianti ’Gioielli’, la cui passione perdura fra i campi di rovine sentimentali del milieu d’appartenenza? Di certo, non solo il cognome allo stato civile, come Julia Kristeva e Philippe Sollers fanno capire aprendo lo scrigno familiare nel volumetto Del matrimonio considerato come un’arte, in uscita adesso in Italia per Donzelli (pagine 144, euro 19). La ’fisiologia del matrimonio’ cara a Balzac è tema letterario in voga da secoli a Parigi, con frequente predilezione per la satira dei ’costumi borghesi’.
Nel preambolo, la Kristeva spiega invece che con il marito ha provato a «raccontare una passione, con precisione, senza vergogna e senza viltà, senza modificare ciò che essa è stata né abbellire il presente, e scongiurando il rischio spettacolare delle ossessioni sentimentali, dei fantasmi erotici dei quali si va compiacendo l’autofinzione del selfie».
Con queste premesse, va detto che il libro raccoglie quattro interventi piuttosto eterogenei (una vecchia intervista al Nouvel Observateur, una dichiarazione amorosa della Kristeva e due duetti discorsivi pronunciati in pubblico) su un arco di vent’anni. E lungo il ’racconto’, il lettore brancola un tantino, soprattutto quando la brillantissima studiosa ragiona sugli schemi psicanalitici fondamentali di matrice freudiana dietro la coniugalità. Ma si tratta di figure complesse. Fino al gusto sottile dell’autocontraddizione, nel caso di Philippe, che indossa spesso in pubblico la maschera dello scrittore dandy vagamente kierkegaardiano, nel cui cuore il Don Giovanni giovanile sopravvive orgogliosamente all’arrivo della passione civile e poi di quella religiosa, coltivata in particolare attraverso un’ammirazione di recente molto esibita per la liturgia cattolica e il Magistero romano.
Philippe, ovvero il ’miglior paziente’ di Julia, certo. E nel volume, lei ironizza sul camaleontismo del marito, maestro di sperimentazioni e pastiche tanto nei sofisticati romanzi indirizzati a un pubblico di aficionados, quanto nella vita. Un ’polimorfo’, spiega la psicanalista, a sua volta campionessa d’eclettismo dal curriculum impressionante, soprannominata in famiglia ’Honoris causa’, come ricorda Sollers, evocando i continui viaggi della moglie per ricevere titoli e premi ai quattro angoli del globo.
L’intervista al settimanale preferito della cosiddetta ’gauche al caviale’, concessa in quel 1996 ancora un po’ nell’onda della ruggente Parigi mitterrandiana, esibisce due celebrità forse troppo intellettuali. Brillante è certo l’analisi della Kristeva sulle nevrosi conclamate di coppie adulate come Sartre-Beauvoir. Ma a volte si sconfina troppo nella teoria. Cos’è in sostanza un matrimonio? «Un modello di armonie dissonanti », conclude la studiosa con l’ennesimo paradosso.
Nel secondo scambio pronunciato davanti a uno squisito parterre accademico (siamo già nel 2011), in una Francia culturalmente disorientata che in 15 anni ha visto tante vecchie certezze e altezzosità sciogliersi come cera, pure la coppia gaudente pare visibilmente cambiata.
Così, fra una discettazione di Julia e una battuta di Philippe, affiora pure l’evocazione di due traumi privati occorsi proprio sul bastimento ’Gioielli’: un aborto clandestino ’dolorosamente subito’, ricorda Julia, prima di evocare in chiusura David, il figlio affetto da handicap che ha rischiato di non farcela. Riappare così il ricordo di una donna disperata per un piccolo, come già milioni di altre su questo vecchio mondo. Stesa su un materassino in una camera d’ospedale, implorando chissà cosa ai piedi di un letto. Su questo intimo versante, è nato il bisogno delle lettere scambiate con «Jean Vanier, cattolico, fondatore dell’Arca, che ha creato case di accoglienza per persone handicappate in centoquaranta paesi in tutto il mondo».
Nel volumetto giunge così uno spartiacque. Perché gli ultimi due testi, pur brevi, sono di un’umanità sorprendente. Sul filo dei ricordi, dal ’patto a due’ Kristeva-Sollers firmato in municipio nel 1967 cominciano a sprizzare scintille calde. Luccicano pepite. Julia se la prende con la «banalizzazione degli spiriti che ci minaccia e che è ai miei occhi il male radicale». E della sua coppia, evoca pure la comune eredità ricevuta da genitori cristiani, ortodossi bulgari nel suo caso, cattolici per Philippe.
Lasciti di famiglia e di studi in scuole religiose nel corso d’infanzie a loro modo trasognanti e che forse non hanno mai smesso di suggerire una strada. Molto è stato poi riposto a lungo in un cassetto, ma nel velluto. Pronto ad offrire vivide emozioni sul filo dei ricordi: «L’adolescente Sollers è un credente ribelle, non smette mai di reinventare il proprio paradiso. Adamo ed Eva erano degli adolescenti. Dante e Beatrice anche, tutti noi siamo degli adolescenti quando siamo innamorati». Julia descrive qui il marito al Collegio dei Bernardini, il centro culturale parigino voluto dal compianto cardinale Jean-Marie Lustiger.
Si termina parlando d’amore, più che di tecniche e transfert erotici. E la brillantissima Julia, emigrata quasi clandestinamente a 25 anni dalla Bulgaria comunista per trovare a Parigi provvidenzialmente le braccia del suo Philippe, esalta allora «il Cantico dei cantici, il testo amoroso da me preferito, che fonda - per la prima volta al mondo, credo - la possibilità di un legame amoroso tra un uomo e una donna: poesia pura, intrecciata con una filosofia dell’impossibile e tuttavia gioiosa».
È un capolavoro misteriosamente sempreverde anche per l’incallito sperimentatore Philippe: «Il Cantico dei cantici dice che l’amore è forte come la morte. Questa cosa m’impressiona molto: se amo, potrò forse essere forte come la morte, o vincere la morte?». Sulla sedicente bocca dongiovannesca, risuonano allora note di tenerezza coniugale: «Continuiamo a essere bambini insieme, a parlarci come due bambini». Mentre Julia spiega alla fine, da psicanalista, con parole comprensibili a tutti, che «dal momento che credo di essere amata - nel senso di una certezza incrollabile -, che il mio papà mi ami, per esempio, che la mia mamma mi ami, allora, la gelosia non ha il potere d’intossicarmi». Alla fine, consola che pure negli alti appartamenti parigini del Quartiere latino con vista sul Senato, il dantesco trasumanar provochi ancora qualche sospiro.
-
> AL DI LA’ DELL’EDIPO ----- COSA VOGLIONO LE DONNE? What Do Women Want? “Il desiderio femminile è come quello dei maschi”18 luglio 2013
Sessant’anni fa Sigmund Freud scriveva all’amico e biografo Ernest Jones: «La vera domanda alla quale nessuno ha risposto, e alla quale io stesso non so dare una risposta nonostante i miei trent’anni di ricerca nell’animo femminile è: cosa vogliono le donne?»
Daniel Bergner ha raccolto in “What Do Women Want?” gli ultimi studi sul piacere senza tabù e vecchi cliché. Scatenando le polemiche
Il sesso delle donne
“Il desiderio femminile è come quello dei maschi”
di Elena Stancanelli (la Repubblica, 18.07.2013)
- IL SAGGIO: What Do Women Want? di Daniel Bergner (Ecco Pr, pagg. 205 euro 15,80) sarà tradotto in Italia da Einaudi Stile libero
Contrordine: non solo il desiderio femminile esiste, ma è potente almeno quanto quello maschile, non ha una propensione monogamica e, pensa un po’, non è neanche legato all’istinto riproduttivo. Non somiglia per niente a un languore romantico, non necessita di una storia intorno. Esattamente come sapevamo che accade agli uomini e agli altri animali, le donne desiderano punto e basta. Cosa? Sesso. Sono mesi che si gira intorno alla faccenda, le classifiche dei libri sono piene di romanzetti rosa virati hard, che esplorano voglie e vogliette, vizi e vizietti. Persino l’ultimo film di Lars Von Trier, Nymphomaniac (di cui cominciano a girare adesso alcuni spezzoni) ha per protagonista una donna che si concede del tutto al proprio desiderio sessuale, testandone i confini e le implicazioni. Protagonista Charlotte Gainsbourg, a dimostrazione che, forse anche più che per gli uomini, le donne considerano ormai il sesso esplicito un territorio non più proibito, quasi mainstream.
Sessant’anni fa Sigmund Freud scriveva all’amico e biografo Ernest Jones: «La vera domanda alla quale nessuno ha risposto, e alla quale io stesso non so dare una risposta nonostante i miei trent’anni di ricerca nell’animo femminile è: cosa vogliono le donne?». Sessant’anni dopo Daniel Bergner - giornalista delNew York Times, già autore di un saggio sulle parafilie, Il lato oscuro del desiderio- risponde con un libro intitolato appunto What Do Women Want?, che uscirà in Italia, tra qualche mese, per Einaudi Stile libero (come il precedente). E contiene interviste a donne normali, ricerche sugli animali, teorie di psichiatri, scienziate, terapiste sessuali. Gli studi sul desiderio femminile sono in ritardo. Quando sono nate le scienze legate alla sessualità, si è dato per scontato che ci si dovesse occupare di disfunzioni/preoccupazioni/meraviglie dell’organo e dell’orgasmo maschile. Anche soltanto perché entrambi garantiscono la conservazione della specie. E quando Galeno sostenne, nel II secolo d. C., che senza il piacere femminile, mediante il quale immaginava che fosse rilasciato l’uovo da fecondare, non era data appunto fecondazione, fece assai peggio alle donne di quanto una teoria del genere farebbe presupporre.
Secondo Bergner infatti, l’idea imposta dal medico greco che i genitali femminili fossero uguali a quelli maschili ma nascosti e un po’ meno funzionali, ha condizionato la nostra visione del piacere. Questa genitalità femminile oscura e goffa, ha imposto per secoli l’idea che l’orgasmo delle donne, e quindi il desiderio, fossero una robetta insignificante, e soprattutto racchiusa in un istante e in un unico e impervio luogo: la vagina, appunto. Il primo passo per rivalutare instensità e potenza del piacere femminile è stato quindi allargare la zona preposta a un altro paio di robette là intorno, che, ben allertate, garantiscono un gran sollazzo. Tra queste il celeberrimo punto G, scoperto nel 1600 da un medico olandese, ma descritto per la prima volta nel 1950 da Ernst Grafenberg, ginecologo tedesco.
Il primo capitolo del libro di Bergner, uno dei motivi per cui all’uscita negli Stati Uniti e poi in Inghilterra si è scatenato un putiferio, si intitola “animali”. E non soltanto perché le protagoniste degli esperimenti di Meredith Chivers, dell’Università di Ontario, sono le scimmie. Chivers ha studiato a lungo, e raccontato in un documentario, una particolare razza di scimmie chiamate Bonobo, note al mondo per due motivi: la mitezza e la libertà dei costumi sessuali. Le Bonobo fanno sesso continuamente, e quindi soltanto in rari casi per riprodursi, in tutte le combinazioni possibili: maschi, femmine, adulti, anziani, giovani... Ma gli animali che danno il titolo al capitolo non sono le scimmie, bensì le femmine della nostra specie. Selezionate alcune volontarie (etero e omosessuali) la professoressa le prepara applicando nella loro vagina un apparecchietto, “plethysmographry”, che registri turbamenti e movimenti. Poi mostra loro una serie di video pornografici, etero, lesbo e gay - e tra questi anche il documentario che illustra gli allegri accoppiamenti delle scimmie Bonobo. Quindi chiede, alle donne non alle Bonobo, di raccontare che cosa hanno sentito durante la visione, se abbiamo provato eccitazione e per cosa.
Collazionando i risultati ottenuti dalla macchinetta con quanto dichiarato, Meredith Chivers ha scoperto che le donne mentono, mentono moltissimo. Che il loro livello di eccitazione è molto più alto di quello che riescono ad ammettere. Cosa che non accade quando ripete lo stesso esperimento coi maschi. Ne deduce che negli uomini il cervello e i genitali stanno dalla stessa parte, sono alleati, nelle donne spesso no. Cioè le donne si vergognano di quello che provano, o peggio neanche se ne accorgono, talmente sono vincolate a quello che pensano dovrebbero provare. Quindi: il desiderio femminile esiste, è potente animale e vivissimo, ma società e cultura lo osteggiano con forza. Le nostre strutture politiche e di convivenza sono fondate su quel minimo di ordine garantito dalla famiglia, la quale, da un certo punto in poi, ha avuto bisogno di trasformarsi da vincolo utilitario a consesso basato sull’amore.
È lì che, spiega Bergner, ci siamo dovuti inventare un paio di bugie cruciali: che le donne desiderano tutta la vita lo stesso maschio (nonostante la natura gridi il contrario) e che l’unico momento in cui desiderano accoppiarsi è durante il periodo fertile. Qualche anno fa, racconta ancora Bergner, la dottoressa Marta Meana dell’Università del Nevada pubblicò un lungo articolo a proposito delle “fantasie di stupro” o di sottomissione, o di sospensione della volontà. È difficile, spiega la dottoressa, trovare un’espressione che tenga conto del risultato dei miei colloqui, senza offendere nessuno. Alcune donne, spiega, ritennero allora insopportabile l’immagine che lei aveva proposto come esercizio: una donna di spalle, in un vicolo scuro, un uomo che la prende da dietro, uno sconosciuto.
Eppure intorno a quella scena si agita, spesso, il desiderio femminile. Altro che monogamia, altro che riproduzione: sottomissione, cinquanta sfumature di qualsiasi cosa. Un po’ di rischio, la possibilità di non dover scegliere e tanto, tanto testosterone. Di questo si compone il nostro desiderio, il desiderio di uomini e donne. Purtroppo, quando la biochimica si inceppa, la faccenda delle donne si fa più complicata. Un Viagra femminile lo stanno ancora sperimentando. Ma già possiamo dire che in ogni caso si tratterà di un bel frullato di testosterone, dopamina, serotonina... cose così. Non un documentario sul Principe Azzurro.
-
> PERVERSIONI --- LA POTENZA DEL DESIDERIO E IL DESIDERIO DI ONNIPOTENZA. GIAMBATTISTA VICO E LA TEOLOGIA DELL’UMANITA’ "TUTTA DISPIEGATA".17 marzo 2013, di Federico La SalaLA POTENZA DEL DESIDERIO E IL PROBLEMA DI DIO. UNA IMPOSTAZIONE ALL’ALTEZZA DI NEWTON E KANT, CHE SI SPINGE IN UN’ORIZZONTE CHE VA OLTRE FREUD E LACAN ...
 GIAMBATTISTA VICO: LA LIBERTA’, LA PROVVIDENZA, E LA TEOLOGIA DELL’UMANITA’ "TUTTA DISPIEGATA". Un breve saggio - di Federico La Sala
GIAMBATTISTA VICO: LA LIBERTA’, LA PROVVIDENZA, E LA TEOLOGIA DELL’UMANITA’ "TUTTA DISPIEGATA". Un breve saggio - di Federico La Sala
 il “Dio” di Vico (...) è il (...) Dio evangelico, il Dio “Chàritas” (il dio della “Grazia”- “Chàris”, e delle “Grazie”, “Chàrites”)! E questo è, per Vico, anche il nome del “Dio provvedente” di tutte le nazioni (...)
il “Dio” di Vico (...) è il (...) Dio evangelico, il Dio “Chàritas” (il dio della “Grazia”- “Chàris”, e delle “Grazie”, “Chàrites”)! E questo è, per Vico, anche il nome del “Dio provvedente” di tutte le nazioni (...)
-
>Perché l’arte deve rimanere senza dio... Fintanto che tutte le devianze restano contenute nel vaso di Pandora dell’arte, la società e la Chiesa sono relativamente protette da queste. Non è prudente scoperchiarlo (di Mario Perniola).1 febbraio 2013, di Federico La Sala
Dopo l’articolo di “Repubblica” su sacro e contemporaneo
Perché l’arte deve rimanere senza dio
di Mario Perniola (la Repubblica, 01.02.2013)
Da qualche tempo la Chiesa cattolica mostra un nuovo e lodevole interesse nei confronti dell’arte contemporanea, nella speranza di ripristinare quel rapporto di collaborazione con gli artisti che portò nel Medioevo e nel Barocco ad esiti eccelsi. Una preoccupazione sottolineata su questo giornale con l’articolo Dio senza arte (20 gennaio) in cui Maurizio Ferraris poneva la questione in questi termini: se scompare l’arte sacra, che fine fa il canone occidentale basato in gran parte su di essa? Che l’argomento sia attuale è dimostrato anche da interventi apparsi subito dopo su Avvenire in cui si ribadiva l’intenzione della Chiesa di aprirsi all’arte contemporanea.
Tuttavia questa buona intenzione trova ostacoli, genera fraintendimenti e crea equivoci. Da un lato si ha l’impressione che l’atteggiamento degli artisti nei confronti della Chiesa sia meramente opportunistico e dettato soltanto dalla supposizione di trovare un committente meno rapace del mercato e più affidabile delle amministrazioni pubbliche; dall’altro ci si chiede se non sia più vantaggioso dal punto di vista della visibilità mediatica e dell’attendibilità nel campo artistico internazionale stare dalla parte della trasgressione, della blasfemia e dell’irriverenza che non dalla parte della fede, del rispetto e della deferenza nei confronti della religione.
La ragione fondamentale di questo malinteso sta nel fatto che lo statuto dell’arte dal Romanticismo in poi è radicalmente cambiato rispetto al passato. L’artista non è più l’artigiano del Medioevo, né il portatore di un sapere professionale, ma l’adepto di una nuova religione, che ha i suoi canoni, la sua gerarchia, le sue reliquie, i suoi martiri, i suoi santi, le sue istituzioni e così via.
Perciò sembra opportuno che la Chiesa prenda atto che il mondo dell’arte è una religione per definizione autonoma con la quale si deve misurare alla pari. Ciò mi sembra impossibile senza l’esistenza di autorevoli mediatori laici, che appartengano a pieno titolo a un mondo che sta agli antipodi della mentalità clericale. In fondo l’idea che l’arte stia dalla parte del male si basa ancora sul presupposto che esista una differenza tra il bene e il male.
L’atteggiamento ostile all’arte visuale non è quindi nichilistico: già Platone sosteneva che l’arte era lontana di due gradi dal vero e in molte culture (come quella ebraica e quella islamica) esiste una profonda diffidenza nei confronti delle immagini. Al polo opposto il cristianesimo ortodosso considera l’icona non come una semplice rappresentazione della divinità, ma come il punto di unione tra il mondo visibile e quello invisibile.
Bisogna aggiungere che la religione dell’arte è diventata nel corso del Novecento qualcosa di molto strano, perché il dubbio e addirittura l’irrisione nei confronti di se stessa è ormai parte essenziale della sua essenza. Oggi un’opera d’arte che non contenga elementi di auto-critica e di auto-contestazione appartiene al kitsch, al dilettantismo o alla comunicazione mass-mediatica.
In altre parole, l’arte è tale solo se è nello stesso tempo anche meta-arte e anti-arte. L’enigma, la simulazione, il plagio, l’equivoco, il paradosso, la contraddizione, l’antinomia, il dilemma, la mise en abîme sono pratiche correnti del fare artistico contemporaneo. Perfino la smaterializzazione e addirittura l’autodistruzione dell’artefatto sono state considerate come operazioni artistiche.
Non è nemmeno necessario produrre opere: si può essere artisti a pieno titolo solo producendo idee e progetti irrealizzabili, praticando stili di vita alternativi e rivoluzionari, compiendo atti iconoclastici, vandalici e perfino terroristici. A tutto ciò bisogna aggiungere che l’arte è sempre stata per eccellenza il luogo in cui ogni sorta di psicopatologie e di perversioni vengono legittimate e convalidate. Fintanto che tutte le devianze restano contenute nel vaso di Pandora dell’arte, la società e la Chiesa sono relativamente protette da queste. Non è prudente scoperchiarlo.
-
> PERVERSIONI ---- AMORE E PSICHE e LE GRAZIE. CANOVA E IL VATICANO18 dicembre 2012, di Federico La Sala
-
> PERVERSIONI ---- Quel che resta del desiderio. Un saggio di Michela Marzano sul tema del rapporto con il corpo (di Anais Ginori)19 luglio 2012, di Federico La Sala
Quel che resta del desiderio
Un saggio di Michela Marzano sul tema del rapporto con il corpo
di Anais Ginori (la Repubblica, 18.07.2012)
In poco meno di mezzo secolo, la pornografia ha perso gran parte della sua carica sovversiva, conquistando l’immaginario di massa, non solo maschile, banalizzandosi persino. L’industria audiovisiva di porno, che a lungo è stata un’avanguardia, una controcultura, è entrata a pieno titolo nel consumo mainstream, con una diffusione e una facilità di fruizione mai sperimentata prima.
Il concetto di trasgressione è stato così continuamente ridefinito, i produttori hanno via via ripiegato su sottogeneri pornografici sempre più specializzati, di nicchia. Sul valore liberatorio e libertario di queste pellicole si dibatte almeno da quando, era il 1972, venne prodotto Gola Profonda. In La fine del desiderio la filosofa Michela Marzano cerca però di far uscire la polemica dalla logica di “genere” sviluppata dalle femministe americane a partire dagli anni Settanta, le quali sono state poi contestate da altre voci all’interno del movimento.
Accanto a chi ha denunciato la reificazione del corpo femminile e gli stilemi della dominazione maschile, c’è chi ha difeso uno spazio di libertà e una presunta funzione emancipatrice. Senza entrare direttamente nel merito, Marzano sposta la discussione sulla decostruzione della soggettività, indagando quelle sottili sfumature che differenziano l’erotismo dalla pornografia. Attraverso una vasta bibliografia, l’analisi comparata di film e romanzi, la filosofa pubblica un saggio in forma di pamphlet preceduto in Italia da polemiche e dibattiti ancor prima di essere tradotto.
L’edizione originale francese risale al 2003 ma La fine del desiderio, nella versione aggiornata degli Oscar Mondadori, non ha perso nulla in pertinenza e attualità, quasi fosse una lettura a consuntivo di un periodo politico da taluni definito “pornocrazia”. Marzano applica infatti la definizione di pornografico (dal latino “scritto sulle prostitute”) al di là dell’aspetto cinematografico, estendendolo alle “condotte”. Il confine estetico, ma non solo, tra quel che è o non è osceno è sempre incerto. Soggettivo, appunto.
Come sosteneva Alain Robbe-Grillet: «La pornografia è l’erotismo degli altri». Sarebbe sbagliato ridurre tutto a una questione di gusto, moralismo, comune senso del pudore. Non si tratta, avverte Marzano, solo di rappresentare più o meno esplicitamente l’atto sessuale. La pornografia diventa tale attraverso la negazione dell’altro, del suo desiderio.
È la “destituzione del soggetto” che rende le persone non più uniche e insostituibili ma personaggi intercambiabili. L’accostamento di corpi che diventano automi, presentati come un “assemblaggio di pezzi”, trascura gli aspetti più oscuri, reconditi, trascendenti del sesso. L’oggetto dell’erotismo, invece, è il corpo erogeno. «Il corpo nel suo insieme, in cui si concretizza il desiderio». È la possibilità, spiega la filosofa, di “toccare ed essere toccati”, sia dal punto fisico che psicologico. La cancellazione del desiderio altrui si ripercuote anche su quello proprio, con comportamenti stereotipati.
La sfida del saggio è sfuggire, come avvertiva Michel Foucault, da una storia della sessualità basata solo sulla repressione. Senza mai limitarsi a una denuncia tout court, Marzano ci invita a interrogarci su come, mettendo in scena gli aspetti più nascosti e rimossi della vita umana, la pornografia svuota di contenuto di mistero, stupore, che da sempre accompagna la sessualità. «È la frattura ontologica che ci caratterizza in quanto esseri umani - ricorda la filosofa - a spingerci a desiderare».
-
> PERVERSIONI ... UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- Il rimedio per la lussuria è l’amore (di Ruben Alves)31 gennaio 2012, di Federico La Sala
La lussuria
di Ruben Alves (Cem-Modialità, n. 1, gennaio 2012)
Lussuria! Che immagini vi vengono in mente quando sentite pronunciare questa parola? Non occorre dirlo, lo sappiamo. Sono immagini di orge, baccanali, uomini e donne che fanno sesso in qualsiasi maniera... Ma tengo a dirvi che la lussuria non è niente di tutto questo. La lussuria non vive nei genitali. Essa vive negli occhi. Proprio così: la lussuria è un modo di guardare. Il resto sono semplici deduzioni algebriche...
Il peccato della lussuria consiste proprio in questo: le persone che ne sono vittime perdono la capacità di vedere i volti. Vedono solo i genitali e ciò che si può fare con questi. In tale maniera, però, diventano incapaci di amare. Perché l’amore non inizia mai nei genitali. L’amore inizia nello sguardo. Guardando nel fondo degli occhi di chi è posseduto dal demone della lussuria, si vede solo una cosa: peni e vagine. Ora, una volta tanto, va ancora bene. Sono parti, piccole parti di un delizioso giocattolo che si chiama «fare l’amore». Ma quando quegli occhi vedono solo questo, il risultato è un’immensa monotonia. Perché tutte le orge, in fondo, sono la stessa cosa.
Quale cura, allora, per il disturbo oftalmico chiamato lussuria? Non la preghiera, neppure la promessa, non la flagellazione, neppure la minaccia. Il rimedio è la poesia. I demoni hanno in odio la poesia. Non c’è lussuria che resista ai poemi di Vinicius de Moraes, di Carlos Drummond de Andrade e di Adélia Prado. Rispetto a quest’ultima, ad esempio, ci sarà mai qualcosa di più erotico della sua poesia intitolata «Matrimonio»?
- Ci sono donne che dicono
 Mio marito, se vuole pescare, che peschi
Mio marito, se vuole pescare, che peschi
 Ma che pulisca i pesci.
Ma che pulisca i pesci.
 Io no. A qualsiasi ora della notte mi alzo
Io no. A qualsiasi ora della notte mi alzo
 Aiuto a pulire le squame, aprire, ritagliare e salare
Aiuto a pulire le squame, aprire, ritagliare e salare
 È così bello, solamente noi due in cucina
È così bello, solamente noi due in cucina
 E ogni tanto i menti s’incrociano
E ogni tanto i menti s’incrociano
 Lui dice cose come «questo è stato difficile»
Lui dice cose come «questo è stato difficile»
 «girò in aria dando colpi di coda»
«girò in aria dando colpi di coda»
 E fa il gesto con la mano
E fa il gesto con la mano
 Il silenzio di quando ci siamo visti per la prima volta
Il silenzio di quando ci siamo visti per la prima volta
 Attraversa la cucina come un fiume profondo
Attraversa la cucina come un fiume profondo
 Infine, i pesci sulla tavola
Infine, i pesci sulla tavola
 Andiamo a dormire
Andiamo a dormire
 Cose preparate sbocciano: siamo sposo e sposa
Cose preparate sbocciano: siamo sposo e sposa
Ai miei tempi antichi di protestante, eravamo soliti fare una cosa chiamata «culto domestico». La famiglia si riuniva per leggere la Bibbia e pregare. Credo che usanze simili sarebbero salutari: le famiglie che dopo cena si riuniscono per leggere poesia. Incluse le Sacre Scritture. Non c’è lussuria che resista al Canto dei Cantici
- Mi baci con i baci della tua bocca.
 Sì le tue tenerezze sono più dolci del vino
Sì le tue tenerezze sono più dolci del vino
 Come sei bella, amica mia, come sei bella
Come sei bella, amica mia, come sei bella
 Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo
Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo
 L’odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi
L’odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi
 Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
 c’è miele e latte sotto la tua linguaCome sono belli i tuoi piedi
c’è miele e latte sotto la tua linguaCome sono belli i tuoi piedi
 Nei sandali, figlia di principe
Nei sandali, figlia di principe
 Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d’artista
Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d’artista
 Il tuo ombelico è una coppa rotonda
Il tuo ombelico è una coppa rotonda
 Che non manca mai di vino drogato
Che non manca mai di vino drogato
 Il tuo ventre è un mucchio di grano
Il tuo ventre è un mucchio di grano
 Circondato da gigli
Circondato da gigli
 I tuoi seni come due cerbiatti
I tuoi seni come due cerbiatti
 Gemelli di gazzella...
Gemelli di gazzella...
 Vieni mio amato... mi sono già tolta i vestiti...
Vieni mio amato... mi sono già tolta i vestiti...
Colui che è tentato dalla lussuria è perché non è amato. Il rimedio per la lussuria è l’amore.
(traduzione di Marco Dal Corso)
- Ci sono donne che dicono
-
> PERVERSIONI ---- La spirale perversa di Adolfine.La sorella di Freud, il romanzo di Goce Smilevski (di Elisabetta Rasy)17 ottobre 2011, di Federico La Sala
La spirale perversa di Adolfine
di Elisabetta Rasy (Il Sole-24 Ore, 16 ottobre 2011
Mentre nessuno se la prende più con il fantasma di Karl Marx - anzi di lui si pubblicano le lettere d’amore - l’ombra di Sigmund Freud si allunga sul ventunesimo secolo continuando a suscitare domande, controversie, emozioni contrastanti. Succede nel film di Cronemberg, A dangerous method, dove le simpatie, nella celebre rottura, vanno al giovane Jung, e succede ora nell’opera di un giovane autore macedone, Goce Smilevski. Ma non si tratta di uno di quei volumoni avvelenati come Il libro nero della psicoanalisi o di qualche pamphlet provocatorio, ma di un romanzo originale e avvincente, intitolato La sorella di Freud.
La protagonista è una delle sorelle del fondatore della psicoanalisi, Adolfine: ne esiste anche su internet una foto insieme alle altre tre sorelle che, dopo varie vicessitudini, passarono come lei la vecchiaia a Vienna: una donna pesante, su cui il tempo ha lasciato molti segni, vestita un po’ disordinatamente. Fu la meno fortunata delle figlie di Jacob e Amalia Freud, anch’esse tutt’altro che fortunate, tranne Anna che presto emigrò in America. Adolfine non si sposò mai, e visse una vita solitaria prima di condividere con le sorelle la peggiore delle morti, ormai tutte e quattro vecchie, deportate e assassinate nei campi di sterminio nazisti, dopo che Hitler aveva annesso l’Austria alla Germania nel 1938.
Freud intanto era fuggito in Inghilterra: i suoi amici più influenti gli avevano organizzato l’espatrio consentendogli di stilare una lista di persone care da portare con sé. Ecco, nella lista le quattro vecchie sorelle non ci sono. Questo è il punto di partenza di Smilevski e della vicenda di Adolfine, in una Vienna dove già infuria la barbarie. Ma dopo la deportazione e la morte nel lager, come un prologo, la storia riprende affidata alla voce della donna, che narra la sua vita ivi compreso il rapporto col celebre fratello.
Freud, prediletto oltraggiosamente dalla madre a scapito del resto della famiglia e totalmente preso da se stesso (il che però vuol dire dai suoi studi), non fa una bella figura, ma fortunatamente non è questo tipo di denuncia e frusta rivendicazione la materia del romanzo.
Nessuna scomunica in nome degli affetti o del femminismo, piuttosto un violento faccia a faccia tra un uomo e una donna animati di passioni e idee nell’atmosfera febbrile della capitale di un impero su uno splendente orlo del baratro, una scena convulsamente mobile nella quale tutte le vecchie certezze sull’ordine e sul disordine svaniscono o si disperdono, fino alla catastrofe finale del nazismo.
La Adolfine di Smilevski sembra la figura animata di un quadro di Schiele, così come il suo amante Rajner e le sue amiche di giovinezza. Nel romanzo Freud aiuta la sorella ad abortire, dopo che il fidanzato si è suicidato: sul muro resta una macchia di sangue che è il centro drammaticamente colorato di una storia in cui tutto è chiaroscuro, una sorta di danza di spettri nella quale si alimentano le passioni che domineranno il Novecento.
Adolfine parla come se fosse sul divano inventato da suo fratello, e il suo racconto non segue la logica di una vicenda lineare ma si inabissa in se stesso per poi riprendere in altro modo un filo che continuamente si spezza e continuamente si riannoda. Per la vena barocca e potente di questo giovane e dotato autore (il romanzo uscito nel 2007 è stato acquistato in molti paesi europei , antologizzato nella «Best European Fiction» del 2010 e premiato internazionalmente) la narrazione si costruisce non come una linea retta ma come un gorgo, una spirale cui contribuiscono in eguale misura il corpo e il pensiero.
Nella discesa agli inferi in cui consiste la sua vita - ma anche quella del mondo di ieri che tramonta sanguinosamente - Adolfine, ferita dalla madre perché soltanto una sorella, niente di più che una sorella, incontrerà altre sorelle: Klara Klimt, sorella di Gustav, sua compagna di passione e pazzia in un manicomio viennese; e, nel lager, Ottla Kafka, che tutto ha dimenticato fuorché il nome del fratello Franz, che ripete come un mantra. È’ questo mondo ctonio di sorelle oscure che Smilevski oppone al cielo, anch’esso doloroso ma alla fine trionfante, dei fratelli, come un coro di donne scarmigliate che oppone la sua verità agli eroi della tragedia.
Adolfine - e questo rende particolarmente interessante il libro dell’autore macedone ben tradotto da Davide Fanciullo -non è un’eroina degli affetti trascurati, della femminilità sottomessa, o semplicemente del (pur importante nel libro) discorso del folle che svela l’insensatezza della ragione. È invece colei che oppone all’utopia progressista del fratello, che vuole liberare l’uomo dalle superstizioni e guarirlo dalle religioni, dalle inibizioni e dalle soggezioni, il senso tragico della vita. Un senso eterno, antico quanto l’umanità, che nessuna liberazione, nessuna affermazione della ragione potrà redimere o cancellare.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 Goce Smilevski, La sorella di Freud,
Goce Smilevski, La sorella di Freud,
 traduzione di Davide Fanciullo,
traduzione di Davide Fanciullo,
 Guanda, Milano, pagg. 334, e. 18
Guanda, Milano, pagg. 334, e. 18 -
>UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- L’educazione sessuale Occorre portare l’educazione sessuale alla vera altezza dell’erotica (risposta di U. Galimberti a Renato Pierri e a Francesca Ribeiro).30 aprile 2011, di Federico La Sala
L’educazione sessuale
Occorre portare l’educazione sessuale alla vera altezza dell’erotica
Risponde Umberto Galimberti *
Benedetto XVI ha affermato che l’educazione sessuale nelle scuole di alcuni paesi europei è una minaccia alla libertà religiosa. Le cose però non stanno così, giacché la morale, compresa quella sessuale, viene inevitabilmente trasmessa dall’intera società (costumi, mezzi di comunicazione di massa, ecc.) Gli insegnanti sono costretti ad affrontare temi che toccano la sfera della sessualità, perché è difficile restare neutrali davanti a problemi quali l’aborto, la contraccezione, l’omosessualità, le coppie di fatto, ecc. In realtà Benedetto XVI ha il timore, sacrosanto essendo il Papa, che nelle scuole venga trasmessa una morale sessuale diversa da quella cattolica. Ma siamo certi che questa sia rispettosa delle libertà individuali?
 Renato Pierri ex docente di religione cattolica
Renato Pierri ex docente di religione cattolica
 renatopierri@tiscali.it
renatopierri@tiscali.itBenedetto XVI forse ha ragione. Nelle scuole bisognerebbe insegnare la morale sessuale della Chiesa cattolica. Nessun rapporto con la persona amata, anche se si è in età matura, persino per tutta la vita, se non si è sposati (art. 2353 del Catechismo). E, in mancanza di rapporti, attenzione a non masturbarsi, perché "la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato" (art. 2352). Gli omosessuali, da accogliere con compassione, sono chiamati alla castità (art. 2358). Quindi nessun rapporto per tutta la vita con persone della stessa identità di genere. Atto "intrinsecamente cattivo", invece, anche per persone sposate in Chiesa, ricorrere al condom al fine di non procreare (art. 2370). Una donna che abortisce, anche nel caso in cui il feto sia affetto da malattia gravissima, oppure concepito a seguito di uno stupro, è un assassina come Caino (Giovanni Paolo II - Evangelium vitae). L’elenco sarebbe lungo, ma questo basta per rendersi conto che l’educazione sessuale cattolica è una minaccia alla libertà della persona.
 Francesca Ribeiro
Francesca Ribeiro
 ribesca@tiscali.it
ribesca@tiscali.itQuando la Chiesa si libererà dall’ossessione sessuale avrà più tempo per parlare di Dio e più capacità di persuadere che Dio è amore. Non nell’accezione protettiva e consolatoria secondo la quale Dio ama gli uomini che ha creato e redento, ma nel senso che senza un sprazzo di trascendenza, di cui Dio è la metafora, la sessualità perde la sua densità, la sua forza, il suo senso, la sua potenza. Questo bisogna insegnare ai giovani. E in questo deve consistere l’educazione sessuale affinché i ragazzi non si limitino alla pura meccanica dei corpi, ma sappiano, al di là del possesso e della loro appropriazione, leggere l’accadere di un mondo quale appare guardato con gli occhi dell’eros.
La negazione della sessualità, la sua proibizione, il silenzio sui temi sessuali, utile solo a custodirne l’ignoranza che non ha mai fatto fare un passo avanti a nessuno nella storia, non sono praticabili in quell’età in cui la natura sprigiona tutta la sua potenza sessuale in quei corpi giovani. E allora, se educazione ci deve essere, affinché la sessualità si esprima a livello umano e non solo animale, è necessario quel raggio di trascendenza, a cui ho accennato, che consente ai corpi di non chiudersi tristemente nel cerchio stretto della loro solitudine che si fa oppressiva, ma sappia articolare la passione in quella polifonia di linguaggi capace di trasfigurare la nudità nell’estasi della partecipazione, in modo da risvegliare la carne dalla sua opacità e, da puri funzionari della specie come natura ci prevede, ci faccia scoprire, proprio nell’atto sessuale, come individui, caratterizzati da un nome proprio che solo l’altro può chiamare.
E tutto ciò, vorrei dire a chi teme l’educazione sessuale intesa come qui ho cercato di illustrare, è profondamente religioso, se è vero quel che leggiamo nel Cantico dei Cantici (7, 12-13): "Vieni mio diletto, usciamo alla campagna, pernottiamo nei villaggi: di buon mattino andremo nei vigneti, vedremo se gemma la vite, se sbocciano i fiori, se fioriscono i melagrani, là ti darò i miei amori".
Educazione sessuale significa allora insegnare ai giovani come si passa dal corporeo all’incorporeo, per scoprire nel sorriso un offerta, nello sguardo una reciprocità di intenzioni, nel gesto quell’indistinta mescolanza di bellezza e tenerezza che consente di esprimere quella che poco prima era una timida gioia nascosta che la sessualità sprigiona. Non è una bella cosa insegnare tutto questo ai giovani, invece di proibire quello che la natura non consente a loro di ignorare?
* la Repubblica/D, 30.04.2011
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO --- LA GELOSIA. PERCHÉ ESSERE GELOSI NON VA PIÙ DI MODA. Un saggio dello psicanalista Benvenuto su com’è cambiata la percezione sociale (di Luciana Sica - Intervista).22 marzo 2011, di Federico La Sala
Un saggio dello psicanalista Benvenuto su com’è cambiata la percezione sociale
PERCHÉ ESSERE GELOSI NON VA PIÙ DI MODA
"L’ossessione dell’esclusività è caduta in disgrazia, sembra un lugubre retaggio del passato. Così la possessività si rivela più per quel che si fa che in quel che si sente"
di LUCIANA SICA (la Repubblica, 22.03.2011)
Come geloso - scrive Roland Barthes - soffro quattro volte: perché sono geloso; perché mi rimprovero di esserlo; perché temo che la mia gelosia ferisca la persona che amo; perché cedo a una banalità». Nei Frammenti di un discorso amoroso, alla fine degli anni Settanta, il critico francese inserisce la figura della gelosia in una sentimentalità "oscena". Eppure quel desiderio di possedere la persona amata - condito dal timore, il sospetto, la certezza della sua infedeltà - non è scomparso, neppure in questo tempo che qualcuno ha chiamato delle "passioni tristi".
«Nel deserto degli affetti di oggi, la possessività è anche più imbarazzante e in genere viene rimossa, schivata, occultata, dissimulata...»: a dirlo è lo psicoanalista Sergio Benvenuto, che a La gelosia ha dedicato un libro in uscita per il Mulino (pagg. 136, euro 9,90). "Impulso naturale o passione inconfessabile?", già il sottotitolo rende problematico un tema che l’autore ripensa anche attraverso la letteratura, il cinema e il teatro.
Davvero la gelosia è solo un banalissimo istinto?
«La gelosia è un sentimento universale, ma anche un’istituzione sociale che ogni epoca e ogni società valuta, censura, esalta, condanna, autorizza. Per dirla con Pasolini, la verità non è in un sogno, ma in molti sogni. Analogamente, la verità sulla gelosia non è detta da una sola teoria, ma da più teorie, anche se io la vedo soprattutto come invidia della libertà dell’altro - e spesso prende il posto lasciato vuoto dall’amore. In Occidente, quella che gli anglofoni definiscono romantic jealousy è ormai un sentimento caduto in disgrazia, appare come un retaggio di una lugubre epoca di chiusura, non più giustificato e privo di istituzioni di sostegno - com’erano le attenuanti per il delitto d’onore. La possessività gelosa si rivela allora più in quel che si fa che in quel che si sente o si dice di sentire. Ma se tendiamo a negare, agli altri e soprattutto a noi stessi, di provare gelosia, inevitabilmente questo sentimento si esprimerà in forme camuffate, ellittiche, anche barocche».
Che intende dire?
«Ci sono varie strategie "antigelose", per evitarne la sofferenza. Alcune sono più soft, come quella molto sospetta di dichiarare orrore della gelosia, o di trovarla impensabile, pur avendo sotto gli occhi prove schiaccianti dell’infedeltà. Ma tra i vari antidoti, più gli uomini che le donne "scelgono" quella che io chiamo la gelosia negativa, fino a ricavare un piacere del tutto stravagante nell’essere traditi: basta che non venga mai spezzata la complicità del gioco. Altrimenti può esplodere la violenza».
Alle Perversioni (Bollati Boringhieri), ha dedicato un saggio importante qualche tempo fa: a lei il "geloso negativo" non sembra un bel po’ masochista?
«La psichiatria oggi chiama le perversioni "amori sbagliati"... Può anche essere una "perversione masochista" spingere la persona amata nelle braccia di altri o di altre, e trarne piacere. Ma qui a contare è l’assenza diffusa di tolleranza nei confronti di un sentimento che inquieta. In effetti ammettere di essere gelosi è aver già perso la partita, significa riconoscere di non aver nessun controllo sull’altro e che l’altro ha il potere spaventoso di tormentarci. Implica un senso d’inferiorità ("cosa ha quell’altro che io non ho?") e una penosa ferita narcisistica. Molti uomini hanno un divorante bisogno di essere amati, proprio per sostenere un’autostima che fa acqua da tutte le parti. Il "geloso negativo" è un bricoleur dell’amore: la promiscuità della sua donna alla fine dimostra che lei ama davvero lui solo».
Insiste molto sulla gelosia maschile. Ma le donne non sono spesso gelosissime?
«Certo che lo sono, ogni volta che non si sentono abbastanza desiderate dal loro compagno - il che è abbastanza frequente. Per gli uomini è diverso, anche perché non possono fingere più di tanto: è il piacere femminile che spesso è truccato».
Non era Freud a dire che c’è una componente omosessuale nella gelosia?
«C’è senz’altro un interesse sghembo per il rivale. Non a caso gli uomini gelosi spesso preferiscono la compagnia maschile a quella femminile, e attribuiscono alle loro donne un desiderio che non osano sessualizzare... La competizione amorosa può portare due uomini a uccidersi, ma anche ad amarsi».
-
> UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- Medici dell’anima? Disavventure sul lettino dello strizza (di Elisabetta Ambrosi).27 gennaio 2011, di Federico La Sala
 Medici dell’anima?
Medici dell’anima?
 Disavventure sul lettino dello strizza
Disavventure sul lettino dello strizza Si discute se escludere il narcisismo dalle patologie psichiche (troppo diffuso per essere a-normale): ma il guaio è districarsi tra mille scuole analitiche
Si discute se escludere il narcisismo dalle patologie psichiche (troppo diffuso per essere a-normale): ma il guaio è districarsi tra mille scuole analitiche di Elisabetta Ambrosi (il Fatto, 27.01.2011)
di Elisabetta Ambrosi (il Fatto, 27.01.2011)Il libro di Elisabetta Ambrosi sottotitolato “Malefatte degli psicoanalisti”. Un sincero appello ai dottori e ai pazienti della psicanalisi moderna. L’autrice ci introduce con pudore nella sua vita privata, a volte lasciando intuire, a volte raccontandosi senza riserve.
Il narcisismo non è più una malattia. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove gli esperti che stanno lavorando alla nuova edizione del Dsm, il manuale per diagnosticare i disturbi mentali ad uso degli psichiatri, stanno discutendo se declassarlo. Il motivo? Troppo diffuso per essere considerato patologico, “a-normale”, appunto. Più che un disturbo di personalità, è un disturbo della società, come aveva capito nel lontano 1979 il pessimista Christopher Lasch, nel suo La cultura del narcisismo.
Tutti colpevoli, nessun colpevole. Può forse rallegrarsene il premier, i cui comportamenti, dopo il caso Ruby, sono stati descritti sotto il segno della psicopatologia. Un narcisista esibizionista o, meglio, un “narcinista”, narciso e cinico, come lo ha definito Massimo Recalcati sul «Fatto». Tanto che qualcuno ha fatto notare che, oltre al medico e al confessore, avrebbe urgente bisogno di uno psicoanalista. A stendersi sul lettino però non dovrebbe essere solo Berlusconi.
Perché, a ben guardare, il premier incarna nevrosi molto moderne. La “sregolazione pulsionale”, l’incapacità di tenere insieme legge e desiderio, la sostituzione del desiderio con il godimento sono patologie di oggi, che affondano le loro radici nella rivoluzione del soggetto di matrice sessantottina. Magari mal interpretata. Ma che comunque ha condotto a una società di uomini e donne, dotati sì di fallo, ma “senza inconscio”, secondo la suggestiva immagine che ne ha dato Recalcati. Uomini che, nella loro adesione all’imperativo del godimento, sessuale o consumi-sta, finiscono dritti dritti nella braccia delle pulsioni di morte.
E DUNQUE, come ha ammesso perfino Giuseppe De Rita, direttore del Censis, le categorie della sociologia non bastano più per spiegare sia la società che la politica. Bisogna tornare a quelle della psicoanalisi. Già, ma di quale psicoanalisi? Perché se è legittimo l’allarme sui fragili elettori-consumatori, lo è pure quello sugli psicoanalisti.
Quale terapia potrà davvero curare la perversione ipermoderna del godimento, l’unica vera odierna legge ad personam? E soprattutto: la psicoanalisi funziona ancora nell’epoca della morte del Padre, e della Legge? In Francia, il dibattito è acceso, come testimonia la mole di pubblicazioni - la più discussa quella di Michel Onfray contro Freud (Crépuscule d’une idole). Da noi invece, di psicoanalisi non si parla più. È come se gli specialisti si fossero ritirati sull’Aventino della psiche, lasciando la discussione su malattie e terapie al salotto televisivo dei vari Crepet.
Rispetto della privacy e divieto di fare diagnosi in pubblico, si difendono. Ma non sarà anche che i nostri strizzacervelli, di fronte alle nuove patologie striscianti, quelle sotto il segno dell’ambiguità, come le ha definite la psicoanalista Simona Argentieri, non sono stati capaci di aggiornarsi? D’altro canto, non solo l’efficacia delle teorie, ma anche le competenze dei singoli analisti sono sottoposte a ben pochi controlli. Una volta entrati sotto il cappello di una scuola accreditata del ministero, raramente devono preoccuparsi di qualcosa, perché quando l’analisi fallisce, ammesso che il paziente se ne accorga, il danno è indimostrabile e non risarcibile . Così, tornando all’ipotetico paziente narciso, è meglio avvisarlo del fatto che, qualora decidesse di entrare in analisi, rischierebbe di incappare in due analisti opposti. Se in cura da un freudiano doc, potrebbe trovarsi di fronte una terapia troppo simile al vecchio, e gratuito, catechismo. Un setting obbligatorio di molte sedute a settimana, in studi bui dove analiste severe (e un po’ frigide) invitano il paziente ad un duro lavoro in vista della guarigione morale. Nella quale il sesso ha perso il suo peso originario, sostituito com’è dall’analisi del transfert con l’analista-madre, che farà di tutto per renderlo dipendente da lei.
IL RISULTATO? Una conversione poco autentica, che finita l’analisi mostrerà le corde. Oppure l’adozione di una doppia verità, ligio a Freud dentro, vanesio pansessualista fuori. Un esito peggiore, però, si avrebbe nel caso di un incontro tra un narciso e un lacaniano. Il linguaggio oscuro, esoterico, in cui si spiega che il desiderio è sempre “altro”, non “possesso”, ma “vuoto”, rischia di avere un effetto paradossale: convincere il fragile sé alla ricerca del godimento della giustezza del suo passare da un fiore all’altro, senza una definitiva scelta mortifera, proprio come insegnava il Maestro. Che malignamente Corinne Maier, nel pamphlet Buongiorno lettino, descrive come “un dandy collezionista, amante delle belle macchine e delle donne. Seduttore (nonostante le sue orecchie smisurate), incapace di rispettare l’autorità, intrattabile e arrogante; apolitico, ma con tendenze conservatrici”.
Due modelli, il disincarnato freudiano assertivo e regolatore, e il lacaniano dissipato, molto simili persino alla nostra politica. L’uno al centrosinistra che, come ha scritto Ida Dominijanni, “occupa il campo della Legge svuotandolo della sua forza simbolica”; l’altro al centrodestra, “che occupa il campo del desiderio svuotandolo della sua forza creati-va”. Se esistono analisti capaci di curare il nostro nar-cinismo, allora, battano un colpo, intervengano nel dibattito. Raccontando cos’è la psicoanalisi e perché serve ancora, quali sono i suoi strumenti e le sue idee forti, in un’epoca di passioni deboli e organi sessuali troppo sviluppati. In questo caso siamo disposti a stenderci sul lettino, assieme al Caimano. Purché, per favore, ci aiutino a trovare il desiderio. Nel pubblico e nel privato.
-
> PERVERSIONI di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO ---- "Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità. Secoli XVI-XVII" (rec. di Adriano Propseri)1 ottobre 2010, di Federico La Sala
L’altro kamasutra scritto da un gesuita
di Adriano Prosperi (la Repubblica, 01.10.2010)
Anche la cultura cristiana ha avuto il suo Kamasutra. Per secoli la scienza del sesso è stata una scienza ecclesiastica. Confessori e direttori di coscienze, messi a guardia del peccato della lussuria e delle infrazioni capitali o veniali ai comandamenti sesto e nono, hanno dovuto illuminare, istruire, punire uomini e soprattutto donne nel segreto della confessione. Un sapere, il loro, tutto e solo libresco, fatto di nozioni mediche, psicologiche, filosofiche innestate sul tronco originario di una religione sessuofobica, guidata da un clero celibatario e da ideali di perfezione angelica. Ma si tratta pur sempre di una religione che ha conosciuto grandi mutamenti: fondamentale fra tutti quello che vide l’ingresso della Chiesa cattolica «nella camera degli sposi», come dice il titolo del libro di Fernanda Alfieri (Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità. Secoli XVI-XVII, il Mulino, pagg. 423, euro 29).
Un libro importante, centrato su di un’analisi per molti aspetti magistrale del monumento della casuistica morale cattolica della Controriforma applicata all’economia sessuale del rapporto coniugale: le Disputationes de sancto matrimonii sacramento (1602-1605), del gesuita spagnolo Tomás Sánchez.
L’opera segnò una svolta rivoluzionaria rispetto alla tradizione perché fece posto al piacere del sesso e alla esplorazione dei suoi veicoli e delle sue tecniche ben al di là dei limiti concessi a denti stretti dai predecessori, tanto da scatenare proteste e censure. Ma se la cultura cattolica con l’opera di Sánchez «libito fè licito in sua legge» lo si dovette alla decisione della Chiesa tridentina di reagire alla proposta della Riforma protestante portando la guerra fuori dai suoi confini, nel bel mezzo del campo occupato dalla famiglia e dalle dinamiche della riproduzione.
La Chiesa tridentina non solo aprì i recinti sacri al matrimonio e portò davanti all’altare gli sposi ma si impegnò a seguirne tutto il percorso di vita, quello diurno e soprattutto quello notturno, riconoscendo una funzione essenziale e moralmente positiva ai rapporti sessuali. Da allora dura la marcia ininterrotta di un’avanzata del magistero ecclesiastico nelle cose del sesso.
Ne registriamo quasi quotidianamente gli esiti nella vita della nostra società civile ogni volta che è questione di concepimento, aborto e giù fino alle polemiche sulle cellule staminali e gli embrioni.
Ed è a certi aspetti radicati nel profondo della vita sociale dei paesi cattolici - al di là di una superficie apparentemente disinibita e di una solo presunta liberazione o parità della donna - che il libro di Fernanda Alfieri fa riflettere.
Ci sono modelli culturali ancora latenti che vennero elaborati e argomentati in quel monumento eretto al sesso coniugale da un missionario spagnolo negli intervalli di un’opera di conquista religiosa e sotto un cielo andaluso dominato dall’azzurro mantello della Madonna vergine e madre dell’Immacolata Concezione.
È a quell’orizzonte che rinvia lo stereotipo femminile degli occhi bassi e della passività affettiva e sessuale di una donna considerata solo un recipiente silenzioso e sottomesso del seme maschile. E tuttavia la persistente autorità ecclesiastica su materie di questo tipo non si capirebbe senza l’opera di Tomás Sánchez: fu lui che rielaborando le fonti di una cultura cristiana più che millenaria, dette argomenti alla avanzata della Chiesa sul terreno della famiglia e del sesso: in primo luogo riportando la materia degli affetti, degli istinti e delle pulsioni sotto il dominio della ragione e facendone oggetto di conoscenza intellettuale.
Per il gesuita come per i suoi discepoli destinati al sacerdozio si trattava di conoscere per guidare e governare. Per questa via si giunse al riconoscimento della positività di sentimenti e istinti e si aprì alla donna la possibilità di vedersi riconosciuta una parte essenziale nel piano divino ricavandone intanto il diritto al possesso del suo uomo e alle prestazioni maritali.
Nel perdurante silenzio delle donne, era la voce del corpo che bisognava interpretare perché il progetto del concepimento andasse pienamente in porto: e quella voce trovò ascoltatori attenti. Occhi freddi ed esperti studiarono fisiologia e psicologia, intercettando tutti i segnali e spiando ogni sintomo per costruire una scienza della psicopatologia sessuale dell’animale femminile, il tutto subordinato alla finalità della riproduzione.
E tuttavia la scienza casuistica del sesso e la pratica delle possibilità infinite di tatti e di contatti illustrata agli ecclesiastici celibatari e per loro tramite ai, e soprattutto alle, penitenti, non poteva non produrre effetti imprevisti dilatando l’orizzonte delle fantasie e innescando reazioni a catena. Non per niente il mondo del libro, ignorando o trasgredendo limitazioni e proibizioni, ha trasformato la scienza teologica della morale in letteratura pornografica: dal Paradiso delle coppie sposate all’Inferno delle biblioteche
-
> PERVERSIONI --- IL SEX APPEAL DELL’INORGANICO - L’IMMAGINARIO PORNOGRAFICO E LA GUERRA DELL’EROS. Intervento di Mario Perniola al Film Forum 2010 (Gorizia-Udine, 19-24 marzo).17 marzo 2010, di Federico La Sala
La guerra dell’eros
Così l’Occidente ha inventato la rivoluzione sessuale
La liberazione dei costumi negli anni Sessanta, che usò i testi di Reich e Marcuse, fu un’arma contro l’Urss, mentre la pornografia è stata usata contro i regimi islamici
di Mario Perniola (la Repubblica, 17.03.2010)
Il testo che anticipiamo è parte dell’intervento che sarà svolto per Film Forum 2010 dedicato all’immaginario pornografico. Il festival si tiene dal 19 al 24 marzo tra Udine e Gorizia
La produzione dei film di Hollywood fu retta dai primi anni ’30 fino al 1966 da un regolamento di autocensura che vietava la rappresentazione di qualsiasi comportamento o immagine ritenuta immorale; questo orientamento viene abbandonato a cominciare dagli anni ‘60. Attraverso una progressiva deregolamentazione si è arrivati alla situazione attuale in cui perfino i bambini attraverso Internet hanno un facile accesso a ogni sorta di video pornografico.
Il punto di partenza di questo sorprendente cambiamento è la cosiddetta Rivoluzione sessuale degli anni ‘60, che resta un evento storico difficile da interpretare: c’è qualcosa di incomprensibile e di enigmatico in questa deregolamentazione che ha trovato il suo avvio negli Stati Uniti, ma si è poi estesa all’Europa occidentale. I paesi comunisti sono invece rimasti fedeli al progetto politico di una società retta da principi di moralità sessuale.
Le idee della Rivoluzione sessuale non erano una novità: esse erano state elaborate negli anni ‘20 e ‘30 dal movimento "Sexpol". Il principale animatore di tale movimento fu lo psicoanalista Wilhem Reich, il quale condusse una battaglia contro due fronti: da un lato contro il nazionalsocialismo, dall’altro contro il comunismo sovietico. Reich attribuiva il successo della propaganda nazifascista all’attivazione di profonde pulsioni inconsce di carattere repressivo e di origine patriarcale; nello stesso tempo stigmatizzava con estrema energia l’involuzione reazionaria della politica e della società sovietica, che aveva ripristinato la legge contro l’omosessualità, ostacolato l’aborto e restaurato il matrimonio e la famiglia coattiva. Qualche anno dopo la morte di Reich, avvenuta nel 1957 in una prigione degli Stati Uniti, il suo libro La rivoluzione sessuale conosce un grandissimo successo e diventa uno dei testi teorici fondamentali di riferimento della deregolamentazione sessuale occidentale, insieme ai testi di Marcuse e di Norman O. Brown. Contemporaneamente opere di narrativa, la cui pubblicazione era stata per decenni bloccata dalla censura, diventano popolarissime.
A chi è stato giovane in Occidente negli anni ‘60 la Rivoluzione sessuale è apparsa come qualcosa di ovvio, strettamente connesso con le idee di democrazia e di sviluppo: guardandola secondo la prospettiva di un orizzonte storico più ampio, essa appare come una breve parentesi tra la repressione delle immagini sessuali durata in Occidente per secoli e l’attuale diluvio di immagini pornografiche accessibili a tutti che crea alla fine, proprio per la sua infinita abbondanza, la scomparsa di ogni tensione erotica. Il carattere straordinario e anomalo della Rivoluzione sessuale degli anni ‘60 trova una spiegazione nel venir meno delle due grandi paure connesse con i rapporti sessuali: la scoperta di una cura capace di sconfiggere la sifilide e la commercializzazione della pillola anticoncezionale (che era stata inventata già trent’anni prima). Tuttavia queste interpretazioni non sono sufficienti a spiegare un fenomeno di massa così rivoluzionario che smantella in pochi anni tabù e divieti secolari.
Un fattore finora non sufficientemente preso in considerazione è quello politico: la Rivoluzione sessuale è stato un aspetto della guerra fredda contro il comunismo, molto più efficace dei missili e della bomba atomica. Insieme alla disponibilità di beni materiali e di consumi, la deregolamentazione sessuale dell’Occidente ha costituito qualcosa di molto più attraente dei Piani quinquennali sovietici.
Alla prima fase della deregolamentazione sessuale, dal 1965 al 1980, che è stata focalizzata sul permissivismo dei comportamenti sessuali, segue una seconda fase in cui in brevissimo tempo viene depenalizzata la pornografia, segregata dai secoli nei bordelli, negli scaffali dei bibliofili, nei boudoir o negli enfers delle biblioteche. Anche in questo caso c’è una spiegazione tecnica, che dipende dalla diffusione delle videocamera e delle cassette video.
Tuttavia questa svolta avrebbe potuto benissimo essere bloccata dalla censura e restare clandestina, come era avvenuto per la fotografia pornografica, la quale ha impiegato più di cento anni per essere legalizzata. Come si spiega dunque questa rapida e improvvisa deregolamentazione della pornografia a partire dal 1980? Certo è che si realizzava in modo veramente derisorio e beffardo un altro aspetto del programma del Sexpol! La famiglia era destabilizzata non dal comunismo, ma dal capitalismo attraverso la televisione, i video e oggi da Internet. I genitori sono così messi fuori gioco, non meno della scuola.
Che cosa è successo nel 1980 di tanto pericoloso e temibile per l’Occidente da indurlo a scegliere una strategia tanto permissiva e lassista? L’11 febbraio 1979 a Teheran viene ufficialmente dichiarata la fine della monarchia e proclamata la Repubblica islamica dell’Iran. Nasce così un regime teocratico e ultra-puritano che si presenta come la prima manifestazione di una Rivoluzione di impatto globale. Dinanzi a un evento tanto inaspettato e contrario a tutte le filosofie della storia democratiche e laiche, l’Occidente elabora due strategie culturali opposte. La prima ha il carattere della rivalità mimetica e porta alla rinascita del fondamentalismo cristiano, che presenta caratteri specifici a seconda dei differenti paesi: negli Stati Uniti porta ad una controrivoluzione conservatrice e neopuritana che si esprime nell’elezione di Ronald Reagan alla presidenza e alla sua campagna contro l’Impero del male.
La seconda strategia condotta simultaneamente alla prima ha invece un segno opposto: la deregolamentazione della pornografia, che offre al mondo intero (ma soprattutto a quello islamico) una sfida di proporzioni colossali: l’immagine del paradiso in terra qui ed ora. Con Internet a partire dai primi anni Novanta è compiuto un passo ulteriore: si passa dalle videocassette pornografiche alla disponibilità diretta e immediata di qualsiasi materiale pornografico. Il punto di arrivo finale è rappresentato dal Web2 e da YouTube dove si può vedere tutto gratuitamente per un tempo illimitato.
Qualche anno fa la pornografia poteva essere definita ancora un mercato moribondo in piena espansione; oggi sembra che essa abbia raggiunto lo stadio del suo compimento. La prospettiva di una pornografia fatta da adolescenti per loro uso e consumo rappresenta la sua fase finale.
-
> PERVERSIONI --- IL ’68, LA CHIESA E L’ABUSO DI CASTITA’. Monsignor Fisichella: «una cultura che ritiene che tutto sia ammissibile», diffusasi dagli anni ’60. Ovvero: non è stata la repressione sessuale a favorire certe pratiche. Bensì la libertà sessuale degli anni 60, etc. Curioso modo di ragionare! (di Bruno Gravagnuolo).17 marzo 2010, di Federico La Sala
Chiesa: abuso di castità
di Bruno Gravagnuolo (l’Unità, 17.03.2010)
Dunque per Monsignor Fisichella, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, pedofilia e abusi sui minori nella Chiesa, dipendono da «una cultura che ritiene che tutto sia ammissibile», diffusasi dagli anni ’60. Ovvero: non è stata la repressione sessuale a favorire certe pratiche. Bensì la libertà sessuale degli anni 60, etc. Curioso modo di ragionare! Ipocrita e irritante. Che la dice lunga su certi orientamenti culturali di questo pontificato, di cui il teologo Fisichella voluto in quel ruolo da Ratzinger pare espressione, almeno in questo caso. Lasciamo da parte il fatto che la Chiesa di Roma ha sempre secretato gli abusi, facendo divieto di rivelare il contenuto dei processi nei tribunali canonici. E che solo quando certi fatti gravi esplodono è poi costretta a dar mostra di intervenire. Il punto è un altro. E sta nel dato incontrovertibile che la Chiesa-Istituzione è sempre stata impermeabile a qualsivoglia ideologia libertaria relativa a sesso e sessualità. Perseverando nella chiusura ermetica su anticoncezionali, celibato, sacerdozio femminile, divorzio, per non parlare di aborto e fecondazione artificiale. E perseverando nell’additare nella castità un perficere perfectum, una meta ideale pure per i laici, fatto salvo l’obbligo di generare per i coniugati. Talché prendersela con la liberazione sessuale è un discorso da carceriere, che davanti a certe evasioni se la prende con le catene troppo lasche. Fughe che purtroppo non sono preti che gettano la tonaca alle ortiche, ma spesso preti che esprimono la loro libido repressa in modo distorto, restando ligi al sacerdozio. È il destino dello zelo ipocrita: il diavolo sessuale cacciato dalla porta rientra dalla finestra. Svelando altarini desolanti: sadismi, violenze, abusi. Con esistenze ireparabilmente rovinate. E arcivescovi e vescovi che coprono i misfatti e tacciono, ad maiorem dei gloriam. Per inciso: il colmo della beffa è che a difendere il tradizionalismo c’è il pio Berlusconi, devoto di Don Verzè. Che dichiara di non aver bisogno di dirgli i suoi peccati, quando si confessa con lui!
-
> PERVERSIONI --- STATO E CHIESA: UN’ALLEANZA A LUCI ROSSE. Una nota di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu, seguita da una riflessione di Franco (Bifo) Berardi29 marzo 2010, di Federico La Sala
STATO E CHIESA: UN’ALLEANZA A LUCI ROSSE. LA CHIESA CATTOLICO-ROMANA, LA MISOGINIA, E LA MISURA DELLA ILLEGALITA’. Una nota di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu, seguita da una riflessione di Franco (Bifo) Berardi sulla classe dirigente del semiocapitalismo barocco.
 La Chiesa e la misoginia
La Chiesa e la misoginia di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu
di Marie-Thérèse Van Lunen Chenu in “www.temoignagechretien.fr” del 24 marzo 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)
in “www.temoignagechretien.fr” del 24 marzo 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)L’ondata di notizie su ripetuti casi di pedofilia nella Chiesa cattolica ha suscitato molti commenti che portano in ritorno delle valutazioni interessanti. Vi si legge che una prima messa in discussione del celibato obbligatorio per i preti trova ora degli ardenti oppositori, mentre restano stigmatizzate la frequente immaturità della scelta di vita da parte di persone troppo giovani, una formazione rimasta a lungo inadeguata nei seminari, la mancanza di relazioni con il mondo femminile, l’autoritarismo, la cultura del segreto e della negazione nell’istituzione ecclesiale.
Mi stupisco tuttavia che il dibattito non sia ancora stato allargato fino a prendere in considerazione il problema sempre più sensibile della marginalizzazione - se non dell’eliminazione - delle donne nelle strutture dell’istituzione romana. E che i commentatori neppure abbiano affrontato un problema di fondo: la natura della testardaggine con cui Roma si impegna nella difesa del primato del sesso maschile.
Quali sono allora le cause e gli effetti di questo attaccamento eccezionale dell’istituzione romana ad un primato del sesso maschile, fino a giungere alla sua vera “sacralizzazione” nel clericalismo? Una critica che potremmo definire “pastorale” (venuta proprio dall’interno della Chiesa) si è unita, almeno da un decennio, ad una prima analisi femminista che smaschera quel gioco semantico che si ostina a chiamare “servizio” ciò che, scelto ed esercitato spesso con la più grande generosità personale, resta tuttavia un monopolio ed un potere.
Ci si chiede allora come questo servizio ultimo della “rappresentazione di Cristo per compiere l’eucarestia”, quel potere-servire che si declina solo al maschile, non influenzi l’identità clericale e, per ciò stesso, l’idealizzazione e il carattere di rifugio che dei giovani possono investirvi? E sembra ingenuo stupirsi che alcuni di loro siano tentati di sfuggire, con questa scelta, ad una identificazione sessuata esigente.
La mia riflessione va quindi più in là rispetto al deplorare ciò che pudicamente viene chiamato “difficoltà a vivere la castità”. Parlo qui delle turbe del comportamento che possono essere legate ad una difficoltà non risolta dell’identificazione personale. Essere capaci di identificarsi come un essere maschile significa poter accettare il “di fronte” di una uguale partner femminile. E sostengo che l’idealizzazione del primato maschile, la sua canonizzazione in qualche modo, e la giustificazione permanente che ne viene fatta attraverso il rifiuto della competenza e dell’autorità delle donne, possono turbare il processo di identificazione maschile e arrivare talvolta ad influenzare una scelta per il presbiterato o la vita religiosa.
In fondo, le cause sarebbero ben più imbricate di quanto non si pensi tra la proibizione fatta alle donne di accedere al ministero sacerdotale e l’obbligo del celibato per il prete maschio. Sono radici profonde e tenebrose che si intrecciano tra denigrazione della sessualità, marginalizzazione delle donne, primato accordato al sesso maschile, sacralizzazione del sacerdozio, rapporto sclerotico alla tradizione e questo governo autoritario, clericale e monosessuato.
Così, che ci si ponga all’interno o all’esterno dell’istituzione, la crisi attuale designa come una sfida insieme ecclesiale e sociale la necessità di un vero dibattito e di cambiamenti la cui importanza non si limiterà al solo campo religioso. Infatti la Chiesa cattolica è in ritardo sulla società per mettere in atto questi cambiamenti che ormai vengono definiti “umani”: nell’identificare e curare le cause di una valutazione negativa della sessualità, le è necessario, al contempo, affrontare il suo rapporto con la sessuazione.
Chi dice “sessuazione” riconosce evidentemente la bi-sessuazione fondamentale dell’umanità. Con quali mezzi allora far comprendere che l’istituzione si è sclerotizzata e si esaurisce in un approccio maschile della femminilità, proprio al contrario rispetto a quello che fu l’atteggiamento di Cristo verso le donne? Non è “la questione delle donne nella Chiesa” che fa problema, come si sente dire con leggerezza..., è quella di una Chiesa autoritaria che difende il suo primato clericale maschile e rifiuta un confronto pieno con una buona metà dei suoi membri.
Si tratta qui di una mancanza strutturale legata, più di quanto non faccia pensare una prima apparenza, agli scandali attuali. Ci si chiede fino a quando Roma penserà di poter attenuare tali scandali con delle scuse pubbliche ed una vergogna manifestata “a nome di tutta la Chiesa”? E fino a quando le donne, che sono state più spesso cuoche che consigliere nei seminari, non esprimeranno pubblicamente il loro disaccordo?
Molte di loro sono già, di fatto, unitamente a degli uomini anch’essi consapevoli delle riforme necessarie, se non in rottura pastorale, almeno in rottura di coscienza con l’istituzione... Accettare in maniera riconoscente e responsabile la sessuazione, la sessualità, e quindi le donne di oggi come vere partner, suppone insieme un lavoro pluridisciplinare ed un ampio dibattito di società e di Chiesa.
Teologia ed ecclesiologia sono interpellate: che cosa abbiamo fatte per perdere la capacità profetica del messaggio cristiano, che testimoniava il principio del rispetto delle donne in un’epoca di misoginia sociale, ma che resta ridotto al silenzio dalla sua contro-testimonianza di sessismo ecclesiale nell’oggi di parità sociale?
La sfida è importante per il cattolicesimo, se vuole conservare il suo posto in seno al cristianesimo e la sua credibilità “umana”. Certi cristiani, e in maggior numero certe cristiane, sperano ancora che la gravità attuale delle accuse e delle messe in discussione possa diventare un punto a cui far riferimento per una conversione profonda del cattolicesimo romano.
*Marie-Thérèse van Lunen Chenu è membro di “Femmes et Hommes en Église” e di “Genre en christianisme”
La misura dell’illegalitàdi Franco (Bifo) Berardi (il manifesto, 27 marzo 2010)
Negli ultimi mesi la protesta contro il regime berlusconiano ha raggiunto toni quasi patetici. Si parla di crisi del berlusconismo come per esorcizzare la realtà di una perfetta corrispondenza tra la corruzione del ceto politico-imprenditoriale e il cinismo diffuso nella società. Ma la crisi dove sarebbe? L’escalation di arroganza non è segno di una crisi, direi, ma del suo contrario: è segno della stabilizzazione di un sistema che non ha più bisogno di legge perché basta la legge del più forte per regolare le relazioni di precarietà, sfruttamento e schiavismo nel campo del lavoro e della vita quotidiana.
Quanto più evidente è il disprezzo del ceto al potere per la legge e le regole, tanto più la protesta si concentra sulla difesa della legalità. Il problema è che la legge e le regole non valgono niente quando non esiste la forza per renderle operanti. E dove sta la forza, cos’è la forza in un sistema centrato sulla produzione mediatica della coscienza? Nel discorso corrente quel che accade in questo paese è visto come una bizzarra forma di corruzione dello spirito pubblico, come una singolare e isolata sospensione della democrazia. Allo stesso modo gli inglesi guardarono agli italiani dopo la prima guerra mondiale, e le democrazie occidentali interpretarono Mussolini: un fenomeno di marginale arretratezza culturale, o piuttosto un’anomalia culturale. Poi l’esempio di Mussolini produsse effetti su larga scala, fino a precipitare il mondo nella più grande carneficina della storia.
Tra riforma e controriforma
Forse occorrerebbe smetterla di considerare il caso italiano come un’anomalia: al contrario è l’esempio estremo degli effetti prodotti dalla deregulation, fenomeno mondiale che distrugge prima di tutto ogni regola nel rapporto tra lavoro e capitale. Vi è certamente una specificità culturale italiana che merita di essere studiata capita, approfondita. Ma grazie a Mussolini e a Berlusconi questa specificità ha finito per esprimersi come forma anticipatrice del destino del mondo.
Nel libro Vuelta de Siglo (Mexico city, Era editorial, 2006) il filosofo messicano Bolivar Echeverria parla di due modernità che configgono e si intrecciano fin dall’inizio del sedicesimo secolo. La prima è la modernità borghese fondata sulla morale protestante e sulla territorializzazione delle cose mondane e del dovere industriale. L’altra è modellata dalla Controriforma e dalla sensibilità del Barocco. Questa seconda modernità è stata rimossa e marginalizzata nello spirito pubblico dell’Occidente capitalista a partire dal momento in cui l’industrializzazione dell’ambiente umano ha richiesto una riduzione del sociale al processo di meccanizzazione. La vita della borghesia industriale è basata sulla severa dedizione al lavoro instancabile e sull’affezione proprietaria ai prodotti del lavoro. La borghesia è una classe territorializzata perché l’accumulazione di valore non può essere dissociata dall’espansione del mondo delle cose fisiche. Non esiste più la borghesia perché la produzione non si svolge più nel borgo, ma nella rete, e la ricchezza non si fonda più sulla proprietà di oggetti fisici, ma sulla deterritorializzazione finanziaria.
Echeverria osserva che fin dal sedicesimo secolo la Chiesa Cattolica ha creato un flusso alternativo di modernità, fondato sulle competenze immateriali dell’immaginazione e sulle potenze della deterritorializzazione linguistica e immaginativa. Il potere spirituale di Roma è sempre stato fondato sul controllo delle menti: questo è il suo capitale, fin quando la sua potenza venne marginalizzata dalla borghesia industriale.
La fonte dell’accumulazione
Ma quando le immagini, non più semplici rappresentazioni della realtà, divengono simulazione e stimolazione psico-fisica, i segni divengono la merce universale, oggetto principale della valorizzazione di capitale. Se l’economia borghese territorializzata era fondata sulla severità iconoclasta del ferro e dell’acciaio, la deterritorializzazione post-moderna è fondata invece sulla macchina caleidoscopica della produzione semiotica. Questa è la ragione per cui possiamo parlare di semiocapitalismo: perché le merci che circolano nel mondo economico - informazione, finanza, immaginario - sono segni, numeri, immagini, proiezioni, aspettative. Il linguaggio non è più uno strumento di rappresentazione del processo economico e vitale, ma diviene fonte principale di accumulazione, che continuamente deterritorializza il campo dello scambio.
La dinamica di progresso e crescita, nata dallo spazio fisico territoriale della fabbrica, ha obbligato le due classi fondamentali dell’epoca industriale, classe operaia e borghesia, al rispetto delle regole politiche e contrattuali. La morale protestante delle regole fonda la contrattazione collettiva e la funzione sociale dello stato.
A partire dagli anni ’70 la relazione tra capitale e lavoro è stata trasformata, grazie alla tecnologia digitale e alla deregulation del mercato del lavoro. Un effetto enorme di deterritorializzazione ne è seguita, e il modello borghese è stato spazzato via, insieme alla vecchia coscienza di classe operaia. La finanziarizzazione dell’economia globale ha eroso l’identificazione borghese di ricchezza proprietà fisica e lavoro territoriale. Quando il lavoro perde la sua forma meccanica e diviene immateriale, linguistico, affettivo, la relazione deterministica tra tempo e valore si rompe. La genesi del valore entra in una fase di indeterminazione e di incertezza. La via è aperta verso un prevalere di una visione neo barocca, e all’istaurazione di una logica aleatoria nel cuore stesso dell’economia. Quando il linguaggio diviene il campo generale della produzione quando la relazione matematica tra tempo-lavoro e valore è rotta, quando la deregulation distrugge tutte le garanzie, solo un comportamento di sopraffazione criminale può prevalere.
La violenza della deregulation
Questo è accaduto, in tutto il mondo non solo in Italia dal momento in cui le politiche neoliberiste hanno occupato la scena. Il principio della scuola neoliberale, la deregulation che ha distrutto i limiti legali e politici all’espansione capitalista non può intendersi come un mutamento puramente politico. Occorre vederlo nel contesto dell’evoluzione tecnologica e culturale che ha spostato il processo di valorizzazione dalla sfera della meccanica industriale al campo della produzione semiotica.
Il lavoro cognitivo non si può ridurre alla misura del tempo dato che il rapporto tra lavoro tempo e valorizzazione diviene incerto, indeterminabile. Il mercato del lavoro globale diviene il luogo della pura legge della violenza, della sopraffazione. Non si tratta più di semplice sfruttamento, ma di schiavismo, di violenza pura contro la nuda vita, contro il corpo indifeso dei lavoratori di tutto il mondo. La violenza è diventata la forza economica prevalente nell’epoca neoliberista. In Messico come in Italia come in Russia come in molti altri paesi il mercato finanziario, il mediascape e il potere politico sono nelle mani di persone che hanno ottenuto il loro potere con l’illegalità e con la violenza. Per non parlare del ruolo che corporation come Halliburton e Blackwater hanno svolto e svolgono nel provocare guerre e nel distruggere vite e città perché questo è il loro lavoro, perché il loro business ha bisogno della guerra per prosperare. La violenza è la forza regolatrice dell’economia semiocapitalista, perchiò non é contrastabile con i richiami alla legalità e alla moralità.
Come cento anni fa littlie è l’avanguardia del capitalismo non protestante e la seconda modernità di Echeverria, che si presentò per alcuni secoli come pura reazione antimoderna emerge oggi come principio fondativo del capitalismo mondiale. L’esperienza italiana durante gli ultimi cento anni è stato il teatro principale di questo ritorno dello spirito barocco. Le performance di Mussolini e di Berlusconi sono fondate entrambe sulla esibizione teatrale dell’energia maschile, ma anche sulla capacità di penetrare nei recessi del linguaggio nel campo profondo dell’autopercezione collettiva.
Curzio Malaparte, in un libro intitolato L’Europa vivente, ragionava su questo punto: il fascismo raccoglie l’eredità della Controriforma e dello spirito barocco, e la trasforma in un’energia che è al tempo stesso anti-moderna e neo-moderna. «Noi saremo grandi anche senza passare con un ritardo di tre secoli attraverso la Riforma: saremo grandi anzi unicamente contro la Riforma. La nuova potenza dello spirito italiano che già si manifesta per chiari segni non potrà essere se non antieuropea».
Sul corpo delle donne
Malaparte è ben consapevole - come lo erano stati i futuristi - del fatto che la modernità che il fascismo afferma è fondata sulla rimozione della femminilità. Il fascismo è sessualità che aborrisce e teme la sensualità. «Soffrire è necessario per vivere. La gloria e la libertà costano sangue, e soffrire bisogna per vivere con superbia e dignità fra superbi. Chi non riconosce questa verità fondamentale della vita umana si condanna alla bestialità. Chi predica l’odio alla sofferenza, chi predica alegge del paradiso e non quella dell’inferno (i socialisti) nega tutto ciò che di grande ha in sé un uomo, cioè tutto quello che un uomo ha in sé di umano. Un’umanità epicurea, paradisiaca, è anticristiana e antiumana» (Malaparte, L’Europa vivente).
La femminilità dell’autopercezione italiana è in gioco, nel caso di Mussolini come nel caso di Berlusconi. Mussolini e i giovani futuristi del 1909 volevano sottomettere disprezzandolo il corpo della donna (e il corpo sociale in quanto sottomesso e femminile). Berlusconi e la classe di lunpen che lo circonda vuole sporcare il corpo della donna, sottometterlo all’autodisprezzo cinico, sentimento prevalente e vincente della classe dirigente del semiocapitalismo barocco.
Le regole che i legalisti rivendicano sono decaduti nella cultura e nel lavoro. Occorre liberare la società dal legalismo, perché la società cominci a non rispettare le regole del semiocapitale, a essere autonoma nella post-legalità che il Semiocapitale ha istituito. Ciò che occorre alla società è la forza per non rispettare le regole non scritte che il capitalismo ha imposto, e per affermare un altro modo di vita, una nuova solidarietà del lavoro. Allora, nel campo senza regole del semiocapitalismo, la società potrà affermare i suoi bisogni e soprattutto le sue potenzialità. Difendere la legge diviene un lavoro risibile, quando il potere dichiara ogni giorno nei fatti che quelle regole non contano più niente. Solo a partire dall’abbandono di ogni illusione legalista sarà possible creare autonomia sociale, essere all’altezza (o se si preferisce alla bassezza) della sfida che il semiocapitale ha lanciato.
-
-
-
> PERVERSIONI ---- Da Dioniso a Jackson così il transessuale moltiplica l’identità (di Umberto Galimberti).26 ottobre 2009, di Federico La Sala
 Miti e personaggi
Miti e personaggi Da Dioniso a Jackson così il transessuale moltiplica l’identità
Da Dioniso a Jackson così il transessuale moltiplica l’identità Se questo è l’uomo nuovo che stiamo creando, si tratta della più grave di tutte le regressioni
Se questo è l’uomo nuovo che stiamo creando, si tratta della più grave di tutte le regressioni
 Bisessuali erano le divinità egiziane e greche, perchè il dio rappresenta l’unità primordiale
Bisessuali erano le divinità egiziane e greche, perchè il dio rappresenta l’unità primordiale di Umberto Galimberti (la Repubblica, 26.10.2009)
di Umberto Galimberti (la Repubblica, 26.10.2009)Più o meno tutti sappiamo che nessuno è "per natura" relegato in un sesso. Oggi, sia la biologia sia la psicologia ci dicono che attività e passività sono iscritte nel corpo di ogni individuo e non come termine assoluto legato a un determinato organo sessuale. Ma questa ambivalenza sessuale profonda deve essere ridotta, perché altrimenti sfuggirebbe all’organizzazione genitale e all’ordine sociale. Tutto il lavoro della cultura ha cercato, dall’origine dei tempi, di dissolvere questa realtà irriducibile, per ricondurla alla grande distinzione del "maschile" e del "femminile", intesi come due sessi pieni, assolutamente distinti e opposti l’uno all’altro.
Bisessuali erano le divinità indiane Dyaus e Parusa, egiziane come il dio Bes, greche come Dioniso, Attis, Adone. A differenza dell’uomo, infatti, il dio rappresenta quell’unità primordiale di cui la bi-sessualità è un’espressione. L’unità degli opposti è il suo tratto distintivo che gli umani collocano nel "sacro" (che in sanscrito vuol dire "separato"), da cui gli uomini sono attratti e al tempo stesso si tengono distanti, perché la confusione dei codici non consente la creazione di una società ordinata.
Questa differenza è ben segnalata da Eraclito che in proposito scrive: «Il dio è giorno e notte, inverno e estate, sazietà e fame, guerra e pace, e si mescola a tutte le cose assumendo di volta in volta il loro aroma». «L’uomo invece ritiene giusta una cosa e ingiusta un’altra e non si confonde con tutte le cose». L’indifferenziato è tratto divino da cui l’umano si separa instaurando le differenze che, sole, consentono un ordinato vivere sociale. Di questa evoluzione Platone ce ne dà in proposito una bellissima descrizione nel Simposio.
Da questo punto di vista non possiamo escludere che il transessuale con la sua con-fusione dei codici sessuali, possa costituire un richiamo archetipico a questa unità originaria segretamente custodita nel fondo della nostra natura, e opportunamente rimossa per costruire identità il più possibile definite in cui riconoscersi. Ma oggi abitiamo l’età della tecnica, dove la realtà tende sempre meno a ospitare l’antica differenza tra "natura" e "artificio", perché quando il mondo che abitiamo è il prodotto della nostra costruzione, solo un ritardo linguistico, può chiamare le scene del mondo che abitiamo "artificiali", tenendole distinte da quelle "naturali".
La "natura" e in particolare la "natura umana" hanno cessato da tempo di avere un contenuto preciso, e quindi di valere come referente e come limite. E il corpo del transessuale, prima di essere una deviazione dalla norma, è una conferma della caduta di questo referente. Ma là dove non c’è referente, dilaga la confusione dei codici, dove non è più ravvisabile un limite, una norma, un orizzonte, una misura, un’identità da salvaguardare, differenze da mantenere, per orientarsi in quell’universo di segni che l’immutabilità della natura rendeva possibili discernere e che l’avvento della tecnica, dal modo di nascere al modo di morire, dal modo di essere uomo o donna, persino dal modo di apparire giovani da vecchi, via via cancella, rendendo indiscernibili le differenze, le stagioni della vita umana, e quindi anche le identità sessuali.
Perché l’androginia di Madonna negli anni Ottanta e la più recente androginia di Michael Jackson hanno attratto così tanti fans? Solo per la loro musica o anche per l’oltrepassamento dell’identità sessuale che, a parere di Jean Baudrillard «accompagna l’oltrepassamento dell’identità politica, per cui è solo per una finzione che si continua a distinguere una destra o una sinistra, quando in verità lo specchio più fedele è la mutazione in atto che ha fatto del politico un transpolitico e del sessuale un transessuale?».
«L’uomo è un animale non ancora stabilizzato», diceva Nietzsche, e Pascal dal canto suo: «L’uomo supera infinitamente l’uomo». Nessuna obiezione quando il contesto era il mondo dello spirito, ma oggi tutto questo è diventato "corpo" e "carne". Per questo il transessuale ci inquieta, per questo lo teniamo ai margini e ai bordi.
Ma la città è già assediata e attraversata da quella direzione e da quel senso che il transessuale indica con il suo stesso corpo: l’abolizione di ogni misura, di ogni limite, di ogni identità, e il progressivo avanzare dell’indifferenziato, da cui l’umanità, temendolo, si era distanziata, relegandolo nel mondo del sacro e del divino, a cui offriva sacrifici, non tanto per propiziarsi i favori degli dèi, quanto per tenerli lontani. Quando Dioniso entra nella città, ci racconta Euripide nelle Baccanti, tutto l’ordine viene sconvolto e ogni misura oltrepassata.
Moltiplicando i segni sessuali, il transessuale moltiplica i giochi, smantella il sesso come primo segno di identità per offrirlo come eccedenza di possibilità, e così configura quella nuova nozione di "individuo", tipico del nostro tempo, che si riconosce solo nella libertà illimitata, senza argini, senza confini, per poi finire col naufragare in quell’indifferenziato che gli uomini hanno immaginato all’origine del mondo, e da cui si sono distanziati per costruire il loro mondo, fatto di volti riconoscibili, per non implodere nella confusione dei codici e dei segni. Se questo è lo scenario, se questo è l’uomo nuovo che stiamo creando, la regressione implicita in questa creazione è la più grave di tutte le regressioni.
-
> CRISTIANESIMO, CATTOLICESIMO, E RIVOLUZIONE SESSUALE. Cosa ne è delle donne ai tempi del Cavaliere (di Michela Marzano) e "l’irrisolto lascito della rivoluzione sessuale (di Francesco D’Agostino).3 agosto 2009, di Federico La Sala
LA POLEMICA
Cosa ne è delle donne ai tempi del Cavaliere
di MICHELA MARZANO *
CENE, balli, barzellette, "ragazze-immagine" in abiti neri e trucco leggero, bellissime escort i cui volti si sovrappongono fino a sfumare l’uno nell’altro... No, non si tratta del copione di un film di serie B, ma di un rituale che, in questi ultimi anni, si è banalizzato in Italia, ripetendosi in modo ossessivo nel cuore stesso del potere, a Palazzo Grazioli come a Villa Certosa, eco di un mondo in cui le donne non sono più che delle controfigure sbiadite.
"Casting", "fashion", "book": le donne, ormai, nell’Italia di Berlusconi, non sembrano più contare per quello che fanno o sanno fare, per le loro competenze professionali, per la loro preparazione o per la loro storia (dolorosa, a volte; difficile, sempre), ma per il ruolo che giocano, per come appaiono, per ciò che non esprimono. Le donne sono sempre più corpi e volti ritoccati per sottomettersi tutti ad un’unica ingiunzione: sii bella e seducimi! "Io sono una bambola" afferma con fierezza una show girl alla televisione, credendo così di essere irresistibile. "Le donne belle vanno sempre con gli uomini ricchi e potenti", sembra confermare Vittorio Sgarbi in una recente intervista telefonica tirando fuori la carta ormai usata e abusata dell’apologia dell’italiano "scopatore". Ma cosa dicono questi corpi sottomessi (alle diete, alla chirurgia plastica, allo sport, allo sguardo dell’uomo), il cui volto rifatto ha ormai perso ogni segno di singolarità e di vulnerabilità? Che tipo di relazione con l’altro possono stabilire? Si può ancora parlare di relazione e di desiderio quando l’alterità (l’irriducibile alterità dell’altro, come direbbe Levinas) scompare sotto la maschera di un oggetto di piacere e di pulsione intercambiabile? Quale donna si rivolgerebbe oggi al truccatore che vuole nasconderle le occhiaie come fece Anna Magnani, che "ci aveva messo degli anni per farsele e non voleva nasconderle"?
"Ad un volto", scriveva Deleuze, "possiamo porre due generi di domande, a seconda delle circostanze: a cosa pensi? Oppure: cosa ti succede, che cos’hai, che cosa senti o che cosa provi?". È attraverso il viso che ognuno di noi può esprimere la propria singolarità e la propria specificità: un viso non è mai "un" viso in generale, ma sempre "il" viso di qualcuno che porta su di sé i segni del tempo che passa, delle emozioni vissute, dei dolori, delle gioie. Cosa accade allora quando "il" viso diventa "un" viso, uno qualsiasi tra i tanti, conforme alle norme in vigore, ma inespressivo: un "volto angelico" di una ragazza, il cui nome può essere Noemi, ma anche Roberta, Barbara, Patrizia, Lucia? Perché in fondo poco importano nome e viso di queste ragazze. Si tratta quasi sempre di giovani donne sorridenti e sognanti. E quando non sono più tanto giovani, tutte continuano a avere le labbra formose, il naso rifatto, le rughe cancellate, l’abito nero, il trucco leggero... per continuare a occupare la scena di una vetrina luccicante, per non smettere mai di sedurre i maschi, per incarnare l’immagine della donna perfetta che continua a guardarsi nello specchio deformante del piacere virile.
Perché allora così poche persone insorgono contro questa mascherata tutta italiana che da anni cancella "il" viso delle donne, per ridurle al ruolo subalterno e umiliante della semplice comparsa teatrale, come se, per continuare a esistere, le donne fossero ormai costrette a interpretare sempre lo stesso personaggio? Perché tante donne credono che il solo modo per emergere dalla massa informe dell’anonimato sia quello di ridursi a oggetti di pulsioni, contemplate per il corpo-feticcio che incarnano, e ridicolizzate - senza per questo scomporsi - per la loro incompetenza professionale davanti alla telecamera?
Non si tratta di criticare le scelte personali di alcune donne. In fondo, ogni persona è libera di fare quello che vuole della propria vita. Perché non diventare una velina? La questione, qui, riguarda la libertà. Quale libertà resta oggi alle donne in un paese in cui il potere in carica propone loro un modello unico di riuscita e di comportamento? Quale libertà resta quando si fa loro credere che il desiderio non sia altro che pulsione? Il desiderio, che è il sale della vita, e che spinge ognuno di noi ad andare verso l’altro, non può ridursi alla voglia frenetica di "consumare" corpi seducenti e impeccabili; il desiderio emerge e si sviluppa solo quando l’altro, l’oggetto del nostro desiderio, resta giustamente "altro": colui o colei che è ciò che io non sono, che ha ciò che io non ho e che, nonostante tutto, al di là della seduzione e dei rapporti sessuali, rimane irraggiungibile. A differenza di un pezzo di pane o di un bicchiere d’acqua che si consumano quando si ha fame o sete, la donna non è un semplice oggetto che può essere consumato a proprio piacimento. E non per ragioni morali (la "moralina", direbbe Nietzsche). Ma perché, molto più semplicemente, in ogni relazione umana c’è un "resto", qualcosa dell’altro che non si può distruggere perché l’altra persona sfugge sempre alla "presa" e, in quanto persona, resiste alla volontà dell’altro di assimilarla a sé. È in questo "resto" che risiede la sua specificità e la sua umanità. Un volto che dice "no" e che si oppone all’onnipotenza del potere, della ricchezza, della violenza. Solo nei film pornografici il volto scompare e non esprime più nulla, producendo un sistema nel quale gli uomini e le donne non sono altro che due polarità complementari: l’attività e la passività, il potere e la disponibilità. Tutto si riduce a ripetizione, accumulazione e moltiplicazione: la ripetizione ossessiva degli stessi gesti; l’accumulazione delle donne come trofei di caccia; la moltiplicazione delle conquiste... Fino a che non emerge un mondo in cui, guardando o essendo guardati, tutti restano intrappolati nella ripetizione di un atto che simula il sesso senza più nessun riferimento all’incontro sessuale, come mostra magistralmente Kubrick nella scena dell’orgia del suo ultimo film, Eyes Wide Shut. Un mondo che, in fondo, altro non è che il vecchio sistema patriarcale in cui gli uomini amano delle donne che non desiderano e desiderano delle donne che non amano, come diceva Freud, e in cui le donne sono costrette a scegliere a quale gruppo appartenere: le "madonne" o le "puttane".
Con il 1968 e la rivoluzione sessuale degli anni Settanta, questo sistema era stato rimesso in discussione: la libertà per le donne di disporre finalmente del proprio corpo aveva come finalità principale il raggiungimento di un’uguaglianza a livello di diritti che doveva permettere a tutti di diventare soggetti della propria vita. Uomini e donne uguali. Uomini e donne capaci di costruire la propria vita, di lottare per affermarsi, di mostrare il proprio valore e le proprie competenze. Che cosa resta, nell’Italia di oggi, di questa rivoluzione? Che messaggio dà alle adolescenti di oggi un paese il cui presidente del consiglio è fiero del proprio machismo? Un paese in cui un personaggio pubblico celebre può dichiarare senza vergogna che "chi scopa bene, governa bene"? Guardando quello che accade negli altri paesi europei, l’Italia "liberista e moderna" sfigura, presentandosi come l’emblema stesso del ritorno all’atavico machismo dei paesi mediterranei. È questo che stupisce e scoraggia quando ci si rende conto che l’unico modello femminile valorizzato oggi in Italia è quello della bambola impeccabile la cui sola preoccupazione è l’immagine del proprio corpo e la seduzione maschile. Non perché non ci si debba occupare del proprio corpo, ma perché quando il corpo non è altro che un oggetto di consumo, la donna perde la possibilità di esprimersi indipendentemente dallo sguardo degli uomini.
Facciamo, allora, in modo che il ventunesimo secolo, col pretesto di essere "alla moda", non sia la tomba di tutte le conquiste femminili del secolo scorso.
* la Repubblica, 30 luglio 2009
DIBATTITOL’irrosolto lascito della rivoluzione sessuale
di Francesco D’AGOSTINO (Avvenire, 1 Agosto 2009)
Condivido tutte le preoccupazioni di Michela Marzano sulla sorte delle donne «ai tempi del Cavaliere» (la Repubblica del 30 luglio): nel contesto del sistema mediatico e culturale oggi dominante, esse si sentono sempre più umiliate, vedendo il loro corpo ridotto a oggetto di consumo e avvertendo la crescente impossibilità di "esprimersi" indipendentemente dallo sguardo degli uomini.
Il dissenso dalla Marzano comincia subito, però, quando essa individua nel 1968 e soprattutto nella rivoluzione sessuale degli anni Settanta un momento di svolta, che avrebbe consentito alle donne di «disporre finalmente del proprio corpo» e a tutti (uomini e donne!) di lottare per costruire secondo libertà la propria vita.
Ancora una volta il 1968 e gli anni Settanta vengono indebitamente mitizzati. Nessuno vuole negare il rilievo sociologico di quegli anni, ma continuare ad attribuire loro il merito di aver (per la prima volta!) messo in discussione il «vecchio sistema patriarcale» che avrebbe governato per millenni il rapporto tra i sessi è profondamente mistificante. Riconosciamo almeno che è dall’avvento del cristianesimo che uomini e donne sono considerati assolutamente pari in dignità e in diritti (nel matrimonio cristiano non c’è differenza tra il rilievo conferito al consenso coniugale dello sposo rispetto a quello della sposa) e che tutte le battaglie per attualizzare questo principio epocale (evangelico nel suo fondamento, ma laicissimo nella sua sostanza) hanno avuto successo solo quando pensate, lette, attivate all’interno della tradizione cristiana e non contro di essa. L’errore del 1968 e degli anni Settanta fu appunto quello di coniugare la "liberazione" della donna a diverse varianti del marxismo e comunque a un materialismo programmatico; e se oggi ci interroghiamo, come giustamente fa la Marzano, su cosa resti di quella "rivoluzione" (per concludere che ne resta ben poco, anzi pochissimo) la ragione consiste probabilmente proprio nella sua velleitarietà antireligiosa.
Posso provare quanto ho appena detto? Ma la prova migliore ce la dà, senza rendersene conto, la stessa Marzano, nel corso delle sue stesse riflessioni, quando mette le mani avanti per prevenire possibili e imbarazzanti critiche dei nostalgici del ’68. «Non si tratta di criticare le scelte personali di alcune donne... - essa scrive - in fondo ogni persona è libera di fare quello che vuole della propria vita». Sarà vero per l’ideologia sessantottina, ma non è vero, non è così, sul piano etico e culturale, che è quello su cui intelligentemente si muove la Marzano (sul piano giuridico, è ovvio che, finché non si danneggiano gli altri, ogni persona è libera di fare ciò che vuole della propria vita: ma qui non stiamo utilizzando le fredde categorie del diritto, ma le calde, caldissime categorie della morale).
Non ci sarà mai liberazione per le donne (e, simmetricamente, per gli uomini) finché si continuerà a pensare che la vita individuale sia moralmente insindacabile, perché insindacabile sarebbe la stessa libertà. La libertà è invece sindacabile, anzi sindacabilissima, quando si allontana dal bene. La libertà per le donne (come per gli uomini) consiste in primo luogo nell’offrirsi allo sguardo degli altri come «persone» e non come «corpi», come persone chiamate a scegliere se svolgere «funzioni» umanizzanti (familiari e sociali), o disumanizzanti (come quella delle veline o delle escort).
Il problema è tutto qui: la rivoluzione sessuale degli anni Settanta, scuotendo alle radici le società occidentali e spezzando il vincolo antropologico essenziale che unisce sessualità e persona, non ha risolto i problemi che intendeva risolvere (e questo spiega le giustificate angosce della Marzano) ed ha anzi creato problemi nuovi, di cui ancora si fatica a prendere coscienza. Questo è il problema.
Francesco D’Agostino
-
> CRISTIANESIMO, CATTOLICESIMO, E RIVOLUZIONE SESSUALE. --- Le donne e la libertà ai tempi del Cavaliere (di Miriam Mafai).4 agosto 2009, di Federico La Sala
Le donne e la libertà ai tempi del Cavaliere
di MIRIAM MAFAI *
E se tutto questo scialo di donne, convocate a Roma da uno spregiudicato affarista di Bari, e messe a disposizione del nostro presidente del Consiglio, avesse provocato, non la simpatia, l’invidia e il consenso di cui parlano i suoi più fedeli collaboratori, ma, soprattutto tra le donne, irritazione, e persino un po’ di vergogna?
E non è possibile che sia stato proprio questo sentimento di una parte dell’elettorato femminile ad aver provocato un sia pur tardivo atteggiamento di critica da parte della stampa e delle gerarchie cattoliche?
Una velina, una escort, una prostituta è una donna che dispone del suo corpo come crede. O come può. Il mestiere più antico del mondo, si diceva una volta. Esercitato in modi diversi, con maggiore o minore eleganza, riservatezza e sobrietà. Un mestiere che si sceglie o al quale si può forse essere costrette. Ma non è lecito pensare che siccome esistono le veline, tutte le donne italiane sarebbero classificabili come aspiranti veline. E la prova di questa latente aspirazione starebbe nel fatto che le donne italiane, giovani e meno giovani, dedicano ormai una cura ossessiva al proprio corpo, sperando di farne strumento non solo di piacere ma anche, se possibile, di guadagno e di successo.
Ha ragione Michela Marzano quando, su queste pagine, qualche giorno fa, denunciava il fatto che questo sia l’unico modello di riuscita e di comportamento che il potere in carica oggi propone alle donne. E’ questo, nei fatti, il modello vincente insistentemente proposto alle donne dalla nostra tv. Donne esibite come merce, donne spogliate, donne in vendita offerte al miglior acquirente: una proposta umiliante che non viene avanzata solo dalla tv berlusconiana, ma anche purtroppo da quella pubblica.
Ma le donne italiane sono davvero tutte, o nella loro maggioranza, disponibili a questa subalternità al desiderio maschile? Io non lo credo. Penso, al contrario, che in maggioranza le donne italiane stiano da tempo perseguendo un’altra strada. Quella della propria realizzazione come individui liberi e responsabili, attraverso una faticosa combinazione tra studio, organizzazione della vita familiare, maternità e lavoro. E questo mi pare il senso dell’interpellanza su Berlusconi presentata la scorsa settimana in Parlamento dalle donne e dalle ex ministre del Pd. E questo mi pare anche il messaggio di quelle 15 mila donne italiane che hanno firmato l’appello della professoressa Chiara Volpato: "il comportamento del premier offende le donne".
Il 1968 ci perseguita. É sempre a quella data che facciamo riferimento per ricordarne le conquiste o lamentarne le sconfitte e le delusioni. Quello che si è convenuto chiamare il 1968 è un processo lungo e tumultuoso che nel nostro paese è durato almeno dieci anni. Ci stanno dentro le occupazioni delle Università e l’autunno caldo operaio, la legge sul divorzio (e il successivo referendum) e lo Statuto dei Lavoratori, il nuovo diritto di famiglia e la legge sull’aborto, la chiusura dei manicomi e la riforma sanitaria, Piazza Fontana e il delitto Moro. Quello che chiamiamo il 1968 è uno spartiacque. C’è un prima e un dopo. E oggi, a distanza di quarant’anni molti di noi continuano a misurarsi con quelle speranze, quei successi e le successive delusioni.
Cosa ne è, si chiede Michela Marzano (che all’epoca, beata lei, non era nemmeno nata) della rivoluzione sessuale di quegli anni, che dava finalmente alle donne la libertà di disporre del proprio corpo, che prometteva a tutti di diventare autonomi soggetti della propria vita? Cosa ne è, di tutto questo, "ai tempi del cavaliere" in un paese in cui il presidente del Consiglio può dichiarare, senza vergogna, che "chi scopa bene governa bene"?
Tutto questo, le veline e le escort, le Noemi Letizia e le Patrizie D’Addario, le feste a Villa Certosa e a Palazzo Grazioli, le barzellette da trivio e le volgarità di Berlusconi ("un uomo che non sta bene" come lo ha definito, correttamente e sobriamente, la moglie Veronica Lario), tutto questo rappresenta senza dubbio un pezzo, il più sgradevole e avvilente del nostro paese, ma non può essere assunto a simbolo dell’Italia, del nostro costume, delle aspirazioni, delle ambizioni, dello stile di vita delle donne italiane di oggi. Al contrario: sono convinta che il femminismo o comunque si voglia chiamarlo, quel movimento cioè che rivendicava la fine di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne, la uguaglianza di diritti e la possibilità, quel movimento nel corso degli anni ha certamente cambiato faccia, stile, modo di esprimersi ma ha messo radici profonde nella nostra cultura e nella nostra vita quotidiana. La rivoluzione femminista, nata negli anni lontani che chiamiamo " il 68", resa possibile anche dal processo di secolarizzazione che allora percorse il nostro paese (coinvolgendo una parte notevole del mondo cattolico), quella rivoluzione si scontrerà negli anni successivi con movimenti e culture che ne tenteranno un ridimensionamento. Parlo di movimenti e culture che esaltano la violenza e il successo, comunque conseguito, che irridono ai deboli o ai meno dotati, e che tentano di riportare la donna a un ruolo subalterno contestandone il diritto alla propria autonoma capacità di decisione anche nel campo delicatissimo della procreazione. (Basti ricordare la vicenda della legge sulla fecondazione assistita, i ripetuti tentativi di rivedere la legge 194, e, in questi giorni la posizione del Vaticano sulla pillola Ru487 e la relativa minaccia di scomunica rivolta ai medici che dovessero prescriverla).
La libertà della donna è certamente a rischio. Ma resta tuttora un elemento fondante della nostra società. Ormai padrone del proprio corpo, le donne se ne possono servire, se vogliono, per fare le veline o per fare carriera, ma anche per scegliere se e come e quando fare un figlio, o per vincere una gara sportiva come le nostre splendide Federica Pellegrini e Alessia Filippi. Si possono servire dalla loro intelligenza per affrontare percorsi di studio e ricerca sempre più complessi, per dare la scalata a posti di sempre maggiore responsabilità. Il fatto è che, purtroppo, non ci vengono mai proposte come modello. Tutti conosciamo la faccia di Patrizia D’Addario. Ma nessuna tv ci propone la faccia di Cristina Battaglia, a 35 anni vicepresidente dell’Enea, o quella di Amalia Ercoli Finzi che al Politecnico di Milano insegna come volare nello spazio, o quella di Sandra Bavaglio, giovane astronoma cui Time ha già dedicato una copertina.
Insomma, il 1968, la sua cultura dell’uguaglianza e dei diritti è ancora tra noi. Quali che siano i messaggi che ci invia una tv sempre più volgare o quelli proposti dal patetico machismo del nostro presidente del Consiglio.
* la Repubblica, 4 agosto 2009
-
-
> PERVERSIONI di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- Polonia, un kamasutra cattolico con la "benedizione" della Chiesa (di Enrico Franceschini).15 maggio 2009, di Federico La Sala
Grande successo per il libro di un frate francescano sulle gioie del sesso "Mostratevi amore in ogni modo": ma è solo per coppie sposate e senza contraccezione
 Polonia, un kamasutra cattolico
Polonia, un kamasutra cattolico
 con la "benedizione" della Chiesa
con la "benedizione" della Chiesa dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI *LONDRA - Sesso, amore e fede. E’ una sorta di nuova santissima trinità, quella celebrata da un libro che è diventato rapidamente un best-seller in Polonia e sta per essere tradotto in mezza dozzina di lingue, compreso l’inglese e l’italiano: "Seks", ovvero sesso, sta scritto a caratteri cubitali in copertina, e nel sottotitolo, molto più in piccolo, "per le coppie sposate che amano Dio". Il Guardian di Londra ne parla oggi in prima pagina descrivendolo come un "kamasutra cattolico": già, perché l’autore è un frate francescano polacco, padre Ksawery Knotz, che prega e lavora in un monastero vicino a Cracovia.
Un manuale di sesso scritto da un sacerdote cattolico sarebbe già abbastanza sorprendente, ma ancora più sorprendenti sono le istruzioni che il frate dà alle coppie. Chi pensasse che il suo libro suggerisce di limitarsi alla posizione "del missionario" e a considerare il coito un esercizio unicamente diretto alla riproduzione della specie, resterebbe deluso, osserva il Guardian. Padre Knotz, al contrario, consiglia di prendere il sesso con allegria e di farlo, per così dire, in tutte le salse. "Ogni atto, un certo tipo di carezze, una certa posizione sessuale, fatto allo scopo di suscitare eccitazione, è permesso e fa piacere al Signore", scrive il frate. "Durante un rapporto sessuale, le coppie sposate possono mostrare il loro amore in qualsiasi modo, possono scambiarsi le carezze più ardite, possono fare ricorso a stimolazioni orali e manuali".
Il libro, che ha ricevuto la benedizione ossia l’approvazione della chiesa cattolica polacca, nota per il suo conservatorismo, segue l’ortodossia tradizionale in altro ambito: si rivolge esclusivamente alle coppie sposate, come se il sesso non potesse esistere fuori dal matrimonio, e scoraggia l’uso di qualunque genere di contraccettivi, "perché possono condurre una coppia fuori dalla cultura cattolica e verso uno stile di vita completamente differente". Ma a parte questo, una volta che l’unione è santificata dal sacramento del matrimonio, sotto le lenzuola tutto è permesso. "Alcune persone credono che il sesso nella vita matrimoniale debba essere privo di gioia, di frivola giocosità, di fantasia e di posizioni eccitanti. Pensano che debba essere triste come un tradizionale inno religioso", afferma padre Knotz nel suo libro. "Fanno fatica a capire che Dio è interessato anche alla felicità della loro vita sessuale, e che anche così ha dato loro un suo dono".
Sebbene il manuale del "kamasutra cattolico" abbia già avuto numerose ristampe in Polonia, e sia in procinto di essere tradotto in slovacco, italiano, inglese e altre lingue, qualcuno si domanda dove abbia messo insieme un’esperienza in fatto di sesso il suo autore, che come frate cattolico ha fatto voto di celibato.
Padre Knotz ammette che le sue informazioni in materia sono "di seconda mano", ma aggiunge che gli hanno dato lo stesso un’ampia conoscenza della materia. "Parlo con un sacco di coppie sposate, li ascolto, e cerco di aiutarli a essere più contenti della loro vita sessuale, a capire che il sesso nel matrimonio non deve avere sensi di colpa o provocare tensioni", spiega. Il successo è tale che, oltre al libro, ha aperto un sito internet dove dispensa i suoi insegnamenti in fatto di sesso ai devoti. A patto che siano sposati, naturalmente.
* la Repubblica, 15 maggio 2009
-
> PERVERSIONI di Sergio Benvenuto. UN CORAGGIOSO PASSO AL DI LA’ DELL’EDIPO ---- Una storia delle perversioni. Elisabeth Roudinesco parla del suo saggio su "la parte oscura di noi stessi".27 novembre 2008, di Maria Paola Falqui
Una storia delle perversioni
Elisabeth Roudinesco parla del suo saggio su "la parte oscura di noi stessi"
Il piacere del male, così nasce la perversione
"Il pedofilo ci fa orrore anche perché mai come oggi la società valorizza l’infanzia A differenza del serial killer che ripugna ma affascina"
"Spesso i mistici sono stati protagonisti di radicali degenerazioni passando dalle vette del sublime agli abissi dell’abiezione"
di Fabio Gambino (la Repubblica, 27.11.08)
PARIGI. «La perversione è lo specchio dei nostri desideri più inconfessabili. Per questo ci fa paura». La psicanalista e storica Elisabeth Roudinesco non ha dubbi: «Tutti dobbiamo fare i conti con la crudeltà e il piacere del male che agiscono in noi in maniera più o meno latente. Sono pulsioni feroci e assassine che crescendo, con l’educazione, impariamo a tenere a bada e a superare. Ma pur seppellite nel profondo del nostro inconscio, esse continuano a ossessionarci».
La studiosa francese lo scrive in un saggio, La parte oscura di noi stessi (Angelo Colla Editore, pagg.183, euro 18), che cerca di ricostruire la percezione della perversione nella cultura occidentale, dal Medioevo ai giorni nostri. Il libro si presenta come «una storia dei perversi», vale a dire di «coloro che sono stati considerati tali dalle società umane, preoccupate di esorcizzare la loro parte maledetta». Per l’autrice, la perversione, «che ha sempre a che fare con l’idea d’inversione e di rovesciamento», è una realtà variabile, relativa e sfuggente, un «sinonimo di perversità» percepito come «una sorta di negativo della libertà» che si trasforma a seconda delle epoche e delle culture.
«La perversione è una costruzione culturale, perché il piacere del male è un dato specifico dell’umano. In natura, la perversione non esiste», spiega Roudinesco, nota anche in Italia per le sue numerose pubblicazioni, tra cui una celebre biografia di Lacan e un corposo Dictionnaire de la psychanalyse. «Il senso comune considera la perversione come la manifestazione della parte bestiale dell’umano, ma l’animale non si rende conto della propria crudeltà. Si ha perversione solo quando si ha coscienza del male che si procura. Il perverso è responsabile delle proprie azioni e ne gode. Non è un folle incapace d’intendere e di volere. La perversione nasce dalla coscienza della norma ed ha bisogno del linguaggio per esprimersi, come per altro ci ha insegnato Sade. In passato, è stata considerata un atteggiamento contro natura oggi è piuttosto vista come un disturbo dell’identità, una deviazione, uno stato di delinquenza».
Ogni epoca ha costruito le proprie figure della perversione?
«La società ha bisogno di rappresentarsi concretamente la perversione per dare corpo e allontanare le paure legate alla parte oscura che sente dentro di sé. Non è possibile pensare una società senza la dimensione del male. Le figure dei perversi sono il capro espiatorio da additare alla comunità. Sapere che la minaccia alla società non viene da noi, ma da qualcun altro, ci tranquillizza e ci rassicura».
Il serial killer e il pedofilo sono le due figure della perversione che dominano la percezione contemporanea. In passato però ce ne sono state altre...
«Ogni epoca si è creata la sua idea di perversione. I grandi criminali seriali sono considerati perversi fin dal Medioevo. Anche l’omosessualità è stata considerata a lungo una forma di perversione contro natura, come pure la masturbazione infantile e l’isteria femminile. Oggi però la loro percezione è cambiata e nessuno le considera più perversioni. Nella società contemporanea la perversione assoluta è incarnata dal pedofilo. La nostra società ne è ossessionata, considera la pedofilia una perversione assolutamente ingiustificabile. Più dello stupro e dell’omicidio. Da un punto di vista storico, è una novità. Il pedofilo ci fa orrore, a differenza del serial killer che ci ripugna ma ci affascina».
Come si spiega tale evoluzione?
«La nostra società accorda ai bambini uno statuto senza precedenti. Valorizzando come mai in passato l’infanzia, oggi qualsiasi aggressione al corpo infantile ci sembra un gesto orribile. Il bambino non può difendersi, può essere plagiato e non può dare il suo consenso, mentre nella nostra cultura l’idea del consenso è fondamentale. Prima di Freud, i medici condannavano la sessualità dei bambini come perversa. Dopo che il fondatore della psicanalisi ha dimostrato la normalità della sessualità infantile, la società l’ha accettata, ma ha anche sentito il bisogno di proteggerla. Per questi diversi motivi la pedofilia è diventata ai nostri occhi la perversione più intollerabile».
La perversione implica solo la sfera sessuale?
«Naturalmente no. I mistici, ad esempio, sono spesso stati protagonisti di forme di perversione molto radicali. Si pensi alle sofferenze che si sono imposti alcuni santi oggi molto venerati, la mortificazione della carne e la flagellazione per purificare il corpo. I rituali che ai nostri occhi appaiono come vere e proprie perversioni, all’epoca erano considerati un mezzo per avvicinarsi a Dio. Ancora oggi ci sono santoni indiani che digiunano fino a trasformarsi in veri e propri scheletri. I mistici oltretutto possono passare dalle vette del sublime agli abissi dell’abiezione. Si pensi a Gilles de Rais, su cui è stato poi costruito il mito di Barbablù. Fu un grande condottiero, animato dalla ricerca del bene, che seguì in battaglia Giovanna d’Arco. Quando questa venne mandata al rogo accusata di essere una strega perversa, egli precipitò nel pozzo delle proprie pulsioni incontrollabili, mettendosi ad ammazzare bambini. Quando la legge degli uomini s’inverte, trasformando la santa in strega, anche Gilles de Rais rovescia i propri comportamenti, diventando un orco assassino».
Personaggi come Barbablù ci fanno paura però ci affascinano. Come mai?
«L’orrore dei grandi perversi violenti ci ha sempre affascinato, da Barbablù a Jack lo Squartatore, fino ai più recenti serial killer cinematografici con la loro violenza piena di rituali macabri. Questi personaggi ci offrono lo spettacolo di quello che non siamo, ma che potremmo forse essere. Ci fanno paura, ma, assistendo alle loro raccapriccianti azioni, ci liberiamo dalla minaccia indefinita e oscura che sentiamo in noi. E’ un fascino torbido che esiste perché tutti, prima o poi, in un modo o nell’altro, ci siamo confrontati con il male. Tutti nascondiamo in noi una componente perversa».
Altri esempi di perversione?
«Oggi un’altra figura percepita come profondamente perversa è quella del terrorista che schianta il suo aereo sui grattacieli di New York. In lui percepiamo una sorta di godimento del male che sta procurando. In tutt’altro ambito, anche nei casi gravi di anoressia c’è una forma di perversione, dato che in essi si manifesta una sorta di godimento della morte di sé».
Nel suo libro lei evoca anche la perversione politica. Come mai?
«Accanto alla perversione individuale, esiste quella collettiva dei sistemi politici che pervertono le loro finalità. In nome del bene, questi istituiscono il male come legge. Le dittature, i fanatismi religiosi mostrano questa inversione della legge che autorizza il crimine. Il nazismo è stato il sistema che più è sprofondato nella perversione, giustificando perfino il genocidio. Il rovesciamento tra male e bene è stato totale. Anche nelle democrazie contemporanee, in nome della sicurezza, della prevenzione e del controllo, si mettono in atto meccanismi che possono diventare perversi. La società di sorveglianza che pretende di controllare e prevenire tutto è una forma di perversione della democrazia».
-
> PERVERSIONI ---- Commette violenza sessuale e maltrattamenti il marito che costringe la moglie "a subire rapporti sessuali plurimi" anche quando la donna non ne ha assolutamente desiderio.25 giugno 2009, di Federico La Sala
 La Cassazione ribadisce che non esiste un diritto all’amplesso
La Cassazione ribadisce che non esiste un diritto all’amplesso
 e conferma la reclusione del marito a sei anni e quattro mesi
e conferma la reclusione del marito a sei anni e quattro mesi Pretende troppo sesso dalla moglie
Pretende troppo sesso dalla moglie
 condannato per violenza sessuale *
condannato per violenza sessuale *ROMA - Commette violenza sessuale e maltrattamenti il marito che costringe la moglie "a subire rapporti sessuali plurimi" anche quando la donna non ne ha assolutamente desiderio. A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma la condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione per un marito di Novara che pretendeva "prestazioni sessuali" dalla moglie arrivando a minacciarla con un macete.
La terza Sezione penale con la sentenza numero 26.345 ha respinto il ricorso di un marito piemontese, condannato dalla corte d’Appello di Torino nel settembre 2008, sia per aver sottoposto a maltrattamenti la moglie, sia per violenza sessuale per averla costretta a subire rapporti sessuali oltre il desiderio della stessa.
Troppo sesso. Inutilmente il marito ha tentato di alleggerire la sua posizione chiedendo alla Cassazione di derubricare i diversi reati in quello di maltrattementi in famiglia visto che, a suo dire, non può commettere violenza sessuale il marito che chiede alla moglie di avere più rapporti. E in effetti, registra la Suprema Corte, la stessa consorte aveva riferito di intrattenere con il marito rapporti sessuali consenzienti e che talora "le erano richieste prestazioni con frequenza troppo elevata che non gradiva".
Nessun diritto all’amplesso. Piazza Cavour ha ribadito che non esiste all’interno di un rapporto coniugale o paraconiugale un "diritto all’amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale. Inoltre non ha valore discriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore "aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali". La moglie, infatti, per non destare allarme nei figli non si opponeva alle pretese del marito e a gesti muti cercava, inutilmente, di farlo desistere.
* la Repubblica, 25 giugno 2009
-
> PERVERSIONI ---- Bagnasco: nel matrimonio l’aiuto dell’intera società.26 giugno 2009, di Federico La Sala
AI CERCATORI DEL MESSAGGIO EVANGELICO. Una nota sulla "lettera" perduta.
Bagnasco: nel matrimonio l’aiuto dell’intera società
di Luciano Moia (Avvenire, 26 Giugno 2009)
«Nel cuore della coppia e della famiglia fondata sul matrimonio sta la sua vocazione di grembo naturale della vita, di prima scuola di umanità, dove le diverse generazioni imparano ed esercitano ogni giorno il gusto e le virtù del vivere non solo accanto ma, ben di più, insieme nel segno delle diverse sfumature dell’amore: dono e perdono, concretezza e sacrificio, pazienza e quotidianità, gioia e dolore». È un passaggio dell’omelia che il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ha pronunciato ieri sera a Cotronei, nel cuore della Sila crotonese, durante la Messa che ha concluso la seconda giornata del convegno «Insieme verso le nozze. La preparazione al matrimonio cristiano», organizzato dall’Ufficio Cei per la pastorale della famiglia.
«Come credenti - ha proseguito il cardinale Bagnasco - non possiamo non desiderare che i giovani che guardano al matrimonio trovino anche l’aiuto dell’intera società dove vivono». Certo, ha spiegato il presidente della Cei, «le responsabilità sono di ciascuno» ma «conosciamo l’influsso che la cultura diffusa, gli stili di vita, i comportamenti conclamati hanno sul modo di pensare e di agire di tutti, in particolare dei più giovani che hanno il diritto di vedersi presentare ideali alti e nobili, come di vedere modelli di comportamento coerenti».
Poi un riferimento al rapporto fra la comunità ecclesiale e la «realtà umana dell’amore». «Il magistero della Chiesa - ha sottolineato Bagnasco - si è speso senza risparmio nell’approfondire questa realtà tanto decisiva e centrale per la vita dei singoli e della comunità stessa». Anzi, ha ribadito con forza il presidente dei vescovi italiani e arcivescovo di Genova, la Chiesa «ne parla con quel vento di profezia che è particolarmente necessario e urgente nel mondo contemporaneo, nel quale la realtà della coppia, e del matrimonio e della famiglia, ma direi dell’amore nel suo complesso, sembra essere affrontata dalla cultura e dal costume in modo relativistico ed emotivo. Come se il valore oggettivo di certi beni - ha esemplificato il porporato - fosse vecchio e superato, e la ricaduta generale delle scelte personali non esistesse o, quanto meno, fosse irrilevante». Proprio la situazione socio-culturale messa a fuoco dagli esperti che hanno arricchito le prime due giornate del convegno. Punto di partenza dell’incontro - a cui sono presenti oltre 300 delegati diocesani e regionali, soprattutto famiglie con figli - una ricerca messa a punto dallo stesso Ufficio nazionale Cei in collaborazione con il Cisf (Centro internazionale studi famiglia).
Probabilmente il dossier più vasto e dettagliato mai realizzato a livello nazionale su un tema che interroga urgentemente Chiesa e società: i giovani, l’amore, il matrimonio, le convivenze. Il lavoro raccoglie i questionari provenienti dalla quasi totalità delle diocesi italiane (192 su 226). Imponente di conseguenza - secondo quanto hanno spiegato il direttore del Cisf Francesco Belletti e il responsabile documentazione dello stesso istituto, Pietro Boffi - il numero dei percorsi di preparazione al matrimonio passato ai raggi X. Un dossier che permette di indagare meglio la situazione dei fidanzati che arrivano a frequentare i vari percorsi di preparazione. Quasi 4 coppie su 10 (38,5%) hanno più di 30 anni. Ma il 15,5 per cento ha più di 35 anni. E al Nord gli «anziani» sono quasi la metà di tutti coloro che desiderano sposarsi in chiesa.
Altrettanto imponenti, e quindi problematiche, le percentuali delle coppie già conviventi. Al Nord la maggior parte (52%) hanno già alle spalle 3 o 4 anni di vita in comune. Ma al di là delle cifre tutti gli intervenuti, a cominciare dal sociologo Franco Garelli, hanno fatto notare che la convivenza, più che prassi more uxorio, è per la maggior parte dei giovani stile di vita, scelta accettata e considerata ormai del tutto normale. Che fare di fronte a queste situazioni difficili? Quali percorsi proporre? «A volte - ha detto ancora Bagnasco - può sorgere la legittima domanda circa l’effettiva efficacia di questa opportunità per le coppie. Ma a questo interrogativo mi pare risponda la parabola evangelica del piccolo seme». In sostanza, ha messo in luce il presidente della Cei, «si tratta non tanto di interrogarci su quali iniziative particolari siano da inventare e da svolgere nelle nostre comunità, ma soprattutto di curare l’attenzione e l’affetto verso chi si prepara alle nozze e si dispone a creare un nuovo nucleo d’amore».
Sulle implicazioni pastorali delle convivenze si era interrogato mercoledì, in apertura del convegno, anche il vescovo di Aosta Giuseppe Anfossi, presidente della Commissione episcopale Cei per la famiglia e la vita. «Questo fenomeno totalmente nuovo nella storia della Chiesa e della civiltà - aveva detto - mette in evidenza una certa paura, una ricerca di sicurezza da parte dei giovani, ma anche le carenze della comunità cristiana che non sa preparare i giovani all’amore con tutto ciò che esso comporta». Anfossi aveva anche sottolineato la crescente difficoltà di presentare la bellezza del sacramento del matrimonio con un linguaggio comprensibile alla maggior patte dei fidanzati, ma si è anche chiesto quanto sia opportuno sorvolare sugli aspetti morali delle convivenze, come spesso avviene anche da parte degli operatori pastorali, quasi che si tratti di uno stile di vita di fatto approvato anche dalla Chiesa. «Ma cosa dev’essere detto ai conviventi - si è chiesto Anfossi - perché essi diventino, in pienezza e verità, buoni cristiani e buoni sposi?».
Luciano Moia
CRISTIANESIMO, CATTOLICESIMO E BERLUSCONISMO. Don Paolo Farinella, prete di Genova, scrive all’Arcivescovo di Genova e al Presidente della CEI, Mons. Bagnasco. Nessuna risposta, né dall’Uomo né dall’Arcivescovo né dal Presidente della CEI. Che dire?! Chi tace ... "acconsente"!!!
-
> PERVERSIONI ---- IL CATTOLICESIMO E LA POLITICA DELLA CARNE. Il filosofo Fabrice Hadjadj, convertito al cattolicesimo, propone una riflessione sulla "profondità dei sessi".10 settembre 2009, di Federico La Sala
-
-
-