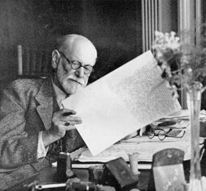
UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! La lezione di Melanie Klein rimeditata da Julia Kristeva, in un commento di Manuela Fraire - a c. di pfls
Amare al cospetto della madre
«Génie féminin». Dopo Colette e Arendt, «Melanie Klein. La madre, la follia» di Julia Kristeva. Relazione d’oggetto. Il matricidio immaginario nella lettura di Kristeva del pensiero kleiniano
di Manuela Fraire (il manifesto, 29.10.2006)
Julia Kristeva, nel libro tratto da una serie di lezioni tenute all’Università Parigi VII (Melanie Klein. La madre, la follia, Donzelli, pp. 291, E 23,50) traccia un profilo inedito della grande psicoanalista centrato sulla metafora del «matricidio» a cui l’autrice assegna un ruolo fondamentale e generativo nell’instaurarsi dello psichismo umano. In francese il titolo è diverso - «Il genio femminile. La follia. Melanie Klein, o del matricidio come dolore e come creatività» -, mentre in italiano il termine matricidio, forse per il suo suono terribile, è stato eliminato.
Del resto preminente è il ruolo che la madre ha nella teoria kleiniana, ruolo invece perlomeno modesto nella teoria di Freud, cosa che ne costituisce l’essenza sia rivoluzionaria che problematica. Il rischio che Klein stessa sottolinea - forte eco del rapporto con la propria madre Libussa - è il blocco della capacità di simbolizzazione nel caso in cui l’attaccamento alla madre arcaica vinca sulla necessità di separarsene affrontando la perdita del primo oggetto d’amore. E’ la perdita, sottolinea Kristeva, che spinge a simbolizzare la cosa perduta.
Tutto, pensiero e lavoro clinico, per Klein si basano - a differenza dal senso comune dell’epoca secondo cui tra madre e neonato vi sarebbe un idillio che in seguito va perduto - sull’ambivalenza che caratterizza l’assoluta dipendenza del piccolo dalla madre fonte di ogni soddisfazione e ogni frustrazione. L’ambivalenza caratterizza dalla nascita il rapporto che l’essere umano instaura con l’ambiente rimanendo sempre in bilico tra riconoscimento dell’altro e rifiuto dell’alterità, la stessa ambivalenza che ha caratterizzato il rapporto di Melanie con uomini e donne, allievi e allieve, figli e figlie nel corso dell’intera vita.
A partire dai rapporti più intimi, e poi nella sua lunga pratica clinica con i bambini, primi fra tutti i propri figli guardati ancora in fasce con occhio «clinico», Klein osserva che ab initio il neonato è animato da violente passioni verso l’oggetto-madre: invece che chiuso nella bolla narcisistica (lo stato anoggettuale di Freud) il neonato avverte la «presenza» dell’altro/madre e con quella inter-agisce. In termini attuali la psiche del neonato kleiniano nasce da subito dentro la relazione. L’atteggiamento di Klein verso la maternità non è né sereno né gioioso, tuttavia è proprio mediante il transfert materno che la psicoanalista cerca di raggiungere la profondità dell’inconscio.
Angoscia legata alla paura di annientamento, e furioso attaccamento accompagnati da invidia, sono la ineludibile condizione del neonato impotente in presenza/al cospetto della madre onnipotente quanto incontrollabile. La percezione precocissima dell’oggetto materno, mette da subito al lavoro una specie di «respirazione psichica» (Guignard) fatta dell’alternanza tra oggetti e situazioni interni e oggetti e situazioni esterni, tra soddisfazione e frustrazione, tra proiezione e introiezione. E Klein precisa «non è l’organismo, ma l’Io, anche se immaturo» che cerca di far fronte alla paura. Quello umano è dunque uno psichismo che si radica e organizza attorno all’esperienza percettiva dell’altro in senso attivo e passivo.
Da qui nasce anche la necessità per l’Io di compiere incessantemente un «lavoro del negativo», espressione dello sforzo di sfuggire all’angoscia primordiale che si attiva nell’esperienza di presenza-assenza dell’altro-madre, avvertita dapprima come presenza non distinta da sé, condizione che genera l’incessante attività, che caratterizza il farsi della vita psichica anche se con toni meno drammatici, del «mettere dentro/buono o sputare fuori/cattivo» . L’immaginario legato al corpo- il dentro-fuori - assume un posto centrale nella concezione dell’apparato psichico di Klein ed è anche uno degli aspetti del suo pensiero che ha maggiormente fecondato la psicoanalisi dopo di lei.
Segretamente ogni donna non perdona alla propria madre la frustrazione che questa le infligge godendo invece che di lei (del suo corpo) del coito con il padre, e che lo nasconde a se stessa e all’altra/altre donne. «Nel marito cercate la madre!» esclama Kristeva sottintendendo che un uomo non perde mai del tutto la madre poiché la ritrova in un’altra donna. Freud intuì la specificità del rapporto madre/figlia nel caso Dora ma troppo tardi.
Pensiero e vita di Klein sono sempre stati «contro-versi», collocati cioé nel verso contrario al senso comune dell’epoca, e forse proprio per questo Melanie, priva di titoli di studio e con lo spirito indomabile della sperimentatrice, ci teneva a essere riconosciuta e accettata dalla comunità psicoanalitica, soprattutto teneva molto a sottolineare la continuità del suo pensiero con quello di Freud. Ma non potè riuscire pienamente nell’intento poiché è stata un’autentica innovatrice, una creatrice di nuove metafore, basti citare «invidia» e «gratitudine», che hanno aperto nuove vie della e alla psicoanalisi, senza le quali oggi sarebbe poco raggiungibile lo stesso Freud. Questo intende Kristeva con il termine «genio» riferito a Klein.
Lo testimoniano d’altra parte l’originalità di Winnicott e Bion, suoi allievi, e l’ispirazione che lo stesso Lacan trasse dalla sua teoria della «relazione d’oggetto». Anche il movimento delle donne è percorso dalla conflittualità che fa risalire al riemergere dell’ambivalenza che ha caratterizzato in passato il rapporto con la madre. Ne riconosce cioé la radice nell’infantile e ne sottolinea un aspetto costitutivo della relazionalità stessa, anche se ha resistito a lungo e ancora permane la tendenza a coprire con l’idealizzazione la conflittualità che caratterizza ogni relazione viva , inclusa quindi quella tra donne, con il rischio di chiudersi in un isolamento schizoide, difesa estrema dal pericolo di scoprire nell’altra donna l’Altro.
Kristeva sembra tagliare la testa al toro quando afferma che «la condizione sine qua non per accedere al simbolo» è sbarazzarsi della madre. Anzi ogni atto veramente creativo testimonia una fantasia riuscita di matricidio, anche se si tratta di «matricidio immaginario», via che secondo Klein e Kristeva bisogna percorrere per giungere alla capacità di simbolizzazione.
E il simbolo da che cosa nasce? «L’impulso a creare simboli - scrive Klein - è così forte perché neanche la madre più amorevole può soddisfare i potenti bisogni emozionali del bambino piccolo». E Kristeva aggiunge: «Lasciate perdere la madre, non ne avete più bisogno: sarebbe questo l’estremo messaggio dei simboli, se potessero spiegare perché esistono». Il matricidio diviene così, nell’interpretazione che Kristeva dà del pensiero di Klein, la chiave di volta del processo di differenziazione, con una propria necessità simmetrica a quella del parricidio, anch’esso del resto immaginario. C’è da chiedersi però se l’uccisione - nella forma del matricidio come in quella del parricidio - non sia una metafora che risente pesantemente di una rappresentazione «patriarcale» della vicenda umana che ha fatto il suo tempo.
Kristeva sottolinea con forza la necessità del «matricidio» sulla scia di uno degli ultimi scritti di Klein (Alcune riflessioni sull’Orestiade, 1960) stabilendo un’antecedenza di ordine mitologico che pone Oreste prima di Edipo. Un paradosso da esplorare che individua nell’uccisione della madre il presupposto per poi accoppiarsi incestuosamente con lei. Un cerchio mortale da cui non si esce, la teoria non ne esce cioè.
Ma se di vita e di morte si deve parlare - e sembra inevitabile quando si tratta delle vicissitudini umane - bisogna riferirsi alla caratteristica specifica dell’essere che è dotato di linguaggio che non solo ha paura della morte ma anche della vita: paura per l’incombere della vita, paura di perdere la vita. Una paura che Klein chiama angoscia e che la cura analitica dovrebbe poter trasformare in dolore: dal panico alla possibilità di pensare.
Il pensiero della differenza compie un salto di cui la psicoanalisi dovrebbe fare tesoro: passa attraverso una fase - immaginaria perché riferita alle donne che si incontrano nella vita reale - che crede di vedere nell’altra donna una «rivale» così potente da doverla uccidere per non essere uccise, ma scommette sulla capacità di «restare al cospetto della madre» senza temere la sua terribile rappresaglia se l’amore, l’investimento, viene spostato su un’altra: su altro. La rivalità tra donne tanto temuta è di marca materna poiché intreccia sempre bisogno e desiderio ed è proprio quest’ultimo che si è cominciato a distaccare dal bisogno di dipendere.
La vera rinuncia riguarda l’insostituibilità della madre, il guadagno è un aumento enorme della capacità di stare in «relazione con»: il desiderio può migrare dalla «madre» a una «donna» e da questa alla «realtà». Questo passaggio ha però bisogno di una madre viva e vitale (ma non è così anche per il padre?). Cosa evoca il matricidio? L’imprigionamento nell’angoscia di annullamento. Ma non è forse nel nome della libertà «immaginare» di separarsi - quanto dolorosamente! - da una madre ancora viva?
- BAMBINE E COMPLESSO DI EDIPO "(...) Come si compie lo sviluppo corrispondente nella bambina? Il nostro materiale diventa qui - incomprensibilmente - molto più oscuro e lacunoso. Anche il sesso femminile sviluppa un complesso edipico, un Super-Io e un’epoca di latenza. Gli si può attribuire anche un’organizzazione fallica e un complesso di evirazione? La risposta è affermativa, ma la situazione non può essere identica a quella del maschio.
 La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
La richiesta femminista di una parità di diritti per i due sessi non può su questi temi andar molto lontano: la differenza morfologica non può non riflettersi in disparità dello sviluppo psichico. Parafrasando un detto di Napoleone, possiamo dire che «l’anatomia è il destino». (...)
 Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
Complessivamente bisogna però riconoscere che le cognizioni da noi acquisite intorno a questo processo evolutivo nella bambina sono insoddisfacenti, lacunose e incerte. (Cfr. S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico", in Opere 1924-1929, vol. X, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 31-33).
- LA NASCITA DELL’ESSERE UMANO E IL GIOCO DEL ROCCHETTO --- LA PSICOANALISI DEI BAMBINI: "JACQUES LACAN E MELANIE KLEIN.UN INCONTRO MANCATO" (di Fabrizio Palombi).
- PENSARE "L’EDIPO COMPLETO": PSICOANALISI, RIVELAZIONE (APOCALISSE), E RINASCIMENTO, OGGI. A MIO PARERE, COLLOCATI COME SIAMO, NELL’ORIZZONTE DI UNA "BIBLICA" CADUTA, NEL "TEMPO FUORI DAI CARDINI" (HAMLET, I.5), POSSIAMO RI-ORIENTARCI E RIPRENDERE IL CAMMINO, CON DANTE ALIGHIERI (E CON LO STESSO SHAKESPEARE): PENSARE DIVERSAMENTE, NELLA LOGICA DEL GIOVANNEO SPIRITO SANTO ("DEUS CHARITAS EST") E DI UNA ANTROPOLOGIA (NON EDIPICA, NON PLATONICA, E NON BACONIANA), E RICONOSCERE (AL DI LA’ DELLA LOGICA TRAGICO-HEGELIANA DEL CATTOLICESIMO DEL "CORPO MISTICO" DEL SIGNORE DI PAOLO DI TARSO E COSTANTINO) IN "GIUSEPPE E MARIA" I "NOSTRI" PROPRI VECCHI GENITORI: "ADAMO ED EVA"; FORSE E’ QUESTA L’UNICA VIA PER USCIRE DALL’INFERNO! (fls).
Sul tema, nel sito e in rete, si cfr.:
A FREUD, GLORIA ETERNA!!! IN DIFESA DELLA PSICOANALISI.
- LA PASSIONE SECONDO TERESA D’AVILA di Julia Kristeva - Festival delle Letterature, 2010)
- L’eletto - Thomas Mann: "Edipo Papa. Il regno di Edipo è di questa terra, ma può diventare anche quello dei cieli. Se allo sconosciuto padre terreno si sostituisce il Padre onnipotente che ha bisogno di un grande figlio perché lo rappresenti nel mondo" (Lea Ritter Santini, Introduzione, Oscar Mondadori 1979).
Federico La Sala
Forum
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! --- ANTROPOLOGIA E PSICOANALISI. LE "EQUE NOZZE" DEI SERPENTI, LA CECITA’ DI TIRESIA, E L’INIZIO DELLA TRAGEDIA.24 dicembre 2023, di Federico La Sala
#COSMICOMICHE (#CALVINO100):
LA #QUESTIONE DELLA FINE DELLE "EQUE #NOZZE" DEI #SERPENTI, LA #CECITA’ DI #TIRESIA, E L’INIZIO DELLA #TRAGEDIA.
Il #caduceo di #Ermes, il #segnavia dei "destini incrociati", la via per uscire dall’#inferno epistemologico (antropologico e cosmologico).
- Un omaggio alla #memoria di #DanteAlighieri, di "Sigismondo di Vindobona" (#SigmundFreud) e di "#Santiago" (#ItaloCalvino)
"Vi era, a Tebe, l’indovino Tiresia figlio di Evere e della ninfa Cariclo, della stirpe di Udeo, uno degli Sparti. Era cieco: della sua cecità e della sua arte profetica si danno versioni diverse. Alcuni dicono che fu accecato dagli dèi perché rivelava agli uomini cose che essi volevano tenere segrete. Ferecide afferma che fu accecato da Atena; Cariclo era molto cara ad Atena ...
 (Tiresia) vide la dea completamente nuda ed essa gli mise le mani sugli occhi e lo rese cieco. Cariclo la supplicò di restituire la vista a Tiresia, ma la dea non aveva il potere di farlo: allora gli purificò le orecchie in modo che potesse intendere il linguaggio degli uccelli e gli fece dono di un bastone di legno di corniolo, con l’aiuto del quale poteva camminare come coloro che vedevano.
(Tiresia) vide la dea completamente nuda ed essa gli mise le mani sugli occhi e lo rese cieco. Cariclo la supplicò di restituire la vista a Tiresia, ma la dea non aveva il potere di farlo: allora gli purificò le orecchie in modo che potesse intendere il linguaggio degli uccelli e gli fece dono di un bastone di legno di corniolo, con l’aiuto del quale poteva camminare come coloro che vedevano.
 Esiodo invece narra che, nei pressi del monte Cillene, Tiresia vide dei serpenti che si accoppiavano, li ferì e, da uomo, fu mutato in donna; poi di nuovo spiò gli stessi serpenti in amore e ridivenne uomo. Per questo #Era e #Zeus, che discutevano se nei rapporti amorosi provassero maggior piacere le donne oppure gli uomini, interrogarono lui. Egli disse che, se nell’amore la somma del godimento era uguale a diciannove parti, nove spettavano all’uomo, dieci alla donna. Per questo Era lo accecò e Zeus gli fece dono dell’arte mantica."
Esiodo invece narra che, nei pressi del monte Cillene, Tiresia vide dei serpenti che si accoppiavano, li ferì e, da uomo, fu mutato in donna; poi di nuovo spiò gli stessi serpenti in amore e ridivenne uomo. Per questo #Era e #Zeus, che discutevano se nei rapporti amorosi provassero maggior piacere le donne oppure gli uomini, interrogarono lui. Egli disse che, se nell’amore la somma del godimento era uguale a diciannove parti, nove spettavano all’uomo, dieci alla donna. Per questo Era lo accecò e Zeus gli fece dono dell’arte mantica."
 (#Apollodoro, Biblioteca III 6, 7: cfr. APOLLODORO, "I MITI GRECI", A CURA DI PAOLO SCARPI TRADUZIONE DI MARIA GRAZIA CIANI. FONDAZIONE LORENZO VALLA / ARNOLDO MONDADORI EDITORE).
(#Apollodoro, Biblioteca III 6, 7: cfr. APOLLODORO, "I MITI GRECI", A CURA DI PAOLO SCARPI TRADUZIONE DI MARIA GRAZIA CIANI. FONDAZIONE LORENZO VALLA / ARNOLDO MONDADORI EDITORE). -
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Un libro eretico: «La porta delle madri», l’ultimo libro della psicoanalista Manuela Fraire edito da Cronopio (di Caterina Venturini).18 novembre 2023, di Federico La Sala
CULTURA
Dentro la relazione dei corpi, tra pratiche e femminismo
- SCAFFALE. «La porta delle madri», l’ultimo libro della psicoanalista Manuela Fraire edito da Cronopio
di Caterina Venturini (il manifesto, 27 settembre 2023)
- [fOTO] Pablo Picasso, «Femme couché e lisant» (1939)
In un momento in cui il dibattito pubblico del nostro Paese, seguendo una tensione diffusa in Occidente, si è polarizzato su opinioni dogmatiche inconciliabili, soprattutto per quanto riguarda le grandi questioni etico-politiche conseguenti al non più ovvio legame tra madre, materno e femminile, esce un libro che partendo da posizioni consolidate non teme di interrogarne i nodi problematici, dovuti alle contraddizioni dei corpi, del desiderio e delle nostre identità sessuali sempre in mutamento.
In una parola: è appena uscito un libro eretico, La porta delle madri (Cronopio, pp. 146, euro 13) e lo ha scritto una grande psicoanalista femminista, Manuela Fraire, che potendo contare su due esperienze di vita ugualmente dense e importanti, una lunga militanza nel femminismo a partire dai gruppi di autocoscienza degli anni 70, e una professione analitica ricca di decenni, non ha avuto esitazione a unire questi due sguardi, compresenti e inseparabili, della sua vita. Sguardi che da sempre la interrogano sui limiti di alcune posizioni dell’una e dell’altra parte, un ancora eccessivo binarismo della psicoanalisi e il pericolo della desessualizzazione dei corpi in funzione del genere dell’ultimo femminismo, spingendola a scrivere quello che a tutti gli effetti si rivela un pamphlet di intenso ragionamento che non solo intreccia fili ed esperienze, ma rilegge anche i propri interventi del passato alla luce dell’attuale.
GIÀ IN UN CONTRIBUTO del 98, Fraire si opponeva «alla maternità come naturale e auspicabile meta della femminilità» credendo «che una decostruzione del paradigma materno da parte delle donne giocava in favore della libertà sia femminile che maschile». All’epoca non si parlava ancora di Gpa (Gestazione per altri) ma a una certa parte di femminismo, che pure aveva attraversato teorie e pratiche della differenza sessuale, era già chiaro come la procreazione non dovesse avere necessariamente come esito la maternità, e come la donna dovesse disgiungersi dalla madre.
Cosa resta allora di quell’enigma del materno che non può che cominciare con Freud, che nel 1932 scrisse che il dottor Breuer cinquant’anni prima aveva in mano la chiave della porta delle madri, ma la lasciò cadere, facendo intendere che quella chiave avrebbe voluto prenderla in mano lui, eppure - ci mostra Fraire - quella chiave non aprirà la porta delle madri fino al nostro secolo quando il femminismo da una parte, la psicoanalisi postfreudiana dall’altra e le nuove famiglie poi, schiuderanno nuovi scenari. Tramontata la famiglia edipica di madre-padre-figlio, c’è stata una riorganizzazione dei ruoli ancora in atto in cui prevalgono come elementi di novità, famiglie monogenitoriali o con due persone dello stesso sesso o in transizione, o che non hanno scelto nessuno dei due. Di questa genitorialità non binaria, non identificata né con un materno né con un paterno, ha senso occuparsi oggi per farsi domande che superino la questione di genere e tornino a occuparsi dei corpi (tutti) dal punto di vista di un sessuale che viene prima di qualsiasi attribuzione.
Tanto più che risulta ormai chiaro che la pulsione dell’infans proviene dalle fantasie che l’adulto (uomo o donna che sia) immette inconsapevolmente nelle cure primarie: fantasie non più asessuali, come voleva Freud ma che contengono la storia sessuale che l’adulto porta con sé (Laplance).
E allora dov’è la differenza tra madri e padri dal momento che chi viene al mondo riconosce molto presto voci diverse e non è solo in simbiosi con la madre? Piera Aulagnier, sempre citata da Fraire, dice che la nascita psichica di un bambino è frutto dell’incontro tra il discorso che gli/le è indirizzato e l’effetto che questo discorso ha sul suo essere/corpo, portando al centro della questione la reale differenza che è quella tra sessuale animale e sessuale umano: ossia il linguaggio che rende la madre biologica sostituibile.
«MADRI SI DIVENTA - dice Fraire - se lo si desidera, a separazione avvenuta tra feto e gestante: la maternità non è legata al corpo più di quanto non lo sia al linguaggio». Parole molto importanti che arrivano dritte al cuore di una questione in cui l’unica differenza tra maschile e femminile risulta, ancora al momento, nel fatto che solo all’interno del corpo delle donne avviene la creazione del vivente. Non a caso, ricorda Fraire, la più grande rivoluzione le donne l’hanno fatta con la depenalizzazione dell’aborto quando hanno affermato una signoria sul loro desiderio di procreare.
Legittimare questa pratica ha portato alla vera liberazione del loro desiderio di maternità, non più vissuta come un destino. Disgiungere definitivamente il femminile dal materno, ha dato anche agli uomini la possibilità di partecipare attivamente alla cura senza necessariamente la supervisione di una donna. Semmai, avverte Fraire, c’è ancora da capire le conseguenze che avrà sull’uomo un’esperienza che implica la totale dipendenza del, e dall’altro, cosa a cui la donna è allenata da secoli.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?!--- Mondi nuovi mai visti prima: "La porta delle madri" di Manuela Fraire. Mettere in campo il sexuale significa allora salire sulla “navicella spaziale” (di Felice Cimatti -16 novembre 2023, di Federico La Sala
L’ORDINE DEI DISCORSI
Mondi nuovi mai visti prima
La porta delle madri di Manuela Fraire.
di Felice Cimatti (FataMorgana-Web, 16 Settembre 2023)
“Domattina ci metteremo in viaggio per il sud”, dice fra sé e sé Nia, l’aliena del capolavoro di Eleanor Arnason, Sigma Draconis (A Woman of the Iron People, 1991), alla fine dell’avventura che l’ha portata a conoscere gli alieni (che in questo caso sono i terrestri, e in particolare Lixia, l’antropologa della spedizione), sbarcati per la prima volta sul suo pianeta. Nia è una vivente simile agli umani ma ricoperta da una folta pelliccia che appartiene ad una civiltà preindustriale, in cui i ruoli di quelli che sulla Terra sarebbero donne e uomini sono profondamente diversi. Le “donne” di Sigma Draconis vivono infatti insieme nei villaggi con i loro figli, mentre gli “uomini”, vivono da soli nelle immense pianure del pianeta (i giovani “maschi” lasciano i villaggi all’inizio della pubertà).
L’eterosessualità è un tabù che può essere infranto solo durante la breve stagione degli amori. Nel romanzo si allude ad eventuali relazioni omosessuali fra le donne dei villaggi (non a quella maschile), alcune delle quali non sono interessate neanche ad avere figli. Nia, tuttavia, è stata cacciata via dal suo popolo - il popolo del ferro; Nia infatti è un’abile fabbro (fabbra?), su Sigma Draconis un tipico lavoro “femminile” - perché aveva voluto vivere stabilmente con un “uomo”. Dopo la fine tragica di questa relazione vive da sola nelle sconfinate praterie delpianeta. Nia, in sostanza, non vive come il suo popolo, e la sua conformazione fisica, avevano deciso che avrebbe dovuto vivere. Nia è libera.
A questo serve la fantascienza, a immaginare forme di vita diverse da quelle che la nostra mancanza di immaginazione, o la nostra paura, ci impedisce di sperimentare. È questo il punto di contatto fra la fantascienza e la psicoanalisi, almeno la psicoanalisi così come la teorizza e la pratica la femminista e psicoanalista Manuela Fraire: il lavoro psicoanalitico, infatti, «mette fuori gioco l’illusione di una ricostruzione da erigere sui resti del passato, poiché a guidare la navicella spaziale in cui si trovano per un certo tempo paziente e analista è pur sempre il desiderio di incontrare mondi nuovi mai visti prima» (Fraire 2023, p. 75). Non è il passato l’oggetto della psicoanalisi, e quindi il rimosso e il già stato (che per sua natura non cerca altro che di ripetersi), è piuttosto l’invenzione di un futuro non ancora immaginato. Si tratta, come scrivevano Deleuze e Guattari, di produrre nuovo inconscio, ossia nuova impensabile vita.
Ma perché, si chiede Fraire, non riusciamo proprio a vederli (e appunto, nemmeno a immaginarli), questi “mondi nuovi”? Perché non riusciamo a vedere l’aliena Nia - una “donna” pelosa con le mani da fabbro - che virtualmente è in ciascuna di noi? Perché ciascuna di noi è intrappolata, come invece non è Nia, nello schema delle identità e dei ruoli che ogni identità sembra inevitabilmente destinata a portarsi con sé. Fraire, abbiamo detto, è prima di tutto una femminista, e quindi è di Nia che ci stiamo occupando. Ecco perché Fraire ci aiuta a sbrogliare il groviglio di associazioni fra identità e doveri che rende così asfissiante la posizione femminile. Si parte, intanto, dalla differenza fra i sessi: «La differenza sessuale nel discorso del femminismo non è quella della donna dall’uomo ma il quid che li unisce e li separa al di là di ogni complementarità. Se femminile e maschile si spartissero tutte le parti che appartengono all’una o all’altro, non vi sarebbe alcun resto, mentre nella differenza sessuale c’è un resto che per la psicoanalisi è il sessuale» (Fraire 2023, pp. 16-17).
Il sessuale, o per usare la formulazione di Laplanche il sexuale, è il campo della sessualità non riproduttiva, ossia il campo vastissimo della sessualità libera e creativa - «il sessuale infantile perverso e polimorfo che precede le assegnazioni» (ivi, p. 45) identitarie sociali - che non rientra nello strettissimo spazio della sessualità al servizio della riproduzione della specie. Il sexuale è libero. Che succede, si chiede Fraire, se questo campo di virtualità non identitarie viene lasciato libero di sperimentare? Si pensi, ad esempio, alla «opportunità che donne e uomini si stanno dando reciprocamente di fare esperienza di una genitorialità risultato della disgiunzione tra procreazione e maternità [che] apre ad un’impresa comune senza cui è difficile immaginare un futuro della specie» (ivi, p. 37). Perché Nia deve per forza essere madre per avere dei figli? E ancora, perché non poter immaginare un mondo in cui «la maternità non è legata al corpo» (ivi, p. 46)? Già, perché no? O perché non accorgersi (una scoperta che Fraire ricava da tante analisi di donne) «che l’esperienza della gravidanza può essere desiderata come fine a sé stessa» (ivi, p. 47) e non per diventare madre?
E ancora, perché non prendere atto con sollievo, e non con rimpianto, che «spettacolare è dunque non il declino del padre, ma del patriarcato come sistema che ha regolato il rapporto tra i sessi. Ci sono le condizioni perché la funzione paterna si smarchi dall’ombra del padre patriarcale?» (ivi, p. 77). Si può essere “padre” senza essere padre biologico, come si può essere “madre” senza essere state le portatrici del neonato? È solo l’utero che definisce l’essenza di una donna? Questo ci mostra Nia, un mondo molto diverso dal nostro ma anche molto simile al nostro, un mondo che in realtà è già presente, è già il nostro mondo, ma non riusciamo a vederlo, come l’esploratrice Lixia che all’inizio non riusciva a capire la stranezza di un mondo in cui l’eterosessualità è quasi un peccato contro natura (un tema simile viene esplorato in un altro appassionante romanzo di Eleanor Arnason, Meduse, Ring of Swords, 1993).
Mettere in campo il sexuale significa allora salire sulla “navicella spaziale” per provare a fare esperienza di “mondi nuovi” in cui «la donna non è colei che NON ha il pene, così l’uomo non è colui che NON ha il seno» (ivi, p. 86). Si tratta di immaginare una “identità” non costruita in contrapposizione ad un’altra identità, come se maschile e femminile esaurissero tutto lo spazio delle possibilità di individuazione. C’è sempre quel “resto”, ci ricorda Fraire, ossia il sexuale, che non è assimilabile alle identità precostituite e già da sempre assegnate. C’è sempre la possibilità di prendere la strada di Nia l’aliena.
Già la sentiamo la scontata obiezione: ma che cos’è una donna se non un vivente che appunto “non ha il pene”? E che cos’è un uomo se non un vivente “che non ha il seno”, e che quindi non può allattare? Ma si può essere madre solo in un modo? E padre soltanto in un modo? In realtà “la novità” del nostro tempo «riguarda una genitorialità non identificata né con il materno né con il paterno, una posizione non di genere, non binaria» (ivi, p. 92). Che una genitorialità del genere sia al momento impensabile (anche se non per tutti) non vuol dire che sia sbagliata o contro natura, ché la storia di Nia ci mostra che la natura è un vincolo di cui non possiamo non tenere conto, ma non un impedimento assoluto. Nia è “donna”, ma questo non significa che non possa scegliere una vita diversa da quella che la sua costituzione fisica, e le tradizioni del popolo del ferro, avevano deciso per lei. Non si tratta nemmeno di inventarsi a capriccio una identità; si tratta piuttosto del faticoso lavoro che porta ogni corpo umano, o quasi umano come quello di Nia, a costruire una identità in cui diventare sé stessi.
E non è certo una caso che Nia sia una “donna”, perché è sul corpo delle donne che è più forte la pressione sociale a identificarsi prevalentemente, se non esclusivamente, con il ruolo di madre. Nia sperimenta sé stessa, sperimenta la propria identità quando si accompagna agli alieni terrestri per scoprire una vita completamente diversa dalla sua. Come scrive Fraire, è «spaventoso ammettere che una donna possiede un corpo dentro il quale può, oltre che fare, anche disfare il vivente. (Frankenstein è il parto della fantasia di una donna e non di un uomo, non bisognerebbe dimenticarlo). Nelle pratiche abortive quando liberamente scelte dalla donna è lei stessa che occupa il posto dello scienziato sperimentatore» (ivi, p. 97). In questo senso aprire “la porta delle madri” (un’espressione usata da Freud) significa liberarle dall’unica identità - quella materna - che sempre di nuovo le si vuole attribuire. Fare la madre, ovunque tale desiderio si manifesti, come reiterazione del dono d’amore che da quella abbiamo ricevuto o come risarcimento per ciò che è mancato nel suo amore, è un’illusione pericolosa. Vuol dire negare ciò che la persona/madre sta a ricordare e testimoniare: che nel legame con la madre c’è fin dall’origine una mancanza, il cui senso in potenza consiste in un’apertura a impedire la fusione, la reduplicazione dell’identità, l’annessione a sé dell’altro (ivi, pp. 116-117).
Torna qui il tema di quel “resto” inassimilabile che sfugge alla presa delle identità precostituite. La madre è madre, ma non è solo madre né principalmente madre. C’è anche questo dietro “la porta delle madri”, un mistero, una “apertura” che non si può rinchiudere in una identità definita una volta per tutte. Torna, soprattutto, il tema della libertà, che è al centro di questo libro. Una libertà che non significa tanto libertà di affermare sé stessi (secondo la formula tautologica dell’identità, A = A), al contrario, è la libertà di perdere sé stessi, cioè di offrirsi all’incontro con l’altro, come Nia nei confronti dell’aliena terrestre Lixia. È questo il desiderio femminile secondo Fraire, un desiderio che non è alla ricerca di ciò che manca, al fine di ricostituire un’unità (sul modello di quella fusionale della madre con il corpo che le cresce dentro), al contrario, un desiderio che cerca l’impensabile e inassimilabile reale del mondo. Fraire pone allora una distinzione radicale fra l’atteso e l’ospite. Nel primo caso «desiderio sta qui per vagheggiamento di qualcuno o qualcosa che appaia al momento dell’incontro come ciò che attendevamo e per ciò stesso conforme. Chiamiamo “l’atteso” l’oggetto che presenta al momento dell’incontro questa caratteristica. Per differenza chiamiamo “l’ospite” quell’oggetto che si presenta con caratteristiche di non riconoscibilità e per ciò stesso difforme» (ivi, p. 138). Anche se quando poi l’incontriamo lo detestiamo, è l’ospite che desideriamo di incontrare (come Nia verso Lixia, e Lixia verso Nia), perché solo l’ospite ci cambia la vita:
- L’ospite, a differenza dell’atteso, non piace né dispiace, lascia invece inter-detti. Si colloca cioè nello spazio in cui il nostro dire non basta per definire. In questo senso egli è difforme, di forma diversa cioè da quella che la nostra immaginazione vorrebbe. In quanto tale esso è anche unico poiché non fa parte di oggetti assimilabili tra loro. Infine esso è solitario in quanto separato da noi e da chi ci è familiare (ivi, pp. 142-143).
I “mondi nuovi mai visti prima” si aprono solo quando ci esponiamo alla possibilità dell’incontro con l’ospite inatteso. Finisce un mondo, ne comincia un altro. La psicoanalisi, e il femminismo, per Manuela Fraire sono due pratiche che non hanno altro scopo che vincere la paura dell’ospite. L’atteso, il noto, l’identità. Quant’era bella la vita prima che arrivassero gli alieni dalla Terra. Ma gli alieni sono ormai sbarcati, in realtà sono già da sempre arrivati. La vita comincia solo quando si apre “la porta delle madri”. Poi non resta che seguire Nia, l’aliena: “Domattina ci metteremo in viaggio per il sud”.
Riferimenti bibliografici
 E. Arnason, Sigma Draconis, Mondadori, Milano 1991.
E. Arnason, Sigma Draconis, Mondadori, Milano 1991. -
>Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- "La porta delle madri": Manuela Fraire. La differenza sotto il segno del sesso (di Franco Lolli).9 novembre 2023, di Federico La Sala
Manuela Fraire. La differenza sotto il segno del sesso.
- Introduzione: La porta delle madri è l’ultimo libro di Manuela Fraire, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, che affronta i temi del femminile e del maschile ma soprattutto riflette sul rapporto madre figlia, sulla differenza tra madri e donne,sulla struttura delle nuove famiglie all’interno della cornice psicoanalitica.(Maria Antoncecchi) *
La differenza sotto il segno del sesso
Recensione di Franco Lolli
Poco più di centocinquanta pagine sono state sufficienti a Manuela Fraire per riportare l’attenzione del lettore, nel suo saggio La porta della madri (Cronopio, pp.146,E. 13,00), i temi che la sua attività di psicoanalista e di donna impegnato nel movimento femminista ha da sempre incrociato e studiato.
Tra questi il concetto di differenza sembra occupare un posto centrale: particolarmente efficace, un passaggio nel quale specifica (rettificando errate opinioni) che “la differenza sessuale nel discorso del femminismo non è quella della donna dall’uomo, ma il quid che li unisce e li separa al di là di ogni complementarietà. Se femminile e maschile si spartissero tutte le parti che appartengo all’uno e all’altro, non vi sarebbe alcun resto, mentre nella differenze sessuale c’è un resto che per la psicoanalisi è il sessuale”
A venire interrogata non è dunque, semplicisticamente, la diversità dell’universo maschile rispetto a quello femminile, bensì l’impossibilità per entrambi di sapere qualcosa sulla sessualità dell’altro. Fraire compie questo passaggio mettendo a fuoco la sottomissione di qualunque corpo umano al regime pulsionale nel quale il dato biologico si interseca con quello linguistico, il reale del corpo con il simbolico della parola, il soma direbbe Freud - con la psiche. In questa ottica, studia la differenza tra madre e donna, tra madre e gestante, tra femminilità e disposizione alla passività, tra istinto e pulsione, tra genere e sesso. E orienta il suo interesse verso le nuove forme di famiglia (omogenitoriali e monoparentali, in particolare), le nuove forme di gravidanza che la tecnologia ha reso possibile e gli aspetti etici legati alle trasformazioni di quello che un tempo veniva definito «legame primario».
Anche in questo ambito, ciò che sembra attrarre soprattutto l’attenzione di Fraire è la differenza: tra l’accudimento del bambino da parte del genitore donna e quello da parte del genitore uomo, ovvero tra un’esperienza di cura radicata nella tradizione e la prassi di chi «non ha an- cora accumulato abbastanza esperienza di allevamento di un infans senza la supervisione di una donna» che gli con- senta di «contare su un sesto senso che gli permetta di decifrare e anticipare i bisogni di chi ancora non parla».
Il libro di Manuela Fraire offre anche, all’interno della sua prospettiva concettuale, una riflessione sulla pratica analitica, alla luce di una serie di interrogativi: sull’eventuale condizionamento del sesso dell’analista, su quanto il controtransfert risenta dei pregiudizi «sessuali» dell’analista, su quale sia il peso dell’identificazione proiettiva.
Tre film, narrati da altrettanti registi uomini - La favorita diretto da Yorgos Lanthimos, Quattro minuti diretto da Chris Kraus, e La donna del tenente francese di Karel Reisz - consentono all’autrice di analizzare altre differenze ancora: quella tra l’atteso e l’ospite, e quelle tra l’essere e il sentirsi soli e, ancora, l’avvertire se stessi come diversi, «i tre volti che può assumere la condizione che chiamiamo solitudine».
*
Fonte: SPi-Web, 02/!!/2023
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! ---ARTE. LETTERATURA, E PSICOANALISI: NOTE SULLA "PRIMA LEGGE DI NATURA" E SULLA DIFFERENZA TRA LA "PIETAS" E LA "CARITAS" ROMANA.9 giugno 2023, di Federico La Sala
FILOLOGIA ANTROPOLOGIA, E PSICOANALISI
LA "PIETAS" DELLA TRADIZIONE DI ROMA E LA "CARITAS ROMANA" NELLA STORIA DELL’ARTE E NELLA LETTERATURA.
ALCUNE NOTE SULLA "PRIMA LEGGE DI NATURA"
- "PRINCIPI DI SCIENZA NUOVA": In somma da tutto ciò, che si è in quest’Opera ragionato, è da finalmente conchiudersi; che questa Scienza porta indivisibilmente seco lo Studio della Pietà; e che, se non siesi pio, non si può daddovero esser saggio." (Giambattista Vico, 1744).
"CARITAS ROMANA"- In Valerio Massimo (sua è la fonte da cui proviene il racconto, ripreso poi da Giovanni Boccaccio, in "De mulieribus claris", con il titolo "Una Giovanetta Romana"), la figlia allatta la vecchia madre in carcere; nella tradizione artistica diventa invece la figlia che allatta il vecchio padre in carcere.
AMORE (CHARITAS): "COME NASCONO I BAMBINI". Come mai questa sottolineatura rappresentativa della giovane donna che allatta il vecchio padre nell’immaginario culturale europeo che ha quasi cancellata l’altra, quella della figlia che allatta la vecchia madre?! Non è tempo di svegliarsi dal sonno dogmatico (Kant) e avere il coraggio di pensare il "complesso edipico completo" (S. Freud) e imparare ad amare il padre e la madre?:
A) LA PIETAS COME ORIGINE DI TUTTE LE VIRTÙ: "Un pretore consegnò al triumviro una donna di nobile stirpe condannata alla pena capitale presso il suo tribunale affinché fosse uccisa in carcere. Colui che era a capo della custodia, dopo averla presa, mosso da misericordia non la strangolò subito: diede anche il permesso alla figlia di andare da lei, ma diligentemente perquisita affinché non portasse del cibo, ritenendo che sarebbe morta di fame. Poiché trascorsero molti giorni, lui stesso si chiedeva con che cosa mai riuscisse a sostentarsi così a lungo, osservando la figlia con più attenzione si accorse che quella, denudando il petto, placava la fame della madre con l’aiuto del suo latte.
 Di uno spettacolo così straordinario quella novità fu portata da lui stesso al triumviro, dal triumviro al pretore, dal pretore al consiglio dei giudici, e procurò alla donna la remissione della pena.
Di uno spettacolo così straordinario quella novità fu portata da lui stesso al triumviro, dal triumviro al pretore, dal pretore al consiglio dei giudici, e procurò alla donna la remissione della pena.
 A che punto non arriva o cosa non escogita la #pietas, che scoprì un nuovo sistema per salvare una madre dal carcere? Cosa c’è di tanto inusitato, che cosa di tanto inaudito se non che una madre sia nutrita dal petto di sua figlia? Qualcuno potrebbe ritenere questo fatto contro natura, se amare i genitori non fosse la prima legge di natura." ("Factorum et dictorum memorabilium libri IX", cit. da Laura R. Bevilacqua, "UN PANTHEON PER LE VIRTÙ II 13, I QUADERNI DEL RAMO D’ORO ON-LINE n. 10 , 2018).
A che punto non arriva o cosa non escogita la #pietas, che scoprì un nuovo sistema per salvare una madre dal carcere? Cosa c’è di tanto inusitato, che cosa di tanto inaudito se non che una madre sia nutrita dal petto di sua figlia? Qualcuno potrebbe ritenere questo fatto contro natura, se amare i genitori non fosse la prima legge di natura." ("Factorum et dictorum memorabilium libri IX", cit. da Laura R. Bevilacqua, "UN PANTHEON PER LE VIRTÙ II 13, I QUADERNI DEL RAMO D’ORO ON-LINE n. 10 , 2018).B) "LA SCENA PERDUTA" E LA "CARITÀ ROMANA" (ALLA LUCE DELLA PSICOANALISI): "[...] Nell’ultimo romanzo di Abraham B. Yehoshua “La scena perduta”, un anziano regista è invitato ad una retrospettiva dei suoi film, durante la quale gli verrà attribuito un premio. Con sorpresa i film che vengono proiettati sono le sue prime prove cinematografiche e Moses si trova ad assistere alle scene che aveva girato allora, usando come set la casa della propria infanzia: è un ritorno alle origini. [...] La retrospettiva servirà a Moses per ricucire un’antica rottura, la fine della collaborazione con il suo creativo, ispirato, sceneggiatore, colui con cui aveva girato le opere più riuscite della sua carriera. Era successo che, al momento di riprendere la scena finale di un film, frutto della fantasia visionaria dello sceneggiatore, il regista avesse esitato, optando per un’altra conclusione, meno ardita e cruda, tradendo la fiducia nell’intuizione e nelle fonti generose della creatività del collega [...]
 la scena ripudiata riprendeva il tema della Caritas Romana, e raffigura la leggenda meravigliosa di Pero e Cimone, messa per iscritto nel primo secolo d.C. da Valerio Massimo nei suoi Factorum et dictorum memorabilium libri IX . Vi si narra di una giovane donna che allatta il vecchio padre.
la scena ripudiata riprendeva il tema della Caritas Romana, e raffigura la leggenda meravigliosa di Pero e Cimone, messa per iscritto nel primo secolo d.C. da Valerio Massimo nei suoi Factorum et dictorum memorabilium libri IX . Vi si narra di una giovane donna che allatta il vecchio padre.- “Si chiama Cimone ed era stato condannato a morire di fame. Sua figlia andava a fargli visita in segreto e lo allattava perché non morisse. Alla fine i carcerieri la sorpresero in flagrante ma rimasero talmente colpiti dalla sua devozione, audacia e originalità che ebbero pietà del padre e lo lasciarono libero.”
Da Guido Reni a Caravaggio, a Rubens, a Murillo, la storia è stata rappresentata poi da innumerevoli pittori: l’impatto dei dipinti si rivela più forte di quello del #racconto e ogni artista ha cercato di presentare la propria versione. Perfino a #Pompei è riemerso un affresco con questo motivo; a #Budapest esiste una statua in cui la donna che allatta il vecchio sorregge un bambino già sazio, col dito in bocca, quasi pronto per addormentarsi. Nel 1606 #Caravaggio riuscì ad inserire la scena, così scandalosa nella sua carnalità, nella Pala d’altare della chiesa del Pio Monte della #Misericordia di #Napoli, sublimando la sua sensualità nella cornice delle opere di misericordia corporale, “dar da mangiare agli affamati e “visitare i carcerati”.
Allo psicoanalista la “retrospettiva” di Yehoshua evoca subito il termine freudiano di Nachträglickheit, che indica il lavoro psichico che torna a ritroso sul passato, per farlo rivivere in una rinnovata significazione affettiva, ricostruendo ogni volta, insieme al soggetto anche l’oggetto di desiderio. E’ quella ciclica e indispensabile modalità del soggetto di accostarsi alle proprie origini, alle fonti di sé, nel corso delle varie tappe della vita.
La storia di Pero, che col suo latte salva Cimone, incatenato e condannato a morire di fame, può rappresentare una delle diverse e inaspettate forme del ripresentarsi della configurazione edipica e del generoso dono d’amore, Caritas -Agape, all’origine dell’esistenza psichica. Quanto con l’età sarà simbolizzato e acquisterà limite e regola definendo il soggetto (il carcere e le catene di Edipo) all’inizio era unione carnale con la madre, senza confini definiti. Il quadro sconvolgente, che ci parla anche di realtà che a volte si rendono dolorosamente presenti nella crisi della coppia di oggi, mostra come nella figlia riviva la madre, nel vecchio il bambino che era stato.
Nel 1920 la psicoanalista Lou Andreas Salomé, a completamento del concetto di narcisismo primario, ci teneva a ricordare a Freud il valore dell’originario materno e gli proponeva: “Allo stato primario è presente un’identità tra mondo e Io, dove non esistono ricordi”, identità che nell’esperienza di godimento ripresenta “quel non-esser-ancora-Io, quell’esser-tu-e-Io che vigeva all’origine.”
Su questo sentimento di estasi, che Romain Rolland aveva chiamato “sentimento oceanico”, nel 1929 (Il disagio della civiltà) Freud si sarebbe fermato a riflettere, riconoscendo come il senso soggettivo dell’Io sia “soltanto un avvizzito residuo di un sentimento assai più inclusivo, anzi di un sentimento onnicomprensivo che corrispondeva a una comunione quanto mai intima dell’Io con l’ambiente”
Può essere doloroso per l’Io, soprattutto dopo essersi dovuto staccare da un’esperienza così appagante ed aver attraversato con fatica le difficili conquiste che portano alla maturità, alla costituzione dei limiti e della conoscenza, tornare a ripensare all’illimitato e al perturbante rapporto con il femminile originario, per andare nuovamente ad attingere alla fonte della saggezza.
Secondo Luce Irigaray (All’inizio, lei era, 2012), per capire qualcosa del “tra-noi”, sarebbe necessario tornare al mondo e alla filosofia dei presocratici. E’ toccante quello che scrive, e che sembra commentare la scena della Caritas Romana: “All’origine è una lei -natura, donna o Dea- che ispira la verità a un saggio... La totalità del discorso è ancora misteriosamente fondata a partire da lei - natura, donna o Dea - che rimane inaccessibile cosa dalla quale sorgono le parole e alla quale sono rivolte.”
Inoltratosi ormai nella vecchiaia, nel 1935, Freud scriveva a Lou Andreas Salomé: “Quanto buon carattere e umorismo ci vogliono per sopportare l’orribile avanzare dell’età! (...) Il giardino là fuori e i fiori della stanza sono belli, ma la primavera come noi diciamo a Vienna, è una presa in giro. Naturalmente sono sempre affidato alle cure di Anna, proprio come una volta ha osservato Mefistofele (Faust II, 7003): «E si finisce che si dipende dalle creature fatte da noi.»”
- Foto: Mathias Meyvogel Caritas Romana
*Fonte: cfr. Maria Pierri, “Questo è il posto, questa è l’origine”, SpiWeb, 4 marzo 2014 (ripresa parziale).
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! ---- Melanie Klein [oggi]: attualità di un pensiero inattuale (di Diomira Petrelli - "KnotGarden")30 maggio 2023, di Federico La Sala
Melanie Klein: attualità di un pensiero inattuale
di Diomira Petrelli *
Melanie Klein è stata, ed è ancora, una figura controversa del movimento psicoanalitico.In un intervento che risale ormai a molti anni fa (era il 1982, in occasione della giornata di studio organizzata in Francia per celebrare l’anniversario della sua nascita) e intitolato “Quando è troppo è troppo” André Green, che per la verità non è mai stato troppo “tenero” con lei, dichiarava che era giunta l’ora di “rendere giustizia” a M Klein, alla cui opera - scrive Green - ci si era riferiti “solo per criticarla” (Green, 1985, 94). Ciò che avrebbe dovuto renderlo possibile era, a suo avviso, il necessario lavoro del lutto successivo alla morte di M Klein che avrebbe dovuto smussare l’eccesso di idealizzazione e di denigrazione che l’aveva circondata in vita.
Oggi, a quarant’anni di distanza, dobbiamo purtroppo confermare questa constatazione, che cioè all’opera di M Klein ci si continui a riferire quasi sempre soprattutto per criticarla. Siamo passati infatti da iniziali adesioni entusiastiche ad una sorta di ostracismo che non fa giustizia all’originalità del suo pensiero. In particolare, in Italia, dopo un breve periodo di forse anche troppo entusiastica adesione, starei per dire idealizzante e di superficie, abbiamo assistito ad una dura reazione a quello che, forse a ragione, è stato definito il “kleinismo”.
Sarebbe invece molto importante, a più di 60 anni dalla sua morte, provare a collocare l’opera di M Klein in una prospettiva storica, cioè all’interno della storia del movimento psicoanalitico e di quella dei suoi concetti, tenendo conto delle “filiazioni” analitiche, sia di quelle più esplicite che di quelle implicite, o, per dirla con Green, dei suoi figli “legittimi” e di quelli “bastardi”.
L’influenza di alcune delle sue idee è probabilmente più grande di quanto oggi non si sia disposti a riconoscere. Alcuni concetti da lei formulati hanno avuto negli anni una grandissima diffusione ma, estrapolati dal contesto del modello teorico clinico di riferimento, hanno finito per assumere un significato molto o, a volte, del tutto diverso rispetto a quello originario. In alcuni casi si è quasi persa traccia della loro prima ed originale formulazione da parte di M Klein. Valga per tutti l’esempio del concetto di identificazione proiettiva che, come scrivono Spillius e O’Shaughnessy, “ha sollevato un inusuale interesse tra gli psicoanalisti” che hanno fatto di esso “usi complessi, a volte confusivi o anche contraddittori” (Spillius, O’Shaughnessy, 2012, 8).
La domanda che ci viene posta riguarda l’attualità del suo pensiero, anzi più precisamente la sua attualità clinica: che cosa della sua teorizzazione reputiamo “indispensabile nel nostro lavoro”, “cosa nella originalità del suo pensiero continua a stimolare la nostra riflessione clinica e tecnica”. È con gli occhi dell’oggi quindi che mi propongo di guardare all’opera di M. Klein interrogandomi, come scrive Derrida, su “quale risposta, quale promessa e responsabilità” possiamo trarne (Derrida, 1995, 49).
Sarebbe impossibile ovviamente parlare del significato dell’intera opera di M. Klein, ho scelto perciò di soffermarmi soltanto su alcuni aspetti che mi sono sembrati “nodi” caratterizzanti sia per novità che per fecondità teorico-clinica.
Vorrei ribadire, prima di tutto, l’originalità del suo pensiero che, a mio avviso, ha rappresentato, dopo Freud, uno dei più importanti cambiamenti del modello di funzionamento della mente. Un cambiamento la cui portata non è stata forse sufficientemente apprezzata, anche per ragioni storico-politiche.
 Mentre Freud era ancora in vita e negli anni immediatamente successivi alla sua morte, nel clima di dispersione e smarrimento determinato nel movimento psicoanalitico dalle tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale, non era facile evidenziare questa novità e M. Klein stessa nella maggior parte dei casi ha teso piuttosto a sottolineare la continuità del proprio pensiero rispetto a quello di Freud e molto meno a mettere in evidenza diversità, cambiamenti o rotture, salvo che in rari casi, sebbene importanti (la precocità del Super-io e del complesso edipico, l’esistenza dell’Io fin dalla nascita, l’interpretazione della femminilità).
Mentre Freud era ancora in vita e negli anni immediatamente successivi alla sua morte, nel clima di dispersione e smarrimento determinato nel movimento psicoanalitico dalle tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale, non era facile evidenziare questa novità e M. Klein stessa nella maggior parte dei casi ha teso piuttosto a sottolineare la continuità del proprio pensiero rispetto a quello di Freud e molto meno a mettere in evidenza diversità, cambiamenti o rotture, salvo che in rari casi, sebbene importanti (la precocità del Super-io e del complesso edipico, l’esistenza dell’Io fin dalla nascita, l’interpretazione della femminilità).Il nuovo modello della mente che emerge nella stanza da gioco: la fantasia inconscia
L’estensione dell’analisi a bambini anche molto piccoli e spesso molto gravi, a volte non in grado né di parlare né di giocare, ha rappresentato per M. Klein una sfida che non solo ha implicato la necessità di inventare una nuova tecnica ma ha anche contribuito a modificare significativamente il suo modello di funzionamento della mente e, di conseguenza, quello del processo psicoanalitico, anche se furono necessari molti anni prima che ciò potesse essere affermato con chiarezza nelle Discussioni Controverse (1943).[1]
La tecnica psicoanalitica del gioco non si intende, a mio avviso, nel suo vero significato se non la si considera nella sua intrinseca correlazione con il concetto di fantasia inconscia. È il concetto di fantasia inconscia che fa del gioco uno strumento psicoanalitico, sul modello del sogno, ed è la drammatizzazione nel gioco che costituisce lo sfondo e il modello della nuova rappresentazione del mondo interno e dei suoi oggetti.
Nel nuovo setting rappresentato dalla stanza da gioco secondo M. Klein tutte le attività del bambino, anche quelle più stereotipate e silenziose, esprimono e drammatizzano i molteplici e mutevoli contenuti del suo mondo interno e possono essere lette come l’esteriorizzazione di fantasie, spesso anche molto articolate, che riguardano la relazione con oggetti, interni ed esterni. Se prescindiamo da questo riferimento clinico e osservativo sarebbe probabilmente difficile comprendere come M. Klein sia potuta giungere a formulare il suo nuovo modello di funzionamento mentale. L’aver considerato il gioco alla stregua del sogno come spontanea, continua e inconsapevole attività rappresentativa di contenuti mentali inconsci segna una svolta fondamentale. Porta infatti M. Klein a mettere l’accento sul flusso ininterrotto di contenuti mentali inconsci che, come “il sogno della veglia” (Bion), accompagna con vivida concretezza fin dall’inizio della vita tutte le attività, dai movimenti più semplici e involontari alle manifestazioni più evolute o razionali.
Sul modello di quanto avviene nel gioco il mondo interno le appare popolato e costituito da una caleidoscopica dinamica tra molteplici oggetti interni - “personaggi”, “parti degli oggetti e del Sé” - che subiscono alterne vicende, in un continuo movimento di scissioni e aggregazioni, espulsioni e interiorizzazioni, che si modellano sul funzionamento corporeo. Vicende drammatiche, accompagnate da fantasie inconsce onnipresenti che sottostanno a tutte le manifestazioni della vita psichica e del comportamento. Questo flusso ininterrotto - una sorta di film nella mente - si rivela non solo attraverso le parole ed il gioco ma anche attraverso tutto il comportamento, la postura corporea e ogni forma di azione.
Si tratta di un diverso modo di concepire la vita mentale ed il suo sviluppo: il bambino piccolo già da molto presto, per M. Klein dalla nascita, “fa esperienza” non solo di sensazioni, percezioni e tracce mnestiche, ma anche di vivide e concrete fantasie, il che fa di lui una persona con un’attività psichica già strutturata, per quanto rudimentale; questa primitiva attività mentale, fatta di fantasie corporee e concrete, permane nelle fasi successive come inconscio sottofondo di tutte le attività mentali, anche di quelle più evolute, che non la soppiantano ma sono in effetti da essa profondamente permeate e che da essa traggono la propria sotterranea forza emotiva. La fantasia inconscia è un’attività continua, ubiquitaria, una sorta di sottofondo inconscio costante.
Klein evidenzia la permanenza di questo mondo di forme interiori, intensamente investite affettivamente, anche nella vita mentale adulta, non solo nel sogno ma anche nella veglia. La riformulazione del concetto di fantasia inconscia esprime quindi il tentativo di rappresentarsi il funzionamento mentale, nelle sue forme più precoci ma anche in quelle più evolute e, soprattutto, la sua vivida concretezza. Queste forme mentali organizzano l’esperienza, sia quella che il bambino fa del proprio corpo, attraverso le sensazioni legate ai suoi organi e al loro funzionamento, sia quella relativa all’ambiente esterno. La fantasia è cioè ritrascrizione e reinterpretazione delle sensazioni e percezioni primitive e immediata e primaria relazione “agita” con l’oggetto. Le prime fantasie sono intessute e nascono da sensazioni e percezioni corporee. È qualcosa che è vividamente vissuto come molto reale e concreto e collocato per lo più nel corpo. Si tratta di vivide fantasie psicosomatiche in cui avviene una prima messa in forma, una “interpretazione affettiva” dei dati sensoriali e percettivi che richiede perciò di postulare già l’esistenza di un Io, per quanto precoce e rudimentale.
 Si comprende che questo modello porti a sviluppare una visione più globale del paziente in cui tutto ciò che egli fa, e non solo quello che dice, diventa importante e comunicativo in quanto portatore di significati emotivi spesso inconsci. L’azione delle fantasie può essere colta a 360 gradi da tutto il comportamento e anche dal modo in cui il paziente gestisce il corpo: come entra e come esce dalla stanza, dove si colloca, cosa fa, dalle particolarità del suo gestire o del suo modo di parlare o di rimanere in silenzio.
Si comprende che questo modello porti a sviluppare una visione più globale del paziente in cui tutto ciò che egli fa, e non solo quello che dice, diventa importante e comunicativo in quanto portatore di significati emotivi spesso inconsci. L’azione delle fantasie può essere colta a 360 gradi da tutto il comportamento e anche dal modo in cui il paziente gestisce il corpo: come entra e come esce dalla stanza, dove si colloca, cosa fa, dalle particolarità del suo gestire o del suo modo di parlare o di rimanere in silenzio.Va sottolineato che per M. Klein, come esplicita con chiarezza S. Isaacs (1948), la fantasia inconscia non è confinata ad alcuni momenti della vita mentale ma è il modo di essere - proto-rappresentativo - della vita mentale stessa. L’ipotesi - e la sfida - è quella di ritenere che sia possibile inferire, e quindi gradualmente comprendere, il significato emotivo di queste fantasie non soltanto attraverso la comunicazione verbale ma anche attraverso altri canali comunicativi, non verbali e preverbali.
Si tratta di un importante cambiamento epistemologico che ha avuto sviluppi significativi. L’uso “esteso” del concetto di identificazione proiettiva - che per M. Klein era appunto una “fantasia inconscia” -, associato a quello di controtransfert, ha avuto, dopo Bion, una vasta applicazione, contribuendo ad affinare le capacità di osservazione, ricezione ed ascolto delle molteplici forme primitive di espressione/comunicazione, preverbale e non verbale, presenti in bambini e adulti, anche molto gravi o molto regrediti.
Il concetto kleiniano di fantasia inconscia ha prodotto un radicale mutamento anche nel modo di intendere i processi di transfert. L’osservazione minuta e dettagliata dei cambiamenti che avvengono nel transfert, anche nel corso di una singola seduta, diventa lo strumento che, più di ogni altro, può permettere di cogliere il carattere delle fantasie che sono attive in quel momento e che si ricollegano alla parte infantile della personalità del paziente e alla sua storia passata, benché, ovviamente, la nostra conoscenza del passato vissuto dal paziente possa essere molto spesso solo ipotetica ed inferenziale. D’altra parte è proprio la comprensione di queste fantasie che ci permette di cogliere gli aspetti più profondi del transfert.
Secondo M. Klein le fantasie inconsce derivano da sensazioni fisiche interpretate come relazioni con oggetti che causano tali sensazioni. La fantasia è cioè l’interpretazione che il bambino dà alle proprie sensazioni e percezioni alla luce degli affetti che in quel momento prova. Sono vissute come fenomeni sia somatici che mentali, intrisi di sensazioni ed affetti. In quanto percezioni sono in rapporto non solo con il corpo ma anche con la realtà esterna. Il funzionamento degli organi del corpo viene tradotto in fantasie mentali, intrise di affetti, che lo collegano all’oggetto e che danno al bambino una primitiva e rudimentale sensazione di sé (me-ness).
Queste ipotesi presupponevano da parte di M. Klein una maggiore fiducia nella permeabilità esistente tra i diversi livelli di funzionamento mentale, come rileva R. Steiner (2007), e una maggiore continuità tra il bambino e l’adulto, cosa che ha spesso determinato l’accusa rivolta agli psicoanalisti kleiniani di infantilizzare i pazienti adulti. Tuttavia, al di là di alcune estremizzazioni che hanno portato a concretizzare eccessivamente fantasie inconsce e oggetti interni, un uso attento di questi concetti può consentire una lettura più vivida ed efficace dei derivati dell’inconscio, che miri a tenere presente da un lato il loro profondo radicamento nel somatico e dall’altro l’intrinseca relazionalità affettiva del Sé con gli oggetti, come un qualcosa che profondamente costituisce il senso di sé[2].
Il punto di massima urgenza, l’angoscia
Un secondo punto nodale riguarda la particolare attenzione e sensibilità nei confronti dell’angoscia che ha caratterizzato tutta l’opera di M. Klein fin dagli esordi.
 Si tratta di una grande capacità di sintonizzarsi sulla qualità dell’angoscia di pazienti anche molto gravi, come ad esempio il piccolo Dick, accompagnata da una straordinaria fiducia nella possibilità di entrare in comunicazione profonda con loro, proprio a partire da quello che lei stessa definisce “il punto di massima urgenza”. Lo descrive così: “Fin dall’inizio, era il 1919, ho ritenuto che la prima cosa da considerare quando mi avvicinavo ad un bambino fossero le sue angosce. Mi sono sentita subito attratta da questo, e quando mi è stato chiesto il perché non sono riuscita a dare una risposta. Tuttavia, interpretavo ogni volta che incontravo l’angoscia, naturalmente, senza attenermi minimamente al principio secondo cui non avrei dovuto interpretare troppo, o troppo in profondità. [...] si potrebbe dire che i cambiamenti nella tecnica sono stati fondamentali e hanno comportato effettivamente un approccio diverso. L’approccio all’angoscia e l’approccio al transfert sono due aspetti interconnessi; credo che soltanto focalizzando l’approccio sulle emozioni, in particolare sull’angoscia, sia stato possibile sviluppare la tecnica” (Klein, 2017, 114-5).
Si tratta di una grande capacità di sintonizzarsi sulla qualità dell’angoscia di pazienti anche molto gravi, come ad esempio il piccolo Dick, accompagnata da una straordinaria fiducia nella possibilità di entrare in comunicazione profonda con loro, proprio a partire da quello che lei stessa definisce “il punto di massima urgenza”. Lo descrive così: “Fin dall’inizio, era il 1919, ho ritenuto che la prima cosa da considerare quando mi avvicinavo ad un bambino fossero le sue angosce. Mi sono sentita subito attratta da questo, e quando mi è stato chiesto il perché non sono riuscita a dare una risposta. Tuttavia, interpretavo ogni volta che incontravo l’angoscia, naturalmente, senza attenermi minimamente al principio secondo cui non avrei dovuto interpretare troppo, o troppo in profondità. [...] si potrebbe dire che i cambiamenti nella tecnica sono stati fondamentali e hanno comportato effettivamente un approccio diverso. L’approccio all’angoscia e l’approccio al transfert sono due aspetti interconnessi; credo che soltanto focalizzando l’approccio sulle emozioni, in particolare sull’angoscia, sia stato possibile sviluppare la tecnica” (Klein, 2017, 114-5).Dick era un bambino di quattro anni, non parlava e non giocava, sembrava ignorare la presenza di M. Klein in quanto essere umano diverso dai mobili della stanza, ma lei, coraggiosamente, istituì un setting, dette nome agli oggetti e avviò un gioco che era una forma di comunicazione sulla sua angoscia più profonda. Al bambino che era corso a rinchiudersi nell’andito tra due porte della stanza esclamando: “Buio!” dice: “E’ buio dentro la mamma. Dick è dentro il buio della mamma” (Klein, 1930, 256).
Più tardi parlando della sofferenza dello schizofrenico scriverà che la mancanza di emotività che rende i pazienti schizoidi incapaci di reazione, la loro apparente assenza di angoscia, deriva in realtà dall’uso massiccio di meccanismi schizoidi che amputano gravemente il Sé e che implicano la dispersione delle emozioni che però, “pur disperse, sussistono sempre nei pazienti”. “In essi l’angoscia latente ha una forma particolare; ed è tenuta latente proprio dal meccanismo speciale della dispersione. Il senso di disintegrazione, di incapacità a provare emozioni, di perdita dei propri oggetti è in effetti l’equivalente dell’angoscia” (Klein, 1946, 430). “Le emozioni erano assenti, le relazioni erano vaghe e incerte, e parti della personalità erano sentite come perdute, tutto pareva morto” (ivi, 431).
Nel Saggio Sul senso di solitudine (1959) tornerà a descrivere gli stati emotivi di questi pazienti che, sebbene apparentemente insensibili, le sembrano mostrare i segni di un’intensa sofferenza. La loro condizione le appare intrisa di disperazione e di rammarico per non poter ristabilire il contatto emotivo con sé stessi e con l’altro. Le scissioni schizoidi portano infatti alla solitudine più profonda: quella di essere tagliati fuori dal proprio Sé. Parlare del loro senso di solitudine significa sottolineare che provano emozioni, profondissime angosce di frammentazione, di perdita di sé, di isolamento, ma anche intravedere la possibilità che ci sia comunque anche in essi una spinta all’integrazione e che su questa base sia possibile agganciarli in un processo terapeutico entrando in contatto con la loro angoscia latente.
Nella comunicazione allo stesso Congresso di Copenaghen del 1959 - Una nota sulla depressione nello schizofrenico - avrebbe parlato della solitudine dello schizofrenico, mettendo in discussione le distinzioni che aveva in precedenza cercato di stabilire, per evidenziare che anche questi pazienti provavano una qualche forma di angoscia depressiva. Mette in evidenza alcuni aspetti di continuità tra le due condizioni (schizoparanoide e depressiva)[3] e riconosce la presenza di sentimenti di depressione e di colpa anche nella posizione schizoparanoide: “Ora - scrive - io considero questa differenziazione troppo schematica. [...] una certa internalizzazione dell’oggetto buono avviene anche nello schizofrenico paranoide” (Klein, 1960, 6), anche se essa differisce per qualità e forza da quella che avviene nel maniaco-depressivo. In questo senso l’angoscia paranoide, relativa allo stato dell’Io, “è costretta ad includere una certa preoccupazione per l’oggetto” (ivi, 7). L’angoscia depressiva e la colpa in questo caso si riferiscono a quella parte dell’Io che è sentita contenere l’oggetto buono e che è vissuta come la parte buona. Angoscia depressiva e colpa vengono però allontanate in modo violento dallo schizofrenico e sono sperimentate solo in alcune aree, da lui sentite come irraggiungibili.
Questa fiducia nella possibilità di stabilire un contatto emotivo profondo, proprio a partire dal contatto con l’angoscia e dalla sedimentazione di un qualche rapporto con l’oggetto buono anche nei pazienti più chiusi e apparentemente insensibili, piccoli o grandi che siano, mi sembra un aspetto importantissimo che ha comportato una significativa modificazione nella tecnica, aprendo la strada a nuove aree di ricerca.
Proprio a partire da questo senso di solitudine e di disperazione M. Klein pensa che sia possibile trovare, nel transfert, un aggancio che permetta di ristabilire il contatto con una qualche traccia, seppur dispersa, dell’oggetto buono.
- CONTINUAZIONE NEL POST SUCCESSIVO
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! ---- Melanie Klein [oggi]: attualità di un pensiero inattuale (di Diomira Petrelli - "KnotGarden")30 maggio 2023, di Federico La Sala
- CONTINUAZIONE DEL POST PRECEDENTE E FINE.
Melanie Klein: attualità di un pensiero inattuale
di Diomira Petrelli *
[...]
Il Sé frammentato e i processi di integrazione
Negli scritti della metà degli anni ’40 M. Klein descrive l’esistenza di fantasie in cui l’Io - o più tardi il Sé - sembra privo di interezza, come se alcune sue parti o funzioni venissero a mancare. I pazienti di cui parla vivono stati di frammentazione, confusione e perdita della capacità di provare emozioni, condizione che viene da loro stessi percepita come una mutilazione, una concreta perdita di parti di sé che restano estraniate, seppellite in oggetti esterni e perciò non più disponibili, irraggiungibili, affette dallo stesso senso di solitudine che prova il soggetto.
 M. Klein interpreta queste fantasie come frutto di difese molto primitive, rispetto ad angosce avvertite come intollerabili, che operano sia immaginando di espellere oggetti cattivi e cattive parti del Sé, sia aggredendo la psiche stessa del soggetto e le parti di essa più consapevoli dell’esperienza emotiva e per questo responsabili dell’angoscia. La contropartita emotiva di queste difese è “un indebolimento eccessivo dell’Io, la sensazione che non vi sia nulla a sostenerlo, e il senso di solitudine” (Klein, 1946, 422), in quanto l’automutilazione conduce sì ad un allontanamento e alla dispersione dell’esperienza emotiva, ma anche a penose sensazioni di confusione e frammentazione, ad angosce per la propria integrità e per la distruzione della capacità di provare emozioni.[5]
M. Klein interpreta queste fantasie come frutto di difese molto primitive, rispetto ad angosce avvertite come intollerabili, che operano sia immaginando di espellere oggetti cattivi e cattive parti del Sé, sia aggredendo la psiche stessa del soggetto e le parti di essa più consapevoli dell’esperienza emotiva e per questo responsabili dell’angoscia. La contropartita emotiva di queste difese è “un indebolimento eccessivo dell’Io, la sensazione che non vi sia nulla a sostenerlo, e il senso di solitudine” (Klein, 1946, 422), in quanto l’automutilazione conduce sì ad un allontanamento e alla dispersione dell’esperienza emotiva, ma anche a penose sensazioni di confusione e frammentazione, ad angosce per la propria integrità e per la distruzione della capacità di provare emozioni.[5]Nel saggio Sul senso di solitudine M. Klein collega il senso di dispersione e di perdita prodotto dalla sensazione di non potersi più ricongiungere con le “parti perdute” ad una menomazione, quasi un danno, del senso di appartenenza: le “parti perdute” hanno subito un processo di scissione e “vengono proiettate in altre persone, contribuendo così al sentimento di non godere del pieno possesso del proprio sé, cioè di non appartenere completamente a sé stessi, né, quindi, a nessun altro.” (Klein, 1959, 144). Queste mutilazioni del senso di sé (“le parti perdute”) si traducono in un’impossibilità per il soggetto di sperimentare l’appartenenza all’altro, sia esso un singolo o un gruppo. Il senso di solitudine e di mancanza inficia l’appartenenza e la capacità di affidarsi.
La ricerca di M. Klein sui processi di scissione contiene osservazioni importanti ed innovative. Accanto ai processi di scissione “normali” e necessari per lo sviluppo ella ne individua altri che conducono alla frammentazione del Sé che ne risulta gravemente danneggiato, in forza e coesione.
Di grande rilievo clinico è l’osservazione della stretta interrelazione esistente tra l’Io e l’oggetto anche a proposito della scissione: l’Io, infatti, non può scindere l’oggetto senza scindersi a sua volta di conseguenza. In questo senso la scissione-frammentazione, nata come difesa dall’angoscia, rappresenta anche una forza mortifera che produce disintegrazione, non solo dell’oggetto ma anche dell’Io. Di fatto la scissione rigida ed estrema dell’oggetto, la negazione completa dell’esistenza dell’oggetto cattivo, implica che vengano denegate e scisse, cioè distrutte, anche le parti dell’Io che sono in rapporto con questo oggetto.
Ciò porta M. Klein ad interpretare la difesa schizoide come un movimento attivo che rivolge le pulsioni distruttive all’interno, cioè contro l’Io stesso, dando luogo alla fantasia di annichilimento di una parte della propria personalità. In questo senso la scissione dell’Io (o del Sé) è sempre inevitabilmente anche una distruzione immaginaria di parti del Sé. Vale a dire che la scissione frammentante, meccanismo di difesa dell’Io contro la pulsione di morte, si rivela essa stessa permeata dalla pulsione di morte e sfocia in un sentimento affine alla morte, la disintegrazione, la confusione e il caos.
L’avere così profondamente compreso i processi di scissione e alcuni loro esiti disastrosi (disintegrazione, frammentazione e confusione) rende ragione della grande importanza data da M. Klein ai processi di integrazione, sia nella teoria che nella tecnica.
In particolare di grande rilievo clinico è la sua comprensione di come la frammentazione, derivante da processi disgreganti di scissione, conduca a stati di confusione estrema (“essere a pezzi e confusi”) la cui profonda dolorosità caratterizza, ad esempio, la condizione degli stati schizofrenici.
In questo senso diventa centrale sia nel suo modello di funzionamento mentale che nel suo modo di intendere il processo psicoanalitico il concetto di integrazione.
Negli scritti compresi nelle Lezioni sulla tecnica (sia nei seminari tenuti nel 1936 che nelle lezioni del 1958) M. Klein ribadisce a più riprese l’importanza e la necessità di tenere insieme, cioè di integrare, sia nella teoria che - soprattutto - nella tecnica, aspetti diversi ed opposti e di vederne la complessa articolazione: amore e odio, transfert positivo e negativo, ma anche transfert e storia, mondo esterno e mondo interno, esperienze reali e fantasie, schemi generali e situazioni particolari.
 Penso che questo sforzo abbia caratterizzato tutta la sua opera. Si coglie nelle brevi illustrazioni cliniche che quello che più la interessa è rintracciare le connessioni, i collegamenti, l’aspetto dinamico del funzionamento mentale, a partire dalla necessità di tenere presenti anche gli aspetti distruttivi e l’odio, fino alla considerazione dell’importanza di rimandare al paziente sempre anche la sua capacità di amare. Questo “stabilire legami [...] è uno degli aspetti più importanti dell’interpretazione e della tecnica” (Klein, 2017, 105). L’interpretazione è un modo di mettere insieme i dati, di stabilire connessioni che possono generare un significato. Il suo intento veramente terapeutico è mettere insieme i pezzi, stabilire i collegamenti - tra emozioni diverse così come tra presente e passato - e farli vivere al paziente nell’attualità del transfert. Ciò - sottolinea - può essere avvertito dal paziente come un’esperienza concreta, qualcosa che accade concretamente dentro di lui, gli “fa sentire che l’interno del proprio corpo è stato trattato adeguatamente da un oggetto buono e soccorrevole” (ivi, p. 100).
Penso che questo sforzo abbia caratterizzato tutta la sua opera. Si coglie nelle brevi illustrazioni cliniche che quello che più la interessa è rintracciare le connessioni, i collegamenti, l’aspetto dinamico del funzionamento mentale, a partire dalla necessità di tenere presenti anche gli aspetti distruttivi e l’odio, fino alla considerazione dell’importanza di rimandare al paziente sempre anche la sua capacità di amare. Questo “stabilire legami [...] è uno degli aspetti più importanti dell’interpretazione e della tecnica” (Klein, 2017, 105). L’interpretazione è un modo di mettere insieme i dati, di stabilire connessioni che possono generare un significato. Il suo intento veramente terapeutico è mettere insieme i pezzi, stabilire i collegamenti - tra emozioni diverse così come tra presente e passato - e farli vivere al paziente nell’attualità del transfert. Ciò - sottolinea - può essere avvertito dal paziente come un’esperienza concreta, qualcosa che accade concretamente dentro di lui, gli “fa sentire che l’interno del proprio corpo è stato trattato adeguatamente da un oggetto buono e soccorrevole” (ivi, p. 100).Le parole che ricorrono di più nelle Lezioni sono legame, correlazione, articolazione ed indicano la sua attenzione per il mobile punto di unione tra aspetti differenti. Non l’amore e/o l’odio ma il rapporto tra l’amore e l’odio, cioè la correlazione, la fluttuazione: “Credo che la difficoltà di rendere piena giustizia sia al transfert positivo sia a quello negativo non sorga dalla sopravvalutazione dell’uno o dell’altro, ma da un’insufficiente comprensione della connessione profonda esistente tra sentimenti positivi e negativi” (ivi, 42).
Tutto ciò implica una visione dinamica del funzionamento mentale, non nel senso di rapporti quantitativi tra forze diverse, ma di un continuo movimento, una fluttuazione e trasformazione tra stati della mente differenti. Il modello genetico è di fatto abbandonato in favore di un modello oscillatorio, continuamente reversibile. I termini opposti non vanno verso una sintesi ma permangono distinti, in tensione, esprimendo diverse polarità, sempre potenzialmente presenti. Il suo sforzo conoscitivo ed interpretativo è quello di tenere insieme tutti questi aspetti che si presentano sparsi e frammentati, spezzettati. La preoccupa recuperare “il filo inconscio” (ivi, 132), il collegamento tra vari “pezzi” del materiale, in una stessa seduta ma anche tra più sedute, espressione ed esteriorizzazione di aspetti scissi e frammentati della mente del paziente e delle sue oscillazioni tra stati mentali differenti.
Proprio la sua capacità di essere così a contatto con un funzionamento mentale fluido, inarrestabile, scoordinato, eppure rigido e violento, come quello che caratterizza i pazienti più gravi, le fa sentire come un pericolo incombente quello della confusione che deriva da un eccesso di frammentazione.
L’integrazione non nasce quindi da un’attitudine intellettuale o intellettualistica ma da uno sforzo di contenimento e di creazione di legami, alla ricerca di un senso della sofferenza, che fa sentire l’altro concretamente “tenuto insieme”, contenuto nella mente.
Il pensiero espresso da M. Klein negli ultimi scritti e specialmente nel saggio incompiuto Sul senso di solitudine ha un carattere particolare, non ben definito e, in qualche modo, sfuggente, ma proprio per questo ha una grande capacità di suscitare interrogativi, di porre domande, di stimolare a pensare.
La riflessione sull’incolmabilità del senso di solitudine è forse il suo aspetto più toccante e profondo, che apre al pensiero e al suo continuo interrogarsi sulla condizione umana, per cui più cerchiamo di vincere il senso di mancanza, più incontriamo il senso del nostro limite e il limite del nostro conoscere. Il paradosso è che proprio dall’accettazione di questi limiti il senso di solitudine, forse, appare acquetato.
Bibliografia
Derrida J. (1995). Mal d’archive une impression freudienne. Paris, Edition Galilée. Trad. it. Napoli, Filema Edizioni, 1996.
Green A. (1985). Trop c’est trop, in Mélanie Klein Aujourd’hui. Lyon, Césura Lyon Edition.
Isaacs S. (1948). Natura e funzione della fantasia. Trad. it. in: (a cura di D. Petrelli) Fantasia inconscia. Roma, Il Pensiero Scientifico Editore, 2007.
Klein M. (1930). L’importanza della formazione dei simboli nello sviluppo dell’Io. Trad. it in: M. Klein Scritti 1921-1958. Torino, Boringhieri, 1978.
Klein M. (1946). Note su alcuni meccanismi schizoidi. Trad. it in: M Klein Scritti 1921-1958. Torino, Boringhieri, 1978.
Klein M. (1953). La tecnica psicoanalitica del gioco: sua storia e suo significato. In: Nuove vie della psicoanalisi. Trad. it. Milano, Il Saggiatore, 1966.
Klein M. (1958). Sullo sviluppo dell’attività psichica. Trad. it in: M Klein Scritti 1921-1958. Torino, Boringhieri, 1978.
Klein M. (1959). Sul senso di solitudine. Trad. it. in: Il nostro mondo adulto ed altri saggi. Firenze, Martinelli, 1972.
Klein M. (1960). A Note on Depression in the Schizophrenic. In M. Klein, Envy and Gratitude and Other Works 1946-1963, 1984. Trad. it. in Richard e Piggle, 1/96, 3-8.
Klein M. (2017). Lezioni sulla tecnica. Trad. it., Milano, Cortina, 2020.
Spillius E., O’Shaughnessy E. (2012). Il concetto di identificazione proiettiva. Trad. it. Roma, Astrolabio, 2014.
Steiner R. (2007). Nota storico-critica. In: (a cura di D. Petrelli) Fantasia inconscia, Roma, Il Pensiero Scientifico Editore, 2007.
—
[1] M. Klein non ha mai mancato di ribadire “il lungo e duraturo influsso” dell’analisi infantile sul suo lavoro; scriveva infatti nel 1953: “Il mio lavoro, sia con i bambini che con gli adulti, e i miei contributi alla teoria psicoanalitica nel complesso, derivano, in definitiva dalla tecnica del gioco sviluppata con bambini piccoli” (Klein, 1953, 29).
[2] “Queste sensazioni (e immagini) sono una esperienza corporea, all’inizio scarsamente in grado di essere collegata ad un oggetto esterno e spaziale. Esse danno alla fantasia una concreta qualità corporea, una condizione me (me-ness) sperimentata nel corpo. A questo livello le immagini sono scarsamente, se non affatto, distinguibili dalle sensazioni reali e dalle percezioni esterne” (Isaacs, 1948, 41).
[3]“Sentimenti di depressione e di colpa, che hanno la loro più ampia espressione nella fase in cui si presenta la posizione depressiva, sono già operativi (secondo le mie più recenti convinzioni) nella fase schizo-paranoide” (Klein, 1960, 6).
[4] Riferendosi alla scoperta di Freud della polarità e dell’impasto delle pulsioni di vita e di morte, operanti fin dalla nascita scrive infatti: “Io ho potuto riconoscere l’operare di queste forze primordiali in conflitto tra loro osservando nei processi psichici dei bambini in tenera età la costante presenza della lotta tra la spinta irrefrenabile a distruggersi e quella a proteggersi, tra l’impulso ad aggredire gli oggetti e quello a salvaguardarli. Ciò mi ha consentito di comprendere più a fondo l’essenziale importanza clinica della concezione di Freud delle pulsioni di vita e di morte” (Klein, 1958, 540).
[5]“Nei pazienti schizoidi l’assenza di angoscia è solo apparente. I meccanismi schizoidi implicano infatti la dispersione delle emozioni, e quindi anche dell’angoscia, ma pur disperse esse sussistono sempre nei pazienti. [...] allorché le emozioni erano assenti, le relazioni erano vaghe e incerte, e parti della personalità erano sentite come perdute, tutto pareva morto. Ora questo è appunto l’equivalente di un’angoscia gravissima. Essa è tenuta latente dalla dispersione ed è provata continuamente” (Klein, 1946, 431).
Diomira Petrelli, Napoli
 Centro Napoletano di Psicoanalisi
Centro Napoletano di Psicoanalisi* Fonte: Centro Veneto di Psicoanalisi
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Come una voragine che abita il profondo. “Alcune riflessioni sull’Orestiade” di Melanie Klein (di Franca Munari)14 febbraio 2023, di Federico La Sala
Come una voragine che abita il profondo.
 “Alcune riflessioni sull’Orestiade” di Melanie Klein
“Alcune riflessioni sull’Orestiade” di Melanie Kleindi Franca Munari (Centro Veneto di Psicoanalisi)
Nella trilogia Eschilo fa apparire gli dei in numerosi ruoli simbolici, e io ho cercato di spiegare come ciò contribuisca alla ricchezza e al significato della tragedia. Concluderò con l’ipotesi ... che la grandezza delle tragedie di Eschilo ... derivi dalla sua comprensione intuitiva dell’inesauribile profondità dell’inconscio e dal modo in cui questa comprensione si ripercuote sui personaggi e sulle situazioni che egli crea. (Melanie Klein)
L’Orestiade
L’Orestiade è una trilogia formata dalle tragedie Agamennone, Coefore e Eumenidi, con cui Eschilo vinse nel 458 a.C. le Grandi Dionisie.
Le tragedie che la compongono rappresentano un’unica storia suddivisa in tre episodi: l’assassinio di Agamennone da parte della moglie Clitennestra, la vendetta del loro figlio Oreste che uccide la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e la sua assoluzione finale ad opera del tribunale dell’Areopago.
Gli antefatti
Agamennone, sovrano della polis di Argo, alla partenza per la guerra di Troia non aveva venti favorevoli così, per propiziarsi gli dei, aveva sacrificato la figlia Ifigenia, di bellezza eccezionale. In questo modo la flotta aveva potuto alzare le vele. Al suo ritorno Clitennestra aveva perciò deciso di vendicare il sacrificio della figlia, convincendo Egisto, cugino del marito e suo amante, ad aiutarla in tale impresa.
Il fantasma di Ifigenia. Orestiade. Teatro greco di Siracusa. Regia di Davide Livermore, 2022.
A questa esplicita motivazione va aggiunto il fatto che Agamennone l’aveva stuprata e sposata contro la sua volontà sottraendola al suo primo marito e uccidendo il loro bambino. Presto era partito lasciandola sola per dieci anni per la guerra di Troia causata dal tradimento di Elena nei confronti di Menelao, fratello di Agamennone; ed Elena, donna di incomparabile bellezza, fuggita per amore con Paride a Troia, è sorella di Clitennestra - dobbiamo supporre sorella molto invidiata, vuoi per la bellezza, vuoi per la realizzazione affettiva. Inoltre Agamennone, tornato da Troia, aveva imposto alla moglie la presenza di Cassandra, la principessa troiana fatta schiava e da lui presa come amante.
Insomma le ragioni di Clitennestra, sia di odio nei confronti di Agamennone, sia edipiche - come ripetutamente sottolinea Klein - sono molte e complesse e alle sue ragioni si sommano le ragioni di Egisto, figlio dello stupro di Tieste, fratello gemello di Atreo - padre di Agamennone e Menelao - di sua figlia Pelopia, sacerdotessa di Atena, dopo che Atreo, che si era impadronito del regno, aveva ucciso i suoi altri figli e glieli aveva ammanniti a un banchetto al quale lo aveva invitato con l’inganno.
Nella trilogia dell’Orestiade, la prima tragedia, Agamennone, narra come Agamennone, di ritorno dalla guerra, venga ucciso a colpi di scure dalla moglie Clitennestra, con l’aiuto di Egisto.
Le Coefore prende il nome dalle coefore, le portatrici di libagioni per i defunti, che si recano sulla tomba di Agamennone. È il racconto di come Oreste, dieci anni dopo l’omicidio del padre Agamennone, torni ad Argo e, su ordine di Apollo, porti a compimento la propria vendetta dando la morte alla propria madre ed al suo amante.
Subito appaiono le Erinni, dee vendicatrici dei delitti. Inseguito da loro, Oreste fugge, sotto gli sguardi stupiti del coro, che non può vedere le terribili dee (si tratta infatti di oggetti interni nota M. Klein).
Le Eumenidi prende il nome dalle Erinni, nate dal sangue della castrazione di Urano a opera di suo figlio Cronos, dee vendicatrici dei crimini verso la famiglia, le quali erano chiamate anche Eumenidi (ossia “le benevole”) quando erano in atteggiamento positivo. In questa terza parte dell’Orestea viene narrata la lunga persecuzione delle Erinni nei confronti di Oreste.
Oreste e le Erinni. Orestiade. Teatro greco di Siracusa. Regia di Davide Livermore, 2022.
Braccato dalle Erinni per il matricidio, Oreste chiede aiuto al dio Apollo che lo invia ad Atene, presso il tempio della dea Atena. Prima dell’inizio del processo, le Erinni riflettono preoccupate sulle conseguenze di una possibile assoluzione di Oreste: questo fatto potrebbe indurre alla licenza tutti i mortali, e causare un forte aumento degli omicidi tra consanguinei.
Le Erinni interrogano Oreste che si difende spiegando di aver agito per una vendetta legittima, e su ordine di Apollo. Quest’ultimo poi interviene difendendolo: il figlio ha lo stesso sangue del padre e quindi ha il diritto di vendicarlo. Con il voto favorevole di Atena, Oreste viene assolto.
Le Erinni reagiscono con rabbia alla sentenza, minacciando a più riprese morte e distruzione. Atena tuttavia riesce a calmarle e, garantendo loro venerazione eterna, le convince a diventare Eumenidi, ovvero divinità della giustizia anziché della vendetta.
Nella lettura kleiniana della trilogia è la declinazione edipica a strutturare e organizzare gli eventi interni ed esterni dei protagonisti. Ne sono esempi l’edipo invertito di Oreste nei confronti di un padre idealizzato con il quale si identifica spostando l’odio su Egisto, l’amante della madre, come quello delle Erinni nei confronti della loro madre la Notte che invocano a loro protezione contro Apollo, il dio del sole. L’Orestiade dà però agio a M. Klein di connettere questa analisi con le sue tematiche di fondo, le angosce persecutorie innanzitutto.
“Il bambino che ha un rapporto di amore con la madre, inconsciamente ha il terrore di essere divorato, fatto a pezzi e distrutto da lei. Queste angosce, pur se modificate da un crescente senso della realtà, continuano a prodursi in maggiore o minor misura per tutto il periodo della prima infanzia. [...] Fanno parte della posizione schizo-paranoide [... che] comporta [...] anche forti impulsi distruttivi (la proiezione dei quali crea oggetti persecutori) e scissione della figura della madre in una parte malvagia e in una parte buona idealizzata” (Klein 1959, 40). Su questa base si svilupperanno il risentimento, i sentimenti di deprivazione, come anche l’ammirazione e l’invidia, prima nei confronti della madre e poi anche del padre.
La tragedia appunto mette in scena Clitennestra che uccide Agamennone facendolo a pezzi con una scure e sappiamo che i fratellastri di Egisto furono uccisi e cucinati da Atreo per farli mangiare al loro padre Tieste. Ifigenia fu sacrificata dal padre per avere venti favorevoli alla partenza per Troia, Oreste fu allontanato da casa dalla madre dopo la partenza di Agamennone, non sappiamo se per proteggerlo - spesso i figli dei re venivano uccisi per assicurarsi un potere duraturo dopo che ci si era liberati dei padri - o se per avere la libertà di stare con Egisto.
Processi simbolici e creativi
Sappiamo che nel corso della sua ricerca M. Klein aveva sempre posto in connessione la possibilità del prodursi dei processi simbolici e creativi con il raggiungimento della posizione depressiva e della capacità di riparazione. E molti autori ancor oggi sono rimasti ancorati a queste sue formulazioni. In questo lavoro, uno dei suoi ultimi, assistiamo ad un mutamento, meglio forse ad un ampliamento, di queste sue precedenti affermazioni. Il cambiamento si annuncia in più punti.
Ad esempio quando afferma che la scissione dell’oggetto può riuscire solo fino a un certo punto e per questo il bambino non può sfuggire ai sentimenti di colpa, che insieme alle esperienze di sofferenza, depressione e di accresciuto amore per l’oggetto risveglieranno il bisogno di riparazione. “Tutti questi processi sono connessi con la tendenza del bambino verso la formazione del simbolo e fanno parte delle sue fantasie inconsce” (Klein 1959, 41).
Dove M. Klein afferma che “tutti questi processi”, quindi anche le scissioni, conducono alla produzione di simboli e di fantasie.
Klein ritrova anche nel “ritmo” di hubris (l’arroganza) che non conosce limiti ed è basata sull’avidità - in questo caso si tratta dell’ubriacatura di potere - con Dike, la giustizia che punisce con la morte, un diverso alternarsi delle posizioni ps/d. Così avviene per l’impietoso Agamennone, così avviene per la tracotante Clitennestra, è Klein a citare questo suo dire, una sorta di aforisma dell’hubris: “Chi ha paura dell’invidia ha paura di essere grande” (Klein 1959, 48). Ma, attenzione, lo cita a proposito delle possibili inibizioni del talento e delle potenzialità causate dal senso di colpa. È un secondo indizio, insieme alla precedente sottolineatura di “tutti questi processi” di quell’importante cambiamento del suo pensiero relativamente al prodursi dei processi simbolici e creativi che essa consegna a quest’opera.
Infatti se in un primo tempo Klein aveva ritenuto che la formazione dei simboli nella posizione depressiva fosse dovuta prevalentemente all’inibizione degli impulsi istintuali diretti, prevalentemente aggressivi, nei confronti dell’oggetto, di modo che questi risultassero disponibili per la sublimazione, “solamente nei lavori più maturi Klein riconoscerà che le parti scisse del Sé e degli oggetti, proiettate all’esterno poiché fonte di angoscia e di dolore, posseggono ‘elementi preziosi della personalità e della vita di fantasia e sono anche fonte di ispirazione nell’attività artistica e di numerose altre attività intellettuali’ (Klein, 1958, 550), ammettendo così l’esistenza di un legame tra i processi più precoci della mente e la produzione simbolica dell’adulto e pertanto che questa non è dovuta esclusivamente alla riparazione” (Calamandrei 2016, 279).
Si tratta in fondo della evoluzione dello straordinario e, spazialmente e temporalmente, ubiquitario potere, proto-rappresentativo e proto-narrativo, assolutamente strutturante per la psiche, della fantasia inconscia.
Freud aveva in un certo senso anticipato queste riflessioni, quando nella Postilla a Psicologia delle Masse e analisi dell’Io, a proposito di una sua riflessione sull’orda primordiale aveva scritto:
“La cocente privazione fu forse ciò che indusse uno dei singoli a svincolarsi dalla massa e a trasporsi nel ruolo del padre. Chi fece questo fu il primo poeta epico, e il passaggio si compì nella sua fantasia. Il poeta contraffece la realtà accordandola alla propria nostalgia. Inventò il mito eroico. Eroe fu colui che da solo aveva ammazzato il padre, il quale nel mito appariva ancora come mostro totemico. Come il padre era stato il primo ideale del bimbo maschio così ora nell’eroe, che vuole sostituire il padre, il poeta creò il primo ideale dell’Io” (Freud 1921, 322-323).
Riproponendo in questa ipotetica narrazione il passaggio dal fatto alla fantasia nella filogenesi, così come era accaduto per l’ontogenesi: dall’incesto alla fantasia dell’incesto, “Non credo più ai miei neurotica!”. Ma anche connettendo direttamente simbolizzazione e sublimazione e transitando attraverso quella visionarietà che è generata e governata dagli affetti.
Il suo Eroe soggiace alla rimozione, idealizzato, idealizzante, non potrà sfuggire alla persecutorietà, anche se uccide, legittimamente, mostri e non padri:
Ercole a ripetizione e gli costerà la salute mentale...
Edipo ucciderà scientemente la Sfinge e poi Laio, quasi per caso.
Teseo il Minotauro e poi il padre “per distrazione”.
Oreste, creatura di Eschilo, il primo dei tragediografi, è l’unico ad uccidere “consapevolmente” l’amante della madre (sostituto del padre) e poi la madre stessa: avant-coup del trauma mitico, dell’assassinio fondante.
“Dal momento in cui all’inizio della vita post-natale, le fantasie riempiono la vita mentale, compare un forte impulso a riferirle a diversi oggetti - reali o fantastici - che divengono simboli e procurano uno sbocco alle emozioni del bambino piccolo. [...] L’impulso a creare simboli è così forte perché neanche la madre più amorevole può soddisfare i potenti bisogni emozionali del bambino piccolo. [...] Solo se nell’infanzia la formazione del simbolo è in grado di svilupparsi con tutta la sua forza e in tutta la sua varietà e se non è ostacolata da inibizioni, allora l’artista adulto può fare uso delle forze emozionali che sono alla base del simbolismo (Klein 1959, 76-7).
“Quando [il bambino] può dire “maman”
A proposito di L’enfant et les sortilèges, l’opera di Ravel su libretto di Colette, sulla quale Melanie Klein nel 1929 scrisse un breve e densissimo saggio Situazioni d’angoscia infantile espresse in un’opera musicale e nel racconto di un impeto creativo, Julia Kristeva così commenta la conclusione dell’opera, quando appunto il bambino può dire “maman”. Il bambino aveva attaccato, danneggiato e anche distrutto oggetti e animali. Gli animali lo rimproverano e lo attaccano, come le Erinni. Nel parapiglia anche lo scoiattolo viene ferito e il bambino lo cura fasciandogli la zampa, a sua volta viene ferito e invoca la madre. Gli animali constatando che il bambino è buono, “È buono il bambino, è bravo, molto bravo. È così dolce”, si trasformano in oggetti soccorrevoli e lo conducono verso la casa, chiamando anche loro la madre, così come le Erinni si erano trasformate in Eumenidi.
“Quando [il bambino] può dire ‘maman’ non si tratta più di un’osmosi con sua madre intrisa di godimento e di rabbia: chiamandola mette a distanza i desideri ambivalenti che la concernono. [...] Meravigliosamente chiarito dalla perspicacia di Melanie Klein il genio di Colette traccia qui la via che conduce al superamento della colpa propria di questo edipo arcaico con una madre onnipotente, e trasforma le attitudini rabbiose, come i disturbi maniacali o del carattere, ma anche le psicosi infantili, in una riparazione. Ma questa evoluzione benefica si produce se - e soltanto se - un riconoscimento del desiderio edipico e delle sue ambivalenze ha avuto luogo. Per Klein questo riconoscimento prende l’aspetto di un’esperienza depressiva: io scopro che il mio desiderio per Maman è un desiderio di ucciderla, che Eros è Thanatos. Edipo? Forse; io sono soprattutto ancora un Oreste, ma il saperlo mi rende libero: io accetto di perdere Maman il mio dispiacere significa che io assumo il mio desiderio per essa e questa rinuncia è la via regia della mia autonomia, di dire, della mia capacità di pensare, di creare, di vivere” (mia traduzione) (Kristeva 2002, 178).
Nella sua disamina del concetto di sublimazione nella letteratura psicoanalitica Evelyne Sechaud (2005) scrive:
“La preoccupazione di risparmiare l’oggetto indirizza le pulsioni primitive in una nuova direzione e inibisce le pulsioni primitive di distruzione e di autodistruzione. E’ in questa fase depressiva che Melanie Klein colloca la genesi della formazione dei simboli. Lo spostamento dello scopo istintuale comporta il rimpiazzo dell’oggetto originario della pulsione con degli oggetti sostitutivi: è così che la sublimazione si collega alla formazione del simbolo” (Sechaud 2005, 1345).
Ma c’è di più, a partire dal discorso kleiniano, Sechaud, riprende il testo di Kristeva consacrato a Melanie Klein a proposito dell’idea che è dalla perdita della madre (che nell’immaginario rimanda alla morte della madre) che si organizza la capacità simbolica del soggetto.
Appoggiandosi al dramma di Oreste, Melanie Klein fa del matricidio la condizione per accedere al simbolo; e Julia Kristeva si chiede: “Il dramma di Oreste le serve forse per introdurre il suo pensiero sulla nascita dei simboli, un’apologia dei simboli? Oppure la divagazione mitologica serve per dire che il simbolo è l’omicidio della madre? O ancora che non esiste migliore omicidio della madre che il simbolo?” (Kristeva 2000, 148). “Assassinio immaginario evidentemente!” Ci rassicura Sechaud (2005, 1345). “I crimini e altri passaggi all’atto più o meno aggressivi non sono che fallimenti del simbolo, segnalano uno scacco del matricidio immaginario, l’unico ad aprire la strada del pensiero” (Kristeva 2000, 148).
Postilla
Ritrovo qualcosa di molto simile in La ragazza dello Sputnik (1999) di Murakami Haruki, in un dialogo fra i due protagonisti, Sumire aspirante scrittrice e il giovane narratore senza nome della storia, innamorato di lei.
“Ho la testa piena di cose che vorrei scrivere. E’ come un assurdo magazzino tutto stipato di roba, - disse Sumire. - Immagini, scene, frammenti di discorsi, figure di persone ... a volte queste cose sono così scintillanti, piene di vita e sento che mi urlano: Scrivici! In quei momenti mi sembra che stia per nascere un romanzo meraviglioso. [...] Ma appena provo a scrivere, mi rendo conto che qualcosa di essenziale è andato perduto [...] Forse mi manca qualcosa. Qualcosa di assolutamente essenziale per diventare uno scrittore.”
[Così le risponde il narratore:]
“Nell’antica Cina intorno alle città si erigevano delle alte muraglie, nelle quali venivano costruite delle grandiose e splendide porte [...] A queste porte era attribuito un significato molto importante. Il loro scopo non era solo quello di permettere alla gente di entrare e uscire, ma si credeva che in esse abitassero gli spiriti della città. [...] Sai come facevano gli antichi cinesi a costruirle? [...] Andavano nei luoghi dove in passato si erano svolte delle battaglie e lì raccoglievano tutte le ossa sparse per terra o sepolte che riuscivano a trovare. [...] Poi all’ingresso delle città costruivano delle enormi porte dove venivano incastonate le ossa. Gli abitanti speravano che, grazie a questo tributo in loro onore, i soldati defunti avrebbero protetto le loro città. Ma non era ancora abbastanza. Finito di costruire le porte, radunavano un certo numero di cani vivi e con il pugnale gli tagliavano la gola. Quindi versavano il loro sangue ancora caldo sulle porte. Mischiando le ossa consumate e il sangue fresco, gli antichi spiriti avrebbero acquistato un potere magico. [...] Scrivere romanzi è un po’ la stessa cosa, puoi raccogliere tutte le ossa che vuoi, costruire la porta più splendida del mondo, ma ciò non basta a produrre un romanzo che sia vivo. Una storia, in un certo senso non appartiene a questo mondo. Per creare una vera storia è necessario un battesimo magico che riesca a mettere in contatto questo mondo con quell’altro.
 Cioè vorresti dire che anch’io devo trovarmi il mio cane.
Cioè vorresti dire che anch’io devo trovarmi il mio cane.Annuii.
 e che devo far scorrere il suo sangue caldo [...]. Se possibile vorrei evitare di uccidere animali - disse infine.
e che devo far scorrere il suo sangue caldo [...]. Se possibile vorrei evitare di uccidere animali - disse infine.- Naturalmente intendevo solo in senso metaforico... non voglio mica farti uccidere veramente un cane” (Murakami 1999, 18-19).
Gli elementi indispensabili all’accesso alla creatività ci sono tutti e coincidono:
la necessità del contatto [di] questo mondo con quell’altro: la comunicazione conscio inconscio;
le ossa rimaste dalle battaglie: i resti dei violenti scontri con “le parti scisse del Sé e degli oggetti, proiettate all’esterno poiché fonte di angoscia e di dolore”;
il sangue dei cani sacrificati: l’uccisione (rituale) necessaria.
Naturalmente intendevo solo in senso metaforico. “Assassinio immaginario evidentemente!”
Bibliografia
Calamandrei S. (2016). L’identità creativa. Milano, FrancoAngeli.
Colette (1915). L’enfant et les sortilèges. L’0rchestra virtuale del Flaminio. flaminioonline.it
Freud S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’Io. OSF 9.
Klein M. (1929). Situazioni d’angoscia infantile espresse in un’opera musicale e nel racconto di un impeto creativo. In Scritti 1921-1958. Torino, Boringlieri.
Klein M. (1958). Sullo sviluppo dell’attività psichica. In Scritti 1921-1958. Torino, Boringhieri.
Klein M. (1959). Alcune riflessioni sull’Orestiade. In Il nostro mondo adulto e altri saggi. Firenze, G. Martinelli & C., 1991.
Kristeva J. (2000). Il genio femminile, t. II: Melanie Klein. Roma, Donzelli Editore, 2010.
Kristeva J. (2002). Le génie féminin, t. III: Colette, Paris, Gallimard, 2004.
Murakami Haruki (1999). La ragazza dello Sputnik. Torino, Einaudi, 2001.
Sechaud É. (2005). Perdre sublimer... Rev. Franç. Psychanal. 69(5): 1309-1379.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"! --- Ripartire dall’opera di Maurice Ravel e Colette, "L’Enfant et les sortilèges": un saggio psicoanalitico in musica (di Franca Munari).31 marzo 2022, di Federico La Sala
PSICOANALISI ANTROPOLOGIA FILOSOFIA E FIABA. TRACCIA PER UNA SECONDA RIVOLUZIONE COPERNICANA... *
L’Enfant et les sortilèges: un saggio psicoanalitico in musica
Opera in due parti di Maurice Ravel su libretto di Colette
di Franca Munari (Centro Veneto di Psicoanalisi)
- [Foto] L’Enfant et les sortilèges di Ravel
L’Enfant et les sortilèges è un’opera composta da Maurice Ravel fra il 1919 ed il 1925, su libretto di Colette. Si tratta della seconda ed ultima opera lirica di Ravel. Capolavoro di orchestrazione, L’Enfant et les sortilèges viene spesso eseguita in forma di concerto anche per le difficoltà della sua messa in scena. Fu rappresentata per la prima volta il 21 marzo 1925 nella Salle Garnier del Grand Théâtre di Montecarlo, orchestra diretta da Victor de Sabata, coreografia di George Balanchine, regia di Raoul Gunsbourg.
E’ composta da una successione di quadri indipendenti costituiti da una moltitudine di generi musicali, dal jazz al foxtrot passando per il ragtime, la polka, il valzer ed infine un coro di musica sacra. Con quest’opera Ravel ebbe modo di dimostrare le sue capacità di compositore e di orchestratore, che gli consentirono di tradurre in suoni tutte le onomatopee contenute nel libretto di Colette, utilizzando spesso come strumenti oggetti inconsueti come la grattugia per il formaggio, la raganella a manovella, la frusta, i crotali, un ceppo di legno, o strumenti desueti come eoliofoni, flauto a coulisse ed il nuovissimo, per l’epoca, e originale luthéal. Più vicino alle attuali commedie musicali che ad un’opera, L’Enfant et les sortilèges è un lavoro senza precedenti nel repertorio di Ravel: esprime la sensibilità del compositore e nello stesso tempo rivela il suo gusto per l’incantesimo e la minuziosità della sua orchestrazione.
Straordinaria l’animazione - e raramente questa parola fu più appropriata - degli oggetti concreti di Colette e la loro trasposizione in musica di Ravel. Walt Disney con le sue Silly Simphony (1929-1939) e poi con Fantasia (1940) era ancora di là da venire.
Il libretto.
C’è un bambino nella sua stanza
Il Fanciullo, sei o sette anni, siede al tavolino
Non ho voglia di fare i compiti
 Ho voglia di andare a passeggiare.
Ho voglia di andare a passeggiare.
 Ho voglia di mangiare tutti i dolci.
Ho voglia di mangiare tutti i dolci.
 Ho voglia di tirare la coda al gatto.
Ho voglia di tirare la coda al gatto.
 E di tagliare quella dello scoiattolo
E di tagliare quella dello scoiattoloHo voglia di sgridare tutti!
 Ho voglia di mettere la mamma in castigo.
Ho voglia di mettere la mamma in castigo.
Nella descrizione della madre che entra nella stanza, madre di cui si vede solo la parte inferiore del corpo le indicazioni di scena dicono:
 “S’apre la porta. Entra la Madre, o piuttosto quello che ne permettono di vedere il soffitto molto basso e le proporzioni della scena, ove tutti gli oggetti sono di dimensioni esagerate per mettere in evidenza la piccolezza del Fanciullo: cioè una giubba, la parte inferiore d’un grembiule di seta, la catenella d’acciaio da cui pende un paio di forbici, e una mano. Questa mano s’alza, interroga con l’indice.”
“S’apre la porta. Entra la Madre, o piuttosto quello che ne permettono di vedere il soffitto molto basso e le proporzioni della scena, ove tutti gli oggetti sono di dimensioni esagerate per mettere in evidenza la piccolezza del Fanciullo: cioè una giubba, la parte inferiore d’un grembiule di seta, la catenella d’acciaio da cui pende un paio di forbici, e una mano. Questa mano s’alza, interroga con l’indice.”La madre sgrida e punisce il bambino che non ha fatto i compiti e ha sporcato di inchiostro il tappeto, dandogli solo tè senza zuchero e pane secco per merenda.
Quando la madre se ne va il bambino “Con un manrovescio fa saltare la teiera e la tazza, che vanno in pezzi. S’arrampica sulla finestra, apre la gabbia dello Scoiattolo e con la sua penna di ferro punge la bestiola che, ferita, stride e scappa via; poi tira la coda al Gatto, che soffia e si nasconde sotto una poltrona. Impugna l’attizzatoio come una spada, sparpaglia il fuoco, rovescia il bricco. S’avventa contro le figurine della tappezzeria lacerandole. Apre la cassa dell’orologio e si aggrappa al bilanciere d’ottone, che si stacca e gli resta fra le mani. Poi fa a pezzi quaderni e libri.”
Gli oggetti maltrattati gli si rivoltano contro.
- [Foto] L’enfant et les sortilèges par l’opéra de Lyon (1999)
IL FUOCO
Saltellando fuori del camino, sottile, scintillante di pagliuzze d’oro:
Indietro!
 Io riscaldo i bravi bambini, ma brucio i cattivi!
Io riscaldo i bravi bambini, ma brucio i cattivi!
 Piccolo barbaro impudente,
Piccolo barbaro impudente,
 tu hai insultato tutti gli Dei protettori,
tu hai insultato tutti gli Dei protettori,
 che stanno fra l’infelicità e la tua
che stanno fra l’infelicità e la tua
 fragile barriera.
fragile barriera.
 Ah! Tu hai brandito l’attizzatoio,
Ah! Tu hai brandito l’attizzatoio,
 rovesciato il bollitore,
rovesciato il bollitore,
 sparpagliato i fiammiferi, attenzione!
sparpagliato i fiammiferi, attenzione!
 Attenzione al Fuoco che danza!
Attenzione al Fuoco che danza!
 Tu fonderai come un fiocco
Tu fonderai come un fiocco
 sulla sua lingua scarlatta!
sulla sua lingua scarlatta!
 Ah! Attenzione! Io riscaldo i bambini buoni!
Ah! Attenzione! Io riscaldo i bambini buoni!
 Attenzione! Brucio quelli cattivi!
Attenzione! Brucio quelli cattivi!
 Attenzione! Attenzione! Attento a te!
Attenzione! Attenzione! Attento a te!IL FANCIULLO
Ho paura, ho paura!
A questo punto compaiono la gatta e il gatto di casa che la corteggia.
Approcci, ripulse, schermaglie
IL GATTO E LA GATTA
nhou! Mòrnàou, nàour, moàou!
 Monhin! Méràhon!
Monhin! Méràhon!In realtà i gatti hanno un vero e proprio amplesso, la musica lo descrive chiaramente, e nella realizzazione scenica il bambino li guarda attonito e anche spaventato.
- [Foto] L’enfant et les sortilèges par l’opéra de Lausanne (2014)
Uscito in giardino il bambino viene rimproverato dalle bestie per aver separato le coppie della libellula e del pipistrello, e perché i piccoli del pipistrello sono rimasti senza madre.
IL FANCIULLO
Senza madre!...
 [Guardando il gatto e la gatta che si fanno le coccole e le altre coppie di animali]
[Guardando il gatto e la gatta che si fanno le coccole e le altre coppie di animali]
 Si amano. Sono felici. Non si curano di me...
Si amano. Sono felici. Non si curano di me...
 Si amano... non si curano di me... io sono solo...
Si amano... non si curano di me... io sono solo...
 Mamma!...
Mamma!...LE BESTIE
Ah! c’è il Bambino col coltello!
 C’è il Bambino con il bastone!
C’è il Bambino con il bastone!
 Il bambino cattivo della gabbia!
Il bambino cattivo della gabbia!
 Il bambino cattivo della reticella!
Il bambino cattivo della reticella!
 Quello che non ama nessuno
Quello che non ama nessuno
 e che nessuno ama.
e che nessuno ama.
 Dobbiamo fuggire?
Dobbiamo fuggire?
 No! Bisogna castigarlo.
No! Bisogna castigarlo.
 Io ho i miei artigli!
Io ho i miei artigli!
 Io ho i miei denti!
Io ho i miei denti!
 Io le mie ali dotate di unghie!
Io le mie ali dotate di unghie!
 Uniamoci, uniamoci! Ah!
Uniamoci, uniamoci! Ah!Gli oggetti attaccati diventano persecutóri
- [Foto] L’enfant et les sortilèges par l’opéra de Lyon (1999)
Si fanno tutte addosso al Fanciullo per ferirlo; nella lotta si feriscono anche fra loro. Il Fanciullo cade a terra malconcio. Quasi nello stesso tempo un piccolo scoiattolo, ferito nella mischia, gli cade accanto con un grido acuto. Il Fanciullo si toglie un nastro dal collo e fascia la zampa ferita dello Scoiattolo, poi ricade senza forze. Silenzio e stupore delle bestie
LE BESTIE
(esitando, in sordina)
ma...mma
LE BESTIE
È buono, il bambino, è bravo, molto bravo, è
 così bravo e così buono.
così bravo e così buono.
 Ha medicato la ferita, tamponato il sangue.
Ha medicato la ferita, tamponato il sangue.
 È bravo, così bravo, così dolce.
È bravo, così bravo, così dolce.
 È buono il bambino, è bravo, molto bravo.
È buono il bambino, è bravo, molto bravo.
 È così dolce
È così dolceIL FANCIULLO
(tendendo le braccia)
Mamma!
(Una luce si accende dietro i vetri nella casa. Nello stesso tempo la luna, non velata da nubi, e i riflessi rossi e d’oro del sole tramontato, inondano il giardino di limpida chiarezza. Canto di usignoli, mormorio di alberi e di bestie. Le bestie, ad una ad una, ritirano al Bambino il loro aiuto diventato inutile, sciolgono armoniosamente, con rimpianto, il loro gruppo che si era stretto attorno a lui, ma continuano a scortarlo, anche se da un po’ più lontano: gli fanno festa con lo sbatter delle ali, con capriole di gioia, e poi, fermando all’ombra degli alberi il loro benevolo corteo, lasciano il Bambino solo. In piedi, luminoso e biondo, in un alone di luna e di aurora, tende le sue braccia verso ciò che le bestie hanno chiamato «Mamma!»)
La dichiarazione del bambino relativa alla sua sofferenza per l’esclusione edipica: “Si amano. Sono felici. Non si curano di me...” sembra far infuriare tutti gli animali che ha attaccato, fino a quando lui non fascia con la sua sciarpa la zampa dello scoiattolo che nel parapiglia si è ferito. Le bestie si arrestano vedendo che lo ha fatto e lo aiutano cercando di riportarlo a casa dove potranno aiutarlo.
Questa “favola” e il lavoro di Melanie Klein su di essa, Situazioni d’angoscia infantile espresse in un’opera musicale e nel racconto di un impeto creativo mi tornano sempre alla mente quando lavorando mi accade di assistere ad una situazione o una fase di distruttività rabbiosa, e in qualche modo disperata, di un paziente, adulto o bambino.
Melanie Klein non vide questa rappresentazione, ma lesse la recensione della sua messa in scena berlinese, dove portava il titolo di La parola magica, fatta da Eduard Jakob sul Berliner Tageblatt dal quale prese il contenuto dell’opera e presentò questo lavoro, alla Società britannica di psicoanalisi il 15 maggio 1929. (Munari 2021)
- “I risultati del mio lavoro mi hanno indotta a concludere che la fase in cui il sadismo è al suo culmine in tutte le zone erogene da cui trae origine, precede il primissimo stadio anale, e che essa assume un’importanza speciale per il fatto di coincidere con lo stadio di sviluppo nel quale compaiono per la prima volta le tendenze edipiche. Ciò vuol dire che il conflitto edipico esordisce sotto il dominio assoluto del sadismo. La mia tesi che la formazione del Super-io si conforma strettamente fin dal principio alle tendenze edipiche e che pertanto l’Io cade sotto il potere del Super-io già in età molto precoce spiega, a mio parere, perché questo potere ha una forza tanto tremenda da far sì che, quando gli oggetti sono introiettati, gli attacchi sferrati contro di essi con tutte le armi del sadismo suscitino nel soggetto la paura di subire attacchi dello stesso tipo da parte degli oggetti esterni e di quelli interiorizzati.”(Klein 1929, 341)
La cosa straordinaria è la costanza nella clinica del ritrovamento e della ripetizione della costellazione di questi temi a contenuto distruttivo, ovviamente diversamente declinati e diversamente rappresentati in scene a seconda del soggetto, seguiti da elementi intensamente persecutori, fino, attraverso il lavoro analitico, a una riparazione finalmente possibile. Proprio come in questa favola, in cui Colette si fa letteralmente “psicoanalista di bambini”, così la definisce Julia Kristeva nel volume a lei consacrato, di Il genio femminile (2002).
Bibliografia
Colette (19) L’enfant et les sortilèges. Trad. it. del libretto. L’orchestra virtuale del Flaminio. flaminioonline.it
Klein M. (1929) Situazioni d’angoscia infantile espresse in un’opera musicale e nel racconto di un impeto creativo. In Scritti 1921-1958, Boringhieri, Torino.
Kristeva J. (2002) Le génie féminin, t. III: Colette, Paris, Gallimard, 2004
Munari F. (2021) Favole: L’enfant et les sortilegès. Le trame dell’edipo. Centro Veneto di Psicoanalisi, 23 gennaio 2021
Ravel M. Colette L’enfant et les sortilèges. Par Opera de Lyon. youtube
Ravel M. Colette L’enfant et les sortilèges. Par Opera de Lausanne. youtube
*
NOTA: RIPARTIRE DAL BAMBINO. ...
Ricordando il lavoro su "Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe" (Bruno Bettelheim, 1976), un gran plauso a Franca Munari per la ripresa della riflessione su "L’Enfant et les sortilèges", opera composta da Maurice Ravel fra il 1919 ed il 1925, su libretto di Colette (pseudonimo di Sidonie-Gabrielle Colette) intitolato inizialmente "Divertissement pour ma fille"!
Tenendo ferme acquisizioni già presenti nel "lavoro di Melanie Klein su di essa" (1929), Munari formidabilmente così commenta: "La cosa straordinaria è la costanza nella clinica del ritrovamento e della ripetizione della costellazione di questi temi a contenuto distruttivo, ovviamente diversamente declinati e diversamente rappresentati in scene a seconda del soggetto, seguiti da elementi intensamente persecutori, fino, attraverso il lavoro analitico, a una riparazione finalmente possibile. Proprio come in questa favola, in cui Colette si fa letteralmente “psicoanalista di bambini”, così la definisce Julia Kristeva [...]".
Detto questo, a ben vedere, c’è solo da ripartire dal Bambino e (almeno e ancora!) del gioco del rocchetto ... dare il via a una seconda rivoluzione copernicana non solo in filosofia, ma anche in psicoanalisi! Se non ora, quando?!
Freud (come Mosé) non ha cercato di nascere a sé stesso oltre sé stesso e salvarsi dalla claustrofilia?!
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo" --- Riprendere il filo del discorso dalle riflessioni “fallimentari” di Freud sul “caso clinico di Dora” o, se si vuole e meglio, della “Madonna Sistina".9 settembre 2020, di Federico La Sala
ANTROPOLOGIA, PSICOANALISI, E POLITICA
ALTRO CHE LACAN, "RITORNARE" A FREUD E AD ALESSANDRO MANZONI...
FORSE è meglio riprendere il filo del discorso dalle riflessioni “fallimentari” di Freud sul “caso clinico di Dora” o, se si vuole e meglio, della “Madonna Sistina”(cfr. S. Freud, “Frammento di un’analisi d’isteria”, 1901/1905) e, rianalizzando la ‘possessione’ di Lacan per “L’origine del mondo” di Courbet, ripartire dalle indicazioni critiche di Alessandro Manzoni sul caso della monaca di Monza e di un’antropologia zoppa e cieca - edipica, appunto - fondata sull’ordine simbolico della madre. Vogliamo o non vogliamo uscire dalla caverna?! O no?! Sapere aude!
Federico La Sala
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- L’orizzonte "cosmoteandrico" e la "sacra" famiglia imperiale costantiniana.3 gennaio 2020, di Federico La Sala
“DE DOMO DAVID”?! GIUSEPPE, MARIA, E L’IMMAGINARIO “COSMOTEANDRICO” (COSMOLOGIA, TEOLOGIA, E ANTROPOLOGIA!) DELLA CHIESA CATTOLICO-COSTANTINANA... *
- Nota di commento a margine di "De Domo David. 39 autori per i 400 anni della confraternita di San Giuseppe di Nardò" (cfr. "Fondazione Terra d’Otranto", 10.11.2019).
CARDINALE CASTRILLON HOYOS: “Duemila anni fa, un ovulo fu miracolosamente fecondato dall’azione soprannaturale di Dio, da questa meravigliosa unione risultò uno zigote con un patrimonio cromosomico proprio. Però in quello zigote stava il Verbo di Dio”(dichiarazione del Cardinale Dario Castrillon Hoyos alla XV conferenza internazionale del Pontificio consiglio, la Repubblica del 17 novembre 2000, p. 35)
PAPA FRANCESCO: “«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4,4). Nato da donna: così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto ma, come ci ha detto il Vangelo, è stato «concepito nel grembo» (Lc 2,21): lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Nel grembo di una donna Dio e l’umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più: anche ora, in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c’è la nostra carne umana! [...]” (LIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, Omelia di papa Francesco, Basilica Vaticana, Mercoledì, 1° gennaio 2020).
*
A) - La costruzione del ’presepe’ cattolico-romano .... e la ’risata’ di Giuseppe!!!
 MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;
MEMORIA DI FRANCESCO D’ASSISI. “VA’, RIPARA LA MIA CASA”!!!;B) Il magistero della Legge dei nostri Padri e delle nostre Madri Costituenti non è quello di “Mammona” (“Deus caritas est”, 2006)! EUROPA: EDUCAZIONE SESSUALE ED EDUCAZIONE CIVICA. ITALIA “NON CLASSIFICATA”!!! Per aggiornamento, un consiglio di Freud del 1907.
C) GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di “pensare un altro Abramo”.
Federico La Sala
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Psicoanalisi e femminismo (di Luisa Muraro e Lucetta Scaraffia).3 dicembre 2019, di Federico La Sala
UNA CATTOLICA, UNIVERSALE, ALLEANZA "EDIPICA": L’ ORDINE SIMBOLICO DELLA MADRE REGNA ANCORA COME IN TERRA COSI’ IN CIELO...
Psicoanalisi e femminismodi Luisa Muraro e Lucetta Scaraffia *
Su Sette Corriere della sera del 22 novembre 2019 è apparso un articolo di Lucetta Scaraffia, Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi, chiarissimo in quello che dice. Potete leggerlo qui di seguito. È un testo di notevole interesse perché attira l’attenzione e fa luce sulla parte avuta dalla psicoanalisi nella rivoluzione femminista del ventesimo secolo. L’autrice finisce con un punto di domanda, giustamente, e invita così ad approfondire l’argomento.
Per parte mia ci tengo a dire che la “sconfitta” della psicoanalisi avviene su un antico campo di battaglia, quello dell’autorità della parola, autorità negata alle donne dal regime patriarcale, e campo di battaglia dalle donne tenacemente tenuto aperto attraverso i secoli. Parlo dell’isteria. Dedicandosi alla cura dell’isteria, Freud ha avuto il merito innegabile di essere entrato nel campo di battaglia e di sbagliare, sì, ma in un modo significativo: è il suo inconscio che lo fa sbagliare e lui finisce che se ne accorge. Se possiamo fare festa per la fine del discredito patriarcale e l’affermarsi di autorità femminile nella vita pubblica, qualcosa dobbiamo anche a lui. A sua volta, lui deve qualcosa, o molto, all’umanità femminile. (Luisa Muraro)
Corriere della sera - Sette, 22 novembre 2019
Ida, le molestie e la sconfitta della psicanalisi
di Lucetta Scaraffia *
Quando Ida ha acconsentito alla richiesta del padre, che voleva far curare da Freud i suoi strani disturbi (afonia, svenimenti, tosse continua), la ragazza sperava che il dottore avrebbe creduto alle sue parole, convincendo così anche suo padre che l’amico di famiglia Hanss Zellenka l’aveva molestata con insistenza e pesantemente, per mesi, suscitandole profondo turbamento e paura. Le molestie erano cominciate quando aveva solo tredici anni, e lei si era trovata invischiata in una situazione angosciosa: le vacanze con la famiglia Zellenka sul lago di Garda - dove la madre Pepina l’aveva accolta con un affetto e una simpatia che le mancavano in casa - nascondevano un segreto imbarazzante.
Pepina era in realtà l’amante del padre di Ida, un ricco industriale, che si era portato in vacanza la figlia per mascherare la relazione. E proprio mentre la ragazza cominciava ad accorgersene, diveniva oggetto di corteggiamenti e molestie da parte di Hanss, il marito di Pepina. È questa situazione difficile all’origine dei suoi disturbi di salute ma, come quasi tutte le giovani donne in casi analoghi, Ida ha paura di parlarne e si sente confusamente colpevole, finché un episodio più grave non la induce a raccontare tutto alla madre. Il padre, prontamente informato, convoca Hanss, il quale non solo nega indignato ma ritorce su Ida le accuse, consigliando di mandarla in cura da Freud.
Ferita dall’incomprensione paterna, Ida lo sarà ancor più dolorosamente da Freud che, dopo averla spinta a parlare, comprensivo - finalmente qualcuno la prendeva sul serio! - le aveva spiegato la sua complicata interpretazione dell’episodio. Secondo Freud le parole della ragazza rivelavano un suo amore edipico verso il padre, spostato poi su Hanss, e di conseguenza «lei non aveva affatto paura del signor Zellenka ma piuttosto di se stessa, e più precisamente della tentazione di cedere al signor Zellenka».
Ida reagisce a questa nuova cocente delusione interrompendo la cura con Freud, e proseguendo, sia pure con fatica, nella sua vita di donna che si sarebbe sposata, avrebbe avuto un figlio, avrebbe lavoratoe sarebbe scampata alla persecuzione nazista fuggendo prima a Parigi e poi negli Stati Uniti, dal figlio. Una vita dura e drammatica, che racconta alla nipote, autrice della bella biografia a lei dedicata. La vita di una donna che dal rifiuto dell’interpretazione di Freud ha tratto forza e coraggio. Una posizione totalmente diversa da quella che lo stesso Freud rivela concludendo la narrazione dell’analisi: «Promisi comunque di perdonarla per avermi privato della soddisfazione di guarirla radicalmente». E se invece Ida si fosse guarita da sola rifiutando l’interpretazione di chi non considerava vere le sue parole?
Ida è Dora, la protagonista del primo caso clinico di Freud, che su questo ha costruito la sua ipotesi sulle cause dell’isteria, considerando il caso come prova chiara e convincente della sua teoria del complesso di Edipo.
Agli occhi di una donna di oggi, invece, la vicenda di Ida appare solo come la drammatica storia di una ragazza molestata che non viene creduta dagli uomini ai quali si rivolge per avere aiuto. Il padre, probabilmente anche perché segnato da sensi di colpa nei confronti di Hanss, crede a questi piuttosto che alla figlia, mentre Freud dà credito al padre, e si lascia influenzare dal desiderio di trovare nei desideri edipici rimossi la causa dell’isteria. Le malattie di Ida, invece, rivelano piuttosto la sofferenza di una donna le cui parole non vengono ascoltate né rispettate. Una donna che non viene presa sul serio, proprio come tante altre sue contemporanee - ma anche molte più vicine a noi - che non hanno visto riconosciuto il valore delle loro parole.
La biografia di Ida (scritta dalla pronipote Katharina Adler, Ida, Sellerio 2019) rovescia la storia raccontata da Freud: non si tratta della prima paziente alla quale è stata diagnosticata e curata l’isteria, ma una delle tante - troppe - donne che hanno subito due forme di violenza, quella sessuale e quella contro la loro identità perché le loro parole non vengono credute. È la storia narrata dal punto di vista delle donne, che vedono le cose molto diversamente dagli uomini, ma non sono ascoltate.
C’è voluta una lunga battaglia, combattuta dalle donne, perché le parole delle vittime venissero ascoltate e prese seriamente in considerazione, perché le vittime stesse non fossero sempre considerate possibili complici della violenza - Ida aveva forse provocato, magari anche inconsapevolmente, come insinua Freud, il violento? - e venissero invece aiutate a superare il trauma, e risarcite.
Nell’ordinamento giuridico italiano gli articoli del codice Rocco, vigenti fino al 1996, punivano ogni tipo di violenza o molestia sessuale - sia sulle donne che sui minori - come «delitto contro la morale pubblica e il buoncostume». Tutelavano cioè quello che veniva considerato un bene collettivo e non la vittima. È stato solo nel 1996, grazie alle pressioni del movimento femminista, che viene promulgata la nuova legge per cui lo stupro diventa reato contro la persona, e di conseguenza l’attività sessuale riconosciuta come frutto di una libera scelta perché rientra nel diritto proprio dell’individuo.
Mentre nella fase precedente si collocava al primo posto la condizione di vita della comunità, che per il legislatore costituiva il massimo valore, oggi a essere valorizzata è invece la dimensione individuale di chi subisce il reato, divenuta il bene giuridico protetto dalla legge. Rivendicando la loro posizione di vittime della violenza, le donne capovolgono la situazione di debolezza in cui si trovavano, s’impadroniscono del potere di accusa, le loro parole si caricano di valore, e hanno finalmente diritto di essere ascoltate.
Oggi Ida troverebbe ascolto, Hanss verrebbe punito per molestie su una minore, e Freud non avrebbe più la possibilità di elaborare la sua teoria sull’isteria. Un caso in cui la psicanalisi, elemento fondamentale della nostra modernità, viene forse sconfitta dalla realtà che sta nelle parole delle donne?
(www.libreriadelledonne.it, 29 novembre 2019)
* Sul tema, nel sito, si cfr.:
DONNE, UOMINI E VIOLENZA: "Parliamo di FEMMINICIDIO". La crisi epocale dell’ordine simbolico di "mammasantissima" ("patriarcato": alleanza Madre-Figlio).
DONNE, UOMINI, E DISORDINE SIMBOLICO
"CHI" SIAMO NOI, IN REALTÀ. RELAZIONI CHIASMATICHE E CIVILTÀ: UN NUOVO PARADIGMA. CON MARX, OLTRE.
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
LO SPIRITO CRITICO E L’AMORE CONOSCITIVO. LA LEZIONE DEL ’68 (E DELL ’89).
Federico La Sala
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- “Il clown senza padre”. Intervento di Sergio Benvenuto al convegno "Il padre oggi".21 novembre 2019, di Federico La Sala
IL CLOWN SENZA PADRE
di Sergio Benvenuto (Le parole e le cose, 19 Novembre 2019)
- [Intervento tenuto al convegno Il padre oggi, 26-27 ottobre 2019, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma. Il convegno è stato organizzato dall’IPRS (Istituto Psicoanalitico per la Ricerca Sociale) e dall’IREP].
1.
Il film Joker di Todd Phillips, che circola attualmente in Italia, è tratto dai fumetti di Batman, ma in realtà è ispirato sia al romanzo di Victor Hugo L’uomo che ride, sia al film V for Vendetta di James McTeigue.
Il protagonista di Joker, Arthur, è un giovane comico fallito, con ricoveri psichiatrici nel suo pedigree, che si adatta a fare il clown di strada. Questo quasi-psicotico vive da sempre con la madre stramba, non ha mai conosciuto suo padre. A un certo punto Arthur si convince, credendo a rivelazioni della madre, di essere il figlio di un grande magnate, Thomas Wayne (questo è il nome del padre di Bruce Wayne, alias Batman, nei famosi fumetti; un padre assassinato). Wayne si candida a sindaco di Gotham, alias fumettistica di New York. La madre sostiene di essere stata l’amante di Wayne da giovane e di aver avuto da lui Arthur, figlio che il padre non ha riconosciuto. Ma secondo un’altra versione, Arthur sarebbe stato adottato dalla madre, che da piccolo avrebbe abusato di lui, fino a finire lei in manicomio. Non sapremo mai, fino alla fine del film, se Wayne è davvero il padre di Arthur o no. Arthur è marcato come figlio di NN.
Arthur, una sera, spara a tre yuppies che lo aggrediscono in metropolitana e li uccide. Si diffonde la voce in tutta l’America che uno mascherato da clown è l’assassino dei tre brokers. Ben presto questo clown giustiziere diventa un eroe per la massa dei diseredati di Gotham, che protestano contro il potere indossando tutti una maschera da clown che ride. È interessante che tutti i mascherati da clowns siano uomini. L’intera città è messa a ferro e fuoco da migliaia di clowns. Arthur, che nel frattempo ha ucciso la madre e varie altre persone, viene riconosciuto come l’assassino dei tre yuppies e glorificato dai clown ribelli. Nel frattempo un uomo, anch’egli mascherato da clown, uccide Wayne. Non dico il finale.
- [Foto] Arthur the Joker
Mi sono soffermato su questo film perché mi pare che esso esprima a suo modo il passaggio dal padre edipico freudiano a quello che chiamerei il nuovo Edipo, dove alla figura del padre si sostituisce una nuova figura pervasiva: quella del “potere”. O, come si dice in America, “the system”. Paolo Sorrentino, in un film recente, lo ha chiamato Loro. Chi sono Loro? Loro sono tutti coloro che hanno potere: i politici soprattutto, i ricchi, i grandi imprenditori, le star... Forse, col tempo, anche noi psicoanalisti... Tutti coloro che ormai vengono chiamati winners, di fronte ai quali soffre e si rode la massa dei losers.
2.
La figura del clown malinconico ha una storia secolare. I fools di Shakespeare hanno il compito di far ridere il re, ma di fatto seguono il re nella sua rovina. Dicono al re delle verità inascoltate perché amare. Il fool denuncia la follia dei re.
Gwynplaine è il protagonista di L’uomo che ride di Hugo, pubblicato nel 1869. Gwynplaine è stato rapito da piccolo in Inghilterra da furfanti i quali gli hanno fatto subire un’operazione al volto grazie a cui egli ha l’aria di ridere sempre. Viene adottato da un vagabondo che mette in scena poi uno spettacolo comico ambulante centrato sul ruolo ridanciano di Gwynplaine. Quindi l’agnizione: si scopre a un certo punto che il saltimbanco è in realtà il figlio di un lord d’Inghilterra. Il lord di Hugo corrisponde al magnate Wayne di Joker. Gwynplaine, riconosciuto nobile, farà un discorso alla Camera dei Lord in cui attaccherà i loro privilegi, ma farà solo ridere....
La differenza importante tra il romanzo di Hugo e il film del 2019 è che in Hugo si scopre che Gwynplaine è veramente figlio di un lord, mentre in Joker si ha l’impressione che il padre tycoon sia un delirio della madre. Inoltre, in Joker si compie un parricidio che non accade nel romanzo di Hugo, anche se esso viene compiuto da un misterioso killer mascherato da clown. La rivolta dei diseredati con le maschere da pagliacci in Joker ricorda molto la rivolta cieca, senza fine e senza fini, dei gilets gialli francesi.
Una variante su questo tema è il film V for Vendetta del 2006. In un futuro distopico, un misterioso radicale anarchico, abbigliato come Guy Fawkes e con una maschera fissa in un riso costante, solleva i britannici contro un regime fascista oppressivo. Guy Fawkes fu l’artefice della fallita Congiura delle polveri del 1606, un evento rimasto memorabile nella tradizione popolare inglese: il complotto mirava a far esplodere il re James 1° d’Inghilterra e i membri del Parlamento, insomma tutto il sistema politico inglese. Tuttora il 5 novembre in Inghilterra si brucia l’effigie di Guy Fawkes. Evidentemente negli ultimi anni questa figura di iperbolico regicida si è ribaltata in un personaggio positivo - insomma, oggi si è dalla parte del “figlio parricida”. La maschera e il logo ‘V per Vendetta’ sono stati adottati da vari movimenti populisti, anche dal nostro Movimento 5 Stelle, guidato da un joker appunto, Beppe Grillo.
- [Foto] Maschera di Guy Fawkes
3.
In vario modo, tutte queste opere girano attorno al tema del parricidio, o all’uccisione di una figura potente. Il parricidio, la grande ossessione di Freud. Quasi ognuno di noi ha un’ossessione spirituale; quella di Freud era il parricidio. Esso è il senso ultimo dell’Edipo.
Freud stimava come massimi capolavori della letteratura occidentale tre opere: l’Edipo re di Sofocle, l’Amleto, e I Fratelli Karamazov di Dostojevskij. Li preferiva perché tutti e tre hanno a che fare con l’omicidio del padre, e inoltre il parricidio, diretto o indiretto, è legato alla rivalità tra padre e figlio per il possesso di una donna. Parricida è sempre il figlio maschio, perciò Freud ha parlato di Edipo e non di Edipo-Elettra, per esempio, come qualcuno ha proposto. Ovvero, anche la donna è “edipica”. Cosa che non è piaciuta a tante femministe. Ora, Freud fa del parricidio non solo la fantasia fondamentale di ogni soggetto, ma anche l’atto inaugurale della Kultur, della civiltà, ovvero della vita sociale, che per lui segna l’inizio anche della psiche individuale. La psiche, l’inconscio, per Freud è frutto di un evento storico, e questo evento è il parricidio. Non potendolo dimostrare, Freud ha fatto ricorso a ricostruzioni apertamente mitiche, che oggi non possono mancare di farci sorridere - molta acqua è passata sotto i ponti dei nostri metodi storiografici.
In Totem e tabù ha immaginato l’assassinio del padre dell’orda primordiale da parte dei suoi figli maschi coalizzati, allo scopo di dividersi equamente tra loro le donne dell’orda, che prima il padre-padrone accaparrava tutte per sé. In Mosè e il monoteismo, il testamento visionario di Freud, vuole persuaderci che Mosè, il quale non sarebbe stato ebreo ma egiziano, è stato ucciso dagli ebrei stessi, che non volevano sottomettersi alle regole severe del monoteismo imposto da Mosè. In questo caso il parricidio, o regicidio potremmo dire, non è motivato da una rivalità per la conquista delle donne, ma da un rifiuto che oggi chiamiamo “populista” del potere monoteistico. Dietro la religione ebraica, Freud vede una sorta di Guy Fawkes giudeo che ride alle spalle di Mosè.
Si è detto tante volte che questa centralità del padre, e quindi del parricidio, nella visione di Freud non è oggi più attuale, perché rifletteva una società ancora patriarcale, la quale in questo ultimo secolo si è in gran parte dissolta. In realtà, come abbiamo detto, per Freud il padre è figura centrale dell’inconscio per un vero e proprio peccato originale, un crimine inaugurale a cui è legata tutta la nostra storia, e che è appunto il parricidio. Ovvero, lungi dal prendere sul serio il primato della società patriarcale, Freud ne drammatizza il declino e la scomparsa. La sua ossessione teorica del parricidio fa eco al tema di Nietzsche della morte di Dio. Nietzsche pensava che Dio, ucciso dagli umani, sia un evento storico, come per Freud è un evento storico la messa a morte del padre. La differenza è che mentre l’uccisione di Dio per Nietzsche è un evento moderno che apre la modernità, l’uccisione del padre per Freud è un evento arcaico, è l’atto primordiale che apre a un tempo la vita sociale e l’inconscio individuale. Prima di questo evento per Freud non c’è psiche individuale, ma solo collettiva.
Come ha poi detto esplicitamente Lacan, il padre di cui si occupa la psicoanalisi è sempre il padre morto - anche se il padre reale è vivo e vegeto. Non è la morte di nostro padre ma la morte del Padre, ovvero della funzione strutturante simbolica della paternità. In altri termini, il nostro avversario non ha più una qualifica fallica, non è più il nostro generatore, ma è un altro collettivo, chiamato, come in Sorrentino, Loro - il Sistema, “i poteri forti” come si dice oggi. È come se la psiche umana si fosse ri-collettivizzata: morto il padre individuale, ci schiaccia il Padre simbolico, che in qualche modo ci castra tutti come popolo impotente. Insomma, non è più il padre di famiglia a spiegare un certo odio per il potere politico, è l’odio per il potere politico a riflettersi, talvolta, nell’odio per il padre familiare.
4.
Perché, da Shakespeare fino a Joker, il poveraccio, il subalterno, il perdente, assume spesso le forme comiche del saltimbanco, del buffone, come Rigoletto o come il Canio pagliaccio di Leoncavallo? Da dove deriva questa antinomica sovrapposizione tra il buffo e il tragico? Ricordiamo che nelle tragedie antiche i personaggi umili, la gente del popolo, erano per lo più figure comiche, ridicole, mentre figure tragiche erano re e regine. Il clown, il pagliaccio, è la figura stessa del figlio - non della figlia. Credo che le clown donne siano rare. I clown sono i figli maschi castrati, direbbe Freud, come allegoricamente è castrato il Gwynplaine di Hugo. Il subalterno ride, ma la sua risata è congelata, assume la fissità di un ghigno perturbante. Le masse, si sa, vogliono ridere, ridere sempre, e per questo non fanno affatto ridere, e sono spregiate. Ma il clown è il figlio matto, fool appunto, matto perché senza padre. Se mi si concede un’intemperanza allegorica, possiamo vedere la fiumana irosa dei clown in Joker come una massa senza padre. La strana teoria lacaniana della psicosi come forclusion, pignoramento, del Nome-del-Padre, mi sembra derivare proprio da questa figura secolare e metafisica del giullare senza padre e senza patria, quindi pazzo, che ride del potere proprio perché ne è dominato. L’eterna pasquinata dei deboli.
Oggi si parla sempre di populismo. In particolare di populismo di destra, che esalta contro la globalizzazione, contro il cosmopolitismo, il narcisismo patriottico e vernacolare della propria Heimat. Il populismo, si dice, è ringhioso, è la rabbia dei marginali contro le élites prestigiose, politici e scienziati, finanzieri sinistre e intellettuali. La funzione paterna è oggi socializzata, dicevamo, e assume le forme persecutorie di un potere che pare manipolarci. Tramontato l’Edipo familiare, imperversa un Edipo politico.
La figura del padre e della sua morte in Freud è certamente una costruzione mitica. Ma i miti sono sintomi, sono un modo di mi-dire, mezzo-dire, la verità. La verità è che, col declino della cultura patriarcale, il padre tiranno oggi non è più tanto incontrato in casa, ma nella proiezione iperbolica di un assetto sociale. Il padre edipico si è disimpastato da quel poveraccio che, di fatto, è ogni padre - i miei pazienti oggi considerano istanze super-egoiche più le madri che i padri. Il padre da uccidere è l’Altro imperscrutabile del potere, il caleidoscopio diffratto delle innumerevoli figure del dominio.
Quest’anno gli ucraini hanno eletto presidente del loro paese, con una valanga di voti, Volodymyr Zelenskij, un attore comico, di fatto un clown, senza alcuna esperienza politica. Era chiamato nel suo paese joker. Il film Joker, girato prima di questa elezione, mostra che, come diceva Wilde, la vita imita l’arte. Del resto, attualmente anche noi in Italia siamo governati da una forza ideata da un attore comico. E dopo tutto, non sembra imitazione di un clown lo stesso Boris Johnson, premier britannico? In Ucraina, in Gran Bretagna e in Italia vengono innalzati dai figli perdenti, irrilevanti, castrati, dei clown, contro la serietà accigliata di Loro. È giunta l’ora del rovesciamento, quella del potere dei buffoni. Ma il figlio-che-ride rischia di diventare, a sua volta, il nuovo despota, un despota che gli stessi figli hanno eletto.
Nota:
L’ESISTENZA DEL COMPLESSO EDIPICO COMPLETO" (S. FREUD, "L’IO E L’ES "), L’INDICAZIONE DI ELVIO FACHINELLI *, E "IL CLOWN SENZA PADRE" ....
"TODO MODO": A CHE GIOCO GIOCHIAMO?!! "La princeps einaudiana è del 1974 e, per comprendere a pieno l’ironica e durissima denuncia civile di questo breve romanzo di Sciascia, bisognerebbe intavolare una seduta spiritica ed evocare la mai defunta processione politico-economica dei primi anni Settanta in Italia. Razza padrona di Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani esce lo stesso anno per Feltrinelli ... Il romanzo giunge così al delitto-contrappasso, al quale ne seguono altri, ma il dispositivo spaziale, o il quadrilatero semiotico, è già dato: la Chiesa (don Gaetano), lo Stato (il procuratore Scalambri), la Corruzione (l’onorevole Michelozzi), la Pena (l’assassino). [...] Il "todo modo" del titolo dice appunto questo, un “con ogni mezzo” che getta un ponte aberrante e tuttavia reale tra gli Esercizi spirituali di Loyola e il Principe di Machiavelli (Matteo Meschiari, "Todo modo", Doppiozero, 21 ttobre 2019).
* Si cfr.: "CON KANT E FREUD, OLTRE. Un nuovo paradigma antropologico: la decisiva indicazione di ELVIO FACHINELLI"; e, ancora, "GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo".
Federico La Sala
-
> UN NUOVO UMANESIMO?!Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- La gioia della verità. Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco. Note.21 giugno 2019, di Federico La Sala
IL PRIMOGENITO TRA MOLTI FRATELLI E LA COSTITUZIONE DOGMATICA DELL’IMPERO SU CUI NON TRAMONTA MAI IL SOLE...*
1. La gioia della verità (Veritatis gaudium) esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra, non abita e non condivide con tutti la Luce di Dio[1]. La verità, infatti, non è un’idea astratta, ma è Gesù, il Verbo di Dio in cui è la Vita che è la Luce degli uomini (cfr. Gv 1,4), il Figlio di Dio che è insieme il Figlio dell’uomo. Egli soltanto, «rivelando il mistero del Padre e del suo amore, rivela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione»[2].
Nell’incontro con Lui, il Vivente (cfr Ap 1,18) e il Primogenito tra molti fratelli (cfr Rm 8,29), il cuore dell’uomo sperimenta già sin d’ora, nel chiaroscuro della storia, la luce e la festa senza più tramonto dell’unione con Dio e dell’unità coi fratelli e le sorelle nella casa comune del creato di cui godrà senza fine nella piena comunione con Dio. Nella preghiera di Gesù al Padre: «perché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi» (Gv 17,21) è racchiuso il segreto della gioia che Gesù ci vuole comunicare in pienezza (cfr 15,11) da parte del Padre col dono dello Spirito Santo: Spirito di verità e di amore, di libertà, di giustizia e di unità. [:::] "(Costituzione Apostolica «Veritatis gaudium» di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, 29.01.2018. Proemio)
*
SUL TEMA, NEL SITO, SI CFR.:
- Costituzione dogmatica della chiesa "cattolica"... e costituzione dell’Impero del Sol Levante. Un nota sul “disagio della civiltà”
L’EREDE: IL PESO DEI PADRI (ATEI E DEVOTI). UN’EREDITA’ ANCORA PENSATA ALL’OMBRA DELL’"UOMO SUPREMO" E DEL "MAGGIORASCATO".
GUARIRE LA NOSTRA TERRA: VERITÀ E RICONCILIAZIONE. Lettera aperta a Israele (già inviata a Karol Wojtyla) sulla necessità di "pensare un altro Abramo"
Federico La Sala
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) --- Simone de Beauvoir, la rivoluzione del femminile, Julia Kristeva (di Francesca Rigotti).17 giugno 2018, di Federico La Sala
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA DELL’UOMO A UNA DIMENSIONE... *
Julia Kristeva
De Beauvoir. Quando la donna diventò soggetto
di Francesca Rigotti (Il Sole-24 Ore, Domenica, 17.06.2018)
- Julia Kristeva,Simone de Beauvoir. La rivoluzione del femminile, trad. di Alessandro Ciappa, Donzelli, Roma, pagg. 140, € 19.
Il prossimo anno ricorrerà il settantesimo dalla pubblicazione di Il secondo sesso, di Simone de Beauvoir (1949), ma non è una cattiva idea cominciare fin d’ora a celebrarlo. Perché quel libro ha rappresentato un evento culturale, una svolta antropologica, una rivoluzione copernicana: con esso, grazie ad esso il soggetto donna si afferma sulla scena dalla quale non sarà più possibile cacciarlo via. E questo per merito di una filosofa e scrittrice, aristocratica, esistenzialista e comunista nonché femminista dell’uguaglianza, il cui status di autrice originale, col suo approccio che è una sintesi di esistenzialismo, hegelianesimo, marxismo e antropologia, si è finalmente consolidato dopo decenni di alterna fortuna.
Lo riconosce Julia Kristeva, migrante venuta da lontano non normalista francese, a sua volta femminista differenzialista e teorica della psicoanalisi, disciplina verso la quale Simone de Beauvoir non nascondeva la propria antipatia e diffidenza. Eppure la vita e l’opera di De Beauvoir (1908-1986) hanno rivoluzionato mentalità e costumi, imprimendo «un’accelerazione all’emancipazione del secondo sesso dopo millenni di dominazione patriarcale e maschile» - riconosce Kristeva in questa raccolta di saggi che invita a rileggere le pagine di una filosofa dalla scrittura romanzesca e di una scrittrice dall’argomentazione filosofica proprio nella nostra epoca polverizzata, nella quale parecchie donne sembrano riadagiarsi nel conformismo sociale.
Alcune correnti femministe rimproverano a De Beauvoir di aver insistito sul registro universale dell’eguaglianza finendo per non vedere, se non negare, il corpo femminile con le sue caratteristiche specifiche tra cui la maternità e l’omosessualità femminile. Eppure ciò non è sufficiente - ribatte proprio Kristeva - a cancellare l’importanza del pensiero di De Beauvoir oggi, non come passaggio storico superato ma in quanto presentificazione degli atti di affermazione del soggetto donna. Operazione che Simone de Beauvoir conduce, sottolinea Kristeva, nei saggi come pure attraverso i romanzi, nei quali la singolarità individuale dei personaggi si trasforma in universalità collettiva politica. Una sfida raccolta anche da Il secondo sesso, ove si invita a singolarizzare il politico e a politicizzare il singolare.
Il lascito di De Beauvoir a tutte le donne è in ogni caso il culto della libertà: la libertà è la sua stella polare, la libertà di Socrate, di Pascal, dell’Illuminismo, di Hegel, di Marx, di Arendt. La libertà che spetta alle donne se riusciranno a uscire dalla condizione di minorità per ottenere la piena eguaglianza, nella polifonia delle posizioni delle donne, femministe o meno, universaliste, differenzialiste, #me too, femen, non una di meno, e se non ora quando. Si potrebbe credere che per riconoscere questo ruolo fondamentale a Simone de Beauvoir Kristeva la spinga verso criteri differenzialisti che non erano i suoi; a me sembra invece che Kristeva rimanga sempre rispettosa e attenta alle peculiarità del pensiero di De Beauvoir di cui affronta persino i sogni, quelli di cui la scrittrice fa dono al lettore in A conti fatti: sogni di cadute e voli, di maternità e fughe e di fughe dalla maternità, nei quali si mostra la geniale capacità dell’autrice di svelare ciò che è più intimo conciliandolo con i disagi dell’epoca per trasformarli in priorità politiche.
Sul tema, nel sito, si cfr.:
- FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA, E ANATOMIA...
 IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
IN NOME DELL’EMBRIONE, UNA VECCHIA E DIABOLICA ALLEANZA. Anche dopo l’ammissione del medico Giovanni Valverde (1560)
 DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
DONNE, UOMINI, E SCIENZA: "Avrei voluto con mio honore poter lasciar questo capitolo, accioche non diventassero le Donne più superbe di quel, che sono"!
UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud)
CREATIVITÀ: KANT E LA CRITICA DELLA SOCIETÀ DELL’UOMO A "UNA" DIMENSIONE. Una sollecitazione a svegliarsi dal sonno dogmatico.
FREUD, KANT, E L’IDEOLOGIA DEL SUPERUOMO
Federico La Sala
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico kantiano: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio". - Ripensare le figure della maternità.14 maggio 2018, di Federico La Sala
Pensare l’ "edipo completo"....
PLAUDENDO al lavoro e alla sollecitazione delle Autrici di "ripensare le figure della maternità", e, al brillante saggio introduttivo di Daniela Brogi, "Nel nome della madre. Per un nuovo romanzo di formazione", mi sia lecito ricordare che il programma di Freud, al di là dei molteplici e "interessati" riduzionismi (in nome del padre o in nome della madre), era quello di = Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico kantiano: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio"; e, possibilmente e ’finalmente’, uscire fuori dalla "caverna", dalla "preistoria", e portarci (tutte e tutti) DAL "CHE COSA" AL "CHI".
Federico La Sala
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"! La lezione di Melanie Klein --- Come è difficile dire “grazie” (anche in amore): Invidia e gratitudine (di Massimo Recalcati).6 novembre 2016, di Federico La Sala
I tabù del mondo
Come è difficile dire “grazie” (anche in amore)
È diventato sempre più complicato ringraziare, mentre è più facile invidiare, dimenticare cosa si è ricevuto da genitori o maestri. Per Melanie Klein l’origine dell’invidia è nel rapporto possessivo del bambino col seno materno. Crescere è liberarsi dal sentimento di dipendenza, accedere alla gratitudine
Nella preghiera non si chiede nulla, ma si è riconoscenti del dono dell’essere È il tratto di ogni discorso amoroso: saper vedere la grazia dell’Altro
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 6.11.2016)
La gratitudine è sempre più un sentimento raro e misconosciuto nel nostro tempo. A prevalere non è la gratitudine ma l’invidia. È questa una coppia concettuale al centro dell’ultimo grande lavoro di Melanie Klein (Invidia e gratitudine), una dei più grandi psicoanalisti dopo Freud. Se la gratitudine è diventata oggi un tabù del quale quasi vergognarsi, l’invidia sembra invece governare l’avidità acefala della pulsione ipermoderna. Molto più facile invidiare che ringraziare. Sapere dire “grazie!” sembra essere diventato un tabù. Lo diceva Voltaire quando ricordava che è più facile condividere i dolori di un amico che i suoi successi.
Ma perché la gratitudine è divenuta così rara? Perché si dimenticano sempre più rapidamente i doni ricevuti? Accade tra genitori e figli, come tra allievi e maestri. Sul posto di lavoro, come nei legami di amicizia. A dominare è il fantasma dell’invidia: distruggere l’oggetto che ci soddisfa perché troppo ricco di vita, mordere la mano che ci nutre. È una constatazione amara che faceva anche Alda Merini quando ricordava che l’invidia si scatena sempre di fronte alla felicità della vita piena dell’altro.
L’invidia nega ogni forma di gratitudine e di memoria: vuole la morte dell’Altro, il suo sbandamento, la sua caduta, la sua corruzione morale. Non a caso Melanie Klein situava l’invidia nel rapporto originario che l’essere umano intrattiene con la madre, il cui prototipo si troverebbe nella relazione del bambino col seno. Nessun seno può, infatti, sottrarsi ai colpi dell’invidia primaria dell’infante. Nemmeno una particolare abbondanza del seno è sufficiente - come ricordava già Freud - a soddisfare pienamente la spinta avida della pulsione orale. Anzi, solitamente il seno più invidiato è quello che si è rivelato più generoso. È proprio il seno più ricco, più vitale, che diviene più facilmente oggetto d’odio. Il soggetto vive infatti la sua vita - la vitalità ricca del seno - come il segno della sua indipendenza e alterità. Dunque come l’esistenza di un oggetto sul quale la pulsione del soggetto non può mai avere il dominio assoluto. Non è infatti il bambino a decidere i tempi della presenza o dell’assenza del seno. Questo genera una condizione di frustrazione che rafforza l’avidità distruttiva della pulsione e la sua invidia. Anche quando la pulsione può godere della presenza del seno, la sua intensità è così insaziabile che rischia di danneggiarlo, di distruggerlo.
Questa attività di distruzione - continua Klein - tende a generare fantasmi di persecuzione: la mano morsa ritorna come mano che vuole uccidere. Più il soggetto scatena la sua distruttività sull’oggetto più l’oggetto diviene persecutorio. Una fortunata serie cinematografica come Alien non parla che di questa trasformazione. In modo più divertente lo fa anche Woody Allen in Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere, dove un enorme seno - oggetto originario dell’amore invidioso - rotola minaccioso da una montagna rischiando di schiacciare il soggetto impegnato in una fuga.
La gratitudine sorge dal timore di avere danneggiato l’oggetto con la propria insaziabile voracità. Per Klein essa può sorgere solo da una trasformazione depressiva dell’angoscia che non è più causata dall’oggetto (dalle angosce persecutorie che la sua ritorsione aggressiva provoca), ma per l’oggetto, per la sua integrità, per la sua esistenza offesa. L’accesso alla gratitudine dipende dai ri-morsi provocati dalla distruttività esercitata verso l’Altro amato, colpevole di non essere di nostra proprietà esclusiva. Essa è un movimento di riparazione che riconosce all’oggetto la funzione vitale che ha avuto per la nostra vita. È l’effetto del riconoscimento del debito simbolico che ci lega all’Altro. La vita che nega l’esistenza separata dell’oggetto è, invece, vita persa nell’odio e nell’invidia distruttiva.
Riconoscere l’assoluta alterità dell’oggetto è una tappa essenziale nel processo di umanizzazione della vita: non posso divorare, assimilare, governare, rendere simile a me, l’alterità dell’Altro. Per il bambino è questo incontro a generare l’esperienza primaria della frustrazione: chi mi soccorre, chi placa l’urgenza dei miei bisogni, non è in mio possesso, non mi appartiene. L’amore non è appropriazione. L’invidia scaturisce da questo sentimento di impotenza e di dipendenza. La sua meta è distruggere l’alterità dell’Altro per ribadire una illusoria indipendenza del soggetto.
Diversamente l’accesso alla gratitudine significa il riconoscimento di tutto quello che ho ricevuto dall’Altro. Ringraziare significa riconoscere la grazia dell’Altro, la sua assoluta differenza. In questo senso la forma più alta della gratitudine è quella della preghiera nella quale si ringrazia del dono dell’essere, del dono della nostra presenza nell’essere.
Nella gratitudine infatti - come nella forma più radicale della preghiera - non si chiede nulla, ma, semplicemente, si ringrazia di ciò che si è ricevuto. È il tratto essenziale di ogni discorso amoroso: ti sono grato per nessuna delle tue proprietà o qualità, per nessun tuo attributo, ma della tua stessa esistenza. Spinta al fondo la gratitudine è la forma più alta del riconoscimento della vita dell’Altro come vita piena e autonoma, impossibile da raggiungere. Per questa ragione il sentimento della gratitudine sconfina nell’amor fati con il quale Nietzsche definiva il rapporto dell’uomo con il proprio destino: la gratitudine è sempre gratitudine per l’evento stesso del mondo.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- “Il mito e la colpa: il caso di Edipo” (di Maurizio Bettini)8 ottobre 2016, di Federico La Sala
-
MICHEL SERRES - UNA CONFESSIONE (DA "IL MANCINO ZOPPO"). AL DI LA’ DI EDIPO: LA FILOSOFIA DI UN ALTRO SOCRATE.
Una rilettura dell’eroe di Sofocle come protagonista del primo “cold case” della letteratura
Edipo
Perché il giallo dell’innocente colpevole è il delitto perfetto sognato da Hitchcock
di Maurizio Bettini (la Repubblica, 08.10.2016)
- L’INCONTRO. Oggi alle 10 Maurizio Bettini tiene una lectio nell’ambito del 900fest di Forlì, intitolata “Il mito e la colpa: il caso di Edipo”
Quando l’uomo giunse a Tebe, terrorizzato, la notizia sconvolse la città: Laio, il re, era stato assassinato. Nel frattempo però un altro evento aveva sparso il terrore. Si diceva che un essere spaventoso e seducente nello stesso tempo - corpo di leone, ali di uccello, testa e petto di donna - si fosse appollaiato su una roccia e da lì, bloccando la via, sfidasse i passanti a risolvere un enigma. Una musica dolce era la sua voce, ma la Sfinge - così si chiamava - era crudele. Nessuno era stato capace di trovare la soluzione, e tutti erano stati divorati dal mostro. Poi però era comparso lo zoppo. Dicevano che fosse arrivato trascinando i piedi nella polvere, ma quando si trovò di fronte alla Sfinge non ebbe paura. Si appoggiò, mise la mano al mento, come se pensasse, poi pronunziò la risposta. La Sfinge, sconfitta, aveva urlato e si era gettata giù dalla rupe. Tebe era libera.
 Lo zoppo si chiamava Edipo e in città lo portarono in trionfo. Gli dettero in moglie la regina vedova, Giocasta, e lo fecero re di Tebe. Adesso la città era felice, ma passati alcuni anni, le sventure ricominciarono. La peste infatti afferrò Tebe, e con la peste la carestia. La città è di nuovo immersa nella disperazione.
Lo zoppo si chiamava Edipo e in città lo portarono in trionfo. Gli dettero in moglie la regina vedova, Giocasta, e lo fecero re di Tebe. Adesso la città era felice, ma passati alcuni anni, le sventure ricominciarono. La peste infatti afferrò Tebe, e con la peste la carestia. La città è di nuovo immersa nella disperazione.Siamo giunti così all’inizio dell’Edipo re di Sofocle, di cui abbiamo raccontato l’antefatto. Adesso il re è sulla scena e, pressato dai vecchi di Tebe, dichiara di aver mandato a consultare l’oracolo. La risposta giunge, ed è chiara: il sangue di Laio chiede vendetta, e l’ignoto assassino si trova in città. Al re non resta dunque che cominciare a indagare - è un grande solutore di enigmi, chi meglio di lui potrà risolvere questo mistero? Edipo assume dunque il ruolo di detective, alle prese con un “cold case”, come oggi si dice. E da buon detective si preoccupa subito di cercare indizi: «Come sarà possibile trovare la traccia di un crimine antico, difficile da decifrare?», si chiede. Ma poi è più fiducioso: «Un solo dettaglio può aiutarci a scoprire molte cose, basta lo spunto, anche piccolo, di una congettura».
 Come si vede del detective Edipo ha assunto anche il linguaggio. «Da solo, non potrò seguire le tracce molto a lungo» dice ancora «se non dispongo di qualche segno ».
Come si vede del detective Edipo ha assunto anche il linguaggio. «Da solo, non potrò seguire le tracce molto a lungo» dice ancora «se non dispongo di qualche segno ».Eccolo anzi sottoporre sospettati e testimoni ad interrogatori invero serrati mentre - come ogni investigatore che si rispetti - fa ricorso alle regole della logica per escludere determinate ipotesi: «Infatti l’uno non potrebbe essere la stessa cosa dei molti», dirà a un certo punto. Sotto i nostri occhi si svolge un’inchiesta che, come vedremo, è costruita su uno straordinario gioco di incastri, tale da superare la fantasia di qualsiasi giallista.
Solo che Edipo non è solo un investigatore, è soprattutto un eroe tragico. Che nel profondo del cuore cela, come si sa, un terribile segreto. Prima di giungere a Tebe, infatti, un oracolo gli aveva predetto un destino di sventura: «Ucciderai tuo padre e ti unirai a tua madre! ». Per questo Edipo era scappato da Corinto, dove viveva con i suoi genitori, Polibo e Merope, il re e la regina di quella città. Che altro avrebbe potuto fare se non fuggire il più lontano possibile da padre e madre?
Ma torniamo sulla scena di Sofocle, l’inchiesta infatti va avanti. Finalmente è stato individuato il testimone chiave, un servo che accompagnava Laio il giorno dell’omicidio. Interrogato, l’uomo riesce solo a ricordare che il fatto si era svolto sulla via che da Tebe porta a Delfi, a un bivio: Laio stava sul suo carro, dice, e gli assassini - uno solo? molti? - lo avevano trafitto.
A questo punto, però, la vicenda ha una brusca impennata: il detective è preso dall’angoscia. Egli ricorda infatti che prima di giungere alla rupe della Sfinge, sulla via di Tebe, aveva incrociato un arrogante che gli aveva chiesto il passo con la frusta. Edipo l’aveva tirato giù dal carro e l’aveva ammazzato. Dunque quell’uomo era Laio? Ed era lui stesso, Edipo, l’assassino? Se è così, e tutto lo fa credere, l’inchiesta condotta da Edipo ha condotto a questo paradossale risultato: l’assassino altri non è che il detective.
Ma ecco un nuovo colpo di scena, in questa vicenda la suspense è incalzante. C’è infatti un nuovo mistero da risolvere, ci sarà bisogno di ascoltare nuove testimonianze e di comporre altri indizi. Giunge infatti un messaggero da Corinto: Polibo, il padre di Edipo, è morto. Almeno c’è questo sollievo, pensa il re, non ho ucciso mio padre, il mio destino non si è compiuto. Racconta dunque dell’oracolo al messaggero e l’altro quasi si mette a ridere. Per questo sei fuggito da Corinto, gli dice? Per paura di uccidere tuo padre? Ma no, Polibo non era il tuo vero padre. Ti ho raccolto io, trovatello, sulla montagna, e ti ho portato a lui, che ti ha adottato. Di chi son figlio allora? Chiede il re ancora più sconvolto. Chi sono io? Da detective che era, Edipo si vede sempre più trasformato in oggetto di indagine. Anche in questa seconda, inattesa tappa dell’inchiesta, il servo che aveva assistito all’uccisione di Laio si conferma nel ruolo di testimone chiave.
Tanti anni prima, racconta, quando pascolava le greggi sui monti, gli era stato ordinato di uccidere un bambino: il figlio di Laio e Giocasta, di cui il re voleva liberarsi. Aveva le caviglie trafitte, quel bambino, e lui non aveva avuto il coraggio di ucciderlo. Per questo lo aveva abbandonato sui monti, dove l’altro, l’uomo di Polibo, lo aveva raccolto e portato a Corinto. Edipo è zoppo, il piccolo aveva le caviglie forate: tutti gli indizi convergono, dunque quel bambino era lui, Edipo. Al termine della sua indagine il detective non solo ha scoperto di essere lui l’assassino che cercava, ma anche di aver compiuto punto per punto il proprio destino: ha ucciso suo padre, Laio, e ha concepito figli da sua madre, Giocasta. Edipo, il detective, risolvendo un caso di omicidio ha scoperto di essere un mostro.
La vicenda dello zoppo che scioglie enigmi, e indagava su un omicidio eccellente, è ciò che un giallo (riuscito) difficilmente arriva ad essere: una grande riflessione sulla “colpa”. Edipo, l’assassino, l’incestuoso che appesta Tebe, in realtà è contemporaneamente un innocente. Perché nessuno di questi delitti egli lo ha voluto commettere, il destino ha deciso per lui - ma nonostante questo Edipo è un colpevole, un impuro.
Proviamo a tradurre questa categoria arcaica, mitica, di “destino” in quelle che useremmo noi al suo posto: come il crescere in condizioni sociali miserabili e degradate. Dopo di che immaginiamo che, in simili situazioni, qualcuno uccida, contamini di sangue la città, diventi un mostro. Colpa? Destino?
-
MICHEL SERRES - UNA CONFESSIONE (DA "IL MANCINO ZOPPO"). AL DI LA’ DI EDIPO: LA FILOSOFIA DI UN ALTRO SOCRATE.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) --- Se il desiderio si trasforma in una trappola (di M. Recalcati)4 settembre 2016, di Federico La Sala
- UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio".
I tabù del mondo
Se il desiderio si trasforma in una trappola
La mantide religiosa incarna la femmina assassina e mostra il nesso tra godimento sessuale e morte Lacan usa la sua immagine per spiegare che l’angoscia non sorge dal confronto con la nostra libertà ma quando ci sentiamo ridotti ad oggetti passivi e siamo dati in pasto alle pulsioni dell’Altro
Questo cannibalismo atroce che fa tremare l’immaginario maschile si ritrova nei fantasmi della letteratura popolare e in quelli dei nevrotici studiati da Freud
di Massimo Recalcati (la Repubblica, 04.09.2016)
Uno strano e inquietante insetto ha da sempre catturato attorno a sé l’interesse degli studiosi più diversi. Si tratta della Mantide religiosa. Il suo nome antico di Mantis, che significa “profetessa”, è già significativo di un certo alone di sacralità che la circonda. Rogers Callois, fondatore nel 1938 con Georges Bataille e Michel Leiris del celebre Collegio di Sociologia, né ha, in pagine memorabili contenute ne Il mito e l’uomo, scolpito il ritratto.
La caratteristica principale di questo insetto femmina, dalle proporzioni infinitamente più grandi di quelle del maschio, è quella di divorare il proprio partner durante o dopo l’accoppiamento sessuale. Ma il suo “carisma” non si realizza solo in questo modo.
Al suo sguardo era attribuito sin dall’antichità un potere magico. Nella Roma imperiale si diceva che se qualcuno cadeva malato era colpa dello sguardo della Mantide che era caduto sullo sventurato. Ma il punto cruciale che ha reso questo insetto un oggetto di studio costante nei secoli resta indubbiamente la convergenza inquietante di appetito sessuale e voluttà alimentare.
In un articolo del 1784 scritto da J.L.M. Poiret viene resa nota l’osservazione della Mantide che decapita il maschio prima di accoppiarsi con lui per divorarlo interamente dopo la copula. Questo cannibalismo atroce non può non fare tremare l’immaginario maschile. Gli etologi si sono interessati alle ragioni di questo comportamento.
Per alcuni l’orrenda decapitazione del maschio prima del rapporto sessuale è finalizzata ad incentivare i movimenti spasmodici del coito rendendo l’erezione più turgida. Ma l’insaziabilità della Mantide si manifesta altresì nel fatto che proprio durante il coito inizia il divoramento del suo amante.
Decapitato e divorato il povero mantide si trova senza alcuna voglia ad essere protagonista di uno dei peggiori incubi di Dario Argento. Si tratta di un cannibalismo primordiale che mescola insieme la pulsione sessuale alla pulsione orale. Ella non gode dell’organo sessuale del maschio ma del suo corpo intero.
Nella lettura popolare di tutti i tempi il motivo degli spettri femminili che divorano i loro amanti è assai ricorrente. Si tratta di creature demoniache che hanno solitamente l’aspetto di donne di estrema bellezza che seducono le loro vittime prima di nutrirsi del loro corpo. La stessa vagina si presta in questi racconti a diventare una sorta di arma micidiale che anzichè provocare il piacere del maschio lo può inghiottire minacciosamente.
Callois riporta a questo proposito un racconto eschimese dell’Ottocento dove un celibe viene sedotto da una bellissima giovane. Nella notte d’amore trascorsa insieme, l’uomo finì però per sprofondare letteralmente nel corpo di lei fino a scomparire del tutto. Al risveglio mentre la bella preda uscì dall’igloo per urinare, espulse dalla sua vagina lo scheletro del suo povero amante! Freud stesso aveva rintracciato la frequenza dell’immagine della vagina dentata nei fantasmi sessuali dei nevrotici a cui, per esempio, riconduceva il sintomo dell’eiaculazione precoce.
Il tabù della Mantide inscena quello della femmina assassina che avvelena, contagia, inghiotte, divora il maschio che vorrebbe godere di lei. Ma più in generale mostra il nesso profondo che unisce il godimento sessuale alla morte. È un tema ampiamente sviluppato da Freud: esiste una prossimità profonda tra il pieno soddisfacimento sessuale e l’esperienza della morte.
Jacques Lacan nelle lezioni di apertura del Seminario X (1962-63) dedicato al tema dell’angoscia ha rievocato lo spirito maledetto della Mantide religiosa. Volete sapere quando si prova l’angoscia? Volete sapere in che condizione ci si trova quando si è angosciati? Lacan porta i suoi allievi a seguirlo in un sentiero stretto. Diversamente da quello che pensavano Freud, Heidegger e Sartre l’angoscia non è senza oggetto, non è percezione del nulla o della nostra libertà. Egli rievoca la Mantide per contestare l’idea di matrice esistenzialista che l’angoscia ci confronti con la nostra libertà più propria e con il dilemma della scelta.
Dalla Mantide Lacan trae un altro insegnamento sull’angoscia: essa sorge non quando siamo confrontati con la nostra libertà ma, al contrario, quando ci sentiamo ridotti ad oggetti passivi del desiderio dell’Altro che si para dinnanzi a noi come un enigma invalicabile. È quello che avviene in un bambino inerme di fronte all’onnipotenza dell’Altro che si prende cura di lui. Cosa vorrà da me? Cosa mi farà? Mi divorerà, mi ucciderà o mi risparmierà? L’angoscia appare quando siamo confrontati con il carattere radicalmente enigmatico del desiderio dell’Altro.
La figura della Mantide religiosa si presta più di ogni altra ad incarnare questo carattere. Provate, dice Lacan ai suoi allievi sbigottiti, ad immaginare di essere di fronte ad una Mantide e pensate di avere stampata sul vostro volto l’immagine del mantide maschio e, dunque, di conoscere la sorte spaventosa che vi attende. Immaginatevi cioè di essere “presi” come oggetto del godimento dell’Altro.
Ecco questa condizione è all’origine dell’angoscia: essere gettati in pasto al desiderio dell’Altro, assoggettati, subordinati, sovrastati dal desiderio dell’Altro. In questo senso l’angoscia non segnala affatto la nostra libertà ma il sentirsi inchiodati all’immagine dell’oggetto del godimento dell’Altro - del mantide maschio - senza alcuna possibilità di fuga.
-
>Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Uccidere o genitori: verità nascoste. La genitorialità non è una funzione che si eredita (di Sarantis Thanopulos).14 novembre 2015, di Federico La Sala
La rubrica settimanale di Sarantis Thanopulos
Uccidere i genitori
Verità nascoste
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 14.11.2015)
Un ragazzo ha ucciso la madre e ferito gravemente il padre della sua fidanzatina, con la complicità di lei. Le vittime si opponevano al loro legame. Una ragazza ha ucciso la madre che le aveva proibito l’uso di internet, a causa del suo cattivo rendimento a scuola. In occasione di queste catastrofi affettive ci si interroga sempre sui motivi. Regolarmente le cause scatenanti appaiono del tutto sproporzionate all’enormità dell’azione in cui trovano sbocco.
Nel primo interrogarsi sull’uccisione dei genitori, nell’ambito della tragedia greca, lo sguardo si muove tra l’omicidio preterintenzionale del padre (Laio) da parte di Edipo e l’omicidio intenzionale della madre (Clitemnestra) da parte di Oreste -istigato dalla sorella Elettra. Edipo cancella dalla sua strada un padre di cui ignora l’identità, un estraneo che non l’ha riconosciuto come figlio. La responsabilità è di Giocasta: estorcendo un figlio da Laio, che ne era contrario, l’ha espulso dalla sua vita di donna/madre. Oreste elimina intenzionalmente Clitemnestra, perché lei, uccidendo Agamennone, l’ha privato del padre, delegittimandolo come uomo. Il parricidio di Edipo certifica la non esistenza del padre, il matricidio di Oreste afferma la necessità della sua permanenza.
In entrambi i casi, l’eliminazione del padre da parte della madre è un atto intenzionale che rescinde il legame di lui con il figlio. Mentre Edipo fa propria l’intenzione materna, inconsapevole del suo significato e delle sue implicazioni, Oreste afferma la propria opposta intenzionalità e elimina la madre uxoricida. Il primo precipita nel baratro della cecità, il secondo si avvia a un doloroso riscatto.
La prospettiva tragica lega l’uccisione dei genitori alla dissoluzione del legame coniugale. La dissoluzione fa diventare la madre una figura autocentrata che, ignorando la figlia, usa il figlio per annientare il padre. Per i figli -fratello e sorella- l’unica salvezza possibile è di sconfiggere la volontà autocratica che la madre/Sfinge incarna. Senza cadere nella tentazione di risposare la sua causa, restaurandola nella sua potenza (la contraddizione in cui si è perso Edipo).
La tragedia colloca il parricidio e il matricidio al centro del conflitto psichico dell’essere umano: la sua oscillazione tra l’uccisione interiore preterintenzionale del padre, che lo lascia indefinito nella sua identità, e l’uccisione intenzionale della madre autocratica, che gli consente di definirsi. L’uccisione concreta della madre e/o del padre, denuncia l’impossibilità del conflitto (il cui esito decide il grado di sanità psichica del soggetto). La sostituzione della sponda genitoriale allo sviluppo di una vera conflittualità con regole astratte, al tempo stesso restrittive e indefinite, preclude ai figli lo sviluppo di una vera intenzionalità e responsabilità. L’eliminazione fisica del genitore rende manifesto il vuoto nel luogo psichico che dovrebbe ospitarlo come autorità interna. L’esplicitazione del vuoto interno invoca l’intervento di un’autorità normativa esterna, cerca nella punizione l’argine all’indeterminatezza della propria vita.
La lezione da trarre dal matricidio e dal parricidio, è che la relazione tra genitori e figli non è naturale, né sacra, ma un riconoscimento reciproco tra soggetti desideranti. La genitorialità non è una funzione che si eredita: i genitori se la devono conquistare. Quando i genitori non riescono a impegnarsi in modo personale e si affidano a un’anonima interpretazione normativa della loro funzione, i figli possono cercare nella norma il genitore «vero» e materializzarlo nell’intervento repressivo della legge.
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Verità nascoste. Arsa viva (di Sarantis Thanopulos).15 febbraio 2016, di Federico La Sala
Verità nascoste.
Arsa viva
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 13.02.2016)
Attribuiamo responsabilità paterna a ogni uomo che ha procreato, anche suo malgrado o senza averne una reale consapevolezza. A fondare la funzione paterna è per noi sufficiente il «legame di sangue». Così quando un uomo attenta alla vita di un suo figlio/a, la nostra comprensione si impiglia nei sentimenti di terrore e di orrore, che sfociano regolarmente nel rigetto puro e semplice (e per nulla catartico) di un atto «contro natura».
La tendenza a confondere le forze naturali che alloggiano in noi, la loro socializzazione che consente la loro espressione creativa e costruttiva e l’apparato normativo che agisce in senso puramente repressivo, raggiunge il suo apice quando i genitori, piuttosto che proteggere, minacciano intenzionalmente l’esistenza materiale dei figli.
Nel nostro sforzo di capire, privilegiamo la patologia del singolo: il fallimento individuale è l’eccezione (devianza) che salva natura, società e norma. Restano in ombra il fallimento delle relazioni, l’assenza di genitori veri in grado di riuscire o fallire nel rapporto con i figli.
L’infanticidio non è l’atto di genitori falliti, ma di adulti rimasti bambini, impossibilitati a crescere.
Il quarantenne che di recente a Napoli ha dato fuoco alla donna da cui aspettava una figlia, ha aggiunto all’intenzione femminicida quella infanticida. Ha dato configurazione manifesta, concreta, a un fatto che sottende ogni azione distruttiva contro la donna: l’impossibilità di raggiungere la posizione paterna.
Nella violenza dell’uomo nei confronti della compagna, c’è sempre un nodo profondamente irrisolto con la propria madre: il sentirsi dominato da lei, restata priva di un interlocutore adulto del suo desiderio erotico. La madre, che ha perso i propri appigli reali al mondo, rivolge tutto il suo interesse al figlio maschio con cui si identifica nell’illusione di un comune destino autarchico. Il figlio avverte la madre come sacra e inviolabile per il suo desiderio e, al tempo stesso, come detentrice di un potere assoluto su di lui.
L’uomo violento investe la sua donna (con o senza l’involontaria complicità di lei) con l’enorme ambivalenza nutrita nei confronti di una figura materna da cui si sente castrato. Nella cieca ribellione che guida la sua violenza, è anche presente la voglia di profanazione del corpo materno: il disperato, impossibile tentativo di dare al proprio desiderio una forma.
Quando un uomo è orfano di padre fuori e dentro di sé, la figura della compagna incinta può fare da argine al suo odio (se qualcosa del padre resta vivo), ma può anche intensificarlo. Nella compagna può rivivere il fantasma di una madre androgina che si è impadronita di lui e della sua condizione virile.
L’uomo vede, allora, inconsciamente nel bambino che abita il corpo della sua donna la presenza di un fratello/sorella rivale (la prova che lui non è necessario) o la raffigurazione di se stesso inglobato da lei (la prova che è necessario solo se abdica a un’esistenza personale).
La scelta di far ardere viva la propria compagna gravida, ha un forte significato simbolico che mette insieme tre prospettive divergenti.
Incendiare con il fuoco della propria passione un oggetto di desiderio inaccessibile. Lasciarla bruciare da sé (nel più potente sogno di soddisfazione autoerotica), nella speranza di vederla risorgere dalle sue ceneri come araba fenice. Incenerire la madre-strega e il suo potere d’incantesimo.
È nella prima prospettiva, in cui il desiderio respira per l’ultima volta, che il padre appare fugacemente prima di svanire.
Egli non esiste indipendentemente dalla sua posizione effettiva come soggetto desiderante nella vita.
-
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! -- Grandi uomini, piccoli padri. Maurizio Quilici mette a nudo le biografie di non grandi ma grandissime menti, nel loro rapporto con i figli.4 novembre 2015, di Federico La Sala
Quilici, Grandi uomini, piccoli padri
Galileo, Rousseau, Manzoni, Tolstoj, Einstein, Chaplin e i figli
di Elisabetta Stefanelli *
- (ANSA) - ROMA, 4 NOV - MAURIZIO QUILICI, ’GRANDI UOMINI, PICCOLI PADRI’ (Fazi Editore, pp. 239, euro 16,50).
Genio e paternità, due parole che, insieme, sono naturalmente portatrici di vicende esistenziali complesse. Un binomio che non è difficile immaginare inconciliabile, ma per quanto la fantasia possa esercitarsi liberamente non si arriva ad ipotizzare nel dettaglio quanto funesta può essere la convivenza con la propria prole per uomini che hanno fatto la storia della letteratura, della filosofia, della scienza. Benvenuto quindi ’Grandi uomini, piccoli padri’, il libro in cui con maniacale determinazione e giusto distacco Maurizio Quilici mette a nudo le biografie di non grandi ma grandissime menti, nel loro rapporto con i figli, troppo spesso vittime innocenti dell’eccesso di genialità.
Abbandonati, maltrattati, dimenticati, lasciati a morire soli e magari di stenti nonostante, spesso, dimostrassero per questi padri-geni un affetto e una devozione infiniti.
Un lavoro enorme di ricerca che l’autore ha la capacità di riassumere con verve giornalistica in sei vite condensate in minisaggi che sono come indagini processuali. Sei capitoli dedicati rispettivamente a Galileo, Rousseau, Manzoni, Tolstoj, Einstein e Charlie Chaplin. Storie pesanti narrate con leggerezza per mettere a fuoco la vita di geni assoluti, uomini noti a tutti per le loro opere, la loro arte, le loro scoperte, che hanno segnato e accompagnato la storia dell’umanità eppure, come si scopre nel libro di Quilici, assolutamente misteriosi se si va a indagare il lato privato della loro esistenza.
Misteriosi nel senso che nel rapporto con i figli hanno spesso tenuto atteggiamenti palesemente contradditori rispetto alle loro teorie, pure caparbiamente inseguite negli scritti e nella vita pubblica.
Così, senza voler entrare troppo nei dettagli del volume che da questo punto di vista è una scoperta, basti pensare ad uno dei protagonisti, quel Jean-Jacques Rousseau, padre della pedagogia, che ebbe ben cinque figli da Thérèse, donna di umili origini disprezzata e sposata solo dopo molti anni. Tutti e cinque i bambini, senza esclusione, furono abbandonati per sua volontà appena nati all’Ospizio dei Trovatelli per finire tra gli orfani. Senza mai cercarli, senza rimpianti. Al punto che quando qualcuno come la signora di Luxembourg, moglie del Maresciallo di Francia, decise di adottare il primogenito, l’unico a cui era stata affidata una traccia per poi eventualmente ritrovarlo, non riuscì nemmeno a farlo perché all’orfanatrofio non se ne sapeva più nulla.
Questo era Rousseau, lo stesso uomo che nell’Emilio aveva scritto: "Colui che non può compiere i doveri di padre non ha neppure il diritto di diventarlo. Non ci sono né povertà, né lavori, né rispetto umano che lo dispensino dal nutrire i suoi bambini e dall’educarli lui stesso". Ma, viene da chiedersi, un piccolo padre può dirsi in ogni caso un grande uomo? (ANSA).
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! -- L’oscuro oggetto del desiderio e l’analista (di Sarantis Thanopulos)1 novembre 2015, di Federico La Sala
L’oscuro oggetto del desiderio e l’analista
di Sarantis Thanopulos (il manifesto, 31.10.2015)
- Può l’analista gestire il proprio lavoro senza mai sentirsi toccato nel suo modo più personale di essere e entrare in crisi? La domanda è stata posta al «Colloquio» organizzato il weekend scorso dal Centro di Psicoanalisi di Palermo e avente come tema il «controtransfert».
Il controtransfert è la reazione dell’analista al “ transfert” del paziente. Il transfert è la tendenza universale a trasferire nelle relazioni significative della vita aspetti conflittuali rimossi della propria infanzia nella speranza che possano essere risolti. Anche il controtransfert ha carattere universale: ci relazioniamo con le persone a cui siamo affettivamente legate, accettando, inconsciamente, di abitare, in parte, la scena della loro storia obliata.
L’analisi è impostata in modo da facilitare lo sviluppo di entrambe le correnti, che sono fatte della stessa materia del sogno, il luogo in cui i vissuti rimossi tornano alla vita. Attraverso la comprensione del posto che inconsciamente occupa, di volta in volta, nella storia del paziente, che torna al presente, l’analista può accedere alla natura più profonda della domanda che gli è rivolta. Ciò gli consente anche la riparazione delle aree di una propria cecità nei confronti della relazione, l’elaborazione della riluttanza ad affrontare questioni che attivano i propri conflitti inconsci.
L’analista è impegnato in modo più diretto quando incontra il paziente a partire dal proprio desiderio e mette in discussione il proprio modo di essere nel mondo. L’analisi riceve dalla madre del paziente in eredità il modo in cui lei l’ha accolto. La madre accoglie il bambino in due modi opposti. Per certi aspetti proietta su di lui parti irrisolte di sé e, affidandogli un ruolo messianico, rimanda al futuro, in modo consolatorio, l’incontro con l’inconsueto.
Nella direzione opposta, il nuovo arrivato attiva in lei il desiderio di rimettersi in gioco, accettando le perturbazioni necessarie di cui è foriero il cambiamento. Più la madre (sostenuta dal padre) riesce a mantenersi nella seconda prospettiva, più il bambino è vivo e desiderabile e la madre gode della riapertura dei propri confini con la vita.
L’analista deve farsi carico di situazioni in cui la madre non è riuscita a far sentire il figlio pienamente autorizzato a essere vivo per conto suo. Nelle condizioni più drammatiche il paziente lotta per evadere dalla prigionia di uno sguardo esterno alla sua soggettività, che ha preconfezionato la sua posizione nel mondo. Non può farlo se non destabilizza l’assetto dell’analista, obbligandolo a uscire dal suo centro di gravità, a esporsi, rischiare. L’analista è in difficoltà: la persona che cura si è posta fuori dall’obnubilamento della propria esistenza e non vuole essere interpretata, ma vista come se fosse arrivata al mondo per la prima volta.
La domanda del paziente, inevitabilmente contraddittoria e confusa, disorienta. L’analista rischia una crisi perturbante d’identità, la confusione dei propri interessi con quelli dell’altro (il caso di Jung con la Spielrein). Tuttavia, questa è per lui l’opportunità di andare oltre la paura che oscura il nostro oggetto di desiderio, al punto di fare dell’oscurità la cosa desiderata.
Scoprire che l’irriducibile differenza dell’altro, percepita come minaccia di destabilizzazione della propria identità (il fondamento della paura), è per costui l’unica possibilità di sentirsi vivo. Chi è veramente vivo non ci minaccia, il pericolo viene dalla non vita che invade la vita. Liberare la vita dalla morte, attraversando una crisi delle proprie vedute, è la vocazione di fondo dell’analista.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) --- un orologio astronomico impostato per segnare l’ora sino al 9999. Per chi suona l’ora della fine del maschio (di Julia Kristeva)16 giugno 2015, di Federico La Sala
Per chi suona l’ora della fine del maschio
di Julia Kristeva *
- Il destino della virilità in Occidente
è un tema discusso da secoli.
 Oggi è solo più urgente che mai inventare nuove strategie amorose
Oggi è solo più urgente che mai inventare nuove strategie amorose
La virilità appare in crisi perché si trasforma. Da sempre? Ho potuto constatarlo a Versailles, alla luce del sole. Nella sala del pendolo di Luigi XV troneggia, sotto forma di mobile sprezzantemente osceno, un orologio astronomico impostato per segnare l’ora sino al 9999. Il robot androide (fantoccio fallico, ode a Priapo) divarica le gambe rococò per mettere in evidenza la potenza virile che si suppone governi il regno, uomini e donne, la terra e le stelle.
Che quell’essere scabroso sia stato agghindato con tutti gli intarsi dorati di Francia per nascondere l’inizio della fine del maschio occidentale, del maschio in generale?
Il pendolo, progettato dall’orologiaio reale Claude-Siméon Passemant, ci prova: l’automa androide è un sosia di Luigi XV. Il re "beneamato", che com’è noto rimase sempre un orfano ansioso, fu un cacciatore intrepido ed è passato alla storia come predatore sessuale: innanzitutto della propria sposa (dalla quale ebbe dieci figli, tre morti in giovane età), e poi delle tante amanti "grandi" e "piccole" (ebbe almeno 14 figli illegittimi). Senza contare che Madame de Pompadour, non paga d’essere la favorita, pare si atteggiasse a primo ministro, prendendosela con lo sfrontato orologiaio che si permetteva di esporre gli ingranaggi fisici dell’autorità.
A meno che l’ingegnoso artigiano non abbia invece voluto proclamare di fronte alla corte e al mondo, stupefatti, che la "virilità" - maschile, monarchica, politica - fosse sul punto di scomparire. "Signore e Signori", dice in sostanza l’ingegnere del re, "il personaggio principale altri non è che il Tempo, accompagnato solo dai suoi: coloro che lo sanno misurare, calcolare, riprodurre, pensare...". Questo, perlomeno, è ciò che sostiene Nivi, una psicologa che mi assomiglia e che ritiene che i francesi siano in anticipo sugli altri quando annunciano al mondo intero che "il re è nudo" e il maschio pure. Le "folies françaises" non sono nate con il Sofitel o il Carlton.
La virilità, mito superato e realtà indispensabile, cosa sarà mai, in effetti? La prestazione di un atleta sessuale? L’autorità del maschio? L’arte di vivere propria di un essere umano dotato di cromosomi e testosterone? La sua parola, la sua scrittura? La paura della castrazione? Terribile o giubilatoria, questa sottopone la sessualità maschile a una prova radicale e complessa. Georges Bataille (rivista L’Acéphale, 1936-1939; L’Erotisme, 1957) ne ha sondato i tormenti e i trionfi estatici, sino alla decapitazione praticata oggi dagli jihadisti folli di Dio. Questo rito immemore e antichissimo concretizza lo spettro del perdere e del far perdere l’organo capitale (testa e/o pene), e attizzando l’abiezione mortifera dei fanatici mobilita industrie militari, mafie, trattative politiche e voyeurismo iperconnesso.
Rimane la virilità simbolica, il cui mito si rifugia ormai negli eroi dei tempi moderni. "Il sapiente", sereno, ascetico. "L’artista", che si diverte proclamandosi "ateo del sesso": la sua libidine è interamente assorbita dall’invenzione di nuovi linguaggi, si perdona e ci perdona, accompagnato da un’intensa miscela di spiritualità. E infine "il politico", ultimo custode della posa fallica: ne gode, ne approfitta, se ne fa grande e non l’abbandona soprattutto nelle inevitabili traversate del deserto, poiché questa fede senza innocenza non conosce la parola "mai".
Il matrimonio è alla portata di tutti, certuni e certune preferiscono coprirsi il volto con un velo, mentre altri vogliono essere tutto e avere tutto... L’emancipazione delle donne e i loro progressi sociali, che accentuano la bisessualità fisica delle madri e delle amanti, oggi sconvolgono gli uomini, che di fronte a loro percepiscono un «rischio di omosessualità» (Colette) - a meno che non si tratti di una speranza.
Il maschio occidentale tuttavia non ha perso, benché le vite quotidiane siano più difficili da elaborare rispetto alle tecniche, alle rivoluzioni, alla governance politica, al culto o alla blasfemia. Nuovi legami amorosi sono più che mai necessari, perché i due sessi - che non se ne stanno tranquilli sulle due sponde della differenza sessuale - accordino le proprie esperienze interiori, i loro stati quantici. (Traduzione di Marzia Porta)
* Julia Kristeva (nella foto), linguista, psicanalista, filosofa e scrittrice, ha appena pubblicato in Francia il romanzo L’horologe enchantée (Fayard) e il 22/6 sarà al 17° Suq Festival di Genova per la prima rappresentazione italiana del suo testo teatrale Teresa mon amour.
*
- Il destino della virilità in Occidente
è un tema discusso da secoli.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) ---- Psicoanalisi e femminismo. Madre, soggetto d’amore. Una lucida analisi di Jessica Benjamin (di Vittorio Lingiardi).23 febbraio 2015, di Federico La Sala
Uomini e donne, per un "cambio di civiltà". Basta con la connivenza all’ordine simbolico della madre!!!
Psicoanalisi e femminismoMadre, soggetto d’amore
Una lucida analisi di Jessica Benjamin spiega perché i legami affettivi si trasformano spesso in dolorosi rapporti di potere
di Vittorio Lingiardi (Il Sole-24 Ore, Domenica, 22.02.2015)
- Jessica Benjamin, Legami d’amore, traduzione di Anna Nadotti, Raffaello Cortina, Milano, pagg. 220, € 24,00
La riflessione freudiana sull’autorità «ha luogo in un mondo esclusivamente maschile. La lotta per il potere si svolge tra padre e figlio; la donna non vi ha parte alcuna, se non come ricompensa o perché induce alla regressione, oppure come terzo vertice di un triangolo. Non c’è lotta tra uomo e donna in questa storia; anzi, la subordinazione della donna all’uomo è data per scontata, invisibile». Ma la teoria femminista «non può accontentarsi di conquistare per le donne il territorio degli uomini».
Il femminismo, quando incontra la psicoanalisi, ha un compito più complesso: trascendere la contrapposizione. Perché questo avvenga è però necessario che la psicoanalisi rinunci a quelle certezze che, con mano maschile, ha scritto sul corpo delle donne. Rinunci alla polarizzazione di genere, «origine profonda del disagio della nostra civiltà». Apra la gabbia teorico-evolutiva della «scissione tra un padre simbolo di liberazione e una madre simbolo di dipendenza», perché per i bambini di entrambi i sessi tale scissione significa che «l’identificazione e l’intimità con la madre devono essere barattate con l’indipendenza» (e dunque «diventare soggetto di desiderio comporta il rifiuto del ruolo materno», se non della stessa identità femminile). Impari a pensare alla madre «come soggetto a pieno diritto» e non «semplice prolungamento di un bambino di due mesi».
La vera madre non è semplicemente oggetto delle richieste del suo bambino, ma «è un altro soggetto il cui centro indipendente deve restare al di fuori del bambino se dovrà sapergli concedere il riconoscimento che cerca». Solo se la madre diventa soggetto, e non solo oggetto d’amore del bambino, prenderà vita quel reciproco riconoscersi che per tutta la vita nutrirà le relazioni d’amore.
È il 1988 e così scriveva Jessica Benjamin in Legami d’amore, il saggio psicoanalitico e femminista sui rapporti di potere nelle relazioni amorose che la rese famosa nel mondo. Tradotto a regola d’arte da Anna Nadotti per Rosenberg & Sellier, ma da tempo introvabile, il volume viene oggi riproposto da Raffaello Cortina, a conferma dell’interesse della sua casa editrice per un pensiero psicoanalitico d’eccellenza. La nuova edizione, un rosso cuore annodato in copertina, comprende una riflessione dell’autrice sull’attualità del suo saggio, e un testo introduttivo («Vivi in presenza di un altro uguale») a cura di chi scrive e di Nicola Carone.
«Come se avessimo bisogno di una qualche prova della persistenza del patriarcato - scrive Benjamin 25 anni dopo, cioè oggi - la passività e la sottomissione non hanno abbandonato il discorso del femminile». Ma anziché indagare il tema del sadomasochismo dal punto di vista dell’«indignazione morale», lo considera da quello della psicoanalisi e delle cicatrici psichiche prodotte dai percorsi obbligati del binarismo di genere. «In che modo il dominio è radicato nei cuori di coloro che vi si sottomettono?».
Perché Cinquanta sfumature di grigio è diventato un bestseller per giovani madri e per donne manager? Le prime risposte di Benjamin (una delle quali è «perché queste donne vogliono arrendersi al controllo, vogliono perdersi») risalgono al 1967, quando Histoire d’O, letto dal mio gruppo poco dopo de Beauvoir, mi ha consentito di capire le molte permutazioni del desiderio che avrebbero trovato espressione culturale anni più tardi».
Domande solo apparentemente pop che trovano risposte complesse nell’analisi della dinamica servo-padrone di hegeliana memoria, o nel concetto di «complementarità scissa», cioè un sistema dinamico in cui ciascuna incarnazione del partner (sadico, masochista; colui che agisce, colui che viene agito) «dipende dall’altro». Un’idea che diventerà centrale per la comprensione delle impasse cliniche, ma anche delle relazioni tra carnefice e vittima e di quelle «relazioni simmetriche nelle quali ciascuna persona si sente di subire, ciascuna persona sente di aver ragione, ciascuno ha paura di essere incolpato».
Non stupisce che oggi Benjamin si stia dedicando al progetto politico-psicoanalitico di declinare la sua teoria del riconoscimento in una teoria della testimonianza. In The Discarded and the Dignified, ultimo scritto non ancora pubblicato, racconta la sua collaborazione, da cinque anni a questa parte, con il Community Mental Health Programme di Gaza. La scommessa è quella di costruire un dialogo con i professionisti della salute mentale israeliani e palestinesi. Di fronte ai traumi, dice, spesso reagiamo appellandoci al senso di «ciò che è giusto o sbagliato» e perdiamo la possibilità di avvicinarci in maniera autentica all’esperienza di chi soffre.
Essere testimoni e non spettatori indignati rientra invece in un più ampio processo di umanizzazione di vittime e carnefici, in cui le prime non aspirino a una qualche fantasia di vendetta o, al contrario, di rassegnazione malinconica per rimediare alla perdita di persone care o alla violazione di parti di sé e le seconde prendano contatto con parti dolorose di sé dissociate. Nato per fare luce sul perché spesso preferiamo «il dolore che accompagna la sottomissione» al «dolore che accompagna la libertà», Legami d’amore ha nei fatti inaugurato il progetto di una psicoanalisi relazionale e intersoggettiva.
Il motivo per cui sono diventata psicoanalista, dice Benjamin, è stato «la ricerca di una guarigione e di un’integrazione personale». Come intellettuale, genitore, clinica, attivista politica, aggiunge, «cercherò di essere più integrata e di fare in modo che ciò che dico vada insieme a ciò che faccio per tutte quelle parti che non riguardano solo la mia guarigione personale, ma si estendono anche al lavoro e allo stare con gli altri». Creatura di confine, spigolosa e sincera, Benjamin riesce a far dialogare posizioni diverse e spesso in conflitto. «Per quanto mi riguarda - dice - sono arrivata alla convinzione che l’esperienza di essere spinta in più di una direzione nello stesso momento è una cosa fondamentale per la mia vita psichica».
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) ---- la psicoanalisi ateo-devota, "la dignità necessaria alle unioni gay" (di Bernard-Henri Lévy), e la svolta della Cassazione (di Elsa Vinci)12 gennaio 2013, di Federico La Sala
PREMESSA SUL TEMA:
La dignità necessaria alle unioni gay
di Bernard-Henri Lévy (Corriere della Sera, 11 gennaio 2013)
Il dibattito sul matrimonio gay ha preso una piega strana e talvolta inquietante. Sorvolo sugli ipocriti che fingono di rimpiangere i bei tempi dell’omosessualità deviante, ribelle, e refrattaria a «entrare nella norma». Sorvolo sulla condiscendenza delle anime belle secondo cui «il popolo», in tempi di crisi, avrebbe altre gatte da pelare piuttosto che queste storie di borghesi bohémien (non si osa dire di pederasti). Sorvolo infine sul comico panico di chi ritiene che il matrimonio gay (ribattezzato a torto matrimonio «per tutti» dai suoi sostenitori troppo prudenti, e privi del coraggio di dire pane al pane, vino al vino) sia una porta aperta alla pedofilia, all’incesto, alla poligamia.
Non si può invece sorvolare su quanto segue.
1) Sul modo in cui è percepito l’intervento delle religioni in tale baruffa. Che le religioni debbano dire il loro parere su una vicenda che è sempre stata, e lo è ancora, al centro della loro dottrina, è normale.
Ma che questo parere si faccia legge, che la voce del gran rabbino di Francia o quella dell’arcivescovo di Parigi sia più di una voce fra tante altre, che ci si nasconda dietro alla loro grande ed eminente autorità per chiudere la discussione e mettere a tacere una legittima domanda di diritti, non è compatibile con i principi di neutralità sui quali, da almeno un secolo, si suppone sia edificata la nostra società. Il matrimonio, in Francia, non è un sacramento, è un contratto.
E se è sempre possibile aggiungere il secondo al primo, e ciascuno può stringere, se lo desidera, un’unione supplementare davanti al prete, non è di questo che tratta la legge sul matrimonio gay.
Nessuno chiede ai religiosi di cedere sulla loro dottrina. Ma nessuno può esigere dal cittadino di regolare il proprio comportamento sui dogmi della fede. Si crede di andare in guerra contro il comunitarismo ed è la laicità ad essere discreditata: che cosa ridicola!
2) Sulla mobilitazione degli psicoanalisti o, in ogni caso, di alcuni di loro, che si ritiene dovrebbero fornire agli avversari della legge argomentazioni scientifiche e, forti della loro autorità, provare che questo progetto causerebbe un altro malessere, stavolta mortale, nella civiltà contemporanea.
Leggete la letteratura sull’argomento. Non ci sono indicazioni, per esempio, che suggeriscano una predisposizione all’omosessualità in caso di adozione da parte di una coppia gay. Non ci sono effetti perversi particolari quando si strappa un bambino da un sordido orfanotrofio e lo si trasferisce in una famiglia con un solo genitore o con genitori omosessuali amorevoli. E se pure questo dovesse provocare un turbamento, lo sguardo che la società impregnata di omofobia porta sul bambino sembra sia infinitamente più sconvolgente della apparente indistinzione dei ruoli nella famiglia così composta...
3) Sulla famiglia, appunto. La sacrosanta famiglia che ci viene presentata, a scelta, come la base o il cemento delle società.
Come se «la» famiglia non avesse già tutta una sua storia! Come se ci fosse un solo modello, e non invece molti modelli di famiglia, quasi omonimi, che si succedono dall’antichità ai nostri giorni, dai secoli classici ai secoli borghesi, dall’età delle grandi discipline (quando la cellula familiare funzionava, in effetti, come ingranaggio del macchinario del controllo sociale) a quella del «diritto alla ricerca della felicità» di cui parlava Hannah Arendt in un testo del 1959 sulle «unioni interrazziali» (in cui il matrimonio diventa un luogo di pienezza e di libertà per il soggetto)!
Come se la banalizzazione del divorzio, la generalizzazione della contraccezione o dell’interruzione volontaria di gravidanza, la moltiplicazione delle adozioni e delle famiglie single, il fatto che oggi siano più numerosi i bambini nati fuori dal matrimonio che da coppie sposate, come se la disgiunzione, infine, del sessuale dal coniugale, non avessero fatto vacillare il modello tradizionale ben al di là di quello che mai farà una legge sul matrimonio gay che, per definizione, riguarderà solo una minoranza della società!
La verità è che gli avversari della legge sempre più difficilmente riescono a dissimulare il fondo di omofobia che governa i loro discorsi.
Preferiamo una posizione di dignità (perché fondata sul principio di universalità della regola di diritto), di saggezza (talvolta il diritto serve a prendere atto di una evoluzione che il Paese ha già voluto e compiuto) e di fiducia nell’avvenire (chissà se non toccherà ai gay sposati, non di impoverire, ma di arricchire le arti di amare e di vivere di una società alla quale, da mezzo secolo, hanno già dato tanto?).
Possa il legislatore decidere serenamente e senza cedere alla pressione delle piazze né all’intimidazione dei falsi sapienti: è in gioco, in effetti, ma non nel senso che ci viene detto, l’avvenire di quella bella illusione che è la convivenza democratica.
(traduzione di Daniela Maggioni)
"I bambini crescono bene anche nelle famiglie gay"
la svolta della Cassazione
di Elsa Vinci (la Repubblica, 12 gennaio 2013)
Basta pregiudizi. «Un bambino può crescere in modo sano ed equilibrato anche con una coppia omosex, non vi sono certezze scientifiche o dati di esperienza che provino il contrario». La sentenza, definita «storica» dall’Arcigay, è quella con cui la Corte di Cassazione ha legittimato l ’affido di un bimbo a una coppia formata da due donne. La presidente della prima sezione civile, Maria Gabriella Luccioli, aveva aperto il solco della giurisprudenza nel marzo dell’anno scorso, quando sancì che «i gay hanno diritto a una vita familiare». Adesso afferma quanto «il mero pregiudizio possa essere dannoso per lo sviluppo di un minore».
Così è stato respinto il ricorso di un padre musulmano. L’uomo, un egiziano che vive a Brescia, si era rivolto alla Suprema Corte per contestare la sentenza d’appello che nel luglio 2011 aveva affidato la figlia alla ex compagna. Il padre lamentava che la donna fosse andata a vivere con una assistente sociale della comunità per tossicodipendenti in cui, anni prima, era andata a disintossicarsi. «Non è idoneo per mia figlia essere educata in un contesto formato da due donne legate da una relazione omosessuale», contestava. Proprio lui che si era allontanato dalla bimba quando aveva solo 10 mesi, si è messo a invocare l’articolo 29 della Costituzione e, sottolineando di essere musulmano, il diritto del minore ad essere educato secondo i principi religiosi di entrambi i genitori.
La Corte gli ha ricordato che con la sua condotta violenta - aggrediva l’ex compagna - è stato lui piuttosto a turbare la figlia. Poi si è sottratto agli incontri protetti con la piccola e ha assunto «un comportamento non improntato a volontà di recupero e poco coerente con la richiesta di affidamento condiviso». Sulla relazione omosessuale dell’ex convivente, la Cassazione ha sottolineato come «alla base delle doglianze del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, ma solo mero pregiudizio». Insomma «si è dato per scontato ciò che invece è da dimostrare». Maria Gabriella Luccioli, prima donna a essere nominata presidente di sezione della Suprema Corte, è nota per importanti innovazioni nel diritto di famiglia.
Esultano le associazioni omosex, ma restano divisi i politici. E c’è lo sconcerto della Conferenza episcopale: «Non si può costruire una civiltà sui tribunali», dice monsignor Domenico Sigalini, presidente della commissione Cei per il Laicato. Scontate le critiche di Carlo Giovanardi e Maurizio Gasparri del Pdl, ma da un altro esponente del Popolo della libertà, Giancarlo Galan, arriva un giudizio opposto. «Questa sentenza è un passo avanti - dice - Perché lo Stato laico deve ascoltare i cittadini e nessun altro».
Per Ignazio Marino, del Pd, la Corte ha sancito un principio di civiltà: «La capacità di crescere un figlio non è prerogativa esclusiva della coppia eterosessuale ma riguarda anche gli omosessuali e i single. L ’importante è che l’adozione venga disposta nell’interesse del minore». Non è favorevole il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, che auspica però «maggiore tutela per le coppie di fatto». Contrario anche il presidente della Camera, Gianfranco Fini, che nello specifico tuttavia giudica la sentenza «sacrosanta». Medici e specialisti invitano a valutare di volta in volta ma il Movimento italiano genitori invoca «i principi di natura». Mentre la polemica si infiamma, le associazioni omosessuali chiedono alla futura maggioranza di legiferare in merito.
In Europa l’adozione per gli omosessuali è legale in diversi paesi: Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Belgio, Olanda. Nel 2008 la Corte di Strasburgo ha stabilito infatti che anche i gay hanno diritto alla genitorialità, lasciando ai paesi dell’Unione la libertà di decidere. Le legislazioni restano molto diverse.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) ---- Qual è il bene che va tutelato. Giusta la decisione della Cassazione se tutela il bene del bambino (di Silvia Vegetti Finzi)12 gennaio 2013, di Federico La Sala
 Qual è il bene che va tutelato
Qual è il bene che va tutelato
 Giusta la decisione della Cassazione se
tutela il bene del bambino
Giusta la decisione della Cassazione se
tutela il bene del bambino di Silvia Vegetti Finzi Corriere della Sera, 12 gennaio 2013)
di Silvia Vegetti Finzi Corriere della Sera, 12 gennaio 2013)Per un bambino è meglio crescere con un papà e una mamma. Ma ciò non autorizza, in situazioni diverse, a intervenire nella sua vita con provvedimenti violenti.
La questione dell’omosessualità, a lungo considerata una colpa o una malattia, sta subendo una radicale trasformazione. Riconosciuta coma un’inclinazione sessuale, né immorale né patologica, si sta ridefinendo come una modalità relazionale, come uno scambio di sentimenti e comportamenti che coinvolgono altri, che non necessariamente condividono la medesima inclinazione.
Questa prospettiva rende il problema più complesso ma al tempo stesso impedisce di appellarsi a principi astratti e impersonali, lontani dalla realtà, che è sempre particolare e contingente. Fermo restando che per un bambino è meglio crescere con un papà e una mamma, ciò non autorizza, in situazioni diverse, a intervenire nella sua vita con provvedimenti violenti, che frantumano il fragile tessuto dei legami affettivi.
Non sempre una relazione di coppia prosegue così com’era iniziata, capita che, per motivi non sempre comprensibili, si interrompa e che il figlio sia posto di fronte a un bivio esistenziale.
In questo caso le posizioni dei genitori sono molto diverse: l’uomo che si è rivelato violento e incapace di mantenere relazioni paterne, mentre la madre ha sempre tenuto accanto a sé il figlio, convivendo con l’assistente sociale conosciuta nella comunità in cui si era precedentemente disintossicata. Per questo le era stato concesso l’affidamento esclusivo del bambino.
Affidamento contestato dal padre soprattutto in nome della religione musulmana che non ammette figli educati da coppie omosessuali.
Ma i giudici della Cassazione hanno preso in considerazione il bene del minore. Un bene, che non consiste nei diritti dei genitori, e neppure in una situazione familiare formalmente «normale», ma nella possibilità di crescere e di realizzare le sue potenzialità.
È sempre accaduto che, in determinate circostanze, i bambini siano stati accuditi e amati da due donne. E di solito se la sono cavata piuttosto bene. Su questa constatazione si basa la decisione dei giudici di salvaguardare, anche in condizioni difficili, il benessere del bambino, ma non solo. La pretesa del padre è stata rigettata perché l’uomo «non ha fornito alcuna specificazione delle ripercussioni negative... dell’ambiente familiare in cui il minore vive presso la madre».
La sentenza afferma quindi l’opportunità di valutare la situazione concreta e di mettere al primo posto l’interesse del figlio, a scapito delle affermazioni di principi generali e astratti, incapaci di cogliere gli aspetti vitali di alcune relazioni parentali.
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) ---- i ragazzi crescono meglio in una famiglia arcobaleno che con un solo genitore (di Massimo Ammaniti)13 gennaio 2013, di Federico La Sala
Ma i ragazzi crescono meglio in una famiglia arcobaleno che con un solo genitore
di Massimo Ammaniti (Corriere della Sera, 13 gennaio 2013)
Oggi la famiglia tradizionale, ad esempio quella della Vienna asburgica descritta da Sigmund Freud, non rappresenta più il modello dominante: è sempre più frequente che un genitore single si occupi dell’educazione dei figli o più spesso dell’unico figlio oppure si creino famiglie ricomposte in cui convivono figli di precedenti legami con quelli nati dalla relazione attuale. È evidente che la tradizionale divisione dei ruoli si modifichi sostanzialmente: il genitore singolo può fare da padre e da madre allo stesso tempo oppure nelle famiglie ricomposte non è detto che il nuovo partner del genitore sia disposto a svolgere un ruolo genitoriale.
Questa breve premessa per dire che il mondo della famiglia deve essere visto con occhi nuovi e il dibattito su coppie gay o lesbiche dovrebbe necessariamente tener conto di questi cambiamenti.
Si tratta di un terreno scivoloso, infatti nelle proprie convinzioni intervengono modelli mentali profondamente introiettati durante l’infanzia nella propria famiglia oppure si fa riferimento a teorie psicologiche nate in un contesto culturale e sociale del passato. Come viene ribadito dalla sentenza di questi giorni della Cassazione, il dibattito non può non tenere conto dei dati di ricerche svolte in questo ambito, anche perché in altri Paesi si sono accumulate esperienze consistenti di famiglie di coppie omosessuali con figli.
In un recente articolo del 2011 pubblicato su una rivista francese, «Encephale», viene riferito che in Francia vi sono circa 200-300 mila bambini che vivono in famiglie omosessuali e pertanto servirebbero indagini più approfondite per valutare lo sviluppo dei bambini che crescono in queste famiglie.
Gli studi che sono stati effettuati fino ad ora, soprattutto negli Stati Uniti, mettendo a confronto famiglie di coppie omosessuali con quelle eterosessuali hanno messo in luce che i bambini di coppie omosessuali mostrano uno sviluppo psicologico non diverso dagli altri bambini. E questo non riguarda solo le capacità di socializzazione o il funzionamento affettivo ma anche la costruzione dell’identità di genere, ambito in cui potrebbero emergere maggiori difficoltà.
Gli studi non si fermano solo ai primi anni di vita dei bambini, che sono stati seguiti anche durante l’adolescenza, quando si sviluppa e si stabilizza l’orientamento sessuale e la stessa identità personale dei ragazzi. Anche in questo periodo non emergono differenze rilevanti e non sembrano emergere confusioni dell’identità di genere.
Sicuramente è ancora troppo presto per affermare che i bambini cresciuti in famiglie di coppie omosessuali non abbiano difficoltà in quanto questi studi devono essere replicati anche in gruppi più grandi utilizzando metodiche di indagine più approfondite. Tuttavia emergono fin da ora risultati abbastanza rassicuranti sullo sviluppo dei bambini di coppie omosessuali, che mostrano un funzionamento migliore dei bambini cresciuti in famiglie con un solo genitore.
Da queste osservazioni ci si può chiedere se sia realmente necessaria la presenza di un padre e di una madre in carne ed ossa o se non siano più significativi in famiglia modelli identificativi paterni e materni.
Questo tema era stato sviluppato in passato dallo psicoanalista Franco Fornari che aveva parlato di due codici simbolici, quello paterno e quello materno, che interverrebbero nella costruzione della personalità.
Mentre il codice materno è rappresentato dal principio di appartenenza, ossia la dimensione mentale di cura, di condivisione affettiva e di protezione soprattutto nei momenti di difficoltà, il codice paterno al contrario si basa sul riconoscimento delle capacità e dell’efficienza, sul sostegno dell’autonomia e dell’indipendenza favorendo in questo caso l’esplorazione e l’affermazione personale.
I due codici convivono in ognuno di noi, con una maggiore espressività, ma non sempre, del codice materno nelle donne e di quello paterno negli uomini, anche se ci sono esempi assolutamente contrastanti.
Ritornando alle coppie lesbiche o gay i due codici possono essere maggiormente personificati in uno o nell’altro partner, creando una dinamica di significati simbolici che vengono internalizzati dal bambino. Si tratta evidentemente di un’ipotesi ma che potrebbe spiegare perché i bambini di coppie omosessuali crescono adeguatamente raggiungendo una propria identità sessuale matura.
*Professore di Psicopatologia dello sviluppo all’Università La Sapienza di Roma
-
-
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo" ---- Freud e il senso della divisione tra i ruoli (di Silvia Vegetti Finzi) - Le famiglie gay e i figli. Intervista a Fulvio Scaparro (di Luisa Pronzato)7 gennaio 2013, di Federico La Sala
Freud e il senso della divisione tra i ruoli
«Ai bambini servono entrambe le figure»
di Silvia Vegetti Finzi (Corriere della Sera, 02.1.2013)
Da tempo la psicoanalisi ha perso la capacità di sollecitare la riflessione collettiva sulle strutture profonde che reggono l’identità individuale e sociale e ciò proprio nel momento in cui si delineano radicali trasformazioni. A rompere questo silenzio giunge quanto mai opportuno l’invito che Ernesto Galli della Loggia rivolge agli psicoanalisti perché non temano di far sentire la loro opinione, anche quando non è conforme al «mainstream delle idee dominanti».
Ormai le psicoanalisi sono tante e non parlano «con voce sola» ma, come storica e teorica del campo psicoanalitico, farò riferimento a Freud, che non credo abbia esaurito il suo compito di fondatore e di maestro. Poiché da oltre un secolo i suoi eredi raccolgono e interpretano, attraverso la pratica dell’ascolto e della cura, i vissuti consapevoli e inconsapevoli della nostra società, mi sembra doveroso interrogare un sapere che si fonda sull’Edipo, così come è stato tramandato dalla tragedia di Sofocle.
L’Edipo, che Freud definisce «architrave dell’inconscio», è il triangolo che connette padre, madre e figlio. Entro le sue coordinate si svolgono i rapporti inconsci erotici e aggressivi, animati dall’onnipotenza Principio di piacere, «voglio tutto subito», che coinvolgono i suoi vertici. Per ogni nuovo nato il primo oggetto d’amore è la madre ma si tratta di un possesso sbarrato dal divieto dell’incesto, la Legge non scritta di ogni società.
Questa impossibilità è strutturante in quanto mette ognuno di fronte alla sua insufficienza (si desidera solo ciò che non si ha) e alla correlata impossibilità di colmare la mancanza originaria. Il figlio che vuole la madre tutta per sé innesca automaticamente una rivalità nei confronti del padre, che pure ama e dal quale desidera essere amato.
La contesa, che si svolge nell’immaginario, termina per due motivi: per il timore della castrazione, la minaccia di perdere il simbolo dell’Io, e per l’obiettivo riconoscimento della insuperabile superiorità paterna. Non potendo competere col padre, il bambino s’identifica con lui e sceglie come oggetto d’amore, non già la madre, ma la donna che le succederà.
Attraverso questo gioco delle parti, il figlio rinuncia all’onnipotenza infantile, prende il posto che gli compete nella geometria della famiglia, assume una identità maschile e si orienta ad amare, a suo tempo, una partner femminile. Tralascio qui il percorso delle bambine, troppo complesso per ridurlo a mera specularità. Ma già quello maschile è sufficiente a mostrare come l’identità sessuale si affermi, non in astratto, ma attraverso una «messa in situazione» dei ruoli e delle funzioni che impegna tanto la psiche quanto il corpo dei suoi attori.
Se, come sostiene Merleau Ponty, «noi non abbiamo un corpo ma siamo il nostro corpo», non è irrilevante che esso sia maschile o femminile e che il figlio di una coppia omosessuale non possa confrontarsi, nella definizione di sé, con il problema della differenza sessuale. La psicoanalisi non è una morale e non formula né comandamenti né anatemi ma, in quanto assume una logica non individuale ma relazionale, mi sembra particolarmente idonea a dar voce a chi, non essendo ancora nato, potrà fruire soltanto dei diritti che noi vorremo concedergli.
Tra questi, credo, quello di crescere per quanto le circostanze della vita lo consentiranno, con una mamma e un papà.
Le famiglie gay e i figli
«Più attenzione ai bambini per essere buoni genitori»
intervista a Fulvio Scaparro
a cura di Luisa Pronzato (Corriere della Sera, 3 gennaio 2013)
Niente guerre sui bambini, niente fanatismi né da parte di chi sostiene le famiglie omoparentali né da parte di chi non le accetta. Fulvio Scaparro, psicoterapeuta e neuropsichiatra che sulla famiglia lavora da una decina di lustri, non prende parte.
«Concordo con Silvia Vegetti Finzi sul Corriere di ieri: i bambini hanno diritto di crescere per quanto le circostanze della vita lo consentiranno con una mamma e con un papà», dice. «Ma non seguo il discorso di Ernesto Galli della Loggia che nel suo editoriale di domenica ha sostenuto che i genitori omosessuali non possono creare buone famiglie».
I genitori, sostiene Scaparro, non sono buoni sulla base del loro orientamento sessuale. Due mamme, due papà. Genitori dello stesso sesso. La società sta attrezzandosi a considerarli al pari di ogni padre e ogni madre. La politica (le leggi) e l’etica spesso non trovano accordo.
Galli della Loggia nel suo editoriale ha investito la psicanalisi perché legga, al di là delle morali, le dinamiche che si creano crescendo con genitori dello stesso sesso. Silvia Vegetti Finzi, seguendo le teorie freudiane, ha rimesso il punto sulla necessità della figura maschile e femminile nella costruzione dell’identità.
«Per dirla con Freud, è costruttivo crescere con modelli nei diversi generi», dice Scaparro. «Ma oggi l’identità non si costruisce solo nel rapporto con i genitori. Si diventa grandi attraverso un’intensa rete di persone di ogni sesso, dagli zii all’allenatore, agli amici dei genitori che diventano affettuosi riferimenti al di là del grado di parentela».
Scaparro riporta al pensiero di Winnicott e alla definizione di «ambiente sufficientemente buono». Necessario per uno sviluppo cognitivo e psicologico equilibrato», dice Scaparro. L’elenco è lungo qualche decennio di studio ma si sintetizza con il contenimento, la stimolazione cognitiva e affettiva, l’attendibilità e coerenza degli adulti, l’empatia, l’ascolto, la flessibilità. In pratica la sicurezza e guida della famiglia. «Un clima attento anche a dire no quando è il momento. Un ambiente non dico privo di tensioni ma dove si imparano le regole della convivenza tra diversi e la difficile arte di non trasformare i conflitti in guerra né il confronto in opposizione muro a muro. Non c’è una di queste voci che genitori dello stesso sesso non possano garantire». È una questione di diritto alla famiglia più che di genere dei genitori... «Si parla delle nuove famiglie ma la discussione è al calor bianco quando si tocca il tema, ormai la realtà, delle famiglie omoparentali», insiste lo psicoanalista.
«Di fronte ad attacchi forsennati come quelli di chi sostiene che crescere con genitori omosessuali è un’aberrazione che produrrà psicotici e psicotiche, ci sono studi che lo smentiscono. Come quello del francese Boris Cyrulnik che mostra come i bambini cresciuti con genitori omosessuali non abbiano più difficoltà psicologiche degli altri. Forse il problema è che i loro genitori devono dimostrare di essere migliori degli altri. Devono essere perfetti. E perfetto non è nessun genitore».
E allora, continua lo psicoanalista «non gridiamo allo scandalo, non fa bene ai bambini. Ascoltiamo piuttosto chi queste esperienze le vive, i genitori gay e i loro figli. Loro sono in grado di dirci come si cresce con due mamme o due papà. Forse non sempre bene. Esattamente come con una madre e un padre che non riescano a essere genitori sufficientemente buoni». Mi ha colpito, conclude Scaparro la testimonianza di un bambino. «Sto bene in questa casa con i mie due papà, peccato che non possa parlarne. Mi prendono in giro».
Luisa Pronzato
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud) --- Cicli di vita e conflitti tra le generazioni. Siamo la terra dei nonni di Edipo (di Silvia Vegetti Finzi)30 maggio 2012, di Federico La Sala
Siamo la terra dei nonni di Edipo
Gli anziani sono il vero welfare dei giovani, ma ne inibiscono la crescita
di Silvia Vegetti Finzi (Corriere, 30.05.2012)
- Cicli di vita e conflitti tra generazioni
 Pubblichiamo una sintesi della relazione sulla famiglia che Silvia Vegetti Finzi tiene al festival dell’Economia di Trento e Rovereto, che comincia domani e prosegue fino a domenica 3 giugno. «Cicli di vita e rapporti tra generazioni» è il tema di questa edizione, cui intervengono tre premi Nobel: Christopher Pissarides, Dale T. Mortensen e Eric S. Maskin. Partecipano inoltre altri protagonisti del mondo dell’economia come Barry Eichengreen, Olivia S. Mitchell, Thomas Piketty, George Soros, Adair Turner. Tra gli italiani intervengono i ministri Elsa Fornero e Corrado Clini, il segretario della Cgil Susanna Camusso, l’imprenditore Carlo De Benedetti, i magistrati Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino.
Pubblichiamo una sintesi della relazione sulla famiglia che Silvia Vegetti Finzi tiene al festival dell’Economia di Trento e Rovereto, che comincia domani e prosegue fino a domenica 3 giugno. «Cicli di vita e rapporti tra generazioni» è il tema di questa edizione, cui intervengono tre premi Nobel: Christopher Pissarides, Dale T. Mortensen e Eric S. Maskin. Partecipano inoltre altri protagonisti del mondo dell’economia come Barry Eichengreen, Olivia S. Mitchell, Thomas Piketty, George Soros, Adair Turner. Tra gli italiani intervengono i ministri Elsa Fornero e Corrado Clini, il segretario della Cgil Susanna Camusso, l’imprenditore Carlo De Benedetti, i magistrati Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino.
 Il festival è promosso dalla Provincia autonoma, dal Comune e dall’Università di Trento.
Info www.festivaleconomia.it
Il festival è promosso dalla Provincia autonoma, dal Comune e dall’Università di Trento.
Info www.festivaleconomia.it
È indubbio che la famiglia abbia subìto negli ultimi anni radicali trasformazioni per cui non si può più parlare di «famiglia» ma di «famiglie», tante sono le modalità di aggregazione con cui si configura la sfera privata. Da sempre la famiglia costituisce l’unico luogo in cui si incontrano tutte le generazioni, ma il modo con cui si posizionano e relazionano varia secondo i tempi e i luoghi.
Una variazione recente ha modificato la struttura interna della famiglia, indipendentemente dalla sua forma anagrafica. Mi riferisco alla posizione assunta negli ultimi decenni dai nonni, al fatto che, sulla scacchiera dei rapporti familiari, i genitori dei genitori occupino ora una casella centrale e determinante. I motivi di questo spostamento rinviano alla funzione di ammortizzatore sociale svolta dalla famiglia in questi anni di crisi.
Se l’Italia non ha sinora registrato la rovina economica e sociale in cui sono precipitate molte famiglie di altri Paesi, ad esempio gli Stati Uniti, dove le fasce più deboli del ceto medio, travolte dai debiti, hanno perso tutto, cadendo in condizioni di povertà estrema, è anche perché, da noi, la famiglia ha sopperito in buona parte alla drastica riduzione dei redditi e all’aumento della disoccupazione. La famiglia, con le sue reti informali di solidarietà, è stata il più efficace baluardo per contenere la crisi e proteggerci, almeno sinora, da un disastro epocale. Non si tratta però della famiglia in generale, ma di una particolare tipologia, quella composta da nonni, genitori e figli che sono contemporaneamente nipoti.
La configurazione tradizionale si è radicalmente modificata per la centralità assunta dai nonni. Nella famiglia tradizionale i nonni erano figure autorevoli e importanti, ma il loro ruolo era soprattutto simbolico. Non intervenivano nelle decisioni dei figli coniugati e non interferivano nell’educazione dei nipoti. Rappresentavano, per così dire, la stirpe, lo «stemma araldico» dal quale discendevano le identità individuali.
Tuttavia, nella tarda modernità, per i giovani disoccupati, è sempre più difficile trovare una risposta soddisfacente. I «lavoretti», parziali, precari, marginali, sottopagati non sono certo in grado garantire appartenenza e identità.
Nell’indifferenziato della società definita «liquida», ma che io direi piuttosto «vischiosa», i punti fermi sono altri: i genitori e, sempre più frequentemente, i nonni che, appartenendo alla «generazione fortunata», hanno fruito del posto fisso, di buone retribuzioni e sufficienti pensioni, che con i loro risparmi sono diventati proprietari della prima e talora della seconda abitazione.
Il nostro Paese, con quasi dodici milioni di persone sopra i 65 anni, è il più anziano d’Europa e uno di quelli dove molti vecchi vivono ancora in famiglia: il 30 per cento della popolazione over 65 convive con un figlio, contro la media europea del 20. Non parcheggiati come in un posteggio ma come membri attivi, partecipi e, spesso decisivi, soprattutto quando divengono nonni. La loro funzione è triplice: finanziaria, organizzativa e affettiva.
Per aiutare le famiglie più giovani, spesso in difficoltà, i nonni hanno devoluto, in questi ultimi anni, gran parte dei loro risparmi. Nella nostra incerta contemporaneità, i nonni costituiscono «punti fermi» affettivi per i figli e soprattutto per i nipoti.
Nonni importanti, quindi, ma protagonisti di una congiuntura che, secondo le previsioni, non potrà durare in eterno, destinata a finire quando la crisi economica, che si sta rivelando interminabile, avrà esaurito le loro risorse economiche e la loro disponibilità fisica e psichica verrà meno. Si profila all’orizzonte una nuova famiglia più europea, meno italiana, ma i nonni non so no destinati, come i dinosauri, a scomparire per una glaciazione epocale. Forse verrà meno il loro contributo economico, si ridurrà la disponibilità assistenziale, ma non credo scomparirà mai la generosa espressione del loro affetto e della loro solidarietà.
Vi sono consuetudini che non perderanno facilmente il senso che hanno ritrovato in questi anni. Recarsi periodicamente a trovare i nonni, festeggiare da loro il Natale, considerarli depositari della storia collettiva e di famiglia, nonché testimoni delle relative ricorrenze, ascoltare i loro ricordi, trarre, dalla discendenza delle generazioni, sentimenti di continuità e di appartenenza costituiscono efficaci antidoti alla dispersione e all’anonimia di una società che solo il prefisso «post» sembra definire. In questi difficili anni la famiglia, comunque costituita, rappresenta una grande, inestimabile risorsa, ma proprio il suo punto forte, il patrimonio «nonni», porta con sé alcune problematiche conseguenze.
Il loro indispensabile apporto, in termini finanziari, organizzativi e affettivi può provocare infatti nuove dipendenze. Effetti regressivi rispetto all’apertura che caratterizzava la famiglia degli anni 70 e 80. L’immaginazione che alimentava le utopie e le sperimentazioni di nuovi modi di vivere insieme sembra aver lasciato il posto a un immaginario omologato che recupera, anche nelle situazioni meno favorevoli, i valori tradizionali del matrimonio, dei rapporti di consanguineità, la proprietà dei figli e dei beni. Vanno in questo senso il desiderio di sposalizi celebrati con fasti tradizionali e il ricorso alla fecondazione artificiale da parte di persone sole che preferiscono avere un figlio con margini di consanguineità piuttosto che rivolgersi all’adozione e all’affido, valorizzati negli anni delle conquiste civili.
Per certi aspetti sembra che la crisi economica stia egemonizzando gli schemi concettuali con cui pensiamo la famiglia e, mentre la frammentazione sociale moltiplica le forme della parentela, l’immaginario ne ripropone una sola, quella edipica. Con la differenza che il posto del padre appare sovrastato da quello del nonno, garante del «nome» e della genealogia familiare.
Mentre i nonni esercitano, come abbiamo visto, forme di potere e di autorità, spesso ma non sempre avallate da personale autorevolezza, i figli, trovando il posto già occupato, stentano a raggiungere il vertice spettante al padre, finendo per attestarsi in un gradino intermedio tra l’essere figli e genitori. I bambini che crescono accanto a un papà tornato figlio, o a una mamma che ridiventa figlia, tendono a maturare precocemente, assumendo, nei loro confronti, atteggiamenti protettivi che invertono l’ordine delle generazioni. Vi sono aspetti positivi in questa inversione, come quando i ragazzi, nativi digitali, insegnano ai genitori e ai nonni l’uso del computer e di altri strumenti elettronici. Ma non sappiamo ancora cosa comportino, sulla lunga distanza, questi mutamenti nell’ordine delle generazioni.
- Cicli di vita e conflitti tra generazioni
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Madri invidiose depresse possessive. Quell’ombra nascosta dietro la maternità (di Giuseppina Manin e Federica Mormando)24 marzo 2012, di Federico La Sala
Il lato oscuro della maternità
Madri invidiose depresse possessive
Quell’ombra nascosta dietro la maternità
di Giuseppina Manin e Federica Mormando (Corriere della Sera, 24.03.2012)
«Chi asciugava i pianti miei? Mamma buona era lei... Chi in cucina cucinava? Mamma cuoca canticchiava... Io la sera nel lettino, Mamma a nanna lì vicino...». Amorosa, premurosa, affettuosa. «Mamma Tutto», come elencava una canzoncina da Zecchino d’oro di qualche decennio fa. Ma di quel «tutto» la retorica di una maternità sacra e intangibile, rimuoveva il lato perturbante, là dove covano disagi, angosce, violenza. Se una donna poteva permettersi di essere fredda, apatica, persino malvagia, il passaggio nella categoria delle madri le garantiva automaticamente la remissione di ogni peccato e una patente di santità e virtù eterne. E se poi, per caso orrendo, qualcuna avesse osato incrinare quell’immagine di perfezione, l’appellativo giusto era bell’e pronto: madre snaturata.
Eppure sarebbe bastato prestar ascolto alle filastrocche e alle favole, quelle che ogni mamma recita ai suoi bambini, per rendersi conto che le cose non stavano proprio così. Mammine che cullavano i loro bebè con «Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do, lo darò all’uomo nero, che lo tenga un mese intero...» potevano dare a pensare. Quanto alle fiabe, da Pollicino a Hansel e Gretel, da Biancaneve a Cenerentola, sembrano inventate per evocare situazioni da brivido: bambini abbandonati, seviziati e minacciati di morte proprio da chi più gli sta vicino...
«La grande astuzia della fiaba è di scindere la figura materna in due: la mamma buona, quasi sempre opportunamente morta, e quella cattiva, incarnata da una matrigna o da una strega», spiega Lella Ravasi-Bellocchio, psicanalista junghiana, autrice di numerosi testi sul rapporto madri-figli. L’ultimo titolo, «L’amore è un’ombra» (Mondadori, pp. 160, 17 euro) si spinge a indagare proprio in quei luoghi oscuri del materno che, assicura l’autrice, «sono tanto duri da attraversare». Luoghi estremi, popolati di mamme psicotiche, pronte a scannare i loro figli. Magari cancellando subito dopo ogni memoria, fingendo un incidente domestico, dandone la colpa a misteriose voci interiori...
Casi finora relegati nella cronaca nera e negli archivi psichiatrico-giudiziari. Cominciare a parlarne al di là di inutili demonizzazioni è un tentativo coraggioso di sollevare scomodi veli. Non a caso sullo stesso tema sono in uscita due film italiani, «Maternity Blues» di Fabrizio Cattani, nei cinema a fine aprile, e «Baby Blues» di Alina Marazzi, appena terminato. Per inoltrarsi in questi insidiosi territori, il libro di Ravasi-Bellocchio si dimostra una guida preziosa. Attingendo alle testimonianze di colleghi che hanno avuto in cura alcune «sventurate», l’autrice le mette a confronto con l’agghiacciante archetipo di Medea.
Con il sostegno della psicanalisi e il conforto di poesie di Sylvia Plath, Attilio Bertolucci, Christa Wolf, Montale e Lamarque, si ripercorrono così le favole nere di Gemma e di Rosa, di Teresa e Caterina, di Wanda, Liliana, Dolores... Nomi fittizi per storie fin troppo vere.
Ma l’indagine si spinge oltre, alle radici di un male segreto, molto più diffuso di quanto si pensi. «Tutte le mamme possono essere terribili», recita il sottotitolo del libro. Se i casi di violenza omicida sono per fortuna pochi, moltissimi risultano quelli di insidiosa violenza quotidiana. Madri invidiose, possessive, depresse, narcisiste. Capaci di creare simbiosi asfissianti e ricatti affettivi, di innescare catene di colpe e risentimenti. Che uccidono senza uccidere. Predatrici di pudore, rispetto e innocenza. L’Ombra con cui fare i conti.
«Le madri sono tramite di vita e di morte. Il conflitto è lì. Riconoscere la violenza del materno è un percorso aspro ma necessario per ogni figlio». Bisogna calarsi, come dice Goethe nel «Faust», nell’abisso del Regno delle Madri. «Le Madri non sono le mamme - precisa Ravasi-Bellocchio - ma la profondità inconscia del materno. La parte matrigna che trasforma il "son tutte belle le mamme del mondo" in qualcosa di misterioso e terribile. Ma anche liberatorio. La discesa nel pozzo della malinconia diventa così l’approdo alla consapevolezza e alla creatività».
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! ---- “L’amore in più", la filosofa Badinter racconta come è stato creato il mito della femminilità legato ai figli (di Anais Ginori - Contro Madre Natura. "Accettiamo la fragilità dell’amore materno").14 marzo 2012, di Federico La Sala
Contro Madre Natura
"Accettiamo la fragilità dell’amore materno"
 Mentre torna in libreria il suo saggio “L’amore in più", la filosofa Badinter racconta come è stato creato il mito della femminilità legato ai figli
Mentre torna in libreria il suo saggio “L’amore in più", la filosofa Badinter racconta come è stato creato il mito della femminilità legato ai figli
 "È stato Rousseau a costruire il modello della mamma buona e di quella cattiva"
"È stato Rousseau a costruire il modello della mamma buona e di quella cattiva"
 "La prima agenzia di balie aprì a Parigi. Nel ’700 in Francia ricorrere a loro era normale"
"La prima agenzia di balie aprì a Parigi. Nel ’700 in Francia ricorrere a loro era normale" di Anais Ginori (la Repubblica, 14.03.2012)
di Anais Ginori (la Repubblica, 14.03.2012)PARIGI. Nel 1780 il prefetto di polizia di Parigi lanciava un inedito allarme. Dei ventunomila bambini che nascevano ogni anno nella capitale, appena mille venivano allattati dalle madri. Gli altri piccoli lasciavano il seno materno per la casa lontana di una nutrice mercenaria. Elisabeth Badinter ripercorre attraverso i secoli le differenti incarnazioni della maternità. Per quali ragioni, si è chiesta la filosofa, la madre indifferente del diciottesimo secolo si è mutata nella madre-pellicano contemporanea? Quando venne pubblicato la prima volta, nel 1980, L’amore in più provocò un acceso dibattito. «A trent’anni di distanza, è ancora difficile accettare che l’amore materno non sia indefettibile» racconta Badinter in occasione della riedizione del saggio, in uscita per Fandango. Nel salone affacciato sui giardini del Luxembourg, Badinter accende una sigaretta. "Figlia spirituale" di Simone de Beauvoir, come si definisce, sta scrivendo un libro su Maria Teresa d’Austria sovrana illuminata ma anche madre di sedici figli, una riflessione intorno ai due corpi della Regina.
Madre non si nasce, ma si diventa?
«Sì, perché l’istinto materno è un mito. Lo studio del comportamento delle donne attraverso i secoli, ci fa capire che non esiste una legge universale. Anzi osserviamo un’estrema variabilità degli atteggiamenti a seconda della cultura, delle ambizioni personali, del contesto sociale e famigliare. Può sembrare crudele, ma l’amore materno è soltanto un sentimento, e dunque è incerto, fragile, imperfetto. Non va dato per scontato. È in più».
L’eterna opposizione tra Natura e Cultura?
«In tutti i sostenitori dell’allattamento materno, dall’Antichità fino ai giorni nostri, si ritrova una professione di fede naturalista. È la natura, si dice, che ordina alla madre di allattare e disobbedire è male dal punto di vista fisico. Poi è subentrata una condanna morale e religiosa. Ma io non credo che gli ormoni del maternage, l’ossitocina e la prolattina, siano sufficienti a realizzare il miracolo di una fusione totale con il proprio figlio. È successo invece il contrario. Già in passato, ogni volta che le donne hanno avuto la possibilità di sfuggire a un destino obbligato, lo hanno fatto».
Quando si manifesta la prima volta il rifiuto dell’allattamento?
«La denuncia di Plutarco è la prima di cui si ha conoscenza. L’antica Roma era una società sofisticata per l’epoca e molte donne non volevano dare le "mammelle" ai piccoli. L’abitudine del baliatico risale invece al tredicesimo secolo in Francia. La prima agenzia di collocamento di nutrici fu aperta a Parigi per le famiglie aristocratiche, poi si generalizzò nel diciottesimo. In nessun altro paese europeo ci sono state così tante donne che non si sono occupate dei loro bebè, apparentemente incuranti della spaventosa mortalità infantile. Un’aberrazione della Storia ancora studiata da sociologi e antropologi. Si chiama "il caso delle francesi". Per questo fenomeno furono trovate una quantità di giustificazioni economiche e demografiche. Ma rimane il fatto che il presunto istinto materno era improvvisamente scomparso».
Perché allora, alla fine del diciottesimo secolo, le francesi aderiscono con entusiasmo alla nuova filosofia naturalista?
«La scienza demografica, che comincia a svilupparsi, sottolinea l’importanza per una nazione del numero di cittadini. È Jean-Jacques Rousseau, con la pubblicazione di Emilio nel 1762, a dare un decisivo avvio alla famiglia moderna fondata sull’amore materno. Costruisce un’ideale femminile di felicità e uguaglianza, riuscendo a convincere molte donne che occupandosi solo dei figli, con dedizione e sacrificio, assumeranno un ruolo fondamentale nella società. Ma nel momento stesso in cui si esalta la grandezza e la nobiltà di questo compito, si finisce per condannare tutte le donne che sono incapaci di assolverlo perfettamente. Rousseau inventa il modello della buona e della cattiva madre che ci portiamo dietro ancora oggi».
L’altro elemento chiave nella costruzione della maternità moderna è la psicoanalisi.
«Grazie a Sigmund Freud, la madre è promossa principale responsabile del benessere del suo rampollo. Un’ultima missione che completa la definizione settecentesca. Il ruolo materno diventa ancor più impegnativo e faticoso di quello del padre. Dalla responsabilità alla colpevolezza il passo è breve. Sono stata molto colpita da una psicoanalista come Françoise Dolto che nelle sue trasmissioni radiofoniche sosteneva che i padri non dovevano toccare i bebè. Oggi evidentemente l’amore materno non è più appannaggio esclusivo delle donne. I nuovi padri si comportano come le madri e amano i bambini al pari di loro. E questo dimostrerebbe la non specificità sia dell’amore materno che di quello paterno».
La prima a rimettere in discussione l’istinto materno è stata Simone de Beauvoir.
«Eppure le è stato negato il diritto di parlare della maternità solo perché non l’aveva sperimentata. È una contestazione assurda dal punto di vista teorico e anche pratico. Molte altre femministe seguaci di Beauvoir, come me, hanno avuto bambini. Ma in qualche modo è passata l’idea che femminismo e maternità non fossero compatibili. Da questo equivoco è scaturito il femminismo della differenza, radicalmente opposto, che mette la maternità al centro dell’identità femminile».
Le donne oggi hanno un rapporto diverso con il loro corpo. Il rifiuto della femminilità di Beauvoir è superato?
«Fino a una certa epoca la femminilità ha rappresentato l’obbligo di essere mogli, madri e casalinghe. Tutto ciò che Beauvoir non è stata. Bisogna contestualizzare il suo pensiero. Detto questo, posso esprimerle una critica. Pensava che la femminilità fosse unicamente culturale. La mia convinzione profonda è invece che esista una bisessualità in ognuno di noi. Ci sono donne estremamente virili e uomini con caratteristiche femminili. Anzi, una delle conquiste del femminismo, che molti ignorano, è aver moltiplicato i modelli anche maschili».
La maternità consapevole è veramente libera?
«Progressi scientifici e sociali come la contraccezione o il diritto all’aborto hanno svelato la complessità e le contraddizioni del desiderio di maternità. Si può programmare o ritardare la nascita di un figlio, desiderare di rimanere incinta e poi abortire, sentirsi pronte e avere una crisi di rigetto dopo il parto. I progressi delle tecniche di fecondazione dividono ormai sessualità e procreazione. Grazie alla maternità surrogata, ci sono madri che non partoriscono. Mai nella storia siamo state così libere di scegliere o no di avere figli. Per paradosso, però, la maternità consapevole si è caricata ancora di più di doveri e responsabilità. È questa pressione montante che ho denunciato nel mio ultimo libro, Il Conflitto, concepito come prosecuzione di L’amore in più. Pensavo di poter commentare nuovi progressi rispetto all’analisi di trent’anni fa, e invece ho dovuto constatare un rischio di regressione su molti temi. Non avrei immaginato di ritrovare una nuova santificazione della natura, contro le malefatte della cultura e della scienza, che ricorda il pensiero di Rousseau vecchio di duecentocinquanta anni».
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! ---- «Fede e umanesimo laico dialogano grazie a Freud» intervista a Julia Kristeva (di Stefano Montefiori).25 marzo 2011, di Federico La Sala
- [PSICOANALISI ’CATTOLICA’ - L’ORDINE DELLA MADRE (DI EDIPO): LACAN INTERPRETA "KANT CON SADE" E SI AUTO-INTERPRETA CON "L’ORIGINE DEL MONDO" DI COURBET
«Fede e umanesimo laico dialogano grazie a Freud»intervista a Julia Kristeva,
a cura di Stefano Montefiori (Corriere della Sera, 25 marzo 2011)
Il Bisogno di credere: prepolitico, prereligioso. A questo istinto dell’uomo Julia Kristeva ha dedicato un libro (edito in Italia da Donzelli) e l’intervento che pronuncerà questa mattina, alla Sorbona, nella seconda giornata del «Cortile dei Gentili». Uno spazio di dialogo e di confronto tra mondo religioso e intellettuali non credenti, alla ricerca dei valori comuni e della complementarità, dove la grande semiologa «bulgara d’origine, francese di nazionalità, europea di cittadinanza e americana d’adozione» ripercorrerà i grandi momenti dell’umanesimo secondo questa traiettoria: Erasmo, Diderot, Sade, Freud.
«L’opera di Freud - spiega la Kristeva - è la cerniera tra le due frontiere dell’esperienza umana: lo scatenamento delle passioni da una parte e la morale dall’altra. Solo la teoria freudiana permette di coordinare questi due aspetti».
 Ormai da qualche anno la moda del tempo, anche e soprattutto tra gli intellettuali non credenti, è
demolire l’opera di Freud, accusata di essere una falsa scienza dal Libro nero della psicoanalisi
(Fazi) fino agli ultimi saggi di Michel Onfray.
Ormai da qualche anno la moda del tempo, anche e soprattutto tra gli intellettuali non credenti, è
demolire l’opera di Freud, accusata di essere una falsa scienza dal Libro nero della psicoanalisi
(Fazi) fino agli ultimi saggi di Michel Onfray.«Sono solo fenomeni mediatici, che non mi interessano. Non vedo come si possa affrontare la questione della religione senza tenere conto di ciò che Sigmund Freud ci insegna sull’essere umano, e cioè che l’homo sapiens è homo religiosus: il bisogno di sapere si traduce in un bisogno di credere, il sapere può decostruire il credere, ma non può esistere senza il credere. Ci siamo abituati ad attaccare l’opera di Freud perché ha detto che le religioni sono un’illusione e questo infastidisce molto gli uomini di fede; è vero, i fenomeni religiosi talvolta portano alla nevrosi se non all’oscurantismo e all’integralismo, ma Freud non si limita a questo. Mostra anche come la psicanalisi sia la sola delle scienze umane in grado di avvicinare il fenomeno religioso in maniera delicata, riconoscendone il radicamento profondo nell’uomo. Penso che il dialogo che cominciamo in questi giorni a Parigi possa avvenire a partire da questo tipo di approccio. Con delicatezza».
 Lei come si definisce in rapporto alla religione?
Lei come si definisce in rapporto alla religione?«Mi interessa l’umanesimo, la differenza tra l’umanesimo cristiano e quello dei Lumi, e come quest’ultimo può rispondere alle questioni della nostra epoca, dalla libertà sessuale al ruolo della donna, alle crisi dei giovani e del multiculturalismo. Non si tratta di distruggere la religione, come hanno tentato di fare i totalitarismi, ma neanche di accettarla: serve un lavoro di rivalutazione della memoria».
 Questo umanismo è ateo, agnostico o credente?
Questo umanismo è ateo, agnostico o credente?«Io appartengo alla variante dell’umanesimo dei Lumi: un ateismo in senso sartriano, che è quindi un’"esperienza crudele e di lungo respiro". Cerco di continuare quel lavoro».
 Nell’intervento, Julia Kristeva citerà L’esistenzialismo è un umanesimo di Jean-Paul Sartre (Mursia)
e la Lettera sull’ «umanismo» di Martin Heidegger (Adelphi).
Nell’intervento, Julia Kristeva citerà L’esistenzialismo è un umanesimo di Jean-Paul Sartre (Mursia)
e la Lettera sull’ «umanismo» di Martin Heidegger (Adelphi).«Sartre parla molto della libertà, l’esistenza dell’uomo precede l’essenza, ed è una libertà che si conquista con scelte e rischi; dalla parte di Heidegger il problema è più complesso: non si pone né per Dio né contro Dio né nell’indifferentismo, ma cerca di cogliere l’uomo in rapporto al linguaggio. Ma solo Freud riesce a mettere in relazione la follia umana e il bisogno di valori. Come diceva Jung, il credere non può essere cancellato, può essere solo sublimato. Il percorso psicanalitico è in fondo un modo di sublimare questo bisogno di credere».
Julia Kristeva crede molto nell’utilità di spazi di confronto come «Il Cortile dei Gentili», «che non può restare un’occasione isolata». Il suo progetto è creare un’istituzione permanente, un luogo di studio che aiuti a «rispondere al malessere dell’uomo moderno in modo post-religioso, ma tenendo conto dell’apporto delle religioni».
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! ----la psicanalisi freudiana, la strada maestra per trasvalutare (di Julia Kristeva - Se Teresa d’Avila incontra una strizzacervelli).22 giugno 2010, di Federico La Sala
IL PROBLEMA MOSE’ E LA BANALITA’ DEL MALE: FREUD NELLA SCIA DI KANT (MA NON DEL TUTTO). Un’ipotesi di ricerca - di Federico La Sala
Se Teresa d’Avila incontra una strizzacervelli
di Julia Kristeva (La Stampa, 22 giugno 2010)
La scrittrice e psicanalista francese (di origine bulgara) Julia Kristeva è ospite della serata conclusiva del festival Letterature di Roma (oggi alle 21, Basilica di Massenzio), a cui partecipa anche Tiziano Scarpa. Leggerà un testo inedito dal titolo La Passione secondo Teresa D’Avila (la santa a cui ha dedicato il saggio Teresa, mon amour, Donzelli 2009), del quale anticipiamo un estratto.
Come spiegare questo strano incontro fra una santa e una strizzacervelli? Non vi dirò tutto. Vi ricorderò soltanto che oggi è impossibile vivere senza accorgersi che gli scontri tra religioni non sono estranei agli scenari economici che incombono sulla nostra quotidianità e minacciano la pace nel mondo. Vi confesso che faccio parte di quei (rari?) scrittori e intellettuali europei convinti che esista una cultura europea di cui non andiamo abbastanza fieri. Io sono profondamente persuasa che solo a partire da una migliore appropriazione critica della pluralità delle sue culture la nostra Europa potrà ricoprire un ruolo decisivo nei diversi conflitti che si affastellano all’orizzonte. Si tratta, esattamente, di una "trasvalutazione" (per usare un termine nietzschiano) dei valori ebraici, cristiani, ma anche musulmani e di quelli della secolarizzazione.
Sì, il filo della tradizione è stato reciso, ci avvertono Tocqueville e Hannah Arendt, e avete dinanzi a voi una donna che si considera atea: non a caso la mia eroina \ finisce il suo racconto su Teresa con una lettera rivolta a Denis Diderot che, al suo tempo, fustigava gli abusi della religione, in particolare nella Religiosa, il celebre romanzo incompiuto.
Ma Diderot, ex canonico e scrittore-filosofo dei Lumi, si rammaricava di non riuscire a finire la sua storia, perché, liberata dagli abusi della vita monastica, la sua religiosa viene gettata in una vita priva di senso.
Ho la pretesa di credere che la psicanalisi freudiana, che interroga i miti e la storia delle religioni, e al tempo stesso spalanca le porte della vita interiore degli uomini moderni, sia la strada maestra per trasvalutare, per l’appunto, quella tradizione che ci precede e con la quale noi, non credenti, abbiamo tagliato il filo. Noi, non credenti. Ma anche noi, credenti molto spesso ridotti a «elementi delle religioni» (come si dice degli «elementi del linguaggio» e dimenticando la complessità dell’esperienza).
-
> UN NUOVO UMANESIMO?! Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! ----"Solo un nuovo umanesimo può fermare il nichilismo" (di Jiulia Kristeva)21 giugno 2010, di Federico La Sala
"Solo un nuovo umanesimo può fermare il nichilismo"
Domani sarà a Massenzio dove leggerà un testo su Santa Teresa d’Avila: "Il suo esempio ci serve anche oggi, contro l’integralismo e il vuoto di valori"
di Jiulia Kristeva (la Repubblica, 21.06.2010)
PARIGI. «Il bisogno di credere è un bisogno prepolitico e prereligioso, sul quale poggia il desiderio di sapere. Riconoscendo l’importanza di tale bisogno, noi atei possiamo favorire il dialogo tra credenti e non credenti, per combattere da un lato il nichilismo e dall’altro l’integralismo». Linguista e psicanalista, saggista e romanziera, Julia Kristeva, dopo Il genio femminile, la trilogia dedicata a Hannah Arendt, Melanie Klein e Colette, ha pubblicato Bisogno di credere (Donzelli), un testo in cui, pur senza rinunciare alle sue convinzioni figlie dell’illuminismo, si confronta con l’universo della fede. Un dialogo che attraversa anche Teresa mon amour. Santa Teresa d’Avila: l’estasi come un romanzo (Donzelli), un libro a metà strada tra romanzo e saggio, che analizza la personalità e gli scritti della santa spagnola del XVI secolo.
Proprio di Teresa d’Avila, la studiosa francese parlerà domani alla Basilica di Massenzio in chiusura del Festival Letterature. «Ho iniziato ad occuparmi di Teresa quasi per caso, scoprendo un personaggio estremamente complesso, ricco e attuale», spiega Kristeva, in questo momento alle prese con la stesura di un nuovo romanzo. «Oggi lo scontro di religioni è una realtà che non possiamo ignorare. Il dialogo quindi è necessario. L’Europa - forse perché ha conosciuto la violenza e l’orrore legati alle religioni, dalle crociate alla Shoah - ha intrapreso, prima con l’illuminismo e in seguito con le scienze umane, un percorso di attraversamento della religione. Non per ghigliottinarla, come ha fatto la Rivoluzione francese, o per rinchiuderla nei gulag, come è accaduto in Unione Sovietica, ma per tentare di "transvalutarla", come direbbe Nietzsche. Attraverso il caso concreto di Teresa, io ho cercato di dare il mio contributo a questo percorso di attraversamento».
Per questo, Monsignor Gianfranco Ravasi l’ha invitata a partecipare al dialogo tra credenti e non credenti. Le sembra un’opportunità?
«Oggi, più ancora del dialogo interreligioso, occorre promuovere il dialogo tra chi crede e chi no, soprattutto in Europa. Appartengo a coloro che, per dirla con Tocqueville e Hannah Arendt, hanno reciso il filo della tradizione. Mi considero una discendente dell’illuminismo e della secolarizzazione che ci hanno messo in guardia contro i rischi della religione: la nevrosi, le illusioni, gli abusi, le guerre. Il filo reciso della tradizione ci ha consentito di muoverci verso la libertà, senza la quale non ci sarebbero il mondo della scienza né quello dell’arte, l’avventura dell’impresa né quella dei nuovi amori. Il filo reciso della tradizione è una conquista importante, ma occorre evitare la deriva verso un nichilismo senza valori e senza autorità. Ecco perché abbiamo bisogno di "transvalutare" la tradizione. Vale a dire ripensarla e attraversala, cercando di trarne tutto ciò che può essere positivo per noi contemporanei. Ciò vale per tutta la tradizione, le tre religioni monoteistiche, ma anche la cultura classica, il taoismo o il confucianesimo».
A chi spetta questo compito?
«Agli intellettuali, ma anche agli artisti, visto che considero la letteratura e le arti delle vere e proprie forme di pensiero. Senza il confronto con la tradizione rischiamo di perderci in un nichilismo depressivo. Sul piano della religione, tale confronto ci consente di capire che la fede non è solamente un vicolo cieco, come diceva Diderot. Condannando la fede, la filosofia dell’illuminismo ha privato il bisogno di conoscenza di un fondamento importante. Per me il bisogno di credere è il fondamento del sapere. È una necessità antropologica che la storia delle religioni ha capitalizzato attraverso le varianti cristiana, islamica, ebraica, taoista. Noi atei dobbiamo riscoprire le radici di tale bisogno, favorendo in questo modo il dialogo tra credenti e non credenti, un dialogo alla pari dove ciascuno possa spiegare e difendere le proprie posizioni».
Il bisogno di credere come si manifesta in Teresa d’Avila?
«Teresa vive una fede sovrannaturale, che esalta il legame amoroso nascosto nella fede. Lo esalta in maniera ideale, ma anche concretamente con tutte le fibre del suo corpo di donna, come testimonia la statua del Bernini nella chiesa romana di Santa Maria della Vittoria. Teresa si esilia nell’alterità divina, rivelando una profondità estrema della vita psichica, che Lacan è stato il primo a mettere in evidenza, parlando del piacere femminile. Nelle sue estasi non c’è solo la felicità dell’incontro con Dio, ma tutta la violenza del piacere, l’annullamento di se stessi e del proprio corpo. Mettendo per iscritto i suoi stati di estasi, Teresa riesce però ad allontanare la loro dimensione mortuaria. Più li descrive, più diventa lucida, agendo nel mondo in maniera concreta».
Nell’abbandono dell’estasi, Dio - per Teresa - cessa d’essere un’entità esterna, diventando una realtà interiore e immanente. È così?
«Nel suo viaggio verso l’altro, Teresa indica un dato importante per la cultura europea. Perché l’io esista, il cogito di Descartes non è sufficiente. L’io ha bisogno dell’altro da sé, con il quale instaura un legame indispensabile. L’io e l’altro s’identificano, si confondono e si portano a vicenda. Teresa crea tale legame con la divinità. Per lei la trascendenza diventa immanenza. In questo modo si colloca sulla via dell’umanesimo cristiano che darà luogo l’umanesimo moderno. Proprio perché Dio e l’infinito sono in lei, Teresa diventa una persona e un linguaggio infinito. Anche per questo affascinò tanto Leibniz».
È per questo che lei la considera una nostra contemporanea?
«Certo. Teresa è una donna eccezionale, un genio femminile che ha innovato la fede cattolica, anticipando la rivoluzione barocca. La sua esperienza parla alle donne moderne e in particolare a quelle che si consacrano alla creazione artistica, lavorando con le immagini e il linguaggio».
Lei è stata una delle voci del femminismo francese. Teresa d’Avila può interessare le femministe?
«Oggi il ritorno della tradizione e la centralità della maternità rimettono in discussione le conquiste del femminismo. Ciò è vero soprattutto quando la maternità è prigioniera delle preoccupazioni materiali e sanitarie. Teresa c’insegna che occorre riuscire a pensare dal punto di vista dell’altro. Non dobbiamo proiettare sui figli i nostri desideri, le nostre angosce, i nostri bisogni, ma considerarli come un altro da sé, cercando di sviluppare la loro alterità. In questa prospettiva, le donne saranno all’avanguardia della civiltà. Come ha fatto Teresa, ogni donna deve cercare di essere singolare. Occorre rifondare l’umanesimo in una direzione che stimoli le singolarità. E’ questo l’insegnamento di Teresa».
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio". La lezione di Melanie Klein rimeditata da Julia Kristeva, in un commento di Manuela Fraire.9 novembre 2006, di Federico La Sala
Nella direzione dell’indicazione relativa al pensare l’ "edipo completo"(Freud), non è male riflettere sulla lettera a cui risponde U. Galimberti ( D La Repubblica delle Donne del 4 novembre 2006, p. 434)
C’è un limite alla pietà?Scrive Freud: "Ho assistito a fenomeni di reciproca coercizione a proposito di giovani donne che si ammalavano mentre assistevano un parente ammalato che di solito era il padre"
Risponde Umberto Galimberti
Erede di una non trascurabile fortuna, agricola e immobiliare, gestita malissimo e in parte dissipata, mio padre, 83 anni, è affetto da una malattia senile degenerativa del sistema nervoso. Non credo ci siano altri figli che abbiano fatto così tanto per un genitore, a partire da quando, oltre 30 anni fa, ci coinvolse in un suo adulterio, sicuramente non l’unico, ma forse il più odioso. La gestione economica è stata sempre più irresponsabile e dissipatoria, le donne e ragazze che inseguiva erano sempre più giovani, il suo ruolo in famiglia, anche con i nipoti, sempre più devastante.
Tre anni fa lo abbiamo costretto a donare tutti i suoi beni immobili (su cui continuava ad accendere ipoteche e debiti assortiti) in cambio di un vitalizio e del pagamento di tutti i suoi debiti (o almeno quelli di cui siamo venuti a conoscenza finora), possibile grazie a un’eredità ricevuta da mia madre. Gli abbiamo pagato tutte le cure specialistiche - analisi, visite, terme, interventi - che lui stesso voleva, senza mai riuscire, per suo rifiuto, a portarlo da un neurologo o simili, gli paghiamo il mantenimento nella grande (e costosa) casa di famiglia a 550 chilometri da dove abitiamo tutti noi, compreso il servizio domestico. Su sua richiesta, abbiamo trovato una badante straniera e abbiamo fatto le pratiche per la sua regolarizzazione. Mia madre, nonostante tutto quello che le ha fatto passare, è ancora e sempre disponibile a venirgli incontro, ma il suo ringraziamento è sempre costituito da un capriccio, un dispetto, l’apertura di un nuovo fronte conflittuale. Io ho 58 anni, un marito impegnato (e impegnativo) e due figli miei (più due suoi) fuori casa che, come tutti i giovani di oggi, vivono modestamente faticando tanto e che vorrei aiutare di più, sia economicamente che come tempo ed energie. E invece tutte le mie energie e il mio tempo libero sono risucchiati da questo vecchio bisbetico, insaziabile e odioso, di cui sono arrivata a desiderare la morte, con più forza ogni giorno che passa.
Come le capisco tutte le tragedie familiari che riempiono le cronache: so benissimo a che livelli di odio si può arrivare quando un familiare sembra risucchiarti la vita stessa. A volte penso all’insieme della nostra famiglia come a un gruppo di pianticelle che non riusciranno mai a vedere il sole finché non sarà caduta la grande quercia che le sovrasta e le tiene al buio.
Dell’affetto che pure avevo per lui, dei bei ricordi della mia infanzia e giovinezza, non è rimasto più niente, ora c’è solo la paura che ogni giorno porti un nuovo problema, questo odio che mi avvelena e il desiderio che gli succeda qualcosa che gli impedisca definitivamente di nuocere, qualcosa che farei succedere io stessa se non sapessi che così il sole non lo vedrei mai più.
È possibile che non si possa fare nulla? Ci dicono che per avere un trattamento sanitario obbligatorio o l’interdizione ci vogliono fatti gravissimi (di sangue) e comunque una causa molto lunga, non compatibile con la sua età. Cosa dobbiamo fare per non morire prima di lui? Lettera firmata
Purtroppo non c’è alcuna legge che tuteli i figli (quando questi non sono più in tenera età) dalla devastazione di genitori che nella loro vita non hanno considerato altro che se stessi, nella forma più deprecabile dell’incuria e dell’egoismo, per cui bisognerebbe anche circostanziare quel comandamento che chiede di onorare il padre e la madre quando questo "onorare" coincide con la distruzione di sé.
Eppure non manca un’ampia letteratura in proposito: dal mito di Crono che divora i suoi figli per timore che questi lo spodestino alle origini della psicanalisi che nasce proprio dall’osservazione, da parte di Freud, di alcune donne, da lui definite "isteriche", che avevano la vita devastata proprio per essersi prese cura a tempo pieno del padre.
La visione prettamente materialista che la cultura cattolica ha della vita, dal momento che la visualizza esclusivamente come evento biologico, produce quei sensi di colpa che lei non confessa, ma inevitabilmente prova quando si augura che la "grande quercia" muoia per concedere un po’ di luce e un po’ di vita alle pianticelle che ha generato. È un sentimento questo che lei ha tutto il diritto di permettersi, a meno che non consideri il diritto della sua vita secondario rispetto al diritto di suo padre. Questo ovviamente non le consente di passare all’atto, ma le permette di collocare alla periferia della sua anima quel padre che, finché è al centro, le proibisce la vita. E se è vero che bisogna amare il prossimo come se stessi è altrettanto vero che neppure la massima evangelica ci chiede di amarlo più di noi stessi.
Che ci siano dei padri e delle madri che mettono al mondo dei figli non per dare ad essi la vita, ma per darla a se stessi tramite loro è una storia vecchia quanto il mondo, se dobbiamo dar credito a tutta quella letteratura sul parricidio che, per quanto aberrante, è un tentativo di rimettere nel suo corso la natura, la quale prevede che i vecchi si congedino, affinché coloro che hanno generato possano avere una vita che non sia solo quella consentita dall’ombra della "grande quercia" che non lascia filtrare un solo raggio di sole. Altro non le so dire, però pubblico la sua lettera che mi pare paradigmatica per riflettere che la vecchiaia non è solo saggezza, spesso è devastazione.
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio". La lezione di Melanie Klein rimeditata da Julia Kristeva, in un commento di Manuela Fraire.9 dicembre 2006, di Federico La Sala
EQUI-LIBRARE IL CAMPO - AL DI LA’ DEL FONDAMENTALISMO MATERNO E PATERNO. Una nota del 2003 (fls).
Saper amare il padre e la madre: restituire la paternità a Giuseppe!!!!
Al di là del fondamentalismo femminista e al di là del fondamentalismo maschilista!
Una risposta-lettera aperta all’ appello PER IL PADRE (di Claudio Risé, primo firmatario e autore del lavoro: IL PADRE - l’assenza inaccettabile, Edizioni San Paolo)
di Federico La Sala *
Comunicato stampa
Un gruppo di docenti universitari, scienziati, giornalisti, professionisti, operatori dell’assistenza ai genitori separati e dei diversi gruppi del movimento degli uomini in Italia, chiede la modifica dell’atteggiamento verso il padre nella cultura corrente, e nelle norme di legge. A un primo appello programmatico, qui riportato, seguiranno adesioni e iniziative volte all’informazione, e al coinvolgimento della classe politica su questo tema. Fin da questo primo documento, inoltre, i firmatari pongono la necessità di un maggior aiuto e riconoscimento al padre disposto ad assumersi ogni onere per il figlio concepito, che la madre sia intenzionata ad abortire.
Per il padre
La figura del padre è stata in Occidente separata dalle sue funzioni educative e sociali. I risultati, del tutto prevedibili secondo tutte le Scienze umane, sono evidenti: insicurezza e difficoltà di iniziativa nei figli; incapacità di accettare il principio d’autorità; solitudine e fatica nelle donne madri nel dover assolvere da sole il peso educativo; frustrazione nei maschi adulti, svalutati in quest’aspetto essenziale dell’identità maschile. Una situazione fonte di danni gravissimi agli individui, alla vita di relazione e familiare, alla società, alla nostra civiltà. Occorrono attenti interventi, che ridiano dignità e responsabilità alla figura paterna.
Di grande significato affettivo, e simbolico, è la posizione del padre nei confronti del figlio procreato. La prassi oggi vigente, priva il padre di ogni responsabilità nel processo riproduttivo. Una situazione paradossale, ingiusta dal punto di vista affettivo, infondata dal punto di vista biologico e antropologico, devastante sul piano simbolico.
Per il bene dei figli, e della società, é necessario che al padre sia consentito di assumere le responsabilità che gli toccano in quanto coautore del processo riproduttivo. I casi di cronaca che presentano la disperazione dei padri, che vogliono, prendendosene ogni responsabilità, il figlio che la madre ha deciso di abortire, sono solo la punta dell’iceberg del lutto dell’uomo-padre, espulso dal processo di riproduzione naturale di cui è promotore. E’ necessario avviare una riflessione collettiva che equipari realmente la dignità della donna e dell’uomo nella procreazione, a garanzia della vita, della famiglia e della società. L’interesse e la volontà della donna devono essere opportunamente tutelati, nel quadro della cura sociale di difesa della vita, e di promozione della famiglia, nucleo vitale della comunità. I sottoscritti cittadini, e gruppi lanciano quindi un forte richiamo alle forze della politica, e della società civile, perché ripensino le norme, e rimuovano i pregiudizi che sottraggono, al di là di ogni senso comune, il padre alla vita del figlio.
Claudio Risé, psicoanalista, Università di Trieste Stefano Zecchi, Università di Milano, Giuseppe Sermonti, professore Emerito di Genetica molecolare Claudio Bonvecchio, Università dell’Insubria Giulio Maria Chiodi, Università Federico II, Napoli Stefano Serafini, Pontificia Università San Tommaso di Roma Giovanni Ventimiglia, Facoltà di Teologia di Lugano e Università Cattolica di Milano Alberto Giovanni Biuso, Università di Milano Cesare Galli, università di Parma Ivo Germano, Università di Bologna Silvio Restelli, Ricercatore presso l’Istituto Regionale per la Ricerca Educativa, Lombardia Guido Milanese, Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore Aldo Brandirali, Assessore Comune di Milano [..... seguono altre adesioni: cfr. http://www.claudio-rise.it/].
Caro dr. Risè....
condivido l’allarme e l’appello PER IL PADRE, ma - in tutta sincerità - Le devo dire che la questione mi sembra appesantita da un’ottica non del tutto limpida (dal piano biologico al piano teologico). In breve: Freud o Jung? Sulla loro strada, meglio Elvio Fachinelli: .Al di là della freccia ferma e della claustrofilia!!! Si tratta di andare avanti: questo è il tempo dell’aprire gli occhi e della mente estatica: si tratta di ristrutturare e riequilibrare tutto il campo e mettere, con tutti gli onori, GIUSEPPE accanto a MARIA! Siamo o non siamo CRISTIANI !!!!!!!?????????
****************
SIAMO nel 2003 d. C.!!!: QUALE ’MODELLO’ DI RELAZIONE IN UNA MODERNA SOCIETA’ DEMOCRATICA? QUALE RAPPORTO TRA LE GENERAZIONI? CITTADINI SOVRANI E CITTADINE SOVRANE, FIGLI E FIGLIE DI ’MARIA’ E ’GIUSEPPE’, O DI ’GIOCASTA’ E ’LAIO’? O, PER CASO E ANCORA, FIGLI E FIGLIE DELLA LUPA (DI REA SILVIA E MARTE)? *********************** GIUSEPPE E’ TORNATO..... MA IN VATICANO NON LO SANNO. Vivono tutti ancora a Tebe, nella città del re Edipo! Con un’antropologia preistorica, la Chiesa Cattolica avanza sicura, verso il tremila prima di Cristo!: a GESU’ ha tolto e negato la paternità di GIUSEPPE: "IL PADRE - l’assente inaccettabile", e tutti gli esponenti della Gerarchia della Chiesa Cattolica - dal primo (con il motto "Totus Tuus") all’ultimo - sono tutti diventati figli di "mammasantissima" ... e noi, uomini e donne, con loro!!! Fino a quando zoppicheremo con i due piedi?: questa è una domanda - già di molti secoli prima di Cristo - del profeta Elia (1 Re: 18, 21), ma - come sa - rilanciata da Sigmund Freud, nel XX secolo dopo Cristo ????????!!!!!!!!!!!
M. cordiali saluti
Federico La Sala
* www.ildialogo.org/filosofia, Martedì, 09 settembre 2003
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Per Risé quel che resta di Freud (dopo 150 anni) è moltissimo, ma - non compreso il ’mosaico’ di Fredu - butta a mare proprio l’essenziale: Edipo e Mosè.16 marzo 2010, di Federico La Sala
150 anni di Freud
Quel che resta di Freud caduti totem e tabù
di Claudio Risé (Il Giornale, 8 febbraio 2006) *
Centocinquant’anni fa, il 6 maggio 1856, nacque Sigmund Freud. A Freiberg (oggi Pribor, Repubblica Ceca), ma a quattro anni era già a Vienna, teatro di tutta la sua vita, e del suo pensiero. E’ probabilmente l’unico medico, (a parte Samuel Hannemann, fondatore dell’omeopatia, nato cent’anni prima di lui, nel 1755), di cui un secolo e mezzo dopo si discuta ancora con tanta passione, e le cui intuizioni pesino ancora così tanto non solo nella pratica terapeutica, ma in tutto il dibattito culturale. Forse perché, ed è il primo elemento da considerare in quest’anniversario, il suo metodo, nato all’interno della medicina, finì fatalmente per scavalcarla, e diventò un punto di confronto obbligato anche per le altre scienze umane: la psicologia, certamente, ma anche la pedagogia, l’antropologia, per non citare che quelle più direttamente coinvolte.
L’ampiezza dello spazio tuttora occupato da Freud nell’insieme delle “Human Sciences” spiega anche l’intensità delle guerre che tuttora si combattono contro di lui, o in suo nome. L’anno scorso in Francia furoreggiò un Livre noir de la psycanalyse, che si proponeva di distruggere ogni residuo di freudismo. Il libro, in parte opera di transfughi scontenti, conteneva soprattutto pettegolezzi, e non causò danni. Da parte freudiana rispose Elisabeth Roudinesco, con un altro piccolo testo Pourquoi tant de haine? (Perché tanto odio?), nel quale autorispondeva alla domanda del titolo dimostrando che tutto questo livore era dovuto al tentativo/bisogno dei terapeuti formati nelle psicoterapie di derivazione anglosassone (cognitivisti e comportamentisti), di conquistare, col supporto della stampa di sinistra, l’importante “mercato” occupato dalla psicoanalisi.
In Italia la diffidenza alla psicoanalisi è un dato ambientale, che non cessò mai. All’inizio del secolo, per via di Cesare Lombroso, organicista di ferro. La Voce le dedicò, è vero, nel 1910, un numero speciale, intitolato La questione sessuale, che andò subito esaurito. Croce, però (che confondeva l’inconscio freudiano con l’inconoscibile), non la poteva soffrire, Gentile non l’amava, e la modesta Rivista italiana di psicoanalisi fu completamente proibita nel 1934. Eppure i rapporti tra Freud e il Duce erano buoni. Il padre di una paziente italiana, amico di Mussolini, gli chiese un libro da offrire al Duce, e Freud, nel 1933, scelse il piccolo carteggio Perché la guerra?, due lettere scambiate con Einstein, con la dedica: “Da parte di un vecchio che saluta nel Legislatore l’Eroe della cultura”. Il Duce probabilmente gradì, e chiese, nel 1938, nel pieno delle leggi razziali, all’ambasciatore italiano a Vienna di fare un passo presso Hitler per evitare l’esilio di Freud (senza riuscirci).
In Italia, tuttavia, Cesare Musatti, ebreo, fu allontanato dopo il 1938 dall’Università, dove insegnava psicologia sperimentale. Pessimi furono poi sempre i rapporti col movimento marxista. Antonio Gramsci notava, già nel 1930, nella letteratura psicoanalitica “un fattore depravante e regressivo... l’abuso e l’irregolarità delle funzioni sessuali” che dopo l’alcoolismo sono “il nemico più pericoloso delle energie nervose”. Dopo la guerra poi, l’influente filosofo marxista Antonio Banfi bolla la psicoanalisi di “fiore putrido del positivismo romantico”, e “metafisica della personalità disciolta”. Dopo la metà degli anni ‘60, venne il disgelo. Tuttavia la legge italiana sulla psicoterapia, firmata dal cattolico-comunista Adriano Ossicini, non nomina mai la psicoanalisi, della quale non si parla neppure nella maggior parte delle facoltà di psicologia.
Malgrado (o forse grazie a) queste ostilità la psicoanalisi tiene. Anche perché nel frattempo, al di là delle divisioni burocratiche delle società analitiche, come campo del sapere si è sostanzialmente riunificata, ricomprendendo anche gli allievi delle varie dissidenze a Freud: da Adler a Reich a Jung, la cui influenza è continuamente cresciuta.
Cos’è che sorregge ancora questo pensiero complesso, eterodosso per vocazione, che si traduce poi in una pratica terapeutica difficile e costosa? La psicoanalisi poggia sempre sulla sua intuizione originaria, quella che idealisti e marxisti non possono mandare giù: l’inconscio. Certo, non solo quello personale, cui si riferiva Freud, ma anche quello collettivo, studiato da Jung. L’inconscio narra ciò che la coscienza ignora e, se non lo ascolti, il nevrotico non guarisce. Certo, per ascoltare l’inconscio, per interpretare un sogno ad esempio, devi essere provvisto di alcune conoscenze, tra le quali molte delle intuizioni freudiane. La teoria della sessualità per esempio, con le sue fasi, orale, anale e genitale, per quanto bizzarra possa sembrare, è puntualmente confermata da un secolo di pratica clinica. Anche “la nostra mitologia”, come lo stesso Freud ironicamente la definiva, e cioè la teoria delle pulsioni come spinte originarie dei comportamenti, appare sostanzialmente insostituibile, a meno di cadere in una mappatura superficiale della situazione, che nulla approfondisce e nulla trasforma.
Più difficile, mi sembra, ricondurre ancora ogni disagio al “romanzo familiare”, allo scenario genitori-figli. La famiglia di oggi (come quella precedente all’800), non è più il teatrino asfissiante studiato da Freud nella Vienna del primo Novecento; inoltre i suoi rapporti con la società sono diversi (come del resto lo erano nei secoli precedenti). Ampiamente fallito, mi sembra, anche il tentativo di ridurre la religione a psicopatologia; così come l’incursione antropologica di Totem e tabù (1913), con il mito inventato dell’orda dei figli che uccide il padre, per tenersene le mogli.
Sarebbe ben strano, del resto, che gli undici massicci volumi dell’Opera Omnia editi da Boringhieri, stessero ancora in piedi tutti, dal primo all’ultimo saggio. Quel che rimane è comunque moltissimo. Forse abbastanza per altri centocinquant’anni.
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Ma quante sciocchezze scrive il «filosofo» Michel Onfray nel suo ultimo saggio su Freud! (di Bruno Gravagnuolo).5 maggio 2010, di Federico La Sala
Onfray: un bigotto anti Freud
di Bruno Gravagnuolo (l’Unità, 05.05.2010)
Ma quante sciocchezze scrive il «filosofo» Michel Onfray nel suo ultimo saggio su Freud! Se non fosse che Onfray è ben noto per la sua «specialità» scandalismo pruriginoso e distruttivo si potrebbe parlare di un vero e proprio Malleus maleficarum contro la psicoanalisi, di caccia alle streghe.
Ma siamo in tempi di esibizionismo narcisistico e nessuno si scandalizza più di certe scomuniche, specie se vibrate da uno Sgarbi francese come Onfray, tardo epigono dell’antipsicoanalismo transalpino sulla scia del Libro nero della psicoanalisi. Però le bestialità vanno rettificate. Ad esempio ne Il crepuscolo di un idolo. L’affabulazione freudiana (tra poco per Ponte alle Grazie) ci sono affermazioni assurde.
Tipo: Freud nascose il suo debito con Nietzsche. È falso. Freud confessò il suo debito, scrivendo che non voleva leggere troppo Nietzsche, per non restarne influenzato!
Falso che Freud teorizzasse la rinuncia alla sessualità... per sublimarla nella psicoanalisi. Vero è invece che «sublimazione» significa canalizzazione e investimento (parziale) della sessualità in oggetti d’amore o in creatività. Così come è falso che Freud pensasse che «non si guarisce mai» perché non ci si può sottrarre alle «pulsioni». Non si guarisce se si negano e rimuovono le pulsioni.
Falso che Freud appoggiasse i fascismi.Credeva di poter salvare il salvabile agli inizi, e per salvare la psicoanalisi in Italia fa una innocua dedica a Mussolini in Perché la guerra. Grottesca poi l’accusa di aver inventato «l’attenzione intermittente»... per potersi appisolare in seduta. È una cosa che come è noto ha a che fare con l’immedesimazione emotiva col paziente e che richiede un certo fluttuare della mente dell’analista.
Folle infine l’accusa di antisemitismo, sol perché il Mosè di Freud non era ebreo ma egiziano. Era solo un’ipotesi. Ma conta in Mosè e il Monoteismo l’esaltazione del Dio ebraico, vera roccia dell’Autorità e della Civiltà per Freud, un gigante che la puerilità bigotta di certe accuse come quelle di Onfray ci fanno apprezzare ancora di più.
-
-
>Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico: diventare maggiorenni) --- Sorpresa, "il ritorno del padre" (C. Risé): a guidare l’uscita dal deserto, i Millennials (di Massimo Calvi).25 giugno 2022, di Federico La Sala
Sorpresa, il padre sta tornando. Anche grazie allo smart working
- Claudio Risé: pandemia e lavoro agile hanno agevolato il rientro in famiglia degli uomini. Tendenza che va consolidata
di Massimo Calvi (Avvenire, martedì 7 giugno 2022
Papà è tornato a casa. Dopo decenni di «assenza inaccettabile», il padre ha finalmente fatto ritorno tra le mura domestiche, ha voglia di famiglia, di passare del buon tempo coi figli, e di lasciare loro qualcosa di più e di diverso da un’eredità di soli beni materiali. Che cosa? È presto per dirlo, ma la semplice presenza di un padre, restituito alla famiglia dalla nuova dimensione che ha assunto la casa dopo l’esperienza della pandemia, dei lockdown e del lavoro da remoto che ne è seguito, è già di per sé sufficiente a mettere in moto un cambiamento capace di segnare un’epoca.
Claudio Risé, psicoterapeuta e psicoanalista di formazione junghiana, il tema lo conosce a fondo: per anni ha indagato la crisi del ruolo paterno e l’origine e le conseguenze che l’espulsione dei padri dal nucleo familiare hanno provocato nelle persone e nella società. In un noto libro del 2003, Il Padre, l’assente inaccettabile, ma anche in Il mestiere di padre, come in molti altri saggi, ha aiutato a leggere in questa uscita di scena della figura paterna una delle ragioni del declino del senso religioso e della capacità di dare un significato alle prove della vita, spiegando molto del buio che ha segnato l’esistenza delle giovani generazioni.
Oggi Risé è in libreria con un nuovo testo, Il ritorno del padre (Edizioni San Paolo), aggiornamento del precedente, che sta riscuotendo grande interesse perché coglie un cambiamento forse inatteso, e apre uno sguardo rinnovato sui fenomeni in atto. Ciò che si starebbe manifestando è il tramonto della cultura degli anni Settanta e Ottanta e dei miti che hanno caratterizzato quella stagione, comprese le leggi che hanno contribuito all’indebolimento della famiglia. A guidare l’uscita dal deserto rappresentato dal «cinquantennio dei comportamenti sfrenati e dell’affettività gelida» sono i Millennials, i nati tra il 1980 e il 1990, ovvero i figli di chi è stato studente nel ’68, dunque la generazione che per prima si è trovata a pagare in pieno il prezzo di quella rivoluzione.
Uno degli effetti più visibili del cambio nei costumi sociali che ha caratterizzato gli anni 70 è stato il rigetto del matrimonio: a un certo punto per una generazione di maschi sposarsi è diventata una prospettiva da evitare, anche per la paura di ritrovarsi a vivere il dolore di un’esperienza traumatica che spesso era stata sperimentata in prima persona. Oggi invece, a detta di Risé, il giovane maschio è tornato a desiderare un nucleo all’interno del quale scambiare affetti e cure, «e se trova una ragazza che condivida questo sogno è ormai spesso in grado di sposarla».
Sull’espressione che usa Risé, «in grado» ci si potrebbe scrivere un intero saggio, perché è proprio l’uscita di scena del padre uno dei fattori all’origine del crollo dell’autostima nei figli. Ma è nella modalità in cui sta avvenendo questo clamoroso ritorno del padre, che si può cogliere l’intuizione di uno sguardo nuovo, forse quello che più merita di essere seguito nel tempo. Il cammino di riavvicinamento del padre alla famiglia era in corso da tempo, sottotraccia, e la pandemia lo ha probabilmente fatto detonare: la costrizione durante i periodi di lockdown prima e la possibilità dello smart working poi, potrebbero aver segnato un punto di non ritorno, grazie all’aumento significativo del tempo che il padre ha incominciato a passare in casa.
Questo movimento interessa tutte le età dai Millennials in avanti: generazioni forse meno avventurose delle precedenti, ma desiderose di stare di più con i figli e di migliorare la situazione affettiva propria e della prole. E non è proprio il padre di famiglia, come notava poeticamente Péguy, il solo avventuriero del mondo moderno?
Anche il fenomeno recentissimo della Great Resignation, la grande dimissione, che può essere letta dalle nostre parti come l’indisposizione ad accettare lavori totalizzanti, e che qualcuno ha visto come una forma di deriva individualistica e di rinuncia alla dimensione comunitaria della vita in azienda, per Risè può invece esprimere una tensione positiva. E se fosse una richiesta di tempo che prelude alla realizzazione come padri? L’embrione cioè di un desiderio che può rimettere al centro dell’esistenza «gli affetti, la famiglia e la fede, rimossi spesso negli ultimi 50 anni dalle ambizioni economiche e ansie per i diversi tipi di status sociale».
Non è la rinuncia al lavoro, insomma, quello che starebbe andando in scena, ma un poderoso processo di riconquista di quell’equilibrio familiare precedente alla rivoluzione industriale e all’avvento - dopo l’assenza delle figure paterne causato dalle due guerre - di imprese sempre più simili a voraci realtà aziendali che hanno finito per inghiottire ogni attività degli uomini arrivando ad ostacolare «la trasmissione diretta della maschilità».
La tarda modernità del ’900 descritta da Risé è una società inquietante, un mondo in cui le imprese-Grandi-madri hanno contribuito a creare il mito del guadagno e del successo per legare gli esseri umani alla dimensione delle cose, del consumo e dell’appagamento dei soli bisogni materiali, una società popolata da individui gentili, allegri, fintamente buoni, ma fondamentalmente fragili, soli, sradicati e incapaci di vedere la ferita, affrontare la perdita, sopportare il sacrificio, e dunque di elevarsi verso l’alto.
Se la cancellazione del padre è stato il processo con cui l’Occidente ha voluto eliminare l’esperienza di Dio non è detto che ora riportando il padre a casa tornerà anche tutto il resto - e d’altra parte la riscoperta della "famiglia di una volta" dovrebbe saper fare selezione conservando solo le cose buone. Il dato vero è che un po’ ovunque, dagli Stati Uniti all’Europa, oggi si legifera per agevolare il nuovo protagonismo dei padri. Processi che vanno sostenuti e rafforzati: la storia procede per cicli, dunque la decadenza non è un destino ineluttabile, matrimonio e natalità possono ancora rifiorire, la famiglia come gesto d’amore e «dono di sé agli altri» può ancora farsi rivedere. Per ora c’è che, fosse anche per qualche ora di smart working in più, il padre vuole ritornare. E, come sostiene Risé, «il padre non ritorna mai da solo, ma lo segue anche tutto il mondo Famigliare».
- Un saggio rilancia una presenza sempre meno significativa
Il ritorno del padre (Edizioni San Paolo 2022, pp. 220, euro 18,00) è il nuovo libro di Claudio Risé, psicoterapeuta e psicoanalista, già docente di Scienze sociali alle Università di Trieste-Gorizia, dell’Insubria (Varese) e della Bicocca (Milano). Il testo è un’edizione, completamente rivista alla luce delle profonde trasformazioni avvenute in questi anni, di un suo celebre saggio, Il Padre l’assente inaccettabile, uscito sempre per San Paolo nel 2003. Quasi due decenni dopo siamo di fronte a una svolta epocale. Scrive Risé: «Dal punto di vista psicologico il padre porta nella vita umana l’esperienza dinamica del muoversi, dell’andare. Fa dell’esistenza un movimento verso la pienezza con Dio e, allo stesso tempo, dona una liberazione dall’attaccamento, dall’egoistico trattenere e trattenersi, freno di ogni ricerca e divenire». Risé lavora da decenni sulla psicologia del maschile e sui problemi derivanti dalla crisi della figura paterna. Su questo tema ha pubblicato per San Paolo anche Il mestiere di padre. Tra i suoi testi più noti, Essere Uomini e Parsifal (Red edizioni), Cannabis. Come perdere la testa e a volte la vita (San Paolo 2007); Il maschio selvatico/2 (San Paolo 2015); Donne selvatiche (con M. Paregger, San Paolo 2015).
-
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio". La lezione di Melanie Klein rimeditata da Julia Kristeva, in un commento di Manuela Fraire.9 dicembre 2006, di Federico La Sala
Madri divise tra amore e odio verso i figli
di Umberto Galimberti (“la Repubblica”, 28 giugno 2002)
Il ritmo inquietante con cui, nel nostro tempo, si succedono i casi di infanticidio non ci consente più di relegare queste tragedie nella «casistica psichiatrica» e qui liquidarle nel perfetto stile della rimozione. La ricorrenza di simili eventi, ormai così frequente, obbliga tutti noi a una riflessione più seria, che forse può prendere le mosse da questa semplice domanda: è cambiato qualcosa nel rapporto madri e figli che la retorica dei buoni sentimenti custodisce e difende come la forma più sacra e indubitabile delle relazioni d’amore?
La risposta è: in parte no e in parte sì, ma entrambe le parti vanno esplorate, per scoprire e per rendersi conto, là dove nulla è cambiato, che l’amore materno non è mai solo amore perché ogni madre è attraversata dall’amore per i figli ma anche dal rifiuto dei figli, e là dove qualcosa è cambiato nel modo odierno di fare famiglia, si tratta di capire perché il rifiuto assume così di frequente la forma del gesto omicida.
1. Là dove nulla è cambiato. Incontriamo l’eterna ambivalenza del sentimento materno che solo il nostro terrore di sfiorare qualcosa che appartiene alla sfera del sacro non ci fa riconoscere. E così finiamo con il sapere troppo poco di noi e della potenza dei nostri moti inconsci. La retorica dei buoni sentimenti è una spessa coltre che stendiamo sull’ambivalenza della nostra anima, dove l’amore si incatena con l’odio, il piacere con il dolore, la benedizione con la maledizione, la luce del giorno con il buio della notte. Perché nel profondo tutte le cose sono incatenate e intrecciate in un’invisibile disarmonia. E scrutare l’abisso che queste cose sottende è compito ormai trascurato della nostra cultura che con troppa semplicità distingue il bene e il male come se i due non si fossero mai incontrati e affratellati.
Condannare queste madri per i loro gesti è già nelle cose stesse, nel parere di tutti, e rasenta i limiti dell’ovvio. Ma in ogni condanna che rivolgiamo agli altri c’è un volgare rigurgito di innocenza per noi stessi guadagnato a poco prezzo. Con la condanna, infatti, vogliamo soprattutto evitare di vedere in noi stessi, a livelli più sfumati senz’altro, non così tragici, la stessa ambivalenza che da sempre accompagna i nostri sentimenti per i figli, figli d’amore certo, ma anche di fastidio e in alcuni casi di odio. Non ci sarebbero tanti disperati nella vita se tutti, da bambini, fossero stati davvero amati e solo amati. E invece così non è, e non lo è soprattutto per la donna che, con la possibilità di generare e di abortire, sente dentro di sé, nel sottosuolo mai esplorato della sua coscienza, di essere depositaria di quello che l’umanità ha sempre identificato come «potere assoluto» : il potere di vita e di morte.
Nella donna, infatti, molto più marcatamente che nel maschio, si dibattono due soggettività antitetiche perché una vive a spese dell’altra. Una soggettività che dice «Io» e una soggettività che fa sentire la donna depositaria della «specie» . Il conflitto tra queste due soggettività è alla base dell’amore materno, ma anche dell’odio materno, perché il figlio, ogni figlio vive e si nutre del sacrificio della madre: sacrificio del suo tempo, del suo corpo, del suo spazio, del suo sonno, delle sue relazioni, del suo lavoro, della sua carriera, dei suoi affetti e anche amori, altri dall’amore per il figlio.
Questa ambivalenza del sentimento materno generato dalla doppia soggettività che è in ciascuno di noi, e che il mondo delle madri conosce meglio del mondo dei padri, va riconosciuto e accettato come cosa naturale e non con il senso di colpa che può nascere dall’interpretare come incompiutezza o inautenticità del sentimento quello che è la sua naturale ambivalenza. Qui da Medea, che, come vuole la tragedia di Euripide, uccide i figli che ha generato esercitando il potere di vita e di morte che ogni madre sente dentro di sé, alle madri di oggi che uccidono i figli da loro stesse nati, nulla è cambiato. Perché questa è la natura del sentimento materno, e, piaccia o non piaccia, come tale va riconosciuto e accettato.
2. Là dove qualcosa è cambiato. E’ la forma della famiglia: troppo nucleare, troppo isolata, troppo racchiusa nelle pareti di casa che, divenute troppo spesse, la recingono e la secretano, creando l’ambiente adatto alla disperazione, che non è la depressione. Nel chiuso di quelle pareti ogni problema si ingigantisce perché non c’è un altro punto di vista, un termine di confronto che possa relativizzare il problema, o che consenta di diluirlo nella comunicazione, quando non di attutirlo nell’aiuto e nel confronto che dagli altri può venire. Il nucleo familiare è diventato oggi un nucleo asociale. Quel che succede in casa resta lì compresso e incomunicato. Quando si esce di casa, ciascuno indossa una maschera, quella convenuta, il cui compito è di non lasciar trasparire proprio nulla dei drammi, delle gioie o dei dolori che si vivono dentro quelle mura ben protette.
La tutela della privacy ha proprio nella famiglia il suo cono d’ombra. La non ingerenza nel privato, se da un lato è il fondamento della nostra libertà personale, è anche un fattore di disinteressamento reciproco, e quindi una macchina formidabile che crea solitudine e, nella solitudine quell’ingigantimento dei problemi che la comunicazione sa ricondurre nella loro giusta dimensione, mentre l’isolamento rende di proporzioni tali da farli apparire ingestibili. Fino a quel limite dove l’unica via d’uscita sembra quella della soppressione violenta del problema, non importa in quale modo.
L’incapacità di gestire un regime familiare, dove le difficoltà oggettive possono mescolarsi con i fantasmi della mente e con le speranze deluse, produce una tragedia che forse poteva essere evitata se quel nucleo familiare si fosse aperto e reso permeabile allo scambio sociale, come accadeva presso i primitivi dove i figli erano figli di tutte le donne del villaggio, come accadeva fino a un paio di generazioni fa anche da noi, dove la povertà facilitava la socializzazione e l’aiuto reciproco in quell’incessante andare e vieni tra vicini di casa che rendeva impossibile quando non addirittura innaturale l’isolamento della famiglia.
L’isolamento riduce, e per via della riduzione, potenzia gli oggetti d’amore che per la donna, relegata nella clausura della famiglia, sono i figli e il marito. Qui le dinamiche, oggi, si sono complicate terribilmente, perché l’uomo ha perso il potere che una volta aveva come autorità riconosciuta in famiglia. Bene o male che fosse, forse più male che bene, ma così era, oggi l’uomo, dimessa l’autorità, stenta a trovare un ruolo in famiglia che non sia quello un po’ estrinseco di chi porta i soldi a casa. Per il resto lavora fuori casa e, stante la liceità dell’odierno costume, tende a erotizzare anche fuori casa. All’interno della casa resta solo l’amore incondizionato per i figli, più come idea, più come sentimento che come pratica quotidiana, di solito relegata alla moglie o all’esercito delle baby-sitter. La moglie è lì, spesso solo come anello che chiude il nucleo isolato del sistema famiglia.
E’ a quel punto che i figli diventano armi di ricatto. Dai ricatti che ogni giudice preposto alle separazioni conosce nei minimi e orrendi particolari, al ricatto estremo che solo il potere di vita e di morte, che è alla base del sentimento materno, conosce nella atroce radicalità che Euripide così descrive: «Uccidere le tue creature: ne avrai il coraggio?», chiede il Coro a Medea. E Medea risponde: «È il modo più sicuro per spezzare il cuore di mio marito» .
Scenari paurosi dell’animo umano che vanno riconosciuti e accettati, perché se non sono portati alla coscienza, si traducono facilmente in gesto, in gesto omicida. Non perché improvvisamente si è impazziti, ma perché da sempre si è vissuto con dei sentimenti che erano ignoti a noi stessi, e nell’isolamento impenetrabile in cui oggi vivono le famiglie, non si è avuto modo di comunicarli e, nella comunicazione, portarli alla coscienza e così diluirli, come sempre è avvenuto da che mondo è mondo e come oggi non avviene più.
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! Per andare oltre la vecchia "cattolica" alleanza Madre-Figlio (e portare avanti il programma illuministico: diventare maggiorenni), è necessario (sia per l’uomo sia per la donna) non solo il "parricidio" ma anche il "matricidio". La lezione di Melanie Klein rimeditata da Julia Kristeva, in un commento di Manuela Fraire.13 dicembre 2006, di Federico La Sala
Dalla parte delle madri
di Umberto Galimberti (la Repubblica, 9 dicembre 2006)
“Apolline aspetta un figlio, si sente strana, diversa rispetto alle altre gravidanze. Eppure il medico non ha dubbi: è tutto a posto. Il bambino cresce bene e tutti gli esami sono rassicuranti: ma Apolline è inquieta, come se si trattasse del primo figlio. Le sembra di non sapere niente del parto e di quello che viene dopo. Ha vissuto questi ultimi mesi come se dovesse affrontare qualcosa di ignoto, non osando confessare a chi le sta vicino che ha dei sentimenti strani riguardo a questa nuova maternità”.
Così prende avvio il libro di Sophie Marinopoulos, psicologa clinica e psicoanalista, che esercita a Nantes presso il reparto maternità del centro ospedaliero universitario. Il libro titola Nell’intimo delle madri. Luci e ombre della maternità . La tesi è che l’amore materno non è mai solo amore, perché ogni madre è attraversata dall’amore per il figlio, ma anche dal rifiuto del figlio. Talvolta il rifiuto ha il sopravvento sull’amore, e anche se non si arriva ai casi di infanticidio (il cui ritmo inquietante più non ci consente di relegare queste tragedie nella casistica psichiatrica e qui liquidarle nel perfetto stile della rimozione), l’ambivalenza del sentimento materno obbliga tutti noi a una riflessione più seria, che solo il terrore di sfiorare qualcosa che appartiene alla sfera del sacro ci evita di affrontare.
E così finiamo con il sapere troppo poco di noi e della potenza dei nostri moti inconsci. La retorica dei buoni sentimenti è una spessa coltre che stendiamo sull’ambivalenza della nostra anima, dove l’amore si incatena con l’odio, il piacere con il dolore, la benedizione con la maledizione, la luce del giorno con il buio della notte, perché nel profondo tutte le cose sono intrecciate in un’invisibile disarmonia. E scrutare l’abisso che queste cose sottende è compito ormai trascurato della nostra cultura, che con troppa semplicità distingue il bene dal male, come se i due non si fossero mai incontrati e affratellati.
Nella donna, infatti, molto più marcatamente che nel maschio, si dibattono due soggettività antitetiche perché una vive a spese dell’altra. Una soggettività che dice “io” e una soggettività che fa sentire la donna “depositaria della specie”.
Il conflitto tra queste due soggettività è alla base dell’amore materno, ma anche dell’odio materno, perché, come ci ricorda Sophie Marinopoulos, il figlio, ogni figlio, vive e si nutre del sacrificio della madre: sacrificio del suo tempo, del suo corpo, del suo spazio, del suo sonno, delle sue relazioni, del suo lavoro, della sua carriera, dei suoi affetti e anche amori, altri dall’amore per il figlio. Se poi il figlio è figlio dell’illegalità, del tradimento, della povertà, della paura, della sprovvedutezza, allora non solo il conflitto tra le due soggettività, ma anche l’impossibilità di prefigurare un futuro per il figlio scava nell’inconscio della madre quel che non vuol vedere e constatare ogni giorno: che il proprio figlio è troppo distante troppo dissimile dal proprio sogno o dal proprio desiderio.
È a questo punto che l’ambivalenza amore-odio, che il mondo delle madri conosce meglio del mondo dei padri, si potenzia e chiede una soluzione che non può trovarsi se non nel riconoscimento e nell’accettazione di questa ambivalenza come cosa naturale, e non con il senso di colpa che può nascere dall’interpretarla come incompiutezza o inautenticità del proprio sentimento.
Ma oggi tutto si complica per effetto della trasformazione che in questi anni ha subito la famiglia: troppo nucleare, troppo isolata, troppo racchiusa nelle pareti di casa che, divenute troppo spesse, la recingono e la secretano, creando l’ambiente adatto alla disperazione, che non è la depressione. Nel chiuso di quelle pareti ogni problema si ingigantisce perché non c’è un altro punto di vista, un termine di confronto che possa relativizzare il problema, o che consenta di diluirlo nella comunicazione, quando non di attutirlo nell’aiuto e nel confronto che dagli altri può venire.
Il nucleo familiare, osserva infatti Sophie Marinopoulos, è diventato oggi un nucleo asociale. Quel che succede in casa resta lì compresso e incomunicato. Quando si esce di casa, ciascuno indossa una maschera, quella convenuta, il cui compito è di non lasciar trasparire proprio nulla dei drammi, delle gioie o dei dolori che si vivono dentro quelle mura ben protette.
La tutela della privacy ha proprio nella famiglia il suo cono d’ombra. La non ingerenza nel privato, se da un lato è il fondamento della nostra libertà personale, è anche un fattore di disinteressamento reciproco, e quindi una macchina formidabile che crea solitudine e, nella solitudine, quell’ingigantimento dei problemi che la comunicazione sa ricondurre nella loro giusta dimensione, mentre l’isolamento li rende di proporzioni tali da farli apparire ingestibili. Fino a quel limite, dove l’unica via d’uscita sembra la soppressione violenta del problema, non importa in quale modo.
L’incapacità di gestire un regime familiare, dove le difficoltà oggettive possono mescolarsi con i fantasmi della mente e con le speranze deluse, produce una tragedia che forse poteva essere evitata se quel nucleo familiare si fosse aperto e reso permeabile allo scambio sociale, come accadeva presso i primitivi dove i figli erano figli di tutte le donne del villaggio, come accadeva fino a un paio di generazioni fa anche da noi, dove la povertà facilitava la socializzazione e l’aiuto reciproco, in quell’incessante andare e venire tra vicini di casa che rendeva impossibile, quando non addirittura innaturale, l’isolamento della famiglia.
La riduzione dei contatti sociali potenzia gli oggetti d’amore che per la donna, relegata nella clausura della famiglia, sono i figli e il marito. Al giorno d’oggi queste dinamiche si sono complicate terribilmente, perché l’uomo ha perso il potere che una volta aveva come autorità riconosciuta in famiglia. Bene o male che fosse, forse più male che bene, ma così era.
Dimessa l’autorità, oggi l’uomo stenta a trovare un ruolo in famiglia che non sia quello un po’ estrinseco di chi porta i soldi a casa. Per il resto lavora fuori casa e, stante la liceità dell’odierno costume, tende a erotizzare anche fuori casa.
All’interno della casa resta solo l’amore incondizionato per i figli, più come idea, più come sentimento che come pratica quotidiana, di solito relegata alla madre o all’esercito delle baby-sitter. La madre è lì, spesso, solo come anello che chiude il nucleo isolato del sistema famiglia.
Occorre allora denunciare, come fa Sophie Marinopoulos, la cultura dell’isolamento in cui la sacralizzazione del privato ha ridotto di fatto la famiglia, che troppo spesso registra in sé l’effetto del collasso sociale. Se infatti la società è solo la sommatoria delle solitudini delle famiglie, e i valori che oggi circolano non sono più solidarietà, relazione, comunicazione, aiuto reciproco, ma business, immagine, ricchezza, tranquillità, tutela della privacy, perché una famiglia inavvertita e inascoltata, e che a sua volta non ha voglia di farsi notare né di parlare, perché questa famiglia dovrebbe essere indotta a generare e per giunta con gioia?
Il rimedio suggerito è allora quello di “accudire le madri”, perché, per la forma che ha assunto la nostra società, forse, per molte donne, troppa è la metamorfosi del loro corpo, la rapina del loro tempo, l’occupazione del loro spazio fisico ed esteriore, interiore e profondo. E quando l’anima è vuota e nessuna carezza rassicura il sentimento, lo consolida e lo fortifica, il terribile è alle porte, non tanto come atto inconsulto, ma come svuotamento di quelle risorse che fanno argine all’amore separandolo dall’odio, allo sguardo sereno che tiene lontano il sentimento truce.
E allora non basta che i padri assistano al parto, come è costume dei tempi, molto più utile assistere madre e figlio nel logorio della quotidianità, accarezzare l’una e l’altro per creare quell’atmosfera di protezione che scalda il cuore e tiene separato l’amore dall’odio. Lavoro arduo, che tutti coloro che amano conoscono in quella sottile esperienza dove incerto è il confine tra un abbraccio che accoglie e un abbraccio che avvinghia e strozza.
La natura contamina questi estremi. E la madre, che genera e cresce nell’isolamento e nella solitudine, conosce quanto è fragile il limite. Non sa più cosa accade dentro di lei, e le sue azioni si compiono senza di lei. Per questo, natura vuole che a generare si sia in due, non solo al momento del concepimento e del parto, ma soprattutto nel momento dell’accudimento e della cura.
Dove a essere accudito, prima del figlio che segue la sua cadenza biologica, è la madre, che ha messo a disposizione prima il suo corpo, poi il suo tempo, poi il suo spazio esteriore e interiore, infine l’ambivalenza delle sue emozioni che camminano sempre sfiorando quel confine sottile che separa e a un tempo congiunge la vita e la morte, perché così vuole la natura nel suo aspetto materno e crudele, che le madri avvertono quando affondano in quella luce nera e così poco rassicurante che fa la sua comparsa nell’abisso della solitudine.
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!!16 gennaio 2007, di Federico La Sala
Un viaggio nel dolore inconfessabile
Reportage «Madri assassine» di Adriana Pannitteri, Gaffi editore. Vite negate. Omicidi agghiaccianti per donne schiacciate da un muto disagio
di Giovanni Senatore (il manifesto, 14.01.2007)
Adriana Pannitteri, giornalista Rai, volto del Tg1, è andata di persona a immergersi nello sguardo, pieno di dolore, di disperazione, a volte assente, di quelle donne così particolari: le mamme che hanno ucciso i propri figli e che dopo avere occupato con il loro gesto prime pagine di giornali e telegiornali, finiscono nelle celle linde e senza agenti dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, sul lago di Garda, struttura unica nel suo genere in Italia e in Europa.
E da questo viaggio attraverso i meandri della mente, le parole, le lacrime, i corpi di donne travolte, spesso nella solitudine, dalla incapacità di affrontare il rapporto con un essere umano appena nato o nei primi mesi di vita, ha preso forma un libro.
Si intitola Madri assassine - diario da Castiglione delle Stiviere (editore Gaffi, pp. 120, euro 10), straordinario percorso umano, tragico e rivelatore, in un mondo fatto di segni invisibili e di atrocità. «Per me non è un libro, ma il libro», afferma Adriana Pannitteri, che alterna la cronaca letteraria delle visite e dei colloqui con le protagoniste ad una narrazione semi-immaginaria, affidata ad una bambina, Maria Grazia, che ripercorre vicende dell’infanzia dalle quali emerge la figura di una mamma con problemi psichici. In apertura del libro, scrive: «E’ a Castiglione che sono andata a cercare la follia e il suo volto più inaccettabile». Un tempo manicomio criminale, con oltre 1000 reclusi in condizioni disumane, Castiglione oggi è l’unico ospedale psichiatrico giudiziario in Italia (150 ricoverati, 50 donne, 10-12 le madri assassine, ad aprile 2006) ad ospitare donne che hanno ucciso i propri figli. Niente agenti penitenziari, soltanto medici e infermieri, tutto personale del ministero della Sanità e degli enti locali, celle con il nome di fiori, una piscina, libero accesso alla tv. Si punta molto sul lavoro: pittura, formazione professionale, biblioteca. C’è la psicoterapia, ma prevale l’uso dei farmaci, nei casi più gravi la contenzione».
Storie di «omicidi agghiaccianti»: neonati messi in lavatrice, affogati, chiusi vivi dentro uno zaino, la bocca sigillata con la cucitrice per impedirgli di urlare. Atroce quotidianità, purtroppo. «Adriana è voluta andare oltre la cronaca - spiega la psichiatra Annelore Homberg nella prefazione - ha cercato di capire cosa accade a queste donne sia prima che dopo il fatto, anche per sfatare l’idea terrificante dell’espiazione, della punizione: devono avere la vita distrutta, perchè hanno distrutto quella del figlio. Il suo merito è quello di non avere creduto al concetto di male: le malattie vanno comprese nel loro originarsi. Si tratta di curarle, guarirle, prevenirle».
Tante persone negli incontri pubblici rivolgono ad Adriana Pannitteri domande sempre uguali: «Ma come è possibile», «è inconcepibile», «era una mamma felice», «aveva tutto: una famiglia normale...». E centinaia di donne, intanto, le confidano: «Anche io ho avuto un momento di difficoltà dopo il parto». «Due cose fanno più paura alla gente: il raptus e l’idea che la malattia mentale sia ereditaria - racconta la giornalista -. In realtà nei casi citati nel libro queste donne, in qualche modo, avevano avuto già problemi di depressione, di disagio psichico ed avevano lanciato un segnale di aiuto: forse se fossero state curate prima non avrebbero ucciso. C’è poi una tendenza americana - aggiunge - a ritenere che tutto è governato dal Dna, compreso il disagio mentale. Non è così. E’ tempo di liberarsi da queste cose. C’è una difficoltà a capire che spesso il disagio mentale si annida nella normalità, in relazioni malate; non si uccide un figlio per un momento di stress... E’ necessario allora dare alle persone la conoscenza e gli strumenti per riconoscere la malattia».
«Lo stesso concetto di raptus è assolutamente fasullo - afferma Annelore Homberg -. Questi casi non c’entrano niente con un’esplosione incontrollata di affetti. Il problema casomai è l’anaffettività, la mancanza di affetti. Molte volte prima c’è un’alterazione del pensiero, all’inizio invisibile, fino ad arrivare al livello cosciente, come delirio manifesto. Nella sua indagine giornalistica, Adriana scopre qualcosa che gli psichiatri dovrebbero sapere - prosegue la Homberg -: dietro questi delitti ci sono lunghe storie cliniche, sviluppate negli anni, ci sono state richieste di aiuto che l’ambiente intorno non ha avuto la sensibilità di capire, segnali rivolti anche a specialisti, non solo ai medici di famiglia. C’è da chiedersi se l’attuale formazione di psichiatri e psicologi è sufficiente per cogliere la distruttività della malattia mentale».
Nel libro parlano anche il direttore di Castiglione delle Stiviere, Antonino Calogero, il medico, dottor Esti, gli infermieri. Gite nel bosco. La spesa tutte insieme. «E’ un luogo veramente particolarissimo - insiste Adriana -, c’è un clima infinitamente migliore rispetto all’ospedale giudiziario o al carcere. Il grande interrogativo che mi resta, però, è quante di queste donne riescono ad uscire dal tunnel e a vivere decentemente? Questo loro non te lo dicono».
Solo una mamma «assassina» su tre finisce nella struttura speciale sul lago di Garda. «Il nodo fondamentale, nel bene e ne male, è chi fa la perizia, gli psichiatri di cui si avvalgono i magistrati», spiega la Pannitteri. E c’è anche il caso di Maria Patrizio, la madre che annegò il figlio nella vaschetta da bagno, in attesa di giudizio, dichiarata «sana di mente», che ora dovrebbe lasciare Castiglione, per andare in carcere.
Secondo l’Istat, venti figli all’anno vengono uccisi dai genitori. «Non mi sentirei di dire che sono casi in aumento - dice Adriana Pannitteri -, credo che in passato se ne parlasse pochissimo. Cogne ha acceso una luce su casi confinati in brevi di cronaca». I crimini in famiglia, invece, sono aumentati di sei volte in soli cinque anni». Il libro è organizzato attorno al racconto, fantastico, di una bambina, Maria Grazia e si chiude con una luce di speranza.
-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!!4 giugno 2007, di Federico La Sala
DIRITTO
Se a Roma il «pater familias» era sovrano assoluto e i cristiani introdussero l’idea dei «doveri» del genitore, dal Medioevo in poi l’autorità sui figli è entrata in crisi. Un saggio di Marco Cavina spiega perché
Paternità, un declino durato mille anni
di Giulia Galeotti (Avvenire, 02.06.2007)
Che l’autorità paterna sia un concetto giuridico ormai superato è noto. Meno note sono però le profonde variazioni che essa ha vissuto nei secoli, variazioni oggetto del recente volume di Marco Cavina, Il padre spodestato. Se l’autorità paterna era assoluta per i potenti padri biblici e romani, una novità l’ha proposta il cristianesimo, introducendo due principi rivoluzionari: la rottura dei vincoli familiari in nome di valori più alti e, soprattutto, l’affiancare al concetto di potere quello di dovere del padre. Altri snodi cruciali saranno poi due momenti piuttosto vicini tra loro, la Rivoluzione francese e gli anni Sessanta del Novecento: dopo una longevità millenaria, infatti, in soli due secoli si è realizzato il definitivo affossamento dell’autorità paterna. Il volume, ricco d’informazioni (specie fino a tutta l’età moderna), mostra che il quadro è più complesso di quanto ci si aspetterebbe. Una riprova sono gli oltre venti punti in cui i trattatisti del tardo Medioevo individuavano le articolazioni dell’autorità paterna. Molti i diritti, come la vendita dei figli per necessità di fame, il diritto del padre di uccidere la figlia colta in adulterio, l’obbligo del figlio di seguire la religione paterna (salvo che per i figli di ebrei), il potere di far incarcerare o castigare dal giudice il figlio. Non mancavano però i doveri, come la perdita della patria potestà per induzione della figlia alla prostituzione o l’obbligo di riscattare il figlio prigioniero. Al godimento di vantaggi e privilegi pubblici per meriti paterni, corrispondeva specularmente l’imposizione di svantaggi per peccati o delitti del medesimo.
Secondo Cavina, docente di Storia del diritto medievale e moderno, il progressivo annientamento del potere paterno ha dei precisi responsabili: l’individualismo borghese, l’industrializzazione, lo statalismo, la trasformazione del mercato del lavoro e l’emancipazione femminile. Come per il giusnaturalismo lo Stato non è più un’autorità per diritto divino, ma per libero contratto tra gli individui, così la famiglia è fondata non più su un padre investito di potere naturale, ma su una pattuizione. Si parlava dunque di legittimazione gerarchica sulla base dell’atto di generazione; di legittimazione contrattualista in nome del tacito consenso dei figli; soprattutto, però, era seguita la spiegazione funzionale-utilitaria: il potere del padre sul figlio era dovuto all’incapacità di quest’ultimo di gestirsi autonomamente (da cui il venir meno della perpetuità della patria potestà del modello romano). La motivazione per sottrarre all’autorità paterna buona parte delle sue articolazioni sarebbe stata l’interesse del figlio: è in nome di costui che lo Stato entra nella famiglia. «Un puerocentrismo promosso dallo Stato divenne la parola d’ordine delle democrazie liberali», scrive Cavina. Tra l’altro, ciò è l’ennesima riprova dell’infondatezza dello stereotipo che vuole i totalitarismi particolarmente invasivi nelle relazioni domestiche, mentre si tratta di un’"invasione" condivisa in toto dalle politiche democratiche.
Cavina coglie due "capitolazioni" emblematiche per l’autorità paterna in età contemporanea. Il primo durissimo colpo le viene inferto nell’Ottocento quando istituti come la diseredazione o la libertà testamentaria vengono fortemente ridotti: riformare il sistema successorio in senso egualitario significa, infatti, sottrarre al padre qualsiasi possibilità di investire patrimonialmente il proprio successore. L’altro attacco, molto più recente, è quello al cognome paterno, simbolo della supremazia del padre e strumento per garantire l’unità domestica. Via via che nei vari Paesi si è diffusa la possibilità di scegliere il cognome per i figli, infatti, «il cuore stesso del patrimonio simbolico trasmesso dal padre è stato annientato, o quasi». Con quali conseguenze, è da vedere. Questo però il diritto non lo dice, potendo solo registrare i cambiamenti in atto.
 Marco Cavina
Marco Cavina
 Il padre spodestato
Il padre spodestato
 L’autorità paterna dall’antichità a oggi
L’autorità paterna dall’antichità a oggi Laterza. Pagine 360. Euro 20,00
Laterza. Pagine 360. Euro 20,00-
> Pensare l’ "edipo completo"(Freud), a partire dall’ "infanticidio"!!! --- Da Freud a Brecht, i personaggi di Edipo e Antigone restano due punti fermi della cultura contemporanea (di Daniele Piccini - Sofocle, la colpa e la ribellione).7 marzo 2012, di Federico La Sala
Sofocle, la colpa e la ribellione
Da Freud a Brecht, i personaggi di Edipo e Antigone restano due punti fermi della cultura contemporanea
di Daniele Piccini (Corriere della Sera, 07.03.2012)
È il 15 ottobre del 1897 quando per la prima volta Sigmund Freud, scrivendo a Wilhelm Fliess, fa riferimento all’Edipo re di Sofocle per avvalorare la sua teoria dei rapporti familiari, incentrata su quello che chiamerà poi il complesso di Edipo. La tragedia, come Freud precisò in seguito, sarebbe qualcosa come la materializzazione di un sogno, che mette in scena la pulsione del personaggio all’amore per la madre e all’odio omicida per il padre e li rappresenta come effettivamente avvenuti, scatenando il senso di colpa e la catastrofe: una trama, dunque, che permetterebbe di leggere l’abisso dell’inconscio, le pulsioni di una fase dello sviluppo infantile. La tragedia di Sofocle, rappresentata forse tra il 430 e il 425 a.C., diventa la matrice di una delle più celebri teorie della psicanalisi, inaugurando un ricchissimo filone di interpretazioni e di riscritture.
Era giusta o forzosa la lettura freudiana, il suo catturare la complessa materia dell’Edipo re, inchiodandola alla definizione del complesso edipico? Molti hanno accettato la traccia interpretativa, altri vi si sono opposti, considerandola un tradimento dell’originaria verità della tragedia (ad esempio Jean-Pierre Vernant).
Basta leggere il libro ricco e denso di Guido Paduano, Lunga storia di Edipo re. Freud, Sofocle e il teatro occidentale, per rendersi conto della vastissima trama esegetica e interpretativa che ha preso ad oggetto Edipo, così come del ventaglio di riscritture, variazioni, adattamenti che esso ha generato, in epoca antica e moderna: dall’Oedipus di Seneca a Corneille, da Hugo von Hofmannsthal a Pasolini e Testori.
Il fascio di luce, concentrato e unidirezionale, gettato dal fondatore della psicanalisi sulla tragedia obbliga a prendere atto di una circostanza, «che non è mai stato forse compiuto nessun altro così profondo e impegnativo, così rischioso e commovente, atto di fiducia nella letteratura e nel suo valore di verità» (Paduano). Vale a dire che Freud trattò le ombre dell’irripetibile stagione tragica ateniese come cose salde, accettando il potenziale veritativo dell’opera di Sofocle (vissuto per ben novant’anni, tra il 496 e il 406 a.C., nell’Atene democratica). Con ciò ci obbliga a considerare la prepotente forza semantica della tragedia, giacimento di senso pressoché inesauribile.
Il meccanismo edipico enucleato da Freud è rinvenibile nella tragedia, ma essa non vi si esaurisce, pronta a liberare nuovi significati. Certo, la lettura freudiana può vantare appoggi e indizi sparsi nell’Edipo re, come quando Giocasta, proprio nel tentativo di dissuadere Edipo dalla sua pervicace indagine, gli dice: «Tanti uomini prima d’oggi si sono congiunti in sogno con la propria madre».
Ma d’altra parte la tragedia è anche altro: è sottolineatura di una radicale ironia tragica, che vede il detentore del potere trascinato da un potere verticale e inconoscibile, il decifratore di enigmi incapace di decifrare se stesso; è evocazione della fatalità del furore divino, di cui gli uomini sono succubi, sebbene Edipo collabori attivamente, per smania di conoscere, alla propria distruzione; è riflessione sul potere che scivola verso la chiusura e la tirannide.
Il dato che balza in evidenza, nell’osservare il brulicare di letture e controinterpretazioni, è che il fondo dell’opera è inattingibile: Edipo re è voce del paradosso, della fragilità che si scopre tale sotto armature di regalità, è inchiesta rovinosa e monito sull’abissalità del volere divino, sulla perentorietà della profezia; è creatura viva e non infilzata negli album di una storiografia letteraria (o psicanalitica) pacificamente risolta. È, insomma, avventura intellettuale in movimento.
Non minore capacità di parlare attraverso i secoli e le culture (arrivando a interessare quella cristiana) è da riconoscersi all’eroina, inflessibile quanto il fratello-padre Edipo, che dà il titolo alla tragedia rappresentata nel 442 a.C.: Antigone.
Coinvolta nella terribile catastrofe paterna (è evocata in chiusa dell’Edipo re, cronologicamente successivo), è lei che nell’Edipo a Colono accompagna il genitore cieco in esilio. Nella tragedia che la vede protagonista si oppone al nuovo re di Tebe, Creonte (suo zio), che dopo la vicendevole uccisione di Eteocle e Polinice, fratelli di Antigone, permette di seppellire il primo, ma non il secondo, considerato per il suo assalto a Tebe traditore della patria. Antigone decide di dare sepoltura al corpo di Polinice nonostante il bando del re, incarnando quello spirito della «sorellanza» tanto caro ai lettori idealisti e romantici, che imposero il mito moderno della tragedia.
La conflittualità tra le due istanze è radicale: Creonte parla in nome del rispetto delle leggi umane, giuste o ingiuste che siano, e scivola verso la tirannia; Antigone è accesa di folle devozione per le leggi non scritte degli dei: stoltezza apparente che si nutre di ragione profonda. Le opposte inflessibilità confliggono e non c’è tempo, secondo il demone tragico, per accordarle.
Perciò Antigone brilla nel breve spazio della sua obiezione: personaggio che il Novecento ha rivestito (con Brecht, ad esempio) del motivo della resistenza allo Stato totalitario oppure ha rivisitato obliquamente, quasi come una creatura invasata e consacrata alla morte (così in Ritsos, che la fa rievocare dalla sorella Ismene: le molte riscritture del personaggio sono squadernate nell’affascinante Le Antigoni di George Steiner). Anche Creonte accende domande: può egli rappresentare le legittime ragioni dello Stato, come il filone interpretativo hegeliano suggerisce, o incarna piuttosto l’arbitrio del tiranno? Le voci di queste dramatis personae sono nel cuore della nostra democrazia, imperfetta come ogni altra costruzione civile. Clamano e risuonano, si agitano in noi.
-
-
-
-
-